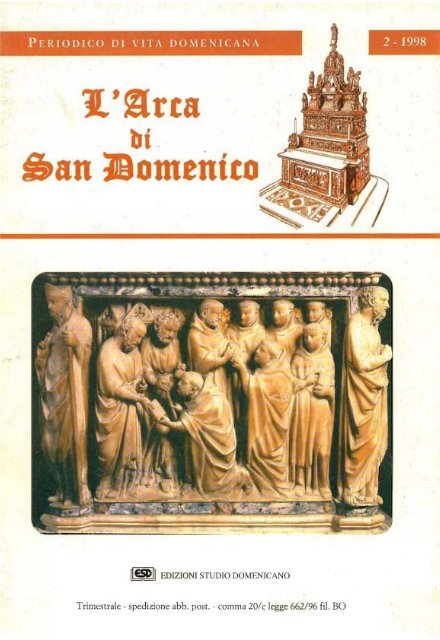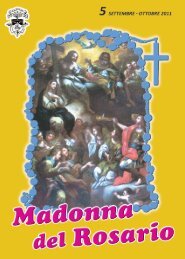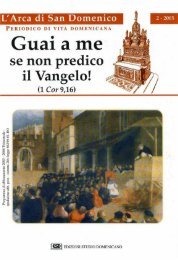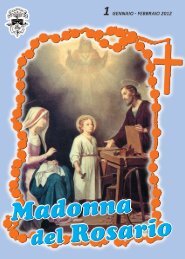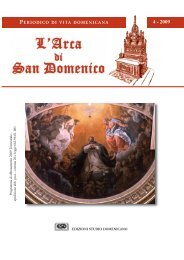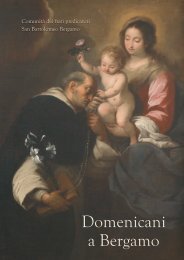aprile - giugno - (Domenicani) - Provincia San Domenico in Italia
aprile - giugno - (Domenicani) - Provincia San Domenico in Italia
aprile - giugno - (Domenicani) - Provincia San Domenico in Italia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
I punto<br />
Il Capitolo Generale dei <strong>Domenicani</strong><br />
BOLOGNA, LUGLIO-AGOSTO 1998<br />
Gli amici dei <strong>Domenicani</strong> di Bologna sanno che nei mesi di luglio e agosto 1998 si<br />
tiene, nel Convento di S. <strong>Domenico</strong>, 1'assemblea generale - o Capitolo Generale - dei<br />
rappresentanti dei settemila Frati Predicatori sparsi <strong>in</strong> tutto il mondo.<br />
Il programma di vita dei <strong>Domenicani</strong>, e di tutti gli altri religiosi, uom<strong>in</strong>i e donne,<br />
deve proprio sembrare utopistico e bizzarro agli uom<strong>in</strong>i del nostro tempo. Da una<br />
parte un mondo materialista, tutto protesto verso "valori" terreni, quali l'affermazione,<br />
la personalità, il piacere, la posizione sociale, il denaro; dall' altra una schiera compatta<br />
- anche se numericamente <strong>in</strong>fima rispetto a quelli che ricercano una vita facile - che<br />
faticosamente, ma con tanto coraggio, si sforza di predicare beni spirituali, cioè impalpabili,<br />
e futuri.<br />
Questi religiosi sono proprio dei coraggiosi. Per Cristo hanno lasciato tutto (case,<br />
genitori, una loro famiglia) per predicare la Buona Novella. E qu<strong>in</strong>di, <strong>in</strong> nome del loro<br />
Maestro crocifisso, essi parlano d'amore quando c'è odio, <strong>in</strong>vitano alla povertà terrena<br />
<strong>in</strong> cambio di ricchezze soprannaturali, <strong>in</strong>dicano la castità come mezzo per consacrarsi<br />
completamente al Dio <strong>in</strong>visibile, predicano 1'obbedienza per arrivare a una totale liberazione<br />
e accolgono la sofferenza <strong>in</strong> vista della glorificazione.<br />
Ma il loro coraggio si sp<strong>in</strong>ge anche oltre. Ogni tre anni essi si radunano <strong>in</strong> Capitolo<br />
(la parola Capitolo è il dim<strong>in</strong>utivo del lat<strong>in</strong>o "caput", cioè capo, testa) per eleggere i<br />
superiori maggiori dell'Ord<strong>in</strong>e, ma sopratutto per esam<strong>in</strong>arsi, <strong>in</strong>terrogarsi, r<strong>in</strong>novarsi<br />
e aggiornarsi. Il compito primario del Capitolo qu<strong>in</strong>di consiste nel predisporre uom<strong>in</strong>i,<br />
leggi e strumenti per un' azione più efficace, una testimonianza più vera, rispecchiandosi<br />
nel modello Gesù Cristo e confrontandosi con le esigenze della società di oggi.<br />
Ci vuole coraggio, e molto, anche per quest'opera di r<strong>in</strong>novamento. Si tratta di riconoscere<br />
eventuali manchevolezze, di r<strong>in</strong>unciare ad alcune sicurezze del passato, di<br />
aprire nuove vie che non sono mai prive di rischi. Uniça e sola garanzia la parola di<br />
Gesù: "lo sono con voi tutti i giorni, f<strong>in</strong>o alla f<strong>in</strong>e del mondo" (Mt 28,20).<br />
I <strong>Domenicani</strong> si consolano anche ricordando le parole del loro. Fondatore il quale,<br />
proprio qui a Bologna, prima di morire ha promesso loro: "Vi sarò più utile dal cielo di<br />
quanto non lo sia stato <strong>in</strong> terra".<br />
3<br />
P. VINCENZO BENETOLLO O.P.
Frati <strong>Domenicani</strong><br />
U n nuovo<br />
Capitolo Generale<br />
a Bologna<br />
Nei prossimi mesi di luglio e di agosto<br />
si celebrerà nel nostro Convento di<br />
<strong>San</strong> <strong>Domenico</strong> il 284 0 Capitolo Generale<br />
dell'Ord<strong>in</strong>e Domenicano, che sarà il<br />
trentaduesimo celebrato a Bologna.<br />
La decisione di far svolgere il Capitolo<br />
nella città <strong>in</strong> cui è morto <strong>San</strong> Domelùco<br />
è stata presa nel 1995 dal precedente<br />
Capitolo, che si è tenuto a Caleruega, <strong>in</strong><br />
Spagna, il piccolo paese <strong>in</strong> cui <strong>San</strong> <strong>Domenico</strong><br />
è nato.<br />
"Dalla nascita alla Gloria" o, se si<br />
preferisce, "La memoria delle due nascite":<br />
questa sembra essere stata l'idea che<br />
si è voluto suggerire, riprendendo forse<br />
l'<strong>in</strong>tuizione che già aveva guidato i Frati<br />
Capitolari negli anni 1958 e1961, anni <strong>in</strong><br />
cui i Capitoli si svolsero con la stessa<br />
successione: cioè Caleruega prima e Bologna<br />
poi.<br />
In questo secolo qu<strong>in</strong>di due Capitoli<br />
Generali si sono svolti a Bologna, dopo<br />
un tempo lunghissimo, più di due secoli,<br />
di "dimenticanza".<br />
I Capitoli Generali a Bologna<br />
Nel XIII secolo <strong>in</strong>fatti a Bologna vennero<br />
celebrati ben diciotto Capitoli, altri<br />
quattro nel XIV, tre nel XV, solo uno nel<br />
XVI e XVII, due nel XVIII; dal 1748 al<br />
.1961 viè stata, come si diceva, una lunga<br />
<strong>in</strong>terruzione.<br />
La pr<strong>in</strong>cipale ragione storica di questa"<br />
dimenticanza", oltre allo sviluppo<br />
dell'Ord<strong>in</strong>e <strong>in</strong> tutte le parti del mondo e,<br />
di conseguenza, alla possibilità di. una<br />
più ampia scelta tra le città dove <strong>in</strong>dire i<br />
Capitoli, è stata la duplice soppressione<br />
degli Ord<strong>in</strong>i religiosi avvenuta <strong>in</strong> <strong>Italia</strong>.<br />
4<br />
La prima soppressione del Convento<br />
di Bologna è stata decretata dal Senato<br />
cittad<strong>in</strong>o il 6 <strong>giugno</strong> 1798: ai 103 Frati<br />
viene vietato di vivere <strong>in</strong> comune, viene<br />
proibito di portare l'abito religioso e<br />
viene imposto di abbandonare <strong>in</strong> brevissimo<br />
tempo (dieci giorni) il Convento.<br />
Era questa una conseguenza dell' occupazione<br />
napoleonica: l'entrata <strong>in</strong> città delle<br />
truppe francesi era <strong>in</strong>fatti avvenuta il lO<br />
<strong>giugno</strong> 1796. Il Convento è dest<strong>in</strong>ato <strong>in</strong><br />
parte a caserma, a biblioteca municipale,<br />
a scuole pubbliche e ad abitazioni civili.<br />
Solo ilIo gennaio 1826 i Frati, che<br />
avevano ricostituito una comunità a<br />
Bologna dal 3 febbraio 1824, <strong>in</strong>com<strong>in</strong>ciarono<br />
a entrare <strong>in</strong> possesso, con gravi difficoltà,<br />
della chiesa e del Convento.<br />
Quando il 7 luglio 1866 il Parlamento<br />
italiano approvò la legge che sancì una<br />
seconda soppressione degli Ord<strong>in</strong>i religiosi,<br />
i Frati non erano ancora riusciti a<br />
riappropriarsi completamente dei locali<br />
del Convento.<br />
Poi nel 1904 riottennero l'uso della<br />
chiesa e di altri ambienti vic<strong>in</strong>i, e solo<br />
dal 1924 furono restituiti "<strong>in</strong> uso" il<br />
primo chiostro e alculÙ locali adiacenti.<br />
Altre restituziolÙ -' sempre "<strong>in</strong> uso" -<br />
concesse verso il 1955 hanno permesso,<br />
tra l'altro, il riprist<strong>in</strong>o della biblioteca<br />
monumentale ... e anche la possibilità di<br />
ospitare nuovamente i Frati Capitolari!<br />
Che cosa è e che cosa fa<br />
un Capitolo Generale<br />
Nell'Ord<strong>in</strong>e Domenicano il Capitolo<br />
Generale è l'organo più alto di governo<br />
e dell'esercizio dell'autorità. Infatti è<br />
compito del Capitolo Generale trattare e
def<strong>in</strong>ire quanto riguarda il bene di tutto<br />
l'Ord<strong>in</strong>e ed eleggere, quando necessita,<br />
il Maestro Generale.<br />
Ci sono tre tipi di Capitolo Generale:<br />
il Capitolo elettivo, che nom<strong>in</strong>a il nuovo<br />
Maestro Generale dell'Ord<strong>in</strong>e, quello dei<br />
Def<strong>in</strong>itori (sono i rappresentanti eletti<br />
che non ricoprono la carica di superiore)<br />
e quello dei Priori <strong>Prov<strong>in</strong>cia</strong>li (cioè i Frati<br />
che hanno responsabilità di governo nelle<br />
Prov<strong>in</strong>ce religiose). L'autorità delle tre<br />
assemblee è <strong>in</strong> pratica la stessa, perché<br />
ognuna può rivolgere esortazioni, decidere<br />
di apportare variazioni nella legislazione,<br />
<strong>in</strong>trodurre cambiamenti immediatamente<br />
operativi (quasi dei decreti<br />
L'organizzazione<br />
Lo svolgimento di un Capitolo Generale<br />
è piuttosto complesso. Sono veramente<br />
passati i tempi <strong>in</strong> cui il Capitolo<br />
doveva durare solo una settimana (l'ottava<br />
di Pentecoste), oppure dieci giorni,<br />
e i cui partecipanti erano normalmente<br />
ventic<strong>in</strong>que o al massimo una trent<strong>in</strong>a e<br />
tutti parlavano soltanto <strong>in</strong> lat<strong>in</strong>o ...<br />
La preparazione immediata del Capitolo<br />
avviene, oggi, almeno a tre livelli.<br />
Prima di tutto si svolgono gli <strong>in</strong>contri<br />
dei futuri Capitolari, che <strong>in</strong>com<strong>in</strong>ciano a<br />
conoscersi, almeno per regioni l<strong>in</strong>guistiche,<br />
<strong>in</strong> modo da abbozzare i contenuti e<br />
metodi di lavoro.<br />
5<br />
Frati <strong>Domenicani</strong><br />
legge che hanno valore f<strong>in</strong>o al Capitolo<br />
successivo), stabilire ord<strong>in</strong>azioni per tutto<br />
l'Ord<strong>in</strong>e, aprire nuove case, chiedere<br />
al Maestro Generale di farsi carico dell' esecuzione<br />
di alcune decisioni ...<br />
Perché un cambiamento delle leggi<br />
dell'Ord<strong>in</strong>e (le Costituzioni) diventi stabile,<br />
è necessaria l'approvazione di tre<br />
Capitoli uno di seguito all' altro.<br />
L'alternanza di un Capitolo di Def<strong>in</strong>itori<br />
e di un Capitolo di Priori <strong>Prov<strong>in</strong>cia</strong>li,<br />
dopo il Capitolo elettivo, serve a mantenere<br />
un buon equilibrio e un consenso<br />
generalizzato nello sviluppo della legislazione,<br />
<strong>in</strong> relazione alle esigenze sempre<br />
nuove della vita concreta dei Frati .<br />
. Il Salone fatto costruire<br />
nel 1497 dal giurista<br />
Lodovico Bologn<strong>in</strong>i<br />
per ospitare la biblioteca.<br />
In questa sala si terranno<br />
le sedute<br />
. del Capitolo Generale.<br />
C'è poi il compito di coord<strong>in</strong>are tutti<br />
questi <strong>in</strong>contri e di preparare (con traduzione<br />
<strong>in</strong> più l<strong>in</strong>gue) tutti i documenti<br />
prodotti (la relazione del Maestro<br />
Generale e degli altri ufficiali suoi collaboratori,<br />
le diverse relazioni dei Priori<br />
<strong>Prov<strong>in</strong>cia</strong>li, le numerose richieste e<br />
<strong>in</strong>terrogazioni rivolte al Capitolo), che<br />
viene svolto con la consueta competenza,<br />
data la lunga esperienza, dai confratelli<br />
e consorelle che lavorano nella<br />
segreteria generale dell'Ord<strong>in</strong>e.<br />
Vi è <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e il lavoro di organizzazione<br />
più concreta, che è svolto da una segreteria<br />
apposita del Capitolo, per garantire<br />
il buon funzionamento di tutto ciò che
Frati <strong>Domenicani</strong><br />
serve alle attività dell' assemblea: la traduzione<br />
simultanea, la votazione elettronica,<br />
i computer, i collegamenti<br />
Internet, i viaggi culturali di relax, il<br />
contatto con le Autorità locali (ecclesiastiche,<br />
ma anche civili: amm<strong>in</strong>istrative,<br />
culturali, f<strong>in</strong>anziarie, associative e di<br />
categoria ... ), i rapporti con i mass media,<br />
l'<strong>in</strong>dicazione degli it<strong>in</strong>erari per giungere<br />
al Convento, la fraterna accoglienza e la<br />
serena convivenza di tutti i partecipanti.<br />
In pratica, dalla matita al modem ... all'aereo.<br />
Partecipanti, commissioni<br />
e svolgimento<br />
Al Capitolo Generale "Bologna 98"<br />
saranno presenti <strong>in</strong> tutto 125 partecipanti<br />
così suddivisi: sessanta sono i Frati Capitolari<br />
con diritto di voto: il Maestro dell'Ord<strong>in</strong>e,<br />
trentasette Priori <strong>Prov<strong>in</strong>cia</strong>li, tre<br />
Vicepriori <strong>Prov<strong>in</strong>cia</strong>li, nove Vicari Generali,<br />
otto delegati di Vicariati Regionali o<br />
<strong>Prov<strong>in</strong>cia</strong>li e due delegati dei Conventi<br />
sotto la diretta giurisdizione del Maestro<br />
dell'Ord<strong>in</strong>e .<br />
. Otto saranno gli <strong>in</strong>vitati: tre Monache,<br />
due Suore e tre Laici.<br />
Inoltre, quali aiuti per il concreto 1/ funzionamento"<br />
delle attività capitolari, vi<br />
saranno: diciassette traduttori e <strong>in</strong>terpreti<br />
(due Suore e qu<strong>in</strong>dici Frati), quattro Frati<br />
studenti per la stesura dei verbali, due<br />
Frati che cureranno gli Atti (i documenti<br />
f<strong>in</strong>ali), un esperto di Internet e diciotto<br />
religiosi e due religiose che assicureranno<br />
i vari servizi, soprattutto l'organizzazione<br />
delle celebrazioni liturgiche.<br />
Inoltre vi sarà una Segreteria, composta<br />
da quattro Frati, che avrà il compito<br />
di coord<strong>in</strong>are tutte le attività.<br />
I primi quattro giorni del Capitolo<br />
sono dedicati a favorire la conoscenza<br />
reciproca dei Capitolari mediante discussioni<br />
su temi generali, ovviamente<br />
di <strong>in</strong>teresse comune, e <strong>in</strong>contri di preghiera:<br />
nei primi tre giorni molti dibatti-<br />
6<br />
ti, nel quarto silenzio e preghiera.<br />
I temi prescelti sono i seguenti: Missione<br />
e Cultura; l'Ord<strong>in</strong>e <strong>in</strong> Asia; la Donna<br />
nell'Ord<strong>in</strong>e e nella Chiesa; la Famiglia<br />
Domenicana: affettività e formazione;<br />
Governo domenicano: democrazia e collaborazione.<br />
Alcuni esperti presenteranno<br />
una breve relazione e i Capitolari, prima<br />
<strong>in</strong> piccoli gruppi l<strong>in</strong>guistici poi <strong>in</strong> assemblea<br />
plenaria, si conosceranno ... discutendo.<br />
Dal qu<strong>in</strong>to giorno <strong>in</strong> poi <strong>in</strong>izieranno i<br />
lavori delle commissioni. Tutti i Capitolari<br />
sono già stati, anche se <strong>in</strong> modo<br />
solo provvisorio, assegnati ad apposite<br />
commissioni (Comunità e formazione;<br />
Famiglia Domenicana; Economia; Governo;<br />
Costituzioni; Missione dell'Ord<strong>in</strong>e) <strong>in</strong><br />
ragione delle loro richieste e anche delle<br />
l<strong>in</strong>gue conosciute.<br />
Quando ogni commissione avrà elaborato<br />
le sue proposte le presenterà all'assemblea<br />
plenaria che le voterà. Se non<br />
saranno approvate verranno r<strong>in</strong>viate alla<br />
commissione perché le rielabori secondo<br />
i criteri suggeriti dall' assemblea.<br />
Realizzazioni avvenute<br />
e <strong>in</strong> divenire<br />
Il Convento di Bologna, con l'aiuto di<br />
tanti amici (sono stati costituiti un Comitato<br />
d'Onore, presieduto dal Card<strong>in</strong>ale<br />
Arcivescovo e dal Prefetto, e un Comitato<br />
Operativo), si sta preparando all'<strong>in</strong>contro<br />
anche con una serie di lavori<br />
di restauro e miglioramento dell' edificio<br />
e degli ambienti.<br />
La completa ristrutturazione del Collegio<br />
Universitario adiacente al Convento,<br />
il restauro del reliquiario del "Capo di<br />
<strong>San</strong> <strong>Domenico</strong>", la ripulitura dell'<strong>in</strong>terno<br />
della Basilica, di alcuni dip<strong>in</strong>ti, di gruppi<br />
scultorei significativi e del coro, la sistemazione<br />
del chiostro d'<strong>in</strong>gresso con il fissaggio<br />
di tutte le lapidi, l'illum<strong>in</strong>azione<br />
della Piazza <strong>San</strong> <strong>Domenico</strong>, la ripulitura<br />
della cappella dell' Arca di <strong>San</strong> Domeni-
Frati <strong>Domenicani</strong><br />
Il Savonarola a Bologna<br />
Parlando di Girolamo Savonarola,<br />
viene immediato collegare le vicende del<br />
grande domenicano alla città di Firenze,<br />
teatro delle sue più celebri predicazioni e<br />
dei suoi <strong>in</strong>terventi <strong>in</strong> campo politico, f<strong>in</strong>o<br />
all'impiccagione e al rogo, avvenuti <strong>in</strong><br />
piazza della Signoria il 23 maggio 1498.<br />
Molto meno conosciuta è la presenza<br />
del Savonarola a Bologna: otto anni <strong>in</strong> totale,<br />
e di fondamentale importanza nella<br />
sua formazione.<br />
Non è questa la sede per trattare i complessi<br />
problemi relativi alla scomuhica,<br />
ampiamente esam<strong>in</strong>ati da vari studiosi,<br />
fra i quali i domenicani Centi e Scaltriti,<br />
come pure dall' ormai" classica" biografia<br />
scritta dal marchese Ridolfi. Padre Centi<br />
sta attualmente curando una serie di<br />
pubblicazioni dal titolo Quaderni del qu<strong>in</strong>to<br />
centenario (vedi pago lO).<br />
Qui si vogliono <strong>in</strong>vece considerare gli<br />
anni giovanili del Savonarola, trascorsi<br />
<strong>in</strong> modo significativo anche nel Convento<br />
domenicano di Bologna.<br />
Nato nella vic<strong>in</strong>a Ferrara nel 1452, f<strong>in</strong><br />
dalla sua agiata giov<strong>in</strong>ezza Savonarola<br />
si dedica allo studio delle opere di <strong>San</strong><br />
Tommaso d'Aqu<strong>in</strong>o, del quale <strong>in</strong> seguito<br />
diverrà confratello; ancora lontano<br />
dalla vocazione religiosa, già pone le<br />
basi filosofiche, sviluppate più tardi a<br />
Bologna, della sua vigorosa testimonianza<br />
profeti ca.<br />
La sua giovanile <strong>in</strong>quietud<strong>in</strong>e di fronte<br />
alla corruzione morale della società e<br />
della Chiesa stessa si accompagna alla<br />
ricerca della propria vocazione. Durante<br />
una gita a Faenza, il giovane Girolamo è<br />
scosso da una frase della Genesi, ascoltata<br />
durante una predica: vàttene dal tuo<br />
paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo<br />
padre (Gen 12, 1). Dopo un <strong>in</strong>tero anno di<br />
tormento <strong>in</strong>teriore, all' età di ventitrè<br />
8<br />
anni egli risponde a quel grido lasciando<br />
improvvisamente la casa paterna: il 24<br />
<strong>aprile</strong> 1475, senza dir nulla ai familiari,<br />
parte a piedi per Bologna, dove, il giorno<br />
stesso, bussa alla porta del Convento patriarcale<br />
di <strong>San</strong> <strong>Domenico</strong>.<br />
Il giorno dopo scrive al padre: ... Non<br />
sarà stata una grande <strong>in</strong>gratitud<strong>in</strong>e la mia,<br />
ad aver pregato Iddio che mi mostri la via<br />
dritta per la quale io ho a camm<strong>in</strong>are, e lui<br />
essendosi degnato di mostrannela, e poi che<br />
io non l'avesse accettata? E poco tempo<br />
dopo ai familiari, che lo volevano medico<br />
come il nonno, scrive:rà ancora di rallegrarsi<br />
perché Dio lo ha fatto medico di<br />
anime, anziché medico di corpi.<br />
Il 26 <strong>aprile</strong> Savonarola riceve l'abito<br />
domenicano dal Priore di Bologna, Fra<br />
Giorgio da Vercelli ed un anno dopo, nel<br />
1476, fa la professione nell'Ord<strong>in</strong>e dei<br />
Frati Predicatori.<br />
Nel Convento bolognese, presso l'arca<br />
del <strong>San</strong>to Padre <strong>Domenico</strong>, fra Girolamo<br />
trascorre gli anni della sua formazione<br />
<strong>in</strong>iziale; l'anno di noviziato sarà sempre<br />
da lui ricordato "con parole di desiderio,<br />
come un perduto bene" (R. Ridolfi): trovai<br />
la libertà, e quivi facevo tutto quello che io<br />
volevo, né altro desideravo, se non fare tutto<br />
quello che mi era detto e comandato (Prediche<br />
sopra Aggeo). Dispensato dalle lezioni<br />
di grammatica grazie agli studi precedenti,<br />
egli può dedicare tutto il suo noviziato<br />
alla preghiera e alla contemplçtz:ione.<br />
Il Convento patriarcale è <strong>in</strong> quegli anni<br />
considerato un modello di osservanza,<br />
eppure al giovane ferrarese quell' osservanza<br />
appare una mera ipocrisia: tornare<br />
alla purezza delle orig<strong>in</strong>i domenicane<br />
è già allora uno dei suoi primi pensieri,<br />
ed egli cerca di viverla personalmente,<br />
muovendo altri a fare altrettanto con<br />
l'esempio.
Dopo la professione i superiori, conoscendo<br />
il suo <strong>in</strong>gegno e la sua cultura, lo<br />
sp<strong>in</strong>gono a impegnarsi a pieno nello studio.<br />
Sulle cattedre dello Studium dei <strong>Domenicani</strong><br />
bolognesi siedono famosi professori,<br />
fra i quali i reggenti Fra <strong>Domenico</strong><br />
da Perpignano e Fra Pietro da Bergamo;<br />
quest'ultimo, grande teologo, è l'autore<br />
della celebre Tabula Aurea. Durante<br />
lo studentato di Fra Girolamo è maestro<br />
degli studi Fra Niccolò da Pisa, dotto<br />
predicatore e autore di scritti ascetici.<br />
I già approfònditi studi filosofici svolti<br />
dal Savonarola a Ferrara trovano <strong>in</strong><br />
quest' ambiente il loro coronamento: a<br />
Bologna, guidato da così illustri maestri,<br />
egli si dedica soprattutto alla teologia.<br />
Qui le meditate letture della Sacra Scrittura,<br />
di cui egli raggiunge una conoscenza<br />
straord<strong>in</strong>aria, gli fanno "lievitare nella<br />
mente" le immag<strong>in</strong>i profetiche che, amu<br />
dopo, scuoteranno l'uditorio durante le<br />
sue predicazioni.<br />
Qui, nella nuova e solenne biblioteca<br />
conventuale costruita pochi anni prima,<br />
Fra Girolamo cont<strong>in</strong>ua la sua <strong>in</strong><strong>in</strong>terrotta<br />
9<br />
Frati <strong>Domenicani</strong><br />
Dip<strong>in</strong>to su tavola<br />
del XV secolo,<br />
conservato<br />
nel Convento<br />
di <strong>San</strong> Marco<br />
a Firenze,<br />
raffigurante<br />
l'impiccagione<br />
t di Savonarola<br />
e dei suoi due<br />
compagni<br />
<strong>in</strong> piazza<br />
della Signoria.<br />
consuetud<strong>in</strong>e con gli scritti di <strong>San</strong> Tommaso.<br />
Vent' aIU1Ì più tardi egli parlerà dell'Aqu<strong>in</strong>ate<br />
<strong>in</strong> questi term<strong>in</strong>i: lo gli volsi<br />
sempre grande bene et ebbilo <strong>in</strong> riverenza ... lo<br />
non so nulla; pur quel poco che io so, l'ho perché<br />
sono stato sempre nella sua dottr<strong>in</strong>a. Lui<br />
fu veramente profondo; e quando voglio<br />
diventare piccol<strong>in</strong>o, lo leggo, e parmi che lui<br />
sia un gigante et io nulla (Predica XI sull'Esodo).<br />
Studia anche la retorica sotto la guida<br />
dell'umanista Giovanni Garzoni, docente<br />
all'università, amico dei Frati e devotissimo<br />
verso l'Ord<strong>in</strong>e.<br />
In seguito il Savonarola fa ritorno a<br />
Ferrara, probabilmente per un corso di<br />
perfezionamento. Term<strong>in</strong>ati gli anni della<br />
formazione <strong>in</strong>iziale con l'ord<strong>in</strong>azione<br />
presbiterale ed assegnato al Convento di<br />
<strong>San</strong>ta Maria degli Angeli <strong>in</strong> Ferrara, egli<br />
<strong>in</strong>izia a predicare, non solo nella città natia,<br />
ma anche nelle città vic<strong>in</strong>e; nel 1482<br />
viene nom<strong>in</strong>ato "lettore" del Convento<br />
di <strong>San</strong> Marco <strong>in</strong> Firenze, con l'ufficio di<br />
<strong>in</strong>segnare la Scrittura; negli éllU1Ì seguenti<br />
alterna l'<strong>in</strong>segnamento e la predicazione.
A teneo Domenicano<br />
F ilosofia:<br />
il piacere di pensare<br />
Che cosa è la filosofia?<br />
Si potrebbe rispondere che la filosofia<br />
è quella cosa con la quale o senza la quale<br />
uno rimane tale e quale.<br />
Troppo facile liquidare la questione<br />
<strong>in</strong> questo modo.<br />
Adesso la dico grossa: Ma tu lo sai<br />
che per filosofare occorre saper pregare e<br />
per pregare occorre saper filosofare?<br />
Lo so che sembra una cosa strana, molto<br />
strana: sembra proprio di dirla grossa ...<br />
Forse però questa stranezza dipende<br />
dal nostro immag<strong>in</strong>ario. Noi immag<strong>in</strong>iamo<br />
che la preghiera sia un qualcosa che<br />
ha a che fare con il cuore, mentre la filosofia<br />
avrebbe a che fare con la ragione.<br />
Per questo motivo opponiamo pregare a<br />
filosofare.<br />
Ma se considerassimo la cosa <strong>in</strong> modo<br />
più realistico, l'opposizione si rivelerebbe<br />
nulla. Nulla perché sia il pregare<br />
che il filosofare sono attività del pensiero<br />
al suo livello più alto.<br />
Ho la vaga impressione che comunemente<br />
non si sappia che cosa voglia dire<br />
pensare, che cosa sia il pensare. Figuriamoci<br />
se si è capaci di riconoscere il grado<br />
più alto o profondo del pensare ...<br />
E se c'è tanta ambiguità su che cosa<br />
sia il pensare, non deve stupire il fatto<br />
che non si apprezzi la filosofia.<br />
Eppure il pensare dovrebbe essere 1'esperienza<br />
più normale che ci sia.<br />
Sì, voglio, dire che l'uomo <strong>in</strong> quanto<br />
uomo pensa. E vero che l'uomo è un animale,<br />
e qu<strong>in</strong>di vive una vita nell' ord<strong>in</strong>e<br />
della sensibilità.<br />
In quanto animale, io mangio, bevo,<br />
donno, posso riprodurmi, percepisco colori,<br />
suoni, odori, sapori, soffro e godo,<br />
amo e aggredisco, immag<strong>in</strong>o e ricordo ...<br />
11<br />
Ma l'uomo è un animale particolare.<br />
È un animale che pensa. E se la filosofia è<br />
il modo più profondo di pensare, l'uomo<br />
che r<strong>in</strong>unciasse a filosofare r<strong>in</strong>uncerebbe<br />
al piacere che più gli è connaturale.<br />
D'accordo, filosofare sarà pure un piacere,<br />
ma ancora non si è detto che cosa è<br />
la filosofia e che cosa significhi filosofare.<br />
La prima tentazione è quella di dire<br />
che la filosofia è un determ<strong>in</strong>ato tipo di<br />
sapere, magari eccellente o particolarmente<br />
rigoroso, ma sempre settoriale e<br />
posto accanto ad altri tipi di sapere.<br />
Si potrebbe però anche dire che la<br />
filosofia, dato che si occupa di tutto, anzi<br />
del tutto, non è semplicemente un settore<br />
del sapere, ma è un sapere totale, un<br />
sapere esagerato: un sapere tutto di tutto,<br />
capendo tutto.<br />
Ma si dà anche la possibilità di una<br />
posizione assolutamente opposta, cioè<br />
quella per la quale la filosofia è una pura<br />
ricerca per la ricerca: una ricerca senza<br />
sbocchi e che non si prefigge scoperte<br />
decisive, perché sa che non può scoprire<br />
niente di def<strong>in</strong>itivo.<br />
Non si potrebbe poi sostenere che la<br />
filosofia, più che un sapere, sia una saggezza<br />
pratica? Quando comunemente si<br />
dice: "Ma prendi la vita con filosofia!",<br />
non si <strong>in</strong>tende forse dire proprio questo?<br />
E con questa espressione si vuole dire<br />
che nella pratica quotidiana non bisogna<br />
caricarsi <strong>in</strong>utilmente di preoccupazioni.<br />
Qu<strong>in</strong>di la filosofia, più che un sapere<br />
teorico, sarebbe un modo di vivere.<br />
Allora, <strong>in</strong> che cosa consiste la filosofia?<br />
Beh, si potrebbe dire che la filosofia,<br />
nella sua dimensione di ricerca, è <strong>in</strong> modo<br />
complessivo un po' tutte queste descrizioni.<br />
Evidentemente però solo se
L'ultima conferenza del 1997/98: "A<br />
proposito d'Africa, conoscere per rispettare",<br />
<strong>in</strong>tende evidenziare l'importanza<br />
di conoscere le culture africane e manifestarne<br />
la ricchezza, nell'<strong>in</strong>tento di <strong>in</strong>staurare<br />
un rapporto paritario con l'occidente<br />
europeo.<br />
La tradizionale conclusione delle attività<br />
co<strong>in</strong>cide con l'assemblea dei soci e<br />
gli appuntamenti riprenderanno ai pri-<br />
Centro <strong>San</strong> <strong>Domenico</strong><br />
mi di ottobre con la conferenza di <strong>in</strong>augurazione<br />
del nuovo Anno Sociale, per<br />
celebrare la ricorrenza del ventennale<br />
dei tre pontefici che si sono succeduti<br />
nell'arco di tre mesi nel 1978.<br />
A tutti voi, un augurio di serenità<br />
nella certezza di rivedervi presto.<br />
LA SEGRETERIA DEL CENTRO SAN DOMENICO<br />
La Presidente del Centro, Valeria Cicala,<br />
conferisce l'associazione "ad honorem" a Sergio Zavoli<br />
Assemblea dei Soci del Centro <strong>San</strong> <strong>Domenico</strong><br />
Martedì 9 <strong>giugno</strong> 1998 alle ore 20,30<br />
Sala della Traslazione - Convento di <strong>San</strong> <strong>Domenico</strong><br />
Piazza <strong>San</strong> <strong>Domenico</strong>, 13 - Bologna<br />
I Soci sono <strong>in</strong>vitati a partecipare per esercitare<br />
il loro diritto di voto (Parcheggio possibile nella piazza).<br />
15
Si effettueranno registrazioni delle<br />
produzioni musicali e vocali eseguite dai<br />
bamb<strong>in</strong>i, con successivo riascolto e analisi,<br />
ovviamente guidati dall'<strong>in</strong>segnante.<br />
Inoltre, la proposta di compagnie di<br />
spettacoli musicali per bamb<strong>in</strong>i è molto<br />
vasta. Anche grazie a questo verrà proposta<br />
una uscita per far partecipare i<br />
bamb<strong>in</strong>i a una o più rappresentazioni di<br />
questo tipo.<br />
Inoltre si potrà partecipare a laboratori<br />
strutturati, sempre proposti dalle com-<br />
Suore' Missionarie di <strong>San</strong> Sisto<br />
pagnie presenti <strong>in</strong> città, da cont<strong>in</strong>uare e<br />
prolungare anche presso la scuola.<br />
Sarà possibile preparare una esibizione<br />
canoro-musicale, dove i bamb<strong>in</strong>i<br />
potranno dimostrare anche ai genitori,<br />
parenti e amici tutto ciò che hanno<br />
appreso dall' esperienza proposta.<br />
Tutto il nuovo progetto è stato approvato,<br />
con la soddisfazione di tutte noi.<br />
Rendiamo Grazie al <strong>San</strong>to Padre Domeruco.<br />
SUORE DOMENlCANE MISSIONARlE DI S. SISTO<br />
Alcuni bamb<strong>in</strong>i della Scuola Materna S. Giuseppe con i loro strumenti musicali<br />
Quand'io più non sarò,<br />
le mie opere fioriranno<br />
Dagli scritti di SUOR M. ANTONIA LAl.lA<br />
Fondatrice delle Suore Domenicane di S. Sisto<br />
17<br />
La vita e le attività di Su or M. Antonia Lalia<br />
sono presentate nel volume:<br />
Cron A cII e e fioretti<br />
del mOtlRstero di {In Sisto all'Appia,<br />
a cura di P. RAIMONDO SP1AUl, ESD, 1993.
Suore Domenicane della Beata Imelda<br />
Imelda Lambert<strong>in</strong>i 1320 -1333<br />
Il 12 maggio si celebra la festa della<br />
Beata Imelda, giovane domenicana vissuta<br />
nei primi anni del 1300. La vita di<br />
Imelda Lambert<strong>in</strong>i si svolge tutta attorno<br />
al desiderio ardente di <strong>in</strong>contrare e<br />
ricevere Gesù nell'Eucaristia. Tutto <strong>in</strong> lei<br />
è proteso a questo grande evento. "Ho<br />
desiderato ardentemente di mangiare questa<br />
Pasqua con voi ... " (Le 22, 15) aveva detto<br />
Gesù e Imelda ha realizzato quello stesso<br />
ardente desiderio.<br />
L'avvenimento<br />
A 13 anni, Imelda ha già lasciato la<br />
famiglia per consacrarsi a Dio, è novizia<br />
nel monastero domenicano di Valdipietra<br />
<strong>in</strong> Bologna, ma nori. ha ancora potuto<br />
fare la sua prima Comunione. Perché?<br />
Le leggi della Chiesa del tempo non<br />
permettevano di ricevere l'Eucarìstia<br />
prima di compiere 14 anni; Imelda però<br />
non cessa di chiedere di essere ammessa<br />
al banchetto eucaristico e, <strong>in</strong> tale richiesta<br />
<strong>in</strong>cessante, si sviluppa la sua <strong>in</strong>tensa<br />
spiritualità eucaristica.<br />
Desiderio, amore, preghiera, perdono,<br />
donazione <strong>in</strong>condizionata di sé, lode,<br />
adorazione, gioia, supplica ... : tutto il suo<br />
essere è proteso a Gesù, non c'è più nes':<br />
suna voce della terra che superi quella<br />
<strong>in</strong>teriore che chiama <strong>in</strong>cessantemente<br />
Colui da cui Imelda si sente amata, scelta,<br />
chiamata a vivere senza riserve:<br />
"Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete,<br />
bussate e vi sarà aperto ... " (Le 11, 9).<br />
Conv<strong>in</strong>ta che la Parola di Gesù è vera<br />
ed efficace, Imelda la trasforma <strong>in</strong> preghiera<br />
e Gesù questa volta risponde e<br />
viene a lei nell'Eucaristia.<br />
18<br />
"Miracolosamente un'Ostia si posò sopra<br />
Imelda ... Tutto era <strong>in</strong>ondato di luce ... Il<br />
sacerdote prese l'Ostia e comunicò Imelda".<br />
(Cf. T. CENTI, La Beata Imelda Lambert<strong>in</strong>i,<br />
Firenze 1955; e I santi della Chiesa bolognese,<br />
a cura di E. Lodi, Bologna 1987).<br />
F<strong>in</strong>almente il Cielo ha risposto e il desiderio<br />
ardente di Imelda è divenuto<br />
realtà: l'amore ha v<strong>in</strong>to tutte le resistenze<br />
umane; ella ha <strong>in</strong>contrato, accolto Gesù<br />
nella sua vita per sempre. Quello stesso<br />
giorno, 12 maggio 1333, Imelda morì. La<br />
sua vita si è veramente trasformata <strong>in</strong> un<br />
cantico perenne d'amore a Gesù. Imelda,<br />
giovanissima, visse e morì d'amore!<br />
La storia<br />
Lambert<strong>in</strong>i è un nome illustre nella<br />
storia bolognese, specialmente dopo che<br />
un Lambert<strong>in</strong>i - Benedetto XIV - è salito<br />
alla Cattedra di Pietro nel 1740.<br />
Ma già qualche secolo prima, tale<br />
nome spicca accanto a quello di altre importanti<br />
famiglie bolognesi: i Pepoli, i<br />
Malvezzi, i Bentivoglio ... Egano Lambert<strong>in</strong>i,<br />
il padre di Imelda, si fa conoscere<br />
nel 1329 come capitano difensore del Comune<br />
e del popolo; la sorella di lui è fondatrice<br />
di un Monastero; Guido, il figlio<br />
primogenito, si arruola nelle milizie cittad<strong>in</strong>e<br />
e si segnala nelle imprese militari.<br />
Dalle seconde nozze di Egano con la<br />
nobile Castora de' Galluzzi, nasce Imelda.<br />
Le notizie biografiche di colei che è la<br />
protagonista di un episodio straord<strong>in</strong>ario<br />
sono scarse; <strong>in</strong>certa la data di nascita,<br />
forse il 1320.<br />
Il 12 maggio 1333, vigilia dell' Ascensione,<br />
è ricordata la sua morte dopo l'<strong>in</strong>contro<br />
prodigioso con Gesù Eucaristia.
te <strong>in</strong>valicabile di ogni visione mortale,<br />
permette al genere umano di agire e di<br />
operare. Tuttavia, l'uomo classico non<br />
spera mai la salvezza dal suo essere<br />
mortale: la speranza può avere <strong>in</strong> sé un<br />
valore ma mai un fondamento. Gli dei<br />
ellenici non sono "salvatori", vivono nella<br />
pace di una suprema beatitud<strong>in</strong>e, <strong>in</strong>curanti<br />
della felicità e della sofferenza del<br />
mondo. Sulla enorme difficoltà umana<br />
nel trovare dimostrazioni logiche, rigorose<br />
o almeno persuasive al problema<br />
escatologico, già Platone aveva avuto<br />
una profeti ca <strong>in</strong>tuizione:<br />
"Su questo problema non c'è che una<br />
cosa da fare di queste tre: o apprendere<br />
da altri come stanno le cose; o scoprirlo<br />
da sé; o, se ciò è impossibile, accogliere<br />
la migliore e meno contestabile delle<br />
idee umane, e su questa lasciarsi trasportare<br />
come su una zattera, arrischiando<br />
così la traversata della vita;<br />
salvo che uno non possa fare il tragitto,<br />
con maggior sicurezza e con m<strong>in</strong>or pericolo,<br />
su una più solida barca, cioè con<br />
qualche div<strong>in</strong>a rivelazione" (Fedone) .<br />
La religione cristiana con la Risurrezione<br />
di Cristo va oltre la soglia della .<br />
morte, supera l'<strong>in</strong>eluttabile, ci fa sperare<br />
oltre e contro ogni limite visibile.<br />
La speranza nella tradizione giudaicocristiana<br />
assume, qu<strong>in</strong>di, un significato<br />
assolutamente positivo; essa si collega<br />
al term<strong>in</strong>e salvezza: è speranza di salvezza<br />
dal nostro essere semplicemente<br />
mortali e, soprattutto, è una Speranza<br />
con un fondamento chiaro e def<strong>in</strong>ito: la<br />
fede <strong>in</strong> Gesù Cristo, nella Verità della<br />
Sua Persona.<br />
23<br />
Diversa, <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e, è la radice della speranza<br />
laica <strong>in</strong> senso moderno, una speranza,<br />
cioè, che si fonda sulla forza della<br />
razionalità umana <strong>in</strong> costante conflitto<br />
con l'imprevedibile <strong>in</strong>contro con il futuro.<br />
È una speranza che si dispone nella previsione<br />
di un progetto sulla base di un<br />
sapere personale: <strong>in</strong> questo caso la speranza<br />
si riduce al nostro tentativo di raggiungere<br />
<strong>in</strong> un momento a venire ciò che<br />
abbiamo progettato perché lo riteniamo<br />
realizzabile.<br />
La speranza laica si muove sul piano<br />
della natura umana e, proprio per questo,<br />
non è di grande aiuto nel sollevare<br />
l'uomo dalla condizione che genera la<br />
necessità di sperare. Il progetto da realizzare<br />
è una proiezione dell'uomo nel<br />
futuro; sotto un certo aspetto si potrebbe<br />
affermare che la speranza, per essere<br />
veramente utile, deve valere più dell'uomo<br />
stesso, <strong>in</strong> quanto arriva dove l'uomo<br />
non ha la certezza di poter arrivare.<br />
Dal punto di vista cristiano, <strong>in</strong>vece, la<br />
natura dell'uomo, pur essendo <strong>in</strong>f<strong>in</strong>itamente<br />
distante dalla l\Jatura div<strong>in</strong>a, nella<br />
pienezza dei tempi viene da Essa "attraversata":<br />
l'uomo raggiunge la coscienza<br />
della dignità della propria natura così<br />
permeata e da qui è messo <strong>in</strong> grado di .<br />
partecipare a una Speranza che non<br />
<strong>in</strong>ganna e che, pur essendo dono soprannaturale,<br />
trova dimora nell'animo<br />
umano, diviene tensione fiduciosa, fonte<br />
.di gioia, consolazione e libertà.<br />
MARIA PAOLA SACCANI
Istituto T<strong>in</strong>cani<br />
ome è nata la biblioteca<br />
• • •<br />
per l glovanl<br />
La Biblioteca per i giovani è nata <strong>in</strong><br />
quegli anni sessanta quando altrove montavano<br />
aspre contestazioni giovanili,<br />
spesso difficili da gestire.<br />
Si trattava di una di quelle realtà fiorite<br />
quasi per germ<strong>in</strong>azione spontanea.<br />
La domanda sul come andrebbe forse<br />
più logicamente rivolta alla Provvidenza<br />
- che <strong>in</strong> questi lunghi anni non si è mai<br />
smentita - e alle segrete e mai sopite forze<br />
<strong>in</strong>ventive della prof. Maria Teresa Pascucci,<br />
Missionaria della Scuola, Insegnante<br />
di Matematica e Fisica.<br />
Al suo coraggio, alla sua geniale capacità<br />
di attuazioni concrete si deve la nascita,<br />
e qu<strong>in</strong>di lo sviluppo, di tutte quelle<br />
<strong>in</strong>iziative che oggi fioriscono nella fervida<br />
realtà dell'Istituto T<strong>in</strong>cani di Bologna.<br />
Dunque: COME È NATA? Direi ... fuori<br />
di lì. Se per "Biblioteca" <strong>in</strong>tendiamo non<br />
soltanto la disponibilità di libri e strutture,<br />
ma anche la realtà di un "centro di<br />
<strong>in</strong>contro" per e con i giovani, come momento<br />
forte per confrontarsi e approfon- .<br />
dire argomenti comunque formativi, per<br />
creare comunicazione e partecipare esperienze,<br />
si può dire che il nucleo <strong>in</strong>iziale<br />
della Biblioteca per i Giovani era un lievito<br />
che fermentava già da alcuni' anni e<br />
aveva preso consistenza tra gli allievi del<br />
vic<strong>in</strong>o Istituto Pier Crescenzi, dove Maria<br />
Teresa Pascucci svolgeva il corso pilota<br />
per la Fisica (metodo PSSC). Dal Pier<br />
Crescenzi alla campagna modenese, a<br />
Gaggio di Piano, dove Maria Teresa Pascucci<br />
andava periodicamente con gruppi<br />
di allievi, ospiti di una villa rustica<br />
("La Calonga") messa a disposizione dai<br />
coniugi Mario Felice e Vittoria Bianchi.<br />
24<br />
Lì trascorrevano alcune giornate (<strong>in</strong><br />
media una volta al mese) <strong>in</strong> discussioni<br />
formative, ore di spiritualità, svaghi.<br />
N egli annali si <strong>in</strong>com<strong>in</strong>ciano ad annotare<br />
le date: 28 novembre 1965, ultima<br />
riunione a Gaggio di Piano. Lo stesso<br />
giorno si spegneva, al primo piano di<br />
Piazza S. <strong>Domenico</strong> 3, Francesca Tabanelli,<br />
una delle due sorelle proprietarie<br />
dello stabile.<br />
Immediatamente dopo, al pianterreno<br />
dello stesso palazzetto ottocentesco <strong>in</strong><br />
Piazza S. <strong>Domenico</strong> si liberavano, uno<br />
dopo l'altro, i due appartamenti occupati<br />
dagli studi legali. Non ci volle molto -<br />
per la lungimiranza della prof. Pascucci<br />
e della fondatrice delle Missionarie della<br />
Scuola, la Madre Luigia T<strong>in</strong>cani, che da<br />
Roma consigliava e precorreva i tempi -<br />
a <strong>in</strong>dividuare <strong>in</strong> quei locali ora liberi una<br />
sede ideale per avviare una biblioteca<br />
con strutture stabili, per quei giovani che<br />
a mano a mano aumentavano.<br />
La superstite delle sorelle Tabanelli ,<br />
Ester - che ricordiamo qui con viva gratitud<strong>in</strong>e<br />
per aver reso possibile l'attuazione<br />
di un sogno! - si dimostrò sensibile<br />
al problema e acconsentì ai primi<br />
lavori di ripulitura del pianterreno; che<br />
la loro casa, ubicata <strong>in</strong> zona così privilegiata<br />
della città, potesse diventare col<br />
tempo centro di apostolato e di cultura<br />
non le era certo cosa sgradita.<br />
Da allora, tra operai, picconi e calc<strong>in</strong>acci<br />
si aprì un cantiere <strong>in</strong> Piazza S. <strong>Domenico</strong><br />
3, che per qualche anno non si è<br />
quasi più fermato.<br />
lO febbraio 1966: prima riunione dei<br />
giovani <strong>in</strong> Piazza S. <strong>Domenico</strong>; 17 febbraio<br />
1966: <strong>in</strong>com<strong>in</strong>cia il prestito dei
primi libri. Pochi, pochissimi libri, i primi<br />
che era stato possibile mettere <strong>in</strong>sieme.<br />
Poi <strong>in</strong>com<strong>in</strong>ciarono le donazioni da<br />
varie parti.<br />
Intanto Ester Tabanelli donava alla<br />
biblioteca la sua "Enciclopedia Treccani",<br />
una delle prime 5000 copie del 1929.<br />
Con 1'arredamento proveniente dalla<br />
"Calonga" di Gaggio di Piano, nel frattempo<br />
venduta, fu possibile arredare i<br />
nuovi locali e lentamente - lentamente<br />
solo a causa dello spazio che scarseggiava<br />
- la Biblioteca diventa un piacevole<br />
luogo di <strong>in</strong>contro per i giovani che 1'avevano<br />
eletta a loro seconda casa. Ormai i<br />
giovani non provenivano più soltanto<br />
dal vic<strong>in</strong>o Pier Crescenzi, ma anche dal<br />
Liceo Righi, dal M<strong>in</strong>ghetti, dal Galvani,<br />
dall'Istituto Marconi e da àltre scuole<br />
superiori di Bologna. La Biblioteca si<br />
qualificò subito come luogo di libertà,<br />
luogo di aperto confronto, luogo di formazione<br />
e di accoglienza senza barriere. E non è<br />
poco per quei tempi, dato che trent' anni<br />
or sono le cose non stavano esattamente<br />
come oggi. Ciò che sa di cristiano si<br />
coniuga sempre, e ovunque, con ciò che<br />
sa di libertà.<br />
Ho detto senza barriere: il selciato della<br />
Piazza S. <strong>Domenico</strong> (allora non ancora<br />
zona pedonale) "avvertiva" i passi<br />
forti e spediti dei giovani conv<strong>in</strong>ti, che<br />
correvano verso la biblioteca, ma ascoltava<br />
- vorrei dire "pesava" - anche il<br />
passo <strong>in</strong>certo e spesso restio dei nuovi,<br />
esitanti e perplessi, amici di amici, sp<strong>in</strong>ti<br />
forse solo dalla curiosità di vedere; ci si<br />
andava anche perché quel luogo poteva<br />
essere utile, o per non abbandonare l'amico<br />
diventato assiduo frequentatore.<br />
Poi, a mano a mano,la cerchia si allarga;<br />
chi arriva <strong>in</strong>certo e un po' sospettoso ne<br />
riparte sempre con qualche <strong>in</strong>terrogativo<br />
<strong>in</strong> più, e generalmente più disposto<br />
all' amicizia e al confronto: una nuova<br />
porta si era aperta.<br />
25<br />
Istituto T<strong>in</strong>cani<br />
Migliorava <strong>in</strong>tanto l'arredamento,<br />
aumentavano le strutture, si raddoppiavano<br />
le attività parallele. Vi erano anche<br />
alcune attrattive concrete: dalla "Calonga"<br />
erano giunte raccolte di giornali e<br />
riviste importanti, di grande curiosità<br />
storica per i giovani: giornali del 1920-21,<br />
alcune riviste relative alla Prima guerra<br />
mondiale e agli anni immediatamente<br />
successivi, perf<strong>in</strong>o alcuni cimeli relativi<br />
alla battaglia di Solfer<strong>in</strong>o e S.Mart<strong>in</strong>o.<br />
E poi - occorre sottol<strong>in</strong>earlo con forte<br />
senso di gratitud<strong>in</strong>e - nella Biblioteca erano<br />
disponibili molti docenti delle scuole<br />
cittad<strong>in</strong>e, sempre pronti a spendere il<br />
proprio tempo libero per quei giovani.<br />
Il fervore organizzativo cresceva, le<br />
esigenze dei giovani altrettanto.<br />
21 settembre 1967: donazione di 200<br />
volumi, con relative scaffalature, da parte<br />
dell'Ente N azionale per le Biblioteche popolari<br />
e scolastiche. Cont<strong>in</strong>uavano <strong>in</strong>tanto<br />
i doni di amici affezionati: 60 classici<br />
UTET dalla maestra Casal<strong>in</strong>i, numerosi<br />
volumi dalla signora Giorgi, dalla signora<br />
Fontana, dalla signora Cesira Taroni.<br />
La rete della collaborazione si allargava.<br />
Nel 1967 i volumi schedati erano circa<br />
1.500. Anche i giovani aumentavano. Al<br />
decimo anno di vita i giovani registrati <strong>in</strong><br />
biblioteca erano circa 1.500.<br />
Leggiamo negli annali redatti dalla<br />
Pascucci: "<strong>in</strong> biblioteca non c'era nessuno<br />
oggi'; (perché gli studenti non arrivavano<br />
a 30); e poi altrove: "il numero dei<br />
ragazzi è talmente alto che la sera sembra<br />
di essere pazze!".<br />
I lavori proseguono. Leggiamo dalle<br />
cronache: /I demolizione muro nella sala<br />
grande";" demolizione pareti nelle salette";<br />
/I dalla cant<strong>in</strong>a, che non serve più per<br />
il carbone, può venire una magnifica sala!<br />
C'è un soffitto a botte, anteriore al 1200".<br />
Il tempo non ha smentito i pronostici<br />
di Maria Teresa Pascucci: la "magnifica<br />
sala" è nata, ed è sotto gli occhi di tutti.
Istituto T<strong>in</strong>cani<br />
Il6 marzo 1973 muore Ester Tabanelli,<br />
con la consolazione di aver già visto la<br />
propria casa diventata fuc<strong>in</strong>a di attività.<br />
Le ATTIVITÀ, <strong>in</strong>fatti, si sviluppavano e<br />
cosÌ anche le collaborazioni più belle e<br />
fruttuose: nel dicembre 1966 la prof. Lia<br />
Roveda aveva <strong>in</strong>com<strong>in</strong>ciato le sue magistrali<br />
lezioni di filosofia e nel dicembre<br />
1967 la prof. Vera Passeri Pignoni <strong>in</strong>com<strong>in</strong>ciava<br />
la preziosa collaborazione che<br />
dura tuttora, con grande soddisfazione<br />
di tutti. Non penso vi sia argomento che<br />
non sia stato trattato negli <strong>in</strong>contri della<br />
Biblioteca: letteratura, arte, filosofia, teologia<br />
- con la preziosa collaborazione dei<br />
<strong>Domenicani</strong> del vic<strong>in</strong>o studio bolognese -<br />
narrativa, musica, mistica, storia, didattica<br />
... qualunque possibile esigenza trovava<br />
una risposta adeguata e puntuale.<br />
Il 3 <strong>giugno</strong> 1976, dopo una cena, preceduta<br />
da una tavola rotonda e da una<br />
Messa, presenti M. Teresa Pascucci, Vera<br />
Passeri Pignoni, Valeria Rubbi Telmon e<br />
alcuni Padri <strong>Domenicani</strong> del vic<strong>in</strong>o convento<br />
di S. <strong>Domenico</strong>, nasce un'idea:<br />
"Tutta l'attività collaterale alla Biblioteca<br />
è stata spunto per darci l'idea di <strong>in</strong>iziare<br />
l'anno prossimo un lavoro di <strong>in</strong>contri<br />
26<br />
con gli adulti, per portare un nostro piccolo<br />
tassello, data l'asserita accusa di<br />
I disorganizzazione della cultura cattolica'<br />
che piove da parte di tanti, non si sa<br />
quanto giustamente".<br />
Nasceva il FUTURO del "T<strong>in</strong>cani"! La<br />
"Biblioteca dei giovani" aveva compiuto<br />
il suo proprio camm<strong>in</strong>o, ma dalle esigenze<br />
emerse era nato il futuro del "T<strong>in</strong>cani".<br />
Ciò stava a dimostrare che la fame<br />
della mente umana non conosce età, come<br />
non conosce età l'esigenza di cercare<br />
e creare luoghi di <strong>in</strong>contro e di s<strong>in</strong>cero<br />
dialogo. E anche questo ha cercato di offrire<br />
il "Centro" di Piazza S. <strong>Domenico</strong> 3.<br />
Cosa può esservi di più necessario <strong>in</strong><br />
un' epoca tecnicizzata e meramente produttiva,<br />
quale la nostra, <strong>in</strong> cui spesso non<br />
rimane tempo per il rapporto umano?<br />
I GIOVANI di allora - diciamo i "fondatori"<br />
- sono oggi professionisti affermati<br />
nella società, ma il camm<strong>in</strong>o da essi<br />
aperto - con grande entusiasmo, anche<br />
se con fatica; come accade per ogni fase<br />
pionieristica - non si è più arrestato.<br />
NICOLINA IORIO<br />
Sala per sem<strong>in</strong>ari<br />
: l
Opera <strong>San</strong> <strong>Domenico</strong><br />
per i figli della Div<strong>in</strong>a Provvidenza<br />
L I Istituto delle Farlott<strong>in</strong>e<br />
«Signore, io credo al Tuo amore per noi,<br />
alla materna Tua bontà e Provvidenza che<br />
regge il mondo e le anime, all'<strong>in</strong>f<strong>in</strong>ita Tua<br />
giustizia e misericordia».<br />
Queste parole, tratte dalla prefazione a<br />
un suo scritto, rivelano quale spirito di<br />
fede e di carità animasse Assunta Viscardi,<br />
che ha <strong>in</strong>iziato e guidato per tanti anni<br />
l'Opera di <strong>San</strong> <strong>Domenico</strong> per i Figli della<br />
Div<strong>in</strong>a Provvidenza.<br />
Se tutte le creature, specialmente le<br />
più misere ed emarg<strong>in</strong>ate erano oggetto<br />
delle attenzioni e preoccupazioni di Assunta<br />
Viscardi, certamente fu l'<strong>in</strong>fanzia il<br />
centro della sua attività e di quella di<br />
coloro che le furono accanto nella costituzione<br />
dell'Opera. Infatti lo spirito<br />
materno e la formazione di <strong>in</strong>segnante<br />
ed educatrice sp<strong>in</strong>sero "la maestr<strong>in</strong>a",<br />
come veniva chiamata f<strong>in</strong> dal 1932, a<br />
<strong>in</strong>teressarsi dei fanciulli sbandati che -<br />
raccolti sui viali di S. Michele <strong>in</strong> Bosco e<br />
riuniti nel cortile dei Frati (cioè a <strong>San</strong><br />
<strong>Domenico</strong>) da lei e dalle sue consorelle,<br />
soprattutto Clotilde Lelli - venivano sostenuti<br />
materialmente e spiritualmente e<br />
aiutati a <strong>in</strong>serirsi presso Enti o Istituti già<br />
attivi <strong>in</strong> città.<br />
Questa "opera senza muri" trovò una<br />
propria sede quando, grazie a due diverse<br />
donazioni (la prima nel 1950 e l'altra<br />
nel 1954), si poterono accogliere le fanciulle<br />
<strong>in</strong> un edificio di via della Battaglia<br />
e i fanciulli presso uno stabile della campagna<br />
di Colunga.<br />
Sorsero così gli Istituti dei Farlotti e delle<br />
Farlott<strong>in</strong>e. "Farlotto" <strong>in</strong> dialetto romagnolo<br />
è il piccolo dell' averla, un m<strong>in</strong>uscolo<br />
uccell<strong>in</strong>o che immediatamente evoca l'idea<br />
del bimbo <strong>in</strong>erme, bisognoso di cure<br />
e di attenzioni.<br />
27<br />
Nei primi anni del secondo dopoguerra<br />
i bamb<strong>in</strong>i orfani o lasciati a se stessi<br />
erano numerosi. Per questi fanciulli<br />
. occorreva provvedere non solo al nutrimento,<br />
ma anche a un' adeguata educazione<br />
umana e cristiana. Ad essi si sono<br />
dedicate con umile ma coraggiosa energia<br />
le Terziarie Domenicane, <strong>in</strong> particolare<br />
appunto Assunta Viscardi, Angela<br />
M<strong>in</strong>gazzi, Valent<strong>in</strong>a Turchi e molte altre,<br />
sotto la guida del P. Ludovico Cibotti e<br />
poi del P. Anton<strong>in</strong>o Berizzi. Molte naturalmente<br />
sono state le persone che con la<br />
loro generosa opera e le loro offerte hanno<br />
permesso a tanti bamb<strong>in</strong>i di essere<br />
accuditi ed educati.<br />
Ancor oggi l'Opera di <strong>San</strong> <strong>Domenico</strong><br />
cont<strong>in</strong>ua nella sua missione a favore del<br />
!'<strong>in</strong>fanzia <strong>in</strong> difficoltà, grazie anche alla<br />
preziosa collaborazione della Congregazione<br />
delle Suore dell'Immacolata. Sono<br />
<strong>in</strong>fatti le "Sorelle" dell'Immacolata<br />
che, aiutate da alcuni volontari, seguono<br />
con amore e dedizione i bamb<strong>in</strong>i, svolgendo<br />
il loro apostolato secondo le l<strong>in</strong>ee<br />
<strong>in</strong>dicate dal loro fondatore, il sacerdote<br />
<strong>Domenico</strong> Masi: «L'educazione dei fanciulli<br />
e dei giovani, per formare personalità<br />
umane e cristiane capaci di affrontare<br />
responsabilmente la vita, di usare e valorizzare<br />
le realtà terrene, illum<strong>in</strong>andole<br />
con la certezza della fede». Attualmente<br />
la comunità delle Sorelle dell'Immacolata<br />
è costituita da otto Suore, sotto la guida<br />
della superiora Sr. Silvana Purificati. Di<br />
queste otto, due sono presenti f<strong>in</strong> dal Sorgere<br />
dell'Istituto: Sr. Roberta e Sr. Eugenia.<br />
Gli Istituti dei Farlotti e delle Farlott<strong>in</strong>e<br />
sono ora riuniti <strong>in</strong> un solo Istituto<br />
(quello di via della Battaglia IO), che accoglie<br />
<strong>in</strong>sieme maschi e femm<strong>in</strong>e. Esso· è
Opera <strong>San</strong> <strong>Domenico</strong> per i figli della Div<strong>in</strong>a Provvidenza<br />
dotato di ampi e lum<strong>in</strong>osi locali e di un<br />
vasto parco attrezzato; <strong>in</strong> questi anni ha<br />
ospitato tantissimi bamb<strong>in</strong>i, molti dei<br />
quali vi hanno trascorso tutto il periodo<br />
della loro formazione, aiutati a cogliere i<br />
valori positivi della vita, preparati a operare<br />
scelte libere e responsabili, educati a<br />
maturare atteggiamenti di tolleranza,<br />
condivisione e solidarietà.<br />
L'Istituto cont<strong>in</strong>ua naturalmente anche<br />
a far fronte alle situazioni d'emergenza:<br />
sono i casi <strong>in</strong> cui i piccoli, tempo- .<br />
raneamente privi di uno o di entrambi i<br />
genitori o appartenenti a famiglie di<br />
nomadi o immigrati <strong>in</strong> difficoltà, vengono<br />
accolti nell'Istituto anche per periodi<br />
molto lunghi, <strong>in</strong> attesa che gli Enti pubblici<br />
responsabili trov<strong>in</strong>o il modo di <strong>in</strong>serirli<br />
<strong>in</strong> famiglie affidatarie o adottive, o<br />
magari di re<strong>in</strong>serirli nella famiglia d'orig<strong>in</strong>e<br />
che si fosse ricompattata.<br />
Oltre a questo servizio l'Istituto svolge<br />
oggi un' opera che risponde a una esigenza<br />
fortemente sentita nel territorio: 1'assistenza,<br />
l'<strong>in</strong>segnamento e 1'educazione di<br />
bimbi dai 3 ai 13 anni appartenenti a<br />
famiglie che, prevalentemente per esigenze<br />
di lavoro, non possono seguire i<br />
loro figli nell' arco della giornata e qu<strong>in</strong>di<br />
ricorrono all' aiuto delle Suore.<br />
28<br />
Nell'Istituto c'è una classe di scuola<br />
materna (34 bimbi), un' attività di doposcuola<br />
(50 ragazzi circa) per alunni di<br />
scuola elementare e media, un servizio<br />
di assistenza nell' orario di pre- e <strong>in</strong>terscuola,<br />
e anche durante il tragitto tra le<br />
scuole pubbliche (che hanno orari differenziati)<br />
e l'Istituto, e <strong>in</strong>f<strong>in</strong>e un servizio<br />
mensa per tutti.<br />
Le prospettive per il futuro sono piuttosto<br />
impegnative perché le esigenze<br />
sono sempre più pressanti: richieste di<br />
potenziamento della scuola materna che<br />
già si prepara a istituire un' altra classe;<br />
necessità di un ambiente per il doposcuola<br />
che sia più attento ai bisogni dei m<strong>in</strong>o<br />
.ri (eventuali disagi scolastici, malessere<br />
nelle relazioni e nell'apprendimento ... );<br />
opportunità di collegamento con le altre<br />
strutture educative del territorio; organizzazione<br />
di <strong>in</strong>contri formativi per aiutare<br />
i genitori nel loro ruolo di educatori.<br />
L'Opera di <strong>San</strong> <strong>Domenico</strong> per i Figli<br />
della Div<strong>in</strong>a Provvidenza si propone di<br />
cercare modalità sempre più consone per<br />
compiere <strong>in</strong> modo efficace il suo servizio<br />
a favore dell'<strong>in</strong>fanzia, seguendo il carisma<br />
di <strong>San</strong> <strong>Domenico</strong> e l'<strong>in</strong>segnamento<br />
di Gesù Cristo.<br />
ANNA PAOLA MARTELLI
FIVET:<br />
i figli <strong>in</strong> provetta<br />
"Perché la Chiesa, che si proclama custode<br />
della vita e della famiglia, giudica moralmente<br />
illecita la fecondazione artificiale, non<br />
considerando illegittimo desiderio delle coppie<br />
sterili di avere un figlio?".<br />
Il Sig. Bentivoglio di Bologna, nella lettera<br />
che ha fatto pervenire alla nostra redazione,<br />
ci chiede di dare una risposta a un problema<br />
molto attuale ai nostri giorni. Noi rispondiamo<br />
molto volentieri, seguendo soprattutto ·<br />
quelle che sono le <strong>in</strong>dicazioni della Chiesa<br />
Cattolica, attraverso il Magistero, <strong>in</strong> materia<br />
di fecondazione artificiale.<br />
"Far West", "Provetta Selvaggia" sono<br />
soltanto due delle colorite espressioni con le<br />
quali i quotidiani descrivono 1'assenza, <strong>in</strong><br />
<strong>Italia</strong>, di leggi che regol<strong>in</strong>o la "Fecondazione<br />
Artificiale". La Chiesa Cattolica <strong>in</strong>vece, già<br />
nel 1987 con un documento della Congregazione<br />
per la Dottl<strong>in</strong>a della Fede dal titolo<br />
Il rispetto della vita umana nascente e la dignità<br />
della procreazione (documento meglio<br />
conosciuto come Donum Vitae) , ha dato delle<br />
risposte precise e specifiche ai pr<strong>in</strong>cipali<br />
<strong>in</strong>terrogativi sollevati a: proposito delle tecniche<br />
di fecondazione artificiale.<br />
Seguendo le <strong>in</strong>dicazioni del documento,<br />
per procreazione artificiale o fecondazione<br />
artificiale (comunemente chiamata FIVET:<br />
Fecondazione In Vitro Embrio-Transfer) si<br />
<strong>in</strong>tendono le diverse procedure tecniche<br />
dirette a ottenere un concepimento umano <strong>in</strong><br />
maniera di versa dall' unione sessuale dell' uomo<br />
e della donna.<br />
Prima di tutto bisogna fare una dist<strong>in</strong>zione<br />
eticamente rilevante tra fecondazione artificiale<br />
omologa ed eterologa.<br />
La fecondazione artificiale omologa è la<br />
tecnica diretta ad ottenere un concepimento<br />
umano a partire dai gameti (spermatozoo e<br />
. ovulo) di due sposi uniti <strong>in</strong> matrimonio: l'<strong>in</strong>contro<br />
dei gameti avviene <strong>in</strong> provetta, cioè<br />
fuori del rapporto sessuale.<br />
Opera <strong>San</strong> <strong>Domenico</strong> per ì figli della Divìna Provvidenza<br />
29<br />
La fecondazione artificiale eterologa<br />
<strong>in</strong>vece è la tecnica usata per ottenere un concepimento<br />
a partire dai gameti provenienti da<br />
un donatore o da donatori esterni alla coppia<br />
unita <strong>in</strong> matrimonio: anche <strong>in</strong> questo caso<br />
l'<strong>in</strong>contro dei gameti si attua <strong>in</strong> provetta.<br />
La fecondazione "<strong>in</strong> vitro" prevede una<br />
serie di atti, il primo dei quali è il reperimento<br />
dell' ovulo femm<strong>in</strong>ile. A questo scopo la<br />
donna assume degli Olmoni per produrre un<br />
numero di ovuli supeliore alla norma. Questi<br />
ovuli vengono prelevati e fecondati per ottenere<br />
embrioni che per alcuni giorni sono coltivati<br />
<strong>in</strong> vitro (cioè <strong>in</strong> provetta). Successivamente<br />
solo alcuni di questi embrioni sono<br />
trasferiti nelle vie genitali della donna; i<br />
rimanenti, chiamati embrioni soprannumerari,<br />
vengono congelati (crioconservazione)<br />
oppure distmtti.<br />
La percentuale di successo di queste tecniche<br />
è pari al 4-5% rispetto alle fecondazioni<br />
messe <strong>in</strong> atto: cioè per ogni bamb<strong>in</strong>o nato,<br />
20-25 embrioni vengono sacrificati; è evidente<br />
perciò che la nascita di un bamb<strong>in</strong>o<br />
concepito <strong>in</strong> provetta costi un numero elevato<br />
di esseri umani che vengono soppressi appena<br />
concepiti.<br />
Tuttavia questo altissimo pedaggio non è<br />
il criterio pr<strong>in</strong>cipale per la valutazione morale<br />
negativa della fecondazione artificiale.<br />
Infatti il Magistero, nel documento che<br />
abbiamo citato all'<strong>in</strong>izio, sottol<strong>in</strong>ea <strong>in</strong> particolare<br />
che 1'atto procreativo non può essere<br />
separato dall'atto coniugale: <strong>in</strong> altre parole si<br />
afferma che per sua natura l'atto sessuale è<br />
<strong>in</strong>sc<strong>in</strong>dibilmente unitivo (cioè dono d'amore)<br />
e procreativo (cioè aperto alla vita). Si tratta<br />
qu<strong>in</strong>di dell'atto d'amore che unendo <strong>in</strong> modo<br />
<strong>in</strong>timo, esclusivo e strettamente personale i<br />
coniugi, li rende capaci di generare la vita<br />
umana. È nel loro corpo e solo per mezzo del<br />
loro corpo che gli sposi possono diventare<br />
padre e madre. Perciò non si può separare<br />
l'<strong>in</strong>tenzione procreativa e il rapporto coniugale,<br />
e qu<strong>in</strong>di non è ammissibile un atto sessuale<br />
che non sia aperto alla vita, o il concepimento<br />
di una vita che presc<strong>in</strong>da dall'atto<br />
sessuale.
La fecondazione artificiale implica i seguenti<br />
passaggi: il prelievo dei gameti (e ciò<br />
crea molto spesso notevoli disagi), la loro<br />
preparazione, la collocazione <strong>in</strong> vitro ecc.<br />
Tutti questi atti si verificano al di fuori del<br />
corpo dei coniugi, mediante l'<strong>in</strong>tervento di<br />
terze persone, la cui competenza e attività<br />
tecnica determ<strong>in</strong>ano il successo o il fallimento<br />
dell' <strong>in</strong>tervento; la vita e l'identità del<br />
nascituro viene perciò delegata alle capacità<br />
dei medici e dei biologi.<br />
Come può un figlio che viene "concepito"<br />
a queste condizioni essere il frutto dell' amore<br />
dei suoi genitori? Il desiderio di un<br />
figlio è un fatto naturale, tuttavia il figlio non<br />
è un diritto ma un dono del matrimonio. Un<br />
figlio deve essere desiderato per se stesso e<br />
non può essere visto come "qualcosa" che<br />
colma un vuoto o che serve per gratificare i<br />
genitori. Volere un figlio a "tutti i costi"cioè<br />
a costo di sacrificare vite umane, a costo<br />
di fare violenza alle leggi della natura e di<br />
offendere la dignità della persona e la sacralità<br />
della procreazione - non può essere considerato<br />
un segno di amore e di donazione.<br />
Un figlio - <strong>in</strong> quanto tale - non deve essere<br />
il prodotto di un <strong>in</strong>tervento di tecniche<br />
mediche e biologiche; con la fecondazione<br />
artificiale <strong>in</strong>vece si considera il "frutto del<br />
L'ID egDamento<br />
della ble a<br />
ulla e. lIulllltè<br />
Opera <strong>San</strong> <strong>Domenico</strong> per i figli della Div<strong>in</strong>a Provvidenza<br />
concepimento" come una cosa, il risultato di<br />
un <strong>in</strong>tervento di avanzata tecnologia scientifica.<br />
L'utilizzo di tecniche mediche per facilitare<br />
il concepimento non è un fatto per se<br />
stesso cattivo. L'<strong>in</strong>tervento medico è lecito<br />
quando però non si sostituisce all'atto coniugale,<br />
ma lo facilita nel raggiungimento dei<br />
suoi obiettivi naturali.<br />
Sono queste le ragioni che permettono di<br />
comprendere perché solo l'atto di amore<br />
coniugale sia considerato, nell'<strong>in</strong>segnamento<br />
della Chiesa Cattolica, degno della procreazione<br />
umana. Non si può ammettere di conseguenza,<br />
che la preoccupazione esclusiva e<br />
prevalente nella procreazione artificiale<br />
umana sia quella di dare una risposta ai pur<br />
comprensibili desideri degli adulti; il legittimo<br />
e lodevole desiderio di avere un figlio<br />
non può trasformarsi nel presunto diritto di<br />
ottenerlo a ogni costo. Per questo motivo il<br />
Magistero, <strong>in</strong> quest' epoca di massima confusione<br />
circa la fecondazione artificiale, non si<br />
stanca di ripetere che <strong>in</strong> primo luogo devono<br />
essere garantiti i diritti del figlio concepito:<br />
diritto alla vita, alla famiglia, ma soprattutto<br />
alla dignità di persona.<br />
FRA FABRIZIO MARIA ZORZAN O.P.<br />
L'<strong>in</strong>segnamento della Chiesa sulla sessualità<br />
a cura di M. COLOMBO KAPSA (pp. 160, L. 15.000)<br />
Il testo raccoglie alcuni documenti Magisteriali su una<br />
tematica cosi importante e attuale come quella della<br />
sessualità, a cui è connesso anche il problema della<br />
difesa della vita e della dignità della persona .<br />
I documenti , presentati <strong>in</strong> modo schematico, SOI1O :<br />
Humanae vitae (del 1968), Persona Humana (del 1975),<br />
Donum vitae (del 1987), Sessualita umana: verità e<br />
significato (del 1995).<br />
La presentazione schematica facilita la lettura e l'<strong>in</strong>dividuazione<br />
dei passi particolarmente significativi, e favorisce<br />
la riflessione, anche comunitaria, sulle tematiche<br />
fondamentali sviluppate dai documenti.<br />
30
Padri <strong>Domenicani</strong><br />
Convento S. <strong>Domenico</strong><br />
Piazza S. <strong>Domenico</strong> 13 - 40124 - Bologna<br />
TeI. 051/64.00.411<br />
Hanno sede presso il Convento:<br />
- Ateneo Domenicano<br />
. TeI. 051/58.21.76 - 58.16.83<br />
- Centro S. <strong>Domenico</strong><br />
TeI. 051/58.17.18<br />
- Edizioni Studio Domenicano<br />
Te!. 051/58.20.34<br />
Laici <strong>Domenicani</strong><br />
TeI. 051/64.00.500<br />
Monastero S. Agnese<br />
Via Pianoro 14 - 40134 Bologna<br />
Tel. 051/44.30.50<br />
Suore Domenicane del SS. Sacramen to<br />
Via Mascarella 62 .. 40126 Bologna<br />
TeI. 051/24.14.35<br />
Suore Domenicane di S. Cater<strong>in</strong>a da Siena<br />
Via Palestro 6 - 40123 Bologna<br />
Tel. 051/58.22.02<br />
Suore Domenicane Missionarie di S. Sisto<br />
Via Clelia Barbieri·2 - 40132 Bologna<br />
TeI. 051/56.15.01<br />
Suore Domenicane della Beata Imelda<br />
Via di Barbiano 14 - 40136 Bologna<br />
TeI. 051/33.23.38<br />
Suore Domenicane Opera S. Maria di Nazaret<br />
Via Capramozza 6 - 40123 Bologna<br />
TeI. 051/58.36.54 .<br />
Istituto T<strong>in</strong>cani<br />
Piazza S. <strong>Domenico</strong> 3 - 40124 Bologna<br />
TeI. 051/26.98.27<br />
Opera di S. <strong>Domenico</strong> per i figli della Div<strong>in</strong>a Provvidenza<br />
Piazza S. <strong>Domenico</strong> 5 - 40124 Bologna '\.<br />
TeI. 051/22.61.70<br />
!<br />
ù