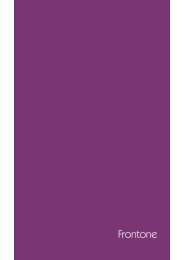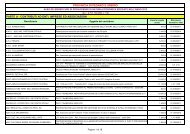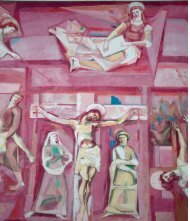Ornamental botanicals and rosette motifs 32 33 - Provincia di ...
Ornamental botanicals and rosette motifs 32 33 - Provincia di ...
Ornamental botanicals and rosette motifs 32 33 - Provincia di ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Gli ornati vegetali e i motivi a rosoni<br />
A partire dal I sec. a.C. e poi in epoca imperiale, tra il I e II<br />
sec. d.C., si manifesta un graduale arricchimento dei motivi<br />
decorativi: le figure geometriche, infatti, si uniscono ai motivi<br />
vegetali, cre<strong>and</strong>o uno stile che per la sua ricchezza ornamentale<br />
e per l’uso insistito dell’elemento naturalistico, prende il nome<br />
<strong>di</strong> “stile fiorito”.<br />
Ad impreziosire i mosaici <strong>di</strong> questo periodo, infatti, troviamo<br />
tralci <strong>di</strong> acanto o d’edera, piante <strong>di</strong> vite, fogliette <strong>di</strong> ulivo,<br />
gemme pronte ad aprirsi, foglie cuoriformi e trilobate,<br />
infiorescenze a calice, <strong>rosette</strong>, stelle <strong>di</strong> quattro petali, <strong>di</strong>versi<br />
fiori policromi e fantasiosi a petali gigliati o semplicemente<br />
lanceolati.<br />
Spesso, una fascia naturalistica fa da cornice al tessuto<br />
geometrico: essa viene abitualmente decorata da girali d’acanto<br />
uscenti da una parte e dall’altra <strong>di</strong> un calathos centrale, mentre<br />
dagli steli interni spiccano protomi animali. Tale motivo trova<br />
ampia fioritura in epoca romana benché le sue ra<strong>di</strong>ci risalgano<br />
all’età ellenistica; in particolare, è tipica <strong>di</strong> questo periodo la<br />
rappresentazione del personaggio femminile alato che talvolta<br />
ve<strong>di</strong>amo emergere dal calathos centrale mentre trattiene con<br />
le mani il fregio che si sviluppa a destra e a sinistra del suo<br />
corpo.<br />
Nel III sec. d.C. la crisi economica, politica e culturale che<br />
coinvolge il mondo romano si riflette anche nelle espressioni<br />
artistiche cre<strong>and</strong>o un nuovo linguaggio formale: la decorazione<br />
vegetale, infatti, allontan<strong>and</strong>osi dai delicati e complessi arabeschi<br />
<strong>di</strong> età adrianea, tenderà verso effetti più vistosi e pesanti sia<br />
pure in qualche modo più naturalistici, come ad esempio, nei<br />
tralci da cui pendono grappoli e pampini o negli elementi<br />
floreali che nascono da crateri posti sugli angoli del mosaico.<br />
Talora, inoltre, nel campo tessellato bianco viene inserita una<br />
decorazione centrale a tappeto quadrato contenente un<br />
cerchio interamente occupato da un gr<strong>and</strong>e rosone con<br />
elementi <strong>di</strong>sposti a raggera e decrescenti verso il centro.<br />
<strong>32</strong> <strong>33</strong><br />
<strong>Ornamental</strong> <strong>botanicals</strong> <strong>and</strong> <strong>rosette</strong> <strong>motifs</strong><br />
Starting in the 1st century BC <strong>and</strong> continuing in Imperial era,<br />
between the 1st <strong>and</strong> 2nd century AD, we see the gradual<br />
growth of decorative <strong>motifs</strong>. The geometric figures combine<br />
with botanical <strong>motifs</strong> creating a style called stile fiorito (flowery)<br />
because of its ornamental richness <strong>and</strong> its consistent use of<br />
Naturalistic elements.<br />
In this period we find mosaics adorned with acanthus <strong>and</strong> ivy<br />
vines, grapevines, olive leaves, flower buds ready to open,<br />
heart shaped <strong>and</strong> tri-lobed leaves, flowering chalices, <strong>rosette</strong>s,<br />
four petaled stars <strong>and</strong> various imaginative, polychromatic<br />
flowers with lily or simple narrow leaves.<br />
Frequently a border of natural elements frames a geometric<br />
composition. This border is usually decorated with acanthus<br />
<strong>motifs</strong> coming out from both sides of a central calathos while<br />
animal shapes leap out from the internal stems. This motif<br />
became highly popular in the Roman era even though its<br />
origins date back to the Greek era. Also typical of this era is<br />
the representation of a winged woman who sometimes<br />
emerges from a central calathos while hol<strong>di</strong>ng a frieze that<br />
continues to the right <strong>and</strong> to the left of her body.<br />
In the 3rd century AD, the economic, political <strong>and</strong> cultural<br />
crisis that hit the Roman world is reflected in artistic expression<br />
creating a new formal language. We see the botanical<br />
decorations <strong>di</strong>stance themselves from the delicate <strong>and</strong> complex<br />
arabesques of the Adrianea era to become gau<strong>di</strong>er <strong>and</strong> heavier<br />
but in some ways more naturalistic. This can be seen, for<br />
example, in the grapes <strong>and</strong> leaves hanging from the vines or<br />
in the floral elements which emerge from craters positioned<br />
in the corners of the mosaic.<br />
Sometimes we find a white tessellated field interrupted by a<br />
central decoration consisting of a square mosaic which contains<br />
a circle completely covered by a <strong>rosette</strong> with elements ra<strong>di</strong>ating<br />
in a decreasing manner towards the centre.<br />
Sant’Angelo in Vado: mosaico della caccia, particolare
Ornati vegetali e rosoni Floral decorations <strong>and</strong> <strong>rosette</strong> <strong>motifs</strong>
34 35<br />
Pesaro<br />
Domus presso il Palazzo della <strong>Provincia</strong>.<br />
Mosaico del vano A, I-II sec. d. C.<br />
“...Nella fascia, dopo un rettangolo vuoto, si succedono riquadri<br />
con al centro un motivo decorativo che è ancora ben leggibile<br />
solo nei primi due: si tratta rispettivamente <strong>di</strong> un’infiorescenza a<br />
calice entro un girale, il tutto a tessere nere, e <strong>di</strong> una rosetta<br />
policroma a otto petali...”<br />
[Campagnoli, 2002, p. 98]<br />
“...si nota che una fascia bianca con riquadri profilati <strong>di</strong> nero ornati<br />
da fiori e da motivi stellari <strong>di</strong>vide il tappeto con i cerchi allacciati<br />
da un altro mosaico, che si intravede appena ai margini dello<br />
scavo...”<br />
[Merc<strong>and</strong>o, 2003, p. <strong>32</strong>1]<br />
Pesaro<br />
Domus presso il Palazzo della <strong>Provincia</strong>.<br />
Mosaico del vano A, I-II sec. d. C.<br />
“...Del tappeto opposto a fondo bianco, si vede una fascia<br />
marginata <strong>di</strong> nero, con girali e fiori intorno ad un motivo geometrico<br />
<strong>di</strong> losanghe. I fiori dei girali sono più schematici <strong>di</strong> quelli della<br />
fascia centrale e sembrano tutti neri; ancora però si alternano i<br />
calici e le <strong>rosette</strong> o le stelle <strong>di</strong> quattro petali...”<br />
[Merc<strong>and</strong>o, 1984, p. 212]
Pesaro<br />
Domus presso la sede della Banca delle Marche in via<br />
Perticari.<br />
Mosaico, II sec. d.C.<br />
“...L’interno dell’ esagono è completamente riempito da un rosone<br />
colorato: un fiore a tre petali ver<strong>di</strong> gigliati e tre pistilli rosa sorgenti<br />
da un seme a forma <strong>di</strong> ruota (a fondo rosso filettato <strong>di</strong> nero),<br />
si alterna con uno a sei petali elicoidali ver<strong>di</strong> con solcatura bianca,<br />
<strong>di</strong>sposti intorno ad uno stesso seme; l’esagono centrale sembra<br />
invece decorato con una serie <strong>di</strong> spirali, sempre <strong>di</strong>sposte a<br />
rosone…Al <strong>di</strong> fuori del cerchio, in uno degli angoli <strong>di</strong> risulta, si<br />
conserva uno dei motivi decorativi, in bianco e nero: da un’anfora<br />
nera con decorazioni bianche, si <strong>di</strong>partono, contrapposti, girali<br />
d’edera; nell’altro angolo rimane una fronda verticale affiancata<br />
da tralci, sempre d’edera...”<br />
[Campagnoli, 2002, p. 97]
36 37<br />
Colombarone<br />
Villa romana e Chiesa <strong>di</strong> San Cristoforo “ad Aquilam” in via<br />
Flaminia.<br />
Mosaico del vano B, III-IV sec. d.C.<br />
“...Schema compositivo <strong>di</strong> stelle formate dall’intersezione <strong>di</strong> due<br />
quadrati costituiti da matasse sfumate bianco rosse l’uno e bianco<br />
e nere l’altro determinanti un ottagono contenente una sorta <strong>di</strong><br />
fiore a petali alternati, quelli frastagliati <strong>di</strong> colore verde con contorno<br />
nero e quelli lanceolati rossi, con bottone centrale nero e tessera<br />
rossa nel mezzo...”<br />
“...Lungo la linea marginale si susseguono semiottagoni contenenti<br />
mezzo fiorone...”<br />
[Trovabene, 1998, p. 122]<br />
Colombarone<br />
Villa romana e Chiesa <strong>di</strong> San Cristoforo “ad Aquilam” in via<br />
Flaminia.<br />
Mosaico del vano L, III-IV sec. d.C.<br />
“...il vano L presenta su fondo bianco un motivo <strong>di</strong> cerchi che si<br />
intersecano a formare fiori quadripetali e quadrati dai lati convessi,<br />
con al centro un piccolo fiore schematizzato...”<br />
[Campagnoli, 2002, p. 162]
Sant’Angelo in Vado<br />
Domus presso Campo della Pieve in via Ghibelline.<br />
Mosaico <strong>di</strong> Bacco, I-IV sec. d.C.<br />
“...i quattro triangoli perimetrali tra le due circonferenze <strong>di</strong> tessere<br />
nere intervallate da quella centrale bianca ed il bordo costituito<br />
da linee <strong>di</strong> tessere nere (quella interna più sottile,le tre esterne<br />
alternate a linee bianche via via più ampie) e dalla fascia <strong>di</strong><br />
triangoli isosceli <strong>di</strong> tessere nere allineate con il vertice attaccato<br />
alla base del successivo, sono occupati da figure femminili che,<br />
con le braccia allargate, reggono imponenti racemi floreali con<br />
lunghi steli, foglie cuoriformi e frastagliate che si <strong>di</strong>partono dal<br />
busto delle figure stesse..."<br />
[De Marinis, Quiri, 2005, p. 840]<br />
Sant’ Angelo in Vado<br />
Domus presso Campo della Pieve in via Ghibelline.<br />
Mosaico <strong>di</strong> Medusa, I-IV sec. d.C.<br />
“...I quadrati delimitati dalla medesima treccia policroma che<br />
caratterizza il cerchio, presentano motivi geometrici e svastica<br />
complessa alternati a motivi floreali identici, costituiti da quattro<br />
boccioli che si <strong>di</strong>partono dalla rosetta centrale nel registro esterno;<br />
in quello interno i boccioli e le foglie sono più stilizzati, la rosetta<br />
centrale è polilobata e più complessa... i rombi presentano un<br />
fiore centrale con due stami e pistillo opposti... All’esterno del<br />
cerchio, nei quattro triangoli delimitati dalla cornice quadrata <strong>di</strong><br />
linee nere e fascia <strong>di</strong> triangoli quasi caliciformi con lati leggermente<br />
concavi, sono raffigurati vasi identici a coppie nei rispettivi campi<br />
opposti dai quali nascono vigorosi cespugli rampicanti con fiore<br />
centrale e rami con foglie cuoriformi o trilobate e gemme pronte<br />
ad aprirsi. I vasi, un calice ed un capace cratere, palesano, con<br />
le loro strutture e appen<strong>di</strong>ci, un origine da modelli metallici...”<br />
[De Marinis, Quiri, 2005, p. 841]
38 39<br />
Sant'Angelo in Vado<br />
Domus presso Campo della Pieve, in via Ghibelline.<br />
Mosaico geometrico, I-IV sec. d.C.<br />
“...mosaico a complessi motivi geometrici bianchi e neri e policromi...<br />
uno stretto rettangolo delineato dalla doppia treccia policroma<br />
e da una linea <strong>di</strong> tessere nere reca un bordo figurato occupato<br />
al centro da un cespo vegetale caliciforme dal quale si <strong>di</strong>partono<br />
due lunghi viticci attorcigliati con foglie e steli, che a loro volta<br />
formano quattro cerchi entro i quali sono raffigurate due coppie<br />
identiche ma speculari <strong>di</strong> animali: quelle interne pantere<br />
retrospicienti, quelle esterne capri selvatici in veloce movimento...”<br />
[De Marinis, Quiri, 2006, p. 598]<br />
Fano<br />
Museo Civico.<br />
Mosaico <strong>di</strong> Dioniso su pantera, I-II sec. d.C.<br />
“...Lungo uno dei lati minori del tappeto musivo corre una fascia<br />
che sottintende una partizione tra due zone pavimentate a<br />
mosaico. Questa è decorata con girali d’acanto uscenti da un<br />
calathos centrale. Il calathos è costituito da due or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> foglie:<br />
dal suo centro emerge un personaggio femminile alato che<br />
trattiene con la mano destra e la mano sinistra rispettivamente<br />
l’inizio del girale destro e <strong>di</strong> quello sinistro. Le ondulazioni dei girali<br />
si svolgono organicamente e simmetricamente per tutta la<br />
lunghezza della fascia e dagli steli interni spiccano protomi<br />
animali...”<br />
[Purcaro, 1992, p. 289]<br />
“...Nei riquadri sono iscritti quadrati minori con i lati decorati con<br />
denti <strong>di</strong> lupo contenenti a loro volta quadrati più piccoli entro i<br />
quali è inserito un cerchio scuro decorato con una margherita a<br />
sei petali...”<br />
[Purcaro, 1992, p. 288]
Castelleone <strong>di</strong> Suasa<br />
Domus dei Coie<strong>di</strong>i presso il Parco Archeologico in strada<br />
<strong>di</strong> Pian Volpello.<br />
Mosaico del Vano BC, I-IV sec. d.C.<br />
“...Lo schema è incorniciato, sui quattro lati, dal motivo dei girali<br />
vegetali, desinenti in foglie a cuore, originati da un kantharos<br />
centrale...”<br />
[Laurenti, 1995, p. 407]<br />
Castelleone <strong>di</strong> Suasa<br />
Domus dei Coie<strong>di</strong>i presso il Parco Archeologico in strada<br />
<strong>di</strong> Pian Volpello.<br />
Mosaico del Vano E, I-IV sec. d.C.<br />
“...Gli esagoni (sette) ...sono ornati dalla stessa infiorescenza,<br />
mentre nell’esagono centrale, sempre entro una cornice a treccia,<br />
si esp<strong>and</strong>e un motivo a raggera <strong>di</strong> fiori e <strong>di</strong> foglie simili all’acanto<br />
che sorgono da un piccolo rosone. Un motivo a racemi occupa<br />
anche gli angoli <strong>di</strong> risulta...”<br />
[Merc<strong>and</strong>o, 2003, p. <strong>32</strong>9]<br />
“...decorazione <strong>di</strong> elegantissimi cespi vegetali, che nell’esagono<br />
centrale assume l’aspetto <strong>di</strong> una “gir<strong>and</strong>ola” acantizzata molto<br />
particolare e per la quale non conosco confronti iconograficamente<br />
pertinenti e qualitativamente <strong>di</strong> livello paragonabile a questo,<br />
soprattutto per il solido naturalismo che caratterizza proprio le<br />
parti vegetali...”<br />
[De Maria, 1996, p. 405]<br />
Alla pagina successiva: Pesaro, mosaico presso il Palazzo della <strong>Provincia</strong>,<br />
particolare
42 43<br />
Pesaro<br />
Domus presso la sede della Banca delle Marche in via<br />
Perticari.<br />
Mosaico, II sec. d.C.<br />
“...Sul fondo bianco si svolge con sobria policromia (rosa ocra,<br />
rosso, verde) la decorazione a esagoni <strong>di</strong>sposti intorno ad un<br />
esagono centrale, per gran parte non conservato. La cornice che<br />
racchiude il cerchio contenente la decorazione e che contorna i<br />
vari poligoni non è a treccia, ma è formata da una serie <strong>di</strong><br />
astragali e <strong>di</strong>schetti neri; una seconda cornice delimita ogni<br />
esagono con un motivo poco evidente ad elementi arcuati in<br />
rosso e rosso ocra; ancora una terza cornice sottile rossa e nera,<br />
racchiude la decorazione interna, formata da un rosone <strong>di</strong> sei<br />
petali ver<strong>di</strong>, ricurvi, sorgenti con motivo a gir<strong>and</strong>ola da un seme<br />
a forma <strong>di</strong> ruota...”<br />
[Merc<strong>and</strong>o, 2003, p. <strong>32</strong>9]<br />
Fano<br />
Domus presso il Teatro della Fortuna in Piazza XX<br />
Settembre.<br />
Mosaico, II-III sec. d.C.<br />
“...Una cornice con una treccia serpentiforme con occhio al<br />
centro inquadra un emblema quadrato entro il quale è inscritto<br />
un cerchio. La decorazione è costituita dallo sviluppo <strong>di</strong> intrecci<br />
curvilinei <strong>di</strong> fasce che danno origine ad un rosone formato da<br />
sei cerchi allacciati entro i quali sono inseriti cerchi minori. Lo<br />
spazio centrale <strong>di</strong> questi ultimi è privo <strong>di</strong> decorazione oppure<br />
vi sono inscritti rispettivamente esagoni a lati convessi o cerchi<br />
ottenuti con tessere <strong>di</strong> colore <strong>di</strong>verso. La zona centrale del<br />
rosone è occupato da un esagono <strong>di</strong> risulta, decorato con un<br />
fiore a sei petali...”<br />
[Purcaro, 1992, p. 293]
44 45
Ancona<br />
Museo archeologico delle Marche.<br />
Mosaico, III sec. d.C., dal Parco Archeologico <strong>di</strong> Fossombrone.<br />
“...intorno, <strong>di</strong>sposti simmetricamente si alternano motivi a croce<br />
con treccia bianca e rossa su fondo nero e ottagoni contenenti<br />
un ottagono più piccolo, con cornice a triangoli, che in tre casi<br />
contiene un quadrifoglio nero e nel quarto caso un fiore <strong>di</strong> otto<br />
petali lanceolati neri su fondo bianco. Il resto del tappeto è<br />
occupato da motivi <strong>di</strong> losanghe e al centro <strong>di</strong> ogni lato da un<br />
rettangolo con pelte contrapposte a motivi triangolari neri in<br />
campo bianco con seme rosso al centro. In un riquadro centrale<br />
è inscritto il rosone a triangoli bianchi e neri, con una foglia d’edera<br />
negli angoli <strong>di</strong> risulta. Intorno, <strong>di</strong>sposti simmetricamente, si alternano<br />
motivi a croce con treccia bianca e rossa su fondo nero e ottagoni<br />
contenenti un ottagono più piccolo, con cornice <strong>di</strong> triangoli, che<br />
in tre casi contiene un quadrifoglio nero e nel quarto caso un fiore<br />
<strong>di</strong> otto petali lanceolati neri su fondo bianco...”<br />
[Merc<strong>and</strong>o, 2003, p. <strong>32</strong>8]