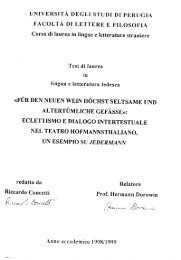Gli incontri di una vita. Conversazione con ... - Cristina Campo
Gli incontri di una vita. Conversazione con ... - Cristina Campo
Gli incontri di una vita. Conversazione con ... - Cristina Campo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
È senza dubbio un vantaggio che negli Stati Uniti non sembri esserci stigma sul<br />
lavoro manuale. Ma c’è un pericolo: che così non si vedano più le offese alla persona umana che<br />
non feris<strong>con</strong>o il corpo, come la <strong>con</strong>danna a <strong>vita</strong> a un lavoro a <strong>di</strong> cui sia impossibile percepire il<br />
senso – come <strong>con</strong>tinuare per sempre a produrre un bullone -- che era quello che Simone aveva<br />
denunciato nella Con<strong>di</strong>tion Ouvrière. Negli anni Sessanta negli Stati Uniti non si capiva già più che<br />
anche questa denuncia era essenziale alla Con<strong>di</strong>tion Ouvrière, non meno della denuncia delle<br />
paghe, degli orari , dei ritmi <strong>di</strong>sumani. Infatti vari e<strong>di</strong>tori rifiutarono la traduzione, quando mio<br />
marito l’ebbe terminata, «perché le <strong>con</strong><strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> lavoro erano mutate – gli orari, i ritmi, i salari».<br />
Era pur vero ancora che il lavoro <strong>di</strong> fabbrica non aveva un suo senso anche in sè, come lo ha, ad<br />
esempio, il lavoro dei campi, ma solo nel guadagno. Ma questo non <strong>con</strong>tava.<br />
Invece per Simone questa offesa inflitta all’anima <strong>con</strong>tava quanto quella inflitta al<br />
corpo dalla miseria e dalla fatica. E aveva pensato che fosse essenziale sentirla, e aiutare gli altri a<br />
sentirla, invece che anestetizzarsi – per questo aveva gettato via ogni schermo. Forse noi abbiamo il<br />
<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> avere un atteggiamento <strong>di</strong>verso <strong>di</strong> fronte alla nostra e altrui sofferenza, ma io credo che<br />
bisogni capire quale fu l’atteggiamento <strong>di</strong> Simone <strong>di</strong> fronte a questa sofferenza, per intendere il suo<br />
pensiero, e magari la sua morte.<br />
Che rapporto aveva Simone Weil <strong>con</strong> le sue origini ebraiche?<br />
Nel saggio Le ra<strong>di</strong>ci ebraiche del moderno, Sergio Quinzio cita Simone Weil, accanto a Weininger,<br />
come “uno dei più drammatici casi <strong>di</strong> antisemitismo ebraico”. E d’altronde, certe pagine della sua<br />
opera, come le Lettere a un religioso, dove la polemica <strong>con</strong>tro l’ebraismo e il ‘Dio degli eserciti’<br />
del Vecchio Testamento raggiunge punte <strong>di</strong> <strong>una</strong> certa asprezza, potrebbe indurre a ritenere non del<br />
tutto infondato tale giu<strong>di</strong>zio. Se<strong>con</strong>do Lei, qual è la prospettiva più corretta in cui dovremmo porci<br />
per affrontare questo problema?<br />
Intanto, non solo l’aspetto – come <strong>di</strong>cevano a France Libre --, ma anche certi tratti del<br />
carattere <strong>di</strong> Simone erano tipicamente ebraici. E ci rimanda ad altri straor<strong>di</strong>nari esponenti anomali<br />
dell’ebraismo, non ultimo Wittengstein, anche l’assolutezza degli ideali – si pensi alla de<strong>di</strong>zione<br />
alla verità e alla giustizia -- , che aveva in gran parte assorbito dai genitori. Io tendo a credere che<br />
certe ra<strong>di</strong>ci in apparenza recise (in questo caso dall’agnosticismo e dall’assimilazione) <strong>con</strong>tinuino<br />
per qualche generazione a dar frutti. Carattere e ideali, <strong>di</strong>cevo. Simone si dava <strong>con</strong> un’intensità che<br />
si ritrova più spesso tra gli Ebrei. Penso alla sua urgenza <strong>di</strong> essere al centro delle cose, proprio nel<br />
cuore delle situazioni più tragiche. E a quell’acuità della coscienza che permette <strong>di</strong> sentire come<br />
“reale” “la muta caduta <strong>di</strong> stelle lontane” -- come scrisse un altro Ebreo anomalo, Hofmannsthal. Il<br />
male <strong>di</strong> un’altra carne era “reale” per lei come quello della sua propria carne. In questo, <strong>di</strong>ceva,<br />
<strong>con</strong>siste l’attenzione che è la sola virtù. Ma, a leggerla bene, si ha l’impressione che questa “virtù “<br />
le fosse <strong>con</strong>naturale -- il che non è proprio della virtù, faticosa <strong>con</strong>quista se<strong>con</strong>do quel Rousseau<br />
che lei ingiustamente non amava. Ora, anche questa capacità <strong>di</strong> identificazione io ho ris<strong>con</strong>trato –<br />
<strong>con</strong> cospicue eccezioni, come <strong>Cristina</strong> e la Ortese – <strong>di</strong> preferenza in Ebrei. E potrei <strong>con</strong>tinuare.<br />
Ma che lei stessa si collocasse tra gli Ebrei, invece, è impossibile sostenere. Ancora ci<br />
si interroga sul perché, e non pretendo <strong>di</strong> aver io la risposta, ma voglio <strong>con</strong><strong>di</strong>videre qualche<br />
riflessione. Un’educazione razionalista non dovette <strong>con</strong>tribuire a farle sentire <strong>di</strong>versa<br />
dall’appartenenza ad un clan l’appartenenza a un gruppo definito da <strong>una</strong> fede che né lei né i suoi<br />
genitori avevano ere<strong>di</strong>tato. Forse nell’infanzia aveva anche assorbito qualcosa dell’ironia <strong>con</strong> cui la<br />
madre <strong>con</strong>siderava (come ho già accennato) la famiglia paterna, legata a quella fede ma insieme ai<br />
valori piccolo-borghesi. Per noi oggi è <strong>di</strong>fficile pensare che ri<strong>con</strong>oscersi ebrei potesse essere<br />
fierezza <strong>di</strong> un privilegio sociale. Ma prima della persecuzione, gli Ebrei, per lo più agnostici e<br />
assimilati, che frequentavano i Weil erano professionisti stimati e agiati, e formavano un gruppo <strong>di</strong><br />
élite nella borghesia intellettuale parigina me<strong>di</strong>o-alta. Mi rac<strong>con</strong>tò Elena Bemporad, la figlia<br />
dell’e<strong>di</strong>tore fiorentino, che alle elementari, (nel se<strong>con</strong>do decennio del ‘900), se sentiva qualcuno<br />
<strong>di</strong>re che la sua famiglia, anch’essa assimilata e non praticante, era ebrea «credeva che significasse