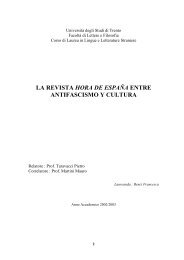L'antologia di «Solaria - CIRCE
L'antologia di «Solaria - CIRCE
L'antologia di «Solaria - CIRCE
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
La seconda antologia <strong>di</strong> Solaria appare, rispetto alla prima, sfrondata <strong>di</strong> molti nomi e per alcuni <strong>di</strong><br />
essi – come per quello del Bonsanti l’esclusione, anche se si giustifica con l’assai scarsa presenza <strong>di</strong><br />
scritti nelle annate della rivista, appare veramente ingiusta quando si pensi che proprio Bonsanti è<br />
colui che per alcuni anni – come si è scritto <strong>di</strong>anzi – influì sull’orientamento della rivista nel senso<br />
<strong>di</strong> un adeguamento dei suoi temi alla letteratura italiana dell’epoca e in particolare a quelli <strong>di</strong> una<br />
letteratura fiorentina. Certo egli rappresentò anche nella rivista l’espressione delle sue zone meno<br />
«impegnate» su un piano parapolitico o metapolitico, a vantaggio <strong>di</strong> una maggiore accentuazione<br />
sui problemi <strong>di</strong> stile e <strong>di</strong> linguaggio, ma si è visto come una tale accentuazione sia appunto anche in<br />
funzione dell’angolazione anticonformista <strong>di</strong> Solaria non soltanto rispetto al regime dell’epoca, ma<br />
anche rispetto al provincialismo particolarista dell’ambiente letterario italiano <strong>di</strong> quegli anni.<br />
Solaria – occorre <strong>di</strong>rlo – si trovava ad operare su un terreno già <strong>di</strong>ssodato dalla Voce e in<br />
particolare, nel campo letterario, dalla Voce derobertisiana, <strong>di</strong> cui, in certo senso, La Ronda romana<br />
è una continuazione, almeno sul piano della polemica stilistica. Ma si tratta <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ssodamento non<br />
sempre positivo. Uno dei meriti <strong>di</strong> Solaria – documentabile sia nella prima che nella seconda<br />
antologia – è stato infatti quello <strong>di</strong> fare accettare nella letteratura italiana uno scrittore come Svevo,<br />
e con Svevo <strong>di</strong> aprire alla letteratura italiana le possibilità <strong>di</strong> una narrativa <strong>di</strong> indagine psicologica,<br />
senza tuttavia una rinuncia <strong>di</strong> carattere contenutistico alle innegabili acquisizioni stilistiche <strong>di</strong> tutta<br />
una letteratura che a Firenze e a Roma aveva avuto in quegli anni uno sviluppo ragguardevole<br />
appunto nella Voce derobertisiana e nella Ronda cardarelliana e cecchiana. La scoperta <strong>di</strong> Svevo da<br />
parte <strong>di</strong> Montale era già avvenuta negli anni precedenti, e coeva a Solaria era stata la perentoria<br />
segnalazione sulla Fiera letteraria dell’epoca da parte <strong>di</strong> Benjamin Crémieux e <strong>di</strong> Valéry Larbaud<br />
segnalazione accettata a denti stretti dallo stesso giornale. Si deve a Solaria (e penso in gran parte<br />
allo stesso Bonsanti) se le molte ostilità dei nostri letterati verso lo scrittore triestino siano andate<br />
progressivamente attenuandosi proprio nel clima europeo <strong>di</strong> Solaria, e se Svevo poté entrare nella<br />
nostra letteratura non come fatto polemico o scandalistico, ma a pieno <strong>di</strong>ritto in un suo nuovo<br />
spirito europeo, che ne giustifica pienamente l’apparente «barbaricità», e – malgrado le<br />
contrad<strong>di</strong>zioni e gli apparenti <strong>di</strong>slivelli linguistici e stilistici della sua narrativa, contrad<strong>di</strong>zioni e<br />
<strong>di</strong>slivelli <strong>di</strong> cui ha fatto giustizia una critica più avvertita <strong>di</strong> cui, con Leo Ferrero, con Debenedetti,<br />
con Ferrata, con Montale, con Morra, con Raffaello Franchi (uno scrittore ingiustamente<br />
<strong>di</strong>menticato), con Chiaromonte, Solaria fu l’espressione – ne rivela l’alto livello anche su un piano<br />
stilistico.<br />
L’antologia del Siciliano è appunto la documentazione <strong>di</strong> una siffatta apertura moderna ed europea.<br />
Essa molto giustamente si apre con uno scritto <strong>di</strong> Leo Ferrero (del 1928) «Perché l’Italia abbia una<br />
letteratura europea»che è non soltanto un invito alla sprovincializzazione della nostra cultura<br />
letteraria, ma altresì un richiamo ad una intelligenza della nostra tra<strong>di</strong>zione letteraria che appunto si<br />
richiami ai suoi valori europei, al suo universalismo. È uno scritto tutto attuale e <strong>di</strong> una attualità così<br />
forte, così perentoria, anche per il profondo spirito europeistico che lo anima, da offrire tutt’oggi<br />
una guida e una in<strong>di</strong>cazione vali<strong>di</strong>ssima. Partendo appunto da quello scritto il Siciliano ha angolato<br />
la sua scelta strutturandola sul sostanziale proustismo e valérismo del primo tempo della rivista<br />
attraverso gli scritti raccolti nel primo capitolo: <strong>di</strong> Ungaretti, della Manzini, <strong>di</strong> Montale, <strong>di</strong> Solmi;<br />
nelle sue istanze stilistico-narrative («Tra Svevo e Gadda») nel capitolo secondo, istanze riprese e<br />
sviluppate altresì nel terzo (dove è riportato un fondamentale saggio <strong>di</strong> Debenedetti su Saba).<br />
De<strong>di</strong>cando poi il quarto capitolo a «Tendenze e utopie», il Siciliano ha tenuto particolarmente ad<br />
affermare, negli scritti <strong>di</strong> Chiaromonte, <strong>di</strong> Ferrata, <strong>di</strong> Timpanaro, <strong>di</strong> Aventi il clima <strong>di</strong> rischiosa<br />
esperienza che caratterizzò la rivista della cultura letteraria italiana. Ma forse la sua parte più<br />
interessante è l’«Appen<strong>di</strong>ce» dove hanno trovato posto scritti come la «Lettera su Svevo» <strong>di</strong> James<br />
Joyce, il commento al suici<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Majakòvskij <strong>di</strong> Renato Poggioli, un saggio su Mann dello stesso,<br />
due scritti su cinema <strong>di</strong> Debenedetti e Montale e l’interessantissimo «Come un attore può arrivare<br />
allo stile» <strong>di</strong> Leo Ferrero.<br />
In: «La Fiera letteraria», a. XIV, n. 13 (29 marzo 1959), pp. 1-2