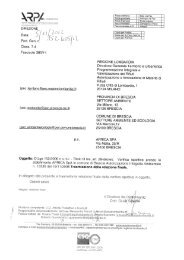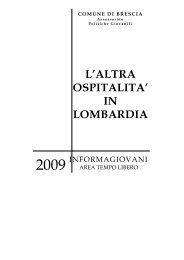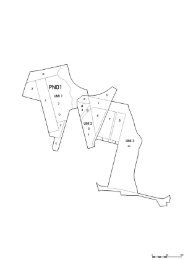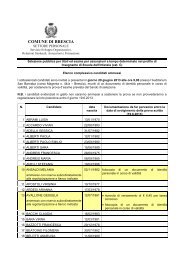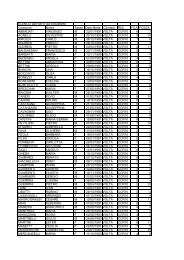CORSO CAVOUR - Comune di Brescia
CORSO CAVOUR - Comune di Brescia
CORSO CAVOUR - Comune di Brescia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>CORSO</strong> <strong>CAVOUR</strong><br />
1. palazzetto Stacchini, n.4<br />
2. chiesa <strong>di</strong> sant’Alessandro<br />
3. palazzo Martin già Monti, n.37<br />
Toponomastica e cenni storici<br />
La strada che collega corso Magenta con via Vittorio<br />
Emanuele II percorre l’antico tracciato che conduceva<br />
alla porta urbica meri<strong>di</strong>onale <strong>di</strong> sant’Alessandro. Il rivellino<br />
semicircolare, costruito a <strong>di</strong>fesa del varco, fu demolito<br />
nel 1804 e la struttura fu definitivamente alterata nella<br />
seconda metà del secolo per la realizzazione <strong>di</strong> piazzale<br />
Cremona. Per secoli, fino alla seconda metà dell’Ottocento,<br />
la strada era nota come via Sant’Alessandro o via<br />
Borgo Sant’Alessandro per la presenza dell’omonima<br />
chiesa. Fu infatti solo nel 1861 che la via venne intitolata<br />
a Camillo Benso conte <strong>di</strong> Cavour (Torino 1810-1861),<br />
statista piemontese e primo ministro del Regno d’Italia<br />
tra i principali protagonisti del Risorgimento italiano.<br />
Passeggiando per corso Cavour<br />
Sul versante occidentale della via, si scorge una piccola piazzetta dominata dall’elegante<br />
prospetto del palazzetto, <strong>di</strong> gusto eclettico, eretto dall’architetto Ulisse<br />
Stacchini (1) nel 1926, oggi filiale della banca Unicre<strong>di</strong>t. Fino al secolo precedente<br />
qui insisteva un mulino sul piccolo fiume Molin del Brolo.<br />
Poco oltre sul versante orientale della via si apre la più ampia piazzetta <strong>di</strong> Sant’Alessandro,<br />
che deve l’intitolazione alla presenza dell’omonimo luogo <strong>di</strong> culto<br />
(2) (cfr. visita guidata, p.).<br />
In questo spazio trova collocazione una bella fontana eretta nel 1787 su <strong>di</strong>segno<br />
dell’architetto Giovanni Donegani, grazie alle generose offerte dei conti Martinengo<br />
Colleoni.<br />
Prossimo all’incrocio con via Vittorio Emanuele II, al civico 37 è il palazzo Martin<br />
già Monti (3), e<strong>di</strong>ficato dall’architetto Giulio Todeschini nel 1550, per inizia-<br />
96
tiva <strong>di</strong> monsignor Girolamo Monti, inglobando un precedente corpo <strong>di</strong> fabbrica<br />
quattrocentesco. Il palazzo rimase <strong>di</strong> proprietà della famiglia Monti fino al XIX<br />
secolo quando fu acquistato dal commendatore Giulio Togni e dal dotto Giorgio<br />
Porro Savol<strong>di</strong> in occasione del matrimonio dei rispettivi figli Enrico Porro e Bruna<br />
Togni. Dopo pochi anni il palazzo venne nuovamente venduto alla famiglia<br />
Martin De Miranda, attuale proprietaria. Il palazzo ospitò nei primi decenni del<br />
Novecento la celebre sartoria Edvige Bellman, frequentata tra gli altri da Gabriele<br />
d’Annunzio. Oggi, sud<strong>di</strong>viso in vari appartamenti, il palazzo è parzialmente<br />
abitato dai proprietari mentre il piano nobile è occupato dallo stu<strong>di</strong>o del restauratore<br />
Gianmaria Casella.<br />
La sobria facciata è scan<strong>di</strong>ta in tre or<strong>di</strong>ni da due fasce marcapiano fortemente aggettanti,<br />
tali da sembrare quasi dei cornicioni su cui poggiano <strong>di</strong>rettamente le finestre<br />
sormontate, al secondo piano, da un architrave sostenuto da mensolette. Il<br />
portale in bugnato richiama le cantonate laterali. Nel concio <strong>di</strong> chiave dell’arco,<br />
si inserisce lo stemma della famiglia Monti sud<strong>di</strong>viso in due campi con una colomba<br />
che reca un ramoscello d’ulivo nel becco, accanto un muro merlato, in<strong>di</strong>ce<br />
della baronia acquisita nel 1812, nel campo inferiore una montagna a <strong>di</strong>eci<br />
punte. Il portale inquadra<br />
una straor<strong>di</strong>naria veduta<br />
prospettica che attraversa il<br />
cortile interno per sfondare<br />
nel giar<strong>di</strong>no retrostante. Il<br />
profondo giar<strong>di</strong>no <strong>di</strong> matrice<br />
settecentesca stu<strong>di</strong>ato su<br />
un insieme <strong>di</strong> figure circolari,<br />
è stato gravemente<br />
danneggiato da un bombardamento<br />
della seconda<br />
guerra mon<strong>di</strong>ale, nel quale<br />
andarono <strong>di</strong>strutte le statue<br />
e la fontana del XVIII secolo<br />
che l’impreziosivano.<br />
Oggi presenta aiuole <strong>di</strong> forma<br />
irregolare. Curiosa è la<br />
presenza <strong>di</strong> una lieve altura<br />
che nasconde una ghiacciaia<br />
ipogea, un tempo destinata<br />
alla conservazione de-<br />
Palazzetto Stacchini<br />
97
gli alimenti deperibili.<br />
Nel corpo orientale della fabbrica si aprono due sale dai soffitti con lacunari <strong>di</strong>pinti<br />
del tardo Cinquecento, opera forse <strong>di</strong> Lattanzio Gambara. Nel corpo occidentale<br />
si trova una grande sala voltata e decorata nei primi anni del Novecento<br />
con medaglie <strong>di</strong> Cesare Bertolotti che inquadrano stucchi <strong>di</strong> Arturo Castelli. Verso<br />
sud, un’altra sala conserva affreschi <strong>di</strong> Eliodoro Coccoli con Flora, puttini in<br />
gioco, un gatto ed una scimmia (1923).<br />
In questa stessa ala si apre lo scalone settecentesco, costituito da due rampe con<br />
balaustra in marmo. Nella volta un affresco presenta la Fama che sorregge lo<br />
stemma della famiglia Monti.<br />
Al piano nobile si apre una lunga galleria decorata nel XVIII secolo, forse da Pietro<br />
Scalvini, con fregi, gonfaloni, ban<strong>di</strong>ere, fiori e grottesche. Dalla galleria, sulla<br />
destra, si accede ad un prima sala decorata in stile neoclassico. Le pareti ospitano<br />
vedute d’antichità greco-romane che, sebbene non archeologicamente preci-<br />
Palazzo Martin già Monti:<br />
Giuseppe Manfre<strong>di</strong>ni, Rovine, affresco, fine XVIII – inizio XIX secolo<br />
98
se, si caricano <strong>di</strong> un accento visionario atto ad esaltare preromanticamente la sublime<br />
magnificenza dell’architettura. La scenografica decorazione sembra riconducibile<br />
al pennello <strong>di</strong> Giuseppe Manfre<strong>di</strong>ni.<br />
VISITA GUIDATA<br />
Chiesa <strong>di</strong> sant’Alessandro<br />
Orario <strong>di</strong> apertura:<br />
da lunedì a venerdì 7.00 – 11.00; 16.30 – 18.00;<br />
sabato e domenica 8.30 - 11.00; 17.00 – 19.00<br />
Cenni storici<br />
La chiesa, <strong>di</strong> origini antiche, risalirebbe alla prima<br />
metà del V secolo secondo la tra<strong>di</strong>zione che la vuole<br />
fondata dal vescovo bresciano Gau<strong>di</strong>oso, del quale qui<br />
si conservano le reliquie. Nel 1136 venne eletta canonica<br />
e ricostruita nel primo quarto del Quattrocento.<br />
Nel 1430 giunsero infatti a <strong>Brescia</strong> da Bologna i frati<br />
serviti <strong>di</strong> Maria che tanto si impegnarono nella cura e<br />
nell’abbellimento della chiesa antica e dell’attiguo<br />
convento. Nel 1466 la nuova chiesa venne consacrata<br />
dal vescovo Domenico de Dominicis che accanto all’antico<br />
titolo <strong>di</strong> Sant’Alessandro la de<strong>di</strong>cò a Maria<br />
Vergine.<br />
In epoca rinascimentale i servi <strong>di</strong> Maria commissionarono<br />
a Lattanzio Gambara un ciclo <strong>di</strong> affreschi de<strong>di</strong>cati<br />
a storie della vita della Vergine, <strong>di</strong> Mosè, Aronne e<br />
Melchisedec, purtroppo perduti nel corso dei lavori<br />
settecenteschi <strong>di</strong> ampliamento assieme ad un ciclo <strong>di</strong><br />
mezze lune <strong>di</strong> Camillo Rama (1628) con episo<strong>di</strong> della vita <strong>di</strong> Maria ed un polittico<br />
della Natività del Romanino (1525) entro ancona <strong>di</strong> Stefano Lamberti nel<br />
coro. L’opera che rappresentava l’Adorazione del Bambino da parte dei santi Gerolamo,<br />
Alessandro, Filippo e Gaudenzio, si trova oggi alla National Gallery <strong>di</strong><br />
Londra. Per questa stessa chiesa Moretto aveva <strong>di</strong>pinto una tela con San Rocco,<br />
attualmente a Budapest.<br />
Nel 1769 la chiesa subì gravi danni dovuti all’esplosione della polveriera <strong>di</strong> San<br />
Nazaro al punto che sul finire del secolo la chiesa fu oggetto <strong>di</strong> un importante in-<br />
99
tervento <strong>di</strong> ricostruzione progettato dall’architetto Giovanni Donegani che interessò<br />
anche lo spazio antistante dove, demolita una casa degli Avogadro Fenaroli<br />
(come ricorda una lapide sull’angolo esterno della chiesa), venne allestita la<br />
piazzetta impreziosita dalla fontana con vasca a forma <strong>di</strong> valva <strong>di</strong> conchiglia progettata<br />
dallo stesso Donegani (1787) e realizzata grazie al generoso contributo dei<br />
conti Martinengo Colleoni.<br />
Nel 1797 nell’ambito delle soppressioni monastiche viene soppressa la Congregazione<br />
dei servi <strong>di</strong> Maria e con essa il convento stesso, destinato ad arsenale ed<br />
ospedale militare. Il convento comprendeva due chiostri che insistevano sul lato<br />
settentrionale della chiesa: il primo, laddove sorgono oggi il cinema ed il bar, era<br />
quadrangolare circondato da portici con sei arcate a tutto sesto; il secondo, verso<br />
est, aveva forma irregolare. I due chiostri furono <strong>di</strong>strutti dal bombardamento aereo<br />
che colpì <strong>Brescia</strong> il 2 marzo 1945.<br />
Chiesa <strong>di</strong> Sant’Alessandro<br />
100<br />
Esterno<br />
La facciata fu compiuta dall’architetto<br />
Carlo Melchiotti<br />
tra il 1894 ed il 1903, recuperando<br />
il progetto settecentesco<br />
del Donegani, mai realizzato<br />
per mancanza <strong>di</strong> fon<strong>di</strong>.<br />
Divisa in due or<strong>di</strong>ni, presenta<br />
un sobrio ingresso centrale<br />
con copertura semicircolare,<br />
sormontato da ampio<br />
finestrone quadrangolare ed<br />
inquadrato tra due coppie <strong>di</strong><br />
colonne corinzie poggianti<br />
su alti stilobati. Su <strong>di</strong> esse<br />
poggiano l’architrave ed il<br />
timpano triangolare con profilo<br />
dentellato movimentato<br />
da margini esterni aggettanti<br />
in accordo con i volumi del<br />
corpo sottostante.
Interno<br />
L’interno, a pianta longitu<strong>di</strong>nale, venne realizzato su progetto dello stesso Donegani,<br />
in stile classicheggiante con quattro altari per lato inseriti entro cappelle con<br />
ampi archi a pieno centro, scan<strong>di</strong>te da possenti colonne corinzie in scagliola <strong>di</strong>pinta<br />
a imitazione del marmo. La cornice dentellata che corre al <strong>di</strong> sopra funge<br />
da elemento unificatore sottolineando il perimetro della chiesa.<br />
La navata unica è coperta da una volta a botte che si interrompe in corrispondenza<br />
dell’altar maggiore, su cui insiste un’ampia cupola, per chiudersi nell’area del<br />
coro.<br />
Partendo dal lato destro, sopra la moderna cappella del Battistero (a) si trova la<br />
tela del bresciano Gerolamo Rossi con la Beata Vergine che concede l’abito nero<br />
ai Servi <strong>di</strong> Maria. Secondo la tra<strong>di</strong>zione la Vergine apparve in visione nel 1239 a<br />
sette uomini fiorentini donando loro il proprio abito nero, emblema dei dolori da<br />
lei sofferti. L’abito che sarebbe <strong>di</strong>venuto quello dell’or<strong>di</strong>ne dei serviti in<strong>di</strong>cava la<br />
particolare devozione dei frati all’Addolorata. Il <strong>di</strong>pinto fa parte <strong>di</strong> una serie <strong>di</strong><br />
quattro tele già ante per l’organo dell’Antegnati. Ritraggono momenti salienti<br />
dell’or<strong>di</strong>ne dei Servi <strong>di</strong> Maria e storie della vita <strong>di</strong> sant’Alessandro. Il ciclo potrebbe<br />
datarsi dopo il 1610, quando venne istituita la “Scuola dell’Addolorata” o<br />
“dell’Abito”.<br />
Il primo altare (b) ospita una delle opere più pregevoli dell’intera chiesa: la pala<br />
con l’Annunciazione attribuita a Jacopo Bellini (1444). Il <strong>di</strong>pinto concepito come<br />
un grande <strong>di</strong>ttico documenta la transizione nel gusto pittorico della nostra città<br />
dallo stile tardo gotico al primo rinascimento. Retaggio del gotico fiorito è la raffinata<br />
decorazione delle vesti dorate dei personaggi nonché l’eleganza delle pose<br />
e la maestosa cornice. Mentre segnali <strong>di</strong> una sensibilità moderna si leggono nella<br />
costruzione prospettica degli spazi. Nella predella si susseguono cinque scene<br />
della vita <strong>di</strong> Maria (la Nascita, la Presentazione al Tempio, la Visitazione, il Miracolo<br />
della Madonna della Neve e la Dormitio).<br />
Sul secondo altare (c) domina la Deposizione <strong>di</strong> Vincenzo Civerchio (1504).<br />
L’opera denota la ripresa <strong>di</strong> modelli nor<strong>di</strong>ci o ferraresi nei ritratti taglienti e nel<br />
forte intento drammatico che pervade l’intera scena. In primo piano si stagliano<br />
le figure della Madonna e della Maddalena che sorreggono il corpo <strong>di</strong> Cristo, alle<br />
cui spalle si trovano Adamo e i santi Paolo ed Alessandro. Sullo sfondo, uno dei<br />
paesaggi più belli dell’autore, domina una veduta del Golgota con i soldati e le<br />
tre croci su due delle quali giacciono ancora i corpi dei ladroni. In basso a sinistra<br />
si riconosce la porta del sepolcro aperta a preludere alla Resurrezione <strong>di</strong> Cristo.<br />
Successivi episo<strong>di</strong> della vita <strong>di</strong> Cristo sono illustrati nella predella: l’Incredu-<br />
101
lità <strong>di</strong> san Tommaso, il Noli me tangere e l’Incontro sulla via <strong>di</strong> Emmaus. Il paliotto<br />
d’altare ed il tabernacolo sono <strong>di</strong> Carlo e Giovanni Carra.<br />
Sul terzo altare (d) si trova oggi una statua moderna dell’Addolorata, opera <strong>di</strong><br />
Angelo Righetti (1943) che sostituisce l’antica <strong>di</strong> Gregoretti. Il complesso dell’altare<br />
marmoreo è impreziosito da statue <strong>di</strong> Antonio Callegari che ritraggono la<br />
Fede e la Carità. Sulla cimasa curvilinea quattro angeli sorreggono le arma Christi<br />
(chio<strong>di</strong>, croce, lancia, martello). L’altare proviene dalla chiesa <strong>di</strong> Santa Giulia<br />
dove evidentemente doveva essere de<strong>di</strong>cato al tema eucaristico. Fu alienato in seguito<br />
alla soppressione della chiesa benedettina e venduto a Sant’Alessandro nel<br />
1804.<br />
Sopra il quarto altare (e) si conserva un Ecce homo <strong>di</strong> Lattanzio Gambara (1563).<br />
L’affresco strappato e portato su tela faceva originariamente parte della decorazione<br />
pittorica della cappella del Santissimo Sacramento.<br />
Di Antonio Callegari è l’altorilievo in marmo con il Compianto su Cristo morto<br />
tra la Vergine e la Maddalena. L’ovato era originariamente parte del paliotto dell’altare<br />
attualmente in sagrestia.<br />
Sopra la porta laterale (f) campeggia una tela <strong>di</strong> Gerolamo Rossi che ritrae sant’Alessandro<br />
con il labaro e<br />
il cavallo. Sant’Alessandro<br />
era un soldato del III-IV secolo<br />
della legione Tebea<br />
contrad<strong>di</strong>stinta dal giglio riprodotto<br />
sul suo labaro. Rifiutatosi<br />
<strong>di</strong> eseguire condanne<br />
sui cristiani fu decapitato<br />
a Bergamo.<br />
Sull’altare maggiore (g) una<br />
tela <strong>di</strong> Pietro Moro racconta<br />
il Martirio <strong>di</strong> sant’Alessandro<br />
(1790). Il <strong>di</strong>pinto venne<br />
commissionato al pittore veneziano<br />
per colmare la lacuna<br />
lasciata dall’alienazione<br />
del polittico del Romanino,<br />
oggi alla National Gallery <strong>di</strong><br />
Londra.<br />
L’altare maggiore in marmo<br />
fu scolpito da Alessandro<br />
Jacopo Bellini, Annunciazione, 1444<br />
102
Monti su <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> Luigi Arcioni (1911). Sotto la mensa si conserva l’urna con<br />
le reliquie <strong>di</strong> San Gau<strong>di</strong>oso, vescovo bresciano del V secolo cui si riconduce tra<strong>di</strong>zionalmente<br />
la fondazione della chiesa.<br />
A destra (h) si trova l’organo <strong>di</strong> Giovanni Tonoli (1884) che ha sostituito il precedente<br />
dell’Antegnati.<br />
A sinistra (i) campeggia il <strong>di</strong>pinto settecentesco <strong>di</strong> Giuseppe Tortelli con la Vergine<br />
che consegna l’abito nero ai servi <strong>di</strong> Maria.<br />
Passando al lato sinistro, sopra la porta laterale (l) si trova un’altra tela <strong>di</strong> Gerolamo<br />
Rossi con Il miracolo degli idoli che cadono davanti a sant’Alessandro.<br />
Nella passio leggendaria si racconta che al suono delle preghiere del Santo una<br />
statua <strong>di</strong> Marte sarebbe caduta a pezzi tra lo stupore degli astanti.<br />
Sopra il quinto altare (m) campeggia Un miracolo <strong>di</strong> san Filippo Benizzi (1623),<br />
opera <strong>di</strong> Grazio Cossali. La tela ci mostra il generale dell’Or<strong>di</strong>ne dei Servi <strong>di</strong> Maria<br />
che, come un novello Mosè, per <strong>di</strong>ssetare gli abitanti della città <strong>di</strong> Siena colpita<br />
da siccità, fa sgorgare l’acqua da una roccia colpendola con un bastone. Pregevole<br />
è pure la piccola porta del tabernacolo, <strong>di</strong>pinta all’inizio del XVII secolo<br />
con la scena del Compianto su Cristo morto.<br />
Sul sesto altare (n) domina una tela <strong>di</strong> Gerolamo Rossi con la Beata Vergine col<br />
Bambino ed i santi Gerolamo, Giovanni Evangelista, Francesco d’Assisi, Onorio<br />
Vescovo. Evidente è il richiamo a Moretto nella scelta compositiva della <strong>di</strong>sposizione<br />
su due registri. In quello superiore campeggiano su un trono aereo la Madonna<br />
ed il Bambino, mentre in quello inferiore i santi si <strong>di</strong>spongono secondo<br />
schema semicircolare che si apre al centro sulla veduta <strong>di</strong> un paesaggio naturale.<br />
I colori improntati a toni luminosi sono piuttosto un richiamo alla pittura del Veronese.<br />
L’altare successivo (o) accoglie un <strong>di</strong>pinto settecentesco <strong>di</strong> Giuseppe Tortelli de<strong>di</strong>cato<br />
a due servi <strong>di</strong> Maria. Gesù guarisce san Pellegrino Laziosi toccandogli la<br />
piaga sulla gamba, mentre santa Giuliana Falconieri gravemente malata non potendo<br />
ricevere la Comunione poggiò l’Ostia consacrata sul suo cuore.<br />
L’ultimo altare (p) è sormontato da una tela cinquecentesca <strong>di</strong> Luca Sebastiano<br />
Aragonese che ritrae san Luigi re <strong>di</strong> Francia fra i santi Rocco e Sebastiano. Nel<br />
registro superiore si scorge Cristo con gli strumenti della passione.<br />
Segue infine la cappella del crocifisso (q) che ospita l’ultimo <strong>di</strong>pinto <strong>di</strong> Gerolamo<br />
Rossi, già impiegato come anta interna d’organo, con il piccolo san Filippo<br />
in braccio alla madre che la invita a far l’elemosina ai servi <strong>di</strong> Maria.<br />
Domina in controfacciata la tela <strong>di</strong> Enrico Albricci con la Visitazione (1755-<br />
1760).<br />
103