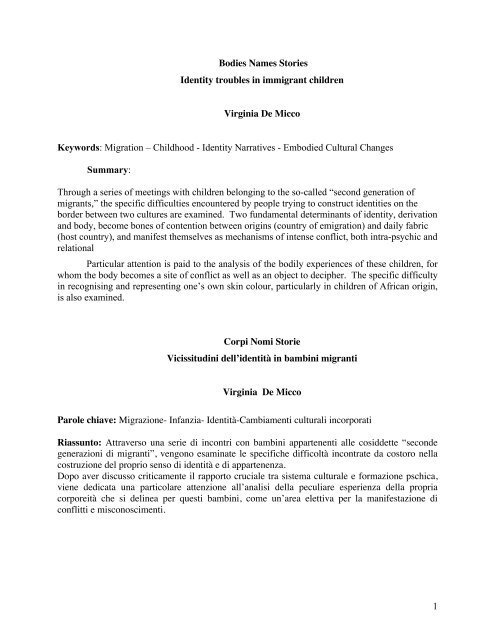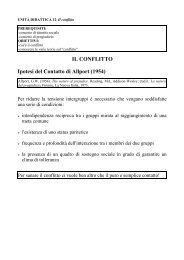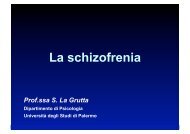articolo De Micco - Facoltà di Scienze della Formazione
articolo De Micco - Facoltà di Scienze della Formazione
articolo De Micco - Facoltà di Scienze della Formazione
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Bo<strong>di</strong>es Names Stories<br />
Identity troubles in immigrant children<br />
Virginia <strong>De</strong> <strong>Micco</strong><br />
Keywords: Migration – Childhood - Identity Narratives - Embo<strong>di</strong>ed Cultural Changes<br />
Summary:<br />
Through a series of meetings with children belonging to the so-called “second generation of<br />
migrants,” the specific <strong>di</strong>fficulties encountered by people trying to construct identities on the<br />
border between two cultures are examined. Two fundamental determinants of identity, derivation<br />
and body, become bones of contention between origins (country of emigration) and daily fabric<br />
(host country), and manifest themselves as mechanisms of intense conflict, both intra-psychic and<br />
relational<br />
Particular attention is paid to the analysis of the bo<strong>di</strong>ly experiences of these children, for<br />
whom the body becomes a site of conflict as well as an object to decipher. The specific <strong>di</strong>fficulty<br />
in recognising and representing one’s own skin colour, particularly in children of African origin,<br />
is also examined.<br />
Corpi Nomi Storie<br />
Vicissitu<strong>di</strong>ni dell’identità in bambini migranti<br />
Virginia <strong>De</strong> <strong>Micco</strong><br />
Parole chiave: Migrazione- Infanzia- Identità-Cambiamenti culturali incorporati<br />
Riassunto: Attraverso una serie <strong>di</strong> incontri con bambini appartenenti alle cosiddette “seconde<br />
generazioni <strong>di</strong> migranti”, vengono esaminate le specifiche <strong>di</strong>fficoltà incontrate da costoro nella<br />
costruzione del proprio senso <strong>di</strong> identità e <strong>di</strong> appartenenza.<br />
Dopo aver <strong>di</strong>scusso criticamente il rapporto cruciale tra sistema culturale e formazione pschica,<br />
viene de<strong>di</strong>cata una particolare attenzione all’analisi <strong>della</strong> peculiare esperienza <strong>della</strong> propria<br />
corporeità che si delinea per questi bambini, come un’area elettiva per la manifestazione <strong>di</strong><br />
conflitti e misconoscimenti.<br />
1
Corpi Nomi Storie<br />
Vicissitu<strong>di</strong>ni dell’identità in bambini migranti<br />
Virginia <strong>De</strong> <strong>Micco</strong><br />
*Secondo Jean Paul Raison, la migrazione è un “fenomeno sfuggente”, caratterizzato<br />
elettivamente dalla sua <strong>di</strong>namicità: è strutturalmente ‘sfuggente’ in quanto ‘zona’ <strong>di</strong> passaggi, <strong>di</strong><br />
trasformazioni, <strong>di</strong> cambiamenti dagli esiti incerti, luogo dove per eccellenza la <strong>di</strong>namica culturale<br />
e sociale si ‘incarna’ nella <strong>di</strong>namica psichica e relazionale.<br />
Nell’avvicinarsi al mondo delle migrazioni la psicoanalisi si trova così confrontata con i<br />
<strong>di</strong>sagi <strong>di</strong> quelle che l’antropologo Arjun Appadurai chiama le ‘identità <strong>di</strong>asporiche’, <strong>di</strong>sagi che<br />
comunque è particolarmente adatta a riconoscere proprio per quella <strong>di</strong>mensione insita nel suo<br />
movimento teorizzante, nel suo itinerario conoscitivo, volto a fantasticare, tradurre, indovinare,<br />
secondo la nota formula freu<strong>di</strong>ana. Volto cioè a cogliere i passaggi (traduzione/transfert), gli<br />
slittamenti <strong>di</strong> senso, la necessità <strong>di</strong> comprendere in parte e a tratti (indovinare traduce infatti er-<br />
raten, dal latino rata, parte) 1 , frutto <strong>della</strong> sua vocazione ra<strong>di</strong>calmente antisistemica (Paul-Laurent<br />
Assoun).<br />
E già che ci siamo varrà la pena <strong>di</strong> sottolineare quantomeno l’ ‘assonanza’ tra la <strong>di</strong>aspora,<br />
richiamata da Appadurai, e la “psicoanalisi scienza ebraica”, permeata dunque nelle sue stesse<br />
ra<strong>di</strong>ci da una sorta <strong>di</strong> inestinguibile essenza <strong>di</strong>asporica, ovverosia <strong>di</strong> attitu<strong>di</strong>ne a ‘pensare’ la<br />
<strong>di</strong>aspora. Secondo Appadurai tale ‘forma storica’ dell’identità in<strong>di</strong>viduale sarebbe specifica<br />
dell’era <strong>della</strong> globalizzazione, segnata da due fenomeni principali: la deterritorializzazione delle<br />
comunità e degli in<strong>di</strong>vidui e la rilevanza dei mezzi <strong>di</strong> comunicazione <strong>di</strong> massa. Il primo elemento<br />
segna la rottura <strong>della</strong> ‘solidarietà’ organica tra un territorio, una comunità e una tra<strong>di</strong>zione<br />
culturale, mentre il secondo esalta modalità <strong>di</strong> trasmissione culturale sul piano orizzontale, per<br />
così <strong>di</strong>re, piuttosto che verticale contribuendo a trasformare in profon<strong>di</strong>tà le ere<strong>di</strong>tà culturali e le<br />
configurazioni <strong>di</strong> comunità in cui riconoscersi: comunità virtuali, comunità molto più<br />
1 Cfr. Luchetti A., Fantasticare, tradurre, indovinare, in “Riv. Psicoanal.”, 48, 1, 2002.<br />
2
‘immaginate’ 2 dunque, che comunità storicamente connotabili capaci <strong>di</strong> segnare una continuità e<br />
un’evoluzione nel tempo. La <strong>di</strong>ffusione nello spazio sembra sostituire la ‘profon<strong>di</strong>tà’ nel tempo.<br />
In particolare, questa identità ‘nomade’ che si costruisce tra <strong>di</strong>versi ancoraggi culturali,<br />
lungo frontiere culturali incerte e instabili, riguarda le cosiddette ‘seconde generazioni’ <strong>di</strong><br />
migranti. Già in questa definizione ‘<strong>di</strong> seconda generazione’si rende evidente come la qualità<br />
dell’essere immigrato permanga attraverso le generazioni, e venga ambiguamente mantenuta<br />
attraverso la <strong>di</strong>scendenza, anche quando si tratta a tutti gli effetti <strong>di</strong> bambini nati nel paese <strong>di</strong><br />
accoglienza che per loro, dunque, non è un paese ‘straniero’ ma, spesso, l’unico che abbiano mai<br />
conosciuto e a cui possano sentire <strong>di</strong> appartenere. La qualità astratta e ‘originaria’ dell’essere<br />
straniero sembra sostanziarsi nelle caratteristiche <strong>della</strong> filiazione, dell’‘essere figlio <strong>di</strong>’<br />
immigrati, <strong>di</strong> stranieri e, spesso, nella corporeità, che si attesta come marca inequivocabile <strong>di</strong> un’<br />
origine ‘altra’.<br />
Per questi bambini due determinanti centrali dell’identità, la filiazione e la corporeità,<br />
<strong>di</strong>ventano terreno <strong>di</strong> contesa tra or<strong>di</strong>ne originario ( paese <strong>di</strong> emigrazione) e trama <strong>della</strong><br />
quoti<strong>di</strong>anità ( paese <strong>di</strong> immigrazione), e si manifestano come luoghi <strong>di</strong> intensa conflittualità sia<br />
intrapsichica che relazionale.<br />
Il materiale che verrà <strong>di</strong>scusso nel presente <strong>articolo</strong> proviene da una serie <strong>di</strong> incontri con<br />
ragazzi migranti avvenuti nell’ambito <strong>di</strong> una ricerca presso un centro <strong>di</strong> accoglienza per minori 3 ,<br />
in cui, riprendendo alcune in<strong>di</strong>cazioni winnicottiane, si intendeva lavorare sulla possibilità <strong>di</strong><br />
attivare canali <strong>di</strong> comunicazione profonda anche al <strong>di</strong> fuori <strong>di</strong> autentici setting terapeutici.<br />
Non si tratta <strong>di</strong> fornire un ulteriore terreno <strong>di</strong> esercitazione per una psicoanalisi applicata,<br />
quanto piuttosto <strong>di</strong> delineare le possibilità <strong>di</strong> una psicoanalisi profondamente ‘implicata’ in nuovi<br />
contesti sociali e culturali, attraversati da profon<strong>di</strong> processi <strong>di</strong> trasformazione sul piano<br />
antropologico, i quali, inevitabilmente, si riflettono nella costruzione delle traiettorie identitarie<br />
dei singoli e delle comunità.<br />
Gli incontri si proponevano <strong>di</strong> sondare l’intreccio singolare tra identità e memoria che<br />
veniva a delinearsi nell’esperienza <strong>di</strong> questi bambini, prestando particolare attenzione al modo in<br />
cui erano capaci <strong>di</strong> raccontare la propria storia: autorappresentarsi in termini ‘storici’ implicava<br />
2<br />
Riferimento a quelle che, in altro contesto, B. Anderson in<strong>di</strong>vidua come Comunità immaginate, Manifestolibri,<br />
Roma 1996.<br />
3<br />
Accoglienza limitata al sostegno scolastico per i bambini <strong>di</strong> seconda generazione, le cui famiglie sono presenti sul<br />
territorio.<br />
3
infatti un vincolo simbolizzante in cui era inclusa la propria origine, o meglio sottintendeva una<br />
domanda sulla propria appartenenza. Nella particolare situazione <strong>di</strong> bambini impegnati in un<br />
transito migratorio tale costruzione <strong>della</strong> memoria in<strong>di</strong>viduale si ritrova ingaggiata su due fronti,<br />
in quanto implica una (ri)costruzione non solo del passato in<strong>di</strong>viduale ma comporta anche uno<br />
sforzo <strong>di</strong> collocazione in un ‘gruppo’ interno.<br />
Hilflosigkeit e cultura<br />
La questione <strong>della</strong> migrazione chiama inevitabilmente ed imme<strong>di</strong>atamente in causa quella<br />
<strong>della</strong> costituzione culturale <strong>della</strong> psiche in<strong>di</strong>viduale: <strong>della</strong> intelaiatura culturale che regge<br />
l’apparato psichico. E’ nella stessa con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> Hilflosigkeit che si situa la ra<strong>di</strong>ce del vincolo<br />
culturalizzante: in fondo l’essere umano è destinato (nel senso <strong>di</strong> committed) alla socialità dalla<br />
sua stessa biologia in quanto necessita <strong>di</strong> un altro apparato psichico che <strong>di</strong>a senso e fruibilità alle<br />
sue stesse esperienze primarie e richiede un apparato segnicosimbolico, un apparato culturale<br />
dunque, che è sempre già lì ed è sempre già dato, entro e attraverso il quale possa trovare<br />
strumenti <strong>di</strong> rappresentazione emotiva e simbolica atti a costruire la propria interiorità. E’ nella<br />
con<strong>di</strong>zione stessa <strong>della</strong> prematurità sul piano biologico che si situano contemporaneamente sia la<br />
necessità dell’accu<strong>di</strong>mento, col suo portato <strong>di</strong> imme<strong>di</strong>ato inserimento in un tessuto relazionale e <strong>di</strong><br />
‘infiltrazione’ inconscia <strong>della</strong> psiche nascente 4 , sia la necessità <strong>di</strong> inclusione in un tessuto<br />
simbolico e <strong>di</strong> affiliazione ad un lignaggio, ovverosia ad un sistema <strong>di</strong> rappresentazioni<br />
socioculturali in cui il poter-si <strong>di</strong>re “figlio <strong>di</strong>” abbia un senso, in quanto rientra in un registro <strong>di</strong><br />
significazione. A riprova del legame esistente tra con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> prematurità e con<strong>di</strong>zione culturale<br />
basti pensare a due dati elementari: uno strutturale ed un altro storico. In primo luogo lo svincolo<br />
da un registro istintuale/naturale pienamente ‘maturo’ alla nascita rende contemporaneamente<br />
possibile e necessario il ricorso ad una pluralità <strong>di</strong> riposte <strong>di</strong>versificate, flessibili e mo<strong>di</strong>ficabili,<br />
risposte ‘culturali’ appunto, che si situano su un registro ‘antropologico’ piuttosto che biologico:<br />
si libera cioè lo spazio per l’appren<strong>di</strong>mento/accu<strong>di</strong>mento. Come si vede si tratta esattamente <strong>della</strong><br />
stessa con<strong>di</strong>zione che apre lo spazio perché la pulsione e l’inconscio si instaurino nella psiche al<br />
posto dell’ istinto: in questo senso lungi dall’essere opposte l’una all’altra pulsione e cultura si<br />
ritrovano invece simultaneamente instaurate nella psiche: il luogo <strong>della</strong> pulsione è lo stesso in cui<br />
4 Come si ricorderàLaplanche in<strong>di</strong>viduaproprio in questa “con<strong>di</strong>zioneantropologica fondamentale” ciò che<br />
determina la formazione dell’inconscio in<strong>di</strong>viduale.<br />
4
si indova la cultura. E’ nell’immaturità biologica che si situa dunque la possibilità perché risposte<br />
pulsionali/culturali e non istintuali/naturali si <strong>di</strong>spieghino: ad ulteriore riprova <strong>di</strong> questa<br />
con<strong>di</strong>zione generale va considerato come esista una correlazione positiva tra grado <strong>di</strong> immaturità<br />
alla nascita nelle <strong>di</strong>verse specie <strong>di</strong> mammiferi, e la conseguente durata <strong>della</strong> necessità <strong>di</strong><br />
accu<strong>di</strong>mento da parte dell’adulto, e possibilità <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>mento (in<strong>di</strong>viduale) e <strong>di</strong> trasmissione<br />
(gruppale) <strong>di</strong> risposte ine<strong>di</strong>te. La possibilità <strong>di</strong> sviluppare, entro certi limiti, un carattere<br />
in<strong>di</strong>viduale va dunque <strong>di</strong> pari passo con la possibilità <strong>di</strong> trasmettere e apprendere un sistema<br />
culturale.<br />
Dunque più alto sarà il grado <strong>di</strong> immaturità biologica alla nascita più sarà alto il livello <strong>di</strong><br />
‘<strong>di</strong>pendenza’ dal sistema ‘culturale’ (sistema <strong>di</strong> risposte apprese/trasmesse suscettibile <strong>di</strong><br />
evoluzione) all’interno del quale si viene allevati.<br />
Da un punto <strong>di</strong> vista storico, viceversa, si può osservare come il sistema culturale stesso<br />
incida ‘retroattivamente’ sul livello <strong>di</strong> ‘maturazione’ psichica, se non imme<strong>di</strong>atamente biologica,<br />
dal momento che una <strong>di</strong>latazione sempre crescente <strong>della</strong> strumentazione culturale da apprendere<br />
<strong>di</strong> fatto prolunga i tempi <strong>di</strong> immaturità sul piano in<strong>di</strong>viduale, con la conseguenza <strong>di</strong> espandere<br />
sempre più il ‘margine’ pulsionale mentre si allontana sempre più la cogente necessità del bisogno<br />
naturale. Insomma, paradossalmente, rispetto alle classiche formulazioni freu<strong>di</strong>ane bisogna anche<br />
tenere presente come più cultura significhi più pulsionale, spesso non adeguatamente<br />
simbolizzato, soprattutto laddove le capacità tecnologiche non sono supportate da adeguate<br />
capacità rappresentative.<br />
A proposito del cosiddetto ‘stato <strong>di</strong> impotenza o <strong>di</strong> <strong>di</strong>saiuto’ varrà la pena <strong>di</strong> sottolineare<br />
come la traduzione <strong>di</strong> Hilflosigkeit sia piuttosto fuorviante poiché letteralmente in<strong>di</strong>ca “il fatto <strong>di</strong><br />
essere senza aiuto”, si tratta cioè <strong>della</strong> sostantivizzazione, ossia la reificazione linguistica, <strong>di</strong> una<br />
mancanza, uno dei miracoli del linguaggio. Sebbene Freud introduca, come noto, il termine a<br />
proposito dell’incapacità del neonato <strong>di</strong> compiere l’azione specifica volta al sod<strong>di</strong>sfacimento del<br />
bisogno, forse potrà essere utile sciogliere l’area semantica contenuta nella parola Hilfe per<br />
coglierne alcuni aspetti significativi, che purtroppo non sono resi perfettamente né dall’idea <strong>di</strong> im-<br />
potenza né da quella <strong>di</strong> aiuto (ad-iuvare, chiamare in soccorso). Hilfe infatti, deriva dalla ra<strong>di</strong>ce<br />
indogermanica kelb (che poi passa nell’altotedesco helfan, hilpan) che significa esattamente,<br />
puntellare, sostenere, appoggiare e dalla ra<strong>di</strong>ce kel che in<strong>di</strong>ca mettere al sicuro, coprire, ancora più<br />
specificamente avvolgere, coprire con un involucro. Insomma essere hilflos significa anche essere<br />
5
‘scoperto’ ,in un certo senso, e senza sostegno, per cui non è che l’impotenza viene ‘avvertita’ nel<br />
momento in cui il bisogno non viene sod<strong>di</strong>sfatto, essa è semplicemente non sostenibile: è uno<br />
stato <strong>di</strong> insostenibilità.<br />
L’infans è in maniera in<strong>di</strong>sgiungibile e in<strong>di</strong>stinguibile hilflos, senza parola e senza<br />
involucro. Ecco perché il sistema linguisticoculturale attraverso il quale la madre lo significa e<br />
dunque lo ‘contiene’ costituisce un vero e proprio involucro semantico senza il quale la psiche non<br />
può svilupparsi. Se è vero che la madre è qui che tiene il suo bambino è altrettanto vero che è lì<br />
che lo contiene, se riesce davvero a contenerlo è solo perché è lì, in un altrove culturale, che lo<br />
significa: <strong>di</strong> fatto accettando <strong>di</strong> farlo nascere culturalmente ipso facto se ne ‘espropria’ cedendolo<br />
ad un’or<strong>di</strong>ne culturale che lo affilia, rendendolo soggetto.<br />
E’ proprio lo stu<strong>di</strong>o delle ‘molteplici singolarità <strong>di</strong> un fenomeno collettivo’ quale quello<br />
migratorio – per usare un’espressione dell’antropologa Amalia Signorelli – che mette<br />
particolarmente in risalto questa <strong>di</strong>mensione costitutiva <strong>della</strong> cultura per la psiche in<strong>di</strong>viduale.<br />
Non sarà sfuggita la possibilità <strong>di</strong> leggere le righe precedenti anche alla luce <strong>della</strong> ‘questione<br />
<strong>della</strong> psicosi’ . Non si tratta <strong>di</strong> un’eco casuale: si ricorderà come per gli stu<strong>di</strong> psichiatrici, in<br />
particolare del dopoguerra, proprio le patologie dei migranti <strong>di</strong>ventarono un terreno <strong>di</strong> aspra<br />
contesa relativamente alla possibilità <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare delle ‘psicosi psicogene’, ovverosia<br />
integralmente ‘scatenate’ dall’esperienza migratoria. La rimessa in <strong>di</strong>scussione ‘dalle<br />
fondamenta’ del legame strutturale tra psiche e sistema culturale, inteso proprio in quel senso <strong>di</strong><br />
essenziale involucro semantico, che inevitabilmente l’esperienza migratoria comporta, espone<br />
esattamente ad un rinnovato rischio <strong>di</strong> non riuscire a ri-simbolizzare i contenuti psichici secondo il<br />
nuovo or<strong>di</strong>namento culturale. Già Leòn e Rebecca Grinberg nel loro pionieristico, e per certi versi<br />
ancora insuperato, lavoro sulla Psicoanalisi <strong>della</strong> migrazione e dell’esilio, introdotto in Italia da<br />
Mauro Mancia in tempi non sospetti <strong>di</strong> facili mode, sottolineavano come l’emigrazione costituisca<br />
in un certo senso una vera e propria esperienza <strong>di</strong> rinascita, con il rischio che l’impossibilità <strong>di</strong> ri-<br />
affiliarsi al nuovo universo <strong>di</strong> significazione in cui si è immersi, comporti una insanabile ferita<br />
dell’involucro psichico.<br />
Strutturazione psichica e strutturazione culturale “conservano dei rapporti omologhi: una<br />
è il doppio dell’altra”, come sostiene Tobie Nathan; secondo questo autore gli immigrati soffrono<br />
elettivamente per una per<strong>di</strong>ta del doppio culturale, che rende particolarmente fragile non solo la<br />
6
struttura identitaria, l’Io più precisamente, ma soprattutto quel confine tra interno ed esterno che<br />
rappresenta un or<strong>di</strong>ne inaugurale tanto per la psiche quanto per la cultura. In particolare sottolinea<br />
come il transito migratorio possa mettere particolarmente a rischio la possibilità <strong>di</strong> sentire la<br />
propria realtà interna come qualcosa <strong>di</strong> ricco e <strong>di</strong> inviolabile, dunque <strong>di</strong> intimamente<br />
appartenente, dal momento che “l’interno non può costituirsi se non in rapporto con un esterno<br />
che possieda struttura identica”, che sia cioè il doppio <strong>di</strong> quella struttura interna, in cui quin<strong>di</strong>,<br />
aggiungerei, quella stessa struttura interna può rispecchiarsi e riconoscersi. Tutto ciò ci fa capire<br />
del resto quanto nell’esperienza migratoria possano <strong>di</strong>ventare labili, nello specifico senso <strong>di</strong><br />
essere a rischio <strong>di</strong> una rottura simbolica, proprio tutte le membrane e gli involucri corporei e<br />
psichici.<br />
Quello che i corpi <strong>di</strong>cono…<br />
Vorrei soffermarmi a questo proposito sulla specifica <strong>di</strong>fficoltà incontrata dai bambini <strong>di</strong><br />
origine africana nel riconoscere e rappresentare il colore <strong>della</strong> propria pelle. Sulle frontiere<br />
corporee si addensano, infatti, conflittuali elaborazioni <strong>di</strong> poste in gioco simboliche , affettive e<br />
relazionali che fanno dei ‘corpi’ dei veri e propri precipitati <strong>di</strong> significati, il più delle volte in<br />
larga parte inconsapevoli. Quello che il corpo esprime e veicola può essere cioè totalmente<br />
ignorato nei <strong>di</strong>scorsi e nelle rappresentazioni consapevoli <strong>di</strong> sé. Nel caso dei bambini, poi, sarà<br />
interessante notare come i loro corpi, in quanto ricettacoli <strong>di</strong> attitu<strong>di</strong>ni culturali e <strong>di</strong> cure<br />
parentali, sono anche testimoni <strong>di</strong> una valorizzazione transgenerazionale: ciò a cui un gruppo<br />
familiare, ma più in generale un gruppo sociale, dà importanza sarà inscritto più o meno<br />
profondamente nei corpi dei bambini, dei ‘<strong>di</strong>scendenti’. Insomma è come se il corpo non<br />
appartenesse loro completamente ma fosse anche locutore silenzioso <strong>di</strong> un ‘progetto’<br />
comunitario. Il corpo dunque, “il primo e il più naturale strumento dell’uomo” secondo Marcel<br />
Mauss, si trova nel transito migratorio all’incrocio tra co<strong>di</strong>ci culturali e simbolici <strong>di</strong>fferenti e<br />
potenzialmente conflittuali.<br />
“Nell’immigrazione”, scrive Abdelmalek Sayad, “l’emigrato fa un’altra esperienza del<br />
proprio corpo. Lo scopre <strong>di</strong>verso da quello degli altri(…) come ‘corpo’ socialmente ed<br />
esteticamente definito in termini <strong>di</strong> corpo estraneo”(p.271). Nel nuovo corpo sociale il corpo del<br />
migrante, ‘culturalizzato’ secondo un <strong>di</strong>verso or<strong>di</strong>ne, apparirà sia agli altri che a sè stesso<br />
paradossalmente ‘innaturale’. Da qui derivano tutta una serie <strong>di</strong> attitu<strong>di</strong>ni profondamente<br />
7
conflittuali rispetto al proprio corpo, ed il tentativo <strong>di</strong> renderlo <strong>di</strong> nuovo ‘naturale’ riadattandolo<br />
all’or<strong>di</strong>ne culturale del paese <strong>di</strong> immigrazione; basti pensare, come esempio estremo, ai tentativi<br />
talvolta drammatici <strong>di</strong> cambiare il colore <strong>della</strong> propria pelle attraverso sostanze chimiche, oppure<br />
al contrario all’angoscia <strong>di</strong> <strong>di</strong>ventare bianco, <strong>di</strong> perdere il proprio colore ‘naturale’. E’ dunque<br />
proprio nel corpo che si cristallizza il conflitto delle appartenenze.<br />
Secondo Di<strong>di</strong>er Anzieu, come noto, il sentimento <strong>di</strong> avere un Io è in<strong>di</strong>sgiungibile e,<br />
quando le cose vanno bene, in<strong>di</strong>stinguibile da quello <strong>di</strong> avere una pelle, al punto tale che lo<br />
psicoanalista francese parlerà <strong>di</strong> un Io-pelle. Tale livello dell’esperienza precoce dell’Io,<br />
contemporaneamente elementare e fondamentale nelle sue stesse modalità <strong>di</strong> formazione, si<br />
integra nel sentimento e nella imme<strong>di</strong>ata percezione <strong>di</strong> sè attraverso una complessa modalità <strong>di</strong><br />
scambio percettivo-comunicativo col corpo materno, in cui rivestono un ruolo fondamentale le<br />
stimolazioni tattili e quelle au<strong>di</strong>tive. Esso è letteralmente impregnato <strong>di</strong> aspetti culturalmente<br />
con<strong>di</strong>zionati, che si esprimono specificamente nelle modalità peculiari <strong>di</strong> prestare le prime cure ai<br />
bambini: dal modo <strong>di</strong> maneggiarli a quello <strong>di</strong> regolare il contatto corporeo tra madre e bambino,<br />
nonché nel complesso sistema <strong>della</strong> voce.<br />
Nella costituzione <strong>di</strong> questo involucro tattile –au<strong>di</strong>tivo il livello visivo entra molto poco,<br />
anzi quasi per nulla, poiché il livello del riconoscimento visivo ha molto più a che fare con la<br />
capacità <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenziazione che non con questo aspetto basilare <strong>di</strong> flui<strong>di</strong>tà, contatto e<br />
comunicazione. Col riconoscimento visivo infatti si delimitano i contorni, i confini se si vuole,<br />
<strong>della</strong> propria persona e dell’altro, inoltre i marcatori sociali <strong>della</strong> <strong>di</strong>fferenza si rendono<br />
particolarmente evidenti, anzi <strong>di</strong>rei specificamente si fissano, nella percezione visiva. A livello<br />
visivo, infatti, gli aspetti <strong>della</strong> percezione <strong>di</strong> sé stessi si fondono con quelli <strong>della</strong> rappresentazione<br />
<strong>di</strong> sé stessi. In questa costruzione <strong>della</strong> propria immagine, con cui si è letteralmente chiamati ad<br />
identificarsi, confluiscono aspetti psicologico-relazionali e simbolico-sociali, che costituiscono<br />
una inseparabile intelaiatura simbolica <strong>della</strong> propria immagine affettivamente vissuta, ovverosia<br />
del proprio Io.<br />
Nel caso dei bambini figli <strong>di</strong> genitori <strong>di</strong> origine africana, ci troviamo <strong>di</strong> fronte ad una<br />
situazione singolare, in quanto può verificarsi una frattura proprio fra i due livelli descritti, tra la<br />
pelle in quanto involucro tattile-au<strong>di</strong>tivo e la pelle in quanto rappresentazione visiva <strong>di</strong> sé,<br />
ovverosia, un po’ schematicamente, tra percezione e rappresentazione <strong>di</strong> sé, tra le quali possono<br />
8
stabilirsi faglie e piani <strong>di</strong> clivaggio conflittuali. Un buon esempio <strong>di</strong> questa specifica <strong>di</strong>fficoltà<br />
può essere rappresentato dal fatto che questi bambini possono vedersi e anche riconoscersi come<br />
‘neri’, ma non riescono a ‘rappresentarsi’ come tali, così non riescono a <strong>di</strong>segnarsi né a colorarsi.<br />
Quando le cose funzionano bene, ovverosia avvengono in un ambiente capace <strong>di</strong><br />
sostenere affettivamente e simbolicamente la costituzione identitaria, la pelle <strong>di</strong>venta un<br />
‘coerente’ perimetro sensibile ed iscrivibile socialmente, quando invece si crea , come nel nostro<br />
caso, uno squilibrio o ad<strong>di</strong>rittura un contrasto tra superficie sensibile e superficie socialmente<br />
riconoscibile, la pelle <strong>di</strong>venta uno ‘spazio’ problematico e non può più essere assunta in maniera<br />
irriflessa e imme<strong>di</strong>ata, ‘naturale’ dunque, ma <strong>di</strong>venta luogo <strong>di</strong> intensa interrogazione e<br />
rielaborazione psichica e simbolica. Questi bambini non potranno eludere la domanda, che<br />
magari resterà del tutto inconscia ed inesprimibile ma non per questo meno pressante, su che cosa<br />
significa essere nero.<br />
Winnicott sottolinea che se la madre è sufficientemente responsiva, il bambino vede sé<br />
stesso riflesso nel suo sguardo e può identificarsi con quell’immagine amata <strong>di</strong> sé che vede<br />
riflessa nello sguardo materno. E’ proprio questo, a mio avviso, uno dei livelli che permette <strong>di</strong><br />
‘naturalizzare’ il corpo sociale, dal momento che quell’immagine <strong>di</strong> sé che è l’Io ‘naturale’ è<br />
simbolicamente intessuta: la madre non può guardare il suo bambino che attraverso quelle<br />
modalità culturalmente con<strong>di</strong>zionate attraverso le quali può rappresentarselo, riecheggiando in<br />
questo la funzione delle “strutture strutturanti” secondo Pierre Bour<strong>di</strong>eu. A questo proposito<br />
Francesco Conrotto sottolinea la funzione simbolizzante dello sguardo materno, il quale fa sì che<br />
il bambino venga “significato dalla madre dentro l’or<strong>di</strong>ne simbolico che riconosce la <strong>di</strong>fferenza<br />
tra i sessi e le generazioni”(p.46). Pochè si tratta sempre <strong>di</strong> uno specifico or<strong>di</strong>ne simbolico, <strong>di</strong> un<br />
or<strong>di</strong>ne culturale, questo ci fa capire come nel momento in cui lo sguardo materno fa ‘nascere’ il<br />
suo bambino in quanto soggetto ipso facto lo rende soggetto culturale, con tutte le intuibili<br />
conseguenze che possono verificarsi nel momento in cui quello stesso ‘sguardo fondatore’ è<br />
abitato da una costante inquietu<strong>di</strong>ne ‘rappresentativa’ed ‘affettiva’. Inquietu<strong>di</strong>ne che corrisponde<br />
all’ incertezza <strong>di</strong> poter ‘affiliare’ il proprio stesso figlio al proprio lignaggio, ovverosia alla catena<br />
delle proprie appartenenze simboliche, <strong>di</strong> assegnarlo cioè al posto <strong>di</strong> proprio <strong>di</strong>scendente. I figli<br />
<strong>della</strong> migrazione sono in un certo senso tutti figli bastar<strong>di</strong>, figli senza padre, senza quel garante<br />
9
dell’or<strong>di</strong>ne simbolico 5 che consente allo stesso sguardo materno <strong>di</strong> funzionare in una compiuta<br />
<strong>di</strong>rezione ‘soggettivante’.<br />
Quando l’or<strong>di</strong>ne simbolico dei significati vacilla, come accade nell’esperienza migratoria,<br />
non si può più essere sicuri dell’ ‘ovvietà’ del mondo. Anche il proprio corpo rientra in questa<br />
per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> ovvietà, il colore <strong>della</strong> pelle sembra rendere questi bambini contemporaneamente più<br />
nu<strong>di</strong> e più opachi degli altri, insieme sovraesposti e invisibili: sovraesposti percettivamente ed<br />
invisibili socialmente. Ciò rafforza quella <strong>di</strong>vergenza tra superficie percepita e rappresentata <strong>di</strong> sé<br />
che sottolineavamo prima, pertanto i bambini si sforzeranno più o meno consapevolmente <strong>di</strong><br />
riequilibrare questi due piani, cercando <strong>di</strong> rendere impercettibile la loro <strong>di</strong>fferenza al fine <strong>di</strong><br />
rendere pienamente visibile, ed accettabile, la loro presenza: paradossalmente ciò che si vede non<br />
è ciò che si percepisce, anzi nei casi più estremi sembra che si possa essere visti solo a patto <strong>di</strong><br />
non percepire più qualcosa <strong>di</strong> sé. Il proprio corpo <strong>di</strong>venta allora un oggetto da decifrare, esso reca<br />
inscritti dei ‘segni’che il soggetto stesso può non comprendere, percepiti dal contesto <strong>di</strong> nuova<br />
socializzazione ma fino ad allora ‘ignorati’ da chi li portava: i loro corpi dunque già parlano<br />
attraverso un co<strong>di</strong>ce che come soggetti non decifrano.<br />
E questo in un duplice senso: da un lato in quello già descritto che il loro corpo reca<br />
inscritti dei ‘segni’, fino ad allora ‘ignorati’, che vengono percepiti dal contesto <strong>di</strong> nuova<br />
socializzazione, una sorta <strong>di</strong> sospetto e <strong>di</strong> sorveglianza da parte <strong>di</strong> questi bambini nei confronti<br />
del loro stesso corpo e dell’interesse che può suscitare. Dall’altro nel senso che spesso sono<br />
‘chiamati’ a testimoniare attraverso il loro stesso corpo il benessere conquistato con<br />
l’emigrazione, si tratta <strong>di</strong> una sorta <strong>di</strong> vero e proprio mandato familiare espresso nel corpo <strong>di</strong><br />
questi bambini che sembrano, del tutto inconsapevolmente, incaricarsi <strong>di</strong> curare le ferite dei loro<br />
genitori: se questi hanno sofferto la fame, ad esempio, i figli dovranno essere la prova vivente <strong>di</strong><br />
un’alimentazione abbondante, testimoniare continuamente o meglio incarnare l’abbondanza.<br />
Leòn e Rebeca Grinberg in<strong>di</strong>viduavano, infatti, come tratto caratteristico nei figli <strong>di</strong><br />
immigrati un sovrainvestimento del comportamento alimentare, me<strong>di</strong>ato dalle attitu<strong>di</strong>ni familiari:<br />
la possibilità <strong>di</strong> mangiare in abbondanza <strong>di</strong>ventava allora una prova essenziale del miglioramento<br />
delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> vita cercato e raggiunto. Esibire un corpo ben nutrito, anzi nutrito in<br />
abbondanza, rappresenta in questo senso un ribaltamento, una formazione reattiva potremmo <strong>di</strong>re<br />
5 La figura paterna e in particolare la funzione paterna in quanto specifico operatore simbolico è quella che viene più<br />
danneggiata dall’esperienza migratoria, tale destrutturazione <strong>della</strong> funzione paterna si conferma costantemente anche<br />
quando i flussi migratori presentano caratteristiche sociologiche molto <strong>di</strong>fferenziate tra <strong>di</strong> loro.<br />
10
parafrasando un lessico psicoanalitico, dell’angoscia relativa alla penuria, un’affermazione dello<br />
status raggiunto, del miglioramento delle con<strong>di</strong>zioni materiali. I due stu<strong>di</strong>osi sottolineavano ad<br />
esempio come alcune famiglie <strong>di</strong> immigrati potessero investire nella spesa alimentare risorse<br />
economiche spropositate, molto superiori anche a quelle delle famiglie autoctone, fino a<br />
costituire in alcuni casi una preoccupazione ed un assillo costanti, <strong>di</strong>ventando la principale<br />
attività quoti<strong>di</strong>ana. Attualmente tale investimento coinvolge più in generale la sovrabbondanza <strong>di</strong><br />
merci percepita come tipica del paese <strong>di</strong> immigrazione, per cui i bambini non saranno solo nutriti<br />
in abbondanza, ma anche vestiti con una cura del tutto particolare, ‘rimpinzati’ <strong>di</strong> giocattoli e <strong>di</strong><br />
‘oggetti’ rappresentativi del benessere e <strong>della</strong> partecipazione a uno stile <strong>di</strong> consumo ‘occidentale’.<br />
Proprio mentre le letture del fenomeno migratorio sembrano costantemente enfatizzare la<br />
‘carenza’, la mancanza sotto la cui impronta si svolgerebbe l’intero arco dell’esperienza<br />
migratoria, i migranti al contrario cercano <strong>di</strong> esibirne continuamente l’abbondanza. Sembra che si<br />
tratti proprio <strong>di</strong> una sorta <strong>di</strong> comportamento ‘compensativo’, in larga parte inconsapevole sul<br />
piano psicologico, che assume poi significati complessi sul piano delle relazioni sociali.<br />
I migranti, infatti, si trovano spesso incastrati in una sorta <strong>di</strong> vera e propria situazione <strong>di</strong><br />
“doppio legame” col paese ospite, parafrasando il concetto introdotto da Gregory Bateson a<br />
proposito <strong>della</strong> genesi <strong>della</strong> schizofrenia ed adattandola al nostro contesto sociale. Secondo<br />
Bateson l’in<strong>di</strong>viduo “si trova prigioniero <strong>di</strong> una situazione in cui l’altra persona [nel nostro caso<br />
l’intero contesto costituito dal paese <strong>di</strong> immigrazione, n.d.A.] che partecipa al rapporto emette<br />
allo stesso tempo dei messaggi <strong>di</strong> due or<strong>di</strong>ni, uno dei quali nega l’altro. E, infine, l’in<strong>di</strong>viduo è<br />
incapace <strong>di</strong> analizzare i messaggi che vengono emessi, al fine <strong>di</strong> migliorare la sua capacità <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>scriminare a quale or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> messaggio debba rispondere”.<br />
Potremmo formulare così questo “doppio messaggio” emesso dal contesto <strong>di</strong> adozione: se<br />
volete essere accettati dovete essere come noi, ma non potrete mai essere come noi. Esaminiamo<br />
come funzioni relativamente all’adozione <strong>di</strong> un certo stile <strong>di</strong> consumo e all’uso delle merci:<br />
certamente l’immagine dell’immigrato bisognoso <strong>di</strong> tutto, sporco, lacero e affamato induce moti<br />
<strong>di</strong> rifiuto nella quoti<strong>di</strong>anità delle relazioni sociali, per essere ammesso alle quali è necessario che<br />
prima venga pulito, rivestito e rifocillato, che assuma cioè un aspetto compatibile con alcune<br />
transazioni sociali ‘or<strong>di</strong>narie’. Se, però, ‘eccede’ nell’adozione <strong>di</strong> un certo ‘stile’<br />
comportamentale, nell’illusione che questo gli consenta un pieno accesso ad una ‘parità’ sociale<br />
con gli autoctoni, gli permetta cioè <strong>di</strong> non rimanere più ai margini dello spazio sociale, potrà<br />
ricevere una brutta sorpresa. Se alcuni comportamenti verranno letti come ‘eccessivi’, ovverosia<br />
come intenzionalmente tesi ad uscire da quello spazio marginale che è evidentemente l’unico che<br />
la società <strong>di</strong> accoglienza ritiene legittimo, i moti <strong>di</strong> rifiuto o i veri e propri atti <strong>di</strong>scriminatori<br />
potranno aumentare in un modo che all’immigrato apparirà del tutto incomprensibile. Si<br />
11
vengono così a creare equivoci ed incomprensioni che qualcuno etichetta come ‘transculturali’ ,<br />
ma che ben poco hanno a che fare con le culture intese come sistemi coerenti <strong>di</strong> significati<br />
simbolici reciprocamente irriducibili (non ci si capisce perché non si con<strong>di</strong>vide la stessa cultura) ,<br />
ma molto hanno a che fare con <strong>di</strong>namiche <strong>di</strong> contatto interculturale imme<strong>di</strong>atamente immerse in<br />
‘inconfessabili’ e minute, quoti<strong>di</strong>ane, logiche <strong>di</strong> dominio e <strong>di</strong> inferiorizzazione.<br />
In definitiva sembra proprio che con i loro stessi corpi questi bambini debbano<br />
contemporaneamente manifestare e curare profonde ferite transgenerazionali e altrettanto<br />
profonde lacerazioni nei rapporti comunitari. L’assunzione <strong>della</strong> propria corporeità, come<br />
elemento costitutivo <strong>della</strong> propria identità, è sempre il frutto <strong>di</strong> una autopercezione me<strong>di</strong>ata dallo<br />
sguardo dell’altro. Come ho già sottolineato è lo sguardo <strong>della</strong> madre quello che costituisce<br />
primariamente lo specchio in cui il bambino si guarda e ‘apprende’ la sua corporeità, e sa del suo<br />
corpo; i sentimenti che abitano questo sguardo, che può essere compiaciuto, oppure preoccupato,<br />
amoroso o <strong>di</strong>stratto, etc., vengono letteralmente incorporati e rappresentano una sorta <strong>di</strong> matrice<br />
dell’immagine <strong>di</strong> sé, mo<strong>della</strong>no in un certo senso la corporeità che verrà d’ora in poi percepita<br />
attraverso una determinata intonazione affettiva. Se questo sguardo materno costitutivo avrà<br />
allora impresso nel corpo dei figli la preoccupazione <strong>di</strong> non essere sufficientemente nutrito o <strong>di</strong><br />
non essere sufficientemente curato, questo potrà tradursi in una permanente attitu<strong>di</strong>ne a mangiare<br />
in abbondanza o a curare all’eccesso il proprio corpo, tutto ciò però al <strong>di</strong> fuori <strong>di</strong> una<br />
consapevolezza chiara, ed in una prospettiva in cui il corpo ipernutrito o ipercurato deve servire<br />
anche a curare le ferite <strong>della</strong> generazione precedente. Il corpo ipernutrito, anche in un regime <strong>di</strong><br />
abbondanza dei beni materiali in cui la preoccupazione reale per la scarsità <strong>di</strong> cibo non sussiste<br />
più, deve allora incessantemente cancellare la preoccupazione dallo sguardo materno. A<br />
quest’ultimo si sovrappone poi lo sguardo comunitario, che intesse la corporeità <strong>di</strong> significati<br />
simbolici e ‘incarica’ il corpo stesso <strong>di</strong> rappresentare l’appartenenza ad uno specifico<br />
or<strong>di</strong>namento culturale: “il corpo porta l’identità sociale, è questa stessa identità”, scrive<br />
Abdelmalek Sayad. Se però questo sguardo comunitario sarà ‘<strong>di</strong>sputato’ tra comunità d’origine e<br />
comunità <strong>di</strong> nuova socializzazione, si comprende come il corpo <strong>di</strong>venti terreno <strong>di</strong> una ‘contesa ‘<br />
simbolica , la cui posta in gioco <strong>di</strong>fficilmente potrà essere assegnata in maniera definitiva.<br />
…e quello che i nomi tacciono<br />
Come sottolinea Sayad, anche “il nome stesso, il nome che si porta, il ‘nome proprio’,<br />
nella misura in cui fa parte del corpo e in cui dà nome al corpo, non sfugge (…)alla logica propria<br />
<strong>della</strong> dominazione simbolica” (p.347)<br />
A sottolineare questa sorta <strong>di</strong> costante scambio metonimico tra co<strong>di</strong>ci inscritti nella<br />
12
corporeità e co<strong>di</strong>ci linguistici sta, infatti, la scelta e l’uso dei nomi dei bambini. Ci riferiamo qui<br />
sempre ai bambini <strong>di</strong> origine africana, nati o arrivati molto piccoli in Italia. In questo caso la<br />
partita identitaria che si gioca attorno a questi aspetti fondativi dell’essere sociale appare<br />
evidente: il nome che viene imposto ai bambini, e che sarà scelto secondo criteri che rivelano il<br />
‘progetto’ comunitario <strong>di</strong> cui sono portatori, sarà poi ciò che più intimamente sentiranno <strong>di</strong><br />
essere (il nome proprio appunto), ciò con cui sono letteralmente chiamati ad identificarsi.<br />
Innanzi tutto occorre sottolineare come questi bambini tendano ad identificarsi, e a venire<br />
identificati, col solo nome proprio, mentre il loro cognome viene usato con molta più <strong>di</strong>fficoltà<br />
nelle interazioni sociali che li riguardano, <strong>di</strong>rei ad<strong>di</strong>rittura che risulta ‘incollocabile’. Così come<br />
è concepito nel territorio, <strong>di</strong> adozione il cognome segna l’appartenenza alla <strong>di</strong>scendenza paterna,<br />
in esso cioè si concentrano gli aspetti ‘ufficiali’ dell’identità, aspetti pubblici e burocratici certo<br />
ma anche aspetti <strong>di</strong>stintivi, strettamente in<strong>di</strong>viduanti sul piano delle interazioni sociali; il<br />
cognome evita ‘confusioni’ con altri in<strong>di</strong>vidui che portano lo stesso nome proprio ad esempio. Il<br />
fatto <strong>di</strong> possedere un cognome colloca l’in<strong>di</strong>viduo in un or<strong>di</strong>ne comunitario, <strong>di</strong>sposto sia lungo<br />
l’asse verticale (la <strong>di</strong>scendenza), sia lungo quello orizzontale (la collateralità), definendolo come<br />
appartenente a quell’or<strong>di</strong>ne, simultaneamente sociale e culturale, rendendolo<br />
contemporaneamente titolare <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti e soggetto ad obblighi, è insomma il marchio <strong>della</strong> sua<br />
esistenza in quanto soggetto storico tributario <strong>di</strong> un or<strong>di</strong>ne culturale. Uno dei primi effetti che si<br />
ottiene in<strong>di</strong>cando una persona solo col proprio nome, come accade spesso anche agli immigrati<br />
adulti, è dunque quello <strong>di</strong> farli imme<strong>di</strong>atamente ‘scivolare’ verso uno stato <strong>di</strong> ‘naturalità’ , in cui<br />
il nome <strong>di</strong>venta poco più <strong>di</strong> una estensione corporea. Si ha un nome cioè come si ha un corpo, si<br />
riconosce loro tutt’al più una <strong>di</strong>mensione affettiva, come si dà un nome a un animale domestico<br />
che entra in una sfera familiare, ma non una compiuta <strong>di</strong>mensione <strong>di</strong> appartenenza ad una<br />
comunità storicamente determinata, <strong>di</strong>rei ‘umana’ tout court, è come se implicitamente li si<br />
facesse recedere ad un livello <strong>di</strong> umanità costitutivamente inferiore.<br />
E’ interessante notare come ciò avvenga anche quando non c’è un’intenzione deliberata in<br />
tal senso e come dunque la situazione sia più complessa <strong>di</strong> quanto suggerirebbe questa<br />
osservazione iniziale, nel senso che vi è una sorta <strong>di</strong> tacita collaborazione tra chi nomina e chi è<br />
nominato.<br />
La tendenza a riferirsi a questi bambini solo col loro nome è talmente forte da affermarsi<br />
anche in alcune situazioni ‘pubbliche’. Anche a scuola vengono identificati spesso solo con il<br />
loro nome, e loro stessi talvolta non conoscono il loro cognome, oppure, anche se lo conoscono<br />
formalmente, lo ‘usano’ con una evidente mancanza <strong>di</strong> familiarità, non rientra nella loro<br />
percezione-rappresentazione <strong>di</strong> se stessi. Sia per se stessi che per gli altri sono solo Marina,<br />
Walter , Patricia, Jill. Il fatto che il cognome non rimanga ‘fissato’ nemmeno nell’esperienza<br />
scolastica <strong>di</strong> questi bambini è particolarmente significativo , infatti è proprio con l’esperienza<br />
13
<strong>della</strong> scolarizzazione che i bambini tendono a includere nell’immagine <strong>di</strong> sé il proprio cognome,<br />
ad identificarsi con esso e con quel che significa, ad usarlo in maniera appropriata, trovano cioè<br />
una collocazione efficace per questo livello rappresentativo <strong>della</strong> loro identità e si collocano in<br />
essa. E’ ben noto del resto come all’ingresso in un nuovo paese sia spesso corrisposta anche<br />
l’attribuzione <strong>di</strong> un nuovo nome, affinchè risultasse più ‘assimilabile’ al nuovo contesto, e ciò sia<br />
in termini ufficiali, da parte <strong>di</strong> funzionari pubblici, che nelle transazioni quoti<strong>di</strong>ane, da parte del<br />
nuovo contesto sociale o da parte degli immigrati stessi. Una delle giustificazioni più frequenti è<br />
che i cognomi stranieri sarebbero <strong>di</strong>fficili da pronunciare e da scrivere: per il valore ‘legale’ che<br />
rivestono devono invece essere trascritti con particolare attenzione, insomma appaiono<br />
‘ingombranti’ e poco assimilabili, nel senso <strong>di</strong> non ‘<strong>di</strong>geribili’, non metabolizzabili per il tessuto<br />
<strong>di</strong> accoglienza. Nella loro mancanza <strong>di</strong> familiarità da una parte e nel loro forte valore <strong>di</strong><br />
appartenenza ad un altro contesto ‘politico’, ad un altro or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> riconoscimento in<strong>di</strong>viduale e<br />
collettivo, il cognome ‘sporge’ come un elemento <strong>di</strong> estraneità, pertanto verrà ignorato, quasi<br />
messo tra parentesi, e così facendo, anche attivamente cancellato, almeno in una parte importante<br />
dell’esperienza sociale <strong>di</strong> questi bambini. E’ evidente come invece i nomi propri siano più<br />
facilmente metabolizzabili: sono più facilmente italianizzabili (Klau<strong>di</strong>an <strong>di</strong>venta Clau<strong>di</strong>o, Patricia<br />
<strong>di</strong>venta Patrizia), quelli anglofoni (Jill, Walter) sono imme<strong>di</strong>atamente recepiti vista la familiarità<br />
me<strong>di</strong>atica con i nomi <strong>di</strong> origine inglese, ma queste spiegazioni sul piano <strong>della</strong> pratica <strong>di</strong><br />
assimilazione linguistica sono secondo me insufficienti. La percezione <strong>della</strong> intrasformabilità del<br />
cognome, che sembra insi<strong>di</strong>osamente spostarsi solo su un piano eufonico e percettivo – il tendere<br />
a <strong>di</strong>menticare, dunque a non vedere e non sentire, qualcosa che viene avvertito come ‘scomodo’ –<br />
traduce invece l’irriducibilità dell’altro in quanto persona, in quanto appartenente ad un altro<br />
or<strong>di</strong>namento sociale e culturale. La pretesa <strong>della</strong> trasformabilità totale dell’altro passa infatti<br />
attraverso una sua mo<strong>di</strong>ficazione da persona, in<strong>di</strong>viduo sociale titolare <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti e <strong>di</strong> obblighi sia<br />
sul piano sociale che simbolico, a non-persona 6 , scivolando verso quello statuto natural-affettivo<br />
citato prima.<br />
Per gli stessi bambini il loro ‘strano’ cognome risulta ingombrante e ‘incollocabile’: sui<br />
loro quaderni e sui libri, ad esempio, in<strong>di</strong>cano spesso solo il loro nome oppure commettono errori<br />
<strong>di</strong> ortografia nel trascrivere il loro cognome, esso sembra ostacolare quel processo <strong>di</strong> mimesi sul<br />
piano sociale e in<strong>di</strong>viduale in cui sono impegnati con tutte le loro forze. Sembra che li metta <strong>di</strong><br />
fronte al conflitto centrale <strong>della</strong> loro appartenenza. Il loro cognome significa il conflitto: “si è<br />
vero sei nato qui parli italiano ti senti italiano, ma sei straniero”, porti un cognome che ti fa<br />
straniero. Ecco perché sono i primi a cercare <strong>di</strong> ‘<strong>di</strong>menticarlo’, o meglio ad aderire alla<br />
scotomizzazione attivata <strong>di</strong> fatto dal contesto <strong>di</strong> adozione, in fondo un’altra forma <strong>di</strong> “violenza<br />
6 Cfr. Dal Lago A., Non-persone.L’esclusione dei migranti in una società globale, Feltrinelli, Milano, 1999.<br />
14
simbolica”, per usare l’espressione <strong>di</strong> Pierre Bour<strong>di</strong>eu 7 . Tale sottrazione identitaria può apparire<br />
allora come con<strong>di</strong>zione necessaria, come ciò che salva da un conflitto insuperabile mentre è<br />
esattamente ciò che lo istituisce come tale . Bisogna precisare come tali fenomeni, e tale conflitto,<br />
siano particolarmente rilevanti nel caso dei bambini che abbiamo in<strong>di</strong>cato come appartenenti alla<br />
seconda generazione <strong>di</strong> migranti, pur riguardando tutti i giovani ospiti del centro e più in<br />
generale anche gli immigrati adulti. Per questi ultimi infatti la capacità <strong>di</strong> mantenere integro un<br />
nucleo fondante ed originario dell’identità anche in con<strong>di</strong>zioni avverse, per così <strong>di</strong>re, è molto<br />
maggiore, ricor<strong>di</strong>amo le parole <strong>di</strong> Klau<strong>di</strong>an, un giovane immigrato adulto <strong>di</strong> prima generazione,<br />
“se vuoi chiamarmi Clau<strong>di</strong>o, va bene allora sarò Clau<strong>di</strong>o, ma lo sarò per te, dentro <strong>di</strong> me continuo<br />
ad essere Klau<strong>di</strong>an”. I termini del conflitto, per quanto esistente e lacerante, sono più chiari, più<br />
consapevoli, certo potrà rivelarsi illusoria questa pretesa <strong>di</strong> mantenere inalterata la propria<br />
identità profonda nel momento in cui tutta la propria vita reale preme affinchè sia messa in gioco,<br />
non<strong>di</strong>meno esiste la possibilità <strong>di</strong> essere i soggetti del proprio conflitto. Per i bambini <strong>di</strong> seconda<br />
generazione invece tale area conflittuale è costitutiva <strong>della</strong> loro stessa identità ‘profonda’, <strong>di</strong> ciò<br />
che più intimamente sono, è <strong>di</strong>fficile pertanto che possano esprimere, cioè letteralmente “premere<br />
fuori, mettere fuori” questo conflitto, piuttosto (come evidenziato prima) lo portano incorporato:<br />
potremmo <strong>di</strong>re che sono oggetto del loro conflitto.<br />
A conferma dei valori e delle aspettative che passano attraverso i nomi dati ai bambini,<br />
può manifestarsi su questo piano anche una sorta <strong>di</strong> implicito ‘progetto’ familiare. Come<br />
sottolinea Giorgio Cardona, infatti, “il sistema <strong>di</strong> denominazione è un co<strong>di</strong>ce culturale che opera<br />
in<strong>di</strong>pendentemente dalla funzione dei singoli nomi come etichette dei singoli(…) Oltre o più che<br />
essere un <strong>di</strong>spositivo classificatorio conoscitivo, esso è un meccanismo <strong>di</strong> controllo sociale, che<br />
regola e riequilibra le relazioni personali”. Sembra che anche al <strong>di</strong> fuori <strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong><br />
denominazione strettamente co<strong>di</strong>ficato all’interno <strong>di</strong> un or<strong>di</strong>ne sociale, i genitori immigrati<br />
cerchino, attraverso i nomi dati ai figli, <strong>di</strong> regolare e riequilibrare i rapporti col paese <strong>di</strong><br />
immigrazione. A tale esigenza risponde la frequente progressiva occidentalizzazione, e infine<br />
italianizzazione, dei nomi dati ai figli: contemporaneamente ambiguo omaggio alla nuova<br />
‘famiglia’ , al nuovo paese <strong>di</strong> cui i bambini fanno parte e tentativo <strong>di</strong> incorporare, <strong>di</strong> imprimere in<br />
loro, il potere che questi nomi possono dare. Strategia mimetica, da un lato, <strong>di</strong> ri-appropriazione,<br />
dall’altro.<br />
7 Con questa espressione Bor<strong>di</strong>eu intende in<strong>di</strong>care l’attiva partecipazione, spesso inconsapevole, del dominato alle<br />
strutture che lo dominano.<br />
15
L’identità tra psicoanalisi e antropologia<br />
Un altro degli aspetti centrali per l’attuale riflessione psicoanalitica, suscitato dal mondo<br />
delle migrazioni riguarda la trasmissione psichica attraverso le generazioni e, in maniera ancora<br />
più pervasiva, le stesse modalità psichiche e simboliche attraverso le quali si può instaurare una<br />
catena simbolico-affiliativa, una catena ‘generativa’ appunto.<br />
Il susseguirsi ‘coerente’ dell’or<strong>di</strong>ne delle generazioni costituisce una vera e propria catena<br />
simbolica, ovverosia un generatore <strong>di</strong> senso capace <strong>di</strong> ‘fondare’ l’identità stessa: essa fa sì che il<br />
singolo possa trovare la sua collocazione, il suo ‘posto’ nel mondo, in uno spazio-tempo<br />
simbolizzato, dunque ‘estratto’ dal caos e consegnato alla significazione.<br />
Si intuisce bene come in questi casi il caos lungo la catena delle generazioni e delle<br />
appartenenze simboliche, che implica anche l’or<strong>di</strong>ne <strong>della</strong> sessuazione, comporti caos psichico,<br />
e questo avviene spesso al <strong>di</strong> sotto <strong>di</strong> superficiali livelli <strong>di</strong> buona integrazione o <strong>di</strong> apparenti<br />
adozioni <strong>di</strong> costumi modernizzati o occidentalizzati 8 .<br />
La questione dell’appartenenza e dell’ ‘origine ‘ <strong>di</strong>venta dunque per i bambini migranti<br />
un’area <strong>di</strong> costante ed inesausta interrogazione.<br />
Questione cruciale dell’ identità, <strong>di</strong> ciò che si può assumere come propria identità che, se<br />
è vero che si rende particolarmente apprezzabile nei soggetti migranti, è altrettanto vero che<br />
rappresenta una questione epocale. In questa particolare epoca storica, infatti, si assiste ad un<br />
raddoppiamento <strong>della</strong> fragilizzazione delle strutture identitarie dei singoli e dei gruppi, dal<br />
momento che proprio la cosiddetta globalizzazione comporta sia nei migranti che negli autoctoni<br />
profonde alterazioni degli strumenti psichici e comunitari <strong>di</strong> ‘localizzazione’, ovverosia <strong>di</strong><br />
ra<strong>di</strong>camento e riconoscibilità ‘in’ un gruppo, in uno spazio-tempo culturalmente connotato, ossia<br />
simbolicamente inaugurato. Potremmo <strong>di</strong>re che è proprio l’instabilità del sistema simbolico a cui<br />
la madre può ‘cedere’, può ‘affiliare’ il proprio bambino a mettere costantemente a rischio i<br />
processi identificatori determinando la crescita esponenziale delle patologie identitarie, instabilità<br />
legata all’erosione del sistema <strong>di</strong> significazione costituito dalle ere<strong>di</strong>tà culturali.<br />
In questo particolare momento storico si assiste inoltre ad un riavvicinamento e quasi ad<br />
una sorta <strong>di</strong> scambio <strong>di</strong> posizioni tra psicoanalisi ed antropologia, e mi riferisco specificamente<br />
8 Basti pensare a tale proposito alla delicatissima e controversa questione delle cosiddette mutilazioni, o<br />
mo<strong>di</strong>ficazioni, genitali femminili (M G F), su cui non è possibile soffermarsi in questa sede, e al possibile ruolo che<br />
un puro e semplice <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> queste pratiche potrebbe avere rispetto al rischio <strong>di</strong> sviluppare <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ni psichici per le<br />
giovani immigrate, dal momento che il mancato rispetto <strong>di</strong> questa pratica ‘regolativa’ <strong>della</strong> <strong>di</strong>fferenza sessuale<br />
getterebbe nel caos il sistema simbolico tra<strong>di</strong>zionale delle appartenenze sociali e sessuali.<br />
16
allo stu<strong>di</strong>o delle società complesse, termine col quale si è soliti in<strong>di</strong>care le società (post)moderne<br />
occidentalizzate. Così l’antropologo André Le Bréton sottolinea come <strong>di</strong> fronte al sostanziale<br />
logoramento <strong>di</strong> alcune ‘forme’ collettive nel garantire il senso <strong>di</strong> identità in<strong>di</strong>viduale, i singoli<br />
debbano affidarsi a forme simboliche <strong>di</strong> rimessa al mondo declinate in maniere strettamente<br />
personali. La possibilità <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>are le trasformazioni delle forme simboliche sociali passa<br />
attraverso la necessità <strong>di</strong> osservare le ‘soluzioni’ in<strong>di</strong>viduali: nella declinazione più singolare pare<br />
dunque paradossalmente situarsi, e <strong>di</strong>ssolversi, il sociale nell’era <strong>della</strong> globalizzazione, che da un<br />
lato omogeneizza, dall’altro atomizza (“gli oggetti si mon<strong>di</strong>alizzano, i soggetti si tribalizzano”,<br />
secondo Régis <strong>De</strong>bray).<br />
Parallelamente <strong>di</strong>venta sempre più urgente per gli psicoanalisti interrogarsi su quali<br />
strumenti simbolici i singoli possano avere a <strong>di</strong>sposizione per costituirsi come soggetti, per<br />
‘<strong>di</strong>slocarsi’ rispetto a quegli oggetti che sembrano saturarne lo spazio percettivo e svuotarne lo<br />
spazio psichico. Se è vero che la “cultura è il luogo in cui il soggetto è condannato a vivere”<br />
(Assoun), cosa accade quando essa stessa sembra replicare all’infinito non-luoghi, con la<br />
fortunata formula <strong>di</strong> Marc Augé, piuttosto che ‘significare’ luoghi?<br />
In ambito analitico, del resto, la problematica identitaria è costitutivamente ‘contaminata’<br />
dal rapporto con l’altro. A tale proposito si ricorderanno le parole <strong>di</strong> Freud: “Nella vita psichica<br />
del singolo l’altro è regolarmente presente…e pertanto in questa accezione più ampia ma<br />
in<strong>di</strong>scutibilmente legittima, la psicologia in<strong>di</strong>viduale è al tempo stesso e fin dall’inizio, psicologia<br />
sociale”(p.261). L’identità in<strong>di</strong>viduale appare così intimamente abitata dall’altro, dalla rete delle<br />
identificazioni che ci costituiscono. Essa contiene una fondamentale interrogazione sulla propria<br />
origine: le accidentate vicissitu<strong>di</strong>ni dell’identità in<strong>di</strong>viduale sembrano letteralmente condensare<br />
un percorso attraverso il quale si possa <strong>di</strong>ventare ciò che si è, in un movimento, per così <strong>di</strong>re, <strong>di</strong><br />
soggettivizzazione <strong>della</strong> propria origine, per il quale si è letteralmente chiamati ad identificarsi<br />
col proprio corpo, col proprio nome, con la propria ascendenza. Proprio lungo questi versanti i<br />
bambini immigrati incontrano, come abbiamo visto, particolari <strong>di</strong>fficoltà<br />
Alle identità eccentriche, <strong>di</strong>asporiche, incerte e instabili, che ci propongono le scienze<br />
sociali nell’attuale epoca storica, all’anomia sociale, in un certo senso congiunturale, in<strong>di</strong>viduata<br />
come uno dei tratti <strong>di</strong>stintivi <strong>della</strong> modernità e <strong>della</strong> postmodernità già da Durkheim, la<br />
psicoanalisi risponde evidenziando un ineliminabile livello <strong>di</strong> anomia ‘strutturale’, “l’anomia<br />
17
inconscia”, come sottolinea ancora Assoun. L’anomia dell’Inconscio come svela l’eccentricità<br />
dell’Io, che non è “padrone in casa sua”, non è ‘al centro’ <strong>della</strong> persona, così rivela il vuoto che<br />
abita l’identità in<strong>di</strong>viduale: lungi dall’essere piena e ‘coerente’, appare invece abitata dall’alterità<br />
e dalla molteplicità, in certo senso vuota al suo centro come accade per la materia.<br />
La parentela più profonda tra antropologia e psicoanalisi è costituita, del resto, dal loro<br />
essere tematizzazioni <strong>di</strong>verse e complementari del tema dell’Altro. Senza riconoscimento<br />
possibile dell’alterità, ovverosia senza una istituzione psichica e culturale dell’Altro è impossibile<br />
l’istituzione del soggetto, questo “composto impregnato <strong>di</strong> alterità” con la bella immagine <strong>di</strong> Marc<br />
Augè.<br />
Da questo punto <strong>di</strong> vista la globalizzazione può essere letta come un temerario progetto <strong>di</strong><br />
annullare l’alterità: quello che si intende eliminare alle frontiere riemerge <strong>di</strong> fatto al centro delle<br />
nostre città, con un inquietante slittamento dal riconoscimento dell’alterità alla vaga percezione <strong>di</strong><br />
un doppio deformato. In questa immensa proliferazione del medesimo, che tende a fare dell’altro<br />
poco più che un’immagine deformata <strong>di</strong> sé, è forse ancora più urgente invece riconoscere, e<br />
rispettare, l’irriducibile ‘alterità’ dell’altro culturale in quanto costituisce la stessa ‘con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong><br />
possibilità’ dell’essere ‘soggetti’. In questo senso quell’attitu<strong>di</strong>ne mimetica così attivamente<br />
perseguita, come abbiamo visto, dai bambini migranti, fino a cancellarne il nome e a permearne i<br />
corpi, rappresenta in un certo senso l’esatto contrario <strong>di</strong> un autentica possibilità <strong>di</strong> declinare la<br />
propria ‘<strong>di</strong>fferenza’, che <strong>di</strong>venta tout court anche la propria in<strong>di</strong>vidualità. Il rischio più<br />
consistente è infatti quello <strong>di</strong> equivocare come ‘ottima integrazione’ quella che invece è una<br />
mimesi mutilante, in cui sparisce persino la percezione <strong>della</strong> per<strong>di</strong>ta subita.<br />
La ‘storia’ <strong>di</strong> Marina<br />
Così Marina, che ha 9 anni ed è l’ultima <strong>di</strong> tre sorelle nate in Italia da genitori <strong>di</strong> origine<br />
ghanese, sembra un manuale <strong>di</strong> perfetta integrazione, ma è <strong>di</strong>fficile non chiedersi a che prezzo. Si<br />
sente assolutamente italiana, anzi è italiana, e sottolinea che: “In Africa non voglio andarci, è<br />
pieno <strong>di</strong> insetti schifosi sai? Io o<strong>di</strong>o gli insetti. <strong>De</strong>ll’Africa forse mi piacciono solo gli animali, gli<br />
animali gran<strong>di</strong>. Mia madre è nata in Africa sai, sai dove? Ghana. Quella grande è l’Africa, poi<br />
c’è Ghana” mi <strong>di</strong>ce, come alludendo ad un’immaginaria cartina geografica con un’alzata <strong>di</strong><br />
spalle. “Ieri a scuola ho stu<strong>di</strong>ato i miti greci”, sottolinea subito dopo. “E dei miti africani non ti<br />
interessa, chie<strong>di</strong> mai alla mamma <strong>di</strong> raccontarti qualche favola o qualche storia dell’Africa?” le<br />
18
chiedo, ma subito M. risponde “no, con la scuola an<strong>di</strong>amo anche a fare le gite siamo state anche<br />
al mare al lido delfino, ci hanno detto che c’erano davvero i delfini, lo sai che in Africa li<br />
mangiano i delfini? me l’ha detto mia madre, non avevo mai sentito che si potessero mangiare i<br />
delfini, ma lì li mangiano!” L’apparente <strong>di</strong>vagazione <strong>di</strong> M. sembra dunque sempre ricondurre a<br />
quella che è la sua preoccupazione principale: sottolineare la sua <strong>di</strong>stanza da un continente oscuro<br />
e misterioso, dove tutto sembra rimandare a qualcosa <strong>di</strong> selvaggio, <strong>di</strong> ferino, <strong>di</strong> primitivo, sia nel<br />
paesaggio -i gran<strong>di</strong> animali, gli insetti- sia nei mo<strong>di</strong> d’essere degli uomini, che non sono<br />
immaginabili nella loro concretezza quoti<strong>di</strong>ana ma impegnati in qualcosa <strong>di</strong> inau<strong>di</strong>to appunto:<br />
mangiano i delfini, vivono in luoghi imprecisati che si possono solo intravedere su una cartina<br />
geografica. M. cerca <strong>di</strong> marcare la sua <strong>di</strong>stanza e <strong>di</strong> ‘dominare’ ambiguamente qualcosa da cui<br />
teme fortemente <strong>di</strong> poter essere invece dominata, ovverosia un’origine non declinabile come<br />
appartenenza.<br />
A sua volta Jane, la madre <strong>di</strong> M, sembra non manifestare alcun interesse a rafforzare il<br />
legame delle figlie col suo paese d’origine né a rendere in qualche modo effettiva una qualche<br />
forma <strong>di</strong> trasmissione culturale e <strong>di</strong> legame psichico col suo stesso passato 9 , pur illudendosi che<br />
esso resti indefinitamente recuperabile.<br />
Quel conflitto inevitabile legato alla propria appartenenza, connesso strutturalmente<br />
all’esperienza migratoria, da cui J. ha cercato con tutte le sue forze <strong>di</strong> <strong>di</strong>fendersi sembra ora<br />
annunciarsi nei rapporti con le figlie: da conflitto in<strong>di</strong>viduale <strong>di</strong>venta conflitto<br />
transgenerazionale, esso non coinvolge più solo l’in<strong>di</strong>viduo ma si perpetua lungo la <strong>di</strong>scendenza,<br />
da forma <strong>della</strong> sofferenza personale tende a <strong>di</strong>ventare tratto con<strong>di</strong>viso <strong>di</strong> una seconda generazione<br />
<strong>di</strong> migranti.<br />
Paradossalmente quello che si dà apparentemente sotto la forma del ‘conflitto’ può<br />
rivelarsi invece ad<strong>di</strong>rittura come una sorta <strong>di</strong> inconscia esecuzione <strong>di</strong> un mandato familiare che,<br />
in questo caso, consisterebbe appunto nella necessità <strong>di</strong> ‘occultare’ la propria origine, tagliare i<br />
ponti definitivamente con ‘l’Africa’: ciò che J., la madre <strong>di</strong> M., non può fare in prima persona<br />
viene <strong>di</strong> fatto ‘eseguito’ dalle figlie.<br />
Marina sembra voler mostrare all’interlocutore che non c’è proprio nulla da vedere, che<br />
la sua vita è ovvia,’normale’, quasi ‘senza storia’ verrebbe da <strong>di</strong>re: la strategia <strong>di</strong> occultamento<br />
non potrebbe essere più completa. Come ne La lettera rubata <strong>di</strong> Edgar Allan Poe, nasconde in ciò<br />
9 Anche il nome completamente italianizzato <strong>di</strong> M. rientra in questa attiva strategia <strong>di</strong> mimesi/occultamento.<br />
19
che tutti possono vedere il suo segreto: il miglior nascon<strong>di</strong>glio è proprio ciò che, offerto alla<br />
vista, sfugge allo sguardo. In fondo questo tentativo <strong>di</strong> rendersi identici ai bambini autoctoni,<br />
questa attiva strategia <strong>di</strong> mimetizzazione, conduce a rendersi completamente invisibili, in un certo<br />
senso a sparire alla propria stessa vista.<br />
Il <strong>di</strong>sagio più nascosto è allora quello che viene occultato in una mimesi così perfetta.<br />
Questo tentativo così ingannevole <strong>di</strong> rendere la propria vita del tutto ‘trasparente’, forse ci<br />
potrà far meglio intendere le raccomandazioni <strong>di</strong> segno opposto <strong>di</strong> Edouard Glissant, scrittore e<br />
antropologo creolo, <strong>di</strong> “lasciare all’altro la propria opacità”, e del grande stu<strong>di</strong>oso <strong>di</strong> migrazioni<br />
Abdelmalek Sayad <strong>di</strong> lasciare ai migranti “l’opacità delle loro storie”. Raccomandazioni che uno<br />
psicoanalista può intendere fino in fondo, dal momento che accetta ab initio la parziale<br />
inafferrabilità del proprio oggetto e dei propri pazienti, lasciandosi guidare dalle parole <strong>di</strong> T.S.<br />
Eliot:<br />
Per arrivare dove non sei devi fare la strada per la quale non sei.<br />
E dove sei è là dove non sei.<br />
20
BIBLIOGRAFIA<br />
Anzieu D. (1985), L’Io-Pelle, Borla, Roma, 1994.<br />
Appadurai A., Modernità in polvere, Meltemi, Roma 2001<br />
Assoun P.L., Freud e le sciene sociali. Psicoanalisi e teoria <strong>della</strong> cultura, Borla, Roma, 1999.<br />
Augé M., Storie del presente. Per un’antropologia dei mon<strong>di</strong> contemporanei, Il Saggiatore,<br />
Milano, 1997<br />
Augé M., Il senso degli altri, Boringhieri, Torino, 2000<br />
Bateson G. , Verso un’ecologia <strong>della</strong> mente, Milano, Adelphi. 1972<br />
Bor<strong>di</strong>eu P. (1972), Per una teoria <strong>della</strong> pratica, Cortina, Milano,2003.<br />
Cardona G. R. , Introduzione alla Sociolinguistica,Loescher, Torino. 1987<br />
Conrotto F. , Aspetti metapsicologici e clinici <strong>della</strong> regressione psicotica in L. Rinal<strong>di</strong> ( a cura<br />
<strong>di</strong>), Stati caotici <strong>della</strong> mente, Cortina, Milano, 2003<br />
<strong>De</strong>bray R., cit. in Bronzini G., L’esplosione delle etnie senza <strong>di</strong>ritto internazionale, in “Il<br />
manifesto”, 15 maggio 1999.<br />
<strong>De</strong> <strong>Micco</strong> V., Psicoanalisi e cultura: le tracce <strong>di</strong> un impensato, in Assoun P.L., op. cit, Borla<br />
Roma, 1999.<br />
<strong>De</strong> <strong>Micco</strong> V., Identità, sintomo, cultura: appunti per una clinica interculturale, in “Koinos.<br />
Gruppo e funzione analitica”, genn.-giu. 2004, anno XXV, n.1<br />
<strong>De</strong> <strong>Micco</strong> V., Corpi contesi, storie sospese. Percorsi dell’identità e <strong>della</strong> memoria in bambini<br />
immigrati: uno stu<strong>di</strong>o psicoantropologico, in “Koinos. Gruppo e funzione analitica, 2006, anno<br />
XXVII, n.1;<br />
<strong>De</strong> <strong>Micco</strong> V., Growing up on the border. Identity routes in immigrant children , in “Journal of<br />
European Psychoanalysis”, 2006, II, n.23<br />
Durkheim E., (1893), <strong>De</strong> la <strong>di</strong>vision du travail social<br />
Durkheim E., (1897), Le suicide<br />
Eliot T.S., Quattro quartetti, I ed. ital., Garzanti, Milano, 1959<br />
Freud S. (1921), Psicologia delle masse e analisi dell’Io, OSF, vol 9.<br />
21
Glissant E., Poetica del <strong>di</strong>verso, Meltemi, Roma, 1998.<br />
Grinberg L. e Grinberg R., Psicoanalisi dell’emigrazione e dell’esilio, Angeli, Milano, 1990<br />
Laplanche J., Il primato dell’altro in psicoanalisi,La biblioteca, Roma-Bari, 2000,<br />
Le Breton D., Signes d’identitè. Tatouages, piercing et autres marques corporelles, Metailié,<br />
Paris, 2002<br />
Mauss M. (1950), Le tecniche del corpo, in Teoria generale <strong>della</strong> magia e altri saggi, Einau<strong>di</strong>,<br />
Torino, 1965. Non lo trovo citato nel testo<br />
Nathan T, La follia degli altri, Ponte alle grazie, Firenze, 1990<br />
Raison J.P.,, Migrazione, in Enciclope<strong>di</strong>a, 9, 258-311, Einau<strong>di</strong>, Torino. 1978<br />
Sayad A., La doppia assenza, Cortina,Milano, 2002<br />
Signorelli A., Le molteplici singolarità <strong>di</strong> un processo <strong>di</strong> massa. Alcune riflessioni sullo stu<strong>di</strong>o<br />
antropologico delle migrazioni, in “Etnoantropologia”. N.8/9. 2000<br />
Winnicott D. (1958), Dalla pe<strong>di</strong>atria alla psicoanalisi, Martinelli, Firenze, 1975.<br />
Winnicott D. (1971), La funzione <strong>di</strong> specchio <strong>della</strong> madre e <strong>della</strong> famiglia nello sviluppo<br />
infantile, in Gioco e realtà, Armando, Roma, 1974<br />
aggiungere autori note:<br />
Lucetti<br />
Anderson<br />
Dal Lago<br />
Virginia <strong>De</strong> <strong>Micco</strong>, Membro Associato Società Psicoanalitica Italiana.<br />
Via Caduti sul lavoro 71<br />
81100 Caserta<br />
22