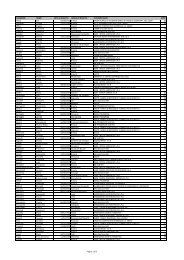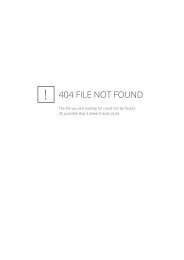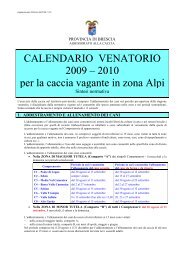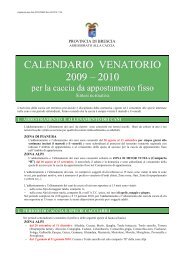N° 67 giugno 2009 - Giornale di Brescia
N° 67 giugno 2009 - Giornale di Brescia
N° 67 giugno 2009 - Giornale di Brescia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ESTRUSIONE - PRESSOCOLATA - FONDERIA - LAMINAZIONE - FINITURE - LAVORAZIONI MECCANICHE - SALDATURA - RICICLO<br />
metef-foundeq<br />
14-17 Aprile 2010<br />
Centro Fiera del Garda Montichiari <strong>Brescia</strong> Italy<br />
l’expo nr 1 nel mondo dei metalli<br />
INTERNATIONAL<br />
ALUMINIUM EXHIBITION<br />
8 th EDITION<br />
INTERNATIONAL<br />
FOUNDRY EQUIPMENT EXHIBITION<br />
5 th EDITION<br />
Due eventi un grande<br />
appuntamento internazionale<br />
in costante sviluppo:<br />
una occasione unica<br />
per incontrarsi e fare business.<br />
Segreteria Organizzativa: EDIMET SPA,<br />
via <strong>Brescia</strong> 117 25018 Montichiari (BS) Italy<br />
Ph. +39 030 9981045 Fax +39 030 9981055<br />
info@metef.com<br />
Patrocinatori:<br />
AIB - AIFM - AIM - AITAL - AMAFOND - ASSOFOND<br />
ASSOMET - CCIAA BS - CEMAFON - CIAL - EAA - ESTAL<br />
FACE - FEDERFINITURA - IIS - OEA - QUALITAL - UNCSAAL<br />
www.metef.com<br />
adnord.it
BRESCIA<br />
ICERCHE<br />
R<br />
Rivista trimestrale e<strong>di</strong>ta a cura<br />
del consorzio Inn.Tec. Srl<br />
con sede in <strong>Brescia</strong>, Piazza Paolo VI, 16<br />
p.iva e c.f. 030<strong>67</strong>310171<br />
Direzione amministrativa e redazione<br />
via Branze, 45 - <strong>Brescia</strong><br />
www.inntec.it<br />
e-mail info@inntec.it<br />
Direttore responsabile<br />
Romano Miglietti<br />
Direttore e<strong>di</strong>toriale<br />
Romano Miglietti<br />
Comitato <strong>di</strong> redazione<br />
Alberto Albertini<br />
Max Bontempi<br />
Angelo Borgese<br />
Maurizio Covri<br />
Alessandro Marini<br />
Silvio Zucchi<br />
Coor<strong>di</strong>namento redazione<br />
Federica Zaccaria<br />
Stampa<br />
Arti Grafiche Apollonio<br />
<strong>Brescia</strong><br />
Prezzi Italia<br />
fascicolo Euro 4,00<br />
abbonamento annuo Euro 12,00<br />
Prezzi Estero<br />
fascicolo Euro 6,00<br />
abbonamento annuo Euro 18,00<br />
spe<strong>di</strong>zione in abbonamento postale,<br />
70% filiale <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong><br />
SOMMARIO<br />
4<br />
5<br />
7<br />
11<br />
14<br />
18<br />
21<br />
24<br />
26<br />
32<br />
35<br />
39<br />
44<br />
48<br />
Momenti Inn.Tec.<br />
Romano Miglietti<br />
E<strong>di</strong>toriale<br />
Alberto Albertini<br />
Borgy Corner<br />
Angelo Borgese<br />
<strong>Brescia</strong>-Milano: 52 minuti<br />
Alessandro Marini<br />
ASM, strumento <strong>di</strong> sviluppo<br />
Silvano Danesi<br />
• Gli anni del teleriscaldamento:<br />
intuito e innovazione<br />
a servizio del territorio<br />
• Renzo Capra,<br />
una vita per l’energia<br />
Federica Zaccaria<br />
Oltre l’Entropia:<br />
quando l’energia <strong>di</strong>venta forma<br />
Stefano Rabolli Pansera<br />
Recupero energetico e biogas:<br />
Progeco, ovvero il valore<br />
della filiera per l’efficienza<br />
delle rinnovabili<br />
Fabio Pelizzari<br />
Au<strong>di</strong>t energetico: il primo passo<br />
verso l’efficienza energetica<br />
Vittorio Bellicini, Simone Zanoni,<br />
Lucio Zavanella<br />
La terza generazione<br />
del fotovoltaico<br />
Angelo Borgese<br />
La pollina: da costo aziendale<br />
a risorsa economica<br />
Maria Chiesa e Giovanna Gagliotti<br />
Idrogeno, “fuel cell”<br />
e utilizzi in ambito automotive<br />
Lorenzo Sbaraini<br />
Fonti rinnovabili:<br />
incentivi al futuro<br />
Marco Tabla<strong>di</strong>ni<br />
ASAP SMF: il prodotto<br />
come servizio “vitamina”<br />
delle nuove sfide competitive<br />
Associati sostenitori<br />
<strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> Ricerche<br />
bieffe<br />
MERAS<br />
VALENTI<br />
Soci sostenitori
4 <strong>Brescia</strong> ricerche <strong>67</strong>/09<br />
BRESCIA<br />
ICERCHE<br />
R<br />
Gentile lettore,<br />
Momenti Inn.Tec.<br />
prosegue in questo numero la pubblicazione <strong>di</strong> contributi che hanno nel tema<br />
‘Energia’ l’elemento <strong>di</strong> comune interesse, sia pur con angolazioni e approcci molto<br />
<strong>di</strong>versi.<br />
E’ superfluo sottolineare la valenza strategica <strong>di</strong> questa tematica e degli impatti<br />
che sempre più prepotentemente continua ad avere sulla nostra vita. Impatti che<br />
potrebbero costituire lo spunto per dare corpo alle iniziative <strong>di</strong> <strong>di</strong>vulgazione e <strong>di</strong>ffusione<br />
dell’innovazione e della ricerca sul territorio che oggi rappresentano la<br />
mission del Consorzio INN.TEC., in linea con gli obiettivi della sua compagine sociale<br />
formata da più <strong>di</strong> 130 imprese che rappresentano la Comunità bresciana degli<br />
Innovatori.<br />
La strutturazione <strong>di</strong> queste iniziative <strong>di</strong> promozione dell’innovazione - che vedono<br />
poi nel CSMT il soggetto deputato a coagulare anche gli interessi degli attori istituzionali<br />
sensibili allo sviluppo tecnologico della nostra provincia - è certamente<br />
un’operazione impegnativa, perché richiede un investimento in termini <strong>di</strong> sostegno<br />
e in termini <strong>di</strong> apporto <strong>di</strong> idee; ma è l’unica che attribuisce valore e senso <strong>di</strong><br />
appartenenza ai nostri Consorziati.<br />
Su questo filone <strong>di</strong> maggior sensibilizzazione relativamente a tematiche che potranno<br />
offrire opportunità competitive per le nostre imprese, si articola lo sviluppo<br />
futuro delle attività <strong>di</strong> INN.TEC., assegnando a <strong>Brescia</strong> Ricerche l’importante<br />
ruolo <strong>di</strong> strumento <strong>di</strong> <strong>di</strong>vulgazione tecnico-scientifica dell’innovazione.<br />
Romano Miglietti
EDITORIALE 5<br />
E<strong>di</strong>toriale<br />
<strong>di</strong> Alberto Albertini<br />
Leggo i titoli dell’agenda <strong>di</strong> un convegno in America: “Environment,<br />
Safety, Energy, Cost Saving”, cioè “Ambiente, Sicurezza,<br />
Energia, Riduzione dei costi”. Poi però basta visitare le loro<br />
aziende manifatturiere e si scopre una notevole incuria, i macchinari<br />
sono obsoleti e inadeguati. Le conseguenze <strong>di</strong> questo anomalo<br />
“State of the industry” (altro titolo ricorrente per capire l’effettivo<br />
stato <strong>di</strong> crisi più che del settore), sono gli sprechi economici ed<br />
energetici, nonché il pericolo per gli operatori.<br />
“Energia” è una parola magica che ricorre sulla bocca <strong>di</strong> tutti: pare ad<strong>di</strong>rittura<br />
terapeutica quando si crede che basti nominarla per risolvere<br />
tutti i problemi. Rimbalza ovunque, in<strong>di</strong>fferentemente dalla<br />
geografia e dal settore, in<strong>di</strong>pendentemente dal fatto che sia seguita<br />
da misure concrete. In Italia è spesso declinata in inglese per renderla<br />
più incisiva. Non vorrei sostituirmi all’impertinente, ma spero<br />
non si verifichi anche da noi la stessa situazione contrad<strong>di</strong>ttoria<br />
americana: molta conversazione, ma minima azione. Mi ha stupito<br />
leggere che in Italia c’è stata un’accelerazione improvvisa nell’impiego<br />
delle energie alternative. Ad esempio nel fotovoltaico siamo<br />
secon<strong>di</strong> solo alla Spagna. Come al solito ci adeguiamo per ultimi alle<br />
norme europee, siamo restii ad accogliere una nuova regola o una<br />
tecnologia innovativa, ma poi per fortuna acceleriamo come nessun<br />
altro sa fare, recuperando in breve tempo le <strong>di</strong>fferenze e i ritar<strong>di</strong>. Lo<br />
facciamo spesso senza un aiuto governativo, senza un vero incentivo,<br />
appesantiti dalla burocrazia. Quando mi trovo in Germania - forse<br />
la nazione con il maggiore sviluppo nelle tecnologie collegate alla<br />
produzione o al risparmio <strong>di</strong> energia - mi rendo conto della nostra<br />
reale arretratezza. Ma non parlo solo <strong>di</strong> tecnologia. Parlo anche <strong>di</strong><br />
come quel Paese ha saputo mutare le abitu<strong>di</strong>ni, i meto<strong>di</strong> costruttivi,<br />
l’organizzazione generale, affinché tutto e tutti si muovano e lavorino<br />
con un medesimo obiettivo. Serve dunque anche un cambio culturale,<br />
soprattutto nel nostro Paese dove la parola energia per ora è<br />
molto impiegata negli spot delle tariffe, o come sinonimo <strong>di</strong> vitalità,<br />
il sintomo <strong>di</strong> una giovinezza eterna che inseguono tutti a qualsiasi<br />
età. Si parla ancora poco <strong>di</strong> attenzione alla natura, <strong>di</strong> tutela del territorio.<br />
Non c’è un’analisi complessiva, una strategia più ampia, un<br />
“padre <strong>di</strong> famiglia” che risolva i contrasti e stabilisca alcune regole,<br />
anche se non potranno sod<strong>di</strong>sfare tutti. Prevale l’euforia e il delirio<br />
del fare, del produrre e del costruire. “Stiamo costruendo il futuro” è<br />
il motto contemporaneo più <strong>di</strong>ffuso. Sì, ma quale? Non a caso la parola<br />
“cultura” viene dal verbo latino “colere”, coltivare. Nel film Matrix<br />
gli umani sono fonte <strong>di</strong> energia elettrica per le macchine, ogni corpo<br />
è una piccola pila mantenuta in vita artificialmente per dare energia<br />
alle macchine che hanno preso il controllo <strong>di</strong> un mondo apocalittico,<br />
perennemente oscurato e inquinato. Oggi la Terra è Terra <strong>di</strong> nessuno,<br />
➙
6 <strong>Brescia</strong> ricerche <strong>67</strong>/09<br />
Ho letto che energia è sinonimo <strong>di</strong> libertà e che la liberalizzazione dell'energia mi avrebbe<br />
concesso una maggiore libertà <strong>di</strong> scelta, ma non sono riuscito a scegliere liberamente un<br />
nuovo fornitore che mi mettesse in con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> risparmiare sul costo dell'energia;<br />
l'economia del Paese è ancora poco competitiva, perché il costo dell'energia è<br />
quattro/cinque volte superiore a quello <strong>di</strong> altre nazioni europee ed anche <strong>di</strong>eci/venti volte<br />
più alto <strong>di</strong> quello <strong>di</strong> altri "competitor", ma il Governo ha detto che sta provvedendo e, con<br />
l'avvento del nucleare, dal 2014 potremo cominciare a risparmiare.<br />
Nel frattempo, visto che il prezzo <strong>di</strong> un barile <strong>di</strong> petrolio è meno della metà <strong>di</strong> quanto<br />
fosse l'anno scorso, portiamo pazienza e teniamo duro; siamo davvero fortunati a vivere<br />
in Italia ed i nostri partner in questo settore ci daranno sicuramente una mano.<br />
L' Enel ci <strong>di</strong>ce che sostiene i campionati mon<strong>di</strong>ali <strong>di</strong> nuoto ed il concerto allo Sta<strong>di</strong>o Olimpico<br />
<strong>di</strong> Tiziano Ferro ed ho saputo che riesce finalmente a ricavare energia elettrica<br />
dall'idrogeno; d'altro canto l'Eni, che non è da meno in tema <strong>di</strong> sponsorizzazioni <strong>di</strong> gran<strong>di</strong><br />
eventi come la mostra <strong>di</strong> Tiziano e del Tintoretto a Venezia, ci fa sapere che il suo<br />
amministratore sta firmando importanti accor<strong>di</strong> che permettono al nostro sistema Paese <strong>di</strong><br />
avere scorte <strong>di</strong> gas e metano per molti anni. E<strong>di</strong>son, intanto, prepara una tessera<br />
personalizzata con la quale possiamo comperare gasolio, energia elettrica, metano e tante<br />
altre belle cose con uno sconto del 20% e prezzi bloccati per i prossimi ventiquattro mesi.<br />
Quasi quasi penso che essere amico <strong>di</strong> queste gran<strong>di</strong> aziende ci farà risparmiare anche<br />
sui costi del pieno <strong>di</strong> benzina e sulla ricarica del telefonino; poi mi accorgo che, sebbene il<br />
momento economico non sia tra i più rosei, le performance in borsa <strong>di</strong> Enel, Eni ed E<strong>di</strong>son<br />
hanno degli aumenti che vanno dal +8,44% nell'ultimo mese al +65,89% dell'ultimo<br />
semestre. Nel frattempo, la nostre bollette sono un onere sempre più insostenibile….<br />
Che faccio? Glielo <strong>di</strong>co ad Enel, Eni ed E<strong>di</strong>son che non mi sento né libero né tutelato?<br />
L’Impertinente<br />
è la grande pila dalla quale succhiare energia senza sosta, incuranti<br />
degli effetti nel breve e soprattutto nel lungo termine. Consiglio una<br />
lettura terapeutica a tutti gli operatori del settore energia: “Giar<strong>di</strong>ni”<br />
<strong>di</strong> Robert Pogue Harrison (Fazi E<strong>di</strong>tore). Una lezione filosofica<br />
perché “nessuna rivoluzione potrà accelerare i tempi della germinazione<br />
o far fiorire il lillà prima <strong>di</strong> maggio”: alla fine il giar<strong>di</strong>niere è<br />
un saggio che dà più <strong>di</strong> quanto prenda (la medesima lezione dovrebbe<br />
valere in amicizia, nel matrimonio, nell’educazione…), che si sottomette<br />
alle leggi della natura, come raccomandavano gli antichi<br />
Greci abitanti del Cosmo. Non pecca <strong>di</strong> hybris, non <strong>di</strong>strugge il giar<strong>di</strong>no<br />
terreno e mortale che abita, perché così facendo <strong>di</strong>struggerebbe<br />
anche se stesso.
BORGY CORNER 7<br />
Borgy Corner<br />
<strong>di</strong> Angelo Borgese<br />
Micro e nanoclusters<br />
29 novembre 1991 la prestigiosa rivista scientifica internazionale<br />
“Science” titolava un suo importante fascicolo: “Engineering a small<br />
“Il<br />
world”, riferendosi al settore delle nanoscienze e delle nanotecnologie.<br />
Molto prima, nel 1959, il grande fisico e Premio Nobel Richard Feynmann, riferendosi<br />
alle potenzialità della materia a <strong>di</strong>mensioni nanometriche, affermava:<br />
“There is plenty of room at the bottom”, che tradotto in modo non letterale<br />
vuol <strong>di</strong>re: “C’è un sacco <strong>di</strong> spazio là sotto”.<br />
Con questa frase Feymann intendeva affermare, “mettere l’accento sulle<br />
enormi potenzialità associate all’evoluzione verso sistemi e <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni<br />
sempre più piccole”.<br />
In quegli anni si era solo agli inizi degli stu<strong>di</strong> e delle applicazioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>spositivi<br />
con <strong>di</strong>mensioni dell’or<strong>di</strong>ne del “micron” ( 10-6 m) , nasceva la “microelettronica”,<br />
mentre ora è in atto il “salto” successivo <strong>di</strong> ricerca e <strong>di</strong> applicazioni verso<br />
il “nanometro” ( 10-9 m).<br />
Oggi i termini “micro e nanoclusters” sono generalmente utilizzati per descrivere<br />
aggregati <strong>di</strong> atomi che sono considerati troppo gran<strong>di</strong> per essere<br />
definiti delle “molecole”, ma troppo piccoli per essere assimilati a porzioni<br />
<strong>di</strong> cristalli; infatti, questi aggregati (“clusters”) non hanno la struttura tipica<br />
della materia allo stato massivo (“bulk”), con <strong>di</strong>mensioni cioè dalla<br />
decina <strong>di</strong> micron in su.<br />
In effetti, si cominciò ad occuparsi <strong>di</strong> particelle con <strong>di</strong>mensioni dell’or<strong>di</strong>ne delle<br />
decine <strong>di</strong> nanometri piuttosto presto, attorno al 1860, periodo in cui nasceva<br />
la chimica dei colloi<strong>di</strong>; tuttavia, come abbiamo detto, solo recentemente è<br />
stato possibile compiere stu<strong>di</strong> e ricerche su sistemi <strong>di</strong> tali <strong>di</strong>mensioni.<br />
Il risultato <strong>di</strong> ciò è stata la scoperta <strong>di</strong> proprietà particolari che non sono riscontrabili<br />
né in aggregati molecolari né in strutture ben più estese come<br />
quelle in bulk.<br />
Proprio per questo tali aggregati si sono imposti all’attenzione <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse<br />
<strong>di</strong>scipline quali la fisica, l’ingegneria, la chimica, la biologia e altre ancora.<br />
Parte della motivazione che conduce a stu<strong>di</strong>are il “cluster” è l’esigenza <strong>di</strong><br />
comprendere come le proprietà fisiche evolvono passando da un atomo ad<br />
una molecola ad un cluster ed, infine, alla materia allo stato massivo.<br />
Oggi si possono evidenziare due tipi <strong>di</strong> effetti legati alle <strong>di</strong>mensioni <strong>di</strong> questi<br />
aggregati: effetti intrinseci, <strong>di</strong>pendenti da specifici cambiamenti delle<br />
proprietà legate alla <strong>di</strong>mensione dell’aggregato e alla sua geometria ed effetti<br />
estrinseci, che riguardano le proprietà <strong>di</strong> superficie dovute al non più<br />
trascurabile rapporto superficie/volume.<br />
sintesi e caratterizzazione <strong>di</strong> cluster e nanostrutture con processi<br />
assistiti da plasma<br />
La sintesi <strong>di</strong> materiali e <strong>di</strong>spositivi basati su strutture nanometriche rappresenta<br />
un obiettivo strategico <strong>di</strong> primario interesse per la scienza e la tecnologia<br />
dei materiali. Se da un lato la realizzazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>spositivi <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni<br />
nanoscopiche costituisce la naturale e necessaria evoluzione nel campo<br />
della microelettronica, della sensoristica e della registrazione magnetica,<br />
dall’altro la creazione <strong>di</strong> nuovi materiali a partire da precursori su scala<br />
➙
8 <strong>Brescia</strong> ricerche <strong>67</strong>/09<br />
nanometrica sta aprendo nuove prospettive per applicazioni industriali,<br />
biome<strong>di</strong>che ed ambientali.<br />
Di particolare interesse per la microelettronica, l’ottica e la micromeccanica è<br />
quella classe <strong>di</strong> oggetti denominata cluster, costituita da aggregati atomici<br />
con un numero <strong>di</strong> componenti che va da qualche decina <strong>di</strong> atomi fino a qualche<br />
migliaio. Oggetti <strong>di</strong> queste <strong>di</strong>mensioni presentano proprietà fisico-chimiche<br />
del tutto peculiari dovute alla coesistenza <strong>di</strong> effetti classici e quantistici.<br />
Un elenco delle applicazioni e degli sviluppi insiti nei nanomateriali richiederebbe<br />
uno spazio molto ampio; in questa sede ci limiteremo ad elencare alcuni<br />
degli esempi più significativi.<br />
Proprietà elettroniche<br />
Gli effetti <strong>di</strong> confinamento degli elettroni <strong>di</strong> valenza conferiscono ai nano aggregati<br />
inusuali caratteristiche ottiche lineari e non lineari che li rendono<br />
can<strong>di</strong>dati ideali per lo sviluppo <strong>di</strong> componenti opto elettronici, emettitori <strong>di</strong><br />
luce, materiali fotosensibili non-lineari, interruttori ottici, fibre ottiche.<br />
Proprietà magnetiche<br />
Sistemi metallici con granulometria iperfine esibiscono una elevatissima magnetoresistenza;<br />
ciò li rende interessanti per l’industria della registrazione<br />
magnetica.<br />
Catalisi<br />
Nano particelle <strong>di</strong> semiconduttori, metalli ed ossi<strong>di</strong> possono essere utilizzati<br />
per la realizzazione <strong>di</strong> catalizzatori, ceramiche e materiali compositi.<br />
Nano aggregati <strong>di</strong> carbonio<br />
Vastissimo interesse hanno suscitato i cluster <strong>di</strong> carbonio basati su strutture<br />
chiuse tri<strong>di</strong>mensionali in<strong>di</strong>cati come fullereni (il capostipite <strong>di</strong> questa classe<br />
<strong>di</strong> aggregati è l’ormai famoso C60). Essi costituiscono una forma allotropica<br />
del carbonio <strong>di</strong>versa da grafite e <strong>di</strong>amante con proprietà elettroniche e strutturali<br />
che li rendono particolarmente interessanti per una vastissima gamma<br />
<strong>di</strong> applicazioni. I fullereni sono i prototipi <strong>di</strong> una classe <strong>di</strong> nano strutture basate<br />
su singoli fogli grafitici dette “nano tubi” o “tubuleni”. Tali strutture sono<br />
l’equivalente su scala nanoscopica delle fibre <strong>di</strong> carbonio. Tra le applicazioni<br />
citeremo solo l’uso dei fullereni per la fabbricazione <strong>di</strong> batterie a stato solido<br />
e superconduttori ad alta temperatura, e dei nano tubi come elementi per la<br />
realizzazione <strong>di</strong> conduttori uni <strong>di</strong>mensionali, punte per microscopi a effetto<br />
tunnel, nano antenne.<br />
Un altro elemento <strong>di</strong> interesse è l’uso dei fullereni come precursori <strong>di</strong> nuovi<br />
materiali a base <strong>di</strong> carbonio e <strong>di</strong> film “<strong>di</strong>amond-like”. Recentemente è stato<br />
inoltre <strong>di</strong>mostrato come fullereni possano essere usati per la carburizzazione<br />
<strong>di</strong> nano strutture e la creazione <strong>di</strong> micro componenti <strong>di</strong> Carburo <strong>di</strong> Silicio<br />
(SiC) integrati su chip preesistenti.<br />
Le tematiche <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong>pendono dal fatto che i meccanismi responsabili<br />
della formazione <strong>di</strong> nano aggregati sono tuttora poco compresi. Ciò rappresenta<br />
una severa limitazione allo sviluppo <strong>di</strong> tecnologie e materiali basati su<br />
tali sistemi. La maggior parte delle tecniche usate per la produzione <strong>di</strong> cluster<br />
fa ricorso alla produzione <strong>di</strong> un plasma dai materiali <strong>di</strong> cui si vogliono produrre<br />
gli aggregati; la termalizzazione e la condensazione delle particelle viene<br />
poi indotta con <strong>di</strong>versi sistemi (espansione a<strong>di</strong>abatica, mescolamento con<br />
un gas <strong>di</strong> buffer, etc.). Diventa quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> primaria importanza essere in grado<br />
<strong>di</strong> controllare le con<strong>di</strong>zioni del plasma <strong>di</strong> partenza, caratterizzarne le con<strong>di</strong>-<br />
➙
BORGY CORNER 9<br />
zioni e mettere in relazione tali con<strong>di</strong>zioni con i prodotti finali. Le tecniche<br />
più utilizzate per la produzione <strong>di</strong> plasmi precursori <strong>di</strong> cluster sono la vaporizzazione<br />
laser, in cui il materiale <strong>di</strong> interesse viene irraggiato con impulsi<br />
laser <strong>di</strong> alta potenza, o la creazione <strong>di</strong> un arco tra due elettro<strong>di</strong> del materiale<br />
<strong>di</strong> cui si vogliono produrre gli aggregati. Nelle moderne tecnologie <strong>di</strong> fabbricazione<br />
<strong>di</strong> film inorganici sottili e nano strutture, l’attivazione delle molecole,<br />
oltre che per via termica, può anche essere effettuata me<strong>di</strong>ante plasmi debolmente<br />
ionizzati; tale proce<strong>di</strong>mento prende il nome <strong>di</strong> deposizione chimica in<br />
fase <strong>di</strong> vapore assistita dal plasma (PACVD). Usualmente la scarica viene<br />
prodotta utilizzando linee <strong>di</strong> trasmissione a ra<strong>di</strong>ofrequenza o microonde terminate<br />
con opportuni sistemi <strong>di</strong> antenne. La PACVD costituisce una metodologia<br />
per la produzione <strong>di</strong> un elevato numero <strong>di</strong> materiali, quali il nitruro e<br />
l’ossido <strong>di</strong> silicio, che vengono usati come indurenti o isolanti. Tali materiali<br />
possono essere prodotti sia come film sottili che come aggregati.<br />
Materiali a base <strong>di</strong> carbonio <strong>di</strong> grande interesse industriale possono essere<br />
sintetizzati a partire da un plasma <strong>di</strong> tipo “glow <strong>di</strong>charge” attraverso la frammentazione<br />
<strong>di</strong> idrocarburi a basso peso molecolare come il metano e l’acetilene.<br />
Anche la produzione <strong>di</strong> <strong>di</strong>meri C2 dalla frammentazione <strong>di</strong> C50 con la<br />
formazione <strong>di</strong> film <strong>di</strong> <strong>di</strong>amanti può essere condotta e controllata in un plasma<br />
<strong>di</strong> Ar/H2/C60.<br />
Processi metallurgici<br />
Nel campo dei materiali metallici sono stati prodotti materiali finalizzati ad usi<br />
precisi e specifici che per le loro caratteristiche (ad es. <strong>di</strong> resistenza meccanica<br />
ad elevata temperatura, <strong>di</strong> resistenza alla corrosione, del loro comportamento<br />
funzionale in determinati campi<br />
ben definiti) hanno raggiunto<br />
prestazioni <strong>di</strong> tutto rispetto. Peraltro,<br />
molto spesso si verifica il<br />
fatto che ad un alto valore tecnologico<br />
del bulk dei materiali<br />
non corrisponda un analogo favorevole<br />
comportamento rispetto<br />
all’interfaccia con l’esterno,<br />
come ad esempio:<br />
• la resistenza meccanica dei<br />
materiali per applicazioni ad<br />
elevata temperatura non può<br />
essere sfruttata appieno a mo-<br />
tivo della scarsa compatibilità<br />
con le con<strong>di</strong>zioni esterne;<br />
Nanocluster <strong>di</strong> oro<br />
• alcune applicazioni biome<strong>di</strong>che non possono essere fatte in quanto il contenuto<br />
<strong>di</strong> certi elementi presenti nei materiali non è tollerabile per particolari<br />
tipi <strong>di</strong> protesi;<br />
• la resistenza meccanica <strong>di</strong> molti materiali, necessaria per applicazioni in<br />
ambiente fortemente aggressivo, non permette il loro impiego a causa del<br />
comportamento chimico nei confronti dell’ambiente circostante.<br />
Anche in questo caso va evidenziato il nuovissimo campo delle nanoparticelle<br />
e delle nanofasi prodotte con tecnologia al plasma; materiali prodotti da queste<br />
basi avrebbero uno sviluppo incre<strong>di</strong>bile se fosse possibile una loro produzione<br />
economicamente valida. Di seguito alcuni esempi esplicativi.<br />
- Realizzazione <strong>di</strong> “coating” antiusura<br />
Le possibili applicazioni spaziano dai componenti meccanici alle protesi biome<strong>di</strong>cali.<br />
➙
10 <strong>Brescia</strong> ricerche <strong>67</strong>/09<br />
La deposizione <strong>di</strong> strati ad elevata durezza, e in alcuni casi con basso attrito, è<br />
ideale per particolari applicazioni in cui l’usura <strong>di</strong> parti meccaniche è critica.<br />
- Realizzazione <strong>di</strong> coating compatibili con l’ambiente esterno<br />
Deposizioni <strong>di</strong> materiali refrattari su metalli possono far crescere la vita dei<br />
componenti metallici a valori impensabili per i componenti in se stessi. Alcuni<br />
tipi <strong>di</strong> rivestimenti conferiscono al materiale la proprietà <strong>di</strong> renderlo compatibile<br />
con determinati ambienti. A titolo <strong>di</strong> esempio: certe protesi in leghe<br />
NiTi a memoria <strong>di</strong> forma non possono essere applicate in quanto il contenuto<br />
<strong>di</strong> nichel viene giu<strong>di</strong>cato pericoloso per la salute; un rivestimento opportunamente<br />
stu<strong>di</strong>ato potrebbe ovviare a tale inconveniente.<br />
- Realizzazione <strong>di</strong> componenti meccanici<br />
Il plasma può essere impiegato per la produzione <strong>di</strong> nanoparticelle de<strong>di</strong>cate<br />
alla produzione industriale <strong>di</strong> strutture meccaniche me<strong>di</strong>ante il semplice processo<br />
<strong>di</strong> formatura <strong>di</strong> polveri nanometriche senza dover ricorrere al doppio<br />
processo <strong>di</strong> sinterizzazione e coniatura. Anche nel caso <strong>di</strong> materiali ceramici<br />
o refrattari la loro sintesi, condotta in plasmi termici, è una tecnologia emergente<br />
per la produzione <strong>di</strong> polveri ultra fini e ultra pure per i processi <strong>di</strong> sinterizzazione<br />
in assenza <strong>di</strong> pressione. In particolare, le tecniche <strong>di</strong> produzione<br />
<strong>di</strong> polveri fini e <strong>di</strong> sinterizzazione senza pressione <strong>di</strong> ceramiche iperpure potranno<br />
generare rilevanti progressi nella produzione dei nuovi materiali superconduttori<br />
ad alta temperatura.<br />
Le necessità più urgenti risiedono nello sviluppo, nell’analisi, negli apparati<br />
<strong>di</strong>agnostici e nella progettazione <strong>di</strong> un semplice reattore adatto per la sintesi<br />
<strong>di</strong> polveri fini refrattarie <strong>di</strong> carburi, nitruri e ossi<strong>di</strong> metallici. La novità dei<br />
meto<strong>di</strong>, in parecchi casi, non ha ancora permesso <strong>di</strong> conoscere i limiti <strong>di</strong> tali<br />
tecnologie, ma si può affermare che ci si aspetta una nuova classe <strong>di</strong> materiali<br />
con caratteristiche eccezionali, impossibili da produrre attualmente.<br />
Materiali organici<br />
Il plasma offre anche nuove opportunità per la sintesi <strong>di</strong> materiali impossibili<br />
da produrre in reattori chimici convenzionali e che possono, invece, essere<br />
sintetizzati in un unico passaggio e deposti già nella forma <strong>di</strong> utilizzo finale,<br />
eliminando in tal modo <strong>di</strong>versi passaggi successivi <strong>di</strong> trattamento.<br />
Un esempio <strong>di</strong> quanto esposto è rappresentato dalla polimerizzazione in ambiente<br />
<strong>di</strong> plasma. Infatti, in particolari con<strong>di</strong>zioni, molecole monomeriche introdotte<br />
in un plasma possono polimerizzare con la produzione <strong>di</strong> polimeri<br />
che hanno caratteristiche non producibili nei convenzionali processi <strong>di</strong> polimerizzazione.<br />
Tale tipo <strong>di</strong> polimerizzazione può produrre sostanze in forma <strong>di</strong><br />
film sottili molto utili in applicazioni quali il coating <strong>di</strong> altri materiali, la costruzione<br />
<strong>di</strong> multistrati per i nastri da registrazione, etc. Nell’area biome<strong>di</strong>ca<br />
tale tecnica permetterà un ulteriore progresso nella ricopertura, con polimeri<br />
biocompatibili, <strong>di</strong> protesi, <strong>di</strong> parti impiantabili, <strong>di</strong> <strong>di</strong>agnostiche me<strong>di</strong>cali.<br />
Le <strong>di</strong>agnostiche per tali tipi <strong>di</strong> plasma consistono nella spettroscopia <strong>di</strong> emissione,<br />
nell’anemometria laser-Doppler, nella spettroscopia <strong>di</strong> fluorescenza indotta<br />
da laser e nella fotografia ad alta velocità. Le polveri refrattarie possono<br />
essere analizzate usando microscopia elettronica, <strong>di</strong>ffrazione a raggi X, BET e<br />
spettroscopia Auger.<br />
Dovrebbe essere inoltre sviluppata una modellistica per l’arco plasma, per il<br />
plasma-jet così come per i reattori a plasma a ra<strong>di</strong>ofrequenza; un’altra parte<br />
<strong>di</strong> modelli andrebbe sviluppata relativamente all’iniezione <strong>di</strong> particelle, al loro<br />
moto, riscaldamento, fusione e alle loro evaporazione nel plasma tenendo<br />
conto delle possibili reazioni chimiche, del brusco raffreddamento (quenching)<br />
e della formazione <strong>di</strong> prodotti finali”.
BRESCIA-MILANO: 52 MINUTI 11<br />
<strong>Brescia</strong>-Milano:<br />
52 minuti<br />
<strong>di</strong> Alessandro Marini<br />
Ho lavorato tutta la vita nei servizi, ma ho sempre amato il truciolo.<br />
Un’affermazione un pò sibillina, <strong>di</strong>te voi? Me ne rendo conto e voglio<br />
spiegarmi…<br />
Da ingegnere meccanico quale sono provo nostalgia per il progetto e la costruzione<br />
<strong>di</strong> qualcosa <strong>di</strong> fisico. Una nostalgia dovuta al mio DNA bresciano,<br />
basata sul “fare” e sul “costruire” qualcosa che si possa guardare, toccare,<br />
annusare; un’attitu<strong>di</strong>ne ra<strong>di</strong>cata, che fa parte del nostro patrimonio<br />
genetico.<br />
Da qui nasce la voglia <strong>di</strong> fare impresa della gente bresciana, che in questo<br />
momento <strong>di</strong> riflessione sull’economia mon<strong>di</strong>ale rappresenta il punto <strong>di</strong> appoggio<br />
del nostro sviluppo territoriale. Come ha scritto <strong>di</strong> recente Marco<br />
Fortis*, l’Italia, nonostante sia bistrattata in tutte le classifiche economiche,<br />
è sempre al secondo posto in Europa per tutto quanto riguarda l’economia<br />
reale, quella dell’agricoltura e dell’impresa. Quella cioè che produce veramente<br />
la ricchezza <strong>di</strong> un Paese, creandola dalle materie prime e con il lavoro<br />
e non solo trasformandola da una natura all’altra. Ed ecco che automaticamente<br />
torniamo al concetto che ha fatto da tema al precedente numero della<br />
rivista e che in questa seconda puntata verrà ulteriormente approfon<strong>di</strong>to: il<br />
legame fra lavoro ed energia. Abbiamo presentato casi aziendali importanti,<br />
all’avanguar<strong>di</strong>a, sintomatici dell’alleanza tra energia e impresa sul territorio<br />
bresciano. Ma parlando <strong>di</strong> energia e territorio locale ci è sembrato doveroso<br />
rendere in qualche modo omaggio ad ASM, un’impresa che ha occupato un<br />
ruolo importante nella crescita della nostra economia territoriale e <strong>di</strong> cui ripercorriamo<br />
la storia, raccontando al contempo anche la storia degli uomini<br />
che attraverso geniali intuizioni, tenacia e soprattutto lavoro durissimo,<br />
hanno contribuito a costruirla: Alfredo Giarratana, Bruno Boni, Gianfranco<br />
Rossi e soprattutto Renzo Capra.<br />
Un innovatore pro<strong>di</strong>gioso, quest’ultimo, che ha saputo trasformare le idee<br />
visionarie <strong>di</strong> Gianfranco Rossi in realtà, prendendo il coraggio a due mani e<br />
portando avanti una sfida meravigliosa a costo <strong>di</strong> scavare per decenni nella<br />
città, affrontando il malumore dei citta<strong>di</strong>ni, pur <strong>di</strong> realizzarla. Ha poi consolidato<br />
il successo in un’impresa che ha creato ricchezza vera nella città, sublimando<br />
quell’associazione con l’impresa energivora dei materiali che è la<br />
più <strong>di</strong>ffusa sul nostro territorio.<br />
Nel momento in cui <strong>Brescia</strong> perde la sua figlia più bella dandola in sposa ad<br />
un principe straniero è importante mettere un punto fermo sulla storia <strong>di</strong><br />
ASM e soprattutto su quella <strong>di</strong> questi ultimi formidabili 30 anni. Gli errori<br />
che ci sono stati – e che probabilmente hanno creato le basi per lo spostamento<br />
dei centri decisionali nel capoluogo lombardo – sono anche figli <strong>di</strong><br />
un modo <strong>di</strong> operare risoluto che ha permesso la creazione del valore e che<br />
ha fatto <strong>di</strong> ASM l’impresa che tutto il mondo ci ha invi<strong>di</strong>ato.<br />
Valore oggi in mano, <strong>di</strong> fatto, ai cugini milanesi. Poco male. Perché nella sfida<br />
globale dei territori la partita la giochiamo nella stessa squadra.<br />
➙
12 <strong>Brescia</strong> ricerche <strong>67</strong>/09<br />
<strong>Brescia</strong>-Milano:<br />
52 minuti<br />
Tuttavia un po’ duole non poter più contare tra le “nostre” un modello eccellente<br />
d’impresa vissuto come servizio al territorio. Il passaggio “ad maiora”<br />
della nostra ASM lascia sicuramente uno spazio, <strong>di</strong>rei un buco, un vuoto<br />
nell’alleanza per lo sviluppo economico sul territorio, che dovrà essere colmato<br />
da chi saprà raccogliere le istanze delle imprese e capire a fondo i loro<br />
bisogni.<br />
Noi come <strong>Brescia</strong> Ricerche cercheremo <strong>di</strong> fare la nostra parte: dal prossimo<br />
numero avremo una nuova rubrica fissa de<strong>di</strong>cata ad energia e territorio che<br />
ci permetterà <strong>di</strong> continuare il <strong>di</strong>alogo iniziato con questi due numeri speciali<br />
per <strong>di</strong>vulgare e <strong>di</strong>ffondere temi scientifici, tecnologici ed economici inerenti<br />
il mondo dell’energia, per creare una finestra su un settore in tumultuosa<br />
evoluzione.<br />
Chiudo segnalando un altro “figlio” della nostra <strong>Brescia</strong> che sta lanciando<br />
un’iniziativa <strong>di</strong> ampio respiro su scala internazionale. Stefano Rabolli Pansera,<br />
giovane architetto bresciano ormai <strong>di</strong> casa a Londra, docente presso la<br />
prestigiosa scuola della Architectural Association, si è trovato a ragionare<br />
sul tema della forma e dell’energia: secondo lui gli architetti hanno per troppo<br />
tempo lasciato agli ingegneri il dominio della tematica energetica nell’ambito<br />
delle costruzioni e delle opere civili. Il risultato è che il tema energetico<br />
gestito dagli ingegneri ha dato origine a realizzazione estremamente<br />
funzionali, ma sicuramente non belle.<br />
Muovendo da questi pensieri Rabolli Pansera ha ideato un progetto affascinante<br />
che, con il patrocinio della Architectural Association e della Biennale<br />
<strong>di</strong> Venezia, vuole riannodare i fili tra forma ed energia, nella ricerca <strong>di</strong> un<br />
nuovo para<strong>di</strong>gma tra energia, arte e architettura.<br />
Nell’articolo all’interno della rivista abbiamo voluto dare spazio a questo<br />
nuovo modo <strong>di</strong> vedere il tema energetico, che sviluppa una innovativa interazione<br />
tra scienza, forma e funzione.<br />
Terremo d’occhio questo esercizio e daremo ancora spazio all’architetto Rabolli<br />
Pansera nei prossimi numeri, per i futuri aggiornamenti del caso. Anche per<br />
non <strong>di</strong>menticare che non c’è limite agli orizzonti che si vogliono scoprire. <br />
* (Sole 24 ore, 11 <strong>giugno</strong> <strong>2009</strong>)
L’UNIONE FA LA FORZA<br />
DEUTSCHLAND<br />
UK<br />
ESPAÑA SL<br />
INDIA<br />
USA, INC.<br />
CANADA LTD.<br />
www.bonomi.it<br />
© BONOMI GROUP <strong>2009</strong> - Tutti i <strong>di</strong>ritti riservati - All rights reserved
14 <strong>Brescia</strong> ricerche <strong>67</strong>/09<br />
La storia dell’Azienda Servizi Municipalizzati <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>, attualmente<br />
confluita in A2A, è intimamente connessa a quella<br />
della capacità progettuale e realizzativa delle classi <strong>di</strong>rigenti<br />
locali, che oggi appare, a <strong>di</strong>re il vero, appannata. Capacità progettuale<br />
e realizzativa delle quali l’ASM è stata, spesso, elemento<br />
<strong>di</strong> eccellenza. Ci sono, in particolare, due perio<strong>di</strong> nei<br />
quali questa attitu<strong>di</strong>ne si è esplicata: la fine dell’Ottocento e<br />
quella della ricostruzione e poi del boom economico successivo<br />
alla seconda guerra mon<strong>di</strong>ale. Si tratta <strong>di</strong> due momenti storici<br />
nei quali gli uomini che hanno governato <strong>Brescia</strong> hanno<br />
espresso la capacità <strong>di</strong> accettare le sfide del futuro.<br />
L’era del liberale e massone Zanardelli:<br />
nasce l’ASM<br />
Il primo riferimento è agli anni del primo periodo unitario,<br />
quando a <strong>Brescia</strong> governava Giuseppe Zanardelli. Nel primo<br />
decennio unitario il Comune fu retto dai liberali moderati e<br />
successivamente, dal 1870 e per circa 25 anni, dagli zanardelliani,<br />
che seppero governare alleandosi con garibal<strong>di</strong>ni e ra<strong>di</strong>cali.<br />
In quegli anni <strong>Brescia</strong> si allargò, inglobando Mompiano,<br />
San Bartolomeo, Sant’Alessandro, San Nazaro. Venne approvato<br />
un nuovo piano regolatore per l’esterno della città, che<br />
<strong>di</strong>ede luogo a una ridefinizione del territorio. In quegli anni si<br />
assistette ad un grande sforzo per l’istruzione: nel 1888, a soli<br />
11 anni dall’introduzione della scuola elementare obbligatoria<br />
e gratuita per tre anni, in città e in provincia erano attive 1.183<br />
scuole con 48 mila allievi, pari all’85% dei fanciulli in età dell’obbligo.<br />
<strong>Brescia</strong> passava dall’essere una realtà agricola all’industria.<br />
Nell’ultimo ventennio del secolo l’industria bresciana<br />
decollò e qui si vede la capacità progettuale e <strong>di</strong> governo delle<br />
classi <strong>di</strong>rigenti, accompagnata da gran<strong>di</strong> opere infrastrutturali.<br />
Siamo negli anni in cui si elettrifica la città e si costruiscono le<br />
tramvie tra <strong>Brescia</strong>, Orzinuovi, Gargnano, Tavernole, Idro. Nel<br />
1883 viene costruita la linea ferroviaria <strong>Brescia</strong>-Parma e nel<br />
frattempo, con il completamento del tratto tra Rovato e Treviglio,<br />
<strong>Brescia</strong> viene collegata a Milano senza passare per Bergamo.<br />
Nel 1885 parte la linea ferroviaria <strong>Brescia</strong>-Iseo, costruita<br />
in soli due anni e poi, subito dopo, viene realizzata la Iseo-Ro-<br />
ASM,<br />
strumento <strong>di</strong> sviluppo<br />
Silvano Danesi<br />
vato. In provincia, in pochi anni, si contano 179 chilometri <strong>di</strong><br />
ferrovia in attività. Nel 1890 l’industria bresciana conta 23 mila<br />
occupati. Nel 1907, sul finire dell’era zanardelliana (Giuseppe<br />
Zanardelli muore nel 1903), <strong>Brescia</strong> sceglie, con referendum<br />
popolari, <strong>di</strong> municipalizzare le tramvie e l’energia elettrica.<br />
Nel 1908 nasce l’Azienda Servizi Municipalizzati.<br />
L’era Boni: l’ASM accompagna<br />
ricostruzione e crescita<br />
Veniamo al secondo dei perio<strong>di</strong> citati: il dopoguerra. E’<br />
qui che nasce la <strong>Brescia</strong> del ferro e dell’acciaio. La tra<strong>di</strong>zione<br />
della meccanica ha ra<strong>di</strong>ci più antiche, come quella<br />
del tessile.<br />
Alla fine del conflitto bellico <strong>Brescia</strong> dovette fare i conti con<br />
una <strong>di</strong>struzione consistente del suo patrimonio abitativo. Nel<br />
solo capoluogo mancavano all’appello 600 fabbricati, mentre<br />
1.500 erano gravemente danneggiati e 4 mila erano intaccati<br />
in forma lieve dai bombardamenti. Le famiglie che chiedevano<br />
assistenza erano 7 mila, per un totale <strong>di</strong> 28 mila persone. A<br />
questo quadro desolante deve aggiungersi quello della <strong>di</strong>soccupazione,<br />
che nell’imme<strong>di</strong>ato dopoguerra crebbe in modo<br />
esponenziale. I <strong>di</strong>soccupati risultavano 35.100 nel 1945, dei<br />
quali ben 30 mila dell’industria; nel 1946 erano saliti a 36.189,<br />
nel 1947 a 41.345 e nel 1948 raggiungevano la cifra <strong>di</strong> 63.009.<br />
La <strong>di</strong>soccupazione raggiunse la sua punta massima nel 1949,<br />
quando i senza lavoro iscritti all’ufficio <strong>di</strong> collocamento raggiunsero<br />
quota 71.489 unità. Gran parte dei <strong>di</strong>soccupati dell’industria<br />
veniva dal settore metalmeccanico, che sentiva i<br />
contraccolpi della fine della guerra, dopo aver subito un’espansione<br />
forzata dal 1938 in avanti. Un dato dà il senso <strong>di</strong><br />
quanto grande fosse stato il boom dovuto agli eventi bellici: il<br />
numero degli addetti delle do<strong>di</strong>ci maggiori aziende per la lavorazione<br />
delle armi era passato, dal 1938 al 1945, da 8.258 a<br />
28.350 unità, mentre gli addetti complessivi all’industria erano<br />
arrivati nel 1945 a 130 mila. La riduzione degli occupati fu<br />
altrettanto consistente del rapido aumento degli stessi, con la<br />
per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> circa 40-50 mila posti <strong>di</strong> lavoro. Si poneva, allora,<br />
un immenso problema <strong>di</strong> riconversione. Gli anni Cinquanta<br />
➙
ASM, STRUMENTO DI SVILUPPO 15<br />
furono, pertanto, un decennio volto alla ricostruzione e un periodo<br />
<strong>di</strong> gran<strong>di</strong> trasformazioni. Nell’e<strong>di</strong>lizia prevalse la ricostruzione,<br />
nelle aziende la riconversione e l’ammodernamento,<br />
nelle campagne una razionalizzazione che indusse migliaia <strong>di</strong><br />
braccianti ad inurbarsi e a <strong>di</strong>ventare, da villici e conta<strong>di</strong>ni, citta<strong>di</strong>ni<br />
e operai. Nel corso del decennio la città e la provincia<br />
mutarono profondamente. Nell’imme<strong>di</strong>ata periferia citta<strong>di</strong>na,<br />
per accogliere i molti immigrati dalla campagna, sorsero i<br />
quartieri nuovi, che si chiamarono Lamarmora, Primo Maggio.<br />
Padre Marcolini e<strong>di</strong>ficò i suoi “villaggi”. A S. Bartolomeo<br />
sorsero le case per i profughi dalmati. La rete filoviaria si estese,<br />
collegando i nuovi agglomerati urbani. La città sanò le sue<br />
ferite e aprì il <strong>di</strong>battito sul nuovo piano regolatore. Questo il<br />
quadro. Qui c’è Bruno Boni. Qui c’è una stagione politica singolare.<br />
Lo sviluppo del secondo dopoguerra fu, come nel periodo<br />
zanardelliano, accompagnato da gran<strong>di</strong> intuizioni, progettazioni,<br />
realizzazioni e tra queste, in primo luogo, la creazione,<br />
si può <strong>di</strong>re la rifondazione, dell’ASM, per dare l’energia<br />
sufficiente alle piccole e me<strong>di</strong>e aziende che avevano ripreso a<br />
marciare e alla città che si espandeva. L’Azienda decise <strong>di</strong> costruire,<br />
alla fine del 1957, la centrale elettrica <strong>di</strong> Cassano d’Adda,<br />
ma a pensare un’azienda autoproduttrice furono Bruno<br />
Boni, Libero Dordoni e l’ingegner Giovanni Rosani, <strong>di</strong>rettore<br />
generale dal 1951. L’iniziativa non fu <strong>di</strong> facile avvio, in considerazione<br />
della presenza della Società Elettrica <strong>Brescia</strong>na, che<br />
gestiva gran parte delle utenze sul territorio e con la quale i<br />
rapporti erano da qualche tempo tesi. Nel 1950 le utenze risultavano<br />
essere aumentate, rispetto a cinque anni prima, del<br />
78% e i rapporti tra le due società furono regolamentati, dal<br />
1946 al 1951, da convenzioni provvisorie. Nel 1955, dopo anni<br />
<strong>di</strong> braccio <strong>di</strong> ferro sui carichi <strong>di</strong> fornitura, la SEB aveva chiamato<br />
in giu<strong>di</strong>zio l’ASM, chiedendo il risarcimento dei danni<br />
subiti a causa dell’eccesso <strong>di</strong> prelievi. La comunità bresciana, e<br />
in particolare la Municipalizzata, non poterono più eludere il<br />
problema <strong>di</strong> garantire alla città ed al suo sviluppo l’autosufficienza<br />
e nel 1957 si cominciò a <strong>di</strong>scutere con l’AEM, l’Azienda<br />
Elettrica Milanese, la costruzione <strong>di</strong> Cassano D’Adda. Va notato<br />
in proposito, senza entrare nei particolari della lunga<br />
vertenza con la SEB, che quando si costruì nel 1961 la centrale<br />
<strong>di</strong> Cassano D’Adda, in Italia si stava <strong>di</strong>scutendo <strong>di</strong> nazionalizzazione,<br />
secondo un’impostazione che il 6 <strong>di</strong>cembre del<br />
1962 portò all’istituzione dell’ENEL. <strong>Brescia</strong>, con la sua strategia<br />
<strong>di</strong> alleanze, remava controcorrente, ma l’impostazione <strong>di</strong><br />
Boni, Dordoni e Rosani si mostrò alla lunga vincente. Progettualità,<br />
dunque, ma anche coraggio <strong>di</strong> essere una voce fuori<br />
dal coro.<br />
La capacità <strong>di</strong> non essere autarchici<br />
e <strong>di</strong> attrarre intelligenze<br />
Bruno Boni, che spesso la cronaca ha <strong>di</strong>pinto come uomo della<br />
brescianità, sindaco autarchico, governatore delle Gallie, alieno<br />
ai richiami della Capitale, mostrò, al contrario, la sua capacità<br />
<strong>di</strong> grande apertura chiedendo a Libero Dordoni, presidente della<br />
Municipalizzata, <strong>di</strong> trovare sul mercato delle competenze un<br />
uomo capace <strong>di</strong> fare dell’azienda lo strumento adatto allo sviluppo<br />
della città e della provincia. Dordoni trovò Gianfranco<br />
Rossi, che arrivò a <strong>Brescia</strong> nel <strong>giugno</strong> del 1960, in un quadro<br />
economico e sociale in rapida evoluzione. La fase della ricostruzione<br />
era finita. I bollettini della Camera <strong>di</strong> Commercio scrivevano<br />
<strong>di</strong> un afflusso abbondante e regolare delle materie prime e<br />
semilavorate e <strong>di</strong> normale <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> forze energetiche a<br />
prezzi generalmente invariati, nonché <strong>di</strong> un vivace ritmo lavorativo<br />
delle aziende trasformatrici e in particolare nell’e<strong>di</strong>lizia.<br />
<strong>Brescia</strong> aveva dovuto affrontare problemi <strong>di</strong> riconversione industriale<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni maggiori <strong>di</strong> ogni altra zona simile, ma<br />
lo sviluppo industriale bresciano si era <strong>di</strong>mostrato assai vivace.<br />
Il processo <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffusione dell’industria nella Bassa <strong>Brescia</strong>na,<br />
zona fino ad allora prevalentemente agricola, fu notevole, con<br />
l’effetto, non secondario, <strong>di</strong> un riequilibrio del territorio e <strong>di</strong> un<br />
freno all’esodo della manodopera che, per le sue proporzioni<br />
(10 mila persone in 10 anni) stava mettendo a rischio l’assetto<br />
<strong>di</strong> intere aree della provincia. Bruno Boni, in un intervento sul<br />
<strong>Giornale</strong> <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> datato 21 aprile 1963, <strong>di</strong>pingeva l’andamento<br />
economico della provincia, come un “meraviglioso sforzo<br />
produttivo”. Il quadro che veniva presentato era dunque <strong>di</strong><br />
grande <strong>di</strong>namicità, ma aveva mo<strong>di</strong>ficato ra<strong>di</strong>calmente gli assetti<br />
socio-economici della realtà provinciale ed aveva causato<br />
sconvolgimenti <strong>di</strong> grande portata nella vita <strong>di</strong> migliaia <strong>di</strong> persone.<br />
Per dare una risposta all’inurbamento <strong>di</strong> una massa consistente<br />
<strong>di</strong> lavoratori, l’attività e<strong>di</strong>lizia assunse caratteri <strong>di</strong> particolare<br />
<strong>di</strong>namicità. Dal 1956 all’agosto del 1960 privati, cooperative<br />
ed enti pubblici costruirono in città complessivamente<br />
44.482 vani utili <strong>di</strong> abitazione. Un contributo essenziale al raggiungimento<br />
<strong>di</strong> uno standard abitativo che desse sod<strong>di</strong>sfazione<br />
alla fame <strong>di</strong> case indotta dai danni della guerra, dallo sviluppo<br />
economico e dallo spostamento <strong>di</strong> masse ingenti <strong>di</strong> lavoratori<br />
dalle campagne verso i centri urbani, lo <strong>di</strong>ede l’iniziativa <strong>di</strong> padre<br />
Ottorino Marcolini, che con la sua cooperativa “La Famiglia”,<br />
nata nel 1954, in pochi anni costruì villaggi attorno alla<br />
città e in alcuni centri della provincia. Se l’e<strong>di</strong>lizia rappresenta<br />
negli anni Cinquanta e nei primi anni Sessanta uno dei settori<br />
più <strong>di</strong>namici, non <strong>di</strong> meno si può <strong>di</strong>re <strong>di</strong> gran parte dei comparti<br />
dell’economia provinciale. La gamma delle produzioni offerte<br />
era ampia. Si andava dalle industrie estrattive (minerali <strong>di</strong><br />
ferro, fluorina, marmo) alle industrie alimentari (casearia, molitoria,<br />
enologica). Uno dei comparti storici era rappresentato<br />
dalle industrie tessili (filati <strong>di</strong> lana, <strong>di</strong> cotone e <strong>di</strong> seta, tessuti <strong>di</strong><br />
lana e <strong>di</strong> cotone, calze, coperte, feltri per cartiere). Le cartiere<br />
nel 1957 producevano 640 mila quintali <strong>di</strong> carta e cartone. Una<br />
presenza considerevole facevano registrare anche l’industria<br />
della trasformazione dei minerali non metallici (cemento, calce,<br />
laterizi) e l’industria elettrica, che nel 1957 produsse 1.123 milioni<br />
<strong>di</strong> Kwh. La colonna portante dell’industria locale era rappresentata<br />
dall’industria metallurgica e meccanica. Un dato<br />
tuttavia, ben più degli altri, dà l’idea della profon<strong>di</strong>ssima trasformazione<br />
avvenuta in quegli anni: tra il 1951 e il 1961 il red<strong>di</strong>to<br />
pro capite ebbe un incremento del 91%.<br />
Lo sviluppo affiancato dalle gran<strong>di</strong> opere<br />
Anche in questo caso, come alla fine dell’Ottocento, lo sviluppo<br />
fu accompagnato da gran<strong>di</strong> opere. I collegamenti <strong>di</strong>ventarono<br />
più efficienti. Venne raddoppiata l’autostrada <strong>Brescia</strong>-<br />
➙
16 <strong>Brescia</strong> ricerche <strong>67</strong>/09<br />
Bergamo, entrò in funzione la Serenissima, che collegò la realtà<br />
bresciana con il Veneto, e fu finanziata dall’Anas la tangenziale<br />
a sud della città. In un quadro <strong>di</strong> grande espansione produttiva<br />
e <strong>di</strong> travolgente <strong>di</strong>namismo sociale, alla compagine<br />
amministrativa che guidava la città si pose il problema <strong>di</strong> adeguare<br />
gli strumenti a <strong>di</strong>sposizione. I Servizi Municipalizzati<br />
erano un’azienda artigianale, a misura della città anteguerra:<br />
un’azienda sempre gestita al meglio, cresciuta <strong>di</strong> pari passo<br />
con le esigenze, con uno staff manageriale familiare. I rapporti<br />
con la città erano <strong>di</strong> vicinato. Le filovie che avevano soppiantato<br />
i vecchi tram non avevano ancora da fare i conti con il boom<br />
dell’automobile, sopravvenuto in parallelo allo sviluppo economico.<br />
Il gas aveva già rubato terreno alle forme tra<strong>di</strong>zionali <strong>di</strong><br />
riscaldamento, ma i meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> produzione erano antiquati.<br />
Dopo la guerra il gasometro era stato ricostruito e rimodernato<br />
e dal 1952 il consiglio comunale aveva deciso la metanizzazione<br />
della città: <strong>Brescia</strong> fu tra le prime, insieme a Cremona,<br />
Piacenza e Lo<strong>di</strong>, ad utilizzarlo. Il metano mise in pensione il<br />
gas, ma l’espansione della città, la costruzione dei villaggi<br />
Marcolini, l’inurbamento <strong>di</strong> migliaia <strong>di</strong> operai provenienti dalle<br />
campagne avevano costretto i Servizi Municipalizzati ad<br />
estendere la rete. La metanizzazione, in ogni caso, aveva marciato<br />
a ritmi serrati, pulendo i cieli della città. La centrale <strong>di</strong><br />
Cassano D’Adda era ormai una decisione presa, così come<br />
l’autoproduzione. Ora si trattava <strong>di</strong> prendere una società che<br />
aveva fatto il suo dovere e <strong>di</strong> metterla al passo dei tempi: un<br />
passo <strong>di</strong> corsa, a tratti un galoppo.<br />
Gianfranco Rossi, un manager per la città<br />
La vecchia impostazione artigianale non bastava più. Bruno<br />
Boni e Libero Dordoni giunsero pertanto alla decisione <strong>di</strong><br />
andare a cercare, come si <strong>di</strong>rebbe oggi “sul mercato”, un ma-<br />
nager che avesse esperienza, cultura, apertura al nuovo, visione<br />
internazionale; ovvero, doti capaci <strong>di</strong> immettere nuova<br />
linfa nell’azienda comunale. Gianfranco Rossi, nato a Bologna<br />
il 15 <strong>giugno</strong> 1916, laureato in ingegneria, libero docente<br />
<strong>di</strong> costruzioni idrauliche all’Università <strong>di</strong> Bologna, funzionario<br />
al Comune <strong>di</strong> Bologna dal 1947 al 1949 e <strong>di</strong>rigente tecnico<br />
dell’Azienda municipalizzata del gas e dell’acqua <strong>di</strong> Bologna<br />
dal 1948 al 1959, aveva tutte le caratteristiche per rivestire il<br />
ruolo che i due amministratori bresciani gli volevano assegnare.<br />
In più, e non è poco, Rossi era un uomo dalla spiccata<br />
intelligenza, dotato <strong>di</strong> una cultura eclettica, pignolo al punto<br />
giusto e, soprattutto, capace <strong>di</strong> senso della misura. Cocciuto<br />
nel perseguire gli obiettivi, preciso fino allo sfinimento nel<br />
cercare le soluzioni migliori, aveva la capacità <strong>di</strong> mettere in<br />
campo tutte le forze necessarie per vincere, ma non per stravincere<br />
o per farsi indebolire in estenuanti guerre <strong>di</strong> posizione.<br />
Al suo arrivo chi lo ebbe al fianco si rese subito conto che<br />
era uomo puntiglioso nel <strong>di</strong>fendere le sue posizioni, ma anche<br />
capace <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azioni, incline a ricercare sempre un punto<br />
<strong>di</strong> accordo. Con i sindacati conduceva lunghe ed estenuanti<br />
trattative, facendo le ore piccole a cui era abituato, essendo<br />
un animale notturno. Alla fine, però, prevaleva sempre l’intesa.<br />
Così fu anche per i contenziosi che l’azienda aveva<br />
aperti con altre società e con il fisco. In poco tempo Rossi riportò<br />
tutto in or<strong>di</strong>ne, eliminando le croste del passato e lucidando<br />
la macchina aziendale. Nell’azienda immise uno stile<br />
nuovo, trasformando lo staff <strong>di</strong>rigente, “procedurizzando” le<br />
operazioni, mutando l’approccio con i problemi e con la città<br />
da artigianale e familiare, in manageriale ed aziendale. In<br />
pochi anni anche l’operatività cambiò decisamente marcia.<br />
Nel 1961 era entrata in funzione la centrale termoelettrica <strong>di</strong><br />
Cassano D’Adda e nel 1962 venne inaugurata una nuova sottostazione<br />
a Est, in via Lucio Fiorentini, che completava l’anello<br />
intorno alla città per la fornitura <strong>di</strong> energia elettrica. La<br />
➙
ASM, STRUMENTO DI SVILUPPO 17<br />
città andava, nel frattempo, illuminandosi “a giorno”, con<br />
nuovi meto<strong>di</strong> che rendevano più sicura la percorrenza notturna.<br />
Nel 1962, per evitare <strong>di</strong> essere soggetti alle multe che<br />
l’ENI imponeva alle aziende <strong>di</strong>stributrici del gas quando superavano<br />
i quantitativi concordati, Rossi fece realizzare un<br />
impianto <strong>di</strong> aria propanata, che consentiva, come si <strong>di</strong>ce in<br />
gergo, <strong>di</strong> “tagliare le punte”, ossia <strong>di</strong> inserire gas in rete in<br />
aggiunta al metano quando i consumi erano eccessivi rispetto<br />
alle normali forniture. Per la città e per i Servizi Municipalizzati<br />
questo impianto significò maggiore autonomia, un<br />
accresciuto potere contrattuale e un indubbio risparmio.<br />
Sempre nel 1962, sulla via maestra tracciata dall’alleanza con<br />
l’AEM, <strong>Brescia</strong> registrò l’accoglimento dei suoi progetti in<br />
campo energetico con l’autorizzazione, firmata dal ministro<br />
Colombo, a costruire in collaborazione con Verona e Vicenza<br />
(poi ritiratasi) una nuova centrale elettrica a Salionze. La<br />
nuova pelle dell’azienda, ormai definita in termini manageriali,<br />
acquistò visibilità anche fisica con l’inaugurazione, il 7<br />
aprile 1963, della nuova sede dei reparti tecnici ed operativi.<br />
Nello stesso anno vennero sperimentati nuovi tubi in plastica<br />
per la rete del metano e si <strong>di</strong>ede inizio ai lavori <strong>di</strong> costruzione,<br />
in via San Donino, a nord della città, <strong>di</strong> un nuovo deposito<br />
per le filovie e i bus. Il vecchio deposito <strong>di</strong> via Donegani<br />
era ormai insufficiente e si apprestava ad andare in pensione,<br />
come molti dei suoi ospiti. In poco tempo, infatti, i<br />
vecchi filobus vennero soppiantati. Il deposito <strong>di</strong> via San Donino<br />
venne completato in un anno e solo tre anni dopo, nel<br />
19<strong>67</strong>, l’ultimo filobus in servizio, dopo trentacinque anni <strong>di</strong><br />
attività filoviaria, si avviava all’ultimo viaggio. Dal 1960 al<br />
1964 la rete del gas acquisì 11 mila nuove utenze e nello stesso<br />
periodo vennero posati 80 chilometri <strong>di</strong> nuove tubature.<br />
Gli acquedotti servirono, nello stesso periodo, 3 mila utenti<br />
in più, con la posa <strong>di</strong> 65 chilometri <strong>di</strong> rete. Le autofilovie<br />
avevano raggiunto 20 linee, con 87 vetture in servizio giornaliero.<br />
L’opera <strong>di</strong> Rossi appariva ormai come uno sforzo costante<br />
<strong>di</strong> innovazione e <strong>di</strong> adeguamento, che dava i suoi frutti<br />
in modo visibile. L’Azienda gestiva il servizio dell’acqua,<br />
quello del gas, quello dell’energia elettrica e i trasporti. Nel<br />
1966 entrò in funzione la nuova centrale <strong>di</strong> Salionze, che sarebbe<br />
stata inaugurata ufficialmente nel luglio del 1968 dal<br />
ministro Giulio Andreotti, che ne aveva appoggiato la costruzione,<br />
in sintonia con le linee d’azione <strong>di</strong> Boni, <strong>di</strong> Dordoni e<br />
<strong>di</strong> Rossi. L’elettrodotto Salionze-<strong>Brescia</strong> fu messo sotto tensione<br />
a 130 mila volt nel 1966. L’Azienda, nel frattempo, si<br />
era andata informatizzando e la sua acclarata strutturazione<br />
manageriale venne premiata per la migliore relazione al bilancio.<br />
Una nuova filosofia organizzativa<br />
per i servizi pubblici<br />
Rossi rappresentò un’immissione benefica <strong>di</strong> capacità <strong>di</strong>rigenziale,<br />
tecnica, progettuale.<br />
In quegli anni c’era anche la voglia <strong>di</strong> guardare lontano, <strong>di</strong> capire<br />
il nuovo che maturava altrove. Rossi, negli anni della sua<br />
permanenza a <strong>Brescia</strong>, non aveva mai smesso <strong>di</strong> progettare, <strong>di</strong><br />
stu<strong>di</strong>are, <strong>di</strong> avviare nuove idee sui binari della sperimentazio-<br />
ne. Uomo <strong>di</strong> ampie vedute, dalle frequentazioni internazionali<br />
intense, il <strong>di</strong>rettore dell’Azienda aveva messo nel cassetto una<br />
notevole quantità <strong>di</strong> progetti, ma soprattutto aveva elaborato<br />
l’idea <strong>di</strong> fondo, il filo conduttore sul quale si sarebbe mossa l’azienda<br />
negli anni a venire. Meglio <strong>di</strong> lui stesso nessuno può<br />
rendere l’idea <strong>di</strong> questa impostazione <strong>di</strong> fondo. A Mosca, dove<br />
tenne la relazione alla VII Conferenza mon<strong>di</strong>ale dell’energia<br />
nell’agosto 1968, Rossi <strong>di</strong>sse: “Necessita concepire in forma<br />
decisamente <strong>di</strong>versa la strutturazione tecnico-funzionale dei<br />
servizi pubblici, facendo largo impiego dei moderni concetti <strong>di</strong><br />
produttività, <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensione ottimale, d’organizzazione orizzontale,<br />
che hanno recentemente dato, e stanno dando, tanti<br />
copiosi frutti nel mondo dell’industria moderna. Soprattutto<br />
l’organizzazione orizzontale rappresenta un elemento nuovo<br />
nel settore dei pubblici servizi e costituisce una grande promessa<br />
per il contenimento dei costi. La produzione, il trasporto<br />
e la <strong>di</strong>stribuzione dell’energia elettrica, del gas combustibile<br />
e dell’acqua potabile, la raccolta e l’incenerimento dei rifiuti<br />
soli<strong>di</strong> urbani, la <strong>di</strong>stribuzione del calore in interi quartieri citta<strong>di</strong>ni<br />
per uso riscaldamento civile o a zone industriali, se esaminati<br />
nelle <strong>di</strong>verse fasi operative, presentano funzioni tra loro<br />
simili o complementari che consentono, in un esercizio congiunto,<br />
la possibilità <strong>di</strong> elevare notevolmente i ren<strong>di</strong>menti<br />
energetici, <strong>di</strong> sfruttare più razionalmente gli eventuali sottoprodotti,<br />
<strong>di</strong> elevare l’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> utilizzazione della mano d’opera,<br />
sempre più costosa per l’evolversi del progresso sociale, e <strong>di</strong><br />
eliminare infine i doppioni con i conseguenti sprechi <strong>di</strong> mano<br />
d’opera, <strong>di</strong> mezzi tecnici e <strong>di</strong> denaro. Il principio dell’organizzazione<br />
orizzontale, in rapporto alla natura delle funzioni e dei<br />
momenti operativi effettivamente necessari sull’intiero quadro<br />
dell’attività aziendale, e non ripartitamente per i <strong>di</strong>versi settori<br />
interessati, trova una proficua applicazione negli impianti a<br />
scopo multiplo per la produzione <strong>di</strong> energia elettrica, gas, acqua<br />
e calore, quivi inclusi i processi per l’incenerimento dei rifiuti<br />
sol<strong>di</strong> urbani”. L’ASM, che deve le sue fortune anche ad un<br />
altro amministratore eccellente come Cesare Trebeschi e a un<br />
tecnico “d’importazione” altrettanto buono come Renzo Capra,<br />
ha una storia continua <strong>di</strong> iniezioni <strong>di</strong> know-how esterno, unito<br />
a virtù locali.<br />
La capacità <strong>di</strong> fare sistema<br />
Abbiamo preso in considerazione due esperienze, quella della<br />
fine dell’Ottocento e quella del dopoguerra. Due mon<strong>di</strong> tra loro<br />
<strong>di</strong>versi, ma accomunati da una classe <strong>di</strong>rigente capace e da<br />
uomini che hanno saputo dare a <strong>Brescia</strong> il meglio <strong>di</strong> sé. C’è un<br />
ulteriore elemento <strong>di</strong> riflessione sul quale vale la pena soffermarsi:<br />
la capacità <strong>di</strong> fare sistema anche dal punto <strong>di</strong> vista sociale.<br />
Nell’un caso e nell’altro la politica seppe assumersi l’onere<br />
della <strong>di</strong>alettica sociale. Nella stagione <strong>di</strong> Zanardelli nacquero,<br />
numerose, le società <strong>di</strong> mutuo soccorso, promosse dai socialisti,<br />
successivamente dai cattolici, ma anche, ed è significativo,<br />
dagli stessi zanardelliani. Nella stagione <strong>di</strong> Boni la Loggia<br />
fu il centro della me<strong>di</strong>azione politica dei conflitti sociali: prima<br />
quelli esplosi nelle campagne, poi quelli relativi al mondo produttivo<br />
industriale. La classe <strong>di</strong>rigente, insomma, seppe accompagnare<br />
lo sviluppo anche me<strong>di</strong>andone i conflitti.
18 <strong>Brescia</strong> ricerche <strong>67</strong>/09<br />
Fino alla fine degli anni ’60 ASM ha rincorso lo sviluppo<br />
della città e della provincia. L’opera del Prof.<br />
Rossi ha permesso <strong>di</strong> mettere l’Azienda al passo con la<br />
città e soprattutto ha posto le basi per il salto in avanti<br />
che l’ha portata a <strong>di</strong>ventare il valore principale della<br />
città. Teleriscaldamento e termoutilizzatore sono state<br />
intuizioni immaginate in quegli anni, ma che hanno<br />
richiesto trent’anni per essere completamente realizzate.<br />
A partire dagli anni ‘60 si assiste poi a una forte riorganizzazione<br />
dei servizi pubblici bresciani, caratterizzata in<br />
particolare da una decisa - e decisiva - spinta alla scelta<br />
energetica. L’avvio della centrale termoelettrica <strong>di</strong> Salionze<br />
garantisce una maggiore in<strong>di</strong>pendenza energetica del<br />
territorio e la municipalizzazione della nettezza urbana<br />
nel 1964 genera l’occasione per ripensare in modo innovativo,<br />
e per l’epoca assolutamente visionario, i servizi del<br />
territorio.<br />
Nel 1964 si affaccia sul palcoscenico della municipalizzata<br />
un attore che <strong>di</strong>venterà protagonista in<strong>di</strong>scusso della storia<br />
<strong>di</strong> ASM fino ai giorni nostri, forte <strong>di</strong> un’esperienza <strong>di</strong><br />
produzione, ma anche <strong>di</strong> commercializzazione dell’elettricità<br />
ed esperto <strong>di</strong> centrali termoelettriche. Si tratta <strong>di</strong><br />
Renzo Capra, chiamato alla <strong>di</strong>visione energia della municipalizzata<br />
dal <strong>di</strong>rettore generale <strong>di</strong> allora, Gianfranco<br />
Rossi, proprio per supportare al meglio l’avviamento della<br />
centrale <strong>di</strong> Salionze: le basi del teleriscaldamento prima e<br />
del termoutilizzatore poi sono state gettate. Chissà se il<br />
prof. Rossi aveva già visto nell’ingegnere piacentino, formatosi<br />
all’ENI <strong>di</strong> Enrico Mattei, l’uomo fondamentale per<br />
realizzare le sue idee e garantire la crescita e lo sviluppo<br />
<strong>di</strong> ASM...<br />
Abbiamo ripercorso la storia <strong>di</strong> quest’avventura proprio<br />
con l’aiuto dell’ing. Capra, raccogliendo i suoi ricor<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
quegli anni formidabili.<br />
Gli anni<br />
del teleriscaldamento:<br />
intuito e innovazione<br />
a servizio del territorio<br />
Federica Zaccaria<br />
Parola d’or<strong>di</strong>ne: in<strong>di</strong>pendenza efficiente<br />
del territorio<br />
Come abbiamo ricordato, in seguito alla municipalizzazione<br />
della nettezza urbana nel ‘64, nasce l’opportunità <strong>di</strong><br />
produrre elettricità autonomamente utilizzando i rifiuti.<br />
E’ proprio sul tema dell’autosufficienza che insiste Rossi<br />
in un suo <strong>di</strong>scorso in occasione del congresso mon<strong>di</strong>ale<br />
sull’energia <strong>di</strong> Mosca, alla fine degli anni ‘60: la visione è<br />
quella <strong>di</strong> rendere un territorio autosufficiente dal punto <strong>di</strong><br />
vista energetico realizzando una filiera <strong>di</strong> servizi che, concatenandosi<br />
fra loro, avrebbero garantito in<strong>di</strong>pendenza<br />
energetica ed efficienza operativa per la città generando<br />
capitale sociale e valore per il territorio.<br />
L’esempio era dato dai Paesi nor<strong>di</strong>ci, dove impianti per<br />
ottenere acqua calda esistevano già (un esempio su tutti,<br />
la prima centrale a elettricità-vapore costruita a Berlino e<br />
risalente ad<strong>di</strong>rittura alla fine del 1800).<br />
Il termoutilizzatore era già un’idea, ma all’epoca si scontrava<br />
con significativi vincoli tecnici che ne impe<strong>di</strong>vano <strong>di</strong><br />
fatto la realizzazione: l’inquinamento prodotto dalla combustione<br />
dei rifiuti e soprattutto la garanzia <strong>di</strong> stabilità dei<br />
carichi nell’utilizzo del calore che negli impianti <strong>di</strong> teleriscaldamento<br />
varia in modo sostanziale tra estate e inverno.<br />
Questi ostacoli non hanno tuttavia smorzato la volontà<br />
degli uomini <strong>di</strong> ASM, che hanno sfruttato ogni occasione<br />
per perseguire il loro obiettivo.<br />
La prima <strong>di</strong> queste occasioni viene fornita dalla costruzione<br />
della nuova area urbana <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> Due. Gli ideatori <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong><br />
Due ed i tecnici <strong>di</strong> ASM iniziano a pensare alla concreta<br />
realizzazione <strong>di</strong> un progetto pilota, comprendente un unico<br />
impianto per il riscaldamento dell’intera zona. Il progetto<br />
prende avvio nel 1972 con una caldaia provvisoria che servì<br />
da “canovaccio” su cui ingegneri, tecnici e maestranze poterono<br />
farsi le ossa. Un anno dopo, nel ‘73, si alza il tiro pene-<br />
➙
GLI ANNI DEL TELERISCALDAMENTO: INTUITO E INNOVAZIONE A SERVIZIO DEL TERRITORIO 19<br />
trando nel cuore della città attraverso la ferrovia e arrivando<br />
in Piazza Vittoria nel 1975; <strong>Brescia</strong> Due aveva cessato il<br />
suo sviluppo, si passava alla conquista del centro storico.<br />
La rivoluzione del calore<br />
Teleriscaldamento, ovvero portare il calore negli e<strong>di</strong>fici citta<strong>di</strong>ni<br />
attraverso una rete <strong>di</strong> tubi all’interno dei quali far<br />
scorrere acqua calda. Una pratica, come accennato, già nota<br />
e applicata in <strong>di</strong>versi Paesi del nord, ma mai utilizzata<br />
prima in una nazione dal clima temperato come la nostra.<br />
Non a caso, è proprio una società svedese - la Energie<br />
Konsult - a coa<strong>di</strong>uvare i tecnici <strong>di</strong> ASM, permettendo <strong>di</strong><br />
superare i vincoli iniziali che causarono ritar<strong>di</strong> nella realizzazione<br />
del teleriscaldamento.<br />
Siamo dunque arrivati al 1975, periodo in cui a guidare la città<br />
c’è il sindaco Bruno Boni (l’anno successivo arriverà Cesa-<br />
Renzo Capra, una vita per l’energia<br />
re Trebeschi, altro sindaco “amico” <strong>di</strong> ASM), mentre il cuore<br />
progettuale, realizzativo e gestionale è sempre Renzo Capra,<br />
<strong>di</strong>rigente dei servizi energetici fino al 1979, anno in cui <strong>di</strong>verrà<br />
<strong>di</strong>rettore generale dell’azienda (dal 1995 al 2007 ne sarà<br />
poi presidente). Da una parte la lungimiranza <strong>di</strong> una classe<br />
politica che riconosce alla municipalizzata autonomia impren<strong>di</strong>toriale<br />
e che farà <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> la “città più teleriscaldata<br />
d’Italia”; dall’altra un tecnico rigoroso, capace <strong>di</strong> destreggiarsi<br />
abilmente (si <strong>di</strong>rebbe, con talento squisitamente politico) e<br />
per svariati anni fra cambi <strong>di</strong> presidenza aziendale e <strong>di</strong> governo<br />
citta<strong>di</strong>no. Nel 1976 parte la seconda <strong>di</strong>rettrice Lamarmora-via<br />
Cremona, con l’attivazione della prima linea <strong>di</strong> cogenerazione<br />
(carbone-metano-olio combustibile) della Centrale<br />
<strong>di</strong> Lamarmora: si inizia a produrre energia e calore e a<br />
far leva sulle opportunità <strong>di</strong> uno sfruttamento efficiente delle<br />
fonti energetiche fossili. Da qui in avanti la strada è in <strong>di</strong>scesa:<br />
nel 1978 si realizza il secondo gruppo <strong>di</strong> cogenerazione <strong>di</strong><br />
Lamarmora, cui segue nel 1986-1987 il terzo, una centrale<br />
Quando Renzo Capra parla della sua storia professionale gli si incen<strong>di</strong>a lo<br />
sguardo, quasi che l’energia e il calore - temi <strong>di</strong> cui si è occupato per tutta una<br />
vita - si sprigionassero attraverso i suoi occhi. E’ la prima cosa che ci colpisce<br />
durante la chiacchierata che ci ha concesso ospiti della sua bella casa, nel caldo<br />
<strong>di</strong> una giornata estiva, sorseggiando una bibita fresca.<br />
L’ing. Capra è uomo solido, concreto, abituato al comando ma al contempo capace<br />
<strong>di</strong> rivivere con sincera partecipazione il passato <strong>di</strong> una città che ha visto<br />
personalità straor<strong>di</strong>narie e gran<strong>di</strong> traguar<strong>di</strong>. Dalle colline piacentine ai vertici<br />
<strong>di</strong> ASM, Capra ha caratterizzato un periodo d’oro per la nostra città, anni in<br />
cui si lavorava per dare a <strong>Brescia</strong> un’in<strong>di</strong>pendenza energetica che avrebbe portato<br />
alla nascita <strong>di</strong> quello che adesso ci sembra normalità, ma che per gli anni<br />
’70 era una vera rivoluzione: il teleriscaldamento. Una svolta che permise ad<br />
ASM <strong>di</strong> iniziare a marciare a un’andatura <strong>di</strong>fferente, più spe<strong>di</strong>ta rispetto alle<br />
altre municipalizzate italiane.<br />
Renzo Capra fu artefice <strong>di</strong> tutto questo, mettendo a <strong>di</strong>sposizione della municipalizzata<br />
l’esperienza accumulata nel Gruppo ENI, a stretto contatto con un altro<br />
“manager <strong>di</strong> razza”, quell’Enrico Mattei che, con lungimiranza e grande coraggio<br />
impren<strong>di</strong>toriale, ci svincolò dalla <strong>di</strong>pendenza petrolifera delle compagnie americane, dando il via al “miracolo economico”<br />
che contribuì a fare dell’Italia il Paese moderno e industrializzato che ora conosciamo.<br />
E, così come Mattei, anche Capra abbracciò fin da subito la convinzione che un’azienda pubblica possa e debba essere<br />
un’impresa forte, capace <strong>di</strong> rivaleggiare con il privato in quanto a efficienza e qualità dei servizi. Capra, dunque,<br />
dopo gli anni in ENI (prima a Ravenna e poi a Gela), approda a <strong>Brescia</strong> nel 1965, assunto dall’ASM come <strong>di</strong>rigente<br />
dei servizi energetici. Da allora l’intero percorso della municipalizzata citta<strong>di</strong>na si intreccia a quello personale<br />
<strong>di</strong> Renzo Capra, in un or<strong>di</strong>to fatto <strong>di</strong> crescita <strong>di</strong> fatturato e <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni, <strong>di</strong> intrecci economici e strategie politiche,<br />
<strong>di</strong> obiettivi ambiziosi ed esiti invi<strong>di</strong>abili.<br />
L’ing. Capra ha sicuramente dato molto alla nostra città e anche ora che non si trova più sotto agli impietosi riflettori<br />
della politica e dei mass me<strong>di</strong>a, se si vuole conoscere la gloriosa storia <strong>di</strong> ASM è a lui che bisogna rivolgersi.<br />
Magari ospiti della sua bella casa, nel caldo <strong>di</strong> una giornata estiva, sorseggiando una bibita fresca.<br />
f.z.<br />
➙
20 <strong>Brescia</strong> ricerche <strong>67</strong>/09<br />
policombustibile a carbone che consente flessibilità <strong>di</strong> utilizzo<br />
del combustibile fossile con una potenza <strong>di</strong> 75 MWe (Mega<br />
Watt elettrico) e 160 MWt (Mega Watt termico).<br />
Nel frattempo viene dato avvio, nel 1983, ad un nuovo<br />
progetto sperimentale <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong> energia con recupero<br />
totale del calore. La “Centrale Diesel Nord”, che è<br />
stata attiva fino alla 2004, utilizzava due motori <strong>di</strong>esel navale<br />
per la produzione <strong>di</strong> energia ed era struttura in modo<br />
da recuperare tutto il calore derivante dalle fasi della<br />
combustione. Furono messe a punto tecnologie <strong>di</strong> scambio<br />
sia per l’acqua <strong>di</strong> raffreddamento che per gli olii lubrificanti<br />
per i quali fu necessario adottare scambiatori innovativi<br />
per garantire il corretto funzionamento. Anche il calore<br />
dei fumi <strong>di</strong> scarico veniva sfruttato per lo scambio<br />
termico, arricchito da una fase <strong>di</strong> post-combustione posta<br />
tra lo scarico dei motori e gli scambiatori.<br />
Energia dai rifiuti<br />
Con il teleriscaldamento ASM è <strong>di</strong>ventata leader in Italia<br />
nella produzione <strong>di</strong> servizi energetici per la città. L’elevatissima<br />
efficienza con cui è in grado <strong>di</strong> utilizzare le fonti<br />
combustibili fossili garantiscono significativi guadagni all’azienda<br />
che li ribalta verso gli azionisti e in particolare<br />
sul Comune <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>, che li può reinvestire sulla città.<br />
L’esperienza fatta viene messa a <strong>di</strong>sposizione anche <strong>di</strong> altre<br />
città per l’attivazione <strong>di</strong> analoghi impianti.<br />
Nel frattempo le tecnologie evolvono e renderebbero possibile<br />
il passo successivo per la realizzazione della visione:<br />
produrre energia utilizzando i rifiuti.<br />
Il primo ostacolo, quello dell’inquinamento generato dalla<br />
combustione dei rifiuti, può essere aggirato con l’adozione<br />
dei filtri a maniche, un sistema <strong>di</strong> depurazione dei fumi con<br />
elevate efficienze <strong>di</strong> captazione delle polveri. Resta il problema<br />
della stabilità dei carichi. Un impianto come un inceneritore<br />
<strong>di</strong> rifiuti garantisce efficienza e soprattutto pulizia ambientale<br />
solo se lavora ad un regime ottimale costante. La<br />
<strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> utilizzo del calore tra estate e inverno da parte<br />
delle utenze domestiche non permette questo equilibrio.<br />
La soluzione all’equazione viene trovata ricercando nella<br />
città gran<strong>di</strong> utilizzatori <strong>di</strong> vapore e <strong>di</strong> calore. Queste utenze<br />
collegate alla rete del teleriscaldamento garantiscono<br />
una grande capacità <strong>di</strong> utilizzo <strong>di</strong> energia termica anche<br />
nei mesi estivi. Con un corretto <strong>di</strong>mensionamento del<br />
nuovo impianto sarà possibile utilizzare la vecchia centrale<br />
policombustibile solo nel corso dell’inverno per coprire<br />
la richiesta <strong>di</strong> calore per il riscaldamento. Il sogno dell’energia<br />
dei rifiuti può finalmente <strong>di</strong>ventare realtà.<br />
Varato alla fine degli anni ‘80, il progetto del Termoutilizzatore<br />
si avvale <strong>di</strong> una ulteriore innovazione progettuale:<br />
la turbina a spillamento (in cui l’utenza termica è servita<br />
da uno spillamento <strong>di</strong> vapore dalla turbina, che viene fatto<br />
condensare in un apposito scambiatore) al posto <strong>di</strong><br />
quella a contropressione (la turbina vede una pressione<br />
più elevata allo scarico rispetto al caso <strong>di</strong> produzione isolata<br />
<strong>di</strong> energia elettrica), sistema utilizzato nei gruppi policombustibile.<br />
L’idea del termoutilizzatore si concretizza<br />
nel 1998: da allora la ciminiera dell’inceneritore svetta alla<br />
periferia Sud della città, caratterizzando lo skyline citta<strong>di</strong>no<br />
con la sua inconfon<strong>di</strong>bile torre colore del cielo.
OLTRE L’ENTROPIA, QUANDO L’ENERGIA DIVENTA FORMA 21<br />
È inusuale il fatto che un architetto riven<strong>di</strong>chi un ruolo<br />
centrale nel <strong>di</strong>battito sull’energia: questa, infatti, sembra<br />
essere una prerogativa esclusiva <strong>di</strong> scienziati e ingegneri.<br />
Tuttavia, l’energia è l’elemento fondamentale nella trasformazione<br />
dello spazio sia dal punto <strong>di</strong> vista statico che<br />
da quello compositivo.<br />
Il laboratorio <strong>di</strong> Ricerca “Oltre l’Entropia, quando l’Energia<br />
<strong>di</strong>venta Forma” è un programma biennale commissionato<br />
dall’Architectural Association, School of Architecture <strong>di</strong><br />
Londra per lo sviluppo del tema dell’energia.<br />
Il laboratorio è proposto da un gruppo trasversale <strong>di</strong> do-<br />
Fig. 1<br />
Oltre l’Entropia,<br />
quando l’energia<br />
<strong>di</strong>venta forma<br />
Stefano Rabolli Pansera<br />
Architectural Association Laboratorio <strong>di</strong> Ricerca<br />
centi e ricercatori ed io ho il piacere e l’onore <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>narlo.<br />
Il programma è stato presentato ufficialmente a Venezia il 6<br />
<strong>giugno</strong> scorso in occasione dell’inaugurazione della Biennale<br />
<strong>di</strong> Arti Visive e costituisce uno dei progetti più ambiziosi<br />
commissionati dall’AA: infatti, si svilupperà sia a Londra<br />
che a Venezia e costituisce il prototipo <strong>di</strong> un nuovo tipo <strong>di</strong><br />
iniziativa culturale e accademica che coor<strong>di</strong>na <strong>di</strong>battiti, mostre<br />
ed iniziative in <strong>di</strong>verse località simultaneamente.<br />
Sebbene sia sviluppato all’interno dell’AA, il laboratorio<br />
si prefigge l’obiettivo <strong>di</strong> creare una collaborazione con<br />
➙
22 <strong>Brescia</strong> ricerche <strong>67</strong>/09<br />
Fig. 2<br />
altre università e istituzioni culturali europee e <strong>di</strong> dare<br />
la massima visibilità internazionale ad una <strong>di</strong>rezione <strong>di</strong><br />
ricerca che non sembra essere stata adeguatamente affrontata.<br />
Il tema deriva dall’urgenza con cui il concetto <strong>di</strong> Energia è<br />
stato <strong>di</strong>scusso recentemente in summit politici, in seminari<br />
<strong>di</strong> economia e in una serie innumerevole <strong>di</strong> ricerche scientifiche,<br />
ma raramente nei <strong>di</strong>battiti culturali e nella sperimentazione<br />
artistica.<br />
Soprattutto nell’ambito architettonico, quello energetico è<br />
stato spesso considerato un problema tecnico da affrontarsi<br />
con strumenti puramente scientifici o come un tema<br />
che si inserisce nell’ambito della cosiddetta “Architettura<br />
Verde” e pertanto riconducibile alla retorica dello “Sviluppo<br />
Sostenibile”.<br />
La <strong>di</strong>sciplina dell’architettura deve riappropriarsi del tema<br />
energetico e può contribuire a formulare una nuova base<br />
per la <strong>di</strong>scussione e per lo sviluppo <strong>di</strong> idee su questo tema<br />
cruciale.<br />
Questa ricerca offre l’opportunità <strong>di</strong> considerare l’energia<br />
come fattore culturale: invece <strong>di</strong> soffermarsi sulle implicazioni<br />
e sulle conseguenze che l’energia può avere sugli e<strong>di</strong>fici,<br />
l’ambizione è quella <strong>di</strong> ripensare il concetto stesso <strong>di</strong><br />
energia al <strong>di</strong> fuori <strong>di</strong> ogni forma <strong>di</strong> applicazione pratica convenzionale.<br />
È insita nella natura umana la necessità <strong>di</strong> dare forma e significato<br />
alla realtà circostante attraverso azioni e progetti:<br />
consumando energia, ci opponiamo continuamente all’entropia<br />
(il livello <strong>di</strong> <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ne sempre crescente nell’Universo)<br />
con la creazione <strong>di</strong> forme sempre nuove, momenti <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne<br />
isolati nel tempo e nello spazio.<br />
Come rivela il titolo stesso, l’Entropia e la Forma sono le fasi<br />
<strong>di</strong>alettiche entro le quali si sviluppa l’esperienza <strong>di</strong> questo<br />
laboratorio.<br />
Il rapporto con l’energia è cruciale anche per l’architettura:<br />
è necessario pensare alla forma non come ad una entità circoscritta,<br />
misurabile e compiuta ma come ad un momento<br />
ultimo <strong>di</strong> un sistema complesso <strong>di</strong> forze che rimangono visibili<br />
nell’evidenza stessa della forma.<br />
Il tentativo, <strong>di</strong>ffuso nella pratica architettonica contemporanea,<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>ssolvere la soli<strong>di</strong>tà della materia con la trasparenza,<br />
con un fascio <strong>di</strong> luce ed, in generale, con una materialità<br />
“debole” è in<strong>di</strong>cativo <strong>di</strong> una nuova sensibilità che mette in<br />
<strong>di</strong>scussione le forme convenzionali del rapporto fra soli<strong>di</strong>tà,<br />
massa ed energia: la composizione formale è come un momentaneo<br />
assestarsi <strong>di</strong> forze alrimenti invisibili.<br />
Gli e<strong>di</strong>fici stessi possono essere considerati come “energia<br />
potenziale bloccata nel tempo”, forze che sono conservate e<br />
latenti, e che possono rilasciare la propria energia potenziale<br />
in ogni momento, come descritto da Aldo Rossi all’inizio<br />
<strong>di</strong> “Autobiografia Scientifica”. Ecco <strong>di</strong> seguito il passo:<br />
“Max Planck era colpito dal fatto che il lavoro spesso non<br />
va perduto, rimane immagazzinato, per molti anni, mai<br />
<strong>di</strong>minuito, latente nel blocco <strong>di</strong> pietra, finché un giorno<br />
puó capitare che il blocco si stacchi e cada sulla testa <strong>di</strong> un<br />
passante uccidendolo.(...) In realtà in ogni artista o tecnico<br />
il principio della continuazione dell’energia si mescola con<br />
la ricerca della felicità e della morte. Anche in architettura<br />
questa ricerca è legata con il materiale e con l’energia.”<br />
Il laboratorio “Oltre l’Entropia, quando l’Energia <strong>di</strong>venta<br />
Forma” prende vita dalla collaborazione fra scienziati, architetti<br />
ed artisti per la costruzione <strong>di</strong> otto installazioni. Dopo<br />
avere definito otto forme <strong>di</strong> energia (nucleare, meccanica,<br />
potenziale, gravitazionale, termica, elettrica, sonora e<br />
magnetica) e otto gruppi <strong>di</strong> ricerca (ognuno dei quali formato<br />
da un architetto, un artista e uno scienziato), il lavoro<br />
è sviluppato in tre fasi:<br />
– interviste, presentazioni e articoli, fase che terminerà con<br />
una visita al Cern a Ginevra nel marzo 2010 in cui, per la<br />
prima volta, tutti i membri dei gruppi si incontreranno;<br />
Fig. 3<br />
➙
OLTRE L’ENTROPIA, QUANDO L’ENERGIA DIVENTA FORMA 23<br />
Fig. 4<br />
– <strong>di</strong>battiti e corrispondenze, che culmineranno con un simposio<br />
all’Architectural Association a Londra nel settembre<br />
2010;<br />
– la costruzione <strong>di</strong> otto installazioni a Venezia, che verranno<br />
presentate alla Biennale delle arti Visive e in un simposio<br />
internazionale nel <strong>giugno</strong> 2011.<br />
Una sperimentazione lunga un trentennio<br />
Alcuni esperimenti, sviluppati in passato, in<strong>di</strong>cano delle<br />
possibili linee <strong>di</strong> sviluppo e <strong>di</strong> sinergia fra queste <strong>di</strong>scipline<br />
e mostrano gli esiti possibili delle installazioni. Ve<strong>di</strong>amoli<br />
<strong>di</strong> seguito.<br />
The Lightning Field (1977) <strong>di</strong> Walter De Maria (Fig. 1)<br />
Questa installazione è costituita da quattrocento aste <strong>di</strong><br />
acciaio inossidabile lucido, installate in una griglia del<br />
lato <strong>di</strong> un miglio. Queste aste, dello spessore <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci<br />
centimetri e dell’altezza <strong>di</strong> sei metri e mezzo, sono <strong>di</strong>stanziate<br />
<strong>di</strong> sessantacinque metri le une dalle altre ed<br />
hanno punte acuminate. Durante le tempeste questo<br />
campo attira i fulmini.<br />
Chizhevsky Lesson (2007) <strong>di</strong> Micol Assael (Fig. 2)<br />
L’installazione è un prototipo <strong>di</strong> un generatore <strong>di</strong> energia in<br />
cui cavi e pannelli <strong>di</strong> rame sono sospesi nello spazio sopra i<br />
visitatori. Con questa <strong>di</strong>stribuzione, l’intera stanza è trasformata<br />
dal momento che le particelle sono caricate e <strong>di</strong>-<br />
ventano anioni creando deboli tensioni elettrosatiche nello<br />
spazio.<br />
Senza Titolo (1997-2001) <strong>di</strong> Massimo Bartolini (Fig. 3)<br />
L’artista ha collaborato con il fisico Leone Fronzoni per la<br />
creazione <strong>di</strong> questa opera che ricrea il solitone (un’onda solitaria<br />
che non <strong>di</strong>ssipa la propria energia ma la mantiene<br />
costante in<strong>di</strong>pendentemente dalla <strong>di</strong>stanza): un’onda perenne<br />
prodotta da pulsazioni calibrate e sintonizzate.<br />
Digestable Gulf Stream (2008) <strong>di</strong> Philippe Rahm (Fig. 4)<br />
Due piani orizzontali <strong>di</strong> metallo su <strong>di</strong>verse altezze. Il piano<br />
più basso è riscaldato ad una temperatura <strong>di</strong> 28 °C, mentre<br />
quello più basso è ad una temperatura <strong>di</strong> 12 °C. Come una<br />
corrente del Golfo in miniatura, la loro posizione crea un<br />
movimento <strong>di</strong> aria che usa la convezione per stimolare un<br />
flusso termico costante.<br />
L’aspetto affascinante <strong>di</strong> queste opere consiste nel fatto che<br />
la <strong>di</strong>stinzione fra arte e scienza si perde nella forza <strong>di</strong> un<br />
nuovo prodotto, che è una sorta <strong>di</strong> prototipo scientifico e<br />
artistico. Nello stesso modo, il successo <strong>di</strong> “Oltre l’Entropia,<br />
quando l’Energia <strong>di</strong>venta Forma” non <strong>di</strong>pende solo dall’originalità<br />
dei risultati formali ma dalla forza e dalla luci<strong>di</strong>tà<br />
con cui gli architetti (insieme ad artisti e scienziati) possono<br />
produrre nuovi orizzonti <strong>di</strong> senso e, forse, nuove “energie”.<br />
Per ulteriori informazioni e per partecipare agli eventi,<br />
contattare:<br />
stefano@rabollipansera.com
24 <strong>Brescia</strong> ricerche <strong>67</strong>/09<br />
La <strong>di</strong>gestione anaerobica è un processo biologico per<br />
mezzo del quale, in assenza <strong>di</strong> ossigeno, la sostanza organica<br />
presente viene trasformata principalmente in<br />
metano e anidride carbonica; questo gas è convenzionalmente<br />
denominato “gas biologico”, o più semplicemente<br />
“biogas”.<br />
La percentuale <strong>di</strong> metano nel biogas varia a seconda del<br />
tipo <strong>di</strong> sostanza organica <strong>di</strong>gerita e delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong><br />
processo, ed è generalmente compresa tra un minimo<br />
del 40% fino a circa il 70%.<br />
Le tecnologie <strong>di</strong> recupero energetico del biogas me<strong>di</strong>ante<br />
cogenerazione sono state inizialmente sviluppate nel<br />
settore delle <strong>di</strong>scariche controllate <strong>di</strong> rifiuti urbani, ambito<br />
in cui negli anni passati sono state accumulate numerose<br />
ed importanti esperienze soprattutto in impianti<br />
<strong>di</strong> taglia me<strong>di</strong>o-grande.<br />
Nella situazione attuale <strong>di</strong> continua ricerca <strong>di</strong> nuove fonti<br />
energetiche, il progresso tecnologico sta aprendo nuove<br />
prospettive nel settore della produzione <strong>di</strong> energia elettrica<br />
e termica da fonti rinnovabili, rendendo possibile l’ingresso<br />
nel mercato dei produttori anche a realtà che in<br />
precedenza avrebbero avuto limitate opportunità; un ulteriore<br />
e fondamentale fattore <strong>di</strong> sviluppo <strong>di</strong> tale settore sono<br />
le politiche <strong>di</strong> incentivazione economica che riconoscono<br />
un valore economico superiore rispetto all’energia prodotta<br />
con fonti non rinnovabili.<br />
Gli sviluppi più recenti della produzione e del recupero<br />
energetico <strong>di</strong> biogas sono sicuramente quelli che riguardano<br />
la <strong>di</strong>gestione anaerobica <strong>di</strong> reflui urbani, zootecnici,<br />
<strong>di</strong> scarti dell’industria alimentare, <strong>di</strong> biomasse in generale.<br />
Il biogas viene utilizzato per alimentare cogeneratori per<br />
la produzione combinata <strong>di</strong> energia termica, energia frigorifera<br />
ed energia elettrica. Sono in fase <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o alcune<br />
Recupero energetico<br />
e biogas: Progeco,<br />
ovvero il valore della<br />
filiera per l’efficienza<br />
delle rinnovabili<br />
Fabio Pelizzari<br />
applicazioni che rendono possibile e sicura l’immissione<br />
<strong>di</strong> biogas nelle reti <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione del gas metano.<br />
Un’esperienza modello<br />
Le aziende nate e cresciute in questo settore sono molte e<br />
nel bresciano il caso <strong>di</strong> Progeco si può definire emblematico.<br />
Nata nel 2000 come “spin-off” <strong>di</strong> Conveco - società<br />
del Gruppo Boldarino fortemente specializzata nella realizzazione<br />
<strong>di</strong> impianti per la captazione, l’estrazione e la<br />
combustione del biogas da <strong>di</strong>scarica - l’azienda ha mosso<br />
i primi passi nel settore delle applicazioni a <strong>di</strong>gestori<br />
anaerobici progettando e costruendo apparecchiature<br />
che, pur nella loro semplicità, rispettavano sia lo stato<br />
dell’arte sia le richieste del mercato.<br />
L’evoluzione del mercato e la continua richiesta <strong>di</strong> nuove<br />
apparecchiature finalizzate all’ottimizzazione e al miglioramento<br />
del ciclo <strong>di</strong> gestione del biogas hanno portato<br />
Progeco a porsi come obiettivo l’acquisizione <strong>di</strong> una posizione<br />
leader in una nicchia <strong>di</strong> mercato ove la specializzazione<br />
e la capacità <strong>di</strong> affrontare problematiche operative<br />
strettamente legate alle singole installazioni e all’esperienza<br />
acquisita, più che a stu<strong>di</strong> teorici <strong>di</strong> valore generale,<br />
giocano un ruolo vincente.<br />
Dai primi filtri a ghiaia e dalle prime torce <strong>di</strong> combustione<br />
biogas <strong>di</strong> tipo “open flare” si è passati successivamente alla<br />
realizzazione <strong>di</strong> speciali <strong>di</strong>spositivi per la raccolta e lo<br />
scarico <strong>di</strong> schiume e condense, a filtri a candele ceramiche,<br />
a torce caratterizzate da migliori prestazioni in termini<br />
<strong>di</strong> efficienza <strong>di</strong> combustione e <strong>di</strong> riduzione <strong>di</strong> emissioni.<br />
Un ulteriore e più recente sviluppo si è avuto nel settore<br />
del trattamento “spinto” del biogas generato in impianti<br />
➙
RECUPERO ENERGETICO E BIOGAS: PROGECO, OVVERO IL VALORE DELLA FILIERA PER L’EFFICIENZA DELLE RINNOVABILI 25<br />
a biomasse <strong>di</strong> grossa taglia appositamente realizzati per<br />
la produzione <strong>di</strong> energia.<br />
“Il problema che affligge in modo significativo tutte le applicazioni<br />
- spiega il <strong>di</strong>rettore generale <strong>di</strong> Progeco, l’ing.<br />
Amedeo Gorlani - è la corrosione, che ha effetti devastanti<br />
sui motori alimentati a biogas. Valvole, cilindri, pistoni,<br />
collettori, tutte le parti a contatto con il biogas richiedono<br />
infatti una manutenzione estremamente accurata. In assenza<br />
<strong>di</strong> un adeguato pre-trattamento del biogas, nella<br />
grande maggioranza dei casi è necessario sostenere elevati<br />
extra-costi <strong>di</strong> manutenzione dopo poche migliaia <strong>di</strong> ore <strong>di</strong><br />
esercizio, proprio a causa del rapido deterioramento dei<br />
motori. Questi interventi comportano inoltre frequenti e<br />
prolungate situazioni <strong>di</strong> fermo-impianto, con conseguenti<br />
ripercussioni sulla red<strong>di</strong>tività dell’investimento. I maggiori<br />
costi <strong>di</strong> gestione e l’accorciamento della vita utile dell’impianto<br />
giustificano ampiamente la scelta <strong>di</strong> effettuare<br />
anche un investimento iniziale de<strong>di</strong>cato ad una sezione<br />
impiantistica finalizzata al trattamento del biogas prima<br />
dell’alimentazione ai gruppi <strong>di</strong> recupero energetico”.<br />
Progeco ha quin<strong>di</strong> puntato sullo sviluppo <strong>di</strong> tecnologie<br />
per il trattamento del biogas per rispondere ad esigenze<br />
che, pur essendo in linea <strong>di</strong> principio abbastanza generali<br />
per quanto riguarda la problematica da risolvere, sono in<br />
realtà contrad<strong>di</strong>stinte dalla necessità <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare un’adeguata<br />
soluzione per ogni applicazione.<br />
“Mentre una volta - prosegue Gorlani - il mercato chiedeva<br />
essenzialmente la <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> componenti standard,<br />
oggi ci troviamo in una situazione <strong>di</strong>ametralmente<br />
opposta: ogni sistema <strong>di</strong> pre-trattamento biogas deve essere<br />
valutato e <strong>di</strong>mensionato in funzione della portata e<br />
delle caratteristiche specifiche del biogas <strong>di</strong>sponibile. La<br />
figura del semplice fornitore è <strong>di</strong> fatto superata, poiché la<br />
realizzazione ottimale <strong>di</strong> un impianto non può prescindere<br />
dal valore aggiunto dato da un approccio ingegneristico<br />
al problema, oltre che dalla competenza, dall’esperienza e<br />
dalla specializzazione. Progeco sta concentrando i propri<br />
sforzi nella progettazione e realizzazione <strong>di</strong> sistemi per il<br />
trattamento <strong>di</strong> biogas composti da più moduli, ognuno dei<br />
quali svolge un particolare compito all’interno della catena<br />
che consentirà <strong>di</strong> portare un biogas adeguatamente pulito<br />
all’alimentazione dei gruppi <strong>di</strong> cogenerazione. Oltre a<br />
componenti ed apparecchiature che oggi possiamo definire<br />
come tra<strong>di</strong>zionali, l’azienda si è specializzata nella realizzazione<br />
<strong>di</strong> sistemi per la rimozione <strong>di</strong> condense e <strong>di</strong><br />
deumi<strong>di</strong>ficazione biogas ed è particolarmente attiva nel<br />
settore delle torri <strong>di</strong> lavaggio gas (o “scrubber”) per l’abbattimento<br />
dell’idrogeno solforato, così come nelle sezioni<br />
finali <strong>di</strong> filtrazione con particolari carboni attivi, che per<br />
così <strong>di</strong>re completano l’opera <strong>di</strong> quanto fatto a monte <strong>di</strong> essi.<br />
Il tutto ovviamente abbinato a sistemi <strong>di</strong> analisi in continuo<br />
della qualità del biogas, per avere sempre sotto controllo<br />
l’efficienza e l’efficacia del processo. La produzione<br />
<strong>di</strong> biogas oggi non può prescindere dall’ottenimento <strong>di</strong> un<br />
gas finale con caratteristiche adeguate per lo scopo per il<br />
quale è stato generato”.<br />
La configurazione <strong>di</strong> un impianto completo è costituita<br />
da una serie <strong>di</strong> sezioni impiantistiche ognuna delle quali<br />
preposta allo svolgimento <strong>di</strong> un compito specifico. A una<br />
prima sezione <strong>di</strong> filtrazione grossolana ne segue una <strong>di</strong><br />
filtrazione fine, entrambe con lo scopo <strong>di</strong> trattenere le<br />
impurità più macroscopiche presenti nel biogas; successivamente,<br />
il biogas viene inviato in uno scrubber, ovvero<br />
una unità <strong>di</strong> lavaggio in controcorrente dove, utilizzando<br />
appositi prodotti chimici adeguatamente dosati e <strong>di</strong>luiti<br />
in acqua, si ottiene la rimozione della maggior parte dell’idrogeno<br />
solforato presente, oltre che <strong>di</strong> altri contaminanti.<br />
Il biogas viene quin<strong>di</strong> raffreddato ad una temperatura<br />
<strong>di</strong> circa 2-4 °C per rimuovere quanta più umi<strong>di</strong>tà<br />
possibile, che sottoforma <strong>di</strong> condensato viene raccolta e<br />
scaricata da uno speciale filtro a ciclone. A questo punto<br />
il biogas, adeguatamente depurato e <strong>di</strong>sidratato, è pronto<br />
per l’alimentazione ai cogeneratori. Nei casi in cui si voglia<br />
procedere ad una depurazione più spinta, a valle <strong>di</strong><br />
quanto precedentemente descritto è installata una batteria<br />
<strong>di</strong> filtri a carboni attivi con specifiche caratteristiche,<br />
a seconda dei contaminanti da abbattere.<br />
Alcune applicazioni <strong>di</strong> successo sono state recentemente<br />
messe in esercizio nel settore dell’industria alimentare ed<br />
in particolare in <strong>di</strong>stillerie, dove è <strong>di</strong> notevole interesse la<br />
possibilità <strong>di</strong> produrre energia elettrica con il biogas generato<br />
nei <strong>di</strong>gestori anaerobici che fanno parte dell’impianto<br />
<strong>di</strong> trattamento acque.<br />
Nei casi specifici, un notevole sforzo si è reso necessario<br />
per ottenere risultati sod<strong>di</strong>sfacenti anche in presenza <strong>di</strong><br />
sostanze che, in determinate con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> concentrazione<br />
e temperatura, potevano dar luogo a un effetto <strong>di</strong> inibizione<br />
al completamento del processo <strong>di</strong> rimozione dell’idrogeno<br />
solforato. Le soluzioni impiantistiche e <strong>di</strong> processo<br />
sviluppate sono in ampia misura trasferibili ad analoghi<br />
casi, ferma restando la necessità <strong>di</strong> una personalizzazione<br />
mirata alle specificità <strong>di</strong> ogni singola installazione.<br />
A fronte dell’esistenza <strong>di</strong> molti tipi <strong>di</strong> biogas, ognuno con<br />
le proprie caratteristiche, l’obiettivo finale <strong>di</strong> trattamento<br />
può essere raggiunto solo percorrendo strade <strong>di</strong>fferenti la<br />
cui scelta molto spesso è effettuata non esclusivamente a<br />
tavolino, ma anche e soprattutto in base ad esperienze<br />
acquisite.
26 <strong>Brescia</strong> ricerche <strong>67</strong>/09<br />
Dall’avvento della rivoluzione industriale si assiste ad un<br />
costante aumento ed alla <strong>di</strong>fferenziazione dei bisogni da<br />
sod<strong>di</strong>sfare, il che ha dato luogo a <strong>di</strong>verse necessità <strong>di</strong> consumo<br />
con un crescente utilizzo <strong>di</strong> energia nelle sue varie<br />
forme. Negli ultimi decenni, però, l’umanità si è resa progressivamente<br />
consapevole <strong>di</strong> quanto sia in<strong>di</strong>spensabile<br />
contenere i consumi. La prima definizione in or<strong>di</strong>ne temporale<br />
<strong>di</strong> sviluppo sostenibile è stata quella contenuta nel<br />
cosiddetto “rapporto Brundtland” (dal nome della presidente<br />
della Commissione, la norvegese Gro Harlem<br />
Brundtland) del 1987 e poi ripresa dalla Conferenza mon<strong>di</strong>ale<br />
sull’ambiente e lo sviluppo dell’ONU (World Commission<br />
on Environment and Development, WCED): “lo<br />
sviluppo sostenibile è uno sviluppo che sod<strong>di</strong>sfa i bisogni<br />
del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni<br />
future <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfare i propri”. Tale definizione<br />
poco si <strong>di</strong>scosta dall’antico motto secondo il quale “non<br />
ere<strong>di</strong>tiamo il mondo dai nostri padri, ma lo pren<strong>di</strong>amo in<br />
prestito dai nostri figli”, tuttavia il consistente progresso<br />
tecnologico e scientifico ha imposto - ed impone - un’adeguata<br />
<strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> energia senza la quale esso stesso si<br />
arresterebbe, con conseguenze impreve<strong>di</strong>bili per l’intera<br />
umanità. Infatti, l’impatto delle attività antropiche sul nostro<br />
pianeta è ben rappresentato dalla cosiddetta Identità<br />
<strong>di</strong> Kaya 1 , che scompone nelle <strong>di</strong>verse componenti i contributi<br />
alle emissioni con la formula sotto riportata:<br />
Figura 1: identità <strong>di</strong> Kaya<br />
Au<strong>di</strong>t energetico:<br />
il primo passo verso<br />
l’efficienza energetica<br />
Vittorio Bellicini, Simone Zanoni, Lucio Zavanella<br />
Dipartimento <strong>di</strong> Ingegneria Meccanica e Industriale Università<br />
degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong><br />
Pur alla luce del recente <strong>di</strong>battito sull’efficacia dell’in<strong>di</strong>catore<br />
economico rappresentato dal PIL (Prodotto Interno Lordo),<br />
è in<strong>di</strong>scutibilmente con<strong>di</strong>visibile il fondamento logico<br />
dell’equazione proposta: le emissioni antropiche sono date<br />
dal prodotto <strong>di</strong> quattro fattori (la popolazione, il PIL pro capite,<br />
l’emissioni per unità <strong>di</strong> energia prodotta ed il consumo<br />
energetico per unità <strong>di</strong> PIL). Nella figura 2 è riportato l’andamento<br />
delle <strong>di</strong>verse componenti dell’identità <strong>di</strong> Kaya dal<br />
1990 (riferimento = 100) a livello mon<strong>di</strong>ale.<br />
Come si può evincere, le emissioni antropiche sono in decisa<br />
crescita, il che causa un’insostenibilità dell’attuale organizzazione,<br />
che mette in deciso dubbio il futuro. Si ritiene<br />
sia quin<strong>di</strong> necessario, e non procrastinabile, intervenire<br />
sulle <strong>di</strong>verse componenti dell’identità in modo da poter garantire<br />
il futuro ed un’equilibrata prospettiva <strong>di</strong> crescita.<br />
Dal momento che è eticamente scorretto pensare <strong>di</strong> ridurre<br />
le emissioni antropiche attraverso il controllo delle nascite<br />
e che in ogni nazione è auspicabile l’aumento della<br />
ricchezza pro capite, risulta evidente che i primi due termini<br />
dell’equazione sono in qualche modo esclusi dalle leve<br />
utilizzabili ai fini delle riduzioni delle emissioni. Gli unici<br />
interventi possibili sono quin<strong>di</strong> quelli pianificabili sulle ultime<br />
due componenti della formula dell’identità: in particolare,<br />
per intervenire sulla penultima componente è necessario<br />
ricorrere a centrali <strong>di</strong> produzione più efficienti o<br />
aumentare il ricorso alla produzione <strong>di</strong> energia da fonti<br />
1 Yoichi Kaya (1993) Environment, Energy, and Economy: strategies for sustainability<br />
➙
AUDIT ENERGETICO: IL PRIMO PASSO VERSO L’EFFICIENZA ENERGETICA 27<br />
Figura 2: andamento delle componenti dell’identità <strong>di</strong> Kaya (fonte: stu<strong>di</strong> economici ed energetici eNi)<br />
Figura 3: consumi totali <strong>di</strong> energia ed energia elettrica in italia<br />
(fonte: elaborazione dati del Bilancio energetico Nazionale)<br />
energetiche rinnovabili. Per intervenire<br />
sull’ultima componente dell’identità <strong>di</strong><br />
Kaya è necessario aumentare l’efficienza<br />
energetica nei processi <strong>di</strong> creazione del<br />
red<strong>di</strong>to (in primis i processi produttivi).<br />
La razionalizzazione dei consumi costituisce<br />
quin<strong>di</strong> non solo una potenziale e<br />
formidabile fonte <strong>di</strong> riduzione dei costi,<br />
ma anche un obbligo morale, un impegno<br />
etico verso il quale bisognerebbe<br />
profondere ogni sforzo possibile. Il risparmio<br />
energetico è quin<strong>di</strong> una ‘pratica’<br />
necessaria ed imprescin<strong>di</strong>bile, dal<br />
momento che la richiesta <strong>di</strong> energia nel<br />
nostro Paese e nel mondo sta aumentando<br />
in modo pressoché costante: ad<br />
esempio, il consumo <strong>di</strong> energia totale e<br />
<strong>di</strong> energia elettrica in Italia sono aumentati<br />
rispettivamente del 5% e del<br />
13% negli ultimi 8 anni (fonte: elaborazione<br />
dati del Bilancio Energetico Nazionale).<br />
Il Piano 20-20-20<br />
Da segnalare in tale ambito il cosiddetto<br />
piano 20-20-20 che, dopo <strong>di</strong>versi<br />
mesi <strong>di</strong> lavoro legislativo, il Parlamento<br />
ha approvato a <strong>di</strong>cembre 2008. Tale<br />
pacchetto ‘clima-energia’ intende definire<br />
le modalità per il conseguimento<br />
dei target che l’UE si è fissata per il<br />
2020: ridurre del 20% le emissioni <strong>di</strong><br />
gas a effetto serra, portare al 20% il ri-<br />
➙
28 <strong>Brescia</strong> ricerche <strong>67</strong>/09<br />
sparmio energetico ed aumentare al 20% la produzione <strong>di</strong><br />
energia primaria da fonti rinnovabili. Da un punto <strong>di</strong> vista<br />
strettamente economico si tratta <strong>di</strong> un risparmio - al 2020<br />
e per l’intera UE - <strong>di</strong> circa 100 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> euro l’anno. La<br />
Direttiva 2006/32/CE, relativa alla promozione dell’uso<br />
efficiente dell’energia negli impieghi finali, ha stabilito per<br />
gli Stati membri un obiettivo nazionale in<strong>di</strong>cativo <strong>di</strong> risparmio<br />
energetico per il 2016 del 9%, da conseguire tramite<br />
servizi energetici ed altre misure <strong>di</strong> miglioramento<br />
dell’efficienza energetica. A questo scopo ogni Stato si è<br />
dotato <strong>di</strong> un Piano Nazionale <strong>di</strong> Azione per l’Efficienza<br />
Energetica.<br />
Nel Piano d’Azione presentato dall’Italia sono illustrati gli<br />
interventi proposti per raggiungere il target che, nel nostro<br />
caso, è stato fissato ad un livello ad<strong>di</strong>rittura superiore (9,6%<br />
<strong>di</strong> risparmio energetico nel 2016) a quello stabilito dalla<br />
Commissione. Vale la pena osservare come anche il nostro<br />
Piano Nazionale per l’efficienza energetica si attenda il<br />
maggior contributo dal settore civile. Dei 126 TWh che rappresentano<br />
il risparmio energetico annuo atteso per il 2016,<br />
57 TWh (pari a circa il 45% del totale) riguardano il settore<br />
residenziale, mentre altri 25 TWh (20%) attengono al terziario,<br />
21 TWh (17%) al settore industriale e 23 TWh (18%)<br />
al settore dei trasporti. La necessità <strong>di</strong> rispondere adeguatamente<br />
alla sfida degli ultimi anni deve innescare una crescente<br />
e ra<strong>di</strong>cata attenzione per il tema dell’efficienza energetica<br />
dei processi e dei sistemi. Infatti, l’efficienza energetica:<br />
• stabilizza o <strong>di</strong>minuisce la <strong>di</strong>pendenza dall’estero;<br />
• contribuisce alla riduzione dell’inquinamento;<br />
• consente <strong>di</strong> evitare la costruzione <strong>di</strong> nuove centrali e reti<br />
<strong>di</strong> trasporto e <strong>di</strong>stribuzione;<br />
• contribuisce alla creazione <strong>di</strong> nuovi posti <strong>di</strong> lavoro e<br />
nuove attività, coinvolgendo le aziende italiane che operano<br />
nel settore;<br />
• fa risparmiare denaro;<br />
• consente <strong>di</strong> ottenere benefici in termini <strong>di</strong> immagine;<br />
• promuove uno sfruttamento sostenibile delle risorse ed il<br />
ra<strong>di</strong>carsi della cultura positiva associata a tale approccio.<br />
Efficienza energetica<br />
In un contesto mon<strong>di</strong>ale sempre più esigente sotto il profilo<br />
dei consumi energetici (energivoro), è <strong>di</strong> fondamentale<br />
importanza non solo trovare i mo<strong>di</strong> più efficienti <strong>di</strong> produzione<br />
<strong>di</strong> energia, ma anche <strong>di</strong> consumare il meno possibile,<br />
il tutto in un’ottica eco-sostenibile. Le logiche <strong>di</strong> risparmio<br />
energetico vanno oggi <strong>di</strong> pari passo con le ricerche<br />
<strong>di</strong> innovazioni per incrementare l’efficienza <strong>di</strong> produzione<br />
energetica. Ad oggi la razionalizzazione dei consumi<br />
rappresenta un’opportunità concreta <strong>di</strong> riduzione dei costi,<br />
che permette alle aziende <strong>di</strong> raggiungere un vantaggio<br />
competitivo e continuativo. Inoltre, il concetto <strong>di</strong> risparmio<br />
<strong>di</strong> risorse va <strong>di</strong> pari passo con quello <strong>di</strong> sostenibilità e<br />
quando si parla <strong>di</strong> risparmio <strong>di</strong> energia inevitabilmente si<br />
fa riferimento all’impatto ambientale. Ricorrendo nuovamente<br />
ad una formula <strong>di</strong> sintesi, è possibile esprimere il<br />
concetto <strong>di</strong> efficienza energetica scomponendo il costo<br />
dell’energia nelle due componenti principali:<br />
Costo energia (€/anno) = consumi (MWh/anno) * costo<br />
unitario (€/MWh)<br />
Per ridurre l’impatto economico del costo energetico si ha<br />
la possibilità <strong>di</strong> agire su due fattori:<br />
• ottimizzazione dei consumi (‘efficienza energetica operativa’);<br />
• riduzione dei costi unitari (‘efficienza energetica amministrativa’).<br />
Le leve <strong>di</strong> azione possono essere <strong>di</strong>verse: per ridurre i<br />
consumi si possono ottimizzare apparecchiature, sistemi e<br />
processi; per ridurre i costi unitari si effettueranno analisi<br />
dei profili <strong>di</strong> consumo (analisi temporale <strong>di</strong> carichi) per<br />
l’ottimizzazione dei contratti <strong>di</strong> fornitura.<br />
L’au<strong>di</strong>t energetico<br />
Prima <strong>di</strong> iniziare a pensare a come ridurre i costi dell’energia<br />
bisogna iniziare a capire dove, quando, perchè e<br />
quanta energia si usa. È questo che ci permette <strong>di</strong> gettare<br />
le basi del miglioramento.<br />
DOVE - I principali centri <strong>di</strong> consumo <strong>di</strong> energia sono i<br />
motori, il riscaldamento, i con<strong>di</strong>zionatori, i sistemi <strong>di</strong> illuminazione:<br />
un semplice sistema <strong>di</strong> mappatura energetica<br />
ci può supportare nell’identificazione dei costi dell’energia<br />
<strong>di</strong> ogni singola utenza.<br />
QUANDO - Un grafico che mostra il consumo energetico<br />
aiuta a capire quali sono i perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> picco e quali no,<br />
quin<strong>di</strong> dove il consumo si concentra maggiormente.<br />
PERCHÈ - Idealmente l’energia consumata serve a produrre<br />
prodotti buoni, quin<strong>di</strong> una misura interessante da<br />
verificare è la quantità <strong>di</strong> energia necessaria per processare<br />
solo prodotti buoni (SEC= specific energy consumption).<br />
L’importanza dell’au<strong>di</strong>t energetico<br />
Un’azione efficace volta a ridurre in modo sensibile il consumo<br />
energetico non è realizzabile senza aver preventivamente<br />
in<strong>di</strong>viduato i fattori <strong>di</strong> spreco, al fine <strong>di</strong> controllarli<br />
in futuro. Lo strumento principale per conoscere e quin<strong>di</strong><br />
intervenire efficacemente sulla situazione energetica è<br />
➙
AUDIT ENERGETICO: IL PRIMO PASSO VERSO L’EFFICIENZA ENERGETICA 29<br />
l’Au<strong>di</strong>t Energetico (AE): si tratta <strong>di</strong> un’analisi approfon<strong>di</strong>ta<br />
della situazione esistente attraverso una raccolta dati<br />
tramite check list e sopralluoghi. Per implementare au<strong>di</strong>t<br />
energetici che apportino una concreta e rilevante razionalizzazione<br />
dei consumi energetici delle imprese è necessario<br />
un continuo aggiornamento sulle ‘best available technologies’<br />
(BAT) 2 <strong>di</strong>sponibili sul mercato per le <strong>di</strong>verse<br />
aree <strong>di</strong> intervento. Il monitoraggio coinvolge tutti i consumi<br />
energetici (elettricità, metano, acqua, riscaldamento,<br />
con<strong>di</strong>zionamento) sia come quantità globale, sia come andamento<br />
nel tempo (giornaliero, settimanale, stagionale,<br />
annuale). Sono sottoposte a verifica anche tutte le apparecchiature<br />
che consumano energia (le macchine produttive,<br />
i sistemi <strong>di</strong> riscaldamento e con<strong>di</strong>zionamento, l’illuminazione,<br />
etc.) e si valutano le prestazioni ‘termiche’ dell’e<strong>di</strong>ficio<br />
per in<strong>di</strong>viduare eventuali ponti termici e superfici<br />
<strong>di</strong>sperdenti. Vale la pena sottolineare il ruolo strategico<br />
ricoperto, nell’analisi della dotazione dell’unità produttiva,<br />
dallo stu<strong>di</strong>o delle dotazioni <strong>di</strong> impianto ‘trasversali’ rispetto<br />
alle varie funzioni produttive, altrimenti noti come<br />
servizi <strong>di</strong> impianto. Una volta raccolti i dati <strong>di</strong> consumo, i<br />
costi energetici ed i dati sulle utenze elettriche, termiche,<br />
frigorifere, acqua (potenza, fabbisogno/consumo orario,<br />
fattore <strong>di</strong> utilizzo, ore <strong>di</strong> lavoro) si procede alla ricostruzione<br />
dei modelli energetici. Da tali modelli sarà possibile<br />
ricavare la ripartizione delle potenze e dei consumi per tipo<br />
<strong>di</strong> utilizzo (illuminazione, con<strong>di</strong>zionamento, freddo per<br />
processo e per con<strong>di</strong>zionamento, aria compressa, altri servizi,<br />
aree <strong>di</strong> processo, etc.), per centro <strong>di</strong> costo, per cabina<br />
elettrica e per reparto, per fascia oraria e stagionale. La situazione<br />
energetica così inquadrata viene analizzata e criticamente<br />
confrontata con parametri me<strong>di</strong> <strong>di</strong> consumo<br />
per in<strong>di</strong>viduare eventuali interventi migliorativi per la riduzione<br />
dei consumi e dei costi. Per ciascuna potenziale<br />
area <strong>di</strong> intervento vengono definiti degli in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> performance<br />
che permettono <strong>di</strong> confrontare la situazione esistente<br />
con le migliori alternative presenti sul mercato e<br />
con altre realtà <strong>di</strong> riferimento. Successivamente viene effettuata<br />
la valutazione tecnico-finanziaria degli interventi<br />
migliorativi in<strong>di</strong>viduati con dettaglio dei risparmi conseguibili<br />
e dei tempi <strong>di</strong> ritorno degli investimenti.<br />
L’AE, quin<strong>di</strong>, costituisce la fase preliminare che precede<br />
l’avvio <strong>di</strong> un qualsiasi progetto <strong>di</strong> Efficienza Energetica: in<br />
base ad esso è possibile stabilire in anticipo se un intervento<br />
possa risultare fattibile e conveniente, sia dal punto vista<br />
tecnico che economico. Vale la pena sottolineare il fatto che<br />
il confronto con le tecnologie <strong>di</strong>sponibili richiede un continuo<br />
aggiornamento, sia sotto il profilo tecnico che econo-<br />
mico, ed una osservazione dei processi produttivi mirata<br />
anche ad identificare possibili sinergie tra fasi produttive<br />
e/o reparti, nonché le opportunità connesse con la valorizzazione<br />
dei cosiddetti ‘cascami energetici’. Anche in assenza<br />
<strong>di</strong> sprechi energetici dovuti ad un utilizzo irrazionale dell’energia<br />
e degli impianti, con l’AE si valutano quali eventuali<br />
consumi possono essere migliorati. I beneficiari a cui è de<strong>di</strong>cata<br />
questa metodologia sono essenzialmente aziende<br />
manifatturiere e società <strong>di</strong> servizi, ma lo strumento dell’Au<strong>di</strong>t<br />
Energetico può essere applicato anche in ambito civile. I<br />
principali passi dello schema <strong>di</strong> au<strong>di</strong>ting energetico proposto<br />
possono essere riassunti nei seguenti 5 passi:<br />
1. Una prima definizione del bilancio energetico aziendale<br />
2. Una corretta allocazione dei costi energetici e responsabilizzazione<br />
dei singoli centri <strong>di</strong> consumo<br />
3. Verifica dell’efficienza <strong>di</strong> apparecchiature, sistemi e<br />
processi in relazione alle BAT<br />
4. In<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> sprechi e <strong>di</strong> possibili aree <strong>di</strong> miglioramento<br />
5. Proposta <strong>di</strong> interventi correttivi e determinazione delle<br />
priorità tra gli stessi<br />
Approccio Life Cycle Cost<br />
L’approccio seguito nelle valutazioni della convenienza tecnico-economica<br />
<strong>di</strong> esecuzione <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> ‘energy saving’<br />
avviene me<strong>di</strong>ante un approccio cosiddetto ‘Life Cycle<br />
Cost’. Si considerano non solo le componenti <strong>di</strong> costo legate<br />
all’investimento nell’apparecchio/macchinario, ma anche<br />
le componenti che si manifestano lungo tutto il periodo<br />
<strong>di</strong> utilizzo dello stesso, quali: costi <strong>di</strong> manutenzione e<br />
costi dell’energia assorbita. Nella maggior parte dei casi<br />
capita infatti che i costi <strong>di</strong> investimento siano nettamente<br />
inferiori rispetto a quelli <strong>di</strong> esercizio. Per illustrare efficacemente<br />
questo concetto basta considerare che il costo totale<br />
(acquisto, manutenzione e consumi) legato al ciclo <strong>di</strong><br />
vita <strong>di</strong> un motore elettrico (tipicamente superiore a 10 anni),<br />
è composto per il 98% dal costo dei consumi <strong>di</strong> energia<br />
elettrica, mentre solo il 2% è dato dal costo iniziale (acquisto<br />
ed installazione) e dalla manutenzione. L’impiego <strong>di</strong><br />
motori moderni ad alto ren<strong>di</strong>mento - od un loro più efficiente<br />
utilizzo - consente <strong>di</strong> ottenere in tempi brevi rilevanti<br />
benefici economici, grazie ai risparmi sulle bollette energetiche.<br />
È evidente che, alla luce <strong>di</strong> queste considerazioni,<br />
è necessario prestare particolare attenzione al ren<strong>di</strong>mento<br />
del motore piuttosto che concentrarsi prevalentemente<br />
2 Con il termine BAT = “Best Available Technologies” si fa riferimento alla più efficiente ed avanzata tecnologia, industrialmente <strong>di</strong>sponibile ed applicabile in con<strong>di</strong>zioni<br />
tecnicamente valide, in grado <strong>di</strong> garantire un elevato livello <strong>di</strong> protezione dell’ambiente nel suo complesso. L’UE è attiva nella preparazione <strong>di</strong> documenti che descrivono<br />
lo stato dell’arte nei vari settori industriali e i relativi standard ambientali collegati alle migliori tecniche <strong>di</strong>sponibili BAT (Best Available Technologies) con la pubblicazione<br />
<strong>di</strong> documenti <strong>di</strong> riferimento BREF (Best Reference).<br />
➙
30 <strong>Brescia</strong> ricerche <strong>67</strong>/09<br />
Figura 4: aree <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>mento relativo alla potenza delle 3 classi <strong>di</strong><br />
motori elettrici<br />
sull’incidenza dei costi d’acquisto o <strong>di</strong> sostituzione del parco<br />
esistente. In Europa esiste un accordo volontario (CE-<br />
MEP) tra i più importanti produttori <strong>di</strong> motori in base al<br />
quale è stata definita una classificazione in tre <strong>di</strong>verse classi<br />
<strong>di</strong> efficienza: EFF1, EFF2, EFF3. I motori EFF1 sono<br />
quelli a più alto ren<strong>di</strong>mento e rappresentano, insieme ai<br />
convertitori <strong>di</strong> frequenza, un’importante soluzione per ridurre<br />
considerevolmente i consumi <strong>di</strong> energia rispetto alle<br />
soluzioni tra<strong>di</strong>zionali (considerando l’elevato impatto,<br />
maggiore del 75%, dei consumi dei motori elettrici sui consumi<br />
complessivi <strong>di</strong> energia nel settore industriale).<br />
Figura 5: ren<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> un motore al variare del fattore <strong>di</strong> carico<br />
Altro aspetto da ricordare, sempre nell’ambito dei motori<br />
elettrici, è la relazione tra il fattore <strong>di</strong> carico (rapporto<br />
tra potenza assorbita e potenza nominale) ed il<br />
ren<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> un motore elettrico. Come si evince anche<br />
dalla figura sotto riportata, la massima efficienza <strong>di</strong><br />
un motore si ha per potenze superiori all’80% <strong>di</strong> quella<br />
nominale; questo significa che motori sovra<strong>di</strong>mensionati<br />
comportano notevoli per<strong>di</strong>te a causa <strong>di</strong> ridotti valori<br />
<strong>di</strong> ren<strong>di</strong>mento.<br />
La struttura<br />
Lo schema <strong>di</strong> au<strong>di</strong>ting proposto consiste in una struttura<br />
<strong>di</strong>namica, così come illustrato nella figura 6. L’in<strong>di</strong>viduazione<br />
<strong>di</strong> inefficienze e la lista dei potenziali interventi<br />
<strong>di</strong> ‘energy saving’ sono basate sui dati contenuti in un<br />
database (DB1) che è il frutto della fusione <strong>di</strong> tre database:<br />
• il database delle BAT (DB2);<br />
• il database con i dati <strong>di</strong> consumo e <strong>di</strong> efficienza specifica<br />
relativi ai <strong>di</strong>versi settori industriali (DB3);<br />
• il database con i risultati dei precedenti au<strong>di</strong>ts (DB4).<br />
Figura 6: struttura <strong>di</strong>namica dell’au<strong>di</strong>t energetico<br />
Gli interventi<br />
Il confronto tra le tecnologie attualmente in uso dalla<br />
realtà oggetto dell’au<strong>di</strong>t energetico e le migliori <strong>di</strong>sponibili<br />
sul mercato consente <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare le maggiori inefficienze<br />
per ciascuna delle aree <strong>di</strong> analisi. Successivamente<br />
la valutazione <strong>di</strong> tali inefficienze in relazione alle BAT<br />
consente <strong>di</strong> definire delle proposte <strong>di</strong> intervento la cui<br />
priorità <strong>di</strong>pende da due fattori:<br />
➙
AUDIT ENERGETICO: IL PRIMO PASSO VERSO L’EFFICIENZA ENERGETICA 31<br />
• rilevanza dei consumi della specifica area <strong>di</strong> analisi rispetto<br />
ai consumi complessivi;<br />
• gap tra la tecnologia in uso e la migliore <strong>di</strong>sponibile sul<br />
mercato.<br />
Nella maggior parte dei casi, in ambito industriale, i risparmi<br />
più significativi si possono ottenere intervenendo<br />
sui sistemi motori, utilizzando apparecchi più efficienti o<br />
attraverso una regolazione più razionale che prevede l’utilizzo<br />
<strong>di</strong> inverter in sostituzione <strong>di</strong> sistemi tra<strong>di</strong>zionali <strong>di</strong><br />
tipo <strong>di</strong>ssipativo. In alcuni settori industriali che richiedono<br />
un apporto continuativo e rilevante <strong>di</strong> energia termica<br />
e/o frigorifera una soluzione che consente un elevato risparmio<br />
<strong>di</strong> energia primaria, oltre che una riduzione dei<br />
costi energetici, è rappresentata dalla cogenerazione/trigenerazione<br />
ad alto ren<strong>di</strong>mento. La produzione combinata<br />
<strong>di</strong> energia elettrica e calore/freddo autoconsumati in<br />
loco risultano sia energeticamente che economicamente<br />
convenienti rispetto alle forme <strong>di</strong> approvvigionamento<br />
tra<strong>di</strong>zionali e <strong>di</strong>sgiunte; inoltre, una <strong>di</strong>ffusione su larga<br />
scala <strong>di</strong> questa soluzione, che potrebbe trovare spazio anche<br />
in ambito civile, consentirebbe <strong>di</strong> abbattere i carichi<br />
sulle reti <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione con conseguente riduzione delle<br />
per<strong>di</strong>te <strong>di</strong> rete. Altri interventi interessanti per il settore<br />
industriale riguardano il recupero dei cascami termici che<br />
altrimenti andrebbero <strong>di</strong>ssipati (recupero calore dai fumi,<br />
dal raffreddamento dei forni, dei compressori, etc.), l’utilizzo<br />
<strong>di</strong> trasformatori efficienti, la gestione dei picchi <strong>di</strong><br />
consumo ed il rifasamento dei carichi.<br />
Un possibile intervento può riguardare anche l’impianto<br />
<strong>di</strong> illuminazione con l’applicazione <strong>di</strong> apparecchi più efficienti,<br />
l’utilizzo <strong>di</strong> sistemi <strong>di</strong> controllo e <strong>di</strong> gestione delle<br />
lampade (sensori <strong>di</strong> presenza, temporizzatori, etc.) ed un<br />
maggior sfruttamento della luce naturale.<br />
Conclusioni<br />
Ottimizzare il consumo <strong>di</strong> energia non significa necessariamente<br />
una <strong>di</strong>minuzione degli utilizzi, che si tradurrebbe<br />
in un abbassamento dell’attuale tenore <strong>di</strong> vita, ma una<br />
razionalizzazione degli stessi per evitare gli sprechi. Senza<br />
contare che una maggiore produzione energetica comporta,<br />
inoltre, un inevitabile incremento delle emissioni inquinanti,<br />
che aggravano una situazione ambientale già<br />
adesso molto critica. L’efficienza energetica è un ottimo<br />
sistema per contenere e ridurre i rischi del modello <strong>di</strong> sviluppo.<br />
Il risparmio energetico è la prima e imme<strong>di</strong>ata fonte<br />
<strong>di</strong> energia, accessibile a tutte le imprese, <strong>di</strong> qualsiasi<br />
settore, con tempi <strong>di</strong> recupero dell’investimento inferiori<br />
a qualunque tecnologia energetica. L’efficienza energetica<br />
è importante non solo nei processi produttivi, ma anche<br />
nell’erogazione dei servizi (come, ad esempio, l’illuminazione<br />
o il riscaldamento). Aumentare l’efficienza energetica<br />
nei servizi significa, a parità <strong>di</strong> servizi offerti, consumare<br />
meno energia. Come illustrato nel presente articolo,<br />
l’au<strong>di</strong>t energetico è uno strumento in<strong>di</strong>spensabile ed è il<br />
primo passo verso l’efficienza energetica.<br />
Ringraziamenti<br />
Questo lavoro è anche il frutto della collaborazione con<br />
Fedabo srl, la Provincia <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>, la Camera <strong>di</strong> Commercio<br />
<strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>, con i quali il Dipartimento <strong>di</strong> Ingegneria<br />
Meccanica e Industriale dell’Università <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> e il<br />
CSMT hanno attivato <strong>di</strong>versi progetti <strong>di</strong> ricerca per lo<br />
sviluppo <strong>di</strong> au<strong>di</strong>t energetici basati su modelli <strong>di</strong>namici<br />
per la mappatura dei consumi energetici e l’in<strong>di</strong>viduazione<br />
degli interventi <strong>di</strong> efficienza energetica più vali<strong>di</strong> nei<br />
<strong>di</strong>versi settori produttivi della Provincia <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>.
32 <strong>Brescia</strong> ricerche <strong>67</strong>/09<br />
La conversione fotovoltaica della ra<strong>di</strong>azione solare è una<br />
recente acquisizione tra le tecniche <strong>di</strong> produzione dell’energia<br />
elettrica.<br />
Le celle fotovoltaiche sono un’attraente soluzione nel<br />
complesso mondo delle ‘energie rinnovabili’ e il loro sviluppo<br />
ha inizio negli anni ‘50 con la realizzazione dei primi<br />
<strong>di</strong>spositivi pensati per applicazioni spaziali <strong>di</strong> tipo satellitare.<br />
Da quegli anni molta strada si è fatta ed oggi il momento<br />
della commercializzazione, pur nella sua turbolenza indotta<br />
dalle varie politiche <strong>di</strong> sostegno, è una realtà che<br />
tende sempre più ad affermarsi.<br />
Nonostante ciò la produzione fotovoltaica (FV) <strong>di</strong> energia<br />
solare non è ancora economicamente comparabile con<br />
quella tra<strong>di</strong>zionale.<br />
La ragione più significativa degli alti costi dei moduli fotovoltaici<br />
attualmente prodotti è costituita dal costo del materiale:<br />
i wafer <strong>di</strong> silicio puro <strong>di</strong> grado solare impiegato<br />
per la realizzazione delle celle fotovoltaiche mono (mc-Si)<br />
e policristalline (pc-Si), che costituiscono più del 90% del<br />
mercato.<br />
Queste celle, dette <strong>di</strong> ‘prima generazione’, possiedono<br />
un’alta qualità elettronica (elevata lunghezza <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffusione<br />
dei portatori <strong>di</strong> carica), una rilevante stabilità e relativamente<br />
alta efficienza (in un range dal 14 al 20%, a secondo<br />
dello stato cristallino del Si impiegato).<br />
Ma l’alto costo del silicio ultra puro impiegato, unito alla<br />
rilevante quantità <strong>di</strong> materiale (i wafer hanno spessori<br />
compresi tra i 200 e i 300 micron), fa sì che il costo del<br />
modulo finale sia ancora alto. Per questa ragione gli sforzi<br />
della ricerca sono fortemente orientati alla <strong>di</strong>minuzione<br />
dei costi <strong>di</strong> produzione del materiale e alla riduzione degli<br />
spessori.<br />
Si <strong>di</strong>cono <strong>di</strong> ‘seconda generazione’, oggi in avanzata fase<br />
<strong>di</strong> sviluppo, quei moduli fatti con ‘film sottili’ <strong>di</strong> materiali<br />
semiconduttori microcristallini (es. il silicio amorfo idro-<br />
La terza generazione<br />
del fotovoltaico<br />
Angelo Borgese<br />
CSMT - Comitato <strong>di</strong> In<strong>di</strong>rizzo<br />
genato, il <strong>di</strong>seleniuro <strong>di</strong> in<strong>di</strong>o e rame, il telloruro <strong>di</strong> cadmio),<br />
che si ottengono per deposizione su substrati <strong>di</strong>versi<br />
(vetro, metallo, plastica, ecc.) con superfici ampie dell’or<strong>di</strong>ne<br />
del metro quadrato.<br />
Per questi materiali si sono messi in essere processi industriali<br />
che permettono la realizzazione <strong>di</strong> moduli ‘in continuo’<br />
ad elevato grado <strong>di</strong> automazione, con una forte <strong>di</strong>minuzione<br />
dei costi <strong>di</strong> produzione (dovuto anche al fatto che<br />
la quantità <strong>di</strong> materiale fotovoltaico a film sottile risulta<br />
pressoché trascurabile).<br />
L’efficienza dei moduli è un poco più bassa <strong>di</strong> quelli <strong>di</strong><br />
prima generazione e si aggira tra il 13 e il 15% in submoduli<br />
<strong>di</strong> piccola <strong>di</strong>mensione superficiale, mentre per quelli<br />
più ampi attualmente in produzione si ottengono efficienze<br />
intorno al 10%.<br />
La ‘terza generazione’ è quella del futuro - in realtà non<br />
troppo lontano - e si riferisce a tecnologie basate su concetti<br />
assolutamente innovativi, che pur avendo avuto con-<br />
➙
LA TERZA GENERAZIONE DEL FOTOVOLTAICO 33<br />
ferma sperimentale non hanno ancora abbandonato il livello<br />
della ricerca applicata per passare a quello dello sviluppo<br />
industriale.<br />
E’ possibile pensare alla realizzazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>spositivi fotovoltaici<br />
in grado <strong>di</strong> sfruttare una più elevata percentuale<br />
dello spettro solare, che attualmente sfugge alla conversione<br />
fotovoltaica; spingendosi verso il rosso e l’infrarosso si<br />
possono ottenere efficienze anche doppie <strong>di</strong> quelle attuali.<br />
Alla descrizione <strong>di</strong> queste possibilità de<strong>di</strong>chiamo il resto<br />
del presente articolo.<br />
Dispositivi ‘beam splitting’<br />
Attraverso un opportuno sistema ottico la ra<strong>di</strong>azione solare<br />
può essere scomposta nelle sue componenti colorate,<br />
come quando un raggio <strong>di</strong> sole passa attraverso un prisma<br />
<strong>di</strong> vetro; è così possibile inviare queste componenti su celle<br />
fotovoltaiche che esibiscono il massimo della loro efficienza<br />
proprio per quel colore.<br />
Un <strong>di</strong>spositivo ottico così concepito, detto <strong>di</strong> ‘beam splitting’<br />
consentirebbe <strong>di</strong> sfruttare quasi tutto lo spettro solare<br />
ai fini della conversione fotovoltaica, raggiungendo efficienze<br />
complessive teoriche superiori al 60%.<br />
Un sistema costituito da celle al germanio per la componente<br />
rossa, al silicio per quella giallo-verde e all’arseniuro<br />
<strong>di</strong> gallio per quella blu-violetta permetterebbe <strong>di</strong> ottenere<br />
efficienze superiori al 30%.<br />
I <strong>di</strong>spositivi attualmente allo stu<strong>di</strong>o si basano su sistemi ottici<br />
a concentrazione della ra<strong>di</strong>azione solare e hanno <strong>di</strong>mo-<br />
strato sperimentalmente la vali<strong>di</strong>tà del concetto, anche se la<br />
realizzazione pratica risulta molto complessa e costosa.<br />
Celle a giunzioni multiple<br />
Una evoluzione del concetto <strong>di</strong> ‘beam splitting’, anche se<br />
tecnologicamente più complesso, consiste nella realizzazione<br />
<strong>di</strong> un unico <strong>di</strong>spositivo costituito da celle a giunzioni<br />
multiple e sovrapposte costituite da materiali semiconduttori<br />
<strong>di</strong>versi, che rispondono alla conversione fotovoltaica<br />
<strong>di</strong> parti <strong>di</strong>verse dello spettro solare e risultano trasparenti<br />
per il resto della ra<strong>di</strong>azione.<br />
In questo caso, ciascuna giunzione assorbe e converte solo<br />
una parte della ra<strong>di</strong>azione e permette al resto <strong>di</strong> passare<br />
ed essere convertito dalla giunzione successiva.<br />
La struttura del <strong>di</strong>spositivo è realizzata in modo che gli<br />
elettroni fotogenerati alimentino adeguatamente il circuito<br />
esterno, generando una potenza totale somma dei contributi<br />
<strong>di</strong> ogni singola conversione fotovoltaica.<br />
In teoria l’efficienza <strong>di</strong> conversione potrebbe superare anche<br />
l’80%.<br />
In pratica, sono state realizzate celle a tre giunzioni superando<br />
rilevanti problemi tecnologici e ottenendo efficienze del<br />
39% con fosfuro <strong>di</strong> gallio e in<strong>di</strong>o, arseniuro <strong>di</strong> gallio e germanio<br />
con concentrazioni della luce solare pari a 236 volte.<br />
L’alto costo dovuto alla complessità della tecnologia rende<br />
oggi dubbia la competitività <strong>di</strong> questi sistemi <strong>di</strong> conversione,<br />
anche se i risultati già conseguiti incoraggiano a<br />
continuare gli sforzi della ricerca.<br />
I super reticoli<br />
La ricerca volta allo sfruttamento della maggior parte dello<br />
spettro solare percorre cammini sempre più evoluti e<br />
l’idea delle multigiunzioni ha portato recentemente a su-<br />
➙
34 <strong>Brescia</strong> ricerche <strong>67</strong>/09<br />
perare la limitatezza del numero <strong>di</strong> semiconduttori naturali<br />
utilizzabili per la realizzazione <strong>di</strong> questo tipo <strong>di</strong> <strong>di</strong>spositivi.<br />
Qualche tempo fa, nel campo della fisica dello stato solido,<br />
si affermò l’idea che era possibile realizzare materiali<br />
semiconduttori completamente nuovi come sovrapposizione<br />
<strong>di</strong> stati estremamente sottili (da uno a <strong>di</strong>eci nanometri)<br />
<strong>di</strong> semiconduttori naturali; questi impacchettamenti<br />
alternati <strong>di</strong> film nanometrici presero il nome <strong>di</strong> ‘super<br />
reticoli’.<br />
L’idea si deve all’inventore del ‘<strong>di</strong>odo tunnel’ e premio<br />
Nobel per la fisica nel 1973, Leo Esaki, che nel 1970 la<br />
propose quasi come una curiosità scientifica.<br />
Questi nuovi sistemi semiconduttori costituiti da numerosissimi<br />
strati alternativamente “p” e “n”, fino ad ottenere<br />
spessori anche <strong>di</strong> qualche micron, costituiscono <strong>di</strong> fatto<br />
un nuovo semiconduttore cristallino, non esistente in natura,<br />
avente caratteristiche fisiche completamente nuove e<br />
<strong>di</strong>pendenti dallo spessore dei singoli strati sottili che lo<br />
costituiscono.<br />
Modulando opportunamente tale parametro durante la<br />
fase <strong>di</strong> deposizione degli strati, si possono realizzare nuovi<br />
materiali semiconduttori con ‘banda <strong>di</strong> energia proibita’<br />
<strong>di</strong> ampiezza variabile a seconda delle esigenze.<br />
Una tecnologia o, meglio, una nanotecnologia a causa delle<br />
<strong>di</strong>mensioni nanometriche dello spessore dei singoli<br />
strati, atta a realizzare nuovi semiconduttori chiamata<br />
‘band engineering’, attraverso la quale si possono ottenere<br />
caratteristiche ottimali per le esigenze della conversione<br />
fotovoltaica dell’intero spettro solare.<br />
Purtuttavia, l’idea dei super reticoli non sembra, per il<br />
momento, avere una grande valenza pratica e una vera e<br />
propria cella fotovoltaica “multicolore” non è ancora stata<br />
realizzata. L’idea dei super reticoli è andata così progressivamente<br />
perdendo <strong>di</strong> interesse negli anni ‘90 a favore <strong>di</strong><br />
nuovi approcci sempre però basati sulle nanotecnologie<br />
dei materiali.<br />
I nanocristalli<br />
Questi nuovi orientamenti, oggi, promettono e permettono<br />
la realizzazione, con tecnologie più semplici, <strong>di</strong> <strong>di</strong>spositivi<br />
fotovoltaici atti ad un migliore sfruttamento dello<br />
spettro solare, basati sulle proprietà dei cosiddetti ‘nanocristalli<br />
quantistici’.<br />
Senza entrare in particolari eccessivamente specialistici, si<br />
tratta <strong>di</strong> sistemi nanoaggregati cristallini <strong>di</strong> materiale semiconduttore<br />
con simmetria sferica costituiti da un numero<br />
<strong>di</strong> atomi compreso tra 10 e 100, in modo tale che il<br />
suo <strong>di</strong>ametro raggiunga una misura dell’or<strong>di</strong>ne del nanometro<br />
( 10 -9 m).<br />
Questo sistema microscopico, o meglio nanoscopico,<br />
mantiene le caratteristiche a ‘bande <strong>di</strong> livelli’ proprie del<br />
materiale semiconduttore che lo costituisce, con la <strong>di</strong>fferenza<br />
che i livelli, all’interno delle bande, sono spaziati in<br />
energia in modo <strong>di</strong>pendente dagli atomi presenti nell’aggregato<br />
e quin<strong>di</strong> dalle sue <strong>di</strong>mensioni.<br />
Minore è il numero degli atomi e più separati sono i livelli<br />
energetici e quin<strong>di</strong> le bande del sistema, che viene anche<br />
chiamato ‘quantum dot’.<br />
Modulando le <strong>di</strong>mensioni dei ‘quantum dots’ si possono<br />
realizzare <strong>di</strong>versi valori della banda <strong>di</strong> ‘energia proibita’<br />
E g , esistente tra la ‘banda <strong>di</strong> valenza’ e la ‘banda <strong>di</strong> conduzione’<br />
del nanocristallo semiconduttore, conferendo così<br />
allo stesso proprietà optoelettroniche <strong>di</strong>verse e quin<strong>di</strong><br />
possibilità fotoelettroniche ottimali alle varie frequenze<br />
dello spettro solare.<br />
La <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> strati multipli <strong>di</strong> nanocristalli con <strong>di</strong>mensioni<br />
<strong>di</strong>verse, all’interno <strong>di</strong> una giunzione fotovoltaica,<br />
può aumentare la quantità <strong>di</strong> spettro solare utile per la<br />
conversione e quin<strong>di</strong> l’efficienza del <strong>di</strong>spositivo.<br />
Attualmente sono allo stu<strong>di</strong>o ‘quantun dots’ <strong>di</strong> materiali<br />
semiconduttori come l’arseniuro <strong>di</strong> in<strong>di</strong>o, l’arseniuro <strong>di</strong><br />
gallio, il silicio, il seleniuro <strong>di</strong> piombo, il seleniuro <strong>di</strong> cadmio<br />
ed altri, molto importanti per le applicazioni fotovoltaiche<br />
in essere.
LA POLLINA: DA COSTO AZIENDALE A RISORSA ECONOMICA 35<br />
Prima <strong>di</strong> poter comprendere i motivi per cui recentemente<br />
si è cominciato a parlare <strong>di</strong> utilizzo della pollina a fini<br />
energetici è necessario innanzitutto conoscere cosa si intende<br />
quando si parla <strong>di</strong> ‘pollina’. Si tratta <strong>di</strong> un residuo<br />
organico costituito da escrementi del pollame e lettiera a<br />
base vegetale proveniente da allevamenti avicoli. L’idea <strong>di</strong><br />
utilizzare la pollina come combustibile – che, se paragonata<br />
ad altri combustibili come le biomasse, ha un potere calorifico<br />
decisamente inferiore (pari a circa 8 MJ/kg) – scaturisce<br />
dalla problematica connessa al suo smaltimento. In<br />
particolare, fino alla fine del 2007 gli avicoltori avevano tre<br />
possibilità per lo smaltimento delle deiezioni avicole:<br />
- il ritiro da parte <strong>di</strong> <strong>di</strong>tte specializzate secondo il Regolamento<br />
CE N. 1774/2002 del Parlamento Europeo e del<br />
Consiglio del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative<br />
ai sottoprodotti <strong>di</strong> origine animale non destinati al<br />
consumo umano. Questa soluzione, però, implicava oneri<br />
economici non in<strong>di</strong>fferenti per gli avicoltori;<br />
- lo smaltimento in campo come concime tenendo in considerazione<br />
l’adeguamento alla Direttiva 91/<strong>67</strong>6/CEE<br />
(“Direttiva Nitrati”), che limita in modo drastico lo spargimento<br />
<strong>di</strong> reflui zootecnici sui campi;<br />
- il recupero energetico (DM 5/2/98) legato però a con<strong>di</strong>zioni<br />
e vincoli estremamente rigi<strong>di</strong> e non adottabili dal<br />
singolo allevatore, prevedendo la combustione solo in impianti<br />
de<strong>di</strong>cati al recupero energetico <strong>di</strong> rifiuti <strong>di</strong> potenza<br />
nominale non inferiore a 6 MW termici.<br />
Rispetto alle prime due soluzioni la terza comportava<br />
maggiori costi e un iter legislativo estremamente lungo,<br />
spiegato nel D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 (Testo unico<br />
ambientale – VAS,VIA,IPPC). Inoltre, prevedeva vincoli<br />
normativi più restrittivi, in particolar modo per l’incenerimento<br />
secondo il D.M. 5/2/98 e il D.lgs. n. 133 dell’11<br />
maggio 2005. A ciò bisogna aggiungere la maggiore complessità<br />
gestionale in termini <strong>di</strong> registri carico e scarico rifiuti,<br />
norme per il trasporto e l’igiene secondo la <strong>di</strong>rettiva<br />
La pollina:<br />
da costo aziendale<br />
a risorsa economica<br />
Maria Chiesa e Giovanna Gagliotti<br />
Università Cattolica del Sacro Cuore - CRASL<br />
(Centro <strong>di</strong> Ricerche per l’Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile della Lombar<strong>di</strong>a)<br />
CE 1774 che stabilisce in particolare rigide norme sanitarie<br />
per la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, la manipolazione,<br />
la trasformazione, l’uso e l’eliminazione dei sottoprodotti<br />
<strong>di</strong> origine animale. Di conseguenza, fino all’inizio<br />
del 2008 il canale quasi obbligato <strong>di</strong> smaltimento della<br />
pollina per gli avicoltori in Italia era il conferimento a <strong>di</strong>tte<br />
specializzate le quali provvedevano allo smaltimento in<br />
<strong>di</strong>scarica oppure alla conversione quale ammendante. La<br />
nuova normativa dal 2008 (art. 185, comma 2 Decreto<br />
correttivo n.4/2008 del Dlgs 52/06) considera ora la pollina<br />
non più come rifiuto speciale, ma come sottoprodotto<br />
aziendale utilizzabile quin<strong>di</strong> come combustibile anche in<br />
allevamento dell’azienda avicola “De Poli” sita a Montirone (Bs),<br />
dove si è effettuata la sperimentazione<br />
➙
36 <strong>Brescia</strong> ricerche <strong>67</strong>/09<br />
impianti <strong>di</strong> piccola taglia (inferiore ai 6 MW termici), offrendo<br />
nuove opportunità per gli avicoltori. A questo proposito,<br />
è interessante sottolineare come in Regione Lombar<strong>di</strong>a<br />
il mutamento della normativa sia stata supportato<br />
anche dai risultati <strong>di</strong> alcuni progetti <strong>di</strong> ricerca applicata<br />
cofinanziati negli ultimi anni dalla Direzione Generale<br />
Agricoltura. In particolare, nel corso del 2006 l’Università<br />
Cattolica del Sacro Cuore, tramite il Centro <strong>di</strong> Ricerca per<br />
l’Ambiente e lo Sviluppo sostenibile della Lombar<strong>di</strong>a<br />
(CRASL), ha condotto il Progetto REPE (Analisi ambientale,<br />
energetica e gestionale per il REcupero della Pollina<br />
a scopo Energetico), in collaborazione con lo Stu<strong>di</strong>o tecnico<br />
Green Energy s.r.l. e l’azienda Giemme <strong>di</strong> Mola. Obiettivo<br />
del progetto è stata la verifica sperimentale della fattibilità<br />
dell’utilizzo della pollina a fini energetici da un<br />
punto <strong>di</strong> vista energetico, ambientale ed economico allo<br />
scopo <strong>di</strong> affrontare la problematica legata ai problemi attuali<br />
<strong>di</strong> smaltimento della pollina.<br />
Risultati dell’analisi energetica<br />
e ambientale<br />
Il progetto ha previsto test sperimentali <strong>di</strong> utilizzo della<br />
pollina come combustibile su due impianti <strong>di</strong> piccola taglia:<br />
una caldaia da 600 kW termici e un gassificatore da<br />
270 kW termici (quest’ultimo a monte <strong>di</strong> un motore elettrico<br />
<strong>di</strong> potenza nominale pari a 60 kW elettrici). Da un<br />
punto <strong>di</strong> vista ambientale, si è provveduto ad effettuare<br />
l’analisi chimica sia della pollina che delle ceneri prodotte,<br />
unitamente all’analisi delle emissioni in atmosfera a valle<br />
della caldaia e del motore elettrico a valle del gassificatore.<br />
Come è noto, le emissioni atmosferiche <strong>di</strong> un impianto<br />
<strong>di</strong> combustione o <strong>di</strong> un gassificatore, unitamente alla<br />
composizione delle ceneri prodotte dai due impianti, sono<br />
legate alla composizione chimica del combustibile primario.<br />
E’ stata quin<strong>di</strong> dapprima effettuata l’analisi chimica <strong>di</strong><br />
un campione <strong>di</strong> lettiera (composta da pollina all’80% e segatura<br />
al 20%) per quanto riguarda la speciazione dei metalli<br />
presenti. I risultati dell’analisi chimica della pollina<br />
sono strettamente collegati alla composizione del mangime<br />
somministrato ai polli durante la loro crescita. Dalle<br />
analisi chimiche svolte è risultato un valore <strong>di</strong> Cloro elevato,<br />
riscontrato anche nella composizione chimica delle<br />
ceneri, giustificato sia dalla presenza <strong>di</strong> segatura nel combustibile<br />
che dalle usuali pratiche avicole per la <strong>di</strong>sinfezione<br />
della superficie a<strong>di</strong>bita ai polli. Inoltre, si è riscontrato<br />
un valore elevato <strong>di</strong> rame (superiore al valore limite <strong>di</strong> 35<br />
mg/kg), che è legato alla composizione chimica <strong>di</strong> particolari<br />
integratori alimentari somministrati ai polli durante<br />
la loro crescita. Per quanto riguarda le emissioni atmosferiche,<br />
si sono considerati i valori limite contenuti nell’Al-<br />
legato 2 - Sub-allegato 1 del D.M. 05/02/1998 (in particolare,<br />
sono stati considerati i punti 11 e 14 rispettivamente<br />
per la gassificazione e la combustione). Dai test sperimentali<br />
i parametri maggiormente critici che sono stati riscontrati<br />
sia per la gassificazione che per la combustione della<br />
pollina sono il monossido <strong>di</strong> carbonio (CO) e le polveri totali<br />
sospese (PTS). I valori <strong>di</strong> emissione <strong>di</strong> questi parametri<br />
hanno raggiunto in entrambi i casi i valori limite. Per<br />
quanto riguarda gli altri inquinanti monitorati, si sono rilevate<br />
delle criticità per quanto riguarda le prove <strong>di</strong> emissione<br />
in caldaia per parametri contenenti il Cloro (espressi<br />
come Acido Cloridrico, HCl), il Carbonio Organico Totale<br />
(COT) e alcuni metalli pesanti (in particolare il rame -<br />
Cu). Premesso che, per entrambi gli impianti utilizzati, le<br />
misure <strong>di</strong> emissione sono state effettuate senza alcun sistema<br />
<strong>di</strong> abbattimento fumi, sarebbe possibile ridurre le<br />
criticità riscontrate con alcuni accorgimenti tecnici. In<br />
particolare, per il monossido <strong>di</strong> carbonio (CO) i valori elevati<br />
<strong>di</strong> emissione sono da attribuire ad una combustione<br />
non ottimizzata (che potrebbe essere migliorata mo<strong>di</strong>ficando<br />
la geometria del bruciatore della caldaia ed inserendo<br />
una griglia mobile al posto della griglia fissa utilizzata<br />
nel nostro caso stu<strong>di</strong>o, unitamente ad un ricircolo<br />
parziale dei fumi in camera <strong>di</strong> combustione). Per quanto<br />
riguarda le polveri, l’applicazione <strong>di</strong> filtri a maniche per<br />
entrambi gli impianti potrebbe costituire un valido sistema<br />
<strong>di</strong> abbattimento al fine del raggiungimento <strong>di</strong> valori <strong>di</strong><br />
emissione ben al <strong>di</strong> sotto del valore limite giornaliero (pari<br />
a 10 mg/Nm 3 ). Le concentrazioni <strong>di</strong> composti a base <strong>di</strong><br />
Cl (espressi come HCl) e metalli pesanti (tra cui in particolar<br />
modo il Rame - Cu), potrebbero essere ridotti cambiando<br />
da una parte le pratiche <strong>di</strong> <strong>di</strong>sinfezione degli allevamenti<br />
da parte degli allevatori che fanno attualmente<br />
largo uso <strong>di</strong> prodotti clorurati e, dall’altra, stu<strong>di</strong>ando integratori<br />
alimentari per polli con un contenuto rameico possibilmente<br />
inferiore al livello attuale. È stato interessante<br />
verificare che le emissioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ossine e furani<br />
(PCDD/PCDF), che rappresentano a livello <strong>di</strong> sensibilità<br />
pubblica potenziali parametri critici a livello europeo, non<br />
sono risultate critiche per quanto riguarda la combustione,<br />
grazie all’elevata temperatura all’interno della camera<br />
<strong>di</strong> combustione (attorno ai 900 °C). Nel caso della gassificazione,<br />
invece, il valore limite <strong>di</strong> 0,1 ng/Nm 3 per le emissioni<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>ossine è stato raggiunto; una riduzione delle<br />
emissioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ossine potrebbe tuttavia essere ottenuta<br />
agendo sull’abbattimento delle polveri stesse (tramite l’utilizzo<br />
<strong>di</strong> filtri a maniche). Per quanto riguarda le emissioni<br />
<strong>di</strong> metalli pesanti (presenti in gran parte nel particolato)<br />
potrebbero essere ridotte inserendo a valle della camera<br />
<strong>di</strong> combustione e del reattore <strong>di</strong> gassificazione dei filtri<br />
a base <strong>di</strong> carbone attivo. Sulla base <strong>di</strong> tutte le analisi <strong>di</strong> tipo<br />
ambientale condotte all’interno del progetto sono<br />
➙
LA POLLINA: DA COSTO AZIENDALE A RISORSA ECONOMICA 37<br />
quin<strong>di</strong> state valutate le possibili mo<strong>di</strong>fiche da apportare<br />
agli impianti dal punto <strong>di</strong> vista tecnico, al fine <strong>di</strong> migliorare<br />
i processi <strong>di</strong> combustione e <strong>di</strong> gassificazione e ridurre le<br />
emissioni. In particolare, per quanto riguarda l’utilizzo <strong>di</strong><br />
pollina in caldaia, una volta ottimizzata la geometria del<br />
combustore - come accennato in precedenza - sarebbe auspicabile<br />
utilizzare una griglia mobile inclinata impiegata<br />
attualmente in caldaie già in commercio, che bruciano<br />
biomassa legnosa con un elevato tenore <strong>di</strong> umi<strong>di</strong>tà. In<br />
particolare, nel caso specifico (combustione <strong>di</strong> lettiera)<br />
potrebbe essere utilizzato un bruciatore a griglia mobile<br />
inclinata in ghisa al cromo caratterizzata da un funzionamento<br />
orizzontale alternativo a mezzo <strong>di</strong> spintore meccanico<br />
per l’avanzamento controllato del combustibile sulla<br />
griglia. Per quanto riguarda la gassificazione della pollina,<br />
l’inserimento <strong>di</strong> una marmitta catalitica e sonda lambda<br />
garantirebbe il ricircolo dei fumi nel gassificatore con una<br />
riduzione in parallelo degli inquinanti emessi. Al fine <strong>di</strong><br />
migliorare le prestazioni energetiche del sistema per la<br />
produzione <strong>di</strong> energia elettrica sarebbe invece auspicabile<br />
l’impiego <strong>di</strong> una turbina in sostituzione del motore a combustione<br />
interna. Questa variante presuppone un aumento<br />
<strong>di</strong> densità energetica del gasogeno, ovvero del gas composito<br />
prodotto a valle del processo <strong>di</strong> gassificazione. Una<br />
possibile soluzione potrebbe essere data dall’inserimento<br />
<strong>di</strong> un compressore e <strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong> stoccaggio del gas a<br />
monte della turbina.<br />
Risultati dell’analisi economica<br />
Per quanto riguarda l’analisi costi-benefici dell’utilizzo<br />
della pollina a fini energetici si sono valutati <strong>di</strong>versi fattori.<br />
In particolare, sono stati considerati gli eventuali ricavi<br />
economici per gli avicoltori, considerando il mancato costo<br />
<strong>di</strong> smaltimento della pollina, il mancato acquisto del<br />
combustibile per il riscaldamento degli allevamenti (attualmente<br />
dato dal gasolio) e il surplus <strong>di</strong> energia termica<br />
e/o elettrica (prodotto dall’impianto <strong>di</strong> combustione o<br />
gassificazione sottraendo i consumi interni aziendali) che<br />
si potrebbe avere grazie all’utilizzo <strong>di</strong> pollina a fini energetici<br />
e tenendo conto <strong>di</strong> incentivi come il conto energia, i<br />
certificati ver<strong>di</strong> e la tariffa agricola secondo la legge finanziaria<br />
2008. Allo stato attuale gli avicoltori godono dell’acquisto<br />
<strong>di</strong> combustibile detassato agricolo (in particolare<br />
gasolio) a prezzo agevolato pari a 0,7 €/litro. In alternativa,<br />
negli allevamenti viene talvolta utilizzato anche il<br />
gas naturale (al costo <strong>di</strong> 0,5 €/m 3 ). Per quanto concerne<br />
l’energia elettrica, l’impiego <strong>di</strong> sistemi <strong>di</strong> ventilazione (utilizzati<br />
solo nei mesi estivi) penalizza il contratto degli avicoltori<br />
che scontano un fisso elevato <strong>di</strong> allacciamento alla<br />
rete. Dalle analisi effettuate a campione la tariffa me<strong>di</strong>a<br />
stoccaggio <strong>di</strong> pollina in un’azienda avicola<br />
pagata è <strong>di</strong> 0,18 €/kWh con una potenza <strong>di</strong> allacciamento<br />
pari a 40 kW. L’impiego <strong>di</strong> energia sia termica che elettrica<br />
è influenzato dal periodo del ciclo <strong>di</strong> allevamento dei<br />
pulcini. Per un allevamento <strong>di</strong> superficie pari a 7.500 m 2 è<br />
ipotizzabile un costo <strong>di</strong> combustibile per il riscaldamento<br />
tra i 30.000 e i 50.000 €/anno. Dal punto <strong>di</strong> vista dell’energia<br />
elettrica, i consumi, per lo più imputabili al periodo<br />
estivo, sono pari a circa 50.000 kWh/anno. La nuova<br />
Direttiva Nitrati ha <strong>di</strong>mezzato la possibilità <strong>di</strong> span<strong>di</strong>mento<br />
in campo della pollina (portando il carico massimo <strong>di</strong><br />
azoto span<strong>di</strong>bile in campo al valore <strong>di</strong> 170 kg per ettaro <strong>di</strong><br />
terreno): <strong>di</strong> conseguenza, considerando lo smaltimento in<br />
<strong>di</strong>scarica o il conferimento, si ipotizza un costo <strong>di</strong> 0,1€/kg.<br />
Ipotizzando il costo <strong>di</strong> una caldaia a pollina uguale a quello<br />
<strong>di</strong> una caldaia a griglia mobile biomassa legnosa (sistema<br />
a biomassa più costoso sul mercato), un allevamento<br />
<strong>di</strong> 7.500 m 2 necessiterebbe <strong>di</strong> una caldaia <strong>di</strong> potenza nominale<br />
pari a 500 kW. L’investimento previsto per la sola<br />
centrale termica è identificabile in € 150.000; non sono<br />
stati considerati costi aggiuntivi in quanto il materiale è<br />
stoccabile in un silos abitualmente presente nelle aziende<br />
avicole. Ipotizzando un potere calorifico inferiore della<br />
pollina <strong>di</strong> 2,5 kWh/kg ed una necessità energetica <strong>di</strong><br />
715.000 kWh, si eviterebbe lo smaltimento <strong>di</strong> 285 tonnellate<br />
<strong>di</strong> pollina con un ulteriore risparmio <strong>di</strong> 28.500 €/anno.<br />
Nel caso <strong>di</strong> autoproduzione <strong>di</strong> energia elettrica, si è<br />
considerato lo stesso sistema <strong>di</strong> riferimento utilizzato nel<br />
progetto <strong>di</strong> ricerca. Data la complessità del sistema legislativo<br />
applicabile alla produzione energetica (con particolare<br />
riferimento a quella basata su fonti <strong>di</strong> energia rinnovabile),<br />
si sono analizzati i seguenti casi stu<strong>di</strong>o.<br />
- Autoconsumo dell’energia elettrica prodotta, in<strong>di</strong>pendenza<br />
energetica dal punto <strong>di</strong> vista termico anche nei mo-<br />
➙
38 <strong>Brescia</strong> ricerche <strong>67</strong>/09<br />
Gassificatore<br />
menti <strong>di</strong> picco, cessione dell’energia elettrica secondo le<br />
tariffe dell’AEEG, riscossione dei certificati ver<strong>di</strong> per un<br />
periodo <strong>di</strong> 15 anni.<br />
- Autoconsumo dell’energia elettrica prodotta, in<strong>di</strong>pendenza<br />
energetica dal punto <strong>di</strong> vista termico anche nei momenti<br />
<strong>di</strong> picco, cessione dell’energia elettrica secondo le<br />
tariffe dell’AAEG, riscossione dei certificati ver<strong>di</strong> per un<br />
periodo <strong>di</strong> 15 anni, mancato costo per lo smaltimento della<br />
pollina.<br />
- Applicazione del conto energia per biomasse alla produzione<br />
<strong>di</strong> energia elettrica, in<strong>di</strong>pendenza energetica dal<br />
punto <strong>di</strong> vista termico anche nei momenti <strong>di</strong> picco.<br />
- Applicazione del conto energia per biomasse alla produzione<br />
<strong>di</strong> energia elettrica, in<strong>di</strong>pendenza energetica dal<br />
punto <strong>di</strong> vista termico anche nei momenti <strong>di</strong> picco, mancato<br />
costo per lo smaltimento della pollina.<br />
In tutti i casi analizzati è emerso che la <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong><br />
combustibile a costo zero garantirebbe la sostenibilità<br />
dell’investimento anche senza usufruire dei certificati<br />
ver<strong>di</strong> per la produzione <strong>di</strong> energia elettrica da fonti rinnovabili<br />
(rientro economico in 10 anni circa); considerando<br />
anche i certificati ver<strong>di</strong> o il conto energia per biomasse<br />
(promosso dalla finanziaria 2008), il tempo <strong>di</strong> ritorno<br />
dell’investimento si ridurrebbe ulteriormente a<br />
circa 4 anni.<br />
Sviluppi futuri<br />
A seguito dei risultati incoraggianti della ricerca esposti<br />
più sopra e del recepimento da parte dell’Italia della Direttiva<br />
91/<strong>67</strong>6/CEE, nota come “Direttiva Nitrati”, il<br />
CRASL sta continuando a lavorare su questo tema collaborando<br />
con le autorità locali e regionali e con gli operatori<br />
industriali del settore (produttori <strong>di</strong> impianti per la<br />
gestione <strong>di</strong> reflui zootecnici e aziende avicole).<br />
E’ infine <strong>di</strong> fondamentale importanza sottolineare la necessità<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>alogo e confronto <strong>di</strong>retto con gli allevatori<br />
stessi per affrontare le problematiche derivanti dalle attuali<br />
pratiche utilizzate all’interno delle aziende avicole,<br />
sia in termini <strong>di</strong> gestione degli allevamenti stessi che in<br />
termini <strong>di</strong> gestione dei reflui prodotti, per razionalizzare<br />
l’uso <strong>di</strong> pollina (che contiene composti azotati) in agricoltura<br />
quale ammendante e prevenire quin<strong>di</strong> l’accumulo <strong>di</strong><br />
sostanze azotate nei terreni; il tutto rispettando nel contempo<br />
il vincolo della Direttiva Nitrati dato dallo span<strong>di</strong>mento<br />
<strong>di</strong> un carico massimo <strong>di</strong> 170 kg <strong>di</strong> azoto per ettaro<br />
<strong>di</strong> terreno relativamente alle Zone vulnerabili da Nitrati <strong>di</strong><br />
origine Agricola (ZNA), la cui <strong>di</strong>stribuzione a livello nazionale<br />
porta la Provincia <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> a risultare particolarmente<br />
critica.
IDROGENO, FUEL CELL E UTILIZZI IN AMBITO AUTOMOTIVE 39<br />
Oggigiorno si parla molto spesso <strong>di</strong> idrogeno e <strong>di</strong> un suo<br />
possibile utilizzo futuro come combustibile sostitutivo del<br />
petrolio. Il che in linea teorica è possibile, anche se non<br />
mancano problematiche che rendono l’idrogeno ancora<br />
poco sfruttabile. L’articolo qui proposto parla della storia<br />
<strong>di</strong> questo elemento e in particolare <strong>di</strong> come può essere<br />
sfruttato nel campo dell’automotive me<strong>di</strong>ante l’utilizzo<br />
delle celle a combustibile.<br />
Caratteristiche e breve storia dell’idrogeno<br />
L’idrogeno è il più <strong>di</strong>ffuso tra tutti gli elementi presenti<br />
sul pianeta, ma esso è quasi sempre legato ad altri elementi.<br />
La sua molecola (H2 ) è formata da due atomi <strong>di</strong><br />
idrogeno. Non si deve cadere nell’errore <strong>di</strong> considerare l’idrogeno<br />
una fonte energetica. In realtà si ottiene da altre<br />
fonti me<strong>di</strong>ante particolari processi, quin<strong>di</strong> la sua funzione<br />
è propriamente quella <strong>di</strong> un vettore energetico. L’idrogeno<br />
avrebbe una funzione fondamentale come volano energetico.<br />
L’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili potrebbe<br />
essere facilmente conservata nell’idrogeno in forma<br />
<strong>di</strong> energia chimica quando non serve, per poi essere<br />
consumata in un momento <strong>di</strong> necessità.<br />
Questo gas, attraverso la cella a combustibile, può, infatti,<br />
restituire energia in forma elettrica ove e quando essa è<br />
necessaria perché può essere trasportato. Impiegare l’idrogeno<br />
come combustibile sarebbe importantissimo sia<br />
per la sua enorme <strong>di</strong>sponibilità (lo si può ottenere dall’acqua),<br />
sia considerando le esigenze ambientali. La sua caratteristica<br />
più evidente, in relazione all’ambiente, consiste<br />
nel fatto che la sua composizione chimica non contiene<br />
nessun atomo <strong>di</strong> carbonio. Con l’idrogeno, l’umanità,<br />
per la prima volta nella sua storia, potrebbe impiegare un<br />
combustibile in grado <strong>di</strong> fornire energia senza rilasciare<br />
né l’ossido <strong>di</strong> carbonio né l’anidride carbonica. L’idrogeno<br />
Idrogeno, “fuel cell”<br />
e utilizzi in ambito<br />
automotive<br />
Lorenzo Sbaraini<br />
<strong>di</strong>vide con l’ossigeno ed il silicio la classifica degli elementi<br />
più <strong>di</strong>ffusi sul nostro pianeta ed è contenuto nell’acqua<br />
in tutte le forme organiche. Costituisce il 75% della biosfera<br />
terrestre, ma sul nostro pianeta non è <strong>di</strong>ffuso allo stato<br />
puro perché la forza gravitazionale non trattiene le sue<br />
molecole che sono molto leggere. L’idrogeno si può reperire<br />
isolato solo nelle zone vulcaniche, in alcuni siti petroliferi,<br />
anche se piccole quantità, e ad un’altezza <strong>di</strong> 100 km.<br />
Altrimenti è sempre combinato con l’ossigeno nell’acqua<br />
oppure lo si trova legato con il carbonio e con altri elementi.<br />
Anche il 10% del peso del corpo umano è rappresentato<br />
da questo elemento. L’idrogeno, rispetto a tutti gli<br />
altri combustibili, ha il più alto contenuto energetico, in<br />
relazione alla massa. Per produrre energia ottenibile da 1<br />
kg <strong>di</strong> idrogeno occorrono 2.8 kg <strong>di</strong> benzina oppure 2.1 kg<br />
<strong>di</strong> gas naturale. I primi impieghi significativi della cella a<br />
combustibile a idrogeno apparvero nei programmi spaziali<br />
della NASA. Da allora esse furono chiamate prevalentemente<br />
con la denominazione inglese ‘fuel cells’. America e<br />
Russia hanno impiegato costantemente l’idrogeno per alimentare<br />
le cella combustibile a bordo delle prime navicelle<br />
fino allo Space Shuttle. L’attenzione verso l’idrogeno<br />
come possibile fonte <strong>di</strong> energia per i veicoli terrestri e per<br />
i sistemi <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong> elettricità, risale solo agli inizi<br />
degli anni ’70, nel periodo successivo alla prima crisi petrolifera.<br />
Molti scienziati e governi, intimoriti dall’improvvisa<br />
impennata dei prezzi del petrolio, presero in considerazione<br />
l’idrogeno come combustibile per i veicoli, e per le<br />
centrali elettriche <strong>di</strong> piccola taglia furono avviati molti<br />
programmi <strong>di</strong> ricerca per valutare i vantaggi potenziali<br />
dell’utilizzo del gas in campo energetico. Furono altresì<br />
evidenziati i principali problemi tecnici connessi con il<br />
suo impiego: la produzione, lo stoccaggio ed il trasporto.<br />
Durante il ventennio 1975-1995 successivo alla prima crisi<br />
petrolifera, furono sviluppati numerosi sistemi e nuove<br />
tecnologie per ottenere l’energia elettrica anche da fonti<br />
➙
40 <strong>Brescia</strong> ricerche <strong>67</strong>/09<br />
rinnovabili. Aumentava <strong>di</strong> nuovo l’interesse verso l’idrogeno<br />
perché nascevano nuove possibilità <strong>di</strong> realizzare l’elettrolisi<br />
a costi più bassi, mentre si <strong>di</strong>ffondevano le motivazioni<br />
per utilizzarlo nei sistemi <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong> energia<br />
come combustibile alternativo ai derivati del petrolio. Negli<br />
stessi anni gli scienziati pubblicavano i primi rapporti<br />
precisi e molto preoccupati sulle conseguenze dell’effetto<br />
serra. Quin<strong>di</strong>, se inizialmente l’obiettivo che aveva spinto<br />
il ricercatore ad esplorare la possibilità <strong>di</strong> impiego dell’<br />
idrogeno era stato soprattutto quello <strong>di</strong> limitare la <strong>di</strong>pendenza<br />
dal petrolio, negli anni ’90 si aggiungeva anche la<br />
necessità <strong>di</strong> sperimentare soluzioni in grado <strong>di</strong> eliminare<br />
le emissioni <strong>di</strong> gas serra. Con l’inizio dell’ultima decade<br />
del ventesimo secolo, iniziative finalizzate alla <strong>di</strong>ffusione<br />
dell’impiego dell’idrogeno si sono moltiplicate ovunque<br />
nel mondo. La tematica dell’ambiente ha toccato fortemente<br />
anche l’ambito sociale e le comunità hanno attivato<br />
ogni genere <strong>di</strong> iniziativa in tema <strong>di</strong> energie e <strong>di</strong> ambiente.<br />
Si sono formati consorzi ed attività <strong>di</strong> promozione che<br />
hanno proposto modelli energetici basati sulla produzione<br />
<strong>di</strong> elettricità da fonti rinnovabili e sull’idrogeno ottenuto<br />
da elettrolisi. L’obiettivo è ormai quello <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffondere l’utilizzo<br />
dell’idrogeno verso il più grande numero <strong>di</strong> utenti<br />
possibile, in modo da raggiungere un’economia <strong>di</strong> scala<br />
tale da rendere vantaggioso la fabbricazione intensiva dei<br />
sistemi a ‘‘fuel cell’’. L’obiettivo è quello <strong>di</strong> produrre idrogeno<br />
in modo sempre meno <strong>di</strong>pendente dai combustibili<br />
fossili tra<strong>di</strong>zionali.<br />
Quando si parla <strong>di</strong> veicoli ad idrogeno c’è sempre qualcuno<br />
pronto a sostenere che l’idea è un’utopia, che l’idrogeno<br />
non potrà mai essere effettivamente <strong>di</strong>sponibile in modo<br />
capillare sul territorio. Qualcun altro aggiunge che, in ogni<br />
caso, esso sarebbe ricavato da fonti fossili e da processi <strong>di</strong><br />
schema del processo<br />
<strong>di</strong> steam reforming<br />
produzione simili a quelli che sono impiegati per ottenere<br />
il gasolio e la benzina dal petrolio. Quin<strong>di</strong> basati sullo<br />
spreco irreversibile <strong>di</strong> risorse con una collaterale produzione<br />
<strong>di</strong> inquinanti. Per quanto riguarda la produzione sono<br />
<strong>di</strong>sponibili <strong>di</strong>verse tecnologie e naturalmente andrebbero<br />
privilegiate quelle che permettono <strong>di</strong> ottenerlo nel rispetto<br />
<strong>di</strong> due vincoli fondamentali: la compatibilità ambientale ed<br />
un costo <strong>di</strong> produzione accettabile. È contrad<strong>di</strong>ttorio voler<br />
ricorrere all’idrogeno quale combustibile pulito ed economicamente<br />
vantaggioso, producendolo me<strong>di</strong>ante processi<br />
che emettono gas nocivi oppure che sprecano più energia<br />
<strong>di</strong> quella che si desidera utilizzare. Il metodo ideale per la<br />
sua produzione sarebbe ricavarlo dall’acqua, che può essere<br />
scomposta nei suoi due costituenti (idrogeno e ossigeno)<br />
tramite l’elettrolisi. Se però l’energia elettrica necessaria<br />
per questo processo viene prodotta in modo tra<strong>di</strong>zionale,<br />
si ricade nella contrad<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> dover mettere in conto<br />
un certo costo economico e ambientale per ricavare l’idrogeno<br />
perché si continuerebbero a consumare combustibili<br />
fossili. Il processo <strong>di</strong> elettrolisi veramente pulito ed economicamente<br />
vantaggioso deve invece poter impiegare corrente<br />
elettrica ottenuta da fonti rinnovabili e oggi questo è<br />
già possibile. Negli ultimi anni, si sta <strong>di</strong>ffondendo ovunque<br />
un numero <strong>di</strong> iniziative per sviluppare sistemi per ottenere<br />
energia elettrica da fonti rinnovabili. Sono allo stu<strong>di</strong>o anche<br />
nuove metodologie che sfruttano le caratteristiche <strong>di</strong><br />
materiali speciali che possono abbattere in parte l’anidride<br />
carbonica chimicamente durante i processi <strong>di</strong> produzione<br />
<strong>di</strong> idrogeno da fonti fossili. Questi accorgimenti permettono<br />
già oggi <strong>di</strong> avere l’idrogeno attraverso processi quasi<br />
puliti, in attesa che prevalga l’elettrolisi che sfrutta l’elettricità<br />
prodotta da fonti rinnovabili (che è il metodo totalmente<br />
privo <strong>di</strong> emissioni).<br />
➙
IDROGENO, FUEL CELL E UTILIZZI IN AMBITO AUTOMOTIVE 41<br />
Meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> produzione:<br />
lo steam reforming e l’elettrolisi<br />
Il 50% circa dell’idrogeno prodotto nel mondo si ottiene<br />
con lo steam reforming del metano. Il processo è <strong>di</strong>ffuso<br />
ovunque e si basa sulla sua reazione con il vapore acqueo.<br />
Come punto <strong>di</strong> partenza si utilizza il metano contenuto<br />
nel gas naturale. Si potrebbe partire anche dagli idrocarburi<br />
pesanti ottenuti dal cracking del petrolio, ma il prodotto<br />
finale deve essere idrogeno puro con un costo accettabile<br />
e ottenerlo attraverso questa strada sarebbe antieconomico,<br />
perché la spesa energetica necessaria sarebbe<br />
troppo elevata. Lo steam reforming consiste nella reazione<br />
chimica del metano col vapore d’acqua alla temperatura<br />
<strong>di</strong> circa 800 °C e alla pressione <strong>di</strong> 2.5 Mpa in presenza<br />
<strong>di</strong> opportuni catalizzatori, <strong>di</strong> solito a base <strong>di</strong> nichel. Il valore<br />
<strong>di</strong> pressione e <strong>di</strong> temperatura a cui avviene il processo<br />
implicano una certa spesa energetica <strong>di</strong> compressione e<br />
<strong>di</strong> calore. Un primo step <strong>di</strong> reazioni chimiche <strong>di</strong>vide le<br />
molecole <strong>di</strong> metano in idrogeno e in ossido <strong>di</strong> carbonio<br />
(CO). Nel secondo step la miscela contenente CO viene<br />
fatta reagire con altro vapore acqueo alla temperatura <strong>di</strong><br />
circa 400 °C. In tale fase si ottiene anidride carbonica<br />
(CO 2 ) ed ancora idrogeno. Questa seconda reazione si definisce<br />
‘shift’. Il ren<strong>di</strong>mento globale del processo <strong>di</strong> steam<br />
reforming è <strong>di</strong> circa il 65-70%, ma alcuni impianti raggiungono<br />
il 75-85%. Per il ren<strong>di</strong>mento si intende il rapporto<br />
fra il contenuto energetico dell’idrogeno che viene<br />
reso <strong>di</strong>sponibile all’uscita dal processo e quello del metano<br />
<strong>di</strong> partenza, al quale va sommata l’energia spesa per<br />
tenere attivo il ciclo ai valori <strong>di</strong> pressione e temperature<br />
in<strong>di</strong>cati. Gli impianti più moderni sono dotati <strong>di</strong> sistemi<br />
<strong>di</strong> recupero dell’energia contenuta nei gas <strong>di</strong> scarto e dal<br />
vapore; quest’ultimo viene reso <strong>di</strong>sponibile alla pressione<br />
<strong>di</strong> 46 bar e può essere utilizzato per produrre elettricità,<br />
mentre i gas, che contengono un’aliquota <strong>di</strong> circa 50-60%<br />
<strong>di</strong> combustibile, vengono depurati dall’anidride carbonica<br />
e sono riutilizzati per alimentare il processo. L’anidride<br />
carbonica emersa durante questa ulteriore trasformazione<br />
è pari a circa il 40-50% del totale dei gas <strong>di</strong> scarto e viene<br />
eliminata. L’inevitabile produzione collaterale <strong>di</strong> anidride<br />
carbonica costituisce il fattore critico dello steam reforming.<br />
La compatibilità ambientale <strong>di</strong> questo processo oggi<br />
è altamente controllata: la CO 2 prodotta, come già accennato,<br />
viene isolata o abbattuta in loco; la ricerca applicata<br />
più recente è riuscita a renderlo estremamente efficiente e<br />
pulito. Una versione innovativa dello steam reforming,<br />
denominata SER (Sorbion Enhanced Reforming) produce<br />
l’idrogeno a temperatura più bassa. Il SER è abbinato ad<br />
un sistema <strong>di</strong> rimozione selettivo dell’anidride carbonica,<br />
che evita il costo dei sistemi <strong>di</strong> purificazione. Si stanno in<strong>di</strong>viduando<br />
nuovi materiali per l’assorbimento della CO 2<br />
prodotta dal SER per facilitare il suo ‘sequestro’. Dal punto<br />
<strong>di</strong> vista dei consumi questi impianti sono sempre dotati<br />
<strong>di</strong> sottosistemi per il recupero del calore, in modo che il<br />
ren<strong>di</strong>mento energetico globale del sistema sia il massimo<br />
possibile. I costi per produrre l’idrogeno per mezzo dello<br />
steam reforming non sono minori <strong>di</strong> quelli degli altri sistemi<br />
<strong>di</strong> produzione del gas, compresa la già citata elettrolisi.<br />
In questi ultimi anni lo steam reforming ha avuto un<br />
notevole incremento <strong>di</strong> efficienza, grazie all’impiego <strong>di</strong><br />
nuove tecnologie e <strong>di</strong> nuovi materiali. Tale processo per la<br />
produzione <strong>di</strong> idrogeno può anche essere localizzato sul<br />
luogo <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione del gas (vicino alla stazione <strong>di</strong> rifornimento<br />
per i veicoli a idrogeno e agli impianti <strong>di</strong> produzione<br />
<strong>di</strong> energia elettrica ad uso residenziale).<br />
Il processo <strong>di</strong> steam reforming appena descritto si basa<br />
sul metano o sui derivati dal petrolio le cui molecole contengono,<br />
però, oltre all’idrogeno anche carbonio. Quin<strong>di</strong><br />
esiste sempre la necessità <strong>di</strong> eliminare il CO e la CO 2 che<br />
vengono prodotti. L’elettrolisi della molecola dell’acqua è<br />
invece il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>retto e pulito per ottenere l’idrogeno.<br />
Però questa tecnologia contribuisce solo per il 5%<br />
alla produzione mon<strong>di</strong>ale. In sintesi il processo avviene<br />
come segue. Nell’acqua sono immersi due elettro<strong>di</strong>, uno<br />
positivo e uno negativo. Il flusso <strong>di</strong> elettroni, che coincide<br />
con l’elettricità fornita al sistema, entra nella cella dall’elettrodo<br />
negativo attraverso una soluzione acquosa che, in<br />
questo caso, svolge la funzione <strong>di</strong> elettrolita. Sotto l’azione<br />
del campo elettrico generato dagli elettro<strong>di</strong>, l’idrogeno e<br />
l’ossigeno della molecola dell’acqua si separano chimicamente,<br />
<strong>di</strong>ventando ioni e prendendo due <strong>di</strong>rezioni <strong>di</strong>verse.<br />
Le due zone della cella in cui avviene il processo sono<br />
<strong>di</strong>vise da un <strong>di</strong>aframma microporoso che può essere attraversato<br />
solo da ioni. L’idrogeno si accumula quin<strong>di</strong> dalla<br />
parte del catodo e l’ossigeno da quella dell’anodo. L’acqua<br />
consumata durante il processo <strong>di</strong> elettrolisi deve essere<br />
integrata <strong>di</strong> continuo. L’elettrolisi richiede energia perché<br />
la <strong>di</strong>visione della molecola dell’acqua avviene a spese della<br />
corrente elettrica che viene utilizzata nel processo. Il gas<br />
esce alla pressione <strong>di</strong> 6 bar ed è già puro al 99.95%. Normalmente<br />
la corrente elettrica impiegata per il funzionamento<br />
degli elettrolizzatori è quella della rete, prodotta in<br />
prevalenza dalle centrali termoelettriche e quin<strong>di</strong> ottenute<br />
da combustibili fossili. Ma se, come previsto, la <strong>di</strong>ffusione<br />
<strong>di</strong> nuovi sistemi stazionari e veicolari ad idrogeno provocherà<br />
un forte aumento della domanda del gas, si potrà<br />
attivare una sua produzione parallela me<strong>di</strong>ante elettrolisi<br />
alimentata dalla corrente prodotta dalle centrali idroelettriche,<br />
nei momenti <strong>di</strong> minore richiesta <strong>di</strong> rete. La ricerca<br />
applicata è impegnata ad ottimizzare l’elettrolisi in modo<br />
da migliorarne il ren<strong>di</strong>mento e contenere la spesa energetica<br />
per sostenerlo. Una possibilità è quella <strong>di</strong> far avvenire<br />
il processo a temperature più elevate (900-1.000 °C), per-<br />
➙
42 <strong>Brescia</strong> ricerche <strong>67</strong>/09<br />
ché in tali con<strong>di</strong>zioni la reazione elettrolitica è facilitata e<br />
accelerata. Con l’accorgimento della temperatura elevata<br />
il ren<strong>di</strong>mento del processo elettrolitico può aumentare<br />
anche del 30% rispetto a quello dell’elettrolisi standard.<br />
Questo si può ottenere anche senza spesa aggiuntiva <strong>di</strong><br />
energia, per esempio utilizzando il vapore prodotto in eccesso,<br />
a circa 900 °C, da altri processi industriali e che<br />
normalmente viene <strong>di</strong>sperso. Altre ricerche molto recenti<br />
sono tese ad ottimizzare i materiali che costituiscono i due<br />
elettro<strong>di</strong>, in modo da facilitare i flussi <strong>di</strong> corrente al loro<br />
interno e ridurre le per<strong>di</strong>te elettriche.<br />
Dall’idrogeno all’energia elettrica prodotta<br />
dalle “fuel-cell”<br />
Una volta che si ha a <strong>di</strong>sposizione l’idrogeno, questo deve<br />
essere usato nelle celle a combustibile per produrre l’energia<br />
elettrica necessaria a far funzionare un veicolo. Tutte<br />
le celle hanno la medesima struttura <strong>di</strong> base; ovvero sono<br />
costituite da due elettro<strong>di</strong> (un anodo e un catodo) tra i<br />
quali viene interposto un elettrolita che serve per far avvenire<br />
le reazioni elettrochimiche che consentono <strong>di</strong> ottenere<br />
una corrente elettrica partendo dall’idrogeno.<br />
Per offrire una visione <strong>di</strong>namica del funzionamento della<br />
‘‘fuel cell’’ possiamo far riferimento alla seguente figura.<br />
Dal momento in cui la cella 8 (in particolare l’anodo) comincia<br />
ad essere investita dall’idrogeno, si attiva una produzione<br />
progressiva <strong>di</strong> ioni ed elettroni dovuta alla reazio-<br />
ne che si ha nella zona <strong>di</strong> contatto fra l’anodo e l’elettrolita.<br />
La reazione chimica è la seguente:<br />
2H2 ⇒ 4H + + 4e –<br />
Gli elettroni prodotti possono muoversi liberamente, a<br />
partire dalla zona in cui è avvenuta la reazione, solo attraverso<br />
la struttura dell’elettrodo perché solo esso è costituito<br />
da materiale conduttivo. In nessun caso possono attraversare<br />
l’elettrolita. Allo stesso tempo c’è invece una<br />
massiccia migrazione attraverso l’elettrolita dei soli ioni<br />
H + <strong>di</strong>retti all’altro elettrodo (catodo) ove avverrà la reazione<br />
<strong>di</strong> riduzione dell’ossigeno fornito alla cella. Fra i due<br />
ambienti <strong>di</strong> reazione c’è quin<strong>di</strong> un flusso <strong>di</strong> elettroni, e la<br />
circolazione degli elettroni prodotti dalla cella a combustibile<br />
coincide con una corrente elettrica. Un circuito elettrico<br />
provvederà a cedere la potenza prodotta dalla cella<br />
ad un motore elettrico (oppure ad un altro utilizzatore). Il<br />
circuito elettrico esterno necessario per fornire corrente<br />
all’utilizzatore è connesso con l’anodo e si richiude sul catodo.<br />
Presso il catodo avviene la seconda importante reazione<br />
che caratterizza il funzionamento globale della ‘‘fuel<br />
cell’’. Gli elettroni che hanno percorso il circuito elettrico<br />
esterno e ceduto potenza all’utilizzatore, incontrano al catodo<br />
gli ioni H + che hanno attraversato <strong>di</strong>rettamente l’elettrolita,<br />
oltre ad una certa quantità <strong>di</strong> ossigeno che deve<br />
essere assicurato me<strong>di</strong>ante l’alimentazione dall’esterno.<br />
La reazione chimica al catodo è la seguente:<br />
O2 + 4H + + 4e – ⇒ 2H2 O<br />
e produce acqua (calda e <strong>di</strong>stillata).<br />
schema <strong>di</strong> funzionamento<br />
<strong>di</strong> una “fuel-cell”<br />
➙
IDROGENO, FUEL CELL E UTILIZZI IN AMBITO AUTOMOTIVE 43<br />
Quin<strong>di</strong> in ingresso alla cella si hanno idrogeno e ossigeno,<br />
e si ottengono come prodotti finali una corrente elettrica e<br />
acqua.<br />
Le <strong>di</strong>verse tipologie <strong>di</strong> veicoli<br />
I veicoli ad idrogeno sono mossi dall’elettricità prodotta<br />
dalle ‘‘fuel cell’’, ma <strong>di</strong> norma la loro architettura <strong>di</strong> trazione<br />
è ibrida, il che significa che a bordo può essere<br />
presente anche un certo numero <strong>di</strong> batterie. La potenza<br />
viene gestita da un controllo elettronico interfacciato ad<br />
un motore elettrico che trasforma la corrente in energia<br />
meccanica che muove le ruote. Il guidatore dosa la velocità<br />
del veicolo interagendo con il sistema <strong>di</strong> controllo<br />
me<strong>di</strong>ante il pedale dell’acceleratore come nelle automobili<br />
normali. In base alla tipologia <strong>di</strong> vettura (city-car,<br />
berlina, ecc.) il grado <strong>di</strong> ibri<strong>di</strong>zzazione cambia anche in<br />
modo significativo.<br />
Il traffico urbano non permette grande velocità <strong>di</strong> punta.<br />
In tal caso è sufficiente garantire al veicolo una buona<br />
autonomia giornaliera e la possibilità <strong>di</strong> far fronte ai<br />
transitori <strong>di</strong> funzionamento (accelerazioni, decelerazioni,<br />
frenate) che in città sono molto frequenti. Una citycar<br />
mossa esclusivamente dalle batterie classiche ha<br />
un’autonomia <strong>di</strong> circa 50-70 km, molto modesta rispetto<br />
ai 120-140 km e oltre raggiungibile dalla stessa vettura<br />
mossa da un sistema a idrogeno a ‘‘fuel cell’’. I valori potenzialmente<br />
raggiungibili <strong>di</strong>pendono dalle caratteristiche<br />
del mezzo e dalle scelte tecniche del costruttore. Nel<br />
caso <strong>di</strong> un’utilitaria si può adottare un’architettura ibrida<br />
costituita da un piccolo insieme <strong>di</strong> batterie speciali a<br />
basso ingombro coa<strong>di</strong>uvate da uno stack <strong>di</strong> ‘‘fuel cell’’<br />
(centinaia <strong>di</strong> “fuel-cell” collegate tra <strong>di</strong> loro) <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni<br />
contenute e da un super condensatore. Quest’architettura<br />
<strong>di</strong> trazione, ibrida ‘‘fuel cell’’/batteria, garantisce<br />
una buona autonomia, spazio sufficiente a bordo<br />
vettura e ottimi spunti <strong>di</strong> accelerazione. In questa configurazione,<br />
l’intero sistema è <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensione contenuta e<br />
il suo ruolo si riduce a quello <strong>di</strong> sorgente <strong>di</strong> potenza ausiliaria.<br />
Quando la potenza elettrica fornita dalle ‘‘fuel<br />
cell’’ è <strong>di</strong> poco prevalente rispetto a quella fornita dalle<br />
batterie, la configurazione ibrida ‘‘fuel cell’’/batteria si<br />
definisce “load traveller”.<br />
L’energia elettrica delle batterie viene utilizzata quando<br />
sono necessarie buone coppie <strong>di</strong> spunto come nei transi-<br />
tori <strong>di</strong> avviamento del veicolo, nella fase <strong>di</strong> accelerazione<br />
oppure in salita. Per avere un ingombro generale più contenuto,<br />
si cerca <strong>di</strong> adottare batterie molto compatte ad alta<br />
energia specifica (litio-ioni, nichel-idruri metallici, nichel-cloruro<br />
<strong>di</strong> so<strong>di</strong>o, batterie polimeriche, ecc.). Spesso si<br />
fa in modo che le ‘‘fuel cell’’ vengano interfacciate con le<br />
batterie per assicurarne la ricarica. In tali casi saranno le<br />
batterie a fornire in prevalenza la corrente per la trazione.<br />
In linea generale, nei veicoli a idrogeno, si cerca <strong>di</strong> evitare<br />
il collegamento <strong>di</strong>retto tra le ‘‘fuel cell’’ e il controllo del<br />
motore elettrico. Le celle a combustibile rendono al meglio<br />
quando funzionano in con<strong>di</strong>zioni stazionarie, cioè<br />
senza brusche variazioni <strong>di</strong> regime. Interporre le batterie<br />
fra le ‘‘fuel cell’’ e il controllo del motore elettrico permette<br />
<strong>di</strong> allungare la vita dello stack.<br />
In un’altra tipologia <strong>di</strong> configurazione ibrida chiamata<br />
‘range extender’, le ‘‘fuel cell’’ forniscono un’aliquota minore<br />
della potenza elettrica complessiva <strong>di</strong> bordo, mentre<br />
la maggior parte della potenza utilizzata dal motore elettrico<br />
è fornita dalle batterie.<br />
La definizione “range extender” è tipicamente adottata nel<br />
caso in cui i contributi energetici da parte dello stack siano<br />
minori del 25%. In questa configurazione le ‘‘fuel cell’’<br />
hanno soprattutto la funzione <strong>di</strong> caricare le batterie per<br />
garantire maggiori percorrenze al veicolo. Questo, per<br />
esempio, è il caso <strong>di</strong> veicoli elettrici <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni più<br />
gran<strong>di</strong> concepiti originariamente a batterie e che, grazie<br />
alle celle a combustibile, possono aumentare il numero <strong>di</strong><br />
chilometri percorribili oppure, a parità <strong>di</strong> autonomia, possono<br />
avere un ingombro del pacco batterie più ridotto.<br />
Infine, per l’impiego del veicolo fuori città, ove la velocità<br />
me<strong>di</strong>a è più elevata, è preferibile una configurazione<br />
‘‘fuel cell’’ <strong>di</strong>retta, detta anche “full power”. In questo caso<br />
sono le ‘‘fuel cell’’ che provvedono a fornire tutta (o<br />
quasi tutta) la potenza elettrica al veicolo. Un funzionamento<br />
extraurbano basato in prevalenza sulle batterie<br />
tenderebbe a scaricarle troppo in fretta, quin<strong>di</strong> è meglio<br />
che siano le ‘‘fuel cell’’ a sod<strong>di</strong>sfare in modo continuativo la<br />
richiesta <strong>di</strong> potenza. Il pacco-batteria è presente ugualmente<br />
a bordo, ma la sua <strong>di</strong>mensione è volutamente contenuta.<br />
Comunque anche l’architettura “full power” può prevedere<br />
un certo grado <strong>di</strong> ibri<strong>di</strong>zzazione: il motore elettrico<br />
può ricevere energia elettrica in parte dalle ‘‘fuel cell’’ e<br />
in parte dalle batterie. Sarà il sistema <strong>di</strong> controllo a gestire<br />
al meglio l’energia elettrica <strong>di</strong>sponibile a bordo, in relazione<br />
alle caratteristiche del veicolo e alla sua con<strong>di</strong>zione<br />
operativa.
44 <strong>Brescia</strong> ricerche <strong>67</strong>/09<br />
La promozione delle fonti rinnovabili e l’efficienza energetica<br />
sono fra i temi chiave su cui si fonda la politica europea<br />
per contrastare l’inquinamento atmosferico, i cambiamenti<br />
climatici e l’esaurimento delle materie prime. E<br />
parte fondamentale <strong>di</strong> questa politica è la previsione <strong>di</strong><br />
aiuti pubblici specifici per le energie rinnovabili. Il sostegno,<br />
in campo europeo e nazionale,va dalla realizzazione<br />
<strong>di</strong> nuovi impianti alimentati da fonti energetiche alternative,<br />
all’introduzione <strong>di</strong> tecnologie eco innovative in campo<br />
industriale, nonché alla produzione <strong>di</strong> energia pulita.<br />
La situazione in Europa<br />
A livello comunitario il sistema <strong>di</strong> aiuti in campo energetico<br />
fa riferimento a due <strong>di</strong>stinti programmi, “Energia Intelligente<br />
per l’Europa” ed “Ecoinnovazione”.<br />
Nel primo caso ad essere incentivata è l’attività <strong>di</strong> ricerca a<br />
carattere internazionale nel campo dell’efficienza energetica<br />
e dell’uso <strong>di</strong> fonti <strong>di</strong> energia nuove e rinnovabili, mentre<br />
nel secondo caso il sostegno è <strong>di</strong>retto a progetti pilota che<br />
contribuiscano a ridurre l’impatto ambientale e ad ottimizzare<br />
l’uso delle risorse, in particolare attraverso attività <strong>di</strong>mostrative<br />
e <strong>di</strong> <strong>di</strong>sseminazione <strong>di</strong> buone pratiche.<br />
L’invito a presentare proposte è aperto a tutti e prevede<br />
per i progetti selezionati l’erogazione <strong>di</strong> un contributo a<br />
fondo perduto a parziale copertura dei costi progettuali,<br />
in misura variabile dal 50% al 75%.<br />
I ban<strong>di</strong> vengono pubblicati dalla Commissione Europea<br />
con cadenza annuale, l’uscita dei prossimi inviti è attesa<br />
per la primavera del 2010.<br />
In Italia<br />
A livello nazionale è stato recentemente attivato, con una<br />
dotazione <strong>di</strong> 600 milioni <strong>di</strong> euro, il Fondo Rotativo per<br />
l’attuazione del Protocollo <strong>di</strong> Kyoto, istituito dalla Legge<br />
Fonti rinnovabili,<br />
incentivi al futuro<br />
Marco Tabla<strong>di</strong>ni<br />
Gruppo Impresa<br />
Finanziaria per il 2007 e rivolto a imprese, enti <strong>di</strong> ricerca,<br />
ESCO, persone fisiche e giuri<strong>di</strong>che e soggetti pubblici che<br />
intendono investire nel settore.<br />
Ad essere finanziata è l’installazione <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> microgenerazione<br />
ad alto ren<strong>di</strong>mento elettrico e termico e <strong>di</strong><br />
impianti <strong>di</strong> piccola taglia per l’utilizzazione delle fonti rinnovabili<br />
per la generazione <strong>di</strong> elettricità o calore, nonché<br />
la sostituzione <strong>di</strong> motori elettrici con motori ad alta efficienza,<br />
il risparmio energetico, l’eliminazione delle emissioni<br />
<strong>di</strong> protossido <strong>di</strong> azoto dai processi industriali ed in<br />
agricoltura, nonché le attività <strong>di</strong> ricerca.<br />
Sono generalmente ammessi all’incentivo i costi relativi<br />
alla progettazione <strong>di</strong> sistema (compresa l’eventuale realizzazione<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>agnosi energetica e stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> fattibilità) nel limite<br />
dell’8% del totale generale, alle apparecchiature e alla<br />
fornitura <strong>di</strong> materiali e componenti; alle infrastrutture<br />
e opere e<strong>di</strong>li, all’allacciamento alla rete o al montaggio; ai<br />
costi <strong>di</strong> installazione, compresi l’avviamento e il collaudo.<br />
Il fondo prevede la concessione <strong>di</strong> un finanziamento agevolato<br />
a un tasso fisso, <strong>di</strong> durata compresa tra i tre e i sei<br />
anni, nella misura massima del 90% delle spese ammesse<br />
per i soggetti pubblici e del 70% per le imprese, le persone<br />
fisiche e giuri<strong>di</strong>che.<br />
E’ invece riservata agli Istituti Superiori <strong>di</strong> Ricerca, alle<br />
Università e ai loro Consorzi l’opportunità <strong>di</strong> finanziare le<br />
attività <strong>di</strong> ricerca per lo sviluppo <strong>di</strong> tecnologie innovative<br />
per la produzione <strong>di</strong> energia da fonti rinnovabili, per la<br />
produzione, la separazione e l’accumulo <strong>di</strong> idrogeno, per lo<br />
sviluppo <strong>di</strong> materiali, componenti e configurazioni innovative<br />
<strong>di</strong> celle a combustibile. In questo caso il sostegno pubblico<br />
può raggiungere fino al 50% del progetto presentato.<br />
Per la presentazione delle domande si deve ora attendere<br />
la pubblicazione della circolare applicativa.<br />
La produzione <strong>di</strong> energia da fonti rinnovabili, è invece<br />
agevolata tramite incentivi <strong>di</strong> tipo “quota system”, quali i<br />
certificati ver<strong>di</strong> e i titoli <strong>di</strong> efficienza energetica, e <strong>di</strong> tipo<br />
“feed in tariff”, quali il conto energia e la tariffa omnicomprensiva.<br />
➙
FONTI RINNOVABILI, INCENTIVI AL FUTURO 45<br />
Il sistema quota system presuppone l’in<strong>di</strong>viduazione <strong>di</strong> un<br />
soggetto tenuto all’immissione in rete <strong>di</strong> un determinato<br />
quantitativo <strong>di</strong> energia da fonti rinnovabili. Tale obbligo può<br />
essere rispettato me<strong>di</strong>ante la produzione <strong>di</strong>retta <strong>di</strong> energia<br />
pulita o attraverso l’acquisto da soggetti terzi <strong>di</strong> certificati<br />
corrispondenti alla quota <strong>di</strong> energia rinnovabile imposta.<br />
Così avviene per i certificati ver<strong>di</strong>. Il prezzo <strong>di</strong> scambio è pari<br />
alla <strong>di</strong>fferenza tra un valore fisso (180 euro per MWh) ed il<br />
valore annuo del prezzo <strong>di</strong> cessione dell’energia elettrica definito<br />
annualmente dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il<br />
Gas. Per il <strong>2009</strong> il prezzo è <strong>di</strong> 88,66 €/MWh ma, nell’ipotesi<br />
che il produttore decida <strong>di</strong> non immettere sul mercato i propri<br />
certificati ma <strong>di</strong> chiederne il ritiro al soggetto Gestore del<br />
Servizio Elettrico, il GSE, il valore degli stessi sarà ancorato<br />
al valor me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta dell’anno precedente.<br />
A partire dal 2008 il GSE emette certificati in numero pari<br />
al risultato dei MWh prodotti moltiplicati per il corrispondente<br />
coefficiente variabile per ciascuna fonte fra un<br />
minimo <strong>di</strong> 0,8 e un massimo <strong>di</strong> 1,8 (1 per gli impianti e<br />
per le centrali ibride entrati in esercizio prima del 31 <strong>di</strong>cembre<br />
2007, per gli impianti <strong>di</strong> cogenerazione e per impianti<br />
con rifiuti non biodegradabili).<br />
I Titoli <strong>di</strong> Efficienza Energetica, anche detti certificati<br />
bianchi, sono emessi a favore dei soggetti che realizzano<br />
progetti <strong>di</strong> risparmio energetico sulla base <strong>di</strong> una certificazione<br />
effettuata dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il<br />
Gas, quali i <strong>di</strong>stributori <strong>di</strong> energia elettrica e gas naturale<br />
(o società da esse controllate) e le ESCO. Gli interventi <strong>di</strong><br />
risparmio possono essere sia a monte del processo produttivo<br />
sia presso l’utente finale, ad esempio favorendo la<br />
sostituzione <strong>di</strong> elettrodomestici e caldaie in favore <strong>di</strong> apparecchi<br />
a più alta efficienza.<br />
Le operazioni <strong>di</strong> scambio dei certificati bianchi, svolte attraverso<br />
contratti bilaterali o tramite il mercato gestito<br />
dal Gestore del Mercato Elettrico, permettono ai <strong>di</strong>stributori<br />
<strong>di</strong> energia che hanno ottenuto risparmi inferiori al loro<br />
obiettivo annuo e che, quin<strong>di</strong>, non sono in grado <strong>di</strong> ottemperare<br />
agli obblighi <strong>di</strong> legge imposti, <strong>di</strong> adempiere ai<br />
loro impegni. Viceversa i produttori che raggiungono risparmi<br />
eccedenti hanno la possibilità <strong>di</strong> realizzare profitti<br />
vendendo i propri titoli.<br />
Il conseguimento dei Titoli <strong>di</strong> Efficienza Energetica varia in<br />
funzione della tipologia <strong>di</strong> progetto sottoscritto, quin<strong>di</strong>, del<br />
risparmio ottenuto. Le soglie per l’ottenimento del certificato<br />
vanno da un minimo <strong>di</strong> 25 ad un massimo <strong>di</strong> 200 tep annui<br />
(tonnellata equivalente <strong>di</strong> petrolio risparmiata). Un singolo<br />
certificato bianco equivale a un risparmio <strong>di</strong> 1 tep.<br />
Nel sistema “feed in tariff” viene invece incentivata <strong>di</strong>rettamente<br />
l’energia prodotta, che è ritirata ad un valore superiore<br />
a quello <strong>di</strong> mercato poiché comprensivo della quota<br />
<strong>di</strong> incentivo.<br />
Il “conto energia”, gestito dal GRTN, il Gestore del Sistema<br />
Elettrico Nazionale, premia, con tariffe incentivanti e<br />
per un periodo <strong>di</strong> venti anni, l’energia prodotta dagli impianti<br />
fotovoltaici, energia che può essere auto consuma-<br />
ta, anche con il sistema dello scambio sul posto, oppure<br />
venduta al mercato.<br />
In particolare, per gli impianti entrati in esercizio a partire<br />
dal 1 gennaio <strong>2009</strong>, é prevista la corresponsione <strong>di</strong> tariffe<br />
comprese tra 0,353 e 0,480 €/kWh in funzione della<br />
classe <strong>di</strong> potenza degli impianti e del livello <strong>di</strong> integrazione<br />
architettonica.<br />
E’ previsto un incremento del 5% delle tariffe per le scuole<br />
o le strutture sanitarie pubbliche, gli enti locali con popolazione<br />
minore a 5 mila abitanti, gli e<strong>di</strong>fici, i fabbricati e le<br />
strutture <strong>di</strong> destinazione agricola in sostituzione <strong>di</strong> coperture<br />
in eternit o contenenti amianto, gli impianti superiori<br />
a 3kW non integrati il cui soggetto responsabile autoconsumi<br />
almeno il 70% dell’energia prodotta.<br />
In alternativa ai certificati ver<strong>di</strong>, la Legge Finanziaria<br />
2008 ha introdotto il sistema della tariffa omnicomprensiva<br />
per l’energia prodotta da fonti rinnovabili. L’incentivo<br />
varia in funzione della fonte rinnovabile <strong>di</strong> origine, ed è<br />
riconosciuto agli impianti <strong>di</strong> potenza nominale me<strong>di</strong>a annua<br />
non superiore ad 1 MW (o non superiore a 0,2 MW<br />
per gli impianti eolici) entrati in esercizio dopo il 31 <strong>di</strong>cembre<br />
2007. La tariffa varia da un minimo <strong>di</strong> 18 ed un<br />
massimo <strong>di</strong> 30 €cent/Kwh.<br />
Cosa accade in Lombar<strong>di</strong>a<br />
In Lombar<strong>di</strong>a il sostegno alle fonti rinnovabili passa invece<br />
dal Programma Operativo Regionale (POR) e dal nuovo<br />
Piano <strong>di</strong> Sviluppo Rurale (PSR), i programmi cofinanziati<br />
dall’Unione Europea che saranno attivi fino al 2013.<br />
Il riferimento è alle misure dell’Asse 2 del POR che finanziano,<br />
con uno stanziamento <strong>di</strong> 50 milioni <strong>di</strong> euro, la realizzazione<br />
<strong>di</strong> progetti volti alla riduzione dei consumi<br />
energetici, all’incremento della produzione da fonti rinnovabili<br />
e allo sviluppo della cogenarazione. Se si guarda all’entità<br />
delle risorse stanziate sul POR per i temi del risparmio<br />
energetico e dello sviluppo delle fonti rinnovabili,<br />
la Lombar<strong>di</strong>a si colloca nel contesto nazionale fra le prime<br />
<strong>di</strong>eci Regioni. Prime in graduatoria la Campania, con 300<br />
milioni <strong>di</strong> euro <strong>di</strong> fon<strong>di</strong> stanziati, seguono Piemonte e Calabria.<br />
Tale classifica non tiene conto però dell’entità delle<br />
quote <strong>di</strong> contribuzione comunitaria in rapporto allo stanziamento<br />
complessivo che è quasi doppio per le regioni<br />
del Mezzogiorno.<br />
L’obiettivo è incentivare, da un lato interventi innovativi,<br />
anche a valenza <strong>di</strong>mostrativa, mirati a ridurre i consumi e<br />
implementare la certificazione energetica, e, dall’altro, la<br />
realizzazione o l’estensione delle reti <strong>di</strong> teleriscaldamento,<br />
la produzione da impianti mini-idroelettrici e da fonti<br />
geotermiche nonché sistemi a pompa <strong>di</strong> calore.<br />
Fra le prime misure attivate vi è la linea 2.1.2.2, pubblicata<br />
nell’aprile dello scorso anno, che ha messo a <strong>di</strong>sposizione<br />
degli enti locali ben 10 milioni <strong>di</strong> euro per il miglioramento<br />
dell’efficienza energetica degli impianti <strong>di</strong> illumi-<br />
➙
46 <strong>Brescia</strong> ricerche <strong>67</strong>/09<br />
nazione pubblica. Le domande sono ancora in corso <strong>di</strong> valutazione,<br />
mentre sono già state pubblicate le graduatorie<br />
del bando per le reti <strong>di</strong> teleriscaldamento con il quale sono<br />
stati assegnati ad enti locali, imprese, società pubbliche<br />
e private, fon<strong>di</strong> per 19,5 milioni <strong>di</strong> euro con il finanziamento<br />
del POR.<br />
E’ invece aperto fino al 22 ottobre. il bando del POR che<br />
sostiene la ricerca nel settore dell’efficienza energetica con<br />
un contributo a fondo perduto fino all’80% dei costi sostenuti<br />
dalle piccole e me<strong>di</strong>e imprese.<br />
I progetti devono riguardare la messa a punto <strong>di</strong> nuovi<br />
prodotti, processi o servizi e ricadere in una dei seguenti<br />
ambiti: e<strong>di</strong>lizia (materiali, prodotti, processi con caratteristiche<br />
innovative), processi industriali, macchine e motori<br />
elettrici ad alta efficienza energetica, tecnologie avanzate<br />
per l’illuminazione.<br />
Possono ad esempio essere finanziate le spese relative al<br />
personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario),<br />
ai costi degli strumenti e delle attrezzature impiegati nel<br />
progetto; ai costi della ricerca contrattuale, dei brevetti,<br />
delle consulenze e delle competenze tecniche; alle spese<br />
generali (fino al 10% del costo complessivo del personale),<br />
ed altri costi <strong>di</strong> esercizio, incluso il costo dei materiali,<br />
delle forniture e <strong>di</strong> prodotti analoghi.<br />
A <strong>di</strong>sposizione sull’intero territorio regionale vi sono 15<br />
milioni <strong>di</strong> euro.<br />
Opportunità aperte anche per gli enti pubblici. Il riferimento<br />
in questo caso è al bando per la realizzazione <strong>di</strong><br />
Strumenti Settore <br />
FONDO ROTATIVO<br />
KYOTO<br />
NUOVO CONTO<br />
ENERGIA<br />
TARIFFA FISSA<br />
OMNICOMPRENSIVA<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Imprese,<br />
<br />
ESCO, persone<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Persone<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
impianti solari termici destinati alla produzione <strong>di</strong> acqua<br />
ed aria calda, aventi una producibilità uguale o superiore<br />
a 10.000 KWh/anno e dotati <strong>di</strong> contatore <strong>di</strong> calore. Il contributo<br />
è pari al 50% dei costi ammissibili fino ad un massimo<br />
<strong>di</strong> 50 mila euro (60 mila euro se l’impianto è <strong>di</strong>mensionato<br />
anche per la climatizzazione estiva). Le domande<br />
saranno esaminate ed ammesse al contributo seguendo<br />
l’or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> arrivo al protocollo e sino all’esaurimento delle<br />
risorse <strong>di</strong>sponibili.<br />
Si attende invece ancora per la pubblicazione dei ban<strong>di</strong><br />
delle linee 2.1.1.2 per la produzione <strong>di</strong> energia da impianti<br />
mini-idroelettrici, da fonti geotermiche e attraverso sistemi<br />
a pompa <strong>di</strong> calore, e della 2.1.2.1 per il risparmio e la<br />
certificazione energetica.<br />
Il sostegno regionale si concretizza nella concessione <strong>di</strong><br />
un contributo a fondo perduto, e/o <strong>di</strong> un finanziamento a<br />
tasso agevolato, a parziale copertura dei costi <strong>di</strong> ciascun<br />
progetto.<br />
Da ultimo il Piano <strong>di</strong> Sviluppo Rurale, rivolto al sistema<br />
agricolo e agroindustriale, è <strong>di</strong>retto ad incentivare il settore<br />
delle agro energie, delle biomasse nonché la produzione<br />
<strong>di</strong> energia rinnovabile. In particolare la misura 311 prevede<br />
un contributo a fondo perduto per la realizzazione <strong>di</strong><br />
impianti (fino ad 1 Mw) alimentati da fonti alternative,<br />
nonché l’acquisto <strong>di</strong> attrezzature, servizi e macchine funzionali<br />
alla gestione degli impianti stessi.<br />
Per chi investe in rinnovabili le occasioni <strong>di</strong> certo non<br />
mancano!<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
➙
FONTI RINNOVABILI, INCENTIVI AL FUTURO 47<br />
Strumenti Settore <br />
CERTIFICATI VERDI<br />
TITOLI DI EFFICIENZA<br />
ENERGETICA<br />
POR FESR<br />
2007-2013<br />
POR FESR<br />
Misura 1.1.1.1 Azione A<br />
Bando solare termico -<br />
pubblico<br />
PSR Misura 311 Energia<br />
ECOINNOVAZIONE<br />
EIE<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
PMI <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Imprese<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Persone<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Persone
48 <strong>Brescia</strong> ricerche <strong>67</strong>/09<br />
ASAP Service Management Forum (ASAP SMF) accende i riflettori<br />
sul prodotto come servizio, cui de<strong>di</strong>ca il prossimo<br />
convegno intersettoriale, previsto a <strong>Brescia</strong> il 5 e 6 novembre<br />
prossimi. Il tema sta assumendo nuova attualità alla luce<br />
delle contingenze dei mercati: sempre più imprese vorrebbero<br />
ripensare il proprio modello <strong>di</strong> business, non solo per<br />
mantenere margini e quote <strong>di</strong> mercato, ma anche per rispondere<br />
in modo proattivo ad un consumatore che sta cambiando.<br />
Gli acquirenti oggi chiedono non solo una risposta ad un<br />
bisogno emergente, ma esperienze d’uso gratificanti per tutto<br />
il ciclo <strong>di</strong> vita del prodotto.<br />
Il prodotto come servizio impone una nuova strategia: occorre<br />
cambiare la cultura organizzativa e gestionale, con una più<br />
stretta collaborazione fra marketing, operazioni, ricerca e sviluppo,<br />
per affrontare le sfide competitive e cogliere in anticipo<br />
l’orientamento dei clienti. Il convegno indagherà proprio questo<br />
scenario in <strong>di</strong>venire, con due sessioni tecniche, una tavola<br />
rotonda animata dagli amministratori delegati e dagli esponenti<br />
<strong>di</strong> vertice <strong>di</strong> alcune aziende leader, italiane e straniere,<br />
ed il key note speech del professor Andy Neely della Cranfield<br />
School of Management (Regno Unito). I contenuti ed i messaggi<br />
saranno messi a punto, poche settimane prima dell’evento,<br />
dagli stessi top manager industriali che interverranno alla<br />
Un’immagine della scorsa e<strong>di</strong>zione del convegno<br />
ASAP SMF: il prodotto<br />
come servizio<br />
“vitamina” delle nuove<br />
sfide competitive<br />
tavola rotonda, con il supporto dei ricercatori <strong>di</strong> ASAP SMF.<br />
Hanno già aderito importanti realtà industriali, quali: Berloni<br />
Group, Brembo, CMS Industries, Epta Refrigeration, Fiat<br />
Group, Fi<strong>di</strong>a, Franke, GE Oil & Gas, Me<strong>di</strong>amarket, Miele, Océ,<br />
SIAD Macchine Impianti e Volvo.<br />
ASAP Service Management Forum è una community per la<br />
ricerca, la formazione ed il trasferimento <strong>di</strong> soluzioni applicate<br />
alle attività <strong>di</strong> servizio dopo ven<strong>di</strong>ta, cui aderiscono oltre<br />
50 aziende, appartenenti ai settori automotive, apparecchio<br />
domestico e professionale, elettronica <strong>di</strong> consumo, termotecnica,<br />
sistemi <strong>di</strong>gitali e machinery. Nasce nel 2003 dalla collaborazione<br />
<strong>di</strong> gruppi <strong>di</strong> ricerca delle Università <strong>di</strong> Bergamo,<br />
<strong>Brescia</strong> e Firenze, dell’Università Bocconi e del Politecnico <strong>di</strong><br />
Milano, che operano in progetti <strong>di</strong> innovazione gestionale e<br />
tecnologica anche a livello internazionale. ASAP SMF promuove<br />
la cultura organizzativa dei servizi dopo ven<strong>di</strong>ta con<br />
eventi <strong>di</strong> formazione, workshop e convegni, stimolando il<br />
networking professionale e realizzando pubblicazioni tematiche,<br />
tecnico-scientifiche e <strong>di</strong>vulgative. La community ha al<br />
proprio attivo decine <strong>di</strong> workshop e cinque convegni annuali<br />
intersettoriali, cui hanno contribuito relatori aziendali ed accademici<br />
<strong>di</strong> altissimo profilo.<br />
Per approfon<strong>di</strong>menti è <strong>di</strong>sponibile il sito www.asapsmf.org
minori<br />
costi<br />
maggiori<br />
performance<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
maggiore<br />
produttività