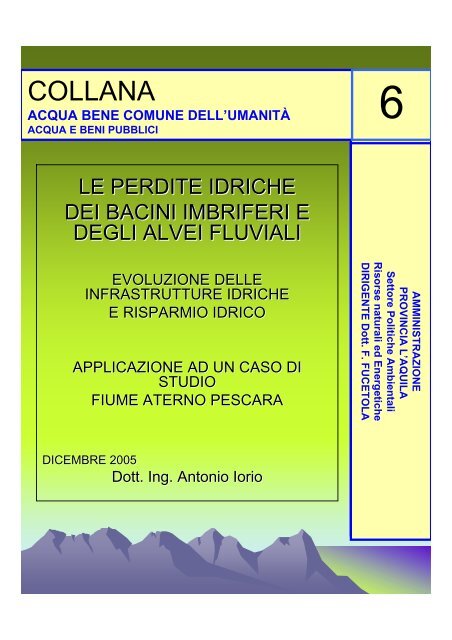Le perdite idriche dei bacini imbriferi e degli alvei fluviali ...
Le perdite idriche dei bacini imbriferi e degli alvei fluviali ...
Le perdite idriche dei bacini imbriferi e degli alvei fluviali ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
COLLANA<br />
ACQUA BENE COMUNE DELL’UMANITÀ<br />
ACQUA E BENI PUBBLICI<br />
LE PERDITE IDRICHE<br />
DEI BACINI IMBRIFERI E<br />
DEGLI ALVEI FLUVIALI<br />
EVOLUZIONE DELLE<br />
INFRASTRUTTURE IDRICHE<br />
E RISPARMIO IDRICO<br />
APPLICAZIONE AD UN CASO DI<br />
STUDIO<br />
FIUME ATERNO PESCARA<br />
DICEMBRE 2005<br />
Dott. Ing. Antonio Iorio<br />
6<br />
AMMINISTRAZIONE<br />
PROVINCIA L’AQUILA<br />
Settore Politiche Ambientali<br />
Risorse naturali ed Energetiche<br />
DIRIGENTE Dott. F. F. FUCETOLA
LE PERDITE IDRICHE DEGLI ALVEI FLUVIALI E<br />
RAPPORTI CON LE DERIVAZIONI<br />
EVOLUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE IDRICHE<br />
E RISPARMIO IDRICO<br />
L’AQUILA DICEMBRE 2005<br />
APPLICAZIONE AD UN CASO DI STUDIO<br />
FIUME ATERNO PESCARA<br />
DOTT. ING. ANTONIO IORIO<br />
Studio Ing. A. Iorio 1
LE PERDITE IDRICHE DEGLI ALVEI FLUVIALI E RAPPORTI CON LE DERIVAZIONI......1<br />
OBIETTIVI DELLO STUDIO...........................................................................................................3<br />
PERDITE AL FONDO NEGLI ALVEI NATURALI...........................................................................................4<br />
LE PERDITE IN ALVEO NEL TRONCO FIUME ATERNO – L’AQUILA MOLINA -.......................................7<br />
PERDITE IN ALVEO DEL TORRENTE RAIALE .........................................................................................12<br />
LE UTILIZZAZIONI IDRICHE NEL BACINO FLUVIALE ATERNO-PESCARA ......18<br />
L’IRRIGAZIONE ......................................................................................................................................18<br />
LE UTILIZZAZIONI IDROELETTRICHE ....................................................................................................22<br />
LE UTILIZZAZIONI POTABILI .................................................................................................................29<br />
LE UTILIZZAZIONI INDUSTRIALI...........................................................................................................31<br />
CONCLUSIONI....................................................................................................................................32<br />
APPENDICE..........................................................................................................................................34<br />
CARATTERI IDROLOGICI DEL BACINO IMBRIFERO ....................................................34<br />
Fiume Aterno .................................................................................................................................34<br />
Fiume Sagittario...........................................................................................................................38<br />
Fiume Pescara...............................................................................................................................41<br />
CENNI SULL'IDROGEOLOGIA .................................................................................................................46<br />
BILANCIO IDROLOGICO.........................................................................................................................58<br />
Studio Ing. A. Iorio 2
Obiettivi dello Studio<br />
<strong>Le</strong> portate <strong>dei</strong> corsi d’acqua sono determinate dagli afflussi meteorici,<br />
dalle caratteristiche territoriali <strong>dei</strong> <strong>bacini</strong> <strong>imbriferi</strong> e dalla natura <strong>dei</strong> suoli nei<br />
quali sono incisi gli <strong>alvei</strong>.<br />
La natura <strong>dei</strong> terreni <strong>degli</strong> <strong>alvei</strong> determina in modo sostanziale le<br />
<strong>perdite</strong> per infiltrazione nel sottosuolo e la capacità quindi di conservare i<br />
corpi idrici fluenti specialmente nei periodi estivi di minore portata.<br />
La gamma della permeabilità <strong>dei</strong> terreni è molto ampia: gli <strong>alvei</strong> in<br />
roccia o in argilla risultano fortemente conservativi nei riguardi <strong>dei</strong> deflussi<br />
mentre gli <strong>alvei</strong> in ghiaie o terreni sciolti sono fortemente disperdenti.<br />
I caratteri di permeabilità <strong>degli</strong> <strong>alvei</strong> risultano determinanti per<br />
valutare le portate minime fluenti nei periodi di magra sia per la<br />
conservazione <strong>degli</strong> equilibri naturali che per la utilizzazione delle acque.<br />
Un caso emblematico è quello del fiume Aterno dalle sorgenti fino alla<br />
confluenza nel fiume Sagittario.<br />
Il bacino imbrifero riceve apporti meteorici dell’ordine di 25 mc/s,<br />
molto elevati rispetto alla media dell’intero bacino Aterno-Pescara, ma<br />
presenta deflussi superficiali assai modesti dell’ordine di 5 mc/s alla sezione<br />
di Molina Aterno.<br />
<strong>Le</strong> <strong>perdite</strong> del bacino sono molto elevate ma ad esse si unisce una<br />
forte permeabilità <strong>degli</strong> <strong>alvei</strong> che lasciano infiltrare nel sottosuolo gran parte<br />
delle acque raccolte.<br />
Studio Ing. A. Iorio 3
Perdite al fondo negli <strong>alvei</strong> naturali<br />
Gli <strong>alvei</strong> <strong>dei</strong> fiumi o canali non rivestiti possono perdere una parte<br />
dell’acqua fluente per filtrazione attraverso la superficie del fondo e delle<br />
sponde.<br />
Il problema delle <strong>perdite</strong> negli <strong>alvei</strong> è stato oggetto di studi, sin<br />
dall’antichità, per dimensionare e realizzare canali per l’irrigazione e per la<br />
navigabilità.<br />
Gli elementi caratteristici per lo studio della questione sono:<br />
- la posizione relativa dell’alveo rispetto al terreno di imposta;<br />
- la posizione relativa dell’alveo rispetto alla eventuale superficie della<br />
falda acquifera naturale all’intorno dell’alveo;<br />
- la capacità di filtrazione <strong>dei</strong> materiali costituenti il fondo e le sponde;<br />
- la dimensione – superficie del fondo e delle sponde bagnate -<br />
dell’alveo.<br />
Un alveo o canale può essere pensile o incassato nel piano campagna.<br />
L’alveo pensile è certamente soggetto a <strong>perdite</strong> più o meno accentuate,<br />
a seconda della natura <strong>dei</strong> materiali del corpo dell’alveo e del terreno di<br />
imposta più o meno permeabili.<br />
e della profondità della superficie della eventuale falda libera.<br />
Nel caso di alveo che incide un territorio nel quale è presente una falda<br />
acquifera naturale, le <strong>perdite</strong> sono condizionate dal dislivello – variabile in<br />
genere nel tempo – che si stabilisce fra il pelo libero nell’alveo e la<br />
superficie della falda.<br />
Il flusso di filtrazione è condizionato anche dalla natura del terreno, più o<br />
meno permeabile, che sostiene la base della falda.<br />
Un alveo parzialmente o totalmente incassato nel terreno può presentare<br />
<strong>perdite</strong> al fondo per filtrazione come quelli pensili.<br />
Il caso che qui interessa è quello di <strong>alvei</strong> dominanti il livello della falda<br />
libera: in caso contrario l’alveo diventa drenante (la falda alimenta il flusso<br />
verso l’alveo).<br />
Studio Ing. A. Iorio 4
<strong>Le</strong> situazioni tipiche che si possono presentare sono esemplificate nella<br />
figura seguente.<br />
Il caso A è quello di un alveo in terreno di permeabilità elevata il cui<br />
fondo domina la falda libera con superficie a profondità dell’ordine della<br />
larghezza dell’alveo.<br />
Il caso B è analogo al precedente ma in terreno poco permeabile.<br />
Studio Ing. A. Iorio 5
Il caso A’ è analogo al caso A ma con superficie di falda molto profonda o<br />
assente che non interferisce con il flusso di filtrazione uscente dall’alveo.<br />
Nel secolo scorso sono stati perfezionati algoritmi di calcolo per valutare<br />
teoricamente le <strong>perdite</strong> per ciascuna situazione tipica – innanzi accennata –<br />
e per i diversi tipi di materiali d’alveo.<br />
Detti schemi sono stati modellati con le tecniche di analogia elettrica ed<br />
in tempi più recenti con i metodi numerici elaborati con calcolatori<br />
elettronici.<br />
A detti studi teorici si è accompagnata una estesa ricerca sperimentale<br />
che ha portato a definire in termini statistici la quantità delle <strong>perdite</strong><br />
riscontrate in migliaia di km di canali in terra di materiali <strong>dei</strong> più diversi tipi.<br />
La letteratura tecnica offre diverse formulazioni empiriche per il calcolo<br />
delle <strong>perdite</strong> ma qui si preferisce quella fornita dal Manuale di Ingegneria<br />
civile ed ambientale - ed. Zanichelli/Esac - che riporta i dati sperimentali per<br />
canali in terra , elaborati da Etcheverry e Harding nel 1933, e rielaborati da<br />
Davis and Sorenson nel 1969, in termini di volume perduto in un giorno (24<br />
ore) per metro quadro di superficie bagnata.<br />
PERDITE AL CONTORNO DI CANALI NON<br />
RIVESTITI DATI TRATTI DA ETCHEVERRY<br />
mc/mq<br />
giorno mc/s / km mq<br />
da a<br />
valore<br />
centrale<br />
Terra argillosa impermeabile<br />
Terra argillosa normale, con strato<br />
impermeabile sotto il fondo del canale con<br />
0,07 0,10 0,17 0,001968<br />
spessore non >60 90 cm 0,10 0,15 0,25 0,002894<br />
Argilla sabbiosa<br />
Argilla con sabbia e ghiaia, ciottoli cementati<br />
0,15 0,23 0,38 0,004398<br />
con argilla 0,23 0,30 0,53 0,006134<br />
Sabbia argillosa 0,30 0,45 0,75 0,008681<br />
Terra sabbiosa 0,45 0,55 1,00 0,011574<br />
Terra sabbiosa con ghiaia 0,55 0,75 1,30 0,015046<br />
terreno ghiaioso permeabile 0,75 0,90 1,65 0,019097<br />
Ghiaia terrosa 0,90 1,80 2,70 0,031250<br />
Studio Ing. A. Iorio 6
<strong>Le</strong> <strong>perdite</strong> in alveo nel tronco Fiume Aterno – L’Aquila Molina -<br />
Il contributo di afflusso (Pioggia efficace = Afflusso meteorico –<br />
Evapotraspirazione reale) alla sezione del bacino a L'AQUILA è dell'ordine di<br />
12,1 mc/s al quale corrisponde una portata di deflusso di 5,71 mc/s<br />
(registrata), pari al 47% dell’afflusso (il 53% si infiltra nel sottosuolo del<br />
bacino e non raggiunge l’alveo nella sezione considerata).<br />
La superficie di falda è a profondità dell’ordine di 100 metri e non<br />
influenza certamente le filtrazioni uscenti dagli <strong>alvei</strong> naturali.<br />
Il contributo di afflusso del sottobacino AQ-MOLINA è dell’ordine di<br />
13,14 mc/s e ci si attenderebbe, considerata la omogeneità geologica del<br />
territorio tributario, un contributo di deflusso in alveo a Molina pari ad una<br />
frazione dell’afflusso analoga a quello di L’Aquila, 47% dell’afflusso efficace,<br />
e quindi pari a 6,2 mc/s.<br />
Il valore medio della portata a Molina risulta di 5,62 mc/s (portata<br />
registrata) il cui ordine di grandezza è effettivamente comparabile con<br />
quello stimato attraverso il contributo di afflusso.<br />
Si osserva tuttavia che la portata fluviale a L’Aquila è di 5,71 mc/s e<br />
che, fluendo a valle, dovrebbe sommarsi a quella di 6,2 mc/s che si forma<br />
nel sottobacino AQ-MOLINA e farebbe ascendere la portata totale a Molina a<br />
11,91 mc/s contro il valore registrato di 5,62 mc/s.<br />
Risulta cioè che, lungo il percorso di circa 40 km, fra la sezione di<br />
L’Aquila e quella di Molina, si perde nel sottosuolo l’intera portata di 5,7<br />
mc/s proveniente dalla sezione di L’Aquila, per un volume medio annuo pari<br />
a 180.070.560 mc.<br />
Il volume medio giornaliero perduto per infiltrazione risulta pari a<br />
493.344 mc/g, equivalente ad una perdita di 12.354 mc /km g.<br />
Confrontando il valore di detta perdita al km con quelli esposti nella<br />
tabella delle <strong>perdite</strong> per canali in terra, di seguito riportata, si rileva che<br />
esso corrisponde alla perdita di un alveo in terreno ghiaioso con sezione<br />
rettangolare delle dimensioni di 6,0 m di base ed altezza di deflusso di circa<br />
0,5 m, pendenza longitudinale del 5 per mille, capace di far defluire la<br />
Studio Ing. A. Iorio 7
portata media di 6 mc/s, pari a quella entrante nel tronco di alveo<br />
considerato.<br />
PERDITE AL CONTORNO DI CANALI NON<br />
RIVESTITI DATI TRATTI DA ETCHEVERRY<br />
mc/mq<br />
giorno mc/s / km mq<br />
da a<br />
valore<br />
centrale<br />
Terra argillosa impermeabile<br />
Terra argillosa normale, con strato<br />
impermeabile sotto il fondo del canale con<br />
0,07 0,10 0,17 0,001968<br />
spessore non >60 90 cm 0,10 0,15 0,25 0,002894<br />
Argilla sabbiosa<br />
Argilla con sabbia e ghiaia, ciottoli cementati<br />
0,15 0,23 0,38 0,004398<br />
con argilla 0,23 0,30 0,53 0,006134<br />
Sabbia argillosa 0,30 0,45 0,75 0,008681<br />
Terra sabbiosa 0,45 0,55 1,00 0,011574<br />
Terra sabbiosa con ghiaia 0,55 0,75 1,30 0,015046<br />
terreno ghiaioso permeabile 0,75 0,90 1,65 0,019097<br />
Ghiaia terrosa 0,90 1,80 2,70 0,031250<br />
I terreni nei quali si sviluppa il tronco fluviale hanno effettivamente<br />
permeabilità molto elevata, ghiaie grosse, come evidenziato nelle notazioni<br />
idrogeologiche relative al territorio del bacino imbrifero, che confermano le<br />
considerazioni svolte innanzi sulle <strong>perdite</strong> al fondo.<br />
Nel periodo estivo gli afflussi meteorici e le portate in alveo sono<br />
molto inferiori e perciò le <strong>perdite</strong> assorbono tutta la portata tanto che a<br />
circa metà del tronco si verifica l’asciutta totale dell’alveo.<br />
Tali considerazioni risultano dai calcoli e sono evidenziate neo grafici<br />
seguenti nei quali si è evidenziata, a titolo esemplificativo, l’immissione<br />
artificiale della portata necessaria per garantire un deflusso minimo<br />
sull’intero tronco.<br />
Da quanto innanzi risulta evidente che il bacino imbrifero dell’Aterno<br />
alimenta prevalentemente per via sotterranea le sorgenti a valle (Gruppo<br />
Pescara e Tirino) e che le <strong>perdite</strong> <strong>dei</strong> deflussi superficiali (per infiltrazione<br />
nel sottosuolo) non fanno che contribuire ai deflussi sotterranei che<br />
comunque raggiungono le sorgenti citate e assicurano il deflusso nel tronco<br />
vallivo dell’Aterno-Pescara a monte delle centrali.<br />
Studio Ing. A. Iorio 8
7,00<br />
6,50<br />
6,00<br />
5,50<br />
5,00<br />
4,50<br />
4,00<br />
3,50<br />
3,00<br />
2,50<br />
2,00<br />
1,50<br />
1,00<br />
0,50<br />
0,00<br />
0<br />
2<br />
4<br />
6<br />
8<br />
10<br />
12<br />
14<br />
16<br />
18<br />
20<br />
22<br />
PORTATA ALVEO MEDIO ANNO<br />
F. ATERNO L'AQUILA MOLINA<br />
CON PERDITE AL FONDO<br />
24<br />
Prog.va alveo (km)<br />
26<br />
Studio Ing. A. Iorio 9<br />
28<br />
30<br />
32<br />
34<br />
36<br />
38<br />
40<br />
42<br />
Q=Qo-<strong>perdite</strong> alveo+C*PEFF (mc/s)<br />
h idrica alveo (m) L = 6 m<br />
Prog.va <strong>perdite</strong> fondo mc/s; Ghiaia terrosa<br />
AFFLLUSSI EFFICACI (mc/s)
3,50<br />
3,00<br />
2,50<br />
2,00<br />
1,50<br />
1,00<br />
0,50<br />
0,00<br />
0,0<br />
L'AQUILA<br />
5,0<br />
10,0<br />
15,0<br />
20,0<br />
PORTATA ALVEO MEDIE ESTIVE<br />
F. ATERNO L'AQUILA MOLINA<br />
CON PERDITE AL FONDO<br />
25,0<br />
Prog.va alveo (km)<br />
30,0<br />
Studio Ing. A. Iorio 10<br />
35,0<br />
MOLINA<br />
40,0<br />
45,0<br />
Q=Qo-<strong>perdite</strong> alveo+C*PEFF (mc/s)<br />
h idrica alveo (m) L = 6 m<br />
Prog.va <strong>perdite</strong> fondo mc/s; terreno ghiaioso<br />
permeabile<br />
AFFLLUSSI EFFICACI (mc/s)
5,50<br />
5,00<br />
4,50<br />
4,00<br />
3,50<br />
3,00<br />
2,50<br />
2,00<br />
1,50<br />
1,00<br />
0,50<br />
0,00<br />
0,0<br />
2,0<br />
L'AQUILA<br />
4,0<br />
6,0<br />
8,0<br />
10,0<br />
12,0<br />
14,0<br />
16,0<br />
PORTATA ALVEO ESTIVE<br />
F. ATERNO L'AQUILA MOLINA<br />
CON PERDITE AL FONDO + immissione ARTIFICIALE<br />
18,0<br />
20,0<br />
22,0<br />
24,0<br />
Prog.va alveo (km)<br />
26,0<br />
28,0<br />
Studio Ing. A. Iorio 11<br />
30,0<br />
32,0<br />
34,0<br />
36,0<br />
38,0<br />
MOLINA<br />
40,0<br />
42,0<br />
Q=Qo-<strong>perdite</strong> alveo+C*PEFF +Q art (mc/s)<br />
h idrica alveo (m) L = 6 m<br />
Prog.va <strong>perdite</strong> fondo mc/s; terreno ghiaioso<br />
permeabile<br />
AFFLLUSSI EFFICACI (mc/s)<br />
Immissione ARTIFICIALE mc/s<br />
Prog.va Immissione ARTIFICIALE mc/s<br />
Portata naturale mc/s
Perdite in alveo del Torrente Raiale<br />
Un ulteriore esempio è dato dalla situazione <strong>dei</strong> deflussi nel torrente Raiale<br />
nel quale per un breve periodo è confluita la portata della sorgente Gran<br />
Sasso Sud e poi captata per uso potabile.<br />
Studio Ing. A. Iorio 12
MESI 8<br />
RISULTATI CALCOLO PORTATE MEDIE AUTUNNO INVERNO -- DEFLUSSO NATURALE RAIALE +SORGENTE GALLERIA SUD<br />
Q=Qo-<strong>perdite</strong><br />
alveo+C*PEFF - irrig<br />
(mc/s)<br />
Prog.va afflussi<br />
(C*PEFF)<br />
(mc/s)<br />
Prog.va<br />
<strong>perdite</strong><br />
fondo<br />
(mc/s)<br />
sez L li km<br />
quota alveo<br />
(m/1000 s.l.m.)<br />
Piazzale Gallerie Sud 0,0 0 0,958 0,500 0,0000 0,000 0<br />
Assergi 1,8 1,8 0,826 0,486 0,2759 0,290 0<br />
Assergi Paganica 5,2 3,4 0,432 0,3226 0,390 0<br />
Assergi Paganica 8,6 3,4 0,650 0,381 0,3693 0,488 0<br />
Paganica Vera 10,2 1,6 0,616 0,268 0,3693 0,601 0<br />
Vera alto 11,9 1,7 0,596 0,196 0,3693 0,673 0<br />
Vera basso 13,0 1,1 0,582 0,175 0,3693 0,694 0<br />
Prelievo<br />
prog.vo<br />
irriguo<br />
(mc/s)<br />
MESI 4<br />
RISULTATI CALCOLO PORTATE MEDIE PRIMAVERA ESTATE -- DEFLUSSO NATURALE RAIALE + SORGENTE GALLERIA SUD<br />
Q=Qo-<strong>perdite</strong><br />
alveo+C*PEFF - irrig<br />
(mc/s)<br />
Prog.va afflussi<br />
(C*PEFF)<br />
(mc/s)<br />
Prog.va<br />
<strong>perdite</strong><br />
fondo<br />
(mc/s)<br />
Prelievo<br />
prog.vo<br />
irriguo<br />
(mc/s)<br />
sez L li km<br />
quota alveo<br />
(m/1000 s.l.m.)<br />
Piazzale Gallerie Sud 0,0 0 0,958 0,500 0,000 0,000 0,000 0,00<br />
Assergi 1,8 1,8 0,826 0,363 0,152 0,289 0,000 0,00<br />
Assergi Paganica 5,2 3,4 0,246 0,178 0,382 0,050 0,50<br />
Assergi Paganica 8,6 3,4 0,650 0,134 0,203 0,469 0,100 1,00<br />
Paganica Vera 10,2 1,6 0,616 0,000 0,203 0,603 0,100 1,00<br />
Vera alto 11,9 1,7 0,596 0,000 0,203 0,603 0,100 1,00<br />
Vera basso 13,0 1,1 0,582 0,000 0,203 0,603 0,100 1,00<br />
Sup<br />
irrigata<br />
kmq<br />
Sup<br />
irrigata<br />
kmq<br />
Studio Ing. A. Iorio 13
RISULTATI CALCOLO PORTATE MEDIE ANNO -- DEFLUSSO NATURALE RAIALE + SORGENTE GALLERIA SUD<br />
Q=Qo-<strong>perdite</strong> alveo<br />
+C*PEFF - irrig<br />
(mc/s)<br />
Prog.va afflussi<br />
(C*PEFF)<br />
(mc/s)<br />
Prog.va<br />
<strong>perdite</strong><br />
fondo (mc/s)<br />
Prelievo<br />
prog.vo<br />
irriguo<br />
(mc/s)<br />
Sup irrigata<br />
(kmq)<br />
sez L li km<br />
quota alveo<br />
(m/1000 s.l.m.)<br />
Piazzale Gallerie Sud 0,0 0 0,958 0,500 0,000 0,000 0,000 0,00<br />
Assergi 1,8 1,8 0,826 0,445 0,235 0,290 0,000 0,00<br />
Assergi Paganica 5,2 3,4 0,370 0,274 0,387 0,017 0,50<br />
Assergi Paganica 8,6 3,4 0,650 0,299 0,314 0,482 0,033 1,00<br />
Paganica Vera 10,2 1,6 0,616 0,179 0,314 0,602 0,033 1,00<br />
INCREMENTO DELLE PORTATE MEDIE ANNO -- DEFLUSSO NATURALE RAIALE + SORGENTE GALLERIA SUD<br />
Q=Qo-<strong>perdite</strong> alveo<br />
+C*PEFF - irrig<br />
(mc/s)<br />
Prog.va afflussi<br />
(C*PEFF)<br />
(mc/s)<br />
Prog.va<br />
<strong>perdite</strong><br />
fondo (mc/s)<br />
Prelievo<br />
prog.vo<br />
irriguo<br />
(mc/s)<br />
sez L li km<br />
quota alveo<br />
(m/1000 s.l.m.)<br />
Piazzale Gallerie Sud 0,0 0 0,958 0,500 0,000 0,000 0,000 0,00<br />
Assergi 1,8 1,8 0,826 0,210 0,000 0,290 0,000 0,00<br />
Assergi Paganica 5,2 3,4 0,202 0,000 0,298 0,000 0,50<br />
Assergi Paganica 8,6 3,4 0,650 0,174 0,000 0,309 0,017 1,00<br />
Paganica Vera 10,2 1,6 0,616 0,127 0,000 0,356 0,017 1,00<br />
Sup irrigata<br />
(kmq)<br />
Studio Ing. A. Iorio 14
1,100<br />
1,000<br />
0,958<br />
0,900<br />
0,800<br />
0,700<br />
0,600<br />
0,500<br />
0,400<br />
0,300<br />
0,200<br />
0,100<br />
0,000<br />
0,0<br />
PORTATE MEDIATE SUI VALORI STAGIONALI MEDI<br />
DEFLUSSO NATURALE PEFF<br />
IN ALVEO CON PERDITE AL FONDO<br />
VALLE PRETARA TORRENTE RAIALE<br />
SORGENTE<br />
GALLERIA SUD<br />
1,0<br />
2,0<br />
3,0<br />
4,0<br />
5,0<br />
6,0<br />
Pro.va alveo km<br />
Studio Ing. A. Iorio 15<br />
7,0<br />
PAGANICA<br />
8,0<br />
9,0<br />
10,0<br />
CONFLUENZA F. VERA<br />
0,051<br />
11,0<br />
quota alveo<br />
(m/1000 s.l.m.)<br />
Q=Qo-<strong>perdite</strong> alveo+<br />
C*PEFF - irrig<br />
(mc/s)<br />
Prog.va afflussi<br />
(C*PEFF) (mc/s)<br />
Prog.va<br />
<strong>perdite</strong> fondo (mc/s)<br />
Prelievo prog.vo irriguo<br />
(mc/s)<br />
Sup irrigata<br />
(kmq)
1,100<br />
1,000<br />
0,958<br />
0,900<br />
0,800<br />
0,700<br />
0,600<br />
0,500<br />
0,400<br />
0,300<br />
0,200<br />
0,100<br />
0,000<br />
0,0<br />
PORTATE ANNUALI MEDIATE SUI VALORI STAGIONALI MEDI<br />
DEFLUSSO NATURALE (PEFF + GALLERIA SUD)<br />
IN ALVEO CON PERDITE AL FONDO<br />
VALLE PRETARA TORRENTE RAIALE<br />
SORGENTE<br />
GALLERIA SUD<br />
1,0<br />
2,0<br />
3,0<br />
4,0<br />
5,0<br />
6,0<br />
Prog.va alveo km<br />
Studio Ing. A. Iorio 16<br />
7,0<br />
PAGANICA<br />
8,0<br />
9,0<br />
10,0<br />
CONFLUENZA F. VERA<br />
0,179<br />
11,0<br />
quota alveo<br />
(m/1000 s.l.m.)<br />
Q=Qo-<strong>perdite</strong> alveo<br />
+C*PEFF - irrig<br />
(mc/s)<br />
Prog.va afflussi<br />
(C*PEFF) (mc/s)<br />
Prog.va<br />
<strong>perdite</strong> fondo (mc/s)<br />
Prelievo prog.vo irriguo<br />
(mc/s)<br />
Sup irrigata<br />
(kmq)
L’acqua che sgorga dalla sorgente Gran Sasso Sud, in media circa<br />
500 l/s, viene dispersa in gran parte, oltre il 80%, lungo il percorso di circa<br />
10 km fino alla confluenza nel F. Vera che a sua volta confluisce nell’Aterno<br />
nei pressi dell’abitato di Bazzano.<br />
Nel migliore <strong>dei</strong> casi la portata media che raggiunge l’Aterno è di 100<br />
l/s, pari al 20% del totale.<br />
A seguito della captazione della sorgente Gran Sasso Sud per uso<br />
potabile e la sua adduzione alla città di L’Aquila mediante acquedotto,<br />
risulta che la quantità di acqua che raggiunge il fiume Aterno è circa il 60%-<br />
70% del totale, superiore di quella che veniva addotta dal Torrente,<br />
considerando anche le <strong>perdite</strong>, all’incirca 30-40%, nelle reti di distribuzione<br />
e di raccolta.<br />
Studio Ing. A. Iorio 17
LE UTILIZZAZIONI IDRICHE NEL BACINO FLUVIALE ATERNO-<br />
PESCARA<br />
L’irrigazione<br />
<strong>Le</strong> più antiche derivazioni sul fiume Aterno sono quelle ad uso irriguo,<br />
rinvenienti da antichi usi dello Stato preunitario, unitamente a quelle di<br />
numerosi mulini.<br />
<strong>Le</strong> concessioni <strong>dei</strong> mulini sono venute a cessare con l’avvento della<br />
produzione di energia termica ed idroelettrica.<br />
<strong>Le</strong> concessioni irrigue sono state rilasciate con i criteri storici, modi ed<br />
usi, e per impianti irrigui costituiti da reti di canali prevalentemente di terra:<br />
- dotazione specifica da 1,0 a 2,0 l/sha;<br />
- uso dell’acqua per tutto l’anno solare, per assicurare<br />
l’approvvigionamento idrico anche per gli usi civili rurali, agricoli e<br />
zootecnici nonché la vivibilità <strong>dei</strong> canali.<br />
I comprensori irrigui si estendono su una superficie territoriale di<br />
circa 7.000 ettari nel bacino dell’Aterno, 10.000 ettari nei sotto<strong>bacini</strong> del<br />
Sagittario e Tirino, e circa 15.000 ettari nel bacino del Pescara.<br />
<strong>Le</strong> utilizzazioni irrigue sono in atto e sono state riorganizzate per la<br />
gran parte con nuove opere di distribuzione.<br />
I nuovi impianti irrigui hanno permesso di ridurre i consumi specifici<br />
per ettaro a valori medi di 0,5 l/sha.<br />
La durata di utilizzazione annuale è limitata alla sola stagione irrigua<br />
(sei mesi) essendo venuti meno, in gran parte, gli altri usi idrici rurali nella<br />
restante parte dell’anno.<br />
Nel bacino Aterno-Sagittario, a monte delle utilizzazioni idroelettriche<br />
del fiume Pescara, i volumi irrigui attualmente impegnati risultano inferiori<br />
di circa il 30% rispetto ai volumi annuali impegnati dalle concessioni<br />
precedenti.<br />
Considerando solo alcune concessioni sull’Aterno e sul Sagittario si è<br />
conseguito un risparmio idrico equivalente ad una portata media annuale di<br />
circa 2,1 mc/s come esposto nella tabella seguente:<br />
Studio Ing. A. Iorio 18
UTILIZZAZIONI IRRIGUE A MONTE DELLE DERIVAZIONI IDROELETTRICHE ENEL FIUME PESCARA (1°, 2°, 3°, 4° SALTO)<br />
BACINO FIUME/SOTTOBACINO DERIVAZIONE<br />
ATERNO-PESCARA ATERNO Molina Aterno<br />
IMPEGNO PORTATA<br />
CONCESSIONI ATTUALI<br />
IMPEGNO PORTATA CONCESSIONI<br />
PREVIGENTI<br />
Q<br />
(mc/s) MESI Q media anno (mc/s) Q (mc/s) MESI Q media anno (mc/s)<br />
Impianto irriguo<br />
Corfinio 2° 1,080 6 0,540 1,080 12 1,080<br />
Domanda in data R.D./D.M.<br />
ATERNO-PESCARA SAGITTARIO DERIVAZIONE CONCESSIONI ATTUALI CONCESSIONI PREVIGENTI<br />
Anversa <strong>degli</strong> Abruzzi<br />
Impianto irriguo<br />
Q<br />
(mc/s) MESI Q media anno (mc/s) Q (mc/s) MESI Q media anno (mc/s)<br />
Sagittario 1° 1,756 6 0,878 1,756 12 1,756<br />
Domanda in data R.D./D.M.<br />
ATERNO-PESCARA SAGITTARIO DERIVAZIONE CONCESSIONI ATTUALI CONCESSIONI PREVIGENTI<br />
Anversa <strong>degli</strong> Abruzzi<br />
Impianto irriguo<br />
Q<br />
(mc/s) MESI Q media anno (mc/s) Q (mc/s) MESI Q media anno (mc/s)<br />
Sagittario 2° 1,500 6 0,750 1,500 12 1,500<br />
Domanda in data R.D./D.M.<br />
IMPEGNO PORTATA IMPEGNO PORTATA CONCESSIONI<br />
ATERNO-PESCARA ATERNO- SAGITTARIO TOTALE DERIVAZIONI CONCESSIONI ATTUALI<br />
PREVIGENTI<br />
Q media anno (mc/s) Q media anno (mc/s)<br />
2,168 4,336<br />
ATERNO-PESCARA ATERNO- SAGITTARIO RISPARMIO IDRICO = IMPEGNO DI PORTATA (PREVIGENTE - ATTUALE)<br />
Q media anno (mc/s)<br />
2,168<br />
Studio Ing. A. Iorio 19
Studio Ing. A. Iorio 20
Studio Ing. A. Iorio 21
<strong>Le</strong> utilizzazioni idroelettriche<br />
<strong>Le</strong> concessioni idroelettriche sull’asta dell’Aterno e del fiume Pescara<br />
sono molto risalienti nel tempo:<br />
- MOLINA ATERNO<br />
La centrale, realizzata nel 1904, è ubicata al confine <strong>dei</strong> Comuni di<br />
Castelvecchio Subequo e Raiano.<br />
- 1° SALTO PESCARA - BUSSI-TOCCO DA CASAURIA<br />
L'impianto di Pescara I salto (PE) è localizzato nel territorio comunale<br />
di Tocco da Casauria. La sua opera di presa e successivamente la<br />
centrale sono agevolmente visibili sulla sinistra della Tiburtina Valeria,<br />
all'altezza di Bussi Officine. La centrale, realizzata nel 1907 dalla<br />
Società Italiana Elettrochimica (che aveva i suoi stabilimenti a Bussi),<br />
fu acquistata dalla SME che aveva realizzato nel 1912 la linea di<br />
trasporto dell'energia elettrica Pescara-Napoli. La centrale attuale,<br />
completamente distrutta nel secondo conflitto mondiale, è stata<br />
ricostruita nel dopoguerra utilizzando il modello originario.<br />
- 2° SALTO - BOLOGNANO<br />
L'impianto, localizzato nel territorio comunale di Bolognano (PE), in<br />
località Piano d'Orta, era in passato chiamato Pescara II salto. La<br />
centrale fu realizzata nel 1912 dalla Società Italiana di Elettrochimica<br />
su progetto dell'ingegnere Ulisse del Buono. Successivamente la<br />
centrale fu acquisita dalla SME. L'impianto utilizza le acque del<br />
Pescara captate in corrispondenza dello scarico della Centrale I salto<br />
mediante una derivazione, in parte a cielo aperto, di notevole<br />
interesse costruttivo. Dalla vasca di carico (conservata nella soluzione<br />
originale) si staccano 5 condotte forzate per alimentare, con un salto<br />
di circa 74 metri, la sottostante sala macchine. La centrale originaria,<br />
con un involucro caratterizzato da sobri riferimenti ad un classicismo<br />
semplificato, è stata completamente distrutta nel periodo bellico e<br />
ricostruita in forme razionaliste nel 1946.<br />
Studio Ing. A. Iorio 22
- 3° SALTO - ALANNO<br />
L'impianto è localizzato nel territorio comunale di Alanno (PE).<br />
L'elemento di maggiore interesse del sistema è la diga di<br />
sbarramento sul Pescara, ben visibile (procedendo verso la costa)<br />
sulla sinistra dell'autostrada e della Tiburtina a meno di 2 chilometri<br />
da Scafa. La diga in terra, per un volume di invaso di circa 1 x 10^6<br />
mc, con una struttura in cemento armato per il sostegno delle<br />
paratoie, fu realizzata tra il 1928 e il 1931. Dal bacino, una<br />
derivazione in parte a cielo aperto trasporta le acque ad una vasca di<br />
carico soprastante la centrale. Quest'ultima distrutta nel Secondo<br />
conflitto mondiale fu ricostruita e riattivata nel 1947.<br />
- 4° SALTO - TRIANO<br />
L'impianto, realizzato tra il 1938 e il 1942, è localizzato nel territorio<br />
comunale di Chieti. L'impianto è alimentato da una derivazione che<br />
ha la sua opera di presa presso lo sbarramento del 3° salto a valle di<br />
Alanno Scalo dalla quale inizia un canale in galleria fino alla vasca di<br />
carico in località Triano. La restituzione della centrale nel Pescara è<br />
ubicata a circa 3 km a monte della stazione idrometrografica di<br />
S.Teresa di Spoltore. La centrale, gravemente danneggiata nel<br />
periodo bellico, fu riattivata nel 1947.<br />
Aterno-Pescara<br />
Prog.va Asta<br />
fluviale km<br />
Altitudine<br />
m s.l.m<br />
Passo Capannelle 0,0 1240<br />
Capitignano 10,0 900<br />
Aterno Treponti 25,0 760<br />
Aterno L'Aquila 43,0 616<br />
CAMPANA 56,0 560<br />
Aterno Molina 82,0 435<br />
S.Venanzio 87,0 250<br />
Aterno-Sagittario<br />
Alloggiamento 98,0 242<br />
Pescara Maraone 100,0 240<br />
Studio Ing. A. Iorio 23
Pescara conf Tirino 105,0 237<br />
Pescara 1° salto 109,0 209<br />
Pescara 2° salto 116,6 93<br />
Pescara 3° salto 124,1 48<br />
Pescara 4° salto 141,6 7<br />
Pescara S. Teresa 144,1 4,5<br />
Pescara Foce 153,0 0<br />
<strong>Le</strong> opere di derivazione delle concessioni idroelettriche sono state<br />
spesso adattate per salvaguardare le preesistenti opere di derivazione<br />
irrigue e le concessioni prevedono obblighi per la salvaguardia <strong>degli</strong> usi<br />
irrigui in atto o futuri (alla data della concessione originaria):<br />
- MOLINA ATERNO, opera di restituzione a monte della derivazione<br />
irrigua di 1,080 mc/s del canale Corfinio 2° (canale in galleria di epoca<br />
romana della lunghezza di circa 5 km);<br />
- 3° SALTO, obbligo di derivazione di 3,5 mc/s ad uso irriguo a favore<br />
<strong>dei</strong> territori in sinistra del Pescara – ex Consorzio Bonifica Vestina -;<br />
- 4° SALTO, obbligo di vettoriamento di 3,5 mc/s nel canale adduttore<br />
MOLINA<br />
della centrale per gli usi irrigui in destra Pescara.<br />
DATI DI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDROELETTRICHE<br />
Superficie<br />
bacino<br />
tributario<br />
kmq<br />
portata<br />
mc/s<br />
salto<br />
m<br />
potenza<br />
nominale<br />
media<br />
Studio Ing. A. Iorio 24<br />
kW<br />
Decreti<br />
concessione<br />
ATERNO 1.303 4,100 14,40 579 D.R. 1936 e D.M. 1948<br />
1° SALTO 2.400 41,200 27,65 11.306 D.R. 1940 e D.M. 1959<br />
2° SALTO in<br />
serie al 1° 2.400 41,200 75,90 30.657<br />
D.P.R. 1951e D.M.<br />
1955
3° SALTO in<br />
serie al 2° 2.609 45,000 48,41 19.794 D.M. 1938<br />
4° SALTO in<br />
serie al 3° 2.609 46,700 48,12 19.675 D.M. 1942<br />
Studio Ing. A. Iorio 25
135<br />
130<br />
125<br />
120<br />
115<br />
110<br />
105<br />
100<br />
95<br />
90<br />
85<br />
80<br />
75<br />
70<br />
65<br />
60<br />
55<br />
50<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
TREPONTI<br />
Stazioni idrometrografiche e centrali<br />
ATERNO-PESCARA<br />
L'AQUILA<br />
5,31<br />
3,86<br />
13,03<br />
42,31<br />
Studio Ing. A. Iorio 26<br />
5,62<br />
31,57<br />
0<br />
5<br />
10<br />
15<br />
20<br />
25<br />
30<br />
35<br />
40<br />
45<br />
50<br />
55<br />
60<br />
65<br />
70<br />
75<br />
80<br />
85<br />
90<br />
95<br />
100<br />
105<br />
110<br />
115<br />
120<br />
125<br />
130<br />
135<br />
140<br />
145<br />
150<br />
155<br />
160<br />
MOLINA ATERNO<br />
Prog.va fluviale km<br />
SUP BACINO kmqx100 PORTATA MEDIA mc/s Altitudine m x 10<br />
ALLOGGIAMENTO<br />
MARAONE<br />
1° SALTO<br />
1° SALTO<br />
PRESA SERIE<br />
QUATTRO SALTI PESCARA<br />
BUSSI<br />
2°SALTO<br />
3° SALTO<br />
4° SALTO<br />
S.TERESA<br />
53,31
Studio Ing. A. Iorio 27
Studio Ing. A. Iorio 28
<strong>Le</strong> utilizzazioni potabili<br />
Sino agli anni 1960 risultavano in atto modeste derivazioni ad uso<br />
potabile, per lo più dislocate in zone ad altitudine elevate, che attingevano a<br />
sorgenti molto lontane dai corsi d’acqua.<br />
La zona del bacino imbrifero dell’Aterno è povera di sorgenti<br />
specialmente ad altitudine superiore ai 700 metri.<br />
Tale situazione aveva costretto alla realizzazione di onerosi sistemi di<br />
adduzione con prelievo di risorse <strong>idriche</strong> fuori del bacino imbrifero:<br />
- il primo è quello del Chiarino che deriva dal bacino del Vomano;<br />
- il secondo è quello della Ferriera che deriva dal bacino del Fucino-<br />
Liri;<br />
- il terzo è quello dell’ex Consorzio del Circondario di Cittaducale che<br />
deriva dal bacino del Velino (Tevere).<br />
Detti sistemi acquedottistici assicuravano la disponibilità di acqua<br />
potabile al minimo indispensabile ma in misura nemmeno sufficiente per<br />
l’epoca.<br />
La quantità media complessiva annuale dell’apporto esterno al bacino<br />
risultava di circa 300 l/s.<br />
Studio Ing. A. Iorio 29
EX CIT<br />
FERRIERA PULCIARA<br />
CHIARINO<br />
APPORTI IDRICI ARTIFICIALI<br />
DA BACINI ESTERNI<br />
Studio Ing. A. Iorio 30
<strong>Le</strong> utilizzazioni industriali<br />
<strong>Le</strong> utilizzazioni industriali riguardano essenzialmente prelievi da<br />
subalvea frazionate in numerosi prelievi di modesta entità.<br />
La caratteristica di detti prelievi, per quanto qui interessa, è la<br />
restituzione totale in alveo delle portate prelevate e di non modificare il<br />
bilancio delle risorse <strong>idriche</strong> superficiali+sotterranee.<br />
Studio Ing. A. Iorio 31
CONCLUSIONI<br />
La possibilità di effettuare prelievi idrici da un corso d’acqua è<br />
condizionata dalla quantità di acqua disponibile e dal rapporto con lo stato<br />
ambientale quo ante e dalle modifiche indotte dai prelievi.<br />
Lo studio della situazione quo ante è spesso caratterizzata da<br />
riferimenti a condizioni naturali ottimistiche rispetto alle condizioni reali: si<br />
immagina che il fiume allo stato naturale possa sempre trovarsi nelle<br />
condizioni ottimali e come tali da preservare.<br />
La realtà è molto variegata e spesso offre delle sorprese inattese.<br />
Alcuni impostazioni naturalistiche spingono a definire minimi deflussi<br />
vitali che non corrispondono alle quantità di deflusso minimo registrate negli<br />
<strong>alvei</strong> cosicché ci si costringe ad impegnare anche le pur limitate risorse<br />
disponibili per lasciarle defluire a valle.<br />
Gli usi millenari delle risorse <strong>idriche</strong> si sono armonizzati con i caratteri<br />
e gli insediamenti propri di ciascuna parte <strong>dei</strong> <strong>bacini</strong> <strong>imbriferi</strong> e risulta assai<br />
problematico cercare di ritornare ad un equilibrio preistorico, non<br />
raggiungibile anche perché non definibile, a meno di mere astrazioni che<br />
portano ad incidere pesantemente sulle attività antropiche attuali.<br />
L’evoluzione delle modalità di captazione, trasporto e distribuzione<br />
delle acque hanno consentito di ridurre fortemente i prelievi idrici,<br />
specialmente per quelli più antichi come quelli irrigui, permettendo grandi<br />
risparmio di acque fluenti con benefici effetti sui deflussi nei periodi<br />
stagionali di minore disponibilità.<br />
<strong>Le</strong> reti di acquedotto potabile che impegnano le risorse <strong>idriche</strong> più<br />
pregiate di sorgente o di falda presentano anche esse elevati progressi per<br />
la riduzione delle <strong>perdite</strong> e quindi per il minore impegno delle stesse.<br />
Il settore potabile tuttavia incide in misura molto ridotta nell’equilibrio<br />
idrologico del bacino imbrifero in quanto di quantità ridotta rispetto alle<br />
acque fluenti e comunque perché restituisce direttamente ai corsi d’acqua<br />
gran parte, circa il 70%, delle acque derivate.<br />
Studio Ing. A. Iorio 32
I prelievi da falda per qualsiasi uso modificano le condizioni locali<br />
della falda e quindi il suo equilibrio tuttavia, a livello di bacino imbrifero,<br />
incidono relativamente trattandosi di utilizzazioni che restituiscono gran<br />
parte delle acque utilizzate.<br />
Resta salvo il principio di tutela qualitativa delle acque e quindi la<br />
necessità di limitarne i prelievi secondo il tipo di utilizzazione e fonte e di<br />
restituire le acque usate a livello di qualità compatibile.<br />
Studio Ing. A. Iorio 33
APPENDICE<br />
Caratteri idrologici del bacino imbrifero<br />
Fiume Aterno<br />
Il Fiume Aterno ha origine dal versante occidentale del Gran Sasso e<br />
scorre in provincia dell’Aquila; il suo bacino idrografico si estende per 1.342<br />
Kmq.<br />
Lungo il suo corso si trovano tre stazioni idrometriche, i cui elementi<br />
caratteristici sono riassunti nella Tab. 1.<br />
Tab. 1 – Caratteristiche idrologiche dell’Aterno a Treponti,<br />
Stazione<br />
idrometric (m.s.m.) sotteso<br />
a<br />
Quota<br />
Bacino<br />
(Kmq)<br />
L’Aquila e Molina<br />
Periodo<br />
di osser-<br />
vazione<br />
Portata<br />
media<br />
annua<br />
(mc/s)<br />
Portata di massima<br />
piena<br />
mc/s data<br />
Treponti 760 114 1937-69 1,13 57 19/9/52<br />
L’Aquila 640 531 1951-69 4,25 221 24/12/59<br />
Molina 435 1.303 1925-69 5,81 143 16/12/57<br />
(Ministero LL.PP. – Servizio Idrografico Pescara 1970)<br />
Studio Ing. A. Iorio 34
Studio Ing. A. Iorio 35
Studio Ing. A. Iorio 36
Gli interventi di sistemazione idraulica lungo il corso dell’Aterno sono<br />
costituiti da difesa di sponda continue e isolate. Numerosi tributari minori<br />
sono interessati da briglie isolate e in serie. L’opera di rimboschimento è<br />
stata attuata su entrambi i versanti del bacino, su aree più estese nel primo<br />
settore montano e nella zona centrale. I comuni interessati sono:<br />
Montereale, Cagnano Amiterno, Barete, Pizzoli, L’Aquila, Barisciano, Poggio<br />
Licenze, Ocre, Fossa, S. Eusanio Forconese, Balascio, Acciano, Navelli,<br />
Castelvecchio Calvisio, S. Pio delle Camere, Castelvecchio Subequo, Molina<br />
Aterno, Fontecchio, Tione <strong>degli</strong> Abruzzi, Goriano Sicoli, Raiano, Vittorito,<br />
Caporciano, Secinaro.<br />
Gli affluenti maggiori dell’Aterno interessati da interventi di<br />
sistemazione sono il Ruara, il Raio e il Fossa (di destra), il Mozzano, il<br />
Studio Ing. A. Iorio 37
Barete, l’Indice e il Ferone (di sinistra), tutti situati nelle province dell’Aquila<br />
e Pescara.<br />
Il fosso di Ruara, che ha confluenza presso Marana, e interessato da<br />
piccole aree di rimboschimento sulla sinistra del medio e basso corso di due<br />
affluenti di sinistra.<br />
Il Torrente Raio, con confluenza presso L’Aquila, presenta piccole aree<br />
di rimboschimento su entrambi i versanti del medio e basso bacino, nei<br />
comuni di Tornimparte, L’Aquila e Scoppito.<br />
Il fosso di Fossa, anch’esso con confluenza presso L’Aquila, è<br />
interessato da difese di sponda lungo il suo corso nei pressi di S. Eusanio<br />
Forconese, Fossa e L’Aquila e da piccoli rimboschimenti su entrambi i<br />
versanti dell’alto bacino in comune di Fossa.<br />
Nel bacino del Torrente Mozzano, che confluisce a sinistra nell’Aterno<br />
presso Montereale, vi sono briglie in serie nell’alto corso e lungo tre<br />
affluenti; gli interventi forestali sono concentrati nell’alto e medio bacino,<br />
nei comuni di Pizzoli, L’Aquila, Capitignano, Montereale.<br />
Nel Torrente Barete si hanno briglie isolate e in serie e piccole aree di<br />
rimboschimenti nell’alto e medio bacino in comune di Barete.<br />
Nei <strong>bacini</strong> <strong>dei</strong> fossi dell’Indice e del Ferone vi sono briglie nel medio<br />
corso di alcuni affluenti e piccole aree rimboschite nei comuni di Pizzoli e di<br />
L’Aquila.<br />
Fiume Sagittario<br />
Il Fiume Sagittario scorre fra l’Appennino abruzzese e il massiccio<br />
della Maiella; il bacino idrografico ha una superficie complessiva di 619<br />
Kmq.<br />
Lungo il suo corso si trovano due stazioni idrometriche, le cui<br />
caratteristiche sono riassunte nella Tab. 2.<br />
Studio Ing. A. Iorio 38
Tab. 2 – Caratteristiche idrologiche del Sagittario a Villalago e<br />
Capo Canale<br />
Stazione<br />
Bacino<br />
Quota<br />
idrometric sotteso<br />
(m.s.m.)<br />
a<br />
(Kmq)<br />
Periodo<br />
di osser-<br />
vazione<br />
Portata<br />
media<br />
annua<br />
(mc/s)<br />
Portata di<br />
massima piena<br />
mc/s data<br />
Villalago 808 108 1932-69 1,44 6,8 12/01/63<br />
Capo<br />
Canale<br />
269 599 1927-69 7,04 58,0 29/06/40<br />
(Ministero LL.PP. – Servizio Idrografico Pescara 1970)<br />
Studio Ing. A. Iorio 39
Sul Sagittario è stato realizzato il lago artificiale di S. Domenico al<br />
Sagittario (1,30 x 10 6 mc).<br />
Gli interventi di sistemazione che interessano direttamente il fiume<br />
comprendono difese di sponda continue nel corso inferiore nei pressi di<br />
Pratola Peligna, Roccacasale, Corfinio e Popoli, briglie isolate distribuite<br />
lungo affluenti minori di destra nei pressi di Sulmona e di Roccacasale;<br />
rimboschimenti su numerose piccole aree nei comuni di Scanno, Villalago,<br />
Bugnara, Goriano Sicoli, Prezza, Sulmona, Pratola Peligna, Roccacasale e<br />
Corfinio.<br />
In comune di Scanno, sulle pendici in destra dell’alto bacino, vi è<br />
un’opera di drenaggio.<br />
Gli interventi attuati nel Fiume Gizio, affluente di destra del<br />
Sagittario, sono costituiti da isolate difese di sponda nel basso corso nei<br />
pressi di Sulmona, da briglie isolate lungo il corso di alcuni suoi affluenti nei<br />
pressi di Rocca Pia, Pettorano sul Gizio, Introdacqua e Pacentro e da piccoli<br />
rimboschimenti nel territorio <strong>dei</strong> suddetti comuni e in quelli di Cansano e<br />
Campo di Giove.<br />
Il rio di Pezzana, affluente di sinistra del Sagittario, è interessato<br />
soltanto da piccole aree di rimboschimento nell’alto e medio bacino, nei<br />
comuni di Cocullo e Anversa <strong>degli</strong> Abruzzi.<br />
Studio Ing. A. Iorio 40
Fiume Pescara<br />
Esso ha origine dalla confluenza, presso Popoli, <strong>dei</strong> fiumi Aterno e<br />
Sagittario e sfocia in mare a Pescara. I due tributari presentano ampi <strong>bacini</strong><br />
di forma aperta, il primo orientato da nord-ovest a sud-est, il secondo da<br />
sud a nord.<br />
di 53 mc/s.<br />
Il bacino idrografico alla foce risulta di 3.169 Kmq con portata media<br />
Studio Ing. A. Iorio 41
Portata Q mc/s<br />
55,00<br />
50,00<br />
45,00<br />
40,00<br />
35,00<br />
30,00<br />
25,00<br />
20,00<br />
15,00<br />
10,00<br />
5,00<br />
0,00<br />
Pescara Bussi<br />
Mediamese<br />
Fiume Aterno-Sagittario-Pescara-Tirino<br />
a Bussi 1948 - 1986<br />
g f m a m g l a s o n d<br />
48,87 50,51 51,73 49,93 44,89 40,36 37,66 37,97 40,83 43,78 47,09 49,96<br />
Mediamingg 44,67 44,98 44,11 45,24 40,40 37,24 36,22 36,41 37,69 41,16 43,29 44,24<br />
Min mese 31,16 33,17 30,63 32,12 29,93 30,64 28,66 28,92 30,31 33,24 35,67 37,77<br />
Min gior 29,40 28,56 29,12 28,84 27,10 27,10 27,70 27,40 29,12 29,96 34,32 34,40<br />
Studio Ing. A. Iorio 42
Il fiume riceve nei pressi di Bussi il cospicuo contributo del fiume<br />
Tirino e quindi attraversa la cordigliera del Gran Sasso-Morrone-Maiella<br />
nella gola di Tre Monti e scende nella valle omonima sino al mare.<br />
Il bacino imbrifero tributario, nella sezione di Bussi, ha una superficie<br />
di 2339 kmq con portate medie di circa 42 mc/s.<br />
Studio Ing. A. Iorio 43
Portata equivalente mc/<br />
SupTOT<br />
kmq *100<br />
AFF TOT<br />
mc/s<br />
ETR<br />
mc/s<br />
PEFF<br />
mc/s<br />
97,94<br />
90,95<br />
83,95<br />
76,95<br />
69,96<br />
62,96<br />
55,97<br />
48,97<br />
41,97<br />
34,98<br />
27,98<br />
20,99<br />
13,99<br />
7,00<br />
0,00<br />
-7,00<br />
-13,99<br />
-20,99<br />
-27,98<br />
-34,98<br />
DT deflusso superficiale<br />
mc/s<br />
Perdite (-) Apporti (+)<br />
del bacino mc/s<br />
Aterno alla<br />
confluenza<br />
Sagittario<br />
Sagittario Aterno-Sagittario<br />
DEFLUSSI NELLE SEZIONI DEL<br />
FIUME ATERNO PESCARA TIRINO<br />
- MEDIO ANNO -<br />
Aterno-Pescara<br />
a Maraone<br />
13,03 5,99 19,61 20,03 3,36 22,82 23,39 31,57<br />
38,22 17,61 56,15 57,35 7,63 63,44 64,98 89,40<br />
12,32 5,63 18,65 19,17 2,58 21,12 21,74 31,11<br />
25,90 11,98 37,50 38,19 5,05 42,32 43,24 58,28<br />
5,62 10,39 15,42 27,31 15,00 19,42 42,31 53,31<br />
-20,28 -1,59 -22,08 -10,88 9,95 -22,90 -0,93 -4,97<br />
Studio Ing. A. Iorio 44<br />
Tirino<br />
Aterno-Pescara-<br />
Tirino<br />
Provincia L'Aquila<br />
Confluenza Tirino<br />
Pescara<br />
(alla foce)
Si rileva la discordanza fra il limite amministrativo della Provincia ed il<br />
limite del bacino imbrifero dell'Aterno-Sagittario-Tirino. Il limite<br />
amministrativo della Provincia di L'Aquila risulta arretrato rispetto al limite<br />
del bacino imbrifero Aterno-Sagittario-Tirino per una superficie di circa 40<br />
kmq (su un totale di 2003) accorpata alla Provincia di Pescara e nella quale<br />
emergono le maggiori sorgenti del bacino e della Regione per un apporto<br />
complessivo di circa 30 mc/s.<br />
Nel bacino del Fiume Tirino, che confluisce nel Pescara poco a nord di<br />
Popoli, si hanno piccole aree di rimboschimento sulle pendici in sinistra<br />
dell’alto e medio bacino nei comuni di Capestrano, Collepietro, Bussi sul<br />
Tirino e S. Benedetto in Perillis ed una più vasta nella zona di valle in<br />
sinistra idrografica in comune di Bussi sul Tirino; briglie isolate e in serie si<br />
trovano lungo il corso di alcuni tributari nei pressi di Capestrano e Bussi sul<br />
Tirino.<br />
Studio Ing. A. Iorio 45
Il bacino dell'Aterno-Pescara alla foce nell'Adriatico ha superficie<br />
totale di 3157 kmq e portate medie annuali di 53 mc/s (medio minime 35<br />
mc/s).<br />
CENNI SULL'IDROGEOLOGIA<br />
La Regione Abruzzo presenta notevoli differenze litologiche tra<br />
formazioni coeve depostesi in diverse condizioni paleogeografiche; perciò è<br />
opportuno distinguere le varie unità litostratigrafiche con caratteri<br />
idrogeologici differenti (fig. 2; cfr. anche fig. 1).<br />
La successione di piattaforma carbonatica subsidente, depostasi du-<br />
rante il Mesozoico, ha uno spessore medio di oltre 3000 m. Sebbene l'intero<br />
pacco di sedimenti presenti caratteri nel complesso omogenei, giocano un<br />
Studio Ing. A. Iorio 46
uolo idrogeologico determinante le variazioni sedimentologiche ed i<br />
processi diagenetici che hanno provocato marcate differenziazioni<br />
litologiche. Al livello del Triassico sup. - Lias inf. si ha uno spessore potente<br />
di dolomie, per lo più primarie, di cui non è nota la base; esse affiorano solo<br />
in pochi punti, ma la loro presenza, a causa della scarsa permeabilità che le<br />
caratterizza (MANFREDINI, 1964; BONI, 1973), ha una particolare<br />
importanza a livello idrogeologico. I sedimenti giurassici e cretacici sono<br />
formati da sequenze calcaree e dolomitiche che dominano alla base e<br />
sfumano gradualmente verso l'alto fino a scomparire al livello del Cretacico<br />
superiore, ove sono molto diffuse le facies calcareo organogene; questo<br />
pacco di terreni, sufficientemente omogeneo, mostra una notevole<br />
permeabilità secondaria dovuta alla fessurazione prodottasi in seguito ai<br />
movimenti tettonici che hanno interessato le masse carbonatiche durante<br />
l'orogenesi appenninica.<br />
Studio Ing. A. Iorio 47
Nelle dolomie saccaroidi secondarie, invece, la permeabilità è relativamente<br />
più bassa, anche causa della minore solubilità. I terreni della piattaforma<br />
sono ottimi acquiferi che alimentano sorgenti con portate di magra di<br />
notevole entità.<br />
La successione mesozoica di transizione è caratterizzata da sedimenti<br />
depostisi lungo la fascia che divideva la piattaforma carbonatica<br />
dall'ambiente pelagico; la loro posizione ed ampiezza ha subito notevoli<br />
variazioni nel tempo. Localmente tali sedimenti poggiano trasgressivi sulla<br />
Studio Ing. A. Iorio 48
piattaforma stessa, dopo che questa è stata interessata da periodi di<br />
emersione e successive variazioni di ambiente.<br />
La facies è caratterizzata dall'alternanza di formazioni prevalentemente<br />
calcaree, localmente dolomitizzate, con altre ad elevata componente<br />
psammitico-pelitica, poste a differenti livelli della successione; questa, in<br />
genere, evolve a partire da una potente formazione basale dolomitico-<br />
evaporitica.<br />
Lo spessore della successione è valutato in 1500 m. La permeabilità<br />
nelle formazioni calcaree fessurate è assai elevata, mentre è molto ridotta<br />
negli orizzonti terrigeni intercalati. Infatti, la presenza delle intercalazioni<br />
marnose ed argillose tende ovviamente ad ostacolare il movimento delle<br />
acque ed inoltre conferisce alla massa una plasticità di insieme che ha<br />
limitato lo sviluppo della fratturazione <strong>degli</strong> strati calcarei sottoposti a<br />
tensioni orogeniche.<br />
I sedimenti di transizione hanno quindi, in massa, una permeabilità<br />
mediamente inferiore a quella <strong>dei</strong> depositi di piattaforma ed una minore<br />
capacità di infiltrazione delle acque meteoriche; essi rappresentano tuttavia<br />
<strong>dei</strong> buoni acquiferi che alimentano sorgenti a grande portata.<br />
I sedimenti sinorogenici e tardo-orogenici di differente età e natura<br />
sono rappresentati da diversi tipi di flysch e dalle coltri alloctone che si sono<br />
deposte o sono state messe in posto durante l'orogenesi.<br />
Tutti questi sedimenti sono caratterizzati da una elevata componente<br />
pelitica che li rende praticamente impermeabili rispetto alle masse<br />
carbonatiche con cui vengono in contatto.<br />
Questi depositi colmano le depressioni che separano gli attuali rilievi,<br />
circondano le strutture carbonatiche isolando-ne gli acquiferi e costituiscono<br />
le soglie dalle quali traggono origine numerose grandi sorgenti; si tratta per<br />
lo più di sorgenti di trabocco.<br />
I sedimenti post-orogenici comprendono i detriti di falda, i coni, le<br />
alluvioni fluvio-lacustri, le argille e le sabbie marine. I terreni hanno una<br />
permeabilità molto variabile in funzione della litologia, della granulometria e<br />
della cementazione; hanno in generale spessori relativamente modesti e<br />
non influenzano sostanzialmente la circolazione profonda delle acque nelle<br />
Studio Ing. A. Iorio 49
strutture carbonatiche.<br />
Fanno comunque eccezione i grandi spessori di sedimenti fluvio-<br />
lacustri a bassa permeabilità (depostisi nelle principali depressioni<br />
tettoniche dell'Aquila e di Sulmona), che hanno funzione di soglia per gli<br />
acquiferi carbonatici.<br />
Un fattore determinante, che ha condizionato il quadro idrogeologico<br />
regionale (fig. 3), va ricercato nell'evoluzione dell'assetto strutturale che le<br />
differenti unità tettoniche hanno subito durante le diverse fasi orogeniche.<br />
Ci si riferisce in particolare ai rapporti di giacitura che le masse<br />
carbonatiche permeabili hanno gradualmente assunto nei confronti <strong>dei</strong><br />
sedimenti terrigeni sin-Orogenici impermeabili I flysch e le coltri alloctone,<br />
plastiche ed impermeabili, sono andate a colmare le depressioni ed i solchi<br />
che si formavano, o preesistevano, all'interno delle aree già costituenti la<br />
piattaforma ed alla sua periferia; in tale posizione sono rimasti implicati<br />
durante le fasi tettoniche successive alla loro deposizione.<br />
Troviamo oggi, di conseguenza, la piattaforma carbonatica smembrata<br />
in grandi settori; ciascuno costituisce una dorsale circondata, quasi ovunque<br />
con perfetta continuità, da solchi più o meno marcati colmi di sedimenti<br />
impermeabili. In tali condizioni ogni unità strutturale si comporta come una<br />
struttura idraulicamente isolata. Il margine occidentale della piattaforma<br />
viene a contatto con la successione di transizione attraverso una «linea»<br />
tettonica di importanza regionale, cioè la «linea» Posta-Olevano.<br />
Poiché le strutture carbonatiche sono saturate alla base da grandi falde<br />
<strong>idriche</strong>, esse alimentano le più grandi sorgenti. <strong>Le</strong> maggiori venute a giorno<br />
delle acque circolanti sono di regola ubicate alla periferia, ovviamente nei<br />
punti posti a quota relativa più bassa del contatto fra rocce carbonatiche e<br />
rocce a forte componente argillosa (flysch s.1. e complessi caotici).<br />
Notevole influenza sulle portate e sul loro regime hanno gli afflussi<br />
meteorici che, nella regione considerata, raggiungono frequentemente valori<br />
abbastanza elevati rispetto alla media di tutto il territorio nazionale (970<br />
mm).<br />
Gran parte delle sorgenti presenti in Abruzzo sono da tempo utilizzate<br />
per uso locale e per l'approvvigionamento idrico <strong>dei</strong> grossi centri abitati e<br />
Studio Ing. A. Iorio 50
delle aree industriali, mentre altre non sono ancora sfruttate.<br />
La distribuzione delle rocce in funzione della permeabilità è<br />
schematicamente illustrata in fig. 2. <strong>Le</strong> principali strutture idrogeologiche<br />
riconosciute sono quelle del Velino-Marsica-Meta e quelle nord-orientali.<br />
Struttura del Velino-Marsica-Meta<br />
E’ possibile isolare la grande struttura idrogeologica che da M. Nuria-M.<br />
Giano (presso le sorgenti del Peschiera, alta valle del Velino) si estende<br />
verso SE al gruppo del Velino e prosegue, oltre il Fucino, nel settore della<br />
Studio Ing. A. Iorio 51
Marsica a SO del F. Sangro, per chiudersi, a sud, nei Monti della Meta con le<br />
sorgenti di Capovolturno.<br />
Se si segue l'andamento <strong>degli</strong> affioramenti di flysch (e se ne considera<br />
la possibile continuità sotto le coperture recenti e gli accavallamenti<br />
tettonici), l'unità risulta circondata da una fascia impermeabile,<br />
probabilmente continua, che la isola dalle strutture vicine. Se ne può<br />
seguire l'andamento a partire da sud, lungo la Val Roveto, fino alle<br />
propaggini settentrionali <strong>dei</strong> Monti Carseolani; più a nord lungo la «linea»<br />
Posta-Olevano; ad est lungo l'alta valle dell'Aterno fino alla Conca<br />
dell'Aquila; da qui verso sud, in corrispondenza della piega-faglia che corre<br />
dall'Aquila al Fucino lungo l'altopiano delle Rocche, tra il Velino ed il Sirente;<br />
oltre il Fucino, lungo la valle del Sangro e quindi più a sud, fino a<br />
Capovolturno. La struttura idrogeologica così definita può essere ricondotta<br />
ad un sistema suddiviso in tre settori da due importanti motivi strutturali e<br />
paleogeografici posti all'altezza del Fucino e <strong>dei</strong> Monti della Meta.<br />
La grande depressione del Fucino è circondata, al suo interno, da<br />
sedimenti in facies di transizione; a livello idrogeologico si può ritenere che<br />
quest'area interna della piattaforma, dove sedimenti terrigeni sono<br />
intercalati a depositi calcarei, segni almeno una discontinuità litologica che<br />
ha la funzione di spartiacque fra il gruppo del Velino e quello della Marsica<br />
occidentale; a quest'ultima si lega la dorsale <strong>dei</strong> Carseolani, che non subisce<br />
l'influenza del Fucino.<br />
Il settore settentrionale (gruppo del Velino), chiuso a sud dal Fucino,<br />
alimenta le grandi sorgenti del Peschiera e di Canetra; il settore meridionale<br />
drena, in direzione opposta, verso le sorgenti del Fibreno, presso Sora.<br />
In corrispondenza <strong>dei</strong> Monti della Meta, un alto strutturale solleva il<br />
basamento dolomitico, che viene così a chiudere verso sud il bacino del<br />
Fibreno. Sulle dolomie liassiche del rilievo poggiano in trasgressione<br />
lacunose successioni di transizione; il settore della Meta risulta pertanto<br />
idrogeologicamente isolato dalla Marsica occidentale e drena a sud verso le<br />
sorgenti di Capovolturno (portata media 6000 l/s, portata minima 3000 l/s).<br />
Studio Ing. A. Iorio 52
Strutture abruzzesi nord-orientali<br />
Una precisa suddivisione <strong>dei</strong> rilievi abruzzesi nord-orientali in<br />
strutture minori diviene sempre più difficile procedendo verso NE. Questo<br />
settore dell'Appennino mostra infatti marcate variazioni litologiche, dovute<br />
ad eteropie di facies poste a differenti livelli della successione stratigrafica.<br />
Siamo ai margini della piattaforma carbonatica dove, in spazi limitati, si<br />
passa ad ambienti di soglia e di transizione esterna, con decise variazioni<br />
litologiche: si perde di conseguenza anche l'omogeneità di comportamento<br />
idrogeologico.<br />
Allo stato attuale delle conoscenze il fattore che sembra dominare è<br />
la morfologia. <strong>Le</strong> grandi depressioni della piana dell'Aquila e soprattutto di<br />
Sulmona-valle del Tirino, ricchissime di grandi sorgenti, determinando forti<br />
dislivelli nei confronti <strong>dei</strong> rilievi che le circondano, sembrano agire da<br />
elementi centripeti e richiamare il drenaggio delle grandi e complesse<br />
strutture del Gran Sasso, Sirente e Morrone. Nettamente isolato da una<br />
continua fascia di flysch risulta invece il gruppo della Montagna Grande,<br />
drenato alle sorgenti di Cauto. Ancor più chiaramente chiusa a scambi con<br />
le strutture vicine è la Maiella, che alimenta alcune sorgenti poste alla sua<br />
periferia lungo il contatto con le marne ad occidente (Unità 13), con il flysch<br />
(Unità 20) ed il Complesso caotico (Unità 23) ad oriente.<br />
Sono stati effettuati numerosi sondaggi in tutta l'area adriatica<br />
dell'Abruzzo, ma generalmente, salvo qualche limitata concentrazione di<br />
sottili livelli d'acqua dolce contenuti per lo più in terreni pleistocenici<br />
(sabbie, ciottoli e ghiaie), fino a 500 m di profondità non si è riscontrata la<br />
presenza di una estesa falda acquifera. L'unico pozzo che ha fornito la<br />
testimonianza di fluidi in strato è il pozzo Casoli 7, in provincia di Chieti, in<br />
cui lo spessore d'acqua si affonda a partire dai 260 m dal piano di<br />
campagna (q. 520 m) e prosegue oltre i 500 m, interessando litotipi calcarei<br />
sicuramente compresi fra il Cretacico inferiore ed il Miocene medio.<br />
Studio Ing. A. Iorio 53
Schema idrogeologico Gran Sasso<br />
<strong>Le</strong> condizioni litologiche e strutturali del massiccio permettono<br />
l'infiltrazione e l'immagazzinamento delle acque meteoriche e di fusione<br />
delle nevi che, per l'assenza o quasi di deflusso superficiale e per i<br />
ridottissimi fenomeni di evapotraspirazione, vanno ad alimentare corpi idrici<br />
più o meno indipendenti. <strong>Le</strong> conoscenze acquisite consentono di individuare<br />
la presenza di due principali tipi di acquiferi:<br />
- Falda di fondo: è una falda imponente, che nonostante la complessità<br />
della struttura del serbatoio, può essere ritenuta, in senso regionale,<br />
unica.<br />
La quota massima che la falda acquifera raggiungeva originariamente nel<br />
settore centrale più elevato della catena, prima <strong>dei</strong> lavori del traforo<br />
auto-stradale e quindi in assenza di drenaggio, era di circa 1600 m,<br />
presentava quindi un'altezza sul piano delle gallerie di oltre 600 m.<br />
La circolazione idrica nella falda profonda, la cui principale area di<br />
ricarica è costituita dalla vasta depressione tettonica di Campo Imperatore,<br />
risulta sostanzialmente condizionata da vari sistemi di faglie e fratture, nel<br />
senso che, mentre alcuni sistemi individuano zone a maggiore permeabilità<br />
e quindi a maggiore drenaggio, altre faglie invece, specie quelle marcate da<br />
spesse fasce di cataclasiti, limitano i travasi tra i corpi idrici contigui,<br />
fungendo da diaframmi impermeabili sotterranei. Si tratta pertanto di un<br />
enorme acquifero carbonatico compartimentato che alimenta tutta una serie<br />
di importanti sorgenti ubicate lungo l'orlo della struttura idrogeologica. La<br />
maggiore permeabilità, e conseguentemente il maggiore drenaggio del<br />
massiccio, sembra legata a sistemi di fratture e faglie a carattere distensivo,<br />
ad andamento appenninico (NO-SE). I flussi idrici sotterranei sono pertanto<br />
tendenzialmente orientati nella medesima direzione e cioè dalle aree più<br />
elevate della catena, verso la zona più depressa a SE costituita dalla<br />
profonda incisione del Fiume Aterno a Popoli. La maggior parte dell'acqua<br />
immagazzinata nell'acquifero carbonatico profondo va quindi ad alimentare<br />
le sorgenti di Capo d'Acqua del Tirino 5 mc/s, del Tirino Inferiore a Bussi 8<br />
Studio Ing. A. Iorio 54
mc/s, di Capestrano 1 mc/s, di San Callisto 2 mc/s e di Capo Pescara 10<br />
mc/s, poste appunto alla base SE della catena. La restante parte alimenta<br />
principalmente le sorgenti del Chiarino, del Rio Arno, del Ruzzo e del Vitello<br />
d'oro, sul fronte esterno della catena, e le sorgenti di Vetoio 0,8 mc/s, di<br />
Tempera e di Capo Vera 2 mc/s, sul fronte interno aquilano. La portata<br />
globale annua di tutte le emergenze alimentate dalla falda di fondo, è di<br />
circa 1.000 milioni di mc.<br />
- Falde sospese: si tratta di falde <strong>idriche</strong> generalmente di modesta entità,<br />
contenute sia nei depositi detritici di copertura e colmamento del<br />
Quaternario, sia nelle rocce calcaree, dove sono sostenute dai livelli marnosi<br />
meno permeabili presenti a varie altezze stratigrafiche della successione<br />
carbonatica. Danno generalmente origine a numerose piccole sorgenti con<br />
portata variabile da 0,1 a 5 l/s e portata complessiva annua di c.. 50 milioni<br />
di mc.<br />
Principali caratteristiche costruttive delle opere in sotterraneo<br />
Il Traforo autostradale del Gran Sasso attraversa la catena mediante<br />
due gallerie parallele della lunghezza di poco più di 10 km e collega il<br />
versante aquilano a SO (lato Assergi) con quello teramano a NE (lato Casale<br />
San Nicola).<br />
A fianco della galleria in via sinistra, a c. 6250 m dall'imbocco di<br />
Assergi, sotto la copertura massima del traforo che è di c. 1400 m, tono<br />
stati scavati i laboratori dell'I.N.F.N. <strong>Le</strong> complesse condizioni lito-strutturali<br />
ed idrogeologiche descritte in precedenza, in particolare la presenza di<br />
potenti acquiferi, di notevoli carichi idrostatici (fino a 64 atmosfere) di faglie<br />
marcate da spesse fasce cataclastiche sotto forti pressioni <strong>idriche</strong> hanno<br />
costituito enormi difficoltà per i lavori di scavo. Basti ricordare<br />
l'attraversamento della faglia di Valle Fredda, durante il quale si verificarono<br />
notevoli ed improvvisi colpi d'acqua, con portate fino a 20.000 l/s e con<br />
conseguente trascinamento in galleria di notevole quantità di materiale<br />
cataclastico.<br />
Per abbattere le enormi pressioni <strong>idriche</strong> e porre quindi in condizioni di<br />
Studio Ing. A. Iorio 55
sicurezza l'avanzamento, il drenaggio naturale esercitato dallo scavo è stato<br />
integrato con un sistema drenante artificiale, realizzato lungo il perimetro di<br />
scavo con cunicoli ed aureole di fori drenanti più o meno radiali lunghi da 20<br />
a 100 m. Una volta rivestita la galleria, il ripristino della pressione idrica sui<br />
rivestimenti, è stato e viene tuttora impedito mediante un continuo<br />
drenaggio e captazione operato a paramento, lungo l'intera sezione ed al<br />
piede. Il notevole drenaggio effettuato dalle gallerie, ha prima interessato le<br />
acque profonde a lentissima circolazione (acque vecchie di qualche decina di<br />
anni), successivamente ha esercitato un'azione di richiamo delle acque più<br />
recenti dai livelli superiori della falda, avviando un lento processo di<br />
mescolamento e di sostituzione.<br />
L'effetto più rilevante dell'azione di drenaggio naturale e/o forzato delle<br />
gallerie è stato il locale abbassamento di 600 m (c. da 1600 m s.l.m. fino<br />
alla quota del piano autostradale) della superficie piezometrica.<br />
Attualmente il probabile profilo piezometrico è verosimilmente<br />
caratterizzato da una depressione lineare localizzata lungo l'asse del Traforo<br />
autostradale che ancora assume il ruolo di importante asse di drenaggio<br />
dell'acquifero carbonatico profondo.<br />
La notevole depressione della superficie della falda ha naturalmente<br />
prodotto vistosi effetti sul sistema delle sorgenti alimentate dalla falda di<br />
fondo, in particolare su quelle prossime al traforo.<br />
La maggiore riduzione si è avuta nelle sorgenti sopra Casale San<br />
Nicola, dove a partire dal 1976 (anno in cui si è iniziato il drenaggio dovuto<br />
agli scavi autostradali sul versante teramano) si è manifestata una<br />
progressiva diminuzione di portata passando da 363 l/s (valore medio<br />
relativo agli anni precedenti al 1976) a 117 1/s con una flessione del 70 %.<br />
Anche le sorgenti del Ruzzo hanno manifestato riduzioni della portata<br />
percentualmente analoghe a quelle di Casale San Nicola, mentre riduzioni<br />
variabili tra il 45 ed il 20 % si sono verificate nelle altre sorgenti, sempre<br />
alimentate dalla falda di fondo precedentemente menzionata.<br />
Nel contempo si è verificato l'efflusso dalle gallerie autostradali nel<br />
versante Nord per circa 1000 l/s e nel versante Sud circa 400 l/s e la<br />
Studio Ing. A. Iorio 56
iduzione della portata della sorgente del Tirino di Capodacqua per circa<br />
1000 l/s.<br />
Il bilancio idrico complessivo delle acque fluenti non appare modificato<br />
nei valori medi, anche se con maggiori escursione della portata fra i valori<br />
massimi e minimi per effetto della diminuzione del volume di invaso<br />
complessivo.<br />
Studio Ing. A. Iorio 57
Bilancio idrologico<br />
Il Servizio Idrografico dello Stato ha realizzato, sin dal 1920, una<br />
estesa rete di stazioni per la rilevazione delle precipitazioni (pluviometri,<br />
nevometri, pluvionivometri) e della temperatura al suolo.<br />
Numerose sezioni <strong>dei</strong> corsi d’acqua sono state attrezzate con stazioni<br />
idrometriche o idrometrografiche.<br />
La successione <strong>dei</strong> dati, per oltre 50 anni, offrono una base statistica<br />
molto attendibile.<br />
La base dati disponibile per il fiume Aterno Pescara permette di<br />
stabilire il bilancio idrologico in numerose sezioni del corso d’acqua dalle<br />
origini fino alla foce a mare.<br />
I risultati <strong>dei</strong> detti bilanci sono riportati nella tabella seguente nella<br />
quale sono esposti:<br />
• La prog.va dell’asta fluviale (km);<br />
• l’area della superficie del bacino imbrifero sotteso S (kmq) in<br />
ciascuna sezione ;<br />
• la portata media annuale Q (mc/s);<br />
• la portata minima assoluta qmin (mc/s);<br />
• l’afflusso medio annuale AFF (precipitazioni) del bacino imbrifero<br />
sotteso espresso in mc/s;<br />
• la precipitazione efficace media PEFF = AFF – ETR, espressa in<br />
(m) e in (mc/s), ove ETR è la evapotraspirazione reale calcolata<br />
con la formula di Coutagne;<br />
• i contributi unitari, espressi in (l/skmq), <strong>degli</strong> afflussi, delle portate<br />
e della precipitazione efficace.<br />
L’equazione del bilancio idrologico in ciascuna sezione è espresso<br />
dalla seguente relazione:<br />
PEFF – Q = +/- D (mc/s)<br />
D = DEFICIT (-), <strong>perdite</strong> sotterranee del bacino sotteso;<br />
D = SURPLUS (+), apporti sotterranei al bacino sotteso.<br />
Studio Ing. A. Iorio 58
L alveo<br />
km SEZIONE<br />
S<br />
kmq<br />
Q<br />
mc/s<br />
BILANCIO IDROLOGICO DEL BACINO IMBRIFERO ATERNO PESCARA<br />
Q/S<br />
l/s/kmq<br />
qmin<br />
mc/s<br />
qmin/S<br />
l/skmq<br />
qmin/L<br />
mc/s/km<br />
AFF<br />
medio<br />
mc/s<br />
Studio Ing. A. Iorio 59<br />
AFF/S<br />
medio<br />
l/s/kmq<br />
PEFF<br />
mc/s<br />
PEFF/S<br />
l/skmq<br />
DEFICIT<br />
SURPLUS<br />
sottobacino<br />
(+) apporti<br />
(-) <strong>perdite</strong> mc/s<br />
Perdite (-)<br />
Apporti (+)<br />
l/skmq<br />
Perdite (-)<br />
Apporti (+)<br />
mc/skm<br />
25 TREPONTI 114 1,08 9,47 0,022 0,193 0,001 3,46 30,39 2,29 20,05 -1,21 -10,57 -0,048<br />
280<br />
288<br />
43 L'AQUILA 531 4,11 7,74 0,326 0,614 0,008 17,14 32,28 11,74 22,11 -7,63 -14,37 -0,177<br />
560<br />
47 VERA 646 5,71 8,84 0,995 1,540 0,021 20,89 32,34 14,32 22,17 -8,61 -13,33 -0,183<br />
800<br />
1.100<br />
82 MOLINA 1.303 5,60 4,30 0,625 0,480 0,008 40,44 31,03 27,32 20,97 -21,72 -16,67 -0,265<br />
85 1.350 5,87 4,35 41,88 31,02<br />
91 CONF SAG 1.400 6,62 4,73<br />
92 ALLOGG 1.961 15,37 7,84 2,57 1,311 0,028 60,35 30,78 38,36 19,56 -22,99 -11,72 -0,250<br />
95 MARAONE 2.003 27,54 13,75 14,39 7,184 0,151 62,12 31,01 39,36 19,65 -11,82 -5,90 -0,124<br />
105 CONF TIRINO 2.357 42,39 17,98 25,41 10,781 0,242 72,12 30,60 44,51 18,88 -2,12 -0,90 -0,020<br />
2.370<br />
2.448<br />
CONF ORTA 2.610 45,66 17,49<br />
2.620<br />
CONF LAVINO 2.705 47,47 17,55<br />
2.711<br />
CIGNO 2.822 49,29 17,47<br />
NORA 3.040 52,63 17,31<br />
3.078<br />
145 S. TERESA 3.120 53,63 17,19 29,63 9,497 0,204 94,98 30,44 58,09 18,62 -4,46 -1,43 -0,031<br />
154 FOCE 3.194 55,00 17,22 29,63 9,277 0,192 97,23 30,44 59,45 18,61 -4,45 -1,39 -0,029
105,00<br />
100,00<br />
95,00<br />
90,00<br />
85,00<br />
80,00<br />
75,00<br />
70,00<br />
65,00<br />
60,00<br />
55,00<br />
50,00<br />
45,00<br />
40,00<br />
35,00<br />
30,00<br />
25,00<br />
20,00<br />
15,00<br />
10,00<br />
5,00<br />
0,00<br />
-5,00<br />
-10,00<br />
-15,00<br />
-20,00<br />
-25,00<br />
-30,00<br />
0<br />
TREPONTI<br />
100<br />
200<br />
300<br />
400<br />
500<br />
600<br />
700<br />
ATERNO PESCARA<br />
AFFLUSSO, DEFLUSSO MEDIO e MINIMO, DEFICIT/SURPLUS BACINO/SOTTOBACINO,<br />
in funzione della superficie progva del bacino imbrifero<br />
BACINO MONTANO ATERNO SAGITTARIO TIRINO VAL PESCARA<br />
L'AQUILA<br />
F.VERA<br />
800<br />
900<br />
1.000<br />
1.100<br />
MOLINA<br />
1.200<br />
1.300<br />
1.400<br />
1.500<br />
1.600<br />
1.700<br />
CONFLUENZA SAGITTARIO<br />
1.800<br />
1.900<br />
2.000<br />
SORGENTI POPOLI<br />
2.100<br />
SUP BACINO IMBRIFERO kmq<br />
Studio Ing. A. Iorio 60<br />
2.200<br />
CONFLUENZA TIRINO<br />
2.300<br />
2.400<br />
2.500<br />
2.600<br />
2.700<br />
2.800<br />
2.900<br />
3.000<br />
3.100<br />
FOCE<br />
3.200<br />
3.300<br />
3.400<br />
Q<br />
mc/s<br />
qmin<br />
mc/s<br />
AFFmedio<br />
mc/s<br />
PEFF mc/s<br />
DEFICIT/SURPLUS<br />
bacino/sottobacino<br />
(+) apporti<br />
(-) <strong>perdite</strong> mc/s
105<br />
100<br />
95<br />
90<br />
85<br />
80<br />
75<br />
70<br />
65<br />
60<br />
55<br />
50<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
0<br />
10<br />
20<br />
30<br />
40<br />
50<br />
ATERNO PESCARA AFFLUSSO, DEFLUSSO MEDIO e MINIMO<br />
in funzione della lunghezza progva alveo<br />
BACINO MONTANO ATERNO SAGITTARIO TIRINO VAL PESCARA<br />
TREPONTI<br />
FIUME ATERNO FIUME PESCARA<br />
L'AQUILA<br />
60<br />
70<br />
MOLINA<br />
80<br />
CONFLUENZA SAGITTARIO<br />
90<br />
SORGENTI POPOLI<br />
Studio Ing. A. Iorio 61<br />
CONFLUENZA TIRINO<br />
100<br />
PROGVA ALVEO km<br />
110<br />
120<br />
130<br />
140<br />
150<br />
FOCE<br />
160<br />
170<br />
Q<br />
mc/s<br />
qmin<br />
mc/s<br />
AFFmedio<br />
mc/s<br />
PEFF mc/s
40,00<br />
38,00<br />
36,00<br />
34,00<br />
32,00<br />
30,00<br />
28,00<br />
26,00<br />
24,00<br />
22,00<br />
20,00<br />
18,00<br />
16,00<br />
14,00<br />
12,00<br />
10,00<br />
8,00<br />
6,00<br />
4,00<br />
2,00<br />
0,00<br />
-2,00<br />
-4,00<br />
-6,00<br />
-8,00<br />
-10,00<br />
-12,00<br />
-14,00<br />
-16,00<br />
-18,00<br />
-20,00<br />
0<br />
TREPONTI<br />
100<br />
200<br />
300<br />
400<br />
500<br />
600<br />
700<br />
800<br />
900<br />
1.000<br />
1.100<br />
ATERNO-PESCARA<br />
afllussi e deflussi per unità di superficie bacino sotteso<br />
BACINO MONTANO ATERNO SAGITTARIO TIRINO VAL PESCARA<br />
L'AQUILA<br />
1.200<br />
MOLINA<br />
1.300<br />
1.400<br />
1.500<br />
1.600<br />
1.700<br />
CONFLUENZA SAGITTARIO<br />
1.800<br />
1.900<br />
Studio Ing. A. Iorio 62<br />
2.000<br />
SORGENTI POPOLI<br />
2.100<br />
SUP BACINO IMBRIFERO kmq<br />
2.200<br />
2.300<br />
2.400<br />
CONFLUENZA TIRINO<br />
2.500<br />
2.600<br />
2.700<br />
2.800<br />
2.900<br />
3.000<br />
3.100<br />
FOCE<br />
3.200<br />
3.300<br />
3.400<br />
Q/S<br />
l/s/kmq<br />
qmin/S<br />
l/skmq<br />
AFFmedio/S<br />
l/s/kmq<br />
PEFF/S<br />
l/skmq<br />
Perdite (-)<br />
Apporti (+)<br />
l/skmq
105,00<br />
100,00<br />
95,00<br />
90,00<br />
85,00<br />
80,00<br />
75,00<br />
70,00<br />
65,00<br />
60,00<br />
55,00<br />
50,00<br />
45,00<br />
40,00<br />
35,00<br />
30,00<br />
25,00<br />
20,00<br />
15,00<br />
10,00<br />
5,00<br />
0,00<br />
-5,00<br />
-10,00<br />
-15,00<br />
-20,00<br />
-25,00<br />
-30,00<br />
0<br />
5<br />
10<br />
15<br />
TREPONTI<br />
20<br />
25<br />
30<br />
35<br />
40<br />
45<br />
ATERNO PESCARA AFFLUSSO, DEFLUSSO MEDIO e MINIMO<br />
in funzione della lunghezza progva alveo<br />
BACINO MONTANO ATERNO SAGITTARIO TIRINO VAL PESCARA<br />
FIUME ATERNO FIUME PESCARA<br />
L'AQUILA<br />
50<br />
55<br />
60<br />
65<br />
MOLINA<br />
70<br />
75<br />
CONFLUENZA SAGITTARIO<br />
80<br />
85<br />
90<br />
95<br />
PROGVA ALVEO km<br />
SORGENTI POPOLI<br />
Studio Ing. A. Iorio 63<br />
100<br />
105<br />
CONFLUENZA TIRINO<br />
110<br />
115<br />
120<br />
125<br />
130<br />
135<br />
140<br />
145<br />
FOCE<br />
150<br />
155<br />
160<br />
165<br />
Q<br />
mc/s<br />
qmin<br />
mc/s<br />
AFFmedio<br />
mc/s<br />
PEFF mc/s<br />
DEFICIT/SURPLUS<br />
bacino/sottobacino<br />
(+) apporti<br />
(-) <strong>perdite</strong> mc/s
35,00<br />
30,00<br />
25,00<br />
20,00<br />
15,00<br />
10,00<br />
5,00<br />
0,00<br />
-5,00<br />
-10,00<br />
-15,00<br />
-20,00<br />
ATERNO PESCARA AFFLUSSO, DEFLUSSO MEDIO e MINIMO<br />
in funzione della lunghezza progva alveo<br />
BACINO MONTANO ATERNO SAGITTARIO TIRINO VAL PESCARA<br />
TREPONTI<br />
FIUME ATERNO FIUME PESCARA<br />
L'AQUILA<br />
VERA<br />
0<br />
5<br />
10<br />
15<br />
20<br />
25<br />
30<br />
35<br />
40<br />
45<br />
50<br />
55<br />
60<br />
65<br />
70<br />
75<br />
80<br />
85<br />
90<br />
95<br />
100<br />
105<br />
110<br />
115<br />
120<br />
125<br />
130<br />
135<br />
140<br />
145<br />
150<br />
155<br />
160<br />
165<br />
MOLINA<br />
CONFLUENZA SAGITTARIO<br />
PROGVA ALVEO km<br />
Studio Ing. A. Iorio 64<br />
SORGENTI POPOLI<br />
CONFLUENZA TIRINO<br />
FOCE<br />
Q/S<br />
l/s/kmq<br />
qmin/S<br />
l/skmq<br />
AFFmedio/S<br />
l/s/kmq<br />
PEFF/S<br />
l/skmq<br />
Perdite (-)<br />
Apporti (+)<br />
l/skmq
I dati e la elaborazione del bilancio idrologico permettono di<br />
evidenziare i caratteri peculiari di ciascuna parte del bacino dell’Aterno e del<br />
Pescara.<br />
Il contributo di afflusso netto (PEFF/S) nel bacino imbrifero<br />
dell’Aterno, dalle sorgenti fino alla confluenza con il Sagittario, presenta<br />
valori dell’ordine di 20 l/skmq contro valori del contributo di deflusso da 10<br />
a 4 l/skmq. Il bacino riceve elevati apporti meteorici netti dell’ordine di 25<br />
mc/s che in gran parte, circa 20 mc/s, si infiltrano nel sottosuolo per<br />
riemergere a valle nel bacino del Pescara e del Tirino.<br />
Alquanto critica appare il comportamento del bacino Aterno rispetto ai<br />
valori minimi che scendono fino a 0,4 l/skmq nella sezione di Molina.<br />
Il bacino del Pescara riceve l’elevato apporto sotterraneo dell’Aterno<br />
attraverso le Sorgenti omonime a Popoli (sorgenti Pescara e S. Callisto) e<br />
quindi del Tirino a Bussi.<br />
In quest’ultima sezione termina il bacino imbrifero interno, racchiuso<br />
dalle grandi catene montuose del Gran Sasso e Morrone; la superficie totale<br />
raggiunge 2350 kmq (circa 75 % del totale) e la portata fluente risulta di<br />
42,4 mc/s (pari all’80% di quella alla foce); la perdita del bacino risulta di<br />
circa 2,0 mc/s, si verifica cioè quasi il pareggio fra afflussi netti e deflussi<br />
con un surplus <strong>degli</strong> afflussi pari a circa 4% della PEFF che alimentano la<br />
subalvea.<br />
<strong>Le</strong> <strong>perdite</strong> rimangono pressoché invariate nel tronco inferiore del<br />
Pescara, fino alla foce, lungo il quale si rileva una estesa falda alimentata<br />
dalle <strong>perdite</strong> dell’alveo.<br />
In conclusione si osserva che il bacino imbrifero dell’Aterno-<br />
Sagittario-Tirino si comporta come un enorme serbatoio sotterraneo<br />
(valutato nell’ordine di un miliardo di mc) che alimenta il suo emissario (Val<br />
Pescara a valle di Bussi) con una grande sorgente di portata media 42 mc/s,<br />
minima 30 mc/s, alla quale si aggiunge fino alla foce l’apporto,<br />
relativamente minore, media 12 mc/s e minima 2 mc/s, proveniente dal<br />
bacino proprio del Pescara esteso 837 kmq (25% del totale).<br />
Studio Ing. A. Iorio 65
Studio Ing. A. Iorio 66