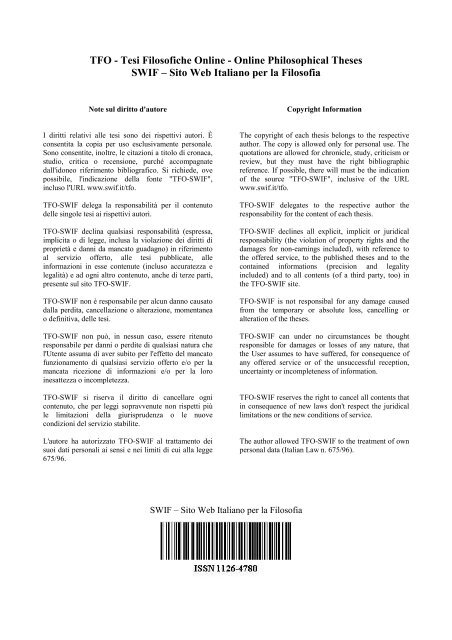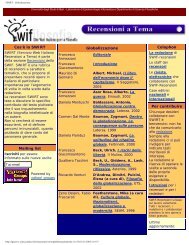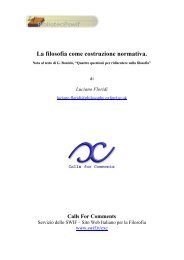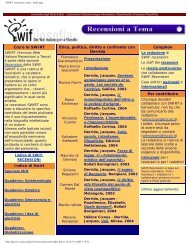TFO - Tesi Filosofiche Online - Online Philosophical Theses SWIF ...
TFO - Tesi Filosofiche Online - Online Philosophical Theses SWIF ...
TFO - Tesi Filosofiche Online - Online Philosophical Theses SWIF ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>TFO</strong> - <strong>Tesi</strong> <strong>Filosofiche</strong> <strong>Online</strong> - <strong>Online</strong> <strong>Philosophical</strong> <strong>Theses</strong><br />
<strong>SWIF</strong> – Sito Web Italiano per la Filosofia<br />
Note sul diritto d'autore<br />
I diritti relativi alle tesi sono dei rispettivi autori. È<br />
consentita la copia per uso esclusivamente personale.<br />
Sono consentite, inoltre, le citazioni a titolo di cronaca,<br />
studio, critica o recensione, purché accompagnate<br />
dall'idoneo riferimento bibliografico. Si richiede, ove<br />
possibile, l'indicazione della fonte "<strong>TFO</strong>-<strong>SWIF</strong>",<br />
incluso l'URL www.swif.it/tfo.<br />
<strong>TFO</strong>-<strong>SWIF</strong> delega la responsabilità per il contenuto<br />
delle singole tesi ai rispettivi autori.<br />
<strong>TFO</strong>-<strong>SWIF</strong> declina qualsiasi responsabilità (espressa,<br />
implicita o di legge, inclusa la violazione dei diritti di<br />
proprietà e danni da mancato guadagno) in riferimento<br />
al servizio offerto, alle tesi pubblicate, alle<br />
informazioni in esse contenute (incluso accuratezza e<br />
legalità) e ad ogni altro contenuto, anche di terze parti,<br />
presente sul sito <strong>TFO</strong>-<strong>SWIF</strong>.<br />
<strong>TFO</strong>-<strong>SWIF</strong> non è responsabile per alcun danno causato<br />
dalla perdita, cancellazione o alterazione, momentanea<br />
o definitiva, delle tesi.<br />
<strong>TFO</strong>-<strong>SWIF</strong> non può, in nessun caso, essere ritenuto<br />
responsabile per danni o perdite di qualsiasi natura che<br />
l'Utente assuma di aver subito per l'effetto del mancato<br />
funzionamento di qualsiasi servizio offerto e/o per la<br />
mancata ricezione di informazioni e/o per la loro<br />
inesattezza o incompletezza.<br />
<strong>TFO</strong>-<strong>SWIF</strong> si riserva il diritto di cancellare ogni<br />
contenuto, che per leggi sopravvenute non rispetti più<br />
le limitazioni della giurisprudenza o le nuove<br />
condizioni del servizio stabilite.<br />
L'autore ha autorizzato <strong>TFO</strong>-<strong>SWIF</strong> al trattamento dei<br />
suoi dati personali ai sensi e nei limiti di cui alla legge<br />
675/96.<br />
<strong>SWIF</strong> – Sito Web Italiano per la Filosofia<br />
Copyright Information<br />
The copyright of each thesis belongs to the respective<br />
author. The copy is allowed only for personal use. The<br />
quotations are allowed for chronicle, study, criticism or<br />
review, but they must have the right bibliographic<br />
reference. If possible, there will must be the indication<br />
of the source "<strong>TFO</strong>-<strong>SWIF</strong>", inclusive of the URL<br />
www.swif.it/tfo.<br />
<strong>TFO</strong>-<strong>SWIF</strong> delegates to the respective author the<br />
responsability for the content of each thesis.<br />
<strong>TFO</strong>-<strong>SWIF</strong> declines all explicit, implicit or juridical<br />
responsability (the violation of property rights and the<br />
damages for non-earnings included), with reference to<br />
the offered service, to the published theses and to the<br />
contained informations (precision and legality<br />
included) and to all contents (of a third party, too) in<br />
the <strong>TFO</strong>-<strong>SWIF</strong> site.<br />
<strong>TFO</strong>-<strong>SWIF</strong> is not responsibal for any damage caused<br />
from the temporary or absolute loss, cancelling or<br />
alteration of the theses.<br />
<strong>TFO</strong>-<strong>SWIF</strong> can under no circumstances be thought<br />
responsible for damages or losses of any nature, that<br />
the User assumes to have suffered, for consequence of<br />
any offered service or of the unsuccessful reception,<br />
uncertainty or incompleteness of information.<br />
<strong>TFO</strong>-<strong>SWIF</strong> reserves the right to cancel all contents that<br />
in consequence of new laws don't respect the juridical<br />
limitations or the new conditions of service.<br />
The author allowed <strong>TFO</strong>-<strong>SWIF</strong> to the treatment of own<br />
personal data (Italian Law n. 675/96).
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI<br />
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA<br />
Corso di laurea in Filosofia<br />
Alienazione dei diritti<br />
dell’uomo nelle tecnologie<br />
comunicative globali<br />
Relatore: Prof. Padre Francesco Sechi<br />
Correlatore: Prof. Paolo Russu<br />
Anno Accademico 1998 - 1999<br />
<strong>Tesi</strong> di Laurea di: Enrico Panai
Premessa metodologica<br />
Si parla di tecnologie comunicative globali, tutte quelle tecnolo-<br />
gie digitali nate all’interno della scienza informatica; cioè l’insieme<br />
delle discipline scientifiche (fisica, ottica, matematica, ecc.) che si oc-<br />
cupano dell’acquisizione, del controllo, dell’elaborazione, della distri-<br />
buzione e della gestione delle informazioni. Con la prima diffusione di<br />
massa della tecnologia digitale, attraverso home e personal computer e<br />
poi la connessione telefonica di tutte queste macchine assieme, attra-<br />
verso i grandi mainframes, si è venuta creando una grande rete comu-<br />
nicativa mondiale, chiamata la rete delle reti, e paragonata per le sue<br />
diramazioni, ad una grande ragnatele mondiale. Conosciuta come In-<br />
ternet, questa grande rete ha in realtà tanti sinonimi: cyber-spazio, la<br />
Rete, Matrix, net, ecc.<br />
Una confusione comune è quella di far corrispondere Internet<br />
con il World Wide Web 1 , cioè con la visualizzazione grafica e iperte-<br />
stuale della rete, grazie a pagine HTML 2 . Il WWW ha reso diffuso il<br />
fenomeno Internet nel 1993 per la sua facilità di utilizzo.<br />
1 WWW = acronimo di World Wide Web (lett. grande ragnatela mondiale), conosciuto<br />
come anche solo come Web, è l’interfaccia grafica della rete [vedi Glossario]<br />
2 HTML = (HyperText Markup Language) è il semplice linguaggio di<br />
programmazione ipertestuale con il quale sono scritti le pagine per il Web.<br />
2
In realtà però Internet, oltre al WWW, comprende e-mail, go-<br />
pher, newsgroup, chat, Cuseeme 3 , VRML, ecc. La consistente quantità<br />
di neologismi e nuovi acronimi, a forte dipendenza anglofona, mi ha<br />
spinto a creare un piccolo glossario, mentre per quanto riguarda la<br />
rete, un breve storia è presente in appendice 4 .<br />
Essendo una tesi sulla rete, non si potevano non citare articoli,<br />
libri o siti presenti in rete, ma il motivo è anche un altro: è comune<br />
opinione ‘parlare di rete in rete’. Naturalmente la quantità di collega-<br />
menti ipertestuali ha reso necessario allegare un supporto digitale, ol-<br />
tre a quello cartaceo, che permetta attraverso i collegamenti iperte-<br />
stuali della tesi in formato HTML 5 , una consultazione delle fonti di-<br />
rettamente ‘in sito’, cioè là dove sono state prese.<br />
Introduzione<br />
Questa tesi non ha, nonostante il nome, un carattere neo-luddi-<br />
sta o pessimista. Si parte dal presupposto di essere a favore della tec-<br />
nica e delle tecnologie comunicative, si desidera ciò nonostante fare<br />
una critica alla tecnica, vedere le nuove tecnologie comunicative glo-<br />
bali sotto uno sguardo non negativo, ma nemmeno reverenziale.<br />
3 [Vedi Glossario]<br />
4 [Vedi Appendice 4 - La storia della rete]<br />
5 Vedi nota 2 a p. 2<br />
3
La double way 6 di fronte ai processi digitali, di rifiuto o di ap-<br />
prezzamento totale, ha bisogno di una mediazione.<br />
«Non ci può essere avanzamento nel campo della tecnica, che<br />
mediante la critica. Non ci si può interessare a un oggetto tecnico,<br />
senza interessarsi alla sua negatività» 7 .<br />
Una nuova tecnologia offre vantaggi importanti, ma ha anche<br />
aspetti negativi ed ignorarli rallenta lo stesso miglioramento tecnolo-<br />
gico. Inventare la nave è lo stesso che inventare il naufragio, inventare<br />
il treno è inventare il deragliamento, inventare l'elettricità è inventare<br />
la scossa.<br />
Ora l'invenzione delle telecomunicazioni, delle reti telematiche,<br />
di Internet, del “cyber-spazio” è anche l'invenzione di un incidente<br />
specifico, che non è altrettanto appariscente dell'incidente ferroviario,<br />
che fa dei morti e crea disordine.<br />
C'è una negatività ed è questa negatività che si cerca di inda-<br />
gare, non per negare il progresso della tecnica, ma, al contrario, nel<br />
tentativo di superare questa situazione.<br />
Per esempio: quando è stata inventata la ferrovia, c'erano due<br />
tipi di ingegneri: gli ingegneri civili, quelli che facevano le strade fer-<br />
rate, i binari ferroviari, i ponti e le gallerie e gli ingegneri meccanici,<br />
che costruivano le locomotive.<br />
6 Double way = le due strade la doppia posizione<br />
7 P. VIRILIO, «La velocità assoluta», 05-09-95 Parigi, MediaMente<br />
4
E la cosa funzionava, deragliamenti a parte. Negli anni ’80 del<br />
secolo scorso, forse nel 1888, gli ingegneri europei si sono riuniti a<br />
Bruxelles e hanno rilevato che il vero problema non era il progresso<br />
della macchina a vapore, della locomotiva, non era lo straordinario<br />
progresso dei ponti metallici, l'apertura di gallerie, ma i troppi inci-<br />
denti 8 . Dunque bisognava impedire il moltiplicarsi degli incidenti. Fu<br />
inventata allora «l'ingegneria del traffico» 9 . Il traffico è diventato un<br />
problema a sé, problema immateriale, ma problema di fondo. Fu in-<br />
ventato allora il block-system 10 , che impedisce il deragliamento e il<br />
block-system ha reso possibile la sicurezza della rete ferroviaria. An-<br />
cora oggi con i treni ad alta velocità 11 , il block-system permette al<br />
treno di andare sempre più veloce. Oggi nelle reti elettroniche bisogna<br />
individuare gli incidenti, i deragliamenti che, in questo caso, non sono<br />
materiali. C'è bisogno di una comprensione della immaterialità della<br />
rete e delle sue incertezze. Questa tesi, seguendo la scia di alcuni filo-<br />
sofi europei - Paul Virilio, Philippe Queau, ecc. - , tenta di occuparsi<br />
dei ‘deragliamenti digitali’, perché sono tutti troppo impegnati - Bill<br />
Gates nel settore economico e Nicholas Negroponte in quello scienti-<br />
8 M. COCCINO & M VEGETTI, Storia moderna e contemporanea, ed. Zanichelli,<br />
1992 Bologna<br />
9 P. VIRILIO, «La velocità assoluta», cit.<br />
10 Block-system = sistema segnaletico, assai sofisticato, con torri di controllo, che<br />
dirigono il traffico ferroviario<br />
11 TGV, Pendolino, ecc.<br />
5
fico e gli altri - nella pubblicità di questi nuovi prodotti e nessuno si<br />
preoccupa della negatività, cioè nessuno si preoccupa del progresso.<br />
«Oggi,- questo ci dicono le due grandi compagnie della Rete<br />
(Microsoft ed Netscape),- potete comunicare con qualsiasi persona del<br />
mondo anche dalla vostra stanza» 12 . Cos’è cambiato? Anche prima si<br />
poteva con un telefono comunicare all’altro capo del mondo. Però<br />
oggi, nel Web, si comunica con persone che non conosciamo, che par-<br />
lano e vivono una lingua diversa, ma che magari hanno il «nostro<br />
stesso interesse per l’ornitorinco» 13 . La televisione, come gli altri me-<br />
dia, ci dava l’informazione senza darci la possibilità di discuterla; il<br />
telefono ci permetteva di discutere un argomento anche con una per-<br />
sona lontana; ma la Rete ci dà la possibilità di trovare qualcuno che<br />
abbia i nostri stessi interessi anche dall’altra parte del mondo.<br />
Questa possibilità di trovare qualcuno che la pensi allo stesso<br />
modo o che abbia i nostri stessi interessi, ha permesso però il moltipli-<br />
carsi, per esempio, delle sette. E il suicidio di massa di San Diego che<br />
ha accompagnato il passaggio della cometa Hale Bopp, è senza dubbio<br />
uno degli aspetti drammatici della Rete.<br />
Oggi, a pochi anni dal duemila, si scopre che i “millenaristi ca-<br />
tastrofici” hanno avuto nella Rete il mezzo per mettersi in contatto e<br />
per unirsi in gruppi religiosi o suicidi. Già adesso quindi con<br />
12 CLARK Jim, «Dalla telecomunicazione analogica a quella digitale» 13-01-96 Roma,<br />
Mediamente<br />
13 U. ECO, «Nomenclatura e democrazia elettronica», 21-09-95 Milano - MediaMente<br />
6
l’Interconnessione Globale i problemi che si scoprono sono notevoli,<br />
ma quando le ipotesi dello scrittore statunitense William Gibson di<br />
una comunicazione visiva (virtual reality 14 ) si saranno realizzate i pro-<br />
blemi saranno sicuramente maggiori. In una stanza potrà esistere il<br />
mondo che si desidera e ci si potrà circondare solo delle persone che la<br />
pensano come noi. Le ipotesi fantastiche gibsoniane di qualche anno fa<br />
ora iniziano a realizzarsi, grazie per esempio alla tecnologia VRML 15<br />
per la modellazione della realtà virtuale e la costruzione di mondi<br />
virtuali.<br />
«Chi si preoccupa della negatività si preoccupa del progresso,<br />
cioè della prevenzione dell'incidente. Adesso la possibilità di incidente<br />
è mascherata per vendere i computer» 16 .<br />
14 Virtual reality = Realtà virtuale<br />
15 VRML = (Virtual Reality Modelling Language) è un linguaggio che serve per la<br />
modellazione della realtà virtuale distribuibile in rete.<br />
16 P. VIRILIO, «La velocità assoluta», cit.<br />
7
PRIMA PARTE<br />
8
Miti e utopie<br />
La televisione ha per prima assunto «le vesti di […] una sorta di mi-<br />
tologia collettiva» 17 . Nella nostra cultura le antiche mitologie, di ori-<br />
gine classica, hanno ormai praticamente perso qualsiasi capacità di<br />
proporsi come rete di raccordo sociale per le proiezioni fantastiche e le<br />
narrazioni di origine collettiva; al loro posto è subentrata la televisione<br />
che ogni giorno ci presenta a modo suo immagini, storie, relazioni e<br />
opinioni chiave, generalmente più o meno accettate. E pian piano, con<br />
la crescita della comunicazione globale, la stessa televisione è stata<br />
surclassata dalla rete. Con l’avvento di una nuova era, quella digitale, i<br />
fanatismi si sono risvegliati, rievocando i fantasmi del passato televi-<br />
sivo e favorendo grossolani errori valutativi per il futuro. Le discus-<br />
sioni hanno a volte perso il loro carattere agnostico, per cadere in pre-<br />
visioni bibliche. La nascita di nuovi miti e nuove utopie (o il riadatta-<br />
mento di vecchi miti e utopie alle moderne tecniche) è stata favorita<br />
dalla rigogliosa letteratura fantascientifica, che ha fornito materiale di<br />
discussione all’ambiente scientifico e filosofico. Scienza e filosofia,<br />
anch’esse, si sono fate fuorviare da dibattiti poco scientifici e assolu-<br />
tamente irreali, superando spesso perfino la fantasia letteraria.<br />
17 A. PEPERZAK, «Etica della comunicazione», 08-05-93 Napoli, MediaMente.<br />
9
Il nome stesso della rete più utilizzata è web, cioè ‘ragnatela’, e non è<br />
questa la prima metafora esistente se si pensa che la prima forma di<br />
organizzazione logica di Internet era stata battezzata gopher 18 .<br />
Web esprime l’immagine della ‘ragnatela’, ma tra le altre proposte di<br />
metaforizzazioni di Internet compare anche quella del ‘labirinto’.<br />
Forse però la metafora della ‘ragnatela’ ha un limite, una debolezza,<br />
per così dire: non c’è infatti ragnatela senza ragno; in altri termini c’è<br />
sempre un elemento che produce e gestisce la rete. In realtà l’idea<br />
stessa di controllo da parte di un osservatore - la più classica che sem-<br />
pre si utilizza è quella del Panopticum, di un occhio, quasi come<br />
l’occhio di Dio che ci guarda e controlla tutto quello che noi facciamo -<br />
è un’idea che non coincide con la realtà di Internet; adesso esistono<br />
una miriade di... ‘occhi di Dio’, per creare una metafora un po’ dissa-<br />
crante. In questo senso la metafora del ‘labirinto’ sembra essere molto<br />
più interessante, poiché nel labirinto si è tutti ugualmente passivi e at-<br />
tivi allo stesso tempo 19 .<br />
Lo strabismo telematico<br />
Nella stima degli aspetti positivi e di quelli negativi della so-<br />
cietà dell’informazione ci sono state considerevoli errori valutativi.<br />
18 Gopher è il nome di un roditore nordamericano; è stato un sistema di<br />
esplorazione della rete a menù, tra gli antenati è quello che più assomiglia al Web<br />
19 T. MALDONADO, «Web: se c’è una ragnatela, deve esserci un ragno», 26-11-97,<br />
Milano, MediaMente<br />
10
Queste sviste, analizzate ne “Lo strabismo telematico” 20 , sono dovute<br />
principalmente al fattore ideologico: si pensa sempre che quando esi-<br />
ste una tecnologia, quest’ultima verrà usata e, di conseguenza, pro-<br />
durrà alcuni effetti. Questa consequenzialità è assolutamente ideolo-<br />
gica, perché, poi, nei fatti, molto spesso così non è. Molti studiosi si<br />
sono uniformati a questa ideologia e a coloro i quali producono queste<br />
tecnologie, ovviamente, conviene che certe conseguenze siano previ-<br />
ste. Una delle maggiori aspettative rispetto alle nuove tecnologie è<br />
sempre stata quella di una crescita notevole del progresso economico<br />
come conseguenza inevitabile dello sviluppo tecnologico. Questo per-<br />
ché uno degli errori fondamentali è stato quello di trasferire all’intera<br />
società alcune previsioni che potevano essere pensate per l’economia<br />
aziendale: dall’azienda alla società nel suo complesso. Ma evidente-<br />
mente, nella società esistono una serie di fattori che concorrono al ri-<br />
sultato che nell’azienda non sono presenti. Simili errori riguardano le<br />
previsione sulla democratizzazione della società grazie all’utilizzo<br />
della rete. Si è dato per scontato che il progresso tecnologico e Internet,<br />
portassero ad una diffusione dell’uguaglianza e quindi alla possibilità<br />
di intervento di tutti su tutto. In realtà, questa possibilità, in qualche<br />
modo, esiste; ma è vero che esiste anche la tendenza opposta: al con-<br />
trollo di tutto e alla sorveglianza di tutti. Le previsioni sono saltate di<br />
tecnologia in tecnologia, come se finalmente una nuova invenzione<br />
20 G. CESAREO, «Lo strabismo telematico», 21-02-97 Roma MediaMente.<br />
11
fosse “la soluzione”. È la stessa logica mitologica di «ricerca di sal-<br />
vezza» 21 in qualcosa di nuovo. Sono state numerose le profezie fatte<br />
sulle nuove tecnologie, come quella probabilmente più infondata:<br />
quella della democrazia. Si è dato per scontato che il progresso tecno-<br />
logico e la rete delle reti, cioè Internet, portasse ad una diffusione<br />
dell’uguaglianza e quindi della possibilità di intervento di tutti su<br />
tutto. In realtà, questa possibilità, in qualche modo, esiste; ma è vero<br />
che esiste anche la tendenza opposta: al controllo di tutto e anche alla<br />
sorveglianza. Del resto anche il mito del telelavoro non ha considerato<br />
la possibilità di alienazione dell’individuo, non lasciando più spazi<br />
privati distinti dal lavoro. È però vero che dal punto di vista morale i<br />
pensatori si sono sbizzarriti con una teoria molto fantasiosa. Quanto<br />
Internet ha iniziato a diffondersi per il mondo, molti pensatori co-<br />
scienti hanno posto il problema di regolamentare la rete. Cosa che ini-<br />
zialmente non è stata fatta, perché molti erano, in un certo modo, per-<br />
suasi che Internet si sarebbe autoregolamentata. Come se Internet<br />
fosse un essere biologico, che raggiunge la sua «stabilità interiore» 22 .<br />
Questa credenza ha fatto negli ultimi tempi correre ai ripari le<br />
maggiori nazioni del mondo, producendo a volte danni, piuttosto che<br />
migliorie.<br />
21 R. GRAVES, I miti greci, ed. Longanesi 1983 Milano, p. 127.<br />
22 P. VIRILIO, «La velocità assoluta», cit.<br />
12
Il mito di Internet riguarda, per esempio, la sua importanza. In<br />
effetti il fenomeno di Internet è molto rilevante nella nostra società, ma<br />
i cambiamenti sociali previsti solo pochi anni fa non si sono avverati.<br />
Infatti «la diffusione del Web è ancora limita» 23 numericamente e a de-<br />
terminate fasce sociali. Il fruitore medio di Internet è un «bianco, an-<br />
glofono, con reddito medio/alto»; ed in ogni caso riguarda principal-<br />
mente il mondo occidentale. Ma chi è stato a costruire e costituire il<br />
mito di Internet? Sono stati diversi gli uomini/personaggi in diversi<br />
settori e principalmente negli USA, dove la tendenza alla mistifica-<br />
zione è molto più forte che in Europa. Le prime voci si sono alzate dal<br />
mondo della ricerca scientifica, portando a divinazione Nicholas Ne-<br />
groponte a cui viene dato, in maniera irrevocabile dalla comunità<br />
mondiale, il titolo di guru. È il fondatore e il direttore del Media Labo-<br />
ratory del MIT 24 negli Stati Uniti, un centro di ricerca con un budget<br />
multi miliardario, orientato esclusivamente sullo studio e la speri-<br />
mentazione delle forme future della comunicazione umana, dalla<br />
istruzione all’educazione. I suoi programmi includono: la televisione<br />
di domani, la scuola del futuro, i sistemi d’informazione e<br />
d’intrattenimento e l’olografia. L’apice della fede nel digitale Negro-<br />
ponte l’ha espressa nel suo libro «Essere digitali» («Being digital»), con-<br />
siderato ormai, molto sbrigativamente, una vera e propria Bibbia della<br />
23 M. C. VETTRAINO SOULARD, «Il mito di Internet», 14-11-96 Milano<br />
MediaMente.<br />
24 MIT = Massachusetts Institute of Technology di Boston<br />
13
nuova era comunicativa. Egli afferma che essere digitali «è semplice-<br />
mente un modo di vivere. Non ha nulla di scientifico, di tecnico o di<br />
teorico. Fa parte della realtà ed è qualcosa che i bambini del mondo<br />
intero capiscono perfettamente; soltanto gli adulti non ne sanno<br />
nulla» 25 . O si crede o no. Sembra un ritorno impetuoso del positivi-<br />
smo. Le grandi scoperte scientifiche del MIT 26 non vengono discusse,<br />
si deve accettare il modello di vita altrimenti si è «fuori dal mondo dei<br />
bit, ancorati nel mondo degli atomi» 27 . Bill Gates, geniale creatore<br />
della Microsoft, è stato invece il guru economico dell’essere digitali.<br />
Bill Gates è un commerciante e la sua religiosità rientra nel settore<br />
economico, ma anche lui da al suo recente libro un titolo profetico: «La<br />
strada che porta a domani» 28 . A regolare politicamente l’impulso pro-<br />
fetizzante della rivoluzione digitale è stato Al Gore, vicepresidente<br />
USA del governo Clinton, il quale però, per non essere meno degli al-<br />
tri, ha trasportato il fervore tecnologico nella politica americana, grazie<br />
al suo ormai famoso programma politico: “Information superhigh-<br />
way” 29 (autostrada dell’informazione).<br />
25 N. NEGROPONTE, «La rivoluzione digitale» 03-06-95 Venezia, Ca’ Foscari -<br />
MediaMente<br />
26 MIT = Massachusetts Institute of Technology di Boston<br />
27 N. NEGROPONTE, Essere digitali, ed. Sperling & Kupfer 1995 Milano, p. 36<br />
28 B. GATES, La strada che porta a domani, ed. Mondadori, 1995 Milano, p. 54<br />
29 Presentato nel 1994 all’assemblea degli Stati Uniti d’America assieme al<br />
documento della Casa Bianca noto come NII (National Information Infrastructure)<br />
14
La scomparsa dei Dinosauri<br />
Il passaggio dall’analogico al digitale viene considerato un pas-<br />
saggio cruciale nella storia contemporanea e anche questo evento<br />
viene mitizzato sia dalla letteratura che dalla scienza. La storia della<br />
scienza e della filosofia è costellata di rivoluzioni ed oggi la<br />
“rivoluzione digitale”, è stata quella che ha posto al centro<br />
d’osservazione non più l’atomo, ma il bit. La scienza e la filosofia sono<br />
così da atomocentriche divenute digitocentriche. Questa grande rivo-<br />
luzione annunciata dai grandi “profeti tecnologici” del nostro secolo, è<br />
stata la causa del passaggio epocale. Siamo entrati nell’era digitale; non<br />
dimenticando però che questa rivoluzione ha investito principalmente<br />
le regioni ricche del mondo e non le altre. Naturalmente stiamo par-<br />
lando di un’era sociologica e non geologica, dove la tecnologia rivolu-<br />
zionaria è posta al centro del passaggio epocale e l’uomo «si deve solo<br />
adattare» 30 . Il passaggio epocale, che attualmente non è concluso, ma<br />
solo iniziato, comporta come tutti i passaggi epocali il declino di qual-<br />
cosa. Lo sviluppo del ‘bit’ fa declinare, fino ad una imminente scom-<br />
parsa, l’analogico. Tutte le tecnologie analogiche possono essere figu-<br />
rate come «grandi dinosauri» 31 , ingombranti e poco agili, destinati a<br />
scomparire per lasciare spazio alle nuove “razze tecnologiche”, più<br />
agili e veloci. La televisione è l’emblema delle tecnologie analogiche<br />
30 N. NEGROPONTE, Essere digitali, cit., p. 79<br />
31 G. GILDER, La vita dopo la televisione (© 1990), ed. Castelvecchi 1995 Roma, p. 23<br />
15
che scompariranno. La televisione con il suo fare autoritario, per cui<br />
l’utente riceve solamente e non può dialogare, è ingombrante, farragi-<br />
nosa ed impositiva. «Scomparirà, questo è il suo destino» 32 . La televi-<br />
sione farà la fine dei dinosauri, occuperà sempre un posto più margi-<br />
nale, fino all’estinzione. Sono i media interattivi che aumenteranno e<br />
la tv verrà così completamente fagocitata. Grazie al contributo della<br />
similitudine dei dinosauri di George Gilder, l’avvento dell’era digitale<br />
viene paragonato al più grande evento della storia del mondo. Si ag-<br />
giunge un altro tassello alla mistificazione del presente.<br />
Il Grande Fratello e Villaggio Globale<br />
Il televisore era servito a George Orwell in “1984” da mezzo per<br />
l’attuazione di una dittatura alienante. Il televisore era la tecnologia<br />
che serviva, per prima nella storia, a dare il potere divino<br />
dell’onniscienza all’uomo. Nel romanzo di Orwell il mezzo per<br />
l’attuazione della dittatura del Socing (Socialismo Inglese) è il televi-<br />
sore. Ma non un televisore completamente «pull» 33 , che cioè fornisce le<br />
informazioni in maniera unidirezionale dall’alto al basso; al contrario<br />
è l’ipotesi di un mezzo interattivo, ma controllato. Il televisore di 1984<br />
funziona si come un normale televisore, ma può contemporaneamente<br />
ricevere informazioni: ascolta e vede tutto ciò che accade. Sembra un<br />
32 G. GILDER, cit., p. 133<br />
33 R. STAGLIANÒ, Circo Internet, ed. Feltrinelli 1997 Milano, p. 25<br />
16
controllore instancabile, ma in realtà è solo il mezzo che serve per<br />
controllare, l’analisi di giudizio resta sempre ad un “uomo control-<br />
lore”. Con Orwell la paura di un controllo costante da parte del<br />
Grande Fratello si materializza. In Oceania 34 la parte grossa del lavoro<br />
sta proprio nel tenere in piedi la struttura della dittatura.<br />
La proposta situazionale di Orwell è, oggigiorno, improponi-<br />
bile, anche se il Grande Fratello concretizza una paura ancestrale ina-<br />
movibile. Orwell però non aveva immaginato che tutta l’opera di con-<br />
trollo potesse essere automatizzata nell’era digitale. Anzi dopo la<br />
«scomparsa dei dinosauri» 35 la possibilità di realizzare un controllo<br />
quasi assoluto diventa praticabile dal punto di vista tecnico. Con la<br />
digitalizzazione di gran parte delle tecnologie e con lo sviluppo di si-<br />
stemi algoritmici sempre più precisi per l’utilizzo delle reti neurali,<br />
ogni movimento, ogni pensiero, ogni azione potrebbe essere control-<br />
lato.<br />
E diverse cose vengono già controllate. Sembra contraddittorio,<br />
ma l’unico modo di essere liberi nel pensiero è sempre di più quello di<br />
scrivere su un «antico diario cartaceo» nascosti in un nicchia al con-<br />
trollo delle tecnologie, come usava fare Winston 36 nella sua piccola<br />
stanza.<br />
34 Oceania è il grande continente dove governa il Grande Fratello, che comprende<br />
la Gran Bretagna<br />
35 G. GILDER, cit., p. 140<br />
36 G. ORWELL, 1984, (© 1949) ed. Oscar Mondadori 1989 Milano<br />
17
Un altro mito che è nato per la televisione e poi è stato riutiliz-<br />
zato per le reti è quello di «villaggio globale». Che iniziò ad intrave-<br />
dersi nel campo letterario già dalla fine degli anni sessanta con la pos-<br />
sibilità di un’unione del mondo, di un Villaggio Globale, teorizzato da<br />
Marshall McLuhan 37 , nel quale poter vivere, avendo, in ogni istante, la<br />
possibilità di sapere cosa avveniva nel resto del mondo. Benché questa<br />
teoria sia stata largamente superata dalla libertà di parola che la Rete<br />
ha dato ad ogni cittadino, cioè dalla possibilità, oggi, di una Intercon-<br />
nessione Globale, idea sviluppata dallo scrittore William Gibson che<br />
teorizzò anche la possibilità dell’aspetto grafico della comunicazione<br />
nel cyber-spazio. La televisione era il medium principale all’epoca di<br />
McLuhan, ma la crescita tecnologica non ha cancellato il mito del vil-<br />
laggio globale, benché sia «cambiato il suo intimo significato» 38 . Il vil-<br />
laggio globale oggi riguarda la comunicazione globale di tipo digitale<br />
e anche i miti democratici che erano legati al «villaggio globale» di<br />
McLuhan ora si ritrovano costantemente nel panorama filosofico e<br />
politico mondiale.<br />
37 M. McLUHAN, La galassia Gutenberg (© 1967), ed. Armando Mondadori 1988<br />
Roma, p.48<br />
38 M. McLUHAN, Gli strumenti del comunicare (© 1964), Il Saggiatore 1967 Milano,<br />
p.76<br />
18
Cybionte e cyborg<br />
Il Cybionte è una metafora proposta da De Rosnay per com-<br />
prendere quello che ci potrebbe succedere nel terzo millennio. Il signi-<br />
ficato di questa parola è la creazione di un organismo planetario, un<br />
macrorganismo, costituito dagli uomini, dalle città, dai centri infor-<br />
matici, dai computer e dalle macchine. Se si dice “città” si sa di cosa si<br />
parla, ma non si possono utilizzare immagini per rappresentare un or-<br />
ganismo planetario costituito da tutti questi sistemi. Perciò De Rosnay<br />
ha creato il termine “Cybionte” che deriva dalla cibernetica (ciber), la<br />
scienza dell’informazione e della regolamentazione nei sistemi com-<br />
plessi, e dalla biologia (bios), che denota un organismo ibrido, nello<br />
stesso tempo biologico, elettronico, meccanico, sociale ecc. Il Cybionte<br />
è più della somma delle sue parti, come il cervello è più della somma<br />
dei suoi neuroni, o il corpo umano è più della somma di quei sessan-<br />
tamila miliardi di cellule che lo costituiscono. Sul piano dell’ecologia,<br />
ricercatori come James Lorlock, hanno proposto l’idea di “Gaia”; cioè<br />
l’idea di una terra, di un sistema-terra che reagisce come un essere vi-<br />
vente, senza essere un vivente. Ma Lorlock non ha parlato della società<br />
umana. Parla sempre dell’uomo come di un parassita che vive sulla<br />
terra. L’uomo sta costruendo un nuovo organismo vivente, un ma-<br />
crorganismo planetario; questo organismo deve imparare a vivere in<br />
simbiosi con “Gaia”, la terra. Questo esige l’ecologia. «Se questa sim-<br />
biosi riesce, allora avremo una possibilità di vivere un terzo millennio<br />
19
e un quarto, positivi per l’umanità, altrimenti andremo verso catastrofi<br />
ecologiche, economiche e sociali» 39 . Il Cybionte è una grande ‘utopia’<br />
del futuro. L’utopia di De Rosnay è molto più articolata di quella del<br />
«villaggio globale» di McLuhan, inoltre necessita di numerose scelte<br />
morali collettive.<br />
L’uomo ha già ed avrà sempre di più una simbiosi con la tec-<br />
nologia. Attualmente sono note soprattutto protesi di tipo medico e te-<br />
rapeutico, ma quasi certamente in futuro i potenziometri fisici e men-<br />
tali saranno molto più comuni. La fantascienza, come sempre, ha cer-<br />
cato di anticipare i possibili futuri. «Neuromante» 40 è la figura fanta-<br />
scientifica più inquietante che la letteratura abbia partorito, per la in-<br />
terazione neurale umana con la rete, o come veniva ancora nominata<br />
dallo scrittore William Gibson, matrice. Probabilmente Case, il prota-<br />
gonista di «Neuromante», è il personaggio più realistico nell’orizzonte<br />
letterario fantascientifico; perché di figure mito-tecnologiche in realtà<br />
ce ne sono state moltissime.<br />
Il tentativo di replicare l’uomo non è nuovo nella storia<br />
dell’umanità, come la leggenda di Pandora creata da Efesto 41 e quella<br />
39 J. DE ROSNAY, «Il Cybionte» 09-05-95 Parigi - MediaMente<br />
40 W. GIBSON, Neuromante (© 1984), Casa Editrice Nord S.r.l., 1993 Milano<br />
41 Pandora fu la bellissima donna di creta, creata nelle fucine di Efesto per<br />
permettere a Zeus di vendicare l’affronto fattogli da Prometeo.<br />
20
del Golem del rabbino Leone ben Bezabel 42 . È cambiato oggi solo il<br />
nome degli esseri mitologici inventati dal nulla. Oggi si chiamano or-<br />
ganismi cibernetici, meglio noti con l’abbreviazione di ‘cyborg’. In pra-<br />
tica organismi non fatti con «materia informe» come nelle leggende,<br />
ma con le più sofisticate tecnologie. Il che, è vero, rende più credibile<br />
la possibilità di creare un cyborg, ma aumenta proporzionalmente la<br />
paura di essere spodestati da una creatura creata dall’uomo, che ac-<br />
quisti in qualche modo coscienza di sé stessa. È sempre più verosimile<br />
l’intuizione di Orwell dove l’uomo, il Grande Fratello, utilizza la tec-<br />
nologia per i suoi scopi negativi, piuttosto di una tecnologia superiore<br />
all’uomo.<br />
Il traduttore universale<br />
Con la nascita dell’universo della comunicazione nascevano an-<br />
che i miti dell’onnipotenza, della onniscienza, i miti della razionalità<br />
perfetta e del controllo totale; il mito della spiegabilità algoritmica<br />
senza residui del mondo e di conseguenza il mito della traducibilità.<br />
Che poi si trattasse di tradurre un testo da una lingua all’altra oppure<br />
di tradurre una parte del mondo in un’altra o in linguaggio matema-<br />
42 Secondo la leggenda nel 1580 il rabbino di Praga Leone ben Bezabel foggiò con<br />
l'argilla una gigantesca figura umana, che chiamò Golem. Golem è una parola ebraica<br />
che significa massa informe. La creatura, che poteva essere animata dalla parola emet<br />
(verità) tracciata sulla fronte, doveva difendere gli ebrei dalle persecuzioni. Se minacciava<br />
di ribellarsi o di diventare troppo violento, il Golem veniva riaddormentato<br />
cancellando la prima lettera di emet per trasformarla in met (morte).<br />
21
tico, poco importava. Il grande mito del traduttore universale, ispirato<br />
anche ai modelli matematici di Shannon e ai modelli linguistici di<br />
Noam Chomsky, non considera che il fenomeno linguistico è molto<br />
più articolato di ciò che fa intravedere la teoria formalizzata; si me-<br />
scolano infatti elementi naturali e convenzionali, sintattici e semantici,<br />
pragmatici e emotivi. Insomma la comunicazione non è un fenomeno<br />
solo biologico, ma anche storico e culturale, soggetto dunque alle con-<br />
tingenze e al dinamismo dei rapporti tra soggetto e soggetto e tra sog-<br />
getto e ambiente.<br />
Quella comunicativa è un’attività intessuta di metafore, di si-<br />
gnificati empirici e impliciti, di ambiguità che screziano e arricchi-<br />
scono il puro scambio di informazioni, corredandole di una serie di<br />
valenze metacomunicative ed extracomunicative, senza le quali lo<br />
scambio sarebbe misero. Come dice Sergio Moravia, mentre Chomsky<br />
cerca «nella mente dell’uomo (o addirittura nel suo corredo genetico)<br />
regole e strutture statiche, invarianti, universali» 43 , altri, tra cui Searle,<br />
ricercano «essenzialmente ciò che in quel luogo si configura, come<br />
concretizzazione di intenzioni/progetti determinati, di significazioni<br />
culturali e di comunicazioni sociali, che trovano le loro determinazioni<br />
finali solo in una dinamica gamma di eventi e situazioni interperso-<br />
nali» 44 .<br />
43 S. MORAVIA, L’enigma della mente, ed. Laterza 1986 Roma, p. 135.<br />
44 S. MORAVIA, cit., p. 282<br />
22
L’evento comunicativo per eccellenza è la conversazione: è in<br />
essa che la dimensione psico-comportamentale dell’uomo emerge in<br />
tutta la sua ricchezza di intenzioni, sottintesi, scopi e rimandi.<br />
Nella conversazione l’ascoltatore è attivo e partecipa alla narra-<br />
zione. La conversazione si può considerare come «una narrazione a<br />
più voci, una narrazione collettiva (o connettiva: a rete) e quindi, come<br />
tutte le narrazioni, un tentativo di dare un senso al mondo e a sé nel<br />
mondo» 45 .<br />
La differenza tra la comunicazione umana e quella informatica<br />
è che quest’ultima è un mero scambio di informazioni attuato con co-<br />
dici semplici e indeformabili e corrisponde pertanto al modello di<br />
Chomsky.<br />
L’intelligenza umana e il suo rispecchiamento verbale invece<br />
sono fenomeni contestuali, sistemici e diacronici.<br />
Un testo è radicato nel mondo e tradurre un testo significa tra-<br />
durre il mondo (o almeno un pezzo di mondo). Non è sorprendente,<br />
come afferma Douglas Hofstadter 46 , che la miglior traduzione inglese<br />
di un romanzo di Dostoevskij sia, in ultima analisi, un romanzo di<br />
Dickens.<br />
Cioè, se si vuole che il lettore «medio» inglese abbia, di fronte<br />
alla traduzione, un’impressione globale «analoga» (o «simile» o «equi-<br />
45 G. O. LONGO, Il nuovo Golem, 1998 ed. Laterza Roma, p. 67<br />
46 D. HOFSTADTER, Gödel, Escher e Bach, ed. Adelphi 1984 Milano<br />
23
valente») all’impressione che il lettore «medio» russo ha di fronte a<br />
Dostoevskij, allora la cosa migliore è fargli leggere Dickens.<br />
Si può pensare alla traduzione come una ri-creazione<br />
dell’opera, che tende ad allentare il legame con l’originale al fine di<br />
renderlo innocuo. La traduzione automatica troverebbe notevoli diffi-<br />
coltà di fronte agli «aloni semantici». In un testo, ogni fonema, sillaba,<br />
frase, ogni elemento linguistico risulta legato in modo più o meno<br />
stretto agli altri elementi. Questo complesso di legami presenta aspetti<br />
sonori, grammaticali, sintattici e semantici (es. attrazione verbale, al-<br />
litterazione, rima) insuperabili. L’alone semantico persiste e si evolve<br />
nella mente. Per la sua specificità è impossibile trasportare compiuta-<br />
mente questo alone, o plesso di legami, da una lingua (cultura) all’atra<br />
se non con quell’operazione temeraria e impossibile che consisterebbe<br />
nel tradurre ogni volta il mondo in sé stesso. L’alone semantico è una<br />
manifestazione della polisemia e dell’ambiguità delle lingue naturali.<br />
Insomma l’alone semantico, che pure costituisce il principale ostacolo<br />
nelle traduzioni, ne permette tuttavia un perfezionamento continuo<br />
per la sua ambiguità. Per poter lavorare con gli aloni semantici, i cal-<br />
colatori dovrebbero forse utilizzare una logica sfumata (fuzzy logic),<br />
ma ad oggi nessuno è riuscito ad ottenere risultati apprezzabili.<br />
Estendendo l’osservazione di Hofstadter, si può forse dire che la ra-<br />
gione per cui un calcolatore non riesce a tradurre un romanzo somi-<br />
glia alla ragione per la quale non riesce a scrivere un romanzo. Alan<br />
24
Turing affermò «solo un calcolatore può capire un sonetto scritto da<br />
un calcolatore», per simmetria si può affermare che «solo un uomo<br />
può capire un sonetto scritto da un uomo», purché abbiano lo stesso<br />
substrato culturale e linguistico.<br />
25
Fisica, Logica e IA.<br />
Questo capitolo cerca di individuare alcune linee di modifica<br />
delle categorie fondamentali della fisica, spostando il centro di gravità<br />
dall’atomo al bit, e come questi cambiamenti abbiano influenzato la<br />
matematica, la logica, la comunicazione globale e la Intelligenza Arti-<br />
ficiale.<br />
Spazio, tempo<br />
Spazio e Tempo sono il background (lo sfondo) nel quale le cose<br />
accadono. La fisica ha sempre considerato tali concetti fondamentali<br />
per l’analisi dell’evento. Anche l’importanza attribuita da Kant a que-<br />
ste categorie ha influito nelle teorie gnoseologiche, fino a nostri giorni.<br />
Gli infiniti punti dell’ordinario spazio fisico hanno sempre sod-<br />
disfatto gli assiomi della fisica meccanica 47 , dove i valori spaziali e<br />
temporali erano costanti e relativi ad un unico sistema, quello di misu-<br />
razione.<br />
47 L. ASTORI, Spazio-Tempo – in Enciclopedia della scienza e della tecnologia – ed. De<br />
Agostini 1995 Milano<br />
26
Con la fisica astronomica si è resa necessaria, per la misura-<br />
zione delle distanze intergalattiche, l’utilizzazione dello spazio a<br />
quattro dimensioni, o spazio-tempo, poiché il sistema di misurazione<br />
della fisica meccanica, precedentemente elaborato, non era più uni-<br />
voco. Era stata la «teoria della relatività speciale o ristretta» di Albert<br />
Einstein a mostrare come un evento avesse valore relativo al sistema<br />
dal quale veniva misurato e non avesse quindi più il carattere di con-<br />
temporaneità assoluta che aveva nella fisica meccanica 48 . Un punto<br />
nello spazio è infatti relativo al sistema dal quale viene misurato. Per<br />
poter analizzare l’evento si devono quindi eseguire almeno due misu-<br />
razione da due sistemi differenti. Cosicché un punto nello spazio-<br />
tempo, detto cronòtopo, ha due quadruplette di coordinate dei due si-<br />
stemi di riferimento. Spazio e tempo sono stati assoluti nella fisica<br />
meccanica, relativi nella relatività speciale, e frazionati o zero approssi-<br />
mativi nell’era digitale. Con l’avvento dell’era digitale e solo all’interno<br />
del digitale, le categorie di spazio e tempo hanno assunto un valore<br />
minimo 49 .<br />
48 La «teoria della relatività speciale o ristretta» del 1905 aveva permesso ad<br />
Albert Einstein di criticare radicalmente i princìpi di spazio e tempo assoluti risalenti<br />
a Newton.<br />
49 Non riporto «valore zero» affermato da Nicholas Negroponte in «Essere<br />
Digitali», perché anche nel digitale il limite è il supporto di trasmissione fisica come<br />
afferma Ellen Ullman in «Out of Time: Reflection on the programming life».<br />
27
Atomo, Bit<br />
Il tipo di rivoluzione che stiamo attraversando con l’avvento del<br />
digitale, è ben espressa da Nicholas Negroponte 50 , uno dei guru<br />
dell’informatica.<br />
«La differenza tra bit 51 e atomi è il modo più semplice di descri-<br />
vere il cambiamento. Infatti, capiamo molto bene il mondo degli atomi<br />
(delle cose, della gente, ecc.). Di fatto tutte le nostre leggi sono co-<br />
struite attorno agli atomi, anche la legge sui diritti d’autore è costruita<br />
attorno agli atomi. Il mondo dei bit è molto interessante perché i bit<br />
non hanno peso, non hanno dimensioni, non hanno colore, viaggiano<br />
alla velocità della luce. Tutti concordano sul fatto che una biblioteca<br />
pubblica sia una buona cosa: una buona cosa per la cultura e per la so-<br />
cietà. Una biblioteca pubblica funziona perché essa si basa su atomi:<br />
dovete portare i vostri atomi alla biblioteca. Allora prendete il libro in<br />
prestito. Non è che un altro atomo, ma - e questo è così ovvio che non<br />
ci pensiamo mai - il guaio è che quando prendete in prestito un atomo<br />
non ci sono atomi rimanenti. Resta uno spazio vuoto. Voi portate il li-<br />
bro a casa, lo leggete, diciamo in una settimana, lo riportate alla bi-<br />
blioteca.<br />
50 Nicholas Negroponte è il fondatore e il direttore del Media Laboratory MIT<br />
(Massachusetts Institute of Technology).<br />
51 Bit è l’acronimo simmetrico di BInary digiT, cioè singolo numero di un sistema<br />
binario, (0,1).<br />
28
Magicamente qualcuno lo prende in prestito di nuovo e lo ri-<br />
porta indietro dopo una settimana. Così 52 persone avranno letto il li-<br />
bro in un anno. Ora invece renderò la biblioteca pubblica “digitale”.<br />
Cambierò solo questo: muterò gli atomi in bit. Non dovrò trasportare i<br />
miei atomi alla biblioteca. È una cosa così ovvia, ma non viene mai<br />
detta: è che quando prendete in prestito un bit, c’è sempre un altro bit<br />
che rimane. Così ora 20 milioni di persone possono prendere in pre-<br />
stito questo libro simultaneamente, senza muoversi di casa, giusto<br />
battendo alcuni tasti e così abbiamo violato le leggi del copyright...» 52<br />
Secondo quanto afferma lo stesso Negroponte, il valore del bit è<br />
dato dalla sua diffusibilità. Ecco allora perché nella storia delle sco-<br />
perte tecnologiche viene data notevolissima importanza all’invenzione<br />
della stampa di Gutenberg 53 . La divulgazione del pensiero era legata,<br />
prima della sua scoperta, alla pesantezza del tempo di realizzazione,<br />
che influiva su tutti gli aspetti divulgativi, da quelli materiali (non esi-<br />
stevano tante copie dello stesso scritto) a quelli economici (il carattere<br />
unico dei manoscritti li rendeva costosissimi). L’invenzione della<br />
stampa a caratteri mobili non ha eliminato i limiti precedenti, li ha solo<br />
alleggeriti di molto. In pratica l’atomicità del supporto è rimasta inva-<br />
riata. La rivoluzione è avvenuta quando il contenuto, digitalizzato, ha<br />
52 N. NEGROPONTE «Dall'atomo al bit» 31-05-95 Roma, Laboratorio, MediaMente<br />
53 L’invenzione dei caratteri mobili da parte di Johannes Gansfleisch von<br />
Gutenberg di Magonza è del 1438.<br />
29
avuto la facoltà di essere indifferente al supporto. Quando, ripren-<br />
dendo le parole di Negroponte, si è passati «dall’atomo al bit».<br />
La scrittura, tra le espressioni umane, era l’unica che potesse<br />
però essere separata in maniera non difettiva dal suo supporto 54 .<br />
Con l’informatica il trasporto dell’informazione è diventato<br />
veloce e leggero 55 . E con la smaterializzazione dell’informazione cam-<br />
bia anche la misurazione del peso dell’informazione: non più peso<br />
atomico, ma peso binario.<br />
Cyber-spazio.<br />
Cyber-spazio «è la trasparenza assoluta di tutti i calcolatori<br />
della terra». Il temine, cyberspace, fu utilizzato per la prima volta da<br />
William Gibson nel suo libro di fantascienza «Neuromancer» 56 e da<br />
allora utilizzato per rappresentare il mondo all’interno della rete.<br />
Nel cyber-spazio l’informazione è libera. Mentre prima qual-<br />
siasi informazione consultabile era legata ad un supporto materiale,<br />
perciò legata alle leggi fisiche di spazio e di tempo della meccanica<br />
classica, oggi l’informazione è stata staccata dal suo supporto mate-<br />
54 Le altre manifestazione umane, pittura, musica ecc., benché anch’esse<br />
digitalizzabili subiscono notevoli menomazioni artistiche dalla trasformazione.<br />
55 Un primo esempio di alleggerimento dell'informazione era avvenuto con<br />
l’invenzione per il telegrafo nel 1844 dell’alfabeto Morse (da parte dell’americano<br />
Samuel Morse). Il Morse restava però un sistema analogico di trasmissione,<br />
l’informazione non veniva disintegrata, come avviene invece con la digitalizzazione,<br />
e la sua manipolabilità restava ancora fortemente limitata.<br />
56 Titolo originale Neuromante di W. GIBSON, cit.<br />
30
iale. Se la «Metafisica» di Aristotele, prima del digitale, aveva un<br />
supporto cartaceo che occupava uno spazio S1, con un numero n di<br />
pagine, mentre la sua stampa occupava un tempo T1 per la realizza-<br />
zione. Dopo la pubblicazione della «Metafisica», perché<br />
l’informazione contenuta al suo interno arrivasse al fruitore, doveva<br />
essere distribuita percorrendo uno spazio geografico S2 in un tempo<br />
T2; il che porta le teorie espresse da Aristotele nella «Metafisica» ad<br />
occupare uno spazio Stot (S1 + S2) ed un tempo Ttot (T1 + T2) determinati<br />
e dato il suo supporto nel caso specifico cartaceo era legata alle leggi<br />
della fisica meccanica 57 . Nell’era digitale, la «Metafisica» può essere<br />
trasformata in numeri utilizzando il più semplice sistema matematico:<br />
quello binario.<br />
Cosa si è fatto? Si è distrutto il supporto cartaceo che ne reggeva<br />
le informazioni. O meglio si sono rese indipendenti dal supporto le<br />
teorie che Aristotele aveva espresso nel suo libro. Rendendole indi-<br />
pendenti dal supporto sono state anche rese indipendenti dalle leggi<br />
della fisica meccanica classica e le limitazioni di spazio e tempo che re-<br />
golavano il testo cartaceo sono state quasi completamente eliminate.<br />
La velocità assoluta 58 è diventata una caratteristica<br />
dell’informazione e della comunicazione.<br />
57 Sono state volutamente considerate solo due estensioni spaziali e temporali,<br />
per semplificare l’esempio.<br />
58 Nell’accezione non fisica, ma letteraria di William Gibson<br />
31
Lo spazio molecolare è stato invece sostituito dallo spazio<br />
astratto della matematica pari quasi allo zero 59 .<br />
Lo spazio S0 in cui l’informazione oggi si muove percorrendolo<br />
in un tempo assoluto pari a T0, viene chiamato “cyber-spazio”.<br />
Infinito, Caos<br />
Un elaboratore elettronico, una macchina a stati finiti, potrà mai<br />
elaborare l’infinito o almeno il concetto di infinito? 60 Certamente i<br />
progressi più significativi della matematica sono scaturiti<br />
dall’elaborazione del concetto di infinito. L’uomo è in grado di for-<br />
mulare il concetto di infinito matematico 61 , ma in realtà si tratta di<br />
qualcosa di incommensurabilmente grande, o più semplicemente al di<br />
fuori dei limiti di un tempo e di un processo finiti. Molto spesso si dice<br />
che l’infinito è correlato al concetto di “insieme che contiene sé stesso”.<br />
Consideriamo i numeri naturali, essi sono infiniti, perché è sempre<br />
possibile trovare il successore di un numero, per quanto grande esso<br />
59 In verità nell’informatica l’informazione continua ad occupare un determinato<br />
spazio fisico, benché piccolissimo; nelle unità di memoria di massa, può essere un<br />
cluster magnetico, ottico, ecc.<br />
60 I teoremi di Gödel hanno dimostrato che ci sono delle verità matematiche che<br />
la mente umana riesce a intuire e che un calcolatore non riesce a dimostrare. In<br />
particolare il teorema dell'incompletezza dimostrava che all'interno di un sistema<br />
alcune leggi non erano dimostrabili nella loro validità e nella loro invalidità se non<br />
facendo diventare incoerente il sistema stesso.<br />
61 Nell’accezione matematica per cui indica la possibilità per una grandezza<br />
variabile finita (come per es. i numeri naturali dell’insieme N { 0, 1, 2,…}, per i quali<br />
è sempre possibile trovare un numero intero più grande di uno dato) di crescere<br />
oltre ogni limite; il simbolo per identificare l’infinito matematico è ∞.<br />
32
possa essere. Certo, ma questa è una pura congettura, nata dal fatto<br />
non verificato, che dato un numero possiamo trovare il successivo<br />
semplicemente sommando una unità; avremmo abbastanza tempo per<br />
farlo? Avremmo abbastanza spazio? Anche se un uomo saprebbe, in<br />
teoria, come farlo, non è immediato che potrebbe realmente riuscirci. Il<br />
riduzionismo fisico ha tentato di fare implodere il concetto<br />
dell’infinito in sé stesso. «Il numero di neuroni del cervello è molto<br />
grande, ma finito, anche la capacità di memoria di un calcolatore può<br />
essere molto grande, ma pur tuttavia finita. Non è difficile program-<br />
mare un elaboratore affinché esegua un ciclo senza fine, il classico loop,<br />
ma prima o poi tale ciclo verrebbe interrotto, o bloccando il pro-<br />
gramma, o spegnendo il calcolatore stesso. L’infinito sembra proprio<br />
che non possa avere una dimora nel cervello o nell’elaboratore, anche<br />
se è possibile concepire qualcosa senza fine, forse proprio per la con-<br />
trapposizione rispetto alle cose che sono finite» 62 .<br />
Opponendosi al riduzionismo, gli studi sulla complessità mi-<br />
rano a descrivere i sistemi osservandone non i componenti bensì i<br />
comportamenti a vari livelli e scoprendone la mutua irriducibilità, che<br />
si manifesta nella presenza di caratteristiche emergenti, non spiegabili<br />
in base al comportamento dei livelli inferiori. Si trovano così due<br />
62 O. BETTELLI, Macchine Intelligenti (© 1997) – ed. ARPA Publishing 1998<br />
Milano, cap V<br />
33
estremi di comportamento: l’ordine 63 e il caos, si pensi ad un solido in<br />
cui gli atomi occupano posizioni fisse e ad un gas in cui gli atomi si<br />
muovono liberamente. Tra questi due estremi, in una zona chiamata<br />
margine del caos, vi sono sistemi le cui componenti sono abbastanza<br />
stabili per immagazzinare informazione ma troppo labili per trasmet-<br />
terla: questi sistemi si possono organizzare, a volte spontaneamente,<br />
per eseguire calcoli, reagire alle perturbazioni e anche manifestare<br />
quel comportamento complesso ed elusivo, stabile, ma non troppo,<br />
che si chiama vita. Sono sistemi aperti, nel senso che sono attraversati<br />
da flussi di energia, materia e informazione che li mantengono lontani<br />
dall’equilibrio. Questi sistemi iniziano ad essere applicati anche ai si-<br />
stemi sociali e culturali. Nella fisica classica le leggi sono sempre state<br />
considerate deterministiche, nel senso che consentirebbero di preve-<br />
dere con precisione assoluta l’evoluzione del sistema considerato<br />
quando sia noto il suo stato in un certo istante. Oggi questa visione,<br />
sostenuta con forza da Laplace 64 due secoli fa, non regge più: si è sco-<br />
perto che anche sistemi semplicissimi, retti da leggi deterministiche,<br />
presentano comportamenti caotici dagli esiti imprevedibili. Questi si-<br />
stemi sono instabili, cioè sensibili alle condizioni iniziali, nel senso che<br />
una modifica, per quanto lieve e non rilevabile con i nostri strumenti,<br />
63 All’interno dell’ordine si trovano tutti i tipi di dualismi fisici e matematici, tra i<br />
quali rientra anche infinito come contrapposizione al finito.<br />
64 Pierre Simone de Laplace (Beaumont-en-Auge-1749-Parigi-1827) era un<br />
matematico francese ed espose nel 1809 i fondamenti del calcolo con funzioni<br />
generatrici.<br />
34
porta ad effetti diversi. Il cosiddetto «effetto farfalla»: il battito d’ali di<br />
una farfalla in Amazzonia potrebbe scatenare un uragano nel Mar<br />
della Sonda. Dunque sistemi assolutamente deterministici possono se-<br />
guire un’evoluzione caotica, da cui l’ossimoro “caos deterministico”, la<br />
scoperta di questa limitazione ha scosso la fiducia illuministica<br />
dell’uomo di conoscere sempre meglio la realtà. Il caos deterministico<br />
fu scoperto più di un secolo fa da alcuni matematici, ma ha cominciato<br />
ad influire sulla nostra visione del mondo dal 1963, quando è stato ri-<br />
scoperto grazie al calcolatore. «Se è vero che noi non sappiamo calco-<br />
lare l’evoluzione di un sistema, per esempio l’Universo, è pur vero che<br />
il sistema sa calcolare perfettamente la propria evoluzione» 65 .<br />
Logiche polivalenti<br />
Da non molto tempo gli scienziati hanno realizzato che le teorie<br />
scientifiche non sono necessariamente teorie certe, anzi, è molto inte-<br />
ressante studiare con metodi certi e rigorosi il concetto di incertezza.<br />
Questo lavoro, dal punto di vista logico e matematico, è stato svolto<br />
soprattutto nell’ambito delle cosiddette logiche fuzzy (fuzzy logics) 66 ,<br />
logiche sfumate. Si tratta di logiche che hanno abbandonato un princi-<br />
pio classico, aristotelico, della logica secondo cui i valori di verità, il<br />
65 G. O. LONGO, cit., p. 25 nota 6<br />
66 M. L. DALLA CHIARA, «Dalla macchina ideale di Turing ai computer reali», 24-03-<br />
98 Firenze, MediaMente<br />
35
vero e il falso, sono due e soltanto due: c’è il vero e c’è il falso, non si<br />
considerano situazioni intermedie tra il vero e il falso, in particolare<br />
non si considerano situazioni semantiche di indeterminatezza e di<br />
ambiguità. Nel nostro secolo, attorno agli anni Venti, è cominciato un<br />
importante studio intorno alle logiche polivalenti. Le logiche poliva-<br />
lenti sono quelle logiche secondo cui i valori di verità possono essere<br />
più di due, tre, quattro, dieci, infiniti, tanti quanti i numeri reali che<br />
stanno nell’intervallo zero/uno. Si è visto che queste logiche fuzzy,<br />
create inizialmente soprattutto per scopi filosofici 67 , negli anni più vi-<br />
cini a noi, Sessanta e Settanta, hanno avuto delle interessanti applica-<br />
zioni tecnologiche; infatti, principalmente i giapponesi, hanno comin-<br />
ciato a costruire macchine che usano essenzialmente logiche di tipo<br />
fuzzy, di tipo sfumato.<br />
Intelligenza Artificiale (IA)<br />
Nata ufficialmente nel 1956 l’Intelligenza Artificiale (IA) 68 si<br />
colloca nel solco della millenaria ambizione dell’uomo di imitare l’atto<br />
divino della creazione. «L’IA è il Golem moderno» 69 . L’IA è nata ani-<br />
mata dall’intento, non di ricostruire l’uomo, ma di riprodurne con<br />
67 Il problema fondamentale era quello di salvare il libero arbitrio, salvarci dal<br />
determinismo della logica, della matematica, della fisica.<br />
68 Roberto Cordeschi, assieme a Vittorio Somenzi, trent'anni fa introdusse il<br />
concetto di intelligenza artificiale in Italia con il libro «La filosofia degli automi».<br />
69 G. O. LONGO, cit., p. 56<br />
36
estrema precisione una sola parte: la mente, o meglio, l’intelligenza<br />
computante, considerata l’aspetto più importante, caratteristico e fon-<br />
damentale dell’uomo. Infatti a quei tempi c’era ancora la tendenza a<br />
identificare la mente con i suoi aspetti razionali, anzi simbolici e algo-<br />
ritmici. La tesi di Church apparteneva alla versione forte dell’IA:<br />
«tutta l’attività mentale dell’uomo è di tipo algoritmico dunque ripro-<br />
ducibile con una macchina discreta» 70 . Affermazione sostenuta anche<br />
da Alan Turing, il quale aveva proposto in maniera indiscutibile, il<br />
«Gioco dell’imitazione» 71 come metodo per il riconoscimento<br />
dell’intelligenza artificiale. L’IA funzionalistica dunque rimuove il<br />
corpo e il suo radicamento nel mondo e accentua le prerogative logico-<br />
razionali della mente umana. Dopo il primo sviluppo in senso funzio-<br />
nalistico, dell’IA, si sono potenziate le teorie strutturalistiche, che ve-<br />
dono nella struttura neuronale la caratteristica fondamentale del cer-<br />
vello. Pur senza cadere nella tentazione di ricreare la struttura neuro-<br />
70 L’ipotesi diventa addirittura ontologica: «I processi mentali di qualsiasi tipo<br />
possono essere simulati da un programma per calcolatore abbastanza potente (cioè<br />
nel quale possano essere programmate tutte le funzioni parziali ricorsive). […] Via<br />
via che l’intelligenza artificiale si evolve, i suoi meccanismi soggiacenti tendono a<br />
coincidere con i meccanismi soggiacenti dell’intelligenza umana».<br />
71 Le macchine ammesse al gioco sono gli elaboratori elettronici digitali,<br />
considerati imitatori universali degli stati discreti. Il «Gioco dell'imitazione» consiste<br />
nell'avere un interrogante e due interrogati. L'interrogante, separato in maniera<br />
fisicamente ermetica dagli interrogati, deve riconoscere quali dei due interrogati è il<br />
computer. In realtà il Test di Turing, così fu rinominato il «Gioco dell'imitazione»,<br />
presentato nel 1950 fu superato solo qualche anno dopo, nel 1965, dal programma<br />
«Eliza» di Weinzebaun; ma ancora oggi viene preso come modello di riferimento<br />
teorico.<br />
37
nale del cervello di Einstein 72 , la matematica ha sviluppato lo studio<br />
delle «reti neurali» 73 , alle quali ha applicato degli algoritmi che aves-<br />
sero uno sviluppo autonomo, detti «genetic algorithms» 74 (algoritmi ge-<br />
netici). La facoltà di autoapprendimento dall’errore 75 ha affascinato<br />
gran parte della scienza, andando ad intaccare i grandi sistemi mate-<br />
matici di tipo probabilistico. La mente umana è molto più lenta delle<br />
macchine a fare calcoli, ma è molto più adatta ad affrontare relazioni<br />
di tipo analogico ad alto livello. Queste considerazioni toccano la na-<br />
tura platonica della matematica: i calcolatori starebbero alle “verità”<br />
matematiche come gli acceleratori di particelle stanno alla “realtà” fi-<br />
sica, entrambe le macchine aiutano a scoprire una realtà preesistente e<br />
ciò rivelerebbe un intreccio tra il platonismo e lo sperimentalismo.<br />
Penrose è riuscito ad esaltare questa similitudine usando in maniera<br />
essenziale i teoremi di Gödel. Il problema è «perché ci sono delle ve-<br />
rità matematiche che la mente umana riesce a intuire e che un calco-<br />
latore non riesce a dimostrare?». L’ipotesi di Penrose è un po’ strana<br />
ed ha suscitato delle reazioni qualche volta anche negative nella co-<br />
munità degli scienziati. Secondo Penrose «il motivo per cui la mente<br />
72 D. HOFSTADTER «Conversazione con il cervello di Einstein» tratto da L’Io della<br />
Mente ed. Adelphi 1985 Milano<br />
73 Il Perceptron è stata la prima rete neurale utilizzata, poi superata dalla<br />
Multilayer Perceptron, dalle reti di Kohonen, dalle reti di Caianello, ecc.<br />
74 F. A. CAMARGO, Learning Algorithms in Neural Networks, Computer Science<br />
Department – Columbia University, 1990 New York, NY, 10027, p. 3<br />
75 Secondo la più famosa regola dell’error backpropagation o della propagazione<br />
dell’errore a ritroso, proposta nel 1986 da Rumelhart, Hinton e William [vedi<br />
Glossario e Appendice 1 – Le reti neurali]<br />
38
umana ha questa capacità tutta peculiare dipende dal fatto che nel cer-<br />
vello umano ci sono dei processi essenzialmente quantistici, poiché la<br />
meccanica quantistica è una teoria indeterministica - mentre le mac-<br />
chine di solito sono deterministiche -, tale indeterminismo essenziale<br />
si verifica nella parte interna dei neuroni del nostro cervello e ci resti-<br />
tuisce questa capacità di capire cose che sfuggono al potere delle mac-<br />
chine». La sua visione dell’IA sembra parallela ai computer quantistici<br />
teorizzati da Feynman 76 . Nell’applicazione ai computer e ai calcoli, gli<br />
elementi di una sovrapposizione quantistica di stati danno luogo a<br />
rami paralleli di calcolo, per cui ogni ramo rappresenta l’elemento di<br />
una sovrapposizione quantistica. Naturalmente, per ottenere, poi, un<br />
risultato definito tutti questi rami diversi devono precipitare su un<br />
unico risultato, deve avvenire quel processo che in meccanica quanti-<br />
stica si chiama ‘collasso della funzione d’onda’. In pratica si è arrivati<br />
a sostenere che il pensiero è un ‘collasso della funzione d’onda’.<br />
76 Richard Phillips FEYNMAN (1918-1988) premio nobel per la fisica nel 1965<br />
39
Percezione<br />
«A livello di percezione dell’universo sensibile probabilmente<br />
non esistono infiniti termini se non piuttosto confini percettivi che non<br />
possono essere trattati e manipolati se non utilizzando il concetto di<br />
infinito dove l’infinito corrisponde all’orizzonte percettivo» 77 . Le per-<br />
cezioni sono state virtualizzate, come lo è stato il corpo, il soggetto<br />
della percezione. Infine la realtà virtuale è arrivata, falsando i nostri<br />
sistemi percettivi, a trasformare le metodologie conoscitive.<br />
Virtuale<br />
Consideriamo l’opposizione semplice quanto ingannevole di<br />
reale e virtuale. Generalmente, la parola virtuale viene utilizzata per<br />
significare l’assenza di esistenza pura e semplice, dal momento che la<br />
77 G. O. LONGO, cit., p. 58<br />
40
“realtà” implicherebbe una effettività materiale, una presenza tangi-<br />
bile.<br />
Ciò che è reale rientrerebbe nell’ordine della presenza concreta<br />
(“l’uovo di oggi”) e ciò che è virtuale in quello della presenza differita<br />
(“la gallina di domani”). La parola virtuale proviene dal latino medie-<br />
vale virtualis, derivato, a sua volta, da virtus, forza, potenza. Nella filo-<br />
sofia scolastica ‘virtuale’ è ciò che esiste in potenza e non in atto. Il<br />
virtuale tende ad attualizzarsi, senza essere tuttavia passato ad una<br />
concretizzazione effettiva o formale. L’albero è virtualmente presente<br />
nel seme. Volendosi attenere rigorosamente al ragionamento filoso-<br />
fico, il virtuale non si contrappone al reale, ma all’attuale: virtualità e<br />
attualità sono due diversi modi di essere 78 . A questo punto è necessa-<br />
rio introdurre una distinzione fondamentale tra possibile e virtuale,<br />
messa in luce da Gilles Deleuze in Differenza e ripetizione 79 . Il possibile<br />
è già interamente costituito, ma rimane nella irrealtà. Senza cambiare<br />
nulla della sua determinazione e della sua natura: «è un reale la-<br />
tente» 80 . Il possibile è esattamente determinato e completo come il<br />
reale: gli manca solo l’esistenza. «La differenza tra possibile e reale è»<br />
dunque «puramente logica» 81 . Il virtuale a sua volta non si oppone al<br />
reale, ma all’attuale. Contrariamente al possibile, statico e già costi-<br />
78 P. LÉVY, Il virtuale (© 1995), ed. Raffaello Cortina Editore 1997 Milano, p. 17<br />
79 G. DELEUZE, Differenza e ripetizione (© 1968), ed. Il mulino 1972 Bologna, p. 12<br />
80 P. LÉVY, Il virtuale, cit., p. 23<br />
81 Ibidem, p. 37<br />
41
tuito, il virtuale è come un complesso in divenire, il nodo di tendenze<br />
e di forze che accompagna una situazione e che richiede un processo<br />
di trasformazione: l’attualizzazione. Il problema del seme, per esem-<br />
pio, è di far crescere un albero. Il seme “è” questo problema, anche se<br />
non si esaurisce in esso. Questo non significa che esso “conosca” esat-<br />
tamente quale sarà esattamente la forma dell’albero, ma a partire dai<br />
vincoli che gli sono propri dovrà inventarlo adattandosi alle circo-<br />
stanze in cui si imbatterà. Pierre Lévy bene differenzia le contrapposi-<br />
zioni reale/virtuale e attuale/virtuale, arrivando a cogliere così il vir-<br />
tuale più simile ad una «potenzialità» aristotelica. «E se la realizza-<br />
zione è quel movimento che porta all’accadere di un possibile predefi-<br />
nito e l’attualizzazione è l’invenzione di una soluzione richiesta da un<br />
complesso problematico, la virtualizzazione può essere definita come<br />
il movimento contrario all’attualizzazione. La virtualizzazione passa<br />
da una soluzione data ad un (altro) problema. Una delle modalità più<br />
importanti del virtuale è il distacco dal qui e ora» 82 . Il virtuale molto<br />
spesso “non è nel ci”». È Michel Serres 83 per primo a descrivere il tema<br />
del virtuale come “fuori dal ci”. L’immaginazione, la memoria, la co-<br />
noscenza, la religione sono dei vettori di virtualizzazione che hanno<br />
fatto che noi abbandonassimo il “ci” molto prima di quanto abbiano<br />
fatto la diffusione dell’informazione e le reti a tecnologia digitale. Es-<br />
82 Ibidem, p. 44<br />
83 M. SERRES, Atlas, ed. Julliard 1994 Paris<br />
42
sere svincolati dal ci, occupare uno spazio inafferrabile, non essere sol-<br />
tanto “nel ci”, tutto questo non impedisce di essere. Benché<br />
un’etimologia non provi molto, la parola esistere proviene precisa-<br />
mente dal latino sistere, essere situato, e dal suffisso ex, fuori da. Esi-<br />
stere è dunque un esser-ci o un uscire dal ci? Dasein o esistenza? È<br />
come se il tedesco sottolineasse l’attualizzazione e il latino la virtualiz-<br />
zazione. Quando una persona, una collettività, un atto,<br />
un’informazione si virtualizzano, si pongono “fuori da ci”. E ciò nono-<br />
stante il virtuale non è immaginario. Produce degli effetti. Sebbene<br />
non si sappia dove, la conversazione telefonica “ha luogo”.<br />
Spazialità. Il contemporaneo moltiplicarsi degli spazi fa di noi<br />
un nuovo genere di nomadi: anziché seguire delle linee di erranza e di<br />
migrazione nell’ambito di una certa estensione, noi saltiamo da una<br />
rete all’altra, da un sistema di prossimità al successivo. L’invenzione<br />
di nuove velocità è stato il primo stadio della virtualizzazione.<br />
L’aumento esponenziale della comunicazione e la diffusione del tra-<br />
sporto rapido riguardano il movimento di virtualizzazione della so-<br />
cietà ed hanno la medesima tensione a “uscire dal ci”.<br />
Virtualizzazione del testo. Lettura, scrittura, digitalizzazione sono<br />
le varie fasi che portano all’ipertesto e l’ipertesto è uno degli esempi<br />
più comuni di virtualizzazione.<br />
43
1. Lettura. Sin dalle origini mesopotamiche, il testo è oggetto vir-<br />
tuale, astratto, indipendente dal tipo specifico di supporto. Leg-<br />
gere, ascoltare, paradossalmente, significa incominciare a trala-<br />
sciare, a trascegliere e a slegare il testo. Lacerando attraverso la<br />
lettura e l’ascolto noi accartocciamo il testo; esso diventa<br />
un’interfaccia con noi stessi. Ascoltare, leggere significa co-<br />
struirsi. Qui il testo funge da vettore. Attraverso la lettura av-<br />
viene l’attualizzazione del testo e con questo si attualizza il no-<br />
stro personale spazio mentale.<br />
2. Scrittura. La scrittura è stata una delle importanti estroflessioni<br />
cognitive dell’uomo. È stata la tecnologia che ha esteriorizzato il<br />
linguaggio. L’introduzione della scrittura ha accelerato un pro-<br />
cesso di sempre maggior artificio, di esteriorizzazione e di vir-<br />
tualizzazione della memoria. La scrittura non può essere ridotta a<br />
mera registrazione della parola. La parziale oggettivazione della<br />
memoria nel testo ha permesso, probabilmente, lo sviluppo di<br />
una tradizione critica. Infatti, lo scritto crea una distanza tra il<br />
sapere e il suo soggetto: lo scrittore. «Forse è perché non sono<br />
più ciò che so, che sono in grado di rimetterlo in discussione» 84 .<br />
84 P. LÉVY, Il virtuale, cit., p. 28.<br />
44
3. Digitalizzazione. Il nuovo testo ha innanzitutto delle caratteristi-<br />
che tecniche riconducibili ad una dialettica del possibile e del<br />
reale. Mentre nella lettura su supporto cartaceo è presente una<br />
attualità del testo (il testo è là, scritto nero su bianco, e non può<br />
essere modificato), nella lettura su video questa presenza stabile<br />
viene meno. Il supporto digitale non contiene testo che possa es-<br />
sere letto dall’uomo, ma una serie di codici informatici che po-<br />
tranno eventualmente essere tradotti da un computer in segni<br />
alfanumerici e visualizzati su display. Lo schermo si presenta,<br />
quindi, come una finestra dalla quale il lettore parte<br />
all’esplorazione di una riserva potenziale. Potenziale e non vir-<br />
tuale, perché il software di lettura predetermina un insieme di<br />
possibili che, per quanto vasto, è comunque numericamente fi-<br />
nito e logicamente chiuso. «Il virtuale appare solo con l’ingresso<br />
nel cerchio della soggettività umana[…]» 85 . Il computer è quindi,<br />
restando nel linguaggio di Lévy, un operatore di potenzializza-<br />
zione dell’informazione. Lo schermo informatico è una nuova<br />
“macchina per leggere”, ma ogni lettura al computer è una edi-<br />
zione, un montaggio singolare.<br />
85 Ibidem, p. 30.<br />
45
4. Ipertesto. È con l’ipertesto che avviene la virtualizzazione del te-<br />
sto e della lettura. «Il testo è trasformato in una problematica te-<br />
stuale» 86 . Sappiamo che nei primi testi alfabetici non vi era sepa-<br />
razione fra le parole. Solo progressivamente furono inventati gli<br />
spazi tra i vocaboli, la punteggiatura, i paragrafi, le suddivisioni<br />
in capitoli, gli indici, gli apparati, l’impaginazione, la rete dei<br />
rimandi delle enciclopedie e dei dizionari, le note a piè di pa-<br />
gina…insomma, tutto ciò che serve a facilitare la lettura e la con-<br />
sultazione dei documenti scritti. Contribuendo a piegare i testi, a<br />
strutturarli, ad articolarli oltre la loro linearità. Queste tecnolo-<br />
gie ausiliari costituiscono quello che potremmo definire un ap-<br />
parato di lettura artificiale. L’ipertesto, l’ipermediale e il multi-<br />
mediale interattivo proseguono un processo secolare di artifi-<br />
cializzazione della lettura. «I dispositivi ipertestuali costitui-<br />
scono una sorta di oggettivazione, di esteriorizzazione, di vir-<br />
tualizzazione dei processi di lettura» 87 .<br />
Il corpo virtuale<br />
Il corpo virtuale è un paradosso introdotto nel 1997 da Antonio<br />
Caronia 88 , il quale, contro la paura della ‘scomparsa’ del corpo tramite<br />
86 Ibidem, p. 32.<br />
87 Ibidem, p. 34.<br />
88 CARONIA Antonio, Il corpo disseminato all'interno e all'esterno del virtuale, EMSF<br />
46
la digitalizzazione, ha invece affermato la nuova centralità del corpo<br />
nell’attività dell’uomo, grazie alle tecnologie digitali. Il corpo, con<br />
l’uso della telecomunicazione digitale, arriva a perdere il riferimento<br />
con lo spazio-tempo cartesiano e con lo spazio-tempo biofisico. La<br />
cosa rilevante che spesso si dimentica è che l’interazione importante<br />
non è quella tra l’uomo e la macchina, ma tra l’uomo e l’uomo mediata<br />
dalla macchina. Questa nuova comunicazione realizza una sorta di<br />
simbiosi tra uomo e macchina. Il corpo in quanto tale non perde cen-<br />
tralità, ma al contrario l’acquista. Tutto ciò ha valore se noi conside-<br />
riamo il corpo non come un semplice concetto biologico, ma come un<br />
concetto culturale. Il processo di disseminazione del corpo nelle reti<br />
implica una ridistribuzione, una ridefinizione del concetto di corpo.<br />
Una teorizzazione sistematica del corpo virtuale è stata proposta da<br />
Pierre Lévy, attraverso le percezioni, le proiezioni, i rovesciamenti e<br />
gli ipercorpi.<br />
1. Percezione. I sistemi di telecomunicazione rappresentano chiara-<br />
mente uno spostamento all’esterno delle funzioni percettive. Il<br />
telefono per l’udito, la televisione per la vista, i sistemi di mani-<br />
polazione a distanza per il tatto e l’interazione sensomotoria.<br />
Grazie agli apparecchi fotografici, alle telecamere e ai registra-<br />
tori possiamo percepire le sensazioni provate da un’altra per-<br />
sona in un altro momento e in un altro luogo. Inoltre, i cosid-<br />
47
detti sistemi di realtà virtuale (RV) ci consentono di sperimen-<br />
tare l’integrazione dinamica di modalità percettive differenti. Ci<br />
è dato quasi di rivivere in tutto e per tutto l’esperienza senso-<br />
riale di un altro. Nella percezione non diminuiamo la nostra<br />
centralità corporea, ma ne acquisiamo di esterne: appropriando-<br />
cene.<br />
2. Proiezione. La funzione simmetrica della percezione è la proie-<br />
zione nel mondo sia dell’azione sia dell’immagine. La proie-<br />
zione dell’azione è naturalmente legata alle macchine, alle reti di<br />
trasporto, ai circuiti di produzione e di distribuzione<br />
dell’energia, alle armi. In questo caso molte persone condivi-<br />
dono gli stessi enormi arti, virtualizzati e deterritorializzati. La<br />
proiezione dell’immagine del corpo in genere viene associata al<br />
concetto di telepresenza. Il telefono, per esempio, opera già<br />
come un dispositivo di questo tipo, in quanto non si limita a tra-<br />
smettere una immagine o una rappresentazione della voce, ma<br />
veicola la voce stessa. Il telefono separa la voce (o corpo sonoro)<br />
dal corpo fisico e la trasmette a distanza. «Il mio corpo fisico è<br />
qui, mentre il mio corpo sdoppiato è al contempo qui e al-<br />
trove» 89 . Il telefono attualizza già una forma parziale di ubiquità<br />
89 Ibidem, p. 19.<br />
48
e il corpo sonoro del mio interlocutore subisce a sua volta il me-<br />
desimo sdoppiamento, di modo che entrambi ci troviamo con-<br />
temporaneamente qui e altrove, ma formando un incrocio ri-<br />
spetto alla dislocazione dei corpi fisici. I sistemi di realtà virtuale<br />
trasmettono più di una semplice immagine: una quasi presenza.<br />
Alcune funzioni corporee, come la capacità di manipolazione le-<br />
gata al coordinamento sensomotorio in tempo reale, vengono di<br />
fatto traslate a distanza nel corso di un processo tecnico com-<br />
plesso che in certi settori dell’industria è padroneggiato sempre<br />
più perfettamente.<br />
3. Rovesciamenti. Che cos’è a rendere visibile il corpo? La sua su-<br />
perficie: i capelli, la pelle,, la vivacità dello sguardo. Oggi<br />
l’iconografia medica mette a nudo l’intero corpo senza bisogno<br />
di incidere la pelle sensibile, né sezionare vasi, né tagliare tes-<br />
suti. Raggi x, scanner, sistemi di risonanza magnetica nucleare,<br />
ecografie, organoscopie virtualizzano la superficie del corpo. A<br />
partire da queste membrane virtuali si possono ricostruire mo-<br />
delli digitali tridimensionali da cui ricavare riproduzioni solide.<br />
Nel regno del virtuale l’analisi e la ricostruzione del corpo non<br />
implica più né dolore né morte. La pelle virtualizzata si fa per-<br />
meabile. L’organismo è rovesciato come un guanto. L’interno<br />
passa all’esterno pur rimanendo dentro, perché la pelle è anche<br />
49
il confine tra sé stessi e l’esterno. Con la telepresenza e i sistemi<br />
di comunicazione i corpi si dislocano all’esterno, diventando<br />
simulacri di sé stessi.<br />
4. Ipercorpi. Nel loro essere fuori i corpi diventano anche della col-<br />
lettività. Al giorno d’oggi cornee, ovuli, embrioni e soprattutto<br />
plasma vengono ‘socializzati’, scambiati e conservati in apposite<br />
banche. Il sangue deterritorializzato scorre da un corpo all’altro<br />
attraverso una vasta rete internazionale. Il corpo collettivo (o so-<br />
cializzato) ritorna a modificare la carne privata, talvolta ripor-<br />
tandola in vita o fecondandola in «vitro». Ciascun corpo diviene<br />
parte integrante di un immenso ipercorpo ibrido e mondializ-<br />
zato.<br />
Realtà Virtuale (RV)<br />
Per capire perché la realtà virtuale è un potentissimo strumento<br />
di conoscenza, bisogna capire due cose molto semplici. La prima è che<br />
cos’è la RV. Al di là di ogni complicazione tecnica, la RV è la possibi-<br />
lità di riprodurre un ambiente o un oggetto. Si può fare attraverso una<br />
tecnologia di computer, ma l’importante è che si faccia in una maniera<br />
e con degli strumenti che permettano di presentarlo allo spettatore in<br />
un modo che tende a essere non distinguibile dalla realtà. Se si rag-<br />
50
giunge questo livello, possiamo dire che la percezione viene ingannata,<br />
l’azione si svolge come se si stesse nella realtà e non lavorando attra-<br />
verso uno strumento. Noi siamo abituati a lavorare attraverso gli<br />
strumenti informatici, adesso, prima abbiamo usato le macchine da<br />
scrivere, sappiamo che imparare a lavorare con queste macchine non è<br />
facile, richiede certi adattamenti, certi aggiustamenti 90 . Dal punto di vi-<br />
sta psicologico abbiamo due modi di conoscere le cose:<br />
l’apprendimento diretto attraverso i sensi (es. la vista) e quello indi-<br />
retto attraverso l’intelletto (es. la lettura). L’apprendimento diretto è<br />
quello più naturale, lo stesso che utilizzano i bambini. Mentre<br />
l’apprendimento intellettuale è un lavoro faticoso, selettivo. Qualcuno<br />
lo sa fare, qualcuno non lo sa fare. Per impararlo bisogna studiare e fa<br />
fatica farlo e quindi non tutti ci riescono e non tutti vanno lontano. La<br />
combinazione di queste due cose, fa sì che la RV possa essere un po-<br />
tente strumento di conoscenza; e questa è la seconda cosa da afferrare.<br />
Nella nostra cultura, conoscenza è sinonimo di lettura di libri e di fa-<br />
tica. Non ce lo siamo inventati perché eravamo particolarmente per-<br />
versi e ci piaceva inventare un modo difficile per apprendere le cose,<br />
ma fino ad oggi, fino all’avvento della RV, quello era l’unico modo che<br />
avevamo per conoscere alcuni tipi di cose molto importanti: ci sono<br />
cose che non si vedono, cose che non si sentono e cose che non si toc-<br />
90 F. ANTINUCCI, «La realtà virtuale come strumento di conoscenza» 10-15-95<br />
Ginevra, MediaMente<br />
51
cano. Tutto ciò che si riferisce a distanze enormi, per esempio al di<br />
fuori della nostra terra, tutto ciò che si riferisce a mondi infinitamente<br />
piccoli, cioè a tutto ciò che in realtà non possiamo percepire diretta-<br />
mente e non possiamo toccare direttamente, non può essere cono-<br />
sciuto e studiato nel modo naturale. Per questo motivo, nel corso dei<br />
secoli, a mano a mano che le nostre conoscenze si approfondivano, noi<br />
abbiamo dovuto tradurlo in questi simboli, che possiamo elaborare<br />
solo con la mente, pensando. Per esempio, i concetti di forza che stu-<br />
diamo nella fisica, dobbiamo immaginarli, perché non li possiamo ve-<br />
dere operare fisicamente. La RV invece permette di costruire ambienti<br />
simulati. Al CNR di Roma il prof. Francesco Antinucci con i suoi col-<br />
laboratori ha costruito uno di questi ambienti in cui le forze si vedono<br />
e si ‘toccano’, cioè si può interagire per vedere gli effetti che produ-<br />
cono. In questa maniera si riesce capire e conoscere il comportamento<br />
dei fenomeni con apprendimento diretto, in modo naturale. Quindi si-<br />
gnifica che, paradossalmente, il progresso delle tecnologie, l’aumento<br />
di potenza e di velocità riporta finalmente le macchine al servizio<br />
dell’uomo e della sua comunicazione naturale. Più si va avanti, più la<br />
tecnologia diventa sofistica, più ha il compito di tornare alla natura,<br />
ma tornare addirittura alla natura più semplice. Con la RV arriva al<br />
culmine la tecnologia user friendly.<br />
52
Infosistema<br />
Lo sviluppo delle tecnologie informatiche ha portato alla na-<br />
scita di un vero e proprio sistema di scambio informazionale con le<br />
sue precise regole. L’aumento della circolazione del dato ha reso molto<br />
complesso l’uso dell’informazione. Per non essere travolti da essa le<br />
grandi compagnie economiche e mediatiche stanno già facendo delle<br />
scelte per noi, come l’invenzione di sistemi per la ricerca automatiz-<br />
zata e noi a nostra volta dobbiamo fare precise scelte nei riguardi<br />
dell’informazione, per non esserne travolti e per non esserne traviati.<br />
Velocità dell’Informazione<br />
Il cyber-spazio diventa sempre più pervasivo e più veloce,<br />
mentre il cyber-tempo, cioè la nostra capacità di elaborazione<br />
dell’informazione che ci proviene dal mondo «dentro» 91 , cyber-spazio,<br />
ha dei limiti invalicabili. Il rapporto tra cyber-spazio e cyber-tempo è il<br />
grande problema dell’epoca in cui stiamo entrando. La velocità reale è<br />
considerata pari allo zero, benché in realtà sia ancora strettamente le-<br />
gata alle capacità dell’hardware e dei collegamenti fisici. Insomma è<br />
91 F. COLOMBO, Confucio nel computer (© 1995), ed. Rizzoli 1998 Milano; p. 23.<br />
Definizione utilizzata per il mondo in rete in contrapposizione col mondo esterno<br />
53
vero che un bit viaggia alla velocità della luce, ma è anche vero che per<br />
formare un documento servono numerosissimi bit e che questi non ri-<br />
escono a passare tutti contemporaneamente per lo stesso cavo di tra-<br />
smissione. Detto questo per precisione tecnica, si può anche affermare<br />
che il tempo di trasmissione o di comunicazione è stato ridotto in ma-<br />
niera considerevole. Sono stati ridotti i tempi di trasmissione, ma per<br />
avere valore un’informazione deve necessariamente essere elaborata.<br />
Dove con “elaborazione dell’informazione” si intende qualsiasi azione<br />
intellettuale sul dato, dalla semplice lettura all’utilizzo della stessa in-<br />
formazione per scopi diversi. La velocità con la quale si ha informa-<br />
zione, porta anche ad avere in breve tempo un enorme mole di dati.<br />
Il gap ora sta quindi non nel trasferimento stesso del dato, pro-<br />
blema predominante in tutta la storia dell’informazione, ma nella sua<br />
elaborazione. La velocità di trasferimento è zero approssimativa 92 , ma la<br />
nostra velocità nell’elaborazione del dato è ancora legata ad un lento<br />
approccio interpretativo. L’esubero di dati non permette alla nostra<br />
mente di stare al passo dell’informazione digitale, creando così una<br />
desincronizzazione tra cervello e bit. Si è creato, con la comunicazione<br />
globale, un mondo immateriale dell’informazione nel quale l’uomo<br />
può avere informazione in modo rapido ed efficiente. Si è puntato lo<br />
sviluppo tecnologico, come ancora avviene, nella rapidità,<br />
92 Per quantità vicina allo zero assoluto.<br />
54
nell’efficienza e nella quantità. Arrivando così a creare un infosi-<br />
stema 93 , nel quale l’uomo non è in grado di interagire consapevol-<br />
mente con il dato perché la sua struttura biofisica non glielo consente.<br />
Non può l’uomo elaborare i dati in veloce formato numerico/binario,<br />
come fa la macchina, ma ha bisogno della “interfaccia” simbolica per<br />
compiere azioni critiche sul dato.<br />
I pesi dell’Informazione<br />
L’informazione ha vari ‘pesi’, il dato è infatti più o meno im-<br />
portante. Verso la metà del Novecento le teorie dell’informazione eb-<br />
bero una scossa dall’opera del matematico ed ingegnere Claude Shan-<br />
non, che, con uno schematismo riduzionistico, formulava i teoremi<br />
sull’entropia (quantità d’informazione generata in media da una sor-<br />
gente) e sulla capacità (quantità d’informazione trasmessa in media da<br />
un canale).<br />
Lo schema di Shannon rispecchia una situazione di trasmis-<br />
sione unidirezionale (dalla sorgente al destinatario) ed è basata<br />
sull’ipotesi che entrambi i soggetti abbiano lo stesso codice di comuni-<br />
cazione e posseggano una conoscenza perfetta dell’universo informa-<br />
zionale entro cui si svolge la trasmissione. In questo modello la comu-<br />
nicazione avviene tramite una successione (discreta) di messaggi ele-<br />
mentari scelti da un repertorio (o dizionario) la cui composizione è<br />
93 Considerato come tutto il mondo dell’informazione digitale<br />
55
nota ad entrambi i soggetti e che rimane immutata nel corso di tutta la<br />
trasmissione. La legge statistica che regge le scelte è fissa e nota ad<br />
entrambi. Nella teoria di Shannon il significato dei messaggi è del<br />
tutto ignorato: la teoria riguarda solo il cosiddetto livello sintattico,<br />
egli era interessato all’informazione presente nelle differenze. Una in-<br />
formazione può essere definita una differenza che genera altre diffe-<br />
renze lungo il canale di comunicazione sorgente/destinatario. Le dif-<br />
ferenze che non producono altre differenze non sono considerate in-<br />
formazione. Questa definizione d’informazione presuppone<br />
l’esistenza di un osservatore (uomo o macchina) in grado di rilevare e<br />
riprodurre le differenze. E poiché ciascun osservatore ha risorse ed<br />
interessi diversi, ciascuno osserverà differenze diverse: dunque<br />
l’informazione ha carattere relativo.<br />
La «teoria di Shannon» è basata sulla definizione matematica<br />
della quantità d’informazione [I(E)] fornita da un evento E; dove<br />
l’informazione I fornita da un evento E è uguale al logaritmo negativo<br />
della probabilità che l’evento si presenti.<br />
56
I(E)= - log P(E)<br />
Rappresentabile anche graficamente.<br />
Benché il riduzionismo di Shannon fu molto utile in ambito tec-<br />
nico, i linguisti che cercarono di applicare queste teorie alla comples-<br />
sità della comunicazione umana, ottennero risultati discutibili. Infatti<br />
nella comunicazione umana il destinatario si colloca di fronte ai mes-<br />
saggi a tre livelli diversi:<br />
1) livello sintattico (il messaggio ricevuto viene riconosciuto di-<br />
verso dagli altri messaggi possibili)<br />
2) livello semantico (il messaggio ricevuto viene confrontato<br />
con altri, precedenti e con il contesto extracomunicativo per ricavarne<br />
il significato)<br />
3) livello pragmatico (il messaggio ricevuto e interpretato viene<br />
utilizzato dal destinatario per conseguire i propri fini).<br />
57
Inoltre nella comunicazione umana destinatario e sorgente si alter-<br />
nano.<br />
Nonostante il riduzionismo di Shannon la collaborazione tra<br />
ingegneria e tra matematica e tra ingegneria e comunicazione fu fe-<br />
condo fino alla creazione della teoria generale dell’informazione a cui<br />
diede notevole contributo quel singolare scienziato/controscienziato<br />
che fu Gregory Bateson. Si deve a lui l’individuazione del carattere<br />
relazionale dell’informazione. Bateson propose di chiamare Pleroma il<br />
mondo della materia e della forza e Creatura il mondo<br />
dell’informazione e della struttura. Ciò che conta nella Creatura sono<br />
le differenze. L’informazione sta nelle differenze e l’unità<br />
d’informazione può essere definita come «la più piccola differenza ca-<br />
pace di causare una differenza». Se diamo un calcio ad un sasso esso<br />
compie una parabola secondo le leggi della meccanica, ma se diamo<br />
un calcio ad un cane, esso può attaccarci sfruttando non l’energia del<br />
calcio, ma l’energia «collaterale» accumulata dal suo metabolismo.<br />
Anche il cane potrebbe compiere una parabola, ma questo aspetto non<br />
è interessante se non in casi molto particolari. Nella rilevanza del pa-<br />
rametro «interesse» si manifesta il fondamentale relativismo<br />
dell’informazione rispetto all’osservatore. Qual è pero il modo di uti-<br />
lizzare l’interesse come parametro di scelta, se l’informazione è babe-<br />
lica?<br />
58
Smart Agents<br />
La politica user friendly, ha portato l’industria del software allo<br />
sviluppo di agenti intelligenti, dei veri e propri programmi per la ri-<br />
cerca delle informazioni. Basati su algoritmi di tipo neurale gli Smart<br />
Agents, studiando le abitudini di ricerca del fruitore, alla fine arrivano<br />
ad avere un comportamento simile a quello dell’utilizzatore nella<br />
scelta delle informazioni. Sono dei programmi che simulano la nostra<br />
libera 94 scelta. Si utilizza quindi la matematica per affidare la cernita<br />
del dato e non si può pretendere che la scelta avvenga per libera asso-<br />
ciazione, come avviene nel nostro cervello; è infatti una scelta quanti-<br />
tativa e non qualitativa. Il dato selezionato dallo Smart Agent sarà non<br />
quello più «interessante», ma quello con maggior quantità di termini<br />
simili. Il che porta addirittura ad una annullamento della possibilità di<br />
“virata intellettuale”. È sicuro comunque che grandi tagli<br />
all’informazione andranno fatti, per poter permettere valutazioni cir-<br />
costanziate e non dispersive. L’informazione autonoma, non vincolata<br />
dai comuni canali mediatici dell’informazione, è stata considerata la<br />
grande rivoluzione giornalistica del secolo. Avere il dato non mediato<br />
inizialmente ha aperto inaspettati spiragli di libertà per poi diventare<br />
la causa stessa della moderna disinformazione. Avere troppi dati,<br />
spesso non certificati, ha portato alla scelta della «iper-oggettività<br />
94 Per questo sono anche chiamati in inglese Free agent, cioè liberi<br />
59
matematica»; cioè in un sistema informazionale (infosistema) nel quale<br />
la notizia viene considerata come dato matematico; e troppe notizie,<br />
oggettivamente e matematicamente inconfutabili, non hanno fatto al-<br />
tro che sviare dal valore dell’interessante. Gli Smart Agents lavorano<br />
sull’aspetto puramente statistico della presenza del “termine”, ma i<br />
lavori sono già iniziati per permettere ai futuri Smart Agents di fare<br />
scelte “critiche” sull’informazione. La cosa naturalmente potrà avve-<br />
nire solo quando saranno stabiliti gli standard di certificazione<br />
dell’informazione a livello internazionale anche se sempre tramite<br />
grandi canali mediatici. Infatti benché si pensasse che la rete avrebbe<br />
ucciso la mediazione, in realtà essa non ha fatto altro che aumentare in<br />
maniera esponenziale i mediatori, arrivando così all’effetto di iperme-<br />
diazione dell’informazione.<br />
Scelta ipo-informazionale<br />
Il lavoro principale perché si sviluppi un infosistema stabile,<br />
una Creatura matura, è quello di rendere l’informazione “pulita”. Di<br />
avere insomma strumenti che ci permettano di scegliere il dato puro e<br />
non l’analisi manipolata di quel dato. Sviluppare sistemi di standar-<br />
dizzazione del mediatore informazionale porterà sicuramente ad una<br />
maggior sicurezza nella navigazione tra i dati. È vero che per avere<br />
stabilità bisogna sacrificare qualcosa e/o qualcuno. Si tende a immo-<br />
lare così le piccole voci solitarie all’interno dell’infosistema o le ideo-<br />
60
logie minoritarie. Ad entrare nel grande sistema di standardizzazione<br />
saranno infatti i grandi mediatori o “trust mediatici”, più che i piccoli<br />
e economicamente poco potenti «urlatori solitari». Bisogna dare<br />
ascolto al piccolo urlatore o alla grande équipe di “esperti in materia”?<br />
Gli esperti potrebbero falsare il dato per problemi economici, ma<br />
l’urlatore potrebbe affermare cose e spacciare dati senza alcuna cogni-<br />
zione di causa. Se è vero che da una parte la standardizzazione porterà<br />
sicurezza, è pur vero che l’informazione sarà sempre più canalizzata e<br />
mediata dal sistema economico. Il contrasto è netto ed insuperabile, la<br />
stabilità starà proprio nell’accettare un’instabilità radicale<br />
dell’infosistema, con i suoi movimenti interni, scontri rivoluzionari e<br />
flames 95 , come nella vita reale perché anch’esso fa parte della vita reale.<br />
95 I Flames sono violente discussioni in rete<br />
61
Conoscenza<br />
La conoscenza ha un valore completamente diverso dal pos-<br />
sesso del dato, essa si basa non sull’aspetto quantitativo<br />
dell’informazione, ma su quello qualitativo. Con l’avvento<br />
dell’ipertesto digitale, con lo spostamento di baricentro nella lettura,<br />
sono venuti ad essere necessari nuove metodologie d’approccio<br />
all’immensità dei dati, tra le quali l’ergonomia intellettuale è la più<br />
propagandata. Grave resta il problema della formazione, che viene di-<br />
sorientata e sempre più allontanata dalla figura del maestro.<br />
Hypertext<br />
«Sappiamo che nei testi alfabetici non vi era separazione fra le<br />
parole. Solo progressivamente furono inventati gli spazi tra i vocaboli,<br />
la punteggiatura, i paragrafi, le suddivisioni in capitoli, gli indici, gli<br />
apparati, l’impaginazione, la rete dei rimandi delle enciclopedie e dei<br />
dizionari, le note a piè di pagina … insomma tutto ciò che serve a faci-<br />
litare la lettura e la consultazione dei documenti scritti» 96 . Queste tec-<br />
nologie ausiliari alla lettura sono state le prime forme di ipertestualità.<br />
La abitudinarietà dell’uso del ‘rimando’ ipertestuale ha impedito per<br />
96 P. LÉVY, Il virtuale, cit., p. 33<br />
62
secoli la sua focalizzazione dal punto di vista teorico, benché la lettura<br />
del testo in maniera “non sequenziale” avvenisse su qualsiasi scritto<br />
con riferimenti locali/interni 97 o globali/esterni 98 o nella parola attra-<br />
verso gli “ipse dixit”.<br />
L’ipertestualità può ritenersi quindi da sempre un elemento<br />
fondante della comunicazione. Perché se era così comune l’ipertesto<br />
non ha assunto la fama dovuta? Forse a causa della polimedialità. Cioè<br />
per il fatto che i collegamenti avvenissero su supporti differenti e fisi-<br />
camente e geograficamente distanti. Del valore dell’ipertesto ci si è resi<br />
conto quando il collegamento è stato possibile all’interno dello stesso<br />
supporto: quello digitale. Cioè quando si è passati da polimedialità a<br />
multimedialità 99 .<br />
Ed è naturalmente all’interno della rete che l’ipertestualità può<br />
raggiungere il suo massimo potenziale. Infatti è nel ciberspazio, «la<br />
turbolenta zona di transito per i segni vettorializzati» 100 , che si «mani-<br />
festerà sempre più la tendenza a sostituire le copie di documenti con<br />
collegamenti ipertestuali» 101 .<br />
97 Come note, indici, sommari, ecc.<br />
98 Come citazioni di altre fonti, bibliografie, ecc.<br />
99 Sul significato da attribuire al termine multimedialità è ancora aperto il<br />
dibattito che vede antagonisti i termini di plurimedialità e di monomedialità. In<br />
questo caso si è voluto intendere il passaggio da numerosi supporti diversi<br />
(polimedialità) ad un unico supporto che racchiudesse in sé in formato digitale i<br />
diversi media (multimedialità). L’utilizzo del termine polimedialità è stato scelto per<br />
non schierarsi nella polemica ancora esistente.<br />
100 P. LÉVY, Il virtuale, cit., p. 36<br />
101 Ibidem, p. 38<br />
63
La scrittura ipertestuale viene detta, in contrapposizione alla<br />
scrittura sequenziale, reticolare, nel senso che «la linea di scrittura<br />
della pratica alfabetica viene frammentata nella molteplicità di nodi<br />
che compongono il ciberspazio» 102 . Dev’essere però dissipata la conce-<br />
zione di ipertestualità legata esclusivamente al testo alfabetico.<br />
Ipertesto digitale «potrebbe essere definito come una serie di in-<br />
formazioni multimodali strutturate reticolarmente a navigazione ra-<br />
pida e conviviale» 103 .<br />
È stato Theodor Holm Nelson che nel 1965 ha proposto il con-<br />
cetto di hypertext, come insieme di documenti che possano essere letti<br />
in maniera “non sequenziale”, e al concetto ha accompagnato il Pro-<br />
getto Xanadu. Il suo progetto era «un sistema per la letteratura», dove<br />
per letteratura egli intende «un sistema elettronico di documenti inter-<br />
connessi», dato che «dobbiamo essere in grado di trattare la rete come<br />
un tutto e i suoi contenuti come un “docuverso” 104 , cioè un universo di<br />
documenti unico» 105 .<br />
A trovare i principi dell’ipertesto è stato il filosofo francese<br />
Pierre Lévy, «al fine di preservare la possibilità di interpretazioni<br />
molteplici del modello dell’ipertesto» 106 :<br />
31-33<br />
102 A. DALLAPINA, Il filosofo nell’ipertesto, 1996 EMSF<br />
103 P. LÉVY, Il virtuale, cit., p. 34<br />
104 Tradotto dall’inglese da docuverse, parola composta da document e universe.<br />
105 T. H. NELSON, «Virtual n.9» 1996 Milano, p.52<br />
106 P. LÉVY, Le tecnologie dell’intelligenza (© 1990), ed. Synergon 1992 Bologna, p.<br />
64
1. Principio di metamorfosi, che rifiuta la staticità e che vede nella<br />
modificabilità continua il valore stesso dell’ipertesto; «così come<br />
il fiume di Eraclito, l’ipertesto non è uguale a sé stesso» 107 .<br />
2. Principio di eterogeneità, per cui l’ipertesto si sviluppa attraverso<br />
media differenti;<br />
3. Principio di molteplicità, attraverso il quale una rete si organizza<br />
su un modello “frattale” 108 , cioè qualsiasi nodo o legame può ri-<br />
sultare composto di una rete.<br />
4. Principio di esteriorità, la rete non possiede unità organica e<br />
quindi gli sviluppi dell’ipertesto sono provocati dall’interazione<br />
di fenomeni esterni.<br />
5. Principio di topologia, la rete non è nello spazio, ma è lo spazio, il<br />
ciberspazio, l’orizzonte attraverso il quale si naviga; la naviga-<br />
zione ipertestuale è dunque un’esperienza immersiva.<br />
6. Principio di mobilità dei centri, la rete non ha centro, o piuttosto,<br />
ha tanti centri luminosi in continuo spostamento; la rete non<br />
possiede nemmeno centro originario.<br />
I dispositivi ipertestuali nelle reti digitali hanno deterritorializ-<br />
zato il testo rendendo la consultazione immediata.<br />
107 P. LÉVY, Il virtuale , cit., p. 38<br />
108 In matematica, figura geometrica di forma irregolare o frammentata, generata<br />
da continue e successive divisioni, con la proprietà di autosimilarità (in cui ogni<br />
minima parte appare approssimativamente simile all’intera figura).<br />
65
Ma lo svilupparsi esponenziale dei nodi ipertestuali ha trasfor-<br />
mato il «consultare» in «brucare» 109 , a causa dell’enorme mole infor-<br />
mativa.<br />
Chi è l’autore dell’hypertext.<br />
«L’autore è chi visualizza il sito» 110 . La maggior parte delle per-<br />
sone leggono un libro o un articolo di una rivista dall’inizio alla fine,<br />
da sinistra a destra, dall’alto in basso 111 . È lo scrittore, colui che rea-<br />
lizza il testo sequenziale, a creare l’esperienza per il lettore. A prescin-<br />
dere dalla personale interpretazione del lettore stesso, egli è guidato<br />
dall’inizio alla fine del suo percorso. Nel processo di lettura iperte-<br />
stuale sono i lettori coloro che creano la propria esperienza, in altre<br />
parole sono loro gli autori.<br />
«La lettura (normale) permette di attualizzare il testo» . La let-<br />
tura permette al testo di diventare interfaccia con noi stessi. «Il testo<br />
funge da vettore, da pretesto all’attualizzazione del nostro personale<br />
spazio mentale». Con la digitalizzazione invece il testo viene poten-<br />
zializzato. Non ha più un andamento unidirezionale, non è più un<br />
media «push» 112 , dal testo al lettore. Lo schermo informatico è una<br />
109 Il verbo brucare è tradotto letteralmente dall’inglese to browse, con il quale si<br />
identifica l’atto di andare a zonzo attraverso la rete tramite il browser, cioè il<br />
software che permette di stare nel World Wide Web e visualizzare le pagine HTML.<br />
110 K. MILBURN e J. BURDMAN, FrontPage – La progettazione delle pagine Web ed.<br />
Tecniche Nuove 1997 Milano, p. 55<br />
111 Riferito naturalmente agli alfabeti occidentali.<br />
112 R. STAGLIANÒ, Circo Internet , cit., p. 25<br />
66
nuova “macchina per leggere”. Ogni lettura al computer diventa una<br />
edizione, un montaggio singolare. «Il navigatore partecipa quindi alla<br />
redazione o quanto meno all’edizione del testo che “legge” poiché è<br />
lui a determinare la sua organizzazione finale (la dispositio della reto-<br />
rica antica)» 113 . Con l’ipertesto quindi ciascuna lettura diventa un vero<br />
e proprio atto di scrittura. La virtualità del testo alimenta la mia intel-<br />
ligenza in atto, costringendola a fare delle scelte di percorso. Non più,<br />
come nel testo sequenziale, un atto di pura accettazione in cui l’unica<br />
volontà è l’interpretazione. La lettura ipertestuale è un insieme disar-<br />
monico di scelte puramente soggettive.<br />
Ergonomia Intellettuale<br />
La facilità di reperimento dei dati grazie alla digitalizzazione e<br />
l’ingrandirsi in maniera esponenziale dei nodi ipertestuali in rete ha<br />
portato ad avere una immensa quantità di informazioni, anche<br />
quando si ricercano informazioni precise e circostanziate. La cono-<br />
scenza è passata dalla euristica alla “discriminazione”. Cioè si è pas-<br />
sati da un’educazione secolare di studio tramite ricerca<br />
d’informazione, alla necessità di arrivare alla verità tramite “tagli”. Il<br />
cambiamento è notevole. Il verbo inglese “to cut” (tagliare) ha assunto<br />
un pregnante significato sia per la conoscenza che per i vari tipi di<br />
composizione artistica. Il problema è quello della eccessiva quantità di<br />
113 P. LÉVY, Il virtuale, cit., p. 35<br />
67
informazioni. Quale deve essere il nostro comportamento di fronte<br />
alla marea di dati dilaganti? Dev’essere quello dell’ergonomia intellet-<br />
tuale.<br />
Il nostro secolo è caratterizzato da scienze ergonomiche. Prima<br />
dall’ergonomia meccanica, in cui noi abbiamo proiettato le nostre fun-<br />
zioni nel mondo meccanico ed elettronico 114 ; ed oggi quella intellet-<br />
tuale. Prima di essere una direzione scientifica, l’ergonomia intellet-<br />
tuale, è la teoria che evidenzia il bisogno del “taglio”, per non restare<br />
travolti dal dato puro. Voler tagliare non significa impedire al dato di<br />
venire alla luce, ma impedire al dato non interpretato di influire signi-<br />
ficativamente nelle scelte umane. Ritorna così ad acquisire notevole<br />
importanza l’ermeneutica, la quale può essere utilizzata con profitto<br />
solo dopo la cernita iniziale del dato. La necessità di risparmiare gli<br />
sforzi intellettuali, come nella scelta delle notizie utili, diviene sempre<br />
più inevitabile. La tecnologia che si sviluppa dalla ergonomia intel-<br />
lettuale è detta “user friendly”, cioè dedicata alla semplificazione della<br />
tecnologia. La nascita di reti neurali dedicate alla ricerca<br />
dell’informazione “interessante” 115 ha ridotto la difficoltà di scelta, ma<br />
anche il potere individuale di scelta. Inoltre, seconda la prospettiva<br />
114 Per esempio, la televisione è la proiezione dell'occhio, la radio dell'orecchio, il<br />
computer della memoria, l'automobile dei piedi.<br />
115 Interessante è assolutamente relativo a colui che ricerca. Le reti neurali, dette<br />
agenti intelligenti o smart agents, in questione ricercano informazioni secondo<br />
l’educazione [vedi Appendice 1 - Le reti neurali] datagli dal possessore del<br />
programma.<br />
68
proposta da De Rosnay, lo “user friendly” ha tra le sue eventualità<br />
quella di interlacciarsi con il cervello, applicando la tecnologia alla<br />
biologia. «L’ultima tappa è il trasferimento diretto di informazioni dal<br />
cervello alle macchine. I giapponesi lo chiamano “silent speech”: di-<br />
scorso silenzioso. Il computer riesce a scoprire la pronuncia di una pa-<br />
rola prima che le labbra si muovano per pronunciarla, individuandola<br />
direttamente nel cervello» 116 .<br />
Benché favorevole allo sconvolgimento dell’umano, lo stesso De<br />
Rosnay avverte che la velocità dell’informazione porterà all’esplodere<br />
de «l’inquinamento dell’informazione» 117 , con il rischio di trasformare<br />
anche la formazione in informazione.<br />
La nuova figura di maestro<br />
La nostra cultura, la nostra civiltà, fin dalle origini, fin<br />
dall’epoca dei Greci, ha conosciuto quello che i Greci chiamavano la<br />
“paideia” e i Tedeschi ”Bildung”, cioè l’educazione, la formazione.<br />
Oggi, soprattutto attraverso la diffusione dell’informazione a distanza<br />
non c’è più il rapporto diretto fra il maestro e l’allievo, non c’è più<br />
educazione, ma solo informazione. Questo può produrre la crescita<br />
dell’informazione, ma la diminuzione della formazione, della cono-<br />
scenza e del sapere. Oggi viviamo un conflitto tra il tempo corto della<br />
116 J. DE ROSNAY, «Il Cybionte» cit.<br />
117 J. DE ROSNAY, «C'è una vita dopo Internet?» 11-02-97 Cannes, MediaMente<br />
69
televisione e dei media e il tempo lungo dell’educazione. Il tempo<br />
corto si manifesta nel video-clip, nello spot della pubblicità, nello<br />
“zapping” che è un saltare da una cosa all’altra. Abbiamo un mosaico<br />
di conoscenze e non l’integrazione che crea cultura.<br />
Il tempo di mediazione con l’informazione è stato ridotto al mi-<br />
nimo. L’importante è avere l’informazione, non saperla gestire in<br />
senso critico.<br />
Il problema sta nell’equilibrio che in futuro bisognerà trovare<br />
tra la scuola reale e la scuola virtuale.<br />
Troppo spesso le politiche scolastiche sono state abbagliate<br />
dallo splendore della tecnologia, senza comprenderne la reale finalità.<br />
Troppo spesso lo “strumento” viene considerato il punto di arrivo<br />
dello sviluppo scolastico, non prendendo in considerazione il fatto che<br />
lo “strumento”, non può essere che un ausilio alla didattica.<br />
L’ipertestualità è sempre stata utilizzata da docenti, che con il solo uso<br />
della parola, integravano il loro specifico sapere ad altri. Non è stato<br />
quindi l’uso dei computer ad introdurre l’insegnamento ipertestuale<br />
nelle scuole. Le moderne tecnologie invece fanno sorgere nuovi pro-<br />
blemi. La velocità di informazione circolante può essere talmente ra-<br />
pida da investire un bambino con un basso livello critico. Il ruolo del<br />
docente dovrebbe diventare perciò quello di mediatore socratico, tra<br />
informazione e sapere. Inoltre gli strumenti tecnologici spesso sono<br />
conosciuti meglio dai discenti, che dai docenti. Ciò crea uno scom-<br />
70
penso nella mediazione. Il docente deve quindi sempre più trasfor-<br />
marsi, non in colui il quale trasmette informazioni (quelle sono ormai<br />
ampiamente disponibili), ma colui il quale cerca di indirizzare nella<br />
scelta, colui che insegna a buttare via le informazioni inutili. Il docente<br />
deve diventare sempre più un docente etico, riprendendo ad esempio<br />
la figura dell’antico “maestro”.<br />
71
Estetica della tecnica<br />
La tecnologia si è sviluppata in maniera quasi incontrollabile.<br />
Le tecniche da semplici mezzi, strumenti in mano all’uomo, sono di-<br />
ventate complesse tecnologie che avvolgono e imbrigliano il quoti-<br />
diano, provocando negli uomini sensazioni nuove, di enorme gran-<br />
dezza e di infinita piccolezza. «Le tecnologie sono diventate le nuove<br />
muse, a volte così incontrollabili da sembrare elementi naturali o divi-<br />
nità […]» 118 .<br />
Estetica della sparizione<br />
«La dimensione estetica è una dimensione curiosa, perché, in ef-<br />
fetti, tutte le tecnologie nel loro aspetto artistico ci rimandano alla ver-<br />
sione di azione» 119 . Così come le avanguardie avevano messo in luce<br />
che ogni atto artistico può essere considerato solo in quanto atto, non<br />
per il suo prodotto. Attraverso la telematica, attraverso il computer,<br />
l’arte digitale, noi possiamo produrre immagini, segni, segnali, forme<br />
e processi creativi che non hanno bisogno del luogo fisico, ma si affi-<br />
dano ad un tragitto e alle dinamiche di Internet, ad una comunica-<br />
118 W. GIBSON, Neuromante, cit., p. 17<br />
119 F. COLOMBO, «Le molteplici dimensioni del mondo delle reti», 05-07-96 Napoli,<br />
MediaMente<br />
72
zione, appunto, telematica. In questo modo l’arte arriva a smaterializ-<br />
zarsi e diventa anoressica, poiché il passaggio dall’oggetto al concetto<br />
diventa sempre più accentuato. L’«estetica della sparizione» 120 ri-<br />
guarda tutti i settori che utilizzano il digitale; si pensi, per esempio,<br />
alla smaterializzazione della moneta che oggi non è altro che informa-<br />
zione: non si spostano più somme di danaro, oro o preziosi, ma pure<br />
informazioni. Così nell’arte l’estetica della sparizione si assottiglia il<br />
materiale artistico a favore del concetto, dell’idea artistica. Natural-<br />
mente, la «anoressia dell’arte» 121 sviluppa una potenzialità enorme per<br />
artisti giovani e meno giovani, con l’introduzione di una virtualità<br />
estetica che prima l’arte non conosceva. L’arte anoressica è in qualche<br />
modo il frutto non negativo della tecnologia perché sviluppa segnali e<br />
forme estetiche che colpiscono oltre l’occhio anche il cervello del frui-<br />
tore. È un’arte che si insinua nella casa, negli spazi della contempla-<br />
zione, è un’arte che sostanzialmente produce anche un’altra conse-<br />
guenza positiva: scardina la cornice obbligata del museo o della galle-<br />
ria, i luoghi deputati dove normalmente l’arte può essere contemplata,<br />
anzi ora la «degustazione può avvenire in ogni spazio domestico, in<br />
ogni camera della nostra abitazione, nei luoghi più inusitati» 122 . Ecco,<br />
dunque, che l’anoressia dell’arte attraverso la telematica non è una<br />
contrazione, una riduzione, un assottigliamento del corpo, ma anzi,<br />
120 P. VIRILIO, «La velocità assoluta», cit.<br />
121 A. BONITO OLIVA, «L’anoressia dell’arte», 20-10-96 Roma MediaMente<br />
122 Ibidem<br />
73
paradossalmente, attraverso l’assottigliamento ottiene il massimo<br />
della dilatazione, di penetrazione capillare che la forma dell’arte può<br />
realizzare uscendo dal luogo di propulsione laddove l’artista ha<br />
mosso la propria mano elettronica, arrivando nei luoghi più disparati<br />
di tutto il mondo. La tecnologia, in questo senso, diviene una sorta di<br />
sostanza estetica che con i suoi vapori e le sue atmosfere può produrre<br />
effetti positivi, è quindi una sorta di «declinazione ecologica della<br />
fantasia che, invece di danneggiare, migliorerà sicuramente il<br />
mondo» 123 . S’è pur vero che l’anoressia dell’arte lascia aperte molte<br />
strade, la possibilità di riproduzione del digitale potrebbe aumentare,<br />
come giustamente fa notare Remo Bodei 124 , il pericolo dell’effetto<br />
Stendhal, per il sovraccarico di stimoli. Si modifica però con l’arte di-<br />
gitale la contemplazione dell’opera d’arte. L’artista digitale non è più<br />
colui che indirizza l’osservatore verso un oggetto esteticamente bello,<br />
ma è colui che ha creato tutte le «possibilità virtuali racchiuse nel<br />
meta-progetto» 125 . L’opera d’arte digitale così non ha più limiti e<br />
l’autentico creatore di ogni prodotto artistico diventa il fruitore.<br />
123 Ibidem<br />
124 R. BODEI, «La comunicazione nel V secolo dell'era globale», 07-05-96 Napoli<br />
MediaMente<br />
125 D. DE KERCKHOVE, «Arte e scienza nella rete» 13-01-96 Roma MediaMente<br />
74
Il sublime tecnologico<br />
L’estetica digitale è basata sul semplice fatto che con la cultura<br />
digitale, la testualità digitale, le immagini digitali si verifica uno spo-<br />
stamento dalla scrittura - basata su segni e superfici fisiche - ai codici.<br />
Ci muoviamo dal materiale all’immateriale. «Il testo diventa<br />
aperto» 126 . La maggior parte della nostra estetica è fondata su fattori<br />
associati alla tecnologia di stampa, che pongono l’enfasi sulla creati-<br />
vità unica di un artista e sul fatto che l’artista è un alienato, una figura<br />
isolata per la maggior parte del tempo. Quando, viceversa, si lavora su<br />
un medium digitale, diventa chiaro, come ribadiscono i post-struttu-<br />
ralisti e gli strutturalisti già da molto tempo, che, in realtà, tutta la<br />
scrittura, tutta la pittura, tutta la creazione di musica è essenzialmente<br />
un’attività cyborg: un’attività collaborativa con tutta la gente che non<br />
ha mai “scritto” nella forma artistica, con cui in genere lavora. Il carat-<br />
tere proprio dell’arte non è il bello. Il carattere proprio dell’arte è il si-<br />
gnificato. Tanto è vero che esiste un’estetica del brutto o molta arte che<br />
non è bella per niente. L’arte è, sostanzialmente, significato. Oggi, la<br />
ricerca estetica va molto di più avviandosi verso la sensorialità, verso<br />
quella che Berenson chiamava la «intensificazione vitale» o le sensa-<br />
zioni immaginarie, piuttosto che verso questa sensazione di bello arti-<br />
stico; nozione, oggi, del tutto impraticabile. Gli artisti dovrebbero<br />
126 G. P. LANDOW., «Il confine aperto del testo» 14-11-96 Milano MediaMente<br />
75
muoversi nella prospettiva del «sublime tecnologico» 127 , cioè: ricerca<br />
collettiva, progetti concettuali collettivi. Che cosa hanno di estetico ri-<br />
spetto ad un semplice tecnico delle interfacce? Hanno di estetico che<br />
producono sensazioni immaginarie reali, attraverso le quali stimolano<br />
intensificazioni vitali, stati sensoriali veri e propri. Questo è un lavoro<br />
che è specificamente estetico, perché è un lavoro al quale i tecnici ne-<br />
cessariamente devono o dovrebbero collaborare, ma che richiede un<br />
tipo di competenza, di atteggiamento della personalità che non ha<br />
niente a che vedere con quello del programmatore o con quello del<br />
creatore di interfaccia. Il «sublime tecnologico» è, in qualche modo, la<br />
nozione dell’oltrepassamento dell’arte ed è un essere collocati al di là<br />
di quelle che erano le categorie specifiche dell’artistico, vale a dire: il<br />
soggetto, l’espressione, la creatività, lo stile. La nozione di sublime<br />
tecnologico, alla quale le nuove tecnologie permettono di accedere, è<br />
una nozione che liquida tutta la struttura concettuale legata<br />
all’artistico e che introduce, invece, quel sistema di categorie concet-<br />
tuali legate, nell’estetica tradizionale, al sublime: la nozione, cioè, di<br />
un soggetto debole, di un soggetto sopraffatto da qualche cosa che non<br />
è soggetto: «è questa la dimensione nella quale le nuove tecnologie<br />
hanno collocato la situazione antropologica in generale» 128 . È una si-<br />
tuazione di debolezza del soggetto, di oltrepassamento<br />
127 M. COSTA, «Il sublime tecnologico» 02-06-96 Firenze MediaMente<br />
128 Ibidem<br />
76
dell’espressione, di venir meno dello stile, del venir meno di tutte<br />
quelle che erano le caratteristiche fondamentali dell’arte tradizional-<br />
mente intesa. Le nuove tecnologie hanno un’enorme influenza sulla<br />
produzione artistica. Infatti tutte le avanguardie artistiche di questo<br />
secolo sono indotte dall’avvento di nuove tecnologie. Tutte le forme<br />
artistiche, per sopravvivere, vivono un’ibridazione reciproca e anche<br />
una contaminazione da parte dei nuovi mezzi di cui dispongono. La<br />
stessa storia dell’avanguardia non si spiega se non come strategia di<br />
sopravvivenza. Il teatro di Brecht, che conta sulla mobilitazione del<br />
pubblico, ad esempio, o quello di Artaud, che fa del teatro<br />
un’esperienza del corpo, sono strategie di sopravvivenza del teatro,<br />
messo di fronte al cinema. Gli artisti tecnologici o i ricercatori estetici<br />
devono oggi rinunciare - e già lo fanno - ad alcune componenti fon-<br />
damentali di quello che era l’artista della tradizione. Loro lavorano<br />
prevalentemente sul piano del concetto, i progetti su cui lavorano<br />
sono concettuali. Il concetto è condivisibile. Questo significa che la<br />
produzione può essere, deve essere e in molti casi lo è già, una produ-<br />
zione concertata, collettiva. Significa che la proprietà esclusiva<br />
dell’opera è una nozione arcaica, così come lo stile che una volta ca-<br />
ratterizzava l’artista. L’estetica contemporanea, in generale la rifles-<br />
sione estetologica contemporanea oggi lavora molto poco sul contem-<br />
poraneo. Ciò è addirittura testimoniato dal fatto che i grandi estetologi<br />
o gli estetologi che noi abbiamo oggi, parlano ancora di arte in termini<br />
77
tradizionali e quando fanno degli esempi citano Holderlin o Van<br />
Gogh. «Questo era, in qualche modo, legittimo fino ad Heidegger.<br />
Heidegger poteva ancora permettersi di discutere dell’arte in questo<br />
modo» 129 . Oggi l’estetica deve molto di più tematizzare, molto di più<br />
problematizzare la situazione che le nuove cose, le nuove tecniche, le<br />
nuove energie ci hanno costretto a considerare. Una vera e propria ri-<br />
flessione estetologica su quello che sta avvenendo oggi, i filosofi prefe-<br />
riscono non farla e preferiscono muoversi su un terreno molto più si-<br />
curo, molto più tranquillizzante, molto più cauto che è ancora quello<br />
dell’arte tradizionale.<br />
129 Ibidem<br />
78
SECONDA PARTE<br />
79
I Lurkers<br />
(prospettiva sociologica)<br />
Con la massificazione delle comunicazioni globali digitali, al-<br />
cuni aspetti sociali vanno cambiando. Nella rete nascono nuove tipo-<br />
logie di persone, ma si rischia anche l’alienazione nella rete. Oltre però<br />
ai neo-luddisti, che criticano lo sviluppo tecnologico in sé, la nuova so-<br />
ciologia della conoscenza avverte: «Restringere la propria finestra sul<br />
cortile del mondo all’angustia dei propri interessi produrrà solo degli<br />
ultraspecialisti asociali!» 130 .<br />
Push VS. Pull<br />
«L’industria culturale di massa» 131 ha contribuito a realizzare<br />
dagli anni ‘30 agli anni ‘70-’80 un processo divulgativo esteso sia ai<br />
ceti maggiormente preparati da un punto di vista culturale che ai ceti<br />
meno avvantaggiati da questo punto di vista. Il processo si é svilup-<br />
pato progressivamente iniziando sempre dalle élites della società; ciò<br />
che differenzia le nuove tecnologie dalle vecchie é il fatto che le nuove<br />
saranno probabilmente in grado di diffondersi e di veicolare cultura<br />
130 R. STAGLIANÒ, Circo Internet, cit., p. 52<br />
131 A. ABRUZZESE «Società di massa e tv generalista», 15-10-96 Venezia,<br />
MediaMente<br />
80
tra tutti i ceti, in direzione orizzontale piuttosto che dall’alto verso il<br />
basso, come é avvenuto in passato. Confrontando il modello televisivo<br />
che distribuisce da uno a molti (push) con quello interattivo del Web<br />
dove ognuno può tirare giù le informazioni che vuole quando lo vuole<br />
(pull) 132 , George Gilder 133 aveva già annunciato la morte della TV. La<br />
«cattiva maestra» ammonita in pubblico da Karl Popper 134 , è però an-<br />
cora il collante che tiene insieme il mondo. Ma sulla lentezza delle<br />
aspettative che si avevano su Internet alcuni hanno ribattezzato la tri-<br />
plice W come World Wide Wait (Grande Attesa Mondiale). Quello che<br />
non si comprende è che i due modelli (Push/Pull), così diversi da non<br />
possono essere confrontati, rispondono anche a caratteristiche com-<br />
pletamente diverse; uno implica la passività l’altro l’attività, uno non<br />
ha bisogno di conoscenze l’altro si. Quello che si potrà fare è trasfor-<br />
mare per chi lo desideri il modello pull con un modello push automa-<br />
tizzato, come hanno tentato già nel 1996 i fratelli Chris e Greg Hassett<br />
con il loro software PointCast 135 che porta le notizie a voi. Ma ciò sna-<br />
turerebbe la creatività ricettiva del Web. Per questo la TV generalista,<br />
push per eccellenza, resterà in vita ancora a lungo. La preparazione, il<br />
sapere sono fondamentali in Internet, o in generale nel media pull, per<br />
132 R. STAGLIANÒ, Circo Internet, cit., p. 54<br />
133 GILDER George, cit., p. 65<br />
134 J. CONDRY & K. R. POPPER, Cattiva maestra televisione, ed. Donzelli 1996<br />
Roma<br />
135 PointCast era uno smart agent della prima generazione, in particolare era un<br />
software basato su algoritmo genetico, che cercava le news interessanti secondo il<br />
profilo culturale dell’utente che lo utilizzava.<br />
81
potere fare scelte accurate sulla giusta informazione. Secondo Walter<br />
Cronkite 136 un pericolo in Internet è che ci siano persone che forni-<br />
scono informazioni senza il benché minimo standard etico. Ci sono in<br />
rete le riviste classiche trasposte in formato digitale o riviste nate ap-<br />
posta per la rete come “Slate” 137 ; ma esistono anche numerosissime in-<br />
formazioni non certificate. Molti hanno la possibilità quindi di dire la<br />
verità al mondo, oppure di far passare per vero il falso. Come distin-<br />
guerlo? Secondo Ted Koppel 138 «Il ruolo del giornalista che sa selezio-<br />
nare le cose più importanti è destinato a diventare sempre più impor-<br />
tante».<br />
Nella rete c’è molta informazione, forse troppa. Se si trascura il<br />
fattore serendipity 139 , la benigna possibilità di fare incontri fortuiti e<br />
fortunati sulle strade del sapere, si rischia di piallare un po’ pericolo-<br />
samente le digressioni che generalmente allargano le prospettive di<br />
ogni lettore.<br />
In questa prospettiva il machete dello smart agent è il benve-<br />
nuto. L’agente intelligente ci aiuterà quindi a selezionare le notizie a<br />
noi più congeniali, magari garantendone la qualità secondo il ricono-<br />
scimento della certificazione dell’informazione oppure modificando le<br />
136 Walter Cronkite è un decano del giornalismo americano e autore del fortunato<br />
A Reporter’s Life<br />
137 Periodico on-line edito da Microsoft<br />
138 Giornalista della ABC<br />
139 Serendipity = lett. la capacità di trovare tesori<br />
82
icerche in base al nostro sviluppo conoscitivo, grazie agli algoritmi<br />
delle reti neuronali.<br />
La società che cambia<br />
«Si sposta il centro di gravità, non più sull’atomo ma sul nu-<br />
mero binario» 140 . Una società dell’informazione è centrata essenzial-<br />
mente su entità immateriali e quindi sui bit 141 . Ci si arriva sostanzial-<br />
mente attraverso quattro ondate, che brevemente sintetizzano la ri-<br />
voluzione dell’IT 142 dagli anni Sessanta ad oggi. Il primo periodo è<br />
quello degli elaboratori centrali, dei mainframes 143 , il cui paradigma di<br />
riferimento sono le istituzioni e le organizzazioni. La seconda ondata è<br />
quella che è caratterizzata dal personal computer, che è degli anni Ot-<br />
tanta e il paradigma di riferimento a questo punto diventano gli indi-<br />
vidui, sia gli individui all’interno delle aziende, che progressivamente<br />
vengono collegati da ponti che sono le reti locali, sia gli individui<br />
all’interno delle loro case, alla fine degli anni Ottanta. Il periodo at-<br />
tuale è il periodo che è segnato dall’ascesa delle autostrade digitali,<br />
ovvero dalla connessione, in un’unica infrastruttura a livello mon-<br />
diale, di tutte quelle isole di cui abbiamo appena parlato. Questa con-<br />
140 N. NEGROPONTE, «La rivoluzione digitale», cit.<br />
141 N. NEGROPONTE, Essere digitali, cit., p. 46<br />
142 IT = (information technology) tecnologia dell’informazione, include tutti i settori<br />
informatici<br />
143 Mainframes = grandi computer [vedi Glossario]<br />
83
dizione attuale è appunto quella che consentirà il passaggio alla<br />
«quarta ondata» 144 , cioè al periodo della costruzione della vera e pro-<br />
pria società dell’informazione, caratterizzata dalla centralità di un<br />
contenuto completamente digitalizzato e totalmente convergente. Si<br />
sta sviluppando quella che Pierre Lévy ha definito “intelligenza col-<br />
lettiva” 145 . Anche se forse l’espressione migliore per descrivere tale<br />
processo l’aveva avuta Orson Welles 146 , tempo prima, quando aveva<br />
detto che «lo scrittore lavora con la penna e il pittore lavora con il<br />
pennello e il cineasta lavora con l’esercito» 147 , perché aveva sottoli-<br />
neato che, per quanto riguarda il cinema, si trattava di un lavoro col-<br />
lettivo, ma dicendo “esercito” ci ricordava che questo lavoro collettivo<br />
non era fatto di persone tutte uguali, tutte felici di lavorare insieme<br />
ma, piuttosto, che si trattava di un lavoro organizzato con dei ruoli,<br />
delle gerarchie e anche, come succede in tutti i buoni eserciti, con dei<br />
problemi di conflittualità all’interno.<br />
Le collaborazioni hanno fatto sorgere una necessità a chi si av-<br />
vicinava alla rete: l’anglofonia. In realtà nella rete si utilizza un gergo.<br />
È vero che gli elementi gergali ad Internet connessi, sono anglicizzanti,<br />
ma un gergo è tutto tranne che una lingua. Quello che si usa princi-<br />
144 R. MASIERO, «Passato, presente e futuro della società dell'informazione», 05-09-95<br />
Parigi - European IT Forum, MediaMente<br />
145 P. LÉVY, Le tecnologie dell’intelligenza, cit., p. 41<br />
146 Orson Welles (Kenosha 1915 – Los Angeles 1985) regista inglese<br />
147 C. M. VALENTINETTI, Orson Welles, ed. Il Castoro 1995 Milano<br />
84
palmente in Internet è un «broken English» 148 , grazie alla caratteristica<br />
sonorità plastica della lingua inglese si può sintetizzare con semplici<br />
suoni, o con vere e proprie sigle gergali. Per esempio: ‘you’ (= tu) viene<br />
sostituito con ‘u’; ‘to’ (= a, verso) con ‘2’; ‘are’ con ‘r’ e ‘asl?’ 149 significa<br />
‘quanti anni hai? di che sesso sei? E da dove digiti?’; ecc.<br />
Ora però inizia a ‘rompersi’ anche l’italiano: dgt significa digiti, ecc.<br />
La rete si è sviluppata negli USA, benché sia nata al CERN di<br />
Ginevra, come del resto gran parte del settore informatico. Questo ha<br />
spinto coloro che volessero usufruire della rete in maniera soddisfa-<br />
cente all’apprendimento della lingua inglese. È un grosso cambia-<br />
mento nella società mondiale, il fatto che la lingua più parlata prima<br />
di Internet, lo spagnolo, sia stato soppiantato dalla lingua più utiliz-<br />
zata nel settore tecnologico, l’inglese. In generale ad affermarsi nel<br />
mondo è l’utilizzatore medio di Internet: cristiano, bianco, ceto me-<br />
dio/alto, anglofono. Benché quindi si propagandi come multietnica, la<br />
rete è il potenziometro della classe sociale meno diffusa al mondo.<br />
Il popolo della rete<br />
Il popolo della rete appartiene in media ad un ceto, ma è aperto<br />
ad ogni nuovo membro. On-line si possono perdere tutte le differenze<br />
esterne, come sesso, razza, altezza, religione ecc. Vale infatti il «non si<br />
148 Broken English = Inglese rotto, spezzato<br />
149 ASL? è l’acronimo di «Age, sex and location?»<br />
85
vede, ergo non rileva» 150 . La vera differenza sta nella competenza tele-<br />
matica. La literacy 151 telematica garantisce infatti oggi molte opportu-<br />
nità supplementari a chi la possiede. In realtà quindi non vengono<br />
fatte discriminanti coscienti, se non quelle linguistiche. Da filtro<br />
all’accesso a Internet fanno ancora i costi, soprattutto in Italia ancora<br />
molto alti.<br />
In buona parte le nuove tecnologie ripropongono il problema<br />
della divaricazione socio-culturale fra le persone. La tecnologia del<br />
computer, però, è relativamente più semplice e più popolarmente ac-<br />
cettabile, più connessa al nostro mondo: in questa realtà multimediale<br />
la giovane generazione si orienta bene, come pure l’anziana, poiché ri-<br />
sulta più semplice attivare e usare un computer, che non sviluppare la<br />
capacità di leggere ed acquisire tranquillità nel consultare un libro. Vi-<br />
sti in questa prospettiva, «gli effetti della distanza culturale fra le per-<br />
sone che può provocare l’approccio alle tecnologie, possono essere<br />
minori, anche se esistono, rispetto alla distanza culturale di qualche<br />
generazione fa» 152 . Il problema dell’analfabetismo informatico, per<br />
esempio, è ancora presente. Ci sono vari gradi di conoscenza informa-<br />
tica. Il livello cognitivo più elementare consiste nella capacità di<br />
orientamento dinanzi ai comandi della tastiera per poter scrivere un<br />
150 R. STAGLIANÒ, Circo Internet, cit., p. 92<br />
151 La literacy è la competenza telematica dell’utente<br />
152 T. DE MAURO, «Alfabetizzazione elettronica e nuovi linguaggi», 20-05-96 Roma,<br />
MediaMente<br />
86
testo, o per produrre un grafico, o per richiamare qualche altro testo.<br />
Questo processo di conoscenza richiede uno sforzo di alfabetizzazione<br />
di poco più complesso di quello che richiedeva anche l’uso di una<br />
macchina da scrivere. Un grado ulteriore di alfabetizzazione elettro-<br />
nica consiste invece nel capire come i programmi sono strutturati: ciò<br />
richiede uno sforzo molto più impegnativo, al quale non tutti sono<br />
abituati. In questo campo di conoscenza si viene quindi formando una<br />
élite. La stessa distinzione viene fatta tra gli utenti della rete, coloro<br />
che usano la rete per comunicare, fare surfing 153 , chattare 154 , ecc. e co-<br />
loro che invece colgono in pieno le potenzialità della rete e la utiliz-<br />
zano per ricerche avanzate o comunicazioni sperimentali. Ad utiliz-<br />
zare in maniera intelligente le comunicazioni globali sono gli scien-<br />
ziati, gli studiosi e perfino gli hackers buoni 155 .<br />
I contatti avvengono attraverso chat e newsgroup e non è raro<br />
che dopo una lunga relazione on-line avvenga un incontro reale in<br />
gergo un F2F (face to face) 156 .<br />
Tra tutti i frequentatori buoni e cattivi della rete un tipo di navi-<br />
gatore spicca tra tutti: il lurker 157 , il «contemplativo» 158 . Il lurker è una<br />
153 Spostarsi tra i siti Web senza una meta precisa come se si cavalcassero le onde<br />
del mare con un surf.<br />
154 Chat (chiacchiera) identifica oramai le chiacchiere con persone sconosciute in<br />
rete, mentre quelle telefoniche vengono chiamate chat-line.<br />
155 [Vedi paragrafo Mondo Hackers nel capitolo Omnipolis]<br />
156 F2F (face to face) = un faccia a faccia<br />
157 Lurker = lett. colui che si nasconde<br />
158 R. STAGLIANÒ, Circo Internet, cit., p. 87<br />
87
sorta di ignavo contemporaneo. È colui che naviga, gira nei<br />
newsgroup 159 , nelle comunità virtuali, nei siti, solamente ‘osservando’<br />
senza mai cioè intervenire e/o schierarsi nelle discussioni né in ma-<br />
niera pubblica né in maniera privata e senza quindi lasciare traccia<br />
(volontaria) 160 del proprio passaggio. La figura del lurker sembra mi-<br />
steriosa, anche se in realtà spesso è legata alla curiosità e alla timi-<br />
dezza, oppure alla semplice paura di fare gaffe digitali. Anche nella<br />
rete, come nella vita civile, si utilizza un codice di comportamento<br />
formale, che va rispettato: la Netiquette 161 . Chiunque non usufruisca<br />
della Netiquette è riconoscibile e può essere distinto dagli altri fre-<br />
quentatori «come un uomo elegante veniva distinto dal volgo» 162 . Per<br />
ovviare i problemi comunicativi della comunicazione scritta le sensa-<br />
zioni vengono trasmesse tramite simboli grafici detti emoticons o smi-<br />
ley 163 , ma si può arrivare anche a liti furiose: i flames. Si può litigare in<br />
rete e per farlo non si usano solo parole più forti, ma si scrivono anche<br />
in maiuscolo. Scrivere in maiuscolo significa strillare ecco perché la<br />
Netiquette lo sconsiglia.<br />
159 Il newsgroup è una bacheca elettronica, dove un gruppo di persone interessato<br />
allo stesso argomento, ‘appende’ lettere (e-mail) pubbliche.<br />
160 Le tracce involontarie invece si possono lasciare grazie ai cookies, [capitolo<br />
Cookies].<br />
161 Netiquette è la fusione delle due parole net (rete) ed etiquette (etichetta), e<br />
costituisce una sorta di galateo comunicativo per Internet.<br />
162 F. COLOMBO, Confucio nel computer, cit., p. 103<br />
163 [vedi Appendice 3 - Smiley]<br />
88
Le regole nell’etichetta della rete sono molte, ecco perché spesso<br />
un newbie 164 fino alla sua piena conoscenza delle tecniche comporta-<br />
mentali preferisce solo osservare: essere un lurker.<br />
Luther Blissett<br />
«Io sono Luther Blissett. Io mi rifiuto di es-<br />
sere limitato da qualunque nome. Io ho tutti i nomi e<br />
sono tutte le cose. Incoraggio tutti i gruppi pop ad<br />
usare questo nome. Io cerco l’illuminazione attraverso<br />
la confusione. Io prospero sul caos. Io respingo il<br />
concetto di copyright. Prendi quello che puoi usare.<br />
Demolisci la cultura seria» 165 .<br />
Questo è il manifesto programmatico di Luther Blissett, uno dei<br />
più enigmatici personaggi culturali, o meglio controculturali, degli ul-<br />
timi anni. Nato con i moderni mass media di tipo pull e ad essi dichia-<br />
ratamente nemico, Luther Blissett in realtà non è una persona, non esi-<br />
ste come individuo. Una delle definizioni che si è dato è quella di “co-<br />
individuo”, una entità cioè composta da centinaia di persone che in Ita-<br />
lia e all’estero usano il suo nome per performance artistiche particolari<br />
e soprattutto per incredibili beffe ai danni dei media tradizionali. Il<br />
164 Un newbie è un neofita della rete, un nuovo frequentatore<br />
165 Sito: «The neW luTHer bliSSett's internet page» La nuova pagina Internet di<br />
Luther Blisset<br />
89
nome deriva forse da un ex calciatore del Milan, ma con Blissett nulla<br />
è certo e tutto è il contrario di tutto.<br />
Luther Blissett balza agli onori della cronaca nazionale nel 1996,<br />
confezionando un falso video su presunte messe sataniche nel viter-<br />
bese. La beffa è essa stessa diabolicamente perfetta, concepita come un<br />
film di Alfred Hitchcock 166 , dura mesi e mesi, coinvolge giornali e tv<br />
locali e culmina con l’invio di un filmato dove si vedrebbe una messa<br />
nera con sacrificio finale umano. Invece è tutto falso, la cassetta com-<br />
pleta, inviata naturalmente dallo stesso Blissett ai media, svela che il<br />
rito satanico è in realtà una sceneggiata, con tanto di tarantella finale<br />
ad opera della supposta vittima.<br />
Altre beffe hanno coinvolto la trasmissione “Chi l’ha visto?”,<br />
sguinzagliata alla ricerca della scomparsa di un presunto artista-illu-<br />
sionista inglese. E ancora, alla biennale di Venezia del 1995, giornali e<br />
riviste si sono lanciati alla ricerca della scimmia pittrice, data come<br />
appuntamento clou della manifestazione. Il Resto Del Carlino lo<br />
scorso anno ha dato ampio risalto alla storia di una prostituta sieropo-<br />
sitiva che bucava i preservativi dei suoi clienti, pubblicandone solo le<br />
iniziali: L. B. Blissett lascia sempre un marchio, un codice, una sigla,<br />
166 Alfred Hitchcock (Londra 1899 – Los Angeles 1980) regista noir inglese<br />
90
qualche cosa che possa far capire al beffato di essere stato vittima di<br />
uno scherzo.<br />
Un falso testo del guru telematico Hakim Bey ha tratto in in-<br />
ganno numerosi critici, presi in giro da Blissett che citava un tale pro-<br />
fessor Mortais Lee, che letto al contrario suona come “li’ mortè”, una<br />
colorita espressione romanesca.<br />
Una clamoroso beffa ha avuto per vittima addirittura la Monda-<br />
dori: lo scrittore Giuseppe Genna è stato convinto via e-mail di aver<br />
ricevuto un testo di controcultura particolarmente importante. Pubbli-<br />
cato il libro, Mondadori e i giornali ricevono il consueto dossier da<br />
Blissett: il testo non è altro che spazzatura telematica, una bufala in-<br />
somma, il libro viene stroncato, Genna e Mondadori dileggiati e tutta<br />
la storia appare naturalmente su Internet sui siti dedicati a Blissett.<br />
Luther Blissett è uno, nessuno centomila; per dirla con il suo<br />
manifesto, tutti possono essere Luther, basta assumerne il nome e fare<br />
qualche cosa che non sia riconducibile ad un solo individuo. «La ne-<br />
gazione dell’identità insieme alla confusione generata nei mass media<br />
è l’obiettivo di Luther, che si alimenta con i riti e le paure quotidiane,<br />
AIDS, violenza, solitudine» 167 . La sua esistenza è come una leggenda<br />
metropolitana, incerta e senza origine e con le leggende si mescola e si<br />
confonde. Prospera e fa proseliti su Internet: la Rete è infatti il luogo<br />
167 E. FERRARI, «Luther Blissett», Approfondimento del 24-10-97, MediaMente<br />
91
ideale per un individuo multiplo senza una identità, che assume di<br />
volta in volta la personalità di chi lo adotta.<br />
Blissett si può ricondurre al movimento neoista e al plagiari-<br />
smo 168 : copiare ed usare le parole degli altri è «un diritto/dovere, le<br />
idee non sono proprietà di nessuno» 169 . Allo stesso movimento, ma<br />
con forme diverse, appartiene Karen Eliot, un’altra co-identità o iden-<br />
tità multipla. Non è mai nata ma esiste, dietro la sua identità si può ce-<br />
lare chiunque, il concetto di responsabilità individuale viene negato.<br />
Karen è un’altra importante identità multipla di grande impor-<br />
tanza per il movimento neoista: nata prima di Blissett, ne anticipa i<br />
modi, anche se i suoi obiettivi sono più dichiaratamente anti-artistici e<br />
più definiti.<br />
Luther Blissett si è confrontato con la realtà quotidiana in<br />
un’aula di tribunale per banali questioni urbane. Durante un happe-<br />
ning 170 di Blissett i partecipanti sono convenuti su un autobus, per fe-<br />
steggiare con pasticcini e bibite. Agli allibiti controllori hanno però di-<br />
chiarato di essere una sola persona, Luther Blissett, e di dover pagare<br />
un solo biglietto. I poliziotti chiamati dai controllori non hanno ap-<br />
168 Movimento che non crede nel copyright come diritto acquisito, e che perciò<br />
plagia le opere artistiche digitali distribuendole gratuitamente in Internet<br />
169 F. BERARDI (Bifo), «Spunti di riflessione» 29-10-96 Bologna, MediaMente<br />
170 Happening = avvenimento, azione<br />
92
prezzato lo spirito della manifestazione, denunciando tutti ed creando<br />
su Internet un dibattito noto come “processo a Luther Blissett”.<br />
Da un lato i partecipanti al “bus neoista”, senza identità e per-<br />
sonalità univoca; dall’altro la giustizia ordinaria, basata sui fatti certifi-<br />
cabili, sulle responsabilità da accertare. Non c’è dubbio che, indipen-<br />
dentemente dal vincitore, è un processo culturalmente interessante e<br />
che crea non poche polemiche e difficoltà anche pratiche, ma d’altra<br />
parte il manifesto finale di Luther Blissett recita:<br />
piacere” 171 .<br />
“se la vita fosse semplice non ci darebbe nessun<br />
171 Sito: «The neW luTHer bliSSett's internet page» La nuova pagina Internet di<br />
Luther Blissett<br />
93
Gaia<br />
(prospettiva ecologica e antropologica)<br />
L’uomo e la natura; diventa sembra più importante equilibrare la<br />
convivenza. L’uomo deve fare dei cambiamenti fondamentali per af-<br />
frontare il futuro. Questi cambiamenti sono possibili grazie anche alle<br />
ecologiche tecnologie informatiche. La scienza tenta di trovare solu-<br />
zioni di tipo genetico ai problemi del mondo, ma forse la strada giusta<br />
è un’altra.<br />
L’Homo Symbioticus<br />
Fino ad adesso abbiamo conosciuto l’homo sapiens, l’homo fa-<br />
ber ed l’homo œconomicus. Adesso Joel De Rosnay 172 , scienziato fran-<br />
cese di indiscussa fama, propone/prevede l’avvento dell’uomo sim-<br />
biotico. Egli ha proposto anche, mitizzandolo un po’, l’uso di un si-<br />
stema complesso, composto da scienze naturali e scienze sociali, chia-<br />
mato Cybionte. Ma la figura antropologica dell’homo symbioticus è<br />
molto più scientifica e articolata.<br />
172 Joel De Rosnay, ha lavorato fino agli anni ’70 al MIT (Massachusetts Institute of<br />
Technology), poi ha coperto numerose cariche pubbliche nelle accademie scientifiche<br />
francesi.<br />
94
L’homo sapiens sa di sapere, mentre l’animale non ha<br />
l’autocoscienza. L’homo faber costruisce degli utensili che nel tempo si<br />
sono evoluti fino a diventare le macchine che sono intorno a noi oggi.<br />
L’homo œconomicus rappresenta ciò che siamo diventati possedendo<br />
e godendo beni e servizi «in modo egoista e facendoci diventare degli<br />
ego-cittadini» 173 . Se continuiamo con questo atteggiamento da «paras-<br />
siti del pianeta» 174 , da fruitori egoisti - le nazioni sviluppate rispetto<br />
alle nazioni in via di sviluppo, le nazioni industriali in rapporto al re-<br />
sto del mondo - andremo verso catastrofi e crisi assai gravi. Da qui è<br />
nata l’idea dell’homo symbioticus. Non è un uomo diverso fisicamente<br />
dall’uomo contemporaneo, ma De Rosnay pensa che «saremo noi<br />
stessi fatti di carne e sentimenti, ma connessi con mezzi estremamente<br />
potenti di elaborazione dell’informazione e di comunicazione audiovi-<br />
siva[...]» 175 . La tv, i sistemi multimediali, Internet e le autostrade<br />
dell’informazione, sono solo l’inizio di quello che ci aspetta nel terzo<br />
millennio. Non avverrà una metamorfosi nell’aspetto biologico, ma bi-<br />
sogna prepararsi a superare quella che lo scienziato francese chiama la<br />
“mediamorfosi”, piuttosto che essere schiavi della nuova rivoluzione<br />
digitale.<br />
173 J. DE ROSNAY, L’uomo, Gaia e il Cybionte, ed. Dedalo, 1997, Bari<br />
174 U. COLOMBO, «Progresso tecnologico e sviluppo eco-sostenibile», 20-05-96, Roma,<br />
MediaMente<br />
175 J. DE ROSNAY, «Il Cybionte» cit.<br />
95
L’evoluzione dall’homo sapiens a quello symbioticus è durata<br />
millenni, ma il cambiamento antropologico dell’homo è diventato più<br />
frequente negli ultimi secoli, quasi in maniera esponenziale. Infatti<br />
l’evoluzione antropologico-culturale ha ritmi maggiori rispetto<br />
all’evoluzione genetica naturale. Per spiegare l’evoluzione biologica,<br />
Jean Baptiste Lamarck 176 aveva proposto un meccanismo basato<br />
sull’ereditarietà dei caratteri acquisiti. In realtà le cose non vanno così,<br />
si è scoperto che esiste una barriera che impedisce al genotipo il pas-<br />
saggio delle modificazioni fenotipiche. Cioè se un individuo nella pro-<br />
pria vita si abbronza perché sta molto al sole, non per questo i suoi fi-<br />
gli nascono più abbronzati, ma nascono più o meno con la stessa capa-<br />
cità di abbronzarsi. Il fatto che i caratteri acquisiti non vengano eredi-<br />
tati è un grande vantaggio per la specie: se il figlio dell’uomo abbron-<br />
zati nascessero già abbronzati perderebbero parte della loro flessibi-<br />
lità. Ciò che si eredita non è la modifica bensì la capacità di modifi-<br />
carsi. Come ha cominciato a insegnarci Darwin 177 le trasformazioni a<br />
livello fenotipico avvengono per mutazione genetica casuale e sono<br />
poi fissate da rigidi meccanismi selettivi. L’evoluzione biologica segue<br />
uno schema darwiano e non lamarckiano. Nell’evoluzione culturale<br />
invece operano meccanismi ereditari di tipo lamarckiano. Nella cul-<br />
176 Jean Baptiste Lamarck (Bazentin 1744 – Parigi 1829) naturalista francese<br />
177 Charles Robert Darwin (Shrewsbury 1809 – Down 1882) scienziato inglese,<br />
divenuto celebre con la teoria evoluzionista espressa in On The Origin Of Species<br />
(1859).<br />
96
tura non c’è come nella biologia una barriera a impedire che<br />
l’adattamento immediato (fenotipico) alla novità si radichi in profon-<br />
dità modificando la struttura (genotipo) della società. E la rapidità di<br />
acquisizione dei fenotipi nei genotipi è tanto maggiore quanti sono gli<br />
strumenti tecnologici che la favoriscono. L’evoluzione culturale ha, ri-<br />
spetto a quella biologica, caratteristiche più «catastrofiche», si svolge<br />
in uno squilibrio permanente, non ha il tempo di progredire con gra-<br />
dualità tramite tentativi ed errori. La cultura è sede di continue «va-<br />
langhe» i cui effetti si propagano rapidamente nel sistema ristruttu-<br />
randolo e trasformandolo. Rispetto alla dinamica biologica, che sta in<br />
quella zona critica tra rigido ordine e disordine totale chiamata mar-<br />
gine del caos 178 , la dinamica culturale è molto più tesa e sostenuta. I<br />
«tempi storici» sono più brevi dei «tempi biologici» 179 . Quindi la no-<br />
stra mutazione in homo symbioticus avanza ad una velocità inaudita<br />
rispetto agli altri cambiamenti antropologici dell’uomo.<br />
178 Tra i due estremi, caos e ordine, nella zona chiamata margine del caos, vi sono<br />
sistemi le cui componenti sono abbastanza stabili per immagazzinare informazione<br />
ma troppo labili per trasmetterla: questi sistemi si possono organizzare, a volte<br />
spontaneamente, per eseguire calcoli, reagire alle perturbazioni e anche manifestare<br />
quel comportamento complesso ed elusivo, stabile, ma non troppo, che si chiama<br />
vita. Sono sistemi aperti, nel senso che sono attraversati da flussi di energia, materia<br />
e informazione che li mantengono lontani dall’equilibrio. Questi sistemi iniziano ad<br />
essere applicati anche ai sistemi sociali e culturali.<br />
179 G. O. LONGO, cit., p.74<br />
97
Ecologia<br />
Sul piano dell’ecologia, ricercatori come James Lorlock 180 ,<br />
hanno proposto l’idea di "Gaia". "Gaia" è l’idea di una terra, di un si-<br />
stema-terra che reagisce come un essere vivente, senza essere un vi-<br />
vente. Ma Lorlock non parla mai della società umana. Parla sempre<br />
dell’uomo come di un parassita che vive sulla terra. Se si considerano<br />
le scienze umane sembra che l’uomo stia costruendo un nuovo organi-<br />
smo vivente, un macrorganismo planetario, e che questo organismo<br />
deve imparare a vivere in simbiosi con "Gaia", la terra. Questo esige<br />
l’ecologia. «Se questa simbiosi riesce, allora avremo una possibilità di<br />
vivere un terzo millennio e un quarto, positivi per l’umanità, altri-<br />
menti andremo verso catastrofi ecologiche, economiche e sociali» 181 .<br />
Si richiede per il futuro un cambiamento radicale dell’uomo attuale.<br />
«Da ego-cittadini dobbiamo diventare eco-cittadini» 182 .<br />
È molto importante continuare a produrre tutto quello di cui<br />
abbiamo bisogno, cercando tuttavia di consumare meno energia e<br />
meno materiali, utilizzando tecnologie il più possibile pulite, benefi-<br />
che nei confronti dell’ambiente: le “eco-tecnologie”. La loro utilizza-<br />
zione dovrebbe anche essere incentivata attraverso strumenti di mer-<br />
cato, che dovrebbero a loro volta penalizzare le tecnologie che inqui-<br />
nano di più, che consumano più energia e che danneggiano l’ambiente<br />
180 J. LORLOCK, «Gaia», 11-09-96 Parigi, MediaMente<br />
181 U. COLOMBO, «Progresso tecnologico e sviluppo eco-sostenibile», cit.<br />
182 J. DE ROSNAY, «C’è una vita dopo Internet?» cit.<br />
98
favorendo di conseguenza quelle più valide. Questo progetto di utiliz-<br />
zazione di risorse eco-tecnologiche orienta la ricerca in modo diverso:<br />
se prima era rivolta a produrre in qualsiasi modo e a costi bassi,<br />
adesso si preoccupa della qualità del prodotto e della qualità della<br />
produzione, pur facendo attenzione ai costi. Per esempio, prima si<br />
usava produrre degli oggetti di consumo durevoli introducendo degli<br />
elementi di obsolescenza pianificata: un frigorifero doveva durare cin-<br />
que/sei anni e poi si buttava via, quindi doveva avere degli elementi<br />
che consentissero, ad un certo punto, di guastarsi; così come<br />
un’automobile: non si premiava la durabilità, ma si badava a produrre<br />
molto, sempre di più, non ad evitare la saturazione dei mercati. Oggi<br />
bisogna stare attenti a produrre bene, anche prevedendo quello che<br />
succederà dopo la fine della vita utile del prodotto. Si comincia a pro-<br />
gettare un’automobile tenendo presente il momento in cui si dovrà<br />
demolire per poter recuperare tutte le sue componenti e riciclarle: que-<br />
sto è già un modo di realizzare una eco-tecnologia. Si deve produrre,<br />
inoltre, anche facendo attenzione che i prodotti consumino il meno<br />
energia possibile. Pensiamo all’illuminazione: le lampade a fluore-<br />
scenza compatta, modernissime, consumano il 20% dell’energia delle<br />
lampade normali a incandescenza, eppure hanno un risultato, in ter-<br />
mini di illuminazione, eccellente. Questi sono gli sviluppi che si pre-<br />
vedono, come anche l’automobile elettrica che potrebbe domani sop-<br />
piantare, almeno in gran parte, l’automobile con motore a combu-<br />
99
stione o a scoppio, poiché essa, per esempio, si adatta molto meglio al<br />
traffico cittadino. Il traffico cittadino, con l’auto elettrica, avviene in<br />
condizioni di completa eliminazione delle emissioni, quindi<br />
dell’inquinamento nell’ambiente delle città.<br />
L’industria informatica fa parte delle eco-tecnologie: ogni volta<br />
che si sostituisce un traffico duro (un trasporto di beni e di merci col<br />
rischio di tenere una enorme quantità di merce in magazzino) con una<br />
informazione, si consente a chi produce di regolare la sua produzione<br />
col metodo cosiddetto “just in time” 183 . In questo modo si produce “al<br />
momento giusto”; cioè quello che serve al momento in cui serve. Gli<br />
strumenti di informazione che le comunicazioni offrono, servono, in<br />
misura fondamentale, a rendere «possibile la società di domani più so-<br />
stenibile» 184 . In questo senso le tecnologie dell’informazione sono tec-<br />
nologie ecologicamente positive.<br />
183 Just in time = al momento giusto<br />
184 U. COLOMBO, «Progresso tecnologico e sviluppo eco-sostenibile», cit.<br />
100
Omnipolis<br />
(prospettiva politica)<br />
Tra globalizzazione economica, profezie democratiche, conqui-<br />
ste e rivolte, le tecnologie comunicative globali sono fra le varie tec-<br />
nologie, quelle che hanno influito maggiormente nel cambiamento<br />
delle visuali politiche.<br />
Glocalizzazione<br />
A partire dal XVIII secolo si apre lo spazio pubblico delle<br />
grandi città dell’Occidente. Adesso le automobili, i mezzi di comuni-<br />
cazione trasformano gli spazi pubblici in spazi di comunicazione tra<br />
un luogo privato e un altro luogo privato. Il luogo privato viene<br />
quindi proiettato in una dimensione esterna, pubblica e, con le tecno-<br />
logie comunicative, globale. Siamo arrivati alla eliminazione dello<br />
spazio pubblico materiale e alla sua sostituzione con spazi privati te-<br />
lematici e telefonici 185 . L’urbanesimo era effettivamente una messa in<br />
opera della localizzazione delle popolazioni nelle grandi città e nei<br />
luoghi di produzione. Questo movimento si risolveva in una urbaniz-<br />
zazione dello spazio reale della geografia. È un elemento fondamen-<br />
185 P. VIRILIO, «La velocità assoluta», cit.<br />
101
tale nella formazione dell’Europa. Ciò che avviene adesso, con le tele-<br />
comunicazioni, è l’urbanizzazione del tempo reale cioè la costituzione<br />
di una città virtuale - una specie di iper-centro - che non sarebbe più<br />
una cosmopoli come Roma o Londra, dove c’era la capitale di uno<br />
stato, quindi di uno spazio reale, come l’Impero romano e l’Impero<br />
britannico, ma l’iper-centro del mondo. In qualsiasi spazio privato ci si<br />
trovi materialmente, ci si trova contemporaneamente nello spazio<br />
virtuale pubblico. In un certo senso non si deve più parlare di<br />
“cosmopolis”, ma di “omnipolis”, la “città delle città”. Le telecomunica-<br />
zioni favoriscono una prossimità temporale, «che forma - lo si voglia o<br />
no - il centro assoluto del mondo» 186 . Quindi questa specie di città<br />
virtuale delle telecomunicazioni è il vero centro. Ma non è più un cen-<br />
tro geometrico e tutte le città reali non sono che la periferia di questo<br />
iper-centro delle telecomunicazioni. Una specie di città delle città che<br />
non è situata in nessun luogo, ma che sta da per tutto ed è il luogo del<br />
potere. Il passaggio è avvenuto dalla poleis greca, in cui il potere era<br />
geometricamente e temporalmente delimitato e localizzato dalle mura<br />
cittadine, alle prime grandi capitali degli Imperi, nelle quali il potere<br />
veniva forzatamente centralizzato lasciando le periferie lontane sia<br />
geometricamente che temporalmente. L’urbanizzazione ha favorito<br />
l’accentramento del potere, mentre le nuove tecnologie hanno nuova-<br />
mente restituito potere al locale. La contrapposizione tra cosmopolis e<br />
186 P. VIRILIO, «La velocità assoluta», cit.<br />
102
omnipolis è parallela a quella tra globale e locale. Le tecnologie comu-<br />
nicative globali hanno inizialmente teso a globalizzare il mondo occi-<br />
dentale, ma allo stesso tempo la loro iper-diffusione ha permesso di<br />
«ridare voce al locale» 187 , in maniera paritaria. Insomma il locale ha fi-<br />
nalmente e per la prima volta nella storia, con le tecnologie comunica-<br />
tive globali di tipo digitale, potuto affermare la propria esistenza at-<br />
traverso un media. La cultura locale, attraverso le possibilità legate ai<br />
nuovi media, aggiunge alla variabile dello spazio, come aspetto di<br />
coesione e di costruzione di identità, un’altra variabile, che è quella<br />
dell’accessibilità, che non necessariamente è definibile, grazie ai nuovi<br />
media, solamente in termini di vicinanza spaziale, ma anche e so-<br />
prattutto in termini di condivisione di interessi 188 . Questo è avvenuto<br />
sebbene non attraverso un media push, che dall’alto verso il basso im-<br />
mette informazione, ma attraverso la rete di Internet, il media pull per<br />
eccellenza, nel quale chiunque voglia può scegliere le proprie infor-<br />
mazioni poste tutte (apparentemente) su un piano orizzontale e perciò<br />
identiche nel loro valore intrinseco.<br />
Il pull permette un’aggregazione di forze sul medesimo inte-<br />
resse, mentre il push tendeva a standardizzare 189 . La globalizzazione<br />
187 B. BANDINU, Lettera a un giovane sardo, ed. Della Torre, febbraio 1997 Cagliari.<br />
188 M. WOLF, «Le nuove tecnologie dell'informazione a servizio della politica» 12-01-96,<br />
Roma, MediaMente<br />
189 Fornendo informazione in maniera unidirezionale e non permettendo il<br />
confronto della base ricettiva dell’informazione, si otteneva l’effetto di appiattimento<br />
di uguaglianza forzata.<br />
103
culturale, che l’affermarsi dei nuovi media comporta, non andrà a de-<br />
trimento delle identità culturali, sociali e politiche nazionali e locali,<br />
ma «determinerà il nascere di nuove identità che alle prime si affian-<br />
cheranno, senza annullarle» 190 . Il fenomeno della “globalizzazione”<br />
implica, nel campo delle comunicazioni, che ci sia una rete sempre più<br />
fitta, sempre più articolata di rapporti tra individui e gruppi, favoriti,<br />
ormai da oltre un secolo e mezzo, dagli strumenti tecnici. Si è iniziato<br />
col telegrafo, si è proseguiti con il telefono, poi con la radio bilocale 191 ;<br />
poi, nel 1922, con la radio circolare, quella che sentiamo oggi. Nel ‘29<br />
sono iniziati i primi esperimenti con la televisione, poi con il magneto-<br />
fono nel ‘38 e poi, nel 1984, siamo giunti ad Internet ad uso civile ed<br />
oggi assistiamo alla diffusione della televisione digitale, satellitare e a<br />
tutti i sistemi multimediali: CD ROM 192 e così via. Quindi, la<br />
“globalizzazione”, da questo punto di vista, oltre che dal punto di vi-<br />
sta economico –perché il termine nasce nell’ambito dell’economia di<br />
un mercato mondiale - implica che vi sia tutto questo sistema di rela-<br />
zioni. Ciò, per certi aspetti, è un vantaggio, perché permette un flusso<br />
di informazioni in tempo (quasi) reale; tuttavia di fronte alla retorica<br />
che si fa della “globalizzazione” nel campo delle comunicazioni, corri-<br />
sponde una concentrazione di carattere economico, che si sviluppa, in<br />
190 M. WOLF, cit.<br />
191 Quella di Marconi, che all’inizio era soltanto da stazione emittente a stazione<br />
ricevente<br />
192 CD-ROM = (Compact Disk –Read Only Memory) cioè unità memoria di sola<br />
lettura con formato CD<br />
104
prospettiva, in tutto il mondo tra catene cinematografiche e televisive<br />
e discografiche; tra giornali, riviste e università, per creare quelle che<br />
vengono chiamate le “mega corporations”, le quali agiranno non sol-<br />
tanto nel campo dell’informazione, ma anche in quello<br />
dell’educazione e della formazione, fino ad arrivare a un sistema di<br />
educazione permanente e a plasmare il senso comune. Il timore è che<br />
questi processi vengano controllati dall’alto in maniera oligarchica e<br />
che tale controllo possa portare, non ad un pensiero unico nel senso<br />
che tutto il mondo possa essere indotto a pensare e a sentire allo stesso<br />
modo, ma certamente ad una riduzione degli spazi di libertà. Nel rap-<br />
porto fra i processi centrifughi e centripeti, globalizzazione e invece lo-<br />
calizzazione, è sorto un neologismo: “glocalizzazione” 193 . Si tratta di<br />
non contrapporre il locale a globale: di non pensare, da un lato, che il<br />
mondo sia unificato e che, di conseguenza, noi tutti siamo inseriti in<br />
un circolo virtuoso attraverso il quale tutta questa ricchezza di infor-<br />
mazioni si dirige verso il meglio. I cosiddetti “localismi” o, per certi<br />
aspetti, quelli che noi chiamiamo “integralismi” possono essere consi-<br />
derati un contraccolpo dei processi di “globalizzazione”. Si pensi so-<br />
prattutto, ad esempio, ai paesi arabi, che una volta seguivano la mo-<br />
dernizzazione occidentale, come la Siria o l’Algeria. La loro chiusura<br />
in se stessi deriva, in fondo, da una percezione di amore quasi tradito,<br />
poiché non si sentono inseriti a pieno titolo e con pari dignità nei pro-<br />
193 R. BODEI, «La comunicazione nel V secolo dell’era globale», cit.<br />
105
getti che contano. In quest’ambito della “globalizzazione” bisogna ve-<br />
dere, dunque, anche gli aspetti di frammentazione locale. Poi c’è la<br />
“localizzazione” come fenomeno economico. Un esempio è la IBM 194<br />
americana, che licenzia quasi metà del suo personale, perché si fa fare<br />
il “software”, cioè i programmi informatici, dagli Indiani perché co-<br />
stano otto volte meno e si fa fare lo “hardware”, cioè le macchine, a<br />
Formosa, oppure a Singapore, perché costano sempre molto meno.<br />
Inoltre c’è un problema di carattere più generale in questa questione<br />
della “localizzazione”: gli investimenti ormai vanno non solo dove c’è<br />
forza-lavoro a basso prezzo, ma anche dove c’è sicurezza politica;<br />
quindi spesso in stati con governi dittatoriali, come gli investimenti<br />
della Fiat in Serbia o Turchia. Quello della glocalizzazione è quindi un<br />
movimento bidirezionale, o meglio un incontro del locale con il glo-<br />
bale, che seppure con molti aspetti positivi, è la fonte di una evolu-<br />
zione dal locale al globale e viceversa abbastanza movimentata. Perché<br />
si stabilizzi ci vorranno «molto tempo e molti morti» 195 .<br />
194 IBM (Information Business Machines) è stata la prima società informatica del<br />
mondo.<br />
195 F. COLOMBO, «L’evoluzione del mondo dei media» 03-07-97 Napoli, Convegno<br />
Telecom, MediaMente<br />
106
Modernizzare la democrazia?<br />
Una delle profezie meno fondate, fino ad ora, è stata quella nota<br />
come «democrazia tecnologica» 196 . Richard Buckminster Fuller 197 teo-<br />
rizzò per primo negli anni ‘40 una democrazia diretta tramite il tele-<br />
fono, poi divenuta con i suoi seguaci la democrazia elettronica (electro-<br />
nic democracy) tramite il computer: anche detta tecnocrazia. Si è dato in-<br />
fatti per scontato che il progresso tecnologico e Internet, portassero ad<br />
una diffusione dell’uguaglianza e quindi alla possibilità di intervento<br />
di tutti su tutto. In realtà questa possibilità, in qualche modo, esiste;<br />
ma è vero che esiste anche la tendenza opposta: al controllo di tutto e<br />
anche alla sorveglianza. Con l’esplosione delle nuove tecnologie la<br />
democrazia si fa sempre più “virtuale”, «la politica si dematerializza:<br />
saltano i mediatori tradizionali» 198 . La fondamentale importanza di<br />
mediazione dell’uomo politico può essere annullata in vista di false<br />
democrazie. Questo processo comporta notevoli rischi come quello<br />
dell’esaltazione delle emozioni in funzione “plebiscitario-referenda-<br />
ria”. È pur vero che la tecnologia porta anche, tra i vantaggi, la possi-<br />
bilità di accedere direttamente a una serie di informazioni e di elabo-<br />
196 G. CESAREO, «Lo strabismo telematico», cit.<br />
197 Richard BUCKMINSTER FULLER (Milton Massachusetts 1913-1993) divenne<br />
grande per l’invenzione della «cupola geodesica» (una sfera composta da tetraedi,<br />
forma architettonica versatile, mobile economica e resistente) e i concetti di<br />
«sinergia» (l’unione rappresenta più della somma delle parti) e di «effimerizzazione»<br />
(la tendenza ad ottenere rendimenti crescenti con sempre minori investimenti di<br />
energia).<br />
198 S. RODOTÀ, «Sviluppo telematico e democrazia», 13-01-96 Roma, MediaMente<br />
107
arle, sempre che si possa avere una pluralità di fonti. Ma quando si<br />
parla dell’apporto che la nuova tecnologia dell’informazione consente<br />
alla politica, spesso si pensa solo alla possibilità di dire la propria in<br />
modo vincolante, dimenticando invece tutti gli aspetti di equilibrio di<br />
sistema, senza i quali la democrazia è pura finzione.<br />
Modernizzare la democrazia deve significare dare un «nuovo<br />
ruolo ai governi nella società informatica» 199 .La struttura dei governi<br />
contemporanei dovrebbe adeguarsi ai nuovi modelli comunicativi<br />
proposti dalle nuove tecnologie : nell’epoca dell’informatica i governi<br />
dovrebbero avere una struttura di rete, essere capaci di fornire servizi<br />
e informazioni in un universo di comunicazione orizzontale.<br />
Le reti civiche per esempio sono un grande esempio di moder-<br />
nizzazione della democrazia, perché mirano a mettere al centro il<br />
«cittadino come individuo» 200 . Le reti civiche dovrebbero servire a<br />
quello che più in generale dovrebbe essere la «rete unitaria» 201 , cioè un<br />
collegamento complessivo tra le reti civiche.<br />
Il progetto della “rete unitaria” nasce dall’idea che il patrimonio<br />
informativo a disposizione dell’amministrazione debba essere messo a<br />
disposizione delle altre amministrazioni e possibilmente anche del<br />
199 D. McKENNA, «Il ruolo dei governi nella società informatica», 10-09-97, Nizza,<br />
MediaMente<br />
200P. FLORES D’ARCAIS, «Politica, politici e cittadini nell’era digitale», 04-07-97<br />
Napoli, MediaMente<br />
201 G. M. REY, «Informatica e pubblica amministrazione», 21-10-1996 Milano, SMAU,<br />
MediaMente<br />
108
paese. Per fare questo occorre modificare tutte le procedure ed i pro-<br />
grammi di elaborazione; ma per modificare le procedure ed i pro-<br />
grammi bisogna modificare l’organizzazione ed i procedimenti. In<br />
questa direzione la rete unitaria non è soltanto un’occasione per far<br />
dialogare una struttura informatica, bensì per riorganizzare la pub-<br />
blica amministrazione in modo tale da renderla cooperativa, federata.<br />
Federata significa, in senso tecnico, che tutti quanti possono condivi-<br />
dere le informazioni; un’amministrazione federata non è necessaria-<br />
mente centrale, ma è decentrata, nel senso che non necessariamente si<br />
interessa alle sue specifiche competenze, ma può dialogare con tutti.<br />
L’idea di fondo consiste nel dare la possibilità al cittadino di andare da<br />
un’amministrazione ed avere informazioni su cosa sta succedendo in<br />
altre amministrazioni; al fine di rendere più flessibili i servizi. Invece<br />
di andare al Comune per i problemi del Comune, alla Prefettura per i<br />
problemi che sono a capo della Prefettura, alla Motorizzazione civile<br />
per quei problemi che fanno capo alla Motorizzazione civile, con una<br />
rete si può andare in una centrale di accesso, in seguito in un ufficio di<br />
accesso e poi, da questo, andare a chiedere l’informazione e a dialo-<br />
gare con tutta la amministrazione del luogo stando seduti al tavolino;<br />
ovviamente l’ideale sarebbe coprire tutto il territorio nazionale e non<br />
solo le città più grandi, facendo così diventare più periferici i piccoli<br />
paesi. Si tratta di una rete molto complessa che tecnologicamente<br />
ormai è stata identificata: si tratta ora soltanto di realizzarla.<br />
109
La prima e la più funzionale rete civica d’Italia è stata quella di<br />
Bologna 202 con le Arcades 203 ,<br />
poi seguita da Modena con Mo Net 204 , da Torino 205 e tante altre.<br />
La informatizzazione delle amministrazioni, quando è stata accompa-<br />
gnata da una “reingegnerizzazione dei processi” 206 ha permesso un<br />
notevole smaltimento del peso burocratico aumentando notevolmente<br />
il contatto tra cittadino e comune. Attualmente in Italia i buoni lavori<br />
di informatizzazione sono stati fatti solo dai comuni delle grandi città<br />
e ciò non ha fatto altro che aumentare la distanza con i piccoli paesi o<br />
le città di periferia. La rete civica anzi sarebbe dovuta servire princi-<br />
palmente a questi ultimi soggetti, per fornire loro nuove prospettive<br />
occupazionali e culturali.<br />
Le reti civiche possono essere così importanti che McKenna ar-<br />
riva a proporre l’idea amministrativa di “Smart Community” 207 . «In un<br />
sistema di governo di tipo industriale, la maggior parte delle regola-<br />
mentazioni e delle politiche vengono definite a livello nazionale o<br />
202 G. BLASI, G. COSENZA, «Le Arcades multimediali a Bologna», 09-21-95 Milano -<br />
SMAU, MediaMente<br />
203 Le Arcades sono dei luoghi di incontro multimediali pubblici sponsorizzati dal<br />
Comune di Bologna, per chi volesse scoprire la reti civica o Internet.<br />
204 Terzo nodo italiano dopo Bologna e Italia On Line, conosciuto come Mo Net<br />
(Modena Network)<br />
205 G. FERRERO, «Un esempio di città cablata», Milano, 19-10-96, MediaMente<br />
206 Process re-engineering, significa riorganizzare il processo, cioè le operazioni<br />
fondamentali della burocrazia, organizzandole in maniera logica e funzionale,<br />
altrimenti la sola informatizzazione può arrivare ad essere lei stessa causa di<br />
problemi.<br />
207 Comunità (Community) intesa brillante (Smart) per il suo attivismo nella vita<br />
pubblica.<br />
110
centrale e questo non garantisce un buon funzionamento; la società si<br />
muove troppo velocemente. Nei paesi che hanno i sistemi di governo<br />
più riusciti, la gran parte dei servizi statali vengono forniti a livello di<br />
comunità o a livello locale. Il lavoro più gravoso dei sistemi governa-<br />
tivi viene assolto dalle comunità. In questo modo, una comunità<br />
“Smart” è il luogo dove la tecnologia arriva ad aiutare i cittadini<br />
nell’ambito dell’educazione, delle cure sanitarie, della sicurezza pub-<br />
blica, in modo che il grosso del lavoro venga svolto dalla comunità,<br />
nel quadro di una politica o di un supporto nazionale: lasciare i detta-<br />
gli dei servizi o dei programmi ai governi locali, mentre si lascia sem-<br />
plicemente un’impostazione di politica nazionale a livello federale o<br />
nazionale» 208 .<br />
Comunità virtuali<br />
La comunicazione in rete ha reso possibile che si venissero a<br />
creare una serie di comunità virtuali intorno ad «interessi comuni» 209 .<br />
Per definire le comunità virtuali si può usare una metafora che viene<br />
dalla letteratura in particolare da Bruce Sterling 210 , uno dei massimi<br />
letterati ‘cyberpunk’, per il quale le comunità virtuali sono isole nella<br />
rete, luoghi tridimensionali che si aprono all’interno della rete telema-<br />
208 D. McKENNA, cit.<br />
209 U. ECO, Kant e l’ornitorinco (© 1980), ed. Bompiani 1996 Milano, p. X<br />
210 B. STERLING, «Letteratura Cyberpunk» 03-12-94 Roma, MediaMente<br />
111
tica e, dove, effettivamente come in una piazza, come in un’Agora<br />
dell’antica Grecia, la gente si incontra, si trova e stabilisce delle rela-<br />
zioni 211 . Ci sono aspetti positivi delle comunità: per esempio possono<br />
essere fruite da punti molto lontani anche spazialmente. Esistono co-<br />
munità dedicate a particolari aspetti della cultura, come il grosso sito<br />
americano alla Brown University che si occupa del Decameron con stu-<br />
diosi che provengono da qualunque parte del mondo. Le comunità di<br />
ricerca sono un aspetto di questi luoghi nella rete; altri aspetti sono le<br />
comunità di azione politica. Questa realtà ha anche un suo lato nega-<br />
tivo, poiché la rete viene utilizzata dalle organizzazioni criminali.<br />
La caratteristica principale delle comunità virtuali è quella di<br />
essere dei potenziometri. Se la comunità che si viene a creare in rete ha<br />
scopi culturali, pacifisti, ecologisti, i risultati possono essere grandi,<br />
perché permettono a gruppi di persone di scambiare idee e di orga-<br />
nizzarsi per il raggiungimento di obiettivi positivi: come quello di una<br />
ricerca o di una manifestazione pacifista. Ma la possibilità organizza-<br />
tiva viene fornita anche a gruppi socialmente pericolosi: come a neo-<br />
nazisti, mafiosi, pedofili, trafficanti di armi, ecc. Le cyberpolizie stanno<br />
nascendo nelle nazioni democratiche per combattere i traffici illeciti<br />
all’interno delle reti. La rete quindi permette ad uomini, con interessi<br />
simili, di incontrarsi molto più facilmente. La rete è quindi un poten-<br />
ziometro, o un catalizzatore d’interesse mentre gli interessi, positivi o<br />
211 P. FERRI, «La comunità virtuale», 26-11-97 Milano, MediaMente<br />
112
negativi per la società, sono solamente umani. Dal punto di vista so-<br />
ciale, la comunità virtuale può facilmente ingenerare alienazione nelle<br />
persone fragili perché concede loro di avere contatti solamente vir-<br />
tuali. Le persone particolarmente deboli sono anche attratte da quelle<br />
comunità che svendono verità divine e che trovano adepti da porre al<br />
loro servizio. Eccessive sono diventate le “cyber sette” che nella rete<br />
trovano campi incolti, ma sono diventati anche molto più pericolosi gli<br />
integralismi: integralismo cristiano, integralismo musulmano, integra-<br />
lismo ebreo. È un grande problema. La guerra santa è all’ordine del<br />
giorno in molti paesi del mondo, Algeri, Serbia e perfino a Parigi con<br />
la “Jihad” 212 . L’integralismo mistico del monoteismo, che è un fatto<br />
pericolosissimo per la pace civile, si accompagna a un integralismo<br />
tecnologico, cioè a un culto della tecnica, a un tecno-culto per un<br />
“deus ex machina”. Non è più il dio della trascendenza del monotei-<br />
smo e quindi dell’integralismo religioso, è l’integralismo di un<br />
dio/macchina, capace di risolvere tutti i problemi.<br />
Questo anche per chi presenta le nuove tecnologie in una<br />
dimensione di fede quasi religiosa. «Di fronte alla tecnica ci sono i<br />
taumaturghi e i drammaturghi» 213 . Taumaturghi sono quelli che<br />
212 Jihad = movimento islamico di liberazione.<br />
213 S. WINKLER, «Le strategie Sun», 04-11-97 Cannes, ITxpo97, MediaMente<br />
113
gridano al miracolo perché Bill Gates ha lanciato “Windows 95” 214 o<br />
perché “Apple” 215 ha prodotto un nuovo modello. I drammaturghi<br />
sono quelli che nell’evoluzione tecnologica vedono il male assoluto.<br />
Quello che manca è la giusta distanza critica che bisognerebbe avere di<br />
fronte a qualsiasi oggetto tecnico. Altrimenti si arriva al tecno-culto, al<br />
“cyber-cult”.<br />
Il primo e più grande teorizzatore delle comunità virtuali è<br />
stato Howard Rheingold 216 . Egli ha il grandissimo merito di essere<br />
stato il primo ad aver riflettuto sulla natura delle comunità virtuali, ri-<br />
flessioni che si sono concretizzate in un suo famoso libro intitolato<br />
Comunità Virtuali 217 che risale agli inizi degli anni Novanta. Inoltre<br />
Rheingold è il primo teorico che ha studiato una particolare comunità<br />
virtuale, ‘Well’, una delle prime nate in America e che dal 1985, anno<br />
in cui è stata fondata, si è sviluppata enormemente e conta oggi oltre<br />
ottantamila aderenti. È stato anche il primo che ha formulato l’idea<br />
che le comunità virtuali potessero rivoluzionare radicalmente le nostre<br />
relazioni e l’ordinamento sociale tradizionale e con questo è stato uno<br />
214 Sistema operativo presentato dalla Microsoft nell’ottobre del 1995, per<br />
l’occasione furono grandi le aspettative, l’evento fu considerato come una<br />
rivoluzione digitale, anche se in realtà è stata solamente una fortunata operazione di<br />
marketing.<br />
215 La Apple per prima inventa un sistema operativo di tipo grafico, in seguito<br />
copiato dalla Microsoft, ma a differenza della Microsoft, la Apple vende i propri<br />
programmi sulle proprie macchine limitandone così la compatibilità.<br />
216 Nato in Arizona, Rheingold (http://www.rheingold.com ) ha studiato<br />
psicologia della conoscenza al Reed College e alla State University of New York.<br />
217 H. RHEINGOLD, The virtual community, 1993, A William Patrick Book,<br />
Addison-Wesley<br />
114
dei tanti mistificatori della rete. L’impegno politico nella rete potrebbe<br />
aumentare molto nel prossimo futuro, tutto dipenderà dal grado di<br />
info-alfabetizzazione o dalla semplificazione nell’utilizzo delle mac-<br />
chine. In ogni caso sarà opportuno mantenere dei filtri politici tra<br />
scelte di governo e emozioni popolari, altrimenti il rischio populistico<br />
e plebiscitario diventerà altissimo.<br />
La comunicazione globale ha creato grandi lobby internazionali<br />
di illegalità. La possibilità della comunicazione crittata 218 ha permesso<br />
a movimenti di delinquenza organizzata, una struttura comunicativa<br />
difficilmente intercettabile. L’entrata della mafia nella comunicazione<br />
globale, anche con l’acquisto di grandi nodi 219 , ha movimentato il set-<br />
tore finanziario ed informatico internazionale. Le cyberpolizie sono ri-<br />
uscite ad intercettare solo minima parte 220 dei movimenti illeciti della<br />
mafia, in tutti i suoi settori: traffico d’armi, di droga, della prostitu-<br />
zione, della vendita di organi e della pedofilia. Il dato che diventa<br />
drammatico all’interno della rete è che gli stessi traffici, in misura<br />
quantitativamente minore, possono essere organizzati da insospetta-<br />
bili cittadini che non hanno ‘reali’ legami con la delinquenza, ma solo<br />
legami ‘virtuali’. Ugualmente facile diventa per i gruppi estremisti<br />
trovare spazi liberi per l’organizzazione. L’ultimo agguato delle BR al<br />
218 Crittare significa codificare dei dati tramite un algoritmo che impedisce<br />
intrusioni illecite.<br />
219 Punto di ingresso nella rete<br />
220 meno dell’1%, dato ottenuto da Ufficio della Polizia Cibertecnologica di<br />
Milano<br />
115
Prof. D’Antona è una dimostrazione lampante di come i servizi tele-<br />
matici possano servire a mantenere i contatti anche con carcerati e a<br />
organizzare o riorganizzare una struttura estremistica. La stessa faci-<br />
lità hanno gruppi terroristici di destra, soprattutto i gruppi xenofobi o<br />
razzisti come dimostrano i numerosi siti contro le razze non ariane.<br />
Questi gruppi sono stati combattuti ed emarginati dalla società civile,<br />
quando ancora i loro incontri erano pubblici ed in un certo senso<br />
‘reali’, ‘tangibili’. Ma quando hanno iniziato la frequentazione della<br />
rete affrontarli è diventato impossibile. Nelle loro comunità virtuali,<br />
sono ammessi solo gli iscritti e non c’è nessuna contestazione che gli si<br />
possa fare in maniera da scuotere l’opinione pubblica. I flames, gli<br />
scontri della rete, restano silenziosi o addirittura inesistenti per il<br />
grande pubblico. In rete l’unico modo di combattere i razzismi è attra-<br />
verso la rete. Ma forse non è abbastanza.<br />
Le nuove colonizzazioni<br />
È stato il vicepresidente statunitense Al Gore il primo a parlare<br />
di «information superhighway» 221 . Si parla molto di “autostrade elettro-<br />
niche”, anche se il termine giusto dovrebbe essere quello di «super-<br />
mercati elettronici» 222 : nella rete infatti si fanno tele-acquisti di infor-<br />
221 All’interno del programma politico presentato nel 1994 all’assemblea degli<br />
Stati Uniti d’America assieme al documento della Casa Bianca noto come NII<br />
(National Information Infrastructure)<br />
222 S. WINKLER, cit.<br />
116
mazione, tele-acquisti di convivialità, tele-acquisti di immagini. Si<br />
tratta dunque complessivamente di tele-acquisti. È però interessante<br />
che si parli di “autostrade”, perché le autostrade hanno una storia che<br />
italiani e tedeschi conoscono bene.<br />
Le “autostrade” e le “Reichautobahne “ sono le vie strategiche fatte<br />
specialmente dal nazismo nella prospettiva della conquista: sono<br />
strade per la conquista. Nella Seconda Guerra Mondiale la conquista è<br />
cominciata in direzione dell’Est, là dove arrivava l’autostrada, la<br />
“Reichautobahn”, verso la Polonia, verso Danzica, nel famoso ‘corri-<br />
doio’ di Danzica. Dunque, «per continuare l’autostrada che andava<br />
verso la Polonia, si dichiarò la guerra» 223 . Non si può dimenticare che<br />
la “autostrada fascista” e la “Reichautobahn nazista” sono state le im-<br />
magini della “conquista”, della grande conquista territoriale del<br />
“Lebensraum”, una specie di colonizzazione nel cuore dell’Europa.<br />
L’immagine mi sembra interessante sotto questo aspetto. Le auto-<br />
strade dell’informazione sono, in un certo senso, delle<br />
“Reichautobahn”, cioè vie di colonizzazione culturale. La cultura co-<br />
lonizzatrice è quella dei bianchi anglofoni. La diffusione dell’inglese,<br />
da quando la rete è entrata a far parte in maniera incisiva nelle comu-<br />
nicazioni globali, ha assunto uno sviluppo esponenziale soprattutto a<br />
discapito del mondo ispanico 224 . Il “gap” fra Nord e Sud va sempre<br />
1996<br />
223 P. VIRILIO, «La velocità assoluta», cit.<br />
224 L. VALERI, «Lo scudo invisibile: Internet contro gli ispanici» da L’America e noi,<br />
117
più accentuandosi e la differenza oltre che geografica è soprattutto in-<br />
formazionale. Gli info-ricchi aumentano giornalmente la distanza da-<br />
gli info-poveri 225 .<br />
La colonizzazione informatica è naturalmente una colonizzazione<br />
culturale. E se si fa un’analogia tra il «dentro e il fuori» 226 , si deve dire<br />
che mentre le colonizzazioni «fuori» fondate sulla forza e sulla po-<br />
tenza sono sempre fallite, le colonizzazioni culturali, «dentro», hanno<br />
sempre lasciato delle tracce. L’India, paese libero e democratico da ol-<br />
tre cinquant’anni, è tuttora un paese con profondissime tracce di cul-<br />
tura inglese; le Filippine, dopo un secolo di sganciamento dagli Stati<br />
Uniti, portano ancora tracce così forti del passaggio americano che esi-<br />
ste tuttora un movimento che vuole trasformare le Filippine nel 51°<br />
Stato americano. Questo ci ricorda che ciò che entra nella nostra vita<br />
interiore è molto più forte di ciò che occupa il territorio attraverso il<br />
potere. E il cyber-spazio è un’avventura interiore. Quanto alla ribel-<br />
lione, esistono due risposte. La prima è nella forma di partecipazione e<br />
di presenza, che deliberatamente impone delle alternative culturali e<br />
nazionali all’interno dell’internazionalità di cyber-spazio. La seconda è<br />
la finta ribellione di coloro che già adesso vivono se stessi come ribelli<br />
in quanto protagonisti della rete, protagonisti del cyber-spazio, che<br />
invece ribelli non sono affatto, perché sono invece già dei sudditi. «La<br />
225 S. GARASSINI, «L’effetto della realtà virtuale e di Internet sulla società moderna»,<br />
21-09-95, Milano, MediaMente<br />
226 F. COLOMBO, Confucio nel computer, cit., p. 26<br />
118
ete diventa persuasione interiore anche quando è vissuta con ribel-<br />
lione» 227 .<br />
Mondo Hackers<br />
Il rivoluzionari «dentro», sono gli “hackers”, che comunemente<br />
vengono definiti “pirati della rete” o “pirati informatici” anche se in<br />
realtà questo termine è utilizzato in maniera generale per identificare<br />
tutti coloro che si avvalgono delle proprie conoscenze informatiche e<br />
di tecnologia delle telecomunicazioni per scoprire ed infrangere le re-<br />
gole attraverso cui queste tecnologie sono gestite.<br />
Se i danni che un hacker può provocare ad un ente privato od<br />
allo stato sono potenzialmente enormi, ciò non significa che la pratica<br />
dell’hacking sia necessariamente usata per scopi illeciti o immorali. In<br />
effetti l’hacking, che oggi è poco più di una moda, ha rappresentato<br />
ancora prima dell’avvento della rete, un modo di appropriarsi in ma-<br />
niera artigianale delle tecnologie telematiche per sondarne le applica-<br />
zioni ancora inesplorate e sconosciute.<br />
I primi hackers smontavano i propri computer, i telefoni e si<br />
procuravano mappe dei tracciati telefonici per capire come e in che<br />
modo si potevano sfruttare le risorse della rete senza pagare una bol-<br />
227 W. GIBSON, Neuromante, cit., p. 30<br />
119
letta troppo salata. In gergo gli hackers vengono chiamati cowboy,<br />
prendendo ispirazione dal cowboy Case 228 .<br />
Ora sono molti i manuali 229 in rete che raccontano i trucchi degli<br />
hackers statunitensi e che vengono messi a disposizione di tutti se-<br />
condo l’idea, tipica degli hackers, di condividere le conoscenze utili a<br />
«sconvolgere l’ordine prestabilito della rete» 230 .<br />
Un altro aspetto importante dell’hacking è la rivendicazione<br />
della libertà di sfruttare tutti gli spazi, quelli pubblici e quelli privati a<br />
cui si può avere accesso attraverso la rete. In effetti, molti dei crimini<br />
per cui gli hackers vengono incriminati e processati non trovano an-<br />
cora una appropriata definizione giuridica.<br />
Il sito 2600 231 , la storica rivista on-line degli hackers di oltreoce-<br />
ano, mostra anche la faccia illegale e meno pulita dell’hacking. Qui si<br />
trovano a disposizione, per chi li vuole scaricare, ogni tipo di stru-<br />
menti per intercettare i codici delle carte di credito di chi fa un acqui-<br />
sto in rete o per simulare la registrazione di software che non è stato<br />
comprato. L’hacking, da un lato mette in luce l’arbitrarietà di alcune<br />
regole sociali e politiche che governano la rete e dall’altro, tuttavia,<br />
228 W. GIBSON, Neuromante, cit.<br />
229 Sito: «Cult of the dead cow» (Culto del cowboy morto); con cowboy si identifica<br />
colui che fa hacking.<br />
230 T. RUSSO, «Hackers: Il manuale dell’Hacker», Navigazione del 09-03-98,<br />
MediaMente<br />
231 Sito: «2600 - The Hacker Quarterly». (2600 – Il quartiere dell’hacker)<br />
120
genera fenomeni di micro e macrocriminalità che mostrano proprio<br />
l’esigenza di queste regole.<br />
Alcuni hackers hanno avuto fama mondiale come Kevin Mit-<br />
nick 232 , divenuto famoso grazie al libro cyberpunk Outlaws and hackers<br />
on the computer frontier, di Katie Hafner e John Markoff 233 , che ne rac-<br />
contava le gesta e arrestato dall’FBI, grazie all’aiuto di un cacciatore di<br />
taglie telematico, come Tsutomu Shimomura, che ha narrato<br />
dell’“inseguimento” cibernetico nel proprio libro: Takedown 234 . Mentre<br />
Robert T. Morris 235 è stato il simbolo delle potenzialità distruttive degli<br />
hackers: è il padre dei crackers 236 . Negli anni ‘80 Morris, figlio di un di-<br />
rigente della NSCAA (National Security Computer American Agency),<br />
l’agenzia di informatica che ha progettato uno dei primi browser, Mo-<br />
saic, comincia ad interessarsi di informatica ed a muovere i primi passi<br />
da hacker. Nel 1988 , Morris, mette alla prova un programma autori-<br />
generantesi, un ‘worm’ 237 come si dice in gergo, di cui stava cercando<br />
di scoprire le potenzialità. Nel giro di qualche giorno il ‘worm’ si dif-<br />
fonde in tutta la rete e mette seriamente in difficoltà in tutto il mondo<br />
232 T. RUSSO, «Hackers: Kevin Mitnick», Navigazione del 10-03-98, MediaMente<br />
233 K. HAFNER & J. MARKOFF, Outlaws and hackers on the computer frontier (lett.<br />
Illegalità e Hackers nella frontiera informatica), California Press 1992 L.A.<br />
234 T. SHIMOMURA, Takedown (lett. Umiliazione) Forgot-Press 1990 L.A.<br />
235 T. RUSSO, «Hackers: Robert T. Morris», Navigazione del 11-03-98, MediaMente<br />
236 I crackers sono quegli hackers che tendono a mandare in crackdown (collasso)<br />
il sistema informatico.<br />
237 Il Worm (verme) è spesso chiamato bug (insetto), ed identifica quei virus che si<br />
autoproducono<br />
121
la possibilità di trasferire dati. Il ‘crackdown’ 238 delle comunicazioni te-<br />
lematiche mondiali sembra vicino e la rete svela la sua fragilità.<br />
A mitizzare la figura di Morris è stato Johnathan Litman con il<br />
primo libro sugli hackers: Watchman 239 . Litman 240 afferma che la figura<br />
dell’hacker sembra da un lato incarnare il prototipo di colui che in-<br />
frange le regole per appropriarsi individualmente di ciò che è pub-<br />
blico. L’etica contemporanea ha creato un nome preciso per queste fi-<br />
gure e li ha chiamati free riders 241 . D’altro lato, gli hacker sembrano na-<br />
scere come risposta a un rischio concreto: la tecnologia può, a volte,<br />
diventare un sapere in mano a pochi, che dettano arbitrariamente le<br />
loro regole.<br />
Ma esistono anche figure come quelle di Richard Stallman 242 ,<br />
hacker e guru cyberpunk, che ha sfidato apertamente, in maniera<br />
quasi donchisciottesca, molte delle limitazioni che la legge impone<br />
all’uso della rete ed alla diffusione del software. Formato nel laborato-<br />
rio di studi sull’intelligenza artificiale del MIT 243 , uno dei più avanzati<br />
del mondo, i cui membri, negli anni ‘80, erano quasi tutti degli hac-<br />
kers, Stallman diventa rapidamente noto negli anni ‘70 per aver pro-<br />
gettato un editor di testi, EMACS, che ha una caratteristica sorpren-<br />
238 Crackdown = crollo, collasso.<br />
239 J. LITMAN, Watchman (lett. Sorvegliante), Sweepings Press, 1989, N. Y.<br />
240 Sito: «Noted & Notorious Hacker Feats» (Celebri e famose prodezze degli<br />
hackers)<br />
241 Free riders = cavalieri liberi.<br />
242 T. RUSSO, «Hackers: Richard Stallman», Navigazione del 12-03-98, MediaMente<br />
243 MIT = Massachusetts Institute of Technology di Boston<br />
122
dente: è infinitamente personalizzabile da parte dell’utente. Stallman<br />
lo distribuisce gratis, a patto che chi ne faccia uso prometta di rendere<br />
pubbliche tutte le sue modifiche. Egli comincia, già in quegli anni a<br />
maturare un’idea che resterà centrale in tutti i suoi progetti, fino ad<br />
oggi: rendere di pubblico dominio ogni tipo di software. La sua con-<br />
vinzione è che «la distanza tra chi usa il software e chi lo progetta va<br />
ridotta, rendendo possibile a tutti di smontare, capire dall’interno, re-<br />
inventare il software che si usa» 244 . Per questo motivo il software pro-<br />
gettato da Stallman viene diffuso gratuitamente ovunque, tramite la<br />
Free Software Foundation 245 , da lui creata. Il suo più grande progetto è<br />
però GNU 246 , che vuole, emulandoli, soppiantare i più grandi sistemi<br />
operativi come Windows e Unix. Un progetto decisamente utopico,<br />
ma che svela come nel mondo dell’informatica l’estro e la genialità di<br />
pochi individui possono arrivare a sfidare le grandi agenzie mondiali<br />
di software.<br />
John Draper 247 non ha fatto in tempo, a vivere gli anni ‘90 da<br />
Hacker, o almeno così sostiene, perché si era già bruciato la fedina pe-<br />
nale negli anni ‘80. Egli appartiene infatti alla generazione più vene-<br />
randa degli hackers, quella degli anni ‘70. Draper, noto come Captain<br />
244 Sito: «Why Software Should Not Have Owners - GNU Project» (Perché il software<br />
non dovrebbe avere proprietari)<br />
245 Sito: «What is the Free Software Foundation? - GNU Project» (Cos’è la fondazione<br />
per il software gratuito?)<br />
246 Sito: «The GNU Project» (Il progetto GNU)<br />
247 T. RUSSO, «Hackers: John Draper», Navigazione del 13-03-98, MediaMente<br />
123
Crunch, è stato, infatti, in prigione per un paio d’anni dall’85 all’87,<br />
per la sua attività di freaker 248 . La prima invenzione da hacker/freaker<br />
di Draper è legata ad una marca di patatine americane, le Captain<br />
Crunch, da cui deriva appunto il suo pseudonimo. Nelle confezioni di<br />
questa marca di patate fritte, Draper trova in regalo un fischietto e<br />
scopre che la frequenza del suo fischio equivale esattamente a quella<br />
del suono che serve alle linee telefoniche americane per dare il segnale<br />
che la telefonata è stata pagata. Inizia quindi a sfruttare la sua scoperta<br />
per ottenere dei collegamenti gratuiti. Negli anni ‘70 Draper lavora<br />
alla Apple, in collaborazione con Steve Wozniak uno dei suoi fonda-<br />
tori, ma spende il suo tempo ad inventare trucchi per costruire il com-<br />
puter perfetto per l’hacking 249 . Ora vive in semiclandestinità ed è an-<br />
cora ricercato dall’FBI 250 .<br />
Censura<br />
L’opinione che commissioni censuratorie possano rinascere è<br />
ormai frequente, ma togliere la libertà alla rete vorrebbe dire elimi-<br />
narne la sua stessa principale peculiarità. Anche se l’idea che si possa<br />
avere un canale di comunicazione quale la rete nella quale non si<br />
248 I freakers sono gli antenati degli hackers, che usano sistemi telematici e non per<br />
imbrogliare le compagnie telefoniche.<br />
249 Sito: «Cap'n Crunch's Home in Cyberspace», (La casa del Capitain Crunch nel<br />
cyber-spazio)<br />
250 Sito: «Interview With John Draper», (Intervista con John Draper)<br />
124
possa né si debba esercitare nessun controllo, costituisce in verità<br />
un’idea stravagante e non perché non rappresenti un’idea interessante<br />
ma perché non corrisponde ai dati reali del problema che noi viviamo.<br />
Infatti non è vero che non esista controllo sulla rete, ci sono tanti mo-<br />
menti di controllo sulla rete e questo è alquanto evidente nel caso dei<br />
grandi vantaggi che si ottengono oggi tra i diversi gruppi finanziari. Il<br />
controllo non è solamente una questione di mercato, ma è soprattutto<br />
una questione di carattere economico e socioculturale. Limitare la de-<br />
linquenza in rete con controlli mirati è molto importante, ma altret-<br />
tanto importante è togliere dalle mani dei grossi gruppi finanziari la<br />
possibilità di controllo e di censura sui cibernauti 251 .<br />
251 I cibernauti sono coloro che ‘navigano’ nella rete.<br />
125
Valorizzazione delle vanità<br />
(prospettiva economica)<br />
Karl Marx aveva previsto la caduta progressiva del “saggio di<br />
profitto” 252 .«Potrebbe verificarsi adesso che è l’immaterialità e non più<br />
come poco tempo fa’ la materialità, a dominare? Niente affatto» 253 .<br />
Oggi con le tecnologie dell’immateriale e del virtuale, in senso largo,<br />
assistiamo a una tendenza inversa alla predizione di Marx, cioè a un<br />
aumento degli utili, mentre per il filosofo tedesco il destino del capita-<br />
lismo era la caduta tendenziale del saggio del profitto. Oggi con le reti,<br />
con i software , con l’industria del virtuale in senso largo, con la sma-<br />
terializzazione del valore aggiunto, accade esattamente il contrario:<br />
più un software è venduto, più un’immagine è distribuita, più colle-<br />
gamenti ha una rete, più prende valore, con un conseguente aumento<br />
degli utili che va in un senso completamente opposto alle predizioni,<br />
non soltanto di Marx, ma dei classici dell’economia. Dunque è una ri-<br />
voluzione fondamentale dei quadri di pensiero economico a cui ci<br />
aveva abituati il XIX secolo.<br />
252 Secondo il quale il mercato ha un livello di saturazione, dopo il quale non ha<br />
più senso la produzione, e così il mercato raggiunge il collasso, avviando le<br />
premesse al comunismo.<br />
253 P. QUEAU, «Diritti d’autore nell’era digitale», 04-09-95 Parigi, MediaMente<br />
126
Globalizzazione<br />
Il termine globalizzazione è stato fonte di violente discussioni<br />
tra economisti ed esperti delle politiche del lavoro. C’è chi è a favore<br />
dei mercati globali e chi contro. Globalizzazione significa non essere<br />
più chiusi nel locale, ma proiettati nel globale. Globalizzazione dei<br />
mercati significa non essere più delimitati e protetti nel commercio dai<br />
confini geografici nazionali, ma significa concorrere nella produzione<br />
con tutti i paesi del mondo. Gli effetti della globalizzazione si sono<br />
sentiti negli ultimi vent’anni con l’aumento notevole della disoccupa-<br />
zione nei paesi occidentali e principalmente in quelli che avevano fer-<br />
ree leggi per la protezione del lavoratore 254 . Questo è avvenuto perché<br />
le centrali di produzione, con l’aumento della coscienza civile 255 , si<br />
sono spostate verso il Sud del mondo dove i costi produttivi erano e<br />
sono nettamente inferiori. Ma la globalizzazione, al livello high-tech 256 ,<br />
ha permesso, grazie alla grande concorrenza, una crescita qualitativa<br />
notevole. È pero anche uno degli elementi che ha aumentato il gap tra<br />
Nord e Sud del mondo, anche se inizialmente si pensava lo potesse<br />
appianare. L’economia cambia profondamente, perché alla economia<br />
materiale a cui siamo abituati, si affianca un livello di economia vir-<br />
tuale. Si ha per esempio la possibilità di fare transazioni finanziarie<br />
254 Mentre negli USA, dove non esistono leggi limitative, il tasso di<br />
disoccupazione resta tra i più bassi del mondo.<br />
255 Leggi per la protezione dell’ecologia, per la sicurezza sul lavoro, per la<br />
previdenza, ecc.<br />
256 high-tech = delle alte tecnologie.<br />
127
senza recarsi in banca o dagli intermediari finanziari, oppure si pos-<br />
sono fare acquisti dall’altra parte del mondo; con l’uso della rete cade<br />
il vincolo della geografia. Cambiano, sostanzialmente, le regole del mar-<br />
keting mix 257 . In un’economia digitale, nella dimensione virtuale basata<br />
su Internet, «il prodotto è sostituito dall’immagine del prodotto» 258 .<br />
Telelavoro<br />
Con l’avvento dell’era digitale e della comunicazione globale si<br />
è pensato che finalmente il lavoro potesse essere trasferito nel domici-<br />
lio del lavoratore, aumentando a quest’ultimo la qualità della vita.<br />
Questo sogno è anch’esso uno «strabismo telematico» 259 . Innanzitutto<br />
cos’è il telelavoro? Esistono due interpretazioni di telelavoro. La prima<br />
vuole che i dipendenti di periferia invece di fare molti chilometri per<br />
raggiungere la sede, operino in uffici periferici aumentando così anche<br />
il contatto con il pubblico. La seconda vuole che i dipendenti operino<br />
nelle loro stesse case. Benché si stia già sperimentando questo tipo di<br />
lavoro, sappiamo che può essere utili e funzionale, come è sempre<br />
stato, per liberi professionisti 260 , mentre può diventare molto perico-<br />
loso per i lavoratori dipendenti, i quali da in lato infatti non riuscireb-<br />
257 Detta anche “regola delle 5 pi”: product (prodotto), price (prezzo), promotion<br />
(promozione), place (distribuzione), position (posizione nel mercato), che servono<br />
come canoni valutativi dell’attività dell’impresa sul mercato.<br />
258 MASIERO Roberto, «Economia digitale e società dell'informazione», 23-09-97<br />
Parigi, MediaMente<br />
259 G. CESAREO, «Lo strabismo telematico», cit.<br />
260 Scrittori, traduttori, giornalisti, architetti, ecc.<br />
128
ero a trovare il momento di distacco tra i lavoro e la vita privata (a<br />
differenza di un libero professionista che può scegliere come gestire<br />
meglio il proprio lavoro e non deve render conto a nessuno del suo<br />
operato), dall’altro potrebbero recare grossi danni all’azienda por-<br />
tando fuori notizie che dovrebbero restare protette. Si è parlato di te-<br />
lelavoro, naturalmente, solo per i lavori concettuali, ma la differenza<br />
con il lavoro a domicilio da sempre conosciuto, è solo quella di un<br />
terminale che collega la casa all’ufficio. Il telelavoro, inteso nella se-<br />
conda forma, non migliorerebbe molto la qualità della vita e se si te-<br />
nessero a mente gli aspetti negativi, come solitudine e ipercontrollo,<br />
allora si potrebbe giustamente affermare che il telelavoro potrebbe<br />
solo peggiorare la qualità della vita. Mentre hanno ottenuto soddisfa-<br />
centi risultati i dipendenti pubblici che operavano agli sportelli vir-<br />
tuali; cioè lavorando in una struttura idonea di un ente, solitamente<br />
pubblico, svolgevano le normali operazioni di sportello, ma ad utenti<br />
che li contattavano via Internet 261 .<br />
Il telelavoro è stata una infausta promessa dei guru<br />
dell’informatica degli ultimi anni; il pericolo sta ora nel fatto che lo<br />
stesso Stato sta provando queste tecniche. E anche lo Stato, ricade in<br />
un errore decennale, credere alla tecnologia, in ritardo e nella forma<br />
sbagliata. Anche le promesse sull’aumento del lavoro grazie alle tec-<br />
nologie sono state numerose negli ultimi anni, ma poco fortunate.<br />
261 Es. Comune di Bologna, di Modena, di Torino, ecc.<br />
129
Nel saggio La fine del lavoro 262 , Rifkin, parlando delle tecnologie<br />
“labour saving”, dell’”engineering” e descrivendo la “Terza Rivolu-<br />
zione Industriale”, pone il futuro come uno scontro fra due forze in-<br />
conciliabili: un’élite cosmopolita di analisti di simboli, “knowledge<br />
workers”, che controlla la tecnologia e la fase di produzione ed un cre-<br />
scente numero di lavoratori, permanentemente in eccesso. Forse ba-<br />
sandosi sulla stessa previsione Furio Colombo inizia il suo Confucio nel<br />
computer 263 , con un sagace racconto in cui degli ‘esperti’ in un «mo-<br />
mento accidentale del futuro» 264 promettono ad un disoccupato e ad<br />
un giovane come le tecnologie in futuro avrebbero risolto il loro pro-<br />
blema. Questa è una promessa ormai abusata, eppure le politiche del<br />
lavoro puntano sul futuro delle tecnologie, senza probabilmente com-<br />
prendere che queste non faranno altro che eliminare posti di lavoro. È<br />
vero e si inizia a vedere, che le tecnologie daranno lavoro e anche ben<br />
retribuito, a coloro i quali le tecnologie le sanno usare: i (IT) knowledge<br />
workers 265 . È vero che l’industria informatica punta a macchine “user<br />
friendly”, di facile utilizzo, ma solo nel settore domestico;<br />
nell’industria produttiva bisogna, per ottenere risultati concorrenziali,<br />
saper utilizzare macchine molto complesse. Le tecnologie, seguendo il<br />
262 J. RIFKLIN, La fine del lavoro, ed. Mondadori, 1993 Milano<br />
263 F. COLOMBO, Confucio nel computer, cit., p. 11-21<br />
264 Ibidem, p. 15<br />
265 Cioè gli Information technology knowledge workers (Lavoratori con esperienza<br />
nella tecnologia dell’informazione)<br />
130
trend attuale 266 , sembra che non incentivino il lavoro in generale, ma<br />
solo quello professionalizzato. Anzi con la globalizzazione si specializ-<br />
zano particolari nazioni in determinate attività produttive: gli indiani<br />
sono considerati ottimi programmatori, gli europei ottimi ricercatori, i<br />
giapponesi ottimi organizzatori, gli statunitensi come sempre ottimi<br />
affaristi, ecc. Il telelavoro, ma soprattutto la telecollaborazione, sono<br />
invece molto usate nel settore high-tech 267 , anche perché spesso gli IT<br />
knowledge workers o sono liberi professionisti oppure hanno posti di<br />
notevole importanza. È aumentato notevolmente per certi lavori,<br />
esempio ne è il laboratorio virtuale, nel quale, tecnici di varie parti del<br />
mondo, si incontrano e, dialogando esclusivamente in inglese, portano<br />
avanti i loro progetti informatici, ingegneristici, architettonici, ecc.<br />
Commercio in rete<br />
Per chi utilizza la rete a bassi costi, globalizzazione economica<br />
vuol dire comprare un prodotto o vendere il proprio dall’altra parte<br />
del mondo. Saltando naturalmente tutti i costi aggiuntivi di distribu-<br />
zione. In realtà, capovolgendo tutte le previsioni negative della rete,<br />
una delle prime società a fare commercio elettronico è stata una libre-<br />
ria. Molti avevano infatti, con l’avvento del digitale, già dato per spac-<br />
266 Sito: Il Sole24Ore Informatica Dicembre<br />
267 High-tech = delle alte tecnologie.<br />
131
ciato il libro. Invece, con la diffusione del web 268 , una piccolo libreria<br />
di Seattle mette il suo catalogo in rete ed inizia ad accettare le ordina-<br />
zioni via e-mail, diventando in poco tempo nota con il suo indirizzo<br />
Internet, www.amazon.com, la più grande libreria del mondo e forse<br />
l’unica libreria ad essere quotata in borsa a Wall Street 269 . Le altre so-<br />
cietà che finora hanno avuto buone possibilità in Internet, sono le im-<br />
prese di servizio, come la Yahoo 270 che ha organizzato un motore di ri-<br />
cerca. Yahoo permette di trovare i siti o tramite un’organizzazione ge-<br />
rarchica di siti visitati e valutati dalla Yahoo stessa oppure grazie<br />
all’uso di word-key 271 , grazie ad un sistema logico di ricerca detto si-<br />
stema booleano 272 .<br />
Per il commercio elettronico 273 è dovuta nascere una nuova<br />
scienza economica, la Webonomics 274 , cioè l’economia del web, che<br />
ancora si basa su poche regole fondamentali:<br />
1) i consumatori pagano raramente un canone per accedere ad un<br />
sito web;<br />
2) i vecchi modelli di vendita della pubblicità non si applicano più;<br />
268 Con il browser Mosaic nel 1993<br />
269 Borsa federale centrale degli USA<br />
270 Siti: «yahoo.com» oppure nella versione italiana «Yahoo.it»<br />
271 Word-key = parola chiave; esempio se cerco una rivista che parla di Socrate, la<br />
word-key sarà appunto «Socrate».<br />
272 Sistema logico per la ricerca, utilizza le espressioni logiche AND, OR, NOT.<br />
[vedi Glossario]<br />
273 Conosciuto come e-commerce<br />
274 E. I. SCHWARTZ, «Advertising Webonomics 101» da Wired n° 4.02 Febbraio 1996<br />
132
3) chi fa marketing è sul Web non per farsi vedere, ma per dei ri-<br />
sultati;<br />
4) i clienti devono essere ricompensati quando concedono infor-<br />
mazioni private su loro stessi;<br />
5) non è la quantità di persone che visitano il sito la cosa impor-<br />
tante, ma la qualità dell’esperienza che vi fanno.<br />
I professori del marketing a. I. 275 oggi hanno dovuto riprendere gli<br />
studi dell’Advertising 276 p. I. 277 ; conoscere testi nuovi e non sempre<br />
affascinanti (Tutto ciò che avreste voluto sapere su HTML e Java e non<br />
avete mai osato chiedere oppure La mia vita con ShockWave) e termini<br />
nuovi (brochureware 278 ).<br />
Nella rete le regole sono diverse. Il gratis ha infatti assunto<br />
un’importanza notevole diventando un paradosso: «si deve regalare la<br />
merce principale per far soldi con i servizi ad essa correlati» 279 .<br />
Gratis si forniscono servizi o doni in cambio di informazioni.<br />
L’informazione è infatti «l’oro dell’era digitale» 280 . Le informazioni che<br />
potrebbero sembrare banali, come quelle suoi propri hobbies, sugli<br />
studi fatti, ecc., diventano però fondamentali per chi voglia proporre<br />
della pubblicità mirata. La pubblicità ha cambiato unità di misura, non<br />
275 a. I. = ante Internet<br />
276 Advertising = marketing pubblicitario<br />
277 p. I. = post Internet<br />
278 Brochureware = la brochure telematica<br />
279 R. STAGLIANÒ, Circo Internet, cit., p. 68<br />
280 N. NEGROPONTE, Essere digitali, cit., p. 72<br />
133
si parla più di share televisivo, basato solamente sulla quantità. Le<br />
nuove unità di misura vogliono mirare giusto: il marketing si fa più<br />
specifico, delimita il target d’azione. Esistono le semplici Hits 281 ; tanto<br />
semplici che Katherine Paine, direttrice del Delahaye Group, alla<br />
quarta edizione del Networked Economy Conference nell’aprile 1997,<br />
ha acronimato Hits in How Idiots Track Success, Come gli Idioti Rile-<br />
vano il Successo. Anche la view 282 è poco specifica. Mentre la più seria<br />
psicografia 283 e il click-through 284 servono per studiare approfondita-<br />
mente la clientela. In rete esiste la pubblicità sotto forma di cartellone<br />
pubblicitario elettronico, detto banner. Un banner però, a differenza di<br />
ogni altra pubblicità, è un collegamento ipertestuale che permette di<br />
andare a visitare immediatamente il sito dell’azienda che pubblicizza<br />
il prodotto/servizio e magari di acquistarlo immediatamente tramite<br />
carta di credito. Possono essere personalizzati. I banner inoltre sono<br />
l’unica fonte di finanziamento per molti siti. È però una pubblicità<br />
«pericolosa» 285 , ma più pericoloso è il fatto che il banner possa essere<br />
mirato. Se infatti io una sola volta ho dato le mie informazioni in rete<br />
in cambio di qualcosa, queste verranno usate per propormi pubbli-<br />
cità/banner mirati. Per esempio se compilando un modulo in cambio<br />
281 La quantità è semplice e apparentemente oggettiva, conta i files scaricati, ma<br />
quando si chiede una pagina HTML possono essere inviati numerosi file (infatti<br />
anche piccole immagini sono file).<br />
282 View = (vista) quantità di visioni della home page di un sito<br />
283 Psicografia = lo studio delle abitudini e delle preferenze d’acquisto<br />
284 Click-through = è l’atto di volontà del cybernauta di visitare un sito tramite<br />
banner<br />
285 F. BERARDI (Bifo), «Spunti di riflessione» cit.<br />
134
di una casella di posta elettronica 286 ho dichiarato di amare la lettera-<br />
tura, è possibile che veda soprattutto banner di società che vendono<br />
libri, mentre se avessi dichiarato di apprezzare la pesca avrei visto<br />
principalmente banner di società che producono attrezzatura sportiva.<br />
A coprire un ruolo importante in questo modello pubblicitario elettro-<br />
nico sono i cookies 287 . Ma anche la possibilità che le informazioni da<br />
me fornite vengano distribuite per la rete senza il mio consenso, visto<br />
che la giurisprudenza in materia cambia da paese a paese, è un rischio<br />
reale. Un sito Internet deve avere diverse caratteristiche, come mettere<br />
a proprio agio il visitatore: «Se l’ambiente elettronico non cattura<br />
l’attenzione del visitatore entro i primi otto secondi, il suo dito non ci<br />
penserà oltre a cliccare altrove verso destinazioni più allettanti» 288 e<br />
deve creare un senso di comunità, ascoltare le opinioni dei visitatori<br />
rispettandone l’individualità, one-to-one 289 , o valorizzare le vanità. Biso-<br />
gna, insomma, dare la possibilità a chiunque di mettere in mostra<br />
qualcosa di sé stessi, come foto, storie, musiche, filmati. Infatti il mo-<br />
vente più sicuro perché si torni in una località telematica è quella di<br />
verificare che la promessa di mettervi on-line sia stata mantenuta. La<br />
voglia di essere protagonisti, potenzialmente di fronte a milioni di<br />
286 È infatti molto comune in Internet avere più caselle di posta elettronica.<br />
287 Dei cookies si discute ampiamente nel capitolo Cookies – prospettiva del diritto<br />
288 Da uno studio/relazione del 1997 pubblicato in rete dalla Università del<br />
Minnesota.<br />
289 Rispettando il visitatore e facendogli credere di dedicarsi solamente a lui.<br />
135
persone 290 , è la componente caratteristica di cui generalmente 291 i cy-<br />
bernauti non difettano. Emozioni da poco, ma «soltanto sapere che il<br />
proprio nome galleggia, a qualsiasi titolo, nella nebulosa telematica<br />
può dare a molti una vertigine di immortalità» 292 . E sull’esaltazione, la<br />
valorizzazione delle vanità puntano gli esperti del mercato elettronico.<br />
Spamming<br />
È la pratica di effettuare spedizioni enormi e indiscriminate di<br />
messaggi non richiesti di posta elettronica, reclamizzanti i prodotti più<br />
vari, a chiunque abbia un indirizzo e-mail.<br />
Sanford Wallace (soprannominato prima SPAMford e poi Spam<br />
King) ventottenne di Dresher, sobborgo di Philadelphia, ha la fama di<br />
«persona più odiata della rete» per averlo inventato. Spamming è un<br />
neologismo; deriva da ‘Spam’ una nota marca di una carne gelatinosa<br />
da spalmare. Ci si immagina la situazione in cui il contenuto della<br />
scatoletta fosse versato di fronte ad un grosso ventilatore che schizzi la<br />
poltiglia in tutte le direzioni. Poco elegante ma efficace: dallo spam-<br />
ming non si salva nessuno. La Cyber Promotions, di cui Wallace è fon-<br />
datore e presidente, è in grado di spedire milioni di e-mail pubblicita-<br />
rie al giorno. Il caso seguito dal giudice distrettuale dell’Ohio, James<br />
290 In realtà senza pubblicizzare l’indirizzo, un sito può restare praticamente<br />
invisibile.<br />
291 Esclusi i lurker<br />
292 R. STAGLIANÒ, Circo Internet, cit., p. 72<br />
136
Graham dovrà decidere sulla causa iniziata da Compuserve contro<br />
Wallace ed in generale i giudici americani spesso sono coinvolti in<br />
cause contro coloro che insistono con la junk mail 293 e spamming. Tut-<br />
tora i togati di tutto il mondo cercano una soluzione legislativa che an-<br />
cora non sono riusciti a trovare, una limitazione però è stata in parte<br />
fornita dalla Netiquette 294 .<br />
293 Junk mail = lett. posta mondezza<br />
294 Netiquette = etichetta della rete, [vedi glossario].<br />
137
Cookies<br />
(prospettiva del diritto)<br />
Le nuove tecnologie hanno permesso di velocizzare e facilitare<br />
gli scambi di informazioni, anche di grosse quantità di dati, così men-<br />
tre i diritti di proprietà entrano in crisi, la facilità di scambio di infor-<br />
mazioni personali mette a dura prova la privatezza dell’individuo. La<br />
possibilità di non rivelare in pubblico le proprie informazioni, o impe-<br />
dire a chi ne sia venuto in possesso di divulgarle diventa un diritto,<br />
quello alla privacy, difeso dalla giurisprudenza delle maggiori na-<br />
zioni.<br />
Copyright & Copyleft<br />
Il problema principale dei diritti d’autore, dei diritti di brevetto<br />
o di marca depositata è che nell’era digitale è possibile una replicabi-<br />
lità infinita quasi a costo zero. A differenza dell’economia del XIX se-<br />
colo o dell’economia del XX, basata sulla materia, l’economia contem-<br />
poranea si fonda nella pura immaterialità. Il problema<br />
dell’immateriale è che non costa niente riprodurlo, diffonderlo e per di<br />
più è assai difficile dare un carattere personale alle idee immateriali o<br />
alle immagini. Sempre più la multimedialità può essere realizzata con<br />
immagini, con suoni che vengono dai più diversi orizzonti. Ed è assai<br />
138
difficile proteggere un software, perché spesso «le idee sono qualcosa<br />
di immateriale alla seconda potenza» 295 . È assai difficile caratterizzare<br />
l’apporto originale di un’invenzione. Oggi si presentano due ordini di<br />
problemi. Primo: la rapida smaterializzazione del supporto<br />
dell’informazione. Secondo: l’incapacità di distinguere precisamente<br />
ciò che è nuovo, ciò che innova, da quello che c’è di originale in<br />
un’opera dello spirito. Questi due parametri di novità fanno pensare<br />
che c’è stata una completa rivoluzione e che il diritto d’autore oggi è<br />
inadeguato.<br />
Qualcuno all’OMPI 296 , pensa che sia possibile usare, modifican-<br />
doli un po’, accordi come quelli della Convenzione di Berna o della<br />
Convenzione di Roma sui diritti d’autore. Però forse è una soluzione<br />
insoddisfacente, perché la rivoluzione che noi stiamo vivendo è al-<br />
trettanto importante dell’invenzione della stampa o dell’invenzione<br />
dell’alfabeto. Ne deriveranno dei quadri mentali completamente di-<br />
versi e dovremo cambiare radicalmente il nostro rapporto con la no-<br />
zione di originalità e quindi con la nozione di protezione dei diritti<br />
d’autore.<br />
La manipolazione digitale pone il problema dei diritti<br />
sull’immagine originale e sull’immagine manipolata, come sui suoni o<br />
sulle altre espressioni artistiche.<br />
295 P. QUEAU, «Diritti d’autore nell’era digitale», cit.<br />
296 OMPI = Organizzazione Mondiale della Proprietà Industriale<br />
139
È un problema questo che si può risolvere in due modi, secondo<br />
che si sia reazionari o che si voglia andare avanti. Se si è reazionari lo<br />
si può risolvere mettendo delle protezioni sulle immagini. Ci sono<br />
delle soluzioni tecniche: si possono codificare le immagini con tecni-<br />
che crittografiche 297 e di “firma elettronica” 298 e quindi si possono de-<br />
cisamente proteggere. Si può evitare che altre persone, che non siano<br />
in possesso della “firma elettronica” vengano a decodificare e a prele-<br />
vare immagini, opere artistiche software. O inversamente si possono<br />
distribuire le immagini e mostrare che non sono state modificate gra-<br />
zie alla prova dell’originalità, legata alla “firma elettronica”. Una ri-<br />
sposta puramente tecnocratica e giuridica, che non prenda in conside-<br />
razione l’ampiezza della rivoluzione culturale che si sta preparando,<br />
sembra essere assolutamente miope.<br />
«[…] è impossibile filosoficamente, ma è possibile tecnologica-<br />
mente creare piccoli spazi riservati, in cui si potrà custodire, con pre-<br />
cauzione, il diritto di proprietà» 299 , in cui ci si potrà chiudere nel pro-<br />
prio “copyright”. Ma c’è un altro concetto, che si mostra più interes-<br />
sante: quello di “copyleft” 300 .<br />
297 È un metodo di codifica dei dati che impedisce intrusioni illecite [Vedi<br />
Glossario]<br />
298 [Vedi Glossario]<br />
299 P. QUEAU, «Diritti d’autore nell’era digitale», cit.<br />
300 R. STALLMAN, «Il copyright è di destra, il copyleft è di sinistra», 05-12-97 Roma,<br />
MediaMente<br />
140
Alle zone privilegiate, private, dei “copyright”, bisognerà op-<br />
porre delle zone generose, di distribuzione dell’informazione, che ser-<br />
viranno per la distribuzione gratuita delle idee, indirizzata soprattutto<br />
verso le scuole, verso l’educazione, educazione in senso lato, verso i<br />
paesi in via di sviluppo, mediante le azioni necessarie a «ridurre le di-<br />
stanze tra gli ‘have’ e gli ‘have not’» 301 , tra chi ha e chi non ha, tra gli<br />
info-ricchi e gli info-poveri. Queste azioni potrebbero appoggiarsi su<br />
un aspetto del diritto d’autore e del diritto morale di proprietà, molto<br />
interessante della giurisprudenza anglosassone, che è il diritto di “fair<br />
use” 302 : un diritto che non è dell’autore, ma del lettore, non del pro-<br />
prietario dell’opera, ma dell’utente, perché bisogna pensare anche al<br />
bene comune e il bene comune esige che si protegga non soltanto il di-<br />
ritto degli autori, ma anche quello degli utenti.<br />
Nella battaglia per l’affermazione del principio di “copyleft” si<br />
è distinto l’ex- collaboratore del MIT 303 ed hacker di fama mondiale:<br />
Richard Stallman. Egli si è dedicato, anche grazie alla sua “Free Soft-<br />
ware Foundation” 304 , al progetto GNU.<br />
GNU è il nome del sistema operativo 305 a cui Stallman e i suoi<br />
collaboratori lavorano già da quattordici anni; questo sistema è inte-<br />
301 P. QUEAU, «Diritti d’autore nell’era digitale», cit.<br />
302 Fair use = diritto di utilizzo<br />
303 MIT = Massachusetts Institute of Technology di Boston<br />
304 Free Software Foundation (Fondazione per il software libero) è un Ente di<br />
beneficenza ufficialmente riconosciuto negli USA.<br />
305 [vedi Glossario]<br />
141
amente costituito da software libero e ciò lo caratterizza rispetto a<br />
tutti gli altri sistemi operativi. Poiché è un software libero, gli utenti<br />
hanno la ‘libertà’, appunto, di modificare il software stesso a seconda<br />
dell’uso che se ne vuole fare, hanno la libertà di studiare come fun-<br />
ziona il software; e grazie al codice sorgente 306 pubblico- non c’è nulla<br />
di segreto all’interno del suo software - e l’utente ha la libertà di fare<br />
copie e distribuirle in modo da condividerle col suo vicino. Inoltre si<br />
ha la possibilità di fare versioni migliorate e diffonderle sulla rete, al<br />
fine di un uso comune; di conseguenza, chiunque può collaborare alla<br />
costruzione della sua comunità. Il significato di software libero consi-<br />
ste in queste tre libertà. L’idea stessa di questo sistema è che ogni sua<br />
parte è software libero, così un utente può usare un computer che ha<br />
esclusivamente software libero per ogni funzione. In questo modo non<br />
si è vincolati a nessun proprietario di programmi.<br />
Ma in generale, a parte i cultori del copyleft, nasce la necessità a<br />
causa della grandezza babelica della rete, di inventare un sistema di<br />
“browsing”, di consultazione virtuale, senza che si sia obbligati ad ac-<br />
quistare l’opera.<br />
Naturalmente c’è differenza tra la protezione dei diritti del<br />
software e la protezione dei diritti del contenuto, delle immagini, dei<br />
testi. Cioè tra il prodotto che possiamo dire finito, terminato e che può<br />
306 È il codice che permette di lavorare al livello del linguaggio di<br />
programmazione, che solitamente e protetto, e permette di anche di creare nuovi<br />
programmi dal software sorgente<br />
142
essere firmato e la nozione di software, che è il mezzo, lo strumento.<br />
Quando si fabbrica una casa con martello e chiodi, non c’è un diritto<br />
d’autore sul martello. Ci può essere un diritto d’autore sul progetto<br />
dell’architetto, ma non sul mattone, sull’armatura. Oggi i software<br />
sono come i martelli e le seghe. Nessuno ha mai pensato a esigere il di-<br />
ritto d’autore sui martelli o sulle seghe, quando si costruisce una casa.<br />
Altrimenti dovremmo immaginare che ci sono diversi livelli del diritto<br />
d’autore. Ad esempio quando si fa un film con gli effetti speciali si<br />
potrebbe immaginare che ci siano i diritti d’autore del regista, quelli<br />
del programmatore degli effetti speciali e anche quelli di colui che ha<br />
progettato il software, che permette di fare gli effetti speciali, eccetera.<br />
Ma poiché questo non è possibile, bisognerà distinguere chiaramente<br />
due regimi: il regime dell’opera finita, dell’opera in senso aristotelico,<br />
cioè il prodotto, l’opera dell’artigiano e ciò che appartiene all’ordine<br />
dei mezzi e che non può essere protetto perché il farlo porterebbe<br />
troppe complicazioni. In ogni caso un irrigidimento del “copyright”<br />
snaturerebbe completamente Internet.<br />
Cookies<br />
I cookies, letteralmente dei biscotti, sono una blandizia del Web<br />
per carpire informazioni. La scoperta dei cookies è avvenuta grazie ad<br />
una versione di Netscape, il browser della Netscape Communication<br />
143
Corporation 307 , che ne rivelava la presenza. Si è scoperto così che i<br />
cookies sono dei piccoli file di testo che vengono depositati sul com-<br />
puter del cybernauta ogni volta che questi visita un sito web; e quando<br />
egli ricapita sullo stesso sito, il server 308 va a leggere le informazioni<br />
contenute nel cookie; esempio che siti sono stati visitati, quante volte,<br />
ecc., raccogliendo così le informazioni necessarie per tracciare un pro-<br />
filo esauriente dei gusti del navigatore, ‘Conoscere’ un navigatore<br />
vuol dire sapere, per esempio, indirizzargli la giusta pubblicità attra-<br />
verso banner personalizzati. Per esempio se si visitano spesso siti de-<br />
dicati alla pesca è possibili che possa iniziare a vedere banner pubbli-<br />
citari riguardanti la pesca anche in siti che non trattano assolutamente<br />
di pesca.<br />
L’ira delle associazioni di tutela dei diritti elettronici si è ab-<br />
battuta fragorosamente sugli smerciatori di questi «alimenti ava-<br />
riati» 309 : sfruttando l’ingenuità di innumerevoli navigatori le aziende<br />
volevano utilizzare questi minuscoli cavalli di Troia per penetrare<br />
subdolamente nella vita privata dell’utente, dritti nel cervello del suo<br />
calcolatore. Il dissidio feroce è ancora una volta tra le ragioni del mar-<br />
keting e quelle della privacy. Per chi deve vendere qualcosa è come<br />
poter studiare i propri potenziali clienti in un laboratorio elettronico.<br />
Di ogni loro mossa, di ogni loro accenno di interesse verso un pro-<br />
307 [Vedi Netscape Communications Corporation]<br />
308 Computer che gestisce il sito Web<br />
309 R. STAGLIANÒ, Circo Internet, cit., p. 119<br />
144
dotto anziché verso un altro, rimane traccia, nei mega cervelloni della<br />
rete. E anche chi invita a sdrammatizzare i sulla riservatezza e coglie<br />
piuttosto i passi avanti sulla strada della personalizzazione del servi-<br />
zio che i cookies fanno fare, non fa che aumentare il timore. I loro di-<br />
fensori affermano che la trappola dei cookies è così scoperta ormai da<br />
essere inoffensiva. Gli antidoti alla loro insinuante presenza sono tali<br />
da ridurre il problema a dimensioni più che accettabili. Il ‘biscotto’<br />
può raccontare qualcosa di voi solo a chi l’ha messo, ma la contro-<br />
obiezione è che si possa sviluppare rapidamente una borsa valori delle<br />
informazioni personali nella quale chi le detiene può rivenderle al<br />
soggetto potenzialmente più interessato.<br />
Privacy<br />
«Stare in rete è tanto discreto come camminare su un tappeto<br />
bianco con delle scarpe intinte nella pece: per quanto stiate attenti, un<br />
segno del vostro passaggio rimarrà» 310 .<br />
La paura del Grande Fratello sembra sempre più avverarsi gra-<br />
zie alle nuove tecnologie, anche se oggi «è il capitalismo a voler essere<br />
il Grande Fratello» 311 . Gli analisti vogliono possedere i dati completi<br />
310 R. STAGLIANÒ, Circo Internet, cit., p. 114<br />
311 RODOTÀ Stefano, «Sviluppo telematico e democrazia», cit.<br />
145
dei clienti per poter sviluppare strategie di marketing mirate al cliente.<br />
Lo scambio dei servizi contro la privacy ha aumentato notevolmente<br />
la quantità di informazioni personali nei grossi DBMS 312 delle grandi<br />
società d’analisi. Proprio quello delle società specializzate nel far rile-<br />
vamenti sulla demografia e sulla psicografia 313 dei cybernauti è uno<br />
dei mercati più floridi e competitivi del momento. La I/Pro 314 , suggeri-<br />
sce addirittura ai cybernauti, per evitare ripetizioni, di compilare una<br />
volta per tutte i propri dati nelle loro pagine; la HotMail 315 , invece re-<br />
gala una casella di e-mail se si compila il loro modulo.<br />
Nel 1996 la Direct Marketing Association, che rappresenta 4000<br />
società in 50 paesi, ha emanato un timido codice di autoregolamenta-<br />
zione. Per fortuna in Italia la legge 316 sulla privacy informatica e non<br />
solo, è abbastanza severa e protegge i dati personali dalla divulga-<br />
zione. Ci sono tanti diritti alla privacy che vengono in conflitto sulle<br />
reti. Perché, ad esempio, se da un lato c’è il diritto alla privacy di un<br />
soggetto, che non vuole che qualcun altro sulla rete riveli i suoi fatti<br />
privati, dall’altro c’è un contrapposto interesse alla privacy di coloro<br />
che, entrando in rete vogliano mantenere l’anonimato, che vogliano<br />
usare un nome fittizio o uno pseudonimo, perché soltanto attraverso<br />
312 DBMS = (Data Base Management System) è l’acronimo delle banche dati<br />
313 Psicografia = lo studio delle abitudini e delle preferenze d’acquisto<br />
314 I/Pro (Internet/Profiles) una delle società di analisi più stimate della rete<br />
315 Sito: «HotMail»; molte altre società chiedono di compilare un loro modulo, ma<br />
alcune, come la HotMail, non fanno alcun dono se non si compilano tutte le parti del<br />
questionario<br />
316 Legge 675 del 31.12.96: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al<br />
trattamento dei dati personali»<br />
146
l’anonimato, quindi la difesa della loro ‘privacy’, riescono ad espri-<br />
mersi al meglio. Qui si rivela un clamoroso conflitto tra due esigenze<br />
di tutela della ‘privacy’. Naturalmente è possibile, anzi è indispensa-<br />
bile trovare un equilibrio, perché altrimenti ci sarà qualcuno indebi-<br />
tamente sacrificato. «Io non posso alzarmi la mattina, andare su una<br />
qualsiasi rete, entrare in un gruppo di discussione e trovare tutte le<br />
mattine qualcuno che mi insulta. Questa è certamente una violazione<br />
della mia sfera privata. Ci sono regole codificate che, in questo caso,<br />
mi consentono, per esempio di chiedere un risarcimento del danno, di<br />
impedire che questa attività di violazione della mia sfera privata con-<br />
tinui» 317 . Ma come si fa se l’altro interlocutore, in nome della sua pri-<br />
vacy, vuole rimanere anonimo? Si è suggerito, per questi casi, che il<br />
nome sia custodito dal gestore della rete e rivelato soltanto se c’è un<br />
problema di questo tipo. I problemi di difesa della privacy, quindi,<br />
devono e possono essere affrontati. Ma c’è anche qualcosa di più, per-<br />
ché il rapporto tra sfera pubblica e sfera privata è stato sin qui codifi-<br />
cato . Alcuni dicono: “io riesco a esprimere tutta la mia personalità,<br />
quindi a costruire pienamente la mia sfera privata sulla rete, soltanto<br />
se, per esempio, posso rimanere anonimo”. È legittimo o non è legit-<br />
timo? In via di principio è legittimo, perché un individuo può supe-<br />
rare attraverso questa dimensione della virtualità della rete una serie<br />
di problemi che altrimenti gli impedirebbero il pieno sviluppo della<br />
317 S. RODOTÀ, «Sviluppo telematico e democrazia», cit.<br />
147
sua personalità, che è una ‘espressione’ che si trova all’inizio della no-<br />
stra Costituzione, come base dei diritti fondamentali della persona.<br />
Naturalmente la possibilità di tracciare un confine netto tra sfera pub-<br />
blica e sfera privata diventa sempre più difficile, perché noi viviamo<br />
sempre di più in pubblico. Nel momento in cui si usa una carta di cre-<br />
dito, si lascia una traccia, una traccia molto forte, perché dice a che ora<br />
si era presenti in quel negozio, che cosa si ha acquistato e quanto si è<br />
speso. Questa è una traccia che riguarda la mia sfera privata, ma che<br />
entra in una dimensione pubblica, perché il gestore della carta di cre-<br />
dito conserva queste informazioni, qualche volta le vende ad altri, che<br />
sono interessati a sapere chi sono coloro i quali comprano certi pro-<br />
dotti, per rivolgere loro, per esempio, una certa pubblicità. La sfera<br />
pubblica e la sfera privata quindi tendono in molti casi a sovrapporsi,<br />
a confondersi.<br />
«Qual è allora il punto finale, provvisorio, come è tutto provvi-<br />
sorio in questa materia?» 318 . Quello fornito nel 1983 dalla Corte Costi-<br />
tuzionale tedesca, quando fu interpellata da alcuni cittadini che obiet-<br />
tavano la legittimità di una legge sul censimento, dicendo che con al-<br />
cune domande invadeva la loro sfera privata: La Corte Costituzionale<br />
diede loro ragione, affermando che tutti i cittadini hanno il diritto<br />
all’autodeterminazione informativa, cioè a stabilire che cosa vogliono<br />
318 S. RODOTÀ, Tecnologie e diritti, ed. Il Mulino, 1995 Bari, p. 24<br />
148
mettere in circolazione, quando sono costretti a mettere in circolazione<br />
delle informazioni. Perché, se si vuole usare la carta di credito, si deve<br />
fornire delle informazioni: non si può non dare il proprio nome. Il di-<br />
ritto della persona è quello di controllare poi l’uso che altri può fare<br />
delle informazioni che egli ha ceduto. Ecco allora la nuova dinamica:<br />
la sfera privata, anche quando parzialmente diventa pubblica, viene<br />
difesa dallo Stato, non però attraverso la vecchia prospettiva che in-<br />
tendeva la privacy come il «diritto d’essere lasciato solo» 319 . Nessuno<br />
può diffondere informazioni sul mio conto diventa invece il diritto di<br />
controllare chi usa le informazioni che mi riguardano.<br />
319 Ibidem, p. 7<br />
149
Scuola dietetica in vista di una maieutica<br />
Apartheid informatica<br />
(prospettiva pedagogica)<br />
Da un punto di vista filosofico, bisogna considerare che i dati a<br />
cui avremo accesso non sono autentici, nello stesso senso in cui non è<br />
autentico un volantino o un articolo di giornale, anche se ci può essere<br />
una firma. Come bisogna acquisire tutta una cultura supplementare,<br />
grammaticale, sintattica, retorica, quello spirito critico che si forma a<br />
scuola con lo studio di decine d’anni, prima di padroneggiare la cul-<br />
tura dello scritto, allo stesso modo bisognerà sviluppare una cultura<br />
del virtuale e ci vorranno decine d’anni per metterla a punto 320 .<br />
Dobbiamo interrogarci sugli effetti che, non tanto<br />
l’introduzione, quanto la diffusione e la generalizzazione delle nuove<br />
tecnologie avrà sulla trasformazione del sapere e dei modi che noi co-<br />
nosciamo, con cui «il sapere si è strutturato in forme di ripetizione, di<br />
apprendimento, di insegnamento, ma anche di pratiche dal basso» 321 .<br />
È un argomento incredibile, perché noi abbiamo già segnali evidenti<br />
che ci dicono che i vecchi media generalisti come la televisione e la ra-<br />
dio, ma soprattutto la televisione, hanno drasticamente modificato sia<br />
320 P. QUEAU, «La rivoluzione del virtuale» 15-12-95 Roma, MediaMente<br />
321 E. MORIN, «Educare ai mass media» cit.<br />
150
i contenuti che le modalità di trasmissione del sapere. E questo già do-<br />
vrebbe indurci ad una ricerca capace di capire in che modo la trasmis-<br />
sione tradizionale del sapere, l’amministrazione da parte dei docenti e<br />
dell’istituzione scolastica e della stessa università del sapere, ricono-<br />
sciuta e formale, si intreccia nel vissuto dei giovani, nel vissuto degli<br />
utenti e nel vissuto degli allievi con tipi di saperi, tipi di linguaggi, ma<br />
anche contenuti di sapere, di relazioni comunicative, di relazioni di<br />
vita, che vengono invece da un altro tipo di magistero, da un altro tipo<br />
di autorità: quello dei media. Ora, se questo era vero e possibile e già<br />
gli studi lo documentano dobbiamo immaginarci che tipo di appro-<br />
fondimento e di cambiamento del processo avverrà con le nuove tec-<br />
nologie. Quasi sicuramente le nuove tecnologie comporteranno un<br />
nuovo tipo di sapere e quindi anche un nuovo tipo di insegnamento e<br />
di professionalità docente.<br />
Internet ci mostra come la didattica a distanza stia portando alla<br />
fine del maestro reale, con la comparsa di una sorta di maestro vir-<br />
tuale, che comporta la perdita di tutti i tratti paralinguistici della co-<br />
municazione: i gesti, la distanza, il tono della voce. Naturalmente, nes-<br />
suna tecnologia di comunicazione, per quanto intensa e coinvolgente<br />
possa essere, potrà sostituire la trasmissione in presenza. Chiunque<br />
abbia realizzato esperienze di formazione a distanza, sa che comunque<br />
c’è una perdita semantica di gestualità, di emotività, di coinvolgi-<br />
mento, oltre che di aspetti linguistici e paralinguistici, che letteral-<br />
151
mente obbligano a riscrivere la deontologia e gli aspetti costitutivi<br />
dell’esperienza di docenza. Più difficile è dire come ciò avverrà. Que-<br />
sto decenni e i prossimi saranno caratterizzati da un intreccio continuo<br />
tra vecchie tecnologie della comunicazione e nuove tecnologie, tra<br />
vecchie forme di trasmissione del sapere e nuove modalità di inven-<br />
zione e di scoperta del sapere e di apprendimento del sapere. Attra-<br />
verso questa transizione, «uno dei modi per salvare, se sarà possibile,<br />
la professionalità docente sarà quello di interagire continuamente tra<br />
forme di insegnamento e contenuti tradizionali e capacità di insegnare<br />
a leggere e a contestualizzare, in termini culturali e più tradizionali, le<br />
nuove tecnologie» 322 . Per quanto possa apparire semplicemente un<br />
processo di ristilizzazione del ruolo, la capacità di “rappresentare”<br />
una discreta cognizione delle nuove teorie, delle nuove metodologie,<br />
delle nuove tecnologie, potrebbe già essere un elemento che possa ri-<br />
mettere il docente in un circuito di modernità e quindi renderlo credi-<br />
bile agli occhi dei suoi allievi. Il problema fondamentale<br />
dell’educazione è che non può darsi educazione se l’operatore della<br />
trasmissione viene considerato un attore del passato. Occorrerebbe che<br />
il nuovo governo dell’istruzione investisse, con coraggio e con deter-<br />
minazione, in grandi progetti, non di solo aggiornamento degli inse-<br />
gnanti, ma di “riacclimatamento” culturale degli insegnanti alle nuove<br />
condizioni del loro agire. Oggigiorno cambia, anzitutto, «l’attitudine<br />
322 S. CERRI, «La formazione a distanza», 21-12-95 Roma, MediaMente<br />
152
del soggetto ad offrirsi in condizioni di vaso vuoto. […] I giovani non<br />
sono assolutamente nell’attitudine di apprendere qualcosa, […] ma<br />
sono nell’attitudine di interagire» 323 . Questo è un mutamento epocale.<br />
Tutte le pratiche dell’istruzione sono fondate sulla trasmissione. Men-<br />
tre tutte le attitudini dei discenti sono fondate sull’interazione. È ne-<br />
cessaria una triangolazione continua tra utenti del processo di forma-<br />
zione e di comunicazione, tecnologie e docenti, i quali devono recupe-<br />
rare un loro ruolo, ponendosi come un elemento di interposizione tra<br />
le tecnologie e i soggetti che accedono ad esse.<br />
Stefano Rodotà ha denunciato il pericolo di una «apartheid in-<br />
formatica» 324 . Ma già alla fine degli anni Ottanta, nelle più difficili<br />
condizioni della scuola, alcuni sociologi 325 avevano prefigurato le con-<br />
dizioni di una nuova ferita; dovuta alle nuove differenze di “chances”.<br />
Noi sappiamo che le disuguaglianze cambieranno nel futuro, poiché<br />
esse possiedono questa natura sordida di presentarsi sempre in ma-<br />
niera diversa rispetto al passato. Le disuguaglianze legate alle ferite di<br />
classe sono diventate più evanescenti, anche se non sono scomparse;<br />
quelle legate alle differenze culturali sono state, in qualche modo, su-<br />
perate dagli anni Ottanta: dal momento in cui c’è stato un exploit della<br />
cultura di massa. Adesso, la nuova frontiera delle disuguaglianze è<br />
323 E. MORIN, cit.<br />
324 S. RODOTÀ, «Sviluppo telematico e democrazia», cit.<br />
325 G. MARTINOTTI «Telegeografia dell'era globale», 05-07-96 Napoli, al Summit<br />
Telecom, Mediamente<br />
153
certamente quella sui nuovi saperi. Quello che bisogna fare è cercare<br />
di governare l’approdo di un numero sempre più vasto di soggetti alle<br />
nuove tecnologie della comunicazione, affinché le nuove tecnologie<br />
non siano il passaporto di nuovi poteri, o di nuove forme di arroganza<br />
e di disuguaglianza sociale: info-ricchi contro info-poveri.<br />
Storia dei fallimenti tecnologici nella scuola<br />
«Gli insegnanti dell’era digitale dovranno imparare a memoria<br />
lo slogan “Learning by doing”, imparare facendo» 326 . Già negli anni ‘70<br />
il professor Seymour Papert 327 del MIT 328 e allievo diretto del peda-<br />
gogo Jean Piaget 329 , teneva convegni dal titolo «Learn Think to Chil-<br />
dren» 330 , cioè “insegnare ai bambini a pensare”. Secondo lui per met-<br />
tere al passo l’insegnamento con la società dell’informazione biso-<br />
gnava anzitutto sbarazzarsi della tirannia delle ‘tre R’ (reading ‘riting<br />
‘rithmetics) 331 . Bisogna rinunciare al puro dato «in vista di una scuola<br />
dietetica» 332 . Questa tesi costruttivista, sta conoscendo oggi riformatori<br />
326 R. STAGLIANÒ, Circo Internet, cit., p. 99<br />
327 S. PAPERT, Learn Think to Children, UCLA (University of California Los Angeles),<br />
1972, L. A., p. 64<br />
328 MIT = Massachusetts Institute of Technology di Boston<br />
329 Jean PIAGET uno dei padri della pedagogia contemporanea<br />
330 S. PAPERT, cit., p. 82<br />
331 È, nell’uso statunitense, la ‘contrazione fonica’ di tre verbi ‘Reading’ (leggere),<br />
‘Writing’ (scrivere) ‘Arithmetic’s’ (aritmetica) che stanno all’italiano “leggere, scrivere<br />
e far di conto”.<br />
332 R. STAGLIANÒ, Circo Internet, cit., p. 104<br />
154
più spinti che criticano la struttura e l’architettura della classe tradi-<br />
zionale 333 . Per abolire i blocchi psicologici si propongono architetture a<br />
‘gruppetto’, ma qualcuno propone addirittura le classi virtuali.<br />
La tecnologia si è sempre scontrata con la scuola perché non si è<br />
riusciti a far interagire la struttura di classe con la dinamicità della<br />
tecnologia comunicativa. L’insegnante deve imparare ad abbandonare<br />
il suo ruolo di “sage on the stage” 334 per assumere quello di “guide and<br />
trainer” 335 della conoscenza.<br />
L’apologia però del edutainment 336 non è l’unica risposta. Il<br />
Postman nel suo libro dal titolo inequivocabile, “The End of Educa-<br />
tion” 337 , irride a coloro che fanno leva sui PC per riformare la scuola:<br />
«Riconoscono una falsa divinità quando ne vedo una».<br />
Verso una maieutica di fine millennio<br />
«Se cinquant’anni fa, sfruttando le potenzialità, peraltro già tec-<br />
nicamente mature, del cinema, si fossero consegnate alle generazioni<br />
future interviste-lezioni filmate, di Einstein e Freud, di Husserl e Hei-<br />
degger, di Croce e Wittgenstein, si sarebbe reso un grande servizio<br />
333 Dove la comunicazione è allievi verso professore e non c’è nessuna<br />
comunicazione fra di loro<br />
334 Sage on the stage = dall’ing. saggio in cattedra<br />
335 Guide and trainer = dall’ing. guida e allenatore/istruttore<br />
336 Edutainment = neologismo inglese formato da ‘Education’ (educazione) e<br />
‘Entertainment’ (intrattenimento)<br />
337 N. POSTMAN, The End of Education, ed. Knopf 1995 N. Y.; prefazione<br />
155
all’umanità» 338 . C’è da chiedersi perché nessuno, pur potendolo fare,<br />
abbia pensato di raccogliere in modo sistematico queste preziose te-<br />
stimonianze della nostra civiltà. Tra le tante ipotesi c’è anche quella<br />
che nessuno credeva che si potesse diffondere il sapere, quello vero, al<br />
di fuori dei libri, dimenticando che duemilacinquecento anni fa, una<br />
polemica analoga e inversa era scoppiata nell’antica Grecia quando<br />
Platone e Aristotele, soppiantarono la comunicazione orale, domi-<br />
nante da Omero fino a Socrate, e imposero la scrittura, strumento con-<br />
siderato a quei tempi, autoritario, sordo e negazione del dialogo ma-<br />
ieutico.<br />
Studiando per anni il cervello e i suoi meccanismi Gardner 339 ha<br />
scoperto l’esistenza di otto diversi tipi di intelligenze, sei in più ri-<br />
spetto alle due prese in considerazione dai test standard per la valuta-<br />
zione del QI. Le nuove tecnologie sono in perfetta sintonia con queste<br />
intelligenze multiple: permettono, infatti, di gestire il materiale di stu-<br />
dio secondo punti di vista diversi, quelli suggeriti dalle diverse intelli-<br />
genze multiple.<br />
Oggi è opportuno accoppiare metodi e tecniche a distanza con<br />
quelli tradizionali. E questo per un’osservazione storica molto ele-<br />
338 R. PARASCANDOLO, «Il paradosso multimediale e l'inganno interattivo», 03-11-<br />
1995 Roma, MediaMente<br />
339 H. GARDNER, «Intelligenze multiple e nuove tecnologie», 10-04-97 Torino,<br />
MediaMente<br />
156
mentare. Duecento anni fa, quando non c’erano le scuole pubbliche,<br />
c’era il tutore che andava a casa di chi poteva permettersi di pagarlo.<br />
Quando furono introdotte le scuole pubbliche e la formazione<br />
divenne obbligatoria, poteva esserci chi riteneva che la formazione del<br />
proprio figlio in una scuola, quindi in un rapporto meno diretto che<br />
col tutore, potesse essere meno efficace. In realtà ciò che si perdeva da<br />
un parte, si guadagnava dall’altra. Analogamente, tecnologia a di-<br />
stanza, informatica, telecomunicazioni sono strumenti che possono ar-<br />
ricchire, non necessariamente arricchiscono, ma possono arricchire la<br />
formazione. Naturalmente, non esiste una ricetta per dire esattamente<br />
quando arricchiscono e quando no.<br />
Però, si può dire con sicurezza che se queste scelte non saranno<br />
fatte e anche con una certa rapidità, molte persone non avranno op-<br />
portunità formative, anche nei paesi “avanzati” come il nostro. In-<br />
somma, la scelta contraria significa lasciar fuori dalla formazione di<br />
base e soprattutto dal «re–training» 340 grandi fasce di popolazione,<br />
perché non ci sono altre possibilità per coprire questi bisogni di conti-<br />
nuo aggiornamento, di continua formazione. Sul problema dei contatti<br />
umani, la persona, cioè il docente, «è sostanzialmente insostituibile in<br />
due momenti formativi» 341 . Il primo è quello motivazionale: il docente è<br />
come uno psicologo, lo diceva anche Platone quando parlava di So-<br />
340 re-training = lett. ri-addestramento, significa fare “formazione continua”<br />
341 S. CERRI, cit.<br />
157
crate e della “maieutica”, cioè della capacità di far nascere i concetti e<br />
quindi di far imparare qualcun altro. L’altro aspetto in cui il docente è<br />
insostituibile, è la valutazione del risultato.<br />
Sicuramente l’insegnante o comunque una persona esperta è<br />
meglio di qualsiasi macchina per valutare una persona. Mentre tutte le<br />
altre componenti del percorso formativo 342 sono e saranno sempre più<br />
sostituibili, almeno in gran parte, da sistemi automatici; le altre no, la<br />
motivazione e la valutazione no.<br />
È vero che con le tecniche a distanza si rischia di isolare gli<br />
studenti; ma quanto sono già autodidatti questi studenti? «Non capita<br />
che in corsi universitari molto affollati si verifichi già un processo di<br />
autoformazione? O addirittura di autoformazione a distanza» 343 .<br />
Quindi quello che si deve ritrovare è la figura del maestro non<br />
unidirezionale, non di docente che trasmette informazioni. Ci sono già<br />
molti modi per procurarsi informazioni. Ma un insegnante che insegni<br />
a scegliere l’informazione, che possa trasmettere «modelli etici selet-<br />
tivi» e possa sviluppare, nello stesso discente, quello spirito critico e<br />
autocritico fondamentale «per galleggiare e non affogare sul mare<br />
dell’informazione» 344 . La centralità sembra tornare ad essere<br />
342 cioè la comunicazione di informazione, la verifica dell'apprendimento sotto<br />
forma di test, la possibilità di costruire oggetti o concetti complicati da concetti più<br />
semplici o oggetti complicati da oggetti più semplici, cioè la sperimentazione<br />
343 S. CERRI, cit.<br />
344 P. QUEAU, «La rivoluzione del virtuale» cit.<br />
158
dell’uomo, sebbene coadiuvato da tecnologie di alto livello tecnico. E<br />
così la «maieutica torna ad essere più importante della scrittura» 345 .<br />
345 R. STAGLIANÒ, Circo Internet, cit., p. 105<br />
159
CONSEGUENZE<br />
Nella prima e nella seconda parte di questa tesi si sono proposti<br />
i grandi cambiamenti epocali per arrivare a discutere dei rischi possi-<br />
bili che deve e dovrà affrontare un diritto civile. Nelle conseguenze si<br />
configurano aspetti rilevanti e si avanzano alcune proposte di solu-<br />
zione filosofiche, politiche e giurisprudenziali.<br />
Conseguenze parte I<br />
Da quando l’informazione è stata automatizzata ed è nata<br />
l’informatica 346 , la rivoluzione è stata esponenziale e «quasi incontrol-<br />
labile, quasi autonoma» 347 . Rivoluzione che in qualche modo ha modi-<br />
ficato il ‘centro di gravità’ dell’agire umano, dall’atomo al bit.<br />
L’informazione, il dato ha assunto crescente valore fino a diventare<br />
elemento predominante nella decisionalità politica, economica, sociale<br />
dell’uomo.<br />
La potenza del cambiamento e la grandezza delle modifiche<br />
sono stati tali da creare, in un’epoca detta scientifica, una nuova mi-<br />
tologia della tecnica. Preoccupazioni ancestrali sono divenuti mostri<br />
346 Informatica = dal fr. informatique neologismo che significa informazione<br />
automatica [Vedi Glossario]<br />
347 G. O. LONGO, cit., p. 12<br />
160
contemporanei, pensati come grandi macchine e immensi sistemi, nati<br />
dall’uomo per annientare l’uomo. I miti, le paure e le utopie sono nate,<br />
principalmente e paradossalmente dagli stessi scienziati.<br />
La rapidità di strabordamento delle alte tecnologie nel mondo<br />
civile, non ha lasciato tempo per l’adattamento, creando profondi di-<br />
vari e distinguendo il mondo in due grandi «ceti informazionali» 348 :<br />
info-ricchi e info-poveri. Il rilevante gap formativo ha messo in crisi in<br />
vecchi sistemi economici, basati sulla produzione e quindi sulla mate-<br />
ria. Nell’economia contemporanea il servizio ha soppiantato i beni<br />
primari e le informazioni hanno assunto un valore di mercato tal-<br />
mente alto, rispetto ai beni materiali, da essere il motore trainante<br />
dell’economia finanziaria internazionale 349 .<br />
Le modifiche fisiche, percettive e antropologiche<br />
dell’«infosistema terrestre» 350 hanno modificato radicalmente le scienze<br />
umane, creando crisi e rinascite delle stesse sotto la nuova ottica bina-<br />
ria. Anche lo spirito critico, formato per la società in secoli di abitudini<br />
culturali e per l’individuo in anni di studio, viene messo in discus-<br />
sione da «grovigli ipertestuali e maree iperinformative di dati» 351 ;<br />
l’uomo si trova gettato di fronte a grandezze informazionali impensa-<br />
348 QUEAU Philippe, «Diritti d’autore nell’era digitale», cit.<br />
349 Il 98 % degli scambi finanziari internazionali è composto da informazione<br />
350 F. COLOMBO, Confucio nel computer, cit., p. 94<br />
351 R. STAGLIANÒ, Circo Internet, cit., p. 23<br />
161
ili, più-che-babeliche, dove la materia tende a sparire e la grandezza<br />
del ‘movimento tecnologico’ ad aumentare.<br />
Nasce quella sensazione di perdita dell’orizzonte, che incute<br />
paure o speranza, ma appare pur sempre sublime. Il virtuale, la co-<br />
municazione globale diviene «tanto un nuovo strumento di intelligi-<br />
bilità quanto uno strumento di alienazione dell'uomo» 352 .<br />
Sociologia<br />
Conseguenze parte II<br />
Tutto ciò che avviene nel computer non è simulazione. Quindi è<br />
una nuova frontiera, perché ci porta a delle avventure che si vivono<br />
soltanto con la mente, ma che non sono simulate. Questo non potrà<br />
che portare conseguenze senza precedenti, alcune delle quali ancora<br />
non conosciamo. Noi non sappiamo ancora come si modificherà il no-<br />
stro comportamento, il nostro modo di pensare, vivendo fuori da quel<br />
particolare tipo di gravità che è la presenza, «la nostra interezza fi-<br />
sica» 353 . Viaggia solo la nostra mente. È la mente che è portatrice della<br />
nostra identità, oppure essa dipende anche dal come appariamo, dal<br />
come ci presentiamo, dal come siamo davvero fisicamente, in natura?<br />
352 QUEAU Philippe, «Diritti d’autore nell’era digitale», cit.<br />
353 F. COLOMBO, Confucio nel computer, cit., p. 114<br />
162
La comunicazione globale è vista come una ‘negativa’ aliena-<br />
zione nell’irrealtà, anche se in realtà sarebbe meglio definirla come<br />
una realtà non locale, oppure come un ‘positiva’ nuova frontiera. A<br />
definirla nuova frontiera sono stati gli statunitensi che hanno riutiliz-<br />
zato un termine forte nel loro paese: frontiera era il ‘glorioso’ far west,<br />
frontiera stellare era lo spazio e frontiera digitale è quella che si sono<br />
spinti a ‘conquistare’. La nuova era digitale, con le sue frontiere, del<br />
resto può bene essere considerata un far west senza leggi dove domina<br />
il più forte. E fino ad ora i fatti lo confermano: con le grandi battaglie<br />
tra le società più importanti del mondo nel settore 354 , ma anche i sin-<br />
goli cibernauti con i loro duelli verbali 355 .<br />
Il rischio di alienazione all’interno delle tecnologie comunica-<br />
tive globali è fortissimo, con la possibilità di perdere identità locali-<br />
stica, trovandosi proiettati in un mondo inesistente, ma giusto. Chi ha<br />
in mano le armi del secolo, cioè le conoscenze informatiche adeguate,<br />
combatte i grandi sistemi e le grandi Corporations con tattiche di<br />
guerriglia digitale diversa. C’è chi ‘attacca’ i sistemi informatici pene-<br />
trandoci dentro, solo per dimostrare a sé stesso e agli altri di saperlo<br />
fare o chi ruba informazioni e le vende a caro prezzo facendo del vero<br />
pirataggio criminale o le regala solo per infliggere duri colpi finanziari<br />
alle grandi società. C’è chi poi ‘attacca e intacca’ i sistemi portandoli al<br />
354 Netscape, Microsoft [vedi Glossario].<br />
355 In gergo flames<br />
163
collasso. Ma queste azioni possono essere fatte solo da rivoluzionari<br />
preparati. Tra la gente comune si usano nuovi modi di fare con la rete,<br />
come i Lurkers che, non arrivando agli estremismi anti-tecnologici dei<br />
neo-luddisti, si oppongono all’alienazione delle reti guardando senza<br />
essere visti. Lasciandosi così la possibilità di dialogare con media oriz-<br />
zontali (pull) 356 .<br />
Un forte rischio, attraverso le reti, per tutte le nazioni occiden-<br />
tali non anglofone, è la perdita di identità locali e linguistiche a favore<br />
della cultura forte ed invasiva degli statunitensi; senza interventi di-<br />
retti, anche linguistici, da parte dei governi, il pericolo è costante.<br />
Etica planetaria<br />
Noi dobbiamo avere dei valori che non siano ‘standard’, ma che<br />
siano la media di qualche cosa. Dobbiamo avere delle regole che ci<br />
permettano di considerare tutti gli uomini come appartenenti ad una<br />
razza umana, senza dimenticare le differenze.<br />
Dobbiamo costituire una «etica planetaria» 357 che punti ad af-<br />
frontare i problemi dell’uomo nel suo complesso, senza vincoli nazio-<br />
nali, perché con le tecnologie comunicative globali questi vincoli sono<br />
già stati abbattuti.<br />
356 [vedi Glossario]<br />
357 BODEI Remo, «La comunicazione nel V secolo dell’era globale», cit.<br />
164
Questo è un compito che sarà difficilissimo. L'incontro tra le<br />
culture, che sembra già compiuto attraverso questi mezzi di comuni-<br />
cazione di massa, in realtà è soltanto all'inizio. Noi siamo al «V° secolo<br />
dell'era globale» 358 , cioè, da quando Cristoforo Colombo ha unito, in-<br />
volontariamente, il vecchio e il nuovo mondo. Ci stiamo ‘globaliz-<br />
zando’, quindi, da soli cinque secoli. Ma la storia dell’homo sapiens,<br />
come dicono gli studiosi della materia, è una storia che ha, per quanto<br />
riguarda la nostra specie, dai 150.000 ai 180.000 anni; cinque secoli,<br />
dunque, rispetto a questa catena evolutiva, se non vogliamo conside-<br />
rare gli antenati, il cosiddetto ‘homo habilis’, sono pochissimi. L’etica<br />
planetaria che va costituendosi riguarda il rispetto del globo a benefi-<br />
cio mondiale, secondo l’analisi dello sviluppo sostenibile. Del resto<br />
gran parte della decisionalità si sviluppa oggi sul concetto sostenibilità<br />
dell’evoluzione umana, senza intaccare in maniera definitiva ‘possibi-<br />
lità’ ecologiche o sociali.<br />
Politica<br />
Esistono rischi reali e attuali sulla manipolazione<br />
dell’informazione grazie alle tecnologie digitali. Benché la comunica-<br />
zione globale favorisca da una parte la veridicità, dall’altra la nega<br />
perché permette la diffusione di false notizie.<br />
358 Ibidem<br />
165
Sulle potenziali manipolazioni dell’informazione futura na-<br />
scono paure o addirittura fobie, che vedono la nascita di un Grande<br />
Fratello. Seppure non politico, come lo aveva previsto Orwell, ma<br />
probabilmente economico e finanziario. A contrastare la credulità po-<br />
polare sulla purezza delle informazioni, ma nato anche per andare<br />
contro il diritto di proprietà intellettuale, c’è il co-individuo Luther<br />
Blissett che con le sue ‘operazioni scoop’ ridicolizza il sistema infor-<br />
mativo massmediatico.<br />
L’informazione distorta ha fatto nascere grandi speranze nelle<br />
politiche del futuro. Ha spinto a credere nella tecnologia fine a sé<br />
stessa, come mezzo per una democratizzazione della società. Dimenti-<br />
cando la centralità dell’uomo nell’opera democratizzatrice, in quanto<br />
elemento mediativo e non mediatico, della politica e soprattutto della<br />
politica democratica nella quale è la rappresentanza a fornire la sicu-<br />
rezza nella giusta scelta e allo stesso tempo ad allontanare i pericoli<br />
plebiscitari, già accennati negli anni passati dai push-media.<br />
Economia<br />
Le battaglie operaie nell’ultimo secolo e mezzo, hanno com-<br />
battuto le forme alienanti del lavoro; come con le tecnologie di seriali 359 ,<br />
nelle quali l’alienazione del lavoro era essenzialmente «alienazione<br />
359 Come la catena di montaggio industriale<br />
166
nella ripetizione» 360 . Con la sempre maggiore automazione meccanica<br />
e soprattutto con quella informazionale, la diminuzione dei compiti e<br />
delle responsabilità ha spostato la causa della alienazione. Non più<br />
centrata sul lavoro, sempre meno presente e più specialistico, ma sulla<br />
«delega tecnologica» 361 , cioè un’alienazione dell’uomo negli automati-<br />
smi. Inoltre aumentando i divari formativi e informazionali e creando<br />
sempre più preparate e meglio retribuite classi di «knowledge wor-<br />
kers» 362 , il divario tra le classi dell’era digitale non ha fatto che au-<br />
mentare, mutando forma dall’alienazione nel lavoro a quella nel non-<br />
lavoro eliminando il diritto alla realizzazione dell’uomo nel lavoro.<br />
Sapere<br />
Tra i diritti che vengono infranti dalle nuove tecnologie, quelli<br />
riguardanti l’infanzia sono i meno osservati. Si parla spesso di rischi<br />
nella comunicazione, a causa della pedofilia o della pornografia. Sono<br />
rischi reali, presenti nella vita comune, ma accentuati dalla facilità con<br />
cui in rete si può contattare una persona. La facilità di contatto favori-<br />
sce la possibilità di adescamento da parte di pedofili o da parte di per-<br />
sone pericolose. Dall’altra parte anche i rischi per un minore di con-<br />
tattare la pornografia sono molto facili, anzi facilissimi visto che l’70%<br />
360 Ibidem<br />
361 QUEAU Philippe, «Diritti d’autore nell’era digitale», cit.<br />
362 Cioè gli Information technology knowledge workers (Lavoratori con esperienza<br />
nella tecnologia dell’informazione)<br />
167
delle immagini che circola in rete è a carattere erotico. Questi rischi si<br />
affrontano in diversi modi. Sarebbe insensato impedire l’uso della rete<br />
ad un minore, vista la diffusione attuale, la scelta migliore dev’essere<br />
quella dell’educazione, anche se non è facile, visto che solitamente<br />
sono i “piccoli” ad avere un miglior rapporto con le tecnologie rispetto<br />
a “grandi”.<br />
Le soluzioni politiche sono state disastrose quando si è cercato<br />
di vietare la pubblicazione di siti porno si sono rivoltate le associazioni<br />
per i diritti di libertà di stampa, perché diversi governi avevano censu-<br />
rato anche newsgroup e siti che contenevano la parola ‘sesso’, seppure<br />
non fossero a contenuto erotico e/o pornografico.<br />
Le soluzioni tecniche 363 finora proposte non risolvono il pro-<br />
blema vista anche la semplicità di elusione dei sistemi protettivi e<br />
tanto meno si può fare con le chat 364 . L’ingresso di insegnamenti etici e<br />
tecnici nelle scuole sarebbe forse una buona soluzione, invece di sup-<br />
porre che meno di questi problemi si parli con i minori meno rischi ci<br />
sono; purtroppo ancora i governi non prendono in considerazione<br />
questa possibilità, puntando tutto sull’aggiornamento tecnico e tec-<br />
nologico delle scuole e niente sulla formazione morale per non af-<br />
frontare indifesi il mondo della rete.<br />
363 I cyber controllori cioè i software che non permettono, a chi non ha la<br />
password di vedere un sito vietato.<br />
364 Software che permettono di chattare (chiacchierare) con persone sconosciute in<br />
rete.<br />
168
Problemi giurisprudenziali<br />
(Controllo globale)<br />
La paura del Grande Fratello è la paura ancestrale della non li-<br />
bertà di pensiero. Paura molto più forte in un mondo occidentale dove<br />
molti limiti sono stati superati. Il Grande Fratello tecnologico sembra<br />
identificarsi con le grandi banche dati delle multinazionali economi-<br />
che che raccolgono dati personali, gusti, hobby, studi fatti, ecc., di<br />
molte persone in tutto il mondo. Come si può fare per intervenire? Sa-<br />
rebbe forse una battaglia improba evitare che i dati circolassero, anche<br />
perché molti continuano a fornire i loro dati a società di raccolta dati<br />
senza nemmeno rendersene conto e senza conoscere le conseguenze<br />
possibili. La soluzione più realistica potrebbe essere quella di controlli<br />
incrociati, sulle grandi banche dati da parte di tutori governativi e as-<br />
sociazioni dei consumatori. Ormai i dati circolano, il controllo deve<br />
evitare che vengano usati in maniera impropria, come già avviene per<br />
la pubblicità subdola (perché mirata e personalizzata) dei banner nel<br />
web. La Comunità Europea sta già iniziando a creare un comitato go-<br />
vernativo per la predisposizione di testi legislativi che regolino il set-<br />
tore informativo e informatico, ma le soluzioni più efficaci potranno<br />
essere prese solo a livello globale, con commissione internazionali.<br />
169
(Privacy)<br />
Quando i fatti personali erano alla mercé della memoria i pro-<br />
blemi della privacy non esistevano. Con le tecnologie digitali e la pos-<br />
sibilità di comunicazione globale si è posseduto avuto il mezzo per<br />
mantenere e diffondere una informazione, anche privata. La limita-<br />
zione temporale di un fatto privato, data dalla «memoria della gente»,<br />
o alla deperibilità di memorie cartacee o magnetiche, lasciava una<br />
buona occasione all’oblio. Si poteva dimenticare, mentre oggi questo<br />
diventa più difficile. La facilità di duplicazione e di divulgazione di<br />
una informazione rendono quasi a-temporale, limando il passato e<br />
appiattendolo all’ora, in una sorta di presente continuo. La tecnologia<br />
dell’informazione modifica il significato del termine ‘memoria’, che<br />
oggi designa soprattutto una memoria esterna, estroflessa, misurabile<br />
con l’unità di misura del digitale: il byte. L’archiviazione tende a dila-<br />
gare, poiché qualunque dato potrebbe essere usato in futuro. Se<br />
l’informazione riguarda la sfera privata di un individuo, si può creare<br />
così un trauma molto forte.<br />
Questa schiacciante mole di dati memorizzati e disponibili, co-<br />
stituisce una minaccia per ogni individuo. L’unica alternativa sembra<br />
essere «l’oblio» 365 . Non un oblio casuale, ma un oblio volontario, se-<br />
lettivo, basato sul desiderio di fare spazio a nuove e più importanti<br />
365 G. O. LONGO, cit., p. 105<br />
170
conoscenze. L’oblio consentirebbe di disporre i ricordi in una dimen-<br />
sione cronologica: grazie al chiaroscuro prodotto dalla maggiore o mi-<br />
nore vividezza dei ricordi si crea un «senso della prospettiva sto-<br />
rica» 366 , che invece viene annullata se i ricordi sono presenti tutti con<br />
uguale forza in un «eterno presente, un […] eterno attuale» 367 .<br />
(Limiti nazionali)<br />
La giurisprudenza attuale è limitata ai confini nazionali. I con-<br />
flitti della rete riguardano la civilistica o la penalistica, ma i confini na-<br />
zionali della giurisprudenza si scontrano con casi internazionali. Ben-<br />
ché la penalistica italiana, come quella di altre nazioni civili occiden-<br />
tali, preveda pene per colpe commesse anche al di fuori dei confini<br />
nazionali, diventa più difficile sbrogliare la questione morale. Esem-<br />
pio: in alcuni paesi del mondo l’abito di acquistare una giovanissima<br />
ragazza come moglie non è considerato illegale, mentre nei paesi occi-<br />
dentali è ritenuto quanto meno immorale; come deve comportarsi uno<br />
stato occidentale se l’acquisto avviene via rete? Problemi analoghi, in<br />
cui vengono a cozzare morali e legislazioni diverse, sono davvero<br />
numerosi. Il problema dell’esempio è un problema limite, ma sulle<br />
questioni del diritto d’autore o degli altri diritti di proprietà intellet-<br />
tuale lo scontro tra nazioni è aperto e duro. Non si vedono ancora pos-<br />
sibilità di soluzione e per ora a pagarne i danni sono su questo fronte<br />
366 Ibidem., p. 107<br />
367 Ibidem, p. 104<br />
171
autori o artisti. Indubbiamente i problemi giuridici extraterritoriali di-<br />
ventano, giorno dopo giorno, talmente rilevanti da costringere<br />
l’utilizzo di filosofie del diritto adeguate al nuove troncone extraterri-<br />
toriale della giurisprudenza.<br />
172
APPENDICI<br />
Appendice 1: Le reti neurali 368<br />
Le radici dell’Artificial Life 369, possono essere rinvenute negli automi di John Von<br />
Neumann e Arthur W. Burks. Nelle parole dello stesso Burks, che fu il continuatore<br />
della sua opera, Von Neumann si chiedeva:<br />
«Quale tipo di organizzazione logica è sufficiente ad un automa<br />
per riprodurre se stesso? Questa domanda non è precisa ed<br />
ammette sia una risposta banale che una interessante. Von Neumann<br />
aveva in mente il fenomeno naturale dell’autoproduzione<br />
quando la pose, ma non tentò di simulare l’autoproduzione di<br />
un sistema naturale a livello genetico e biochimico. Egli voleva<br />
astrarre dal problema naturale dell’autoproduzione la sua<br />
forma logica» 370 .<br />
Il formalismo che permise la realizzazione di un tale sistema, fu proposto da un<br />
suo collega, Stan Ulam, con il nome di Automa Cellulare. Una automa cellulare è<br />
semplicemente un sistema che può avere un numero finito di stati ed il cui stato è<br />
determinato dallo stato di altri automi che lo circondano. Il comportamento degli<br />
automi cellulari diventa interessante proprio perché formano una rete di interazioni,<br />
il cui comportamento globale, nel tempo, non è prevedibile; anche se le leggi che governano<br />
i passaggi di stato per ogni singolo automa sono semplici e ben determinate.<br />
Lo stato di ogni automa di questa rete, in ogni istante di tempo, è determinato<br />
dallo stato posseduto, nell’istante precedente, dagli automi che lo circondano. Con<br />
gli automi cellulari, Von Neumann impostò un sistema capace di autoreplicarsi e<br />
stabilì che qualunque sistema capace di fare ciò, doveva fare uso delle informazioni<br />
contenute nella sua descrizione in due modi fondamentalmente differenti: sia interpretando<br />
che non interpretando. Interpretate le informazioni dovevano tradursi in<br />
azioni da compiere per realizzare il replicante, non interpretate dovevano essere<br />
soltanto copiate, perché sarebbero state l’analoga descrizione per il replicante.<br />
Quando in seguito si scoprì la struttura e il funzionamento del DNA emerse che<br />
erano proprio i modi in cui la cellula fa uso delle informazioni contenute in esso durante<br />
i suoi processi di trascrizione e traduzione da una parte e replicazione<br />
dall’altra.<br />
La storia delle reti neurali inizia con Warren S. McCulloch e Walther Pitts 371 e poi<br />
con il perceptron 372 di Frank Rosenblatt 373. Fino agli anni ottanta l’unico filone di ricerca<br />
sulla Artificial Life è stato quello degli automi cellulari. In seguito vari settori<br />
scientifici si interessano alla Artificial Life. Proprio per unificare gli sforzi e fare il<br />
368 F. A. CAMARGO, cit.<br />
369 Artificial life = Vita Artificiale<br />
370 F. A. CAMARGO, cit., p. 4<br />
371 W. McCULLOCH & W. PITTS. A logical calculus of the ideas immanent in nervous<br />
activity, in Bulletin of Mathematical Biophysics, 1943<br />
372 [Vedi Glossario]<br />
373 F. ROSENBLATT, Two theorems of statistical separability in the perceptron. In<br />
Symposium on the Machanization of Thought Processes, 1959<br />
173
punto della situazione, nel settembre del 1987 si è tenuta a Santa Fe la prima conferenza<br />
sulla Artificial Life (considerato l’atto di nascita ufficiale di questa nuova<br />
scienza), organizzata da Chris Langton del Santa Fe Institute. Ad essa parteciparono<br />
non solo scienziati che in varia misura lavoravano sulla robotica e sulla cibernetica,<br />
ma anche filosofi, chimici e biologi. Oggi possiamo distinguere già due filoni, quello<br />
della robotica e quello delle simulazioni. Nelle simulazioni che si fanno in questo<br />
campo, si utilizzano in genere alternativamente strategie che possono essere considerate<br />
ispirate all’apprendimento in vita (tramite backpropagation 374, principalmente,<br />
ma anche con l’apprendimento competitivo); oppure all’apprendimento su base genetica,<br />
che si compie di generazione in generazione (tramite algoritmi genetici 375).<br />
Le reti hanno oggi trovato utilizzazione soprattutto nei vari campi che richiedono<br />
una percezione artificiale in qualche modo paragonabile a quella umana; oppure alla<br />
necessità di trovare collegamenti o categorizzare situazioni difficilmente definibili. I<br />
principali campi di applicazione sono infatti: visione e riconoscimento di forme grafiche;<br />
interpretazione di segnali; robotica e veicoli autonomi; riconoscimento della<br />
voce; linguaggio naturale; sistemi di supporto alle decisioni; diagnosi; previsioni;<br />
problemi di ottimazione; controllo di processi.<br />
Appendice 2: Estremismi<br />
Esistono esempi di blitzkrieg 376 in ambito elettorale tramite l’e-mail, poco costosa<br />
e molto diffusa. Ma esiste in rete la possibilità di unire estremisti pericolosi<br />
377.<br />
The Hate Page of the Week 378 dove lo studente texano Frank Xavier Placencia ha<br />
deciso di raccogliere i frammenti telematici che dimostrano come antisemitismo e<br />
razzismo siano ancora oggi pericoli per l’umanità.<br />
Il Ku Klux Klan 379 che afferma: «Noi crediamo che ognuno abbia il diritto di essere<br />
fiero della propria razza, il che significa che anche i Bianchi ne hanno diritto».<br />
La Aryan Nation 380 dice:«Noi crediamo che l’ebreo cananita sia il nemico naturale<br />
della nostra Razza Ariana (Bianca). L’ebreo è come un virus distruttivo che<br />
attacca il nostro corpo razziale per distruggere la nostra cultura e la nostra purezza.<br />
[quello che fa guardare] ad una coppia di razza mista con una smorfia di<br />
dolore sul viso e ripugnanza nelle orecchie… No, non è odio: è amore».<br />
L’Associazione Rupe Tarpea 381 rappresentante dell’estrema destra italiana dà il<br />
suo benvenuto alla pagina e propone percorsi alternativi: 1. Se sei un povero disperato<br />
che del pregiudizio antifascista, della chiusura mentale, della limitatezza<br />
intellettuale e della mediocrità fa il proprio stile di vita, allora vattene che è meglio<br />
[N.d.A. l’invito diventa un link ipertestuale che invia in una pagina dedicata<br />
all’omosessualità] visto che lo scoprire che il nemico si sta impossessando dei<br />
mezzi multimediali potrebbe esserti fatale; 2. Se invece ci odi e ci disprezzi dovresti<br />
dare un’occhiata. Per curiosità, per studiare le nostre mosse o magari per<br />
374 [Vedi Glossario]<br />
375 [Vedi Glossario]<br />
376 Blitzkrieg = guerra lampo<br />
377 R. STAGLIANÒ, Circo Internet, cit., p. 46-52<br />
378 http://www.owlnet.rice.edu/~efx/hpotw.html<br />
379 http://www.k-k-k.com/<br />
380 http://rand.nidlink.com/~aryanvic/<br />
381 http://www.atlas.co.uk/perimetro/<br />
174
lasciarci un messaggio di insulti; 3. Porte aperte, infine, ai solidali e simpatizzanti:<br />
per loro si spalancano sentieri elettronici verso Julius Evola, il “Foglio di lotta” e<br />
altri bollettini di militanza nera.<br />
Infine un sito dedicato alle barzellette sui ‘negri’, il Niger Joke Center 382 che<br />
sputa sentenze e freddure: «Sapete perché i negri puzzano? Perché così anche i<br />
ciechi li possono riconoscere» oppure «Sapete perché la California ha così tanti<br />
gay e New York così tanti negri? Perché la California ha scelto per prima…».<br />
O siti del tutto opposti come il sito del Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale<br />
383 del subcomandante Marcos per difendere i diritti del Chiapas nel Messico.<br />
O l’esempio nel 1988 in Brasile. Dopo l’assassinio del leader ecologista Chico<br />
Mendes da parte dei sicari dei proprietari terrieri disturbati dalle sue inesorabili<br />
denunce, si alzò un polverone telematico di e-mail, il tamtam mediatico raggiunse<br />
tutto il globo e la polizia fu spinta a rintracciare ed arrestare velocemente i<br />
colpevoli.<br />
Anche il messaggio di Elstin che chiedeva di opporsi al tentativo controrivoluzionario<br />
dei putschisti di Mosca (nei tre giorni a partire dal 19 agosto 1991) fu<br />
messo in circolo grazie alle massicce spedizioni di e-mail dal piccolo computer<br />
del compagno Dima Volodin. L’annuncio, intitolato sobriamente “Il decreto<br />
Eltsin” chiedeva inizialmente ai destinatari dei newsgroup cui fu inizialmente indirizzato<br />
di «ridistribuire il più ampiamente possibile il seguente messaggio nella<br />
versione russa e nella sua approssimativa traduzione inglese. Sarebbe buona cosa<br />
se raggiungesse le agenzie internazionali di stampa. Grazie. Dima» quindi seguiva<br />
il testo del provvedimento d’urgenza nel quale il Presidente della Repubblica<br />
federale russa informava che «un tentativo di colpo di stato era stato messo<br />
in atto e il presidente dell’URSS, che è il comandante in capo dell’esercito sovietico,<br />
era stato rimosso dal suo posto. Il vicepresidente, il primo ministro, il ministro<br />
della Difesa e quello degli Interni avevano formato un corpo incostituzionale,<br />
con ciò commettendo un crimine di stato. Come risultato di tale azione l’attività<br />
del legittimo esecutivo era paralizzata. In questa situazione io [N.d.A. Boris<br />
Eltsin] decreto: …» e seguivano una serie di contromisure di mobilitazione della<br />
cittadinanza.<br />
Un caso più recente è del 1996 in Jugoslavia, per l’arbitraria e odiosa chiusura<br />
da parte del governo di Slobodan Milosevic di Radio B92. Dopo pochi giorni la<br />
radio fu riaperta in Internet con un pubblico molto più grande.<br />
Il sito dei Tupac Amaru (http://burn.ucsd.edu/~ats/mrta.html) trasmetteva,<br />
durante tutta la fase di sequestro dell’ambasciata giapponese in Perù, l’attività<br />
dei guerriglieri all’interno dell’ambasciata; il giorno dopo l’uccisione dei guerriglieri<br />
la pagina veniva trasformata in una lapide telematica.<br />
Appendice 3: Smiley<br />
Gli smiley (faccine) o emoticon, sono sequenze di caratteri introdotte nel<br />
corso degli anni dagli utenti di posta elettronica per esprimere emozioni, opinioni e<br />
stati d’animo nel contesto dei loro messaggi. Per interpretare uno smiley bisogna<br />
piegare la testa a sinistra e giocare un po’ di fantasia per riconoscere un volto stilizzato.<br />
Per inventarne di nuovi il procedimento è più o meno lo stesso.<br />
382 http://www.whitepower.com/jokes/<br />
383 http://www.ezln.org/<br />
175
Smiley elementari<br />
:-) Smiley base, usato per sottolineare un’affermazione scherzosa.<br />
;-) Smiley ammiccante. L’utente fa l’occhiolino per sottolineare l’intenzione scher-<br />
zosa di un’affermazione sarcastica.<br />
:-( Smiley triste. L’utente non ha gradito l’ultima affermazione o è indispettito o de-<br />
presso per qualche motivo.<br />
:-> L’utente ha appena affermato qualcosa di realmente sarcastico.<br />
:-| Sorriso sardonico.<br />
Variazioni sul tema<br />
:-|| L’utente è arrabbiato.<br />
:/) L’utente non è divertito.<br />
:D L’utente ride.<br />
:O L’utente urla.<br />
:[ L’utente è depresso.<br />
;( L’utente piange.<br />
:’( L’utente piange.<br />
:’-) L’utente piange di gioia.<br />
!-( L’utente ha un occhio nero.<br />
#-) L’utente ha folleggiato per tutta la<br />
notte.<br />
$-) L’utente ha vinto un premio alla<br />
lotteria.<br />
%*} L’utente è ubriaco.<br />
%’) L’utente è ubriaco fradicio.<br />
%+{ L’utente ha fatto a botte (e ha<br />
perso).<br />
%-(I) L’utente ride rumorosamente.<br />
%-) L’utente è strabico.<br />
%-) L’utente sta fissando uno schermo<br />
verde da molte ore.<br />
%-6 L’utente è fuori di testa.<br />
%- L’utente sta morendo dal ridere.<br />
%-\ L’utente è indeciso o in attesa.<br />
&-| L’utente è sull’orlo delle lacrime.<br />
&.(.. L’utente sta piangendo.<br />
&:-) L’utente ha i capelli ricci.<br />
(-) L’utente ha i capelli lunghi (e deve<br />
tagliarli).<br />
{:-) L’utente ha la scriminatura cen-<br />
trale.<br />
{(:-) L’utente porta il parrucchino.<br />
}:-) Utente felice (con parrucchino<br />
sollevato per un colpo di vento)<br />
}:-( Utente triste perché un colpo di<br />
vento gli ha sollevato il parruc-<br />
chino.<br />
‘-) L’utente sta ammiccando.<br />
‘:-) L’utente si è rasato per errore un<br />
sopracciglio (il destro).<br />
,:-) L’utente si è rasato per errore un<br />
sopracciglio (il sinistro).<br />
(-: L’utente è australiano.<br />
(-: L’utente è mancino.<br />
B:-) L’utente porta occhiali da sole<br />
sulla fronte.<br />
:>) L’utente ha il nasone.<br />
:^) L’utente ha il naso rotto.<br />
(:-$ L’utente è malato.<br />
(:-& L’utente è arrabbiato.<br />
(:-( L’utente è indispettito.<br />
(:-O L’utente è sorpreso.<br />
(:-* L’utente manda un bacio.<br />
(:I L’utente è calvo.<br />
) Sorriso.<br />
*
:-x Bacioni!<br />
:-{ L’utente ha i baffi.<br />
:-{) L’utente ha i baffi.<br />
:^{)> L’utente ha barba e baffi.<br />
:-{} L’utente ha il rossetto.<br />
:-| L’utente ha trascorso una giornata<br />
come le altre.<br />
cercatori (ognuno ha un proprio identificativo di posta elettronica). Nasce anche la<br />
prima mailing list non solo lavorativa: SF lovers.<br />
Anni 70<br />
I calcolatori, sia pure con sistemi operativi diversi, per comunicare devono parlare<br />
uno stesso linguaggio: quello che si basa sul packet-switching. Questo linguaggio<br />
raggiunge la piena maturità solo nel 1982 grazie a Vinton Cerf e Bob Khan e alla definizione<br />
del TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol).<br />
Il Transmission Control Protocol spezzetta i messaggi in diversi pacchetti e li riassembla<br />
ordinatamente una volta arrivati a destinazione. L’Internet Protocol ha invece<br />
la responsabilità dell’indirizzamento delle singole porzioni di dati nella rete. Nel ‘73<br />
nasce anche il protocollo per il trasferimento dei dati: FTP (File Transfer Protocol).<br />
Questo protocollo inizia ad essere utilizzato per l’invio di semplici files di testo con<br />
messaggi personali, quella che sarà la posta elettronica. La quantità di files inviati<br />
diviene grandissima e nel 1977 nasce la necessità di costituire un protocollo esclusivamente<br />
per la posta elettronica (e-mail). Nel 79 aumenta l’uso civile della rete, nascono<br />
infatti Usenet (è la prima zona della rete che raccoglie i newsgroup) ed i primi<br />
MUD (Multi User Dungeon, i popolarissimi giochi di ruolo elettronici con più utenti<br />
simultanei.<br />
Anni 80<br />
Nascono la popolare rete universitaria BitNet; la francese Minitel; la rete Fidonet<br />
(una rete mondiale di personal collegati via modem, usata per le banche dati, le BBS,<br />
che assieme a BitNet e altri network costituiscono Outernet, parallela alla cosiddetta<br />
Core Internet). L’originaria vocazione militare di Arpanet viene raccolta nel 1983<br />
dalla rete militare Milnet.<br />
Vengono formulati in questi anni i primi postulati dell’Era Digitale:<br />
La legge di Moore (da Gordon Moore, fondatore della Intel) sostiene che la potenza<br />
di calcolo e la capacità dei computer raddoppia ogni diciotto mesi.<br />
La legge di Metcalfe (da Bob Metcalfe, l’inventore del protocollo Ethernet per la<br />
comunicazione locale tra computer) dice che il valore di una rete è all’incirca proporzionale<br />
al quadrato del numero degli utilizzatori.<br />
Il 1984 è un anno memorabile. Nasce il Macintosh della Apple, il primo personal<br />
computer ad interfaccia grafica: una vera e propria rivoluzione. Lo scrittore William<br />
Gibson dà alle stampe Neuromante (Neuromancer) da cui è stato tratto il termine<br />
cyberspace. La National Science Foundation capisce l’importanza della rete e mette a<br />
disposizione con un atto storico numerosi fondi e mezzi per le infrastrutture e per<br />
ricerche avanzate sull’utilizzo della rete.<br />
La NsfNet (1986) che nasce dalla National Science Foundation, cioè il settore dedicato<br />
al network, collega computer dell’ultima generazione attraverso una dorsale<br />
(backbone) ad alta velocità.<br />
Nel 1988 ci sono le prime prove generali di terrorismo telematico: il «virus di<br />
Morris», diffuso in rete dal cracker Robert T. Morris, colpisce circa 6000 PC sui 60000<br />
collegati (1 su 10).<br />
Molte reti, come FidoNet, convergono in Internet. Nel 1989 muore ufficialmente<br />
Arpanet, ma ormai dilaga il TCP/IP ed anche l’Italia è collegata a NsfNet.<br />
Anni 90<br />
Lo statuto di cittadino elettronico prevede diritti e doveri: negli USA nasce la EFF<br />
(Electronic Frontier Foundation), che si occupa di cyber-right, cioè di giurisprudenza<br />
sulla rete. Di pari passo aumenta il caos in rete. Spuntano software per la ricerca di<br />
179
informazione: Archie, Wais (Wide Area Information Server). Nascono Gopher, primo<br />
tentativo di razionalizzare l’architettura dell’informazione e Pgp (Pretty Good Privacy),<br />
per garantire la sicurezza dei messaggi scambiati.<br />
Internet diventa di massa nel 1993. Nasce il primo browser Mosaic e come afferma<br />
Economist «a Internet spuntano le ali multimediali». Il WWW è l’architettura<br />
ipertestuale/ipermediale della rete concepita al CERN di Ginevra dall’équipe guidata<br />
da Tim Berners-Lee che vi lavora dal 1989. Esplode il traffico (+300%). «Ora anche<br />
un analfabeta informatico può diventare un cybernauta».<br />
Il 9 agosto del 1995 alla prima quotazione a Wall Street, la Netscape di Marc Andreessen<br />
realizza un risultato da record, quasi come quello della Apple nel 1984.<br />
Il 1996 è definito anno III p. M. (post Mosaic).<br />
Si sviluppano VRML (Virtual Reality Modelling Language) e Java (che svolge operazioni<br />
grazie a piccoli programmi chiamati applets) della Sun Microsystem. In questi<br />
anni viene inventato il Network Computer, strumento da $500 dedicato completamente<br />
alla navigazione, che però non ha ancora avuto il successo aspettato, a causa<br />
dei costi telefonici. Nel 1997 in rete si utilizza WebPhone, un sistema per la telefonia<br />
via rete e WebTV; le grandi multinazionali della telefonia e della televisioni entrano<br />
in crisi, iniziano le grandi fusioni internazionali.<br />
Gli indirizzi di dominio per il Web, risultano essere limitati, a causa di una previsione<br />
errata nella progettazione. Inoltre il vecchio Web ha grossi deficit nella sicurezza.<br />
Si progetta così il web 2 (www2), non per l’utilizzazione privata, ma per<br />
grandi banche e grandi sistemi gestionali. La necessita del Web 2 è dovuta anche al<br />
diffondersi in rete dell’e-commerce, il sistema di vendita elettronica, che catalizza la<br />
discussione nell’ultimo anno.<br />
Alla fine del millennio il problema più grande dei grandi sistemi informatici collegati<br />
fra di loro sembra essere un ‘errore’ di programmazione fatto sulla numerazione<br />
delle date. Quando si è iniziata la programmazione il problema principale era<br />
risparmiare spazio. Per questo la data è stata composta di sei cifre due per il giorno,<br />
due per il mese, ma due anche per l’anno. Le date servivano principalmente a ordinare<br />
cronologicamente le operazioni fatte nei grandi data base (banche dati) e venivano<br />
sistemate al contrario (anno/mese/giorno) per costituire una successione numerale<br />
quantitativa, più facilmente riconoscibile. Es. 11 novembre 1996 e 31 settembre<br />
1995; se utilizzo sei cifre al contrario risulteranno rispettivamente 961111 e<br />
950931; messi in ordine di quantità crescente la data più recente risulterà essere la<br />
più grande. Ma se prendo il primo gennaio del 2000 (000101) e cerco di ordinarlo,<br />
questo risulterà un numero più piccolo di tutti e verrà quindi messo per ultimo. Nei<br />
calcoli per differenza dal 31 dicembre del 1999 al primo gennaio del 2000 risulteranno<br />
essere passati quasi 100 anni, creando così problemi a tutto il sistema. Questo<br />
è stato chiamato il virus del millennio o “millennium bug”, che è la grande preoccupazione,<br />
ma anche il grande business, di fine millennio.<br />
180
GLOSSARIO<br />
Agenti intelligenti: (Intelligent agents o smart agents)<br />
Alfanumerico: insieme dei caratteri alfabetici e numerici.<br />
Algoritmi Genetici: Gli algoritmi genetici, in base ad un criterio determinato, portano<br />
alla selezione di algoritmi che danno i risultati migliori ed alla ricombinazione<br />
casuale di alcune loro porzioni e/o alla mutazione di alcune loro parti. In<br />
genere si parte con un certa popolazione di automi che hanno leggere differenze<br />
tra loro e si fanno agire in un ambiente per un certo numero di cicli. In seguito<br />
quelli che si saranno comportati meglio avranno la possibilità di riprodursi. Cioè<br />
si prenderà, ad esempio, il 20% della popolazione che si è comportato nel modo<br />
migliore e da questi, con mutazioni casuali e ricombinazioni, si otterrà anche il<br />
restante 80% di automi; con questa nuova popolazione si farà un’altra sessione di<br />
cicli, al termine dei quali, si ripeterà lo stesso procedimento. All’interno di questo<br />
schema generale, le effettive realizzazioni degli algoritmi possono essere molto<br />
diverse: da programmi in vari linguaggi, a valori di connessioni di reti neurali.<br />
Anonymous FTP: (File Transfer Protocol anonimo) vedi FTP.<br />
Applicazione: qualsiasi software o programma che serva a creare documenti, files,<br />
ecc.<br />
Arcades: sono dei luoghi di incontro multimediali pubblici sponsorizzati dai comuni,<br />
per chi vuole scoprire le reti.<br />
Archie: software inventato nei primi anni ‘90 da Peter Deutsch, Alan Emtage e Bill<br />
Heelan, che serve a trovare in rete il file che si vuole.<br />
ARPA: (Advanced Research Projects Agency) nasce negli USA per merito del Ministero<br />
della Difesa in risposta alle evoluzioni tecnologiche russe; nel 1969 nasce Arpanet,<br />
l’embrione della rete, che serve per salvaguardare i centri nevralgici comunicativi<br />
della nazione in caso di bombardamento.<br />
Arpanet: [vedi Appendice 4 – La storia della rete]<br />
Array: vedi Matrice<br />
Artificial Life = Vita Artificiale<br />
ASCII: (American Standard Code For Information Interchange) codice americano standard<br />
per lo scambio dei dati fra i computer.<br />
Backpropagation: famosa regola dell’error backpropagation, proposta nel 1986 da<br />
Rumelhart, Hinton e William, consiste nella propagazione dell’errore a ritroso.<br />
Vengono prima modificati i coefficienti delle connessioni tra il penultimo e<br />
l’ultimo strato e poi si risale, di strato in strato, fino a modificare quelli delle connessioni<br />
tra il primo e il secondo strato.<br />
Banda, larghezza di: (bandwidth) capacità del cavo in fibra ottica o altro, per la trasmissione<br />
dei dati; generalmente espressa in bits per secondo (bps).<br />
Banner: distintivo o titolo a tutta pagina di un giornale, nella rete identifica il riquadro<br />
promozionale che campeggia sulla parte superiore della pagina, funzionando<br />
anche da link verso il sito dell’azienda che pubblicizza il prodotto.<br />
Baud: (in onore di Émile Bautod, un pioniere francese delle telecomunicazioni) è<br />
l’unità di misura alla quale un modem trasmette i dati, ormai però si tende a<br />
parlare di “bits per secondo” (bps).<br />
BBS: (Bulletin Board System) club on-line, dove gruppi di persone si riuniscono per<br />
discutere sullo stesso argomento, oggi perlopiù sostituiti dai newsgroup.<br />
Beta: è il prototipo di un programma, serve per scoprire gli eventuali errori o bug<br />
(bachi) del software.<br />
Bit: (Binary Digit = numero binario) il «DNA dell’informazione» secondo Nicholas<br />
Negroponte. Si tratta di unità elementari del linguaggio binario (0 e 1); digitalizzare<br />
le informazioni significa ridurre in bits i dati.<br />
181
BitNet: (Because It’s Time Network) è uno dei primi network nato per iniziativa di alcuni<br />
accademici italiani<br />
Block-system: sistema segnaletico, assai sofisticato, con torri di controllo, che dirigono<br />
il traffico ferroviario<br />
BOOLE, George: (Lincoln 1815 – Cork 1864) matematico irlandese che riuscì nella<br />
metà dell’800 ad applicare le regole dell’algebra alla logica inventando la logica<br />
algebrica, o Algebra booleana [vedi].<br />
Booleana, Algebra: detta anche logica algebrica perché verso la metà dell’800 il matematico<br />
irlandese George Boole, riuscì ad applicare le regole dell’algebra alla logica,<br />
in suo onore venne chiamata Algebra di Boole o booleana. Questa algebra<br />
viene usata per la progettazione dei circuiti logici; infatti la teoria delle commutazione,<br />
cioè dei circuiti logici, è basata su quest’algebra. Fondamentalmente è basata<br />
su tre proposizioni vere e false, quindi su tre termini logici: AND, OR e NOT.<br />
Booleano: Sistema logico per la ricerca dell’algebra booleana [vedi Boole, Algebra di],<br />
che utilizza le espressioni logiche AND, OR, NOT. Esempio: se si fosse interessati<br />
alla filosofia digitale, bisognerebbe stringere il campo solo su quel settore, allora<br />
nella casella di testo della ricerca si dovrebbe scrivere filosofia AND digitale, che<br />
significa «cerca tutti i siti dove siano presenti assieme le parole filosofia e digitale».<br />
Ma se volessi cercare siti di filosofia che non parlano del digitale, dovrei<br />
utilizzare l’espressione booleana NOT: filosofia NOT digitale, che significa «cerca<br />
tutti i siti dove sia presente la parola filosofia ma non sia presente la parola digitale».<br />
Infine se volessi allargare il campo di ricerca dovrei scrivere: filosofia OR<br />
digitale, che significa «cerca tutti i siti dove sia presente anche solo la parola filosofia,<br />
solo parola digitale oppure entrambe». In realtà esistono altre espressioni<br />
derivanti dall’algebra booleana.<br />
Bounce: (rimbalzo) quando una e-mail torna al mittente perché l’indirizzo del destinatario<br />
non è corretto o per altri problemi.<br />
Bps: (Bits per secondo) unità di misura per la trasmissione di dati.<br />
Browser: (sfogliatore o brucatore) è il programma che consente di navigare sul<br />
World Wide Web<br />
BUCKMINSTER FULLER, Richard: (Milton Massachusetts 1913-1993) divenne<br />
grande per l’invenzione della «cupola geodesica» (una sfera composta da tetraedi,<br />
forma architettonica versatile, mobile economica e resistente) e i concetti<br />
di «sinergia» (l’unione rappresenta più della somma delle parti) e di «effimerizzazione»<br />
(la tendenza ad ottenere rendimenti crescenti con sempre minori investimenti<br />
di energia)<br />
Bug: (bachi) errori dei programmi. «Millennium Bug» errore nella numerazione dataria<br />
a 6 cifre, nel passaggio al 2000.<br />
Byte: unità di misura dell’informazione, equivale ad un carattere (es. A = 1 byte) ed<br />
è formato da 8 bits (es. 1 byte = 10011100).<br />
Cablare: (dal fr. câble) lett. cavo, quindi l’azione in it. significa fornire una struttura<br />
dei cavi, in particolare cavi di tipo ottico, per la trasmissione per cablogramma<br />
ottico.<br />
Cd-rom: (Compact Disk - read only memory = CD che si può solo leggere) contiene<br />
circa 600 Mb.<br />
Chat: (chiacchiera), attraverso software dedicati alle chat (come IRC o MIRC) si può<br />
dialogare in rete in tempo reale.<br />
Client: (cliente) è il programma presso il computer locale che serve da interfaccia per<br />
comunicare con il server, computer remoto.<br />
Codice sorgente: È il codice che permette di lavorare al livello del linguaggio di programmazione,<br />
che solitamente è protetto e permette anche di creare nuovi programmi<br />
dallo stesso software sorgente<br />
Computer science: (la scienza del computer) locuzione usata dagli anglosassoni per<br />
indicare l’informatica [vedi].<br />
Comunità virtuali: sono costituite da gruppi di persone che condividono specifici<br />
interessi e che ne discutono in rete. Reale è la gente, virtuale è il luogo d’incontro.<br />
182
Cookies: lett. biscotti, sono dei piccoli file di testo che vengono inseriti all’interno del<br />
computer quando si visita un sito, che permettono ai possessori di sito di riconoscere<br />
il visitatore [vedi anche cap. Cookies].<br />
Crackdown: (crollo, collasso) avviene in un sistema informatico complesso quando si<br />
è in presenza di un virus oppure per l’intrusione di un hacker.<br />
Cracker: (da to crack = rompere) colui che cerca il collasso della rete anche tramite<br />
virus da lui stesso inventati.<br />
Criptazione: vedi crittazione<br />
Crittazione: è il metodo di codifica dei dati che impedisce intrusioni illecite. La tecnica<br />
più nota è RSA, l’applicazione che ha avuto maggior successo è Pretty Good<br />
Privacy di Philip Zimmerman. Ciò nonostante esistono sempre gli hackers che riescono<br />
a violarle.<br />
Crittografico: vedi crittazione<br />
Cuseeme: è la contrazione di «You can see me, I can see you» (Tu puoi vedere me ed io<br />
posso vedere te); è in pratica un sistema che permette la comunicazione visiva e sonora<br />
tramite la rete<br />
Cyberpunk: è il nuovo ribelle della frontiera elettronica: «Datemi una connessione<br />
fissa e solleverò il mondo». La paternità dell’espressione risale a Bruce Sterling.<br />
Cyberspace: (cyber-spazio) termine che si deve a William Gibson nel romanzo Neuromante<br />
(1984), usato genericamente per definire il mondo dei computer in rete.<br />
Dial-up: connessione via telefono ad un altro computer, il server, che funziona da<br />
porta d’accesso alla rete.<br />
Dns: è il codice postale generale di Internet.<br />
Dominio: è la targa nazionale di un indirizzo (.it per Italia, .uk per Gran Bretagna,<br />
.jp per Giappone) oppure segnala il tipo di attività (. edu, .org, .com).<br />
Download: è lo scaricamento di un file da un computer remoto (l’operazione contraria<br />
è upload).<br />
e-commerce: commercio elettronico<br />
Edutainment = neologismo inglese formato da ‘Education’ (educazione) e ‘Entertainment’<br />
(intrattenimento)<br />
E-mail: posta elettronica.<br />
Emoticons: sono le icone che esprimono emozioni (vedi smiley).<br />
Fair use = diritto di utilizzo di utilizzo di un software, che però non può essere venduto<br />
o ceduto per profitto.<br />
FAQ: (Frequently Asked Questions, domande chieste frequentemente) sono le risposte<br />
alle domande più frequenti, tentare di ovviare la lettura e chiedere in giro può<br />
esporre al rischio di Rtfm (Read The Fucking Manual).<br />
FEYNMAN, Richard Phillips: (1918-1988) premio nobel per la fisica nel 1965, teorizzatore<br />
dei computer quantistici.<br />
Finger: è lo strumento che vi permette di saperne di più rispetto ad un utente del<br />
quale conoscete solo l’indirizzo e-mail.<br />
Firma digitale: è un file assolutamente autentico che serve come riconoscimento di<br />
autenticità, come carta d’identità digitale.<br />
Firma elettronica: vedi Firma digitale<br />
Flame: (fiammata) è un attacco verbale violento.<br />
Fornitore d’accesso: (o service provider) è chi offre l’accesso a Internet.<br />
Freaker: (da to freak = striare) è il cracker delle linee telefoniche, chiama ovunque<br />
senza pagare.<br />
Free agents: programmi per la ricerca delle informazioni basati su algoritmi di tipo<br />
neurale; vedi Smart Agents<br />
Free riders: (cavalieri liberi) in gergo sono gli hackers più bravi<br />
Freeware: software gratuito disponibile in rete.<br />
FTP: (File Transfer Protocol) è il protocollo che permette il trasferimento di file da un<br />
computer ad un altro.<br />
Gigabyte: (Gb) multiplo del byte; 1 Gb = 1.000.000 Kb.<br />
183
Gopher: (nome di un roditore nordamericano) è un sistema di esplorazione della<br />
rete a menù, tra gli antenati è quello che più assomiglia al Web.<br />
Hacker: (da to hack = fare un colpo) colui che entra nei sistemi degli altri solo per<br />
dimostrare di saperlo fare. Al MIT negli anni 60 alcuni ricercatori si erano riuniti<br />
nel Club del Trenino Elettrico, i più ingegnosi nell’inventare marchingegni erano<br />
chiamati hackers. Oggi significa esperto di rete o pirata informatico.<br />
Home Computer: è la prima generazione dei computer da casa (Commodore, Spectrum,<br />
Amiga), che non possedevano memoria interna, se non la RAM, che utilizzavano<br />
supporti magnetici per la lettura e la memorizzazione dei file.<br />
Host: è il computer remoto attraverso il quale tutti i computer possono comunicare<br />
con tutte le macchine che vi sono connesse.<br />
Hot word: (parola calda) è la parola che solitamente ha un collegamento (link) attivo.<br />
HTML: (Hyper Text Markup Language) è il semplice linguaggio di programmazione<br />
ipertestuale con il quale sono scritti le pagine per il Web. I comandi dell’HTML<br />
sono detti Tags e può essere integrato da altri linguaggi, come Java e Javascript.<br />
HTTP: (Hyper Text Transfer Protocol) è il protocollo per passare da un sito all’altro del<br />
Web. È il prefisso, seguito da due punti e doppio back-slash , nei tipici indirizzi<br />
www; es. http://www.uniss.it.<br />
IBM: (Information Business Machines) è stata la prima società informatica del mondo.<br />
Informatica: dal fr. informatique (contrazione di information automatique) neologismo<br />
che significa informazione automatica, che comparve verso la metà degli anni ’60.<br />
L'informatica si occupa della gestione dei dati, ma anche dell'ingegneria dei calcolatori.<br />
Gli anglosassoni utilizzano la locuzione computer science, che sottolinea<br />
di più la seconda accezione.<br />
Internet: è «la madre di tutte le reti»; nata dal progetto militare di Arpanet, è<br />
l’unione delle reti mondiali, basata sul IP (Internet Protocol).<br />
IRC: (Internet Relay Chat) software per la comunicazione in tempo reale.<br />
ISDN: (Integrated Service Digital Network, rete digitale di servizi integrati) è una rete<br />
molto più veloce (dai 64 Kb/s in su) dei normali doppini di rame.<br />
Java: linguaggio di programmazione per il Web che funziona grazie a piccoli programmi<br />
(applets) inventato dalla Sun Microsystem<br />
Javascript: linguaggio di programmazione per il Web che funziona grazie agli script<br />
Killer application: applicazione killer, nel senso che sbaraglia le altre sul mercato.<br />
Kilobyte: (Kb) multiplo del byte; 1 Kb = 1.030 byte.<br />
Kung fu: fare kung fu con un sistema informatico significa oltrepassare le sue protezioni.<br />
LAN: (Local Area Network) è una rete locale che mette in comunicazione i computer<br />
di una comunità limitata (es. un’azienda, una università); è l’opposto della WAN.<br />
Link: (ancora, collegamento), permette di far saltare l’utente da un punto all’altro<br />
del testo; è l’elemento fondamentale di un ipertesto. Nel Web è riconoscibile per<br />
la scritta sottolineata e di un diverso colore, ma anche le immagini possono essere<br />
collegamenti.<br />
List-Serv: è un sistema automatizzato per la distribuzione di mailing list. Spedendo<br />
un messaggio ad un List-Serv, si ricevono le opinioni di tutti gli altri partecipanti.<br />
Literacy: (lett. il saper leggere e scrivere) è la competenza telematica dell’utente<br />
Logica booleana: vedi Booleana, Algebra<br />
Lurker: nella nuova antropologia della rete sono i contemplativi, coloro che girano<br />
nella rete leggendo i messaggi altrui, ma non prendono mai parte alla discussione.<br />
Mailing list: forum di discussione, dove le opinioni vengono automaticamente spedite<br />
(grazie al List-Serv) nella mailbox dei vari partecipanti alla discussione.<br />
Mainframe: grossi calcolatori dei centri di calcolo utilizzati per fare calcoli complessi,<br />
ora soppiantati da PC server.<br />
Margine del caos: (teoria matematica) Tra i due estremi, caos e ordine, nella zona chiamata<br />
margine del caos, vi sono sistemi le cui componenti sono abbastanza stabili<br />
184
per immagazzinare informazione ma abbastanza labili per trasmetterla: questi sistemi<br />
si possono organizzare, a volte spontaneamente, per eseguire calcoli, reagire<br />
alle perturbazioni e anche manifestare quel comportamento complesso ed<br />
elusivo, stabile, ma non troppo, che si chiama vita. Sono sistemi aperti, nel senso<br />
che sono attraversati da flussi di energia, materia e informazione che li mantengono<br />
lontani dall’equilibrio. Questi sistemi iniziano ad essere applicati anche ai<br />
sistemi sociali e culturali.<br />
Matrice: termine di provenienza matematica, indica una organizzazione a tabella di<br />
elementi omogenei, nella quale ogni elemento è identificato mediante due o più<br />
numeri che rappresentano le sue coordinate (per esempio numero di riga e numero<br />
di colonna) all’interno della struttura stessa. In programmazione sono indicate<br />
con il termine array. Il termine è usato anche per indicare il reticolo di punti<br />
(pixel) che si possono illuminare per rappresentare un carattere alfanumerico<br />
sullo schermo di un terminale di un video.<br />
Megabyte: (Mb) multiplo del byte; 1 Mb = 1.000 Kb .<br />
Microsoft Corporation: Società creata da Bill Gates (l’inventore del Basic) e il suo ex<br />
socio Paul Allen, Microsoft è il più grande fornitore di software per personal<br />
computer del mondo. Con dei ricavi netti pari al prodotto interno lordo delle piccole<br />
nazioni europee, Microsoft impiega più di 18.000 persone in 48 paesi del<br />
mondo.<br />
MIME: (Multipurpose Internet Mail Exstension, estensioni postali multifunzionali di<br />
Internet) è un metodo per collegare il codice binario alla posta elettronica e<br />
quindi inserirvi files di vario genere.<br />
MIRC: (M Internet Relay Chat) software “grafico” per la comunicazione in tempo<br />
reale.<br />
MIT: (Massachusetts Institute of Technology) di Boston<br />
Modem: (acronimo sillabico di Modulatore/Demodulatore) è lo strumento che nel<br />
computer inviante converte le informazioni binarie del computer in segnali analogici<br />
(come un modulatore) che possono così viaggiare via cavo telefonico e che<br />
nel computer ricevente trasforma i segnali analogici in informazioni digitali<br />
(come un demodulatore) permettendo in tal modo la comunicazione fra computer<br />
distanti.<br />
Mosaic: è il primo ed indimenticato browser grafico; inventato nel 1993 dai ricercatori<br />
della NCSA, è stato il detonatore del successo del Web; dell’équipe faceva<br />
parte anche Marc Andreessen, padre di Netscape.<br />
MUD: (Multi User Dungeon, prigioni sotterranee con più giocatori) popolarissimi<br />
giochi di ruolo elettronici con più utenti simultanei.<br />
MUG: (Multi User Game, gioco con più giocatori) popolarissimi giochi di ruolo elettronici<br />
con più utenti simultanei.<br />
Multimedia: è l’integrazione sullo stesso supporto di dati di diversa natura: testi,<br />
foto, filmati, suoni, ecc. Qualche informatico etimologista giura che se ne sia parlato<br />
per la prima volta riguardo al Macintosh della Apple (1984) una macchina<br />
che sin dall’inizio interagiva con immagini, suoni e testi. Per altri l’imprimatur<br />
dell’espressione sarebbe da attribuire a Bill Gates, nell’86. Ma pare che si trovasse<br />
già traccia della parola nella stampa statunitense di dieci anni prima.<br />
Nerds: maniaci del computer<br />
Net: è la rete con la maiuscola, Internet, quella che tutte le altre comprende. Fra i sinonimi<br />
utilizzati nel tempo anche the Cloud (la nuvola), the Matrix (la matrice), the<br />
Datasphere (il globo di dati), the Electronic Frontier (la frontiera elettronica, in memoria<br />
del Far West), The Information Superhighway (la superstrada<br />
dell’informazione).<br />
Net-etiquette: vedi Netiquette<br />
Netiquette: è la fusione delle due parole net (rete) ed etiquette (etichetta). La regola<br />
fondamentale è quella di pensare sempre di comunicare con un’altra persona e<br />
quindi visto che i messaggi sono soprattutto scritti, utilizzare un tono che non<br />
crei ambiguità. Da questa principale ne derivano altre come non inviare messaggi<br />
185
troppo lunghi, magari accompagnati da immagini o suoni, perché rischiano di far<br />
perdere tempo a chi li deve scaricare e leggere. E inoltre ingolfano la rete, già abbastanza<br />
affollata, con byte e byte di dati forse inutili. Oppure non inviare lo<br />
stesso messaggio a centinaia e centinaia di indirizzi. Questo è il cosiddetto<br />
“spamming” e, salvo rare eccezioni, la netiquette lo considera una pessima abitudine.<br />
Ancora peggio se si tratta di messaggi pubblicitari non richiesti. Ed ancora<br />
si dovrebbe evitare di strillare e per iscritto strillare significa scrivere con le lettere<br />
maiuscole; le maiuscole, secondo netiquette, si dovrebbero usare solo nel<br />
caso in cui si vuole enfatizzare un concetto e, anche qui, con moderazione. Ma la<br />
netiquette varia a seconda del contesto in ci si troviamo. Per esempio, se si partecipa<br />
a un gruppo di discussione su un serial televisivo, pettegolezzi e chiacchiere<br />
sui personaggi sono del tutto normali. Le cose invece cambiano se spediamo voci<br />
e notizie incontrollate in una mailing list di giornalisti.<br />
Netscape Communications Corporation,: è l’azienda che nel giro di pochi mesi è<br />
diventata leader mondiale del software di navigazione in Internet, Netscape, figlio<br />
di Mosaic [Vedi].<br />
Newbie: è un neofita della rete, un nuovo frequentatore; è un principiante, una matricola<br />
della rete.<br />
Newsgroup: bacheca elettronica dove ognuno può appendere i suoi messaggi e ricevere<br />
risposta pubblica o privata.<br />
Nodo: continuando la metafora della ragnatela, si definisce in questo modo il singolo<br />
componente informatico di Internet, cioè un computer direttamente collegato.<br />
Off-line: attributo del multimediale, quando questo non si trova in rete, ma per<br />
esempio su Cd-rom.<br />
On-line: attributo del multimediale, quando questo si trova in rete.<br />
Operating system: vedi Sistema operativo<br />
Password: (parola d’ordine) costituita da caratteri alfanumerici, necessaria per aver<br />
accesso ad un sistema chiuso.<br />
PC: vedi Personal Computer<br />
Perceptron: è stata la prima rete neurale inventata ad essere utilizzata, poi superata<br />
dalla Multilayer Perceptron, dalle reti di Kohonen, dalle reti di Caianello, ecc.<br />
Personal Computer: è un computer di piccole dimensioni, a differenza dei grandi<br />
computer aziendali, i mainframe [vedi Glossario], successori degli home computer,<br />
che possiedono una memoria interna.<br />
Pixel: punti elementari dello schermo. Più piccoli sono i pixel maggiore è la definizione<br />
dell’immagine, se invece i pixel sono pochi e grossi l’immagine sembra essere<br />
un «mosaico».<br />
PPP: (Point to Point Protocol) è il protocollo per poter avere accesso ad Internet in<br />
modalità grafica, comunicando con TCP/IP attraverso linea telefonica<br />
(l’alternativa è SLIP).<br />
Protocollo: è il codice di comunicazione, l’idioma attraverso il quale i computer possono<br />
capirsi.<br />
Pull media: tecnologie che permettono la comunicazione orizzontale, come Internet<br />
o le tecnologie comunicative globali<br />
Push media: tecnologie che permettono la comunicazione monodirezionale, come<br />
Tv, radio, ecc.<br />
Realtà virtuale: realtà creata dalle tecnologie digitale<br />
Server: interlocutore del client. Computer o software che permette ad altre macchine<br />
di utilizzare risorse di rete.<br />
Shareware: software disponibile in rete che è possibile provare prima di acquistare.<br />
Sistema operativo: piattaforma del computer; il s. o. è quel software che gestisce il<br />
PC e tutti gli altri software presenti all’interno, è l’interfaccia tra l’uomo e il linguaggio<br />
macchina. Ora sono molto usati i s. o. ad interfaccia grafica, dove cioè le<br />
operazioni non vengono fatte digitando i codici attraverso la tastiera, ma con<br />
semplici movimenti e click del mouse.<br />
186
Sito: ognuno dei singoli luoghi che compongono il Web.<br />
SLIP: (Serial Line Internet Protocol) è il protocollo per poter avere accesso a Internet in<br />
modalità grafica, comunicando con TCP/IP attraverso linea telefonica<br />
(l’alternativa è PPP).<br />
Smart Agents: programmi per la ricerca delle informazioni basati su algoritmi di<br />
tipo neurale; vedi Free Agents<br />
Smiley: sono le composizioni di simboli che identificano un’emozione, es. :-) visto<br />
ruotato di novanta gradi è un viso con un sorriso (☺) ed identifica un sentimento<br />
positivo.<br />
Spam: la coppia di avvocati Canter & Siegel aveva spedito una quantità massiccia (e<br />
non richiesta) di messaggi elettronici per pubblicizzare la propria attività.<br />
L’etimologia ha a che vedere con una marca di carne gelatinosa in scatola e vorrebbe<br />
suggerire il risultato che si otterrebbe mettendola davanti ad un ventilatore<br />
(l’eccezione è evidentemente molto negativa).<br />
Surfing: è la navigazione sulla rete senza uno scopo preciso: da qui deriva il termine<br />
«net-surfer», surfista della rete.<br />
Sysop: (acronimo di System Operator) è il gestore responsabile di un servizio telematico.<br />
TCP/IP: (Transfer Control Protocol / Internet Protocol) è il protocollo condiviso dai vari<br />
network che costituiscono Internet. Inventato nel 1982 da Vinton Cerf e Bob<br />
Khan, funziona in due fasi, prima spezzettando le informazioni e poi indirizzandole<br />
opportunamente.<br />
Telnet: è il protocollo che permette di utilizzare computer remoti come se si trattasse<br />
della propria macchina.<br />
Terabyte: (Tb) multiplo del byte; 1 Tb = 1.000.000.000 Kb.<br />
Thread: (filo) è il filone di conversazione, un argomento discusso per tempo variabile.<br />
Unix: sistema operativo di utilizzo comune su Internet.<br />
Upload: è l’invio di un file ad un computer remoto (l’operazione contraria è<br />
download).<br />
URL: (Uniform Resource Locator) indirizzo unico di identificazione all’interno del<br />
web.<br />
URL: (Uniform Resource Locator, identificatore uniforme di risorse) definisce in maniera<br />
univoca la posizione di una risorsa all’interno della rete.<br />
Usenet: è la zona della rete che raccoglie i newsgroup.<br />
User friendly: sono chiamate così le tecnologie ad ‘interfaccia umana’, cioè di facile<br />
uso<br />
UserID: (User Identification) ovvero il nome scelto o assegnato ad un utente per identificarsi<br />
in un determinato servizio telematico. Quello che solitamente, ma non<br />
sempre, nell’indirizzo di posta elettronica precede la @.<br />
Virtual reality: realtà creata dalle tecnologie digitale<br />
Virus: è un programma progettato per autogenerarsi e moltiplicarsi da un computer<br />
all’altro, danneggiando quelli con cui entra in contatto. Il più funesto che si ricordi<br />
è il «virus di Morris», che il primo novembre 1988 venne diffuso in rete,<br />
contagiando circa 6.000 host.<br />
VRML: (Virtual Reality Modelling Language) è un linguaggio che serve per la modellazione<br />
della realtà virtuale distribuibile in rete<br />
WAIS: (Wide Area Information Server) sistema di software usati per le ricerche su database<br />
di Internet.<br />
ware (-ware): usato per corseware, brochureware, ecc. riferimento a ciò che è immateriale<br />
o riguarda l’immateriale.<br />
Warezer: (da to warez = fare la guerra) ladro di software dalla rete.<br />
Word-key = parola chiave; esempio se cerco una rivista che parla di Socrate, la<br />
word-key sarà appunto «Socrate».<br />
World Wide Web: (Grande Ragnatele Mondiale) con una sineddoche sempre più<br />
diffusa si tende ad identificare con il Web tutto Internet, ma così non è, infatti esi-<br />
187
stono anche newsgroup, e-mail, telnet, FTP, ecc. Nato al CERN di Ginevra nel<br />
1989, il Web è la zona ipermediale della rete basata principalmente<br />
sull’ipertestualità.<br />
WWW: [vedi World Wide Web]<br />
Zippare: in gergo da nerds, i maniaci del computer, sta per archiviare uno o più file<br />
usando il programma PKZIP.<br />
188
BIBLIOGRAFIA<br />
La presente bibliografia, che ha cercato di spaziare su quanto è<br />
in circolazione intorno ai problemi oggetto della ricerca, viene distinta<br />
secondo tipologia di supporto in bibliografia cartacea, che riguarda arti-<br />
coli, riviste e libri appunto su carta, e in bibliografia informatica, che ri-<br />
guarda articoli, libri e siti su supporto digitale. Le citazioni delle bi-<br />
bliografie differiscono, infatti nelle note dei libri o degli articoli con-<br />
sultati in Internet non viene fornito in numero di pagina, perché inesi-<br />
stente, in compenso nella bibliografia viene fornito l’URL (Uniform Re-<br />
source Locator), cioè l’indirizzo web esatto dove ritrovare la fonte citata.<br />
I siti potranno facilmente essere visitati tramite il supporto digitale, il<br />
Cd-rom, allegato alla tesi. Sono stati citati in bibliografia anche alcuni<br />
siti, la consultazione dei siti non è lineare, ma ‘spaziale’, il che vuol<br />
dire che non è stato visitato completamente il sito, anche perché<br />
spesso ciò sarebbe stato improponibile, ma è stato consultato rispetto<br />
agli argomenti trattati in questa tesi.<br />
Articoli<br />
Bibliografia cartacea<br />
ANTOGNAZZA Elena, «Below The Web» da Web marketing tools n° 5 Maggio 1998<br />
ANTOGNAZZA Elena, «Network relationship» da Web marketing tools n° 7/8 Luglio/Agosto<br />
1998<br />
COSTANZO Pasquale, «Aspetti evolutivi del regime giuridico di Internet» da Diritto<br />
dell’informazione e dell’informatica Dicembre 1996<br />
189
DE BIASI Marco, «Interstitial Advertising» da Web marketing tools n° 7/8 Luglio/Agosto<br />
1998<br />
DE MARTINI Corrado, «Telematica e diritti della persona» da Diritto<br />
dell’informazione e dell’informatica Dicembre 1996<br />
ELMER-DEWITT Philip, «Battle for the Soul of the Internet» dal Time del 25 July<br />
1994<br />
GARIBBO Mimmo, «Cookies e dintorni: la parola alla difesa» da Web marketing tools n° 5<br />
Maggio 1998<br />
GHERARDELLI Tony, «Internet e la New Age» da Web marketing tools n° 7/8 Luglio/Agosto<br />
1998<br />
GITLIN Todd, «L’antipolitica di zapping in zapping, cresce il mostro» da Reset n° 8 Settembre<br />
1994<br />
HABERMAS Jürgen, «Così l’omogeneità diventò un veleno» da Reset n° 20 Settembre<br />
1995<br />
MADDOX Tom, «Cyberspace, Freedom, and Law» da Locus January 1993<br />
MADDOX Tom, «Reports from the Electronic Frontier» da Locus November 1992<br />
MADDOX Tom, «The Clipper Chip; Fear, Freedom, and The Singapore Question» da Locus<br />
June 1994<br />
MADDOX Tom, «The Dark Side of the Net» da Locus February 1994<br />
MÖDER Pepe, «L’ipertesto» da Web marketing tools n° 5 Maggio 1998<br />
NELSON Theodor Holm, «Progetto Xanadu» da Virtual n.9, 1996 Milano<br />
SCHWARTZ Evan I., «Advertising Webonomics 101» da Wired n° 4.02 Febbraio 1996<br />
VALERI Lorenzo, «Lo scudo invisibile: Internet contro gli ispanici» da L’America e noi<br />
1996<br />
ZENCOVICH Zeno V., «Limitazioni contrattuali alla manifestazione del pensiero» da Diritto<br />
dell’informazione e dell’informatica, Settembre 1995<br />
Libri<br />
AAVV, Enciclopedia della scienza e della tecnologia per il lemma Spazio-Tempo a cura di<br />
Luca ASTORI– ed. De Agostini 1995 Milano<br />
BANDINU Bachisio, Lettera a un giovane sardo, ed. Della Torre, febbraio 1997 Cagliari.<br />
BARRAGAN Julia, Informatica y decisiom juridica, ed. Fontamara 1994 Città del Mexico<br />
BERRETTI Alberto e ZAMBARDINO Vittorio, Internet – Avviso ai naviganti, ed. Donzelli<br />
1995 Roma<br />
BETTELLI Oscar, Macchine Intelligenti (© 1997) – ed. ARPA Publishing 1998 Milano<br />
BORELLI Piero, Conceptional breakthrough ed. Università di Pisa – Quaderni del seminario<br />
per le scienze giuridiche e politiche 1990 Pisa<br />
BURDMAN Jessica e MILBURN Ken, FrontPage – La progettazione delle pagine Web ed.<br />
Tecniche Nuove 1997 Milano<br />
CAMARGO Francisco A., Learning Algorithms in Neural Networks, Computer Science<br />
Department – Columbia University, 1990 New York, NY, 10027<br />
190
COCCINO Marco & VEGETTI Mario, Storia moderna e contemporanea, ed. Zanichelli,<br />
1992 Bologna<br />
COLOMBO Furio, Confucio nel computer – Memoria accidentale del futuro (© 1995), ed.<br />
Rizzoli 1998 Milano<br />
CONDRY John & POPPER Karl R., Cattiva maestra televisione, ed. Donzelli 1996<br />
Roma.<br />
DE ROSNAY Joel, L’uomo, Gaia e il Cybionte; viaggio nel terzo millennio, ed. Dedalo,<br />
1997, Bari<br />
DELEUZE Gilles, Differenze e ripetizione (© 1968), ed. Il mulino 1972 Bologna<br />
DENNETT Daniel & HOFSTADTER Douglas, L’Io della Mente ed. Adelphi 1985 Milano<br />
DYSON Esther, Release 2.0 – Come vivere nell’era digitale, ed. Mondadori 1997 Milano<br />
ECO Umberto, Come si fa una tesi di laurea (© 1980), ed. Bompiani 1996 Milano<br />
ECO Umberto, Kant e l’ornitorinco (© 1980), ed. Bompiani 1996 Milano, prefazione<br />
GATES Bill, La strada che porta a domani, ed. Mondadori, 1995 Milano<br />
GERIN Guido, Les effets de l’informatique sur le droit à la vie privée (© 1987), ed. CE-<br />
DAM, 1990 Padova.<br />
GIBSON William, Neuromante (© 1984), Casa Editrice Nord S.r.l., 1993 Milano.<br />
GILDER George, La vita dopo la televisione - Il Grande Fratello farà la fine dei dinosauri?<br />
(© 1990), ed. Castelvecchi 1995 Roma<br />
GRAVES Robert, I miti greci, ed. Longanesi 1983 Milano<br />
HAFNER Katie & MARKOFF John, Outlaws and hackers on the computer frontier, California<br />
Press 1992 L. A.<br />
HOFSTADTER Douglas , Gödel, Escher e Bach, ed. Adelphi 1984 Milano<br />
HOFSTADTER Douglas, vedi DENNETT Daniel<br />
KROKER Arthur e WEINSTEIN Michael, Data Trash, ed. Urra Apogeo 1996 Milano<br />
LÉVY Pierre, Il virtuale (© 1995), ed. Raffaello Cortina Editore 1997 Milano<br />
LÉVY Pierre, Le tecnologie dell’intelligenza (© 1990), ed. Synergon 1992 Bologna<br />
LITMAN Johnathan, Watchman, Sweepings Press, 1989, N. Y.<br />
LONGO Giuseppe O., Il nuovo Golem – Come il computer cambia la nostra cultura, 1998<br />
ed. Laterza, Roma<br />
MALDONADO Tomás, Critica della ragione informatica, ed. Feltrinelli coll. Campi del<br />
sapere 1997 Milano<br />
MARKOFF John, vedi HAFNER Katie<br />
McLUHAN Marshall, Gli strumenti del comunicare (© 1964), Il Saggiatore 1967 Milano<br />
McLUHAN Marshall, La galassia Gutenberg (© 1967), ed. Armando Mondadori 1988<br />
Roma<br />
MILBURN Ken, vedi BURDMAN Jessica<br />
MORAVIA Sergio, L’enigma della mente, ed. Laterza 1986 Roma<br />
NEGROPONTE Nicholas, Essere digitali, ed. Sperling & Kupfer 1995 Milano<br />
ORWELL George, 1984, (© 1949) ed. Oscar Mondadori 1989 Milano<br />
PAPERT Seymour, «Learn Think to Children», UCLA (University of California Los<br />
Angeles), 1972, L. A. relation<br />
191
POPPER Karl R. vedi CONDRY John<br />
POSTMAN Neil, The End of Education – Redefining the Value of School, ed. Knopf 1995<br />
N. Y.<br />
RIFKLIN Jeremy, La fine del lavoro, ed. Mondadori, 1993 Milano<br />
RODOTÀ Stefano, Tecnologie e diritti, ed. Il Mulino, 1995 Bari.<br />
SERRES Michel, Atlas, ed. Julliard 1994 Paris<br />
SHIMOMURA Tsutomu, Takedown Forgot Press 1990 L. A.<br />
STAGLIANÒ Riccardo, Circo Internet – Manuale critico per il nuovo millennio, ed. Feltrinelli<br />
1997 Milano<br />
STAGLIANÒ Riccardo, Comunicazione interattiva – La pubblicità al tempo di Internet,<br />
ed. Castelvecchi 1996 Roma<br />
ULLMAN Ellen, Out of Time: Reflection on the programming life, 1997 Information<br />
Technology Department – UCLA University California of Los Angeles L.A.<br />
VACCA Roberto, Dio e il computer (© 1984), ed. Bompiani 1997 Milano<br />
VALENTINETTI Carlo M., Orson Welles, ed. Il Castoro 1995 Milano<br />
VEGETTI Mario, vedi COCCINO Marco<br />
WEINSTEIN Michael, vedi KROKER Arthur<br />
ZAMBARDINO Vittorio, vedi BERRETTI Alberto<br />
Articoli<br />
Bibliografia informatica<br />
ABRUZZESE Alberto, «Società di massa e tv generalista», 15-10-96 Venezia,<br />
http://www.mediamente.rai.it/home\bibliote\biografi\a\abruzzes.htm<br />
ANTINUCCI Francesco, «La realtà virtuale come strumento di conoscenza» 10-15-95 Ginevra,<br />
Convegno Telecom<br />
http://www.mediamente.rai.it/home\bibliote\biografi\a\antinucci.htm<br />
BARICCO Alessandro, «Scrivere, leggere e pensare al computer » 21-04-97, Torino<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\b\baricco.htm<br />
BELOTTI Gabriella, «Progettare ambienti virtuali» 25-10-95, Milano,<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\b\belotti.htm<br />
BENAYOUN Maurice, «World Skin: la pelle del mondo» 08-11-97 Mestre,<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\b\ benayoun.htm<br />
BERARDI Franco (Bifo), «Il reale e il virtuale» 18-10-95 Bologna, MediaMente<br />
http://www.mediamente.rai.it/home\bibliote\biografi\b\berardi.htm<br />
BERARDI Franco (Bifo), «Spunti di riflessione» 29-10-96 Bologna, MediaMente<br />
http://www.mediamente.rai.it/home\bibliote\biografi\b\berardi.htm<br />
BERGAMASCO Massimo «Verso una completa immersione grafica e visiva negli ambienti<br />
virtuali» 08-11-96 Milano,<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\b\bergamas.htm<br />
192
BLASI Giulio e COSENZA Giovanna, «Le Arcades multimediali a Bologna», 09-21-95<br />
Milano - SMAU,<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\b\blasi.htm<br />
BODEI Remo, «La comunicazione nel V secolo dell’era globale», 07-05-96 Napoli<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\b\bodei.htm<br />
BODEI Remo, «Scrittura digitale e filologia», 19-11-92 Napoli<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\b\bodei.htm<br />
BONITO OLIVA Achille, «L’anoressia dell’arte», 20-10-96 Roma,<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\b\bonitool.htm<br />
BRITTON Benjamin, «La grotta di Lescaux in realtà virtuale» 25-10-95 Milano - Facoltà<br />
di architettura<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\b\britton.htm<br />
CAMERLO Humbert, «La ricostruzione virtuale del teatro ‘La Fenice’» 10-04-97 Bologna,<br />
Futur-show,<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\c\camerlo.htm<br />
CANALI Mario, «Arte e realtà virtuale» 25-10-95 Milano - Facoltà di architettura<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\c\canali.htm<br />
CERRI Stefano, «La formazione a distanza», 21-12-95 Roma,<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\c\cerri.htm<br />
CESAREO Giovanni, «Lo strabismo telematico», 21-02-97 Roma<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\c\cesareo.htm<br />
CLARK Jim, «Dalla telecomunicazione analogica a quella digitale» 13-01-96 Roma,<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\c\clark.htm<br />
CLARK Jim, «Le quattro fasi dello sviluppo di Internet» 06-12-96 Roma,<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\c\clark.htm<br />
COCA Antonio, «La formazione multimediale presso l’Università delle Baleari», 08-11-96<br />
– Milano http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\c\coca.htm<br />
COLOMBO Fausto, «L’evoluzione del mondo dei media» 03-07-97 Napoli, Convegno<br />
Telecom<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\c\colomb_f.htm<br />
COLOMBO Fausto, «La forma visiva del testo», 21-02-97 Roma,<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\c\colomb_f.htm<br />
COLOMBO Fausto, «Le molteplici dimensioni del mondo delle reti», 05-07-96 Napoli,<br />
Summit della Telecom sulla società della telecomunicazione",<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\c\colomb_f.htm<br />
COLOMBO Umberto, «Progresso tecnologico e sviluppo eco-sostenibile», 20-05-96, Roma,<br />
http://www.mediamente.rai.it/home\bibliote\biografi\c\colomb_u.htm<br />
COSENZA Giovanna vedi BLASI Giulio e<br />
COSTA Mario, «Il sublime tecnologico» 02-06-96 Firenze<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\c\costa.htm<br />
COSTA Mario, «Il sublime tecnologico», 02-06-96 Firenze,<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\c\costa.htm<br />
DALLA CHIARA Maria Luisa, «Dalla macchina ideale di Turing ai computer reali»,<br />
24.3.98 Firenze<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\d\dallachi.htm<br />
DAMER Bruce «Sherwood City», 31-05-96, Firenze<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\d\damer.htm<br />
193
DE KERCKHOVE Derrick, «Arte e scienza nella rete» 13-01-96 Roma<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\d\dekerckh.htm<br />
DE KERCKHOVE Derrick, «Il neo barocco digitale» 31-05-96 Firenze<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\d\dekerckh.htm<br />
DE KERCKHOVE Derrick, «La mente umana e le nuove tecnologie di comunicazione» 23-<br />
06-95 Napoli<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\d\dekerckh.htm<br />
DE KERCKHOVE Derrick, «Verso la conoscenza connettiva» 11-02-97 Cannes, Milia,<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\d\dekerckh.htm<br />
DE MAURO Tullio, «Alfabetizzazione elettronica e nuovi linguaggi», 20-05-96 Roma<br />
http://www.mediamente.rai.it/home\bibliote\biografi\d\demauro.htm<br />
DE ROSNAY Joel, «C’è una vita dopo Internet?» 11-02-97 Cannes, MILIA<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\d\derosnay.htm<br />
DE ROSNAY Joel, «Il Cybionte» 09-05-95 Parigi - European IT Forum<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\d\derosnay.htm<br />
ECO Umberto, «Nomenclatura e democrazia elettronica», 21-09-95 Milano - SMAU,<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\e\eco.htm<br />
FERRARI Enrico, «Luther Blissett», Approfondimento del 24-10-97, MediaMente<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\tv2rete\mm9798\97102024\a971024.htm<br />
FERRERO Giovanni, «Un esempio di città cablata», Milano, 19-10-96,<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\f\ferrero.htm<br />
FERRI Paolo, «La comunità virtuale», 26-11-97 Milano, MediaMente<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\f\ferri.htm<br />
FLORES D’ARCAIS Paolo, «Politica, politici e cittadini nell’era digitale», 04-07-97 Napoli,<br />
(Convegno Telecom),<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\f\flores.htm<br />
GARASSINI Stefania, «L’effetto della realtà virtuale e di Internet sulla società moderna»,<br />
21-09-95, Milano - SMAU<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\g\ garassin.htm<br />
GARCIA Miguel Angel, «Testo e ipertesto», 23-01-96 Roma<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\g\garcia.htm<br />
GARDNER Howard, «Intelligenze multiple e nuove tecnologie», 10-04-97 Torino,<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\g\gardner.htm<br />
LANDOW George P., «Il confine aperto del testo» 14-11-96 Milano<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\l\landow.htm<br />
LANDOW George P., «La grande potenza del testo quando diventa ipertesto» 26-11-97<br />
Milano http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\l\landow.htm<br />
LINI Domenico, «Il museo scientifico nell’era dell’alta tecnologia e di Internet», 25-10-95<br />
Milano - Facoltà di architettura<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\l\lini.htm<br />
MALDONADO Tomás, «Web: se c’è una ragnatela, deve esserci un ragno», 26-11-97,<br />
Milano,<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\m\maldonad.htm<br />
MARTINOTTI Guido, «Telegeografia dell’era globale», 05-07-96 Napoli, al Summit<br />
della Telecom sulla società della telecomunicazione,<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\m\martinot.htm<br />
MASIERO Roberto, «Economia digitale e società dell’informazione», 23-09-97 Parigi,<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\m\masiero.htm<br />
194
MASIERO Roberto, «Passato, presente e futuro della società dell’informazione», 05-09-95<br />
Parigi - European IT Forum<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\m\masiero.htm<br />
McKENNA Dennis, «Il ruolo dei governi nella società informatica», 10-09-97, Nizza,<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\m\mckenna.htm<br />
MIGLIOLI Lorenzo, «Progetto Parco Navi», 02-06-96 Firenze,<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\m\miglioli.htm<br />
MORIN Edgar, «Educare ai mass media» 19-05-93 Napoli,<br />
http://www.mediamente.rai.it/home\bibliote\biografi\m\morin.htm<br />
MORISSETTE Jule, «Il museo multimediale interattivo» 25-10-95 Milano - Facoltà di architettura<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\m\ morisett.htm<br />
NEGROPONTE Nicholas, «Dall’atomo al bit» 31-05-95 Roma Laboratorio Media-<br />
Mente<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\n\negropon.htm<br />
NEGROPONTE Nicholas, «La rivoluzione digitale» 03-06-95 Venezia – Ca’ Foscari<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\n\negropon.htm<br />
PARASCANDOLO Renato, «Il paradosso multimediale e l’inganno interattivo», 03-11-<br />
1995 Roma,<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\p\parascan.htm<br />
PEPERZAK Adriaan, «Etica della comunicazione», 08-05-93 Napoli<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\p\peperzak.htm<br />
PESCE Mark, «Il Virtual Reality Modelling Language», 31-05-96 Firenze<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\p\pesce.htm<br />
POLISTINA Alessandro, «Nuove tecnologie e design» 09-11-96 Milano,<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\p\polistin.htm<br />
PRISTER Giorgio, «Cittadini e servizi pubblici elettronici», 09-09-97 Nizza, Sophia Antipolis<br />
- France Telecom Agora<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\p\prister.htm<br />
QUEAU Philippe, «Diritti d’autore nell’era digitale», 04-09-95 Parigi - European IT Forum,<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\q\queau.htm<br />
QUEAU Philippe, «La rivoluzione del virtuale» 15-12-95 Roma,<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\q\queau.htm<br />
RECK Hans Hulrich, «Arte e nuovi media», 22-11-96 Roma,<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\r\reck.htm<br />
REY Guido Mario, «Informatica e pubblica amministrazione», 21-10-1996 Milano,<br />
SMAU, http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\r\rey.htm<br />
RODOTÀ Stefano, «Sviluppo telematico e democrazia», 13-01-96 Roma,<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\r\rodota.htm<br />
RONCHI Alfredo, «Progettazione digitale e teledidattica», 19-12-95 Roma,<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\r\ronchi.htm<br />
RUSSO Tommaso, «Hackers: Il manuale dell’Hacker», Navigazione del 09-03-98,<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\tv2rete\mm9798\98030913\n980309.htm<br />
RUSSO Tommaso, «Hackers: John Draper», Navigazione del 13-03-98,<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\tv2rete\mm9798\98030913\n980313.htm<br />
RUSSO Tommaso, «Hackers: Kevin Mitnick», Navigazione del 10-03-98,<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\tv2rete\mm9798\98030913\n980310.htm<br />
195
RUSSO Tommaso, «Hackers: Richard Stallman», Navigazione del 12-03-98,<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\tv2rete\mm9798\98030913\n980312.htm<br />
RUSSO Tommaso, «Hackers: Robert T. Morris», Navigazione del 11-03-98,<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\tv2rete\mm9798\98030913\n980311.htm<br />
STALLMAN Richard, «Il copyright è di destra, il copyleft è di sinistra», 05-12-97 Roma,<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\s\stallman.htm<br />
STERLING Bruce, «Letteratura Cyberpunk» 03-12-94 Roma, MediaMente<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\s\sterling.htm E-mail:<br />
bruces@well.sf.ca.us<br />
TAN Chung-Jen, «Deep Blue», 04-10-97, Milano – SMAU<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\t\tan.htm<br />
VETTRAINO SOULARD Marie Claude, «Il mito di Internet», 14-11-96 Milano<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\v\vettrain.htm<br />
VIRILIO Paul, «La velocità assoluta», 05-09-95 Parigi - European IT Forum,<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\v\virilio.htm<br />
VITTADINI Nicoletta, «Augmented reality e medicina», 25-10-95 Milano - Facoltà di<br />
Architettura,<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\v\vittadin.htm<br />
WINKLER Scott, «Le strategie Sun», 04-11-97 Cannes, ITxpo97,<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\s\scott.htm<br />
WLADAWSKY-BERGER Irving, «Collegamenti in rete», 11-12-96 New York<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\w\wladawsk.htm<br />
WLADAWSKY-BERGER Irving, «Pubblica utilità della rete» 22-10-97 Parigi, IDC<br />
http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\w\wladawsk.htm<br />
WOLF Mauro, «Le nuove tecnologie dell’informazione a servizio della politica» 12-01-96,<br />
Roma, http://www.mediamente.rai.it\home\bibliote\biografi\w\wolf.htm<br />
Libri<br />
CARONIA Antonio, Il corpo disseminato all'interno e all'esterno del virtuale, EMSF<br />
http://www.emsf.rai.it/<br />
DALLAPINA Andrea, Il filosofo nell’ipertesto, 1996 EMSF http://www.emsf.rai.it/<br />
RHEINGOLD Howard, The virtual community, 1993, A William Patrick Book, Addison-Wesley<br />
visibile nel sito http://www.rheingold.com/vc/book/index.html<br />
STERLING Bruce, The Hacker crackdown: law and disorder on electronic frontier, 1992 visibile<br />
nel sito http://www.lysator.liu.se/etexts/hacker/<br />
Siti<br />
«‘Netiquette’ site for business etiquette»; http://www.wp.com/fredfish/Netiq.html<br />
«2600 - The Hacker Quarterly»; http://www.2600.com/mindex.html<br />
«Cap’n Crunch’s Home in Cyberspace», http://www.host.net/~crunch/<br />
«Conoscere il Net»; http://www.learnthenet.com/italian/index.html<br />
«Cult of the dead cow»; http://www3.l0pht.com/~veggie/links.html<br />
196
«EMSF - Enciclopedia Multimediale delle Scienze <strong>Filosofiche</strong>»; http://www.emsf.rai.it/<br />
«Hackers’ Hall of Fame»;<br />
http://eagle.online.discovery.com/area/technology/hackers/golden.html<br />
«HotMail» casellario elettronico; http://www.hotmail.com<br />
«Il galareteo di Emily Postnews» (in italiano);<br />
http://www.polito.it/~bertola/faq/emily.htm<br />
«Il galareteo di Emily Postnews» (testuale);<br />
http://www.guru.apana.org.au/netiquet.htm<br />
«Il galareteo di Emily Postnews»; http://www.clari.net/brad/emily.html<br />
«Il nuovo libro di Luther Blissett»; http://www.2mila8.com/luther/<br />
«Il Resto del Carlino» Pesaro; http://www.pesaro.com/carlino/<br />
«Il Sole 24 Ore»; http://www.ilsole24ore.it<br />
«Interview With John Draper», http://rsphysse.anu.edu.au/~tsb107/draper/<br />
«Karen Eliot»; http://www.pengo.it/luther/bliss5.htm<br />
«Manuale di Netiquette» (Harlene); http://www.inferentia.it/netiquette/<br />
«Netiquette Catalog Page»; http://www.albion.com/netiquette/catNetiquette.html<br />
«Netiquette Guidelines»; http://w3.arl.mil/home/netiquette/rfc18551.html<br />
«Netiquette Home Page»; http://www.albion.com/netiquette<br />
«Noesis <strong>Philosophical</strong> Research on-line» Motore di ricerca filosofico;<br />
http://noesis.evansville.edu<br />
«Noted & Notorious Hacker Feats» (Celebri e famose prodezze degli hackers)<br />
http://www.byte.com/art/9509/sec7/art25.htm#billjoy<br />
«Privacy» sito americano dedicato alla privacy; http://www.privacy.com;<br />
«Privacy» sito italiano dedicato alla privacy; http://www.privacy.it<br />
«Radio Blissett»; http://www.dsnet.it/qwerg/blissett/radiobli.htm<br />
«The GNU Project» http://www.gnu.org<br />
«The How To Hack Manual»; http://www.madness.org/hack/manual.htm<br />
«The Ministry of Truth»; http://www.furt.com/scott/hacker/<br />
«The nasty trick»; http://www.dsnet.it/qwerg/blissett/bliss1.htm<br />
«The neW luTHer bliSSett’s internet page»;<br />
http://www.dsnet.it/qwerg/blissett/bliss0.htm<br />
«What is the Free Software Foundation? - GNU Project» http://www.gnu.org/fsp<br />
«Why Software Should Not Have Owners - GNU Project»<br />
http://www.gnu.org/philosophy/why-free.html<br />
«Yahoo.com» motore di ricerca; http://www.yahoo.com<br />
«Yahoo.it» versione italiana di Yahoo.com; http://www.yahoo.com<br />
197
A<br />
ABC; 83<br />
ABRUZZESE; 81; 193<br />
advertising; 133; 134; 191<br />
AL GORE; 14<br />
algoritmo; 21; 38; 60; 84; 175; 182; 184; 188<br />
sistemi algoritmici; 17<br />
Algoritmi genetici; 38; 175; 182<br />
Amazon; 133<br />
Amazzonia; 35<br />
analogico; 15; 30; 38<br />
tecnologie analogiche; 15; 16<br />
anoressia dell’arte; 74; 194<br />
ANTINUCCI; 52<br />
apartheid informatica; 151<br />
Apple; 115; 125; 180; 181; 186<br />
arcades; 111; 182; 194<br />
ARISTOTELE; 31; 35; 42; 144; 157<br />
ARTAUD; 78<br />
arte digitale; 73<br />
artificial life; vedi intelligenza artficiale<br />
atomo; 14; 28; 34<br />
attualizzazione; 42; 44; 67<br />
autodeterminazione informativa; 149<br />
automa cellulare; 174<br />
autosimilarità, proprietà di; 66<br />
autostrada dell’informazione; 14<br />
autostrade digitali; 84<br />
autostrade elettroniche; 118<br />
B<br />
backpropagation; 175<br />
BANDINU; 104; 191<br />
banner; 135; 145; 171<br />
BATESON; 59<br />
BERARDI; 93; 135; 193<br />
BERENSON; 76<br />
BEY; 92<br />
BEZABEL; 21<br />
bildung; 70<br />
biologia; 19; 98<br />
bit; 14; 15; 26; 28; 29; 55; 84; 161; 196<br />
BLISSETT, Luther; 90; 91; 92; 93; 94; 167;<br />
195; 198<br />
blitzkrieg; 175<br />
block-system; 5<br />
BODEI; 75<br />
BODEI; 75; 106; 166; 194<br />
BONITO OLIVA; 74; 194<br />
booleana, logica; 133; 183; 185<br />
BOOLE, George; 183<br />
BRECHT; 78<br />
Brown University; 113<br />
browser; 67; 122; 133; 144; 181; 186<br />
BUCKMINSTER FULLER; 108; 183<br />
bug; 123; 181; 182<br />
INDICE ANALITICO<br />
BURDMAN; 67; 191; 192<br />
BURKS; 174<br />
byte; 171; 183; 184; 185; 186; 188; 198<br />
C<br />
CAIANELLO, reti di; 38; 187<br />
calcolatore; 24; 25; 32; 33; 35; 37; 38; 145<br />
CAMARGO; 38; 174; 191<br />
caos; 34; 90; 98; 181; 185<br />
capacità; 56<br />
Capitain Crunch; 125<br />
CARONIA; 46; 197<br />
cartesiano; 47<br />
Case; 20; 121<br />
censura; 126<br />
CERN di Ginevra; 86; 181; 188<br />
CERRI; 153; 159; 194<br />
CESAREO; 11; 108; 129; 194<br />
chat; 3; 88; 169; 183; 185; 186<br />
chattare; 88; 169<br />
CHOMSKY; 22<br />
CHURCH; 37<br />
cibernauta; 126; 135; 145; 164; 181<br />
cibernetica; 19; 175<br />
ciberspazio; vedi cyber-space<br />
click-through; 135<br />
Click-through; 135<br />
CLINTON; 14<br />
C. N. R. ; 52<br />
co-identità; 93<br />
co-individuo; 90; 167<br />
collasso della funzione d’onda; 39<br />
COLOMBO Cristoforo; 166<br />
COLOMBO Fausto; 73; 108; 131; 194<br />
COLOMBO, Furio.; 54; 89; 119; 131; 162;<br />
163; 192<br />
COLOMBO Umberto; 96; 99; 101; 194<br />
colonizzazioni; 118; 119<br />
commercio elettronico; 132; 133; 184<br />
computer quantistici; 39; 184<br />
Comunità Europea; 171<br />
comunità virtuali; 89; 113; 115; 117; 183<br />
CONDRY; 82; 192; 193<br />
conoscenza; 42; 50; 51; 56; 63; 68; 70; 81; 86;<br />
87; 88; 90; 115; 156; 193; 195<br />
Conoscenza; 63<br />
cookies; 89; 136; 139; 144; 146; 184;191<br />
copyleft; 139; 141; 142; 143; 197<br />
copyright; 29; 90; 93; 139; 141; 142; 144; 197<br />
CORDESCHI; 36<br />
corpo collettivo; 50<br />
corpo virtuale; 46; 47<br />
cosmopolis; 103<br />
COSTA; 77; 194<br />
crackdown; 122; 123; 184; 197<br />
crackers; 122<br />
Creatura; 59; 61<br />
CROCE; 157<br />
CRONKITE; 83<br />
198
cuseeme; 3, 184<br />
Cyber Promotions; 137<br />
cyber sette; 114<br />
cyber-cult; 115<br />
cybernauta; vedi cibernauta<br />
cybernauti; 137; 147<br />
cyberpolizie; 114; 116<br />
cyberpunk; 113; 122; 123; 184; 197<br />
cyber-spazio; 2; 4; 18; 30; 32; 54; 64; 65; 66;<br />
120; 125; 184<br />
cyber-tempo; 54<br />
cybionte; 19; 20; 70; 95; 96; 192; 195<br />
cyborg; 19; 21; 76<br />
D<br />
DALLA CHIARA; 36; 194<br />
DALLAPINA; 65; 197<br />
DARWIN; 97<br />
dasein; 43<br />
D.B.M.S.; 147<br />
DE KERCKHOVE; 75; 195<br />
DE MAURO; 87; 195<br />
DE ROSNAY; 19; 20; 70; 95; 96; 99; 192;<br />
195<br />
Decameron; 113<br />
delega tecnologica; 168<br />
DELEUZE; 41; 192<br />
democratizzazione; 11; 167<br />
democrazia (elettronica; digitale); 6; 12; 108;<br />
109; 146; 148; 154; 195; 196<br />
DICKENS; 23<br />
digitale; 2; 3; 6; 9; 13; 14; 15; 17; 18; 27; 28;<br />
29; 31; 43; 45; 47; 55; 56; 63; 64; 65; 76;<br />
83; 84; 96; 104; 109; 115; 127; 129; 133;<br />
134; 139; 140; 141; 142; 155; 162; 163;<br />
164; 168; 171; 183; 184; 185; 190; 192;<br />
194; 195; 196<br />
digitalizzazione; 17; 30; 43; 45; 47; 67; 68<br />
dinosauri; 15; 17; 192<br />
discriminazione; 68<br />
dispositio; 68<br />
docuverso; 65<br />
DOSTOEVSKIJ; 23<br />
DRAPER; 125; 196; 198<br />
E<br />
ECO; 6; 113; 192; 195<br />
ecologia; 19; 80; 99; 128<br />
economia aziendale; 11<br />
educazione; 13; 68; 69; 70; 71; 106; 112; 142;<br />
153; 156; 169; 184<br />
edutainment; 156<br />
EFESTO; 20<br />
effetto farfalla; 35<br />
effetto Stendhal; 75<br />
EINSTEIN; 27; 38; 157<br />
ELIOT, Karen; 93; 198<br />
Eliza; 37<br />
EMACS; 124<br />
e-mail; 3; 89; 92; 133; 137; 147; 175; 176;<br />
180; 183; 184; 188 vedi anche posta<br />
elettronica<br />
emet; 21<br />
emoticons; 89<br />
entropia; 56<br />
ERACLITO; 62<br />
era digitale; 15; 27; 31; 164<br />
era globale; 75; 106; 154; 166; 194; 195<br />
ergonomia intellettuale; 63; 68; 69<br />
ergonomia meccanica; 69<br />
ermeneutica; 69<br />
error backpropagation; 38; 182<br />
esteriorità, principio di; 66<br />
estetica del brutto; 76<br />
estetica della sparizione; 73; 74<br />
estetica digitale; 76<br />
etica planetaria; 165<br />
eterogeneità, principio di; 66<br />
euristica; 68<br />
Europa; 13; 103; 118<br />
F<br />
F2F; 88<br />
fair use; 142; 184<br />
fantascienza; 20<br />
F.B.I.; 122; 125<br />
fenotipico; 97<br />
FERRARI; 92; 195<br />
FERRERO; 111; 195<br />
FERRI; 113; 195<br />
FEYNMAN; 39<br />
firma elettronica; 141<br />
fisica; 2; 26; 27; 34; 52; 184<br />
astronomica; 27<br />
meccanica; 27; 31<br />
flames; 62; 89; 117; 164<br />
FLORES D’ARCAIS; 109; 195<br />
formazione continua; 158<br />
frattale; 66<br />
freaker; 125<br />
free agent; 60<br />
free riders; 123; 184<br />
Free Software Foundation; 124; 142; 198<br />
FREUD; 157<br />
friendly; vedi user friendly<br />
funzionalismo; 37<br />
fuzzy logics; 24; 35; 36<br />
G<br />
Gaia; 19; 95; 96; 99; 192<br />
GARASSINI; 119; 195<br />
GARDNER; 157; 195<br />
GATES; 5; 14; 115; 186; 192<br />
genetic algorithms; vedi algoritmi genetici<br />
GENNA; 92<br />
genotipo; 97; 98<br />
GIBSON; 7; 18; 20; 30; 31; 73; 120; 121; 180;<br />
184; 192<br />
GILDER; 15; 16; 17; 82; 192<br />
gioco dell’imitazione; 37<br />
giurisprudenza; 136; 139; 142; 172; 181<br />
globalizzazione; 80; 102; 105; 128; 132<br />
glocalizzazione; 102; 106<br />
G. N. U.; 124; 142; 198<br />
GÖDEL; 23; 192<br />
GÖDEL; teoremi di; 32; 38<br />
Golem; 20; 21; 36<br />
gopher; 3; 10<br />
GRAHAM; 138<br />
199
Grande Fratello; 16; 17; 21; 146; 167; 170;<br />
192<br />
gratis; 134<br />
GRAVES; 12; 192<br />
GUTENBERG; 18; 29; 192<br />
H<br />
hacker; 88; 120; 121; 122; 123; 125; 142; 184;<br />
192; 196; 197; 198<br />
hacking; 120; 121; 125<br />
HAFNER; 122; 192<br />
Hale Bopp; 6<br />
hardware; 55; 107<br />
HASSETT; 82<br />
HEIDEGGER; 79; 157<br />
HINTON; 38; 182<br />
HITCHCOCK; 91<br />
hits; 135<br />
HOFSTADTER; 23<br />
HOLDERLIN; 79<br />
home; 2; 135; 187; 193; 194; 195; 196; 197;<br />
198<br />
homo symbioticus; 95; 96; 98<br />
HotMail; 147; 198<br />
H. T. M. L.; 2; 3; 67; 134; 135; 185<br />
HUSSERL; 157<br />
hypertext; vedi Ipertesto<br />
I. A.; vedi intelligenza artificiale<br />
IBM; 107; 185<br />
Il Resto del Carlino; 91<br />
informatica; 2; 23; 28; 30; 32; 80; 87; 101;<br />
107; 109; 110; 119; 122; 124; 130; 131;<br />
147; 154; 158; 161; 183; 185; 190; 191;<br />
192; 193; 196<br />
Informatica; 110; 132; 161; 185; 191; 196<br />
information superhighway; 14; 118<br />
information technology; 84<br />
informazione; 2; 6; 10; 16; 19; 22; 30; 31; 32;<br />
34; 43; 45; 54; 55; 56; 57; 59; 60; 61; 63;<br />
65; 68; 69; 70; 71; 72; 74; 82; 83; 84; 85;<br />
96; 98; 101; 104; 105; 106; 109; 110; 111;<br />
118; 119; 129; 131; 134; 139; 140; 142;<br />
144; 146; 147; 150; 155; 159; 160; 161;<br />
162; 164; 167; 168; 171; 174; 179; 181;<br />
182; 183; 184; 185; 186; 188; 190; 191;<br />
195; 196; 197<br />
infosistema; 54; 56; 61; 162<br />
ingegneria del traffico; 5<br />
integralismi; 106; 114<br />
intelligenza artificiale; 26; 36; 37; 39; 124;<br />
174; 182<br />
intelligenza collettiva; 85<br />
intelligenza umana; 23; 37<br />
interconnessione globale; 7; 18<br />
interfaccia; 2; 44; 56; 67; 77; 180; 183; 187<br />
Internet; 2; 4; 10; 11; 13; 16; 67; 70; 73; 81;<br />
82; 85; 86; 87; 88; 89; 90; 92; 93; 94; 96;<br />
99; 104; 108; 111; 119; 129; 130; 133; 134;<br />
136; 137; 144; 145; 146; 147; 152; 155;<br />
156; 160; 162; 175; 176; 179; 180; 181;<br />
184; 185; 186; 187; 188; 190; 191; 193;<br />
194; 195; 197<br />
ipercorpo; 47; 50<br />
I<br />
iper-oggettività matematica; 61<br />
ipertesto; 43; 46; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 185;<br />
191; 195; 197<br />
ipertestuale; 2; 3; 46; 63; 64; 65; 66; 67; 68;<br />
71; 135; 162; 175; 181; 185<br />
ipertestualità; 63; 64; 65; 71; 188<br />
ipo-informazionale, scelta; 61<br />
K<br />
KANT; 26; 113; 192<br />
knowledge workers; 131; 132; 168<br />
KOHONEN, reti di; 38<br />
KOPPEL; 83<br />
L<br />
LAMARCK; 97<br />
LANDOW; 76; 195<br />
LANGTON; 175<br />
LAPLACE; 34<br />
learning by doing; 155<br />
lettura; 43; 44<br />
LÉVY; 41; 42; 44; 45; 63; 64; 65; 66; 68; 85;<br />
192<br />
literacy; 87<br />
LITMAN; 123; 192<br />
livello pragmatico; 58<br />
livello semantico; 58<br />
livello sintattico; 57; 58<br />
localismi; 106<br />
localizzazione; 102; 106; 107<br />
logica booleana; vedi booleana<br />
logica fuzzy; vedi fuzzy logics<br />
logica; 26; 185<br />
logiche polivalenti; 35<br />
LONGO; 23; 35; 36; 40; 98; 161; 172; 192<br />
LORLOCK; 19; 99<br />
lurker; 88;<br />
Lurker; 81; 88; 90; 137; 165; 185<br />
M<br />
maestro; 63; 70; 72; 152; 159<br />
maieutica; 151; 157; 159; 160<br />
mainframes; 2; 84<br />
MALDONADO; 10; 80; 192; 195<br />
Mar della Sonda; 35<br />
MARCONI; 105<br />
margine del caos; 34; 98; 185<br />
MARKOFF; 122; 192<br />
MARTINOTTI; 154; 195<br />
MARX; 127<br />
MASIERO; 85; 129; 195; 196<br />
matrice; 20; 186<br />
matrix; 2<br />
McCULLOCH; 174<br />
McKENNA; 109; 112; 196<br />
McLUHAN; 18; 20; 192<br />
meccanica quantistica; 39<br />
mediamorfosi; 96<br />
memoria; 32; 33; 42; 44; 69; 105; 155; 171;<br />
185; 186; 187<br />
met; 21<br />
metafisica; 31<br />
metamorfosi, principio di; 66<br />
200
Microsoft; 6; 14; 83; 115; 164; 186<br />
MILBURN; 67; 191; 192<br />
M. I. T. ; 13; 14; 28; 95; 124; 142; 155; 184;<br />
186<br />
MITNICK; 122; 196<br />
mito; 9; 12; 13; 18; 20; 21; 162; 192; 197<br />
mobilità dei centri, principio di; 66<br />
molteplicità, principio di; 66<br />
Mo Net; 111<br />
MORAVIA; 22<br />
MORIN; 151; 154; 196<br />
MORRIS; 122; 123; 180; 188; 197<br />
MORSE; 30<br />
MORTAIS LEE; 92<br />
multimediale; 46; 87; 157; 187; 194; 196<br />
multimedialità; 64; 139<br />
N<br />
narrazione collettiva; 23<br />
narrazioni; 9; 23<br />
NEGROPONTE; 5; 13; 14; 15; 27; 28; 29; 30;<br />
84; 134; 182; 192; 196<br />
NELSON; 65; 191<br />
neoismo; 93; 94<br />
neo-luddismo; 3; 81; 165<br />
net; 2; 89; 186; 188; 197; 198<br />
netiquette; 89; 138; 186; 197; 198<br />
Netscape; 6; 144; 145; 164; 181; 186; 187<br />
Networked Economy Conference; 135<br />
NEUMANN; 174<br />
neurale; 20; 38; 60; 184; 187; 188<br />
Neuromancer; vedi Neuromante<br />
Neuromante; 20; 30; 73; 120; 121; 180; 184;<br />
192<br />
newbie; 90<br />
newsgroup; 3; 88; 89; 169; 176; 180; 182; 188<br />
NEWTON; 27<br />
N.I.I.; 14; 118<br />
non sequenziale; 64; 65<br />
N.S.C.A.A.; 122<br />
O<br />
oblio; 171; 172<br />
omnipolis; 88; 102; 103<br />
O.M.P.I.; 140<br />
ordine; 34; 41; 98; 114; 121; 144; 181; 185;<br />
187<br />
ornitorinco; 6; 113; 192<br />
ORWELL; 16; 17; 21; 167<br />
P<br />
paideia; 70<br />
PAINE; 135<br />
PANDORA; 20<br />
PAPERT; 155<br />
PAPERT; 155; 192<br />
PARASCANDOLO; 157; 196<br />
PENROSE; 38<br />
PEPERZAK; 9; 196<br />
perceptron; 38; 174; 187<br />
percezione; 40; 47; 48; 51; 107; 175<br />
personal computer; 2; 84; 180; 186<br />
PIAGET; 155<br />
PITTS; 174<br />
plagiarismo; 93<br />
PLATONE; 157; 159<br />
plurimedialità; 64<br />
PointCast; 82<br />
polimedialità; 64<br />
POPPER; 82; 192; 193<br />
posta elettronica; 136; 137; 176; 180; 184;<br />
186; 188, vedi anche e-mail<br />
potenziometri; 20; 113<br />
privacy; 139; 145; 146; 147; 150; 171; 181;<br />
184; 198<br />
proiezione; 48<br />
PROMETEO; 20<br />
psicografia; 135; 147<br />
pull; 16; 82; 90; 104; 165; 187<br />
push; 67; 81; 82; 104; 105; 167; 187<br />
Q<br />
QUEAU; 5; 127; 140; 141; 142; 151; 160;<br />
162; 163; 168; 196<br />
R<br />
reale; 40; 41; 42; 45;<br />
realtà virtuale (RV); 40; 48; 49; 50; 187; 193;<br />
194; 195<br />
regole del marketing mix; 129<br />
reichautobahn; 118<br />
reingegnerizzazione dei processi; 111<br />
relatività speciale o ristretta, teoria della; 27<br />
rete; 2; 3; 5; 7; 9; 10; 11; 20; 23; 30; 38; 43;<br />
46; 50; 54; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68;<br />
75; 81; 83; 85; 86; 88; 89; 90; 92; 104;<br />
109; 110; 113; 116; 117; 118; 119; 120;<br />
121; 122; 123; 126; 127; 129; 132; 134;<br />
135; 136; 137; 138; 143; 146; 147; 165;<br />
169; 170; 172; 174; 175; 179; 180; 181;<br />
182; 183; 184; 185; 186; 187; 188; 195;<br />
197, vedi anche Internet, net, matrix<br />
rete civica; 109; 111, 112<br />
reti; 2; 4; 12; 17; 18; 38; 43; 47; 48; 66; 73;<br />
84; 109; 111; 114; 127; 147; 165; 174; 175;<br />
180; 182; 185; 187; 194<br />
reti neurali; 69<br />
re-training; 158<br />
RHEINGOLD; 115; 197<br />
riduzionismo; 33; 58; 59<br />
RIFKLIN; 131; 193<br />
robotica; 175<br />
RODOTÀ; 108; 146; 148; 149; 154; 193; 196<br />
ROSENBLATT; 174<br />
rovesciamenti; 49<br />
RUMELHART; 38; 182<br />
RUSSO; 121; 122; 123; 125; 196; 197<br />
R.V.; vedi realtà virtuale<br />
saggio di profitto; 127<br />
San Diego; 6<br />
SCHWARTZ; 133; 191<br />
scrittura; 44; 194<br />
SEARLE; 22<br />
serendipity; 83<br />
S<br />
201
SERRES; 42; 193<br />
SHANNON; 22; 56; 57; 58; 59<br />
SHANNON, teoria di; 57<br />
SHIMOMURA; 122; 193<br />
significato; 18; 57; 58; 76<br />
silent speech; 70<br />
Slate; 83<br />
smart agent; 60; 69; 82; 83; 182; 184; 188<br />
smart community; 112<br />
smaterializzazione; 30; 74; 127; 140<br />
smiley; 89; 176; 177; 179; 184; 188<br />
software; 45; 60; 67; 82; 107; 122; 123; 124;<br />
127; 140; 141; 142; 143; 169; 181; 182;<br />
183; 184; 185; 186; 187; 188<br />
SOMENZI; 36<br />
sostenibilità; 166<br />
spamming; 137; 138; 187<br />
spazialità; 43<br />
spazio; 26; 27; 30; 31; 32; 33; 44; 66; 67; 102;<br />
103; 104; 164<br />
spazio-tempo; 27; 47; 191<br />
STAGLIANÒ; 16; 67; 81; 82; 87; 88; 134;<br />
137; 145; 146; 155; 156; 160; 162; 175;<br />
193<br />
STALLMAN; 123; 141; 142; 197<br />
standardizzare; 105<br />
statistica; 57<br />
STERLING; 113; 184; 197<br />
strabismo; 10; 11; 108; 129; 194<br />
sublime tecnologico; 76; 77; 194<br />
surfing; 88<br />
T<br />
tecnocrazia; 108<br />
tecnologia; 2; 4; 7; 11; 12; 15; 16; 20; 26; 43;<br />
44; 51; 69; 71; 73; 75; 76; 84; 87; 100;<br />
109; 112; 120; 123; 130; 131; 152; 156;<br />
158; 167; 168; 171; 191; 195<br />
telefono; 6; 47; 48; 105; 108; 184<br />
telegeografia; 154; 195<br />
telelavoro; 12; 129; 130; 132<br />
televisione; 6; 9; 13; 15; 16; 18; 47; 69; 71;<br />
81; 82; 91; 96; 105; 152; 192; 193<br />
tempo; 19; 26; 27; 29; 30; 31; 32; 33; 49; 55;<br />
70; 71; 103; 106; 174; 193<br />
testo sequenziale; 67; 68<br />
topologia, principio di; 66<br />
traduttore universale; 21<br />
TURING; 25; 36; 37; 194<br />
TV; vedi televisione<br />
ULAM; 174<br />
ULLMAN; 27<br />
Unix; 124; 188<br />
urbanesimo; 102<br />
U<br />
USA; 13; 86; 128; 133; 142; 179; 181; 182<br />
Stati Uniti; 13; 14; 118; 119<br />
user friendly; 53; 60; 69; 70; 131<br />
utopia; 20<br />
V<br />
VALENTINETTI; 85; 193<br />
VALERI; 119; 191<br />
valorizzazione delle vanità; 127; 136<br />
VAN GOGH; 79<br />
VETTRAINO SOULARD; 13; 197<br />
view; 135<br />
villaggio globale; 16; 18; 20<br />
VIRILIO; 4; 5; 7; 12; 74; 102; 103; 118; 197<br />
virtual reality; 7; vedi anche realtà virtuale<br />
Virtuale; 7; 40; 41-47; 49; 50; 60; 71; 74; 75;<br />
103; 108; 113; 114; 115; 117; 127;<br />
128;129; 130; 132; 143; 148; 151; 152;<br />
156; 163; 193<br />
virtualis; 41<br />
virtus; 41<br />
V.R.M.L.; 3; 7; 181; 188<br />
W<br />
Wall Street; 133; 181<br />
WALLACE; 137; 138<br />
web; 2; 6; 10; 13; 67; 82; 88; 133; 144; 145;<br />
145; 171; 181; 183-188; 190; 191; 195<br />
webonomics; 133; 191<br />
WEINZEBAUN; 37<br />
Well; 116<br />
WELLES; 85; 193<br />
WILLIAM; 38; 115; 182; 197<br />
Windows-95; 115; 124<br />
WINKLER; 115; 118; 197<br />
Wired; 133; 191<br />
WITTGENSTEIN; 157<br />
WOLF; 104; 105; 197<br />
word-key; 133; 188<br />
worm; 123<br />
WWW; 2; 181; 188<br />
Xanadu, progetto; 65; 191<br />
Yahoo; 133; 198<br />
zapping; 71; 191<br />
Zeus; 20<br />
X<br />
Y<br />
Z<br />
202
SOMMARIO<br />
Introduzione................................................................................................................2<br />
Premessa metodologica ...........................................................................................2<br />
Prima parte........................................................................................................................8<br />
Miti e utopie ................................................................................................................9<br />
Lo strabismo telematico .................................................................................. 10<br />
La scomparsa dei Dinosauri .......................................................................... 15<br />
Il Grande Fratello e Villaggio Globale........................................................ 16<br />
Cybionte e cyborg ............................................................................................. 19<br />
Il traduttore universale.................................................................................... 21<br />
Fisica, Logica e IA................................................................................................... 26<br />
Spazio, tempo ..................................................................................................... 26<br />
Atomo, Bit ............................................................................................................ 28<br />
Cyber-spazio. ...................................................................................................... 30<br />
Infinito, Caos ....................................................................................................... 32<br />
Logiche polivalenti ........................................................................................... 35<br />
Intelligenza Artificiale (IA) ............................................................................ 36<br />
Percezione ................................................................................................................. 40<br />
Virtuale ................................................................................................................. 40<br />
Il corpo virtuale.................................................................................................. 46<br />
Realtà Virtuale (RV).......................................................................................... 50<br />
Infosistema ................................................................................................................ 53<br />
Velocità dell’Informazione............................................................................. 53<br />
I pesi dell’Informazione .................................................................................. 55<br />
Smart Agents....................................................................................................... 59<br />
Scelta ipo-informazionale............................................................................... 60<br />
Conoscenza............................................................................................................... 62<br />
Hypertext ............................................................................................................. 62<br />
Chi è l’autore dell’hypertext. ......................................................................... 66<br />
Ergonomia Intellettuale................................................................................... 67<br />
La nuova figura di maestro............................................................................ 69<br />
Estetica della tecnica.............................................................................................. 72<br />
Estetica della sparizione.................................................................................. 72<br />
Il sublime tecnologico ...................................................................................... 75<br />
Seconda parte ................................................................................................................ 79<br />
I Lurkers ..................................................................................................................... 80<br />
Push VS. Pull....................................................................................................... 80<br />
La società che cambia....................................................................................... 83<br />
Il popolo della rete............................................................................................ 85<br />
Luther Blissett..................................................................................................... 89<br />
Gaia.............................................................................................................................. 94<br />
L’Homo Symbioticus........................................................................................ 94<br />
Ecologia................................................................................................................. 98<br />
Omnipolis................................................................................................................101<br />
Glocalizzazione................................................................................................101<br />
Modernizzare la democrazia?.....................................................................107<br />
Comunità virtuali............................................................................................111<br />
Le nuove colonizzazioni...............................................................................116<br />
Mondo Hackers ................................................................................................119<br />
Censura ...............................................................................................................124<br />
203
Valorizzazione delle vanità...............................................................................126<br />
Globalizzazione................................................................................................127<br />
Telelavoro ..........................................................................................................128<br />
Commercio in rete...........................................................................................131<br />
Spamming..........................................................................................................136<br />
Cookies .....................................................................................................................138<br />
Copyright & Copyleft ....................................................................................138<br />
Cookies................................................................................................................143<br />
Privacy ................................................................................................................145<br />
Scuola dietetica in vista di una maieutica ....................................................150<br />
Apartheid informatica ...................................................................................150<br />
Storia dei fallimenti tecnologici nella scuola..........................................154<br />
Verso una maieutica di fine millennio .....................................................155<br />
Conseguenze................................................................................................................160<br />
Conseguenze parte I ............................................................................................160<br />
Conseguenze parte II...........................................................................................162<br />
Sociologia ...........................................................................................................162<br />
Etica planetaria.................................................................................................164<br />
Politica.................................................................................................................165<br />
Economia............................................................................................................166<br />
Sapere ..................................................................................................................167<br />
Problemi giurisprudenziali..........................................................................169<br />
(Controllo globale) ........................................................................................169<br />
(Privacy) .........................................................................................................170<br />
(Limiti nazionali) ..........................................................................................171<br />
Appendici .....................................................................................................................173<br />
Appendice 1: Le reti neurali..............................................................................173<br />
Appendice 2: Estremismi ...................................................................................174<br />
Appendice 3: Smiley ............................................................................................175<br />
Smiley elementari............................................................................................176<br />
Variazioni sul tema .........................................................................................176<br />
Smiley orientali ................................................................................................178<br />
Appendice 4: Storia della rete...........................................................................178<br />
Anni 60................................................................................................................178<br />
Anni 70................................................................................................................179<br />
Anni 80................................................................................................................179<br />
Anni 90................................................................................................................179<br />
Glossario .......................................................................................................................181<br />
Bibliografia ...................................................................................................................189<br />
Bibliografia cartacea .............................................................................................189<br />
Articoli ................................................................................................................189<br />
Libri......................................................................................................................190<br />
Bibliografia informatica......................................................................................192<br />
Articoli ................................................................................................................192<br />
Libri......................................................................................................................196<br />
Siti.........................................................................................................................196<br />
Indice Analitico...........................................................................................................198<br />
Sommario......................................................................................................................203<br />
204