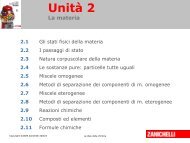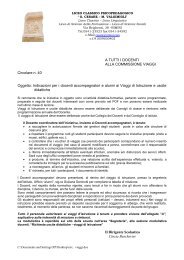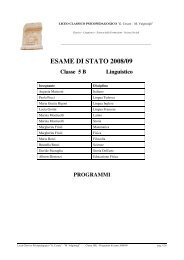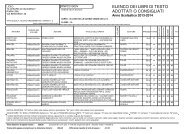esame di stato 2008/09 - Liceo Classico Psicopedagogico Cesare ...
esame di stato 2008/09 - Liceo Classico Psicopedagogico Cesare ...
esame di stato 2008/09 - Liceo Classico Psicopedagogico Cesare ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
LICEO CLASSICO PSICOPEDAGOGICO "G. <strong>Cesare</strong> – M. Valgimigli"<br />
<strong>Classico</strong> - Linguistico - Scienze della Formazione - Scienze Sociali<br />
_____________________________________________________<br />
ESAME DI STATO <strong>2008</strong>/<strong>09</strong><br />
Classe III D CLASSICO<br />
CONSIGLIO DI CLASSE<br />
Insegnanti Materie<br />
Sonia Trubbianelli Italiano e Latino<br />
Marinella De Luca Greco<br />
Dalmazio Rossi Storia e Filosofia<br />
Elena Benigni Matematica e Fisica<br />
Sara Fabbrizioli Scienze<br />
Angela Delucca Inglese<br />
Lorenza Bonifazi Storia dell’Arte<br />
Giuseppina Trigila Educazione fisica<br />
Alessandro don Zavattini Religione<br />
PROGRAMMI SVOLTI<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 1/53
ITALIANO<br />
Testi adottati: coor<strong>di</strong>namento <strong>di</strong> Ezio Raimon<strong>di</strong>, autori M.Anselmi - G.Fenocchio, “Tempi e<br />
immagini della letteratura”, vol.3b-4-5-6, E<strong>di</strong>zioni B. Mondadori.<br />
A.M.Chiavacci Leonar<strong>di</strong>, Dante Alighieri - Para<strong>di</strong>so,E<strong>di</strong>zioni Zanichelli.<br />
Il percorso <strong>di</strong> lettura del Para<strong>di</strong>so comprende il commento e la parafrasi dei canti: I, II (1-45), III,<br />
VI, XI, XV, XVII, XXII (V. 133 – 154), XXX (38-132) , XXXI (1-30/52-90), XXXIII.<br />
Il Romanticismo: inquadramento culturale generale - TOMO 3b /4<br />
Percorsi<br />
Uomo e natura : Il paesaggio.<br />
Tempo fisico e tempo della coscienza: l’idea eroica della morte e della vita. Il concetto <strong>di</strong> “genio”.<br />
Preromanticismo e Romanticismo: la concezione della storia, <strong>di</strong> nazione e <strong>di</strong> popolo.<br />
Classicismo e Romanticismo: l’idea <strong>di</strong> poesia.<br />
Romanticismo europeo ed italiano: p.35-43; p.140-163.<br />
Le patrie del Romanticismo europeo: cenni al romanticismo inglese e francese, p.50-54; il<br />
romanticismo tedesco p.71-74.<br />
L’eroe romantico (p.55-67).<br />
Il Romanticismo italiano, p.140-144.<br />
Il romanzo storico dell’ottocento: p.214-216: una lettura a scelta.<br />
Letture con analisi tematica e formale:<br />
Dal Manfred, <strong>di</strong> G. Byron: “ L’energia dell’eroe romantico”,p.58.<br />
Spirito classico e spirito romantico, <strong>di</strong> A.W. Schlegel, p.145.<br />
Una nuova mitologia, <strong>di</strong> F. Schlegel, p.75<br />
Primo inno alla notte, <strong>di</strong> Novalis, p.81.<br />
M.me de Stael, De l’Alemagne ( sintesi del contenuto), p.111-141.<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 2/53
Il Conciliatore, Pubblico e scopi del gruppo romantico italiano: “Il programma”- confronto con le<br />
riviste “La biblioteca italiana” e “L’antologia”, p.154.<br />
G: Berchet, Lettera semiseria <strong>di</strong> Grisostomo al suo figliuolo, “Il nuovo pubblico della letteratura”,<br />
p.150.<br />
La natura della poesia moderna, <strong>di</strong> L. <strong>di</strong> Breme, p.157.<br />
Il manifesto ironico <strong>di</strong> un grande poeta: Carlo Porta: “El romanticism”, p.161.<br />
Autori<br />
A. Manzoni: vita, opere e poetica<br />
G.Leopar<strong>di</strong>: vita, opere e poetica.<br />
Testi<br />
ALESSANDRO MANZONI:<br />
Gli Inni Sacri, La pentecoste, , p 327.<br />
Le O<strong>di</strong> civili: Il cinque Maggio, p.333.<br />
La lettera a Claude Fauriel, Romanzo storico e romanzesco, p.377.<br />
La lettera a Ms. Chauvet, Poesia e storia, , p. 365<br />
Prefazione al Conte <strong>di</strong> Carmagnola: Riflessione sul teatro, p.339-343.<br />
Le trage<strong>di</strong>e : Adelchi, Dopo la sconfitta: 1° coro, p.348; Il solo riscatto possibile: 3° coro, p.355.<br />
I Promessi sposi: confronto tra le e<strong>di</strong>zioni del ’27 e del ’40:<br />
La revisione linguistica; La rinuncia al romanzesco: Il Conte del Sagrato e l’Innominato, p.392-<br />
398.<br />
Lettura con analisi e commento dei capitoli XIX, XX, XXI,XXII, (l’Innominato).<br />
La produzione saggistica manzoniana: gli scritti linguistici, p.414-415. Testo: Lingua parlata e<br />
lingua letteraria, p.419<br />
Un uso uniforme della lingua, p.420.<br />
GIACOMO LEOPARDI:<br />
Discorso <strong>di</strong> un italiano intorno alla poesia romantica, p.444-445.<br />
L’ideologia politica e civile: Le canzoni All’Italia, Sopra il monumento <strong>di</strong> Dante, Ad Angelo<br />
Mai,p.445-446.<br />
Il linguaggio dell’indefinito: gli I<strong>di</strong>lli, p.448: L’infinito, Alla luna, p. 454-461.<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 3/53
Le Canzoni filosofiche del 1822, p.447: Ultimo canto <strong>di</strong> Saffo, p. 450.<br />
Le Operette morali, p.463467: Dialogo della natura e <strong>di</strong> un Islandese,p.476; Dialogo <strong>di</strong> un<br />
ven<strong>di</strong>tore <strong>di</strong> almanacchi e <strong>di</strong> un passeggere, p.482; Dialogo <strong>di</strong> Tristano e <strong>di</strong> un amico, p.484.<br />
Lo Zibaldone, p.493 :143-144; 646-648;4418-4426, p.494-497. In fotocopia: 1744-1745, 1927-<br />
1929, 169-170.<br />
I canti pisano-recanatesi, p.501: A Silvia, p.504; La quiete dopo la tempesta, p507;Il sabato del<br />
villaggio, p.510; Canto notturno <strong>di</strong> un pastore errante dell’Asia, p. 513.<br />
L’ultimo Leopar<strong>di</strong>: La ginestra, p.540.<br />
In fotocopia: Lettera al Giordani del 2 marzo1818- Lettera al Giordani del 19 novembre 1819-<br />
Naturalismo–Simbolismo- Decadentismo:inquadramento culturale – generale - TOMO 5 e<br />
fotocopie<br />
Percorsi<br />
Uomo e natura: il Positivismo europeo ed italiano<br />
Naturalismo e Verismo<br />
Me<strong>di</strong>cina e scienza<br />
Sociologia e psicoanalisi – Gli orientamenti filosofici del primo novecento (fotocopie).<br />
La civiltà <strong>di</strong> massa e il ruolo del poeta tra simbolismo e decadentismo.<br />
Le Avanguar<strong>di</strong>e: Fauves, Die Brucke, Cubismo, Futurismo.<br />
I poeti maledetti.<br />
La crisi delle certezze nella cultura del novecento.<br />
Il romanzo: tipologie, generi, autori e titoli <strong>di</strong> fine secolo.<br />
La poesia.<br />
Letture con analisi tematica e formale<br />
E. Zola, “Il romanzo sperimentale”; Il ciclo dei Rougon – Macquart.<br />
L. Capuana, Stu<strong>di</strong> sulla letteratura contemporanea,”Il vero e la conquista della forma”, p.131.<br />
Autori<br />
I poeti maledetti: C. Baudelaire, P.Verlaine, A. Rimbaud, S. Mallarmè<br />
Giovanni Verga: vita, opere e poetica.<br />
G. D’Annunzio, vita ,opere e poetica.<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 4/53
G. Pascoli, vita, opere, poetica.<br />
Testi<br />
C. BAUDELAIRE, da “I fiori del male”, p.279-290:<br />
L’albatro<br />
Corrispondenze<br />
Spleen<br />
Lo straniero<br />
P.VERLAINE, p.291:<br />
Arte poetica.<br />
A: RIMBAUD, p.297:<br />
Vocali, p.297<br />
Il battello ebbro, p.300<br />
Lo sregolamento dei sensi, da “Una stagione all’inferno”, p.298-299<br />
“La lettera del veggente”, p.303-304.<br />
GIOVANNI VERGA:<br />
Da “I Malavoglia”:<br />
Prefazione; Capitoli1,2,3,5,9,15, con analisi e commento dei contenuti e dello stile.<br />
LUIGI PIRANDELLO:<br />
Saggio sull’’umorismo,p.657-659; Il flusso continuo della vita, p.659.<br />
I romanzi “umoristici”: da “Il fu Mattia Pascal”( trama), Un impossibile ritorno (cap.18),p.668-679.<br />
Da “Uno, nessuno e centomila”(trama),; Non conclude,p. -686.<br />
Il teatro e la raccolta “Maschere nude” (cronologia e temi)<br />
Lettura integrale dell’ Enrico IV, con commento dei contenuti.<br />
GABRIELE D’ANNUNZIO:<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 5/53
Da “Le lau<strong>di</strong>: Maia”: “L’incontro con U lisse” (fotocopia).<br />
Da “Le lau<strong>di</strong>: Alcyone”:<br />
La sera fiesolana, p.397.<br />
La pioggia nel pineto,p. 400..<br />
Le “Prose <strong>di</strong> romanzi”:<br />
Da “Il piacere”: L’attesa <strong>di</strong> Elena, p.413; Un esteta <strong>di</strong> fine secolo , p. 420-423.<br />
Da “Le vergini delle rocce”: “L’etica del superuomo”,p.424.<br />
Da “Il fuoco”: “Il fauno nel labirinto”, p.429.<br />
GIOVANNI PASCOLI:<br />
Il fanciullino, E’ dentro noi un fanciullino, p.321. La poetica pascoliana.<br />
Da “ Myricae”:<br />
Lavandare, Scalpitio, Temporale, Il lampo,Il tuono, X Agosto, L’assiuolo.<br />
Da “ I Canti <strong>di</strong> Castelvecchio”:<br />
Nebbia, La mia sera.La poesia (fotocopia).<br />
Da “I primi poemetti”: L’aquilone (fotocopia).<br />
Da “ I poemi conviviali”:<br />
Ulisse e Calypso<br />
Scheda: Contini Gianfranco, “I <strong>di</strong>versi linguaggi pascoliani”, p.328.<br />
Il sogno <strong>di</strong> una vita bella. Bellezza, Arte, Vita.(pp. 451-468): L’ESTETISMO.<br />
Testi:<br />
Da “Il ritratto <strong>di</strong> Dorian Gray” <strong>di</strong> O. Wilde:Un decalogo dell’estetismo.<br />
Un nuovo museo <strong>di</strong> A. Conti;<br />
Nella <strong>di</strong>mora <strong>di</strong> Des Esseintes <strong>di</strong> Huysmans;<br />
La Gioconda <strong>di</strong> W. Pater.<br />
Totò Merumeni, <strong>di</strong> G. Gozzano con cenni alla poetica crepuscolare.<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 6/53
IL FUTURISMO (p.500 – 537)<br />
La personalità <strong>di</strong> Filippo Tommaso Marinetti.<br />
La rivista Poesia; I manifesti futuristi; Gli autori principali; Le altre arti; Le riviste.<br />
Il Manifesto tecnico della letteratura futurista.<br />
La poesia paroliberista: “Bombardamento”, p.521; “Campana <strong>di</strong> chiaro <strong>di</strong> luna”, p.524;”La<br />
fontana malata”, p.541.<br />
Percorsi poetici del novecento, vol. 6.<br />
TEMA: La poesia del novecento – linee generali<br />
GIUSEPPE UNGARETTI<br />
L’allegria<br />
Eterno, p.367<br />
In memoria, p.369<br />
Il porto sepolto,p.371<br />
Veglia, p.372<br />
Sono una creatura, p.375<br />
I fiumi, p.377<br />
Dolina notturna, p.382<br />
Soldati, p.384<br />
Il dolore<br />
Tutto ho perduto, p.390<br />
Non gridate più, (fotocopia)<br />
SAGGI<br />
Il valore della poesia, p.391<br />
EUGENIO MONTALE<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 7/53
Ossi <strong>di</strong> seppia:<br />
I limoni, p.407<br />
Non chiederci la parola, p.411(con scheda “Esistenzialismo e poesia”, p.413)<br />
Meriggiare pallido e assorto, p.414<br />
Forse un mattino andando in un’aria <strong>di</strong> vetro, p.416<br />
Le occasioni<br />
Non recidere forbice quel volto (fotocopia)<br />
La casa dei doganieri (fotocopia).<br />
La bufera e altro<br />
L’anguilla, p.432<br />
Piccolo testamento, p.435<br />
Satura<br />
Ho sceso dandoti il braccio…,p.440<br />
Non ho mai capito se io fossi, (fotocopia)<br />
SAGGI<br />
Esistenzialismo e poesia, p.413<br />
Confronto tra la pittura metafisica <strong>di</strong> De Chirico e la poesia metafisica <strong>di</strong> Montale (fotocopia)<br />
Le donne <strong>di</strong> Montale, (fotocopia)<br />
UMBERTO SABA<br />
Canzoniere<br />
Ulisse (fotocopia)<br />
La capra, p.331<br />
Trieste, p.333<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 8/53
Testi: “Letteratura latina” <strong>di</strong> Pontiggia – Gran<strong>di</strong>, vol.3<br />
LATINO<br />
“Forum” - Versioni latine e attività linguistiche per il triennio” <strong>di</strong> Signoracci-Dossi<br />
“Scrittori dell’età imperiale” – Antologia <strong>di</strong> brani scelti : SENECA - TACITO<br />
FINALITA’ e OBIETTIVI GENERALI<br />
• Saper leggere in modo significativo un testo latino, in<strong>di</strong>viduando gli elementi culturali che lo<br />
mettono in relazione con il pensiero e il linguaggio delle letterature europee; saper cogliere il<br />
rapporto <strong>di</strong>namico tra passato e presente e il suo valore <strong>di</strong> civiltà e <strong>di</strong> cultura <strong>di</strong> lunga durata.<br />
• Saper tradurre, comprendere ed interpretare i testi latini con consapevolezza, riconoscendo gli<br />
elementi fondamentali del sistema linguistico, grammaticale, sintattico, metrico e retorico; enucleare<br />
e dedurre il pensiero e lo stile <strong>di</strong> ogni singolo autore anche in considerazione del contesto in cui<br />
opera; operare in modo autonomo la rielaborazione critica degli argomenti, materia <strong>di</strong> programma.<br />
Storia della letteratura :<br />
• CONTENUTI<br />
*Rilettura e approfon<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> un poeta dell’età augustea:<br />
Ovi<strong>di</strong>o – Vita e opere; Lettura in traduzione: “Il mito <strong>di</strong>Pigmalione”.<br />
Lettura dal latino, con traduzione e commento, delle Metamorfosi:<br />
Dedalo e Icaro, VIII,183-235.<br />
Filèmone e Bàuci, VIII, 626-720.<br />
• CONTENUTI<br />
* Ideologia e cultura nell’età <strong>di</strong> Tiberio, Caligola e Clau<strong>di</strong>o.<br />
La storiografia filoimperiale in Velleio Patercolo e Valerio Massimo;<br />
confronto con Livio e Tacito.<br />
Curzio Rufo: la storiografia romanzata.<br />
Cremuzio Cordo: la storiografia del <strong>di</strong>ssenso.<br />
Documenti: Il processo e la morte <strong>di</strong> Cremuzio Cordo nei racconti <strong>di</strong> Seneca e Tacito, p.19.<br />
AUTORI E TESTI<br />
Velleio Patercolo – Historiae II, 127-128 (Elogio <strong>di</strong> Seiano)<br />
Lettura in traduzione e commento,p.23. Testi <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>mento, p.25-26.<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 9/53
Valerio Massimo – Factorum et <strong>di</strong>ctorum memorabilium libri,Un sogno premonitore:(versionario,<br />
p.302-303).<br />
Curzio Rufo – Historiae Alexandri Magni, (contenuto e forme dell’opera): una storia romanzata.<br />
• CONTENUTI<br />
* L’età Neroniana; rapporti tra cultura e potere, nuove sperimentazioni stilistiche ed<br />
espressioni <strong>di</strong> spettacolarità.<br />
Il ruolo del Sapiens: Seneca, vita e opere.<br />
Canoni poetici e gusto ellenizzante: i generi poetici.<br />
La poesia epica <strong>di</strong> Lucano, vita e opere.<br />
Il romanzo <strong>di</strong> Petronio, vita e opere.<br />
AUTORI E TESTI<br />
Seneca<br />
Consolatio ad Marciam, 19,3-20,3, p.178 – la consolazione come genere letterario e suo impianto<br />
filosofico; lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Consolatio ad Polybium, 7, p. 186 – un <strong>di</strong>fficile rapporto con il potere; lettura in traduzione e<br />
contestualizzazione.<br />
De ira,III, 17-19, p.181- III, 36, p.184: la teoria del <strong>di</strong>spotismo illuminato ( confronto con il De<br />
clementia sulla virtù politica del principe e sulla necessità <strong>di</strong> un continuo <strong>di</strong>alogo con se stessi);<br />
lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Apokolokyntosis,5-7,1 (Clau<strong>di</strong>o sale in cielo) , p.207– lo stile della satira menippea e l’ironia<br />
paro<strong>di</strong>stica – lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Epistulae morales ad Lucilium, 1,1-5 (Il tempo e la morte), p.191: approfon<strong>di</strong>mento sul tema del<br />
tempo (confronto con il De brevitate vitae); lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Epistulae morales ad Lucilium, 2(Le letture), p.193: la sapientia è contraria alla curiositas; lettura in<br />
traduzione e contestualizzazione.<br />
Epistulae morales ad Lucilium, 8,1-7 (La libertà del saggio), p.197: “libertas e secessus”; lettura in<br />
traduzione e contestualizzazione.<br />
Epistulae morales ad Lucilium, 41, 1-5 (Dio è in noi),p. 198: il sapiente ed il sublime naturale;<br />
lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Epistulae morales ad Lucilium, 108, 1-7; 13-29 (L’epoca della mia prima giovinezza: gli stu<strong>di</strong><br />
filosofici), p.203 - lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Documenti: La morte <strong>di</strong> Seneca nel racconto <strong>di</strong> Tacito, p.170.<br />
INCONTRO CON L’OPERA: DE BREVITATE VITAE<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 10/53
Tempo e saggezza in Seneca (i brani seguenti sono dal latino):<br />
Brev. vit., 1; 2, 1-3; 4, 1-5; 5; 8; 18, 1-4; 19, 1-2.<br />
Lucano<br />
Pharsalia, I,129-157(La quercia e il fulmine),p.103: l’epos dell’antimito romano.<br />
Pharsalia,VI, 719-830 (Macabro rito <strong>di</strong> necromanzia),p. 106: con letture parallele sul tema della<br />
nekyomanteia: macabra esasperata ricerca del pathos, p.112.<br />
Confronto con l’epos <strong>di</strong> Virgilio, Ovi<strong>di</strong>o e Stazio.<br />
Petronio<br />
Breve storia del romanzo e il romanzo a Roma: confronto con Apuleio.<br />
Il problema dei generi e dei modelli .<br />
Satyricon (trama):<br />
Satyr. 132, 15, p. 263 (Un’ambigua <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> poetica).<br />
Satyr. 1-4, p.239 ( Una <strong>di</strong>sputa “De causis corruptae eloquentiae) - su questo problema confronto<br />
con Quintiliano e Tacito.<br />
Satyr. 32 – 34, p. 241 ( A cena da Trimalchione): su questa lettura fare un’attenta analisi dei<br />
contenuti incentrati sul problema della morte e del tempo, da confrontare con Seneca e Agostino.<br />
Satyr. 61 – 64, p.246 ( Storie <strong>di</strong> lupi mannari e streghe): una lettura <strong>di</strong> puro intrattenimento e <strong>di</strong><br />
evasione per un pubblico semplice.<br />
Satyr. 110, 6 – 113,2, p.255 (La matrona <strong>di</strong> Efeso): la fabula milesia nel romanzo. Documenti:<br />
Ritratto <strong>di</strong> Petronio, da Tacito, p.233.<br />
Film: Il Satyricon <strong>di</strong> Fellini.<br />
• CONTENUTI<br />
* L’età dei Flavi e <strong>di</strong> Traiano; l’ideologia del “buon burocrate” e “l’utile come scopo”; i generi<br />
letterari tornano al classicismo <strong>di</strong> maniera.<br />
Gli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> grammatica e <strong>di</strong> retorica: Quintiliano, vita e opere.<br />
L’epica e la poesia e il ritorno al mito: Stazio, vita e opere.<br />
La poesia epigrammatica: Marziale, vita e opere.<br />
La cultura enciclope<strong>di</strong>ca: Plinio il vecchio,vita e opere.<br />
AUTORI E TESTI<br />
Quintiliano<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 11/53
Institutio oratoria, I,2,17-29, p.280 (Vantaggi della scuola pubblica e gradualità<br />
dell’appren<strong>di</strong>mento) : l’ottimismo educativo quintilianeo.Lettura in traduzione e<br />
contestualizzazione.<br />
Istitutio oratoria,I,8,1-5, p.282 (Il valore formativo delle letture):– l’appren<strong>di</strong>mento dei valori<br />
umani. Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Istitutio oratoria, X,I,125-131, p.283(Lo stile corruttore <strong>di</strong> Seneca): <strong>di</strong>scussione sugli stili e<br />
confronto con Tacito sulle cause della corruzione dell’eloquenza. Lettura in traduzione e<br />
contestualizzazione.<br />
Stazio<br />
Thebais XI, 518 – 595, p.304 (Il duello mortale tra Eteocle e Polinice): il tema della guerra civile e<br />
confronto con Lucano sui temi e gli stili.. Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Marziale<br />
Epigrammata, I,4 a,b, c, d : la poetica; la polemica contro l’epos mitologico;<br />
ritrarre la vita senza retorica. Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Epigrammata, I,10; I,47; II,38; VIII,10; X,8; X,91: gli epigrammi satirici. Lo schema del Lessing.<br />
Letture in traduzione e contestualizzazione.<br />
Liber de spectaculis,7 (Spettacoli: un cruento pantomimo): carattere scenografico e visivo della<br />
Roma <strong>di</strong> Tito. Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Documenti: Il libro “De spectaculis”; M.Citroni e l’epigramma <strong>di</strong> Marziale.<br />
Plinio il Vecchio<br />
Naturalis historia,VII,21-32 passim (Miracula naturae): excursus etnografici tra monstra e<br />
mirabilia- Mirabilia e curiosità: un compen<strong>di</strong>o spettacolare <strong>di</strong> informazioni; il pessimismo plinianeo<br />
sull’uomo; letture in traduzione e contestualizzazione.<br />
Documenti: Plinio il Giovane:- “Vita e morte <strong>di</strong> Plinio il Vecchio”- lettere ,III,5; VI,16; VI,20.<br />
• CONTENUTI<br />
* L’età <strong>di</strong> Traiano, Adriano e degli Antonini: il consolidamento del limes<br />
dell’impero e le suggestioni dell’”altrove”: Roma e i Barbari.<br />
Un brillante uomo politico: Plinio il Giovane.<br />
La posizione storiografica <strong>di</strong> Tacito: vita e opere.<br />
Apuleio un uomo dei tempi nuovi: vita e opere.<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 12/53
AUTORI E TESTI<br />
Plinio il Giovane.<br />
Panegyricus Traiano imperatori 64: tra adulazione e retorica, confronto con il De clementia <strong>di</strong><br />
Seneca. Brano in traduzione e contestualizzazione.<br />
Epistulae VIII, 8 - IX, 36, p.378 - 380 (Le fonti del Clitumno; Dalla villa in Tuscis): forte<br />
descrittivismo e desiderio <strong>di</strong> gloria - arte ed eru<strong>di</strong>zione.<br />
Epistulae X, 96 – 97, p.382 (Carteggio con Traiano): la questione dei cristiani.<br />
Tacito<br />
Dialogus de oratoribus, 36, p.408 (L’antica fiamma dell’eloquenza) – Il problema della decadenza<br />
della oratoria. Lettura in traduzione e contestualizzazione. Confronto con Tacito e Petronio.<br />
Annales, IV,32-33 (Infelicità dello storico moderno) – Un’ analisi della corruzione dei tempi. Lettura<br />
in traduzione e contestualizzazione.<br />
Annales, XIV,3-10 (Il matrici<strong>di</strong>o), p.433 – Un esempio <strong>di</strong> narrazione drammatica e suggestiva.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione (Si ricor<strong>di</strong>no anche i passi degli Annales relativi alle<br />
figure <strong>di</strong> Seneca e Petronio già citati).<br />
Historiae,I,1-3; III,83 (Il proemio; Il degrado morale del popolo romano) – La tesi politica tacitiana<br />
e il confronto con la storiografia giulio-clau<strong>di</strong>a. Letture in traduzione e contestualizzazione.<br />
Agricola,1-3 (Il proemio): un confronto tra passato e presente e damnatio memoriae <strong>di</strong> Domiziano.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Agricola,42, p.412(L’antieroismo esemplare <strong>di</strong> Agricola): gran<strong>di</strong> uomini sotto cattivi principi.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Dal latino: Agr., 30, 2-4; 31, 1-2 ( dal versionario): il <strong>di</strong>scorso <strong>di</strong> Càlgaco ai Calèdoni.<br />
Dal latino: Ann., V, 4 (in fotocopia): riti religiosi degli Ebrei, un excursus storico.<br />
INCONTRO CON L’OPERA: LA GERMANI A (De origine et situ Germanorum)<br />
Un popolo affascinante e pericoloso ( i brani che seguono sono dal latino):<br />
10, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 26, 27, 45.<br />
Apuleio<br />
Metamorfosi, III, 21-25 (Metamorfosi <strong>di</strong> Lucio in asino)<br />
Metamorfosi, XI, 12-15 (Nuova metamorfosi <strong>di</strong> Lucio e svelamento retrospettivo)<br />
La favola <strong>di</strong> Amore e Psiche: trama e significato simbolico<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 13/53
L’orizzonte delle Metamorfosi: delectare et docere; Apuleio e le Milesie; La questione delle fonti;<br />
Un testo a più livelli <strong>di</strong> lettura.<br />
Confronto con il romanzo <strong>di</strong> Petronio.<br />
Agostino<br />
Confessiones XI, 11 - 14 : Dio, l’eternità e il tempo in un confronto con la sapienza <strong>di</strong> Seneca.<br />
(Fotocopie). Brano in traduzione e contestualizzazione.<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 14/53
Testi utilizzati:<br />
GRECO<br />
• Privitera – Pretagostini, Storia e forme della letteratura greca, Einau<strong>di</strong> scuola<br />
• Guidorizzi, La letteratura greca, voll. 2-3, Einau<strong>di</strong> scuola<br />
• Euripide, Ifigenia in Aulide, Dante Alighieri<br />
• Platone, Menesseno, Dante Alighieri<br />
Il teatro<br />
V SECOLO<br />
La trage<strong>di</strong>a:<br />
Notizie generali sulla trage<strong>di</strong>a antica<br />
Eschilo<br />
- Trama <strong>di</strong> tutte le trage<strong>di</strong>e.<br />
- Lettura in italiano dei seguenti passi antologici:<br />
I Persiani, vv.353-432<br />
(La battaglia <strong>di</strong> Salamina)<br />
Obiettivi:<br />
V secolo:<br />
• riconoscere la valenza culturale, politica e<br />
religiosa del teatro tragico e comico<br />
• in<strong>di</strong>viduare l’analoga valenza catartica del<br />
pathos tragico e del riso comico<br />
• in<strong>di</strong>viduare le caratteristiche portanti della<br />
drammaturgia <strong>di</strong> Euripide e gli elementi<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenziazione rispetto ad Eschilo e a<br />
Sofocle.<br />
IV secolo:<br />
• analizzare il mutamento delle forme<br />
teatrali in rapporto alle mutate con<strong>di</strong>zioni<br />
politiche.<br />
Le origini.<br />
Il contesto temporale: gli agoni drammatici<br />
ateniesi.<br />
Il teatro.<br />
La struttura della trage<strong>di</strong>a.<br />
Il costume, la maschera, il coro.<br />
Il concetto <strong>di</strong> catarsi.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Raro esempio <strong>di</strong> attualità <strong>di</strong>rettamente rappresentata<br />
sulla scena tragica: la guerra nella<br />
prospettiva dei vinti.<br />
L’agire umano tra volontà <strong>di</strong>vina e responsabilità<br />
umana.<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 15/53
I Sette contro Tebe, vv. 39-68<br />
(Uno scudo pieno <strong>di</strong> sangue)<br />
I Sette contro Tebe, vv. 631-719<br />
(La settima porta)<br />
Le supplici, vv. 866-949<br />
(Gli Egizi tentano <strong>di</strong> rapire le Danai<strong>di</strong>)<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Esaltazione dei valori civici e religiosi contro la<br />
brutalità degli assalitori.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Complessità della figura <strong>di</strong> Eteocle, eroe animato<br />
da un arcaico senso dell’onore<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
La figura del re Pelasgo, depositario dei valori<br />
democratici contro l’arroganza della tirannide.<br />
Dell’Orestea, l’unica trilogia continua rimastaci, è stata compiuta le lettura integrale da parte<br />
dei ragazzi. In classe sono stati analizzati i seguenti passi:<br />
Agamennone, vv. 1-39<br />
(Prologo notturno)<br />
Agamennone, vv. 40-82; 160-191<br />
(Parodo)<br />
Agamennone, vv. 855-974<br />
(Clitemnestra accoglie Agamennone)<br />
Coefore, vv. 124-305 (Il riconoscimento tra<br />
Oreste ed Elettra)<br />
Coefore, vv. 875-929 (Oreste uccide la<br />
madre)<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
L’inquietu<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> un’atmosfera notturna e cupa.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
L’agire umano è determinato da un sistema <strong>di</strong><br />
invisibili presenze.<br />
Il concetto <strong>di</strong> π≤θει µ≤θοϕ.<br />
La metafora come elemento caratterizzante dello<br />
stile <strong>di</strong> Eschilo.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Il personaggio <strong>di</strong> Clitemnestra dal “maschio<br />
cuore”: la complessità della sua figura all’interno<br />
della quale si mescolano sete <strong>di</strong> vendetta, smania<br />
<strong>di</strong> potere e violenza della passione.<br />
Importanza degli effetti coloristici.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Esempio <strong>di</strong> riconoscimento tragico che avrà<br />
successivi sviluppi.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 16/53
Eumeni<strong>di</strong>, vv. 94-197 (Lo spettro <strong>di</strong><br />
Clitemnestra)<br />
Eumeni<strong>di</strong>, vv. 681-753<br />
(Il processo <strong>di</strong> Oreste)<br />
Sofocle<br />
- Trama <strong>di</strong> tutte le trage<strong>di</strong>e.<br />
- Lettura in italiano dei seguenti passi antologici:<br />
Antigone, vv. 384-525 (Antigone sfida<br />
Creonte)<br />
Antigone, vv. 332-375; 781-800 (Due canti<br />
corali: il progresso umano e la forza dell’amore)<br />
Trachinie, vv. 531-625 (La gelosia <strong>di</strong><br />
Deianira)<br />
Trachinie, 756-812 (Eracle preso nella veste<br />
avvelenata)<br />
Oreste lacerato da due opposte pulsioni.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Scena allucinata e spettrale: la potenza<br />
drammaturgica del teatro eschileo.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Un possibile equilibrio tra gli dèi antichi e quelli<br />
nuovi.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Contrapposizione tra le leggi degli dèi e leggi<br />
degli uomini.<br />
La paradossale contrapposizione tra grandezza<br />
morale e colpa sociale.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
La fiducia nel progresso e nelle potenzialità<br />
dell’uomo.<br />
Il senso del limite.<br />
La forza irresistibile <strong>di</strong> Afro<strong>di</strong>te.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Deianira come emblema dell’assur<strong>di</strong>tà della<br />
con<strong>di</strong>zione umana.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Il momento dell’ ∞ρτι µανθ≤νω, perno della<br />
concezione tragica <strong>di</strong> Sofocle<br />
E<strong>di</strong>po re, vv. 1-77 (Prologo) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 17/53
E<strong>di</strong>po re, vv. 216-275; 316-462 (E<strong>di</strong>po e<br />
Tiresia)<br />
E<strong>di</strong>po re, vv. 1110-1222 (E<strong>di</strong>po comprende il<br />
suo passato)<br />
Euripide<br />
- Trama <strong>di</strong> alcune trage<strong>di</strong>e.<br />
- Lettura in italiano dei seguenti passi<br />
Alcesti, vv. 244-392 (La morte <strong>di</strong> Alcesti)<br />
Alcesti, vv. 747-849 (Eracle mangione)<br />
Medea, lettura integrale da parte dei ragazzi e<br />
in classe lettura particolare dei seguenti passi:<br />
- vv. 446-626 (Medea e Giasone)<br />
- vv. 1021-1080 (monologo <strong>di</strong> Medea)<br />
La peste e le sue arcane motivazioni.<br />
L’anfibologia del linguaggio sofocleo.<br />
La figura <strong>di</strong> E<strong>di</strong>po: da buon re a tiranno.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
In concetto <strong>di</strong> ironia tragica.<br />
La contrapposizione tra vista e cecità fisica e<br />
spirituale.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
La conoscenza destina l’eroe sofocleo alla<br />
solitu<strong>di</strong>ne.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
La celebrazione delle virtù <strong>di</strong> Alcesti in<br />
confronto con la viltà dei genitori <strong>di</strong> Admeto.<br />
Il motivo del “doppio”.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Il personaggio <strong>di</strong> Eracle a metà tra trage<strong>di</strong>a e<br />
comme<strong>di</strong>a.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Lo scontro agonale tra la protagonista (Medea) e<br />
l’antagonista (Giasone).<br />
Le caratteristiche formali dell’agone <strong>di</strong>alettico.<br />
Finezza introspettiva e analisi psicologica dei<br />
personaggi.<br />
Il monologo <strong>di</strong> Medea: momento <strong>di</strong> alta tensione<br />
drammatica e <strong>di</strong> raffinata consapevolezza della<br />
psicologia umana.<br />
Ippolito, vv. 1-57 (Il prologo <strong>di</strong>vino) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 18/53
Ippolito, vv. 311-430 (Fedra confessa il suo<br />
amore)<br />
Ippolito, vv. 616-644 (versi dettati in classe)<br />
Trage<strong>di</strong>a in greco: Ifigenia In Aulide<br />
- Trama <strong>di</strong> tutta la trage<strong>di</strong>a<br />
- Lettura in greco dei seguenti passi:<br />
Prologo, vv. 1-49<br />
Prologo, vv. 117-163<br />
1° Episo<strong>di</strong>o, vv. 335-401<br />
1° Episo<strong>di</strong>o, vv. 440-488; vv. 506-542<br />
2° Episo<strong>di</strong>o, vv. 633-680<br />
La rappresentazione euripidea della <strong>di</strong>vinità.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Il personaggio <strong>di</strong> Fedra si inserisce all’interno<br />
delle straor<strong>di</strong>narie figure femminili <strong>di</strong> Euripide,<br />
sempre in bilico tra ragione e impulsi irrazionali.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
La misoginia e la ⇔βριϕ <strong>di</strong> Ippolito.<br />
Traduzione, analisi sintattica e stilistica.<br />
Originalità del prologo e problemi <strong>di</strong><br />
attribuzione.<br />
Traduzione, analisi sintattica e stilistica.<br />
La complessità della figura <strong>di</strong> Agamennone, in<br />
cui convergono l’amore <strong>di</strong> padre affettuoso e<br />
l’ambizione <strong>di</strong> duce potente.<br />
Traduzione, analisi sintattica e stilistica.<br />
Scontro tra i due fratelli Agamennone e<br />
Menelao, rappresentati nella miseria dei loro<br />
egoismi e delle loro vanità.<br />
Lettura metrica in trimetri giambici,<br />
traduzione, analisi sintattica e stilistica.<br />
Nuovo colloquio tra i due fratelli Atri<strong>di</strong>: nelle<br />
loro <strong>di</strong>verse posizioni e nei loro mutamenti <strong>di</strong><br />
prospettiva si rispecchia l’insanabile incoerenza<br />
dell’animo umano.<br />
Lettura metrica in trimetri giambici,<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 19/53
3° Episo<strong>di</strong>o, vv. 819-854<br />
4° Episo<strong>di</strong>o, vv. 1211-1252<br />
5° Episo<strong>di</strong>o, vv. 1368-1400<br />
traduzione, analisi sintattica e stilistica.<br />
Arrivo al campo greco <strong>di</strong> Clitemnestra con<br />
Ifigenia e il piccolo Oreste.<br />
Lettura metrica in trimetri giambici,<br />
traduzione, analisi sintattica e stilistica.<br />
Incontro tra Clitemnestra e Achille.<br />
L’equivoco della situazione e l’uso <strong>di</strong> un<br />
linguaggio “basso” e “borghese” preludono alla<br />
Comme<strong>di</strong>a Nuova.<br />
Traduzione, analisi sintattica e stilistica.<br />
Monologhi <strong>di</strong> Ifigenia, prima supplice <strong>di</strong> avere<br />
salva la vita, poi desiderosa <strong>di</strong> compiere il<br />
sacrificio.<br />
Ifigenia, emblema dei personaggi euripidei<br />
dominati da una forza ineluttabile che li rende<br />
drammaticamente impotenti.<br />
Letture critiche (su fotocopie) tratte dalle antologie e storie della letteratura greca degli stu<strong>di</strong>osi<br />
Lesky, Del Corno, Rossi, Ferrari.<br />
La comme<strong>di</strong>a ′ρχα ρχα α<br />
Notizie generali sulla comme<strong>di</strong>a antica Le origini:.<br />
Il contesto temporale: gli agoni drammatici<br />
ateniesi.<br />
La struttura.<br />
Il costume, la maschera, il coro.<br />
Catarsi tragica e riso comico.<br />
Libertà compositiva e attualità delle tematiche.<br />
La permanenza delle forme proprie della poesia<br />
giambica (poesia del biasimo e dell’attacco ad<br />
personam)<br />
L’elemento fantastico e surreale.<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 20/53
Aristofane<br />
- Trama <strong>di</strong> tutte le comme<strong>di</strong>e.<br />
- Lettura in italiano dei seguenti passi antologici:<br />
Pace, vv. 1-153 (Trigeo dà la scalata al cielo) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Uccelli, vv. 1-48 (in cerca <strong>di</strong> un luogo dove<br />
vivere).<br />
Lisistrata, lettura integrale da parte dei<br />
ragazzi e in classe lettura particolare dei vv. 1-<br />
246; 430-613; 830-970<br />
♦ Rane, vv. 180-268; 830-870; 1197-1247<br />
(La contesa tra Eschilo ed Euripide)<br />
Due sfere linguistiche in contrasto: il linguaggio<br />
tra-gico e la coprolalia.<br />
Le gioie della pace: la <strong>di</strong>gnità morale del lavoro.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
La fuga nell’utopia e la creazione <strong>di</strong> una città<br />
nuova.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Il rapporto tra la finzione scenica (colpo <strong>di</strong> <strong>stato</strong><br />
delle donne) e la realtà (colpo <strong>di</strong> <strong>stato</strong><br />
oligarchico del 411).<br />
Lo sciopero delle donne come elemento<br />
salvifico: il rovesciamento dei miti misogini.<br />
Lo schema carnevalesco del “mondo alla<br />
rovescia”: la sospensione fantastica della realtà.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Il motivo della crisi della trage<strong>di</strong>a dopo la morte<br />
<strong>di</strong> Euripide e <strong>di</strong> Sofocle.<br />
Il viaggio nell’oltretomba rappresentato con<br />
un’efficace “scenografia verbale”.<br />
L’al<strong>di</strong>là come paese capovolto, simboleggiante<br />
Atene stessa.<br />
La paro<strong>di</strong>a tragica.<br />
L’agone tra Eschilo e Euripide: elementi <strong>di</strong><br />
critica letteraria.<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 21/53
La comme<strong>di</strong>a ν α.<br />
α.<br />
♦ Notizie generali sulla comme<strong>di</strong>a nuova La nuova situazione storica: il tramonto<br />
dell’autonomia della polis, l’ampliamento degli<br />
orizzonti geografici e culturali.<br />
Menandro<br />
Il bisbetico, vv. 1-49 (I turbamenti <strong>di</strong><br />
Cnemone)<br />
Il bisbetico, vv. 711-747 (Il monologo <strong>di</strong><br />
Cnemone)<br />
♦ La ragazza tosata, vv. 1-76<br />
(Il prologo <strong>di</strong> Ignoranza)<br />
♦ Epitrepontes, vv. 266-406 (Il mistero<br />
dell’anello)<br />
Dai Caratteri:<br />
La cafoneria<br />
Teofrasto<br />
Il mutamento delle coor<strong>di</strong>nate fondamentali<br />
dell’immaginario collettivo.<br />
Lo scar<strong>di</strong>namento dei valori tra<strong>di</strong>zionali.<br />
Gli effetti della nuova situazione storico-sociale<br />
sul teatro comico: i mutamenti tematici e<br />
drammaturgici.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Analisi della struttura: riduzione del coro a intermezzo,<br />
<strong>di</strong>visione in atti, rispetto delle convenzioni<br />
teatrali (unità <strong>di</strong> tempo, <strong>di</strong> luogo e <strong>di</strong><br />
spazio).<br />
Analisi della tematica in rapporto al mutamento<br />
del pubblico.<br />
La caratterizzazione psicologica <strong>di</strong> Cnemone,<br />
personaggio non totalmente negativo.<br />
Il messaggio conclusivo <strong>di</strong> solidarietà.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Ar<strong>di</strong>ta rappresentazione <strong>di</strong> un concetto astratto.<br />
Il ruolo della τ∨χη nelle vicende umane.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
La caratterizzazione psicologica dei personaggi<br />
in funzione della costruzione della trama.<br />
Il messaggio <strong>di</strong> filantropia e solidarietà.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Lo schema fisso dei 30 Caratteri e la matrice<br />
aristotelica dei <strong>di</strong>versi tipi morali.<br />
Il rapporto con la comme<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Menandro.<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 22/53
Testo filosofico in greco:<br />
Platone, Menesseno<br />
- Struttura e temi dell’intera opera<br />
- La funzione civica del λ®γοϕ γοϕ πιτ πιτ≤φιοϕ πιτ<br />
φιοϕ φιοϕ<br />
- Confronto con il <strong>di</strong>scorso <strong>di</strong> Pericle in<br />
Tuci<strong>di</strong>de (II, 36-46).<br />
- Lettura in greco dei seguenti passi:<br />
234c-235c Traduzione, analisi sintattica e stilistica.<br />
Socrate elogia gli oratori che realizzano <strong>di</strong>scorsi<br />
funebri commemorativi.<br />
238b-239a Traduzione, analisi sintattica e stilistica.<br />
Lode della che si ricollega sia all’oririgine<br />
(celebrazione dell’autoctonia ateniese) sia<br />
all’educazione (παιδε α). La costituzione<br />
democratica è un’aristocrazia con il consenso del<br />
popolo<br />
246a-c Traduzione, analisi sintattica e stilistica.<br />
Esortazione ai viventi ad essere valorosi come i<br />
progenitori.<br />
246d-247c Traduzione, analisi sintattica e stilistica.<br />
La “rivoluzione” dell’Ellenismo<br />
Esortazione ai figli pronunciata dai caduti stessi.<br />
Obiettivi:<br />
• verificare i cambiamenti indotti nelle tematiche,<br />
nello stile e nella concezione<br />
dell’arte dalla “rivoluzione” politica prodottasi<br />
con la fine della polis e dal<br />
passaggio dalla comunicazione orale a<br />
quella scritta.<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 23/53
Callimaco<br />
- Contenuto e struttura delle varie opere.<br />
- Gli elementi fondamentali e innovativi della<br />
poetica callimachea (accenno al Prologo dei<br />
Telchini): la brevitas e la ποικιλ α.<br />
Aitia, III, (Acontio e Ci<strong>di</strong>ppe) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Epigrammi, Antologia Palatina:<br />
- V, 23 (La bella crudele)<br />
- VII, 525 (Epitafio)<br />
- XII, 43 (Il poema del ciclo)<br />
- XII, 73 (La metà dell’anima)<br />
Teocrito<br />
- Contenuto e struttura degli I<strong>di</strong>lli.<br />
- Il realismo.<br />
- La creazione della poesia bucolica.<br />
- Il <strong>di</strong>stacco ironico dai personaggi (confronto<br />
con Virgilio).<br />
La polemica contro il poema epico tra<strong>di</strong>zionale.<br />
Il gusto delle leggende eziologiche.<br />
Realismo descrittivo: gusto dei dettagli impressionistici<br />
tratti dalla vita quoti<strong>di</strong>ana.<br />
L’interesse eziologico.<br />
La varietà dei temi.<br />
Il gusto dell’eru<strong>di</strong>zione mitologica e dell’arte<br />
allusiva.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
I filoni principali degli epigrammi callimachei.<br />
♦ I<strong>di</strong>lli, XI (Il Ciclope) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
L’umanizzazione <strong>di</strong> Polifemo: confronto con<br />
Omero.<br />
Il valore catartico della poesia.<br />
♦ I<strong>di</strong>lli, XV (Le Siracusane) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Esempio <strong>di</strong> mimo letterario.<br />
Realismo mimetico e psicologico.<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 24/53
Apollonio Ro<strong>di</strong>o<br />
L’encomio dei regnanti.<br />
Sperimentalismo linguistico <strong>di</strong> Teocrito.<br />
- Contenuto e struttura delle varie opere.<br />
- L’innovazione del genere epico:<br />
compromesso tra l’antica tra<strong>di</strong>zione epica e le<br />
nuove esigenze della poesia ellenistica.<br />
- Interpretazioni controverse dell’opera:<br />
fallimento dello statuto eroico o consapevole<br />
realizzazione <strong>di</strong> uno statuto antieroico?<br />
(Paduano).<br />
- La ′µηχαν α <strong>di</strong> Giasone.<br />
♦ Argonautiche, III, vv. 111-160; 275-290 Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Il motivo topico <strong>di</strong> Eros giocatore <strong>di</strong> da<strong>di</strong>.<br />
♦ Argonautiche, III, 616-655; 744-824 Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Antologia Palatina<br />
- Formazione della raccolta.<br />
- Evoluzione<br />
dell’epigramma.<br />
La scuola peloponnesiaca: Anite<br />
Ant. Pal., VI, 312 (Bambini e animaletti)<br />
Ant. Pal., VII, 190, 202<br />
L’inserzione “tragica” nell’epos.<br />
La figura <strong>di</strong> Medea: confronto con Euripide.<br />
Contrasto tra la pace della notte e la lacerazione<br />
inte-riore del personaggio: confronto con<br />
Alcmane, fr. 34 P. e con Virgilio, Eneide, IV, vv.<br />
522-532.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Tematiche: epitafi reali o fittizi per giovani<br />
fanciulle o animali; descrizione <strong>di</strong> paesaggi<br />
bucolici.<br />
Realismo tenue e ironico.<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 25/53
La scuola peloponnesiaca: Nosside<br />
Ant. Pal., VII, 718 (Nosside e Saffo)<br />
Ant. Pal., V, 170 (Il miele <strong>di</strong> Afro<strong>di</strong>te)<br />
La scuola peloponnesiaca: Leonida<br />
Ant. Pal., VII, 715 (Epitafio <strong>di</strong> se stesso)<br />
Ant. Pal., VI, 302 (Gli ospiti sgra<strong>di</strong>ti)<br />
Ant. Pal., VII, 506 (Un destino orribile)<br />
La scuola ionico-alessandrina:<br />
Asclepiade<br />
Ant. Pal., V, 7 (La lucerna)<br />
Ant. Pal., V, 85 (La ragazza ritrosa)<br />
Ant. Pal., V, 169 (Il mantello <strong>di</strong> Afro<strong>di</strong>te)<br />
XII, 46; XII, 50 (Malinconia)<br />
La scuola fenicia: Meleagro<br />
Ant. Pal., V, 179 (Eros <strong>di</strong>spettoso)<br />
Ant. Pal., V, 180 (Eros crudele)<br />
Ant. Pal., V, 151 e 152 (Le zanzare<br />
impudenti)<br />
Ant. Pal., V, 174 (Il sogno)<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Forte richiamo a Saffo.<br />
Le composizioni de<strong>di</strong>catorie.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Descrizione <strong>di</strong> situazioni quoti<strong>di</strong>ane e <strong>di</strong><br />
personaggi umili.<br />
Gusto del macabro e del grottesco.<br />
Gusto della sperimentazione.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Prevalenza della tematica erotico-simposiale e<br />
dei suoi τ®ποι.<br />
Assenza <strong>di</strong> indagine psicologica.<br />
Sensibilità ironica e lievemente malinconica.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Innovatore del genere epigrammatico.<br />
Rinuncia alla brevitas del primo ellenismo e<br />
preferisce epigrammi più lunghi.<br />
Prevalenza della tematica amorosa nella<br />
consueta cornice del simposio.<br />
L’amore visto in una caleidoscopica varietà <strong>di</strong><br />
situazioni e <strong>di</strong> emozioni.<br />
Gusto barocco del bizzarro e del sorprendente.<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 26/53
Il romanzo<br />
Caritone <strong>di</strong> Afro<strong>di</strong>sia, Cherea e Calliroe, I,<br />
1-16 (su fotocopie)<br />
Senofonte Efesio, Storie efesiache,<br />
III, 12 (La seduzione della donnacagna)<br />
Achille Tazio, Leucippe e Clitofonte, I, 3-4; 6<br />
(L’incontro con Leucippe)<br />
Longo Sofista, Dafni e Cloe, Proemio (La<br />
nascita della passione)<br />
Eliodoro, Etiopiche, I, 1-2 (La scena<br />
d’apertura)<br />
Le strutture consuete del romanzo:<br />
variazioni su un modello fisso.<br />
Il τ®ποϕ dell’innamoramento a prima vista e<br />
dello sguardo come mezzo <strong>di</strong> trasmissione<br />
dell’amore.<br />
Il ruolo <strong>di</strong> Eros e <strong>di</strong> Afro<strong>di</strong>te nel romanzo.<br />
Lettura in traduzione e<br />
contestualizzazione.<br />
Il τ®ποϕ del giovane ingiustamente accusato<br />
(confronti con Ippolito).<br />
Lettura in traduzione e<br />
contestualizzazione.<br />
L’incontro con Leucippe.<br />
Un ulteriore esempio del τ®ποϕ dell’innamoramento<br />
a prima vista e dello sguardo.<br />
Il motivo del sogno.<br />
Lettura in traduzione e<br />
contestualizzazione.<br />
Le novità del romanzo e l’abilità delle<br />
strategie narrative.<br />
Lettura in traduzione e<br />
contestualizzazione.<br />
Complessità della tecnica narrativa.<br />
Efficace abilità descrittiva e sensibilità<br />
coloristica.<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 27/53
Introduzione generale<br />
STORIA<br />
Il programma dell’ultimo anno prevede lo stu<strong>di</strong>o del Novecento. Ciò pone subito una questione: qual è il<br />
termine a quo e quale quello ad quem? Naturalmente il calendario non può esserci d’aiuto, come non può<br />
esserlo <strong>di</strong> fatto per nessun secolo. Le date <strong>di</strong> riferimento possono essere invece molteplici: il 1873 (la<br />
“grande depressione”), il 1914-1917 (la Grande Guerra e la rivoluzione russa), per quello che riguarda le<br />
possibili date d’inizio (ma c’è anche chi in<strong>di</strong>ca il 1929). E la data <strong>di</strong> termine secolo? Gli storici sono per lo<br />
più concor<strong>di</strong> nell’in<strong>di</strong>care il 1989, anno della caduta del muro <strong>di</strong> Berlino e della fine dell’esperienza<br />
comunista. Ma non c’è dubbio che la crisi petrolifera del 1973 (e quella del 1979), e il contemporaneo<br />
sviluppo <strong>di</strong> quella che è stata chiamata la Terza rivoluzione industriale, costituiscono momenti assai<br />
significativi per chi stu<strong>di</strong>a la storia novecentesca nella prospettiva prevalentemente economica.<br />
Inoltre: la storia del Novecento è tutta storia contemporanea? Che cosa si intende per “storia<br />
contemporanea”? Ha scritto De Luna: “la frontiera che separa il periodo contemporaneo da quello che lo<br />
precede è un confine mobile, che non cessa <strong>di</strong> spostarsi, confermando una flui<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> termini a quo e ad<br />
quem, che attribuisce alla contemporaneità i tratti <strong>di</strong> un fiume <strong>di</strong> eventi restìo a farsi imbrigliare nell’alveo <strong>di</strong><br />
una qualsiasi perio<strong>di</strong>zzazione”. Possiamo invece in<strong>di</strong>care in un’”umanità completamente massificata” il<br />
tratto caratteristico del secolo: “Nel ‘secolo degli estremi’ (Hobsbawm), <strong>di</strong> massa è stata la partecipazione<br />
politica che è il prius logico del totalitarismo; <strong>di</strong> massa è stata la produzione del sistema industriale così<br />
come <strong>di</strong> massa sono stati i consumi che ha alimentato. Di massa è la morte, che trionfa nelle gran<strong>di</strong> guerre e<br />
negli altri conflitti minori. Di massa sono gli strumenti della comunicazione, quei mass me<strong>di</strong>a che hanno<br />
improntato il Dna, lo stesso patrimonio genetico del XX secolo” (G. De Luna, La passione e la ragione.<br />
Fonti e meto<strong>di</strong> dello storico contemporaneo, La Nuova Italia, Firenze 2001; p. 30). Il Novecento, dunque,<br />
come secolo delle masse, con una perio<strong>di</strong>zzazione che pone al centro il ventennio tra le due guerre mon<strong>di</strong>ali,<br />
quello della “grande trasformazione” stu<strong>di</strong>ata da Polanyi. Di lì, infatti, si <strong>di</strong>partono una serie <strong>di</strong> cerchi<br />
concentrici, che vanno verso il passato (la Seconda rivoluzione industriale e l’imperialismo) e verso il futuro,<br />
avviato dai gran<strong>di</strong> eventi della storia a cavallo tra il XX e il XXI secolo.<br />
M 1 - Il secolo nuovo (1900-1914)<br />
Prima unità: Il mondo della Seconda rivoluzione industriale<br />
I,1: Crisi <strong>di</strong> sovrapproduzione e razionalizzazione dell’economia<br />
- dalla “sottoproduzione” delle società tra<strong>di</strong>zionali alla “sovrapproduzione” dell’economia<br />
industriale (e agraria);<br />
- una questione storiografica: il periodo tardo ottocentesco è <strong>stato</strong> esclusivamente “borghese”? Le<br />
due tesi contrapposte <strong>di</strong> David S. Landes (1969) e Arno J. Mayer (1981);<br />
- la razionalizzazione dell’economia e le sue ragioni storiche: “taylorismo” e “for<strong>di</strong>smo” (analogie<br />
e <strong>di</strong>fferenze);<br />
- crisi della concezione classica liberale e “protezionismo”<br />
I,2: La classe operaia (e il socialismo) e la borghesia (e il nazionalismo)<br />
- la nascita <strong>di</strong> una nuova classe operaia in relazione agli sviluppi del taylorismo e del for<strong>di</strong>smo;<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 28/53
- il conflitto- politico e culturale- tra classe operaia e borghesia: le sue con<strong>di</strong>zioni oggettive;<br />
- il conflitto da un punto <strong>di</strong> vista soggettivo: LETTURA <strong>di</strong> Erich J. Hobsbawm sullo scontro tra<br />
due concezioni del mondo e due universi mentali (cfr. pp. 83-85 del manuale);<br />
- dalla Prima alla Seconda Internazionale: la socialdemocrazia e il “revisionismo” <strong>di</strong> Eduard<br />
Bernstein: LETTURA tratta da I presupposti del socialismo e i problemi della socialdemocrazia<br />
(cfr. pp. 12-13 <strong>di</strong> Attraverso il Novecento)<br />
I,3: Appen<strong>di</strong>ce: Dal for<strong>di</strong>smo al postfor<strong>di</strong>smo<br />
- la trasformazione del lavoro industriale nel Novecento: il “postfor<strong>di</strong>smo” e le sue conseguenze; la<br />
globalizzazione; il declino dello Stato assistenziale e la Terza rivoluzione industriale;<br />
- il caso della “Terza Italia”.<br />
Seconda unità: Sfide per l’egemonia mon<strong>di</strong>ale: l’imperialismo<br />
II,1: Verso la Prima guerra mon<strong>di</strong>ale<br />
- definizione <strong>di</strong> “imperialismo” e suo legame col concetto <strong>di</strong> “nazione”;<br />
- conflitti economici e conflitti politico-ideologici tra le nazioni;<br />
- alcune interpretazioni dell’imperialismo: da Hobson a Lenin a Schumpeter.<br />
II,2: Il caso degli USA: le “corporations” e la “<strong>di</strong>plomazia del dollaro”<br />
II,3: Il razzismo<br />
- Il razzismo come fenomeno moderno: LETTURA <strong>di</strong> un testo <strong>di</strong> Z. Bauman sul legame tra<br />
olocausto e modernità (cfr. pp.194-195 <strong>di</strong> Attraverso il Novecento)<br />
- LETTURA <strong>di</strong> C. Royer sull’ineguaglianza delle razze: il darwinismo sociale (cfr. pp. 20-23<br />
del manuale)<br />
Terza unità: L’età giolittiana<br />
III,1: L’età giolittiana e il decollo industriale dell’Italia<br />
- gli sta<strong>di</strong> economici <strong>di</strong> Watt. W. Rostow: per un inquadramento storico-economico dell’età<br />
giolittiana;<br />
- l’età giolittiana e lo Stato liberale: l’originalità del giolittismo.<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 29/53
III,2: Il riformismo politico<br />
- il programma politico <strong>di</strong> Giolitti tra riformismo e neutralità nei conflitti sociali;<br />
- il <strong>di</strong>fficile rapporto con i socialisti.<br />
III,3: Il secondo periodo giolittiano e la guerra <strong>di</strong> Libia<br />
III,3,1: La guerra <strong>di</strong> Libia: LETTURE <strong>di</strong> testi originali dell’epoca (fotocopie)<br />
La questione del nazionalismo<br />
III,3,2: Il patto Gentiloni e la questione cattolica<br />
III,4: Le tre interpretazioni classiche del giolittismo: B.Croce, G.Volpe, G.Salvemini<br />
LETTURE <strong>di</strong> passi tratti dalle opere dei tre autori (fotocopie)<br />
CONCETTI-CHIAVE del modulo: “crisi <strong>di</strong> sovrapproduzione”, “protezionismo”, “taylorismo” e<br />
“for<strong>di</strong>smo”, “postfor<strong>di</strong>smo”, “imperialismo”, “revisionismo”.<br />
M 2 – La grande trasformazione (1914-1929)<br />
Prima unità: La Prima guerra mon<strong>di</strong>ale<br />
I,1: La crisi dell’equilibrio: le ragioni dell’immane conflitto<br />
- la crisi del sistema dell’equilibrio bismarckiano e la politica <strong>di</strong> Guglielmo II della “grande<br />
Germania”;<br />
- la “Triplice Alleanza” e la “Triplice intesa”;<br />
- ragioni politico-<strong>di</strong>plomatiche, economiche e ideologiche che portano al conflitto.<br />
I,2: Gli esor<strong>di</strong>: 1914-1915<br />
- l’entusiasmo per l’avventura bellica e l’imme<strong>di</strong>ata delusione: la guerra come “festa” dei Futuristi<br />
e la realtà della trincea: LETTURA <strong>di</strong> A. Gibelli sul “nuovo paesaggio mentale” costituito dalla<br />
realtà della trincea (cfr. pp. 185-186 del manuale);<br />
- lo scoppio del conflitto e la costituzione <strong>di</strong> tre fronti (a est, a ovest e nel mare del Nord);<br />
- l’intervento dell’Italia in guerra: dalla contrapposizione tra “neutralisti” e “interventisti” alla<br />
<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> guerra.<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 30/53
I,3: Dal 1915 al 1917<br />
- la situazione <strong>di</strong> stallo degli anni 1915-1916;<br />
- dall’annuncio della “guerra sottomarina totale” all’intervento in guerra degli USA;<br />
- il fronte italiano dalla “Strafexpe<strong>di</strong>tion” a Caporetto: la questione della sconfitta <strong>di</strong><br />
Caporetto per la storia italiana dell’imme<strong>di</strong>ato dopoguerra (interpretazioni storiografiche).<br />
I,4: La fine della Grande guerra<br />
- la controffensiva dell’Intesa e dell’esercito italiano (dal Piave a Vittorio Veneto);<br />
- la nuova situazione geo-politica dell’Europa dopo la pace <strong>di</strong> Versailles;<br />
- un genoci<strong>di</strong>o <strong>di</strong>menticato: quello degli armeni (visione del film: La masseria delle allodole).<br />
Seconda unità: La rivoluzione russa (e la costruzione dell’URSS)<br />
II,1: La Russia tra fine Ottocento e Prima guerra mon<strong>di</strong>ale<br />
- la situazione della Russia tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX;<br />
- il socialismo e la guerra: il fallimento dell’Internazionale;<br />
- la caduta degli zar: febbraio-aprile 1917; il neobolscevismo delle Tesi <strong>di</strong> aprile <strong>di</strong> Lenin.<br />
II,2: La rivoluzione d’ottobre<br />
- dai governi Kerenskij alla pace <strong>di</strong> Brest-Litovsk;<br />
- la costruzione del potere bolscevico tra “terrore rivoluzionario” e guerra civile;<br />
- la costruzione dell’URSS: dal “comunismo <strong>di</strong> guerra” alla NEP.<br />
Terza unità: Un <strong>di</strong>fficile dopoguerra<br />
Esposizione <strong>di</strong> un quadro generale sulla situazione imme<strong>di</strong>atamente postbellica,<br />
finalizzata alla comprensione <strong>di</strong> una “pacificazione impossibile”.<br />
III,1: Gli USA tra “red scare” e “anni folli”<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 31/53
- Il grande Gatsby <strong>di</strong> F. S. Fitgerald: uno squarcio sugli USA degli anni Venti;<br />
- la società americana degli anni Venti: verso la grande crisi del 1929;<br />
- gli “italoamericani”: da emigranti a italiani; Farfariello e Rodolfo Valentino.<br />
III,2: La situazione europea<br />
Francia, Inghilterra, ma, soprattutto, Germania della repubblica <strong>di</strong> Weimar: tra sviluppi culturali e crisi<br />
economica.<br />
Quarta unità: L’avvento del fascismo in Italia<br />
IV,1: Le delusioni della vittoria<br />
- il mito della “vittoria mutilata” e l’atteggiamento politico del governo italiano;<br />
- le tesi <strong>di</strong> C. Balbo esposte ne Le speranze d’Italia (1844) e la politica estera italiana.<br />
IV,2: Le conseguenze economiche e sociali della guerra<br />
- rivolgimenti sociali: il “biennio rosso” e l’occupazione delle fabbriche;<br />
- la situazione economica generale.<br />
IV,3: La situazione politica: i partiti e il governo<br />
- le elezioni del 1919 e le nuove realtà politiche emergenti: il PSI e il PPI;<br />
- l’incapacità dei governi liberali e la figura <strong>di</strong> Giolitti.<br />
IV,4: L’ascesa del fascismo<br />
-<br />
- il fascismo dai fasci <strong>di</strong> combattimento (23 marzo 1919) al PNF (7 novembre 1921);<br />
- la tattica <strong>di</strong> Mussolini tra legalità e illegalità;<br />
- i limiti dell’antifascismo: LETTURA <strong>di</strong> A. Tasca (cfr. manuale pp. 188-190).<br />
IV,5: La presa del potere e l’organizzazione dello Stato totalitario<br />
- due perio<strong>di</strong>: 1) dal 28 ottobre 1922 al 3 gennaio 1925; 2) dal 3 gennaio 1925 in poi;<br />
- la questione del totalitarismo “imperfetto”;<br />
- le leggi “fascistissime”.<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 32/53
CONCETTI-CHIAVE del modulo: “nazionalismo”, “guerra lampo” e “guerra <strong>di</strong> posizione e <strong>di</strong><br />
trincea”, “vittoria mutilata”, “neutralisti”\”interventisti”, “comunismo <strong>di</strong> guerra”, “NEP”, “red<br />
scare”, “biennio rosso”.<br />
M 3 – La grande trasformazione (1929-1945)<br />
Prima unità: Dalla crisi del 1929 alla guerra <strong>di</strong> Spagna<br />
I,1: La crisi del 1929 e il New Deal<br />
- una nuova crisi <strong>di</strong> sovrapproduzione: le cause, le conseguenze e i rime<strong>di</strong>;<br />
- Roosevelt e il “New Deal”: le basi dello Stato sociale americano.<br />
I,2: Il nazismo in Germania<br />
- Hitler dagli esor<strong>di</strong> alla presa del potere;<br />
- l’organizzazione dello Stato totalitario e razziale.<br />
I,3: Lo stalinismo<br />
- l’industrializzazione forzata e la socializzazione delle terre;<br />
- la guerra ai kulaki e la nascita del gulag.<br />
I,4: IL mondo alla vigilia della Seconda guerra mon<strong>di</strong>ale<br />
- la situazione della Cina e del Giappone negli anni Trenta;<br />
- la guerra <strong>di</strong> Spagna e la vittoria del franchismo;<br />
- il precipitare degli eventi tra il 1936 e il 1939.<br />
Seconda unità: Il regime fascista in Italia (1929-1939)<br />
II,1: L’organizzazione interna<br />
- i “Patti lateranensi” e il plebiscito nazionale;<br />
- lo Stato corporativo.<br />
II,2: La “fascistizzazione” dell’Italia:<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 33/53
- il progetto <strong>di</strong> Mussolini e l’organizzazione <strong>di</strong> enti e associazioni;<br />
- la scuola come fabbrica del consenso: dalla riforma Gentile agli anno Trenta;<br />
- l’influenza <strong>di</strong> cinema e ra<strong>di</strong>o: la questione dei mezzi <strong>di</strong> comunicazione <strong>di</strong> massa e il totalitarismo;<br />
- la famiglia fascista: LETTURE (cfr. Attraverso il Novecento, pp. 132-133).<br />
II,3: La politica economica:<br />
- dalla politica liberale alla politica “<strong>di</strong>rigista”;<br />
- l’impatto con la crisi del 1929 e la politica autarchica.<br />
II,4: La politica estera:<br />
- dalla politica <strong>di</strong> continuità con l’Italia liberale alla svolta del 1932;<br />
- ragioni economiche e ideologiche dell’imperialismo fascista;<br />
- processo <strong>di</strong> avvicinamento alla Germania;<br />
- le leggi razziali del 1938: gli ebrei nell’Italia fascista (alcune puntualizzazioni sulla persecuzione<br />
antiebraica in Italia a partire dalle ricerche <strong>di</strong> M. Sarfatti).<br />
Terza unità: La Seconda guerra mon<strong>di</strong>ale<br />
II,1: La prima fase del conflitto (1939-1942)<br />
- l’attacco nazista e l’intervento dell’ Italia in guerra;<br />
- il nuovo or<strong>di</strong>ne europeo e lo sterminio degli ebrei; la tesi <strong>di</strong> R. Hilberg tra “intenzionalisti” e<br />
“funzionalisti”;<br />
- l’intervento degli USA e la guerra nel Pacifico;<br />
- prime sconfitte dell’Asse.<br />
II,2: La seconda fase del conflitto (1942-1945)<br />
- il crollo del fascismo, i “quarantacinque giorni” e la Resistenza in Italia;<br />
- verso lo scontro finale: dallo sbarco in Norman<strong>di</strong>a all’offensiva sovietica;<br />
- l’Italia negli anni 1943-1945: <strong>di</strong>visa e a sovranità limitata.<br />
Quarta unità: Uno sguardo sul secondo dopoguerra: la “guerra fredda” e la decolonizzazione<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 34/53
- la rivalità planetaria tra USA e URSS: le fasi della guerra fredda: il 1956, la “questione tedesca” e<br />
il muro <strong>di</strong> Berlino, la crisi dei missili <strong>di</strong> Cuba, la “glaciazione brezneviana” e la politica del<br />
“multipolarismo”, gli anni Ottanta e Gorbaciov, la fine della guerra fredda; la guerra fredda in<br />
Italia: alcuni momenti;<br />
- “terzo mondo” tra decolonizzazione e sviluppo: alcuni casi (la guerra d’Algeria, la Cina,<br />
l’Estremo oriente e il Me<strong>di</strong>o oriente, la questione palestinese).<br />
CONCETTI-CHIAVE del modulo: “New Deal” e “Welfare State”, “Stato razziale”, “dekulakizzazione”,<br />
“fascistizzazione”, “autarchia”, “nuovo or<strong>di</strong>ne europeo”, “funzionalisti” e “intenzionalisti”,<br />
“costituzione”, “guerra fredda”, “decolonizzazione”.<br />
n.b. I testi in adozione sono: G. De Luna, La scena del tempo, volume terzo, il manuale, Paravia, Torino 2003; G. De Luna,<br />
Attraverso il Novecento, Paravia, Torino 2002.<br />
Le pagine lette e stu<strong>di</strong>ate nel manuale durante l’a.s. (secondo l’or<strong>di</strong>ne seguito):<br />
- M 1: 78, 5-7, 10-12, 12-16, 83-85, 19; 28-43, 47-48, 49, 20-23, 429-435; 55-57, 62-64, 66-73.<br />
- M 2: 43-45, 93-102, 185-186; 40-43, 103-105, 120-124; 113-120, 132-135; 137-161, 188-190.<br />
- M 3: 163-179, 226-230; 197-213; 230-233, 238-255, 267-283, 311-313, 284-287, 314, 316,<br />
318-319, 322-323, 423-424, 310, 343-346.<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 35/53
Introduzione generale<br />
FILOSOFIA<br />
Gli stu<strong>di</strong> e le riflessioni maturate negli a. s. 2006-2007 e 2007-<strong>2008</strong> ci hanno portato a porre l’attenzione<br />
soprattutto sulle problematiche epistemologiche e politiche. Abbiamo così voluto dar séguito a quei lavori,<br />
concentrandoci su alcuni autori e correnti <strong>di</strong> pensiero contemporanei in cui quelle problematiche sono<br />
emerse con particolare rilevanza.<br />
Il nostro scopo è <strong>stato</strong> quello <strong>di</strong> evidenziare alcune tematiche epistemologiche, che ci sono sembrate<br />
particolarmente urgenti in un periodo storico in cui la scienza è spesso messa sotto accusa per ragioni che<br />
attengono più a ragioni ideologiche che filosofiche, più a ragioni <strong>di</strong> potere che <strong>di</strong> ricerca della verità. Anche<br />
per questa ragione abbiamo voluto de<strong>di</strong>care una particolare attenzione al pensiero politico <strong>di</strong> due autori –<br />
John Stuart Mill e Karl Raimund Popper- che hanno sviluppato profonde riflessioni sul tèma della libertà,<br />
quin<strong>di</strong> anche della libertà <strong>di</strong> ricerca, come valore imprescin<strong>di</strong>bile <strong>di</strong> ogni società democratica e moderna. Nei<br />
due autori succitati, inoltre, la riflessione epistemologica e quella politica sono così strettamente collegate da<br />
illuminarsi a vicenda; e ciò costituisce un ulteriore elemento <strong>di</strong> attualità per un’epoca come la nostra, in cui<br />
sembrano farsi largo istanze oscurantiste, finalizzate a impe<strong>di</strong>re la libertà <strong>di</strong> ricerca scientifica e, insieme con<br />
essa, la libertà tout court.<br />
Per tutte queste ragioni, il titolo del nostro programma attuale potrebbe essere questo: Epistemologia e<br />
politica da Stuart Mill a Popper.<br />
M 1 – Il Positivismo: riflessione filosofico-epistemologica e progetto politico<br />
Prima unità: La “filosofia positiva”<br />
I,1: Definizioni e caratteri generali del Positivismo<br />
I,2: La “filosofia positiva”<br />
- LETTURA <strong>di</strong> un testo <strong>di</strong> Comte tratto dal Corso <strong>di</strong> filosofia positiva (fotocopia n.1)<br />
Seconda unità: Il Positivismo <strong>di</strong> Auguste Comte<br />
II,1: La legge dei tre sta<strong>di</strong>, l’evoluzione dello spirito scientifico e l’affermazione dello sta<strong>di</strong>o positivo<br />
- la “legge dei tre sta<strong>di</strong>” (o “stati”) e la duplice attrazione <strong>di</strong> Comte: scientifica e politica;<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 36/53
- la scienza come “previsione razionale”: “scienza, donde previsione; previsione, donde azione”;<br />
- lo sta<strong>di</strong>o positivo come sta<strong>di</strong>o della maturità.<br />
II,2: L’unità della scienza, l’enciclope<strong>di</strong>a del sapere e il compito della filosofia<br />
- l’or<strong>di</strong>ne logico- storico delle scienze;<br />
- l’unità della scienza e l’autonomia delle scienze;<br />
- il compito della filosofia.<br />
II,3: La “politica positiva” tra sociologia e “religione dell’umanità”<br />
- la sociologia e la sua <strong>di</strong>visione in “statica sociale” e “<strong>di</strong>namica sociale”;<br />
- il modello <strong>di</strong> società comtiano.<br />
Terza unità: Il Positivismo in Inghilterra: il <strong>di</strong>battito sull’induzione, l’empirismo <strong>di</strong> J. Stuart Mill,<br />
l’evoluzionismo <strong>di</strong> H. Spencer<br />
III,1: Herschel, Whewell e la rivalutazione delle ipotesi<br />
- il <strong>di</strong>battito sulla natura del metodo scientifico in Inghilterra negli anni Trenta e Quaranta: il<br />
ripensamento critico del metodo induttivo.<br />
III,2: L’empirismo <strong>di</strong> John Stuart Mill e il “metodo deduttivo”<br />
- empirismo e inferenza induttiva;<br />
- il principio dell’uniformità della natura, la legge <strong>di</strong> causazione e il “metodo deduttivo”<br />
- la logica delle scienze sociali e il problema della libertà.<br />
III,3: La libertà e le sue garanzie (LETTURA <strong>di</strong> alcune pagine <strong>di</strong> Sulla libertà <strong>di</strong> Stuart Mill)*<br />
III,3,1: La “tirannia della maggioranza” e il principio dell’autoprotezione della società dall’arbitrio<br />
in<strong>di</strong>viduale lesivo della libertà altrui (pp. 33,41-43, 55-57).<br />
III,3,2: La libertà <strong>di</strong> pensiero e <strong>di</strong> <strong>di</strong>scussione: la “presunzione <strong>di</strong> infallibilità”, la dogmatizzazione <strong>di</strong><br />
un’opinione, la verità parziale delle opinioni in conflitto (69-73, 157-171).<br />
III,3,3: l’in<strong>di</strong>vidualità come uno degli elementi del benessere (pp. 183191, 223-233).<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 37/53
III,3,4: I limiti dell’autorità della società sull’in<strong>di</strong>viduo (pp. 235-241).<br />
III,3,5: Modelli <strong>di</strong> applicazioni del principio fondamentale (nella lettura del quinto, e ultimo, capitolo del<br />
libro, ogni alunno ha scelto uno o più casi concreti alla luce dei quali <strong>di</strong>scutere il principio fondamentale, che<br />
fa da guida all’intero testo).<br />
*[ Il testo <strong>di</strong> Stuart Mill Sulla libertà è <strong>stato</strong> letto nell’e<strong>di</strong>zione Bompiani (“Testi a fronte”), Milano 2007]<br />
III.4: L’evoluzionismo <strong>di</strong> Herbert Spencer<br />
- l’evoluzionismo in generale e il suo significato filosofico;<br />
- Spencer: evoluzione cosmica e progresso;<br />
- Spencer e il darwinismo sociale;<br />
- LETTURA <strong>di</strong> un testo tratto da I primi principi (fotocopia n.2).<br />
CONCETTI-CHIAVE del modulo: “positivismo”, “legge dei tre sta<strong>di</strong>”, “classificazione delle scienze”,<br />
“inferenza”, “principio <strong>di</strong> uniformità della natura”, “legge <strong>di</strong> causazione”, “metodo deduttivo”,<br />
“evoluzionismo cosmico”, “darwinismo sociale”.<br />
M 2 – La seconda rivoluzione scientifica e le origini dell’epistemologia<br />
Prima unità: Lo sviluppo delle scienze nell’Ottocento (caratteri generali)<br />
I,1: Autonomia, specializzazione, professionalizzazione del sapere scientifico e <strong>di</strong>fferenza rispetto alla<br />
filosofia<br />
I,2: La matematica: le geometrie non euclidee e le loro implicazioni filosofiche<br />
I,3: Lo sviluppo della fisica e la crisi del meccanicismo<br />
Seconda unità: Tra Otto e Novecento: la storia e il carattere pragmatico della scienza<br />
II,1: C. S. Peirce: l’abduzione, la fallibilità della scienza e la “regola pragmatica”<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 38/53
- le scienze e i meto<strong>di</strong>;<br />
- l’abduzione;<br />
- la “regola pragmatica”.<br />
II,2: E. Mach: critica del meccanicismo e natura della conoscenza scientifica<br />
- “La storia ha fatto tutto, la storia può tutto mutare”;<br />
- l’analisi delle sensazioni e la natura economica della ricerca scientifica;<br />
- dalla “sostanza” alla “funzione”;<br />
- LETTURA <strong>di</strong> alcuni passi tratti da Die Geschichte und <strong>di</strong>e Wurzel des Satzes von der Erhaltung<br />
der Arbeit (fotocopia n.3).<br />
II,3: P. Duhem: il carattere simbolico-astratto della teoria fisica<br />
- l’oggetto e la struttura della teoria fisica;<br />
- le obiezioni <strong>di</strong> Duhem all’inferenza newtoniana della legge <strong>di</strong> gravità dalle leggi <strong>di</strong> Keplero;<br />
- la “tesi <strong>di</strong> Duhem”.<br />
II,4: Il convenzionalismo <strong>di</strong> H. Poincaré<br />
- la natura convenzionale della geometria;<br />
- la natura convenzionale della fisica.<br />
CONCETTI-CHIAVE del modulo: “abduzione”, “regola pragmatica”, “funzione”, “tesi <strong>di</strong> Duhem”,<br />
“convenzionalismo”.<br />
M 3 – L’epistemologia tra le due guerre mon<strong>di</strong>ali: il Circolo <strong>di</strong> Vienna, Karl Raimund<br />
Popper<br />
Prima unità: Il Circolo <strong>di</strong> Vienna e la “concezione scientifica del mondo”<br />
I,1: Origini e storia del movimento<br />
I,2: Un nuovo modo <strong>di</strong> filosofare: il modello scientifico e l’istanza antimetafisica<br />
- LETTURA <strong>di</strong> alcuni passi tratti dal “manifesto” del Circolo (fotocopia n. 4)<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 39/53
I,3: “Il superamento della metafisica me<strong>di</strong>ante l’analisi logica del linguaggio”<br />
- LETTURA <strong>di</strong> alcuni passi del testo <strong>di</strong> R. Carnap<br />
I,4: Con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> significato e criteri <strong>di</strong> verità<br />
- il “principio <strong>di</strong> verificazione”;<br />
- dalla verifica alla conferma: il processo <strong>di</strong> “liberalizzazione dell’empirismo logico;<br />
- il modello nomologico <strong>di</strong> spiegazione <strong>di</strong> Hempel (e il “modello <strong>di</strong> rilevanza statica” <strong>di</strong> Salmon).<br />
Seconda unità: Karl Raimund Popper: epistemologia e politica<br />
II,1: La teoria della relatività e un nuovo modello <strong>di</strong> demarcazione<br />
-Einstein vs marxismo e psicanalisi: LETTURA <strong>di</strong> un passo dell’autobiografia <strong>di</strong> Popper (fotocopia n.5);<br />
-il “falsificazionismo” (o “metodo delle congetture e confutazioni”).<br />
II,2: Il problema dell’induzione<br />
II,3: La scienza come doxa<br />
-LETTURA del saggio Tre punti <strong>di</strong> vista a proposito della conoscenza (1956).<br />
II,4: Storicismo, totalitarismo, democrazia<br />
-critica della <strong>di</strong>alettica e dello storicismo (LETTURA <strong>di</strong> due passi tratti da Miseria dello storicismo,<br />
fotocopia n.6);<br />
-la “società aperta” e la teoria della democrazia (LETTURA <strong>di</strong> due passi tratti da La società aperta e i suoi<br />
nemici, fotocopia n.7).<br />
CONCETTI-CHIAVE: “principio <strong>di</strong> verificazione”, “conferma”, “spiegazione scientifica”,<br />
“falsificazione”, “storicismo”, “società aperta”.<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 40/53
STORIA DELL’ARTE<br />
1. LE CORTI RINASCIMENTALI IN ITALIA<br />
Geografia e storia dell’arte in Italia nel sec. XV<br />
Le esperienze del primo Rinascimento nelle opere <strong>di</strong> Brunelleschi, Donatello,<br />
Masaccio<br />
Rimini: la presenza <strong>di</strong> Leon Battista Alberti e il Tempio Malatestiano al tempo <strong>di</strong><br />
Sigismondo Pandolfo Malatesta<br />
Urbino: la “città in forma <strong>di</strong> palazzo”, la presenza <strong>di</strong> Piero della Francesca, la sua<br />
formazione e la sua influenza sull’arte urbinate<br />
Elementi <strong>di</strong> nuova urbanistica nelle città <strong>di</strong> Ferrara, Urbino e Pienza<br />
Piero della Francesca a Sansepolcro, Rimini ed Arezzo<br />
Mantova: la presenza <strong>di</strong> L.B.Alberti e il classicismo eroico del Mantegna<br />
Ferrara: l’attività dell’Officina ferrarese nel Salone dei mesi <strong>di</strong> Palazzo Schifanoia<br />
Firenze: il neoplatonismo e l’opera <strong>di</strong> Botticelli<br />
L’eco della pittura fiamminga nell’opera <strong>di</strong> Antonello da Messina<br />
Il colorismo veneto nell’opera <strong>di</strong> Giovanni Bellini<br />
2. LA “MANIERA MODERNA” ED IL SUO SUPERAMENTO NELLE<br />
OPERE DEGLI ARTISTI MANIERISTI<br />
Leonardo da Vinci<br />
Raffaello Sanzio<br />
Michelangelo Buonarroti<br />
Giorgione<br />
Tiziano<br />
Caratteri generali del “manierismo”. Elementi manieristici in alcune opere <strong>di</strong> Michelangelo,<br />
Tiziano, Pontormo, Rosso Fiorentino, Giulio Romano, Correggio, Parmigianino, Giambologna,<br />
Vasari ed eventuali altri artisti scelti dagli allievi<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 41/53
3. IL RINNOVAMENTO DELLA PITTURA FRA IL XVI E XVII SECOLO<br />
ED IL PASSAGGIO ALL’ARTE BAROCCA<br />
Influssi della Controriforma nelle arti<br />
L’Accademia degli Incamminati: il recupero del vero e del classicismo nelle opere<br />
<strong>di</strong> Ludovico, Agostino e Annibale Carracci e dei bolognesi<br />
Il naturalismo <strong>di</strong> Caravaggio e dei caravaggeschi<br />
Il Seicento barocco nelle opere <strong>di</strong> Gianlorenzo Bernini<br />
L’altro volto del barocco nelle opere <strong>di</strong> Francesco Borromini<br />
4. IL SETTECENTO<br />
Pietro Longhi e il vedutismo <strong>di</strong> Canaletto e Guar<strong>di</strong><br />
La scultura <strong>di</strong> Antonio Canova<br />
La pittura <strong>di</strong> Jacques Louis David<br />
5. IL ROMANTICISMO<br />
Neoclassicismo e romanticismo: i due volti dell’Europa borghese tra Settecento e<br />
Ottocento<br />
Aspetti del Romanticismo in Europa: cenni alle opere <strong>di</strong> Caspar David Friedrich,<br />
John Constable, William Turner.<br />
Il Romanticismo in Francia e il nuovo senso della storia nelle opere <strong>di</strong> Theodore<br />
Gericault, Eugene Delacroix,<br />
Il romanticismo in Italia e la pittura storica <strong>di</strong> Francesco Hayez<br />
6. IL REALISMO NELLA PITTURA DELL’OTTOCENTO EUROPEO<br />
Aspetti realistici nell’opera degli artisti del XIX secolo<br />
L’esperienza italiana: il fenomeno dei Macchiaioli e l’opera <strong>di</strong> Giovanni Fattori<br />
L’ esperienza francese: Camille Corot e gli artisti della Scuola <strong>di</strong> Barbizon<br />
Il realismo <strong>di</strong> Gustave Courbet, Daumier, Millet<br />
L’Impressionismo: genesi e caratteri del movimento con l’analisi e il commento <strong>di</strong> alcune opere <strong>di</strong><br />
Edouard Manet, Claude Monet, Edgar Degas, Auguste Renoir<br />
Il superamento dell’impressionismo nelle opere <strong>di</strong> Paul Cezanne, George Seurat, Paul<br />
Gauguin, Vincent Van Gogh, Henri de Toulouse-Lautrec<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 42/53
*Cenni sull’Europa <strong>di</strong> fin de siecle: il Divisionismo italiano <strong>di</strong> Giovanni Segantini e Pelizza da<br />
Volpedo, la Secessione viennese e Gustav Klimt, Edvard Munch<br />
7. UNO SGUARDO AL NOVECENTO<br />
*Il Cubismo e l’opera <strong>di</strong> Pablo Picasso<br />
*Il Futurismo<br />
*Cenni sulla Metafisica <strong>di</strong> De Chirico e l’Art deco<br />
*Argomenti svolti dopo il 15 maggio 20<strong>09</strong><br />
Testo adottato: Cricco-Di Teodoro, Itinerario nell’arte, Zanichelli, voll.2 e 3.<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 43/53
THE ROMANTIC AGE<br />
Revision of the Romantic poets:<br />
William Wordsworth<br />
from the Preface to Lyrical Ballads<br />
A Certain Colouring of Imagination<br />
from Lyrical Ballads<br />
We are Seven<br />
from Poems in Two Volumes<br />
Daffo<strong>di</strong>ls<br />
from Sonnets<br />
Composed upon Westminster Abbey<br />
Samuel Coleridge<br />
from the Preface to Lyrical Ballads<br />
Poetry and Imagination<br />
from the Rime of the Ancient Mariner<br />
Part I<br />
Part III<br />
George Gordon Byron<br />
LINGUA INGLESE<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 44/53
from Don Juan<br />
Search, then the Room<br />
Percy Bysshe Shelley<br />
Ode to the West Wind<br />
John Keats<br />
Ode on a Grecian Urn<br />
THE GOTHIC NOVEL<br />
Mary Shelley<br />
Lettura integrale <strong>di</strong> Frankenstein<br />
THE ROMANTIC NOVEL<br />
Jane Austen<br />
from Sense and Sensibility<br />
He was rich and she was handsome<br />
Willoughby turns Marian down<br />
from Pride and Preju<strong>di</strong>ce<br />
Darcy’s proposal<br />
Elisabeth’s self-realisation<br />
Edgar Alan Poe<br />
The black cat<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 45/53
THE VICTORIAN AGE<br />
The Historical context<br />
Queen Victoria’s accession to the throne<br />
The later years of Queen Victoria’s reign<br />
The British Empire<br />
The social context<br />
A nation of town dwellers<br />
The world picture<br />
The Victorian compromise<br />
An American insight<br />
From the Civil War to the Frontier<br />
The literary context<br />
Aestheticism and Decadence<br />
The rebirth of Theatre<br />
Authors and texts<br />
Charles Dickens<br />
from David Copperfield<br />
The first days at school<br />
Murdstone and Grinsby’s warehouse<br />
The Bronte Sisters<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 46/53
Emily Bronte<br />
from Wuthering Weights<br />
Back to Wuthering Weights<br />
I am Heathcliff<br />
Oscar Wilde<br />
from the Picture of Dorian Gray<br />
The Picture<br />
Dorian’s death<br />
from the Importance of being Earnest<br />
Deceits, tea and muffins<br />
George Bernard Shaw<br />
from Mrs Warren’s profession<br />
Mother and daughter<br />
THE MODERN AGE<br />
The historical context<br />
From Edward VII to World War I<br />
Britain at war<br />
The Twenties and Thirties<br />
World War II<br />
The social context<br />
The Edwar<strong>di</strong>ans<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 47/53
Between the wars<br />
The world picture<br />
The age of anxiety<br />
The literary context<br />
Revolt and experimentation<br />
The <strong>di</strong>vided consciousness<br />
A new realism<br />
The interior monologue<br />
Authors and texts<br />
The War Poets<br />
R. Brooke<br />
The Sol<strong>di</strong>er<br />
S. Sassoon<br />
Glory of Women<br />
Wystan Hugh Auden<br />
Refugees Blues<br />
James Joyce<br />
from Dubliners<br />
Eveline<br />
The Dead<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 48/53
Virginia Woolf<br />
from Mrs Dalloway<br />
The Party<br />
from To the Lighthouse<br />
1 chapter<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 49/53
MATEMATICA<br />
Ripasso del concetto <strong>di</strong> funzione e <strong>di</strong> grafico <strong>di</strong> funzione, dominio e intervalli <strong>di</strong> positività e<br />
negatività.<br />
Funzioni reali <strong>di</strong> variabile reale. Classificazione delle funzioni. Funzioni crescenti e decrescenti;<br />
funzioni pari e <strong>di</strong>spari. Calcolo del dominio <strong>di</strong> funzioni algebriche. Lettura <strong>di</strong> proprietà delle<br />
funzioni a partire dal loro grafico, asintoti, estremo superiore e inferiore, massimo e minimo.<br />
Ripasso della teoria delle coniche, della funzione esponenziale e logaritmica; curve algebriche<br />
deducibili dalle coniche esaminate e grafici <strong>di</strong> funzioni irrazionali. Grafici <strong>di</strong> funzioni modulari e<br />
grafici simmetrici e traslati ottenuti a partire da quelli delle coniche esaminate, dalla funzione<br />
logaritmica ed esponenziale. Equazioni e <strong>di</strong>sequazioni non algebriche risolte per via grafica<br />
Goniometria: definizione <strong>di</strong> seno, coseno, tangente e cotangente a partire dalla circonferenza<br />
goniometrica. Valori e grafici delle funzioni goniometriche e delle loro inverse, archi associati,<br />
formule <strong>di</strong> ad<strong>di</strong>zione, duplicazione, bisezione. Identità, equazioni e <strong>di</strong>sequazioni goniometriche;<br />
risoluzione grafica <strong>di</strong> equazioni e <strong>di</strong>sequazioni lineari in sen(x) e cos(x), equazioni omogenee.<br />
Il concetto <strong>di</strong> punto <strong>di</strong> accumulazione e <strong>di</strong> limite: definizione generale <strong>di</strong> limite. Limite destro e<br />
sinistro, al finito e all'infinito. Limiti delle funzioni elementari. Teoremi dell'unicità del limite,<br />
della permanenza del segno e del confronto. Limiti <strong>di</strong> operazioni tra funzioni e <strong>di</strong> composizioni <strong>di</strong><br />
funzioni. Analisi delle forme indeterminate e alcune tecniche <strong>di</strong> risoluzione: limiti all'infinito <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>fferenze e rapporti tra polinomi, limiti all'infinito <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenze tra ra<strong>di</strong>cali.<br />
Definizione <strong>di</strong> continuità, teorema <strong>di</strong> Weierstrass e degli zeri per funzioni continue in intervalli<br />
limitati e chiusi, analisi dei tipi <strong>di</strong> <strong>di</strong>scontinuità; limiti deducibili dai due limiti fondamentali<br />
dell'analisi. Teoria degli asintoti <strong>di</strong> una funzione e formule per la loro determinazione.<br />
Il concetto <strong>di</strong> derivata e sua definizione: calcolo delle derivate delle funzioni elementari; formule<br />
<strong>di</strong> derivazione della somma, prodotto, quoziente, ra<strong>di</strong>ce, potenza; punti <strong>di</strong> non derivabilità: flessi a<br />
tangente verticale, punti angolosi e cuspi<strong>di</strong>. Regole <strong>di</strong> derivazione delle funzioni goniometriche<br />
fondamentali, della funzione logaritmica ed esponenziale, la derivata delle funzioni composte;<br />
determinazione della retta tangente in un punto ad una funzione.<br />
Teoremi <strong>di</strong> Rolle, Lagrange, De L’Hospital e relative applicazioni.<br />
Stu<strong>di</strong>o analitico <strong>di</strong> funzione: dominio e intervalli <strong>di</strong> positività e negatività, ricerca <strong>di</strong> eventuali<br />
invarianze per simmetria, limiti, ricerca <strong>di</strong> eventuali asintoti verticali, orizzontali e obliqui,<br />
intervalli <strong>di</strong> crescenza e decrescenza (eventuali massimi e minimi), intervalli <strong>di</strong> concavità e<br />
convessità .<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 50/53
Meccanica<br />
FISICA<br />
Concetto <strong>di</strong> energia: energia cinetica, potenziale gravitazionale ed elastica, principio <strong>di</strong> conservazione<br />
dell’energia meccanica. Quantità <strong>di</strong> moto <strong>di</strong> un corpo, impulso <strong>di</strong> una forza, principio <strong>di</strong> conservazione<br />
della quantità <strong>di</strong> moto in un sistema isolato. Definizione <strong>di</strong> momento angolare e sua conservazione in<br />
un sistema isolato. Il momento d'inerzia.<br />
La Gravitazione: le leggi <strong>di</strong> Keplero, legge della gravitazione universale, massa inerziale e massa<br />
gravitazionale. Concetto <strong>di</strong> campo e linee <strong>di</strong> forza, il vettore campo gravitazionale; energia potenziale<br />
gravitazionale.<br />
Termo<strong>di</strong>namica<br />
Ripasso dei concetti base <strong>di</strong> calorimetria (affrontati nei precedenti anni scolastici all'interno<br />
della <strong>di</strong>sciplina "Scienze"): equilibrio termico: la temperatura e la <strong>di</strong>latazione termica dei soli<strong>di</strong>,<br />
dei liqui<strong>di</strong> e dei gas; il gas perfetto, le leggi <strong>di</strong> Boyle e <strong>di</strong> Gay Lussac, la temperatura assoluta,<br />
l’equazione <strong>di</strong> <strong>stato</strong> dei gas perfetti. Il calore: capacità termica e calore specifico, la temperatura<br />
<strong>di</strong> equilibrio, la caloria.La propagazione del calore.<br />
I principi della termo<strong>di</strong>namica: sistemi ed equilibrio termo<strong>di</strong>namico, il principio zero della<br />
termo<strong>di</strong>namica; lavoro eseguito da un gas e rappresentazione nel piano (P,V): le trasformazioni<br />
termo<strong>di</strong>namiche. Energia interna <strong>di</strong> un sistema termo<strong>di</strong>namico, le funzioni <strong>di</strong> <strong>stato</strong>; il lavoro<br />
meccanico compiuto da un sistema termo<strong>di</strong>namico; primo principio della termo<strong>di</strong>namica e sue<br />
applicazioni a trasformazioni isocore, isobare, a<strong>di</strong>abatiche e cicliche. Il secondo principio della<br />
termo<strong>di</strong>namica: enunciati <strong>di</strong> Kelvin e Clausius; ren<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> una macchina termica, cenni alle<br />
trasformazioni reversibili e irreversibili; il ciclo <strong>di</strong> Carnot, il frigorifero. L'entropia.<br />
Elettrostatica ed elettro<strong>di</strong>namica<br />
Il campo elettrico:le linee <strong>di</strong> forza, la legge <strong>di</strong> Coulomb, definizione <strong>di</strong> E, analogie e <strong>di</strong>fferenze con il<br />
campo gravitazionale; campo elettrico ra<strong>di</strong>ale, <strong>di</strong> un condensatore, <strong>di</strong> un <strong>di</strong>polo elettrico.<br />
Elettrizzazione per strofinìo, contatto, induzione; principio <strong>di</strong> conservazione della carica,<br />
l'elettroscopio, corpi conduttori e isolanti. Conduttore in un campo elettrico esterno (induzione);<br />
<strong>di</strong>elettrico in un campo elettrico esterno (polarizzazione). Costante <strong>di</strong>elettrica relativa ed assoluta del<br />
mezzo. L'energia potenziale elettrica, il potenziale elettrico, la conservatività del campo elettrostatico,<br />
le superfici equipotenziali. Campo elettrico e potenziale <strong>di</strong> un conduttore in equilibrio elettrostatico. Il<br />
flusso <strong>di</strong> E; teoremi <strong>di</strong> Gauss e <strong>di</strong> Coulomb. Il potere <strong>di</strong>spersivo delle punte.<br />
Dopo il 15 maggio<br />
La corrente elettrica continua, le leggi <strong>di</strong> Ohm, la forza elettromotrice e la resistenza interna <strong>di</strong> un<br />
generatore. Le resistenze in serie e in parallelo. La prima legge <strong>di</strong> Kirchoff. Effetto Joule, la potenza<br />
ed energia elettrica.<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 51/53
SCIENZE NATURALI<br />
Astronomia<br />
- Teoria del Big Bang. La Terra inserita nello spazio. L’Unità <strong>di</strong> misura astronomica e l’annoluce.<br />
La sfera celeste e le costellazioni. Gli elementi <strong>di</strong> riferimento sulla sfera celeste. Coor<strong>di</strong>nate<br />
astronomiche. Movimenti apparenti degli astri sulla sfera celeste.<br />
- La luminosità delle stelle e le classi <strong>di</strong> magnitu<strong>di</strong>ne. Colore e temperatura delle stelle. L’analisi<br />
spettrale della luce stellare. Effetto Doppler. Volume e massa stellare. Il <strong>di</strong>agramma H-R.<br />
Nascita, vita e morte <strong>di</strong> una stella.<br />
- Le galassie dell’Universo. Galassie in movimento. La Via Lattea. Il red shift delle galassie e la<br />
scoperta dell’espansione dell’Universo.<br />
- Il Sistema Solare. Origine del S.S.. Corpi in movimento uniti dalla forza <strong>di</strong> gravità. Le tre leggi<br />
<strong>di</strong> Keplero. Le principali caratteristiche dei pianeti terrestri e gioviani. Asteroi<strong>di</strong>, comete, meteore<br />
e meteoriti.<br />
Il pianeta Terra<br />
- Forma, <strong>di</strong>mensione e proprietà fisiche della Terra. Il moto <strong>di</strong> rotazione e le sue conseguenze:<br />
alternarsi del dì e della notte, moto apparente della sfera celeste, la forza centrifuga e le<br />
variazione dell’accelerazione <strong>di</strong> gravità, la forza <strong>di</strong> Coriolis. Prova della rotazione: esperienza <strong>di</strong><br />
Guglielmini. Movimento <strong>di</strong> rivoluzione. Conseguenze: giorno solare e giorno sidereo.<br />
Movimento apparente del Sole sullo sfondo dello Zo<strong>di</strong>aco. La prova <strong>di</strong> rivoluzione terrestre:<br />
l’aberrazione stellare. Le stagioni astronomiche<br />
- Il satellite della Terra: Luna<br />
Caratteristiche fisiche generali della Luna. Le quattro ipotesi sull’origine della Luna. La<br />
superficie lunare (mari, altopiani, crateri). I moti lunari: rotazione, rivoluzione e traslazione. Le<br />
fasi lunari. Le eclissi.<br />
- L’orientamento. I punti car<strong>di</strong>nali. Coor<strong>di</strong>nate polari. Latitu<strong>di</strong>ne e longitu<strong>di</strong>ne. La misura del<br />
tempo: giorno civile e sidereo. L’ora vera e fusi orari. Linea del cambio <strong>di</strong> data.<br />
- Caratteristiche generali della litosfera.<br />
La Terra solida<br />
- I minerali. Struttura cristallina e amorfa. La cella elementare. Scala <strong>di</strong> Mohs. Proprietà dei<br />
minerali. Classificazione in base alla composizione (ossi<strong>di</strong>, solfuri, alogenuri, solfati, fosfati,<br />
carbonati, silicati. I silicati: tetraedro, classificazione.<br />
- Le rocce. Concetto <strong>di</strong> roccia e litotipo, struttura e tessitura.<br />
Rocce magmatiche. Dai magmi alle rocce ignee. Composizione. Classificazione.<br />
Rocce se<strong>di</strong>mentarie. Processo se<strong>di</strong>mentario. Struttura, tessitura e classificazione delle rocce<br />
se<strong>di</strong>mentarie: r. detritiche, r. <strong>di</strong> deposito chimico, r. organogene.<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 52/53
Rocce metamorfiche. Processo metamorfico. Tipi <strong>di</strong> metamorfismo.<br />
La <strong>di</strong>namica endogena<br />
- Struttura interna della Terra: crosta, mantello, nucleo.<br />
- Teoria della deriva dei continenti. Tettonica delle placche. Margini <strong>di</strong> placca attivi: convergenti,<br />
<strong>di</strong>vergenti, conservativi; margini passivi. Fondali oceanici. Teoria dell’espansione dei fondali<br />
oceanici. Ciclo <strong>di</strong> Wilson. Punti cal<strong>di</strong>. Tettonica delle zolle associata alle attività sismica e vulcanica.<br />
- Fenomeni vulcanici. Magmi, vulcani e plutoni.<br />
Caratteristiche dei magmi. I prodotti del vulcanismo (lave e piroclasti). Forme degli e<strong>di</strong>fici<br />
vulcanici. Eruzioni <strong>di</strong> tipo esplosive e <strong>di</strong> tipo effusivo.<br />
- Terremoti. Origine. Teoria del rimbalzo elastico. Le onde sismiche profonde e superficiali.<br />
Concetti d’intensità e magnitudo. Gli effetti dei terremoti sul suolo, acque, costruzioni e uomo.<br />
Distribuzione dei terremoti. Il rischio sismico.<br />
CONTENUTI<br />
Atmosfera e Idrosfera<br />
- Composizione e sud<strong>di</strong>visione in strati dell’atmosfera. Temperatura e pressione<br />
atmosferica, i venti. Circolazione dell’aria. L’acqua nell’aria: umi<strong>di</strong>tà, nubi e<br />
nebbie, precipitazioni atmosferiche. Il tempo atmosferico: masse e fronti d’aria,<br />
cicloni, le previsioni del tempo.<br />
- I serbatoi dell’idrosfera e il ciclo dell’acqua. Mari e oceani: il livello del mare, caratteristiche fisicochimiche<br />
e biologiche dell’acqua. I movimenti del mare: le onde, le maree, le correnti superficiali e<br />
profonde.<br />
- Le acque continentali. Le acque sotterranee: falde e sorgenti. Le acque <strong>di</strong> superficie: acque<br />
incanalate, l’acqua dei fiumi. I laghi: evoluzione, caratteristiche fisico-chimiche e biologiche,<br />
classificazione. I ghiacciai: formazione, movimento, struttura e classificazione.<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III D liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 53/53