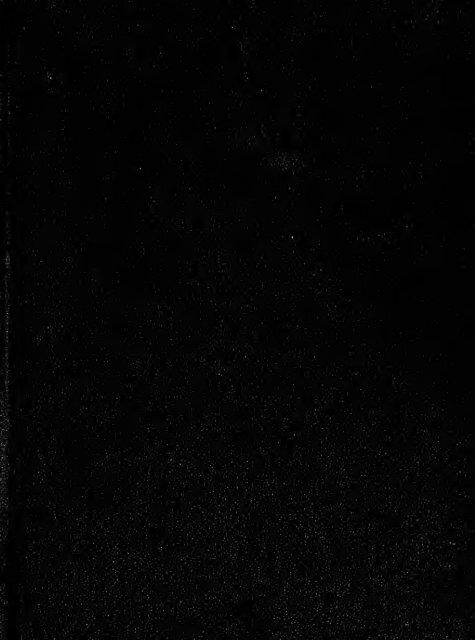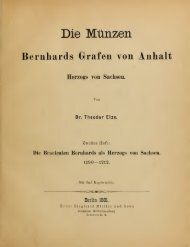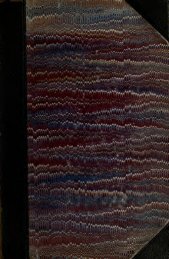Rivista italiana di numismatica e scienze affini - Medievalcoinage.com
Rivista italiana di numismatica e scienze affini - Medievalcoinage.com
Rivista italiana di numismatica e scienze affini - Medievalcoinage.com
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
RIVISTA ITALIANA<br />
DI<br />
NUMISMATICA
i<br />
i
RIVISTA ITALIANA<br />
DI<br />
NUMISMATICA<br />
PUBBLICATA PER CURA DELLA<br />
SOCIETÀ NUMISMATICA ITALIANA<br />
E DIRETTA DA<br />
FRANCESCO ed ERCOLE GNECCHI<br />
MILANO<br />
L. F. CoGLiATi Tip.-E<strong>di</strong>tore<br />
Via Pantano, N. 26.<br />
1897.
Tip. L. F. Cogliati<br />
PROPRIETÀ LETTERARIA<br />
v.lO<br />
- Sez. nel Fio Istituto pti Figli della Provvidenza.
CONSIGLIO DI REDAZIONE<br />
PEL 1897<br />
GNECCHI Cav. Uff. Francesco } ^. .<br />
#<br />
GNECCHI Cav. Uff Ercole<br />
)<br />
AMBROSOLI Dott. Cav. Solonr, Conservatore del Medagliere Nazionale<br />
<strong>di</strong> Brera e Libero docente <strong>di</strong> Numismatica presso la Regia Accademia<br />
> Direttori.<br />
Scient.-Lett. in Milano.<br />
GAVAZZI Cav. Giuseppe.<br />
MOTTA Ing. Emilio, Bibliotecario della Trìvulziana.<br />
PAPADOPOLI Conte Comm. Nicolò, Senatore del Regno, Presidente<br />
della Società Numismatica Italiana.<br />
RUGGERO Cav. Col. Giuseppe.<br />
SAMBON Dott. Arturo Giulio.<br />
VISCONTI March. Carlo Ermes, Conservatore del Museo Artistico<br />
Municipale <strong>di</strong> Milano.<br />
Luppi Cav. Prof. Costantino, Segretario.<br />
•
FASCICOLO L
APPUNTI<br />
DI<br />
NUMISMATICA ROMANA<br />
XLI.<br />
GLI ULTIMI DUPONDII<br />
O LE PRIME MONETE DI BRONZO DEGLI IMPERATORI<br />
DIOCLEZIANO E MASSIMIANO ERCULEO.<br />
È nei primi anni del regno <strong>di</strong> Diocleziano (verso<br />
il 300) che ha luogo la grande riforma monetaria<br />
e un semplice sguardo a una collezione <strong>di</strong> monete<br />
romane basta per rilevare la <strong>com</strong>pleta trasformazione<br />
che avviene, principalmente nel bronzo, fra il regno<br />
<strong>di</strong> Carino e quello <strong>di</strong> Diocleziano. Nulla <strong>di</strong> più<br />
<strong>com</strong>une e noto <strong>di</strong> quelli volgarmente chiamati me<strong>di</strong>i<br />
bronzi dei Tetrarchi, i quali, larghi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro e<br />
scarsi <strong>di</strong> spessore, sorgono in numero abbondantissimo<br />
e si <strong>di</strong>rebbe quasi d'improvviso, con un tipo<br />
<strong>di</strong> fabbricazione tutto nuovo e speciale, a sostituire<br />
quelli rarissimi <strong>di</strong> Caro, Numeriano e Carino, i quali<br />
conservano ancora T antico tipo <strong>di</strong> Aureliano e <strong>di</strong><br />
Probo. Parrebbe quasi che Diocleziano avesse in<br />
ventato il nuovo tipo il primo giorno della sua assun<br />
zione al trono; ma così non è nel fatto e la riforma<br />
avvenne bensì nei principii del regno <strong>di</strong> Diocleziano;<br />
ma non tanto imme<strong>di</strong>ata da non lasciar sussistere<br />
qualche piccola traccia dell' antica monetazione. La<br />
coniazione del bronzo era andata gradatamente sce-
12 FRANCESCO GNECCHI<br />
mando dopo il regno <strong>di</strong> Gallieno, al cessare della<br />
monetazione senatoria. Il sesterzio fu il primo a<br />
s<strong>com</strong>parire e non ne troviamo più alcuno alla metà<br />
del terzo secolo, mentre il dupon<strong>di</strong>o sopravvive<br />
ancora qualche tempo. Rarissimo e quasi eccezionale<br />
sotto gli imperatori antecedenti, continua ad essere<br />
tale nei primissimi anni <strong>di</strong> Diocleziano; pure ce ne<br />
restano ancora parecchi sia <strong>di</strong> lui che <strong>di</strong> Massimiano<br />
Erculeo primo suo associato all'impero. Mommsen<br />
col suo abituale acume avvertì (Voi. IV, pag. 97) che<br />
una parte delle monete (e avrebbe potuto <strong>di</strong>r tutte)<br />
che portano la leggenda lOVI CONSERVATORI e lOVI<br />
FVLGERÀTORI sono coniate suU' antico stampo; ma<br />
sia <strong>di</strong> queste, che <strong>di</strong> alcune altre portanti altri tipi<br />
e altre leggende (PAX e VIRTVS colla figura d'Ercole<br />
o <strong>di</strong> Marte), non fu mai tenuta la debita <strong>di</strong>stinzione<br />
nei cataloghi, dove sono descritte confusamente con<br />
quelle <strong>di</strong> nuovo stampo in modo che riesce affatto<br />
impossibile <strong>di</strong>stinguerle. Il Cohen descrive, fra le altre,<br />
parecchie <strong>di</strong> queste monete, senza accennare menomamente<br />
alla <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> tipo. È perciò che ho<br />
creduto opportuno <strong>di</strong> qui riunire tutti i bronzi <strong>di</strong> tipo<br />
antico <strong>di</strong> Diocleziano e Massimiano Erculeo, i quali<br />
si possono considerare <strong>com</strong>e gli ultimi dupon<strong>di</strong>i.<br />
Sono tutte monete rarissime al pari <strong>di</strong> quelle<br />
simiH dei precedenti imperatori Caro, Numeriano e<br />
Carino, e del medesimo peso, <strong>di</strong> poco superiore ai<br />
5 grammi, mentre quelli <strong>di</strong> nuovo stampo pesano<br />
quasi il doppio (oscillanti fra i pei io grammi). Per<br />
quante ricerche abbia fatto non mi riuscì <strong>di</strong> riunirne<br />
che 5 tipi, ossia:<br />
lOVI CONSERVAI AVG-G<br />
lOVI FVLCtERATORI<br />
PAX AVG ^<br />
VIRTVS AVG (Marte)<br />
VIRTVS AVGG (Ercole)<br />
per Diocleziano.
e uno solo :<br />
GLI ULTIMI DUPONDII l3<br />
VIRTVS AVGG" (Ercole in due pose variate) per Massimiano<br />
Erculeo,<br />
Può darsi, anzi è assai probabile, che gli altri<br />
rovesci <strong>di</strong> Diocleziano siano stati coniati anche per<br />
Massimiano; ma, all' infuori <strong>di</strong> quello ora accennato<br />
colla leggenda VIRTVS AVG, <strong>di</strong> cui posseggo le due<br />
varianti nella mia collezione, è uno solo il bronzo che<br />
ho creduto poter attribuire con sicurezza a Massimiano<br />
Erculeo, quantunque semplicemente riportato da un<br />
vecchio autore, quello col rovescio lOVI FVLG-ERATORI,<br />
rappresentando uno dei tipi esclusivi pei bronzi <strong>di</strong><br />
vecchio stampo. I quali tipi si possono dunque ridurre<br />
ai cinque sopra accennati, notando che i due riferentisi<br />
a Giove appaiono per la prima volta sotto Diocleziano,<br />
gli altri invece con Ercole, Marte o la Pace non sono<br />
che riproduzioni <strong>di</strong> quelli degli imperatori precedenti.<br />
Ecco la descrizione delle monete:<br />
DIOCLEZIANO.<br />
I _ ^ _ iivip DIOCLETIANVS AVG. Testa laureata a destra<br />
col paludamento.<br />
P — lOVI CONSERVAI AVG-G. Giove ignudo a sinistra,<br />
col mantello spiegato <strong>di</strong>etro le spalle. Tiene un fulmine<br />
e un lungo scettro.<br />
Cohen N. 238. Museo <strong>di</strong> Danimarca e mia collezione. Peso gr. 5,800.<br />
Altro esemplare simile, ma <strong>di</strong> conio <strong>di</strong>verso e <strong>di</strong> tipo piut-<br />
tosto barbaro.<br />
Mia collezione. Peso gr. 5,400.
14 FRANCESCO GNECCHI<br />
2. — B' — IMP DIOCLETIANVS AVG. Busto laureato a destra<br />
col paludamento.<br />
5i/ — lOVI FVLGERATORI. Giove ignudo corrente a sinistra<br />
in atto <strong>di</strong> lanciare il fulmine e col mantello sul braccio<br />
sinistro. Ai suoi pie<strong>di</strong> un'aquila.<br />
Cohen N. 255 (i). Museo <strong>di</strong> Danimarca.<br />
3. — ^ — IMP DIOCLETIANVS AVG. Busto laureato e co-<br />
razzato a destra.<br />
P — PAX AV&. La pace corrente a sinistra con un ramo<br />
e uno scettro.<br />
Cohen N. 281. Museo <strong>di</strong> Danimarca e mia collezione. Peso gr. 5,500.<br />
,....^<br />
- ^' — IMP DIOCLETIANVS AVO. Busto laureato e co-<br />
razzato a destra.<br />
(i) Probabilmente è da unire a questa serie anche il MB. descritto<br />
da Cohen al suo N. 225 riportandolo da Tanini, col rovescio: lovi conser<br />
K)vii coNs. Giove ignudo a sinistra, col mantello spiegato <strong>di</strong>etro le spalle,<br />
col fulmine e V asta. Ma, non avendone che la semplice descrizione e<br />
fors' anche in parte errata, (Tanini dà la testa ra<strong>di</strong>ata, mentre è assai<br />
più probabile che fosse laureata) non si può che accennare la cosa che<br />
in modo dubitativo.
GLI ULTIMI DUPONDII I5<br />
^ — VIRTVS AVG-. Marte armato e gra<strong>di</strong>ente a destra<br />
con lancia e scudo.<br />
Mia collezione. Peso gr. 5,500.<br />
f« -^<br />
5. — ^' - IMP DIOCLETIANVS AV&. Busto laureato e co-<br />
razzato a destra.<br />
1^ — VIRTVS AVGG-. Ercole ignudo <strong>di</strong> fronte rivolto a<br />
sinistra, appoggiato alla clava e con un trofeo e la pelle<br />
del leone.<br />
Cohen N. 350. Gabinetto <strong>di</strong> Francia.<br />
MASSIMIANO ERCULEO.<br />
6. - i& - IMP MAXIMIANVS P F AVG". Busto laureato a<br />
destra col paludamento.<br />
^K — lOVI FVLG-ERATORI. Giove ignudo corrente a sinistra<br />
col mantello svolazzante, eh' egli trattiene colla mano<br />
sinistra e in atto <strong>di</strong> lanciare il fulmine. Ai suoi pie<strong>di</strong><br />
un'afi[uila, che pare spaventata.<br />
.Cohen N. 311 da Tanini.<br />
La descrizione <strong>di</strong> questo rovescio corrisponde<br />
esattamente a quella che si <strong>di</strong>ede al N. 2 <strong>di</strong> Diocle-<br />
ziano. Nessun dubbio quin<strong>di</strong> che la moneta, quantunque<br />
per ora non se ne conosca alcun esemplare,<br />
vada attribuita alla vecchia serie.<br />
7. — ^' — IMP MAXIMIANVS AVG. Busto laureato e coraz-<br />
zato a destra.
l6 FRANCESCO GNECCHI<br />
1^ — VIRTVS AVGG. Ercole ignudo <strong>di</strong> fronte rivolto a<br />
sinistra. Tiene colla destra la clava abbassata, colla si-<br />
nistra la pelle del Leone e un trofeo.<br />
Ine<strong>di</strong>to — Mia collezione. Peso gr. 5,400.<br />
Ho già descritto questo bronzo nella Gazzetta<br />
Numismatica <strong>di</strong> Como (1886) e, avvertendo fin d'allora<br />
la <strong>di</strong>fferenza fra i me<strong>di</strong>i bronzi <strong>com</strong>uni dell'epoca e<br />
questo, che era l'unico esemplare a mia conoscenza<br />
e la stretta somiglianza coi me<strong>di</strong>i bronzi <strong>di</strong> Carino,<br />
l'aveva classificato per un piccolo medaglione.<br />
8. — /B' — IMP C MAXIMIANVS P F ÀVG-. Busto laureato a<br />
destra col paludamento.<br />
^ — VIRTVS ÀVG-G-. Ercole ignudo <strong>di</strong> fronte volto a si-<br />
nistra. S'appoggia colla destra alla clava e tiene colla<br />
sinistra l'arco e la pelle del Leone.<br />
Cohen N. 419 — Mia collezione. Peso gr. 5,200.<br />
Ritengo che questo bronzo sia il medesimo che<br />
il Cohen cita da Tanini al suo N. 419. Quantunque<br />
non sia in<strong>di</strong>cato se esso abbia il tipo <strong>com</strong>une dei<br />
nuovi bronzi <strong>di</strong> Massimiano, oppure quello dei vecchi<br />
dupon<strong>di</strong>i, è supponibile ed anzi probabilissimo che<br />
sia del tipo antico per la somiglianza della rappresen-<br />
tazione coir ultimo che abbiamo descritto <strong>di</strong> Diocleziano<br />
e col precedente dello stesso Massimiano.<br />
E per la stessa ragione deve attribuirsi a questa<br />
categoria anche l'altro bronzo che Cohen cita dallo<br />
stesso Tanini al suo N. 418, il quale non è che una<br />
piccola variante del precedente:<br />
g. — ^- iMP MAXIMIANVS P F AVG-. Testa laureata a destra.<br />
^ ~ VIRTVS AVG-G-. Ercole <strong>com</strong>e al Numero precedente.
XLII.<br />
BRONZO INEDITO<br />
DI MASSIMIANO ERCULEO.<br />
n^ I<br />
Alla breve memoria sugli ultimi dupon<strong>di</strong>i può<br />
far seguito e <strong>com</strong>plemento la descrizione <strong>di</strong> un curioso<br />
bronzo <strong>di</strong> Massimiano Erculeo, che mi venne<br />
tempo fa procurato dal <strong>com</strong>pianto Boutkowski e che<br />
non ho mai descritto finora, non avendo mai saputo<br />
decidere a quale categoria <strong>di</strong> bronzi attribuirlo.<br />
^ - VIRTVS MAXIMIANI AVG". Busto ra<strong>di</strong>ato e corazzato<br />
a destra. Tiene colla destra 1' asta, e colla sinistra lo<br />
scudo e due dar<strong>di</strong>.<br />
1^ — VOTA PVBLICA. Nettuno ignudo col tridente e il<br />
piede sinistro appoggiato su <strong>di</strong> una prora <strong>di</strong> nave in atto<br />
d'offrire un delfino a una donna (l'Africa?) che gli sta<br />
<strong>di</strong> fronte tenendo il sistro (?) e la qui testa è ornata della<br />
simbolica proboscide.<br />
Ine<strong>di</strong>to — Peso gr. 6,500. Mia collezione.<br />
Il rovescio è affatto nuovo fra le monete <strong>di</strong> Mas-<br />
simiano Erculeo e la rappresentazione sembra inspi-<br />
rata da un medaglione anepigrafo d'Adriano (Coh.<br />
N. 558), nel quale Nettuno, cogli stessi emblemi e<br />
nell'identica posa del nostro, si trova <strong>di</strong> fronte a<br />
Minerva. Ma ciò che forma l' interesse <strong>di</strong> questo
l8 FRANCESCO GNECCHI<br />
bronzo è piuttosto il dritto e il peso. La testa <strong>di</strong><br />
Massimiano è ra<strong>di</strong>ata e ciò lo esclude dalla categoria<br />
dei vecchi dupon<strong>di</strong>i, nei quali la testa dell'imperatore<br />
è sempre laureata; <strong>com</strong>e ne lo esclude il peso <strong>di</strong> 6<br />
grammi e mezzo, il quale, se è soverchio per un<br />
vecchio dupon<strong>di</strong>o, è troppo leggero pel nuovo bronzo<br />
o follis creato dalla riforma <strong>di</strong> Diocleziano ; e anche<br />
la leggenda VIRTVS MAXIMIANI e il busto a mezza figura<br />
non si trovano mai nelle monete semplici <strong>di</strong> Massimiano<br />
Erculeo; ma solamente fra i suoi medaglioni.<br />
A quale categoria dovremo dunque attribuire il nuovo<br />
bronzo? Ecco un problema, la cui soluzione è pro-<br />
posta agli stu<strong>di</strong>osi.<br />
È poi da sapersi che il medesimo bronzo esiste<br />
anche <strong>di</strong> Costanzo Cloro. Non mi appartiene; ma,<br />
avendolo avuto presso <strong>di</strong> me qualche tempo, ne presi<br />
l'impronta e ne posso offrire la descrizione:<br />
©" - IMP CONSTANTIVS P F AVG-. Busto ra<strong>di</strong>ato a destra<br />
col manto e la corazza. L'imperatore tiene colla destra<br />
l'asta appoggiandola alla spalla.<br />
9* — VOTA PVBLICA. Nettuno e l'Africa <strong>com</strong>e nel precedente.<br />
Ine<strong>di</strong>to — Peso gr. 7.<br />
Si tratta quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> un identico rovescio, e, a<br />
quanto mi pare, prodotto dal medesimo conio, applicato<br />
a due dritti con teste <strong>di</strong>fferenti ; perciò quanto<br />
s' è detto sul bronzo <strong>di</strong> Massimiano può essere ripe-<br />
tuto a proposito <strong>di</strong> quello <strong>di</strong> Costanzo.
XLIII.<br />
UN RIPOSTIGLIO MISERABILE.<br />
Un ripostiglio <strong>com</strong>posto <strong>di</strong> 418 pezzi <strong>di</strong> bronzo<br />
<strong>di</strong> pessima fabbricazione, quasi <strong>com</strong>pletamente illegibili<br />
e del peso <strong>com</strong>plessivo <strong>di</strong> gr. 306, con una me<strong>di</strong>a<br />
cioè per ciascun pezzo inferiore ai •''|^ <strong>di</strong> grammo (0.73)<br />
deve essere necessariamente l'espressione della minima<br />
potenzialità economica e rappresentare l'epoca<br />
la più miserabile. Ciò non toglie però che il piccolo<br />
ripostiglio possa avere un interesse storico-scientifico;<br />
anzi il suo interesse viene appunto da ciò.<br />
Fu ritrovato lo scorso anno presso Perugia,<br />
conservato in un rustico vasetto <strong>di</strong> terra cotta ; e questa<br />
volta mi pare si sia verificato il caso rarissimo d'avere<br />
nelle mani il ripostiglio intatto quale fu ritrovato.<br />
Difatti la tentazione non poteva essere che lievissima<br />
pel ritrovatore.<br />
Ho detto che il ripostiglio si <strong>com</strong>pone <strong>di</strong> 418<br />
pezzi, non oserei quasi <strong>di</strong>re monete, trattandosi in<br />
piccola parte <strong>di</strong> vecchie monete consunte e quasi<br />
tutte frammentate, e nel resto <strong>di</strong> pezzi apparentemente<br />
<strong>di</strong> conio fresco; ma che pure, piuttosto che vere<br />
monete, non sono che simulacri <strong>di</strong> monete o imitazioni<br />
barbare. Precisamente il ripostiglio si <strong>com</strong>pone<br />
<strong>di</strong> N. 17 monetine antiche, N. 65 frammenti <strong>di</strong> vecchie<br />
monete, e <strong>di</strong> N. 336 imitazioni barbare. Fra le vecchie<br />
monete, malgrado l'estrema sconservazione e la spez-<br />
zatura, sono ancora visibili le traccie <strong>di</strong> alcuni nomi.<br />
Il frammento più antico è quello <strong>di</strong> un piccolo bronzo<br />
<strong>di</strong> Clau<strong>di</strong>o Gotico dal rovescio CQNSECRATIO, e a
20 FRANCESCO GNECCHI<br />
questo segue un altro piccolo frammento <strong>di</strong> un dupon<strong>di</strong>o<br />
d'Aureliano, rovescio CONCORDIA. Troviamo<br />
poi un antoniniano <strong>di</strong> Probo, il quale, è conservato<br />
intero <strong>com</strong>e <strong>di</strong>ametro, forse perchè tanto consunto<br />
al rovescio principalmente, da aver perduto la metà<br />
del suo peso originario, e costituisce la moneta piìi<br />
gran<strong>di</strong>osa del ripostiglio, dominando fra le propor-<br />
zioni microscopiche dei pezzi che lo circondano.<br />
Da Probo saltiamo ad epoca molto più recente<br />
con monete e frammenti da cui appajono ancora i<br />
nomi <strong>di</strong> Costante, Graziano, Valentiniano II, Onorio,<br />
Teodosio II e Marciano. Tutte le altre vere monete<br />
sono in uno stato così deplorevole <strong>di</strong> conservazione<br />
da rendere impossibile qualunque classificazione.<br />
Passando ora alla parte più grossa del ripostiglio,<br />
essa ci presenta delle monetine che sembrano coniate<br />
poco prima d'essere state nascoste; ma in modo tanto<br />
barbaro da riuscire assolutamente enigmatiche e non<br />
spiegabili altrimenti che colla supposizione che siano<br />
contraffazioni barbare o per meglio <strong>di</strong>re il prodotto<br />
<strong>di</strong> una coniazione clandestina. Rappresentano da un<br />
lato una testina, dall' altro una figurina maschile<br />
o femminile (imitazioni dell' imperatore o della Vittoria),<br />
un castello, una croce, una corona o un monogramma<br />
indecifrabile e talvolta al dritto e al rovescio<br />
l'imitazione barbara d'una leggenda; ciò che <strong>di</strong>mostra<br />
chiaramente l'intenzione d'imitare i piccolissimi bronzi<br />
degli ultimi imperatori d'Oriente, Arca<strong>di</strong>o, Teodosio II,<br />
Marciano oppure quelle un po' più recenti dei Goti.<br />
Se a ciò aggiungiamo la spezzatura <strong>di</strong> tutte le vecchie<br />
monete superanti la misura minima degli accennati<br />
bronzi imperiali o gotici, si deve convenire che il ri-<br />
postiglio corrisponde appunto all'epoca della estrema<br />
povertà del pubblico erario, al tempo cioè del famoso<br />
e<strong>di</strong>tto (anno 395) che proibiva la coniazione delle<br />
monete <strong>di</strong> bronzo <strong>di</strong> gran modulo (e il gran modulo
UN RIPOSTIGLIO MISERABILE 21<br />
era già un modulo assai ridotto a quest' epoca) e<br />
solo era conservata la moneta spicciola, nummus<br />
centennionalis.<br />
Che se le monete degli Ostrogoti e dei Vandali<br />
furono sempre ritenute quali l'espressione del livello<br />
più basso delle con<strong>di</strong>zioni economiche <strong>di</strong> un paese,<br />
il nostro ripostiglio va ancora più in là e segna il<br />
punto culminante dell* estrema penuria dei tempi.<br />
Non solo, in mancanza <strong>di</strong> monete autentiche e uffi-<br />
ciali, se ne fabbricavano facilmente delle imitazioni,<br />
punzonando alla peggio dei minuscoli frammenti <strong>di</strong><br />
metallo — la falsificazione non è pur troppo prero-<br />
gativa dei tempi <strong>di</strong> miseria — ma si tolleravano nella<br />
circolazione anche le antiche monete preesistenti,<br />
dopo d' averle ridotte, me<strong>di</strong>ante la spezzatura, al<br />
valore della moneta corrente. È certamente il primo<br />
e forse V unico ritorno al sistema del valore del<br />
bronzo <strong>com</strong>misurato al peso, dopo i tempi dell' aes<br />
rude.... E le ridotte proporzioni esprimono eloquentemente<br />
le mutate con<strong>di</strong>zioni sociali!<br />
In seguito a tali considerazioni non è <strong>di</strong>fficile<br />
assegnare molto approssimativamente V epoca del<br />
sepellimento al nostro ripostiglio.<br />
Come più sopra s' è visto, l'ultimo nome ricono-<br />
scibile fra quelli delle vecchie monete è quello <strong>di</strong><br />
Marciano e quin<strong>di</strong> il ripostiglio non potrebbe in nessun<br />
modo essere anteriore alla prima metà del V secolo.<br />
Considerando però <strong>com</strong>e queste vecchie monete siano<br />
in uno stato che <strong>di</strong>mostrano chiaramente d' aver<br />
avuto lunghissimo corso, e , più ancora osservando<br />
le <strong>di</strong>mensioni e il tipo delle monete imitanti quelle<br />
dei Goti, il nostro ripostiglio dovrebbe riferirsi alla<br />
prima metà del VI secolo, epoca nella quale sono<br />
estremamente rari i ripostigli <strong>di</strong> monete <strong>di</strong> bronzo.<br />
E <strong>com</strong>e poteva essere altrimenti, quando si vede<br />
che una riunione <strong>di</strong> piccoli frammenti <strong>com</strong>e quelli
22 FRANCESCO GNECCHI<br />
descritti potevano costituire un tesoretto degno d'essere;<br />
nascosto?<br />
I ripostigli <strong>di</strong> bronzo <strong>di</strong> questi tempi sono tanto<br />
rari che <strong>di</strong> uno solo posteriore all'epoca d'Anastasio<br />
ci resta una accurata e precisa descrizione, quella<br />
<strong>di</strong> Monteroduni nel Sannio.<br />
Di qualche altro <strong>di</strong> poca importanza non abbiamo<br />
che notizie vaghe. Io ebbi anni sono una<br />
parte (circa 200 monetine) <strong>di</strong> un ripostiglio che doveva<br />
essere interessantissimo, degli Ostrogoti e dei<br />
Vandali, coi nomi e monogrammi <strong>di</strong> Odoacre, Teo-<br />
derico, Atalarico, Teodato, Vitige, Baduela, Anastasio,<br />
Ilderico, Gelimaro, oltre ad alcune incerte e bar-<br />
bare che si assomigliano molto a quella del ripo-<br />
stiglio <strong>di</strong> Perugia; ma non mi fu dato <strong>di</strong> sapere né<br />
la provenienza, ne la <strong>com</strong>posizione <strong>com</strong>pleta.<br />
l\ ripostiglio <strong>di</strong> cui ora ho fatto cenno non<br />
contiene un solo pezzo che presenti un valore benché<br />
njÌBÌn]ip pel raccoglitore; tuttavia, sia per l'epoca così<br />
scarsa <strong>di</strong> ripostigli, sia pel fenomeno abbastanza cu-<br />
rioso della frammentazione dei pezzi, sia infine per<br />
1^ specialità <strong>di</strong> essere quasi totalmente costituito <strong>di</strong><br />
monete false dell'epoca, non ho creduto senza inte-<br />
resse il darne una breve notizia.<br />
FRANCESCO GnECCHI.
APPUNTI<br />
DI<br />
NUMISMATICA ITALIANA<br />
XVI.<br />
IL RIPOSTIGLIO DI CAVRIANA,<br />
Nei Comune <strong>di</strong> Cavriana (Prov. <strong>di</strong> Mantova), un<br />
operaio, nel demolire un vecchio muro, scopriva, due<br />
anni or sono, un gruzzolo <strong>di</strong> circa loo monetine<br />
italiane d'argento. Di queste monete, settanta furono<br />
acquistate da un proprietario del luogo, il quale,<br />
solo poco tempo fa, decise d' alienarle. Ho avuto<br />
la fortuna <strong>di</strong> acquistarle tutte e <strong>di</strong> trovarne altre<br />
ch'erano andate <strong>di</strong>sperse; cosicché posso <strong>di</strong>re <strong>di</strong><br />
possedere il ripostiglio nella quasi sua totalità. Il<br />
tesoretto è piccolo, ma molto variato e interessante,<br />
contenendo alcune monete affatto nuove. Credo<br />
quin<strong>di</strong> opportuno pei lettori della <strong>Rivista</strong> il dare una<br />
illustrazione sommaria dei vari tipi <strong>di</strong> monete che vi<br />
trovai, descrivendo quelle nuove e varianti, e riferendomi,<br />
per quelle già pubblicate, alle opere dei<br />
vari autori. Fra le monete nuove, <strong>di</strong> cui possedevo<br />
due esemplari, ne ho <strong>di</strong> buon grado sacrificato uno,<br />
per far eseguire l'assaggio del titolo, e poter così<br />
stabilire con certezza la loro denominazione.<br />
Sono .<br />
tutte monete delle Repubbliche Italiane dei<br />
secoli XII e XIII, e appartengono alle seguenti città :
34<br />
ERCOLE GNECCHl<br />
Acqui, Asti, Bergamo, Brescia, Como, Cortemiglia<br />
Cremona, Lo<strong>di</strong>, Mantova, Milano, Piacenza, Tortona<br />
e Vercelli.<br />
ACQUI.<br />
I. Denaro grosso fgr. 1.250).<br />
^' — + IMPERATOR. Nel campo, in un circolo periato, F R-<br />
(Sull'abbreviazione una croce).<br />
P — + AQVENSIS. Nel campo, e. s., croce.<br />
Questo grosso, per tutto il resto identico a quello<br />
pubblicato da D. Promis, {Monete del Piemonte ine<strong>di</strong>te<br />
rare, Torino, 1852, in-4, pag. 6, tav. I, i), presenta,<br />
<strong>com</strong>e si vede dal <strong>di</strong>segno, la varietà <strong>di</strong> una crocetta<br />
posta sull'abbreviazione delle lettere F R del <strong>di</strong>ritto.<br />
Non mi accadde mai <strong>di</strong> vedere questo simbolo<br />
sulle numerose abbreviazioni che s'incontrano nei<br />
grossi <strong>di</strong> quest'epoca.<br />
Questa croce, che certo non fu messa a caso,<br />
è probabilmente un segno del dominio temporale dei<br />
Vescovi sulla città <strong>di</strong> Acqui, dominio ch'essi avevano<br />
ricevuto dagli Ottoni verso il 900, e che ritennero<br />
fino al XIII secolo (i).<br />
2. Grosso (gr. 1.370).<br />
ASTI,<br />
Promis D., Monete della zecca d'Asti, Torino, 1853, in-4, P- 20, tav. I, i.<br />
(i) Ve<strong>di</strong> Promis D., Monete del Piemonte ine<strong>di</strong>te o rare. Torino, 1852,<br />
Hi-4, pag. 5»<br />
,
APPUNTI DI NUMISMATICA ITALIANA 35<br />
BERGAMO.<br />
3. Grosso (gr. 1.300).<br />
ViMERCATi-Sozzi P., Sulla moneta <strong>di</strong> Bergamo. Ivi, i88i, in-4, tav. I, 8.<br />
4. Obolo (gr. 0.320 — Ti». 192 — scodellato).<br />
^' — FREDERI CVS IMPRT * Busto laureato <strong>di</strong> Federico II<br />
a destra.<br />
P — Veduta della città. Ai lati PGA MVM. In alto, nel<br />
campo, a destra una stella, a sinistra un punto.<br />
5. Obolo (gr. 0.330 — Tit. 224).<br />
Variante del precedente, senza il punto nel campo del<br />
rovescio.<br />
Queste due monetine, che imitano perfettamente<br />
il tipo del grosso, sono, ch'io mi sappia, affatto<br />
ine<strong>di</strong>te e sconosciute.<br />
BRESCIA.<br />
6. Obolo (gr. 0.310 • 0.320 — scodellato).<br />
Bellini V., De Monetis Italiae, etc. Altera Dissertatio, pag. 27, n. i.<br />
COMO.<br />
7. Grosso (gr. 1.320).<br />
Ambrosoli S., Zecche italiane rappresentate nella sua Raccolta<br />
<strong>numismatica</strong>. Como, 1881, in-4, pag. 9, tav. MI, n. 17.<br />
8. Obolo (gr. 0.320 — scodellato).<br />
Ambrosoli S., Op. cit., pag. 8, tav. MI, n. 12.<br />
9. Obolo (gr. 0.320 — id.).<br />
Ambrosoli S., Op. cit., pag. 8, tav. MI, n. 13.<br />
10. Obolo (gr. 0.310-0.320 — id.).<br />
Ambrosoli S., Op. cit., pag. 8, tav. MI, ii. 14.
^ — + • • M<br />
II. Grosso (gr. I.3CX3).<br />
D<br />
•<br />
CARETO<br />
ERCOLE GWECCHI<br />
CORTEMIGLIA.<br />
•<br />
Nel campo, in circolo periato,<br />
Croce. Dal circolo partono due cunei, che si <strong>di</strong>rigono<br />
verso due angoli opposti della croce.<br />
INPERATOR<br />
P — + •<br />
• Nel campo, e. s., in tre righe: hE RIC N.<br />
Ho il piacere <strong>di</strong> aggiungere questo grosso, finora<br />
affatto sconosciuto, alla scarsa serie delle monete<br />
<strong>di</strong> Cortemiglia.<br />
Il Promis (2) afferma che i Signori <strong>di</strong> Cortemiglia<br />
batterono moneta sul principio del secolo XIV, e<br />
nota <strong>com</strong>e in queir epoca aprissero zecca " anche i<br />
marchesi <strong>di</strong> Saluzzo, Incisa e Ponzone^ tutti ugualmente<br />
pretendenti <strong>di</strong>scendere dal celebre Aleramo. „<br />
La moneta ora descritta però è evidentemente<br />
<strong>di</strong> epoca anteriore, ed essendo una perfetta imitazione,<br />
fino nei più minuti particolari, del soldo battuto a<br />
Milano 'da Enrico VI, mi sembra chiaro ch'essa debba<br />
essere contemporanea a quello, o <strong>di</strong> poco posteriore.<br />
L' epoca della sua battitura dovrebbe quin<strong>di</strong> asse-<br />
gnarsi fra gli ultimi anni del secolo XII e i primi<br />
del XIII. Sappiamo che Cortemiglia faceva parte<br />
della pingue ere<strong>di</strong>tà lasciata dal marchese Bonifacio<br />
a' suoi sette figli. Nella <strong>di</strong>visione da essi fatta nel<br />
1142, Cortemigha veniva costituita capo <strong>di</strong> un marchesato<br />
e assegnata ad uno dei figli, pure chiamato<br />
Bonifacio. Morto questi senza prole, i fratelli super-<br />
(2) Promis D., Monete ine<strong>di</strong>le del Piemonte. Torino, 1866, in-4, p. 24-25.
APPUNTI DI NUMISMATICA ITALIANA «7<br />
stiti fecero una seconda <strong>di</strong>visione, ri<strong>com</strong>ponendo i due<br />
nuovi marchesati <strong>di</strong> Clavesana e <strong>di</strong> Cortcmiglia. A<br />
quest* ultimo fu preposto Ottone, figlio primogenito<br />
<strong>di</strong> Enrico il Guercio, marchese <strong>di</strong> Savona. Nella<br />
porzione a lui toccata ed eretta in marchesato, si<br />
trovava il luogo <strong>di</strong> Carretto (3). Da questa piccola<br />
frazione del suo feudo Ottone prese il titolo <strong>di</strong> Mar-<br />
chese del Carretto, nome che restò a tutta la serie<br />
de' suoi successori (4). In un documento dell'anno 1209,<br />
troviamo che il predetto Ottone, col consenso del<br />
figlio, vendeva al Comune <strong>di</strong> Asti tutto quanto possedeva<br />
in Cortcmiglia e in molte altre terre circonvicine,<br />
e contemporaneamente, con altro atto, essi venivano<br />
dal podestà e a nome del Comune <strong>di</strong> Asti, investiti<br />
<strong>di</strong> quelle terre in fendum rectum et gentile (5).<br />
A questo Ottone, che primo prese il titolo <strong>di</strong><br />
Marchese del Carretto, apparterrebbe per avventura<br />
il grosso ora descritto? Metto là quest'idea <strong>com</strong>e<br />
una semplice congettura, vedendo che il tipo della<br />
moneta coincide appunto con quell'epoca; e lascio ai<br />
numismatici più <strong>di</strong> me esperti e provetti <strong>di</strong> esaminare<br />
la questione e pronunciare un giu<strong>di</strong>zio. Quello che<br />
posso asserire con tutta certezza si è che il tipo del<br />
mio grosso non può in alcun modo essere assegnato<br />
all'epoca nella quale pare accertato siano state battute<br />
le altre monete anonime dei Marchesi <strong>di</strong> Cortcmiglia,<br />
ossia al principio del secolo XIV. Lo stesso ripo-<br />
stiglio, nel suo insieme, confermerebbe la mia opi-<br />
nione. Tutte le monete che lo <strong>com</strong>pongono, <strong>com</strong>e lo<br />
provano il tipo e le leggende, appartengono alla fine<br />
(3) Carretto, piccolo <strong>com</strong>une <strong>di</strong> circa 200 abitanti in Prov. <strong>di</strong> Genova,<br />
Gre. <strong>di</strong> Savona.<br />
(4) Cazzerà C, Delle zecche e <strong>di</strong> alcune rare rrjonete degli antichi<br />
marchesi <strong>di</strong> Ceva, Incisa e Cortcmiglia {Mem. dell'Accad. <strong>di</strong> Torino,<br />
serie I, 1833, pag. 94-95)-<br />
(5) Cazzerà, Op. cit., pag. 95.
28<br />
ERCOLE GNECCHI<br />
del secolo XII, e ai primi <strong>di</strong>eci o do<strong>di</strong>ci lustri del XIII,<br />
e nessuna oltrepassa quell'epoca.<br />
Un mio amico numismatico, il quale si propone<br />
<strong>di</strong> illustrare la Zecca <strong>di</strong> Cortemiglia, pubblicherà fra<br />
breve un'altra monetina ine<strong>di</strong>ta dei Marchesi del Car-<br />
retto e <strong>di</strong> epoca forse anteriore alla mia. In quella<br />
circostanza egli ritornerà sulla questione, e saprà<br />
certo risolverla megho ch'io non abbia potuto.<br />
Un' ultima osservazione a proposito <strong>di</strong> questa<br />
moneta. Essa, <strong>com</strong>e si <strong>di</strong>sse, è una imitazione servile<br />
del soldo <strong>di</strong> Enrico VI per Milano. Il suo titolo però,<br />
evidentemente, appare inferiore a quello della moneta<br />
milanese. I Marchesi del Carretto inauguravano con<br />
ciò un sistema che fu poi adottato dagli stessi loro<br />
successori, e specialmente dai Signori <strong>di</strong> Saluzzo,<br />
d' Incisa, <strong>di</strong> Ponzone, e da tutti gli altri così detti<br />
aleramici. Essi copiavano il tipo delle migliori e piìi<br />
accre<strong>di</strong>tate monete contemporanee, perchè avessero<br />
più facilmente corso, e ne alteravano poi spudoratamente<br />
la intrinseca bontà. Furono questi enormi<br />
abusi che provocarono la famosa Grida <strong>di</strong> Enrico VII<br />
del 1310, colla quale venivano messi al bando, insieme<br />
a molte altre monete, imperiales fados in Clivassio,<br />
in Yporeya, in Incixa et in Ponzano in Curtemilia, etc.<br />
12. Soldo (gr. 1.250).<br />
CREMONA.<br />
Tonini P., Della Zecca <strong>di</strong> Cremona (Perio<strong>di</strong>co <strong>di</strong> Nutnis. e Sfragi-<br />
stica, i863, voi. I, pag. 60, tav. IV, n. 4.<br />
13. Obolo (gr. 0.320 ~ Tit. 164 — scodellato).<br />
^ — + FREDERICVS. Nel campo, in un circolo periato,<br />
P ^ R<br />
I<br />
(hnperator).<br />
1
APPUNTI DI NUMISMATICA ITALIANA 29<br />
Dal basso del circolo, partono due cunei che si <strong>di</strong>rigono<br />
al centro.<br />
51 — + • • CREMONA Nel campo, e. s., una stella a sei raggi.<br />
— (Ine<strong>di</strong>ta).<br />
14. Medaglia (gr. 0.320 - Tit. 124).<br />
/B' — + FREDERICVS. Nel campo, in un circolo e. s., .<br />
p<br />
i^c p<br />
9^ — + CREMONA. Nel campo, e. s., croce. In alto, fra i<br />
bracci della croce, due stelle. — (Ine<strong>di</strong>ta).<br />
Di questa medaglia^ detta anche cremonese ^ e<br />
nota dai documenti dell'epoca, fece un primo cenno<br />
il prof. Alessandro Lisini in questa stessa <strong>Rivista</strong> (6).<br />
In esso egli osserva giustamente <strong>com</strong>e il Tonini, nella<br />
sua Illustrazione della zecca <strong>di</strong> Cremona (7), pretese<br />
<strong>di</strong> pubblicare la medaglia, ma s'ingannò, illustrando<br />
invece e dando il <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> un mezzanino, equiva-<br />
lente alla metà del denaro imperiale, mentre la<br />
medaglia ne valeva soltanto la quarta parte.<br />
Nella celebre Convenzione conchiusa nel 1254 fra<br />
le città <strong>di</strong> Bergamo, Cremona, Parma, Brescia, Piacenza,<br />
Pavia e Tortona, allo scopo <strong>di</strong> coniar moneta<br />
uniforme, oltre il grosso ed il mezzanino, si stabiliva<br />
la battitura della medaglia, al taglio <strong>di</strong> 816 per<br />
libbra, al titolo <strong>di</strong> once i %. La medagha doveva<br />
dunque avere il peso <strong>di</strong> gr. 0.399, l'intrinseco <strong>di</strong><br />
gr. 0.50, e la lega <strong>di</strong> gr. 0.349.<br />
Probabilmente questa monetina fu battuta in<br />
(6) A. LisiNi, Medaglie <strong>di</strong> zecche italiane. {<strong>Rivista</strong> It. <strong>di</strong> Nutnis. 1896,<br />
anno IX, fase. II, pag. 229).<br />
(7) Nel Perio<strong>di</strong>co <strong>di</strong> Numismatica e Sfragistica, anno I, pag. 60,<br />
tav. IV, n. 5.
30<br />
ERCOLE GNECCHl<br />
seguito a quella Convenzione, e lo arguisco anche<br />
dalle stellette che vi si scorgono nel <strong>di</strong>ritto e nel ro-<br />
vescio , contrassegno eh' era stato espressamente<br />
convenuto in un articolo <strong>di</strong> quel concordato. In tal<br />
caso la monetina dovrebbe essere stata battuta dal<br />
1254 al 1256, che per soli due anni ebbe vigore quel<br />
trattato. Il peso della mia moneta sarebbe un poco<br />
inferiore a quello prescritto; ma il titolo <strong>di</strong> 124, che<br />
mi risultò all'assaggio, vi corrisponde con precisione,<br />
equivalendo a once i 'l^, ossia ad un ottavo <strong>di</strong> fino.<br />
LODI.<br />
15. Grosso (gr. 1.250).<br />
Al<strong>di</strong>ni P. V., Sopra un'antica moneta <strong>di</strong> Lo<strong>di</strong>. Pavia, 1836, fig.<br />
MANTOVA.<br />
16. Obolo (gr. 0.325 — scodellato).<br />
PoRTioLi A., La zecca <strong>di</strong> Mantova, Parte I. Mantova, 1879, in-8,<br />
tav. ann. n. 3.<br />
17. Medaglia (gr. 0.310).<br />
/B' — + MANTVE. Nel campo, in circolo periato, croce.<br />
In due angoli opposti della croce, due punti.<br />
9' - + VIRGILIVS. Nel campo e. s. ^ ' ^ (Episcopus),<br />
È una variante <strong>di</strong> quella pubblicata dal Portioli<br />
nell'opera citata, tav. ann. n. 4, la quale ha le lettere<br />
e . e . .<br />
nel <strong>di</strong>ritto, e la croce nel rovescio.<br />
MILANO.<br />
18. Denaro (gr. 0.460 — scodellato).<br />
Gnecchi F. e E., Monete <strong>di</strong> Milano ine<strong>di</strong>te. Supplemento {Riv. Ital.<br />
<strong>di</strong> Niint., 1893, fase. I, pag. 50, n. 3).<br />
19. Denaro (gr. Oi470' — id.).<br />
Gnecchi F. e E., Op. cit., pag. 50, n. 4.
APPUNTI DI NUMISMATICA ITALIANA 3I<br />
PIACENZA.<br />
20. Soldo (gr. 0.730).<br />
Muratori L. A., Antiquitates Italicae me<strong>di</strong>i aevi, etc. Voi. II, pag. 723-<br />
724, n. I.<br />
TORTONA.<br />
21. Grosso (gr. 1.850).<br />
Promis D., Monete del Piemonte ine<strong>di</strong>te rare. Torino, 1852, in-4,<br />
pag. 31, tav. II, 8.<br />
22. Soldo (gr. i.ioo).<br />
Promis, Op. cit., pag. 31, tav. II, 9.<br />
23. Denaro piccolo (gr. 0.500 — scodellato).<br />
Promis D., Monete ine<strong>di</strong>te del Piemonte. Torino, i866, in-4, psg- 47»<br />
tav. VI, 62.<br />
24. Denaro grosso (gr. 1.250).<br />
3' — + •<br />
'><br />
FRED'RIC'<br />
VERCELLI.<br />
• Nel campo, in circolo periato, le lettere:<br />
I P, sopra le quali un punto.<br />
^ — + VERCELL€. Nel campo, e. s., croce. Dal circolo<br />
partono due cunei, che si <strong>di</strong>rigono verso due angoli<br />
opposti della croce.<br />
Questa rarissima moneta, la sola che si conosca,<br />
coniata in Vercelli al nome <strong>di</strong> Federico II, fu pubbli-<br />
cata da D. Promis [Monete del Piemonte ine<strong>di</strong>te o rare.<br />
Torino, 1852, pag. 34-36, tav. II, 11).<br />
II mio esemplare ha la variante dei due cunei nel<br />
rovescio, che mancano nel grosso e<strong>di</strong>to dal Promis.<br />
Ercole Gnecchi.
MIRANDOLA<br />
MONETE INEDITE O CORRETTE<br />
Fra le officine monetarie che ebbero vita in<br />
Italia nel secolo XVI, quella dei Pico, signori e poi<br />
duchi della Mirandola, tiene un posto <strong>di</strong>stinto fra le<br />
altre, sia per il numero e la varietà dei suoi prodotti,<br />
<strong>com</strong>e per la bellezza e rarità <strong>di</strong> alcuni <strong>di</strong> essi.<br />
L'Argelati ed il Bellini, e più ancora il Litta,<br />
ed il Kunz, per non nominare che i principali fra<br />
quelli che si occuparono <strong>di</strong> questa zecca, <strong>di</strong>edero<br />
numerosi <strong>di</strong>segni <strong>di</strong> monete della Mirandola; non <strong>di</strong><br />
tutte però, che molte ancor sconosciute si conservano<br />
in pubbliche e private raccolte, o trovansi menzionate<br />
in vecchie tariffe. E farebbe certamente opera<br />
utile per lo stu<strong>di</strong>o della <strong>numismatica</strong> moderna chi,<br />
ricercando gli archivi ed i musei imprendesse ad<br />
illustrare l'intera serie delle monete dei Pico.<br />
In attesa che qualcuno s'accinga a trattare sì<br />
interessante argomento porterò un piccolo contributo<br />
alla conoscenza delle monete mirandolesi, pubblicando<br />
alcuni pezzi passati finora inosservati, o ripro-<br />
dotti con poca esattezza.<br />
Qualcuno <strong>di</strong> questi mi fu cortesemente <strong>com</strong>uni-<br />
cato dai signori Rivani <strong>di</strong> Ferrara, Rizzini <strong>di</strong> Brescia,<br />
e Rizzoli <strong>di</strong> Padova, che mi favorirono le impronte<br />
<strong>di</strong> alcune rare monete della Mirandola che si trovano<br />
nei musei ai quali essi sono preposti, gentilmente<br />
concedendomi <strong>di</strong> renderle <strong>di</strong> pubblica ragione.
34<br />
GIORGIO CIANI<br />
Giovanni Francesco Pico, signore della Miran-<br />
dola, e conte <strong>di</strong> Concor<strong>di</strong>a (1515-1533) aprì la zecca<br />
nella capitale dei suoi non vasti possessi.<br />
Le belle monete d'oro che vi fece coniare sono<br />
in gran parte conosciute per opera degli autori che<br />
ebbi a ricordare; non così alcune d'argento <strong>di</strong> modulo<br />
maggiore, testoni, e mezze lire che s'incontrano<br />
raramente.<br />
Di queste riporterò le seguenti :<br />
C<br />
— i& — Piccola aquila bicipite e sotto in cinque linee<br />
MI RANDV L>€ • DOMINVS •<br />
• C<br />
-^ — OM NIN O in tre linee sul primo foglio <strong>di</strong> un libro;<br />
suir angolo inferiore del secondo foglio K e sotto BA.<br />
Nel campo a sinistra C e sotto I, a destra A.<br />
Argento. Peso Gram. 4,37.<br />
Questo pezzo <strong>di</strong> buon argento che si conserva<br />
nel museo <strong>di</strong> Brescia , è notevole per 1' assenza del<br />
nome del principe, particolarità che si riscontra in<br />
un quattrino dello stesso tipo pubblicato dal Kunz (0,<br />
e da esso pure attribuito a G. Francesco. Il libro<br />
coll'OMNINO si vede su tre altri pezzi che portano il<br />
suo nome e dovea essere una sua impresa, che ben<br />
(i) Perio<strong>di</strong>co <strong>di</strong> Numismatica e Sfragistica, anno II, fase. IV,<br />
tav. Vili, n. 6.
MIRANDOLA 35<br />
conveniva a questo principe che godette a' suoi tempi<br />
fama <strong>di</strong> valente letterato. " Huomo ai tempi suoi<br />
litteratissimo in greco, latino ed hebraico „ è detto<br />
in una cronaca anonima mirandolese C^), e della sua<br />
operosità anche in questo campo lasciò testimonio in<br />
alcune opere <strong>di</strong> vario argomento.<br />
L' OMNINO potrebbe forse ricordare V Omnino<br />
animus fortis et magnus <strong>di</strong>iabus rebus maxime cer-<br />
nitura etc. del grande Arpinate (3), ma le sigle nel<br />
campo possono prestarsi a <strong>di</strong>verse interpretazioni.<br />
Certo si è che devoto all'impero, dal quale riconosceva<br />
le concessioni ed i privilegi avuti, segnò<br />
sempre coli' aquila bicipite tutte le monete che egli<br />
fece coniare.<br />
Ritengo che tanto questo pezzo <strong>com</strong>e il quattrino<br />
illustrato dal Kunz siano da assegnarsi ai primi anni<br />
della sua signoria.<br />
2. — 3^ — IO • FRANCISCVS<br />
•<br />
chioma, volta a sinistra.<br />
PICV8<br />
9I — MO ' FR » PICVS " MIRANDVL/E '^<br />
D<br />
• Testa con lunga<br />
» CO ' C e aquiletta<br />
a due teste che <strong>di</strong>vide la scritta. Nel mezzo un libro<br />
con OM NIN O in tre linee; sull'angolo del secondo<br />
foglio • B • e sotto KA; nel campo a sinistra C e sotto I,<br />
a destra A.<br />
Argento. Peso Gram. 3,95.<br />
(2) Memorie storiche della città e dell'antico ducato delia Mirandola,<br />
ivi 1874, pag. 80.<br />
(3) M. TuLLn CicERONis, Officiorum, lib. I.
36<br />
GIORGIO CIANI<br />
Fu pubblicata nel III voi. delle opere dell' Ar-<br />
sì rozzo ed<br />
gelati che ne <strong>di</strong>ede il <strong>di</strong>segno , ma<br />
in<strong>com</strong>pleto che ho creduto opportuno <strong>di</strong> riprodurlo<br />
valendomi <strong>di</strong> un' impronta <strong>di</strong> questa moneta che si<br />
conserva nel museo <strong>di</strong> Ferrara. Se nella precedente<br />
mancava il nome del principe, in questa v'è ripetuto<br />
anche al rovescio, che è identico a quello <strong>di</strong> un altro<br />
pezzo d'argento (che trovasi pure in oro ed è del<br />
valore <strong>di</strong> tre zecchini) riportato al N. 9 delle tavole del<br />
Litta il cui peso, che desumo da un'esemplare ben con-<br />
servato del museo <strong>di</strong> Ferrara, raggiunge i gram. 5,95.<br />
E da notarsi la <strong>di</strong>fferente <strong>di</strong>sposizione delle<br />
lettere B, K ed A, che vedonsi segnate neh' angolo<br />
inferiore del libro.<br />
Moriva G. Francesco nel 1533 vittima <strong>di</strong> una<br />
congiura or<strong>di</strong>tagli dal nipote Galeotto II che gli<br />
succedette nel dominio (1533-1550).<br />
Di lui si conoscono soltanto 5 monete; lo scudo<br />
d' oro non per anco figurato, il mezzo paolo e due<br />
quattrini delle tavole del Litta, ed una moneta pub-<br />
blicata dal Bellini, detta grosso daF Kunz, che qui<br />
riproduco più correttamente traendone il <strong>di</strong>segno da<br />
un' impronta <strong>di</strong> questo pezzo, il quale si trova nel<br />
museo Bottacin <strong>di</strong> Padova.<br />
3. - ^^ — GALEOTVS • PICVS • Il * MIR • • CONQ<br />
DNS. Scudo<br />
coir arme <strong>di</strong> Mirandola-Concor<strong>di</strong>a e V armetta Pico nel
MIRANDOLA 37<br />
centro, sormontato da un'elmo con lambrecchini e col<br />
cimiero <strong>di</strong> un drago alato nascente.<br />
P — Gallo rivolto a sinistra su d'un caduceo alato, il<br />
tutto entro ghirlanda d'alloro.<br />
Argento. Peso Gram. 2,60.<br />
È <strong>di</strong> buon argento e lavorata finamente; <strong>com</strong>e<br />
m'avverte il chiar. conservatore del Museo Bottacin,<br />
potrebbe essere forse un giulio.<br />
11 gallo sul caduceo alato sembra fosse l'impresa<br />
parlante <strong>di</strong> Galeotto 11 che si riscontra, oltreché su<br />
due suoi quattrini, anche sulla seguente.<br />
4. — /B' — + GALEOTVS •.• PICVS •.' II. Scudo inquartato, e<br />
collo scudetto a scacchi nel mezzo.<br />
^ — '.' MIRAN •<br />
caduceo alato.<br />
CON<br />
• • Q<br />
DOMINVS. Gallo a sinistra su<br />
Argento. Peso Gram. i,oo.<br />
Questa monetina <strong>di</strong> basso argento che serbo<br />
nella mia raccolta apparve alla ven<strong>di</strong>ta della colle-<br />
zione Morbio, e fu descritta al N. 2086 <strong>di</strong> quel ca-<br />
talogo. È verosimilmente un mezzo grosso.<br />
*<br />
* *<br />
A Galeotto II successe nel principato il figlio<br />
Lodovico (1550-1568) del quale si conoscono parecchie<br />
monete. Di Galeotto III che col concorso<br />
del fratello Federico, e sotto la tutela della madre<br />
Fulvia da Correggio, possedette la Mirandola (1568-
38 GIORGIO CIANI<br />
1590 t 1592) è noto finora soltanto lo scudo d'oro<br />
pubblicato dal Kunz (4). Federico II che, morta la<br />
madre, resse da solo il piccolo stato, sembra non<br />
abbia fatto lavorare la zecca.<br />
Non avendo nulla da aggiungere a quanto fu<br />
pubblicato <strong>di</strong> questo periodo, passerò ad Alessandro I<br />
(1602-1637) terzo figlio <strong>di</strong> Lodovico II. Ottenne egli<br />
nel 1617 dall'imperatore Mattia il titolo <strong>di</strong> duca. Fece<br />
coniare moltissime monete, la maggior parte imita-<br />
zioni <strong>di</strong> quelle <strong>di</strong> altri stati, specialmente tedeschi.<br />
5. — ^^ — * ALEXANDER * DVX MIRANDVL/E * I. Suo busto<br />
a destra.<br />
9/ — ® CONCORDI/E ® MARCHIO * III. Scudo coli' arme<br />
solita <strong>di</strong> Mirandola-Concor<strong>di</strong>a, collo scudetto a scacchi<br />
nel centro.<br />
Argento. Peso Gram. 7,67.<br />
È un testone <strong>di</strong> basso argento della mia raccolta,<br />
fatto a somiglianza dei pezzi da 6 batzen del conte<br />
Giov. Reinardo <strong>di</strong> Hanau-Lichtenberg, e destinato<br />
ad essere spacciato nella Germania. Fu figurato, ma<br />
scorrettamente nel Hofmann (s) che in<strong>di</strong>ca per questo<br />
pezzo il valore <strong>di</strong> 12 kreuzer, mentre a quello <strong>di</strong> Hanau<br />
ne assegna 23 %. Si può argomentare da questo<br />
esempio il lucro che questi principi traevano con tali<br />
<strong>di</strong>soneste speculazioni.<br />
(4) Archeografo triestino. Voi. Vili, fase. MI, 1881, n. 5 della tav.<br />
(5) Hofmann, Murtzschliissel. Norimberga, 1683.
6. - ^' - ALE • P • M<br />
•<br />
DVX<br />
MIRANDOLA 39<br />
• •<br />
I CON • • M<br />
III S MAR •<br />
NSPD. Scudo colla solita arma <strong>di</strong> Mirandola-Concor<strong>di</strong>a,<br />
e lo scudetto dei Pico sormontato da corona,<br />
9I — SVB .<br />
ElVS<br />
VMBRA •<br />
bicipite coronata.<br />
DESIDERAVI<br />
• T<br />
•<br />
I<br />
SEDI. Aquila<br />
Argento. Peso Gram. 3,47.<br />
Mezzo testone, esso pure contraffazione dei pezzi<br />
da tre batzen <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi stati e città della Germania.<br />
Nel <strong>di</strong>ritto l'iscrizione finisce col titolo <strong>di</strong> S. Martino<br />
in Spino, feudo dei Pico, che vedesi su qualche altra<br />
sua moneta, e che qui fu messo probabilmente per<br />
rendere meno facile V interpretazione della scritta.<br />
La leggenda del rovescio ricorda il SVB VMBRA<br />
ALARVM TVARVM usata in altre zecche che gareggiavano<br />
fra loro nell'emettere simili prodotti. Questa e<br />
la seguente si conservano nel museo <strong>di</strong> Trento.<br />
7. - ^ — S • POSSIDO ® PROTE ® MIR. Busto <strong>di</strong> santo<br />
vescovo con pastorale, volto a destra.<br />
P — • SVB ElVS • • VMBRA DESIDERAVI • • T SEDI. Aquila<br />
bicipite coronata.<br />
Argento. Peso Gram. 2,45.<br />
•
40<br />
GIORGIO CIANI<br />
È una moneta che imita nel <strong>di</strong>ritto i <strong>di</strong>cken <strong>di</strong><br />
Uri, e nel rovescio i pezzi tedeschi da sei batzen.<br />
Quantunque non porti il nome del principe, ha<br />
però lo stesso, se non identico, rovescio della precedente<br />
e <strong>di</strong> altra simile pubbhcata dal Litta al N. 3<br />
della tavola fra le incerte, ma che spetta verosimilmente<br />
essa pure ad Alessandro I, il quale se fu buon<br />
principe, <strong>com</strong>e è fama, d'altro canto non si peritò <strong>di</strong><br />
contraffare largamente le altrui monete.<br />
8. - ^^ — ® ALEX • DVX •<br />
armatura volto a destra.<br />
^ — SVB • ElVS VMB •<br />
DESID<br />
MIR •<br />
•<br />
T<br />
I<br />
• M<br />
•<br />
• COQ<br />
•<br />
III. Busto con<br />
SEDI. Aquila bicipite<br />
coronata fra le cui teste sorge una croce, e in petto ha<br />
un circolo con entrovi la cifra 3-<br />
Mistura. Peso Gram. 0,90.<br />
Contraffazione anche questa <strong>di</strong> pezzi<br />
kreuzer esistente nel museo <strong>di</strong> Ferrara.<br />
MIRANDOLA 41<br />
Questa moneta che conservo nella mia raccolta,<br />
è figurata nelle tavole dell'Hofmann (^) fra le sconosciute<br />
e valutata 4 kreuser, mentre la moneta che<br />
servì per questa imitazione battuta nella Frisia era<br />
del valore <strong>di</strong> 7<br />
zana (7).<br />
'| 6 krenzer.<br />
Simile contraffazione si ha della zecca <strong>di</strong> De-<br />
L' INSIGNIA ANTIQVÀ ed altre simili leggende ri-<br />
corrono pure sui talleri dello stesso Alessandro I,<br />
messevi per vantare le antiche origini della famiglia<br />
dei Pico.<br />
La scritta del rovescio accenna alla protezione<br />
dell' impero, e si riscontra su altre monete della<br />
Mirandola fatte ad imitazione dei schilling <strong>di</strong> Campen<br />
due dei quali furono illustrati dal Kunz (^).<br />
IO. - /B' — s • ANCT •<br />
AVGVSTINVS<br />
• ADVO<br />
*. Busto <strong>di</strong> santo<br />
vescovo con pastorale nel campo 16 — ... 9.<br />
\jl — ® TVTISSIMA * QVIES ^. Aquila bicipite coronata.<br />
Argento. Peso Grani. 7,19.<br />
Testone anonimo simile a quelli emessi dalle<br />
zecche <strong>di</strong> Dezana, Messerano e Guastalla, parziali<br />
contraffazioni dei <strong>di</strong>cken <strong>di</strong> Uri.<br />
Questo pezzo della mia collezione è alquanto<br />
(6) Hofmann, Mi'tnzschliissel, 1. e.<br />
(7)<br />
tav. Ili, n. 20.<br />
Promis, Monete <strong>di</strong> zecche italiane. Memoria IV, Torino, 1882,<br />
(8) Archeografo triestino. Anno Vili, 1881, n. 6 e 7 della tavola.<br />
6
42 GIORGIO CIANI<br />
liscio nel mezzo del <strong>di</strong>ritto, nò si può rilevare la<br />
cifra che precede il 9. Credo però <strong>di</strong> non errare nel<br />
ritenerlo battuto nel 1619, epoca in cui furono ese-<br />
guite queste e simili imitazioni.<br />
Resterebbe a <strong>di</strong>mostrarsi se questa moneta appartenga<br />
veramente a Mirandola. Me ne persuaderebbe<br />
il n^yotto e la rappresentazione del rovescio,<br />
eguale in tutto a quello della moneta precedentemente<br />
prodotta, ed il santo effigiato nel <strong>di</strong>ritto in onore<br />
del quale Alessandro I eresse, nel 1606, una chiesa (9).<br />
In memoria anzi <strong>di</strong> questo avvenimento egli fece<br />
eseguire una medaglia che vedesi <strong>di</strong>segnata nell'opera<br />
del Litta.<br />
L'attribuzione <strong>di</strong> questa moneta al duca Alessandro<br />
I parmi per ciò sufficentemente provata, ed<br />
il santo vescovo <strong>di</strong> Ippona sarebbe da aggiungersi<br />
alla serie dei santi invocati sulle monete mirandolesi.<br />
II. - ^^ — .<br />
ALEX •<br />
PI VX<br />
• • •<br />
jw.<br />
• MIR • Scudo coronato in-<br />
quartato ad I e 4 partito d' un' aquila e quattro fascie,<br />
a 2 e 3 leone.<br />
DOMINE • CON 633. Croce in circolo<br />
ornato accantonata da quattro testine coronate.<br />
9< — IN • TE •<br />
Mistura. Peso Gram. 2,48.<br />
Ho ricavato il <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> questo soldo da<br />
un esemplare della mia collezione alquanto liscio, ma<br />
che pure serve a <strong>com</strong>pletare il <strong>di</strong>segno datone dal<br />
(9) Restaurata da Alessandro II la chiesa <strong>di</strong> S. Agostino mi si <strong>di</strong>sse<br />
essere andata in rovina in sul principio <strong>di</strong> questo secolo.
MIRANDOLA 43<br />
Litta al N. 9 della tavola. Anche questa è una con-<br />
traffazione <strong>di</strong> altra moneta e precisamente del soldo<br />
ducale <strong>di</strong> Vittorio Amedeo I battuto nel 163 1 (^").<br />
Gli succedette Alessandro II (1637-1691) abiatico<br />
<strong>di</strong> Alessandro I, figlio <strong>di</strong> Galeotto II premorto al padre.<br />
12. — ^' — ALEX :<br />
PI DVX<br />
• • •<br />
:<br />
Il • MIRAN. Testa con lunga<br />
chioma, volta a destra.<br />
HI • • • E : HVIC Scudo coronato partito nel<br />
primo della solita arme <strong>di</strong> Mirandola-Concor<strong>di</strong>a e nel<br />
91 — OMNIA •<br />
centro lo scudetto dei Pico, nel secondo inquartato dei<br />
tre gigli e l'aquila degli estensi.<br />
Mistura. Peso Gram. i,i8.<br />
È una muragliola simile a quelle <strong>di</strong> Francesco I<br />
duca <strong>di</strong> Modena, <strong>di</strong>versa da quelle del Litta (N. 6<br />
ed II della tav.) per lo stemma estense ^lccostato a<br />
quello dei Pico, unione che sembra giustificata, avendo<br />
Alessandro II contratto matrimonio con Anna Beatrice<br />
d'Este, figha <strong>di</strong> Alfonso III duca <strong>di</strong> Modena.<br />
Il primogenito <strong>di</strong> Alessandro II, Francesco morì<br />
nel 1689 due anni prima del padre, lasciando da<br />
Anna Camilla Borghese dei principi <strong>di</strong> Sulmona un<br />
n. 2.<br />
(io) D. Promis, Monete dei reali <strong>di</strong> Savoia. Torino, 1841, tav. XXXIX,
44<br />
GIORGIO CIANI<br />
figlio <strong>di</strong> nome Francesco Maria, che succedette all'avo<br />
nel 1691 sotto la tutela <strong>di</strong> Brigida Pico sua prozia.<br />
Scoppiata la guerra per la successione <strong>di</strong> Spagna<br />
il ducato fu invaso dalle truppe gallo-ispane. 11 gio-<br />
vanetto Francesco Maria essendosi lasciato indurre<br />
ad accettare la protezione della Francia, allorché gh<br />
imperiali occuparono la città fu <strong>di</strong>chiarato fellone e<br />
decaduto dal ducato. Vinti i francesi nel 1706 da<br />
Eugenio <strong>di</strong> Savoja, Luigi XIV s' affrettò a conchiu-<br />
dere un accordo cogli imperiali sacrificando i piccoli<br />
principi italiani, che aveano aderito alla sua causa.<br />
Nel 1707 fu posta in esecuzione la sentenza <strong>di</strong><br />
Vienna, e nel 17 io il ducato della Mirandola venduto<br />
agli Estensi.<br />
Francesco Maria finì i suoi giorni a Madrid<br />
nel 1747.<br />
Di questo principe non era conosciuta alcuna<br />
moneta, e gli autori che trattarono della zecca mirandolese<br />
non accennano ad alcun documento in prova<br />
della sua attività durante il dominio <strong>di</strong> questo duca.<br />
Al chiar. prof. Mariani veniva fatto <strong>di</strong> scoprire<br />
recentemente una monetina <strong>di</strong> rame colla data del<br />
1704 che egli attribuiva a questo principe (").<br />
Il pezzo che egli potè avere mal battuto e <strong>di</strong><br />
cattiva conservazione, <strong>com</strong>e ebbe ad avvertire, non<br />
permetteva la lettura piena delle epigrafi.<br />
Tengo io pure un esemplare <strong>di</strong> questa singolare<br />
moneta, e ne dò qui il <strong>di</strong>segno.<br />
TL<br />
13- —/!>' — ALEX • Il DVX • M Scudo coronato coll'arme<br />
(11) <strong>Rivista</strong> It. <strong>di</strong> Num., 1895, fase. IV, pag. 469-470.
MIRANDOLA 45<br />
inquartata <strong>di</strong> Mirandola-Concor<strong>di</strong>a, ed un capo d'aquila<br />
bicipite.<br />
^ — •<br />
IN • • TE<br />
DOMINE<br />
•<br />
SPE<br />
• • • : 1704 : Croce accanto-<br />
nata da quattro testine e circondata da ornati.<br />
Rame. Peso Grani. 1,23.<br />
Le iscrizioni e la leggenda si <strong>com</strong>pletano col-<br />
l' aiuto della moneta precedentemente citata con :<br />
ALEX • Il DVX . MIRANDV - • IN • • TE DOMINE • SPERAVI : 1704:<br />
L'impronta del <strong>di</strong>ritto è quella dei soliti quattrini<br />
<strong>di</strong> Alessandro li, morto nel 1691; il rovescio è fatto<br />
ad imitazione dei sol<strong>di</strong> <strong>di</strong> Savoja.<br />
Evidentemente questa moneta ci fa certi che la<br />
zecca della Mirandola era aperta nel 1704; resta però<br />
sempre il grave anacronismo a cagione del nome<br />
del principe, perchè non si può ammettere senza<br />
<strong>di</strong>fficoltà che il duca Francesco Maria non abbia<br />
voluto usare del proprio <strong>di</strong>ritto e segnare col suo<br />
nome le monete che faceva battere.<br />
Mancandomi ogni fondamento storico per dare<br />
una ragione <strong>di</strong> tale sconcordanza delle date, non mi<br />
rimane che attendere la spiegazione <strong>di</strong> questa anomalia<br />
da qualche stu<strong>di</strong>oso della storia della Mirandola.<br />
Trento, Novembre i8g6.<br />
Giorgio Ciani.
DUCATONE INEDITO<br />
DI<br />
ALBERICO I CIBO<br />
Principe <strong>di</strong> Massa.<br />
Dopo che il Viani (0 ebbe con singolare eru<strong>di</strong>zione<br />
narrato le imprese dei Cibo signori <strong>di</strong> Massa,<br />
e descrittene, ed illustrate ampiamente le monete,<br />
sembrava essere questa materia esaurita, e chiuso il<br />
campo a nuove scoperte. Ma neppure qui va fallito<br />
il motto, omai proverbiale, della inesauribilità dei<br />
tesori numismatici, e tocca a me in sorte, segnalare<br />
una moneta sconosciuta fin qui, almeno che io sappia,<br />
prodotta dalla zecca <strong>di</strong> Massa Lunigiana.<br />
Questa è venuta alla luce insieme a un ristretto,<br />
ma prezioso ripostiglio, in una località <strong>di</strong> Francia, che<br />
non si è potuto accertare, con pochi altri scu<strong>di</strong> e<br />
ducati <strong>di</strong> Avignone, Genova, Milano, Mantova e<br />
Savoja, della fine del secolo XVI e del principio del<br />
seguente, tutti abbastanza rari. Ora fa parte dell'importante<br />
collezione <strong>di</strong> monete italiane raccolte con<br />
molta cura da S. A. R. il Principe <strong>di</strong> Napoli, della<br />
quale più volte si ebbe ad occupare questa <strong>Rivista</strong>.<br />
Come si vede dall'impronta, è questo un ducutone<br />
o piastra, <strong>com</strong>e allora veniva chiamata, del tempo in
48 O. VITALINI<br />
cui signoreggiava Alberico <strong>di</strong> Lorenzo Cibo (n. 1532<br />
t 1623). Nel <strong>di</strong>ritto il busto a destra, con la epigrafe<br />
ALBERICVS * CYBO * MALASP PRIN o MA<br />
Nel rovescio l'aquila bicipite a volo aperto, che ha nel<br />
cuore lo scudetto dei Cibo, fra gh artigli una banda con<br />
le parole LIBERTAS e Tanno i6-oi; attorno il lemma:<br />
SVB * VMBRA * ALARVM * TVARVM (Peso grammi 32-200).<br />
11 Viani riporta con dotte annotazioni (2) due<br />
altri ducatoni <strong>di</strong>fferenti, che <strong>di</strong>ce essere stati battuti dal<br />
Cibo, ad imitazione e sul tipo della piastra fiorentina,<br />
secondo il decreto del 28 marzo 1593, del peso <strong>di</strong><br />
denari 27 grani 14. Infatti uno ha incisa questa stessa<br />
data col busto e 1' arme; e V altro un bel rovescio<br />
con tre cervi natanti ed il motto — Trauseundum, aid<br />
morien<strong>di</strong>im. — Dei ducatoni <strong>di</strong> Massa si ha memoria<br />
nella tariffa <strong>di</strong> Anversa del 1627, e in una lista <strong>di</strong><br />
monete saggiate in Parma nel 1623: ma questo che<br />
presentasi ora è sconosciuto ed ine<strong>di</strong>to.<br />
L' aquila imperiale fu concessa al nostro Albe-<br />
rico, con privilegio dell'Imperatore Rodolfo II, a dì<br />
17 giugno 1590, aggiuntavi la cartella colla parola<br />
Libertas ad esprimere la in<strong>di</strong>pendenza del principe<br />
nella stessa doverosa soggezione; ed a quell'epoca<br />
in quasi tutte le monete <strong>di</strong> Massa si vede quest'emblema<br />
ed impresa. L'epigrafe — Sub timbra alariim<br />
tuarum — allusiva all' aquila, e nello stesso tempo<br />
alla protezione imperiale, non è nuova nelle monete<br />
<strong>di</strong> Alberico Cibo (3); e si trova adoperata in moltissime<br />
altre monete dei feudatari imperiali, <strong>com</strong>e lo erano<br />
i Fieschi, i Gonzaga, gli Spinola, i Tizzoni (4), in me-<br />
moria delle investiture ricevute, dei privilegi accordati,<br />
e della feudale <strong>di</strong>pendenza. O. Vitalini.<br />
(i) Viani Giorgio, Memoria della famiglia Cybo e delle monete <strong>di</strong><br />
Massa <strong>di</strong> Lunigiana. Pisa, 1808.<br />
(2) L. e. tav. Ili, n. I e 2. (3) Viani, op. cit., tav. V, 6.<br />
(4) Bazzi e Santoni, Vade Mecum, ecc. pag. 107.
SULL'ERRONEA ATTRIBUZIONE AL FRANCIA<br />
DELLE MONETE GETTATE AL POPOLO<br />
NEL SOLENNE INGRESSO IN BOLOGNA DI GIULIO II<br />
PER LA CACCIATA DI GIO. II BENTIVOGLIO<br />
Giuliano Delia Rovere, riescito alla perfine, nel quarto<br />
conclave, dopo <strong>di</strong>ciannove anni <strong>di</strong> speranze e d'intrighi a farsi<br />
eleggere pontefice, pigliando il nome <strong>di</strong> Giulio II, rivolse ogni<br />
pensiero, appena sbarazzatosi de' nemici che 1' attorniavano<br />
nella stessa Capitale, a ricuperare le città smembrate dal<br />
dominio della Chiesa, e a <strong>di</strong>scacciare dall' Italia gli stranieri,<br />
o barbari, <strong>com</strong>' ei li appellava; salvo però <strong>di</strong> chiamarli egli<br />
stesso all'occorrenza per giovarsene a ridurre in atto i suoi<br />
<strong>di</strong>segni. Determinatosi <strong>di</strong> <strong>com</strong>inciar la campagna contro Pe-<br />
rugia e Bologna, tenute in signoria da Giampaolo Baglione<br />
e da Giovanni II Bentivoglio, partì da Roma il 26 agosto<br />
del 1506, ac<strong>com</strong>pagnato da nove Car<strong>di</strong>nali, alla testa <strong>di</strong> soli<br />
500 uomini d'arme. Ad Orvieto viene ad accor<strong>di</strong> col Baglione,<br />
affine <strong>di</strong> valersi <strong>di</strong> lui e de' suoi soldati nell'impresa contro<br />
il Bentivoglio. Rassicurato lungo il viaggio della cooperazione<br />
<strong>di</strong> Luigi XII, al quale si era affrettato Giulio <strong>di</strong> conceder la<br />
facoltà da lui richiesta <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre dei benefizi del Ducato<br />
<strong>di</strong> Milano, continua animoso la sua marcia verso la città nostra.<br />
Avuta contezza il Bentivoglio della sommessione del Baglione<br />
e della defezione del Re <strong>di</strong> Francia e degli altri antichi suoi<br />
alleati, invia ambasciatori al Pontefice, i quali non riescono<br />
a rimuoverlo menomamente dal proposito <strong>di</strong> ottenere la<br />
sottomessione assoluta <strong>di</strong> Bologna all' autorità <strong>di</strong>retta della<br />
Santa Sede, pronto ad aggiungere a tal uopo all'azione dei<br />
soldati l'effetto, non meno temuto in allora, delle armi spi-<br />
rituali. Il che pochi giorni appresso ei fece, lanciando da Forh
50<br />
LUIGI FRATI<br />
la famosa bolla, che fu chiamata una vera crociata (0. In tale<br />
con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> cose perduta il Bentivoglio ogni speranza <strong>di</strong><br />
aiuto e <strong>di</strong> ragionevole <strong>di</strong>fesa, si procacciò dal Signore <strong>di</strong><br />
Francia un salvocondotto, e la sera del primo novembre, a<br />
ore tre <strong>di</strong> notte, al segnale <strong>di</strong> colpi <strong>di</strong> bombarde dato dai<br />
francesi mandatigli incontro dal Chaumont, viceré <strong>di</strong> Milano,<br />
uscì coi figli e molti aderenti da Porta S. Mamolo, dove trovò<br />
l'Allegre, Galeazzo Visconti e Antonmaria Pallavicino con<br />
ottocento cavalieri, che li condussero al campo francese, e<br />
d'in<strong>di</strong> a Busseto, castello del Pallavicino.<br />
Partiti i Bentivogli, furono tosto spe<strong>di</strong>ti quattro oratori<br />
ad Imola, acciò facessero de<strong>di</strong>zione della città al Pontefice,<br />
e lo pregassero a levar l' interdetto, e dar or<strong>di</strong>ne che le<br />
truppe francesi si allontanassero da Bologna. Intanto la Città,<br />
benché sprovvista <strong>di</strong> capo, rintuzzava con energia gli sforzi<br />
dell'esercito asse<strong>di</strong>ante, quando, per consiglio <strong>di</strong> un popolano,<br />
calata la saracinesca <strong>di</strong> ferro alla Grada, le acque rigurgitanti<br />
del Reno allagarono le campagne circostanti a Val <strong>di</strong> Ravone<br />
per modo, che le milizie francesi dovettero abbandonare<br />
l'asse<strong>di</strong>o, e ripararsi a Castel Franco; donde, riscattate le<br />
artiglierie, si ritirarono oltre Scoltenna lasciando hbero il<br />
territorio bolognese.<br />
Erano in questo mezzo venuti a Bologna il Car<strong>di</strong>nale<br />
Frangiotti, destinatovi a Legato, e il Car<strong>di</strong>nale <strong>di</strong> Rohans a<br />
togliere l'interdetto, e ad annunziare l'ingresso del Pontefice<br />
pel giorno <strong>di</strong> s. Martino. Il popolo, che avea già destituito<br />
l'antico magistrato de' Se<strong>di</strong>ci, e creatone un nuovo <strong>di</strong> Venti,<br />
intese con gioia quest' annunzio, posò le armi e riprese i<br />
consueti esercizi della vita, attendendo con impazienza l'ar-<br />
rivo del nuovo Principe. A questo fine si stavano arredando<br />
le vie, per le quali doveva passare, quantunque la piovosa<br />
stagione non concedesse <strong>di</strong> mettere in decoroso assetto, a<br />
seconda del desiderio.<br />
Giunto il Pontefice la sera del io alla casa suburbana<br />
dei Crociferi, ove lasciò buona parte del suo seguito, egli<br />
(i) Ve<strong>di</strong>la riportata nelle Memorie pubblicate per la vita <strong>di</strong> Gio-<br />
vanni II Bentivoglio, del Conte Gio. Gozza<strong>di</strong>ni. Bologna 1839, in-8.<br />
Dee. LXXXIV.
sull'erronea attribuzione al FRANCIA, ECC. 5I<br />
con pochi famigliari a tarda ora entrò privatamente per la<br />
Porta Maggiore a prender stanza nella Commenda de' Cava-<br />
lieri Gerosolimitani, detta la Magione, sprezzando i sinistri<br />
pronostici degli astrologi, onde lo volevano <strong>di</strong>ssuadere dal-<br />
l' entrare in quel giorno. Saputosi 1' arrivo suo, un' ingente<br />
moltitu<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> popolo corse ad incontrarlo e ad applau<strong>di</strong>rlo,<br />
mentre dal pubblico Palazzo e dalle torri della città il rimbombo<br />
delle artiglierie e il suono delle campane davano<br />
segnali <strong>di</strong> esultanza e <strong>di</strong> festa.<br />
Il giorno appresso, a quattro ore prima <strong>di</strong> sera, i Venti<br />
nuovi eletti del popolo in sulla soglia della casa, ove il Papa<br />
aveva pernottato, gli presentarono le chiavi della Città, alla<br />
presenza del Vescovo <strong>di</strong> Bologna, che gli <strong>di</strong>ede a baciare la<br />
croce, <strong>com</strong>e <strong>di</strong> rito; quin<strong>di</strong> salito sopra la se<strong>di</strong>a gestatoria,<br />
preceduto e seguito da numerosissimo e splen<strong>di</strong>do corteo,<br />
del quale facevan parte ventidue car<strong>di</strong>nali, i duchi <strong>di</strong> Mantova<br />
e <strong>di</strong> Urbino, il prefetto <strong>di</strong> Roma, gli oratori dell'Impero, <strong>di</strong><br />
Francia, <strong>di</strong> Spagna, <strong>di</strong> Venezia, <strong>di</strong> Firenze, <strong>di</strong> Genova, ed<br />
altri molti illustri personaggi, fu portato lungo le vie che da<br />
Porta Maggiore conducono alla Cattedrale, e da questa al<br />
pubblico Palazzo, passando sotto tre<strong>di</strong>ci archi trionfali, alla<br />
sommità de' quali si leggeva; — A Giulio II trionfatore de'<br />
Tiranni. — Bologna liberata dalla Tirannide. — A ciascun<br />
lato della strada sorgevano palchi a foggia <strong>di</strong> gallerie, ne'<br />
quali vegliar<strong>di</strong>, matrone e fanciulle stavano ad ammirare la<br />
pompa. Armi, <strong>di</strong>vise, pitture, festoni e fiori pendevano dalle<br />
finestre; tappeti coprivano le vie. Cento giovinetti patrizii<br />
uniformemente vestiti <strong>di</strong> seta, aventi nella destra un bastoncello<br />
dorato, alla cui sommità era una ghianda, emblema<br />
dell'impresa gentilizia del Pontefice, stavano attorno al ma-<br />
gnifico baldacchino <strong>di</strong> broccato d'oro, sotto il quale seduto<br />
era il Pontefice ; sotto altro baldacchino <strong>di</strong> seta' bianca ricamato<br />
in oro era portato il Sacramento. Una selva <strong>di</strong> stendar<strong>di</strong>,<br />
nuvoli d'incenso, ceri, inni e concerti tutto concorreva a<br />
rendere splen<strong>di</strong><strong>di</strong>ssima la solennità. A settantamila persone<br />
a pie<strong>di</strong>, oltre a do<strong>di</strong>ci mila a cavallo fa ascendere il numero<br />
degli astanti Paride Grassi, che <strong>di</strong>resse il cerimoniale della<br />
festa, e che ce ne ha lasciato nel suo Diario una particola-<br />
reggiata relazione. Quasi a notte pervenne il corteo alla
52 LUIGI FRATI<br />
chiesa <strong>di</strong> s. Pietro, dove il Pontefice, ricevuto colle cerimonie<br />
<strong>di</strong> rito, impartì 1' apostolica bene<strong>di</strong>zione al popolo festante.<br />
Poscia, deposti gli abiti sacri, fu trasportato sulla sua se<strong>di</strong>a<br />
al pubblico palazzo nella piazza maggiore della città; dove<br />
al suo apparire, secondochè narra con enfatiche parole il<br />
predetto Grassi, al suono delle trombe, delle tibie e delle<br />
campane tutte della città e al rimbombo delle artiglierie<br />
pareva scindersi il cielo. In mezzo però a tanto frastuono e<br />
popolare tripu<strong>di</strong>o, confuso tra la folla stava silenzioso un<br />
uomo in abito ecclesiastico, <strong>di</strong> aspetto grave e ammalaticcio,<br />
che più tar<strong>di</strong> doveva esser chiamato l'astro della Germania,<br />
il quale paragonando questo trionfo del Vicario <strong>di</strong> Cristo colla<br />
maestà degh Apostoli, che evangelizzarono il mondo, prefe-<br />
riva la grandezza <strong>di</strong> quelli al trionfale spettacolo, al quale<br />
egli assisteva, non senza mestizia (2).<br />
Per rendere più fastosa e lungamente memorabile la<br />
solennità del suo trionfo pensò Giulio a far coniare speciali<br />
monete d'oro e d'argento con leggende allusive all'avveni-<br />
mento. Nei tempi antichi v'era certamente una regola deter-<br />
minata per la <strong>di</strong>stinzione dell'uso dei due metalli in siffatte<br />
largizioni principesche. È Giustiniano istesso, che ce lo attesta<br />
nella centesima-quinta delle sue Novelle (3): " Al solo impe-<br />
" ratore spetta il privilegio <strong>di</strong> sparger l'oro sul popolo, im-<br />
" perocché a lui solo concede sprezzarlo l'apice della fortuna;<br />
" ai consoli poi è <strong>di</strong>cevole poter far uso dell' argento, che<br />
" è ciò vi è <strong>di</strong> più prezioso dopo 1' oro „. Anche a' tempi<br />
de' Carolingi perdurava siffatta <strong>di</strong>stinzione ; perocché, avendo<br />
Clodoveo, a pompa della sua proclamazione, <strong>com</strong>e patrizio<br />
(2) Ex occasione loci, qui est in Ad. Cap. V, confero triumphos, quos<br />
me spedante Julius II egit Bononiae primum, post Romae, cum majestate<br />
Apostolorum, qui codesti dodrina converterent orbent, qui sic miraculis<br />
florerent, ut umbra sola sanarentur aegroti, et hanc magnificientiam<br />
Apostolicam praefero triumphis illis, in quos ipsos tamen nihil scribo<br />
contumeliose, iametsi, ut ingenue <strong>di</strong>cam, tum spedabam, non sine tacito<br />
gemitu. Erasmi Des. Op. omn. T, IX, col. 361.<br />
(3) Soli enim aurum spargere damus imperio, cui soli etiam aurum<br />
contemnere praestat fortunae fastigium ; argentum vero, quod mox post<br />
aurum pretiosissimum fiet, et aliis consulibus largimur decens; et haec<br />
sinimus eos spargere in his, quae vocantur missilia, etc.
sull'erronea attribuzione al FRANCIA, ECC. 53<br />
e console, fatto gettare al popolo monete d'oro (4), un tale<br />
atto fu riguardato <strong>com</strong>e una vera usurpazione dei privilegi<br />
imperiali. Quanto ai Papi, si ha memoria fino da Celestino li,<br />
eletto pontefice nel 1143, <strong>di</strong> limosine fatte <strong>di</strong>stribuire da lui,<br />
quando dalla Basilica Vaticana si recava alla Lateranense a<br />
pigliare possesso; nella qual circostanza si faceva getto <strong>di</strong><br />
monete in cinque luoghi determinati. Nelle descrizioni <strong>di</strong> pos-<br />
sessi posteriori si legge che il Maresciallo della Curia, chiamato<br />
Saldano, cavalcava <strong>di</strong>etro il magistrato romano, avente<br />
ai lati della sella due sacchi <strong>di</strong> monete, carlini, baiocchi e<br />
quattrini, e ne faceva getto a Monte Giordano, presso s. Marco,<br />
vicino a s. Adriano e altrove, e segnatamente per allontanare<br />
la folla dalla persona del Pontefice. E, per accostarsi a tempi<br />
pili vicini a quelli <strong>di</strong> Giulio, togliamo dalla descrizione dell' in-<br />
coronazione <strong>di</strong> Innocenzo Vili, dataci dal Burchard i seguenti<br />
tratti: Recedente Pontìfice de platea s. Petri, Soldanus fecit<br />
tres iactus pecuniarum popido, ut Papa liberins procedere<br />
posset .... e piìj oltre: Soldanus iternm iactus pecuniarum<br />
faciebat. Idem fecit in Monte Jordano, apitd s. Marcum, ad<br />
s. Adrianum, et alibi, ubi populi oppressionem videbat: strano<br />
modo per verità <strong>di</strong> far larga la strada al Pontefice dalla folla;<br />
parrebbe invece che la si avesse a serrarvisi attorno più<br />
spesso, per provocare una gettata <strong>di</strong> monete. Pervenuto il<br />
Pontefice all'aitar maggiore, prosegue il Burchard, ascen<strong>di</strong>t<br />
ad sedem eminentem marmoream in tribuna solita paratam. . .<br />
Quo sic sedente, Car<strong>di</strong>nales omnes eum honorifice elevarunt<br />
<strong>di</strong>centes: Suscitai de ptdvere egenum, et de stercore erigit<br />
pauperem, ut sedeat cum principibus, et solium gloriae teneat.<br />
Quo facto, Pontifex accepit de gremio d. Falconis thesaurarii<br />
sui tres pugillatas quatrenorum et denariorum minutorum<br />
successive, et Inter populum proiecit, <strong>di</strong>cens: argentum et aurum<br />
non est mihi, quod aiitem habeo hoc libi do.<br />
Tutt'altro carattere adunque avea la suntuosa largizione<br />
<strong>di</strong> Giulio, la quale anzi faceva manifesto contrasto con quelle<br />
prescritte dal cerimoniale dell'incoronazione e del possesso.<br />
Egli intese più tosto con tale atto <strong>di</strong> munificenza e liberalità<br />
ad ingraziarsi il popolo, <strong>com</strong>e al medesimo fine non indugiò<br />
(4) Greg. Turòn, Hist. Frane. II. 38.<br />
.
54 LUIGI FRATI<br />
nei giorni appresso a sospendere dazii e gabelle, a <strong>di</strong>minuire<br />
i prezzi delle carni, del vino e d'altri generi.<br />
Le monete gettate al popolo dal Datario <strong>di</strong> Giulio sono<br />
le due riportate nella Tav. I ai n, 2 e 3 ;<br />
1' una in oro del<br />
valore <strong>di</strong> un ducato, del peso <strong>di</strong> grammi 3,40, l'altra in ar-<br />
gento del valore <strong>di</strong> un bolognino e del peso <strong>di</strong> gr. 1.30; l'una<br />
e l'altra avente nel <strong>di</strong>ritto l'arme del Pontefice sormontata<br />
dal triregno e dalle chiavi decussate, e la leggenda: IVLIVS •<br />
Il • PONT • MAX., e nel rovescio • BON • P IVL .<br />
• A • TIRANO<br />
LIBERAT' {Bononia per Julium a fyranno liberata) colla figura<br />
in pie<strong>di</strong> <strong>di</strong> s. Pietro, che tiene le chiavi nella d. e il libro<br />
nella s. Il Cinagli (5), oltre le in<strong>di</strong>cate due monete, riporta<br />
ezian<strong>di</strong>o il mezzo grosso, colle stesse leggende e cogli stessi<br />
tipi, se non che la figura <strong>di</strong> s. Pietro è detta seduta, anziché<br />
in pie<strong>di</strong>. Non so indurmi veramente a prestar fede all'esistenza<br />
<strong>di</strong> questa moneta, stantechè il cerimoniere Paride Grassi, che<br />
le fece coniare, sic<strong>com</strong>e vedremo, non parla nel suo Diario<br />
che <strong>di</strong> due sole, de utroque numismate ; tuttavolta per accertarmi<br />
dell'in<strong>di</strong>cata varietà <strong>di</strong> tipo e del peso, se veramente<br />
rispondente a un mezzo grosso, non ho omesso <strong>di</strong> fare<br />
reiterate ricerche per conoscere in quali mani era trapassata<br />
detta monetuccia dalla raccolta Briganti-Bellini <strong>di</strong> Osimo, dove<br />
si trovava a' tempi del Cinagli; ma finora non mi è riuscito<br />
<strong>di</strong> scoprirne notizia; laonde sarei oltremodo grato al fortunato<br />
possessore <strong>di</strong> essa, se mi fosse cortese dei desiderati ragguagli.<br />
Quanti hanno parlato <strong>di</strong> queste monete, e biografi del<br />
Francia, e scrittori d'arte e numismatici insigni, tutti ad una<br />
voce ripetono che sono desse opera del Francia; e ciò sulla<br />
fede del Vasari, che primo <strong>di</strong>ffuse questa notizia nella vita<br />
<strong>di</strong> lui. Ecco le sue parole: " Tenne continuamente mentre<br />
" che e' visse la Zecca <strong>di</strong> Bologna : et fece le stampe <strong>di</strong> tutti<br />
i conij per quella, nel tempo che i Bentivogli reggevano;<br />
et poi che se n'andarono, ancora mentre che visse Papa<br />
Julio, <strong>com</strong>e ne rendono chiarezza le monete che il Papa<br />
gittò nella entrata sua ; dove era da una banda la sua testa<br />
naturale e dall'altra queste lettere: Bononia per Julium a<br />
" tyranno liberata. Et fu talmente tenuto eccellente in questo<br />
(5) Le Monete de' Papi. Fermo 1848, in-fol., pag. 74, n. 65.
sull'erronea attribuzione al FRANCIA, ECC. 55<br />
" mestiere, che durò a far le stampe delle monete fino al<br />
" tempo del Papa Leone „.<br />
Questo passo è uno de' più errati dello storico aretino ;<br />
posciachè inesatta, <strong>com</strong>e vedremo, è l'asserzione che il<br />
Francia tenesse continuamente mentre ch'ei visse la Zecca<br />
<strong>di</strong> Bologna; non consentanea al vero, sic<strong>com</strong>e <strong>di</strong>mostrerò,<br />
r attribuzione al medesimo delle monete gittate al popolo<br />
neir entrata in Bologna <strong>di</strong> Giulio II; ed è manifestamente<br />
sbagliata la descrizione <strong>di</strong> esse. Quest'ultimo granchio preso<br />
dal Vasari fu avvertito, né poteva non esserlo, dal Cavedoni (6),<br />
dal Giordani (?), e ultimamente dal Friedlaender (8), senza<br />
però che si dessero cura i medesimi d'indagare dond' era<br />
provenuto l'avvertito errore; il quale innanzi a loro avea<br />
indotto il Cicognara (9) a niegare perfino 1' esistenza delle<br />
monete con la leggenda allusiva alla cacciata del Bentivoglio,<br />
riferendo invece ad essa circostanza la medaglia <strong>di</strong> Giulio II<br />
col motto: Cantra stimulum ne calcitres. Ma <strong>di</strong> questa avrò<br />
a fare parola più avanti. Intanto torna in acconcio ricordare<br />
che fino dall' anno 1857 in un articolo, che pubblicai sulla<br />
nostra Zecca, avvertii per la prima volta l'erronea attribuzione<br />
fatta dal Vasari al Francia delle monete in <strong>di</strong>scorso, e mi<br />
riserbai <strong>di</strong> addurne le prove, allorché avessi avuto a mia<br />
<strong>di</strong>sposizione il bolognino d' argento , già della collezione<br />
Schiassi, ora pervenuto al nostro Museo Civico, per riportarne<br />
il <strong>di</strong>segno a maggior <strong>di</strong>mostrazione del mio assunto. Più tar<strong>di</strong><br />
nel 1869, richiesto in proposito dal sig. cav. Morbio, gliene<br />
significai sommariamente le principali in una lettera, ch'egli<br />
rese <strong>di</strong> pubblica ragione nel suo libro : Opere storiconumismatiche<br />
a pag. 84. Ciononostante anche nella nuova<br />
e<strong>di</strong>zione del Vasari gli si é menata buona questa erronea<br />
attribuzione, cui ripetè puranco l'illustre Armand nell'opera<br />
sua : Les Médailleurs italiens. Tom. I, pag. 104, n. 5 (io). Né<br />
(6) Mem. <strong>di</strong> relig., <strong>di</strong> mor. etc, Tom. XII, pag. 73.<br />
(7) Almanacco staiist. Bologtt., anno XII, pag. 271.<br />
(8) Die Italienischen Schaumiinzen etc, pag. 174.<br />
(9) Stor. della Seul. e<strong>di</strong>z. <strong>di</strong> Prato, Tom. V, pag. 426.<br />
(io) Questi però, avuta contezza della mia Memoria sulle Monete<br />
in <strong>di</strong>scorso, rettificò nel tomo III, pag. 30, n. 5 dell'opera sopra in<strong>di</strong>cata<br />
la precedente aggiu<strong>di</strong>cazione colle seguenti parole : Apres les monnaies
56 LUIGI FRATI<br />
è a maravigliarsene: gli errori, quanto più autorevole è lo<br />
scrittore che li <strong>di</strong>vulga, e più lungo il tempo dacché han<br />
messo ra<strong>di</strong>ce, altrettanto è più malagevole lo sra<strong>di</strong>carli<br />
interamente.<br />
Che il Francia non fosse addetto all'officina della zecca<br />
all'epoca dell'ingresso <strong>di</strong> Giulio, e meno poi che la tenesse<br />
continuamente, <strong>com</strong>e <strong>di</strong>ce il Vasari, parmi si abbia ad arguirlo<br />
dalla seguente deliberazione del Senato bolognese, che leggesi<br />
nel Voi. XIII Partitonim, in data 19 novembre del 1508:<br />
Item per decein et novem fabas albas et sex nigras obtenium<br />
fiiit^ quod solvantur de pecuniis extraor<strong>di</strong>nariis Camerae<br />
magistro Francisco Franciae aurifici ducati quinquaginta<br />
aiiri prò mercede sua duarum stamparum sculptarum cum<br />
imagine sanctissimi D. N. et insignibus Communis Bononiae<br />
prò cuden<strong>di</strong>s monetis novis, et prò mercede quarumcumque<br />
aliarum stamparum, qtiae conficiendae forent prò Cecha<br />
t)re<strong>di</strong>cta; ad quas omnes faciendas teneatur et obligatiis sit,<br />
prout sic ipse facere promittit: quae pecuniae deinde exigantur<br />
ac repetantur per ipsam Cameram a magistro Cecchae, qui<br />
ad impensam confectionis stamparum ipsius Cecchae tenetur<br />
et obbligatus est. Il tenore <strong>di</strong> questa deliberazione prova, a<br />
mio avviso, che il Francia fu allora eletto a incisore della<br />
nostra Zecca. E <strong>di</strong> vero, s'egli fosse stato coniatore in essa<br />
anche per l' innanzi, qual ragione vi sarebbe stata <strong>di</strong> stabi-<br />
de Bentivoglio, l'ordre chronologique amenerait, dans la liste des ouvrages<br />
de Francia, les ntonnaies de lules IL Les premieres en date seraient le<br />
ducat d'or et le bolognino d'argent jetés au peitple lors de l'entrée du Pape<br />
à Bologne en ijoó. Au <strong>di</strong>re de Vasari, ces pieces étaient l'ouvrage de<br />
Francia. M. le docteur Luigi Frati, le savant <strong>di</strong>recteur du Museo civico<br />
de Bologne, à qui nous devons de précieuses Communications, a démontré<br />
d'une manière qui nous sentale irréfutable que ces monnaies ne pouvaient<br />
appartenir à Francia. On ne pourrait, au reste, y reconnaitre la main<br />
de ce grand artiste, ni sur le droit de ces pieces avec les armoiries de<br />
lules II provenant de la monnaie romaine, ni sur le revers orné d'une<br />
figure de saint Pierre empruntée à une monnaie d'Alexandre VI. La piece<br />
décrite au n. j de l'oeuvre de Francia y a donc été pfacée à tort, et doit<br />
étre rejetée parmi les ouvrages des médailleurs anonymes du premier<br />
quart du seizi'eme siede.<br />
Par cantre, il faut rendre au Francia les monnaies suivantes, ecc.<br />
quelle cioè da me riportate ai nn. 465 della tavola.
sull'erronea attribuzione al FRANCIA, ECC. 57<br />
lirgli uno stipen<strong>di</strong>o sui fon<strong>di</strong> straor<strong>di</strong>narii della Camera, e sotto-<br />
metterne a scrutinio nel 1508 l'elezione <strong>di</strong> lui a siffatto incarico?<br />
Ciò posto, se il Francia non era coniatore nella Zecca<br />
all'atto della venuta in Bologna <strong>di</strong> Giulio II, si rende vieppiù<br />
improbabile ch'egli così devoto al Bentivoglio e da lui cotanto<br />
riamato e protetto pigliasse incarico, non costretto per debito<br />
<strong>di</strong> ufficio, <strong>di</strong> condur opera, che tornava a perpetuo <strong>di</strong>sdoro<br />
del suo mecenate, e quando le sorti <strong>di</strong> lui negli animi de'<br />
suoi aderenti non dovevano essere per anco totalmente <strong>di</strong>ffi-<br />
date. E vieppiù improbabile ancora si rende l'ammettere in<br />
lui una tale riprovevole condotta <strong>di</strong>etro le testimonianze, che<br />
ci hanno tramandato della sua bontà scrittori contemporanei.<br />
Burzio nella Bononia perlustrata (11) infra le doti dell'animo,<br />
che gli appropria, gli dà pregio ezian<strong>di</strong>o <strong>di</strong> costanza <strong>di</strong><br />
carattere ; e Bartolomeo Bianchini nella vita <strong>di</strong> Codro lo<br />
chiama " amore e delizia nostra, artefice <strong>di</strong> specchiata virtù,<br />
cui tutti amano e ammirano e <strong>com</strong>e nume adorano „ fi2), E<br />
qui è veramente a dolersi che sia ora smarrito o perduto il<br />
registro, che teneva il Francia delle proprie memorie, nel<br />
quale non potevano mancare tratti, donde tralucesse l'imma-<br />
gine dell'animo suo. La sola annotazione, a mo' d'esempio,<br />
della partenza dal suo stu<strong>di</strong>o del <strong>di</strong>scepolo Timoteo Viti,<br />
ricordata dal Malvasia: (13) — 1495 ^d' 4 aprile, partito il<br />
mio caro Timoteo, che Dio le <strong>di</strong>a ogni bene e fortuna —<br />
non ci rivela tutta la soavità del suo animo? Soavità che<br />
traspare ezian<strong>di</strong>o in ogni opera del suo pennello e in quelle<br />
care imagini, <strong>di</strong> cui il Sanzio in una lettera a lui <strong>di</strong>retta gli<br />
scriveva " non vederne da nessun altro più belle e più <strong>di</strong>vote<br />
e ben fatte „<br />
(14). E <strong>di</strong> quanto affetto e <strong>di</strong> quanta estimazione<br />
(11) Ex me etiani Fabri: Aitrifices: Sculptores : atque Pictores nomi-<br />
nan<strong>di</strong>ssimi, inter quos nnus omnium est mihi clarissimiis Francisctis<br />
Francia mmcnpatus.... Hic profecto ingeniosus: affabilis : decorus : et<br />
gravitate morum exornatus.<br />
(12) Huius vero effigiem oris, vulfusque et lineamenta corporis mire<br />
expressit in ae<strong>di</strong>bus Bentivolorum amor et delitiae nostrae Francia<br />
spectatae virtutis artifex, cuius unicum ingenium fastigium pariter omnes<br />
et amant et admirantur, et tamquam numen adorant.<br />
(13) Fels. pittr., Bologna. 1678, I, pag. 55.<br />
(14) Malvasia, Op. cit., Tom. I, pag. 45.
58 LUIGI FRATI<br />
non lo ricambia l'Urbinate in detta lettera; della quale piacemi<br />
riferire le ultime parole, porgendomi esse argomento ad<br />
un'osservazione in conferma del mio assunto. " Fatevi animo,<br />
" gli scrive Raffaello, valetevi della vostra solita prudenza,<br />
" et assicuratevi che sento le vostre afflizioni <strong>com</strong>e mie<br />
" proprie. Seguite ad amarmi <strong>com</strong>e io vi amo <strong>di</strong> tutto cuore „.<br />
Dove non credo arrischiata la supposizione che il Sanzio lo<br />
conforti a tollerare le <strong>di</strong>spiacenze derivategli dalla per<strong>di</strong>ta<br />
del suo mecenate e conseguentemente dal mutato or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong><br />
cose e per parte dei nuovi Signori; <strong>di</strong> che rende indubitata<br />
testimonianza anche il ricordato squitinio per la sua elezione<br />
a coniatore della Zecca; nella quale circostanza sei dei nuovi<br />
reggitori, messa in non cale la molta valentia del Francia,<br />
non seppero tenersi dal manifestargli nell'urna la loro avver-<br />
sione per la passata <strong>di</strong>vozione al Bentivoglio.<br />
Appresso le addotte testimonianze contemporanee riesce<br />
non poco spiacente che patrii scrittori, giurando ciecamente<br />
sulla fede del biografo aretino, gli rinfaccino " <strong>di</strong> non aver<br />
" avuto rossore <strong>di</strong> lavorare nella Zecca a contumelia del<br />
" Bentivoglio, <strong>di</strong> colui che solo valse a farlo grande, che<br />
" gli allogò lavori <strong>di</strong> cesello, e niello, <strong>di</strong> <strong>di</strong>pintura a gran<br />
" numero, che gli fu protettor munifico, e del quale esistono<br />
" pur anche i frutti della protezione principesca, onde volle<br />
" favorirlo. Per certo Michelangelo non avrebbe operato<br />
" così „<br />
(15). Con parole meno dure ricorda questo fatto altro<br />
scrittore i^^), il quale anzi, per attenuarne la sinistra impres-<br />
(15) Muzzi, Ann. <strong>di</strong> Bologna, T. V., pag. 510.<br />
(16) Giordani Gaet., neWAlmanacco statisi, bolog. Anno XII, pag. 274.<br />
" Queste monete erano opera <strong>di</strong> conio del famoso Francesco Francia,<br />
" orefice, niellatore e pittore <strong>di</strong> Bologna; il quale sebbene fosse fami-<br />
" gliare dello scacciato ed infelice Bentivoglio, e ben d'onde avesse per<br />
" <strong>com</strong>piangere la <strong>di</strong>sgraziata sorte <strong>di</strong> un Signore, che tanto lo avea<br />
" amato e beneficato e tenuto in pregio per varie opere d'arti a <strong>com</strong>-<br />
" missione <strong>di</strong> lui condotte, non<strong>di</strong>meno il Francia, saggio qual egli era,<br />
" seppe prudentemente nascondere suo cordoglio, e sofferse anco <strong>di</strong><br />
" formare i conii. per la nuova moneta (essendo egli mastro o capo<br />
" della Zecca bolognese) „. Non sappiamo per verità donde il Giordani<br />
abbia tratto quest' ultima notizia, che il Francia fosse a capo della<br />
Zecca, la quale anzi è recisamente contraddetta dalle parole dall'alle-<br />
gata deliberazione del Senato.
sull'erronea attribuzione al FRANCIA, ECC. 59<br />
sione, finisce coU'ascriverglielo a virtij. Né <strong>di</strong> minore contrad-<br />
<strong>di</strong>zione dà prova lo stesso Vasari, il quale, dopo aver esposto<br />
il Francia a immeritati rimproveri, designandolo capace <strong>di</strong><br />
tanta ingratitu<strong>di</strong>ne verso il suo principale benefattore, poche<br />
righe appresso <strong>di</strong>chiara che " egli ebbe gran<strong>di</strong>ssimo dolore<br />
" de la partita <strong>di</strong> messer Giovanni Bentivogli, perchè haven-<br />
" dogli fatti tanti benefizj gli dolse infinitamente. „<br />
Ma proseguendo le nostre osservazioni, noterò ancora<br />
essere inverosimile che il Francia potesse eseguire quattro<br />
conii in meno <strong>di</strong> otto giorni, quanti ne trascorsero dalla par-<br />
tenza del Bentivoglio all'entrata del Pontefice, non <strong>com</strong>putato<br />
il tempo occorrente alla battitura delle monete. Molto pii^i<br />
consentaneo al vero si è che i conii già preparati portasse<br />
seco qualche ufficiale della Corte, o se furono lavorati nella<br />
nostra Zecca, sic<strong>com</strong>e narra Alamanno Bianchetti nella sua<br />
Cronaca <strong>di</strong> Bologna mss. a pag. 800, si valessero in parte<br />
<strong>di</strong> punzoni già esistenti; asserzione non destituita <strong>di</strong> fonda-<br />
mento, se si confrontano attentamente le figure <strong>di</strong> s. Pietro<br />
delle monete <strong>di</strong> Giulio con quella del ducato del suo prede-<br />
cessore, che ho riportato appositamente al n. i della tavola.<br />
Altro argomento contro l'asserzione del Vasari vuoisi<br />
trarre in<strong>di</strong>rettamente dalle seguenti parole del cerimoniere<br />
Paride Grassi, al quale il Pontefice avea dato incarico <strong>di</strong> far<br />
coniare le monete in <strong>di</strong>scorso : Inde me petiit quantum pecuniantm<br />
populo projiciendarum conflari iussissem: Respon<strong>di</strong><br />
ego ob vias longas a mansione ad cathedralem Ecclesiam,<br />
ad quam primo eundum erat, et demum inde ad Palatium<br />
maius prò sua Sanctitate paratmn, propterea meo quidem<br />
iu<strong>di</strong>cio non sufficere ducatos mille tani ex auro quam moneta^<br />
itaque statuii ut de utroque numismate tria millia, quae con-<br />
signavit illa <strong>di</strong>e inter popidum <strong>di</strong>spergenda d. Joanni Cozza-<br />
<strong>di</strong>tto bononiensi, qui tunc erat Clericus fiscalis, et Daiarius<br />
apostolicus. Fra tanti particolari nulla ci <strong>di</strong>ce il Grassi dell'in-<br />
cisore <strong>di</strong> esse, cui non avrebbe omesso d'in<strong>di</strong>care, a mio<br />
avviso, se questi fosse stato il rinomatissimo Francia. Per la<br />
qual cosa, se il silenzio <strong>di</strong> lui su tale proposito, riesce agli<br />
altri così eloquente, <strong>com</strong>e si pare a me, chiunque ben vede<br />
quanta maggior fede si meriti il Grassi, che scriveva <strong>di</strong> cosa,<br />
<strong>di</strong> cui ei fu sì gran parte; <strong>di</strong> quello che il Vasari il quale
6o LUIGI FRATI<br />
racconta un fatto, per tempo e per luogo, alquanto da lui<br />
<strong>di</strong>scosto, e <strong>di</strong> cui era assai male informato, sic<strong>com</strong>e egli<br />
stesso ne ha pòrto testimonianza manifesta nell'errata descri-<br />
zione delle monete, asserendo che da una banda era la testa<br />
naturale <strong>di</strong> Giulio, e dall'altra la leggenda: Bononia per<br />
Julium a tyranno liberata; <strong>di</strong> che mostra non averle mai<br />
vedute, e <strong>di</strong> aver confuso in una due <strong>di</strong>stinte specie <strong>di</strong> monete :<br />
quelle cioè eseguite dal Francia tra il finire del 1508 e il 1509<br />
(v. Tav. I, n. 4 e 5), le quali hanno appunto l'effigie <strong>di</strong> Giulio li,<br />
appiccicando ad esse il rovescio delle altre gittate al popolo<br />
nel 1506 (Tav. I, n. 2 e 3).<br />
Resterebbe ora a determinare il numero <strong>di</strong> ciascuna<br />
specie <strong>di</strong> dette monete, se l'espressione de utroque mimismate<br />
non lasciasse incerto se il valore dei tre mila ducati fu ri-<br />
partito fra le due specie in parti uguali, <strong>com</strong>e parrebbe aversi<br />
ad argomentare dall'inciso precedente ìnille ducatos tatù ex<br />
auro qiiam moneta. Ciò ammesso, il numero delle monete in<br />
oro sarebbe stato <strong>di</strong> 1500, e <strong>di</strong> oltre 42,000 quelle in argento.<br />
Finalmente altro anche più convincente argomento contro<br />
l'asserzione del Vasari si ritrae dal confronto del lavoro delle<br />
due monete colla leggenda : Bononia per Ji<strong>di</strong>iim. etc. colle<br />
altre riportate ai n. 4 e 5, che sono veramente opera del<br />
Francia, rispondendo esse alla descrizione delle stampe <strong>com</strong>-<br />
messegli nella deliberazione del Senato del 19 novembre 1508.<br />
Basta avere l'occhio mezzanamente educato al sentimento<br />
dell' arte per convincersi della notevole <strong>di</strong>sparità <strong>di</strong> lavoro<br />
che passa fra le une e le altre. Nelle prime la figura del<br />
Santo, il partito delle pieghe, la forma delle lettere, ogni<br />
parte è lavorata me<strong>di</strong>ocremente; laddove nelle due ultime<br />
per lo contrario tutto è con sommo magistero condotto: e la<br />
faccia <strong>di</strong> Giulio piena <strong>di</strong> espressione, la figura del Santo<br />
bellamente atteggiata, la testina finissimamente incisa, bello<br />
e naturale il piegheggiare delle vesti, elegante la forma delle<br />
lettere. Cotalchè reca veramente sorpresa che tanta <strong>di</strong>suguaglianza<br />
<strong>di</strong> lavoro non sia stata per innanzi avvertita; dove<br />
non credo andar lungi dal vero, ritenendo che la somma<br />
rarità delle monete in <strong>di</strong>scorso, e segnatamente del bolognino,<br />
avendo impe<strong>di</strong>to la facilità del confronto, abbia contribuito<br />
a prolungare l'erronea attribuzione, che ho preso a ribattere.
sull'erronea attribuzione al FRANCIA, ECC. 6l<br />
Pertanto se il Morbio alla sommaria in<strong>di</strong>cazione delle<br />
sposte ragioni <strong>di</strong>sse: " aver io provato a tutta evidenza che<br />
"<br />
il famoso zecchino colla leggenda Bononia per Julimn, etc.<br />
" non è lavoro <strong>di</strong> quel grande artista „ (^7), ora che alle<br />
medesime, pili ampiamente <strong>di</strong>chiarate, ho aggiunto e pòrto<br />
modo nell'unita tavola <strong>di</strong> poter quasi toccar con mano l'erro-<br />
neità dell'asserzione del biografo aretino, giova sperare <strong>di</strong><br />
vederla in appresso generalmente rigettata; e <strong>di</strong> tal modo<br />
adempiuto il voto del Breton, laddove, nel suo articolo bio-<br />
grafico del Raibolini, parla delle medaglie eh' egli lavorò :<br />
' La plus célèbre, egli <strong>di</strong>ce, est celle qu' il grava par ordre<br />
''<br />
* de Jules II après l'expulsion des Bentivoglio, avec cette<br />
' legende: Cantra stimulinìi ne calcitrcs. On regrette de voir<br />
le Francia avoir consacré ainsi son talent à immortaliser<br />
l'infortune de ses bienfaiteurs, et nous voudrions, pour son<br />
' honneur, pouvoir regarder <strong>com</strong>me apocryphe une autre<br />
' médaille [leggi monnaie) fort louée par Vasari, qui prétend<br />
' que, faite à la méme occasion, elle portait la legende:<br />
' Bononia per Julium a tyranno liberata „ (i8). La medaglia<br />
superiormente accennata è la bellissima rappresentante la<br />
caduta <strong>di</strong> Saulo, cui reputa il Breton coniata dal Francia per<br />
l'espulsione del Bentivoglio, <strong>com</strong>e prima <strong>di</strong> lui avea opinato<br />
il Cicognara (19), forse entrambi tratti in inganno dal Ve-<br />
nuti (20), il quale per convalidare siffatta opinione non si era<br />
peritato <strong>di</strong> valersi <strong>di</strong> false asserzioni: quali sono che la me-<br />
daglia in <strong>di</strong>scorso (mancante affatto <strong>di</strong> millesimo) riporti<br />
segnato l'anno MDVI, e l'allegare su ciò la testimonianza del<br />
Bonanni (21), il quale per lo contrario segue il Luckius (22),<br />
che la ritiene coniata nel 151 1 e allusiva alla guerra fra<br />
Giulio II e Alfonso duca <strong>di</strong> Ferrara, al qual parere s'attenne<br />
pure il Molinet (23). Che se l'illustre Friedlaender (24) nella<br />
(17) Opere storico-numismatiche, pag. 340.<br />
(18) Nouv. Biog. génér., toni. XLI, col. 483.<br />
(19) Stor. della Scult., e<strong>di</strong>z., cit., tom. V, pag. 426.<br />
(20) Numism. Rem. Pont., Romae, 1744, in-4, pag. 50.<br />
(21) Numism. Pont. Rom., Romae, 1699, in-fol., pag. 146.<br />
(22) Syll. Numism. elegant, Argentor, 1620, in-fol., pag. 21.<br />
(23) Hist. Summ. Pont, per eorum numism., Lutet., 1679, in-fol., p. 32.<br />
(24) Die Italienischen Schaumiinzen, Berlin, 1882, in-4, P^g- i74-
62 LUIGI FRATI<br />
Stupenda opera sui Medaglioni italiani non ha osato proferir<br />
giu<strong>di</strong>zio circa l'artefice <strong>di</strong> questa medaglia, stante l'incertezza<br />
del soggetto, ha però recisamente rigettato l'opinione messa<br />
innanzi dal Cicognara e poscia dal Breton <strong>di</strong> attribuirla al<br />
Raibolini per la cacciata del Bentivoglio, adducendo ad argomento<br />
la stessa eccellenza del lavoro, la quale rende affatto<br />
improbabile che la possa essere fattura <strong>di</strong> pochi giorni. E<br />
con ciò parmi bastantemente <strong>com</strong>provata l'insussistenza anche<br />
<strong>di</strong> questo altro capo <strong>di</strong> accusa apposto al nostro Francia.<br />
Altra erronea opinione sul conto del medesimo era stata<br />
messa fuori anni sono da un dotto bibliografo (25), l'autorità<br />
del cui nome avea procacciato alla medesima, <strong>com</strong>echè <strong>com</strong>-<br />
battuta, una certa consistenza. Sosteneva questi che Fran-<br />
cesco da Bologna, intaghatore de' caratteri <strong>di</strong> Aldo, non altri<br />
fosse che Francesco Raibolini, volgarmente " il Francia „, il<br />
quale stabilita una stamperia a Bologna pubbhcò in sul finire<br />
dell'anno 1516 e nel gennaio del 1517 sei preziosi volumetti (26),<br />
stampati ad imitazione <strong>di</strong> quelli <strong>di</strong> Alessandro Paganino. Non<br />
ha guari però altro bibliografo, Adamo Rossi, pose fine alla<br />
questione, dando ragione ai <strong>di</strong>screpanti dalla prevalsa cre-<br />
denza, mercè la scoperta da lui fatta nell'Archivio <strong>di</strong> Perugia<br />
<strong>di</strong> un documento, dal quale risulta essere Francesco da<br />
Bologna della famiglia Griffi. Così venisse dato che valente<br />
scrittore, pigliando a materia <strong>di</strong> accurato stu<strong>di</strong>o la vita, le<br />
opere e la scuola <strong>di</strong> quest'illustre Maestro, ci desse un lavoro<br />
storico degno <strong>di</strong> lui; il quale, se non fu il primo uomo <strong>di</strong> quel<br />
secolo, <strong>com</strong>e, a detta del Malvasia (27), era stato tenuto a'<br />
suoi tempi, fu senza dubbio il più. grande artista <strong>di</strong> cesello,<br />
<strong>di</strong> niello e <strong>di</strong> pittura, che abbia avuto la patria nostra „.<br />
(25)<br />
Luigi Frati.<br />
Panizzi Ant., Chi era Francesco da Bologna? Londra, 1858, in-8.<br />
(26) Sono dessi i seguenti: Il Canzoniere del Petrarca (20 settembre<br />
T516); — L'Arca<strong>di</strong>a del Sannazaro (3 ottobre); — gli Asolani del Bembo<br />
(30 ottobre); — il Corbaccio del Boccaccio (9 <strong>di</strong>cembre); — le Lettere<br />
famigliari <strong>di</strong> Cicerone (20 <strong>di</strong>cembre) ; — e Valerio Massimo (24 gen-<br />
naio 1517).<br />
(27) Fels. pittr., ed. cit. T. I, pag. 48.
UN NUOVO GROSSO INEDITO<br />
DI<br />
GIO. ANTONIO FALLETTl<br />
CONTE DI BENEVELLO W<br />
Mentre per ogni canto d'Italia corre un fremito <strong>di</strong> gioia,<br />
all'annunzio desiderato delle prossime nozze <strong>di</strong> S. A, R. il<br />
Principe <strong>di</strong> Napoli, io, altero <strong>di</strong> Suo benigno assentimento,<br />
con animo ossequioso e riconoscente, mi permetto <strong>di</strong> dare<br />
notizia <strong>di</strong> un nuovo e preziosissimo cimelio numismatico, che<br />
recentemente è entrato a far parte della splen<strong>di</strong>da raccolta<br />
<strong>di</strong> monete italiane che S. A. coltiva ed accresce, con squisito<br />
<strong>di</strong>scernimento e con intelletto <strong>di</strong> amore. Sono pochi anni che<br />
l'Augusto Principe <strong>di</strong> Sua iniziativa, e con quel <strong>di</strong>letto che<br />
negli animi gentili destano le patrie memorie, va riunendo<br />
una collezione <strong>di</strong> monete, la quale già è ad<strong>di</strong>venuta assai<br />
numerosa, e racchiude pezze <strong>di</strong> gran pregio in ogni metallo,<br />
fra le quali non poche rarissime e talune ezian<strong>di</strong>o uniche.<br />
In queste ultime va <strong>com</strong>preso il grosso <strong>di</strong> cui imprendo<br />
la illustrazione. Proviene dalla ven<strong>di</strong>ta Durazzo, tenuta a<br />
Genova nello scorso maggio, nel cui catalogo era classificato<br />
sotto Bologna, con questa avvertenza: " Ine<strong>di</strong>ta. Sono della<br />
massima persuasione che questa moneta non è coniata a<br />
Bologna; dovendo per altro catalogarla, l'ho inserita in questa<br />
zecca, lasciando allo stu<strong>di</strong>oso acquirente la sod<strong>di</strong>sfazione <strong>di</strong><br />
stu<strong>di</strong>arla e pubblicarla precisamente „.<br />
(i) Pubblicato nello scorso settembre 1896 in occasione delle Nozze<br />
<strong>di</strong> S. A. R. il Principe <strong>di</strong> Napoli. (N. d. D.).
64 O. VITALINI<br />
Godo pertanto <strong>di</strong> poter costatare che questo grosso è<br />
senza dubbio della zecca <strong>di</strong> Benevello (2).<br />
Prima che il <strong>com</strong>m. Vincenzo Promis, in una nota <strong>com</strong>unicata<br />
all'Accademia delle Scienze <strong>di</strong> Torino, nel novembre<br />
del "88, segnalasse due monete <strong>di</strong> Gio. Antonio Falletti (3),<br />
conte <strong>di</strong> Benevello, questo piccolo feudo era del tutto sco-<br />
nosciuto nella <strong>numismatica</strong> <strong>italiana</strong>. Le due monete, allora<br />
prodotte ed illustrate, i^no uno scudo d'oro noto solamente<br />
dalle antiche tariffe, al tipo dell'aquila bicipite e della croce;<br />
e un grosso, nel medagliere <strong>di</strong> S. M. in Torino, coli' aquila<br />
medesima e uno stemma alla banda scaccata <strong>di</strong> tre tiri. Nelle<br />
leggende, che si <strong>com</strong>pletano a vicenda, il lemma <strong>di</strong> onore<br />
Carolus Imp: ovvero Karolns Romanor. Imperai, con le note<br />
nominah del signore o feudatario Jo: Anto: Fa: Comes:<br />
Bene: 1537.<br />
Riproduco dalla detta memoria il grosso <strong>di</strong> argento:<br />
Il eh. autore nelF eru<strong>di</strong>ta monografia concludeva che<br />
tali monete erano state battute forse in Germania, ad imita-<br />
zione <strong>di</strong> simiglianti pezze tedesche, italiane e svizzere, dal<br />
conte <strong>di</strong> Benevello Gio. Antonio Falletti, per privilegio o in<br />
onore <strong>di</strong> Carlo V, nel cui esercito aveva <strong>com</strong>andato un<br />
reggimento <strong>di</strong> fanti italiani. E questi fu il primo e 1' ultimo<br />
conte <strong>di</strong> Benevello, tra il 1520 e il 1550, e durò finche<br />
(2) Benevello, capoluogo <strong>di</strong> mandamento, circondario e <strong>di</strong>ocesi <strong>di</strong><br />
Alba, provincia <strong>di</strong> Cuneo.<br />
(3) La memoria del Promis fu stampata a parte (E. Loescher, To-<br />
rino, in-8, <strong>di</strong> pag. 9) e nel frontispizio incorse l'errore <strong>di</strong> scrivere Gio.<br />
Battista, invece <strong>di</strong> Gio. Antonio Falletti: quest'equivoco fu pur ripetuto<br />
da altri.
UN NUOVO GROSSO INEDITO, ECC. 65<br />
Carlo V non gli tolse la contea, insieme con la signoria <strong>di</strong><br />
Mombarcaro, per investirne un tale D. Alvaro <strong>di</strong> Sanchez<br />
spagnolo, in pena dell'avere il Falletti abbandonato il servizio<br />
imperiale per rivolgersi alla Francia.<br />
La terza moneta, che ora viene alla luce, è pure del<br />
Falletti, ma <strong>di</strong> tipo e leggenda totalmente vari dalle prece-<br />
denti, sebbene sia senza dubbio ad esse contemporanea.<br />
È parimenti un grosso <strong>di</strong> argento: ha nel <strong>di</strong>ritto un<br />
santo vescovo vestito <strong>di</strong> casula, reggente con la sinistra una<br />
lunga croce astata e con la destra le chiavi, in alto l'armetta<br />
de' Falletti (4), in giro<br />
S • PETRVS •<br />
BE •<br />
C<br />
(<strong>com</strong>es)<br />
nel rovescio un cavaliere con la spada in resta, nel giro<br />
CAROL •<br />
in alto l'aquiletta bicipite.<br />
IMPERAI<br />
Il nome <strong>di</strong> Carlo V, 1' aquila imperiale, 1' armetta e le<br />
iniziali BE • C<br />
non permettono dubbiezza alcuna intorno all'at-<br />
tribuzione del grosso al Falletti per Benevello. Anzi possiamo<br />
aggiungere due nuovi in<strong>di</strong>zi tolti dalle figure rappresentanti<br />
san Pietro in vincoli, già assunto a patrono del Comune; e<br />
san Secondo martire, a cavallo, titolo della chiesa parrocchiale.<br />
Ma la singolarità che accresce gran pregio alla moneta<br />
si è quella <strong>di</strong> presentare una tecnica affatto itahana e 1' avvicinarsi<br />
al tipo àeW agontano, tanto da farne credere una<br />
imitazione fedelissima.<br />
È noto che Ancona, antica città marittima e <strong>com</strong>merciale,<br />
(4)<br />
I conti Falletti <strong>di</strong> Villafalletta portano anche oggi d'azzurro,<br />
alla banda scaccata <strong>di</strong> oro e <strong>di</strong> rosso <strong>di</strong> tre file : cimiero, un' aquila <strong>di</strong><br />
nero coronata dello stesso. (V. Calendario d'oro, 1896, pag. 216).
(^ O. VITALINI<br />
coniava sua moneta già nel secolo XIV, e volendo emulare<br />
il cre<strong>di</strong>to, che nelle contrattazioni riscuoteva il matapane <strong>di</strong><br />
Venezia, ne imitò il taglio, migliorandone il valore (5). Le<br />
zecche marchigiane vicine, vista la buona prova, ne seguirono<br />
r esempio, e 1' agontano o ancontano <strong>di</strong>venne moneta conosciuta<br />
e ben ricevuta, <strong>com</strong>e già quella <strong>di</strong> Ravenna, Lucca<br />
e Pavia.<br />
Nell'epoca in cui battè sua moneta il Falletti per il feudo<br />
<strong>di</strong> Benevello, il grosso <strong>di</strong> Ancona presentavasi artisticamente<br />
elegante, trovandosi, in quel tempo, a modellare nelle officine<br />
romane i celebri incisori e zecchieri i Migliori fiorentini.<br />
Il Bellini, nella <strong>di</strong>ss. II, pag, 7 e 8, riporta due esemplari<br />
<strong>di</strong> tal grosso: io do la incisione <strong>di</strong> altro presso <strong>di</strong> me, il<br />
quale a prima vista manifesta tutta la rassomiglianza <strong>di</strong> cui<br />
ho fatto cenno.<br />
Il santo (san Pietro o san Ciriaco), in ambedue le pezze,<br />
ha le medesime vesti, lo stesso atteggiamento, la identica<br />
croce astata terminata a palline , la mitra , T aureola, tutto<br />
perfettamente somigliante. Il cavaliere, andante <strong>di</strong> galoppo<br />
a sinistra, impugna la spada con la destra in alto, pronto a<br />
colpire: e qui pure l'andatura del cavallo, la posa e le vesti<br />
del cavaliere hanno corrispondenza talmente perfetta, da far<br />
supporre che l'impronta sia stata fatta con uno stesso punzone.<br />
Una variante è stata necessariamente introdotta, sostituendo<br />
nel grosso <strong>di</strong> Benevello l'aquiletta bicipite alle chiavi<br />
decussate dell'anconitano; ma anche questa mo<strong>di</strong>ficazione è<br />
talmente riuscita da potersene appena rilevare la <strong>di</strong>fferenza.<br />
E bene scelse il Falletti la imitazione del grosso <strong>di</strong><br />
Ancona, anche per la ragione che il tipo del cavaliere,<br />
(5) Tonini, Period. <strong>di</strong> Numis. e Sfrag., anno II, pag. 203.
UN NUOVO GROSSO INEDITO, ECC. 67<br />
sebbene in movenze non del tutto a questa simili, si trovava<br />
fin da que' tempi nelle monete <strong>di</strong> Milano, <strong>di</strong> Saluzzo, <strong>di</strong><br />
Lavagna e <strong>di</strong> Monferrato.<br />
Due questioni tuttavia lasciò impregiu<strong>di</strong>cate il Promis:<br />
quale, cioè, fosse stata 1' officina produttrice, se <strong>italiana</strong> od<br />
estera; e se la coniazione fosse legale ovvero abusiva e<br />
contraffatta.<br />
Con la osservazione della nuova moneta mi sembra<br />
potersi rischiarare l'uno e l'altro dubbio, affermando essere<br />
la zecca <strong>italiana</strong> e la moneta legale, quantunque <strong>di</strong> tipo<br />
imitato, ma non falsificato.<br />
In fatti la nazionalità della zecca apparisce dai tipi scolpiti,<br />
il santo e il cavaliere. Il santo vescovo, effigiato <strong>com</strong>e<br />
nel grosso <strong>di</strong> Benevello, lo troviamo, oltre Ancona, a Rimini,<br />
Bologna, Reggio, Camerino, Arezzo e Volterra. Del cavaliere<br />
accennammo più sopra, <strong>com</strong>e fosse tipo pre<strong>di</strong>letto da molte<br />
zecche dell'alta Italia. Si manifesta altresì per 1' arte, per il<br />
<strong>di</strong>segno, per la semplicità dei contorni, senza centinature e<br />
perline, e per la correttezza delle lettere.<br />
Escludo finalmente nel Falletti lo scopo <strong>di</strong> contraff'are e<br />
falsificare: chi vuole frodare lo Stato con coni adulterati non<br />
vi spaccia sopra il suo nome e titolo e l'arma patente; ma<br />
stampa leggende anomale, o equivoche, o mancanti, a fine<br />
<strong>di</strong> non essere scoperto e sottoposto alle leggi severe dei<br />
falsari. Di più, il Falletti si sarebbe fatto reo d'ingratitu<strong>di</strong>ne<br />
verso il suo protettore Carlo V, e ciò ripugna per fermo al<br />
carattere leale <strong>di</strong> un condottiero d'armi.<br />
Riepilogando: la esistenza <strong>di</strong> una zecca a Benevello è<br />
omai accertata, sebbene abbia lavorato per breve tempo; e<br />
questo feudo col suo signore Falletti, che fin qui timidamente<br />
erano <strong>com</strong>parsi nella Bibliografia dei sigg. fratelli Gnecchi (6)<br />
e nel Mnnuale dell'Ambrosoli (?), hanno <strong>di</strong>ritto al loro posto<br />
definitivo nei nostri cataloghi e nelle serie <strong>di</strong> monete italiane.<br />
Roma, Agosto 1896.<br />
(6) Milano, 1889. Suppl., Ili, pag. 457.<br />
(7) Milano, Hoepli, 1891, pag. 117.<br />
O. VlTALlNI.
OPERE NUMISMATICHE<br />
DI<br />
CARLO KUNZ<br />
(Continuazione: Ve<strong>di</strong> Fase. IV, 1896).
MISCELLANEA NUMISMATICA ^'^<br />
I.<br />
DELLA ZECCA DI CREMA.<br />
Delle vicende <strong>di</strong> Crema, piccola ma generosa città che<br />
giganteggia nei fasti d'Italia per sublimi esempii <strong>di</strong> fortezza<br />
dettarono pagine accurate ed eloquenti Pietro Terni, Alemanio<br />
Fino, Carlo Sigonio, Giuseppe Racchetti, Francesco<br />
Sforza-Benvenuti, ed altri.<br />
Scopo del presente articolo non essendo che quello <strong>di</strong><br />
toccare brevemente l'argomento delle sue monete, sorpas-<br />
serò quanto ad esso non si riferisce.<br />
Sebbene Crema tar<strong>di</strong> fosse stata assunta al rango <strong>di</strong><br />
città, perchè fino all'anno 1450 s'appagò con quello piii mo-<br />
desto <strong>di</strong> terra o castello, pure l'importanza sua nella storia<br />
generale d'Italia fu tale, ch'è argomento <strong>di</strong> meraviglia <strong>com</strong>e<br />
nei varii rivolgimenti <strong>di</strong> fortuna a' quali andò soggetta<br />
dalla sua fondazione fino al principio del secolo decimoquinto,<br />
mai abbia avuto zecca propria.<br />
E questo un fatto che può francamente affermarsi, perchè<br />
né memorie, né monete stanno in appoggio del contrario, e<br />
conviene <strong>di</strong>scendere fino all' epoca accennata, al tempo cioè<br />
in cui fu governata e dominata dai Benzoni, per rinvenire<br />
i rarissimi cimeli per cui essa pure prende posto, ristretto<br />
bensì ma onorevole, nella serie <strong>di</strong> ciò che si è convenuto<br />
denominare le Zecche d'Italia.<br />
(i) La Miscellanea <strong>numismatica</strong>, <strong>di</strong>visa in cinque capitoli, fu pub-<br />
blicata nel 1867 in opuscolo separato a Venezia coi tipi della Tipografia<br />
del Commercio.<br />
,
72<br />
CARLO KUNZ<br />
Chiarissima famiglia era quella dei Benzeni, la quale,<br />
secondo scrive l'accurato Terni, derivò dall'antichissima dei<br />
Greppi, per un figlio <strong>di</strong> Giovanni Greppo denominato Ben-<br />
zene: e Greppi e Benzoni valsero lungamente a <strong>di</strong>notare lo<br />
stesso casato. Fu desso il più celebre fra tutti quelH che<br />
emersero in Crema, dove primeggiò lungamente per grado<br />
e per fortuna stando sempre alla testa del partito guelfo<br />
nel tempo in cui tutta l'Italia era s<strong>com</strong>buiata dalle civih con-<br />
tese delle due famigerate fazioni. Verso la fine del secolo<br />
decimosesto <strong>di</strong>venne quella famiglia cotanto numerosa che<br />
quasi potea da sé sola, <strong>com</strong>e già quella dei Fabii in Roma,<br />
formare una schiera! Ebbe molti uomini <strong>di</strong>stinti, particolarmente<br />
nelle armi, fra cui Venturino Benzone il vecchio, il<br />
quale nell'anno 1303, allorché Napo della Torre trionfò <strong>di</strong><br />
Matteo Visconti, venne eletto capitano del popolo milanese;<br />
carica insigne che a lui ben si ad<strong>di</strong>ceva, perché guerriero<br />
<strong>di</strong> splen<strong>di</strong>da fama e zelantissimo fautore <strong>di</strong> parte guelfa.<br />
Di lui e degli altri illustri Benzoni v'hanno belle notizie<br />
negli autori nominati, e l'albero <strong>di</strong> questa illustre famiglia<br />
vedesi nel Campidoglio Veneto <strong>di</strong> Girolamo Alessandro Cap-<br />
pellari, opera manoscritta in gran foglio che conservasi in<br />
questa BibHoteca Marciana.<br />
Dopo molti rivolgimenti <strong>di</strong> fortuna, caduta Crema nell'anno<br />
1335 in potere <strong>di</strong> Azzone Visconti, perdette per sempre<br />
la propria sovranità e col cessare della forma repubblicana<br />
ebbe pur fine l'epoca pili luminosa della sua storia. Spenta<br />
la libertà politica, tacquero le fazioni sotto le spire del serpe<br />
visconteo, ma <strong>di</strong>vamparono nuovamente, dopoché Gian Ga-<br />
leazzo coll'oro e coi raggiri, ottenne, nel 1395, dall'impera-<br />
tore Venceslao il titolo <strong>di</strong> duca, trasferibile ai suoi <strong>di</strong>scen-<br />
denti. Guelfi e Ghibellini affilarono <strong>di</strong> nuovo le spade per<br />
straziarsi a vicenda, ed a capo del partito guelfo stettero in<br />
Crema, <strong>com</strong>e per lo passato, i Benzoni.<br />
Morto nell'anno 1402 Gian Galeazzo, in<strong>com</strong>inciò a sfa-<br />
sciarsi la potenza viscontea, e<strong>di</strong>fizio aggregato colle con-<br />
quiste, le <strong>com</strong>pre e le usurpazioni e non cementato dall'opi-<br />
nione dei popoli, ed i partiti, infuriando con nuovo vigore,<br />
spianarono agli ambiziosi la via <strong>di</strong> farsi tiranni della patria loro.<br />
Crema si ribellò a Gabriello Visconti, figHo naturale <strong>di</strong>
MISCELLANEA NUMISMATICA 73<br />
Gian Galeazzo, che a lui donavala per testamento unitamente<br />
a Pisa, e venuti alle mani Guelfi e Ghibellini, dopo atroci<br />
vicendevoli rappresaglie, rimasero i primi vincitori, e per tal<br />
modo fu aperto il varco al dominio dei Benzoni, non altamente<br />
che avvenne a Brescia, a Como, a Cremona, a Lo<strong>di</strong>,<br />
a Bergamo ed in Parma, dove, da mezzo allo s<strong>com</strong>piglio<br />
delle lotte intestine, sorsero tirannelli <strong>di</strong> essa Pandolfo Ma-<br />
latesta, Franchino Rusca, Ugo Cavalcabò, Giovanni da Vi-<br />
gnate, Francesco Scar<strong>di</strong> ed i Rossi.<br />
Nell'anno 1403<br />
il popolo <strong>di</strong> Crema ab<strong>di</strong>cò la millantata<br />
sovranità, conferendola ai fratelli Paolo e Bartolomeo Benzoni.<br />
Tale signoria fu da molti scrittori qualificata usurpazione, e<br />
con ragione, che non era il generale suffragio dei citta<strong>di</strong>ni<br />
cremaschi, ma la fazione guelfa capitanata dallo stesso Paolo,<br />
che <strong>di</strong>ede ad essi il dominio; onde il Racchetti non esitò <strong>di</strong><br />
asserire che i fratelli Benzoni prima si arrogarono il dominio<br />
<strong>di</strong> Crema, poi si fecero proclamare signori da una adunanza<br />
<strong>di</strong> citta<strong>di</strong>ni, nella quale sindaci e consiglieri erano già istrutti<br />
<strong>di</strong> quanto dovevano fare (2). E lo Sforza-Benvenuti aderisce<br />
a tale opinione: " perchè la storia <strong>di</strong> tutti i popoli insegna<br />
" essere vecchia astuzia dei potentati adombrare colle forme<br />
" della legalità le loro soperchierie „ (3). Noi, contemporanei<br />
<strong>di</strong> qualche gran<strong>di</strong>oso fatto analogo, non ci opporremo a così<br />
vera sentenza.<br />
Poco durò la signoria dei due fratelli Benzoni, perchè,<br />
colpiti dalla pestilenza che nell' anno 1405 desolò il suolo<br />
cremasco, morirono entrambi nel castello d'Ombriano dove<br />
eransi ritirati.<br />
Neil' istromento d' investitura dell' anno 1403, era stato<br />
stabilito che a Paolo e Bartolomeo dovessero succedere i<br />
figliuoli nel dominio <strong>di</strong> Crema; <strong>di</strong>sposizione che venne confer-<br />
mata col testamento <strong>di</strong> Paolo a favore dell'unico suo Rizzardo,<br />
e con quello <strong>di</strong> Bartolomeo a prò dei proprii, Daniele, Greppo<br />
e Trippino, ancora fanciulli. Come avvenne or dunque che<br />
nello stesso anno in cui morirono Paolo e Bartolomeo,<br />
(2) Racchetti, Annotazioni al libro III della Storia d'Alemanio Fino.<br />
Tomo I, pag. 175.<br />
(3) Sforza-Benvenuti, Storia <strong>di</strong> Crema. Tomo I, pag. 205.
74<br />
CARLO KUNZ<br />
Crema sia caduta in podestà <strong>di</strong> Giorgio Benzene cugino <strong>di</strong><br />
quegli infanti? Vi hanno tutte le ragioni per credere che<br />
Giorgio abbia strappato col raggiro ai suoi parenti la si-<br />
gnoria. Avvi bensì un istromento d' elezione riportato dal<br />
Fino, reddato a nome del Consiglio generale del Comune, ma<br />
desso non è che una ripetizione del modo già adoperato<br />
da Paolo e Bartolomeo, e per quanto Giorgio Benzone abbia<br />
saputo coonestare il fatto del suo dominio, apparisce chiaramente<br />
essere stato questo il frutto <strong>di</strong> doppia usurpazione.<br />
Giorgio Benzone fu astuto, <strong>di</strong>spotico, rapace e gene-<br />
roso: toglieva colla destra per donare colla sinistra. Temendo<br />
<strong>di</strong> essere trabalzato dalla risorgente potenza dei<br />
Visconti, adoperò tutti i mezzi per guarantirsi la signoria,<br />
vendendo ed affittando i beni confiscati dai Ghibellini, forti-<br />
ficando castelli, innalzando torri gigantesche, facendo larga<br />
provvigione <strong>di</strong> armi, cambiando i castellani delle rocche,<br />
stringendo alleanza con altri tirannelli <strong>di</strong> Lombar<strong>di</strong>a, implo-<br />
rando tregue dal Duca <strong>di</strong> Milano; ma tuttociò non valse<br />
che a <strong>di</strong>fferire la sua caduta.<br />
Spento neir anno 1412 il feroce duca Giovanni Maria<br />
sotto i colpi dei suoi avversarii, successe nel ducato il <strong>di</strong><br />
lui fratello Filippo Maria, che non <strong>di</strong>razzava dagli avi in<br />
perfi<strong>di</strong>a e tenebrosa politica. Ben presto s' avvide Giorgio<br />
che non avrebbe potuto resistergli lungamente, e stabih<br />
perciò <strong>di</strong> amicarselo me<strong>di</strong>ante una transazione, rimettendo a<br />
lui parte <strong>di</strong> quella sovranità eh' erasi arrogata. Dopo nove<br />
anni <strong>di</strong> podestà assoluta, egli rinunziò nelle mani <strong>di</strong> Filippo<br />
Maria alla signoria <strong>di</strong> Crema, per esserne da lui investito<br />
colle prerogative <strong>di</strong> feudatario.<br />
Addì 31 luglio 1414 fu stipulato nel castello <strong>di</strong> Pavia<br />
un accordo, il quale <strong>di</strong>mostrava quanto magra fosse la parte<br />
lasciata dal duca al nuovo suo vassallo, nel tempo stesso<br />
che indoravagh l'offa, investendolo del titolo <strong>di</strong> conte <strong>di</strong><br />
Crema e <strong>di</strong> Pan<strong>di</strong>no, trasferibile a tutta la sua <strong>di</strong>scendenza<br />
mascolina. In quel mezzo, nell' anno 1407, la Repubblica <strong>di</strong><br />
Venezia, smaniosa <strong>di</strong> estendere le sue conquiste in terra-<br />
ferma, riconoscendo importante <strong>di</strong> amicarsi il signore <strong>di</strong><br />
Crema, avevalo insignito del raro e splen<strong>di</strong>do privilegio<br />
della nobiltà veneziana.
MISCELLANEA NUMISMATICA 75<br />
Il Benzene fu zelantissimo nell'adempiere i patti che al<br />
duca lo legavano, sussi<strong>di</strong>andolo <strong>di</strong> denari e <strong>di</strong> milizie, e<br />
guerreggiando egli stesso col proprio figlio Venturino nel-<br />
l'esercito <strong>di</strong> lui; ma tanto fervore per mantenersi in quella<br />
grazia, non bastò a salvarlo, e gli stessi suoi figli <strong>di</strong>edero<br />
occasione al duca Filippo Maria <strong>di</strong> soppiantarlo nel dominio<br />
del territorio <strong>di</strong> Crema. Le insolenze e lascivie loro matu-<br />
rarono le vendette <strong>di</strong> alcune famiglie già partigiane dei<br />
Benzoni, le quali accusandolo <strong>di</strong> fellonia presso il duca, tramarono<br />
in pari tempo <strong>di</strong> privarlo <strong>di</strong> vita.<br />
Giorgio, ch'era d'indole sospettosa, non tardò ad accor-<br />
gersi del sinistro progetto, e, preso da subito timore^ fuggì<br />
da Crema nella notte del 24 gennaio 1423, e seguito dai<br />
quattro figli, incamminossi alla volta <strong>di</strong> Mantova, in<strong>di</strong> a<br />
Venezia, dove fu accolto onorevolmente ed accettata la sua<br />
spada in servizio della Republica. Così perdette per sempre<br />
la signoria <strong>di</strong> Crema, che tenne per nove anni con podestà<br />
assoluta, e per <strong>di</strong>eci quale feudatario del duca <strong>di</strong> Milano.<br />
Giorgio Benzone, sono parole dello Sforza-Benvenuti,<br />
figura storicamente nella schiera dei tirannelH lombar<strong>di</strong> i<br />
quali dopo la morte <strong>di</strong> Gian Galeazzo Visconti ghermirono<br />
un lembo del suo manto ducale; usurpatori tutti, per la più<br />
parte scelleratissimi, ma meno tristo degli altri, non mac-<br />
chiossi d'atroci delitti, e fu più sitibondo <strong>di</strong> denaro che <strong>di</strong><br />
sangue, perchè d' oro necessitava onde sostenere la vacil-<br />
lante signoria.<br />
Fra gli attributi sovrani da lui esercitati v' ha quello<br />
della moneta, che fece improntare col proprio nome. Inutile<br />
sarebbe il cercare le concessioni <strong>di</strong> tale attributo, il quale<br />
non fu che naturale conseguenza della sua usurpazione.<br />
Potrebbero ben esservi contratti <strong>di</strong> zecca ed or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> battitura,<br />
ma poiché a tanti dotti investigatori della storia non<br />
riuscì fino ad ora <strong>di</strong> rinvenirli, rimane solo <strong>di</strong> attenersi alle<br />
scarse e rarissime monete che si hanno <strong>di</strong> lui, le quali non<br />
possono essere state battute che nel tempo in cui il Benzone<br />
fu assoluto signore, cioè dall'anno 1405 al 1414.<br />
Scrive il Terni nella Scelta degli uomini <strong>di</strong> pregio:<br />
Trovansi fino al dì d'oggi alcuni denari d'oro e d'argento<br />
<strong>di</strong> quelli che faceva battere il Benzone, i quali hanno d'un
76<br />
CARLO KUNZ<br />
" lato l'arma Benzona, col motto: In te Domine^ e dall'altro<br />
" l'immagine d'esso Benzone, con lettere che <strong>di</strong>cono: Georgius<br />
" Benzonus dominiis Cremae „ , e ciò vien ripetuto senza<br />
alcun <strong>com</strong>mento dagli autori che a lui successero. L' asser-<br />
zione del Fino, per ciò che riguarda le monete d' oro del<br />
Benzone, non è finora <strong>com</strong>provata e può ritenersi piaggeria<br />
<strong>di</strong> quello storico, che monete d' oro colle effigie <strong>di</strong> principi<br />
del grado <strong>di</strong> lui, nel principio del secolo decimo quinto, sono<br />
quasi irreperibili. Ne esistono però alcune d' argento e <strong>di</strong><br />
lega, e tre ho potuto vederne, ricercando <strong>di</strong>ligentemente<br />
nelle principali raccolte, una sola delle quali trovasi pubbli-<br />
cata dall'Argelati, nel tomo terzo della sua Raccolta, ma con<br />
figura tanto imperfeìta che riprodurla con più esatto <strong>di</strong>segno<br />
<strong>di</strong>venta in<strong>di</strong>spensabile.<br />
La prima (Tavola II, n. i), è un bolognino <strong>di</strong> buon<br />
argento fatto a similitu<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> quelli che prima improntò<br />
Bologna intorno al 1236, e che furono poscia imitati per<br />
lungo tempo in molte altre zecche d' Italia. Da principio<br />
valutati un soldo, o la ventesima parte della lira, sminuirono<br />
successivamente <strong>di</strong> peso, salendo al valore <strong>di</strong> due sol<strong>di</strong>. E<br />
per due sol<strong>di</strong> stimo essere stato emesso questo del Benzone,<br />
il quale, per analogia con altri <strong>di</strong> quel tempo, dovrebbe<br />
avere il peso <strong>di</strong> circa grammi 1,100. Leggesi sul primo lato<br />
<strong>di</strong> esso, nel giro : f georgivs — benz, e nel mezzo con lettere<br />
<strong>di</strong>sposte in forma <strong>di</strong> croce, intorno ad un cerchietto : onvs, sul<br />
secondo lato del giro : d . e . gre . m . , coli' ultima lettera a,<br />
<strong>di</strong> forma maiuscola, nel mezzo fra quattro simili cerchietti.<br />
Superiormente nel giro evvi uno scudetto triangolare, <strong>di</strong>viso<br />
orizzontalmente, col quale al certo si volle raffigurare l'arme<br />
del Comune ch'era <strong>di</strong>visa, <strong>di</strong> vermiglio e d' argento. Erano<br />
questi i colori del marchese Guglielmo <strong>di</strong> Monferrato, il quale<br />
donò il suo stemma ai Cremaschi, nell'anno 1185. Qui non<br />
vedesi che lo scudo, il quale nell'arme era inoltre, <strong>com</strong>e in<br />
quella <strong>di</strong> Monferrato, sormontato da un elmo col cimiero <strong>di</strong><br />
un braccio armato <strong>di</strong> spada, fra due corna <strong>di</strong> cervo, arme<br />
che <strong>di</strong>stingue ancora quella città. Conservo un'impronta <strong>di</strong><br />
questa bella moneta, e mi viene detto che un esemplare <strong>di</strong><br />
essa trovasi nella raccolta del chiarissimo Sig. Cav. Camillo<br />
Brambilla <strong>di</strong> Pavia.
MISCELLANEA NUMISMATICA 77<br />
La seconda moneta del signore <strong>di</strong> Crema, ch'è <strong>di</strong> lega,<br />
a circa la metà <strong>di</strong> fino, trovai pesare grammi i,ooo in esem-<br />
plare <strong>di</strong> buona conservazione. Giu<strong>di</strong>co essere un sol<strong>di</strong>no o<br />
la metà del bolognino. L' iscrizione del primo lato : f geor-<br />
Givs — t BENZONVS, si Completa con quella del rovescio,<br />
ove leggesi : dominvs f creme. 3 e. Nel mezzo del <strong>di</strong>ritto<br />
vedesi l'arme dei Benzoni, uno scudo rotondato vaiato, col<br />
capo carico <strong>di</strong> un cane passante, nell'area del rovescio campeggiano<br />
le iniziali g. b, (Tav. II, n. 2).<br />
È questa l'arme più antica dei Benzoni, e trovasi variamente<br />
raffigurata e descritta negli autori. Perchè se i più<br />
fanno lo scudo <strong>di</strong> vajo col capo d' azzurro caricato <strong>di</strong> un<br />
cane d'argento, alcuni <strong>di</strong>cono lo scudo pa<strong>di</strong>glionato, altri pongono<br />
nel capo un leone, e così variano pure nei colori : ma<br />
è certa la prima lezione quanto all'arme che alzava Giorgio<br />
Benzone nel tempo in cui improntava codesta moneta. L'in-<br />
quartatura vermiglia col leone d'oro ensifero, ch'egli aggiunse<br />
posteriormente, fu <strong>di</strong> concessione del duca Filippo Maria in<br />
occasione che insignivalo del titolo <strong>di</strong> Conte e 1' arme così<br />
inquartata, non sempre degli stessi smalti, fu mantenuta nei<br />
varii rami della sua <strong>di</strong>scendenza.<br />
Di questa moneta esiste una moderna contraffazione,<br />
non <strong>di</strong>fficile a riconoscere al taglio tozzo ed ineguale delle<br />
lettere, alla regolarità del contorno, all' argento troppo fino<br />
ed al peso troppo alto. Un esemplare ch'io conservo <strong>di</strong> cotal<br />
sciagurata manifattura pesa non meno <strong>di</strong> grammi 2,000, il<br />
doppio del peso riscontrato nella moneta genuina ! Ma<br />
giova<br />
notare esservi anche qualche esemplare <strong>di</strong> minor peso, ar-<br />
tificialmente ossidato, onde occultare la troppo finezza del<br />
metallo impiegato (4).<br />
La terza ed ultima moneta del Benzone è quella recata<br />
(4) L'industria dei falsificatori <strong>di</strong> monete, <strong>di</strong> queste arpie che inzozzano<br />
il banchetto <strong>di</strong> una scienza cotanto attraente, fiorisce ancora<br />
sempre, e particolarmente sì numerose sono le contraffazioni <strong>di</strong> mo-<br />
nete venete e <strong>di</strong> quelle dei Patriarchi d'Aquileja, ben note a tutti gli<br />
onesti raccoglitori <strong>di</strong> esse, <strong>com</strong>e ne è nota la provenienza. Per lungo<br />
tempo ebbero desse corso sotto il patrocinio <strong>di</strong> qualche se<strong>di</strong>cente cul-<br />
tore scienziato della <strong>numismatica</strong> e molte <strong>di</strong> esse fecero brutta mostra <strong>di</strong>
78<br />
CARLO KUNZ<br />
dall'Ar^elati, che n'ebbe <strong>com</strong>unicazione da Francesco Schia-<br />
vini. Essa è <strong>di</strong> lega, <strong>com</strong>e la precedente, e dal suo peso,<br />
che trovai <strong>di</strong> grammi 0,500, giu<strong>di</strong>co essere la metà <strong>di</strong> quella,<br />
ossia un mezzo soldo. Offre consimiH leggende, cioè, nel<br />
dritto. GEORGivs .<br />
BENzoNvs,<br />
e nel rovescio : dominvs .<br />
creme<br />
.<br />
3'c, con uno scudetto d'ambo i lati, al principio <strong>di</strong> esse, il<br />
quale, non bene espresso nell' esemplare da me osservato,<br />
stimo essere l'arme del Comune, <strong>com</strong>e nel bolognino. Lo<br />
spazio centrale, chiuso da un cerchio <strong>di</strong> perline, è occupato<br />
nel primo lato da una croce patente, e nel secondo da una<br />
grande g <strong>di</strong> forma gotica (Tav. II, n. 3). Nel <strong>di</strong>segno dell'Ar-<br />
gelati la croce è inoltre accantonata da quattro punti che non<br />
rilevai nell'esemplare in <strong>di</strong>scorso, <strong>di</strong> scadente conservazione.<br />
Sono queste tutte le monete del Signore <strong>di</strong> Crema ve-<br />
nute a mia conoscenza. Col tempo forse ne sorgerà qualche<br />
sé in cospicui medaglieri. Alcune sono imitazioni <strong>di</strong> monete esistenti, altre<br />
prette invenzioni. Resi avvertiti i raccoglitori per molti <strong>di</strong>singanni su-<br />
biti, stanno ora più sulle <strong>di</strong>fese, ma non per questo cessò la frodo-<br />
lenta industria, che anzi assottigliò l'ingegno e destreggiò la mano a<br />
nuove e più raffinate creazioni, ed avendo veduto che i coni adulterini<br />
facilmente venivano smascherati, si rivolse <strong>di</strong> preferenza all'alterazione<br />
delle leggende, me<strong>di</strong>ante la quale monete <strong>com</strong>uni assumono le appa-<br />
renze <strong>di</strong> rarissime. Delle falsificazioni venete ed aquilejesi farò appo-<br />
sito ragionamento in altra occasione, per ora basti questo cenno quale<br />
un primo avvertimento a chi spetta. Che se la frode non si rintanerà,<br />
ma vorrà persistere a suscitare l' indegnazione dei galantuomini, non<br />
mi periterò <strong>di</strong> essere più esplicito. Intanto, onde questo primo ricordo<br />
non resti privo <strong>di</strong> qualche pratica utilità pei troppo fidenti raccoglitori,<br />
segnalerò le seguenti contraffazioni <strong>di</strong> monete d'altre zecche d'Italia,<br />
prodotti quasi tutti della stessa <strong>di</strong>tta.<br />
1. Quattrino <strong>di</strong> Pier Luigi Farnese; quale marchese <strong>di</strong> Novara,<br />
simile a quello riportato dall'Anonimo (Pedrusi ?), autore delle lettere<br />
sopra le zecche <strong>di</strong> Castro e <strong>di</strong> Novara, nella Raccolta del Zanetti,<br />
Tomo V, tav. XVII, n. 7.<br />
2. Soldo <strong>di</strong> Loterio Rusca, signore <strong>di</strong> Como; simile a quello pub-<br />
blicato da Friendlànder : Nuniismata me<strong>di</strong>i aevi ine<strong>di</strong>ta. Tav. I, n. i.<br />
3. Piccolo <strong>di</strong> Treviso; del conte <strong>di</strong> Gorizia Enrico II.<br />
4. Grosso aquilino <strong>di</strong> Parma; quale vedesi nel Trattato delle<br />
monete Parmigiane dell'Affò, nel Tomo V dello Zanetti, tav. I, n. 13.<br />
L'esemplare ch'ebbero sott'occhio l'Affò ed il Zanetti, sciupato in parte
MISCELLANEA NUMISMATICA 79<br />
altra, ma il numero <strong>di</strong> esse resterà sempre estremamente<br />
limitato, ed il possesso anche <strong>di</strong> una sola formerà ognora<br />
bel ornamento <strong>di</strong> qualunque più insigne raccolta. Le ragioni<br />
<strong>di</strong> cotale rarità sono facili a <strong>com</strong>prendere: fatte per uso<br />
esclusivo del piccolo territorio cremasco, il quantitativo <strong>di</strong><br />
esse sarà stato assai limitato, e le ragioni politiche ed economiche<br />
dei governi succeduti a quello del Benzone, le<br />
avranno ben presto fatte sparire dalla circolazione.<br />
Da documenti e statuti del principio del secolo decimo-<br />
quinto apparisce che la moneta allora in uso era la lira<br />
imperiale, il cui rapporto non è agevole determinare, perchè<br />
aveva un corso nominale vario; ma essendo stata Crema<br />
per molti anni soggetta ai duchi <strong>di</strong> Milano, è verosimile che<br />
le monete del Benzone siano state lavorate alla legge <strong>di</strong><br />
quella città.<br />
non permise ad essi <strong>di</strong> dargli quella piìi precisa attribuzione ch'ebbe<br />
dall'illustre signor Comm. Lopez, il quale, colla massima probabilità,<br />
affermalo battuto nell'anno 1341, allorché Parma festeggiò la sua libe-<br />
razione dalla tirannia <strong>di</strong> Mastino della Scala, per opera dei Signori<br />
Correggeschi. Ed infatti, lo scudetto che vedesi al rovescio dopo i tre<br />
punti, nei rarissimi esemplari <strong>di</strong> tale moneta, apparisce caricato <strong>di</strong> una<br />
fascia, eh' è appunto 1' arme dei signori da Correggio. Nella contraffa-<br />
zione in <strong>di</strong>scorso vedesi invece, al luogo <strong>di</strong> quella armetta, una bella<br />
scala a pinoli, supina !<br />
5. Grosso <strong>di</strong> Cortona, analogo a quello recato dal Muratori, imitante<br />
i grossi <strong>di</strong> Siena della prima epoca, che forse non esiste nemmeno<br />
autentico, se, <strong>com</strong>e parmi, ad esso si riferisce quanto scrive lo Zanetti<br />
nel Tomo IV, pag. 521. Il falsatore, prendendo norma dal <strong>di</strong>segno del<br />
Muratori, aggiunse al suo conio una crocetta fra due stellette, al prin-<br />
cipio delle leggende, da ciascun lato.<br />
6. Denaro piccolo <strong>di</strong> Massa <strong>di</strong> Maremma, consimile a quello fatto<br />
conoscere dall'ili, sig. Comm. Promis nella <strong>Rivista</strong> <strong>di</strong> Numismatica.<br />
7. Zecchino <strong>di</strong> Piombino del principe Gian Battista Ludovisi.<br />
8. Bolognino d'Orvieto, col nome <strong>di</strong> Papa Martino V, che sembra<br />
inventato <strong>di</strong> pianta.<br />
9. Quattrino <strong>di</strong> Astorgio Manfre<strong>di</strong> signore <strong>di</strong> Faenza, fatto <strong>di</strong>etro<br />
il <strong>di</strong>segno datoci dal Zanetti. Tomo II, tav. VII, n. i, facilmente cono-<br />
scibile da ciò, che, invece <strong>di</strong> favent d', ha favenie.<br />
cedente.<br />
10. Bolognino <strong>di</strong> Tagliacozzo, d'infelice esecuzione e <strong>di</strong> peso ec
8o CARLO KUNZ<br />
La Repubblica <strong>di</strong> Venezia, che andava <strong>di</strong>latando il suo<br />
dominio nella terraferma, addì i6 settembre dell' anno 1449<br />
s'impossessò <strong>di</strong> Crema, dopo ripetuto asse<strong>di</strong>o <strong>di</strong>retto dal<br />
suo condottiero Sigismondo Malatesta. Da quel giorno, tranne<br />
qualche breve intervallo, non cessò più il dominio <strong>di</strong> Venezia<br />
sopra quella città, perchè durò quanto la Repubblica stessa,<br />
cioè fino all'anno 1797.<br />
Superata la bufera suscitatale contro della lega <strong>di</strong> Cam-<br />
bra!, Venezia rientrò nel 1512 in possesso <strong>di</strong> Crema, rapita<br />
per breve tempo dai suoi avversari, e ne affidò il <strong>com</strong>ando<br />
a Renzo Ceri, gentiluomo romano <strong>di</strong> casa Orsini, riputatis-<br />
simo condottiero, già operoso nel riacquisto <strong>di</strong> quella città.<br />
Combattuti nell' anno 1513<br />
i posse<strong>di</strong>menti della Repub-<br />
blica da nuovi nemici, Crema ebbe a patire per ben quattor-<br />
<strong>di</strong>ci mesi tutte le amarezze ed i sacrifizi che fanno lugubre<br />
corteggio alla guerra, e crebbe al sommo la desolazione della<br />
forte città, dopoché, stretta d'asse<strong>di</strong>o dalle armi sforzesche,<br />
<strong>com</strong>andate da Prospero Colonna e da Silvio Savello, vide<br />
rizzarsi fra le sue mura gli orri<strong>di</strong> spettri della fame e della<br />
pestilenza. Ma "una ar<strong>di</strong>mentosa sortita delle genti <strong>di</strong> Renzo,<br />
operata nella notte del 25 agosto 15 14, pose fine a tanti mali,<br />
e liberò la desolata città.<br />
Non molti giorni prima, avendo quel capitano esaurito<br />
ogni altro mezzo <strong>di</strong> far denaro fece battere moneta <strong>di</strong> ne-<br />
cessità con argenti requisiti. Ecco in qual modo il Fino, se-<br />
guace del Terni, riferisce il fatto.<br />
" Venuto il mese <strong>di</strong> agosto, vedendo Renzo che in Crema<br />
" ci era gran bisogno <strong>di</strong> denaro, pose mano negli argenti<br />
" del Monte <strong>di</strong> Pietà e <strong>di</strong> Santa Maria della Croce, e co-<br />
" minciò a battere certe monete <strong>di</strong> valuta <strong>di</strong> quin<strong>di</strong>ci sol<strong>di</strong><br />
" r una, le quali erano dette Petacchie. Non avevano im-<br />
" pronto alcuno, fuorché una imaginetta <strong>di</strong> San Marco da un<br />
" lato. E perchè l'altre monete che córrevano per il più erano<br />
" false, queste per la loro bontà, avevano gran<strong>di</strong>ssimo corso<br />
" per tutta la Lombar<strong>di</strong>a „.
MISCELLANEA NUMISMATICA 8l<br />
Piacemi anche riportare il passo relativo della cronaca<br />
manoscritta del Terni, che offre qualche interessante dettaglio.<br />
" Absentati i citta<strong>di</strong>ni, Renzo ed il Contareno (5) misero<br />
" mano negli argenti del Monte <strong>di</strong> Pietà e <strong>di</strong> S. Maria della<br />
" Croce, in quelli della gesa <strong>di</strong>co che per voto erano donati<br />
" et batterono alcune monete da 15 sol<strong>di</strong> <strong>di</strong> Milano l'una, et<br />
" non con cuneo ma col martello facevano le piastre d'ar-<br />
" gento, hor quadre, hor tonde, hor <strong>di</strong> sei, hor <strong>di</strong> otto can-<br />
" toni, <strong>com</strong>e per sorte venivano sotto il martello, et da un<br />
" lato solo sculpevano l' imagine <strong>di</strong> S. Marco <strong>di</strong> forma ro-<br />
" tonda tanto piccola che non prendeva il quinto della piastra,<br />
" rimanendo il resto <strong>com</strong>e dall' incu<strong>di</strong>ne era lassato, et per<br />
" rude et poco solemnigiata forma Petacchie erano doman-<br />
" date, et per la loro boutade per tutta la Lombar<strong>di</strong>a eb-<br />
" bono gran corso e questo fu <strong>di</strong> avosto dell'anno 1514 ed<br />
" in tanto maggior pregio erano perchè da ogni lato monete<br />
" false si facevano „.<br />
Malgrado tali particolarità, registrate da uno scrittore che<br />
visse contemporaneo al fatto, dubitai lungamente della esistenza<br />
<strong>di</strong> cotale pezzo ossi<strong>di</strong>onale, imperocché sembravami<br />
che Venezia, cotanto gelosa dei propri <strong>di</strong>ritti e sì provvida<br />
nelle sue leggi monetarie, male avrebbe tollerato che un<br />
Condottiero ed un Rettore <strong>di</strong> città non molto <strong>di</strong>scosta della<br />
metropoli emettessero monete per propria volontà ;<br />
parevami<br />
che se codesta moneta ebbe veramente grande corso per la<br />
sua bontà, in copia non in<strong>di</strong>fferente dovesse essere stata<br />
fabbricata, e però non <strong>di</strong>fficile dovesse riuscire <strong>di</strong> scoprirne<br />
qualche esemplare. Ma né il Fino, che visse pochi anni dopo<br />
il Terni, ne vide alcuna, né gli autori a noi più vicini n'ebbero<br />
conoscenza, e per quante ricerche io abbia fatto in buon<br />
numero <strong>di</strong> raccolte numismatiche italiane ed estere, mi fu<br />
dato poter scoprire tale patacca.<br />
Altra considerazione che rafforzava il mio dubbio era<br />
questa, che l'illustre Lazari, così <strong>di</strong>ligente investigatore delle<br />
monete della Repubblica Veneta, non ne aveva conoscenza<br />
allorché stampò il trattato delle monete de' suoi posse<strong>di</strong>menti,<br />
(5) Bartolomeo Contarini, che fu Rettore dal 20 gennaio 1513 al<br />
6 novembre 1515.
82 CARLO KUNZ<br />
perchè nel caso contrario non avrebbe al certo tralasciato <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>rcene alcuna cosa nel capitolo de<strong>di</strong>cato a quelle della Terra-<br />
ferma Veneta. Ma non quietalo ancora per tanti contrari argomenti<br />
pensai, l'illustre scienziato ne avesse forse poste-<br />
riormente raccolta qualche notizia ed affidatala alle pagine,<br />
nelle quali registrava <strong>di</strong>ligentemente i frutti dei suoi stu<strong>di</strong><br />
sulle monete d'Italia. Il nobilissimo signor Conte Nicolò Papadopoli,<br />
attuale possessore degli stu<strong>di</strong> del Lazari, appena<br />
u<strong>di</strong>to il mio desiderio, con quella rara magnanimità che lo<br />
<strong>di</strong>stingue si degnò concedermi l'ispezione del foglio de<strong>di</strong>cato<br />
alla zecca <strong>di</strong> Crema, sul quale, con grata sorpresa vi<strong>di</strong> un<br />
abozzo <strong>di</strong> <strong>di</strong>segno della patacca <strong>di</strong> Crema, una forma ottan-<br />
golare del <strong>di</strong>ametro <strong>di</strong> 31 millimetri, con un leone in soldo<br />
segnato verso uno dei lati, e dappresso la nota del peso:<br />
den. 7, gr. io del marco <strong>di</strong> Milano^ pari a denari S,ioj8.<br />
Quel <strong>di</strong>segno, essendo fatto sopra carta trasparente ed ap-<br />
plicato al foglio, <strong>di</strong>mostra ch'egli l'abbia tolto da altro <strong>di</strong>segno,<br />
<strong>com</strong>e argomento che anche il peso notatovi l'abbia desunto<br />
da notizia d'altri, ne abbia mai veduta effettiva la moneta in<br />
<strong>di</strong>scorso. Tale in<strong>di</strong>cazione, sebbene vaga, Hmita <strong>di</strong> molto i<br />
miei dubbi. Ammessa pertanto l'esistenza della patacca <strong>di</strong><br />
Crema, essa non sarebbe molto <strong>di</strong>ssimile dai testoni ossi<strong>di</strong>o-<br />
nali battuti in Pavia nell'anno 1524, e da quelli fabbricati in<br />
circostanze analoghe in Cremona nell'anno 1526.<br />
Il chiarissimo signore, cavaliere Carlo Morbio, che ar-<br />
ricchì la <strong>Rivista</strong> della <strong>numismatica</strong> antica e moderna con un<br />
frammento <strong>di</strong> opera sua sulle monetefranco-italiche ossi<strong>di</strong>onali,<br />
ebbe cura <strong>di</strong> registrare una serie <strong>di</strong> monografie numismatiche<br />
che va dettando, fra le quali sarebbevene una de<strong>di</strong>cata a monete<br />
ossi<strong>di</strong>onali <strong>di</strong> Crema e <strong>di</strong> Sabbioneta. In quanto a Crema<br />
giu<strong>di</strong>co che possa appunto trattarsi della patacca dell'anno<br />
1514, e s'è così, permettomi <strong>di</strong> eccitare istantemente quell'il-<br />
lustre <strong>di</strong> tenere al più presto la promessa, a sod<strong>di</strong>sfazione<br />
dei cultori della patria <strong>numismatica</strong>.
MISCELLANEA NUMISMATICA 83<br />
II.<br />
GLI ZECCHINI DI STAMPO VENETO<br />
DELLA ZECCA DI TRÉVOUX.<br />
L'Italia è in debito <strong>di</strong> riconoscenza coli' illustre signor<br />
Arnoldo Morel-Fatio, il quale, preso d'amore pei monumenti<br />
delle sue zecche, ne va mano mano molti illustrando in dotte<br />
ed interessanti memorie. Non meno fortunato nello scoprire<br />
cose peregrine che solerte a renderle <strong>di</strong> pubblica ragione,<br />
egli ad<strong>di</strong>ta vie nuove allo stu<strong>di</strong>oso delle antiche monete, e<br />
rivela agli italiani quale vasto campo <strong>di</strong> fruttuose ricerche,<br />
per la massima parte ancora negletto, abbiano essi nella<br />
propria <strong>numismatica</strong>. Desideriamo che il suo esempio sia<br />
nuovo eccitamento ai valenti cultori <strong>di</strong> questa scienza, e che<br />
lo stu<strong>di</strong>o delle zecche e delle monete d' Italia, alquanto<br />
negletto in confronto <strong>di</strong> quello eh' era nello scorso secolo,<br />
possa riprendere nuovo slancio sotto piìi fehci costellazioni,<br />
e la illustrazione <strong>di</strong> tutte le zecche itahane non resti troppo<br />
più a lungo un pio desiderio. Molto è vero resta ancora a<br />
fare, perchè <strong>di</strong> molte zecche non s' hanno che parziali ed<br />
in<strong>com</strong>plete illustrazioni, <strong>di</strong> molte altre è noto ai più appena<br />
il nome; ma la buona volontà ed il concorde operare non<br />
possono mancare <strong>di</strong> produrre anche in ciò i migliori effetti.<br />
Se i valenti cultori <strong>di</strong> questo importante ramo <strong>di</strong> scibile<br />
trovassero modo <strong>di</strong> far concorrere ad un medesimo fine le<br />
loro fatiche, uscendo dallo sterile isolamento, <strong>com</strong>unican-<br />
dosi reciprocamente i risultati delle proprie osservazioni,<br />
instituendo una associazione regolata, attiva e concorde pel<br />
<strong>com</strong>pletamento <strong>di</strong> un corpo <strong>di</strong> scienza delle monete d'Italia<br />
del Me<strong>di</strong>o Evo e moderne, il bel paese non tarderebbe<br />
<strong>di</strong> ad<strong>di</strong>tare un nuovo monumento meritevole <strong>di</strong> tutta 1' am-<br />
mirazione.<br />
Ben debole è la nostra voce, ma talvolta un sassolino<br />
dà impulso alla valanga: quello che non è possibile a noi,
84<br />
CARLO KUNZ<br />
sarebbe facilissimo a chi, già famoso per molti stu<strong>di</strong>atissimi<br />
dettati, avrebbe per sé la venerata autorità del nome, e<br />
l'esempio <strong>di</strong> una eccezionale attività. La troppa nostra infe-<br />
riorità ci vieta <strong>di</strong> declinarne il nome, che da chiunque sarà<br />
facilmente indovinato.<br />
Chiedendo venia per la <strong>di</strong>vagazione, ritorniamo al chia-<br />
rissimo signor Morel-Fatio, il quale, fornito della piiì squisita<br />
gentilezza e dell* amore più <strong>di</strong>sinteressato per la scienza,<br />
vogliamo credere ci perdonerà se osiamo esporre qui una<br />
nostra idea sovra un punto non ancora bene chiarito <strong>di</strong><br />
<strong>numismatica</strong>, che interessa non meno l'Italia che la Francia.<br />
Fra i dotti lavori, ond' egli va da qualche tempo arricchendo<br />
la rivista francese della Numismatica, havvi una<br />
<strong>di</strong>ssertazione sopra un zecchino <strong>di</strong> stampo veneziano, fatto<br />
battere da qualche principe <strong>di</strong> Dombes nella zecca <strong>di</strong> Trévoux,<br />
il quale, nel posto dove sui veneti zecchini suole leggersi<br />
il nome del doge, offre l'iscrizione franc — princ. (6). Con-<br />
trariamente all'opinione dell'ili, signor Giulio Friedlànder,<br />
che volle tale zecchino battuto dal principe Francesco II <strong>di</strong><br />
Borbone (1582- 1592,) ed a quella del chiariss. sign. P. Mantellier<br />
, seguito dal sig. Poey-d' Avant , che riferivalo al<br />
tempo <strong>di</strong> Anna-Maria Luigia d'Orléans (1650-1693), il signor<br />
Morel-Fatio da molte e <strong>di</strong>ligenti osservazioni guidato, con-<br />
chiuse^ che autore debba esserne stato il principe Gastone,<br />
padre ed imme<strong>di</strong>ato predecessore <strong>di</strong> madamigella d'Orléans<br />
(1627-1650). Non ripeteremo le ingegnose deduzioni colle<br />
quali l'autore tentò <strong>di</strong>mostrare che tale zecchino sia imitato<br />
nelle forme e nelle leggende da quello del doge Francesco<br />
Erizzo, scelto, a suo vedere, <strong>di</strong> preferenza onde maggiormente<br />
ingannare l'occhio, me<strong>di</strong>ante la somiglianza del nome inscritto<br />
sull'originale, col titolo Franciae Princeps posto sulla copia.<br />
Osserveremo soltanto, così <strong>di</strong> passaggio, che se fossevi stata<br />
veramente intenzione <strong>di</strong> ottenere me<strong>di</strong>ante tale contraffazione<br />
una <strong>com</strong>pleta illusione <strong>di</strong> somiglianza [trompe l'ceil) collo<br />
zecchino veneto, non avrebbesi inscritto il nome del santo :<br />
s. M. TREvoL, a rovescio, da sotto in su, ciò che costituisce<br />
(6) Revue Numismatique. Nouvelle sèrie. Tome <strong>di</strong>xième, 1866, pa-<br />
gina 199-204.
MISCELLANEA NUMISMATICA 85<br />
una <strong>di</strong>fferenza ben notabile ed appariscente collo zecchino<br />
<strong>di</strong> Venezia.<br />
Ben <strong>di</strong>sse il chiarissimo numismatico, che dall'attento<br />
esame delle successive mo<strong>di</strong>ficazioni dello stile e degli ac-<br />
cessori dello zecchino veneto possono desumersi utili corollari<br />
per l'attribuzione d'altre consimili monete, e la prova l'ab-<br />
biamo chiara e precisa nel caso presente. Il problema è<br />
facile a sciogliere <strong>com</strong>e quello dell'uovo <strong>di</strong> Colombo, ed<br />
eccone il modo.<br />
Nel tempo del doge Domenico Contarini il <strong>di</strong>segno dello<br />
zecchino subì una mo<strong>di</strong>ficazione, ben nota a tutti quelli<br />
ch'hanno scrutinato intorno alle monete venete. L'asta che<br />
reggono il santo ed il doge, che fino allora, e nel primo<br />
tempo del dogado <strong>di</strong> Domenico Contarini, era ornata <strong>di</strong> una<br />
semplice banderuola, ottenne, oltre questa, una croce. Cotale<br />
accoppiamento <strong>di</strong> croce e banderuola, che non osservasi che<br />
in zecchini "<strong>di</strong> questo doge, chiede ben presto luogo ad una<br />
nuova mo<strong>di</strong>ficazione, perchè durante la stessa ducea del<br />
Contarini fu tolta all'asta la banderuola, e la croce restò da<br />
in<strong>di</strong> in poi costantemente sola, per tutti i tempi successivi,<br />
fino alle ultime cusioni <strong>di</strong> questa celebre moneta.<br />
Hannovi adunque tre varietà dello zecchino <strong>di</strong> Domenico<br />
Contarini: la prima ha l'asta sormontata dalla sola banderuola,<br />
la seconda la banderuola unita alla croce, e la terza la sola<br />
croce. La seconda <strong>di</strong> questa varietà, quella cioè della croce<br />
sovrapposta alla banderuola, non incontrasi <strong>di</strong> altri dogi.<br />
Ora notisi, che lo zecchino <strong>di</strong> Trévoux, che <strong>di</strong>ede argomento<br />
a tante <strong>di</strong>scussioni offre appunto l'asta ornata <strong>di</strong> croce<br />
e <strong>di</strong> banderuola, dunque desso non può essere che la copia<br />
del consimile zecchino del doge Domenico Contarini, e poiché<br />
l'epoca del costui dogado (1659-1675), non corrisponde, pel<br />
Principato <strong>di</strong> Dombes, che a quella <strong>di</strong> madamigella Anna<br />
Maria d'Orléans (1650-1693), che ultima tenne il dominio <strong>di</strong><br />
quello stato, lo zecchino in questione deve necessariamente<br />
ritenersi battuto da essa, a meno che non si volesse invertire<br />
la <strong>di</strong>mostrazione, affermando che Venezia, nell'aggiungere la<br />
croce all'asta del vessillo sui suoi zecchini, abbia preso norma<br />
da una contraffazione fatta in suo danno, ciò che, speriamo,<br />
nessuno vorrà tenere possibile.
86<br />
CARLO KUNZ<br />
A maggiore conferma <strong>di</strong> tale deduzione riportiamo sotto<br />
il n. 4 della Tav. II il <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> uno zecchino <strong>di</strong> Domenico<br />
Contarini, e sotto il n. 6, quello dello zecchino <strong>di</strong> Trévoux,<br />
ritratti entrambi dagli originali, con quanta esattezza ci fu<br />
possibile. Sotto il n. 5, poi offriamo il <strong>di</strong>segno d'altro zecchino<br />
<strong>di</strong> Trévoux, il quale stimiamo fosse fino ad ora ignorato. In<br />
luogo della iscrizione: franc . princ . reca: s . m . trevol,<br />
per cui il nome del Santo protettore <strong>di</strong> quella città vi figura<br />
due volte, e mostra, <strong>com</strong>e l'altro, l'asta sormontata dalla croce<br />
posta in capo della banderuola, sebbene, per essere alquanto<br />
sciupato, poco <strong>di</strong>stinta apparisca la prima, onde deve ritenersi<br />
battuto, al pari <strong>di</strong> quello, al tempo <strong>di</strong> Madamigella d'Orléans.<br />
In appoggio della opinione che quel più noto zecchino<br />
<strong>di</strong> Trévoux spetti al principe Gastone, il prelodato signor<br />
Morel-Fatio porge notizia <strong>di</strong> un pezzo in rame, impresso da<br />
un solo lato, con <strong>di</strong>segno consimile ai predetti zecchini ed<br />
iscrizioni analoghe, infuori della riga destinata al nome, che<br />
in esso suona : dvx . g . dom ; ma poiché nel <strong>di</strong>segno prodotto<br />
avvi una apparenza <strong>di</strong> croce, oltre la banderuola, in capo<br />
all'asta, esso pure deve spettare al tempo <strong>di</strong> Madamigella<br />
d'Orléans, e sarà, probabilmente, <strong>com</strong>e con <strong>di</strong>versa applica-<br />
zione opinò il chiarissimo autore, la prova <strong>di</strong> un primo conio<br />
non gra<strong>di</strong>to della progettata, poscia effettuata contraffazione.<br />
Conchiuderemo ora noi pure, <strong>di</strong>cendo, che tanto quel<br />
saggio in rame, che gli zecchini effettivi <strong>di</strong> Trévoux, fino ad<br />
ora emersi, spettano indubitatamente a Madamigella d'Orléans<br />
e non ad altri, e ch'ebbe pienamente ragione l'Anonimo (Gian<br />
Agostino Gradenigo), il quale, pubblicando prima quello più<br />
noto (7), ad essa riferivalo.<br />
(7) Memorie per servire alPistoria letteraria, (ùéi Valvasense). T. IX.<br />
(1757)1 pag- 402.
MISCELLANEA NUMISMATICA 87<br />
III.<br />
DI UN PICCOLO RIPOSTIGLIO DI MONETE.<br />
Rimasto abbandonato un pegno al Monte <strong>di</strong> Pietà <strong>di</strong><br />
Treviso, era venduto all'asta <strong>com</strong>e <strong>di</strong> uso. Ebbi conoscenza<br />
dell'acquisto tar<strong>di</strong>, ma ancora in tempo per trarne qualche<br />
utile deduzione.<br />
Dal modo ond' era <strong>com</strong>posta quella partitella <strong>di</strong> monete,<br />
m'accorsi subito ch'essa doveva provenire da un ripostiglio,<br />
e giu<strong>di</strong>cai che lo stesso scopritore, forse per tema <strong>di</strong> essere<br />
chiamato a darne ragione, l'avesse depositata al Monte.<br />
L'aspetto generale <strong>di</strong> quelle monete, era tale da far credere<br />
che il nascon<strong>di</strong>glio dì esse possa essere stato il muro <strong>di</strong><br />
qualche vecchio e<strong>di</strong>fizio. Non sono trascorsi molti anni<br />
dacché, lavorandosi in quella città intorno a certe opere del<br />
Sile, si rinvenne nel suo letto grande numero <strong>di</strong> sol<strong>di</strong>ni<br />
veneti della seconda metà del secolo decimo quarto, ch'erano<br />
tutti fortemente anneriti dalla ossidazione. Le attuaU monete<br />
invece erano lampanti ed in parte ricoperte <strong>di</strong> un fino pol-<br />
viscolo biancastro, e la generale ottima conservazione <strong>di</strong> esse<br />
<strong>di</strong>mostrava che poco tempo avessero circolato.<br />
Quanto al numero delle monete <strong>di</strong> quel tesoretto, non<br />
posso in<strong>di</strong>carlo che per approssimazione , per le specie<br />
ch'erano più numerose, laddove, per quelle che si rinven-<br />
nero uniche od in pochi esemplari, posso <strong>di</strong>chiarare esatta<br />
la nota che segue.<br />
Ecco <strong>di</strong> quale monete era <strong>com</strong>posto il tesoretto:<br />
MONETE VENETE.<br />
esetnplari<br />
Grosso <strong>di</strong> Jacopo Tiepolo . i<br />
Grosso <strong>di</strong> Andrea Contarini 2<br />
Grosso <strong>di</strong> Antonio Venier, circa 40<br />
Sol<strong>di</strong>no dello stesso, circa 30<br />
Grosso <strong>di</strong> Michele Steno, circa . . . . . .110
88 CARLO KUNZ<br />
Sol<strong>di</strong>no dello stesso, circa ....<br />
Sol<strong>di</strong>no dello stesso col Cristo risorgente, circa<br />
Tornese (?) <strong>di</strong> Dalmazia<br />
MONETE DI PADOVA.<br />
Carrarino <strong>di</strong> Francesco I con S. Prosdocimo<br />
Carrarino dello stesso con S. Daniele .<br />
Carrarino <strong>di</strong> Francesco II, circa<br />
MONETE DI AQUILEJA.<br />
Denaro del patriarca Marquardo<br />
„ <strong>di</strong> Filippo d'Alen9on .<br />
„ <strong>di</strong> Giovanni <strong>di</strong> Moravia<br />
„ <strong>di</strong> Antonio Gaetani, circa<br />
„ <strong>di</strong> Antonio Panciera, circa<br />
Monetina esotica<br />
esemplari<br />
• 25<br />
. 60<br />
4<br />
3<br />
14<br />
2<br />
I<br />
3<br />
15<br />
60<br />
Numero totale approssimativo 375<br />
Pel tempo in cui furono improntate cotali<br />
quella <strong>di</strong> Dalmazia e la esotica, delle quali<br />
valga il seguente prospetto :<br />
Jacopo Tiepolo<br />
Andrea Contarini .<br />
Antonio Venier<br />
Michele Steno.<br />
Francesco I da Carrara<br />
Francesco II da Carrara<br />
Marquardo<br />
Filippo d'Alen9on .<br />
Giovanni <strong>di</strong> Moravia<br />
Antonio Gaetani .<br />
Antonio Panciera .<br />
monete, esclusa<br />
<strong>di</strong>rò pili<br />
I<br />
avanti,<br />
1229- 1249<br />
1368 1382<br />
1382- 1400<br />
1400- 1413<br />
1355- 1388<br />
1388- 1405<br />
1365- 1381<br />
1381- 1388<br />
1388- 1394<br />
1395- 1402<br />
1402- 1418<br />
L'epoca più vicina risulta adunque essere quella del<br />
Patriarca Antonio Panciera, ma poiché il tesoretto non pa-<br />
lesò alcuna moneta <strong>di</strong> Tommaso Mocenigo, che tenne la<br />
somma podestà della Repubblica, dall' anno 1414 al 1423, e<br />
fu quin<strong>di</strong> per molti anni contemporaneo al Panciera, devesi<br />
argomentare che i molti denari <strong>di</strong> costui che facevano parte<br />
<strong>di</strong> esso tesoretto siano stati battuti nei primi anni del suo<br />
patriarcato, e che il nascon<strong>di</strong>glio del piccolo peculio abbia
MISCELLANEA NUMISMATICA 89<br />
avuto luogo sotto il dogado <strong>di</strong> Michele Steno che a <strong>com</strong>-<br />
porlo contribuì colle sue monete più <strong>di</strong> alcuno degli altri<br />
principi nominati.<br />
La monetina non peranco qualificata, della quale piacemi<br />
riportare il <strong>di</strong>segno al n. 9 della stessa tavola, sorpassa gli<br />
angusti limiti delle mie cognizioni, ma se volessi credere<br />
alla autorità, non sempre sicura, del Welzl (8), spetterebbe a<br />
Mirxe II, principe <strong>di</strong> Valacchia, che tenne il potere negli<br />
anni 1419-1420. Se così fosse quel denaretto sarebbe in or-<br />
<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> tempo posteriore a tutte le altre monete del tesoretto,<br />
e <strong>di</strong>mostrerebbe che non al tempo dello Steno, ma a quello<br />
bensì <strong>di</strong> Tommaso Mocenigo dovrebbe riferirsi ii suo occul-<br />
tamento. Ma poiché ciò sembra inverosimile, per la già<br />
esposta ragione della totale assenza <strong>di</strong> monete <strong>di</strong> quest' ul-<br />
timo, e pel fatto della più lontana derivazione del danaretto in<br />
questione, credo poter conchiudere, piuttosto che a Mirxe II,<br />
spetiare egli debba a Giovanni Mirxe <strong>di</strong> lui padre, che resse<br />
lo scettro dei Voivo<strong>di</strong> agli anni 1393-1419, e ciò che vedesi<br />
delle sue iscrizioni rafforza tale ipotesi.<br />
Ostende quel denaro sul lato principale la figura del<br />
principe, che tiene colla destra un' asta e colla sinistra il<br />
globo crucigero. Sul rovescio vedesi l'arme <strong>di</strong> lui, cioè uno<br />
scudo inclinato, partito, colla prima partizione fasciata., e la<br />
seconda caricata <strong>di</strong> una lettera simile ad una T <strong>di</strong> forma<br />
gotica. Lo scudo è sormontato da un elmetto col cimiero <strong>di</strong><br />
un'aquila, e l'iscrizione suona d'ambo i lati ugualmente,<br />
cioè: t l'^tii.dpdYL. Il suo peso è <strong>di</strong> grammi 0,240.<br />
È probabile che tale moneta abbia circolato quale un<br />
sol<strong>di</strong>no, unitamente ai nominati sol<strong>di</strong>ni ducali, che in quel<br />
tempo molta era la confusione e soltanto ban<strong>di</strong> e leggi severe<br />
potevano infrenare il corso abusivo delle monete d'altri paesi.<br />
Giovi notare che, fra circa quaranta grossi del doge<br />
Antonio Venier, non uno eravi <strong>di</strong> quelli del primo stampo<br />
da lui usato, col rovescio privo del motto : gloria . t . soli,<br />
e ciò proverebbe che pochissimi ne siano stati battuti, e<br />
spiegherebbe l'attuale loro estrema rarità. All'incontro il<br />
(8) Calalogue de la grande collection Velzl, T. II. Deuxième Partie,<br />
n. 12002- 12004.
gO . CARLO KUNZ<br />
sol<strong>di</strong>no <strong>di</strong> Michele Steno, col tipo <strong>di</strong> G. Cristo uscente dal<br />
sepolcro, che fino ad ora avevasi in conto <strong>di</strong> raro, mercè<br />
questo ritrovo, che ne offerì circa sessanta esemplari, <strong>di</strong>venne<br />
<strong>com</strong>une.<br />
Altra particolarità degna <strong>di</strong> rimarco è questa, che tutti<br />
i carrarini <strong>di</strong> Padova avevano una piegatura in traverso,<br />
fatta a mano, e ciò potrebbe avere rapporto colla notizia<br />
riferita da Rambaldo degli Azzoni, nel suo Trattato 'della<br />
zecca <strong>di</strong> Treviso (9), che neh' anno 1355 i carrarini fossero<br />
in Treviso esclusi dal <strong>com</strong>mercio, con bando del governo<br />
<strong>di</strong> Venezia del 15 <strong>di</strong>cembre, e che nel 1379, tanto i vecchi<br />
quanto i nuovi carrarini, venissero ban<strong>di</strong>ti da Venezia e da<br />
tutte le altre città e terre a lei soggette. Questa guerra alle<br />
monete dei signori <strong>di</strong> Padova fu un prelu<strong>di</strong>o dell' altra più<br />
seria che la Repubblica mosse agli stessi Carraresi, che nel-<br />
l'anno 1405 finì colla totale loro rovina.<br />
Di questi carrarini, il solo che presentasse qualche <strong>di</strong>f-<br />
ferenza da quelli riportati dal Verci, era uno <strong>di</strong> Francesco II,<br />
colla sigla t del zecchiere Giovanni degli Arienti, posta alla<br />
sinistra anziché alla destra del Santo.<br />
Tralascio altre riflessioni che potrebbe inspirare la riu-<br />
nione <strong>di</strong> quelle monete, l'occultamento delle quali sarà stato<br />
motivato da mera avarizia, per <strong>di</strong>re qualche cosa della mo-<br />
neta <strong>di</strong> Dalmazia, la quale fra tutte era indubitamente la più<br />
interessante.<br />
Quattro erano gli esemplari <strong>di</strong> essa, due integri e due<br />
mancanti, ma tutti <strong>di</strong> conio sì fresco da far credere che poco<br />
o nulla avessero circolato (Tav. II, n. 7 e 8).<br />
Il <strong>com</strong>pianto illustre autore del trattato delle Monete dei<br />
Posse<strong>di</strong>menti Veneziani, in base <strong>di</strong> un decreto dell'anno 1410,<br />
contenuto nel Capitolare delle brache, conchiuse (io) che in<br />
quell'anno si battesse nella zecca <strong>di</strong> Venezia per uso della<br />
Dalmazia questa moneta alla quale egli stimò poter assegnare<br />
il nome ed il valore <strong>di</strong> un tornese, la quale specie <strong>di</strong> moneta<br />
viene da lui più avanti (") determinata pari a quattro ba-<br />
(9) Zanetti, Nuova Raccolta delle monete d' Italia, Tomo IV, p. 157.<br />
(io) Lazari, Monete dei Posse<strong>di</strong>menti Veneziani, pag. 11.<br />
(11) Idem, pag, 68.
MISCELLANEA NUMISMATICA 9I<br />
gattini, ovvero alla terza parte del soldo. La <strong>com</strong>parsa <strong>di</strong><br />
quattro esemplari della moneta Dalmatiae nel nostro teso-<br />
retto, nel quale primeggiavano per numero le monete del<br />
doge Michele Steno (1410-1413), viene ottimamente in appoggio<br />
dell'argomentazione del Lazari, che tale moneta sia<br />
stata battuta nel tempo <strong>di</strong> quel doge. Non così posso con-<br />
venire con lui sul valore per cui tale moneta sia stata emessa.<br />
Ma se la sua deduzione riuscì, a mio vedere, su questo punto<br />
meno esatta, devesi <strong>di</strong> ciò accagionare unicamente la meno<br />
che me<strong>di</strong>ocre conservazione dell' unico esemplare eh' egli<br />
potè esaminare <strong>di</strong> questo cimelio della veneta <strong>numismatica</strong>.<br />
Tutti quattro gli esemplari in <strong>di</strong>scorso, anziché mostrare<br />
la lega bassa dei tornesi battuti per il Levante, apparivano<br />
fatti <strong>di</strong> un argento <strong>di</strong> poco inferiore a quello dei sol<strong>di</strong>ni <strong>di</strong><br />
Michele Steno, ed il peso riscontrato in essi era <strong>di</strong> grammi<br />
0,650; 0,720; 0,780; 0,840; e però circa il doppio <strong>di</strong> quello<br />
dei predetti sol<strong>di</strong>ni, che in molti ottimi esemplari trovai co-<br />
stantemente <strong>di</strong> grammi 0,410. Da ciò credo poter dedurre<br />
che tale moneta sia stata emessa per il valore <strong>di</strong> un mezza-<br />
nino <strong>di</strong> grosso, ovvero per due sol<strong>di</strong>, ed il vedere <strong>com</strong>e più<br />
tar<strong>di</strong> la monetazione da due sol<strong>di</strong> o gazzetta fu spesse volte<br />
realizzata nelle monete destinate ad aver corso nella Dalmazia,<br />
mi conferma maggiormente in questo pensamento.<br />
In altro errore, meno facile a giustificare, incorse il<br />
Lazari a proposito dello scudo raffigurato sulla moneta<br />
Dalmatiae , il quale presentogli ardua ed insormontabile<br />
<strong>di</strong>fficoltà. Parendogli scorgere in esso l'arme dei Contarini,<br />
e non sapendo a quale personaggio <strong>di</strong> questa famiglia potesse<br />
attribuirsi, immaginò, ma senza averne molta persuasione<br />
egli stesso, che tale moneta fossesi da prima battuta sotto<br />
la ducea <strong>di</strong> Andrea Contarini (1368- 1382), e che rinnovan-<br />
dosene la battitura nel 1410, si conservasse il vecchio tipo.<br />
Come mai a quell'occhio cotanto sicuro potè apparire quello<br />
scudo spartito in rombi verticalmente <strong>di</strong>sposti, se già in quel<br />
poco felice <strong>di</strong>segno del suo libro eseguito da un logoro<br />
esemplare, scorgesi <strong>di</strong>stintamente lo scudo caricato <strong>di</strong> una<br />
banda scaccheggiata a tre or<strong>di</strong>ni? Di più, <strong>com</strong>e potè egli<br />
affermare che l' arme dei Contarini fosse rombeggiata, se<br />
nessuna fra le tante armi che portavano i vari rami <strong>di</strong> quel
92<br />
CARLO KUNZ<br />
casato, quali vedonsi nelle opere del Coronelli, del Frescot<br />
e d'altri, è <strong>di</strong> tale foggia?<br />
Ma anche tali abbagli <strong>di</strong>ventano perdonabili per chi sa<br />
quanto tempo e fatiche esigano i lavori positivi della scienza,<br />
e per chi conosce la genesi <strong>di</strong> quel libro, fatto per una spe-<br />
ciale circostanza, nel brevissimo tempo <strong>di</strong> poche settimane,<br />
esclusa ogni possibilità <strong>di</strong> revisioni e <strong>di</strong> correzioni.<br />
h' arme raffigurata sul mezzanino <strong>di</strong> Dalmazia, non è<br />
adunque quella dei Contarini, ma piuttosto <strong>di</strong> una delle due<br />
famiglie Surian, cioè d'oro, con una banda a tre or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong><br />
scacchi, d' argento e <strong>di</strong> negro. Ciò erasi <strong>di</strong> già avvertito<br />
nell'opera che porta il titolo: Storta dei dogi <strong>di</strong> Venezia, e<br />
viene in conferma dell'assioma, non esservi libro tanto cattivo<br />
che non contenga alcuna buona cosa.<br />
Restami ancora a rilevare la singolarità <strong>di</strong> uno dei quattro<br />
esemplari rinvenuti <strong>di</strong> tale moneta, il quale offeriva lo sbaglio<br />
dell'arme <strong>di</strong>segnata a rovescio, per cui la banda scaccheg-<br />
giata in essa fu convertita in sbarra. Le figure 7 ed 8 della<br />
tavola mostrano entrambe le varietà.<br />
Sciolta una parte della non insormontabile <strong>di</strong>fficoltà,<br />
rimane l'altra, eh' è quella <strong>di</strong> sapere quale fosse il Surian<br />
ch'ebbe autorità <strong>di</strong> tramandare la sua insegna sulla nostra<br />
moneta, sic<strong>com</strong>e investito <strong>di</strong> offici dal governo della Repubblica<br />
in cose della Dalmazia. Chiarire questo punto non<br />
dovrebbe essere più arduo per quelU che hanno la pratica<br />
<strong>di</strong> così fatti stu<strong>di</strong> e possono con agevolezza consultare le<br />
memorie che serbano gli archivi <strong>di</strong> Venezia.
MISCELLANEA NUMISMATICA 93<br />
IV.<br />
SESINO Di MESSERANO<br />
contraffatto allo stampo veneziano.<br />
Ovvia e notissima moneta veneziana è lo sesino, il quale,<br />
<strong>com</strong>e <strong>di</strong>nota il nome, ebbe valore pari a 6 bagattini o a due<br />
quattrini. Introdotto per la prima volta nell'anno 1545, sotto<br />
il dogado <strong>di</strong> Francesco Dona continuò a battersi dai susse-<br />
guenti dogi, escluso Marcantonio Trevisan, fino all'anno 1603,<br />
in cui sotto il doge Marino Grimani, ne cessò la fabbricazione<br />
e si bandì dagli Stati della Repubblica, per le innumerevoli<br />
contraffazioni ch'eransi introdotte dall'estero.<br />
Codeste contraffazioni, che in passato collocavansi quali<br />
varietà fra le monete venete, <strong>di</strong>vennero al nostro tempo<br />
oggetto <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o speciale, ed a ragione, poiché per esse<br />
viene a spargersi molta luce in altri rami della <strong>numismatica</strong>.<br />
Che se da una parte, colla piij giusta loro attribuzione, la<br />
serie veneta perde cose che credeva proprie, se ne avvan-<br />
taggiano altre minori ma interessanti zecche.<br />
Il carattere pila saliente <strong>di</strong> cotali adulterazioni è la qualità<br />
del metallo, poiché invece <strong>di</strong> essere formate <strong>di</strong> lega, <strong>com</strong>e<br />
i veri sesini veneziani, sono esse <strong>di</strong> schietto rame.<br />
Le contraffazioni del sesino veneto, fino ad ora cono-<br />
sciute, possono <strong>di</strong>vidersi nelle seguenti categorie:<br />
1. Imitazioni uscite da un gruppo <strong>di</strong> zecche minori<br />
del Piemonte, fra le quali v' hanno numerose varietà <strong>di</strong><br />
Frinco, ed alcune poche <strong>di</strong> Passerano e <strong>di</strong> Messerano. Non<br />
è inverosimile che col tempo se ne scoprano altre <strong>di</strong> qualche<br />
zecca poco <strong>di</strong>scosta da quelle.<br />
2. Numerose varietà <strong>di</strong> coni, i quali, se nelle leggende<br />
e nei simboli nulla offrono che li <strong>di</strong>stingua a primo aspetto<br />
dai ducali, si palesano per adulterazioni allo schietto rame<br />
onde sono formati ed al peso quasi sempre <strong>di</strong> molto inferiore<br />
al normale, che nei genuini <strong>di</strong> buona conservazione oltrepassa<br />
i grammi 1,500. Sono il più spesso <strong>di</strong> una eleganza <strong>di</strong> lavoro<br />
che palesa la mano <strong>di</strong> artefici italiani, né <strong>di</strong>spero che col
94<br />
CARLO KUNZ<br />
tempo, coir aiuto <strong>di</strong> quei confronti dei quali tanto si giova<br />
lo stu<strong>di</strong>o dalle antiche monete, possa trovarsi la nicchia per<br />
molti <strong>di</strong> essi in taluna delie minori zecche d'Italia. Che se<br />
alla correzione delle leggende, ed al peso più vicino al legale,<br />
accoppiano una rimarchevole rozzezza <strong>di</strong> lavoro, allora sono da<br />
ritenersi quali prodotti <strong>di</strong> volgari falsari, operanti alla macchia.<br />
3. Abbondevoli sono pure certe contraffazioni <strong>di</strong> fab-<br />
brica barbara e con leggende scorrette, dalle quali a stento<br />
si ricava il nome del doge, eh' è il più sovente quello <strong>di</strong><br />
Lorenzo Friuli. La provenienza levantina <strong>di</strong> esse, e 1' uso<br />
frequente della delta ^ in luogo delle lettere latine a e v,<br />
offrono argomento <strong>di</strong> crederle fabbricate da maldestri falsi-<br />
ficatori sopra qualche scoglio dell'Arcipelago greco.<br />
4. Pongo ultime due contraffazioni, le quali si <strong>di</strong>stinguono<br />
essenzialmente da tutte le altre per le loro iscrizioni.<br />
La prima offre dal lato della croce il nome: Domenico. tiberti,<br />
e intorno al leone del rovescio quello <strong>di</strong> Francesco . tiberti;<br />
r altra ripete quest' ultimo nome su ambo i lati. Chi erano<br />
codesti due consanguinei, e dove furono lavorate queste<br />
imitazioni? Ogni mio scrutinare in proposito riuscì fino ad<br />
ora indarno, ed è perciò che rac<strong>com</strong>ando caldamente questi<br />
misteriosi incogniti alle menti acute ed agli amatori delle cose<br />
ardue e bizzarre. Aggiungerò, che forse potrà giovare, il<br />
lavoro rozzo e stentato <strong>di</strong> questi mendaci sesini offerire<br />
qualche analogia con quelli accennati nella precedente categoria,<br />
ed il peso essere superiore al normale nel primo<br />
esemplare, <strong>di</strong> poco inferiore nel secondo (12).<br />
Fra le varie vicende delle contraffazioni dello sesino<br />
veneto merita essere ricordata la seguente. Girolamo Molin<br />
che fu Rettore <strong>di</strong> Cattaro per la Repubblica Veneta dall'anno<br />
1610 al 1612, e poi nuovamente fra il 1634 ed il 1636, si<br />
servì <strong>di</strong> cotali falsi sesini per improntare i follari segnati<br />
colla sua arme e colle sue iniziali. Ciò apparisce chiaramente<br />
(12) Codesti sesini coi nomi dei Tiberti sono menzionati anche<br />
dall'esimio sig. Comm. D. Promis nell' ultima lodatissima sua pubblica-<br />
zione col titolo : Monete ine<strong>di</strong>te del Piemonte. Torino, 1866, collo stesso<br />
fine <strong>di</strong> eccitare i raccoglitori a stu<strong>di</strong>arli. Onde giovare quanto è da me<br />
a tale intento, coglierò la prima occasione che mi si presenti per <strong>di</strong>vul-<br />
gare le loro immagini.
MISCELLANEA NUMISMATICA 95<br />
per molti esemplari <strong>di</strong> tale moneta, nei quali il conio nuovo<br />
<strong>di</strong> Cattaro non bastò a cancellare le traccia precedenti del<br />
sesino: e che qui si tratti <strong>di</strong> sesini falsi e non dei genuini è<br />
prova lo schietto rame onde sono formati cotali pezzi. Non<br />
potendosi ammettere che il Rettore <strong>di</strong> Cattaro abbia operato<br />
in tale guisa senza il consenso del governo dal quale era<br />
investito, è giocoforza supporre che la Repubblica, effettuando<br />
il bando dei sesini nell'anno 1603, or<strong>di</strong>nasse una separazione<br />
dei buoni dai cattivi, e cedesse questi al Molin acciò se ne<br />
servisse per improntare le monete onde abbisoghava la pro-<br />
vincia da lui governata. Ebbe luogo adunque una vera riabili-<br />
tazione per questi poveri condannati, i quali, sotto la guaren-<br />
tigia <strong>di</strong> due sacre immagini poterono nuovamente arrischiarsi<br />
nel consorzio degli onesti. In questa vicenda, che <strong>di</strong>rò drammatica,<br />
dei falsi sesini, avvi un insegnamento morale, imperocché<br />
non sono essi <strong>di</strong>ssimili da certi messeri i quali, per quanto<br />
facciano, non arrivano a cancellare la loro colpevole origine<br />
sotto gli orpelli coi quali tentano confondere l'altrui giu<strong>di</strong>zio.<br />
Fra le numerose contraffazioni <strong>di</strong> tal genere, avvene una<br />
nella quale le solite rappresentazioni della croce pomata o<br />
pisana e del leone in soldo, sono ac<strong>com</strong>pagnate dalla leg-<br />
genda: NON NOBIS DOMINE SED — NOMINI TVO DA GLORIAM,<br />
<strong>di</strong>visa sui due lati. Usai da lungo tempo <strong>di</strong> collocare codesta<br />
imitazione fra le monete <strong>di</strong> Messerano, perchè il motto: Non<br />
nobis domine^ non nobis^ sed nomini tuo da gloriam, era<br />
particolare ai Ferrerò <strong>di</strong> Biella che redarono il principato <strong>di</strong><br />
Messerano dai Fieschi <strong>di</strong> Genova, ac<strong>com</strong>pagna la loro arme<br />
e leggesi in molte monete <strong>di</strong> essi. Restai perplesso vedendo<br />
che due illustri autori, in recenti pubblicazioni, abbiano asse-<br />
gnato questo sesino alla zecca <strong>di</strong> Frinco (13). Cresce peso<br />
a questa opinione la circostanza che nella varietà recata dal<br />
sign. Morel-Fatio, il libro, ovvero scudo, che stringe fra le<br />
branche il leone, vedesi caricato <strong>di</strong> tre mazze poste in palo.<br />
Ben lontano da me il pensiero <strong>di</strong> voler porre in dubbio<br />
l'esattezza <strong>di</strong> quel dettaglio, il quale, essendo tale, dà piena<br />
(13) Promis, Monete dei Ra<strong>di</strong>cati e dei Mazzetti. — Morel-Fatio,<br />
Monnaies iné<strong>di</strong>tes de Frinco. — Revue Numismatique^ N. S. T. X. (1865),<br />
pag. 269-284.
^6<br />
CARLO KUNZ<br />
ragione per l'attribuzione <strong>di</strong> quel sesino alla zecca dei Maz-<br />
zetti, mi faccio lecito <strong>di</strong> produrre qui altro consimile, il quale<br />
mostra lo scudetto attraversato obbliquamente da tre semplici<br />
linee (Numero io della tavola). Ora, se si riflette che l'arme<br />
de' Fieschi, la quale entrò a <strong>com</strong>porre quella dei Ferrerò<br />
signori <strong>di</strong> Messerano, quasi simbolo <strong>di</strong> questa città o dell'in-<br />
tiero Marchesato, era uno scudo d' argento caricato <strong>di</strong> tre<br />
bande d'azzurro, il presente nostro sesino viene a qualificarsi<br />
da se stesso e colla massima evidenza per un prodotto della<br />
zecca <strong>di</strong> Messerano. Vero è bensì che l'aspetto dell'accennato<br />
scudetto non corrisponde perfettamente all'arme dei Fieschi,<br />
perchè invece <strong>di</strong> tre bande mostra tre sbarre,, ma sono d'avviso<br />
che ciò debba riporsi unicamente a carico dell'incisore del<br />
conio, e che qui si ripeta uno sbaglio consimile a quello già<br />
osservato in un esemplare del mezzanino <strong>di</strong> Dalmazia.<br />
Da questo fatto stimo ora poter avere conferma l'attribuzione<br />
a Messerano <strong>di</strong> tutti i sesini col motto: Non nobis<br />
domine sed nomini tuo da gloriam, con riserva per la varietà<br />
palesata dal chiarissimo signor Morel-Fatio, la quale reste-<br />
rebbe alla serie numerosa dei sesini <strong>di</strong> Frinco.<br />
Che in Messerano si contraffacessero monete veneziane<br />
è provato da or<strong>di</strong>ne trasmesso al residente veneto in Milano,<br />
in seguito a decreto del Senato <strong>di</strong> data 3 marzo 167 1, affinchè<br />
movesse lagni che li zecchieri <strong>di</strong> Casale passavano a Messerano<br />
e nelle zecche delle Langhe (Tassarolo, Ronco e Mor-<br />
zasco) per battervi zecchini ed altre monete adulterate. Ciò<br />
risulta dalle Deliberazioni del Senato {secrete), <strong>di</strong> quell'anno,<br />
conservate nel R. Archivio ai Frari, e sono debitore <strong>di</strong> tale<br />
notizia al chiarissimo signor cav. Nicolò Barozzi, mentissimo<br />
<strong>di</strong>rettore della Civica Raccolta Correr. Qui si tratterebbe<br />
bensì <strong>di</strong> epoca posteriore a quella dei sesini, ma è molto<br />
probabile che quello non sia stato il primo caso <strong>di</strong> adultera-<br />
zioni <strong>di</strong> monete venete eseguite nella zecca <strong>di</strong> Messerano.<br />
Quanto all'epoca in cui furono battuti i sesini <strong>di</strong> Messerano,<br />
credo non <strong>di</strong>scostarmi troppo dal vero, fissandola al tempo<br />
del principe Francesco Filiberto Ferrerò, il quale fu contempo-<br />
raneo dei dogi Pasquale Cicogna e Marino Grimano, che ultimi<br />
improntarono legalmente col proprio nome cotale moneta.
MISCELLANEA NUMISMATICA<br />
V.<br />
DI QUALCHE MONETA OSSIDIONALE.<br />
Il brano già menzionato <strong>di</strong> opera ine<strong>di</strong>ta sulle monete<br />
Franco-Italiche ossi<strong>di</strong>onali, che il chiarissimo signor cav. C.<br />
Morbio inseriva nella <strong>Rivista</strong> della Numismatica, contiene<br />
preziose notizie sull'argomento e porge nuova testimonianza<br />
della molta eru<strong>di</strong>zione storica dell'autore non meno che del<br />
tesoro <strong>di</strong> monete d' Italia adunato nei suoi medaglieri. Ma,<br />
<strong>com</strong>e avviene quasi sempre in lavori <strong>di</strong> tal fatta, non tutte<br />
registrò egli, nelle serie esposte, le monete ossi<strong>di</strong>onali del-<br />
l'alta Italia e della Dalmazia, e però nutro fiducia che la sua<br />
ben nota cortesia non sarà per mancarmi se oso accennare<br />
qui alcuna sua omissione.<br />
Fra le monete <strong>di</strong> Mantova, oltre lo scudo, o piuttosto<br />
ducato, che tale lo <strong>com</strong>prova il suo peso, che offre l'imma-<br />
gine del Santo Andrea, evvi anche il mezzo, simile in tutto<br />
a quello, fuorché nella proporzione <strong>di</strong> peso e <strong>di</strong> modulo.<br />
Un esemplare <strong>di</strong> esso conservasi nella raccolta municipale<br />
<strong>di</strong> Mantova, formata per cura <strong>di</strong> quell'egregio signor conte<br />
Francesco Beffa-Negrini. Prototipo <strong>di</strong> tale ducato <strong>di</strong> basso<br />
argento deve essere stato il consimile <strong>di</strong> argento fino che<br />
neir esergo del primo lato offre il solo nome della città :<br />
MANTv^. E <strong>di</strong> questo pure esiste la metà, e l'unico esemplare<br />
a me noto <strong>di</strong> così bella e rara moneta serbasi nella cospicua<br />
raccolta <strong>numismatica</strong> che l'egregio signor cav. Nicolò Bottacin<br />
munificentemente donava testé alla città <strong>di</strong> Padova.<br />
Lo stesso posso anche affermare per lo scudo dal mira-<br />
sole, del quale evvi parimente la metà, che là, dove l'intiero<br />
porta iscritto il numero i6o, offre invece il numero 80, l'uno<br />
e l'altro esprimenti la quantità dei sol<strong>di</strong> ond'erano <strong>com</strong>posti<br />
tali pezzi. Di questo mezzo scudo, che fu già segnalato dal<br />
catalogo Reichel, esiste pure un esemplare nella menzionata<br />
raccolta padovana, contrad<strong>di</strong>stinto dal millesimo 1629. E<br />
poiché tali pezzi sono plasmati <strong>di</strong> buon argento, e dello<br />
13<br />
97
98<br />
CARLO KUNZ<br />
scudo intiero esistono almeno tre varietà, cogli anni 1628,<br />
1629 e 1630, dubito che possano ascriversi alle categorie<br />
delle monete battute per necessità.<br />
A <strong>com</strong>pletamento <strong>di</strong> quanto il benemerito autore espose<br />
sulla moneta del blocco <strong>di</strong> Venezia dell' anno 1813, siami<br />
lecito aggiungere quanto segue:<br />
Nel Giornale <strong>di</strong> quanto è accaduto in Venezia durante<br />
l'asse<strong>di</strong>o 1813-1814, alla data del 20 gennaio 1814 leggesi:<br />
" La Commissione tem{)oraria <strong>di</strong> finanza, attesa la scarsezza<br />
" <strong>di</strong> numerario, ha creduto bene <strong>di</strong> determinare che venisse<br />
" coniata e posta in corso una moneta <strong>di</strong> blocco, per l'am-<br />
" montare <strong>di</strong> un solo milione,<br />
" Questa misura reclamata dalie circostanze e dalla<br />
" prudenza, fu approvata anche dal signor Comandante<br />
" Superiore e ne furono or<strong>di</strong>nati alla zecca i punzoni. Cinque<br />
" devono essere le monete ; da<br />
una parte avranno l' in<strong>di</strong>ca-<br />
" zione del loro valore e dall' altra l' iscrizione : Blocco<br />
" Venezia: da L. 1,60; da Cent. 80; 40; 20 e io,<br />
<strong>di</strong><br />
" Li punzoni già ultimati esistono presso la Commissione<br />
" suddetta, e si crede che a momenti nella zecca si darà<br />
" mano all'opera, a meno che il suddetto signor Comandante<br />
" non cangi opinione. „<br />
Nella stessa cronaca, al giorno 22 gennaio dello stesso<br />
anno, trovasi poi quanto segue : " Nel Giornale Dipartimen-<br />
" tale <strong>di</strong> questa città oggi pubblicato si legge, che il Comando<br />
" Superiore, onde togliere i timori sulla fabbricazione <strong>di</strong><br />
" moneta <strong>di</strong> blocco e <strong>di</strong> carta monetata, che si erano prò-<br />
" pagati fino in Ancona, previene il pubblico, essere asso-<br />
" lutamente false siffatte voci, ed essere ferma sua volontà<br />
" che non abbia luogo né carta monetata, né moneta <strong>di</strong><br />
" blocco, e che inoltre tutti quelli che importeranno viveri,<br />
" troveranno protezione e buona accoglienza e ne riceve-<br />
" ranno subito il pagamento in buone valute. „<br />
Erano stati approntati i punzoni per le cinque monete,<br />
ma <strong>di</strong> una sola, della maggiore, furono fatti i coni, e <strong>di</strong> essa<br />
un solo esemplare in argento, <strong>com</strong>e doveva avere effetto,<br />
era a mia cognizione, quello che serbasi nel Regio Gabinetto<br />
<strong>di</strong> Brera in Milano, donatovi dal barone Galvagna, allora<br />
prefetto dell'Adriatico, Dai coni, che ora si conservano a
MISCELLANEA NUMISMATICA 99<br />
Vienna, furono fatte in tempo posteriore alcune prove in<br />
piombo o col metodo della galvanoplastica, che possono<br />
vedersi nelle raccolte. Il signor cav. Morbio afferma <strong>di</strong> pos-<br />
sedere cotale rarissimo pezzo in argento e della stessa pro-<br />
venienza <strong>di</strong> quello del Gabinetto <strong>di</strong> Brera, e ce ne congra-<br />
tuliamo sinceramente. Ai leggitori che non avessero sott'oc-<br />
chio la <strong>Rivista</strong> della Numismatica, non sarà <strong>di</strong>scaro <strong>di</strong> vedere<br />
al numero ii della tavola una fedele immagine <strong>di</strong> codesto<br />
interessante progetto.<br />
Oltre le monete da cinque franchi e da un franco, fuse<br />
in Cattare, durante l'asse<strong>di</strong>o dell'anno 1813, esiste quella da<br />
<strong>di</strong>eci franchi, più rara bensì <strong>di</strong> quelle, ma già prodotta nella<br />
Storia metallica della Rivoluzione francese del Millin ed in altre<br />
opere. Cotale doppio scudo non <strong>di</strong>versifica dallo scudo sem-<br />
plice che nelle proporzioni <strong>di</strong> peso e <strong>di</strong> modulo e nelle note<br />
del valore e del peso inscrittevi.<br />
Pongo fine a questa <strong>di</strong>gressione rivelando una moneta<br />
la quale, se restò ignota al chiarissimo signor cav. Morbio,<br />
sfuggì del pari alle ricerche dei molti egregi autori che usarono<br />
la loro <strong>di</strong>ligenza a raccogliere ed illustrare le monete del<br />
tempo a noi piìi vicino. Povero n'è il concetto e rozzo il<br />
lavoro, ma interessante riesce per le circostanze in cui emerse,<br />
e merita se ne conservi memoria, <strong>di</strong> preferenza alla maggior<br />
parte dei gretti e monotoni prodotti delle zecche moderne.<br />
È questo un pezzo da 25 centesimi, <strong>di</strong> necessità, operato<br />
nell'anno 1814 entro la fortezza asse<strong>di</strong>ata <strong>di</strong> Palma Nuova.<br />
È consimile al notissimo pezzo da 50 centesimi emesso ivi<br />
nella stessa occasione, e l'immagine che può vedersene al<br />
numero 12 della tavola mi <strong>di</strong>spensa dal farne la descrizione.<br />
11 solo esemplare venuto a mia cognizione è posseduto<br />
dall'egregio sig. professore Gian Battista Dal Negro <strong>di</strong> U<strong>di</strong>ne,<br />
possessore <strong>di</strong> belle raccolte scientifiche e <strong>di</strong>stinto per rara<br />
eru<strong>di</strong>zione non meno che per singolare affabilità e modestia. Di<br />
bassa lega <strong>com</strong>e il pezzo maggiore, pesa grammi 9,650. È pro-<br />
babile che la emissione <strong>di</strong> tale moneta non abbia avuto luogo,<br />
ma sia rimasta allo sta<strong>di</strong>o <strong>di</strong> progetto, per esserne cessato<br />
poco appresso il bisogno che ne faceva decretare lo stampo.<br />
Venezia nelV aprile del 1866.
ILLUSTRAZIONE<br />
DI UNA MONETA INEDITA DI FABRIANO (i)<br />
Lettera a A. R. Caucich.<br />
Poiché Ella si è de<strong>di</strong>cata con tanto fervore allo stu<strong>di</strong>o<br />
delle antiche monete, devo ritenerla adorna <strong>di</strong> quella abne-<br />
gazione e <strong>di</strong> quella gentilezza che non vanno mai <strong>di</strong>sgiunte<br />
dal sincero amore per la scienza, ed è perciò che fommi<br />
lecito <strong>di</strong> esporle un mio pensiero sulla moneta <strong>di</strong> Fabriano<br />
del Car<strong>di</strong>nale Giuliano de' Me<strong>di</strong>ci da Lei <strong>di</strong>chiarata nell'ultimo<br />
numero del Bullettino <strong>di</strong> Numismatica Italiana, <strong>di</strong>etro <strong>di</strong>segno<br />
inviatole dall' 111."'° sig. Cav. Gaetano De-Minicis.<br />
Né mi accusi <strong>di</strong> andare in traccia del pelo nell' uovo<br />
imperocché non evvi cosa priva d'importanza nell'or<strong>di</strong>ne dei<br />
fatti scientifici, che senza analisi non può esservi sintesi e<br />
senza le più minuziose osservazioni lo scibile umano non<br />
sarebbe al punto in cui si trova. Una linea <strong>di</strong> più o <strong>di</strong> meno od<br />
in <strong>di</strong>versa giacitura nello spettro progettato del prisma rivela<br />
nuovi o <strong>di</strong>fferenti elementi nella sostanza in <strong>com</strong>bustione, e<br />
forse quelle linee, dapprima tenute in nessun conto, servi-<br />
ranno col tempo a palesare al paziente indagatore la natura<br />
<strong>di</strong> corpi mon<strong>di</strong>ali slanciati a <strong>di</strong>stanze in<strong>com</strong>mensurabili.<br />
Ma, scendendo a cose più modeste, ecco <strong>di</strong> che si tratta.<br />
Avendo io pure già posseduto in doppio esemplare la mo-<br />
netina da Lei pubblicata, ne trassi un <strong>di</strong>segno che tuttora<br />
conservo, e del quale le mando esatto fac-simile. Ora, con-<br />
(i) Quest' articoletto fu pubblicato nel Bullettino <strong>di</strong> Numismatica<br />
Italiana <strong>di</strong> Firenze. Anno II, 1868, N. 3, pag. 18-20. (Nota della Direzione).<br />
,
I02 CARLO KUNZ<br />
frontando tale <strong>di</strong>segno con quello da Lei riportato, vi scorgo<br />
fra l'uno e l'altro notabile <strong>di</strong>vario nella rappresentazione che<br />
occupa il campo del secondo lato <strong>di</strong> essi, abbenchè a me<br />
sembri che in ambo i casi trattisi <strong>di</strong> una stessa moneta. Chi<br />
fece quel suo <strong>di</strong>segno vide nell'oggetto in questione l'incude<br />
col sovrastante martello, arme della città <strong>di</strong> Fabriano, ma<br />
temo che la non perfetta conservazione <strong>di</strong> quel pezzo e la<br />
rimembranza d'altra moneta riportata dal Ramelli, sulla quale<br />
<strong>com</strong>pariscono quei simboli, abbiangli fatto prendere abbaglio.<br />
Sovra gli esemplari da me osservati stava altra cosa,<br />
cioè un e<strong>di</strong>fizio. A prima vista sospettai potesse desso per<br />
avventura raffigurare il forte castello <strong>di</strong> quella città, ma,<br />
notando le varie parti ond' era costituito, abbandonai tosto<br />
cotale idea. Ed infatti , quel tetto acuminato , quella linea<br />
orizzontale interme<strong>di</strong>a e quegli archi sottoposti, <strong>di</strong>mostrano<br />
trattarsi qui d'altra specie <strong>di</strong> costruzione, più umile e posta<br />
in basso loco, a livello <strong>di</strong> un piano. Notato ciò, non era<br />
<strong>di</strong>fficile immaginare <strong>com</strong>e quel <strong>com</strong>plesso avesse per iscopo<br />
<strong>di</strong> rappresentare o simboleggiare un molino o fabbrica <strong>di</strong><br />
carta, e parmi rispondano mirabilmente a tale concetto la<br />
forma semplice dell'e<strong>di</strong>fizio, gli archi sul quale s'erge, i quali<br />
sarebbero le vòlte del canale per entro al quale scorre l'acqua,<br />
alimento in<strong>di</strong>spensabile <strong>di</strong> siffatti opifici, e perfino l'oggetto<br />
ricurvo sporgente dal destro lato del casamento, nel quale<br />
sono <strong>di</strong>sposto a ravvisare la ruota che trasmette l'impulso<br />
agli interni congegni della officina.<br />
E noto il vanto che gode la città <strong>di</strong> Fabriano <strong>di</strong> essere,<br />
se non la prima, <strong>com</strong>e vorrebbero il Tiraboschi ed altri,<br />
perchè la Spagna potrebbe forse contestarle tale primato,<br />
al certo fra le primissime che abbia introdotto la preziosa<br />
industria della fabbricazione della carta <strong>di</strong> stracci <strong>di</strong> lino,<br />
avendosi documenti della fine del secolo XIII che lo <strong>com</strong>pro-<br />
vano. E notissimo altresì quanto codesta industria vi abbia<br />
dappoi sempre prosperato, favorita mirabilmente dalle felici<br />
<strong>di</strong>sposizioni dei suoi abitanti, dall'aria saluberrima e dall'acqua<br />
perenne del fiume Giano che l'attraversa, e <strong>com</strong>e fino al dì<br />
d' oggi le sue fabbriche <strong>di</strong> carta si mantengano floride, e<br />
conservino l' antica tra<strong>di</strong>zionale loro fama, in onta ai tanti<br />
nuovi trovati dell'industria. Così essendo, a nessuno sembrerà
ILLUSTRAZIONE DI UNA MONETA INEDITA DI FABRIANO I03<br />
per avventura strano od inverosimile che sovra una delle sue<br />
monete abbiasi voluto serbare ricordo <strong>di</strong> sì bella prerogativa.<br />
Se mi <strong>di</strong>lungassi più a lungo su tale proposito abuserei<br />
gravemente della sua <strong>com</strong>piacenza e però faccio punto, ba-<br />
standomi <strong>di</strong> avervi richiamata la sua attenzione, ed aggiun-<br />
gerò soltanto che, dei due esemplari <strong>di</strong> cotale piccolo già da<br />
me posseduti, uno, il meglio conservato, pesava <strong>com</strong>e il suo,<br />
milligrammi 550, e 1' altro, alquanto logoro, non arrivava a<br />
m. 500. In entrambi poi lessi chiaramente: ivl. car. me<strong>di</strong>cee.<br />
anziché me<strong>di</strong>ces, per cui, piuttosto che errore, potrebbe rite-<br />
nersi in quella finale b (2) adombrato il coniatore od il massaro<br />
della zecca.<br />
Ma poiché Ella fu sì cortese da leggere questa tiritera,<br />
vuole concedermi eh' io aggiunga altra breve osservazione,<br />
pur restando entro i limiti della zecca fabrianese? Sì? Ebbene,<br />
eccola. Io sono d'avviso che il quattrino del Car<strong>di</strong>nale Giuliano<br />
de' Me<strong>di</strong>ci, riportato dal Ramelli, sia identico a quello ch'Ella<br />
inseriva s.otto il n. 4 della ristampa della sua memoria, quale<br />
una varietà nuova <strong>di</strong> esso. L' esemplare veduto dal Ramelli<br />
era in parte logoro, <strong>com</strong>e prova la lacuna della scritta alla<br />
destra del Santo, e quella corrosione impe<strong>di</strong>vagli senza dubbio<br />
<strong>di</strong> ravvisare ciò che vi fosse da quello stesso lato fra il Santo e<br />
la leggenda. Un più integro esemplare palesò a Lei in quel sito<br />
l'incu<strong>di</strong>ne, arme e simbolo parlante <strong>di</strong> Fabriano; con ciò Ella<br />
pose in sodo per sempre quel quattrino e fece ottimamente.<br />
Mi creda con particolare stima<br />
Venezia, il dì 20 Marzo 1868.<br />
Suo Devotissimo<br />
Carlo Kunz.<br />
(2) Questa lettera è l'iniziale del nome dello zecchiere Niccolò<br />
Baldantonj <strong>di</strong> Gubbio. (Nota della Direzione del BuUettinó).
I04<br />
CARLO KUNZ<br />
Dietro osservazioni, che il sig. Caucich faceva, repli-<br />
cando alla riportata Lettera, il sig. Ktmz rispon-<br />
deva <strong>com</strong>e appresso:<br />
.... Nel tempo stesso eh' Ella non approvava tutte le<br />
ragioni contenute nella mia lettera del 20, dello scorso marzo<br />
sul piccolo <strong>di</strong> Fabriano dell'Illustre sig. Cav. De-Minicis, volle<br />
fare pure atto <strong>di</strong> somma cortesia accordandole un posticino<br />
nel prossimo numero del Bullettino, <strong>com</strong>e scorgo dalla bozza<br />
<strong>di</strong> stampa che si <strong>com</strong>piace mandarmi. Contemporaneamente<br />
Ella mi manda della stessa moneta un impronto, dal quale<br />
rilevo <strong>com</strong>e il mio scetticismo fosse infondato, imperocché<br />
gli è bene un ponte, un incu<strong>di</strong>ne ed un martello che costi-<br />
tuiscono l'assieme del suo rovescio. Le rendo grazie <strong>di</strong> tutto,<br />
e mi affretto <strong>di</strong> fare ammenda e <strong>di</strong> constatare formalmente<br />
l'esistenza <strong>di</strong> quel tipo, godendo anche <strong>di</strong> ciò, perchè così<br />
invece <strong>di</strong> una moneta nuova <strong>di</strong> Fabriano, possiamo annove-<br />
rarne due: ciò che non è senza importanza, trattandosi <strong>di</strong><br />
una zecca della quale avanzano sì scarsi prodotti. Molta<br />
parte <strong>di</strong> quella lettera non avrebbe ora più ragione <strong>di</strong> essere<br />
pubblicamente conosciuta; ma dacché il farvi i necessari<br />
mutamenti le recherebbe <strong>di</strong>sturbo e per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> tempo, mi<br />
rassegno, <strong>com</strong>e desidera, sia stampata <strong>com</strong>e sta, salvo il<br />
<strong>di</strong>ritto da parte sua <strong>di</strong> farvi i <strong>com</strong>menti che crederà all'uopo....
ANCORA UNA MONETA DI FABRIANO (^)<br />
Lettera a A. R. Caucich.<br />
Eccole un'altra pietruzza pel grande e<strong>di</strong>fizio della num-<br />
mografia <strong>italiana</strong> intorno al quale con vera <strong>com</strong>piacenza ve<strong>di</strong>amo<br />
accorrere sempre nuovi e valenti operai.<br />
Lo Scilla, descrivendo due quattrini <strong>di</strong> Fabriano, esten-<br />
denti da un lato l' arme me<strong>di</strong>cea colle sovrastanti insegne<br />
del dominio pontificio, e dall' altro l' immagine dell'apostolo<br />
San Pietro, fu d'avviso che si dovessero riferire a Leone X,<br />
per la somiglianza dell' intaglio con altre monete del detto<br />
ponteftcey e pari opinione espresse il Bellini, allorché, nella<br />
seconda sua <strong>di</strong>ssertazione' sulle monete d' Italia, produsse il<br />
<strong>di</strong>segno d'uno <strong>di</strong> siffatti quattrini. Il Ramelli, pur aderendo<br />
allo Scevolini che scrisse, Leone X, perdonando ai Fabria-<br />
nesi la loro ostilità, avere ad essi concesso <strong>di</strong> battere quat-<br />
trini e mezzi quattrini, sdegnò riconoscere negli anzidetti<br />
quattrini fregiati dell' arme me<strong>di</strong>cea la moneta <strong>di</strong> quel pon-<br />
tefice, ma stimò poter piuttosto assegnarli a Clemente VII,<br />
e, afììne <strong>di</strong> non lasciare affatto deserto Leone X, sentenziò,<br />
la moneta battuta al tempo <strong>di</strong> questi fosse il quattrino che<br />
al Santo Precursore collega il nome e l'arme del car<strong>di</strong>nale<br />
Giulio de' Me<strong>di</strong>ci, dallo zio preposto al governo della città<br />
<strong>di</strong> Fabriano dopo ch'essa ritornò all'ubbi<strong>di</strong>enza della Chiesa.<br />
L'opinione del Ramelli sembrò avvalorata dal fatto segnalato<br />
dall' istrumento <strong>di</strong> zecca del 7 maggio 1529, col quale venne<br />
imposto a Mastro Pierreale <strong>di</strong> battere quattrini che da un<br />
lato abbiano l'arme <strong>di</strong> Clemente VII, e dall'altro /* immagine<br />
(i) Fu pubblicato né[ Bullettino <strong>di</strong> Numismatica Italiana <strong>di</strong> Firenze.<br />
Anno II, 1868, N. 6, pag. 49-50 (Nota della Direzione).<br />
14
I06 CARLO KUNZ<br />
<strong>di</strong> S. Pietro, sennonché la moneta della quale ora le mando<br />
un fedele <strong>di</strong>segno, mostra che nel dare esecuzione ai capi-<br />
toli stipulati in quel contratto, non fu per essa osservata a<br />
puntino la citata prescrizione, giacché in cotesto indubitato<br />
quattrino <strong>di</strong> Clemente VII, non è già S, Pietro, ma bensì il<br />
Battista che ve<strong>di</strong>amo raffigurato, <strong>com</strong>e appunto nel quattrino<br />
<strong>di</strong> pili vecchia riconoscenza ch'egli fece improntare nel tempo<br />
in cui non era che car<strong>di</strong>nale e governatore <strong>di</strong> Fabriano. Né<br />
voglio perciò negare che altri ancora ne possano essere stati<br />
battuti al <strong>di</strong> lui nome, poscia che <strong>di</strong>venne Pontefice, colla<br />
effigie del Principe degli Apostoli, ma intanto l'esistenza <strong>di</strong><br />
codesto mi richiama alla mente l'opinione surriferita dello<br />
Scilla e del Bellini che giu<strong>di</strong>carono del tempo <strong>di</strong> Leone X, i<br />
quattrini anonimi coll'arme me<strong>di</strong>cea e l'immagine <strong>di</strong> S. Pietro<br />
e mi porta alla conclusione che quegli egregi possano bene<br />
avere còlto nel segno. S' é così, sarebbero essi <strong>di</strong> quei quat-<br />
trini prescritti nel breve pontificio del 1520, battuti sub ea<br />
liga qua in urbe romana cu<strong>di</strong>tur, né soltanto la lega, ma il<br />
tipo pure <strong>di</strong> quattrini romani <strong>di</strong> quel pontefice si sarebbe in<br />
essi mantenuto. E parmi anche vera la somiglianza dell'in-<br />
taglio con altre <strong>di</strong> lui monete, notata dallo Scilla, che con<br />
qualche evidenza potrei <strong>di</strong>mostrare se non temessi <strong>di</strong> abu-<br />
sare della Sua indulgenza.<br />
Ammesso ciò, avremmo ora quattro categorie <strong>di</strong> monete<br />
<strong>di</strong> Fabriano : il piccolo autonomo, il cui tempo dal solo <strong>di</strong>segno<br />
del Ramelli non é concesso poter determinare; i quattrini<br />
<strong>di</strong> Leone X; quelli <strong>di</strong> Giulio de' Me<strong>di</strong>ci car<strong>di</strong>nale, e finalmente<br />
il quattrino dello stesso dopo che assunse colla tiara il nome<br />
<strong>di</strong> Clemente VII.<br />
Questo fa parte della insigne raccolta <strong>di</strong> monete <strong>di</strong> zecche<br />
italiane posseduta dal nobile signor conte Nicolò Papadopoli,<br />
il quale, modello del vero gentiluomo, adorno delle piiì<br />
squisite doti dello spirito e del cuore, ed entusiasta per tutto
ANCORA UNA MONETA DI FABRIANO IO7<br />
ciò che all'arte, alla scienza, aironore dell'Italia si riferisce,<br />
acconsentì gentilmente ch'io ne facessi menzione quale una<br />
bella ed opportunissima aggiunta alle monete della zecca<br />
fabrianese.<br />
Mi creda con tutta la stima<br />
Venezia, 20 Settembre 1868.<br />
Suo dev.""" servo<br />
Carlo Kunz.
VARIETÀ<br />
Ven<strong>di</strong>ta della Collezione Sambon, — Da molti anni<br />
il Cav. Giulio Sambon attende con infinita cura a raccogliere<br />
le monete me<strong>di</strong>oevali dell'Italia meri<strong>di</strong>onale principalmente<br />
collo scopo <strong>di</strong> dare una illustrazione <strong>di</strong> quelle zecche poco<br />
stu<strong>di</strong>ate finora e quin<strong>di</strong> poco conosciute. Il lavoro illustrativo<br />
è ormai <strong>com</strong>piuto per opera del figlio Dott. Arturo Sambon<br />
e vedrà presto la luce, pubblicato per cura della Società<br />
Napoletana <strong>di</strong> Storia patria.<br />
Raggiunto con questo V intento principale della Colle-<br />
zione, questa sarà ora <strong>di</strong>spersa al pubblico incanto; e se ne<br />
in<strong>com</strong>incerà la ven<strong>di</strong>ta il 5 prossimo aprile in Milano presso<br />
r impresa <strong>di</strong> Ven<strong>di</strong>ta dello stesso Cav. Giulio Sambon.<br />
Iniziata nel 1865, la Collezione Sambon potè arricchirsi<br />
<strong>di</strong> quanto offrivano <strong>di</strong> interessante per la serie meri<strong>di</strong>onale<br />
le Collezioni Fusco, Tafuri, Spinelli, Rossi, Fasi, Boyne ed<br />
altre vendute da quell'epoca in poi, ed ora può considerarsi<br />
<strong>com</strong>e un insieme veramente prezioso per quanto riguarda le<br />
zecche napoletane, e <strong>com</strong>e la piii <strong>com</strong>pleta fin qui apparsa<br />
in ven<strong>di</strong>ta.<br />
Fra le maggiori rarità, ci basterà citare il Tari d'Amalfi<br />
dell' imperatrice Costanza e 1' altro <strong>di</strong> Enrico VI colla leggenda<br />
HENRicvs SEXTvs ROMANCI^ iMPERATOR : la moneta<br />
d'argento battuta ad Amalfi nel 1251. Fra le monete <strong>di</strong> Aquila,<br />
il mezzo carlino <strong>di</strong> Giovanna II, il carlino <strong>di</strong> Alfonso /, l'ar-<br />
mellino <strong>di</strong> Fer<strong>di</strong>nando I, ecc. Fra quelle <strong>di</strong> Benevento, il<br />
soldo e terzo <strong>di</strong> soldo, unici, <strong>di</strong> Luitprando colla madre<br />
Scauniperga, ecc. Fra quelle <strong>di</strong> Brin<strong>di</strong>si: i rarissimi multipli<br />
<strong>di</strong> Tari <strong>di</strong> Corrado, Manfredo e Carlo d'Anjou e i denari<br />
<strong>di</strong> Carlo III e Giovanna IL Di Capua, i follari <strong>di</strong> Pandolfo IV,<br />
<strong>di</strong> Riccardo, <strong>di</strong> Roberto II, ecc. Di Civitaducale, il bolognino
no VARIETÀ<br />
autonomo. Fra i follari <strong>di</strong> Gaeta, quelli del Duca Ruggiero,<br />
<strong>di</strong> Tancre<strong>di</strong>, colla testa <strong>di</strong> leone; <strong>di</strong> Enrico VI e Costanza<br />
con IMP. lAE . MAiESTA. Della pili alta importanza è il denaro<br />
battuto neirSSi a Oria da Gaideriso ex-principe <strong>di</strong> Benevento,<br />
in nome e sotto la protezione <strong>di</strong> Basilio, Leone e Alessandro,<br />
imperatori d' Oriente. Interessantissimo il carlino battuto a<br />
Lecce dal principe <strong>di</strong> Taranto, a nome <strong>di</strong> Renato d'Anjoii.<br />
Nella ricchissima serie napoletana, citeremo: i denari <strong>di</strong><br />
Basilio e Atanasio II: il follaro autonomo del 1137; il mezzo<br />
saluto d'oro <strong>di</strong> Carlo I d'Anjou; il carlino <strong>di</strong> Giovanna I e<br />
Luigi <strong>di</strong> Taranto e quello <strong>di</strong> Carlo III Durazzo; il mezzo<br />
carlino <strong>di</strong> La<strong>di</strong>slao e quello <strong>di</strong> Giovanna II; la doppia d'oro<br />
<strong>di</strong> Fer<strong>di</strong>nando I d'Aragona col busto; il ducato d'oro d'Al-<br />
fonso II col ritratto <strong>di</strong> suo padre; il ducato, il carlino <strong>di</strong><br />
Fer<strong>di</strong>nando II; il ducato d'oro <strong>di</strong> Lodovico XII <strong>di</strong> Francia;<br />
quello <strong>di</strong> Fer<strong>di</strong>nando il Cattolico e Isabella coniato a Napoli<br />
da Gia<strong>com</strong>o Tramontano nel 1503, unico; il mezzo scudo<br />
ossi<strong>di</strong>onale <strong>di</strong> Carlo V, battuto a Napoli nel 1528; il mezzo<br />
scudo e le sue frazioni dello stesso coll'aquila a due teste; il<br />
tari <strong>di</strong> Filippo III col ritratto <strong>di</strong> Margherita d'Austria; il<br />
mezzo ducato dello stesso e il suo ducato e mezzo ducato<br />
d'argento del 1617 col motto: qvod vis.; i <strong>di</strong>versi tipi del<br />
ducato e mezzo ducato d' argento <strong>di</strong> Filippo IV; la prova<br />
dello scudo d'argento del 1636 col motto potentes fvlminas<br />
HOSTEs; il tari coi busti accollati <strong>di</strong> Carlo II e <strong>di</strong> Maria<br />
Anna tutrice, unico. I tre rarissimi cavalli <strong>di</strong> Fer<strong>di</strong>nando /,<br />
battuti ad Amatrice. Fra le monete Siciliane {Messina e<br />
Palermo) noteremo il carlino <strong>di</strong> Alfonso I d'Aragona, <strong>di</strong><br />
tipo napoletano; il ducato d'oro <strong>di</strong> Giovanni II d'Aragona;<br />
il doppio reale <strong>di</strong> Fer<strong>di</strong>nando il Cattolico col suo ritratto; il<br />
mezzo ducato d'oro <strong>di</strong> Carlo V, pure col ritratto ; la doppia<br />
oncia d'oro <strong>di</strong> Carlo VI col motto : avstriacis ra<strong>di</strong>is clarior<br />
e la veduta della Sicilia, unico; il mezzo scudo palermitano<br />
^\ Filippo V col motto: fidelitas . felicitatis . omen e il 4<br />
tari con: clavso iani templo. Nella ricca serie <strong>di</strong> Salerno:<br />
il due tari d'oro <strong>di</strong> Gisulfo II colla doppia leggenda latina e<br />
cufica; il follaro <strong>di</strong> Gisulfo II; quello <strong>di</strong> Gisulfo I, con amor<br />
POPVLi : e quelli <strong>di</strong> Roberto Guiscardo, <strong>di</strong> Guglielmo duca col<br />
tipo del cavaliere, e quello <strong>di</strong> Ruggero II. Citeremo finalmente
VARIETÀ III<br />
il mezzo carlino <strong>di</strong> Fer<strong>di</strong>nando I d'Aragona, battuto a Reggio;<br />
il cavallo <strong>di</strong> Fer<strong>di</strong>nando, <strong>di</strong> Sulmona; quello <strong>di</strong> Federico<br />
d'Aragona, <strong>di</strong> Tagliacozzo; le rare monete <strong>di</strong> Ortona: quelle<br />
feudali del Vasto, e specialmente lo zecchino e lo scudo <strong>di</strong><br />
Cesare d'Avalos, e lo zecchino <strong>di</strong> Belmonte, del principe<br />
Antonio Pignatelli.<br />
Il catalogo descrittivo <strong>di</strong> questa importantissima Colle-<br />
zione, arricchita <strong>di</strong> tavole e <strong>di</strong> illustrazioni nel testo, sarà<br />
messo a <strong>di</strong>sposizione degli amatori, prima della ven<strong>di</strong>ta^ al<br />
prezzo <strong>di</strong> io lire. Dopo la ven<strong>di</strong>ta il medesimo Catalogo, coi<br />
prezzi ottenuti, sarà messo in ven<strong>di</strong>ta a L. 25. (Per <strong>com</strong>mis-<br />
sioni e schiarimenti rivolgersi all'Impresa <strong>di</strong> Ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> Giulio<br />
Sambon. Milano, Corso Vittorio Emannele, 37).
ATTI<br />
DELLA<br />
SOCIETÀ NUMISMATICA ITALIANA<br />
Seduta del Consiglio ii Febbraio 1897.<br />
(Estratto dai Verbali).<br />
La seduta è aperta alle ore 13. Sono presenti i Sigg. :<br />
Cav. Uff. Francesco Gnecchi, Cav. Uff. Ercole Gnecchi, Vice-<br />
Presidenti ; Dott. Cav. Solone Ambrosoli, Cav. Giuseppe<br />
Gavazzi, Ing. Emilio Motta e il Cav. Prof. C. Luppi, Segretario.<br />
I. Viene proposto a Socio effettivo il Sig. Francesco<br />
Traversa <strong>di</strong> Bra. È ammesso ad unanimità.<br />
IL Si stabilisce la <strong>com</strong>posizione del I fascicolo 1897<br />
della <strong>Rivista</strong>.<br />
III. Si dà <strong>com</strong>unicazione dei seguenti doni pervenuti<br />
alla Società :<br />
Ambrosoli Dott. Cav. Solone.<br />
Le sue pubblicazioni: Di un singolare cavallotto al tipo bellinzonese.<br />
Milano, 1897; ii^-S fìg- — Vocabolarìetto pei numismatici in<br />
sette lingue. Milano, 1897; in-32.<br />
Gapobianchi Cav. Vincenzo.<br />
La sua pubblicazione: Appunti per servire all'or<strong>di</strong>namento delle<br />
Monete coniate dal Senato <strong>di</strong> Roma dal 1184 al 1439 e degli<br />
stemmi primitivi del Comune <strong>di</strong> Roma. Estratto dagli Atti della<br />
R, Società Romana <strong>di</strong> Storia patria. Roma, 1896.<br />
Gnecchi Cav. Uff. Ercole.<br />
Pigorini Luigi, Memorie storico-numismatiche <strong>di</strong> Borgotaro, Bar<strong>di</strong><br />
e Compiano. Parma, 1863; in-8, con 3 tav. — De Minicis<br />
Avv. Gaetano, Le monete gravi e le ghiande missili <strong>di</strong> Fermo.<br />
»5
114<br />
ATTI DELLA SOCIETÀ NUMISMATICA ITALIANA<br />
Fermo, 1868; in-8, con una tav. — Quattro cataloghi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta<br />
<strong>di</strong> monete.<br />
Gnocchi Cav. Uff. Francesco.<br />
Das Kaiserlich — Konigliche Miinz-und Antiicen — Cabinet beschrieben<br />
von Joseph Arneth. Vienna^ 1854.<br />
Luppi Cav. Prof. Costantino.<br />
Saraceno Vittorio, Trattato, ossia tariffa <strong>di</strong> tutte le monete d'oro<br />
e d'argento secondo il loro valore <strong>com</strong>unemente corso dalli 15<br />
maggio 1658 sino al presente. Torino, 1776; in-8, con unita altra<br />
tariffa. Torino, 1779; pure in-8 fig. — Impronti, peso e valore<br />
delle monete d'oro e d'argento correnti negli Stati <strong>di</strong> S. S. R. M.<br />
il Re <strong>di</strong> Sardegna <strong>di</strong> qua dal mare. Torino, 1786; in-8 fig. —<br />
Tariffe del corso e valore delle monete, reali decreti a ciò<br />
relativi e ragguaglio della lira <strong>italiana</strong> colle altre legalmente<br />
in corso nel Regno d'Italia. Milano, 1808; in-8 fig. — // corso<br />
abusivo delle valute considerato <strong>com</strong>e causa del deprezzamento<br />
e conseguente fusione dei pezzi da 20 carantani. Milano, 1852;<br />
in-8. — Vignati Cesare, Lo<strong>di</strong> e il suo territorio. Milano, 1860;<br />
in-8 fig. — Latuada Serviliano, Descrizione <strong>di</strong> Milano ornata<br />
con molti <strong>di</strong>segni in rame delle fabbriche più cospicue, ecc.<br />
Milano, 1737; cinque tomi in-8.<br />
Museo Britannico.<br />
Catalogne of the Greek Coins of Caria, Cos, Rhodes etc. by Barclay<br />
V. Head D. L. C, Ph. D, Keeper of the department of Coins<br />
and Medals. Londra^ 1897.<br />
IV. Le due Commissioni incaricate dell'esame dei lavori<br />
presentati pei due Concorsi Gnecchi (N. 2) e Papadopoli^. 3) (i)<br />
presentano le loro relazioni, che a questo verbale si uniscono<br />
<strong>com</strong>e allegati A e B. Informano poi, <strong>com</strong>e, date le risultanze<br />
dei Concorsi, in seguito alle quali non si fa luogo a premio<br />
per quello Papadopoli, mentre viene proposta la <strong>di</strong>visione<br />
del premio fra i due concorrenti per quello Gnecchi, pure<br />
accordando eventualmente qualche vantaggio al lavoro con-<br />
trad<strong>di</strong>stinto col motto: Alma mater stu<strong>di</strong>orum; e per <strong>di</strong> più,<br />
considerata la mole ed il merito dei due lavori presentati,<br />
esse abbiano creduto conveniente <strong>di</strong> fare ufficii presso l'Ili.<br />
(i) Ve<strong>di</strong> Riv. It. <strong>di</strong> Numismatica, anno Vili, 1895, ^^sc. II, pag. 269-70.
ATTI DELLA SOCIETÀ NUMISMATICA ITALIANA II5<br />
Sig. Conte Papadopoli perchè volesse generosamente per-<br />
mettere che l'importo del premio da lui ban<strong>di</strong>to venisse<br />
aggregato al premio Gnecchi.<br />
Ottenuta l'adesione cortese dell'egregio senatore, le<br />
Commissioni propongono quin<strong>di</strong> che il premio (ora <strong>com</strong>plessivamente<br />
<strong>di</strong> L. iioo) da assegnarsi al Concorso Gnecchi /^r<br />
la migliore Illustrazione <strong>di</strong> una zecca <strong>italiana</strong>, o anche solo<br />
<strong>di</strong> un periodo <strong>di</strong> essa, vada <strong>di</strong>viso <strong>com</strong>e segue: L. 600 al-<br />
l'autore della memoria Alma mater stu<strong>di</strong>orum (Illustrazione<br />
della zecca <strong>di</strong> Bologna), L. 500 a quello della memoria Pru-<br />
dentis socia (Illustrazione della zecca <strong>di</strong> Fano); fatta con<strong>di</strong>-<br />
zione tuttavia al primo <strong>di</strong> adempiere ad alcune modalità<br />
stabihte dalla Commissione.<br />
Dopo <strong>di</strong> che, aperte le schede suggellate corrispondenti<br />
ai motti segnati sulle rispettive memorie, risulta che autore<br />
del manoscritto Alma mater stu<strong>di</strong>orum è il Conte Dott. Fran-<br />
cesco Malaguzzi- Valeri (Bologna) ; e del manoscritto Prudentis<br />
socia è il Sig. Rag. Giuseppe Castellani (Santarcangelo <strong>di</strong><br />
Romagna).<br />
Ai quali, per conseguenza, si <strong>di</strong>chiarano conferiti i due<br />
premi suddetti, non senza un plauso all'Ili. Sig. Presidente<br />
per l'agevolezza da lui gentilmente accordata.<br />
La seduta è sciolta alle ore 15.<br />
Allegato A.<br />
CONCORSO PAPADOPOLI (N. 2).<br />
(Per una Memoria che proponga il sistema migliore e piti<br />
pratico per or<strong>di</strong>nare le Collezioni <strong>di</strong> monete italiane,<br />
abbandonando l'or<strong>di</strong>ne alfabetico e seguendo una ripar-<br />
tizione conforme alla storia e alla geografia).<br />
1° Concorrente. Motto: In nummis historia.<br />
La Commissione ritiene che non si possa prendere in seria<br />
considerazione questo lavoro, e per la brevità affatto schematica<br />
<strong>di</strong> esso, e per la sua mancanza <strong>di</strong> qualsiasi originalità nell'insieme<br />
e ne' particolari.
Ile ATTI DELLA SOCIETÀ .NUMISMATICA ITALIANA<br />
2° Concorrente. Motto : Labor et fides.<br />
Questo lavoro, più importante (senza paragone) e assai migliore<br />
del precedente, non va immune tuttavia da gravissimi <strong>di</strong>fetti.<br />
Dal punto <strong>di</strong> vista scientifico, è farraginoso e anche talvolta<br />
contrad<strong>di</strong>ttorio; e, — col dare un predominio esclusivo al concetto<br />
politico, — ha l'inconveniente <strong>di</strong> smembrare, anzi <strong>di</strong> sbocconcellare<br />
ad<strong>di</strong>rittura le singole serie.<br />
Esso inoltre è ben lungi dall' esser pratico (checché ne creda<br />
l'autore) ; basti l'accennare alla proposta <strong>di</strong> or<strong>di</strong>nare le zecche minori<br />
<strong>di</strong> ciascuna regione secondo la loro <strong>di</strong>stanza dalla zecca principale,<br />
proposta che ognun vede quanto sia <strong>di</strong> applicazione incerta e <strong>di</strong>ffi-<br />
cile, allorché le zecche minori d'uno stato siano alquanto numerose.<br />
Duole quin<strong>di</strong> alla Commissione <strong>di</strong> non poter <strong>di</strong>chiarare meri-<br />
tevole <strong>di</strong> premio né l'uno né l'altro dei due concorrenti,<br />
Milano, 1° febbraio iSqj.<br />
La Commissione<br />
Giuseppe Gavazzi — Emilio Motta — Giuseppe Ruggero.<br />
Allegato B.<br />
CONCORSO GNECCHI (N. 3).<br />
(Per la migliore Illustrazione <strong>di</strong> una zecca <strong>italiana</strong> od anche<br />
solo <strong>di</strong> un periodo <strong>di</strong> essa, purché tale illustrazione porti<br />
nuova luce alla scienza.<br />
I due lavori presentati offrono una singolare analogia fra loro.<br />
Essi sono <strong>di</strong> mole pressoché eguale, e si <strong>di</strong>vidono ciascuno in<br />
tre parti precipue: storia della zecca; — descrizione delle monete;<br />
— documenti.<br />
L'analogia fra i due lavori è tale, che la parte storica <strong>di</strong> ciascuno<br />
<strong>di</strong> essi é sud<strong>di</strong>visa nello stesso numero <strong>di</strong> capitoli, e che ciascun<br />
lavoro contiene una Bibliografìa egualmente <strong>di</strong>sposta in or<strong>di</strong>ne<br />
alfabetico.<br />
a) Manoscritto col motto: Prudentis socia.<br />
È lavoro degno <strong>di</strong> lode, anzitutto, dal punto <strong>di</strong> vista strettamente<br />
numismatico, per la <strong>di</strong>ligenza con la quale l'autore ha radunato il
ATTI DELLA SOCIETÀ NUMISMATICA ITALIANA 117<br />
materiale delle sue descrizioni <strong>di</strong> monete, e da musei pubblici e<br />
da raccolte private, non essendo colpa sua se, <strong>com</strong>' egli deplora,<br />
rimasero inaccessibili alle sue ricerche molte altre collezioni.<br />
Per una zecca secondaria, qual è Fano, sembra infatti che l'aver<br />
riunito più <strong>di</strong> dugento descrizioni <strong>di</strong> monete sia una bella testimo-<br />
nianza della cura posta dall'autore nel suo lavoro.<br />
Questo si estende specialmente nella parte economica, ed è fatto<br />
in modo coscienzioso; è corredato infine <strong>di</strong> buona copia <strong>di</strong> documenti,<br />
D' altra parte, la redazione è alquanto arida, e non mancano<br />
inoltre <strong>di</strong>suguaglianze e stonature, che dovrebbero esser tolte, se si<br />
desse alle stampe.<br />
b) Manoscritto col motto : Alma<br />
mater stu<strong>di</strong>orum.<br />
Il lavoro è denso <strong>di</strong> notizie positive, reca molto materiale <strong>di</strong><br />
documenti, ed è assai importante anche per la storia dell'arte.<br />
La sezione storica è poggiata sovra solide ricerche d'archivio,<br />
ciò che le conferisce un carattere schiettamente originale.<br />
Di contro a questi pregi, la Commissione deve osservare che<br />
la forma si risente della fretta con cui senza dubbio è stato <strong>com</strong>pi-<br />
lato il lavoro, e che la sezione descrittiva è in<strong>com</strong>pleta, <strong>com</strong>e l'autore<br />
stesso riconosce, essendo stata redatta soltanto sulle opere già e<strong>di</strong>te<br />
e su <strong>di</strong> un ristretto numero <strong>di</strong> collezioni.<br />
Considerato adunque che i due lavori, presentando innegabili<br />
pregi sostanziali, ma nello stesso tempo non essendo scevri <strong>di</strong> <strong>di</strong>fetti<br />
<strong>di</strong> forma, press' a poco si equilibrano per merito, la soluzione più<br />
razionale sembra quella <strong>di</strong> <strong>di</strong>videre il premio fra i due concorrenti,<br />
fors'anche accordando qualche preferenza all'autore della memoria<br />
Alma mater stu<strong>di</strong>orum. Al medesimo tuttavia dovrebb' esser fatto<br />
obbligo <strong>di</strong> <strong>com</strong>pletare la sezione descrittiva del suo lavoro (e <strong>di</strong><br />
allegare gli in<strong>di</strong>ci promessi dei locatarii della zecca, degl'incisori<br />
dei conii, dei saggiatori, degli artisti, ecc.) prima <strong>di</strong> ricevere la parte<br />
<strong>di</strong> premio a lui destinata.<br />
Milano, 20 gennaio 189J.<br />
La Commissione<br />
Solone Ambrosoli — Giuseppe Gavazzi — C. E. Visconti.<br />
Finito <strong>di</strong> stampare il 20 marzo 1897.<br />
Scotti Reno, Gerente responsabile.
TAVOLE.
Anno X, 1897.<br />
RIVISTA ITALIANA DI NUMISMATICA<br />
L. FRATI. — Sull'erronea attribuzione al Francia delle monete gettate al popolo nel<br />
solenne ingrresso in Bologna <strong>di</strong> Giulio II per la cacciata <strong>di</strong> Gio. II BentlTOgllo.<br />
Tav. I.
RIVISTA ITALIANA DI NUMISMATICA<br />
Anno X, 1897. • Tav. II.<br />
C. KUNZ. — Miscellanea Namismatica.
FASCICOLO II.
APPUNTI<br />
DI<br />
NUMISMATICA ROMANA<br />
XLIV.<br />
SULLE RESTITUZIONI.<br />
Monete postume in genere — Periodo delle Restituzioni<br />
Definizioni e caratteri — Origine e scopo<br />
Classificazione e collocamento — Descrizione.<br />
(Tavola III).<br />
Fra le caratteristiche <strong>di</strong> concetto che <strong>di</strong>stinguono<br />
la monetazione imperiale romana da qualunque altra,<br />
v'ha quella delle Restituzioni. Tutti conoscono tali<br />
monete; ogni trattato <strong>di</strong> <strong>numismatica</strong>, per quanto<br />
elementare, ne parla, più o meno <strong>di</strong>ffusamente, e<br />
tutte le collezioni ne posseggono. Di esse, <strong>com</strong>e <strong>di</strong><br />
tutto ciò che ha attinenza alla <strong>numismatica</strong> romana,<br />
si occuparono parecchi vecchi autori (0 , i quali,<br />
anche in questo <strong>com</strong>e in molti altri argomenti, volendo<br />
troppo supporre e troppo indovinare, aumentarono<br />
le <strong>di</strong>fficoltà reali, ne crearono anche <strong>di</strong> im-<br />
maginarie, entrarono in <strong>di</strong>squisizioni lunghissime e<br />
fecero delle ipotesi talvolta anche assurde o stram-<br />
palate, tmiiis <strong>di</strong>gna Harduini ingenio, <strong>com</strong>e <strong>di</strong>ce<br />
Eckhel nella sua aurea Doctrina , nella quale (2)<br />
(i) Bimard, Le Beau, ecc.<br />
(2) Voi. V, Capo XVII, pag. 97 e segg.
124<br />
FRANCESCO GNECCHI<br />
rende conto <strong>di</strong> tutto e, riassumendo il meglio, ne fa<br />
una chiara esposizione; ma, dopo <strong>di</strong> lui, le Resti-<br />
tuzioni non formarono più, per quanto io mi sappia,<br />
oggetto <strong>di</strong> uno stu<strong>di</strong>o speciale.<br />
Può darsi quin<strong>di</strong> che, a un secolo <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanza,<br />
uno sguardo generale e sintetico, che tutte le abbracci,<br />
presenti ancora qualche interesse, e non<br />
abbiano a riuscire affatto inutili alcune considerazioni<br />
su quella serie <strong>di</strong> monete presa nel suo <strong>com</strong>plesso.<br />
Chi scrive non ha menomamente la pretesa <strong>di</strong> <strong>di</strong>r<br />
cose molto profonde ne <strong>di</strong> esporre idee molto ar<strong>di</strong>te.<br />
Dirà invece cose molto semplici ed esporrà idee molto<br />
piane; ma può darsi che la naturalezza valga meglio<br />
delle ipotesi artificiose e che la semplicità spieghi<br />
meglio d'un ragionamento troppo <strong>com</strong>plicato.<br />
MONETE POSTUME IN GENERE.<br />
Le monete <strong>di</strong> restituzione, <strong>com</strong>e lo <strong>di</strong>ce il nome,<br />
vanno collocate fra le postume, relativamente all'Augusto<br />
che viene restituito; e formano anzi uno dei tre<br />
gruppi nei quali le monete postume vanno <strong>di</strong>vise. Ci<br />
conviene osservare dapprima questi tre gruppi nel loro<br />
insieme, onde vederne la concatenazione e la naturale<br />
<strong>di</strong>scendenza. Formano il primo gruppo le monete <strong>di</strong><br />
semplice memoria, il secondo quelle <strong>di</strong> consacrazione,<br />
il terzo quelle <strong>di</strong> restituzione.<br />
Le monete semplicemente postume, sono quelle<br />
coniate da un principe in memoria e ad onore del<br />
suo imme<strong>di</strong>ato antecessore, e portano da un lato l'ef-<br />
figie del principe che si intende ricordare, dall'altro<br />
il nome — raramente l' effigie — <strong>di</strong> quello che le<br />
fece coniare, ac<strong>com</strong>pagnato spesso da una data.<br />
Le monete <strong>di</strong> consacrazione, coniate <strong>com</strong>e le<br />
prime dall'imperatore o dal senato, portano al dritto
SULLE RESTITUZIONI 125<br />
l'effigie dell'Augiisto, del Cesare o delFAugusta passata<br />
nel numero degli Dei, al rovescio un emblema<br />
della consacrazione, il rogo, l'aquila, il carpento o<br />
simili, e la costante leggenda CONSECRATIO, senza<br />
alcuna in<strong>di</strong>cazione del nome, né l'effigie <strong>di</strong> chi ne<br />
or<strong>di</strong>nò la coniazione e senza alcuna data. Ciò che<br />
del resto sarebbe superfluo, essendo evidente che<br />
tali monete venivano emesse nell'occasione in<strong>di</strong>cata<br />
e quin<strong>di</strong> imme<strong>di</strong>atamente dopo l'apoteosi del principe<br />
<strong>com</strong>memorato, per or<strong>di</strong>ne del suo successore.<br />
Nelle monete <strong>di</strong> restituzione finalmente, al nome<br />
del principe che fa coniare la moneta in onore d'un<br />
antecessore più o meno lontano, viene aggiunta, a<br />
spiegazione del fatto, la parola RESTITVIT.<br />
In or<strong>di</strong>ne cronologico apparvero per le prime<br />
quelle <strong>di</strong> semplice <strong>com</strong>memorazione, le quali in<strong>com</strong>inciano<br />
al principio dell' impero. Seguirono le restituzioni<br />
inaugurate da Tito e Domiziano, e vennero<br />
per ultimo le consacrazioni in<strong>com</strong>inciate al tempo<br />
d'Adriano.<br />
Il senato romano non si decise che tar<strong>di</strong> ad<br />
imprimere sulle monete da lui emesse, l'effigie del-<br />
l' imperatore regnante, e assai prima 1' avevano im-<br />
pressa i triumviri, i <strong>di</strong>ttatori, i prefetti della flotta e<br />
i <strong>com</strong>andanti le truppe (imperatores) sulle monete da<br />
essi <strong>di</strong>rettamente coniate, ossia sull'oro e sull'argento.<br />
Allorché il senato iniziò la sua coniazione in<br />
Roma, il che fu sotto Tiberio, per un certo tempo<br />
<strong>di</strong> Tiberio non vi pose che il nome da un lato, mentre<br />
sull'altro vi collocava la testa d'Augusto. Tale fu<br />
l'origine delle monete postume, e se ne ha la spie-<br />
gazione assai naturale nella ritrosia che il senato,<br />
geloso della propria autorità, aveva ad imprimervi<br />
l'effigie dell'imperatore regnante, e nella preferenza<br />
a vedervi piuttosto quella dell' imperatore defunto.<br />
L' origine e 1' adozione delle monete <strong>di</strong> consa-
126 FRANCESCO GNECCHI<br />
crazione pure si spiegano assai facilmente, essendo<br />
monete <strong>com</strong>memorative dell'ultimo glorioso episo<strong>di</strong>o<br />
dell'Augusto <strong>di</strong>vinizzato; mentre quelle che <strong>di</strong>edero<br />
più a pensare ai nummografi furono le monete re-<br />
stituite. Intorno ad esse si formò un <strong>com</strong>plesso <strong>di</strong><br />
problemi, alla soluzione o alla eliminazione dei quali<br />
potrà forse contribuire l'esposizione piana e precisa<br />
dello stato <strong>di</strong> fatto, il che è ciò che tenterò <strong>di</strong> far(;,<br />
prima <strong>di</strong> entrare ad indagarne l'origine e lo sccpo.<br />
PERIODO DELLE RESTITUZIONI.<br />
Le Restituzioni non sono molto numerose; pochi<br />
sono i nomi che vi figurano <strong>com</strong>e restituiti e pochis-<br />
simi quelli dei restitutori; breve è quin<strong>di</strong> il periodo in<br />
cui quest'uso durò presso i romani. Le più antiche<br />
sono quelle <strong>di</strong> Tito e Domiziano, le più recenti quelle<br />
<strong>di</strong> M. Aurelio e L. Vero, senza che neppure vi sia una<br />
continuazione <strong>di</strong> nomi in questo breve lasso <strong>di</strong> tempo.<br />
Tito e Domiziano inaugurarono questa serie con<br />
monete <strong>di</strong> bronzo e non furono seguiti che da Nerva;<br />
o, per esprimere la cosa più esattamente, fu il senato<br />
che, durante il regno <strong>di</strong> questi tre imperatori, restituì<br />
alcuni de' suoi bronzi, sesterzii, dupon<strong>di</strong>i ed assi (tutti<br />
portano le lettere S C) coi nomi <strong>di</strong> precedenti imperatori,<br />
in<strong>com</strong>inciando da Augusto.<br />
Al nome <strong>di</strong> Tito il senato restituì monete <strong>di</strong><br />
Augusto, Livia, Agrippa, Tiberio, Druso, Nerone<br />
Druso, Germanico, Agrippina Madre, Clau<strong>di</strong>o e Galba.<br />
Al nome <strong>di</strong> Domiziano, monete <strong>di</strong> Augusto,<br />
Agrippa, Tiberio, Druso, Germanico, Clau<strong>di</strong>o.<br />
Al nome <strong>di</strong> Nerva finalmente, monete d'Augusto<br />
e d' Agrippina Madre.<br />
L' imperatore Tito, l' inauguratore delle restituzioni,<br />
ne fu anche il più abbondante produttore. Domi-
SULLE RESTITUZIONI 12?<br />
ziano si accontentò <strong>di</strong> riprodurre una parte <strong>di</strong> quelle<br />
emesse da Tito; Nerva fu ancora più parco <strong>di</strong> re<br />
stituzioni, quantunque le sue, per la maggior parte<br />
non siano riproduzioni <strong>di</strong> quelle de' suoi antecessori<br />
Con Nerva cessano le restituzioni senatoriali<br />
e in<strong>com</strong>inciano quelle coniate <strong>di</strong>rettamente dagli im<br />
peratori. Quattro soli sono gli imperatori che restituì<br />
Nerva, Trajano<br />
rono monete imperiali d' argento :<br />
Adriano e M. Aurelio associato con L. Vero; il solo<br />
Trajano coniò le restituzioni in oro. Aggiungerò anzi<br />
.che le restituzioni <strong>di</strong> Nerva, Adriano e M. Aurelio<br />
possono considerarsi quasi <strong>com</strong>e eccezioni, non essendocene<br />
pervenuto che un solo tipo o due per ciascheduno,<br />
mentre la sola vera serie è quella <strong>di</strong> Trajano.<br />
Nerva restituì un denaro d' Augusto che a noi<br />
pervenne in unico esemplare. Adriano un denaro <strong>di</strong><br />
Trajano e un medaglione asiatico d'Augusto Tuno<br />
e Taltro conosciuti per uno o due esemplari; Marco<br />
Aurelio e L. Vero pure restituirono un solo denaro,<br />
quello della Legione VI <strong>di</strong> M. Antonio, del quale però<br />
ci pervennero esemplari in numero grande, così da<br />
renderli <strong>com</strong>uni in tutte le collezioni.<br />
Trajano è il solo che ci fornisca una vera serie<br />
<strong>di</strong> restituzioni in oro e in argento. Conosciamo finora<br />
51 denari repubblicani d'argento restituiti e precisa<br />
mente delle famiglie: Aemilia, Caecilia, Carisia, Cassia<br />
Clau<strong>di</strong>a, Cornelia, Cornuficia, Decia, Di<strong>di</strong>a, Eppia<br />
Horatia, Julia, Junia, Livineia, Lucretia, MamiHa<br />
Marcia, Maria, Memmia, Minucia, Norbana, Numonia<br />
Pompeia, Porcia, Quinctia, Rubria, Scribonia, Servilia<br />
Sulpicia, Titia, Tullia, Valeria, Vipsania, pili alcuni<br />
denari incerti.<br />
Le sue restituzioni imperiali finora conosciute<br />
sono 16 in oro, che ricordano i nomi <strong>di</strong> Giulio Cesare,<br />
Augusto, Tiberio, Clau<strong>di</strong>o, Galba, Vespasiano,<br />
Tito e Nerva; una in argento in memoria d'Augusto.
1-28<br />
FRANCESCO GNECCHI<br />
Dopo Trajano V uso delle restituzioni è abbandonato,<br />
e non è se non a un secolo e mezzo <strong>di</strong> <strong>di</strong>-<br />
stanza, ossia all'epoca <strong>di</strong> Filippo o <strong>di</strong> Gallieno, che<br />
troviamo una nuova serie <strong>di</strong> restituzioni imperiali<br />
coniate coll'argento <strong>di</strong> bassa lega che allora correva;<br />
ma queste si chiamano abusivamente restituzioni, o<br />
per lo meno non lo sono nel senso in cui inten<strong>di</strong>amo<br />
le restituzioni or<strong>di</strong>narie. Sono denari coniati al nome<br />
e ad onore <strong>di</strong> antichi imperatori e precisamente <strong>di</strong><br />
Augusto, Vespasiano, Tito, Nerva, Trajano, Adriano,<br />
Antonino Pio, Marco Aurelio, Commodo e Settimio<br />
Severo, col costante rovescio della consacrazione,<br />
rappresentato o dall'ara accesa o dall'aquila; ma senza<br />
la minima intenzione <strong>di</strong> arieggiare una riconiazione<br />
d'antiche monete, meno forse un' unica eccezione,<br />
quella che riproduce al rovescio <strong>di</strong> Trajano il tipo<br />
della VIA TRAIANA.<br />
L'epoca <strong>di</strong> tale coniazione non è bene precisata<br />
ma deve certo oscillare fra il regno <strong>di</strong> Filippo e<br />
quello <strong>di</strong> Gallieno; dal tipo però si attribuirebbero<br />
più volentieri al primo che non al secondo e potrebbe<br />
darsi che fossero state coniate in occasione della<br />
celebrazione del millennario <strong>di</strong> Roma, fatta una ec-<br />
cezione pel denaro sopra accennato col rovescio<br />
della Via Trajana, il quale, dalla fabbricazione, si<br />
<strong>di</strong>rebbe coniato al tempo <strong>di</strong> Gor<strong>di</strong>ano Pio.<br />
DEFINIZIONE E CARATTERI DELLE RESTITUZIONI.<br />
Contrariamente alle monete postume dei primi<br />
due gruppi, che sono <strong>di</strong> conio affatto originale, le<br />
restituzioni portano nel loro stesso nome il significato<br />
d'una rievocazione. Difatti ecco <strong>com</strong>e esse sono<br />
definite nei trattati <strong>di</strong> <strong>numismatica</strong>:<br />
" Monete restituite sono quelle che furono riconiate
"<br />
SULLE RESTITUZIONI I29<br />
in epoca posteriore a quella della pruìia loro eniis-<br />
" sione e che portano il nome del principe che le fece<br />
" coniare seguito dalla parola RESTITVIT o piti <strong>com</strong>u-<br />
" nemente REST. „<br />
oppure:<br />
" Restituite si chiamano quelle monete^ sia conso-<br />
" lari che imperiali, le quali, oltre al tipo primitivo<br />
" e alla primitiva iscrizione, />or/rt«o /"/ nome dell' im-<br />
" peratore che le fece riconiare, aggiuntovi REST o<br />
" RESTITVIT.<br />
„<br />
Dalle quali definizioni, parrebbe che le monete<br />
restituite dovessero essere perfette riconiazioni <strong>di</strong><br />
monete già coniate da altro principe, ossia esatte<br />
riproduzioni <strong>di</strong> monete anteriori.<br />
Questo è appunto il concetto che generalmente<br />
e volgarmente ne è risultato, mentre il fatto non è<br />
tale e le restituzioni non sono tutte né sempre ri-<br />
produzioni <strong>di</strong> monete preesistenti.<br />
Come si può vedere dalla descrizione che ac<strong>com</strong>pagna<br />
questa memoria, le restituzioni dei denari<br />
repubblicani eseguite da Trajano sono le più fedeli agli<br />
archetipi. Vengono appresso quelle coniate dal senato,<br />
le quali per lo piij, ma non sempre, riproducono nello<br />
stesso modulo monete originariamente coniate dal<br />
principe che si intende ricordare; e per ultimo, <strong>com</strong>e<br />
le meno fedeli agli antichi tipi, le restituzioni imperiali<br />
d'oro e d'argento. E il perchè <strong>di</strong> questo fatto non<br />
è <strong>di</strong>fficile indagarlo. I denari repubblicani hanno tipi<br />
così speciali e in<strong>di</strong>viduali che non era possibile confon-<br />
dere l'uno coll'altro, senza produrre un anacronismo o<br />
una <strong>di</strong>ssonanza; e, volendo ricordare una data fami-<br />
glia, era necessario riprodurre fedelmente il dritto e il<br />
rovescio <strong>di</strong> una data moneta coi suoi tipi e colle sue<br />
leggende. È con queste norme che esse vennero<br />
coniate, e le troviamo tutte fedelissime agli originali.
130<br />
FRANCESCO GNECCHI<br />
meno forse qualche lieve ed eventuale eccezione, pic-<br />
colo particolare, <strong>di</strong> cui qui non è il caso <strong>di</strong> occuparci.<br />
Nelle restituzioni imperiali invece varie <strong>di</strong>fferenze<br />
<strong>di</strong> tipo, <strong>di</strong> leggenda e <strong>di</strong> modulo s' incontrano già in<br />
quelle <strong>di</strong> bronzo, ove troviamo degli assi che portano<br />
il tipo d'un antico sesterzio, e qualche tipo anche vi<br />
appare che non figurò mai nelle monete originarie.<br />
Tali <strong>di</strong>fferenze poi sono assai maggiormente accen-<br />
tuate nelle restituzioni d'argento e d'oro.<br />
Ebbi già occasione <strong>di</strong> rilevare questo fatto<br />
nell'anno 1888 (3), quando <strong>di</strong>e<strong>di</strong> la descrizione <strong>di</strong> una<br />
nuova restituzione <strong>di</strong> Trajano. Riassumendomi ora<br />
brevemente, mi limiterò a richiamare <strong>com</strong>e dalla unita<br />
descrizione risulti che oltre la metà delle restituzioni<br />
imperiali è costituita da monete <strong>di</strong> cui non esistono<br />
gli archetipi, e precisamente su 17 restituzioni co-<br />
nosciute non ne contiamo che 7, nelle quali i dritti<br />
e i rovesci corrispondano a quelli delle monete ori-<br />
ginarie e vi corrisponda pure il metallo.<br />
. La<br />
definizione delle Restituzioni si può dunque<br />
rettificare <strong>com</strong>e segue:<br />
" Monete restituite sono quelle che un principe<br />
" coniò in memoria e coli* effigie <strong>di</strong> un suo predecessore,<br />
" apponendovi anche il proprio nome seguito dalla<br />
" parola REST o RESTITVIT „ e si può aggiungere:<br />
" Tali monete sovente riproducono più o meno esatta-<br />
" mente vere monete del principe <strong>com</strong>memorato, talvolta<br />
" invece non vi hanno alcun riscontro. „<br />
In termini più brevi:<br />
" Le monete restituite sono vere supposte ripro-<br />
" duzioni <strong>di</strong> monete anteriori, sulle quali viene aggiunto<br />
" il nome del principe che ne fece la coniazione seguito<br />
" — quasi sempre — dalla parola RESTITVIT. „<br />
(3) Riv. It. <strong>di</strong> Num. Appunti <strong>di</strong> Num. Romana, N. i.
SULLE RESTITUZIONI I3I<br />
ORIGINE E RAGIONE DELLE RESTITUZIONI.<br />
Abbiamo visto nel principio <strong>di</strong> questa memoria<br />
<strong>com</strong>e avessero origine le monete postume e <strong>com</strong>e<br />
da queste siano derivate le restituite. Il nome d'Augusto<br />
s'imponeva sempre ed esercitava sempre il suo<br />
fascino sull'impero da lui fondato. È naturale quin<strong>di</strong><br />
che questo nome, glorificato subito dopo la sua morte<br />
sulle monete <strong>di</strong> Tiberio coH'epiteto <strong>di</strong> PATER PATRIAE<br />
e <strong>di</strong> DIVVS, venisse rievocato anche più tar<strong>di</strong> e la<br />
rievocazione fu opera del senato, il quale inaugurò<br />
così il sistema delle restituzioni.<br />
E qui sorgono ad<strong>di</strong>rittura le cento <strong>di</strong>mande che<br />
<strong>di</strong>edero luogo alle più o meno serie — e alcune<br />
anche amene, — supposizioni dei numismatici antichi,<br />
che qui non è più il caso <strong>di</strong> riportare, perchè ormai<br />
definitivamente abbandonate; ma alle quali una ri-<br />
sposta esauriente non venne finora data neppure dai<br />
moderni ^4). Perchè tale iniziativa nella monetazione<br />
romana venne presa dal senato e non dall'imperatore<br />
stesso? Perchè la coniazione <strong>di</strong> tali monete<br />
senatorie ha un sì breve periodo ? Perchè, al cessare<br />
<strong>di</strong> questa, in<strong>com</strong>incia, pure per un breve periodo, la<br />
coniazione da parte degli imperatori?<br />
E, venendo poi a <strong>di</strong>scutere e vagliare i nomi<br />
dei principi restituiti : con quale criterio se ne fece<br />
una scelta? Non certo appoggiandosi ai meriti perso-<br />
nali, giacché, se non abbiamo restituzioni <strong>di</strong> Caligola<br />
e <strong>di</strong> Nerone, ne abbiamo però <strong>di</strong> Tiberio e <strong>di</strong> Clau<strong>di</strong>o.<br />
E perchè, per esempio, Nerva restituì solo monete<br />
(4) Difatti anche l'Articolo consacrato alle Restituzioni nel recentissimo:<br />
Diciionary of roman coins <strong>di</strong> Stevenson Smith e Madden (Londra<br />
1888) si chiude con queste parole: " It must be confessed that the resto-<br />
" ralions in question are stili left among the unsolved rid<strong>di</strong>cs of ancient<br />
" numismatisni. „
132 FRANCESCO GNECCHI<br />
d'Augusto e d'Agrippina madre e non del buon Tito<br />
o del grande Vespasiano? E perchè M. Aurelio e<br />
L. Vero, dopo alcuni anni che le restituzioni erano<br />
cessate, pensarono a restituire l'unica Legione VI <strong>di</strong><br />
M. Antonio?<br />
Ecco altrettanti problemi che sarebbe certo in-<br />
teressante l'indagare; e, pensando ai quali, fui io pure<br />
lungamente dubbioso, finché un bel giorno mi venne<br />
la convinzione, che, se essi rimarranno probabilmente<br />
per sempre insoluti presi ad uno ad uno nei loro<br />
particolari, per la spiegazione dei quali ci mancano<br />
ormai i necessari elementi, considerati invece in modo<br />
generale, presentano una soluzione molto piana. Mi<br />
pare anzi che i <strong>di</strong>versi problemi accennati, meglio<br />
che sciogliere singolarmente, si debbano eliminare in<br />
blocco. E, per bene esprimere il mio concetto, mi si<br />
permetta <strong>di</strong> esporre <strong>com</strong>e io, riportandomi a quei<br />
tempi, immagino che realmente siano andate le cose.<br />
Premettiamo che uno dei più prepotenti tiranni<br />
che dominano le umane vicende, è l'uso; ed anzi,<br />
per adoperare un' altra parola, la quale, sotto una<br />
veste pili leggera e con un' apparenza assai poco<br />
scientifica, esprime però piìi precisamente il mio<br />
pensiero, la moda. Questa dea o semidea, che sembra<br />
portare con se il profumo della freschezza e della<br />
novità, è vecchia quanto il mondo e venti secoli or<br />
sono esercitava il suo fascino precisamente <strong>com</strong>e lo<br />
esercita al giorno d'oggi e <strong>com</strong>e verosimilmente lo<br />
eserciterà sui mortali fin che questi passeggeranno<br />
sotto la volta del cielo.<br />
Orbene, senza ricercare cause recon<strong>di</strong>te e pro-<br />
fonde, io penso che a lei sola si debba attribuire l'appa-<br />
rizione, la successiva trasformazione e il cessare delle<br />
restituzioni. Una mo<strong>di</strong>ficazione nella monetazione romana<br />
è un semplice episo<strong>di</strong>o che riesce assai facilmente<br />
spiegabile con quella sola causa, alla quale
SULLK RESTITUZIONI I33<br />
vanno attribuiti avvenimenti <strong>di</strong> ben maggiore importanza.<br />
Tito e Domiziano, volendo rievocare la memoria<br />
d'Augusto, fanno la trovata delle restituzioni, il<br />
che avviene probabilmente nell'anno 80 o 81 dell'era<br />
volgare, poiché buona parte delle restituzioni <strong>di</strong> Tito<br />
portano appunto la data del suo ottavo consolato.<br />
L'idea piace e, <strong>di</strong>etro alle prime, se ne fanno altre,<br />
finché la volubile moda si volge ad altro e le restituzioni<br />
cessano con Trajano, per fare poi ancora una<br />
eccezionale apparizione sotto Adriano e più tar<strong>di</strong><br />
sotto Marc'Aurelio e Lucio Vero (5).<br />
La monetazione romana , per<br />
<strong>com</strong>e<br />
sé stessa eminentemente<br />
<strong>com</strong>memorativa ,<br />
or<strong>di</strong>nariamente<br />
registrava, raffigurandoli sui rovesci, tutti gli avve-<br />
nimenti che si andavano giornalmente svolgendo, si<br />
occupava egualmente degli avvenimenti passati, <strong>di</strong><br />
mano in mano che si andavano <strong>com</strong>memorando e<br />
li celebrava, rievocando con una restituzione, il nome<br />
<strong>di</strong> uno dei precedenti imperatori o d'un personaggio<br />
insigne, il cui nome fosse collegato coU'avvenimento<br />
<strong>com</strong>memorato.<br />
(5) Un esempio che si acconcia benissimo al caso 1* abbiamo nella<br />
coniazione delle monete multiple (piéforts) nella <strong>numismatica</strong> <strong>italiana</strong> ed<br />
estera me<strong>di</strong>oevale, coniazione che fiorì qua e là a brevi perio<strong>di</strong>, e un<br />
altro l'abbiamo nella medaglistica <strong>italiana</strong> durante il principio <strong>di</strong> questo<br />
secolo. La produzione delle medaglie, da qualche tempo limitatissima,<br />
prende uno straor<strong>di</strong>nario sviluppo all'epoca dell'epopea napoleonica.<br />
Le medaglie si coniano a centinaia, ogni fatto grande o piccolo viene<br />
<strong>com</strong>memorato con una apposita medaglia. E l'esuberanza raggiunge tali<br />
limiti che, non bastando più gli eroi né gli uomini gran<strong>di</strong> nelle arti, nelle<br />
lettere o nelle <strong>scienze</strong>, vengono coniate medaglie in onore <strong>di</strong> tutte le<br />
celebri cantatrici, delle vezzose seguaci <strong>di</strong> Tersicore e persino dei co-<br />
reografi! La febbre durò pochi anni e la produzione delle medaglie si<br />
ridusse ben presto alle sue giuste proporzioni. Il raccoglitore <strong>di</strong> meda-<br />
glie italiane che verrà fra molti anni non potrà spiegarsi quel periodo<br />
che abbraccia il primo quarto del nostro secolo, fecon<strong>di</strong>ssimo e specia'mente<br />
fecondo <strong>di</strong> tnedaglie per gli eroi e le eroine da teatro, se non<br />
<strong>di</strong>cendo: fu un capriccio della moda! e sarà nel vero. Io penso che la<br />
stessa cosa sia avvenuta per le restituzicni romane.
134 FRANCESCO GNECCHI<br />
Il culto degli anniversari non è certamente una<br />
novità dei nostri tempi; era anzi vivissimo presso i<br />
Romani (informino i voti, le feste e i giuochi), ed è<br />
da essi che noi l'abbiamo ere<strong>di</strong>tato.<br />
Se tutte le restituzioni portassero una data — ed<br />
è deplorevole che invece non ve ne sia che un certo<br />
numero <strong>di</strong> quelle <strong>di</strong> Tito coli' unica data, <strong>di</strong> cui si<br />
fece cenno più sopra — vi troveremmo probabilmente<br />
molte coincidenze interessanti. Durante il regno <strong>di</strong><br />
Tito e Domiziano cade il centenario della morte<br />
d'Agrippa, il cinquantennario della morte d'Agrippina,<br />
<strong>di</strong> Tiberio e <strong>di</strong> Clau<strong>di</strong>o, e <strong>di</strong>fficile sarebbe il <strong>di</strong>re oggi<br />
<strong>di</strong> quanti altri importanti avvenimenti relativi agli<br />
altri personaggi restituiti cadessero gli anniversari in<br />
quel periodo. Fatto sta che la monetazione se ne im-<br />
padroniva, senza troppo sottilizzare se il nome, cui<br />
l'avvenimento si riferiva, fosse veramente glorioso,<br />
oppure semplicemente opportuno al momento. E ciò<br />
significherebbe che la scelta dei personaggi non va<br />
molto indagata, non essendo sempre libera e spontanea;<br />
ma <strong>di</strong>pendendo bene spesso da circostanze o<br />
da casualità passaggere. Di quanti fra i nostri anni-<br />
versari i posteri cercheranno invano la ragione!<br />
E da ciò si può anche dedurre che la restituzione<br />
si riferiva al personaggio, non già alla moneta. Lo<br />
spirito della restituzione non era certamente quello<br />
<strong>di</strong> riconiare una precisa moneta <strong>di</strong> tempi anteriori,<br />
bensì <strong>di</strong> ricordare un principe passato. Per far questo<br />
si coniava una moneta che ne riproducesse il nome<br />
e l'effige e si sceglieva generalmente un rovescio che<br />
avesse appartenuto alle sue monete; ma, anche quando<br />
si seguiva questa norma — il che non era costante —<br />
non s' andava allo scrupolo nella riproduzione dei<br />
particolari. Inutile quhi<strong>di</strong> il sottilizzare sulla maggiore<br />
o minore fedeltà delle riproduzioni, superflue le inda-<br />
gini per trovare ad ogni restituzione il suo archetipo
SULLE RESTITUZIONI I35<br />
e vana la frase assai <strong>com</strong>une che <strong>di</strong> una data resti-<br />
tuzione l'archetipo non si è ancora trovato. Non si<br />
è trovato e non si troverà mai per la semplice ra-<br />
gione che non ha mai esistito.<br />
Tutto ciò vale per le restituzioni imperiali, intorno<br />
alle quali i <strong>di</strong>versi problemi non avrebbero dunque<br />
più ragione <strong>di</strong> esistere. Ma, al cessare <strong>di</strong> queste, ci<br />
troviamo <strong>di</strong> fronte alle repubblicane <strong>di</strong> Trajano le<br />
quali, per quanto ci si presentino sotto un aspetto piìi<br />
chiaro e più facilmente spiegabile, non mancarono <strong>di</strong><br />
dar luogo esse pure a lunghe <strong>di</strong>spute fra i cercatori <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>fficoltà. Osserviamo anche queste dalla loro origine.<br />
Durante il primo secolo dell'impero continuarono<br />
ad essere in corso gli antichi denari della Repubblica;<br />
ma, sic<strong>com</strong>e, per quanto consunti dalla lunga circo-<br />
lazione, pure avevano sempre un intrinseco superiore<br />
a quello dei denari imperiali, si presentava <strong>com</strong>e<br />
regola <strong>di</strong> saggia amministrazione economica quella<br />
<strong>di</strong> una rifon<strong>di</strong>ta generale e Trajano decise <strong>di</strong> adottarla.<br />
Eseguendo tale riforma, era anche naturale che gli<br />
<strong>di</strong>spiacesse rinunciare <strong>com</strong>pletamente alle tra<strong>di</strong>zioni<br />
gloriose che questi denari repubblicani ricordavano,<br />
e da ciò pare naturalissimo sia sorta l'idea <strong>di</strong> conservarne<br />
una memoria, riconiando un certo numero <strong>di</strong><br />
monete che riproducessero gli antichi tipi.<br />
Ecco l'origine molto naturale e facilmente accet-<br />
tabile delle restituzioni <strong>di</strong> Trajano. Essa venne infatti<br />
generalmente accettata; ma le <strong>di</strong>fficoltà nacquero in»<br />
vece al punto <strong>di</strong> indagare o <strong>di</strong> indovinare quali furono<br />
i criteri che presiedettero alla scelta delle monete da<br />
restituire; perchè, mentre ci mancano fra le restituzioni<br />
quelle <strong>di</strong> molte famiglie patrizie ed illustri, ne<br />
abbiamo altre <strong>di</strong> famiglie plebee e quasi ignote. Dato<br />
che si voglia entrare nel merito della questione,<br />
bisogna osservare in primo luogo che molte famiglie<br />
le quali ora per noi riescono oscure e certi nomi che
136<br />
FRANCESCO GNECCHI<br />
sono affatto ignoti al giorno d'oggi, assai probabilmente<br />
non erano tali allora; in secondo luogo che<br />
noi non possiamo valutare le influenze che avranno<br />
esercitato famiglie tuttora esistenti, che contavano<br />
antichi magistrati monetarii fra i loro antenati e che<br />
avevano i loro nomi iscritti sulle monete, le private<br />
ambizioni, gli interessi personali e via <strong>di</strong>cendo.<br />
Una considerazione però è superiore ad ogni altra<br />
ed è che tutti questi ragionamenti sono fatti in base<br />
ai soli monumenti che ci sono pervenuti, mentre non<br />
sappiamo quanti ce ne restino ignoti.<br />
La coniazione <strong>di</strong> queste restituzioni pare sia<br />
stata molto ristretta, e certo limitatissima in confronto<br />
alla sterminata monetazione <strong>di</strong> Trajano, <strong>di</strong>modoché<br />
è certo che noi non la conosciamo che assai in<strong>com</strong>pletamente,<br />
scarsissimo essendo il numero degli<br />
esemplari che ci sono pervenuti.<br />
I denari repubblicani furono restituiti non al peso<br />
originario, ma al peso dei denari del tempo <strong>di</strong> Trajano,<br />
ciò che era appunto nello spirito della riconiazione<br />
generale e quin<strong>di</strong> entrarono nella circolazione, <strong>com</strong>e<br />
evidentemente appare dallo stato <strong>di</strong> conservazione<br />
in generale me<strong>di</strong>ocre o cattivo, caso <strong>com</strong>une a tutte<br />
le monete rare, fra cui non v'ha scelta e ogni esem-<br />
plare è scrupolosamente conservato. Dall' arte finis-<br />
sima <strong>di</strong> queste restituzioni, anche relativamente al resto<br />
della coniazione <strong>di</strong> Trajano, appare evidentemente<br />
che i con! furono apprestati con cura speciale, probabilmente<br />
dagli artisti addetti all'incisione <strong>di</strong> quelli<br />
dell'oro; quin<strong>di</strong> è probabile che <strong>di</strong> ciascun tipo non<br />
si fossero incisi che pochissimi coni. Non oserei certo<br />
<strong>di</strong>re, <strong>com</strong>e alcuno vorrebbe supporre, che fosse stato<br />
fatto un solo conio <strong>di</strong> ogni tipo perchè, quantunque<br />
le poche volte che mi occorse <strong>di</strong> vedere la stessa<br />
moneta in due esemplari, (caso che è naturalmente<br />
raro, vista l' estrema rarità <strong>di</strong> queste monete) mi
SULLE RESTITUZIONI I37<br />
parve <strong>di</strong> poter quasi sempre verificare che i <strong>di</strong>versi<br />
esemplari erano prodotti dallo stesso conio , mi<br />
avvenne però anche il caso contrario, e cito l'esempio<br />
del mio denaro della Cornelia (Bah. N. 17) già nella<br />
Coli. Gosselin, poi Bclfort, il quale è prodotto da un<br />
conio <strong>di</strong>verso da quello dell'esemplare <strong>di</strong> Vienna.<br />
Ad ogni modo resta assodato che i denari e gli<br />
aurei restituiti <strong>di</strong> Trajano, rari nel loro <strong>com</strong>plesso,<br />
sono tutti singolarmente rarissimi e possiamo <strong>di</strong>re con<br />
sicurezza che fra le monete <strong>di</strong> Trajano le piij rare sono<br />
le sue restituzioni. Difatti, un secolo fa non se ne conosceva<br />
che la metà <strong>di</strong> quelle che ora si conoscono,<br />
qualcheduna appare <strong>di</strong> tempo in tempo e ne va mano<br />
mano aumentando la serie; molte poi non sono conosciute<br />
che per un unico esemplare. Può darsi che<br />
alcune altre esistano in piccole collezioni ignorate e,<br />
assai più che nelle collezioni, altre parecchie possono<br />
giacere ancora nascoste in quel gran serbatojo che<br />
è la terra, da dove forse non usciranno mai. Di altre<br />
infine, data l'esiguità della coniazione, è assai pro-<br />
babile che non ne sia rimasto più alcun esemplare,<br />
che fra l' esserne sopravissuti pochissimi, uno solo o<br />
nessuno la <strong>di</strong>fferenza è assai piccola. E dunque lecito<br />
supporre che il numero delle famiglie, cui venne reso<br />
l'onore della restituzione, fosse assai più grande <strong>di</strong><br />
quello che a noi consta. Io penso che fosse estesissimo<br />
e andrei volontieri fino ad ammettere, <strong>com</strong>e<br />
ipotesi più naturale, che tutte le monete repubblicane<br />
ancora in circolazione al tempo <strong>di</strong> Trajano fossero<br />
restituite. Col che intendo <strong>di</strong>re che, se alcuni tipi<br />
non lo furono, la ragione si deve ricercare in ciò,<br />
che probabilmente quelli, <strong>di</strong> cui era stata più scarsa<br />
in origine la coniazione, erano già s<strong>com</strong>parsi dal<br />
mercato monetario, e certo non è a supporsi che<br />
Trajano, si sia occupato a <strong>com</strong>pletare la serie delle<br />
sue restituzioni con quella cura assidua e paziente<br />
18
138<br />
FRANCESCO GNECCHI<br />
che impiegherebbe oggidì un raccoglitore; ma si sia<br />
accontentato <strong>di</strong> restituire quei denari che naturalmente<br />
gli cadevano sotto mano. Ammesso ciò, rimarrebbe<br />
levato <strong>di</strong> mezzo <strong>com</strong>pletamente anche per<br />
queste il famoso problema della scelta.<br />
E così, da quanto finora siamo andati <strong>di</strong>cendo,<br />
risulterebbe che tutta la faccenda delle restituzioni,<br />
sia repubblicane sia imperiali, invece <strong>di</strong> presentarsi<br />
irta <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà, <strong>di</strong> dubbii e <strong>di</strong> stranezze inespHcabili,<br />
apparirebbe facile e piana, <strong>com</strong>e del resto è natu-<br />
rale che sia, perchè nell'or<strong>di</strong>ne dei fatti non è strano<br />
se non ciò che ignoriamo o che conosciamo male.<br />
" Forse per più sottil persona si vedrebbe in<br />
" ciò più sottile ragione; ma questa è quella ch'io<br />
" ne veggio e che più mi piace (^). »<br />
CLASSIFICAZIONE E COLLOCAMENTO<br />
DELLE RESTITUZIONI.<br />
Lasciando ora il campo della speculazione, veniamo<br />
ad una questione positiva <strong>di</strong> fatto.<br />
In tutti i cataloghi e in tutte le collezioni, le<br />
restituzioni sono collocate sotto il nome del principe<br />
restituito e, <strong>di</strong>rò anzi in via più generale, tutte le<br />
monete postume sono collocate sotto il nome del<br />
principe <strong>com</strong>memorato; così noi ve<strong>di</strong>amo attribuite<br />
ad Augusto i bronzi coniati in Roma al suo nome<br />
sotto Tiberio, e le sue restituzioni coniate tanti anni<br />
dopo da Tito, Domiziano, Nerva, Trajano o Adriano.<br />
Ciò è evidentemente un anacronismo. Può passare<br />
che le monete <strong>di</strong> consacrazione facciano quasi un<br />
seguito alle monete dell'imperatore consacrato, <strong>com</strong>e<br />
impresse imme<strong>di</strong>atamente dopo la sua morte, quasi<br />
(6) Dante, La Vita Nuova. § XXX.
SULLE RESTITUZIONI I39<br />
episo<strong>di</strong>o finale e, <strong>com</strong>e <strong>di</strong>ce la stessa parola, consacrazione<br />
dell'estinto, e d'altronde queste monete non<br />
portano mai il nome <strong>di</strong> chi le ha coniate; ma le<br />
monete postume e <strong>di</strong> restituzione non v' ha dubbio<br />
che devono essere collocate ed attribuite a chi le<br />
ha fatte coniare, qualunque sia il nome che esse<br />
vogliono ricordare e 1* effigie che portano, la quale<br />
costituisce il rovescio e non il dritto della moneta.<br />
L'aver considerato <strong>com</strong>e dritto il lato della testa<br />
fu il primo malinteso che portò l'errore <strong>di</strong> collocamento<br />
delle monete restituite; mentre il dritto è<br />
quello che porta il nome dell' Augusto che fece<br />
coniare la moneta (7), e se, per una semplice acciden-<br />
talità o, <strong>di</strong>remo più precisamente, per l'indole della<br />
moneta stessa, il rovescio, invece <strong>di</strong> una rappresen-<br />
tazione storica, allegorica, religiosa od altro, porta<br />
un ritratto d' un principe trapassato , ciò non ne<br />
mo<strong>di</strong>fica punto la natura e non ne muta la proprietà.<br />
Si lasci dunque che Tito e Domiziano abbiano nella<br />
serie delle proprie monete quelle da essi restituite al<br />
nome d'Augusto, <strong>di</strong> Livia, d'Agrippa e via <strong>di</strong>cendo,<br />
Nerva monete colla testa d'Augusto e d'Agrippina<br />
madre, Trajano tutte le numerose sue restituzioni<br />
repubblicane ed imperiali; sarà assai più ragionevole<br />
che <strong>di</strong>sseminarle in un periodo <strong>di</strong> quattro secoli. Le<br />
teste <strong>di</strong> G. Cesare, d'Augusto, <strong>di</strong> Galba o qualunque<br />
altra e tutti gli antichi tipi repubblicani non faranno<br />
che aumentare le varietà de' rovesci dei <strong>di</strong>versi<br />
restitutori, mentre le monete sono e resteranno<br />
sempre vere e proprie monete <strong>di</strong> chi le ha fatte<br />
coniare e non mai dei principi restituiti. Fare altrimenti<br />
e seguire l'antico sistema <strong>di</strong> classificazione sarebbe<br />
<strong>com</strong>e attribuire ad Anco Marzio o a Numa Pompilio<br />
alcune monete dei Calpurni e dei Marci perchè<br />
(7) E così le ho <strong>di</strong>sposte nella tavola.
140<br />
FRANCESCO GNECCHI<br />
portano le teste <strong>di</strong> quei re. Nelle monete della Re-<br />
pubblica a nessuno è mai venuto il pensiero <strong>di</strong> fare<br />
una simile classificazione perchè V anacronismo e<br />
l'assurdo sarebbero troppo evidenti; si è adottato<br />
invece generalmente per le imperiali perchè s'è co-<br />
minciato da principio a scambiare il dritto pel rovescio<br />
e perchè l'anacronismo non riusciva così patente;<br />
esso però esiste egualmente ed è da augurarsi che<br />
l'errato sistema cessi nelle classificazioni che aspirano<br />
al nome <strong>di</strong> serie.<br />
DESCRIZIONE DELLE RESTITUZIONI.<br />
A Augusto.<br />
RESTITUZIONI DI TITO,<br />
1. Sesterzio. — Sconosciuto a Cohen. Coli. Gnecchi (8).<br />
^B" — DIVVS AVGVSTVS PATER. Augusto ra<strong>di</strong>ato seduto<br />
a sinistra con un ramo e un lungo scettro. — 1^ — IMP<br />
T CAES DIVI VESP F AVG P M TR P P COS Vili. Nel<br />
campo RESI S C. (Anno 80 o 81 d. C).<br />
2. Sesterzio. — Coh. suppl. 68.<br />
^ - DIVVS AVGVSTVS PATER. Augusto ra<strong>di</strong>ato seduto<br />
a sinistra con una patera e uno scettro. — 1^ — T CAES<br />
DIVI VESPI F AVG P M TR P Vili. Nel campo REST S C.<br />
3. Sesterzio. — Coh. 481.<br />
^ — DIVVS AVGVSTVS PATER. Augusto ra<strong>di</strong>ato seduto<br />
a sinistra con un ramo e un lungo scettro. Davanti a<br />
lui un'ara accesa. - 1^ - IMP T CAES DIVI VESP F<br />
AVG P M TR P COS Vili REST. Nel campo S C.<br />
(8) Ve<strong>di</strong> Gazze/fa Nuniisinatica <strong>di</strong> Como. Anno i886.
SULLE RESTITUZIONI<br />
4. Sesterzio. — Coh. 482.<br />
La stessa moneta senza la parola RESI nel rovescio.<br />
Di queste quattro varietà <strong>di</strong> un tipo simile, quelle coli' ara accesa<br />
hanno il loro archetipo nel sesterzio d'Augusto coniato sotto Tiberio<br />
(Coh. N. 27). Le prime sono due varietà in cui<br />
I4I<br />
1' ara venne soppressa.<br />
5. Dnpon<strong>di</strong>o. — Coh. 488.<br />
^ — DIVVS AVG-VSTVS PATER. Testa ra<strong>di</strong>ata a destra. —<br />
9 - IMP T VESP AVG RESI S C Vittoria che vola a<br />
sinistra con uno scudo sul quale si legge S P Q R.<br />
6. Dnpon<strong>di</strong>o. — Coh. 487.<br />
La stessa moneta con testa ra<strong>di</strong>ata a sinistra.<br />
Questo tipo della Vittoria è pure conosciuto in un dupon<strong>di</strong>o d'Au-<br />
gusto coniato sotto Tiberio (Coh. N. 280).<br />
7. Asse. — Coh. 483.<br />
^' - DIVVS AVGVSTVS PATER. Testa ra<strong>di</strong>ata a destra.<br />
- 9/ - IMP T VESP AVG- REST S C. Aquila su <strong>di</strong> un<br />
globo, rivolta a destra.<br />
8. Asse. — Coh. 484.<br />
La stessa moneta con testa ra<strong>di</strong>ata a sinistra.<br />
9. Asse. — Coh. 484 var.<br />
Come il precedente con RESTITVIT.<br />
10. Asse. — Coh. suppl. 70.<br />
^ - DIVVS AVGVSTVS PATER. Testa ra<strong>di</strong>ata a destra.<br />
- 91 - IMP T VESP AVG REST S C Aquila su <strong>di</strong> un<br />
globo rivolta a sinistra.<br />
11. Asse. — Coh. suppl. 69.<br />
La stessa moneta con testa ra<strong>di</strong>ata a sinistra.<br />
12. Asse. — Coh. Aggiunte N. 5, pag. 417.<br />
Variante del N. 11. (Coh. suppl. 70) con RESTITVIT.<br />
13. Asse. — Coh. 485.<br />
^ — DIVVS AVGVSTVS PATER. Testa ra<strong>di</strong>ata a destra.<br />
- 5< - IMP T VESP AVG REST. Aquila su <strong>di</strong> un fulmine<br />
rivolta a sinistra.<br />
14. Asse. — Coh. 486.<br />
La stessa moneta con testa ra<strong>di</strong>ata a sinistra.
142<br />
FRANCESCO GNECCHI<br />
15. Asse. — Ine<strong>di</strong>ta. Coli. Brera.<br />
B' — DIVVS AVG-VSTVS PATER. Testa ra<strong>di</strong>ata a sinistra.<br />
- 9* - IMP T CAES AVG RESTITVIT. Aquila su <strong>di</strong> un<br />
cippo volta a sinistra.<br />
L'aquila sul globo è rappresentata in un asse d'Augusto coniato<br />
sotto Tiberio (Coh. N. 282); sul fulmine e sul cippo non la troviamo<br />
nei bronzi d'Augusto.<br />
16. Asse. — Coh. 489.<br />
& — DIVVS AV&VSTVS PATER. Testa ra<strong>di</strong>ata a sinistra.<br />
— ^ IMP T AVG REST S C. Ara e all'esergo PROVIDENT.<br />
17. Asse. — Coh. 489 var.<br />
La stessa moneta con — 9* — IMP T VESP AVG REST.<br />
i8. Asse. — Coh. Aggiunte 4.<br />
ÌB' — Come il precedente. - ^ — IMP T CAES AVG<br />
RESTITVIT. Ara e all'esergo PROVIDER".<br />
Anche quest'ultimo tipo è conosciuto e anzi <strong>com</strong>unissimo in un asse<br />
d'Augusto coniato sotto Tiberio (Coh. N. 272).<br />
B Livia.<br />
1. Diipon<strong>di</strong>o. — Coh. 6.<br />
^ — IVSTITIA. Busto <strong>di</strong>ademato <strong>di</strong> Livia a destra. —<br />
9( - IMP T CAES DIVI VESP F REST. Nel campo S C<br />
2. Dupon<strong>di</strong>o. — Coh. 7.<br />
^' - Lo stesso. - P — IMP T CAES DIVI VESP F AVG<br />
P M TR P P P COS Vili RESTITV in doppia leggenda.<br />
Nel campo S C (Anno 80 o 81 d. C).<br />
3. Dupon<strong>di</strong>o. — Coh. 8.<br />
^ — PIETAS. Busto velato <strong>di</strong> Livia a destra. — p — IMP<br />
T CAES DIVI VESP F AVG RESTIT. Nel campo S C<br />
4. Dupon<strong>di</strong>o. — Var. del prec. Coli. Gnecchi.<br />
Varietà del precedente con REST.<br />
5. Dupon<strong>di</strong>o. — Sconosciuto a Coh. Coli. Gnecchi (9).<br />
^ - PIETAS. Busto velato <strong>di</strong> Livia a destra. — 9* — IMP<br />
(9) Ve<strong>di</strong> Gazzetta Numismatica <strong>di</strong> Como 1886.
SULLE RESTITUZIONI I43<br />
T CAES DIVI VESP F AVG P M TR P P P COS Vili<br />
RESTITVIT in doppia leggenda. Nel campo S C. (Anno 80<br />
o 8[ d. C).<br />
I due tipi ivsTiTiA e pietas dei dupon<strong>di</strong>i <strong>di</strong> Livia sono esattamente<br />
riprodotti nelle Restituzioni. Potrebbe darsi che si ritrovasse anche la<br />
restituzione del terzo che porta la leggenda salvs avgvsta, del quale<br />
nell'archetipo esiste l'asse e il dupon<strong>di</strong>o. Nei primi due tipi non vi<strong>di</strong><br />
mai che dupon<strong>di</strong>i.<br />
C Agrippa.<br />
I. Asse. -- Coh. 5.<br />
/B' — M AGRIPPA L F COS MI. Testa a sinistra colla corona<br />
rostrale. - :^ - IMP T VESP AVG- REST S C. Nettuno<br />
col tridente e un delfino.<br />
Questa Restituzione riproduce fedelissimamente (<strong>com</strong>prese le leggende<br />
originali, a cui viene aggiunta quella <strong>di</strong> Restituzione) il <strong>com</strong>une<br />
me<strong>di</strong>o bronzo d'Agrippa.<br />
D Tiberio.<br />
1. Sesterzio. — Coh. 57.<br />
B' - CIVITATIBVS ASIAE RESTITVTIS. Tiberio laureato<br />
seduto a sinistra con una patera e uno scettro. —<br />
P - IMP T CAES DIVI VESP F AVG P NI TR P P P COS<br />
VIII REST. Nel campo S C. (Anno 80 o 81 d. C).<br />
Esatta riproduzione del bronzo <strong>di</strong> Tiberio (Coh. N. 51).<br />
2. Asse. — Coh. 58.<br />
/B* - TI CAESAR DIVI AVG F AVGVST IMP Vili. Testa<br />
nuda a destra. - ^f - IMP T CAES DIVI VESP F AVG<br />
RESTITVIT. Nel campo S C (Anno 75<br />
d. C).<br />
3. Asse. — Coh. 59.<br />
& — Medesima leggenda. Testa nuda a sinistra. —<br />
^ - IMP T CAES DIVI VESP F AVG REST. Nel campo S C.<br />
4. Asse. — Coh. 60.<br />
/©' — Come il precedente. - 9^ — IMP T CAES DIVI<br />
VESP F AVGVST TR P P P COS Vili RESTITVIT (in<br />
doppia leggenda). Nel campo S C
144<br />
FRANCESCO GNECCHI<br />
5. Asse. — Coh. 60 var.<br />
^ — Come il precedente. - ^ - IMP T CAES DIVI<br />
VESP F AVG- P M TR P P P COS<br />
doppia leggenda). Nel campo S C<br />
Vili RESTITVIT (in<br />
Questi quattro assi riproducono, colla semplice mutazione della<br />
leggenda nel rovescio, quelli descritti ai Numeri 30 a 33 <strong>di</strong> Cohen.<br />
6. Asse. — Coh. 61.<br />
^ — Come i due precedenti. - 9/ - IMP T CAES DIVI<br />
VESP F AVG RESI S C. Caduceo alato.<br />
Simile all'asse descritto al N. 37 <strong>di</strong> Tiberio.<br />
E Druso.<br />
1. Asse. — Coh. 4.<br />
'!& — DRVSVS CAESAR TI AVO F DIVI AVG N- Testa nuda<br />
a sinistra. — P - IMP T CAES DIVI VESP F AVG REST.<br />
Nel campo S C<br />
2. Asse. — Coh. 5.<br />
';& - Come il precedente. - ^1 — IMP T CAES DIVI<br />
VESP F AVG P M TR P P P COS Vili RESTITV (in dop-<br />
pia leggenda). Anno 80 o 81 d. C.<br />
Riproduzione dei due assi <strong>di</strong> Druso. Coh. N. 2 e 3.<br />
F Nerone Druso.<br />
I. Sesterzio. — Coh, 7.<br />
^ - NERO CLAVDIVS DRVSVS GERMANICVS IMP. Testa<br />
nuda a sinistra. — :^ — IMP T CAES DIVI VESP F AVG-<br />
P M TR P P P COS Vili REST. Nel campo S C (Anno<br />
80 o 81 d. C).<br />
Archetipo sconosciuto. Di Nerone Druso non abbiamo che un solo<br />
sesterzio coniato sotto Clau<strong>di</strong>o, sul cui rovescio, Druso è rappresentato<br />
seduto in mezzo a delle armi. La descritta restituzione non è conosciuta<br />
che per un esemplare appartenente già alla collezione Duprè.<br />
G Germanico.<br />
I. Asse. — Coh, 8,<br />
^ - GERMANICVS CAESAR TI AVG F DIVI AVG N. Testa<br />
nuda a destra. — \^ — IMP T CAES DIVI VESP P AVG<br />
REST. Nel campo S C.
SULLE RESTITUZIONI I45<br />
2. Asse. — Coh. 9.<br />
;& — Come il precedente. - T^ - IMP T CAES DIVI VESP<br />
F AVG P M TR P P P COS Vili RESTITV (in doppia leg-<br />
genda). Nel campo S C (Anno 80 o 8i d. C).<br />
3. Asse.<br />
^ —<br />
— Coh. suppl. 4.<br />
Medesima leggenda. Testa nuda a sinistra. —<br />
I^ - IMP T CAES DIVI VESP F AV& P M TR P P P<br />
COS vili RESTITVIT in doppia leggenda. Nel campo S C<br />
Le tre restituzioni riproducono i tre assi <strong>di</strong> Germanico (Coh. 2, 3 e 4)<br />
coniati sotto Caligola e l'altro (Coh. 6) coniato sotto Clau<strong>di</strong>o, i quali tutti<br />
non hanno al rovescio che le lettere s e con leggenda <strong>com</strong>memorante<br />
l'imperatore che le fece coniare.<br />
H Agrippina Madre.<br />
[. Sesterzio. — Coh. 3.<br />
^ - AGRIPPINA M F GERMANICI CAESARIS. Busto a<br />
destra. - 1> - IMP T CAES DIVI VESP F AVG P M TR<br />
P P P COS Vili REST. Nel campo S C (Anno 80 o 81 d. C).<br />
Riproduzione del sesterzio coniato da Clau<strong>di</strong>o in onore d'Agrippina<br />
(Coh. N. 2); solo che la leggenda originale riferentesi a Clau<strong>di</strong>o venne<br />
sostituita da quella <strong>di</strong> restituzione.<br />
/ Clau<strong>di</strong>o.<br />
1. Sesterzio. — Coh. gì.<br />
^^ - TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP P P.<br />
Testa laureata a destra - P — IMP T VESP AVG REST<br />
S C. La Speranza che cammina a sinistra con un fiore<br />
e sollevandosi la veste.<br />
2. Sesterzio. — Coh. 90.<br />
La stessa, con testa laureata a sinistra.<br />
Tipo esatto del sesterzio colla leggenda spes, descritto al N. 88 <strong>di</strong><br />
Cohen.<br />
3. Dupon<strong>di</strong>o. — Coh. 92.<br />
/!>' — TI CLAVDIVS CAES AVG P M TR P IMP P P. Testa<br />
nuda a destra. - ^ — IMP T CAES AVG REST S C.<br />
Cerere velata seduta a sinistra con due spighe e una torcia.<br />
Tipo identico del dupon<strong>di</strong>o colla leggenda ceres avgvsta, descritto<br />
al N. 72 <strong>di</strong> Cohen.<br />
'9
146<br />
FRANCESCO GNECCHI<br />
4. Asse. — Coh. 93.<br />
ly - TI CL CÀESAR AVG- P M TR P IMP P P. Testa nuda<br />
a destra. - P - IMP TITVS VESP REST S C Pallade<br />
galeata a sinistra con un'asta e portando la mano alla<br />
bocca.<br />
5. Asse. — Sconosciuto a Cohen. Coli. Gnecchi.<br />
^ - T CLÀVDIVS CAESAR AVG- P M TR P IMP. Testa<br />
nuda a destra. - ^l^ — IMP T VESP AVG REST. Pallade<br />
<strong>com</strong>e nel precedente.<br />
Questi due ultimi assi hanno il tipo dell' asse colla leggenda con-<br />
STANTiAE AVGvsTi, descntto al N. 37 <strong>di</strong> Cohen.<br />
6. Asse. — Coh. 94,<br />
^ - TI CLÀVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP P P. Te-<br />
sta nuda a destra. — P — IMP T VESP AVG REST S C.<br />
Pallade galeata a destra collo scudo e in atto <strong>di</strong> lanciare<br />
un giavellotto.<br />
7. Asse. — Coh. 95.<br />
La stessa con testa nuda a sinistra.<br />
Tipi dell'asse senza leggenda, ma colla rappresentazione <strong>di</strong> Pallade<br />
battagliera, descritto al N. 87 <strong>di</strong> Cohen.<br />
K Galea.<br />
r. Sesterzio. — Coh. 247.<br />
rB' - IMP SER SVLP GALBA CAES AVG TR P. Testa laureata<br />
a destra. — :^ — IMP T CAES DIVI VESP F AVG<br />
P M TR P P P COS Vili REST. Nel campo S C. (Anno<br />
80 o 81 d. C).<br />
2. Asse o Dupon<strong>di</strong>o? — Coh. 248.<br />
^ - SER GALBA IMP CAES AVG TR P. Testa laureata<br />
a destra. - 1^ - IMP T CAES DIVI VESP F AVG REST.<br />
Nel campo S C.<br />
3. Dupon<strong>di</strong>o. — Sconosciuto a Cohen. Coli. Gnecchi (^o).<br />
^ - SER GALBA IMP CAES AVG TR P. Testa laureata a<br />
destra. - 9^ - IMP T CAES DIVI VESP F AVG P M TR<br />
(io) Pubblicato nella Gazzetta Numismatica <strong>di</strong> Como anno 1886.
SULLE RESTITUZIONI<br />
P P P COS Vili RESTITVIT. In doppia leggenda. Nel<br />
campo S C<br />
Di Galba non si conoscono bronzi colle semplici lettere s e al rovescio.<br />
4. Asse o Dupon<strong>di</strong>o? — Coh. 249.<br />
1& - SER GALBA IMP CAES AVG- TR P. Testa laureata a<br />
destra. - ^1 — IMP T VESP AVO REST S C. La Libertà<br />
con un berretto e uno scettro.<br />
Molti sono i bronzi (assi e dupon<strong>di</strong>i) <strong>di</strong> Galba col tipo della Libertà<br />
e colle leggende libertas avgvsta o libertas pvblica. — Ve<strong>di</strong> Cohen<br />
da N. 134 a 155.<br />
5. Asse o Dupon<strong>di</strong>o? — Coh. 250.<br />
^ - Come i precedenti. - 1^ — IMP T VESP AVG REST<br />
S C. La Pace laureata a sinistra colla cornucopia e con<br />
una face abbassata, con cui dà fuoco ad un mucchio d'armi.<br />
La Pace con questi emblemi è rappresentata in un dupon<strong>di</strong>o <strong>di</strong><br />
Galba descritto al N. 173 <strong>di</strong> Cohen, colla leggenda paxs avgvsti.<br />
A Augusto.<br />
RESTITUZIONI DI DOMIZIANO.<br />
1. Asse. ~ Coh. 490.<br />
^ — DIVVS AVGVSTVS PATER. Testa ra<strong>di</strong>ata a sinistra.<br />
Sopra una stella. - ^^ - IMP D CAES AVG RESTITVIT<br />
S C. Aquila su <strong>di</strong> un globo rivolta a destra.<br />
Vedansi i tipi simiU <strong>di</strong> Tito. (5, 6, 7, 8).<br />
2. Asse. — Coh. 491.<br />
^ — Come il precedente. — 1^ — IMP D AVG REST S C.<br />
Ara. AU'esergo PROVIDEIT.<br />
Vedasi il tipo simile <strong>di</strong> Tito (N. 13).<br />
Il Cohen (Suppl. N. 71) pubblica, <strong>com</strong>e altra restituzione <strong>di</strong> Domi-<br />
ziano, la seguente:<br />
D — DIVVS AVGVSTVS PATER. Tcsta ra<strong>di</strong>ata a sinistra. — R — imp<br />
D VESP AVG REST s c Vittoria che cammina a sinistra con uno scudo<br />
su cui si leggono le lettere s p q r.<br />
E nella li E<strong>di</strong>zione aggiunge che questo bronzo è <strong>di</strong> fabbrica asiatica.<br />
Quanto a me inclinerei a credere che sia un bronzo barbaro, nel quale<br />
venne mutato per errore il t in un d, perchè il nome <strong>di</strong> Vespasiano<br />
non si vede mai associato a quello <strong>di</strong> Domiziano e si tratterebbe quin<strong>di</strong><br />
del Dupon<strong>di</strong>o restituito da Tito.<br />
I47
148 FRANCESCO GNECCHI<br />
B Agrippa.<br />
I. Asse. — Coh. 6.<br />
B' — \A AG-RIPPA L F COS III. Testa a sinistra colla co-<br />
rona rostrale. - ^ - IMP D AVG RESI S C Nettuno<br />
<strong>di</strong> fronte col tridente e un delfino.<br />
Tipo del bronzo <strong>com</strong>une d'Agrippa, <strong>com</strong>e la restituzione <strong>di</strong> Tito.<br />
C TlBEBIO.<br />
I. Asse. — Coh. 62.<br />
^' - TI CAESAR DIVI AVO F AVGVST IMF Vili. Testa<br />
laureata a sinistra. — ^ - IMP D CAES DIVI VESP F<br />
AVG REST. Nel campo S C<br />
Tipo <strong>di</strong> alcuni bronzi <strong>di</strong> Tiberio, <strong>com</strong>e le restituzioni <strong>di</strong> Tito (N. 2,<br />
3. 4. e 5).<br />
D Druso.<br />
I. Asse. — Coh. 6.<br />
^B' - DRVSVS CAESAR TI AVG F DIVI AVG N. Testa nuda<br />
a sinistra. - 1^ - IMP D CAES DIVI VESP F AVG RESI.<br />
Nel campo S C<br />
Tipo identico alla restituzione <strong>di</strong> Tito (N. i).<br />
E Germanico.<br />
I. Asse. — Coh. IO,<br />
^^ - GERMANICVS CAESAR TI AVG F DIVI AVG N. Testa<br />
nuda a sinistra. - ^ - IMP D CAES DIVI VESP F AVG<br />
REST. Nel campo S C.<br />
Tipo identico alla restituzione <strong>di</strong> Tito (N. i).<br />
F Clau<strong>di</strong>o.<br />
T. Sesterzio. — Coh. 96.<br />
-B' - TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M TR P IMP P P.<br />
Testa laureata a sinistra. — Ijj - |mP D CAES AVG<br />
REST S C La Speranza che cammina a sinistra con un<br />
fiore e sollevandosi la veste.<br />
Tipo identico alla restituzione <strong>di</strong> Tito (N. i).
SULLE RESTITUZIONI I49<br />
2. Asse. — Sconosciuto a Cohen, Coli. Romussi a Milano.<br />
,& - TI CLAVDIVS CAESAR AVO P M TR P IMP P P.<br />
Testa nuda a destra. - 1^ - IMP P AVG RESI S C<br />
Pallade galeata e collo scudo a destra in atto <strong>di</strong> lanciare<br />
un giavellotto,<br />
3. Asse. — Coh. suppl. 14.<br />
fB* — Leggenda <strong>com</strong>e il precedente; ma testa nuda a<br />
sinistra. — ^ — Come il precedente.<br />
4. Asse. — Sconosciuto a Cohen, Coli. Gnecchi.<br />
Come il precedente colla leggenda del rovescio IMP DOMIT<br />
AVO REST S C<br />
Ve<strong>di</strong> 1 tipi identici alle restituzioni <strong>di</strong> Tito. (N. 6 e 7).<br />
A Augusto.<br />
RESTITUZIONI DI NERVA.<br />
(Argento).<br />
r. Denaro (^i). — Coh. 492 d'Augusto.<br />
ly — DIVVS AVGVSTVS. Testa nuda d'Augusto a destra.<br />
- 9( — IMP NERVA CAES AVG REST. Capricorno a<br />
destra con un globo e un timone ; sul suo dorso una<br />
cornucopia.<br />
Riproduzione del denaro N. 52 <strong>di</strong> Cohen.<br />
2. Sesterzio. — Coh. 493.<br />
,& — DIVVS AVGVSTVS. Testa laureata a destra. — 1^ -<br />
IMP NERVA CAESAR AVGVSTVS REST. Nel campo S C.<br />
3. Sesterzio. — Coh. 494.<br />
i^ — DIVVS AVGVSTVS. Testa laureata a sinistra. —<br />
^ — Come il precedente.<br />
I sesterzi d'Augusto colle lettere s e occupanti il campo del rove-<br />
scio e con leggenda relativa a Tiberio (mutato qui nella leggenda <strong>di</strong><br />
restituzione) non hanno mai al dritto la testa d'Augusto, bensì la sua<br />
figura seduta colla leggenda <strong>di</strong>vvs avgvstvs pater (quali furono resti-<br />
tuiti da Tito), oppure il carro tirato dagli elefanti o finalmente lo scudo<br />
coi capricorni. Dimodoché il vero archetipo si può <strong>di</strong>re che non esiste.<br />
(11) L'esemplare riprodotto alla tavola appartiene al Museo Britannico<br />
e forse è unico.
I50<br />
4. Sesterzio. — Coli. 499.<br />
FRANCESCO GNECCHI<br />
iSf - IMP NERVA CAESAR AVCrVSTVS RESI. Augusto seduto<br />
a sinistra, presso <strong>di</strong> un' ara accesa, con un ramo<br />
d'alloro e lo scettro. — ^ — DIVVS AVGVSTVS. Nel<br />
campo S C.<br />
Il dritto è imitato dal sesterzio coniato da Tiberio (Coh. 27) colla<br />
leggenda <strong>di</strong>vvs avgvstvs pater, alla quale, eccezionalmente venne so-<br />
stituita la leggenda <strong>di</strong> restituzione, che solitamente è posta al rovescio.<br />
Al rovescio venne <strong>di</strong> conseguenza collocata la leggenda del dritto abbreviata<br />
in DIVVS AVGVSTVS.<br />
5. Dupon<strong>di</strong>o. — Coh. 495.<br />
^ - DIVVS AVGVSTVS. Testa ra<strong>di</strong>ata a destra. — IJf —<br />
IMP NERVA CAES AVG REST S C Timone su <strong>di</strong> un globo.<br />
Il tipo del timone su <strong>di</strong> un globo non si conosce fra le monete<br />
d'Augusto, ma solamente fra quelle <strong>di</strong> Tiberio (V. Coh. N. 26, 27, e 28),<br />
e sono assi.<br />
6. Asse. — Coh. 496.<br />
1& — Stessa leggenda. Testa nuda a destra. — I^ — IMP<br />
NERVA CAES AVG REST S C. Altare.<br />
Tipo dell'asse N. 272, a cui venne soppressa la leggenda provident.<br />
7. Asse. — Coh. 497.<br />
^ - Come il precedente. - 9/ - IMP NERVA CAES AVG<br />
REST S C Fulmine.<br />
Tipo dell'asse N. 281.<br />
8. Asse. — Coh. 498.<br />
^ — Come il precedente. — ?! - IMP NERVA CAES AVG<br />
REST S C Aquila su <strong>di</strong> un fulmine rivolta a destra.<br />
9. Asse. — Sconosciuto a Cohen, Collez. Doimo Savo a Spalato.<br />
^ - Come il precedente. — 9/ - IMP NERVA CAES AVG<br />
REST S C Aquila su <strong>di</strong> un globo, rivolta a destra.<br />
B Agrippina Madre.<br />
I. Sesterzio. — Coh. suppl. 2.<br />
,^ — AGRIPPINA M F GERMANICI CAESARIS. Busto a destra.<br />
- ^ — IMP NERVA CAES AVG P M TR P COS<br />
III P P. Nel campo REST S C<br />
Riproduzione del sesterzio coniato da Clau<strong>di</strong>o in onore d'Agrippina;<br />
solo che alla leggenda originale del rovescio venne sostituita quella<br />
<strong>di</strong> restituzione.
SULLE RESTITUZIONI<br />
RESTITUZIONI DI TRAJANO (12).<br />
A Giulio Cesare.<br />
1. Aureo (13). — Coh. 53.<br />
©' - C. IVLIVS CAES IMP COS III. Testa nuda <strong>di</strong> Giulio<br />
Cesare a destra. - 1^ - IMP CAES TRAIAN AVO GER<br />
DAC P P RESI. Venere seminuda a destra appoggiata<br />
a una colonna con un elmo e un'asta.<br />
L'archetipo <strong>di</strong> questa restituzione non esiste. Il rovescio della Ve-<br />
nere Vittoriosa, quale viene qui rappresentato, non appare che sotto<br />
Augusto ed è poi riprodotto da Tito.<br />
2. Aureo. — Coh. 54.<br />
i^ — DIVVS IVLIVS. Testa nuda <strong>di</strong> G. Cesare a destra.<br />
— IJ( — Leggenda <strong>di</strong> restituzione <strong>com</strong>e la precedente.<br />
Nemesi che cammina a destra con un caduceo. Ai suoi<br />
pie<strong>di</strong> un serpente.<br />
Anche <strong>di</strong> questa restituzione l'archetipo non esiste. La Nemesi non<br />
è introdotta che nelle monete <strong>di</strong> Clau<strong>di</strong>o.<br />
B Augusto.<br />
1. Denaro. — Coh. 500.<br />
^ — CAESAR III VIR R P C. Testa<br />
^ — Leggenda e. s. Se<strong>di</strong>a curule,<br />
nuda<br />
su cui<br />
a destra. —<br />
una corona.<br />
Manca l'archetipo. Il tipo della se<strong>di</strong>a curule viene introdotto solamente<br />
da Tito e Domiziano.<br />
2. Aureo. — Coh. 501.<br />
^ — DIVVS AVGVSTVS. Testa laureata a destra. — pi —<br />
Leggenda e. s. Aquila romana fra due insegne.<br />
Manca l'archetipo. Il rovescio dell' Aquila romana fra le due insegne<br />
è proprio del solo Nerone.<br />
3. Aureo. — Coh. 502.<br />
^' — CAESAR AVG-VSTVS DIVI F PATER PATRIAE. Testa<br />
(12) Si omette la serie delle restituzioni repubblicane le quali sono<br />
troppo note e d'altronde qui non avrebbero interesse, essendo, <strong>com</strong>e si<br />
<strong>di</strong>sse, la riproduzione esatta dei denari originali.<br />
(13) Tutte le restituzioni <strong>di</strong> Trajano riprodotte nella tavola appartengono<br />
alla mia collezione.<br />
15I
152<br />
FRANCESCO GNECCHI<br />
laureata a destra. — ^ — Leggenda <strong>di</strong> restituzione e. s.<br />
Coccodrillo a destra.<br />
La rappresentazione del coccodrillo è riprodotta dal denaro d'Augusto<br />
che porta la leggenda aegypto capta. (Coh. 41). È variata anche<br />
la leggenda del dritto, la quale nel denaro originale è caesar cos vi,<br />
ed è levato il bastone augurale che pure figura nell'originale <strong>di</strong>etro la<br />
testa d'Augusto. Di più la testa d'Augusto, nuda nel denaro, qui è laureata.<br />
C Tiberio.<br />
I. Aureo. — Coh. 63.<br />
^ — -W CAESAR DIVI AVO F AYGVSTVS. Testa laureata<br />
a destra. — p — Leggenda e. s. Livia seduta a destra<br />
con uno scettro e un fiore.<br />
Questa restituzione riproduce esattamente 1' aureo o il denaro <strong>di</strong><br />
Tiberio col rovescio <strong>di</strong> Livia meno la leggenda pontif maxim del rovescio.<br />
D Clau<strong>di</strong>o.<br />
1. Aureo. — Coh. 97.<br />
^ — DIVVS CLAVDIVS. Testa laureata a destra. — ^ —<br />
Leggenda e. s. La Concor<strong>di</strong>a seduta a sinistra con una<br />
patera e una doppia cornucopia.<br />
L'archetipo manca. Il tipo della Concor<strong>di</strong>a, <strong>com</strong>e qui rappresentato,<br />
non appare che sotto Vitellio e viene poi adottato da Vespasiano e<br />
da Tito.<br />
2. Aureo. — Coh. Suppl. 15.<br />
^ — 1\ CLAVD CAESAR AVO P M IR P VI IMP X. Testa<br />
laureata a destra. — ^ — Leggenda e. s. La Speranza<br />
che cammina a sinistra, con un fiore e sollevandosi la<br />
veste.<br />
E il tipo <strong>di</strong> un sesterzio <strong>com</strong>une <strong>di</strong> Clau<strong>di</strong>o, il quale porta la leggenda<br />
SPES avgvsta; manca però sia nell'oro che nell'argento.<br />
3. Aureo. — Sconosciuto a Cohen, Coli. Gnecchi (h).<br />
^' — DIVVS CLAVDIVS. Testa laureata a destra. —<br />
^ — Leggenda e. s. Vesta velata e <strong>di</strong>ademata seduta<br />
a sinistra con una patera e una face.<br />
L'archetipo manca, e la rappresentazione <strong>di</strong> Vesta è contemporanea<br />
a TraJane.<br />
(14) Pubblicato nella Riv. It. <strong>di</strong> Num. 1888. Appunti <strong>di</strong> Num. Rem.<br />
N. I. Ve<strong>di</strong> riproduzione nella unita tavola III.
E Galea.<br />
SULLE RESTITUZIONI 15<br />
I. Aureo. — Coh. N. 251.<br />
^ — GALBA IMPERATOR. Testa laureata a destra. —<br />
p — Leggenda e. s. La Libertà a sinistra col berretto<br />
e un'asta.<br />
Esiste un aureo <strong>di</strong> Galba con questa rappresentazione al rovescio<br />
ac<strong>com</strong>pagnata dalla leggenda libertas pvblica. Al dritto porta imp<br />
GALBA.<br />
F Vespasiano,<br />
1. Aureo. — Coh. 507.<br />
^ - IMP CAESAR VESPASIANVS AVG COS Villi. Testa<br />
laureata a destra. — ^ — Leggenda e. s. Prigioniero<br />
inginocchiato appie<strong>di</strong> d'un trofeo.<br />
Questo rovescio non appare che sotto il regno <strong>di</strong> Tito.<br />
2. Aureo. — Coh. 508.<br />
^' - DIVVS VESPASIANVS. Testa laureata a destra. -<br />
P — Leggenda e. s. Fulmine alato su <strong>di</strong> un trono.<br />
Anche questo rovescio non appare che sotto il regno <strong>di</strong> Tito.<br />
3. Aureo. — Coh. suppl. 94.<br />
^' - DIVVS VESPASIANVS. Testa laureata a destra. -<br />
^ — Leggenda e. s. Busti affrontati e paludati <strong>di</strong> un<br />
giovane a testa nuda con un caduceo <strong>di</strong>etro le spalle<br />
(Mercurio?) e d' un uomo barbuto (Ercole?) pure a capo<br />
scoperto. Al <strong>di</strong>sotto un astro.<br />
L'archetipo <strong>di</strong> questa moneta non solo ci manca fra le monete <strong>di</strong><br />
Vespasiano, ma ci è affatto sconosciuto. Potrebbe darsi si trattasse<br />
d'una moneta estremamente rara, <strong>di</strong> cui non giunse alcun esemplare<br />
fìno a noi.<br />
G Tito.<br />
I. Aureo. — Coh. 317.<br />
^' - IMP TITVS CAES VESPASIAN AVG P M. Testa lau-<br />
reata a destra. — j^ — Leggenda e. s. Trofeo.<br />
La moneta è conosciuta fra quelle <strong>di</strong> Tito, con leggenda in<strong>di</strong>cante<br />
una data al rovescio.
154<br />
FRANCESCO GNECCHl<br />
2. Aureo. — Coh. 318.<br />
^ _ DIVVS TITVS. Testa laureata a sinistra. — 5* —<br />
Leggenda e. s. Fulmine alato su <strong>di</strong> un trono.<br />
Nel rovescio è qui riprodotta una vera moneta <strong>di</strong> Tito, senza la<br />
leggenda, che nelle monete originarie porta varie date. Questo rovescio<br />
è quello che appare anche nell'aureo che lo stesso Trajano restituì <strong>di</strong><br />
Vespasiano, e che fu descritto al N. 12. Anzi aggiungerò che i due<br />
esemplari della mia collezione, uno col nome <strong>di</strong> Vespasiano l'altro con<br />
quello <strong>di</strong> Tito, hanno il rovescio prodotto dall'identico conio.<br />
H Nerva.<br />
1. Aureo. — Coh. 124.<br />
^ — DIVVS NERVA. Testa laureata a destra. - :^ -<br />
Leggenda e. s. Nerva con uno scettro e un ramo, seduto<br />
su <strong>di</strong> un carro tirato da due elefanti.<br />
L'archetipo manca fra le monete <strong>di</strong> Nerva. Un rovescio simile, se<br />
non identico, è conosciuto in un aureo <strong>di</strong> Nerone e Agrippina.<br />
2. Aureo. — Coh. 125.<br />
i^ - DIVVS NERVA. Testa laureata a destra. - ^ - Leggenda<br />
e. s. Due mani giunte.<br />
Moneta <strong>com</strong>une fra gli aurei e i denari <strong>di</strong> Nerva, con leggenda<br />
in<strong>di</strong>cante una data.<br />
A Augusto.<br />
RESTITUZIONI D'ADRIANO.<br />
I. Medaglione d'argento <strong>di</strong> conio asiatico. Coh. 503.<br />
^ — IMP CAESAR AVG-VSTVS. Testa nuda a destra. -<br />
^ — HADRIANVS AV& P P REN. Adriano velato a de-<br />
stra. Tiene un mazzo <strong>di</strong> spighe (15) nella destra ed ha la<br />
sinistra avvolta nella toga.<br />
In questo medaglione troviamo eccezionalmente la parola ren<br />
(ovavit) in luogo <strong>di</strong> rest (ituit), motivo pel quale la moneta non la si<br />
(15) Cohen <strong>di</strong>ce con ima patera; ma è evidentemente un errore,<br />
perchè Cohen descrive l'esemplare <strong>di</strong> Londra, e l'esemplare <strong>di</strong> Londra<br />
è quello che figura pel primo nell'unita tavola, ove si vedono chiaramente<br />
due spighe nella destra dell'imperatore. Il secondo esemplare della<br />
stessa tavola III (che ho creduto pure <strong>di</strong> riprodurre, trattandosi forse dei<br />
due soli esemplari esistenti da questa rarissima moneta) appartiene alla
SULLE RESTITUZIONI I55<br />
vorrebbe ritenere una vera restituzione, argomentando che più probabilmente<br />
potesse riferirsi al rinnovamento <strong>di</strong> qualche tempio o <strong>di</strong> qualche<br />
monumento; e anche Eckkel, dopo aver citate le <strong>di</strong>verse opinioni, con-<br />
clude <strong>di</strong>cendo : Arbitretitr lector, cuj'us explicaiio videatur praeferenda.<br />
Quanto a me, considerando che il verbo renovare ha molto prossimamente<br />
lo stesso significato del verbo restituire, che si tratta <strong>di</strong> una co-<br />
niazione asiatica, il che può far ammettere una piccola <strong>di</strong>fferenza lin-<br />
guistica, e che infine si tratta <strong>di</strong> una rievocazione <strong>com</strong>e è nell'indole<br />
<strong>di</strong> tutte le altre restituzioni, non esisterei a collocarla fra queste.<br />
B Trajano.<br />
I. Denaro. — Coh. 541.<br />
B' - DIVVS TRAIANVS PATER AVG-VSTVS. Busto laureato<br />
a destra. - ^ — m? HADRIAN DIVI NER TRAIAN OPT<br />
FIL RES. Adriano sacrificante presso <strong>di</strong> un'ara.<br />
Il tipo non esiste fra le monete <strong>di</strong> Traiano. Pare che Adriano si<br />
sia piuttusto ispirato alle monete proprie, riproducendo il tipo <strong>di</strong> un<br />
suo denaro che porta la leggenda vota pvblica, e ac<strong>com</strong>pagnando<br />
colla propria figura sacrificante 1' omaggio figliale d' una rievocazione<br />
dell' effigie paterna. A questa dunque unicamente si riferisce la resti-<br />
tuzione.<br />
RESTITUZIONE M. AURELIO E LUCIO VERO.<br />
A M. Antonio.<br />
(Argento).<br />
I. Denaro. — Coh. 84.<br />
B — ÀNTONIVS AVGVR III VIR R P C Galera pretoriana.<br />
— ^ — LEG- VI. Aquila legionaria tra due insegne mi-<br />
litari. All'intorno: ANTONINVS ET VERVS REST.<br />
Questa restituzione riproduce esattamente il denaro della Leg. VI<br />
<strong>di</strong> M. Antonio, meno la <strong>di</strong>fiferenza <strong>di</strong> leggenda, la quale nel denaro<br />
originario è semplicemente ant avg in luogo <strong>di</strong> antoninvs avgvr.<br />
mia collezione. Come si vede è prodotto da altro conio e nella mano<br />
dell'imperatore si vedono tre spighe. Riesce tanto più strana la descri-<br />
zione <strong>di</strong> Cohen, perchè anche Eckhel, il quale riportava la moneta da<br />
Vaillant (Voi. II, pag. 30), <strong>com</strong>e esistente nel Museo Apostolo Zeno (e<br />
forse è il medesimo esemplare del Museo Britannico) <strong>di</strong>ce: Figura togata<br />
stans d. duas spicas praefert, sinistra togae involuta (Voi. V, pag. 102).
Prospetto riassuntivo delle Restituzioni imperiali<br />
Tipo Moneta Restitutori<br />
Aquila legionaria Denaro<br />
Venere<br />
M. ANTONIO<br />
GIULIO CESARE<br />
M. Aurelio e L, Vero
SULLE RESTITUZIONI 157<br />
Tipo Moneta Restitutori<br />
S e nel campo Sesterzio<br />
S C nel campo Asse<br />
S C nel campo<br />
La Speranza Sesterzio<br />
Cerere Dupon<strong>di</strong>o<br />
Pallade pacifica Asse<br />
(Tipo della Costanza)<br />
Pallade guerriera Asse<br />
La Concor<strong>di</strong>a Aureo<br />
La Speranza Aureo<br />
Vesta Aureo<br />
S C nel campo Sesteriio<br />
S C nel campo Dupon<strong>di</strong>o<br />
La Libertà Asse?<br />
La Pace Asse?<br />
La Libertà Aureo<br />
Trofeo Aureo<br />
Fulmine sul trono Aureo<br />
Due busti Aureo<br />
Trofeo Aureo<br />
Fulmine sul trono Aureo<br />
Carro d'elefanti Aureo<br />
Due mani giunte Aureo<br />
Adriano sacrificante Denaro<br />
NERONE DRUSO<br />
Tito —<br />
GERMANICO<br />
Tito Domiziano<br />
AGRIPPINA MADRE<br />
Sesterzio Tito — Nerva —<br />
CLAUDIO<br />
Tito Domiziano<br />
Tito<br />
Tito<br />
—<br />
Domiziano —<br />
Tito Trajano<br />
Trajano<br />
Trajano<br />
GALEA<br />
Tito<br />
Tito<br />
Tito<br />
Tito<br />
VESPASIANO<br />
TITO<br />
NERVA<br />
TRAJANO<br />
— Trajano<br />
Trajano<br />
Trajano<br />
Trajano<br />
Trajano<br />
Trajano<br />
Trajano<br />
Trajano<br />
—<br />
—<br />
— Ad;-iaD0<br />
Francesco Gnecchi.
LO ZECCHINO DI PORCIA<br />
Fra le monete cosidette " <strong>di</strong> ostentazione „, e<br />
tutte qual piia qual meno pregevoli e rare, le quali<br />
furono coniate al <strong>di</strong> là delle Alpi nel secolo scorso<br />
per conto <strong>di</strong> signori italiani, quasi soltanto a far<br />
pompa dell'arme sormontata dal berretto principesco,<br />
e del titolo <strong>di</strong> Principe del Sacro Romano Impero, la<br />
meno nota e insieme la piij squisitamente preziosa è<br />
forse lo zecchino fatto coniare, probabilmente a Vienna,<br />
da Annibale Alfonso Emanuele <strong>di</strong> Porcia nel Friuli,<br />
Tanno 1704.<br />
La esigua schiera delle rimanenti monete <strong>di</strong><br />
ostentazione suddette, <strong>com</strong>prende quelle <strong>di</strong> Antonio<br />
Tolomeo Gallio Trivulzio per il suo feudo <strong>di</strong> Retegno<br />
in Lombar<strong>di</strong>a, le monete <strong>di</strong> Belgioioso, pure in Lom-<br />
bar<strong>di</strong>a, del Vasto negli Abruzzi, <strong>di</strong> Belmonte e <strong>di</strong><br />
San Giorgio nelle Calabrie, e <strong>di</strong> Ventimiglia in Si-<br />
cilia; <strong>com</strong>e dall'elenco qui appresso.
l6o<br />
SOLONE AMBROSOLI<br />
RETEGNO.<br />
Antonio Tolomeo Gallio Trivulzio barone (1708-26):<br />
zecchino del 1724 (1), zecchino del 1726 (2), tallero (3) e mezzo<br />
tallero (4).<br />
lero (6).<br />
BELGIOIOSO.<br />
Antonio da Barbiano principe (1769): zecchino {5) e tal-<br />
VASTO.<br />
Cesare d'Avalos marchese (1706): pezzi in oro battuti<br />
coi conii del tallero (7), zecchino (8), mezzo zecchino (9), tal-<br />
lero (io) e mezzo tallero (11).<br />
(i) Monnoies en or, qui <strong>com</strong>posent une des <strong>di</strong>fférentes parties du Ca-<br />
binet de S. M. l'Empereur. Vienne, 1759. — (a pag. 263).<br />
n. 4).<br />
LiTTA, Famiglie celebri d'Italia. Gallio <strong>di</strong> Como. — (n. 4).<br />
Gnecchi (F. ed E.), Le Monete dei Trivulzio. Milano, 1887. — (tav. Vili,<br />
(2) Gnecchi, op. ^it. — (tav. Vili, n. 5).<br />
(3) Monnoies en argent, qui <strong>com</strong>posent une des parties du Cabinet,<br />
etc. Vienne, 1759. — (^a pag. 473).<br />
LlTTA, 1. c. — (n. 5).<br />
Gnecchi, op. cit. — (tav. Vili, n. 6).<br />
Catalogo della Collezione A. Cantoni. Milano, 1887. - (tav. Ili, n. 1201).<br />
(4) Monnoies en argent, etc. — (a pag. 473).<br />
Litta, 1. e. — (n. 3).<br />
Gnecchi, op. cit. — (tav. Vili, n. 7).<br />
(5) Benaven (J. M.), Le Caissier Italien. Tome II. — (tav. 8r, n. io).<br />
Ambrosoli (S.), Zecche Italiane. Como, 1881. — (tav. I-II, n. 8).<br />
(6) Ambrosoli, op. cit. — (tav. I-II, n. 9).<br />
(7) Monnoies en or, etc. — (a pag. 258).<br />
(8) Ivi.<br />
Collezione Sambon: Monete dell'Italia meri<strong>di</strong>onale. Milano, 1897. —<br />
(tav. IX, n. 1534).<br />
(9) Ambrosoli (S.), Il mezzo zecchino del Vasto. — In <strong>Rivista</strong> Italiana<br />
<strong>di</strong> Numismatica. Anno IV. Milano, 1890. — (a pag. 543).<br />
(io) Monnoies en argent, etc. — (a pag. 474).<br />
Catal. d. Collez. Cantoni. — (tav. Ili, n. 1497).<br />
(11) Monnoies en argent, etc. — (a pag. 474).
LO ZECCHINO DI PORCIA l6l<br />
BELMONTE.<br />
Antonio Pignatelli principe (1733): zecchino (12).<br />
SAN GIORGIO.<br />
Giovanni VI Domenico Milano marchese (1732): doppio<br />
zecchino (13), zecchino (14), tallero [?] e mezzo tallero (15).<br />
Mezzo tallero <strong>com</strong>memorativo, del 1740.<br />
Gia<strong>com</strong>o IV Francesco Milano marchese (1753): tal-<br />
lero (16).<br />
VENTIMIGLIA.<br />
Giovanni Requesens conte (1725): doppio zecchino (^7) e<br />
mezzo tallero (iS).<br />
A questo elenco sarebbe forse da aggiungere Io<br />
zecchino <strong>di</strong> cui fece preparare i conii nel 1731 il<br />
principe Nicolò Meli-Lupi <strong>di</strong> Soragna nell'Emilia (^9),<br />
(12) KòHLER (J. D.), Htstorische Miins-Belustigung. Voi. XVIII.<br />
Nurnberg. — (a pag. 257).<br />
Monnoies en or, etc. — (a pag. 261).<br />
Catalogo della Collesione del Cav. Giancarlo Rossi. Roma, 1880. —<br />
(tav. I, n. 346).<br />
Catalogo della Collezione Fusco. Roma, 1882. — (tav. I, n. 89).<br />
Catal. d. Collez. Sambon. — (tav. IX, n. 1533).<br />
(13) Monnoies en or, etc. — (a pag. 260).<br />
(14) Ivi.<br />
(15) KuNZ (Carlo), // Museo Bottacin annesso alla Civica Biblioteca e<br />
Museo <strong>di</strong> Padova. — In Perio<strong>di</strong>co <strong>di</strong> Numismatica e Sfragistica per la<br />
storia d'Italia, <strong>di</strong>retto dal March. Carlo Strozzi. Volume terzo. Firenze,<br />
1871. — (tav. XII, n. 7).<br />
(16) Monnoies en arg., etc. — (a pag. 469).<br />
Catal. d. Collez. Rossi. — (tav. VII, n. 4604).<br />
(17) Monnoies en or, etc. — (a pag. 264).<br />
(18) Monnoies en arg., etc. — (a pag. 474).<br />
(19) PiGORiNi (Luigi), Moneta, medaglie e sigilli dei Marchesi e Prin-<br />
cipi <strong>di</strong> Soragna. Parma, 1867. — (alla tav. annessa).<br />
Catal. d. Collez. Rossi. — (tav. VII, n. 4846).<br />
Ambrosoli (S.), Zecche Italiane. Como, 1881. — (tav. III-IV, n. 3).
l62<br />
SOLONE AMBROSOLl<br />
se la cussione <strong>di</strong> quella moneta avesse effettivamente<br />
allora avuto luogo (^o).<br />
Ad ogni modo (prescindendo se si vuole da Soragna,<br />
che costituisce un caso isolato; il quale d'altronde<br />
non infirma ciò che sto per <strong>di</strong>re), uno sguardo<br />
all'elenco basterà per <strong>di</strong>mostrare che nessuna delle<br />
signorie ivi <strong>com</strong>prese ^^^\ eccetto Belmonte, ebbe una<br />
monetazione così scarsa <strong>di</strong> specie <strong>com</strong>e la ebbe Porcìa;<br />
poiché questi due feu<strong>di</strong> soltanto sono rappresentati<br />
rispettivamente da un'unica specie monetaria: lo zec-<br />
chino.<br />
Bisogna aggiungere poi, che se lo zecchino <strong>di</strong><br />
Belmonte è moneta rara, quello <strong>di</strong> Porcia lo è in<strong>com</strong>parabilmente<br />
<strong>di</strong> pili, oltre all'essere rarissimo in<br />
via assoluta : ci troviamo quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> fronte ad una<br />
moneta che occupa un posto affatto privilegiato nella<br />
serie <strong>italiana</strong>.<br />
Ed eccone la descrizione:<br />
Oro. Zecchino.<br />
i& - HAN :<br />
ALP<br />
: EM :<br />
SA<br />
:<br />
ROM<br />
: IMP : PRIN : A : PORO<br />
ti {rosela).<br />
Entro cerchio <strong>di</strong> perline: busto del Principe, <strong>di</strong> fronte,<br />
con corazza e grande parrucca inanellata.<br />
(20) PiGORiNi, op. cit. — (a pag. 13 : " .... certo si è che delle mo-<br />
" nete del tempo non ve ij'ha alcuna, e che a noi rimangono appena<br />
" quei conii a monumento della zecca <strong>di</strong> Soragna. I quali, lodevolmente<br />
" conservati nell'archivio dei Meli-Lupi, servirono a battere a' giorni<br />
" nostri, per cura dei possessori, poche prove <strong>di</strong> zecca in oro, rame e<br />
" piombo, conservate oggi in alcuni pubblici e privati medaglieri „).<br />
KuNZ, Il Museo Bottacin. — In Period. <strong>di</strong> Num. e S/rag. Voi. II. — (a<br />
pag. 114-15 : " La maniera d'intaglio <strong>di</strong> quello zecchino non autorizze-<br />
" rebbe per avventura la credenza che sia stato eseguito in qualche<br />
" zecca lontana, forse in quella <strong>di</strong> Vienna? E il modo della concessione,<br />
" con esclusione della effigie del feudatario e la prescrizione dell'aquila<br />
" imperiale, alla quale fa riscontro la leggenda che accenna aWa. prote-<br />
" zione cesarea, non sarebbe forse stato trovato poco lusinghiero e mo-<br />
" tivo per cui non fu dato intiero sviluppo a quel progetto? „).<br />
(21) Per ciò che concerne Retegno, s'intende che qui si parla solamente<br />
<strong>di</strong> Antonio Tolomeo Gallio Trivulzio.
LO ZECCHINO DI PORCÌA 163<br />
P - •<br />
•<br />
COMES AB : ORTENBVRG- • [rosetta) • 17-04<br />
Entro cerchio e. s. : arme <strong>di</strong> forma ellittica, inquartata e<br />
caricata d'uno scudetto centrale, circondata <strong>di</strong> fregi e<br />
sormontata da berretto principesco.<br />
Se consultiamo le Tavole sinottiche del Promis [^^\<br />
o la Bibliografia delle Zecche Ilaliane dei fratelli<br />
Gnecchi ^^3), ve<strong>di</strong>amo che il <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> questo zecchino<br />
ci è dato soltanto dal catalogo del Gabinetto Imper.<br />
<strong>di</strong> Vienna N). Da un'impronta dell'esemplare <strong>di</strong> quel<br />
Gabinetto, favoritami dall'amico mio Dott. Roberto<br />
von Schneider, è tolta appunto la riproduzione che<br />
correda il presente articolo. Per <strong>com</strong>pletare la descrizione<br />
ho avuto la fortuna <strong>di</strong> potermi valere <strong>di</strong> un<br />
altro esemplare, posseduto dalla ili.ma Sig.^ March.''<br />
Teresa Visconti Sanseverino, <strong>di</strong>scendente per Hnea<br />
materna dalla famiglia Porcia.<br />
La moneta, <strong>com</strong>e si vede, invece <strong>di</strong> recare zC^<br />
l'arme semplice, <strong>com</strong>une a tutta la famiglia (^^<br />
Porcia: " D'azzurro a sei gigli d'oro, 3, 2, i; \t/<br />
(22) Promis (Vincenzo), Tavole sinottiche delle monete battute in Italia<br />
o da Italiani all'Estero, dal secolo VII a tutto l'anno 1868. Torino, 1869.<br />
- (a pag. 171).<br />
(23) Gnecchi (F. ed E.), Saggio <strong>di</strong> Bibliografia <strong>numismatica</strong> delle<br />
Zecche Italiane me<strong>di</strong>oevali e moderne. Milano, 1889. — (a pag. 299).<br />
(24) Monnoies en or, etc. — (a pag. 211).<br />
Ma anche le pubblicazioni che registrano soltanto o che citano insomma<br />
più o meno incidentalmente la moneta <strong>di</strong> Porcia si riducono a<br />
ben poche; ecco quelle che sono a mia notizia:<br />
Bazzi (G.) e Santoni (M.), Vade-mecutn del raccoglitore <strong>di</strong> tnonele italiane, ossia Reper-<br />
torio numismatico, ecc. Camerino, 1866. — (a pag. 172).<br />
Tonini (P.), Topografia generale delle Zecche Italiane. Firenze,<br />
Promis (V.), Tavole sinottiche. — (a pag. 171).<br />
1869. — (a pag. 39).<br />
Gnecchi (F. ed E.), Le Monete dei Trivulzio. - (a pag. XXIX).<br />
Gli stessi, Saggio <strong>di</strong> Bibliografia, ecc. — (a pag. ago).<br />
Blanchet (J.-Adrie:i), Nouveau Manuel de Numismatique du moyen àge et moderne. Tome<br />
second. Paris, 1890. — (a pag. 344).<br />
Ambrosoli (S ), Numismatica (Manuali Hoepli). Milaho, 1891. — (a pag. ia8).<br />
LaZzarini (Alfredo), Castelli friulani:<br />
n. 77. U<strong>di</strong>ne, 30 marzo 1895.<br />
Porcia. - In Giornale <strong>di</strong> U<strong>di</strong>ne. Anno XXIX.<br />
Ambrosoli (S.), Manuale <strong>di</strong> Numismatica<br />
pag. 164).<br />
(Manuali Hoepli). 2» e<strong>di</strong>z. Milano 1895. - (a<br />
Annuario della Nobiltà Italiana. Bari, 1897. - (a pag. 936).
164<br />
" al capo del secondo „<br />
SOLONE AMBROSOLI<br />
(25), reca Tarme eh' è propria<br />
del principe <strong>di</strong> Porcia: " Inquartato : nel 1° e 4°<br />
>^^ " d'argento incappato <strong>di</strong> rosso, a tre semivoli<br />
^^ " dell'uno nell'altro, i due del capo addossati<br />
^W^ " {Ortemburg) ; nel 2° e 3° <strong>di</strong> rosso alla fascia<br />
" d'argento, alla torre dello stesso, aperta <strong>di</strong> nero,<br />
" movente dalla punta dello scudo, e merlata <strong>di</strong><br />
" rosso, attraversante sulla fascia {Mitterburg). Sul<br />
" tutto <strong>di</strong> Porcia „ (26).<br />
I Principi <strong>di</strong> Porcia, infatti, sono fra l'altro anche<br />
Conti <strong>di</strong> Ortemburgo e <strong>di</strong> Mitterburgo ; anzi, la <strong>com</strong>-<br />
posizione dello stemma, e il titolo <strong>com</strong>itale che lo<br />
circonda sullo zecchino, potrebbero far nascere il<br />
dubbio che si tratti <strong>di</strong> una moneta battuta bensì da<br />
un Porcia, ma pei feu<strong>di</strong> testé nominati (27). Tanto più<br />
che i Conti Vidman, dai quali i Porcia <strong>com</strong>perarono<br />
Ortemburgo nel 1662 per 365,000 e più fiorini (28)^<br />
avevano già avuto ed esercitato il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> zecca (29).<br />
II Car<strong>di</strong>nale Cristoforo Vidman coniò, fra altre<br />
monete, uno zecchino che con lo stemma inquartato,<br />
nel 1° <strong>di</strong> Ortemburgo anch'esso, e con la epigrafe<br />
(25) Annuario della Nobiltà Italiana [<strong>di</strong>retto da Goffredo <strong>di</strong> Crolla-<br />
lanza]. Anno XIX. Bari, 1897. — (a pag. 937).<br />
Il <strong>di</strong>segno dell'arme si trova nello stesso Annuario, 1896; e in: Tet-<br />
TONi (L.) e Sala<strong>di</strong>ni (F.), Teatro aral<strong>di</strong>co, voi. IV, Lo<strong>di</strong>, 1844.<br />
" D'azur à six fleurs-de-lis d'or; au chef du méme „ (Rietstap^<br />
Armorial general. Tome II. Goiidn, 1887).<br />
(26) Annuario della N^ob. It., 1897, '• e.<br />
Nel grande Numismatisches IVappen-Lexicon del pur <strong>di</strong>ligentissimo<br />
Rentzmann, tav. ii, n. 69, lo stemma inquartato suddescritto è erroneamente<br />
attribuito a Ortenburg (anzi, a Ortenburg <strong>di</strong> Baviera).<br />
(27) Veggasi la nota precedente. Il Rentzmann ha confuso VOrtenburg<br />
<strong>di</strong> Carinzia con quello <strong>di</strong> Baviera, ma in ogni modo ha creduto evi-<br />
dentemente che si trattasse <strong>di</strong> una moneta coniata per un feudo <strong>di</strong><br />
tal nome.<br />
(28) Beckh-Widmanstetter (Leopold von), Die kàrntnerischen Crafen<br />
von Ortenburg. Wien, 1890. — (a pag. 12-13).<br />
(29) Ivi. — (a pag. II).
LO ZECCHINO DI PORCÌA 165<br />
COMES AB ORTENBVRG ^3°) arieggia talmente lo zecchino<br />
<strong>di</strong> Annibale Alfonso da rafforzare la supposi-<br />
zione che anche quest'ultima moneta possa essere<br />
<strong>di</strong> Ortemburgo.<br />
Se così fosse, del resto, non sembri audacia la<br />
mia, ma a rigor <strong>di</strong> logica si potrebbe (o piuttosto si<br />
dovrebbe) collocare lo zecchino <strong>di</strong> Annibale Alfonso<br />
fra le " monete battute da Italiani all'Estero „, ed<br />
elevare Ortemburgo a " zecca <strong>italiana</strong> „.<br />
Ma senza indugiarci a <strong>di</strong>scutere i motivi pei quali<br />
questo zecchino va assegnato a Porcia e non ad altre<br />
" zecche „ (per servirci <strong>di</strong> un'espressione impropria<br />
ma ormai tra<strong>di</strong>zionale in Italia), lo stesso più volte<br />
citato catalogo del Gabinetto Imp. <strong>di</strong> Vienna {Mon-<br />
notes en or, 1759) ci presenta una soluzione elegante,<br />
benché empirica, del dubbio intorno a cui <strong>di</strong>scorriamo.<br />
Il grande catalogo <strong>di</strong> Vienna infatti, che per la sua<br />
indole stessa, o almeno per ragioni <strong>di</strong> luogo e <strong>di</strong><br />
tempo, ci può quasi fornire una " interpretazione<br />
autentica „, nella medesima pagina 211 del volume<br />
suddetto riproduce i <strong>di</strong>segni delle monete del Car<strong>di</strong>-<br />
nale Vidman intitolandole <strong>di</strong> Ortemburgo, e piiì sotto<br />
ci dà il <strong>di</strong>segno della moneta <strong>di</strong> Annibale Alfonso<br />
intitolandola <strong>di</strong> Porcia.<br />
Continueremo quin<strong>di</strong> senza esitanza, col Promis<br />
e con gli altri nostri nummografi, ad annoverare<br />
Porcia fra le zecche italiane, quantunque la sua<br />
moneta sia certamente battuta al <strong>di</strong> là delle Alpi.<br />
Diamo ora uno sguardo alle circostanze nelle<br />
quali fu coniata.<br />
Intorno all' antichissima origine della famiglia<br />
Porcia scrissero, per tacere del Sansovino (31), del<br />
(30) Monnoies en or, etc. — (a pag. 211).<br />
(31) Sansovino (Francesco), Della origine, et de' fatti delle Famiglie<br />
illustri d'Italia. In Vinegia, 1582. — (a pag. 240 e segg.).
l66 SOLONE AMBROSOLI<br />
Verci (32) e d'altri, più recentemente il eh. e <strong>com</strong>pianto<br />
Stefani (33) e il canonico Degani (34).<br />
Essa è senza dubbio fra le case più illustri del<br />
Friuli, produsse gran numero <strong>di</strong> personaggi <strong>di</strong>stinti,<br />
e s' imparentò con nobilissime famiglie (35).<br />
Né, per potersi chiamar antica e per essere il-<br />
lustre, aveva bisogno che il P. Antonio Tadeo, terziario<br />
<strong>di</strong> S. Francesco e prefetto del Seminario <strong>di</strong> Gra<strong>di</strong>sca,<br />
nel de<strong>di</strong>care la barocca sua Galleria panegirica al<br />
conte Gio. Andrea <strong>di</strong> Porcia, con secentistica ampollosità<br />
ed esagerazione in<strong>com</strong>inciasse <strong>com</strong>e segue:<br />
" Se insino le Stanze Troiane apprestarono le Culle ai<br />
" Pargoletti Vostri Aui, Illustrissimo Signor Conte; de' quali<br />
"<br />
i Figli con la fuga schermiti da quelle fiamme nemiche,<br />
" sotto il Cielo dell' Orse à sé, & à suoi Parti, riportarono<br />
" sicuro soggiorno. Se TAlemagna fecondata de' suoi figli<br />
" trinciati dalle vostre sciable; produsse alle destre, vittoriose<br />
" le palme, & inaffiata col sangue dalle vostre piche, partorì<br />
" le rose, per incoronar le tempie Auite de vostri Scipioni.<br />
" Se la Gallia per il sommo capitale delle prodezze de vostri<br />
" Epaminon<strong>di</strong>, impegnata; si <strong>di</strong>simpegnò col esborso de' primi<br />
" honori <strong>di</strong> sua Reggia, e col inesto de Regij Gigli donati<br />
" alle vostre insegne. Se l'Augustissima Casa d'Austria,<br />
(32) Verci (Giambatista), Storia della Marca Trivigiana e Veronese.<br />
Venezia, 1786-91.<br />
(33) Stefani (Federigo), Di Guecelletto da Praia e dell'origine de'<br />
Principi e Conti <strong>di</strong> Porcia e Brugnera. Venezia, 1876.<br />
(34) Decani (Ernesto), La Cronaca <strong>di</strong> Pre' Antonio Purliliese. — In<br />
Archivio Veneto, T. XXX VI, 1888.<br />
Lo STESSO, Gtiecello II <strong>di</strong> Prata. — In Atti dell'Accademia <strong>di</strong> U<strong>di</strong>ne,<br />
Serie li, Voi. IX, 1893.<br />
(35) Per le numerose pubblicazioni che concernono la famiglia<br />
Porcia, veggasi la Bibliografia del Friuli <strong>di</strong> Giuseppe Valentinelli<br />
(Venezia, 1861): alla quale formano continuazione i due volumi della<br />
Bibliografia storica friulana dal 1861 al iSSj <strong>di</strong> Giuseppe Occioni-<br />
Bonaffons (U<strong>di</strong>ne, 1883 e 1887).<br />
Alcuni cenni biografici <strong>com</strong>pen<strong>di</strong>osi dei Conti <strong>di</strong> Porcia si trovano<br />
nell'opera <strong>di</strong> Giandomenico Ciconi: U<strong>di</strong>ne e sua provincia (seconda e<strong>di</strong>-<br />
zione, U<strong>di</strong>ne, 1862; — a pag. 362-64).<br />
V. anche un articolo del Conte Alfonso Porcia nel Corriere <strong>di</strong> Go-<br />
rizia, anno X, n. 37 (26 marzo 1892).<br />
1
LO ZECCHINO DI PORCÌA 167<br />
" delle Spagne con i Tosoni, della Germania con le Contee,<br />
" dell'Imperio con i Principati, della sua Corte con le prime<br />
" Prefetture, & ai Sommi Pontefici con iterate, & applau<strong>di</strong>te<br />
" Ambasciarle, riconobbe i vostri saputissimi Soloni. E final-<br />
" mente se '1 Vicario <strong>di</strong> Christo con il decoro delle Mitre,<br />
" con le Secretane del Vaticano, con le Plenipotenze delle<br />
" Nonciature, e col Ostro delle Sacre Porpore rauuisò i<br />
" vostri religiosissimi Aaroni.... „ (36).<br />
Ciononostante, quantunque la nobiltà della fa-<br />
miglia Porcia debba <strong>di</strong>rsi assai antica, la <strong>di</strong>gnità <strong>di</strong><br />
Principe è in essa relativamente <strong>di</strong> fresca data, risalendo<br />
soltanto alla metà circa del Sec. XVII.<br />
Per maggior chiarezza, riproduco qui un brano<br />
della genealogia dei Principi e Conti <strong>di</strong> Porcia,<br />
<strong>com</strong>pilata dal Dott. A. Joppi <strong>di</strong> U<strong>di</strong>ne, e che devo<br />
alla gentilezza del Sig. Antonio Toffoli.<br />
Brano iella Geiealogia de' Principi b Conti ili Porcia (Friffl)<br />
DEL Dottor Antonio Joppi <strong>di</strong> U<strong>di</strong>ne<br />
Conte Giovanni Sforza <strong>di</strong> Porcia, morto 1624.<br />
(I Principe) Giovanni Fer<strong>di</strong>nando, nato 1606, morto 1665 ;<br />
creato Principe del Sacro Romano Impero<br />
dall' imp. Leopoldo I in Vienna, il 17 febbraio 1662.<br />
(li Principe) Giovanni Carlo, morto 1667.<br />
(III Principe) Gio. Francesco Antonio, morto 1698,<br />
I<br />
I<br />
I<br />
,*, Non ebbe figli, ed il Principato passò in un ramo collaterale de' Conti Porcia, cioè nel Conte<br />
(IV Principe) Gerolamo Ascanio <strong>di</strong> Porcia,<br />
del fu Conte Fer<strong>di</strong>nando Guido.<br />
I<br />
(V Principe) ANNIBALE ALFONSO EMANUELE,<br />
nato 1679, morto 1742.<br />
(36) Tadeo (P. Antonio), Galeria Panegirica dell'Illustrissima, &' Eccellentissima<br />
Casa <strong>di</strong> Portia, de<strong>di</strong>cata all'Illustrissimo Signor, Sig/ Gioanni<br />
Andrea <strong>di</strong> Portia, Conte del Sacr. Rom. Imperio, <strong>di</strong> Brugnara, &c. &c.<br />
<strong>di</strong> Sua Maestà Cesarea Cameriere, Signore <strong>di</strong> Senesecchia, Prem,<br />
Ortemburg, & Ospitol; Cavaliere Gierosolimitano, e Commendatore <strong>di</strong><br />
Stragau, &c. &c. — In U<strong>di</strong>ne, appresso gii Schiratti, 1679.
l68<br />
SÒLONE AMBROSOLI<br />
Da questo brano, che ho potuto Jwinplei<strong>di</strong>c col<br />
raffronto <strong>di</strong> altri alberi genealogici cortesemente <strong>com</strong>unicatimi<br />
dal Sig. Conte D/ Alfonso Porcia, ve<strong>di</strong>amo<br />
che il primo personaggio della famiglia insignito del<br />
principato fu Giovanni Fer<strong>di</strong>nando.<br />
Il relativo <strong>di</strong>ploma dell' Imp. Leopoldo I è in<br />
data del 17 febbraio 1662 (v. Appen<strong>di</strong>ce, A), e in<br />
esso si concede anche espressamente al Principe ed<br />
a' suoi successori il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> zecca (v. Appen<strong>di</strong>ce, B).<br />
Nella chiusa dello stesso <strong>di</strong>ploma si accorda poi al<br />
Principe la facoltà <strong>di</strong> trasferire o concedere ad altri<br />
(in <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> prole mascolina) i privilegi tutti che<br />
solennemente sono registrati nel <strong>di</strong>ploma medesimo,<br />
e il primo dei quali è per l'appunto il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> zecca<br />
(v. Appen<strong>di</strong>ce, C).<br />
Questo caso si avverò per il Principe Gio. Fran-<br />
cesco Antonio, morto improle, dal quale il principato<br />
passò al Conte Gerolamo Ascanio, che alla sua volta,<br />
col consenso imperiale, vi rinunciò a favore del<br />
proprio figlio Annibale (37), Ed è precisamente questi<br />
il Principe Annibale Alfonso Emanuele che, <strong>com</strong>e<br />
sappiamo, fece coniare lo zecchino <strong>di</strong> Porcia.<br />
Uomo <strong>di</strong> preclaro ingegno, dopo una giovinezza<br />
<strong>di</strong>visa fra gli stu<strong>di</strong> e gli esercizi cavallereschi, e dopo<br />
<strong>di</strong> essere stato per vari anni generale <strong>di</strong> Carlstadt<br />
nei Confini croati, Annibale Alfonso fu nominato da<br />
Carlo VI a suo consigliere intimo, a capitano supremo<br />
<strong>di</strong> Carinzia, ed ebbe altre cariche ed onori,<br />
<strong>com</strong>e si può leggere <strong>di</strong>ffusamente nel volume a lui<br />
de<strong>di</strong>cato da Adamo Matteo de Sukoviz sotto il titolo:<br />
Marcus Porcius Caio re<strong>di</strong>vivus (38).<br />
(37) Annuario della Nob. It., 1897. — (a pag. 936 : " Giovan-Francesco-<br />
" Antonio, f improle 8 apr. 1698. Il tit. <strong>di</strong> Princ. del S. R. I. venne<br />
" allora rinnov., per concess. imp. 3 sett. 1698, in favore <strong>di</strong> Gerolamo,<br />
" ciambellano del duca <strong>di</strong> Baviera, il quale ne fece rinunzia al proprio<br />
" figlio Annibale, consigl. dell'imper. Carlo VI e capit. <strong>di</strong> Carinzia „),<br />
(38) V. Appen<strong>di</strong>ce, D.
LO ZECCHINO DI PORCfA 169<br />
Ma per noi la sua personalità ritrae un carat-<br />
tere <strong>di</strong> particolare interesse dall'aver egli fatto uso<br />
del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> coniar moneta; quantunque, <strong>com</strong>e altri<br />
Principi del suo tempo, per la cussione materiale<br />
abbia ricorso senza dubbio all'opera <strong>di</strong> qualche zecca<br />
maggiore, e, più presumibilmente, alla zecca <strong>di</strong> Vienna;<br />
e quantunque si sia limitato <strong>di</strong> certo a far battere un<br />
ristrettissimo numero <strong>di</strong> esemplari, <strong>com</strong>e lo attesta<br />
la straor<strong>di</strong>naria rarità del suo zecchino.<br />
In virtù <strong>di</strong> questa coniazione, sia pure scarsis-<br />
sima, sia pure effimera, Annibale Alfonso <strong>di</strong> Porcia<br />
prende posto per un istante nella serie <strong>numismatica</strong><br />
<strong>italiana</strong>; spero quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> non aver forse fatto cosa<br />
<strong>di</strong>scara ai lettori della <strong>Rivista</strong> col richiamare la loro<br />
attenzione sulla quasi <strong>di</strong>menticata <strong>di</strong> lui moneta.<br />
Prima <strong>di</strong> chiudere, mi si permetta <strong>di</strong> ringraziare<br />
i Sigg. March. Carlo Ermes Visconti, Conte D."" Al-<br />
fonso Porcia, e Antonio Toffoli, che mi furono liberah<br />
<strong>di</strong> notizie e <strong>di</strong> cortesi schiarimenti.<br />
Milano, giugno iS^j.<br />
Solone Ambrosoli.
APPENDICE<br />
A.<br />
So haben Wir <strong>di</strong>esem allem nach aus oben angezogenen,<br />
und mehr andern Ursachen, und zu gnà<strong>di</strong>gster<br />
Erkanntniss solches furtreflich ruhmlichen Verhaltens, und<br />
langwierig getreuen Ver<strong>di</strong>enens mit wohl bedachtem Muthe,<br />
gutem Rathe, aus selbst eigener Bewegnuss, und rechtem<br />
Wissen, obbenannten Unsern Obristhofmeister Johann Fer<strong>di</strong>nand<br />
Grafen von Portia, und Brugnera in den Stand,<br />
Ehre, und Wùrde, Unserer, und des heil. Reichs Fùrsten<br />
gnà<strong>di</strong>glich erhoben, gewur<strong>di</strong>get, und gesetzt, auch ihn der<br />
Schaare, Gesell- und Gemeinschaft anderer Unserer, und des<br />
heil. Reichs Fiirsten zugefugt, zugesellt, und vergHchen,<br />
dazu ihm den furstlichen Titul, und Namen zu fiihren gna<strong>di</strong>gUch<br />
bewilliget, und gegeben, auch sich also zu nennen<br />
zugelassen, und erlaubt, jedoch dergestalt, dass allezeit der<br />
primogenitus den fursthchen Stand, und Namen fùhre : da<br />
<strong>di</strong>eser aber keinen mannlichen Leibserben hinterhesse, alsdann<br />
aus seinem Geschlechte, und zwar derjenige, welchen<br />
er zum Erben aufnehmen, oder in Ermanglung der Institution,<br />
sein rechtmàssiger Erb aus dem Grafen von Portia Ge-<br />
schlechte seyn wird, und dessen àltester Sohn, und also fort,<br />
und fort allein der primogenitus in dem Fiirstenstande suc-<br />
ce<strong>di</strong>ren, <strong>di</strong>e andern aber in dem Grafenstande verbleiben<br />
sollen „.<br />
Fùrst von Portiaischen Familie<br />
Herrlichkeiten. — (s, 1. d. st. né a.)- —<br />
(a pag. 11-12).<br />
B.<br />
Als nàmlich, und fiirs erste, so haben Wir zur Erzeigung<br />
Unserer grossen Mil<strong>di</strong>gkeit, und gna<strong>di</strong>ger Neigung<br />
gegen mehr gedachtem Fiirsten von Portia Ldl. auch dero<br />
Erben, und Nachkommen mit Consens, und Einwilligung<br />
Unserer, und des heiligen Reichs Kuhrfursten <strong>di</strong>ese besondere<br />
Gnade gethan, und Freyheit gegeben; thun, und
LO ZECCHINO DI PORCfA I7I<br />
geben <strong>di</strong>e ihnen auch von ròmischer kais. kònig. und<br />
landsfiirstlicher Machtvollkommenheit wissentlich in Kraft<br />
<strong>di</strong>eses Briefs also, dass scine Liebden, dero Erben, und<br />
Nachkommen, wann ihnen solches iiber kurz, oder lang<br />
gelegen, und gefallig, in ihren Landen, Herrschaften, und<br />
Gebieten, so sie itzt haben, und in kunftiger Zeit noch ferner<br />
ùberkommen, eine Miìnzstàtte bauen, und aufrichten lassen,<br />
und darinn durch ihre ehrbare, redliche Munzmeister, <strong>di</strong>e<br />
sie zu einer jeden Zeit dazu verordnen, allerley goldenund<br />
silberne Miìnzsorten klein, und gross, in allermassen<br />
solches Unser, und des heihgen Reichs Munze<strong>di</strong>kt, und<br />
Ordnung zulasset, und andern, so aus Unsern, oder Unserer<br />
Vorfahrer kais. kònig. oder landsfiirstlichen Begnadungen zu<br />
miinzen Macht haben, mit Umschriften, Bildnissen, Wappen,<br />
Gepràgen auf beiden Seiten miinzen, und schlagen lassen,<br />
damit treulich gebaaren, und handlen sollen, und mògen,<br />
von allermanniglich unverhindert : doch sollen alle solche<br />
golden- und silberne Miinzen, <strong>di</strong>e sie, wie obstehét, schlagen,<br />
und miinzen lassen, von Strichnadl, Korn, Schrot, Gran,<br />
Gehalt, Werth, und Gewicht vorbertihrter Unserer, und<br />
des heiligen Reichs, auch anderer Unserer Erbkònigreiche,<br />
Furstenthiimer, und Lande (darinnen dergleichen Miinzen<br />
geschlagen werden) der Miinzordnung gemàss, und nicht<br />
geringer seyn; auch wo Wir, oder Unsere Nachkommen,<br />
kiinftig iiber kurz, oder lang der Mtinz halber Aenderung,<br />
und andere Ordnung fiirnehmen, geben, und machen werden,<br />
solle scine Liebden der Fiirst von Portia, scine Erben, und<br />
Nachkommen sich alsdann auch derselben gemass halten „.<br />
Fiirst von Portiaischen Familie<br />
Herrlichkeiten. — (a pag. 25-26).<br />
Zu dem alien geben Wir Unserm lieben Oheim des<br />
Furstens von Portia Ldl. dero Erben, und Nachkommen,<br />
<strong>di</strong>esa besondere Freyheit, vollkommene Macht, und Gewalt,<br />
dass er als primus aquirens in defectum prolis masculince <strong>di</strong>eses<br />
Unser kais. Beneficium einem jedweden seines Namens^<br />
und Stammes, oder einem andern, wen er hiezu am besten
172<br />
SOLONE AMBROSOLI<br />
qualifìcirt befindet, nach seinem Belieben per ultimam volun-<br />
tatem, seu Inter Vivos quocunque modo gànzlichen ubertnachen^<br />
verleihen, iransportiren, uberlassen, und ce<strong>di</strong>ren mòge,<br />
alles von mehr beruhrter kais. Machtvollkommenheit, und in<br />
Kraft <strong>di</strong>eses Briefes, welchen nun des Fiirsten von Portia<br />
Ldl. solches Unser Privilegium, oder eine, oder mehrere<br />
Gnaden derselben, wie obstehet, ce<strong>di</strong>ren, und theilhaftig machen<br />
wird, der solle solches nichtweniger, als wenn ihm das<br />
von Uns seJbst verliehen wàre, nach seinem Gefallen niitzen,<br />
und niessen, ohne mànnigliche Verhinderung „.<br />
Fiirst von Portiaischen Familie<br />
Herrlichkeiten. — (a pag. 67).<br />
D.<br />
Primogenitus <strong>com</strong>itis Hieron3'mi Ascanij, Hannibal tenerae<br />
adhuc aetatis Porcià in Bavariam ad agnatum Maximilianum<br />
deductus, ab eodem sollicitè educatus, & ad quaevis<br />
tum privata, tum publica stu<strong>di</strong>a, & equestria exercitia serio<br />
applicatus in omnibus, & singulis ad invi<strong>di</strong>am usque mire<br />
proficiens, prout ejus aevi <strong>com</strong>militones ho<strong>di</strong>edum attestantur,<br />
ipsùmque quilibet cum eodem per aliquod agens tempus, in<br />
omni scibili magistrum : in juri<strong>di</strong>cis alterum Catonem ; in<br />
historia vero, & politicis omnino defaecatissimum, ac consummatissimum<br />
, jure merito ju<strong>di</strong>caverit. Rarae profectò hoc<br />
saeculo in principe viro virtutes.<br />
Non tantum haeres principis Francisci Antonij, sed &<br />
priùs Maximiliani agnati, ejùsque conjugis natae L. B. à Spi-<br />
rinig, ac sic proprietarius dominiorum superioris, & inferioris<br />
Lauterbach, Hornegg, & Meillhoffen, nec non <strong>di</strong>versorum in<br />
Bavaria palatiorum, & honorum : occasione cujus per aliquot<br />
cum aula Bavarica tum ibi, tum in Belgio tempus morabatur:<br />
variàque ibidem obivit munia.<br />
Sed vocatus ad capessendam praefati principis Francisci<br />
Antonij haere<strong>di</strong>tatem se se Viennam contulit, ubi Leopoldo<br />
Caesari vix rara hujus principis talenta innotuére, eundem in<br />
suum ad aulam Moscoviensem resolvit magnum legatum.<br />
Quo au<strong>di</strong>to duo id Caesari ministri improbàre : esse nimirum<br />
hunc principem ad delicatum hoc, & grave munus perquàm
LO ZECCHINO DI PORCfA I73<br />
juvenem; Quibus Caesar haec in terminis reposuit percunctando:<br />
An locuti sint in serijs principi à Porcia? negantes<br />
jussit, illi loqui; multum in hoc principe reperturos, quod<br />
illis deest, ut <strong>di</strong>scant.<br />
Quo autem fato legatio haec, ad quam eò magnificentiùs<br />
prò Caesaris gloria gerendam, magnos ex proprio princeps<br />
impen<strong>di</strong>t sumptus, ad hoc usque momentum sensibiles, suum<br />
non sit sortita efiectum, id passim ex aliis constat.<br />
Interrupto ergo hoc legationis munere renuntiatur gene-<br />
ralis Carolosta<strong>di</strong>ensis Croaticorum, maritimorùmque confiniorum,<br />
cui per aliquot laudabiliter praefuit annos: ob aèris<br />
autem intemperiem ad sui conservationem necesse habuit id<br />
resignare.<br />
Ad sedandum, in <strong>com</strong>itatu Goritiensi anno 1713 exortum<br />
rusticorum tumultum, au<strong>di</strong>endas, & decidendas causas, nec<br />
non puniendos authores, deputatur cum Christophoro <strong>com</strong>ite<br />
à Wildenstein, moderno <strong>di</strong>gnissimo <strong>di</strong>rectore regiminis Aust:<br />
Inter: & Joanne Josepho à Luidl, ho<strong>di</strong>erno secretano, &<br />
referendario IntrAust: Viennae mentissimo, principalis <strong>com</strong>missarius,<br />
quam <strong>com</strong>missionem per decem menses, in loco<br />
Goritiae continuatam, cum susceptis in se sponte proprijs<br />
impensis feliciter terminavit: ut optimo jure de ilio <strong>di</strong>ci possit,<br />
eundem non sibi, sed Caesari natum, facultatésque ipsius<br />
magis bono publico, ac propriae utilitati deservire.<br />
Dum vero invictissimus Caesar, & gloriosissimus triumphator<br />
Carolus VI. &c. &c. qui ob <strong>di</strong>urnam in vin<strong>di</strong>canda,<br />
& asserenda sibi avita Hispaniarum monarchia à Germania<br />
absentiam, subjectorum, ipsorùmque qualitatum notitiam,<br />
redux non habuit ex asse, talenta hujus principis percepit,<br />
eundem sibi à consilijs intimum efifectivum, suùmque archidu-<br />
catùs Carinthiae supremum Capitaneum, & principalem Inte-<br />
rioris Austriae <strong>com</strong>missarium, ampia cum authoritate renuntiat.<br />
Sed haec duntaxat fore praelu<strong>di</strong>a ad altiora quis non videt?<br />
aC DeVs hoC faXIt aMen (39) „.<br />
De Sukoviz (Adamus Matthaeus),<br />
Marcus Porctus Caio re<strong>di</strong>vivus et in<br />
integrum restitutus in celsissimo Principe,<br />
& Domino, Domino Hannibale<br />
Alphonso Emanuele S. Rom. Imp.<br />
Principe à Porcia, &c. — Augustae<br />
Vindelicorum, 1716. — (a pag. 89-92).<br />
(39) Cronogramma dell'anno 1716 (MDCCXVI), in cui fu pubblicato<br />
il libro.
IL PRIVILEGIO DI ZECCA<br />
ACCORDATO DALL'IMPERATORE MASSIMILIANO II<br />
A FERRANTE GONZAGA<br />
1° Marchese <strong>di</strong> Castiglione delle Stiviere<br />
Mai fu noto se la zecca <strong>di</strong> Castiglione sia stata<br />
aperta in virtù <strong>di</strong> un Privilegio speciale; e quanti<br />
scrissero intorno alla medesima, si limitarono a ri-<br />
portarne notizie e documenti, senza accennare alle<br />
ragioni della sua origine, perchè da nessuno cono-<br />
sciute. Ed anche lo scrivente che ebbe ad illustrare<br />
in modo assai dettagliato la zecca stessa W, in quel<br />
volume accennò alla mancanza <strong>di</strong> documenti in pro-<br />
posito: anzi aggiunse essere probabile che non fosse<br />
stato d'uopo un Privilegio apposito, perchè il <strong>di</strong>ritto<br />
<strong>di</strong> battere moneta era implicito fra i molti della<br />
erezione del Marchesato.<br />
Ma le <strong>di</strong> lui indagini non cessarono per questo,<br />
e furono anzi coronate da pieno successo, perchè lo<br />
condussero a scoprire il Privilegio speciale con cui<br />
r Imperatore Massimiliano II concedeva a Ferrante<br />
Gonzaga, i° Marchese <strong>di</strong> Castiglione, il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />
monetazione : prezioso documento che è lieto <strong>di</strong><br />
rendere noto ai cultori della Numismatica, qui ripro-<br />
ducendolo.<br />
A. Agostinl<br />
(i) Ing. A. Agostini, Castiglione delle Stiviere dalle sue origini<br />
geologiche fino ai nostri giorni. Parte III, La Zecca.
176 A. AGOSTINI<br />
Privilegium Monetan<strong>di</strong><br />
Maximilian II, 1564-70,<br />
Pro. IH. Marchiane Ferrante de Gonzaga.<br />
Maximilianus II &. Ad futuram rei niemoriam : Recognoscimus,<br />
et notum facimus tenore praesentium universis: Etsi ex innata<br />
nostra benignitate inclinati sumus ad exercendam munificentiam<br />
nostrani Caesaream in quoscumque nostros , et Sacri Romani<br />
Imperij sub<strong>di</strong>tos, ac fideles, qui tum vitae morumque honestate,<br />
probitate et integritate, tum fide, constantia, et benemeren<strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o,<br />
ahimique promptitu<strong>di</strong>ne erga nos, et sacrum Imperium, inclytamque<br />
nostram Austriae domum, ea sese <strong>di</strong>gnos red<strong>di</strong>derint, more Divorum<br />
praedecessorum Nostrorum Romanorum Imperatorum, ac Regum,<br />
qui <strong>di</strong>vino exemplo et instituto edocti, censuere Imperialem Tronum<br />
nihii magis decere, quam beneficentiam et liberalitatem suam nuliis<br />
tenere finibus circumscriptam: Tamen existimamus illorum etiam<br />
in primis rationem esse habendam, qui a maioribus et parentibus<br />
illustri loco natis, atque de Imperio Sacro optime mentis, genus et<br />
originem trahunt, praesertim si ipsi quoque laudatis illorum vesti-<br />
giis insistentes, domesticam ac gentilitiam gloriam, rebus fortiter<br />
praeclare gestis, et virtute partam, ijsdem stu<strong>di</strong>is, ac meritis, tueri<br />
et integram conservare student. Quemadmodum enim alios Natalium<br />
splendore antecellunt, sic etiam Reipublicae prae caeteris, non<br />
solum eximio ornamento, sed summo quoque praesi<strong>di</strong>o esse possunt.<br />
Quamobrem cum 111. noster, et Sacri Imperij Princeps, fidelis<br />
<strong>di</strong>lectus Ferrantes ex Marchionibus de Gonzaga Dominus Castioni<br />
a Stiverijs natus sit ex 111. familia Marchionum de Gonzaga, quae<br />
non modo vetustate, et nobilitate, sed fide quoque et constantia<br />
erga Divos antecessores nostros, et Sacrum Imperium, admodum<br />
est insignis atque conspicua, inclytaeque Domui nostrae Austriacae<br />
a multis saeculis ad<strong>di</strong>ctissima, unde plures praeclari atque rei<br />
bellicae gloria praestantes viri et <strong>di</strong>gnitatis atque auctoritatis Impe-<br />
ratoriae acerrimi vin<strong>di</strong>ces pro<strong>di</strong>erunt, ipseque Ferrantes, a proge-<br />
nitorum suorum virtute mime deflectat, sed avitam generis sui<br />
nobilitatem et eminentiam excellentibus animi sui dotibus ingiter<br />
tueri ac retinere connitatur, atque nos et sacrum Imperium, summa
IL PRIVILEGIO DI ZECCA, ECC. I77<br />
fide, integritate atque observantia, colat, siculi etiam universam<br />
Domum nostrae Austriae orni offitiorum genere demereri nunquam<br />
cessai, atque haud dubie in futurum quoque nullam unquam occasionem<br />
praetermissurus esl, eiusmo<strong>di</strong> praeclaram voluntatem suam<br />
reipsa magis magisque <strong>com</strong>proban<strong>di</strong>. Nos sane existimamus, non<br />
solum Caesarea noslra munificenlia <strong>di</strong>gnum, verum etiam omni<br />
rationi, et aequitali consentaneum esse, quod vicissim buie tam<br />
eximiae animi illius promptitu<strong>di</strong>ni mutua nostra Caesarea gratia, et<br />
benignitate respondeamus, eumque insigni aliquo ornamento cronde-<br />
coremus, quo non tam ipse congruum virtuti suae praemìum consequatur,<br />
sed ipsius etiam posteritas, et alii quoque hoc exemplo<br />
ad eadem virtutis stu<strong>di</strong>a accendantur. Itaque motu proprio, et ex<br />
certa nostra scientia, animoque bene deliberato, et sano accedente<br />
Consilio, prò ea, quam oblinemus auctoritate Caesarea, deque eiusdem<br />
polestatis plenitu<strong>di</strong>ne, ante<strong>di</strong>cto 111. Ferranti Marchioni de Gonzaga,<br />
eiusque filijs haere<strong>di</strong>bus , et descendentibus legittimis benigne<br />
de<strong>di</strong>mus, concessimus, et elargiti sumus, libertatem et fàcultatem<br />
in castro et oppido suo Castioni a Stiverijs, officinam Monetariam<br />
fabrican<strong>di</strong>, et construen<strong>di</strong>, monetamque auream, argenteam et aeream<br />
cuiusquam generis et valoris, Armorum suorum insignis, ac nominis<br />
inscriptione signatam cuden<strong>di</strong>, dummodo cudatur bona sincera et<br />
iusta, quae non sit deterior illa, quam caeteri Italiae Principes,<br />
Divorum antecessorum nostrorum Romanorum Imperatorum ac<br />
Regum concessione cudunt, ita ut nemo in hac parte iustam conque-<br />
ren<strong>di</strong> causam habere queant, prout tenore praesentium damus,<br />
conce<strong>di</strong>mus et elargimur, volentes, et hoc Caesareo e<strong>di</strong>cto nostro<br />
firmiter statuentes, ut praefatus 111. Ferrantes, eiusque filij, haeredes,<br />
posteri, atque in loco supranominato successores legitimi, absque<br />
omni impe<strong>di</strong>mento, et obstaculo, possint et valeant deinceps in<br />
perpetuum Monetam auream, argenteam et aeream, bonam tamen<br />
ac sinceram et iustam nec deteriorem illa, quae ut ante <strong>di</strong>ctum est,<br />
a caeteris Italiae Principibus, sacro Romano Imperio subiectis, iuxta<br />
tenorem et praescriptum Privilegiorum ipsis desuper a Divis Romanorum<br />
Imperatoribus, ac Regibus concessorum, cu<strong>di</strong>tur, in eodem<br />
loco suo Castioni cudere, seu cu<strong>di</strong> facere, ac omnibus et singulis<br />
gratijs, libertatibus, privilegiis, immunitatibus, praerogativis , et<br />
luribus, in hoc parte uti, frui, potiri, et gaudere, quibus caeteri<br />
Principes et Or<strong>di</strong>nes Sacri Romani Imperii, fàcultatem cuden<strong>di</strong><br />
monetam habentes, utuntur, fruuntur, potiuntur, et gaudent, con-<br />
suetu<strong>di</strong>ne, vel de Iure, omni impe<strong>di</strong>mento, vel contra<strong>di</strong>ctione postpo-<br />
sita. Quocirca mandamus etiam et praecipimus firmissime universìs<br />
ac singulis Electoribus, et Principibus, tam Ecclesiasticis, quam<br />
Saecularibus, Archiepiscopis , Episcopis, Ducibus, Marchionibus,
I-yS A. AGOSTINI<br />
Comitibus, Baronibus, Militibus, Nobilibus, Clientibus, Capitaneis,<br />
Vicedominis, Locumtenentibus, Gubernatoribus, Vicegerentibus<br />
Praesidentibus, Praefectis, Castellanis, Rectoribus, Magistratibus,<br />
Antianis, Vexilliferis, Potestatibus, Civius Magistris, Consulibus, et<br />
omnibus denique nostris, et sacri Imperii sub<strong>di</strong>tis, ac fidelibus<br />
<strong>di</strong>lectis, tam in Italia, quam in Germania, et alibi existentibus,<br />
cuiuscumque gradus, status, or<strong>di</strong>nis, con<strong>di</strong>tionis, et <strong>di</strong>gnitatis fueritit,<br />
ut saepefato IH. Principi nostro Ferranti ex Marchionibus de Gon-<br />
zaga, et ante<strong>di</strong>ctis eius filiis, haere<strong>di</strong>bus et successoribus legitimis<br />
in memorata libertate, praerogativa, et facultate cuden<strong>di</strong> Monetam<br />
in praenominato Castro et loco Castìoni, ipsis jam per nos concessa,<br />
nihil prorsus negotii, molestiae vel impe<strong>di</strong>menti ullo quaesito colore<br />
<strong>di</strong>recte vel in<strong>di</strong>recte exhibeatur, sed illos ea libere uti, frui et potiri<br />
sinant, et ab aliis quoque prò sua quisque parte omni id stu<strong>di</strong>o<br />
fieri curent, et secus minime faciant, quatenus nostram, et sacri<br />
Imperij in<strong>di</strong>gnationem gravissimam, et mulctam sexaginta Marcharum<br />
auri puri fisco nostro Imperiali, et parti laesae, omni spe<br />
veniae sublata, ex aequo pendendam incurrere noluerint, quam<br />
poenam temerarijs violatoribus, et contemptoribus huius nostrae<br />
concessionis ac gratiae irrogandam decernimus. In cuius rei fidem<br />
et testimonium has literas manu nostra propria subscriptas sigilli<br />
nostri Caesarei appensione <strong>com</strong>muniri iussimus. Datum Viennae<br />
trigesima Maij Anno Domini JMillesimo quingentesimo sexagesimo<br />
septimo.<br />
,
CONTRIBUTI<br />
ALLA<br />
Storia del ripostiglio consolare<br />
DI<br />
PALAZZO CANAVESE<br />
Se la moneta antica ha un valore in sé, doppio ne<br />
acquista quando, invece d'essere isolata, fa parte <strong>di</strong> un<br />
ripostiglio che offra allo stu<strong>di</strong>oso un <strong>com</strong>plesso <strong>di</strong> dati<br />
cronologici e numismatici <strong>di</strong> maggior entità, e permetta <strong>di</strong><br />
assorgere ad induzioni precise sul periodo in cui tali monete<br />
furono coniate e sul popolo che le usò in quel periodo.<br />
Perciò rilevai l'importanza del ripostiglio <strong>di</strong> Romagnano<br />
Sesia, che ebbi la fortuna <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>are quando era ancóra<br />
integro (i), e, nell'impossibilità <strong>di</strong> farlo acquistare pel Museo<br />
<strong>di</strong> Antichità in Torino, rac<strong>com</strong>andai al proprietario <strong>di</strong> ven-<br />
derlo intero o <strong>di</strong> tenerlo, piuttosto che togliergli ogni valore<br />
col <strong>di</strong>viderlo (2). In quell' occasione osservai inoltre quanto<br />
siano rari i ripostigli consolari nell'Alta Italia e specialmente<br />
nel Piemonte (3), per il che tanto maggiore è l'obbligo <strong>di</strong><br />
seguire la traccia <strong>di</strong> quelli <strong>di</strong> cui si ha qualche notizia. Fra<br />
i ripostigli allora citati v'era quello <strong>di</strong> Palazzo Canavese,<br />
presso Ivrea, il cui ritrovamento risale non al 1886, <strong>com</strong>e<br />
(i) Ve<strong>di</strong> <strong>Rivista</strong> <strong>italiana</strong> <strong>di</strong> Numismatica, voi. Vili (1895), P^g- 4955<br />
voi. IX (1896), fase. II, pag. 233-246 e nota i. — Ne parlò anche il eh. cav.<br />
prof. Ferrerò in Atti dell'Accademia delle Scienze <strong>di</strong> Torino, voi. XXXI,<br />
pag. 766-775.<br />
(2) Ve<strong>di</strong> <strong>Rivista</strong> cit., voi. VIII (1895), pag. 494. Con molto piacere<br />
venni a sapere che il ripostiglio <strong>di</strong> Romagnano Sesia fu acquistato<br />
intiero dal eh. cultore <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> archeologici cav. Giuseppe Assandria<br />
in Torino.<br />
(3) Ve<strong>di</strong> <strong>Rivista</strong> cit., voi. IX (1896), pag. 244, nota 4.
l8o SERAFINO RICCI<br />
era stato da me desunto dalle relazioni, ma alla primavera<br />
del 1884. Quantunque pur troppo del ripostiglio <strong>di</strong> Palazzo<br />
non si possa ricostruire la storia e fare l'illustrazione <strong>com</strong>pleta<br />
<strong>com</strong>e <strong>di</strong> quella <strong>di</strong> Romagnano Sesia, pure credo non scevro<br />
d'interesse scientifico il raccogliere intorno a quello tutti i dati<br />
possibili, in aspettazione d'altri ancora più particolareggiati.<br />
Il <strong>com</strong>pianto sen. Fabretti, già <strong>di</strong>rettore del R. Museo<br />
<strong>di</strong> Antichità in Torino, negli Atti della Società <strong>di</strong> Archeologia<br />
e Belle Arti per la provincia <strong>di</strong> Torino, del gennaio 1887,<br />
dava un breve cenno sul ripostiglio dei nummi consolari<br />
d'argento <strong>di</strong> Palazzo Canavese, che allora s'era rinvenuto<br />
contemporaneamente ad un altro abbastanza importante <strong>di</strong><br />
monete imperiali, dei <strong>di</strong>ntorni <strong>di</strong> Settimo Torinese, <strong>di</strong> cui si<br />
ebbe notizia troppo tar<strong>di</strong>, per impe<strong>di</strong>rne la <strong>di</strong>spersione.<br />
" Il ripostiglio <strong>di</strong> Palazzo — così scrive il Fabretti —<br />
caduto nelle mani <strong>di</strong> un i<strong>di</strong>ota, aveva il peso <strong>di</strong> circa <strong>di</strong>eci<br />
chilogrammi, e la maggior parte delle monete che lo <strong>com</strong>po-<br />
nevano, tra le quali erano molti e <strong>di</strong> ottima conservazione<br />
i denari dei monetari <strong>di</strong> Augusto, fu venduto qua e là alla<br />
spicciolata, spesso a vilissimo prezzo ; altre giacciono tuttora,<br />
non viste da alcuno, chiuse in un sacchetto e sottratte allo<br />
sguardo <strong>di</strong> chicchessia fino al giorno che saranno <strong>di</strong>vise tra<br />
coloro che ne reclamarono la proprietà „ (4).<br />
Mi ricordava <strong>di</strong> questo cenno riassuntivo del Fabretti<br />
quando, i primi giorni del <strong>di</strong>cembre scorso, venne al Museo<br />
da Palazzo Canavese un tal Giuseppe Landorno, uomo rozzo,<br />
ma non del tutto ignaro <strong>di</strong> ciò che aveva fra le mani, por-<br />
tando un gruzzolo abbastanza rilevante <strong>di</strong> monete consolari<br />
d'argento, oltre una <strong>di</strong> bronzo imperiale irreconoscibile, e ne<br />
offriva alla Direzione la ven<strong>di</strong>ta. Io accertai innanzi tutto la<br />
provenienza delle monete da Palazzo Canavese e la loro<br />
pertinenza al ripostiglio medesimo, particolare sul quale<br />
s'erano levati dei dubbi, <strong>di</strong>cendolo scoperto in vai d'Aosta (5),<br />
ed, esaminati tutti i pezzi per riconoscere se vi fosse qualche<br />
moneta non ancora rappresentata nel Gabinetto Numismatico,<br />
trova,! che tre<strong>di</strong>ci dei pezzi del Landorno non erano ancóra<br />
(4) Ve<strong>di</strong> Atti della Soc. <strong>di</strong> Archeologia e Belle Arti cit., voi. V, pag. 20.<br />
(5) Ve<strong>di</strong> Op. cit., voi. V, pag. i28-i29u
CONTRIBUTI ALLA STORIA DEL RIPOSTIGLIO CONSOLARE, ECC. l8l<br />
posseduti, e ne proposi la <strong>com</strong>pera al sig. Direttore (6), avendo<br />
poi cura <strong>di</strong> notare la rappresentanza e la citazione corrispon-<br />
dente ad ognuna anche delle altre monete, tanto nel Catalogo<br />
del Fabretti quanto in quello del Babelon (7).<br />
Le monete esaminate salgono a 159. M' accorsi tosto<br />
da un esame preliminare che il ripostiglio doveva essere<br />
stato <strong>di</strong> speciale importanza, se ben 59 famiglie vi erano<br />
rappresentate in sole 159 monete, ed eranvi alcune importanti<br />
e tutte <strong>di</strong> buona conservazione. Ma questa importanza si rileva<br />
ancor più, pensando quanto grande dovesse essere il numero<br />
<strong>com</strong>pleto <strong>di</strong> tutto il ripostiglio, se pesava originariamente ben<br />
IO chilogrammi.<br />
Cercai <strong>di</strong> sapere dal proprietario Landorno <strong>com</strong>e avvenne<br />
il ritrovamento e la <strong>di</strong>spersione del tesoretto, e quali speranze<br />
vi fossero <strong>di</strong> ri<strong>com</strong>porlo, almeno in gran parte. Le notizie<br />
che potei raccogliere dalla viva voce del Landorno e dalla<br />
convenzione scritta già fin dal settembre 1885 fra i membri<br />
della famiglia e i parenti più prossimi dei Landorno, circa<br />
la sud<strong>di</strong>visione <strong>di</strong> tal genere <strong>di</strong> sostanza, sono le seguenti:<br />
La primavera del 1884 Giuseppe Landorno, mentre<br />
attendeva a lavori <strong>di</strong> escavazione in un appezzamento <strong>di</strong><br />
<strong>com</strong>une proprietà coi fratelli, rinveniva un vaso ripieno <strong>di</strong><br />
antiche monete d'argento, della Repubblica, dei vari conso-<br />
lati o legionarie, che furono in parte vendute in varie località<br />
— e <strong>di</strong> queste non v' è più modo <strong>di</strong> rinvenire le traccie<br />
sicure (8) — in parte <strong>di</strong>sperse fra i parenti, in modo che la<br />
parte maggiore rimanente del tesoretto intero risaliva a<br />
Kg. 5.8, sequestrati dai carabinieri in Andorno nel 1885, e,<br />
prima della detta convenzione, ancóra nelle loro mani.<br />
Fatta poi la convenzione (9), e <strong>di</strong>viso in parti eguali ciò<br />
(6) Ve<strong>di</strong> l'elenco dei denari d'argento <strong>com</strong>perati a pag. 193.<br />
Ve<strong>di</strong> pag. 186 e segg.<br />
(7)<br />
(8) So da gentile <strong>com</strong>unicazione del chiar. cav. Ercole Gnecchi che<br />
un buon numero dei denari consolari d'argento <strong>di</strong> Palazzo Canavese<br />
giunsero anche sul mercato numismatico <strong>di</strong> Milano, e che il fratello,<br />
chiar. cav. Francesco, ne acquistò parecchi, che ora non potrebbe più<br />
identificare, fra cui una Julia, che fu aggiunta nell'elenco a p. 194, n. 2934.<br />
Tra i nummi in ven<strong>di</strong>ta si notava una Cornuficia, rarissima, il cui tipo<br />
in argento rappresenterebbe un valore <strong>di</strong> catalogo dai 400 ai 500 franchi.<br />
(9) Porta la data del 17 settembre 1885.
l82 SERAFINO RICCI<br />
che del ripostiglio era stato raccolto, fissarono le con<strong>di</strong>zioni<br />
reciproche d'interesse tra i fratelli, e alla detta convenzione<br />
s'aggiunse la clausola " che le monete tuttora sotto sequestro,<br />
appena rilasciate, venissero inventariate e ritirate dal <strong>com</strong>une<br />
zio delle parti, dott. Monti Antonio fu Pietro, con incarico <strong>di</strong><br />
curarne la ven<strong>di</strong>ta e <strong>di</strong> ripartirne il prezzo nelle proporzioni<br />
fissate „, e simili.<br />
Secondo le attestazioni del Landorno Giuseppe, il preci-<br />
tato Sig. Monti avrebbe dovuto avere circa un quattrocento<br />
monete del ripostiglio, cioè circa Kg. 0.8 <strong>di</strong> argento, che,<br />
sommato con Kg. 0.6 circa, a cui sale il peso <strong>com</strong>plessivo<br />
delle monete da me esaminate, porterebbe a circa Kg. 1.5,<br />
cioè a poco meno <strong>di</strong> un terzo del totale raccolto dai cara-<br />
binieri, quella parte <strong>di</strong> monete del ripostiglio che parrebbe<br />
doversi ancora ritrovare e stu<strong>di</strong>are.<br />
Ma, scritto in proposito al dott. Monti precitato, egli mi<br />
rispose che, " per circostanze in<strong>di</strong>pendenti affatto dalla sua<br />
volontà, anzi, contro suo volere, erano state alienate le monete<br />
in <strong>di</strong>scorso, senza badare a pregio né reale né d'antichità;<br />
e, mentre egli, sebbene non assoluto proprietario, le avrebbe<br />
conservate ad opera scientifica, il vero possessore le aveva<br />
ritirate e ne aveva fatto spreco. „<br />
Per il che, da quella parte credo riesca oltremodo <strong>di</strong>ffi-<br />
cile l'identificazione delle monete vendute, e stimo già gran<br />
ventura che il desiderio <strong>di</strong> vendere una piccola parte <strong>di</strong>spo-<br />
nibile mi abbia fatto capitare fra le mani quelle 159 che<br />
esaminerò fra poco. Se non che, avendomi il Landorno dati<br />
altri nomi <strong>di</strong> acquirenti delle monete <strong>di</strong> Palazzo fin dai primi<br />
perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>spersione, non ho ancóra perduta la speranza <strong>di</strong><br />
potere in sèguito aggiungere maggiori contributi alla storia<br />
e all'illustrazione <strong>di</strong> uno dei ripostigli consolari più impor-<br />
tanti del Piemonte.<br />
Ecco l'elenco delle monete esaminate; prima per famiglie,<br />
secondo il catalogo del Fabretti (1°), poi in or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> tempo,<br />
(io) Seguo la 2* e<strong>di</strong>z."* più recente del Catalogo del Fabretti, <strong>com</strong>e la<br />
più <strong>com</strong>pleta; è il voi. IV (1881, Monete consolari e imperiali) dell'opera<br />
Regio Museo <strong>di</strong> Torino, e fa parte del Catalogo generale dei Musei, Gallerie<br />
e Biblioteche del Regno. La i* e<strong>di</strong>z.'', del 1876, non <strong>com</strong>j)rende che la<br />
prima serie delle monete consolari, senza gli ulteriori acquisti fino al i88r.
CONTRIBUTI ALLA STORIA DEL RIPOSTIGLIO CONSOLARE, ECC. 183<br />
secondo la classificazione cronologica proposta dal Babelon.<br />
Il primo elenco cita anche il numero delle monete <strong>di</strong> ogni<br />
tipo, e quin<strong>di</strong> costituisce la somma <strong>di</strong> tutte quelle esaminate ;<br />
il secondo elenco cita solo i tipi delle famiglie rappresentate<br />
entro i nove perio<strong>di</strong> della classificazione cronologica della<br />
Repubblica romana, in<strong>di</strong>pendentemente dal numero <strong>di</strong> mo-<br />
nete che esiste per ogni tipo.<br />
FAMIGLIE CONSOLARI<br />
RAPPRESENTATE NEL TESORETTO DI PALAZZO CANAVESE<br />
Aemilia . .<br />
IN ORDINE ALFABETICO
i84
CONTRIBUTI ALLA STORIA DEL RIPOSTIGLIO CONSOLARE, ECC. 185<br />
Tituria . . .
i86<br />
SERAFINO RICCI
CONTRIBUTI ALLA STORIA DEL RIPOSTIGLIO CONSOLARE, ECC. 187
i88<br />
SERAFINO RICCI
IO<br />
CONTRIBUTI ALLA STORIA DEL RIPOSTIGLIO CONSOLARE, ECC. 189
igo<br />
SERAFINO RICCI
CONTRIBUTI ALLA STORIA DEL RIPOSTIGLIO CONSOLARE, ECC. I9I
192<br />
SERAFINO RICCI
CONTRIBUTI ALLA STORIA DEL RIPOSTIGLIO CONSOLARE, ECC. I93<br />
ELENCO DELLE MONETE CONSOLARI<br />
DI PALAZZO CANAVESE<br />
ACQUISTATE DALLA DIREZIONE DEL R. MuSEO DI ANTICHITÀ IN ToRINO.<br />
I Calpurnia, del tipo Fabretti, n. 1490, con caduceo e g da un<br />
lato, V e G dall'altro; ve<strong>di</strong> Babelon I, p. 292, n. 12 (89 a. C).<br />
I Calpurnia, del tipo Fabretti, n. 1421, 1447, con f da un lato,<br />
testa d'asino dall'altro; ve<strong>di</strong> Babelon, ibidem, (89 a, C).<br />
I Calpurnia, del tipo Fabretti, n. 1572 e segg., con la variante<br />
della spica; ve<strong>di</strong> Babelon I, p. 301, n. 26 (64 a. C).<br />
I Clau<strong>di</strong>a, del tipo Fabretti, n. 1787, col n. lxviii; ve<strong>di</strong> Babelon I,<br />
P- 349, n. 5 (84<br />
a. C).<br />
I Corneliaf del tipo Fabretti, n. 2079, con la variante s; ve<strong>di</strong> Ba-<br />
belon I, p. 399-400, n. 24 (90 a. C).<br />
I Fundania, del tipo Fabretti, n. 2700 e segg., con lettera a; ve<strong>di</strong><br />
Babelon I, p. 515, n. i, (loi a. C).<br />
I Julia, del tipo Fabretti, n. 2903 e segg., con protome <strong>di</strong> cavallo<br />
e tridente; ve<strong>di</strong> Babelon lì, p. 6-7, n. 5 (88 a. C).<br />
I Julia, del tipo Fabretti, n. 2910 e segg., col n. ixxix; ve<strong>di</strong> Ba-<br />
belon II, p. 6-7, n. 5 (88 a. C).<br />
1 Julia, del tipo Fabretti, n. 2991 e segg., con tridente e luna<br />
crescente da un lato, e na sotto la quadriga; ve<strong>di</strong> Babelon II,<br />
pag. 6-7, n. 5 (88 a. C).<br />
I Julia, del tipo Fabretti, n. 3074, con variante del fiore <strong>di</strong>etro<br />
la testa <strong>di</strong> Venere, ve<strong>di</strong> Babelon II, p. 12, n. 12 (50 a C).<br />
I Marcia, del tipo Fabretti, n. 3551, col n. xxxvi; ve<strong>di</strong> Babelon II,<br />
p. 196, n. 27 (84 a. C).<br />
I Tituria, del tipo Fabretti, n. 4913 e segg., con la variante del-<br />
i'armatura; ve<strong>di</strong> Babelon II, p. 499,<br />
n. 6 (88 a. C).<br />
I Tituria, del tipo Fabretti, n. 4913 e segg., <strong>com</strong>e sopra, con la<br />
variante dello strigile degli attrezzi atletici; ve<strong>di</strong> Babelon II,<br />
p. 499,<br />
n. 6, <strong>com</strong>e sopra (88 a. C).<br />
"5
194<br />
SERAFINO RICCI<br />
Dall'esame precedente delle monete <strong>di</strong> Palazzo Canavese<br />
risultano finora i seguenti dati, relativi a quel ripostiglio. Esso<br />
è <strong>com</strong>posto esclusivamente <strong>di</strong> nummi consolari d' argento,<br />
non essendo calcolabile quell'unico bronzo imperiale irreco-<br />
noscibile, <strong>di</strong> provenienza dubbia, e, secondo me, non prove-<br />
niente dal medesimo scavo. Delle 159 monete esaminate, 156<br />
appartengono alla repubblica romana, e si estendono dal 217<br />
a. C, col denaro della Baebia, coniato da Cn. Baebius Tarn-<br />
pilus, al 20 a. C, con quello della Petronia, coniato da P.<br />
Petronius Turpilianus.<br />
Tre nummi appartengono al periodo augusteo, e furono<br />
coniati sotto Augusto, dopo il 28 a. C. ; non toccano però<br />
nessuno l'Era Volgare. È verosimile che il ripostiglio intero<br />
fosse ben piii riccamente rappresentato, e si estendesse in<br />
un periodo <strong>di</strong> tempo molto maggiore, se in così piccolo<br />
numero <strong>di</strong> monete già si può abbracciare lo spazio <strong>di</strong> tempo<br />
<strong>di</strong> quasi due secoli. E tale doveva essere la copia e la varietà<br />
dei tipi da far supporre si trattasse veramente <strong>di</strong> cassa mili-<br />
tare per il pagamento delle truppe <strong>di</strong> presi<strong>di</strong>o, probabilmente<br />
alla vicina Epore<strong>di</strong>a (Ivrea), che, fondata nel 100 a. C. nel<br />
paese dei Salassi, e più tar<strong>di</strong> retta <strong>com</strong>e municipium con<br />
magistrati in<strong>di</strong>pendenti, era, <strong>com</strong>e Augusta Praetoria (Aosta),<br />
uno dei centri militari <strong>di</strong> maggior importanza per tener testa<br />
alle invasioni e alle ribellioni dei popoli Alpini.<br />
La maggior parte delle monete non eccede l'importanza<br />
e il valore me<strong>di</strong>o, però alcuni pezzi sono rari ; oltre la Cornu-<br />
ficia già citata, ch'io non ebbi nelle mani, citerò la Garcilia<br />
n. 2759, che ha il valore <strong>di</strong> catalogo <strong>di</strong> Fr. 50; XAugusius<br />
n. 37, che ha quello <strong>di</strong> Fr. 30; là Baebia n. 1224 = Fr. 25,<br />
la Petronia n. 4166 = Fr. 20; la Vihia n. 5171 = Fr. 15;<br />
Pompeo Magno = Fr. 15; la Julia n. 3143 = Fr. io. Il<br />
valore <strong>com</strong>plessivo <strong>di</strong> catalogo delle monete da me vedute<br />
ammonterebbe a Fr. 516, e si può immaginare il valore <strong>di</strong><br />
tutto il ripostiglio, anche non eccedendo la me<strong>di</strong>a del valore<br />
<strong>di</strong> quelle esaminate, qualora si pensi che queste rappresen-<br />
tano solo Vo <strong>di</strong> quelle sequestrate dai carabinieri dopo le prime<br />
<strong>di</strong>spersioni. Questo rende ancor maggiore il <strong>di</strong>spiacere <strong>di</strong><br />
aver tanto perduto per incuria e per inscienza <strong>di</strong> chi rinvenne<br />
e possedette nei primi anni il tesoretto <strong>di</strong> Palazzo, il quale
CONTRIBUTI ALLA STORIA DEL RIPOSTIGLIO CONSOLARE, ECC. I95<br />
non ha, secondo me, importanza esclusivamente <strong>numismatica</strong>,<br />
ma anche archeologica, in quanto che finora è l'unico ritrovamento<br />
d'antichità <strong>di</strong> un certo valore, avvenuto nella zona<br />
<strong>di</strong> quel territorio (21).<br />
Il Canavese è in generale poco rappresentato nell'anti-<br />
chità classica, e per nulla affatto sinora nella sezione piemon-<br />
tese del Museo; si ha però qualche notizia spora<strong>di</strong>ca <strong>di</strong><br />
ritrovamenti (22). P. es. <strong>di</strong> S. Giusto Canavese si conoscono<br />
alcune sepolture romane, <strong>di</strong> cui la suppellettile era <strong>com</strong>posta<br />
per ogni tomba <strong>di</strong> un' umetta <strong>di</strong> terra grossolana, coperta<br />
da una coppa <strong>di</strong> terra rossa piii fina, capovolta, e tre vasi<br />
con largo ventre, manico e collo stretto. La tomba era quin<strong>di</strong><br />
ad incinerazione, e vi appartenevano pure un piccolo balsa-<br />
mario <strong>di</strong> vetro bianco ed un me<strong>di</strong>o bronzo <strong>di</strong> Tiberio; altri<br />
fittili ed un<strong>di</strong>ci monete imperiah <strong>di</strong> me<strong>di</strong>o bronzo, da Tiberio<br />
a Tito, furono scoperte in un luogo vicino a quello del ritrovamento<br />
precedente, anzi nello stesso fondo, ma nella parte<br />
spettante al Comune <strong>di</strong> Foglizzo (23).<br />
Un'iscrizione latina del monastero <strong>di</strong> S. Ponzo Canavese<br />
presso Valperga cita una certa Matilda Paterna ex pago<br />
Licirro, vico Navelis, che ci dà il titolo romano <strong>di</strong> quei <strong>di</strong>n-<br />
torni (24). Pure <strong>di</strong> Valperga citano epigrafi romane (25), ed<br />
(21) Per gentile <strong>com</strong>unicazione del figlio Ludovico dell'on. Marchese<br />
Carlo Compans <strong>di</strong> Brichanteau, che aveva anni fa alcuni posse<strong>di</strong>menti<br />
a Palazzo Canavese, ho potuto sapere che furon trovate dal giar<strong>di</strong>niere<br />
<strong>di</strong> casa alcune monete sparse nel terreno, e venute in luce in occasione<br />
<strong>di</strong> lavori campestri, con qualche lucerna <strong>di</strong> terra cotta e non pochi lacri-<br />
matoi; il che farebbe pensare a tombe romane. Le monete da me vedute<br />
l' anno scorso erano anch' esse repubblicane, e d' argento, una della<br />
Fannia, coniata da M. Fannius, che risale al 149 a. C. (Babelon I, p. 491,<br />
n. i), un' altra della Thoria, coniata da L. Thorins Balbus del 79 a. C.<br />
(Babelon II, p. 487), e una terza della Rubria, <strong>di</strong> L, Rubrius Dossenus<br />
del 49 a. C. (Babelon II, pag. 406, n. i).<br />
(22) Descrisse il Canavese e ne raccolse le memorie storiche A.<br />
Bertolotti nei siioi lavori : Passeggiate nel Canavese, Ivrea, Curbis, 1867-<br />
1872 (voi. 6); Fasti Canavesani, ibidem 1870; Gite nel Canavese, ibidem 1872.<br />
(23) Ve<strong>di</strong> Notizie degli Scavi, 1894, P« 187.<br />
(24) Q.(orpns) \(nscriptionnm) l^fatinarum) V, 2, 7923. Della medesima<br />
provenienza sono le iscrizioni C. I. L. V, 2, 7882 e 6917, questa riveduta e<br />
corretta dal eh. Pais {Notizie Scavi 1883, p. 149).<br />
(25) Notizie degli Scovi, 1883, p. 149-150.
196<br />
SERAFINO RICCI<br />
una ne abbiamo nella Collezione lapidaria del Museo, da<br />
Forno <strong>di</strong> Rivara (catalogo n. 3397). S. Martino Canavese ci<br />
<strong>di</strong>ede un vaso d' argilla giallognola, citato e illustrato dal<br />
<strong>com</strong>pianto avv. Vittorio Del Corno (26).<br />
Tutta la zona d'Ivrea e delle sue torbiere, giù fin oltre<br />
Piverone e il Lago <strong>di</strong> Viverone, è conosciuta fin dal tempo<br />
preromano, e splen<strong>di</strong>damente rappresentata al Museo <strong>di</strong><br />
Antichità in Torino dalla Collezione Gastal<strong>di</strong> (27), che prima<br />
trovavasi al Museo Civico (28). Palazzo Canavese, che è fra<br />
Piverone ed Ivrea, trovasi sulla via romana che da Lomello<br />
(Laumellum) per Vercelli (Vercellae) conduceva ad Ivrea,<br />
passando appunto per Dorzano e Piverone; è quin<strong>di</strong> verosi-<br />
mile che, se finora esso non ha dato molto agli stu<strong>di</strong> archeo-<br />
logici, ne possa dare in sèguito, per scavi fortuiti o siste-<br />
matici che siano condotti lungo la strada romana.<br />
Torino, Maggio 1897.<br />
(R. Museo d'Antichità).<br />
Serafino Ricci.<br />
(26) Ve<strong>di</strong> Atti della Società <strong>di</strong> Arch. e B. A. in Torino, II, p. 120,<br />
tav. V, n. 9.<br />
(27) Ve<strong>di</strong> Gastal<strong>di</strong> B., Nuovi cenni sugli oggetti <strong>di</strong> alta antichità<br />
trovati nelle torbiere e nelle marniere dell'Italia. Torino, Marzorati, 1862;<br />
Iconografia <strong>di</strong> alcuni oggetti <strong>di</strong> remota antichità rinvenuti in Italia, in<br />
Memorie dell'Accademia delle Scienze <strong>di</strong> Torino, serie II, tomo XXVI<br />
(1871). Cfr. dott. De Agostini; Le torbiere dell'anfiteatro morenico d'Ivrea<br />
in <strong>Rivista</strong> geografica <strong>italiana</strong> II (1895), ^^sc. V, pag. 287.<br />
(28) Sul trasporto della Collezione Gastal<strong>di</strong> dal Museo Civico al R.<br />
Museo d'Antichità, ve<strong>di</strong> in questa <strong>Rivista</strong> <strong>di</strong> Numismatica, IX (1896),<br />
pag. 245, n. 5.
OPERE NUMISMATICHE<br />
DI<br />
CARLO KUNZ<br />
(Continuazione: Ve<strong>di</strong> Fase. I, 1897).
IL MUSEO BOTTACIN<br />
ANNESSO ALLA CIVICA BIBLIOTECA E MUSEO DI PADOVA (i)<br />
Fra tanto attuale fervore per gli stu<strong>di</strong> patrii, è indubitato<br />
che anche la scienza che ha per oggetto le antiche monete,<br />
principale ausiliaria della cronologia e della storia, dovrà<br />
riacquistare in Italia quell'intiero favore e quella <strong>di</strong>ffusione<br />
che a ragione si merita. Tacendo <strong>di</strong> alcune splen<strong>di</strong>de ecce-<br />
zioni, havvi bensì ancora qualche tiepidezza, prodotta più<br />
che altro, da estrinseche cagioni, ma sorgono anche tuttodì<br />
in<strong>di</strong>zi consolanti del contrario, e sono : il numero ognor<br />
crescente <strong>di</strong> raccolte numismatiche pubbliche e private, le<br />
pubblicazioni <strong>di</strong> singole o perio<strong>di</strong>che opere nummografiche<br />
che ad intervalli <strong>com</strong>pariscono, e quelle <strong>di</strong> maggiore entità<br />
che da alcuni valenti si stanno dettando.<br />
Salutiamo con gioia questo ravvivato in<strong>di</strong>rizzo delle<br />
menti verso lo stu<strong>di</strong>o della patria <strong>numismatica</strong>, imperocché<br />
siamo d' avviso eh' esso sia destinato a rendere importanti<br />
servigi ed accrescere gloria al bel paese. Ed invero, non<br />
sono le monete monumenti parlanti delle età passate; fonte<br />
ricchissima per la cognizione della cronologia, della storia,<br />
dell'archeologia; specchio sincero delle con<strong>di</strong>zioni civili, delle<br />
tendenze religiose, dello stato economico e <strong>di</strong> quello delle<br />
arti nelle città e regioni in cui ebbero corso? Se così non<br />
fosse, tutti i governi civili profonderebbero tante cure e tanti<br />
tesori nella fondazione od ampliazione <strong>di</strong> ricchissimi gabinetti<br />
numismatici, e nobili municipi, gareggiando con essi a tenore<br />
dei propri mezzi, porrebbero sì amorevole stu<strong>di</strong>o nel <strong>com</strong>-<br />
porre raccolte <strong>di</strong> monete, sia pure della sola provincia o<br />
(i) Pubblicato nel Perio<strong>di</strong>co <strong>di</strong> <strong>numismatica</strong> e sfragistica per la storia<br />
d'Italia. Firenze 1868, Anno I (N. d. D.).
200 CARLO KUNZ<br />
città propria? E magnanimi citta<strong>di</strong>ni, inspirati da tale verità,<br />
farebbero ad essi generosa cessione delle collezioni intorno<br />
alle quali spesero cure infinite e tempo e ricchezze? È d'uopo<br />
convenire che nelle antiche monete siavi ben più <strong>di</strong> quanto<br />
la folla dei profani è <strong>di</strong>sposta <strong>di</strong> ravvisare, se ve<strong>di</strong>amo, per<br />
citare pochi esempì, il dominatore della Russia decretare<br />
l'acquisto <strong>di</strong> vistosissime raccolte già <strong>di</strong> privata ragione ; il<br />
Museo Britannico non trascurare occasione, ne arrestarsi a<br />
<strong>di</strong>spen<strong>di</strong> per l'incremento delle proprie collezioni, ed aggiun-<br />
gere premuroso perfino serie tali la cui imme<strong>di</strong>ata utilità per<br />
esso non apparisce a prima vista, <strong>com</strong>e ad esempio la<br />
cospicua raccolta <strong>di</strong> monete venete già formata da Enrico<br />
Koch in Trieste, e fare altrettanto i governi <strong>di</strong> Prussia e <strong>di</strong><br />
Francia, e questo, con decreto speciale del Ministero della<br />
Pubblica Istruzione, notisi bene, autorizzare la spesa <strong>di</strong> ben<br />
trentamila franchi per l'acquisto <strong>di</strong> un solo aureo medaglione<br />
<strong>di</strong> Eucratide, re della Battriana!<br />
Per ciò che riguarda raccolte numismatiche formate da<br />
privati e generosamente donate a città <strong>di</strong> loro pre<strong>di</strong>lezione,<br />
basti citare il defunto benemerito citta<strong>di</strong>no Camillo Bruzzoni,<br />
che legava alla sua Brescia la ricchissima serie <strong>di</strong> monete e<br />
medaglie, precipuamente italiane, da lui adunata, raccolta<br />
che attende ancora <strong>di</strong> essere convenientemente <strong>di</strong>sposta e<br />
cribrata; l'illustre <strong>com</strong>mendatore canonico Spano, che cedeva<br />
al Regio Museo <strong>di</strong> Cagliari la importante serie <strong>di</strong> monete<br />
ed altre antichità dell'isola Sarda, con somma <strong>di</strong>ligenza da<br />
lui <strong>com</strong>posta, e finalmente il chiarissimo signor cavaliere<br />
Nicolò Bottacin, il quale in pari modo donava alla città <strong>di</strong><br />
Padova l'egregia collezione <strong>di</strong> monete e medaglie che con<br />
gran<strong>di</strong>ssimo amore e lauto <strong>di</strong>spen<strong>di</strong>o andò formando nella<br />
cortese Trieste, che per molti anni ebbe la ventura <strong>di</strong> annoverarlo<br />
<strong>di</strong>stinto ed onorato citta<strong>di</strong>no. E fece opera magnanima<br />
e giusta, avvegnaché quella dotta ed illustre città, nella cui<br />
provincia egli ebbe i natali, fosse ben degna <strong>di</strong> tale prefe-<br />
renza, e meritasse <strong>di</strong> aggiungere a tanti altri titoli <strong>di</strong> gloria<br />
ed al possesso del più antico giar<strong>di</strong>no botanico, <strong>di</strong> ricchis-<br />
sime raccolte paleontologiche, zoologiche, e mineralogiche,<br />
<strong>di</strong> ampie biblioteche ed archivi, e <strong>di</strong> una pregevole pinacoteca,<br />
un sì segnalato gabinetto numismatico, il quale <strong>com</strong>pen<strong>di</strong>a
IL MUSEO BOTTACIN 20l<br />
in sè la storia d'Italia delle età <strong>di</strong> mezzo e dei tempi a noi<br />
più vicini. E la città per tal modo pre<strong>di</strong>letta corrispose degnamente<br />
a tanta liberalità, perchè tosto la illustre sua<br />
rappresentanza sanzionò riconoscente l'accettazione del co-<br />
spicuo dono, ed annuì ai desideri espressi dall'egregio cava-<br />
liere, statuendo quella raccolta fosse conservata in apposita<br />
sala del Civico Museo, la quale avesse titolo <strong>di</strong> Museo<br />
Bottacin, e decretando inoltre l'aggregazione dell'illustre<br />
donatore alla citta<strong>di</strong>nanza padovana, <strong>com</strong>e poco appresso la<br />
insigne Accademia della stessa città acclamavalo suo socio<br />
onorario. Né a ciò soltanto si arresteranno le premure della<br />
illustre Rappresentanza padovana, ma siamo convinti che.<br />
<strong>com</strong>e ella provvederà nell'avvenire pel più conveniente col<br />
locamento della sua Civica Biblioteca e Museo, farà quanto<br />
è da lei acciò anche le serie numismatiche del Museo Bottacin<br />
siano sempre custo<strong>di</strong>te, nonché aumentate colle più amore-<br />
voli cure, e ne sia colle dovute cautele facilitata l'ispezione<br />
agli stu<strong>di</strong>osi.<br />
Se le raccolte sono la suppellettile in<strong>di</strong>spensabile d'ogni<br />
stu<strong>di</strong>o scientifico, gli arsenali, per così <strong>di</strong>re, nei quali la<br />
scienza ritrova le più valide armi per la conquista del vero,<br />
conviene tuttavia che 1' uso <strong>di</strong> esse ne sia facilitato in tutti<br />
i mo<strong>di</strong> possibili, coli' or<strong>di</strong>namento più opportuno e razionale,<br />
colla cortese prestazione per parte degli incaricati alla loro<br />
custo<strong>di</strong>a, e con cataloghi stampati che ne <strong>di</strong>vulghino anche<br />
ai lontani la conoscenza.<br />
Sono i cataloghi per mio avviso tanto importanti, che<br />
nessuna collezione <strong>di</strong> qualche entità dovrebbe esserne priva ;<br />
sono essi altrettante guide che segnalano all'attenzione degli<br />
stu<strong>di</strong>osi ciò che a loro può maggiormente interessare, li<br />
sollevano da molte noiose ricerche, e li aiutano in quelle che<br />
per iscopo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> speciali vanno facendo. Qualora si aves-<br />
sero stampati con buon metodo e precisione i cataloghi delle<br />
principali raccolte <strong>di</strong> monete <strong>di</strong> zecche italiane, sarebbe già<br />
fatto un passo gigante verso quella <strong>com</strong>pleta illustrazione<br />
<strong>di</strong> esse, la quale, me<strong>di</strong>ante singole monografie, non potrà<br />
essere ottenuta che in lungo lasso <strong>di</strong> tempo. Di ciò emmi<br />
chiaro essere convinti anche il prelodato <strong>com</strong>mendatore Spano,<br />
che dettò il catalogo delle raccolte da lui donate al Regio
202<br />
CARLO KUN2<br />
Museo <strong>di</strong> Cagliari, l'illustre dottore Luigi Pigorini, che <strong>di</strong>ede<br />
principio alla pubblicazione <strong>di</strong> quello del Regio Museo par-<br />
mense, alle dotte sue cure affidato, e l' egregio cavaliere<br />
Bottacin, il quale si è proposto <strong>di</strong> effettuare quello delle<br />
monete e medaglie che <strong>com</strong>pongono il Museo da lui intitolato.<br />
Ma poiché la <strong>com</strong>pilazione <strong>di</strong> un catalogo generale <strong>di</strong> tutte<br />
le serie ivi accolte richiederà tempo, ho stimato potesse<br />
intanto tornare opportuna una succinta notizia che desse<br />
ragione dell'importanza <strong>di</strong> quelle raccolte, e ne facesse ri-<br />
saltare i pregi generali e le specialità più meritevoli <strong>di</strong><br />
rimarco. Gli è ben vero essersi <strong>di</strong> già ciò fatto per opera<br />
dell'illustre signor professore Andrea Gloria nella Relazione<br />
dei doni offerti al Civico Museo, impressa nell' anno 1867,<br />
ma poiché suo scopo era soltanto quello <strong>di</strong> porgere una<br />
generale idea del Museo Bottacin, così restami ancora campo<br />
aperto per farne alquanto più lungo ragionamento, ed è ciò<br />
che ora intraprendo.<br />
Il Museo Bottacin, <strong>com</strong>e <strong>di</strong>sse <strong>di</strong> già il prelodato signor<br />
professore, <strong>com</strong>ponesi <strong>di</strong> sei parti o serie <strong>di</strong>stinte, <strong>di</strong>sposte<br />
con bell'or<strong>di</strong>ne in altrettanti stipi <strong>di</strong> elegante e soHdo lavoro,<br />
eseguiti a spese dello stesso donatore, unitamente ad ogni<br />
altro arredo in<strong>di</strong>spensabile a quella sala. Il primo contiene<br />
la serie delle monete <strong>di</strong> zecche italiane, escluse quelle che<br />
fanno parte delle seguenti: pontificia, veneta e napoleonica;<br />
il secondo rinchiude la serie delle monete, bolle e medaglie<br />
dei romani pontefici; il terzo quello delle monete venete; il<br />
quarto una collezione <strong>di</strong> monete e medaglie della grande<br />
rivoluzione europea, <strong>di</strong> Napoleone I sino al trasporto delle<br />
sue ceneri a Parigi, e dei membri della sua famiglia; nel<br />
quinto è <strong>di</strong>sposta una incipiente raccolta <strong>di</strong> nummi dell'antica<br />
Roma repubblicana ed imperiale, e nel sesto una collezione<br />
<strong>di</strong> fac-simili <strong>di</strong> oltre tremila pregevoli cammei, che si conservano<br />
in vari Musei d'Europa. Il centro della sala è adorno<br />
<strong>di</strong> una vaga custo<strong>di</strong>a a vetri, nella quale per ora stanno<br />
esposti alcuni pregevoli medaglioni d' argento e <strong>di</strong> bronzo,<br />
una raccolta <strong>di</strong> monete, medaglie e sigilli che ricordano i<br />
fatti che iniziarono e portarono quasi a <strong>com</strong>pimento la in<strong>di</strong>-<br />
pendenza <strong>di</strong> tutta Italia, ed un prezioso aureo anello-sigillo<br />
pel doge Paolo Renier. Ammiransi inoltre in quella sala un
IL MUSEO BOTTACIN 203<br />
pilo <strong>di</strong> bronzo, opera squisita <strong>di</strong> Andrea Briosco, detto il<br />
Riccio, rinomato plasticatore padovano; il busto in terracotta<br />
del nominato doge, modellato dalla mano dell'immortale<br />
Canova; quello in gesso del pontefice Pio VII, dallo stesso;<br />
una copia, pure in gesso, della effigie del cantor dell'Inferno,<br />
opera del secolo XV, che serbasi in bronzo nel Museo Nazionale<br />
<strong>di</strong> Napoli, ed una serica ban<strong>di</strong>era militare della Veneta<br />
Repubblica.<br />
Fra cotante preziosità riunite ne sarebbe mancata una<br />
essenzialissima, quella dei libri, elemento e scorta in<strong>di</strong>spen-<br />
sabile d'ogni stu<strong>di</strong>o, ma anche a ciò seppe provvedere il<br />
previdente donatore, me<strong>di</strong>ante buon novero d'opere <strong>di</strong> storia,<br />
d'archeologia e d'arte, pelle quali egli si è proposto <strong>di</strong> far<br />
foggiare apposito mobile in armonia coi ricordati, quando<br />
altra sala <strong>di</strong> maggiore capacità ne permetterà il collocamento.<br />
Né con ciò è ancora segnato l'ultimo confine alla generosità<br />
del benemerito cavaliere, avvegnaché egli continui senza posa<br />
ad aggiungere cose nuove al santuario <strong>di</strong> sua creazione, il<br />
quale non passa giorno, può <strong>di</strong>rsi, che non vada arricchendosi<br />
maggiormente in monete, in medaglie, in libri od altre pre-<br />
gevolissime cose. Egli vi ha consacrato ormai ogni suo<br />
pensiero, da quando, abbandonate le cure del <strong>com</strong>mercio,<br />
fissò stabile <strong>di</strong>mora nella città antenorea. £ necessario che<br />
ciò sappia l'Italia, la quale, se ognora onorò i figli egregi<br />
che la illustrarono colle opere dell'ingegno e del valore, non<br />
mancherà <strong>di</strong> acclamare altamente suo benemerito chi, muni-<br />
ficentemente largendole i frutti della sua colta e <strong>di</strong>ligente<br />
operosità, mostrava una volta <strong>di</strong> piia <strong>com</strong>e, anche all' infuori<br />
del ministero della spada, o <strong>di</strong> quella della parola, si possa<br />
<strong>di</strong>ventare grandemente utili al proprio paese.<br />
Ed ora passerò ad accennare per sommi capi quanto<br />
custo<strong>di</strong>scono quei medaglieri, dall'or<strong>di</strong>ne dei quali <strong>di</strong>scostandomi<br />
in parte, seguirò per le monete italiane il geografico-<br />
politico, sic<strong>com</strong>e quello che meglio sod<strong>di</strong>sfa alle ragioni<br />
scientifiche, per rapporto alla storia del passato, alla quale<br />
cosifatti monumenti si riferiscono.<br />
Sorpassando le ragioni che consiglierebbero <strong>di</strong> collocare<br />
prime nell' or<strong>di</strong>ne delle monete italiane quelle che portano<br />
impressi i nomi dei re e degli imperatori <strong>di</strong> stirpe ostrogota,
204 CARLO KUNZ<br />
longobarda, franca, <strong>italiana</strong> e tedesca, senz' altra in<strong>di</strong>cazione<br />
delle zecche onde uscirono, per essere desse ancora in iscarso<br />
numero in questo museo, e soltanto della serie dei re goti,<br />
con pochi denari dal tempietto e colla leggenda xpistiana<br />
RELiGio, furono aggiunte le prime alle monete della zecca<br />
<strong>di</strong> Ravenna, ed inserite le altre fra quelle <strong>di</strong> Milano, nella<br />
cui zecca alcune con qualche verosimiglianza , altre con<br />
certezza si ritengono battute.<br />
IL PIEMONTE E LA LIGURIA<br />
Torino.<br />
Al nome <strong>di</strong> questa principale zecca della reale <strong>di</strong>nastia<br />
<strong>di</strong> Savoia, onde non ismembrare <strong>di</strong> troppo la loro serie,<br />
si raccolsero tutte quelle monete che dal conio <strong>di</strong>stinto, o<br />
pei nomi locali inscrittivi piìi che con semplici iniziali, o per<br />
circostanze particolari <strong>di</strong> loro battitura non fannosi a prima<br />
vista riconoscere per fattura <strong>di</strong> altre zecche.<br />
Ove si rifletta alla doviziosità <strong>di</strong> questa classe, quale ci<br />
fu rivelata dall'opera insigne dell'illustre sig. <strong>com</strong>mendatore<br />
Promis, è giuocoforza confessare essere ben arduo raggiun-<br />
gere in essa quel grado <strong>di</strong> perfettibilità ond'è suscettibile,<br />
amenochè uno non voglia de<strong>di</strong>carvisi con ispeciale pre<strong>di</strong>le-<br />
zione; ma tuttavia non è spregevole il novero e la qualità<br />
dei pezzi già raccolti, fra cui sembranmi degni <strong>di</strong> menzione<br />
i seguenti :<br />
Un denaro <strong>di</strong> tipo ginevrino, per opinione <strong>di</strong> quell'egregio<br />
autore battuto nella zecca <strong>di</strong> Nyon dal conte Amedeo VII;<br />
due esemplari, uno dei quali con leggende scorrette, del<br />
ducato d'oro del duca Lodovico, fatto a similitu<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> quelli<br />
<strong>di</strong> Milano dei duchi viscontei; un denaro piccolo <strong>di</strong> Filiberto I,<br />
un testone <strong>di</strong> Carlo I; un denaro ine<strong>di</strong>to <strong>di</strong> Carlo II (Vedasi<br />
tav. IV, n. i); due scu<strong>di</strong> d'oro ed un tallero col duca
IL MUSEO BOTTACIN 205<br />
battagliero a cavallo, <strong>di</strong> Emmanuele Filiberto; il ducato d'oro<br />
col simulacro della Madonna <strong>di</strong> Vico, due <strong>di</strong>icatoni ed un<br />
mezzo ducatene dall'arme, uno scudo <strong>di</strong> Vercelli col Beato<br />
Amedeo, e due mezzi scu<strong>di</strong> Spa<strong>di</strong>ni, uno dei quali contro-<br />
marcato, ed una lira <strong>di</strong> Carlo Emmanuele I; un ducatene <strong>di</strong><br />
Vittorio Amedeo I; la doppia da due <strong>di</strong> Maria Cristina, tutrice<br />
dell'infante Francesco Giacinto; un quarto <strong>di</strong> ducatene della<br />
seconda reggenza <strong>di</strong> quella principessa, sfuggito alle <strong>di</strong>ligenti<br />
ricerche dell'esimio Commendatore (Tav. IV, n. 2); lo zecchino<br />
dell'Annunziazione, nonché la sua metà, <strong>di</strong> Carlo Emma-<br />
nuele III, ed altre belle cose in tutti i metalli, che oltrepas-<br />
sano il numero <strong>di</strong> cento pezzi.<br />
Di questa stessa zecca evvi poi un denaro piccolo tornese<br />
<strong>di</strong> Filippo principe d'Acaia.<br />
Asti.<br />
Venendo alle minori zecche del Piemonte, e procedendo<br />
per or<strong>di</strong>ne approssimativo <strong>di</strong> anzianità, incontriamo Asti che<br />
da Corrado II ebbe il privilegio della moneta, e tenne zecca<br />
operosissima, in fuori <strong>di</strong> qualche breve interruzione, pel corso<br />
<strong>di</strong> tre secoli e mezzo, <strong>com</strong>e <strong>di</strong>mostrò con altro lodatissimo<br />
dettato il predetto signor Commendatore. Ma, quantunque<br />
codesta zecca vanti numerosi monumenti, sono dessi per la<br />
massima parte rari, e pochi ne serba questo museo, per cui<br />
limiterommi a citare la pregevole parpagliela dalla croce del<br />
re Lodovico XII, ed il cavallotto del principe Emmanuele<br />
Filiberto.<br />
Alessandria.<br />
Delle sole tre monete finora conosciute, lavorate entro<br />
le mura <strong>di</strong> questo forte propugnacolo d'Italia, evvi la ossi-<br />
<strong>di</strong>onale da <strong>di</strong>eci sol<strong>di</strong>, <strong>di</strong> schietto rame, fatta battere dal<br />
governatore marchese <strong>di</strong> Caraglio, in <strong>di</strong>stretta <strong>di</strong> numerario,<br />
mentre eravi bloccato dal generale Maillebois, nell'anno 1746;<br />
e per <strong>di</strong> più sia ricordata la non rara medaglia colla effigie<br />
del re Carlo Emmanuele III, <strong>com</strong>memorativa <strong>di</strong> quell'asse<strong>di</strong>o.
206<br />
CARLO KUNZ<br />
Novara.<br />
Questa città, sì <strong>di</strong> sovente contrastata a furore d'armi,<br />
i cui monumenti numismatici sono pochi e tutti notevoli per<br />
rarità, è rappresentata da tre monete, cioè, dal prezioso<br />
grosso col nome <strong>di</strong> un Enrico imperatore, che l' illustre<br />
<strong>com</strong>mentatore delle zecche del Piemonte determinò essere<br />
il sesto; dal denaro piccolo imperiale che lo stesso giu<strong>di</strong>cò<br />
appartenere alla prima metà del secolo XIII, mentre il chia-<br />
rissimo signor D/^ P. Caire vorrebbelo più antico, e forse<br />
del vescovo Guglielmo Torniello, intorno al 1153, e finalmente<br />
da un sesino o quattrino che sia, <strong>di</strong> Pier Luigi Farnese, il<br />
quale, sebbene fosse contemporaneamente duca <strong>di</strong> Parma e<br />
Piacenza, non potè, <strong>com</strong>e tale, esercitare la facoltà <strong>di</strong> battere<br />
moneta che in questo suo inferiore dominio dal rango <strong>di</strong><br />
marchesato.<br />
SusA.<br />
Più antica fra le zecche dei conti <strong>di</strong> Savoia, e pella quale<br />
il Rabut tentò riven<strong>di</strong>care un tremisse merovingio, non figura<br />
che per un solo denaro, facile a rinvenire, <strong>di</strong> Amedeo III.<br />
Tortona.<br />
Le pochissime monete esistenti <strong>di</strong> questa città ricordano<br />
tutte l'imperatore Federigo II che nell'anno 1248 accordavale<br />
il privilegio della zecca, e poiché vi sono rarissime le sud<strong>di</strong>-<br />
visioni del grosso, non possiamo affermare che il possesso<br />
delle due varietà <strong>di</strong> esso, la prima delle quali con la croce<br />
ac<strong>com</strong>pagnata da due anelletti , che mostra carattere <strong>di</strong><br />
maggiore antichità, è <strong>di</strong> qualche pregio.<br />
Acqui.<br />
Contemporanea a quella <strong>di</strong> Tortona, questa zecca, oltre<br />
a monete simili a quelle, segnate dal nome del secondo<br />
Federico, ne vanta alcune del vescovo Oddone Berlinghieri,
IL MUSEO BOTTACIN 207<br />
dei primi anni del secolo XIV, tutte rarissime, sì le prime<br />
che le seconde, ond'è che con piacere notiamo l'esistenza<br />
del denaro mezzano col nome <strong>di</strong> quell'imperatore, <strong>di</strong>vulgato<br />
dalla <strong>Rivista</strong> Italiana della Numismatica.<br />
Vercelli.<br />
Al pari delle due precedenti ebbe questa antichissima<br />
città da Federigo II il privilegio della moneta, ma <strong>di</strong> quel<br />
primo periodo della sua zecca è noto un solo pregevolissimo<br />
grosso, del quale forse col tempo si scuopriranno le parti<br />
aliquote. Fu poi operosissima sotto il dominio dei duchi <strong>di</strong><br />
Savoia, pel corso <strong>di</strong> oltre un secolo, dal 1530 in poi, e le<br />
monete battutevi essendo per lo più contrad<strong>di</strong>stinte dalla<br />
iniziale del suo nome, tacerò <strong>di</strong> esse per la già esposta ra-<br />
gione, e limiterommi a segnalare due pezzi i quali ricordano<br />
l'asse<strong>di</strong>o sostenutovi dal governatore marchese Dogliani a<br />
nome della duchessa Maria Cristina, reggente e tutrice del<br />
figlio Francesco Giacinto, contro le armi <strong>di</strong> Spagna, nel-<br />
l'anno 1638.<br />
Il primo è un quarto <strong>di</strong> lira <strong>di</strong> bassa lega che <strong>di</strong>fferisce<br />
da quelH riportati dall'illustre Commendatore Promis, ma è<br />
invece uguale alla doppia, e mostra dunque che gli stessi coni<br />
servirono per due effetti. Il secondo è un mezzo soldo <strong>di</strong> lega<br />
ancor più povera, pochissimo <strong>di</strong>ssimile da quello che figura<br />
nella <strong>di</strong>ssertazione delle monete ossi<strong>di</strong>onali del Piemonte.<br />
Chivasso e Casale.<br />
Raccogliamo in solo gruppo queste due città, nelle quali<br />
i marchesi del Monferrato fecero lavorare il maggior numero<br />
delle loro monete, per esserci impossibile <strong>di</strong> trovare la linea<br />
matematica che <strong>di</strong>stingue i prodotti monetali dell' una da<br />
quelli dell' altra. Alla prima, nella quale forse anche Man-<br />
fre<strong>di</strong> IV, marchese <strong>di</strong> Saluzzo, pretendente al marchesato <strong>di</strong><br />
Monferrato, fece battere un suo denaro imperiale, spettano<br />
verosimilmente quattro monete <strong>di</strong> questa raccolta : un grosso<br />
ed un mezzo grosso <strong>di</strong> Giovanni I e due quarti <strong>di</strong> grosso<br />
<strong>di</strong> Teodoro IL E giacché l'esimio illustratore <strong>di</strong> questa serie
2o8 CARLO KUNZ<br />
lasciò indeterminato l'oggetto simulante una S coricata che<br />
osservasi sovra uno <strong>di</strong> tali pezzi, siami lecito notare essere<br />
quello un nastro o cartello colle estremità attortigliate in senso<br />
opposto, che per tale si manifesta sul nostro perfetto esemplare.<br />
Fra le monete della stirpe paleologa che con più cer-<br />
tezza si possono assegnare alla zecca <strong>di</strong> Casale, vogliono<br />
essere ricordati un bel esemplare del cornabò <strong>di</strong> Bonifacio II,<br />
ed un cavallotto <strong>di</strong> Gian Giorgio, alle quali può aggiungersi<br />
il rolabasso col cervo accosciato, improntato del nome del-<br />
l'imperatore Carlo V, tutti pezzi <strong>di</strong> qualche pregio.<br />
Delle monete uscite dalla stessa zecca, mentre il Mar-<br />
chesato ubbi<strong>di</strong>va ai Gonzaghi signori <strong>di</strong> Mantova, sarà detto<br />
più avanti.<br />
Ivrea.<br />
Codesta sede dei celebri marchesi che <strong>di</strong>edero all'Italia<br />
tre re, non vanta finora che due sole monete inscritte del<br />
suo nome e <strong>di</strong> quello d'un imperatore Federico, verosimilmente<br />
il secondo, in omaggio, sembra, <strong>di</strong> privilegio conces-<br />
sole, ma battute nei primi anni del secolo XIV, in uno dei<br />
brevi intervalli <strong>di</strong> sua in<strong>di</strong>pendenza. In tanta penuria il gabi-<br />
netto Bottacin è pago <strong>di</strong> possedere il grosso tirolino e fa<br />
assegnamento sul tempo, ch'è galantuomo pel più raro pic-<br />
colo imperiale.<br />
CORTEMIGLIA.<br />
Di questo già feudo dei marchesi del Carretto, i quali<br />
piuttosto per arbitrio che per concessione vi batterono mo-<br />
neta nel principio del secolo XIV, cessando ben presto in<br />
forza <strong>di</strong> <strong>di</strong>vieti dell'imperatore Enrico VII, evvi pure un grosso<br />
tirolino, quello <strong>di</strong> Manfredo II, prezioso non meno <strong>di</strong> tutte<br />
le altre monete improntate del nome <strong>di</strong> quei marchesi.<br />
Aosta.<br />
Che i Salassi che ne popolavano la vallata vi abbiano<br />
avuta propria moneta è opinione che s'accostò alla certezza
IL MUSEO BOTTACIN 209<br />
dacché gli illustri investigatori T. Mommsen ed A. <strong>di</strong> Long-<br />
périer ne esposero i so<strong>di</strong> argomenti, <strong>com</strong>e non è forse in-<br />
fondato il sentimento <strong>di</strong> coloro che a questa città attribui-<br />
scono alcuni tremissi <strong>di</strong> stile merovingio. Checché ne sia <strong>di</strong><br />
ciò, basti pel caso nostro constatare che il conte Amedeo Vili<br />
vi fece aprire una zecca, e che altri principi della stessa<br />
stirpe vi fecero lavorare monete, inscrivendo talvolta in esse<br />
il nome latino <strong>di</strong> Augusta Praetoria. Non sono molte quelle<br />
<strong>di</strong> tal fatta e però non deve sorprendere se due sole ne<br />
serba questo museo, cioè due quarti <strong>di</strong> soldo col nome <strong>di</strong><br />
Emmanuele Filiberto.<br />
Carmagnola e Saluzzo.<br />
Sebbene per un denaro fatto palese dal più volte en<strong>com</strong>iato<br />
<strong>com</strong>mendatore Promis, apparisca che un figlio <strong>di</strong> Tommaso<br />
I, marchese <strong>di</strong> Saluzzo, esercitasse la prerogativa della<br />
zecca in Dogliani in sul principio del secolo XIV, ed in quel<br />
torno il marchese Manfredo IV, <strong>com</strong>e fu già avvertito, fa-<br />
cesse altrettanto in Chivasso od altrove, ed altri dello stesso<br />
casato abbiano probabilmente nello stesso secolo fatto bat-<br />
tere moneta (denari imperiali), pure, <strong>di</strong> una loro zecca sta-<br />
bile e duratura non bassi in<strong>di</strong>zio che verso la fine del se-<br />
colo XV, allorché ne apersero una in Carmagnola, seguita<br />
da altra in Saluzzo, e dal marchese Lodovico II (1475- [504),<br />
non già da Lodovico I, <strong>com</strong>e vorrebbero i Muletti, deve ri-<br />
conoscersi il principio <strong>di</strong> queste zecche, i cui prodotti, nella<br />
massima parte dei casi è per noi sì <strong>di</strong>fficile, per non <strong>di</strong>re<br />
impossibile, <strong>di</strong> sceverare, che, almeno fintanto che quel lu-<br />
minare della <strong>numismatica</strong> <strong>italiana</strong> non ci abbia data la loro<br />
storia, non possiamo fare a meno <strong>di</strong> riunirle in un solo ma-<br />
nipolo.<br />
Le poche monete finora poste assieme <strong>di</strong> questa serie<br />
spettano ai marchesi Lodovico II', Michele Antonio, e Francesco,<br />
né sono rare, ad eccezione <strong>di</strong> un quattrino del primo<br />
che offre inscritta la parola noc, motto a grido <strong>di</strong> guerra,<br />
hellicus clamor^ usato da quella valorosa prosapia, che al<br />
Sanquintino parve enigmatico, ma non é punto, mentre, <strong>com</strong>e<br />
già avvertiva il Denina, è quella una voce tedesca che suona,<br />
37
2IO<br />
CARLO KUNZ<br />
ancora. Che se la lezione sulla moneta in <strong>di</strong>scorso è sba-<br />
gliata, in più luoghi del castello <strong>di</strong> Saluzzo quella parola<br />
leggesi invece correttamente, noch (2).<br />
Dezana.<br />
È sorprendente la ricchezza <strong>di</strong> questa zecca quale si<br />
manifestò per le opere degli illustri Friedlaender, Cazzerà,<br />
Promis e Morel-Fatio, e pronostico <strong>di</strong> quanto talune altre<br />
serie numismatiche <strong>di</strong> città italiane <strong>di</strong>venteranno per opera<br />
<strong>di</strong> quei valenti che con amore si accingeranno a tesserne<br />
la storia.<br />
Il gabinetto del quale vado brevemente informando conserva<br />
fra le monete <strong>di</strong> questa categoria le seguenti degne<br />
<strong>di</strong> ricordanza: Due cavallotti ó\ Lodovico I Tizzone; il testone<br />
dell' usurpatore Pietro Berard ; il testone dall' aquila e dal<br />
santo <strong>di</strong> Gianbartolomeo Tizzone, ed un esemplare <strong>di</strong> buona<br />
lega della murajuola col Santo Germano del conte Agostino.<br />
Offre inoltre qualche interesse un quattrino del conte Del-<br />
fino colla H coronata e la croce gigliata, il quale sul primo<br />
lato, dopo il nome reca le iniziali A. F, ed al rovescio, dopo<br />
i titoli e l'anno 1585, le lettere R. G. Poiché queste <strong>di</strong>no-<br />
tano Rolando Gastaldo, quelle, non per anco osservate, al-<br />
ludono verosimilmente ad un <strong>com</strong>pagno <strong>di</strong> quel zecchiere.<br />
Montanaro.<br />
Rammembrando il numero esiguo e la singolare rarità<br />
delle monete finora emerse, dagli abati <strong>di</strong> san Benigno <strong>di</strong><br />
Fruttuaria fatte battere nelle loro terre <strong>di</strong> Montanaro e <strong>di</strong><br />
Lombardore, non è piccolo vanto per questo museo posse-<br />
(2) Non è insolito trovare nelle monete italiane motti tedeschi tolti<br />
dalle imprese <strong>di</strong> quelli che le fecero battere, ed il più <strong>di</strong> sovente in<br />
forma scorretta. Cosi, ad esempio, in moneta <strong>di</strong> Milano <strong>di</strong> Lodovico Sforza,<br />
reggente lo stato in nome del nipote, leggesi: ich vergies nix, io non<br />
<strong>di</strong>mentico; sovra un grosso della stessa città <strong>di</strong> Francesco 11 Sforza:<br />
MIT ZAiT, col tempo; su molti pezzi <strong>di</strong> Alberico I Cybo, marchese <strong>di</strong><br />
Massa: von gueten in pesser, <strong>di</strong> bene in meglio; in un soldo <strong>di</strong> Fran-<br />
cesco II marchese <strong>di</strong> Mantova: bider craft, possanza leale.
IL MUSEO BOTTACIN 211<br />
derne tre. La prima, che per <strong>di</strong> più è anche ine<strong>di</strong>ta, è<br />
un cavallotto anonimo, il quale, per l'analogia che presenta<br />
con altri simili pubblicati da Tenivelli, Mader e Litta, credo<br />
spettare al Car<strong>di</strong>nale Bonifacio Ferrerò che primo fra quelli<br />
abati esercitò il <strong>di</strong>ritto della moneta, per concessione <strong>di</strong><br />
papa Clemente VII (Tav. IV, n, 3). Le altre due, che por-<br />
tano il nome dell'abate Fer<strong>di</strong>nando Ferrerò, sono quelle che<br />
vedonsi raffigurate nelle tavole del Litta, grosso forse la<br />
prima, quattrino la seconda.<br />
Crevacuore e Messerano.<br />
Da più autori fu riportato un privilegio dell'anno 1249,<br />
col quale Guglielmo Imperatore concedeva ai Fieschi, con<br />
altri <strong>di</strong>ritti, quello pure della zecca, ed il Litta affermò, an-<br />
cora prima <strong>di</strong> quell'anno avere essi battuto moneta in qua-<br />
lità <strong>di</strong> Conti <strong>di</strong> Lavagna. Gli angusti limiti del presente<br />
lavoro non concedono <strong>di</strong>gressioni suU' atten<strong>di</strong>bilità <strong>di</strong> tali<br />
notizie, ne io sarei da tanto <strong>di</strong> farle concludenti, ma poiché<br />
in breve sarà fatta pienissima luce anche in questo campo<br />
per opera <strong>di</strong> chi già tanta ne versò sulla patria <strong>numismatica</strong>,<br />
basterà per intanto ch'io mi attenga al fatto delle mo-<br />
nete <strong>di</strong>vulgate dei signori <strong>di</strong> Messerano, le quali non risal-<br />
gono più in là del principio del secolo XVI, e spettano in<br />
parte a due personaggi della famiglia Fieschi, ed in maggior<br />
copia a sei del casato Ferrerò <strong>di</strong> Biella che da quelli ere-<br />
<strong>di</strong>tarono feu<strong>di</strong> e privilegi.<br />
Furono le loro monete battute in Crevacuore ed in Mes-<br />
serano, e sebbene non manchi a questo gabinetto l'anonimo<br />
grosso tirolino colla leggenda: moneta nova crepachorii,<br />
evidente fattura del secolo XIV, emmi quel pezzo ancora<br />
troppo oscuro perchè io possa azzardarne qualche attribu-<br />
zione. Le altre monete più sicure e più osservabili dell'una<br />
e dell'altra zecca sono le seguenti: Di Lodovico II con Pier<br />
Luca Fieschi evvi il testone coll'aquila ed il San Teonesto<br />
a cavallo; <strong>di</strong> Lodovico II solo, due testoni colla <strong>di</strong> lui effige<br />
ed il santo assiso; <strong>di</strong> Pier Luca II, il testone dall'aquila col<br />
santo ritto, e sono tutte belle monete.<br />
I Ferreri contano otto pezzi, e sono rimarchevoli la imita-
212 CARLO KUNZ<br />
zione del bianco <strong>di</strong> Bologna del marchese Besso; due talleri<br />
del principe Filiberto Ferrerò; il quattrino anonimo sul quale<br />
un poco avveduto nummografo, invece del nome <strong>di</strong> Creva-<br />
cuore volle scoprire quello <strong>di</strong> Carmagnola; feudo dei Sa-<br />
luzzesi, ed un quattrino foggiato ad imitazione <strong>di</strong> alcuni <strong>di</strong><br />
Milano <strong>di</strong> Filippo IV, il quale, per essere sciupato, mi lascia<br />
dubbioso, ma che forse appartiene al principe Francesco Lo-<br />
dovico Ferrerò.<br />
Passerano.<br />
In breve volgere <strong>di</strong> tempo il novero delle monete uscite<br />
da questo s<strong>com</strong>parso castello dei Conti Ra<strong>di</strong>cati, tratte dal-<br />
l'obblio quase tutte per opera <strong>di</strong> due <strong>di</strong>hgentissimi ricerca-<br />
tori, s'accrebbe <strong>di</strong> tanto da detestare invi<strong>di</strong>a a molte città<br />
d'alta storica rinomanza. Sono per la massima parte prodotti<br />
clandestini e contraffazioni d'altre zecche, emessi con iscopo<br />
d'illecito guadagno nel corto intervallo <strong>di</strong> pochi anni, dal<br />
1581 al 1598. Sette, tutte prive <strong>di</strong> nomi personali, ne con-<br />
serva il Museo Bottacin, fra cui una che seppe occultarsi<br />
alle ricerche <strong>di</strong> quei valenti, una parpagliuola cioè <strong>di</strong> schietto<br />
rame, fatta con più intiera somiglianza <strong>di</strong> quelle <strong>di</strong> Milano<br />
dalla Provvidenza, perchè ne ripete esattamente le leggende<br />
e soltanto i due quarti dell'arme ostendenti ivi il biscione<br />
visconteo, sono in questa occupati dal castagno sbarbicato<br />
dei Ra<strong>di</strong>cati. (Tav. IV, n. 4).<br />
Frinco.<br />
Altra effimera zecca ch'ebbe vicende simili alla precedente<br />
e l'onore degli stessi illustratori. Cinque sono le mo-<br />
nete che trovammo <strong>di</strong> questa officina, ma nessuna ci offerse<br />
qualche particolarità degna <strong>di</strong> rimarco.<br />
Pria <strong>di</strong> abbandonare il Piemonte conviene ch'io accenni<br />
a due monete che vi hanno relazione. La prima è il denaro<br />
dal tempietto, <strong>di</strong> Lodovico I, signore <strong>di</strong> Vaud, terzogenito
IL MUSEO BOTTACIN 21<br />
<strong>di</strong> Tommaso II, conte <strong>di</strong> Savoia, battuto nella zecca <strong>di</strong><br />
Thierrens presso Modone. La seconda è un denaro che al<br />
nome <strong>di</strong> Aimone, tracciato negli angoli d'una croce, ed al<br />
titolo <strong>di</strong> duca del Ciablese, unisce sul secondo suo lato il<br />
tempietto, simbolo della religione cristiana, attorniato dalla<br />
corrispondente inscrizione: xpi(sti)ANA religio. Tale pezzo<br />
che al certo fu battuto al <strong>di</strong> là delle Alpi, volle il marchese<br />
<strong>di</strong> Pina emesso da Aimone conte <strong>di</strong> Savoia (1329-1343) in<br />
san Maurizio d'Agauno nell'alto Ciablese, ma potrebbe <strong>di</strong><br />
ciò dubitarsi, non vedendolo figurare fra le monete <strong>di</strong> questo<br />
conte proposte dal <strong>com</strong>mendatore Promis. E tale dubbio si<br />
rafforza alla vista <strong>di</strong> quel tempietto <strong>di</strong> pretta forma carolingia,<br />
che consiglia a tenerlo più antico. Gli è perciò che oserei<br />
attribuirlo ad Aimone signore del Ciablese, terzogenito del<br />
conte <strong>di</strong> Savoia Tommaso I, morto intorno al 1238, se a<br />
ciò non si opponesse il titolo <strong>di</strong> duca che ac<strong>com</strong>pagna il<br />
nome, titolo il quale, secondo Guichenon, soltanto in quel-<br />
l'anno sarebbe stato accordato al conte Amedeo IV, dall'im-<br />
peratore Federico IL<br />
Genova.<br />
Sebbene si abbiano alcune pregevoli <strong>di</strong>ssertazioni sulla<br />
moneta genovese, manca tuttora una storia <strong>com</strong>pleta <strong>di</strong> essa,<br />
e la mancanza, sta, <strong>com</strong>e per qualche altra primaria zecca<br />
d'Italia, in ragione <strong>di</strong>retta della sua importanza e della ric-<br />
chezza dei suoi prodotti, al che si aggiunge in questo caso<br />
la <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> concordare la serie metallica colla cronologica<br />
per ciò che riguarda le monete piii antiche dei dogi perpetui.<br />
Ma evvi fondamento a sperare che presto possa essere riem-<br />
piuta tale lacuna, sapendosi <strong>com</strong>e da alcuni egregi eru<strong>di</strong>ti <strong>di</strong><br />
quella città si stanno <strong>di</strong>ligentemente raccogliendo i materiali<br />
per tale effetto.<br />
Questa città è sufficientemente rappresentata nel museo<br />
padovano, contando oltre ottanta monete fra le quali ferma-<br />
rono la mia attenzione le seguenti. Della prima epoca, del-<br />
l'anno 1139 fino al 1339, il quarto <strong>di</strong> genovino d'oro ed il<br />
genovino coll'acclam azione Janua quam Deus protegat. Del<br />
tempo dei dogi perpetui e dei dominatori stranieri, un grosso<br />
3
214<br />
CARLO KUNZ<br />
ed un mezzo grosso <strong>di</strong> Filippo Maria Visconti ; un grosso ed un<br />
più raro mezzo grosso <strong>di</strong> Pietro Fregoso il giovane; \\ genovino<br />
d'oro ed un grosso <strong>di</strong> Galeazzo Maria Sforza; un magnifico<br />
pezzo, forse testone maggiore da venti sol<strong>di</strong> <strong>di</strong> Gian Galeazzo<br />
Maria Sforza; un grosso <strong>di</strong> Battista Fregoso; un bel testone <strong>di</strong><br />
Lodovico XII, ed un mezzo testone <strong>di</strong> Francesco I (Tav.IV, n,6).<br />
Ho scavalcato un pezzo che sembrami rimarchevole, per<br />
poter <strong>di</strong>rne con agio qualche cosa. È desso un mezzo grosso<br />
anonimo e privo <strong>di</strong> numero d'or<strong>di</strong>ne, colla leggenda: ianva.<br />
Q. DEVS. PROTEGAT, la qualc, secondo il Gandolfi, non sa-<br />
rebbe stata usata sulle monete che fra gli anni 1252-1339,<br />
e secondo l'illustre conservatore del gabinetto Reale <strong>di</strong> To-<br />
rino, avrebbe avuto tempo ancor più limitato {Monete <strong>di</strong> Sa-<br />
vona, pag. 23). Ben alieno dall'oppormi a tanto sapere, ed<br />
ammettendo anzi incontrastabile quel criterio in tesi gene-<br />
rale, questa moneta, segnerebbe una eccezione, perchè allo<br />
stile si palesa <strong>di</strong> molto posteriore, onde inclino a crederla<br />
battuta in occasione <strong>di</strong> qualche vacanza o mutamento <strong>di</strong> go-<br />
verno, per cui nell'entusiasmo del momento, si ritornò a quel-<br />
l'antica invocazione. Dirò <strong>di</strong> più : quella moneta offre sì grande<br />
analogia coi mezzi grossi col duca Filippo Maria Visconti,<br />
che non sembrami troppo azzardato tenerla fabbricata nel-<br />
l'anno 1436, nel quale i Genovesi, insorgendo, si liberarono<br />
dall'aspro governo <strong>di</strong> quel principe. (Tav. IV, n. 5).<br />
Abbondano le monete della terza epoca, in tutti i me-<br />
talli, ma dacché esse porgono in generale poco interesse,<br />
mi restringerò a ricordare due rari pezzi, che stimo quarti<br />
<strong>di</strong> ducatoni, i quali arieggiano le forme delle monete vene-<br />
ziane nelle loro rappresentazioni del Redentore che bene<strong>di</strong>ce<br />
al doge genuflesso. Il primo è dell'anno 1554, ed il secondo,<br />
notevolmente <strong>di</strong>fferente pel <strong>di</strong>segno, del 1563. (Tav. IV, n. 7).<br />
Savona.<br />
Una sola moneta, un ottenne da tre denari <strong>di</strong> Lodovico XI,<br />
rappresentava questa città allorché ispezionai i medaglieri del<br />
museo Bottacin, ma, intanto che ripassavo gli appunti fatti,<br />
l'indefesso donatore vi aggiunse il prezioso fiorino d'oro, in-<br />
cunabulo <strong>di</strong> questa zecca, battuto intorno all'anno 1350.
IL MUSEO BOTTACIN 2I5<br />
Tassarolo.<br />
Feudo principale della potente famiglia Spinola, eretto<br />
in contea nell'anno 1560 in favore <strong>di</strong> Marcantonio dall'impe-<br />
ratore Fer<strong>di</strong>nando I, le monete poco numerose battutevi dal<br />
<strong>di</strong> lui figlio Agostino e dal nipote Filippo hanno tutte pregio<br />
<strong>di</strong> rarità e godo perciò poter segnalare l'esistenza <strong>di</strong> quattro<br />
fra esse.<br />
Del Conte Agostino, oltre al quarto <strong>di</strong> scudo col mille-<br />
simo 1607, e l'ottavo simile, ma privo della data, evvi un<br />
pezzo non osservato dal <strong>di</strong>ligente Olivieri, il cui <strong>di</strong>segno tor-<br />
nerà gra<strong>di</strong>to ai cultori della patria <strong>numismatica</strong>. È desso<br />
una parpagliuola fatta con esatta imitazione <strong>di</strong> alcune uscite<br />
dalla officina <strong>di</strong> Casale nel tempo in cui vi ebbero dominio<br />
i duchi <strong>di</strong> Mantova. (Tav. IV, n, 8),<br />
Del conte Filippo osservasi il ducatone col problematico<br />
Santo a cavallo che vuole essere rac<strong>com</strong>andato agli eru<strong>di</strong>ti<br />
agiologisti.<br />
Ronco.<br />
Di codesto feudo d'altro ramo degli Spinola conviene<br />
ricordare un ottavetto del marchese Napoleone, che offre la<br />
data 1669. Al pari d'altri da me veduti è d'aspetto sì nuovo<br />
e sì lampante da indurre sospetto che ne esistano tuttora i<br />
coni e da essi, in tempo a noi vicino, ne siano stati battuti<br />
alcuni esemplari a <strong>com</strong>piacimento dei raccoglitori smaniosi<br />
<strong>di</strong> cose peregrine.<br />
LoANO.<br />
Dopoché l'imperatore Carlo V donava, nell'anno i547><br />
gran parte dei feu<strong>di</strong> <strong>di</strong> ragione dei Fieschi all'illustre Andrea<br />
Doria, non trascorse gran tempo che i costui successori vol-<br />
lero far uso del privilegio della moneta che ad essi da quei<br />
possessi derivava, e pria che altrove in Loano, le cui poche<br />
monete fino ad ora scoperte sono tutte <strong>di</strong> molta rarità, ond'è<br />
che anche il possesso d'una sola accresce merito a qualunque
2l6<br />
CARLO KUNZ<br />
raccolta. Quella che serba codesto gabinetto è un luigino<br />
della principessa Violante Lomellini Doria, già e<strong>di</strong>to per il<br />
Mantellier, il quale, sebbene non offra il nome <strong>di</strong> quella feuda-<br />
taria, pure pei documenti riferiti dall'Olivieri chiaramente ap-<br />
parisce essere stato lavorato per <strong>di</strong> lei or<strong>di</strong>ne.<br />
TORRIGLIA.<br />
Anche in questo minore lor feudo vollero i Doria con-<br />
cedere a privati impren<strong>di</strong>tori facoltà <strong>di</strong> lavorarvi monete della<br />
specie degli ottavetti o luigini d'imitazione, pel <strong>com</strong>mercio del<br />
levante, ed è della stessa principessa Violante quello che si<br />
osserva nel nostro gabinetto, ed al pari del precedente è<br />
privo del suo nome, ma i documenti ed i punzoni scoperti<br />
dall'Olivieri <strong>di</strong>mostrano con evidenza ancor maggiore che ad<br />
essa si deve assegnare. L'esemplare ch'ebbe sott'occhio il<br />
Mantellier portava impresso l'anno 1666; altro descritto dal<br />
Reichel era contrassegnato dall'anno 1667, e se questo mostra<br />
invece la data 1668, ciò serve a <strong>com</strong>provare l'attività <strong>di</strong> una<br />
officina della quale sono ora sì fenomenali i prodotti.<br />
Cade opportuno accennare qui ad altri due luigini <strong>di</strong><br />
tipo trevolziano, i quali, avvegnacchè tuttora indeterminati,<br />
potrebbero per avventura essere usciti da taluna delle tante<br />
officine abusive della Liguria nelle quali si lavorò tale specie<br />
<strong>di</strong> moneta, e che per tale titolo sono da rac<strong>com</strong>andare allo<br />
stu<strong>di</strong>o dei nummofili italiani.<br />
Il primo, che fra gli incerti fu riportato anche in <strong>di</strong>segno<br />
dal Mantellier, ma coll'anno 1668, mentre il nostro reca la<br />
data 1669, offre sui due lati la scritta : partes volvptati —<br />
ORiENTALivM DiCAT^i:. Lo scudo, invece dei tre gigli aral<strong>di</strong>ci,<br />
è occupato da tre fiori o ramoscelli a cinque foglie che il Mantellier<br />
<strong>di</strong>sse impropriamente gigli naturali. Quegli emblemi<br />
non rassomigliano nemmeno tanto ad alabarde da potersi<br />
ammettere senz'altro essere questo una varietà degli otta-<br />
vetti suggeriti alla principessa Violante dal P. Noceti, sui<br />
quali i gigli furono cambiati in alabarde, perchè, oltreché
IL MUSEO BOTTACIN 21<br />
<strong>di</strong>fferenti, <strong>com</strong>e afferma l' Olivieri, ne erano le leggende,<br />
indecoroso ed inverosimile deve tenersi il consiglio del<br />
motto Partes voluptati^ <strong>di</strong>retto da un simile consigliere ad<br />
una principessa scrupolosa la quale appellavasi ai teologi e<br />
sopra altre consimili sue monete <strong>di</strong>chiarava la propria effìgie<br />
pillerà virtiitis imago.<br />
Il secondo <strong>di</strong> questi luigini, descritto da Mantellier e da<br />
altri autori francesi, colla data 1667, ovvero 1668, porta la<br />
seguente leggenda, <strong>di</strong>visa sui due lati, ma principalmente da<br />
quello dell'arme: partes curiositate — et delectatione<br />
DiGNE (sic). Lo scudo è caricato dei tre gigli col lambello e<br />
sott' esso notasi la lettera A, nella quale si potrebbe forse<br />
credere adombrata la zecca spinolina <strong>di</strong> Arquata, se dessa<br />
non fosse troppo frequente sulle monete <strong>di</strong> tal specie, quale<br />
nota o finzione della zecca <strong>di</strong> Parigi, Anche per questo<br />
ottavetto presiedette adunque una idea satirica suggerita<br />
dalle abitu<strong>di</strong>ni galanti <strong>di</strong> madamigella <strong>di</strong> Montpensier, e<br />
perciò cre<strong>di</strong>amo dovere escludere l'ipotesi che sia stato bat-<br />
tuto per autorità <strong>di</strong> qualche principessa.<br />
Monaco.<br />
Evvi fondata lusinga che non tarderà molto ad essere<br />
fatta <strong>di</strong> pubblica ragione la storia <strong>numismatica</strong> <strong>di</strong> questo<br />
Principato, che un egregio cavaliere sta dettando, altro in-<br />
<strong>di</strong>zio che ne fa pronosticar bene per l'avvenire <strong>di</strong> questo<br />
stu<strong>di</strong>o in Italia.<br />
Fra le poche monete <strong>di</strong> questa serie che serba la num-<br />
moteca padovana, meritano ricordanza uno scudo ed un luigino<br />
del principe Onorato II, ed un luigino <strong>di</strong> gentile lavoro<br />
col nome e le sembianze <strong>di</strong> Lodovico I.<br />
Cagliari.<br />
Mercè il Bullettino archeologico ed il Catalogo dell'illustre<br />
<strong>com</strong>mendatore Spano, le nostre cognizioni sulle più antiche<br />
monete dell'isola <strong>di</strong> Sardegna sonosi <strong>di</strong> molto accresciute,<br />
ma non basta ; abbiamo <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> attendere ben più dal suo<br />
colto ingegno e dalla sua operosità, ed una storia <strong>com</strong>pleta<br />
a8<br />
7
2l8<br />
CARLO KUNZ<br />
delle zecche <strong>di</strong> quella regione porrebbe il colmo alla sua<br />
benemerenza ed alla nostra gratitu<strong>di</strong>ne.<br />
Le monete <strong>di</strong> quest' or<strong>di</strong>ne finora collocate nel meda-<br />
gliere Bottacin, ad eccezione <strong>di</strong> poche dell'ispano re Carlo II,<br />
spettano ai regnanti <strong>di</strong> Savoia e furono battute per la massima<br />
parte in Torino, pei bisogni dell'isola. Primeggia una<br />
doppietta <strong>di</strong> Carlo Emmanuele III; un reale <strong>di</strong> Carlo Emmanuele<br />
IV, ed un pezzo da tre cagliaresi <strong>di</strong> Vittorio Emmanuele<br />
I, notevoli questi due per certo originale arcaismo<br />
particolare alla zecca <strong>di</strong> Cagliari, riattivata dopo quasi secolare<br />
riposo per or<strong>di</strong>ne del re Vittorio Amedeo III, <strong>com</strong>e<br />
insegna il più volte lodato <strong>com</strong>mendatore Promis.<br />
Murato e Corte.<br />
Sebbene l'isola <strong>di</strong> Corsica segua ora altro destino po-<br />
litico da quello dell'Italia, il tenore della sua storia passata,<br />
dei suoi costumi, della sua lingua, non permettono <strong>di</strong> stac-<br />
care gli scarsi suoi monumenti monetali da quelli delle altre<br />
zecche della penisola.<br />
Fanno tuttora deficienza le povere monete lavorate in<br />
Sartena dall'effimero re Teodoro, ma non mancano parecchie<br />
<strong>di</strong> quelle che il condottiero Paoli fece battere in Murato ed<br />
in Corte, ed è <strong>di</strong> qualche rarità un pezzo d'argento da venti<br />
sol<strong>di</strong>, che all'anno 1766 che porta impresso, mostra essere<br />
uscito dal secondo <strong>di</strong> quei luoghi.<br />
LA LOMBARDIA<br />
Milano.<br />
La splen<strong>di</strong>da metropoli dell' Insubria, famosa per tanti<br />
gloriosissimi fatti antichi e moderni, che fu patria <strong>di</strong> elettissima<br />
falange d' uomini illlustri in ogni maniera <strong>di</strong> umane<br />
<strong>di</strong>scipline, che nelle proprie monete offre uno specchio quasi
IL MUSEO BOTTACIN 219<br />
continuo della sua storia <strong>di</strong> ben se<strong>di</strong>ci secoli, attende ancora,<br />
non <strong>di</strong>remo chi ne sappia, ma chi ne voglia illustrare degnamente<br />
i fasti monetali : imperocché <strong>di</strong> tanta dottrina ella<br />
è sempre ostello, che ove un impulso fosse dato, o per<br />
opera <strong>di</strong> un solo, o con mezzi riuniti, una si deplorevole<br />
lacuna non tarderebbe a s<strong>com</strong>parire. Perchè, ciò che fu fatto<br />
con ottimo successo nel Belgio ed altrove non potrebbe<br />
tentarsi per questa ed altre città d'Italia, instituendo concorsi<br />
che avessero per oggetto la storia delle loro monete?<br />
Non è forse argomento codesto meritevole dei riflessi delle<br />
illustri accademie che onorano quasi tutte le città italiane?<br />
E non sarebbe tale <strong>com</strong>pito opportunissimo a quest'ora in<br />
cui con nobilissima gara, alle sonnifere Arca<strong>di</strong>e d'un tempo<br />
che fu, vanno subentrando associazioni più positive e <strong>com</strong>-<br />
missioni ch'hanno per iscopo lo stu<strong>di</strong>o della storia patria?<br />
Per Milano poi in ispecialità sono tutti i materiali già pub-<br />
blicati e tanti ve ne saranno al certo d'ine<strong>di</strong>ti che <strong>di</strong> molto<br />
ne sarebbe facilitato il lavoro per quei generosi che voles-<br />
sero intraprenderlo.<br />
Le monete dei bassi tempi e moderne della zecca <strong>di</strong><br />
Milano raccolte nel museo ch'è obbietto <strong>di</strong> questa rassegna<br />
sono numerose, perchè oltrepassano le duecento, non <strong>com</strong>-<br />
prese quelle delle Repubbliche Cisalpina ed Italiana, del<br />
Regno Napoleonico e del Regno attuale.<br />
La più antica è il denaro a monogramma che primo il<br />
Le Blanc assegnò a Carlo Magno, ma che in tempo a noi<br />
vicino, con altri simili d'altre zecche, <strong>di</strong>ede argomento a vi-<br />
vacissime controversie sostenute da sì valenti campioni che<br />
arduo poteva sembrare il definitivo giu<strong>di</strong>zio se spettasse a<br />
Carlo Magno, a Carlo il Calvo od a Carlo il Grosso; sen-<br />
nonché le ragioni addotte in fine a favore del primo dal<br />
chiariss. sig. dottore Vincenzo Promis nei suoi stu<strong>di</strong> sulla<br />
origine della zecca veneta, sembrano sì convincenti da con-<br />
sigliare il bando d'ogni altra opinione. Viene secondo il de-<br />
naro <strong>di</strong> Lotario I; poi seguono un denaro largo <strong>di</strong> Lodo-<br />
vico II e tre denari più larghi semibratteati <strong>di</strong> Carlo il<br />
Grosso, <strong>di</strong> Guido <strong>di</strong> Spoleto e <strong>di</strong> Berengario I, i quali, quan-<br />
tunque privi del nome <strong>di</strong> questa città vi appartengono senza<br />
contrasto, perchè pari tecnica, peso, lega e* modulo osser-
220<br />
CARLO KUNZ<br />
vansi per uno il quale oltre i nomi dei re Arnolfo e Berengario<br />
offre quello della città inscritto entro il tempietto. Non<br />
mancano i denari <strong>di</strong> forma più ovvia col nome locale, dello<br />
stesso Berengario I, <strong>di</strong> Ottone I, <strong>di</strong> Corrado II, e parecchi<br />
denari e denari terzoli dei due primi Federici e <strong>di</strong> qualche<br />
Enrico. Tanto per le monete dei re d'Italia fino al tempo in<br />
cui Milano, considerandosi in<strong>di</strong>pendente, tralasciò d'inscri-<br />
vervi i loro nomi. Di questa epoca, repubblicana o Torriana<br />
che <strong>di</strong>re si voglia, non mancano i facili grossi <strong>di</strong> vario <strong>di</strong>-<br />
segno, seguiti da presso da alcuni grassoni e grossi e de-<br />
nari <strong>di</strong> Enrico VI, Enrico VII e Lodovico V il Bavaro.<br />
Eccoci alle monete che segnano il dominio della potente<br />
famiglia Visconti pella quale la potestà fu sorgente <strong>di</strong> tali<br />
sventure da bilanciare quasi il cumulo delle sue colpe. Le<br />
più meritevoli <strong>di</strong> rimarco sono un grosso <strong>di</strong> Luchino e Giovanni<br />
coll'arme <strong>di</strong> casato; il grosso <strong>di</strong> Giovanni, ultima mo-<br />
neta <strong>di</strong> questa zecca imitante le forme <strong>di</strong> alcune degli im-<br />
peratori d'Oriente dei secoli XI e XII; il pregevolissimo<br />
fiorino d'oro segnato dei nomi dei tristi fratelli Barnabò e<br />
Galeazzo II ; quello <strong>di</strong> pari impronto e rarità del solo Bar-<br />
nabò, ed altro non meno rimarchevole col duca a cavallo in<br />
arnese da torneo, la cui attribuzione a Galeazzo II richiama<br />
alla mente i dubbii concepiti dal Giulini che spetti forse a<br />
Gian Galeazzo. Di Filippo Maria non sono spregevoli il<br />
grosso che lo rappresenta a cavallo ed il soldo col santo in<br />
cattedra.<br />
La seconda Repubblica, ch'ebbe si corta durata e finì<br />
colla de<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> Milano a Francesco Sforza, ci porge il<br />
mezzo ambrosino d'oro, un soldo ed un denaro.<br />
Con Francesco Sforza, il valoroso e prudente capitano,<br />
ha principio una nuova serie <strong>di</strong> monete la quale mostra<br />
quale grado <strong>di</strong> eccellenza avesse toccato la piccola arte non<br />
meno delle arti monumentali nel tempo in cui Milano fu go-<br />
vernata da lui e dai suoi <strong>di</strong>scendenti, e <strong>com</strong>e anche in questo<br />
caso, secondo spesso si nota, un grande carattere storico<br />
sia scintilla che desta <strong>di</strong>ntorno a se ogni sorta <strong>di</strong> progressi<br />
e <strong>di</strong> perfezionamenti. Figurano vantaggiosamente in questa<br />
categoria due ducati d'oro dello stesso Francesco; un grosso<br />
<strong>di</strong> Bianca Maria, tutrice <strong>di</strong> Galeazzo Maria; tre grossi colla
IL MUSEO BOTTACIN 321<br />
eflìgie <strong>di</strong> questo malvagio principe, ed il pregevole testone<br />
della <strong>di</strong> lui vedova la debole ed avvenente Bona <strong>di</strong> Savoia.<br />
Se le monete del costoro figlio Gian Galeazzo Maria e del<br />
<strong>di</strong> lui zio Lodovico non possono qualificarsi rare, vanno però<br />
ricordate per la squisitezza dell'intaglio, in ispecialità il te-<br />
stone che riunisce i ritratti <strong>di</strong> entrambi, una fra le più felici<br />
opere del bulino. L'ultimo periodo del dominio degli Sfor-<br />
zeschi, alternato con quello <strong>di</strong> due re stranieri, porge i se-<br />
guenti pezzi <strong>di</strong> maggior momento: due <strong>di</strong>fferenti testoni ed<br />
un soldo coll'arme d'ambo i lati <strong>di</strong> Lodovico XII; un pegione<br />
e due quattrini <strong>di</strong> Massimiliano Sforza.<br />
La decadenza d'ogni buona cosa, che seguì dappresso<br />
le orme della dominazione spagnuola e s'impresse profondamente<br />
nelle belle arti, degradò anche quella del conio che<br />
<strong>di</strong>venne rozza e manierata dopo aver date alcune ultime<br />
prove <strong>di</strong> valentìa sotto Carlo V. Sono infatti opere egregie<br />
tre testoni <strong>di</strong> questo imperatore i quali attestano quanto esi-<br />
mio fosse l'artista che li eseguiva, sia desso il Caradosso<br />
od altri. Dei regni seguenti, abbondevolmente rappresentati<br />
in tutti i metalli, meritano osservazione un mezzo scudo da<br />
55<br />
sol<strong>di</strong> <strong>di</strong> Filippo II, non accorsoci ancora nelle opere con-<br />
sultate (Tav. V, n. i); un soldo colla effigie dello stesso,<br />
accollata ad una testa muliebre, verosimilmente quella della<br />
<strong>di</strong> lui quarta moglie Anna d'Austria (Tav. V, n. 2); un quat-<br />
trino <strong>di</strong> Filippo III, non raro, ma che non trovammo nei libri<br />
(Tav, V, n. 3); una lira <strong>di</strong> Filippo IV, descritta dall'Appel<br />
ma non raffigurata (Tav. V, n. 4); un ducato o filippo <strong>di</strong><br />
Filippo V d'Angiò ed un mezzo filippo <strong>di</strong> Carlo III (VI), che<br />
del pari ci riuscì nuovo (Tav. V, n. 5).<br />
La monetazione degli ultimi regnanti <strong>di</strong> casa d'Austria<br />
non porge cose degne <strong>di</strong> rimarco. Le monete delle due ul-<br />
time Repubbliche e quelle del Regno Napoleonico, lavorate<br />
in gran parte con ottimo magistero, appartengono <strong>com</strong>e fu<br />
già avvertito, ad altra serie in questo museo.<br />
Pavia.<br />
Cotesta antica e gloriosa città che fu sede dei re Goti<br />
dopo ch'ebbero perduta Ravenna, e residenza dei Longobar<strong>di</strong>
222<br />
CARLO KUNZ<br />
che vi innalzarono quel singolarissimo tempio de<strong>di</strong>cato al-<br />
l'Arcangelo Michele, sotto le cui vòlte tanti re d'Italia as-<br />
sunsero la corona, non tarderà molto, speriamo, a mostrare<br />
una storia della famosa sua zecca, per opera dell'illustre cavaliere<br />
il quale con due recenti pubblicazioni nummografiche<br />
seppe conquistare <strong>di</strong> botto seggio primario fra i cultori <strong>di</strong><br />
tale stu<strong>di</strong>o.<br />
Non sono molte le monete <strong>di</strong> questa serie collocate finora<br />
nel museo padovano e possono annoverarsi le seguenti:<br />
Un denaro <strong>di</strong> Lotario I; altro più raro e perfetto che intorno<br />
al monogramma <strong>di</strong> Ugo <strong>di</strong> Provenza reca inscritto il <strong>di</strong> lui<br />
nome seguito da quello <strong>di</strong> suo figlio Lotario II, ch'egli as-<br />
sunse collega del regno nell'anno 931 ; un terzo <strong>di</strong> Ottone I<br />
nel quale il nome della città è preceduto dal titolo onorifico<br />
<strong>di</strong> inclita, e finalmente uno <strong>di</strong> Enrico II il Santo.<br />
Nessuna rarità si riscontra negli altri pezzi degli impe-<br />
ratori tedeschi ed in quelli dei duchi <strong>di</strong> Milano.<br />
Cremona.<br />
Le monete finora a noi pervenute <strong>di</strong> questa città non<br />
contrad<strong>di</strong>cono al notissimo <strong>di</strong>ploma, riportato dal Muratori,<br />
col quale l'imperatore Federico I le concesse il privilegio<br />
della moneta nell'anno 1155. Ma può egli affermarsi recisamente<br />
che non possa rinnovarsi per essa qualche fatto ana-<br />
logo a quello che avvenne per Piacenza, un tremisse della<br />
quale, improntato del nome <strong>di</strong> re Desiderio, rivelò la origine<br />
ben più remota della sua zecca <strong>di</strong> quanto fino allora era<br />
creduto? Ma, sia pure infondata tale lusinga, Cremona offre<br />
vasto argomento <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o nelle sue monete, specialmente<br />
nel tempo in cui, reggendosi a libertà, segnava sovr'esse il<br />
nome dell' Enobarbo; graziosi nummoli i quali per entro ad<br />
una certa apparente monotonìa <strong>di</strong> tipo offrono numerose va-<br />
rietà pel peso, la lega e lo stile, ed attestano la grande<br />
operosità della sua ofTicina.<br />
Fra i pezzi <strong>di</strong> codesta zecca notammo nel Museo Bot-<br />
tacin il grosso piuttosto raro dalla iniziale e dal titolo che<br />
alludono al nominato imperatore; un denaro mezzano che<br />
per la forma rotonda o gotica <strong>di</strong> più sue lettere mostra es-
IL MUSEO BOTTACIN 223<br />
sere battuto nel secolo XIII innoltrato, ed è forse l'ultima<br />
moneta <strong>di</strong> questa città che ricorda il Barbarossa ; un denaro<br />
<strong>di</strong> Azone Visconti, ed un soldo coll'arme inquartata, <strong>di</strong> Fran-<br />
cesco I Sforza, che amo credere lavorato, non meno d'altre<br />
sue monete, in questa zecca anziché nella milanese, per certa<br />
maniera particolare d'intaglio e per la forma <strong>di</strong> alcune let-<br />
tere che non mi offre analogie nelle monete <strong>di</strong> Milano.<br />
Brescia.<br />
Non è grande il numero delle monete <strong>di</strong> questa generosa<br />
città che figurano nell'ottimo trattato del Doneda, <strong>com</strong>-<br />
pletato dalle note, dai documenti e dai <strong>di</strong>segni del <strong>di</strong>ligente<br />
ed arguto Zanetti, ed il poco che potè aggiungervi dopo ot-<br />
tanta anni il preclaro autore delle Storie Bresciane consta<br />
<strong>di</strong> varietà o sud<strong>di</strong>visioni delle monete pria recate, battute in<br />
omaggio del primo Federico od in nome del solo Comune,<br />
ed in un singolare pezzo <strong>di</strong> Pandolfo Malatesta, eh' è forse<br />
il bol<strong>di</strong>no non rinvenuto dal numismatico bolognese, sul quale,<br />
ostinato <strong>com</strong>e sono, persisto a vedere una testa d'Ercole,<br />
perchè tale n'è il carattere e così vedo rappresentato quel-<br />
l'eroe sovra alcune medaglie greche, non esclusa quella ap-<br />
parenza <strong>di</strong> veste intorno al collo.<br />
Tranneché del Malatesta, <strong>di</strong> nessun altro dei signori che<br />
vi ebbero dominio hannosi monete, e quanto a quelle che<br />
vi avrebbe fatte battere lo spagnuolo leardo, asse<strong>di</strong>ato entro<br />
la città dai Veneziani nell'anno 15 15, convien restarne molto<br />
dubbiosi.<br />
Ninna moneta bresciana essendo intieramente ovvia, pos-<br />
sono annoverarsi tutte le possedute, che sono: un denaro<br />
piccolo col nome dell'imperatore Federico; A grosso àsii due<br />
santi che lo Zanetti ascrisse alla vacanza dell'impero dopo<br />
la morte <strong>di</strong> Federico II; il mezzano del Comune colla testa<br />
<strong>di</strong> Santo Apollonio, ed un quattrino malatestiano.<br />
Como.<br />
Molti eru<strong>di</strong>ti scrittori trattarono della moneta <strong>di</strong> Como<br />
ed almeno do<strong>di</strong>ci constami ch'abbiano riportato anche <strong>di</strong>se-
224<br />
CARLO KUNZ<br />
gni <strong>di</strong> esse, ma tuttavia siamo ancora lontani dal possedere<br />
una <strong>com</strong>pleta illustrazione dei prodotti della sua zecca, per<br />
cui torna opportunissima la istanza dell'illustre cav. Camillo<br />
Brambilla, il quale, <strong>di</strong>chiarando con soda dottrina tre sue<br />
monete, scriveva: " Resta anche per questa serie il desiderio<br />
" che qualche eru<strong>di</strong>to <strong>com</strong>asco si faccia a riunire gli impronti<br />
" e ad illustrarli, aggiungendovi quanto alle ricerche <strong>di</strong> altri<br />
" fosse per avventura sfuggito. „<br />
Pel documento riferito dal Rovelli resta <strong>com</strong>provato Fe-<br />
derico I avere battuto moneta a Como; ottime ragioni, alle<br />
quali potrebbe aggiungere qualche altra, adduce il nominato<br />
cavaliere per assegnare allo stesso oltreché gli oboli caucei<br />
improntati dal nome imperiale anche tutti i grossi ad effigie ;<br />
ma forsechè non tutti si adatteranno senza contrasto a tale<br />
opinione, e sia pure, che l'attrito d'opposti e ragionati pareri<br />
giova grandemente a dare risalto alle verità scientifiche (3).<br />
(3) Anche resimio conservatore del gabinetto <strong>di</strong> Torino, <strong>di</strong>chiarando<br />
testé un grosso <strong>di</strong> questa città, battuto dal Comune a nome <strong>di</strong> Lodovico<br />
il Bavaro, sembra esprimere tale opinione.<br />
Gli autori che ragionarono sui grossi <strong>com</strong>aschi ad effigie non stimarono<br />
opportuno <strong>di</strong> notare alcune essenziali <strong>di</strong>fferenze che in essi si<br />
osservano. Sono que' grossi <strong>di</strong> due specie ben <strong>di</strong>stinte. Alcuni, e sono<br />
i più numerosi, hanno l'aquila rivolta verso la sinistra dell'osservatore<br />
e la leggenda che vi corre intorno suona brevemente: cvmanvs; in altri,<br />
più rari, l'aquila guarda a destra, ed è ac<strong>com</strong>pagnata dall'iscrizione:<br />
civiTAS cvMANA. Potrebbero notarsi alcune altre <strong>di</strong>fferenze in poco rilievo,<br />
ma lo stile fra l'una e l'altra specie, tranne qualche maggior<br />
finezza d'intaglio nei secon<strong>di</strong>, è uguale <strong>com</strong>e uguali ne sono il peso ed<br />
il titolo e mostrano perciò che furono battuti ad una stessa legge. Ora,<br />
ammessa l'opinione del chiarissimo cav. Brambilla, non potrebbe dedursi<br />
a <strong>com</strong>pletamento quasi <strong>di</strong> essa, che questi secon<strong>di</strong> grossi, sui quali la<br />
parola Civitas sarebbe equivalente a Comunitas, siano stati battuti dopo<br />
la lunga lotta fra l'imperatore ed i Comuni lombar<strong>di</strong>, che colla pace<br />
<strong>di</strong> Costanza (1183) finì per consolidare questi in repubbliche? Ben vorrebbe<br />
egli già nella sola parola Cumanus dei primi grossi sottintendere<br />
Populus, ma il sottinteso, se vi è, non dà ancora a <strong>di</strong>vedere quella sicurezza<br />
della propria libertà e <strong>di</strong>ritti annessi che esprime senza reticenza<br />
la parola Civitas. E sarebbe forse puerilità ammettere che<br />
anche l'aquila rivolta in altra <strong>di</strong>rezione serva all'espressione <strong>di</strong> tale<br />
concetto, quasi a <strong>di</strong>notare le mutate sorti della città? Che se Como,<br />
emancipata dalla imme<strong>di</strong>ata supremazia dell'impero volle pur mantenere<br />
l'impronta ed il nome imperiale, può averlo fatto, oltreché per<br />
l'omaggio che continuava a prestare agli imperatori, per ragioni economiche.<br />
Esempi analoghi non mancano, e l'assenza totale <strong>di</strong> monete<br />
repubblicane <strong>di</strong> questo tempo rende forse più probabile tale supposizione.
IL MUSEO BOTTACIN 225<br />
Le monete che rappresentano questa città nel nostro<br />
gabinetto sono: un obolo cauceo del Barbarossa; due <strong>di</strong> quei<br />
grossi ad effigie imperiale; il grosso <strong>di</strong> Franchino Rusca, il<br />
quale quantunque s'intitolasse Capitano e signore del Comune<br />
e del popolo <strong>di</strong> Como, improntando sovr'esso le sole iniziali<br />
del proprio nome e lasciando il posto d'onore pel nome in-<br />
tiero <strong>di</strong> Lodovico V che avealo creato suo vicario, palesava<br />
quanto fosse sempre da esso <strong>di</strong>pendente, ed un denaro <strong>di</strong><br />
Azone Visconti.<br />
Lo<strong>di</strong>.<br />
Le sole monete che con certezza possono attribuirsi a<br />
questa città sono un grosso ed un denaro piccolo, sul lato<br />
principale dei quali, intorno al nome abbreviato del suo santo<br />
protettore Bassiano, si legge: imperator. f. Questa lettera<br />
deve tenersi allusiva all'imperatore Federico II da cui, secondo<br />
Tristano Calco, ebbe Lo<strong>di</strong> il <strong>di</strong>ritto della moneta nel-<br />
l'anno 1239.<br />
Il grosso fu pubblicato dal Giovanelli, poi nuovamente<br />
dall'Al<strong>di</strong>ni, e questi, avvertita l'esistenza d'altra moneta <strong>di</strong><br />
consimile tipo, ma <strong>di</strong> bassa lega, reputavala il denaro del<br />
soldo lo<strong>di</strong>giano. Alludeva egli certamente all'accennato pic-<br />
colo, del quale porgo il <strong>di</strong>segno tratto dall'esemplare <strong>di</strong> questo<br />
Museo (Tav. V, n. 6), che serba anche il grosso, preziosi<br />
pezzi entrambi.<br />
Bergamo.<br />
Numerosa, sebbene monotona, è la serie delle monete<br />
uscite dalla zecca <strong>di</strong> Bergamo, perchè tutte offrono il nome<br />
e l'effigie dell'imperatore Federico II, e sul secondo lato<br />
un'e<strong>di</strong>fizio. Ma fra tanta conformità <strong>di</strong> tipo quanta varietà<br />
nel peso, nel metallo, nella paleografia delle leggende, nei<br />
segni <strong>di</strong> zecca e nelle forme architettoniche dell'e<strong>di</strong>fizio, che<br />
ora presenta l'aspetto <strong>di</strong> un tempio, or quello <strong>di</strong> un palazzo<br />
civico irto <strong>di</strong> merlature e più raramente <strong>di</strong> un castello <strong>di</strong><br />
severa costruzione o <strong>di</strong> una semplice torre o porta turrita!<br />
Tale multiformità ci fa dubitare della opinione <strong>di</strong> quelli che<br />
29
226 CARLO KUNZ<br />
vollero ravvisare sovra codeste monete la rappresentazione<br />
fedele <strong>di</strong> un determinato e<strong>di</strong>lìzio, e preferiamo invece tro-<br />
varvi nulla più che un simbolo generico della città, abban-<br />
donato al capriccio degli artisti intagliatori. Tanta varietà <strong>di</strong><br />
cose mostra inoltre quanto operosa fosse questa zecca, du-<br />
rante il secolo XIII, ed in parte del XIV, e persuade del-<br />
l'opportunità <strong>di</strong> una storia <strong>di</strong>ligente e documentata <strong>di</strong> essa,<br />
che tale invero non è una se<strong>di</strong>cente critica lucubrazione, nella<br />
quale le singolari cabalistiche scoperte della lega d'antimonio<br />
e della orientazione dei due lati delle monete vanno <strong>di</strong> pari<br />
passo colla povertà delle notizie e colla deficienza <strong>di</strong> senso<br />
pratico.<br />
Airinfuori delle nìonete impresse in omaggio <strong>di</strong> quell'im-<br />
peratore non apparisce che Bergamo ne abbia battute altre.<br />
Il quattrino del tempo in cui ella ubbi<strong>di</strong>va alla repubblica <strong>di</strong><br />
Venezia fu notoriamente lavorato nella zecca <strong>di</strong> questa città.<br />
Nessuna rarità rinvenni nei grossi e nei denari mezzani,<br />
sì scodellati che piani, del museo padovano.<br />
Monza.<br />
Estore Visconti, bastardo del duca Barnabò, che tenne<br />
Monza pel corso <strong>di</strong> cinque anni, tentò rendersi signore <strong>di</strong><br />
Milano alla morte del duca Giovanni Maria, ed associatosi<br />
per tale effetto Gian Carlo, <strong>di</strong>scendente legittimo <strong>di</strong> Barnabò,<br />
potè riuscirvi, ma per brevissimo tempo, perchè dopo un<br />
solo mese ne fu scacciato dal nuovo duca Filippo Maria, che<br />
asse<strong>di</strong>ollo poi nel castello <strong>di</strong> Monza, dove rimase ucciso per<br />
un colpo <strong>di</strong> spingarda. Erami necessario premettere brevemente<br />
questi notissimi fatti per venire alle seguenti domande.<br />
E egli verosimile che tutte le monete che sopravanzano,<br />
battute da Estore Visconti e da Gian Carlo, siano state la-<br />
vorate nella zecca <strong>di</strong> Milano durante quel brevissimo periodo<br />
<strong>di</strong> un mese, fra le angoscie <strong>di</strong> una contrastata occupazione,<br />
e nessuna sia stata battuta in Monza, dove per ben cinque<br />
anni Estore solo o congiuntamente al nipote potè esercitare<br />
tranquillo il potere coi <strong>di</strong>ritti da esso <strong>di</strong>pendenti? Non so capa-<br />
citarmi <strong>di</strong> ciò, per quanto da molti si neghi recisamente che<br />
Monza abbia avuto officina monetaria nel tempo <strong>di</strong> questi
IL MUSEO BOTTACIN 227<br />
signori, e fino a ragioni bene chiarite, che quelle addotte dal<br />
Frisi non convincono punto, continuerò ad intitolare tutte le<br />
loro monete da questa città, dove la mummificata salma <strong>di</strong><br />
Estore mostra ancora allo stupito viandante la frattura del<br />
proiettile che lo trasse a morte.<br />
Tre sono le monete <strong>di</strong> questi viscontei<strong>di</strong>; un grosso <strong>di</strong><br />
Estore che pel Santo Ambrogio raffiguratovi sembrò (e nulla<br />
più) al Litta coniato in Milano, ma che potrebbe invece <strong>di</strong>-<br />
notare semplice artifizio <strong>di</strong> pretendente intento a prepararsi<br />
la strada al dominio <strong>di</strong> quella città; un denaro dello stesso,<br />
che, sebbene sciupato, mostra essere <strong>di</strong>fferente da quelli<br />
delle tavole del Litta, perchè d'ambo i lati le sue iscrizioni<br />
finiscono colla parola ....modoetie, doppia affermazione adunque<br />
<strong>di</strong> questa zecca (Tav. V, n. 7); ed un denaro coi nomi<br />
<strong>di</strong> entrambi questi apocrifi sovrani, per adoperare l'espres-<br />
sione del Verri, simile al n. 73 <strong>di</strong> quelle tavole.<br />
Mesocco e Musso.<br />
Fu nell'anno 1496 che il maresciallo Gian Gia<strong>com</strong>o Tri-<br />
vulzio ottenne dall'imperatore Federico III la conferma del<br />
possesso <strong>di</strong> Mesocco e della valle Mesolcina, che ora fa parte<br />
del Cantone de' Grigioni con privilegio <strong>di</strong> battervi monete<br />
d'oro e d'argento, <strong>com</strong>e insegna Pietro Mazzucchelli nella<br />
storia <strong>di</strong> quel prode capitano, dettata dal Rosmini. Avendo<br />
egli nell'anno 1508 fatto acquisto del castello <strong>di</strong> Musso presso<br />
la sponda occidentale del Lario, ottenne quattro anni dopo<br />
estensione <strong>di</strong> quel privilegio anche per questo secondo pos-<br />
se<strong>di</strong>mento, da Luigi XII, ond'è che in entrambi quei luoghi<br />
devono essere state battute le numerose sue monete. E però<br />
<strong>di</strong>fficile e forse impossibile <strong>di</strong> fare la parte <strong>di</strong> ciascheduna<br />
<strong>di</strong> queste zecche, per cui non avanza altro partito che rac-<br />
coglierle al nome della prima e più importante.<br />
Delle cinque monete che osservammo <strong>di</strong> Gian Gia<strong>com</strong>o<br />
Trivulzio, per tacere <strong>di</strong> quelle del <strong>di</strong> lui nipote Gian Fran-<br />
cesco, che sarebbero battute parte a Mesocco e parte a Ro-<br />
veredo, e delle quali una sola, un bel cornabò figura in<br />
questo gabinetto, merita essere segnalata una, la quale <strong>di</strong>f-<br />
ferisce da quelle che produsse il Mazzucchelli. Vi corrispon-
228 CARLO KUNZ<br />
dono per gl'impronti i numeri 21 e 17 <strong>di</strong> questo autore, ma<br />
la prima, che più si accosta, sembra essere un testone, ed<br />
alla seconda, ch'egli trasse dal Bellini, può farsi <strong>com</strong>petere<br />
il nome <strong>di</strong> grassone, laddove questa nostra, che già al<br />
modulo mostra <strong>di</strong> rappresentare un minor valore, e pesa<br />
grammi 2,450, sarà un grosso semplice (Tav. V, n. 8).<br />
Furono indubitatamente lavorate nell'ora smantellato ca-<br />
stello <strong>di</strong> Musso le monete <strong>di</strong> Gian Gia<strong>com</strong>o Me<strong>di</strong>ci, che se<br />
ne rese padrone nell'anno 1523. Pochi anni appresso l'imperatore<br />
Carlo V investivalo dei titoli <strong>di</strong> marchese <strong>di</strong> Musso<br />
e conte <strong>di</strong> Lecco, con facoltà <strong>di</strong> battere moneta. Sono tutte<br />
pregevoli le <strong>di</strong> lui monete e <strong>di</strong> egregio lavoro il testone sul<br />
quale è figurata una nave in burrasca col Medeghino che<br />
ne ammaina la vela e ne regge il timone.<br />
Oltre al quattrino <strong>di</strong> questo marchese colla personifica-<br />
zione del fiume Adda, posso affermare il possesso ài^ grosso,<br />
probabilmente una delle monete della zecca <strong>di</strong> Brianxona<br />
poste al bando con grida del 1529 dal duca Carlo II <strong>di</strong> Sa-<br />
voia, che volle far conoscere l'Argelati, ma senza riuscirvi<br />
appieno, per cui un nuovo <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> esso non sarà sgra-<br />
<strong>di</strong>to (Tav. V, n. 9).<br />
Retegno.<br />
Nell'anno 1654 l'imperatore Fer<strong>di</strong>nando II eresse questa<br />
terra del Lo<strong>di</strong>giano in baronia imperiale a favore del car-<br />
<strong>di</strong>nale Gian Gia<strong>com</strong>o Teodoro Trivulzio, in <strong>com</strong>penso del<br />
perduto possesso <strong>di</strong> Mesocco, con facoltà <strong>di</strong> battervi moneta,<br />
e ciò è confermato da un <strong>di</strong> lui scudo recato dal Litta.<br />
Estinto nell'anno 1678 il ramo <strong>di</strong> questi Trivulzi col<br />
principe Antonio Teodoro, Retegno passò per ere<strong>di</strong>tà a<br />
Gaetano Gallio <strong>di</strong> Como, il quale, assunto il nome <strong>di</strong> Antonio<br />
Gaetano Trivulzio, vi fece battere alcune belle monete<br />
d'oro e d'argento che sono verosimilmente le ultime uscite<br />
da questa zecca, perchè quelle <strong>di</strong> Antonio Tolomeo, che<br />
nell'anno 1708 ottenne dall'imperatore Giuseppe I conferma<br />
degli anteriori privilegi, hanno una foggia <strong>di</strong> fabbrica stra-<br />
niera, <strong>com</strong>e tante altre monete <strong>di</strong> principi italiani, i quali,<br />
particolarmente nella prima metà del secolo XVIII, avendo
IL MUSEO BOTTACIN 229<br />
Ottenuto facoltà <strong>di</strong> battere moneta, fecero lavorare in qualche<br />
zecca non propria alcune specie d'oro e d'argento quasi per<br />
mera ostentazione <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>ritto.<br />
Di questi principi serba il nostro museo un triplice ed<br />
un doppio ducato o filippo <strong>di</strong> Antonio Teodoro, un ducato<br />
<strong>di</strong> Antonio Gaetano ed il mezzo tallero <strong>di</strong> Antonio Tolomeo.<br />
Maccagno.<br />
Come fu <strong>di</strong> già avvertito in breve monografia inserita<br />
nella <strong>Rivista</strong> della Numismatica, possedeva il signor cava-<br />
liere Bottacin, ancor prima ch'egli avesse fatto dono delle<br />
sue collezioni, una imitazione dei batzen <strong>di</strong> Lucerna, eseguita<br />
in Maccagno dal conte Jacopo III Mandelli. Avendo dappoi<br />
potuto esaminare tale moneta, mi persuasi non essere già<br />
segno <strong>di</strong> zecchiere lo scudetto che vedesi sul suo rovescio,<br />
ma bensì un'arme partita, caricata nel primo punto dei tre<br />
leopar<strong>di</strong> dei Mandelli e monocrona nel secondo (4).<br />
Un quattrino aggiunto posteriormente mostra bene una<br />
testa simile a quella del signore <strong>di</strong> Maccagno e l'arme in-<br />
quartata <strong>di</strong> due aquile e due leoni, ma le leggende man-<br />
canti non danno bastante certezza che gli appartenga.<br />
Principato <strong>di</strong> Belgiojoso.<br />
Antonio I Barbiano, creato principe dall'imperatore Giu-<br />
seppe II, fece battere nell'anno 1769 uno zecchino ed un<br />
tallero che, <strong>com</strong>e i pezzi del principe Antonio Tolomeo<br />
Trivulzio, sembrano usciti da qualche zecca straniera, la<br />
quale, potrebbe per avventura essere quella <strong>di</strong> Monaco <strong>di</strong><br />
Baviera. Quantunque tali monete siano state coniate piii che<br />
altro per pompa <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto, non posso convenire nell'opinione<br />
che non abbiano circolato perchè sono fatte alla stessa legge<br />
(4) Alle monete del Mandelli descritte in quell'articolo deve aggiun-<br />
gersi altra imitazione <strong>di</strong> moneta maggiore, <strong>di</strong>cken, o testone, <strong>di</strong> Lucerna,<br />
ch'erami ignota allora, perchè soltanto in quel torno veniva pubblicata<br />
dall'illustre signor Morel-Fatio; ma a tale omissione suppliva poi il<br />
chiarissimo Olivieri nella <strong>Rivista</strong> stessa.
230<br />
CARLO KUNZ<br />
d'altre consimili <strong>di</strong> Germania, ed il tallero incontrasi quasi<br />
sempre sdruscito.<br />
Questo gabinetto possiede il tallero,<br />
Masegra (?)<br />
Che <strong>di</strong>re <strong>di</strong> certi pezzettini <strong>di</strong> rame, che non vi mancano,<br />
i quali da un lato portano la scritta: <strong>di</strong> Beccaria, e dall'altro:<br />
I QUATRiNO, ovvero V2 QUATR? SuUa fede dell' Appell, che<br />
<strong>di</strong>sse possessore del Castello <strong>di</strong> Masegra e d'altri luoghi<br />
presso Sondrio un Antonio Beccaria, il quale assalito dai<br />
Veneziani nell'anno 1447, seppe sostenersi fintantoché ven-<br />
negli aiuto dalle armi del duca <strong>di</strong> Milano, e pei bisogni del<br />
momento fece battere queste se<strong>di</strong>centi monete, un ricerca-<br />
tore <strong>di</strong> cose peregrine accolse Masegra senz'altro esame nel<br />
novero delle zecche italiane del secolo XV. Ma chi osserva<br />
senza prevenzione quei pezzi facilmente si persuade che non<br />
in quel secolo, ma tutt'al piìi verso la fine del decimottavo,<br />
se non nei primi anni del presente, furono lavorati, e l'essere<br />
dessi battuti fuori della legge delle monete del tempo, scor-<br />
retti nella parola quattrino e nemmeno proporzionati fra loro,<br />
perchè il secondo pesa piìi del primo, <strong>di</strong>ssuade dal tenerli<br />
effettive e pubbliche monete. Per quale uso siano stati fatti<br />
noi so, ma certamente per uno molto privato, per contras-<br />
segni <strong>di</strong> qualche fabbrica, o pedaggio, o tassa locale, se pure<br />
la parola beccarla non sia da prendersi alla lettera <strong>com</strong>e la<br />
voce bovi della presunta moneta <strong>di</strong> Degagna dello stesso<br />
scopritore. Lasciando ad altri la soluzione <strong>di</strong> sì poco inte-<br />
ressante indovinello, credo si possano per intanto senza rimorso<br />
riporre quei pezzi in <strong>com</strong>pagnia delle tessere, dei<br />
bottoni e delle marche da giuoco <strong>di</strong> Norimberga.<br />
Carlo Kunz.
NECROLOGIA<br />
H. HOFFMANN.<br />
Il 30 Aprile scorso moriva a Parigi il Sig. H, Hoffiuann,<br />
notissimo nel mondo numismatico <strong>com</strong>e negoziante <strong>di</strong> monete<br />
e <strong>com</strong>e scrittore.<br />
Fu uno <strong>di</strong> quegli uomini che devono a sé stessi la<br />
propria fortuna. Nato ad Amburgo il 16 Agosto 1823, fu poi<br />
naturalizzato francese. Giovanissimo ancora si recò in Francia<br />
col padre che negoziava in conchiglie e minerali; ma appas-<br />
sionato delle monete, a 17 anni, senza aver avuto nessuna<br />
speciale istruzione, ne intraprese il <strong>di</strong>fficile <strong>com</strong>mercio. Du-<br />
rante parecchi anni, povero, fece il giro della Francia a pie<strong>di</strong><br />
con poche monete baronali nella valigia, fermandosi in ogni<br />
città ove sapeva esistere qualche raccoglitore. Nel 1845 si<br />
trovò in grado <strong>di</strong> recarsi a Londra per la ven<strong>di</strong>ta Thomas,<br />
poi nel 1847 a Vienna per la ven<strong>di</strong>ta Welzl de Wellenheim,<br />
e da allora si può <strong>di</strong>re in<strong>com</strong>inciata la sua fortuna.<br />
Dotato, <strong>com</strong>e era, <strong>di</strong> tutte le facoltà necessarie pel <strong>com</strong>-<br />
mercio delle monete, possedendo nel medesimo tempo il gusto<br />
e l'occhio sicuro, si fece ben presto una grande posizione,<br />
e la sua casa venne ad annoverarsi fra le primissime nel<br />
<strong>com</strong>mercio delle monete e, più tar<strong>di</strong>, delle antichità in genere.<br />
Moltissime fra le ven<strong>di</strong>te più importanti furono a lui confidate,<br />
e citeremo le collezioni: Barone Behr, Dupré, Colson, Gréau,<br />
de Moustier, Barre, His de la Salle, Bompois, Castellani (a<br />
Roma) Gariel, de Belfort, Photiadès-Pachà.<br />
I Cataloghi illustrati erano sconosciuti prima <strong>di</strong> lui. E<br />
al Sig. Hofifmann che dobbiamo la trasformazione dei cataloghi<br />
in vere opere da biblioteca e da consultazione, mentre<br />
prima non erano che semplici programmi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, senza
232<br />
NECROLOGIA<br />
alcun valore scientifico, e che nessuno si curava <strong>di</strong> con-<br />
servare.<br />
Dal 1862 al 1864 pubblicò un bollettino perio<strong>di</strong>co " Le<br />
Numismate „. Ma l'opera a cui resterà unito il suo nome <strong>com</strong>e<br />
nummografo, è quella <strong>com</strong>parsa nel 1879 col titolo " Les<br />
Monnaies royales de France „ che è il vade-mecum del rac-<br />
coglitore <strong>di</strong> questa serie <strong>di</strong> monete, la quale ha anche varii<br />
punti <strong>di</strong> collegamento colla nostra <strong>numismatica</strong> me<strong>di</strong>oevale<br />
per le numerose e interessanti monete franco italiane.<br />
Quantunque negoziante, il Sig. Hoffmann amava il bello<br />
anche per conto proprio, <strong>com</strong>perava per passione, vendeva<br />
con <strong>di</strong>spiacere, e si può <strong>di</strong>re che fosse nell'indole piuttosto<br />
raccoglitore che negoziante. Egli è vivamente <strong>com</strong>pianto da<br />
tutti i numismatici che hanno conosciuto e apprezzato il suo<br />
sapere e la sua rispettabilità.<br />
F. G.
BIBLIOGRAFIA<br />
LIBRI NUOVI.<br />
Le Riviste niimisaiaticiie francesi (Revue Numismatique,<br />
Annuaire de Numismatique, Gazette Numismatique fran9aise).<br />
Come tutti sanno, esistevano in Francia due perio<strong>di</strong>ci <strong>di</strong><br />
Numismatica, la Revue numismatique, che a ragione si vanta<br />
d'essere la piìi antica d'Europa e che nello scorso 1896 pubbli-<br />
cava il suo cinquantesimo volume e VAmmaire de mimismatique<br />
nato col sorgere della Società <strong>numismatica</strong> francese per ini-<br />
ziativa del Visconte de Ponton d'Amécourt nel 1865(1). Ma due<br />
perio<strong>di</strong>ci del medesimo genere e <strong>di</strong>retti al medesimo intento,<br />
quando si tratta <strong>di</strong> una scienza i cui adepti sono tanto limi-<br />
tati, non possono a meno che avere i medesimi lettori e sono<br />
quin<strong>di</strong> troppi in un paese, si tratti pure d'un paese eminen-<br />
temente colto e straor<strong>di</strong>nariamente ricco <strong>com</strong>e la Francia,<br />
Da tempo <strong>di</strong>fatti i due perio<strong>di</strong>ci vi stavano a <strong>di</strong>sagio e<br />
la fusione, da molti lungamente desiderata, ormai s'imponeva.<br />
Fu collo scorso anno che VAnmiàire, con lodevole abnega-<br />
zione, decise <strong>di</strong> sopprimere le proprie pubblicazioni, e la sua<br />
redazione si unì a quella della Revue, concentrandovi così<br />
tutta l'attività <strong>numismatica</strong> francese.<br />
Col cessare <strong>di</strong>^iVAnnuaire, la Revue <strong>di</strong>ventò anche l'organo<br />
ufficiale della Società <strong>numismatica</strong> francese, la quale<br />
d'ora innanzi farà centro ad essa. Il momento psicologico<br />
della Revue viene segnato coll'inaugurazione <strong>di</strong> una nuova<br />
serie nella sua pubblicazione, contrad<strong>di</strong>stinta <strong>com</strong>e la quarta<br />
nel 1° fascicolo apparso nel corrente 1897.<br />
(1) Oltre alle due riviste si pubblicava e si pubblica ancora il Buileiin<br />
de Numismatique <strong>di</strong> R. Serrare, il quale però va messo in una<br />
categoria a parte, essendo un foglio d' informazioni piuttosto che una<br />
vera rivista.<br />
30
234<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
La prima serie era durata dal 1836 al 1855 sotto la <strong>di</strong>re-<br />
zione dei fondatori Cartier e de la Saussaye, la seconda<br />
(nonvelle sèrie) dal 1856 al 1877 sotto la <strong>di</strong>rezione De Witte<br />
e Longpérier, la terza dal 1883 al 1896 sotto la Direzione<br />
Barthèlemy, Schlumberger e Babelon, a cui, per <strong>di</strong>rigere la<br />
quarta, ora iniziata, si aggiungono i Sig. E. Caron e A. de<br />
Belfort, l'antico presidente e decano della Società, e l'antico<br />
<strong>di</strong>rettore dell'Annuaire.<br />
Se la fusione delle due Riviste fu trovata buona dal corpo<br />
dei numismatici francesi, <strong>com</strong>e fu approvata, cre<strong>di</strong>amo, anche<br />
da tutti gli altri, vi fu però chi la pensò <strong>di</strong>versamente e, nello<br />
stesso punto in cui VAnnuaire si eclissava, sorgeva la nuova<br />
Gazette Numismatique fran^aise <strong>di</strong>retta da F. Mazerolle ed<br />
e<strong>di</strong>ta da R. Serrure. La Gazette in<strong>com</strong>inciò le sue pubblica-<br />
zioni coiranno corrente e ne abbiamo sott'occhio l'elegantis-<br />
simo primo fascicolo.<br />
Il suo formato e il suo volume sono superiori ad ogni<br />
altro, la sua veste è piìi splen<strong>di</strong>da; ma il suo programma, per<br />
quanto tenti <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenziarsi dagli altri consimili, è sempre<br />
suppergiù il programma d'un perio<strong>di</strong>co <strong>di</strong> <strong>numismatica</strong> con<br />
tendenza a una certa quale modernità, con aspirazioni artistiche,<br />
con inten<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> cimentarsi anche nel campo<br />
economico, senza punto escludere la <strong>numismatica</strong> classica,<br />
almeno la romana. Il programma infine è molto vasto, anzi,<br />
se gli si volesse muovere un appunto, sarebbe precisamente<br />
quello d' essere troppo vasto, ma non altrettanto deciso<br />
e specializzato. Se il perio<strong>di</strong>co intende essere soprattutto<br />
artistico, occuparsi con pre<strong>di</strong>lezione delle opere d' incisione<br />
e della medaglistica antica e moderna e figurare nei salotti<br />
eleganti allato alle Riviste <strong>di</strong> pittura, <strong>di</strong> scoltura e d'arte in<br />
generale, <strong>com</strong>e lo in<strong>di</strong>cherebbero anche la sua leggiadra veste<br />
esteriore, 1' accuratezza e nitidezza tipografica e le splen-<br />
<strong>di</strong>de fotoincisioni — il che sarebbe opportunissimo per <strong>di</strong>stac-<br />
carsi nettamente dalla Revue de<strong>di</strong>ta <strong>com</strong>pletamente alla<br />
scienza, — forse vi si contengono materie che poco possono<br />
interessare a chi si occupa puramente d'arte. Per contro la<br />
parte <strong>numismatica</strong> appare soverchiamente ridotta per chi lo<br />
considerasse <strong>com</strong>e perio<strong>di</strong>co scientifico. E resta ancora la<br />
parte economica, la quale richiede una categoria <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>osi.
BIBLIOGRAFIA 235<br />
<strong>di</strong>fferente da quella che attende alla <strong>numismatica</strong> e <strong>di</strong>fferente<br />
da quella che si occupa d'arte.<br />
Chi, per esempio, si interessa alla bella monografia del<br />
MazeroUe sulla vita e l'opera <strong>di</strong> F. C. Chaplain, <strong>com</strong>e alla<br />
cronaca artistica dello stesso, <strong>di</strong>fficilmente si interesserà alle<br />
monete carolingie, a quelle <strong>di</strong> Filippo VI e del principe <strong>di</strong><br />
Taranto, e neppure alla cronaca monetaria o alle monete <strong>di</strong><br />
nichelio in Francia e all'estero (O-<br />
Secondo il nostro modo <strong>di</strong> vedere, il mezzo <strong>di</strong> tracciare<br />
un programma preciso e che totalmente si staccasse da ogni<br />
perio<strong>di</strong>co numismatico non sarebbe mancato e sarebbe stato<br />
quello <strong>di</strong> fare non una Gazette Numismatique, ma una Gazette<br />
Médaillistiqiie . In tal caso la nuova gazzetta avrebbe avuto<br />
a sua <strong>di</strong>sposizione un campo, se non vergine, vastissimo e<br />
<strong>com</strong>pletamente a sé. Giacche è d'uopo convenire una buona<br />
volta che, se le Riviste Numismatiche si sono finora <strong>di</strong> quando<br />
in quando occupate anche della medaglistica — e, chi è senza<br />
peccato, lanci la prima pietra, — l'hanno fatto perchè non<br />
esistono riviste speciali per la medaglistica e, ogni volta che<br />
si sono occupate <strong>di</strong> medaglie, sono uscite dalla loro orbita<br />
invadendo un campo che non era il proprio. La <strong>numismatica</strong><br />
è una scienza, la medaglistica un'altra, <strong>com</strong>e un'altra ancora<br />
è la sfragistica, le quali ultime, giova ripeterlo, nulla hanno a<br />
che fare colla <strong>numismatica</strong>, quantunque ben sovente siano<br />
state considerate <strong>com</strong>e rami, vogliasi pure secondarli, <strong>di</strong><br />
questa. L'opportunità della <strong>di</strong>visione venne riconosciuta anche<br />
dallo stesso Sig. Serrure nella prefazione alla Numismatique<br />
da Moyen Age (nota a pag. XXX); ed ora che le <strong>scienze</strong><br />
tendono a specializzare, è troppo naturale ch'essa abbia ad<br />
essere seguita nella pratica.<br />
Ritornando dunque all'argomento, è in questo senso che<br />
noi avremmo inteso una nuova <strong>Rivista</strong>, de<strong>di</strong>ta alle medaglie<br />
e, se si vuole, anche alle monete considerate sotto il rapporto<br />
artistico; ma sbarazzata da tutto il resto, dalla partita numi-<br />
smatica, cioè, e da quella economica. La Francia sarebbe<br />
stata la prima ad offrire l'esempio <strong>di</strong> una <strong>di</strong>visione tanto<br />
(i) E qui noteremo incidentalmente <strong>com</strong>e fra i paesi che impiegano<br />
il nichelio, l' Italia sia stata <strong>di</strong>menticata.
236<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
razionale, e non dubitiamo che avrebbe trovato il terreno<br />
adatto per tale riforma. Del resto, ci siamo permesse tali<br />
osservazioni perchè, facendo una recensione, cre<strong>di</strong>amo do-<br />
veroso esprimere tutto l'animo nostro ed esporre ogni consi-<br />
derazione che ci si affaccia alla mente, sia che essa suoni<br />
approvazione, sia invece che essa accenni ad un <strong>di</strong>verso<br />
modo <strong>di</strong> vedere. Ma è giusto aggiungere che noi giu<strong>di</strong>chiamo<br />
da lontano e in un ambiente forse <strong>di</strong>verso da quello in<br />
cui la nuova Gazzetta è nata. Chi s' è messo alla testa<br />
dell'impresa, è certamente persona degna d'ispirare ogni<br />
fiducia, avrà considerata la cosa più davvicino, avrà potuto<br />
pesare in anticipazione tutte le obbiezioni e fondare un Pe-<br />
rio<strong>di</strong>co destinato a una lunga e fortunata carriera, ciò che<br />
noi auguriamo ben cor<strong>di</strong>almente.<br />
F. G.<br />
Nachtràge und Berichtigungen zur Munzkunde der Rómischen<br />
Republik im Anschluss an Babelon' s Verzeichniss der Consular-<br />
Miinzen, von M. Bahrfeldt.<br />
Il Sig. Bahrfeldt è uno specialista ben conosciuto per<br />
le monete della Repubblica Romana; <strong>di</strong> più è uno specialista<br />
tedesco. Queste due qualifiche danno un'idea dell' eru<strong>di</strong>to,<br />
paziente e minuzioso lavoro pubblicato recentemente, o,<br />
<strong>di</strong>remo meglio, in corso <strong>di</strong> pubblicazione, perchè, quantunque<br />
l'autore me n'abbia gentilmente favorita una copia <strong>com</strong>pleta,<br />
non ne è finora pubblicata che la prima metà nel Volume<br />
1896 della Numismatische Zeitschrift, uscito nello scorso<br />
mese <strong>di</strong> marzo.<br />
Il Bahrfeldt ha riassunto in questo suo lungo stu<strong>di</strong>o tutti<br />
gli stu<strong>di</strong>i suoi e queUi d' altri, apparsi qua e là su <strong>di</strong>versi<br />
perio<strong>di</strong>ci, che si occuparono <strong>di</strong> monete della Repubblica<br />
Romana, dopo la pubblicazione dell'Opera <strong>di</strong> Babelon, ossia<br />
nell'ultimo decennio.<br />
Per la <strong>com</strong>pilazione del suo lavoro l'A. ebbe a sua<br />
<strong>di</strong>sposizione, oltre la sua collezione, quella del D. Haeberling<br />
<strong>di</strong> Francoforte, e quella del Cav. Giulio Bignami, recen-<br />
temente passata al Comune <strong>di</strong> Roma, le cui molte ine<strong>di</strong>te
BIBLIOGRAFIA 237<br />
dovevano venir pubblicate per la prima volta nella nostra<br />
<strong>Rivista</strong> e, se non lo furono, ne fu causa un malinteso, che<br />
ora non occorre menzionare; ma che certamente con noi<br />
deplorerà l'antico proprietario <strong>di</strong> quella collezione, a cui mancò<br />
così un'illustrazione speciale che ne avrebbe accresciuto il<br />
pregio e conservata la memoria.<br />
L'opera del Bahrfeldt passa quasi i limiti <strong>di</strong> una pubbli-<br />
cazione da perio<strong>di</strong>co, raggiungendo oltre 350 pagine, con un<br />
corredo <strong>di</strong> 14 tavole. Molte sono le monete nuove che il<br />
suo lavoro porta in luce o almeno coor<strong>di</strong>na, prendendole<br />
da altre pubblicazioni, abbondanti sono i <strong>com</strong>menti e le<br />
osservazioni che ac<strong>com</strong>pagnano la descrizione d'ogni moneta,<br />
<strong>com</strong>e eru<strong>di</strong>te le illustrazioni intorno a parecchie famiglie o a<br />
parecchi gruppi <strong>di</strong> monete, moltissime infine sono le rettifiche<br />
che fa all'opera <strong>di</strong> Babelon. Basti <strong>di</strong>re che più o meno a lungo<br />
<strong>di</strong>scorre intorno ad oltre 600 monete riguardanti la più gran<br />
parte delle famiglie romane, 151 cioè sulle 181 conosciute.<br />
La pubblicazione è dunque troppo voluminosa, e, <strong>di</strong>rò<br />
anche, troppo dotta, perchè in questo cenno bibliografico<br />
si possa entrare a <strong>di</strong>scutere singolarmente qualche giu<strong>di</strong>zio,<br />
o qualche apprezzamento, che forse non potrebbe essere<br />
da tutti con<strong>di</strong>viso, e d'altronde non mi sentirei la forza <strong>di</strong><br />
mettermi ex abnipto a <strong>com</strong>battere un avversario tanto ben<br />
agguerrito in materia. Mi accontenterò <strong>di</strong> fare qualche osser-<br />
vazione in via generale e prima <strong>di</strong> tutto, allo scrittore tanto<br />
minuzioso e tanto preciso mi sia permesso muovere una<br />
piccola critica, che parrà strana al primo accennarla, sulla<br />
mancanza cioè <strong>di</strong> minuziosità e <strong>di</strong> precisione in qualche passo<br />
del suo lavoro.<br />
Ho detto che l'A. ebbe a sua <strong>di</strong>sposizione parecchie<br />
collezioni pubbliche e private; ne avrebbe potuto aver altre,<br />
per esempio, quella dello scrivente, purché l'avesse chiesta.<br />
Dopo un'ispezione, sarebbe stato più regolare l'accettare o<br />
il condannare una moneta, e parecchi punti assai facilmente<br />
chiaribili sarebbero stati chiariti, cosicché non rimarrebbero nel<br />
suo lavoro senza una risoluzione e con un punto interrogativo.<br />
E valgano due esempi. Al n. 32 àéS^C Antonia, riportando dalla<br />
nostra <strong>Rivista</strong> un bronzo <strong>di</strong> Atratino, l'A. si <strong>di</strong>manda : Manca<br />
proprio davvero e <strong>com</strong>pletamente l' interpunzione ? Al n, 34
238<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
della stessa Antonia, riportando un aureo <strong>di</strong> M. Antonio<br />
e Antillo da me pure pubblicato, rimane in dubbio se la<br />
leggenda sia M. F. N., <strong>com</strong>e si legge sulla nostra <strong>Rivista</strong>,<br />
oppure M. F. M. N., <strong>com</strong>e si legge sull'esemplare <strong>di</strong> Berlino,<br />
Non sarebbe stata cosa assai semplice e più concludente<br />
la <strong>di</strong>manda <strong>di</strong> uno schiarimento o <strong>di</strong> un calco al possessore<br />
delle monete, il quale vive ancora e sarebbe stato felicissimo<br />
<strong>di</strong> <strong>com</strong>piacerlo?<br />
Il lavoro del Sig. Bahrfeldt, condotto secondo l'or<strong>di</strong>ne<br />
alfabetico delle famiglie, segue l'opera <strong>di</strong> Babelon pagina<br />
per pagina, moneta per moneta. L'A. prende ad esaminare<br />
quest'opera al principio dei nomi <strong>di</strong> famiglia ossia alla pag. 93<br />
del primo volume e lo ac<strong>com</strong>pagna passo passo fino all'ultima<br />
pagina del secondo. E lo analizza, e lo sviscera, e lo inqui-<br />
sisce e lo critica, non solo coH'acutezza del critico, colla<br />
pazienza e la minuziosità del certosino ; ma <strong>di</strong>rei quasi col-<br />
r accanimento del persecutore.<br />
Si <strong>di</strong>rebbe che Aristarco goda <strong>di</strong> maneggiare il flagello;<br />
tanto che qua e là lascia sfuggire alcune espressioni che si<br />
' sarebbero potuto desiderare piti cavallerescamente gentili al-<br />
l'in<strong>di</strong>rizzo <strong>di</strong> una personalità che giustamente tiene uno dei<br />
primissimi posti fra gli scrittori moderni <strong>di</strong> <strong>numismatica</strong>, e i<br />
cui pregevoli volumi sono nelle mani <strong>di</strong> tutti i raccoglitori.<br />
Certo io, <strong>com</strong>e già <strong>di</strong>ssi, non intendo entrare nel merito delle<br />
<strong>di</strong>vergenze, <strong>com</strong>e non intendo menomamente limitare la libertà<br />
delle opinioni. Alludo semplicemente alla questione <strong>di</strong> forma,<br />
la quale ha essa pure la sua importanza, giacché un libro è<br />
<strong>com</strong>posto <strong>di</strong> due elementi, la sostanza e la forma, e su questi<br />
va giu<strong>di</strong>cato. Una forma misurata, corretta, ossequiosa verso<br />
l'avversario è bene spesso piia efficace d'una troppo fote ed<br />
impetuosa, e, <strong>com</strong>e splen<strong>di</strong>do esempio <strong>di</strong> tale verità si potrebbe<br />
ad<strong>di</strong>tare il nostro Manzoni — il Dante senza fiele —<br />
nelle sue controversie col Sismon<strong>di</strong>, le cui idee erano pure<br />
tanto <strong>di</strong>verse dalle sue!<br />
A parte queste osservazioni, il lavoro del Bahrfeldt<br />
può essere considerato <strong>com</strong>e un importantissimo contributo<br />
al Corpus numorum definitivo, e l'autore della Description<br />
historique et chronologique des monnaies de la répuhliqiie<br />
romaine, sorpassando alle mende accennate, può nullameno
BIBLIOGRAFIA 339<br />
essergli grato d'avergli preparato delle abbondanti aggiunte,<br />
delle numerose rettifiche e un accuratissimo errata-corrige (0<br />
per una eventuale e, ci auguriamo, prossima seconda E<strong>di</strong>zione.<br />
F. G.<br />
Misins (P. Aristot.), ^TO'-ysia ttì; 'Apyata; NofxtfTy.aTDcr; rxot Te-<br />
vf/.à n;o>.syóp.£va t'^? Noa'.cy.aToXoy^a; toO 'Exxs/.iou. MeTà
240<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
anno lectivo de 1894-95. — Vili : —<br />
1895-96. — Lisboa, Imprensa nacional, 1896.<br />
Curso do anno lectivo de<br />
Il eh. Prof. Vasconcellos, che da vari anni insegna Nu-<br />
mismatica dalla cattedra appositamente istituita per questa<br />
<strong>di</strong>sciplina presso la Biblioteca Nazionale <strong>di</strong> Lisbona, nel pre-<br />
sente opuscolo ci dà il sommano delle lezioni da lui profes-<br />
sate negli ultimi due anni accademici.<br />
Cre<strong>di</strong>amo interessante il farne un riassunto.<br />
Anno 1894-95.<br />
Il corso consistette <strong>di</strong> 44 lezioni.<br />
Parte del tempo fu de<strong>di</strong>cata allo stu<strong>di</strong>o della Numismatica<br />
generale: scopo della Numismatica; <strong>di</strong>visioni <strong>di</strong> questa scienza;<br />
nomenclatura, ecc.<br />
Un'altra parte fu de<strong>di</strong>cata allo stu<strong>di</strong>o storico <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse<br />
monete imperiali romane.<br />
Gli alunni, non solo esaminarono tutte le monete delle<br />
quali si trattava in ciascuna lezione, ma ne classificarono per<br />
iscritto anche molte altre.<br />
Libro <strong>di</strong> testo: il Cohen.<br />
Anno 1895-96.<br />
Il corso consistette <strong>di</strong> 47 lezioni.<br />
Parte I. — Numismatica generale; nomenclatura sviluppata;<br />
falsificazioni.<br />
Parte II. — Elementi della storia della Repubblica Romana;<br />
stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> varie monete che vi si riferiscono.<br />
Parte III. — Come lo stu<strong>di</strong>o delle monete della Repubblica<br />
Romana possa giovare alla cognizione dell'etnografia e della<br />
storia della Penisola Iberica.<br />
Parte IV. — Riepilogo della materia già svolta; <strong>di</strong>stribuzione<br />
cronologica delle serie numismatiche; storia sommaria<br />
della Numismatica.<br />
Nella storia della Numismatica furono trattati questi punti :<br />
1. Collezioni:<br />
a) private;<br />
b) musei pubblici.<br />
2. Società, viaggi e congressi.<br />
3. Insegnamento ufficiale e privato.<br />
4. Bibliografia.<br />
5. Commercio delle monete destinate alle collezioni ed<br />
allo stu<strong>di</strong>o.
BIBLIOGRAFIA 24I<br />
Nella breve <strong>di</strong>ssertazione: Objedo da Numismatica, che<br />
ac<strong>com</strong>pagna YEleucho, il Prof. Vasconcellos, prendendo in<br />
esame una moneta dell'attuale re Luigi I <strong>di</strong> Portogallo, pone<br />
in chiaro i molteplici aspetti sotto i quali si può considerarla;<br />
e si associa all'opinione dello scrivente, che la Numismatica<br />
sia una scienza a sé, una scienza autonoma; mentre <strong>di</strong>chiara<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>ssentire dal Prof. Bonnet, il quale, nel suo lavoro La<br />
philologie classique, sostiene che la Numismatica, essendo<br />
costituita da un <strong>com</strong>plesso <strong>di</strong> nozioni <strong>di</strong>sparatissime, non sia<br />
altro che una scienza convenzionale.<br />
S. A.<br />
Heiii*^' Francois Itraiidl, Erster Medailleur an der kóniglichen<br />
Mttnze und Professor der Gewerbe-Academie zu Berlin (1789-<br />
1845). Leben und Werke. Bearbeitet und herausgegeben von<br />
seiner Enkelin Hildegard Lehnert. — Berlin, Hessling, 1897. —<br />
(Un voi. in-4 gr., con 22 tav. in fototipia).<br />
Pubblicazione <strong>di</strong> gran lusso, la quale interessa anche la<br />
Numismatica <strong>italiana</strong>.<br />
Brandt, nativo della Chaux-de-Fonds, entrato <strong>com</strong>e allievo<br />
neir officina per la incisione delle medaglie <strong>di</strong>retta da Droz<br />
presso la Zecca <strong>di</strong> Parigi, dopo assiduo lavoro riuscì nel 1813<br />
a riportare il gran premio <strong>di</strong> Roma, e quivi passò tre anni;<br />
sinché fu chiamato a Berlino, dove fece una rapida e fortu-<br />
nata carriera.<br />
Fra le moltissime medaglie da lui incise notiamo, in<br />
or<strong>di</strong>ne cronologico, le seguenti; eseguite nella quasi totalità<br />
durante il suo soggiorno in Roma:<br />
1815. Med. per il ritorno <strong>di</strong> Pio VII a Roma.<br />
" » in onore <strong>di</strong> Guillon .Lethière, Direttore dell'Accad. <strong>di</strong><br />
Francia a Roma.<br />
» » in onore <strong>di</strong> Luigi XVIII <strong>com</strong>e Conservatore dell'Acc.<br />
<strong>di</strong> Fr. a Roma.<br />
181 7. » papale per il riacquisto <strong>di</strong> varie provincie.<br />
" n » <strong>di</strong> premio.<br />
» » in onore <strong>di</strong> Luigi XVIII, per la ristauraz. della chiesa<br />
della Trinità dei Monti a Roma.<br />
3'
2|2<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
J817. Med. in onore <strong>di</strong> Canova e del pittore rom. Vincenzo Ca-<br />
muccini (progetto?).<br />
» » in onore <strong>di</strong> Thorvaldsen (eseguita in Roma <strong>di</strong>etro le<br />
in<strong>di</strong>cazioni <strong>di</strong> T. stesso).<br />
» » per la ricostruz. del Teatro S. Carlo in Napoli.<br />
» » per la riapertura » » »><br />
1838, n in onore <strong>di</strong> Orazio Vernet, Direttore dell'Accad. <strong>di</strong><br />
Francia a Roma.<br />
Il volume è adorno <strong>di</strong> un ritratto <strong>di</strong> Brandt, tolto da un<br />
bel medaglione modellato dal suo amico il celebre scultore<br />
David d'Angers.<br />
Die Medaillen und Miìnzen des Gesammthauses Wittelsbach. Auf<br />
Grund eines Manuscripts von J. P. Beierlein bearbeitet und<br />
herausgegeben vom K. Conservatorium des Miinzkabinets. —<br />
I. Band. — Miìnchen, 1897. — (Un voi. in 4, con 5 tav. in<br />
eliogr. e molte incisioni nel testo).<br />
E la prima parte <strong>di</strong> un'opera descrittiva, la quale si<br />
<strong>di</strong>stingue per quella minuziosa esattezza che caratterizza i<br />
nostri colleghi tedeschi. Concerne anche la Numismatica ita-<br />
liana: veggansi le monete milanesi, <strong>com</strong>asche e savonesi <strong>di</strong><br />
Lodovico il Bavaro. Fra le medaglie riprodotte nelle tavole<br />
che corredano questo bel volume, notiamo la medaglia <strong>di</strong><br />
Violante Beatrice principessa <strong>di</strong> Toscana.<br />
Forster (Alb.) und Schmid (Rich.), Die Miìnzen der freien<br />
Reichsstadt Augsburg, von erlangtem Milnzrecht (1521) an bis<br />
zum Verluste der Reichsfreiheit (1805), nach Originalen be-<br />
schrieben. — Augsburg, 1897 (Verlag von Dr. E. Merzbacher,<br />
MUnchen). — (Un opusc. <strong>di</strong> pag. VI-50, con 8 tav. in fototipia).<br />
Da questa <strong>di</strong>ligente monografia della zecca <strong>di</strong> Augusta<br />
possiamo desumere un particolare che interessa la Numisma-<br />
tica <strong>italiana</strong>; — cioè che i due piccoli ferri da cavallo, i quali<br />
(insieme con l'emblema civico della pigna) figurano anche su<br />
<strong>di</strong>verse monete <strong>di</strong> Cesare D'Avalos marchese del Vasto,
BIBLIOGRAFIA 243<br />
battute in quella zecca bavarese (i), sono il contrassegno o<br />
l'arme parlante della famiglia Holeisen, in cui era per cosi<br />
<strong>di</strong>re <strong>di</strong>venuto ere<strong>di</strong>tario l'ufficio <strong>di</strong> zecchiere.<br />
S. A.<br />
Artom Ern.f La moneta fiduciaria e le classi lavoratrici; stu<strong>di</strong>.<br />
Torino, Clausen, in-8, p. 31.<br />
Carotina dott. Fi/., Il valore della moneta; stu<strong>di</strong>. Palermo, Alberto<br />
Reber e<strong>di</strong>t. (stab. tip. Virzì), 1897, inA P- viij, 117, L. 3.<br />
Ambrosoli dott. Sol., Vocabolarietto pei numismatici (in 7 lingue).<br />
Milano, 1897, Ulrico Hoepli e<strong>di</strong>t. (tip. Lombar<strong>di</strong> <strong>di</strong> M. Bellinzaghi), L. 1,50<br />
Armoiries et décorations par Jules Martin, de Montalbo et Raymond<br />
Richebé. Illustration de Joseph van Driesten, in-32 ili. Paris, libr. des<br />
conteiiiporains, 1896. [Notizie che concernono 257 or<strong>di</strong>ni e 39 medaglie].<br />
Babelon E., Les origines de la monnaie, considérées au point de<br />
vue économique et historique. Paris, Firmin Didot, 1897, in-18, p. xii-427.<br />
Reinach Th., Les origines du bimétallisme: étude sur la valeur<br />
proportionelle de l'or et de l'argent dans l'antiquité grecque. Paris,<br />
Feuardent et RoUin, 1897, in-8, p. 55.<br />
Crédano P., Du ròle de l'État en matière monétaire. Histoire de<br />
la monnaie; le mono-métallisme -or; les crises monétaires. Paris,<br />
Rousseau, in-8, p. 336.<br />
Coutil L., Inventaire des monnaies gauloises du département de<br />
l'Eure. Évreux, impr. Hérissey, 1897. [BuUetin de la Soc. libre d'agr.<br />
du dép. de l'Eure].<br />
Blancard Louis., Les deniers d'argent mérovingiens. Marseille,<br />
Barthelet, 1896, in-8, p. 14 fig. (Extr. des " Mémoires de l'Académie<br />
de Marseille „).<br />
Blancard Louis, Sur l'agnel d^or imité du sarrazinas chrétien d'Acre.<br />
Marseille, imp. Barthelet, 1896, in-8 fig., p. 3. (Extr. des " Mémoires de<br />
l'Académie de Marseille „).<br />
Lavoix Henri, Catalogne des monnaies musulmanes de la Bibliothèque<br />
nationale. Égypte et Syrie. Paris, impr. nationale, 1896, in-8, p. ix-<br />
562 et IO pi.<br />
Blanchet A., Les monnaies grecques. Paris, Leroux, in-8, p. 115 et pi.<br />
Amardel G., L'atelier monétaire de Saint-Lizier. Narbonne, Caillard,<br />
(i) Cfr. Ambrosoli, Il mezzo zecchino del Vasto. — (In Riv. It. <strong>di</strong><br />
Num., anno IV, 1890; — a pag. 545).
244<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
1896, in-8, p. i8. (Extr. du Bulletin de la <strong>com</strong>mission archéologique de<br />
Narbonne, 2" semestre 1896).<br />
Thereaux L., Les systèmes monétaires, in-8. Paris, Leroux.<br />
Joseph Paul u. Fellne.r Ed., Die Mùnzen von Frankfurt am Main.<br />
Frankfurt, J. Baer, 1896, in-8 gr., p. ix-68i, 75 Tfln et 52 ili.<br />
Die Medaillen und Milnzen des Gesammthauses Wittelsbach. Hrsg.<br />
vom k. Conservatorium des Milnz-Cabinets. I Bd. I. Theil. Mit 5 Tafln<br />
u. Zeichn. im Texte. Miinchen, Franz in Commission, 1897, i""4-<br />
Truhelka d.^ C. , Verzeichniss der bosnischen , serbischen und<br />
bulgarischen Munzen des Landes-Museums in Sarajevo. Wien, Gerold,<br />
in.8, p. 21 e 34 fig.<br />
Domanig K., Portràtmedaillen des Erzhauses Oesterreichs von<br />
Kaiser Friedrich III bis Kaiser Franz II. Wien, Gilhofer u. Rauschburg,<br />
1896, in-4 gr., p. 40 e 50 tav.<br />
Beschorner H., Das Amt Freiberg und seine Verwaltung uni <strong>di</strong>e Mitte<br />
des 15. Jahrh's dargestellt an der Hand Freiberger Miinzmeisterpapiere<br />
aus den Jahren 1445-1449. I. Theil. (Diss. inaug. Lipsia), in-8, p. 38.<br />
Tobler-Meyer W., Die Mùnz- und Medaillen-Sammlung des Herrn<br />
Hans Wunderly von Muralt in Zilrich. I, 2. Die Munzen und Medaillen<br />
der 8 alten Orte ausser Zilrich. Ziirich, A. MuUer, 1896, in-8, p. xxiii-392.<br />
Beschreibung von Munzen u. Medaillen des Fùrstenhauses Baden<br />
in chronolog. Folge aus der Sammlung des Kommerzienrates O. Bally<br />
in Sàkkingen. I. Theil: Munzen u. Medaillen des Zàhringen-Ba<strong>di</strong>schen<br />
Fùrstenhauses. Mit 2 farbigen u. 12 schwarzen Tafeln, sowie einigen<br />
Textabb. Aarau, H. R. Sauerlànder' und C, 1897, ^^ ^^^'^ P- xxxvii-i22.<br />
D. Manuel Fernandes y Lopez, El Tesoro Visigòtico de la Capilla.<br />
Sevilla, imprenta " El Pervenir „, 1895, p. 165 in-8 e fotogr. [Cfr. la<br />
larga recensione <strong>di</strong> E. Hiibner in Deutsche Litteratur Zeitung <strong>di</strong> Berlino,<br />
n. 3, 1897, p. 498-502].<br />
Beauvois, Médailles romaines d'or et d'argent d'avant le milieu du<br />
VI° siede trouvées dans les pays scan<strong>di</strong>naves, par P. Hauberg, traduit.<br />
Copcnhague, imp. de Thiele, in-8 gr., p. 25.<br />
Bergsoe V., danske Medailler fra 1782-1892. XV Tavler i Lystryk<br />
med dansk og fransk Text. Kopenhagen, Gyldendal, in-4 i"-<br />
Bergsoee V., Trankebar Moenter. Copenhagen, 1895, in-4, p. 76 e 2<br />
tav. [Monete <strong>di</strong> Trankebar (1644-1845) con monete e medaglie concer-<br />
nenti il <strong>com</strong>mercio danese nelle In<strong>di</strong>e Orientali (1657-1777)].<br />
Serrure, Les Monnaies des Voconces. Essai d'attribution et de classe<br />
ment chronologique. Bruxelles, chez l'auteur, in-8, p. 96.<br />
Allard A., La crise agricole. Exposé <strong>di</strong>dactique de ses origines<br />
monétaires (Millcnaire du royaumc de Hongrie, 1896). Bruxelles, soc.<br />
belge de librairie, 1896 in-8, p. 240.<br />
-
BIBLIOGRAFIA 245<br />
McPherson Logan G., The monetary and banking problem. New-<br />
York, Appleton, in-8, p. v-i35.<br />
Barker Wharton, Bimetallism; or, the evils of gold monometaUism<br />
and the benefits of bimetallism. Philadelphia, Barker Pubi. C.°, in-8,<br />
p. xv-330.<br />
Walker Francis A., International Bimetallism. New-York, H. Holt<br />
et C.°, in-8, p. v-297.<br />
Loivry R., Shall the United States undertake alone the free coinage<br />
of Silver at the ratio of sixteen to one? Chicago, H. Kerr, in-8, p. in-272.<br />
Harper I. IV., Money and Social Problems. London, Oliphant, in 8,<br />
p. 380.<br />
Schoenhof L, A history of money and prices. New-York, Putnam's<br />
Sons, in-8, p. xvii-352.<br />
PERIODICI.<br />
E. M.<br />
Revue NuMiSMATiQUE, <strong>di</strong>rlgée par A. de Barthélemy, G. Schlum-<br />
berger, E. Babelon (Secrétaire de la Rédaction: J.-A. Blanchet).<br />
Paris, chez Rollin et P^euardent.<br />
Troisième serie. — Tome quatorzième. — Quatrième trime-<br />
stre 1896.<br />
Rouvier [D'' Jules), Une métropole phénicienne oubliée: Lao-<br />
<strong>di</strong>cée, métropole de Canaan [Continuazione e fine]. — Babelon (E.),<br />
Médaillon d'or de Gallien et de Salonine. — Prou (M.), Monnaies<br />
mérovingiennes acquises par la Bibliothèque nationale de 1893 à<br />
1896. — La Tour {H. de), Médailles modernes récemment acquises<br />
par le Cabinet de Franca [Continuazione]. — Chronique [Numismatica<br />
etiopica]. — Necrologie [A. Boutkowski. — Umberto Rossi]. —<br />
Collection Montagu: Prix d'adju<strong>di</strong>cation des monnaies grecques.<br />
Bulletin bibliographique. — Pério<strong>di</strong>ques. — Table métho<strong>di</strong>que des<br />
matières pour 1896. — 2 tav.<br />
Quatrième sèrie. — Tome premier. — Premier trimestre 1897.<br />
Avertissement [Col primo trimestre 1897, l'antica ed autorevole<br />
Revue, che ormai può vantare un <strong>com</strong>plesso <strong>di</strong> ben 50 volumi,<br />
inizia una nuova serie, la quarta, <strong>di</strong>ventando organo della Société<br />
fram^aise de Numismatique, il cui Annuai re ha. sospeso le proprie<br />
pubblicazioni coli' ultimo fascicolo dello scorso anno]. — Blanchet<br />
(J.-Adrien), Les monnaies coupées [L'A., dopo <strong>di</strong> aver esaminato<br />
le opinioni <strong>di</strong> Morel-Fatio e d'altri intorno alle monete spezzate,<br />
—
246<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
passa in rassegna <strong>di</strong>versi ripostigli nei quali se ne trovavano in<br />
maggiore o minor numero, e delle epoche più <strong>di</strong>verse, de' paesi<br />
più svariati, richiama l'attenzione sull'uso che tuttora se ne fa presso<br />
alcuni popoli, e conchiude che, <strong>com</strong>e nei tempi più recenti e nell'evo<br />
me<strong>di</strong>o, anche nell'antichità le monete furono spezzate allo scopo <strong>di</strong><br />
ottenere delle sud<strong>di</strong>visioni atte a facilitare le transazioni <strong>com</strong>merciali.<br />
A quest'articolo dell'egr. Sig. Blanchet può servire <strong>di</strong> <strong>com</strong>ple-<br />
mento la breve memoria: Un ripostiglio miserabile, pubblicata da<br />
Frane. Gnecchi nel precedente fase, della nostra <strong>Rivista</strong>], — Bordeaux<br />
{Paul), L'adjonction au domaine royal de la chàtellenie de Dun et<br />
les deniers frappés à Dun par Philippe I^"" et Louis VI. — Gennep<br />
{A. Raugé van), Jetons de Savoie [Accurato supplemento all'opera<br />
<strong>di</strong> Vino. Promis : Tessere <strong>di</strong> principi <strong>di</strong> Casa Savoia relative ai<br />
loro antichi Stati, Torino, 1879. Il Sig. van Gennep aggiunge, alla<br />
lista dei personaggi <strong>di</strong> cui Promis ha pubblicato i gettoni, due<br />
arcivescovi <strong>di</strong> Lione, una regina <strong>di</strong> Francia, una duchessa <strong>di</strong> Savoia,<br />
alcuni zecchieri e membri della Corte dei Conti <strong>di</strong> Ciamberì. Ben<br />
a ragione, l'A. osserva essere probabile che esistano ancora altri<br />
pezzi interessanti, <strong>di</strong>sseminati qua e là nelle collezioni, ed esprime<br />
la speranza che forse questo primo supplemento possa far decidere<br />
i possessori <strong>di</strong> quei pezzi a darne la descrizione ed il <strong>di</strong>segno]. —<br />
Mowat {Robert), Combinaisons secrètes de lettres dans les marques<br />
monétaires de l'Empire Romain [La prima parte <strong>di</strong> quest'ingegnosa<br />
ricerca intorno ai contrassegni adoperati nelle zecche imperiali<br />
romane. Il punto <strong>di</strong> partenza per il sig. Mowat è lo stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> A.<br />
de Longpérier sulle officine della Tetrarchia <strong>di</strong> Diocleziano, conti-<br />
nuato poi dal Kolb nella Num. Zeitschrift <strong>di</strong> Vienna. Ma ai risul-<br />
tati già acquisiti da quegl' indagatori, <strong>com</strong>e anche dal Dott. Missong<br />
per le monete <strong>di</strong> Probo, l'A. aggiunge del proprio osservazioni<br />
acutissime e sorprendenti, <strong>com</strong>e quella che le lettere A, E, Q, V, 1,<br />
T, I, sparse ed intercalate nei segni monetarii <strong>di</strong> Probo, potreb-<br />
bero in<strong>di</strong>care riunite uno dei nomi <strong>di</strong> quell' imperatore, poiché questi<br />
si chiamava appunto anche Equitius o Aequitius]. — La Tour [H.<br />
de), Médailles modernes récemment acquises par le Cabinet de<br />
France [Continuazione]. — Mélanges et documents. — Chronique<br />
(Ripostigli. — Corso libero <strong>di</strong> Numismatica greca, professato da<br />
Teodoro Reinach alla Sorbona. — Casette nuntismatique frangaise],<br />
— Necrologie [La Sig."'* Matilde F"riedlander, <strong>di</strong> Gotemburgo nella<br />
Svezia, m. a Parigi il 17 <strong>di</strong>e. 1896. De<strong>di</strong>catasi alla Numismatica,<br />
aveva acquistato una grande conoscenza pratica delle monete, par-<br />
ticolarmente orientali. Di queste, lascia una pregevole raccolta <strong>di</strong><br />
circa 8000 pezzi. La Sig."^ Friedlander possedeva inoltre una bella<br />
serie <strong>di</strong> monete svedesi]. — Bulletin bibliographique [Lavoix: Ca-
BIBLIOGRAFIA 247<br />
talogue des ntonnaies musulmanes de la Bibliothèque Nattonale. —<br />
Ambrosoli: Vocabolarietto pei numismatici, in 7 lingue], — Procèsverbaux<br />
des séances de la Société Frangaise de Numismatique. —<br />
2 tav.<br />
Gazette numismatique frangaise, <strong>di</strong>rigée par Fernand Maze-<br />
roUe et é<strong>di</strong>tée par Raymond Serrure. Rédactìon et Administration :<br />
53,<br />
rue de Richelieu, Paris.<br />
1897. — I""^ livraison.<br />
A nos lecteurs [Programma. La Gazette si occuperà anche della<br />
Numismatica <strong>italiana</strong> in quanto si riannoda alla Numismatica fran-<br />
cese, e così delle monete dei Normanni, degli Angioini, <strong>di</strong> Carlo Vili,<br />
<strong>di</strong> Lodovico XII, <strong>di</strong> Francesco I, e della monetazione napoleonica].<br />
— F. Mazerolle, J.-C. Chaplain, membre de l'Institut. Biographie<br />
et catalogne de son ceuvre [Con uno splen<strong>di</strong>do ritratto e con bel-<br />
lissime tav. <strong>di</strong> medaglie in fototipia]. — Pinette [Paul], Le trésor<br />
de Bourgneuf. Monnaies Carolingiennes [Con figure nel testo e<br />
tavola in fotot.] — Vé<strong>di</strong>e {Georges), La trouvaille d'Évreux. Monnaies<br />
de Philippe VI, de Jean le Bon et de Charles le Mauvais<br />
[Con figure nel testo]. — Sambon {Arthur), Les monnaies d'argent<br />
frappées en 1460 par ordre du due d'Anjou et du prince de Tarente<br />
dans le Royaume de Naples et le monnayage frauduleux de Fer<strong>di</strong>nand<br />
I^r d'Aragon [Con figure nel testo]. — Serrure [R.), Contri-<br />
butions à la numismatique tournaisienne [Con fig. nel testo, e con<br />
una tav. in fotot. che riproduce una curiosa medaglia ine<strong>di</strong>ta del<br />
Gabinetto <strong>di</strong> Parigi]. — Denise (H.), Les monnaies de nickel en<br />
France et à l'étranger. I. Le nickel à l'étranger [Con figure nel<br />
testo, e con una tav. in fotot.]. — Engel (A.), Comptes rendus:<br />
Die Munzen v. Frankfurt a. Main, par E. Fellner et P. Joseph.<br />
— Mazerolle (F.), Chronique artistique. — Denise (//.), Chronique<br />
monétaire. — Ambrosoli (S.), Correspondance italienne [La <strong>Rivista</strong><br />
Ital. <strong>di</strong> Numismatica. — La Società Numism. Ital. — Fremii Pa-<br />
padopoli e Gnecchi. — Premio Grazioli presso l'Accademia <strong>di</strong> Belle<br />
Arti in Milano, per l'incisione delle medaglie. — II R. Gabinetto<br />
Numism. <strong>di</strong> Brera. — Ripostigli scoperti durante l' anno 1896.<br />
— Necrologie : Giuseppe Fiorelli, Umberto Rossi]. — Nouvelle^<br />
<strong>di</strong>verses.<br />
[N. B. — Questa prima <strong>di</strong>spensa della Gazette sarà spe<strong>di</strong>ta alle<br />
persone che ne faranno domanda, contro pagamento <strong>di</strong> 5 franchi. Le<br />
<strong>di</strong>spense successive non saranno poste in ven<strong>di</strong>ta separatamente].<br />
^
248<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
BuLLETiN DE NaMtSMATiQUE. Pubblicato da Raimondo Serrure in<br />
Parigi. — Voi. Ili, <strong>di</strong>sp. io, luglio 1896.<br />
Comte de Castellane, Les premìers écus à la couronne fabriqués<br />
à Poitiers, — Mazerolle (F.), Dispute entre les ouvriers de la<br />
Monnaie de Paris et Jean Beaucousin, tailleur, au sujet de la<br />
fourniture des coins nécessaires pour fabriquer les pièces de six<br />
et de trois blancs, 13 juin 1583. — Livres nouveaux. — Revue des<br />
Revues. — Lectures <strong>di</strong>verses. — Livres en préparation. — Acadé-<br />
mies et Sociétés. — Les musées. — Les trouvailles. — Les nou-<br />
velles émissions. — Les ventes [Collezione Montagu]. — Necrologie.<br />
Disp. II, settembre 1896,<br />
Comte de Castellane, Fontenay-le-Corate, atelier de Charles VII,<br />
régent, puis roi, entre 1420 et 1430. — Serrure (R.), La collection<br />
Lefèvre van den Berghe. — Livres nouveaux — Revue des Revues.<br />
— Lectures <strong>di</strong>verses [Vitalini: Un nuovo grosso ine<strong>di</strong>to <strong>di</strong> Gio. Antonio<br />
Falletti, conte <strong>di</strong> Benevello]. — Livres en préparation. — Les<br />
sociétés savantes. — Les musées. — Les expositions. — Les trou-<br />
vailles [Ripostiglio <strong>di</strong> Bondeno]. — Les ventes. — Necrologie. — i tav.<br />
Disp. 12, novembre 1896,<br />
Comte de Castellane, Les écus à la couronne au type accoste<br />
de deux fleurs de lis couronnés, fabriqués à Romans de 1435 à<br />
1445. — Zay [E.], Numismatique franco-africaine. — Livres nouveaux.<br />
— Revue des Revues. — Lectures <strong>di</strong>verses. — Académies<br />
et Sociétés. — Les trouvailles, — Les nouvelles émissions. — Les<br />
ventes. — Necrologie [A, Boutkow^ski].<br />
Voi. IV, <strong>di</strong>sp. I, gennaio 1897.<br />
Comte de Castellane, Denier blanc de Charles V au K couronne,<br />
frappé à Limoges, — Raimbault {Maurice), Les faux louis de La<br />
Rochelle. — Richebé (R.), Médailles à retrouver. — Un procès. —<br />
La plus ancienne monnaie féodale d'Anvers. — Livres nouveaux.<br />
— Revue des Revues. — Lectures <strong>di</strong>verses. — Publications<br />
annoncées [La Gazette numismatique francaise]. — Académies et<br />
Sociétés. — Les musées. — Les trouvailles. — Les ventes. —<br />
Necrologie.<br />
Disp. 2, febbraio 1897.<br />
Gillard {Henri), Le trésor du Poiré de Velluire (Vendée). —<br />
Serrure (/?.), Jetons rares ou iné<strong>di</strong>ts. — Livres nouveaux [Ambro-
BIBLIOGRAFIA 249<br />
soli: Vocabolarietto pei numismatici]. — Revue des Revues. —<br />
Lectures <strong>di</strong>verses. — Publications annoncées. — Académies et So-<br />
ciétés. — Les musées. — Les trouvailles. — Les nouvelles émissions.<br />
— Les ventes. — Necrologie. — 2 tav.<br />
Dlsp. 3, marzo 1897.<br />
Sambon {Arthur), Monnaies iné<strong>di</strong>tes de l'Italie meri<strong>di</strong>onale:<br />
[Denier iné<strong>di</strong>t de Louis II, empereur, et Adelchis, prince de Béné-<br />
vent (866). — Denier iné<strong>di</strong>t de Guaimar I, prince de Salerne (880-<br />
901). — Les tarins d'Amalfi. — La réforme du billon napolitain<br />
par Charles II et les pontifes Martin IV et Honorius IV. — Ducat<br />
napolitain de Fer<strong>di</strong>nand le Catholique et Isabelle de Castille, frappé<br />
en 1503 par le <strong>com</strong>te Jean-Charles Tramontano]. — Zay (E.), Au<br />
colonies: ce que coùte la copie d'un document historique. — Livres<br />
nouveaux \Numismatique francaise : Catalogue-guide illustre de<br />
l'amateur. Deuxiéme partie, Monnaies féodales et provinciales de<br />
France et de VOrient latin\. — Revue des Revues. — Lectures<br />
<strong>di</strong>verses. — Académies et Sociétés [Le riunioni della Société<br />
francaise de Numisntatique\.<br />
Disp. 4, aprile-maggio 1897,<br />
R. S., La Monnaie de Luxembourg sous Philippe II, roi d'Espa-<br />
gne. — Lo stesso, Le voi au jeton. — Zay (E.), Une facétie de<br />
graveur. — Livres nouveaux. — Revue des Revues. — Lectures<br />
<strong>di</strong>verses. — Académies et Sociétés [Premio AUier de Hauteroche,<br />
conferito al nostro eh. collega Blanchet pei suoi lavori <strong>di</strong> Numisma-<br />
tica antica, e in particolare pei suoi due volumi <strong>di</strong> volgarizzazione:<br />
Les Monnaies grecques e Les Monnaies romaines. — Concorso<br />
Gnecchi per la Numismatica classica. — Comitato internazionale<br />
per offrire un ricordo al Sig. G. Cumontj. — Les expositions. —<br />
Les musées [Cre<strong>di</strong>to <strong>di</strong> 420,000 franchi, chiesto alla <strong>com</strong>missione<br />
del bilancio per acquistare pel Gabinetto Numismatico <strong>di</strong> Parigi la<br />
Collez. Wad<strong>di</strong>ngton, <strong>di</strong> monete greche]. — Nouvelles émissions, —<br />
Les trouvailles. — Les ventes [Ven<strong>di</strong>ta della Collez. Sambon in<br />
Milano, coi prezzi principali raggiunti]. — Necrologie,<br />
Revue suisse de Numismatique (Dir. Paul-Ch. Stroehlin). — Tome<br />
VI, seconde livraison. — Genève, 1897.<br />
Imhoof- Blumer (F.), Zur Munzkunde Kleinasiens [Continuaz.j,<br />
— Vallentin {Roger), De la carne et de la demi-carne, - De<br />
JVitte {A.y, Une lettre inè<strong>di</strong>te de Charles-Norbert Roéttiers, gra-<br />
33
250<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
veur general des monnaies de France, à Jacques Roèttiers, graveur<br />
general aux Pays-Bas autrichiens. — A. C, L'ancienne monnaie<br />
genevoise pendant la période fran^aise (1798-1813). — L. C, Das<br />
kleinste Bank-Billet der Schweiz. — Médailles suisses nouvelles (V).<br />
— Mélanges. — Société suìsse de Numismatique [Necrol. del Conte<br />
Tarqu. Gentili <strong>di</strong> Rovellone]. — 4 tav.<br />
La Circulaire numismatique universelle. Pubblicata da Paolo<br />
Stroehlin a Ginevra.<br />
N, 18, febbraio 1897.<br />
[Con questo numero, — ed esponendone francamente i motivi<br />
in una spiritosa <strong>com</strong>unicazione « ai clienti ed ai lettori », — la<br />
interessante Circulaire sospende le proprie pubblicazioni, lasciando<br />
vivo rimpianto <strong>di</strong> sé in quanti ne apprezzavano la non lieve utilità<br />
pratica e l'esattezza].<br />
Revue Belge de Numismatique. — Bruxelles, 1897, première livraison.<br />
Blanchet {J.-Adrien), Monnaies en or des empereurs Trébonien<br />
Galle et Volusien. — V'^ B. de Jonghe, Monnaies de Reckheim.<br />
— O^ de Limburg-Stirum, Monnaies des <strong>com</strong>tes de Limburg-sur-<br />
la-Lenne [terzo art.]. — Alvin [Fred.), Sous tapés et sous marqués.<br />
— De Witte {A.), Les pièces d'or et d'argent à l'effigie de l'em-<br />
pereur Francois I^"", frappées à Anvers, en 1751. — Picqué {Cam),<br />
La médaille de Geneviève d'Urfé, duchesse de Croy. — Maxe-<br />
Werly (Z,.), Notes sur quelques plateaux de balance. — Mélanges.<br />
— Société Royale de Numismatique: Extraits des procès-verbaux.<br />
— 6 tav.<br />
1897, deuxième livraison.<br />
Bahrfeldt (M.), Les deniers consulaires restitués par Trajan.<br />
— De Witte {A.), Les jetons et les médailles d'inauguration frappés<br />
par ordre du gouvernement general aux Pays-Bas autrichiens (1717-<br />
1792). — De Meunynck {A.), Médailles de l'école des Beaux-Arts<br />
de la ville de Lille et origines de cet établissement. — Rouyer (/.),<br />
Le nom de Jesus employé <strong>com</strong>me type sur les monuments numis-<br />
matiques du XV siècle, principalement en France et dans les pays<br />
voisins [terzo articolo]. — V'^ B. de Jonghe, Un sceau de Burckard,<br />
seigneur de Fénestrange ou Vinstingen. — Necrologie [Le <strong>com</strong>te<br />
Tarquin Gentili <strong>di</strong> Rovellone, par M. le V'e B. de Jonghe]. —<br />
Mélanges. — 3 tav.
BIBLIOGRAFIA 25 1<br />
TlJDSCHRIFT VAN HET NeDERLANDSCH GeNOOTSCHAP VOOR MuNT- EN<br />
Penningkunde. — Amsterdam.<br />
5 anno (1897), fase. I.<br />
De IVtite (A.), Le jeton dans les <strong>com</strong>ptes des maitres des<br />
monnaies du duché de Brabant aux XVII^ et XVlIIe siècies [Continuazione].<br />
— Mej. M. de Man, De oorsprong der zilveren Manen.<br />
— D. C, Paulus van Vianen. — ^. S., Eenige opmerkingen naar<br />
aanlei<strong>di</strong>ng van de 's-Hertogenbossche Geefhuispenningen. — IV. S.,<br />
Eeenige opmerkingen omtrent de 's-Hertogenbossche Brandspuitpenningen.<br />
— Inhoudsopgave der Tijdschriften <strong>di</strong>e het Genootschap<br />
in ruiling ontvangt. — Gemengde berichten.<br />
Fase. II, 1897.<br />
Roest {Th. M.), Les monnaies des seigneurs de Bronehorst-<br />
Batenbourg. — Mej. M. de Man, Penningen van het St. Lucia- of<br />
Bakkerinnegilde te Zierikzee. — Snoeck [M. A.), Bijdragen tot de<br />
Penningkunde van Noord-Brabant. — Zwierzina {W. K. F.),<br />
Besehrijving der Medailles sedert 23 November 1890 tot i Januari<br />
1897 geslagen aan de Kon. Fabriek van Zilverwerken, firma C. J.<br />
Begeer te Utrecht. — D. C, In memoriam Mr. G. J. Th. Beelaerts<br />
van Blokland. — In memoriam M. W. J. Royaards van den Ham.<br />
— Inhoudsopgave der Tijdschriften <strong>di</strong>e het Genootschap in ruiling<br />
ontvangt. — Gemengde berichten. — 2 tav.<br />
Zeitschrift fììr Numismatik, herausgegeben von Alfred von Sallet.<br />
— XX Band. Heft 3 und 4. — Berlin, Weidmannsche Buch-<br />
handlung, 1897.<br />
Quilling (F.), Ausgewahlte ròmische Miinzen und Medaillen<br />
der stadtischen Munzsammlung in Frankfurt a. M. — Sallet (A. v.),<br />
Silbermiinze eines baktrischen Kònigs Antiochus. — Pernice (E.),<br />
Ueber den Wert der monumentalen und litterarischen Quellen an-<br />
tiker Metrologie. — Seltmann {E. /.), Une<strong>di</strong>rte ròmische Kaiser-<br />
mtinzen. — Imhóof-Blumer (F.), Zur Miinzkunde des Pontos, von<br />
Paphlagonien, Tenedos, Aiolis und Lesbos. — Gaebler (//.), Zur<br />
Munzkunde Makedoniens. II. — Buchenau (//.), Die àltesten Munzen<br />
der Grafen von Katzenelenbogen. — Mailer (L.), Fin Ansba-<br />
cher Schilling des Markgrafen Albrecht Achilles von Brandenburg.<br />
— Koetschau (K.), Die Medaille auf Degenhard Pfefflnger. —<br />
Kleinere Mittheilungen. — Literatur. — Nekrologe. — Register. —<br />
Sitzungsberichte der Numismatischen Gesellschaft zu Berlin, 1896.<br />
— 5 tavole.
252<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
NuMisMATiscHE Zeitschrift, herausgegeben von der Numismatischen<br />
Gesellschaft in Wien.<br />
XXVIII Band, Jahrgang 1896.<br />
Bahrfeldt (M.), Nachtrage imd Berichtigungen zur Munzkunde<br />
der ròmischen Republik. — Seeck (Otto), Sesterz und Follis. —<br />
Belhdzy {Johann), Die Wiener Mark vor 1694 und <strong>di</strong>e Wiener<br />
Pfenninge im XIV. Jahrhundert. — Fiala (Eduard), Zutheilungen<br />
an bòhmische Munzmeister und Munzstatten. — Fiala (Ed.) ,<br />
Verschiedenes aus der Haller Munzstatte. — Schalk {Dr. Cari),<br />
Der Wiener Munzverkehr vom Jahre 1650 bis zum Jahre 1750. —<br />
Fiala {Ed), Die Beamten und Angehòrigen der Prager Munzstatte<br />
1626-1700. — Ernst [C. von), Die Miinzbuchstaben S. F., T. S.,<br />
F. S. auf Thalern der Kaiserin Maria Theresia mit der Jahreszahl<br />
1780. — Numismatisciie Litteratur [<strong>Rivista</strong> <strong>di</strong> Storia antica e Scienze<br />
<strong>affini</strong>^ Messina, 1895-96]. — Jahresbericht der Numismatischen<br />
Gesellschaft. — 14 tav.<br />
MONATSBLATT DER NuMISMATISCHEN GeSELLSCHAFT IN WlEN.<br />
N. 162, gennaio 1897.<br />
Voetter [Otto), Anfange der Antoniniane. — Versammking der<br />
numism. Gesellschaft am 16. Dee. 1896. — Vermehrung der Miinzensammlung.<br />
— Besprechungen. — Literatur. — Verschiedenes.<br />
N. 163, febbraio 1897.<br />
Ernst [Karl R. v.), Medaillen aus nicht gewohnlichen oder<br />
seltenen Metallen. — Maser [D/ L. Karl), Miinzenfunde [Ripostiglio<br />
<strong>di</strong> Dignano presso Pola]. — Jahresversammlung der numism. Ge-<br />
sellsch. V. 27. Jann. 1897. — Besprechungen [Ambrosoli: Vocabola-<br />
rietto pei numismatici]. — Literatur. — Verschiedenes.<br />
N. 164, marzo 1897.<br />
Ernst (Karl R. v.), Medaillen aus nicht gewohnlichen oder<br />
seltenen Metallen [Continuaz. e fine]. — Kenner (Fr.), Zur Ge-<br />
schichte der Medaille [Le medaglie italiane del Rinascimento ;<br />
articolo assai importante]. — Domanig (D.'' Karl), Der Fund von<br />
Arbesbach. — Versamml. d. numism. Gesellschaft am 24 Febr. 1897^<br />
— Besprechungen. — Literatur. — Verschiedenes. — i tav.<br />
N. 165, aprile 1897.<br />
Kenner, Zur Geschichte der Medaille [Continuazione]. — Miinzenfunde.<br />
— Ord. Versamml. d. Num. Ges. am 17. Marz 1897. —
BIBLIOGRAFIA 353<br />
Vermehrung der Miinzensammlung. — Besprechungen. — Numism.<br />
Literatur. — Verschiedenes [Medaglia per il monumento a Dante<br />
in Trento].<br />
N. i66, maggio 1897.<br />
Kttbitschek, Ein spates Zeugnis der Sesterzenrechnung. —<br />
Kemier, Zur Geschichte der Medaille [Continuazione]. — Rhode<br />
{Theodor), Eine òsterreichisch-franzòsische Goldnitinze [Prova <strong>di</strong><br />
zecca d'un pezzo in oro da io fiorini = 25 franchi, all'effigie d<br />
Napoleone III, coniato a Parigi nel 1867]. — Hollschek, Schatz<br />
fund in Harmanitz. — « Concorso <strong>di</strong> Numismatica classica » [Con<br />
corso Gnecchi, colle con<strong>di</strong>zioni in extenso]. — Versamml. d. numism<br />
Gesellsch. am 7. Aprii 1897 [Interessante conferenza del <strong>di</strong>stinto<br />
artista Prof. Stefano Schwartz sulle placchette con ritratti eseguiti<br />
a sbalzo]. — Besprechungen. — Literatur. — Verschiedenes [La<br />
quarta serie della Revue numismatique <strong>di</strong> Parigi].<br />
N. 167, giugno 1897.<br />
Kenner, Zur Geschichte der Medaille [Continuazione]. — Renyier<br />
{V. v.), Bericht des Comités fur <strong>di</strong>e unterrichtliche Verwendung<br />
der Miinzenkunde an den òsterreichischen Mittelschuien [Re-<br />
lazione del <strong>com</strong>itato per l'utilizzazione della Numismatica nell'in-<br />
segnamento presso le scuole secondarie austriache]. — Versamml,<br />
d. numism. Gesellsch. am 26 Mai 1897. — Besprechungen. — Lite-<br />
ratur. — Verschiedenes [Per il 60""° <strong>com</strong>pleanno del medaglista<br />
viennese Giuseppe Tautenhayn; con riproduz. <strong>di</strong> alcune sue me-<br />
daglie e placchette].<br />
The Numismatic Chronicle and Journal of the Numismatic Society.<br />
— London.<br />
1896. - Part II.<br />
Wroth ( Warwick), Greek Coins acquired by the British Museum<br />
in 1895. — Evans {Arthur J.), Contributions to Sicilian Numismatics.<br />
— Macdonald {George), Notes on Combe' s Catalogue of the Hunter<br />
Cabinet. — White King (Z,.) and Fos/ ( /^/7//aw), Some Novelties<br />
in Moghal Coins. — Miscellanea. — 6 tav.<br />
1896. — Part III.<br />
Macdonald {George), On a Find made in the Lipari Islanda,<br />
inclu<strong>di</strong>ng an Unpublished Coin of Rhegium. — Evans {Sir John),<br />
Roman Coins found at Brickendonbury, Hertford. — Bagnali-
254<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
Oakeley (Mrs), A Hoard of Roman Coins found at Bishop's Wood,<br />
Ross-on-Wye. — Pritchard {John £".), Notes on a Find of Roman<br />
Coins near Cadbury Camp (Clevedon), Somersetshire. — Rapson<br />
{E. J.), On the Attribution of Certain Silver Coins of Sassanian<br />
Fabric. — Sandeman {J. G.), On the Bezant of James I. — Weber<br />
(F. P.), " Perkins School-Tokens » of the Seventeenth Century.<br />
— Miscellanea. — 2 tav.<br />
1896. — Part IV.<br />
White King (L.), History and Coinage of the Barakzai Dynasty<br />
of Afghanistan. — Notices of Recent Numismatic Publications. —<br />
Miscellanea. — Procee<strong>di</strong>ngs of the Numismatic Society: Session<br />
1 895-1 896. — 2 tav.<br />
1897. Part I.<br />
Seltmann {E. /.), Supposed signs of value on early coins of<br />
Himera. — Hill [G. F.), Oinoanda: a new Greek mint. — Lambros<br />
ij. P.). On a coin of Hierapytna, in Crete, hitherto wrongly attributed.<br />
— Montagu (The late H.), Rare and unpubiished Roman<br />
gold coins in my Collection. — Miscellanea. — 2 tav.<br />
MoNTHLY Numismatic Circular. Pubblicata da Spink e figlio, Londra.<br />
N. 50, gennaio 1897.<br />
Hands (A. W.), Chats on Roman Coins with Young Collectors<br />
[Continuazione]. — A Variety in Henry VI, Nobles. — A Remarkable<br />
Coin. — Gnecchi {Frane), Legends on Roman Coins. —<br />
Huth (Reg.), Exact Weights of Spanish Dollars. — Another Bri-<br />
stol Trader's Token. — Sales (The Montagu Sale of English Coins,<br />
Third Portion). — Obituary (A. Boutkowski). — Catalogne of Coins<br />
and Medals for Sale. — Advertisement, Notices, &c.<br />
N. 51, febbraio 1897.<br />
IVebster, The unique Juxon Medal of Charles I***. — Hands,<br />
Chats on Roman Coins &c. [Continuazione]. — Bagnall-Oakeley<br />
{Mary E.), Roman Coins found in the Forest of Dean (Part III). —<br />
Yelland {Al/. C. W.\ Australian Tokens. — IVaters {Arthur JV.),<br />
A Curios Blundered Bronze Coin. — Pièce de deux francs de la<br />
<strong>com</strong>mune libre de Moresnet. — La médaille de l'Exposition natio-<br />
naie suisse à Genève, 1896. — Varia (Austro-Hungarian Currency;<br />
— Chinese Currency). — Correspondence. — Numismatic Societies.<br />
— Numismatic Books, Magazines, Catalogues, &c. — Finds. — Cata-<br />
logue of Coins and Med. for Sale. — Advertisements, Notices, &c.
BIBLIOGRAFIA 255<br />
American Journal of Numismatics. — Boston.<br />
N. 155, anno 1897.<br />
Crosby (S. S.), The Cents of 1793. — Commemorative Medal,<br />
Ancient and Honorable Artillery Company, — Bastow {J. W.),<br />
Spanish American Coinage, Mexico. — McLachlan (R. IV.), L'Arbre<br />
Croche In<strong>di</strong>ans. — Storer {H. R.), The Medals, Jetons and<br />
Tokens Illustrative of the Science of Me<strong>di</strong>cine. — Red Jacket Me-<br />
dals. — Marvin {W. T. R.), Masonic Medals. — Obituary: Ale-<br />
xander Boutkowski. C. H. Wright. — Tntnian {T. Charles), To an<br />
Old Coin [Sonetto]. — Medal of St. Luke's Hospital, New York.<br />
— Notes and Queries. — E<strong>di</strong>torial. — 2 tav.<br />
S. A.<br />
Atti e memorie della R. Deputazione <strong>di</strong> storia patria per le Pro-<br />
vincie <strong>di</strong> Romagna, Serie 3% voi. XIV, fase. IV-VI, 1896-97 : Salvioni<br />
G. B., Sul valore della lira bolognese. [I. La zecca <strong>di</strong> Bologna nel 1291;<br />
II. La zecca nel 1296; III. I " Veneziani <strong>di</strong> rassa „ nel 1305; IV. Il va-<br />
lore in oro della lira bolognese dal 1264 sino alla coniazione del fiorino<br />
d'oro in Bologna, 1380].<br />
Rassegna nazionale, i° giugno 1897: Rossi Aless., Le fasi attuali<br />
dell'argento.<br />
BuLLETTiNo della Commissione Archeologica <strong>com</strong>unale <strong>di</strong> Roma,<br />
gennaio-marzo 1897, f^sc. I, a. XXV: Serafini Camillo, L'arte nei ritratti<br />
della Moneta Romana Repubblicana. Con i tavola.<br />
Archivio storico romano, voi. XIX, fase. III-IV, 1896: Capobianchi<br />
V., Le immagini simboliche e gli stemmi <strong>di</strong> Roma.<br />
Ren<strong>di</strong>conti R. Accademia dei Lincei, s. V, voi. VI, fase. I, 1897:<br />
Garufi dott. A,, Di una monetazione imperiale <strong>di</strong> Federico II transitoria<br />
fra' Tari e gli Augustali.<br />
Illustrazione <strong>italiana</strong>, n. 5, 1897: La medaglia d'onore ad Edoardo<br />
Compans de Brichanteau.<br />
L'Economista, 13 <strong>di</strong>e. 1896: La coniazione delle monete al Giappone.<br />
Nuova Antologia, 16 giugno 1897 [Ambrosoli, Vocabolarietto pei<br />
numismatici].<br />
Chronique des arts^ n. 31, 1896, e n. i, 1897: Les médailles <strong>com</strong>mémoratives<br />
de la visite du Tsar. — Les monnaies de la collection<br />
Montagne.<br />
Bulletin de correspondance hellénique, 1896, gennaio-novembre:<br />
Svoronos, La numismatique de Delphes. — Reinach Th., Observations<br />
sur le système monétaire delphique du IV siècle.<br />
La Science sociale, t. XXIII, fase. V, 1897 : Babelon E., De l'utilité<br />
scientifique des collections de monnaies anciennes.
256<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
Revue des arts décoratifs, mai 1897: S. de Vaire, Nouvelles monnaies<br />
de MM. Roty et D. Dupuis.<br />
Gazette des beaux-arts, 1° giugno 1897: Schéfer Gaston, Le due<br />
d'Aumale [con 2 medaglie del duca e del castello <strong>di</strong> Chantilly].<br />
BuLLETiN de la Société des sciences historiques de l'Yonne, année<br />
1896, voi. LVI: Ed. de Luze, La CoUection Gariel : les monnaies des<br />
ducs de Bourgogne.<br />
Société de l'histoire de Paris, Bulletin, 1897, ^ivr. I: Prou M., Les<br />
monnaies de Rouchard, <strong>com</strong>te de Paris.<br />
Bulletin historique de l'Auvergne, 1896, n. 9-10: Dourif à.^, Notes<br />
numismatiques.<br />
Gazette des Beaux-arts, 1" novembre 1896: Mazerolle F., Visites<br />
de Pierre le Grand et de Nicolas II à la Monnaie des Médailles.<br />
Notes d'art et d'archeologie, gennaio 1897: C Clair, Les jetons<br />
fran9ais.<br />
Le Monde Illustre, 13 febbr. 1897: Noseroy N., Nouvelles monnaies.<br />
Tour du Monde, 12 <strong>di</strong>cembre 1896: /. B., Pour voyager à Madagascar<br />
(lexique franco-malgache; monnaies de Madagascar).<br />
Société nationale des Antiquaires de Frange, séance du 23 décembre<br />
1896 et du 6 janvier: Mowat, Communication relative aux lettres<br />
secrètes employées par les monétaires romains de l'epoque imperiale.<br />
— Babelon, Sur un médaillon d'or à l'effigie de Gallien et de Salonine.<br />
Mémoires de la Société nationale d'agriculture, sciences et arts<br />
d'Angers, t. IX, pag. 228-458: PlanchenaiiU Adrien, La monnaie d'Angers.<br />
Origine — La monnaie royale (1319-1738) — La juris<strong>di</strong>ction de la<br />
monnaie jusqu'en 1791.<br />
Revue de Gascogne, <strong>di</strong>cembre 1896: Carsalade du Pont 1. de, Un<br />
trésorier du Fezensaguet au XIV® siede.<br />
Revue des 2 mondes, 15 novembre 1896: Lévy R. G., Evolution<br />
monétaire.<br />
Revue catholique des Revues, 5 novembre 1896: Le bimétallisme<br />
International (Revue politique et parlementaire).<br />
Revue archéologique, nov.-<strong>di</strong>cembre 1896: Furtwaengler A., Note<br />
sur une monnaie de Trézène.<br />
Memorial <strong>di</strong>plomatique, 28 mars 1897 '•<br />
^-<br />
Molina, La réforme<br />
monétaire en Russie.<br />
La nature, 27 février 1897: Leroy M., La frappe d'une médaille.<br />
L'Univers et le Monde, 28 avril 1897: E. Tavernier, A quoi peut<br />
servir une collection de médailles.<br />
AssociATioN Catholique, avril 1897; Savatier //.^Théorie de la valeur.<br />
Le Figaro, 27 avril 1897: M. Talmeyr, La Tranche (des pièces de<br />
monnaie),<br />
CoMPTE Rendu de l'Académie des sciences morales et politiques,<br />
novembre 1896: luglar C, Rapport sur le concours pour le prix Rossi,<br />
à décerner en 1896. Du rapport de valeur entre les deux métaux servant<br />
de monnaie, et notamment de la possibilité pour les gouverne-
BIBLIOGRAFIA 257<br />
ments de maintenir entre les <strong>di</strong>vers métaux servant de monnaie un<br />
rapport de valeur autre que celui résultant de l'offre et de la demande.<br />
Deutsches Wochenblatt, n. 11-12, 1897: Kardorff-Wabnitz W. voit..<br />
Die japanische Goldwahrung.<br />
Globus, 71 Bd, n. 13- 15: Gótze, Die trojanischen Silberbarren der<br />
Schliemann-Sammlungen. (Ein Beitrag zur Urgeschichte des Geldes).<br />
Mit Abblgn.<br />
Die Umschau, a. I, n. 15, 1897 ^ prec. : Lhlers O., Das Geld.<br />
Deutsche Rundschau, giugno 1897: Seeck Otto., Die Entstehung<br />
des Geldes.<br />
Iahrbuch fiir Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirth-schaft im<br />
deutschen Reich, Jahrg. XXI, 1897; Helfferich Karl., Aussenhandel und<br />
Valutaschwankungen.<br />
Heral<strong>di</strong>sche Mittheilungen V. Kleeblatt, n. 5: Zur Munzgeschichte<br />
der Stadt Hannover.<br />
Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift, voi. VII, fase. I, 1896:<br />
Friedensburg, Stu<strong>di</strong>en iiber Schlesische Milnzen.<br />
JahrbQcher des Vereins ftir Meklenburgische Geschichte u. Alterthumskunde,<br />
Jahrg. LXI, 1896: Oertzeu, Miinzenfund in Mamerow.<br />
Westdeutsche Zeitschrift fììr Geschichte und Kunst XV, 1896,<br />
fase. 3: Ritterling E., Romischer Miinzfund in Marienfels.<br />
Historisches Jahrbuch, (Gòrres), voi. XVIII, fase. I: Sàgmùller,<br />
Der Schatz Johannes XXII.<br />
Zeitschrift ftìr Social u. Wirthschaftsgeschichte, voi. V, fase. III,<br />
Weimar, 1897<br />
von Troyes ans dem 13 Jahrhundert.<br />
• Schaube A., Ein italienischer Coursbericht von der Messe<br />
Anzeiger des germanischen National-Museums, 1896, n. 5: K. Sch,<br />
Die Sammlung Niirenbergischer Milnzen des Freiherrn J. Ch. S. von Kress.<br />
Sitzungsberichte dell'Accademia <strong>di</strong> Monaco, 1896, fase. Ili, (sex.<br />
storica): Riggauer, Joh. B. Fickler als Numismatiker.<br />
Sitzungsberichte dell'Accademia <strong>di</strong> Monaco (sez. storico-filosofica)<br />
1896, fase. 4: Riggauer, Uber Munzen des Hauses Wittelsbach.<br />
Bayerische Gewerbe-Zeitung 1897, n. 1-3 : Hampe d/ Th., Ein neues<br />
oesterreichisches Medaillenwerk.<br />
Zeitschrift des bayerischen Kunst-Gewerbe-Vereins in Mtìnchen,<br />
1897, fase. MI e III: Habich G., Moderne Medaillenkunst.<br />
Der Formenschatz, (L'Art pratique), fase. II, tav. n. 19 e fase. Ili,<br />
tav. n. 41: Médailles italiennes du XV siede et du XVI siècle — Me-<br />
dailles de Jean Reinhart m.édailleur (Médailles de Charles V et Fer<strong>di</strong>nand!).<br />
33
258<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
Die Zukunft, n. 30, 1897: Kleinwdchter Friedr, Die Valuta-Reform in<br />
Oesterreich-Ungarn.<br />
Carinthia, LXXXVI, n. 1-6, 1896: Hauser, Keltische Miinzen.<br />
Archaeologisch- Epigraphische Mittheilungen aus Oesterreich-<br />
Ungarn, XIX, 2, 1896: Groag Edmund, Patricier und III viri monetales.<br />
Annales du Cercle archéologique d'Enghien, IV, livr. 4: Cumont<br />
G., La trouvaille numismatique de Saint-Pierre-Cliapelle. — Decleve I.,<br />
Biographie de Renier Chalon.<br />
Bulletin de l'Académie d'archeologie de Belgique, 1896, XXVII:<br />
A. de IVitte, Le développement de la science numismatique en Belgique<br />
de 1830 à 1895.<br />
Anzeiger fiir Schweizer. Altertumskunde, n. 1, 1897 : Stuckelberg E. A.,<br />
Die Agnus-Dei Medaillen.<br />
Bollettino storico della Svizzera Italiana, anno XIX, N. 3-5,<br />
marzo-maggio 1897<br />
: Ambrosoli S., Di un singolare cavallotto al tipo<br />
bellinzonese (riprod. dalla Riv. It. <strong>di</strong> Num.) — (Incopertina: Ambrosoli,<br />
Vocabolarietto).<br />
The Nation, 4 febbraio 1897: The bimetallic Reaction.<br />
The Forum, 1897, febbraio: Peffer W. A., The cure for a vicious<br />
monetary system.<br />
Journal of the Royal statistical society, ma^zo 1897: Atkinson<br />
F. J., Silver prices in Jn<strong>di</strong>a.<br />
Annals of the American Acad. of politic. and soc. science, IX, 2:<br />
Tiedemann C. C, Silver free Coinage and the legai Tender Decisions.<br />
The economic Journal, voi. VI, n. 24, London 1896: Miklaschevskyi,<br />
Monetary reform in Russia. — Jacobsen, Goid^ Silver and-silk trades in<br />
sixteenth century, Milan.<br />
Yale Review, novembre 1896: Walker A. F. et Farnam H. JV.,<br />
International Bimetallism.<br />
Magazine of art, maggio 1896: Lewis F. Day, La nuova moneta<br />
inglese.<br />
The contemporary Review, febbraio 1897 • Money and investments.<br />
Nationaloekonomisk Tidsskrift, n. 4, 1897 : Bisgaard H. L., L'avvenire<br />
del bimetallismo — L'America ed il sistema monetario.<br />
Revista de la Asociacion artistico-arqueologica Barcelonesa, ottobre<strong>di</strong>cembre<br />
1896: Berlonga R. de.^ Numismatica [il tesoro dei monti Gaetani,<br />
vicino a Malaga, marzo 1895].<br />
E. M.
VARIETÀ<br />
CONCORSO DI NUMISMATICA CLASSICA(')<br />
(N. 4).<br />
1. I fratelli Francesco ed Ercole Gnecchi offrono un premio<br />
<strong>di</strong> L. 1500 all'autore della Memoria o delle Memorie più<br />
importanti <strong>di</strong> Numismatica classica (greca o romana)<br />
che la <strong>Rivista</strong> Italiana <strong>di</strong> Numismatica avrà pubblicato<br />
nel triennio 1897 -1898- 1899.<br />
2. Il Concorso è aperto ai Numismatici d'ogni paese; ma le<br />
memorie dovranno essere presentate in italiano, in<br />
3.<br />
francese o in latino.<br />
I lavori potranno essere mandati alla Segreteria della<br />
Società Numismatica Italiana sia firmati che anonimi;<br />
in questo secondo caso dovranno esser ac<strong>com</strong>pagnati da<br />
busta suggellata, con un motto, <strong>com</strong>e <strong>di</strong> pratica. A tempo<br />
opportuno non sarà aperta che la scheda corrispondente<br />
al lavoro eventualmente premiato.<br />
4. Al Concorso sono ammessi tutti i lavori <strong>di</strong> Numismatica<br />
5.<br />
classica, pubblicati durante il triennio 1897-98-99 nella<br />
<strong>Rivista</strong> Italiana <strong>di</strong> Numismatica^ a meno <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione<br />
contraria degli autori (2), fatta alla presentazione del<br />
lavoro o anche in qualunque momento successivo fino<br />
alla chiusura del Concorso.<br />
I lavori presentati saranno pubblicati nella <strong>Rivista</strong> colle<br />
norme solite per tutte le altre pubblicazioni e in or<strong>di</strong>ne<br />
<strong>di</strong> presentazione.<br />
6. Il Giurì sarà <strong>com</strong>posto <strong>di</strong> 5 membri, la cui nomina viene<br />
<strong>di</strong>sciplinata <strong>com</strong>e segue. L'ufficio <strong>di</strong> giurì è offerto ai<br />
Direttori dei Gabinetti Numismatici <strong>di</strong> Parigi, Londra,<br />
(1) (V. Atti della S. N. I. Seduta 20 aprile 1897, e Assemblea generale<br />
dei Soci 2 giugno 1897 in questo medesimo fascicolo pag. 265 e 269).<br />
(2) È superfluo accennare che i primi a fare tale <strong>di</strong>chiarazione sono<br />
i promotori del Concorso.
26o VARIETÀ<br />
Berlino, Vienna e Milano. Quando alcuno fra questi, per<br />
qualsiasi motivo, non intendesse accettare personalmente,<br />
verrà sostituito da altro officiale del museo stesso o anche<br />
da persona della medesima nazione, estranea al Museo,<br />
che il Direttore è pregato <strong>di</strong> voler gentilmente in<strong>di</strong>care.<br />
7. Il Giurì è tenuto ad inviare il proprio verdetto alla Se-<br />
greteria della Società Numismatica Italiana entro il 1°<br />
Trimestre dell'anno 1900.<br />
8. Il premio potrà anche eventualmente essere <strong>di</strong>viso in due,<br />
in modo però che al primo non spettino meno <strong>di</strong> L. 1000.<br />
9. Compito del Giurì sarà quello <strong>di</strong> rispondere al quesito:<br />
Quale fra i collaboratori della <strong>Rivista</strong> Italiana <strong>di</strong> Numi-<br />
smatica durante il triennio 1897-98-99 abbia fornito con<br />
una o più memorie il più importante contributo alla<br />
Numismatica classica, principalmente sotto il punto <strong>di</strong><br />
vista d'aver apportato nuova luce alla scienza.<br />
Eventualmente poi giu<strong>di</strong>cherà se altri possa essere<br />
meritevole <strong>di</strong> una porzione <strong>di</strong> premio e in quale misura,<br />
<strong>com</strong>e all'articolo o.<br />
Milano, 20 Aprile iSpj.<br />
Premio <strong>di</strong> Numismatica, — Il premio Duchalais pel<br />
1896 è stato conferito dall'Accademia delle Iscrizioni e Belle<br />
Lettere al Sig. H. de la Tour, per l'insieme de' suoi lavori<br />
sui Medaglisti del Rinascimento, pubblicati nella Revue Nu-<br />
mismatique.<br />
Medaglia pontificia <strong>com</strong>memorativa, — Pel 20 feb-<br />
braio 1897 è stata coniata dal Cav. Bianchi, incisore dei pa-<br />
lazzi apostolici, la medaglia <strong>com</strong>memorativa del 19° anno del<br />
pontificato <strong>di</strong> Leone XIII. Nel <strong>di</strong>ritto ha 1' effige del Papa<br />
coll'epigrafe : Leo XIII Pont. Max. Sacri Princ. A. XIX.<br />
Nel rovescio la Vergine in trono col Bambino, che offre al<br />
mondo il Rosario. Varie figure, quali in pie<strong>di</strong> quali in gi-<br />
nocchio, rappresentano i varii popoli. Sulla destra Leone XIII<br />
in pie<strong>di</strong> presenta questi fedeli alla Vergine. In giro l'epigrafe:<br />
Praesi<strong>di</strong>um <strong>di</strong>vinae matris acceptissima Rosarii praece exorandum.<br />
Queste medaglie <strong>com</strong>memorative degli anni del Pontifi-<br />
cato si coniano ogni due anni.
vARrETÀ a6i<br />
Dell'tiiilità scientifica delle collezioni <strong>di</strong> monete<br />
antiche, — Su questo tema il chiar." Direttore del Gabinetto<br />
<strong>di</strong> Parigi Ernesto Babelon pronunciava un eru<strong>di</strong>tissimo <strong>di</strong>-<br />
scorso nella seduta generale del Congresso delle Sociétés<br />
savantes il 24 aprile scorso. Quel <strong>di</strong>scorso ci parve tanto<br />
interessante per tutti quelli che si occupano <strong>di</strong> <strong>numismatica</strong><br />
che credemmo far cosa grata a tutti i nostri lettori chiedendo<br />
air illustre autore il permesso <strong>di</strong> riprodurlo nella nostra<br />
<strong>Rivista</strong>. Il permesso venne gentilmente accordato, e, dolenti<br />
<strong>di</strong> non poter dare tale riproduzione nell' attuale fascicolo<br />
abbiamo almeno la <strong>com</strong>piacenza d'annunciarlo pel terzo.<br />
Ven<strong>di</strong>ta Sanibon» — Sul principio dello scorso aprile<br />
ebbe luogo in Milano la ven<strong>di</strong>ta (da noi annunciata nel preced.<br />
fascicolo) dell'importante collezione <strong>di</strong> monete dell'Italia me-<br />
ri<strong>di</strong>onale radunata dal Cav. Giulio Sambon. La ven<strong>di</strong>ta fu<br />
animatissima, e il ricavo toccò quasi le 40,000 lire.<br />
Ecco alcuni dei prezzi più notevoli raggiunti:<br />
N. IO. Tari <strong>di</strong> Enrico VI, imp., coniato ad Amalfi . . L. 400<br />
» 90. Denaro d'Adelchi, duca <strong>di</strong> Benevento, col nome<br />
dell' imp. Ludov. II » 360<br />
n 98. Denaro anonimo ossi<strong>di</strong>onale <strong>di</strong> Benevento (a. 891) »> 345<br />
» 244. Da 9 tari <strong>di</strong> Corrado imp » 350<br />
»> 276, Follaro <strong>di</strong> Riccardo II, princ. <strong>di</strong> Capua ....»> 400<br />
>• 384. Denaro <strong>di</strong> Basilio imp.; coniato a Napoli ...» 455<br />
n 387. Denaro anonimo <strong>di</strong> Napoli » 485<br />
n 388. Denaro degl'imp. Basilio, Leone e Alessandro,<br />
coniato a Oria » 330<br />
" 428. Denaro <strong>di</strong> Gaimaro I, princ. <strong>di</strong> Salerno. ...» 330<br />
» 451. Follaro <strong>di</strong> Gisolfo I e Pandolfo, princ. <strong>di</strong> Capua,<br />
coniato a Salerno » 400<br />
n 531. Follaro <strong>di</strong> Sergio III, coniato a Sorrento . . . »» 265<br />
» 532. Da 8 tari <strong>di</strong> Carlo I d'Angiò, coniato a Tunisi . » 695<br />
» 543. Reale o augustale dello stesso » 360<br />
n 748. Doppio ducato d'oro <strong>di</strong> Fer<strong>di</strong>n. I d'Aragona . . » 500<br />
» 897. Ducato d'oro <strong>di</strong> Lodov. XII <strong>di</strong> Fr., coniato a Napoli » 600<br />
n 930. Mezzo scudo ossi<strong>di</strong>onale <strong>di</strong> Napoli (a. 1528) . . » 495<br />
» 1224. Tari d'arg. <strong>di</strong> Carlo II <strong>di</strong> Spagna, minorenne. . » 645<br />
n 1310. Doppia oncia d'oro <strong>di</strong> Carlo 111 d'Austria ...» 695<br />
» 1520. Doppio bolognino <strong>di</strong> Civitaducale " 560<br />
» 1533. Zecchino <strong>di</strong> Belmonte " 610<br />
» 1534. Zecchino del Vasto " l^o
ATTI<br />
DELLA<br />
SOCIETÀ NUMISMATICA ITALIANA<br />
Seduta del Consiglio 20 Aprile 1897.<br />
(Estratto dai Verbali).<br />
La seduta è aperta alle ore 15. Il Consiglio è quasi al<br />
<strong>com</strong>pleto.<br />
I. Il Vice-Presidente Francesco Gnecchi prende la parola<br />
per riferire <strong>com</strong>e il 22 Marzo scorso si fosse recato in <strong>com</strong>-<br />
pagnia del Presidente Conte Papadopoli a Firenze, onde of-<br />
frire in nome della Società Numismatica Italiana a S. A. R.<br />
il Principe <strong>di</strong> Napoli la Presidenza Onoraria. I due rappre-<br />
sentanti furono accolti al Palazzo Pitti colla massima cortesia<br />
e Tofiferta venne graziosamente accettata.<br />
Il Consiglio applaude all'alto onore che vien fatto alla<br />
Società e vota il seguente or<strong>di</strong>ne del giorno da essere trasmesso<br />
al Principe stesso :<br />
" Il Consiglio della Società Numismatica Italiana, nella<br />
" sua adunanza 20 Aprile 1897, lieto e riconoscente a S. A. R.<br />
" il Principe <strong>di</strong> Napoli per la graziosa accettazione della<br />
" Presidenza onoraria, Gli presenta i suoi piia vivi e rispet-<br />
" tosi ringraziamenti a nome della Società, augurandosi che<br />
" questa abbia sempre a <strong>di</strong>mostrarsene degna. „<br />
Su proposta della Presidenza, viene pure votata all'u-<br />
nanimità una pergamena, che sarà presentata ai Soci nel<br />
giorno dell'Assemblea generale e poi offerta al Principe <strong>com</strong>e<br />
ricordo del fausto avvenimento.
264<br />
ATTI DELLA SOCIETÀ NUMISMATICA ITALIANA<br />
Continuando la narrazione dell'u<strong>di</strong>enza, il Vice-Presidente<br />
racconta che i due mandatari furono trattenuti a lungo dal<br />
Principe a <strong>di</strong>scorrere della Società, della <strong>Rivista</strong> e <strong>di</strong> numi-<br />
smatica in genere, cose tutte a cui S. A. R. si interessa<br />
immensamente, e ad esaminare una parte della collezione del<br />
Principe stesso, che va ogni giorno aumentando <strong>di</strong> numero<br />
e <strong>di</strong> valore.<br />
II. Viene data <strong>com</strong>municazione dell' accordo fatto col<br />
Municipio <strong>di</strong> Milano per la nuova Sede Sociale nel Castello<br />
Sforzesco. Il locale concesso alla Società Numismatica è<br />
attiguo a quelli concessi alla Società Storica Lombarda, anzi<br />
le due società avranno <strong>com</strong>une la sala delle u<strong>di</strong>enze. Il locale<br />
è accordato gratuitamente per 15 anni a partire dal prossimo<br />
San Michele; la Società Numismatica però concorrerà per<br />
L. 2000, una volta tanto, pel ristauro.<br />
Il Marchese Carlo Ermes Visconti fa alcune osservazioni<br />
sulla convenienza <strong>di</strong> uno scambio del locale offerto dal Mu-<br />
nicipio con altri due locali fra quelli accordati alla Società<br />
Storica e che forse meglio si presterebbero alla nostra. Si<br />
rimette la decisione ad un sopraluogo della Presidenza della<br />
nostra Società con quella della Società Storica.<br />
III. Si passa alla <strong>di</strong>scussione del bilancio consuntivo<br />
del 1896 da presentarsi alla prossima assemblea dei soci.<br />
È approvato.<br />
IV. Viene proposto a Socio corrispondente il Sig. Antonio<br />
Annoni, ed è ammesso all'unanimità.<br />
V. Si determina la <strong>com</strong>posizione del II fascicolo della<br />
<strong>Rivista</strong> e si prendono anche gli accor<strong>di</strong> pel III, essendone<br />
in gran parte già pronta la materia.<br />
VI. Si stabilisce che l'Assemblea dei Soci abbia ad aver<br />
luogo il giorno 2 Giugno e se ne forma l'or<strong>di</strong>ne del giorno<br />
<strong>com</strong>e segue:<br />
I." Nomina <strong>di</strong> S. A. R. il Principe <strong>di</strong> Napoli a Presidente Onorario<br />
della Società.<br />
2.° Presentazione del Bilancio consuntivo 1896.<br />
3.° Relazione sull'andamento della società durante il 1896.<br />
4.** Nomina delle cariche sociali del 1897-98.
ATTI DELLA SOCIETÀ NUMISMATICA ITALIANA 365<br />
VII. I Vice-presidenti Francesco ed Ercole Gnecchi an-<br />
nunciano un Concorso <strong>di</strong> propria iniziativa con un premio <strong>di</strong><br />
lire 1500 per il più importante lavoro <strong>di</strong> Numismatica clas-<br />
sica che sarà apparso nella <strong>Rivista</strong>, durante il triennio<br />
1897-98-99, a cui potranno prender parte i numismatici d'ogni<br />
paese che abbiano collaborato alla <strong>Rivista</strong> nel detto triennio<br />
e che non abbiano <strong>di</strong>chiarato <strong>di</strong> rinunciarvi.<br />
A norma del programma (0, il giurì rimane fin d' ora<br />
<strong>com</strong>posto <strong>com</strong>e segue:<br />
Signor Ernesto Bahelon, conservatore del Gabinetto<br />
Numismatico <strong>di</strong> Parigi, signor Warwick Wroth F. S. A.<br />
Segretario della Società Numismatica <strong>di</strong> Londra e conser-<br />
vatore aggiunto al Museo Britannico, Dottor Enrico Dressel,<br />
conservatore aggiunto del Museo <strong>di</strong> Berlino, Dottor F. IV.<br />
Kubitschek <strong>di</strong> Graz, in rappresentanza del Direttore dell'I.<br />
R. Gabinetto <strong>di</strong> Vienna e Cav. Dottor Solone Ambrosoli,<br />
<strong>di</strong>rettore del Regio Gabinetto Numismatico <strong>di</strong> Brera.<br />
Vili. Il Segretario dà <strong>com</strong>unicazione dei seguenti doni<br />
pervenuti alla Società :<br />
Bordeaux Paul <strong>di</strong> Neuilly.<br />
Le sue pubblicazioni : Les monnaìes frappées par Francois I.*^""<br />
<strong>com</strong>me Conile de Provence. Paris, 1896. — Les gros et denii-<br />
gros des gens d'arme de Charles VII à la croix cantonnée.<br />
Paris, 1896. — Étude critique du Catalogne des monnaies<br />
carolingiennes frangaises de la Bibliothèque Nationale de Paris<br />
par M."" Prou. Bruxelles, 1897.<br />
Gnecchi Cav. Uff. Francesco.<br />
Monete orientali; 5 in argento e 29 in rame.<br />
Monete varie me<strong>di</strong>oevali e moderne; 30 in argento e 90 in rame.<br />
Monete romane; 180 in bronzo.<br />
Luppi Cav. Prof. Costantino.<br />
Langlumé J. Tableau des monnaies d'or et d'argent des principaux<br />
états du monde, avec leur valeur en francs, leur poids, leur<br />
tìtre, etc. Paris, in- 16 con Tav.<br />
(i) Inserito fra le notizie in questo medesimo fascicolo (Ve<strong>di</strong> pag.259).<br />
34
266 ATTI DELLA SOCIETÀ NUMISMATICA ITALIANA<br />
Osnago Enrico.<br />
N. 71 monete <strong>di</strong> zécche italiane, delle quali 52 in ^gento e 19 in<br />
rame. Vi si trovano monete rare, e fra le zecche rappresentate<br />
citeremo: Como, Messerano, Ro<strong>di</strong>, Sebenico e Villa <strong>di</strong> Chiesa.<br />
Seletti Avv. Cav. Emilio.<br />
Iscrizioni Cristiane in Milano anteriori al IX Secolo, e<strong>di</strong>te a cura <strong>di</strong><br />
V. Forcella e <strong>di</strong> E. Seletti. Codogno, 1897.<br />
. Assemblea Generale dei Soci 2 Giugno 1896.<br />
L' assemblea è convocata per le ore io. Oltre il Con-<br />
siglio, sono presenti parecchi Soci <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse parti d' Italia.<br />
Per prima cosa il Presidente Conte Papadopoli annuncia<br />
ai Soci l'accettazione della Presidenza Onoraria della Società<br />
da parte <strong>di</strong> S. A. R. il Principe <strong>di</strong> Napoli, che viene accolta<br />
colla massima sod<strong>di</strong>sfazione da tutti i soci presenti non solo,<br />
ma anche da alcuni assenti che con lettere e telegrammi, <strong>di</strong><br />
cui si dà lettura, uniscono i loro voti.<br />
Si presenta e si firma quin<strong>di</strong> la pergamena che in ricordo<br />
del fausto avvenimento verrà presentata al Principe stesso.<br />
Il vice presidente, Francesco Gnecchi, legge, a nome<br />
del Consiglio, la seguente relazione sull' andamento della<br />
Società durante il 1896:<br />
Egregi Colleghi,<br />
Dopo qualche anno <strong>di</strong> vita modesta, ma pur feconda ed<br />
attiva, la quale servì a far conoscere e, <strong>di</strong>remo, a inse<strong>di</strong>are<br />
la nostra Società fra le consorelle, il vostro Consiglio nell'occasione<br />
dell'Adunanza generale <strong>di</strong> quest'anno, nel quale si<br />
<strong>com</strong>pie il quinquennio dalla fondazione della Società e il decennio<br />
da quello della <strong>Rivista</strong>, prova un singolare <strong>com</strong>piacimento,<br />
essendo in grado, <strong>di</strong> <strong>com</strong>unicare due avvenimenti,<br />
l'uno <strong>com</strong>piuto, l'altro in via d'attuazione, i quali non potranno<br />
che contribuire ad elevare il prestigio del nostro<br />
Sodalizio. Allu<strong>di</strong>amo all'accettazione della Presidenza Onoraria<br />
della nostra Società da parte <strong>di</strong> S. A. R. il Principe
ATTI DELLA SOCIETÀ NUMISMATICA ITALIANA 267<br />
<strong>di</strong> Napoli, <strong>di</strong> cui avete avuto notizie dal verbale dell' ultima<br />
seduta del Consiglio, e che oggi venne uificialmente proclamata,<br />
e al prossimo trasporto della nostra sede nel Castello<br />
Sforzesco <strong>di</strong> Milano.<br />
L'avere a nostro Presidente Onorario il primo dei nostri<br />
Soci, S. A. R. il Principe <strong>di</strong> Napoli, mentre è per noi altissimo<br />
onore e segno della stima che la nostra Società ha<br />
saputo acquistarsi nel breve periodo della sua vita, c'impone<br />
anche l'obbligo <strong>di</strong> curarne con tanto maggior impegno il<br />
progresso e lo sviluppo, e <strong>di</strong> tendere sempre più in alto colle<br />
nostre aspirazioni nel campo scientifico.<br />
Il cambiamento della nostra sede attuale con quella splen-<br />
<strong>di</strong>da che il Municipio <strong>di</strong> Milano gentilmente ne consente nel<br />
Castello Sforzesco, mentre ci mette nella felice con<strong>di</strong>zione<br />
<strong>di</strong> una vita <strong>di</strong> intimità colla Società Storica Lombarda che<br />
ci sarà vicina e colla quale avremo anzi <strong>com</strong>une la sala delle<br />
adunanze, ci offre anche uno sgravio finanziario, vantaggio<br />
non trascurabile, viste le con<strong>di</strong>zioni economiche della nostra<br />
Società, che pur troppo non sono floride.<br />
Possiamo dunque rallegrarci dei due avvenimenti ed accoglierli<br />
<strong>com</strong>e felici auguri a bene sperare per l'avvenire.<br />
Soci.<br />
Il numero dei Soci, alla fine del 1896, era <strong>di</strong> 93, <strong>di</strong> cui<br />
40 effettivi e 53 corrispondenti. Gli associati alla <strong>Rivista</strong> erano<br />
in numero <strong>di</strong> 108, con un leggero aumento su quello dell'anno<br />
precedente.<br />
Forse l'essere in certo modo avvicinati alla Società Sto-<br />
rica Lombarda potrà suggerire qualche <strong>com</strong>binazione atta<br />
a procurarci dei Soci ; ma per ora ogni supposizione sarebbe<br />
prematura.<br />
Biblioteca.<br />
Alla fine del 1896, mercè le generose donazioni, <strong>di</strong> cui<br />
si tenne nota nei resoconti delle sedute del Consiglio, la<br />
nostra Biblioteca raggiungeva il numero <strong>di</strong> 460 volumi e<br />
510 opuscoli.<br />
A fronte dei vantaggi che ci offre il trasloco nel Castello<br />
la nostra Biblioteca soffrirà invece un danno, che è bene<br />
segnalare. In questa vecchia sede, la vicinanza della ricca<br />
biblioteca <strong>numismatica</strong> del nostro Segretario Cav. Prof. Luppi<br />
era <strong>di</strong> grande sussi<strong>di</strong>o ai nostri stu<strong>di</strong>osi, perchè lasciata liberalmente<br />
a <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> tutti. Il trasloco ci priverà <strong>di</strong>
208 ATTI DELLA SOCIETÀ NUMISMATICA ITALIANA<br />
tale vantaggio; quin<strong>di</strong>, mentre ren<strong>di</strong>amo pubbliche grazie al<br />
prof. Luppi, pel tempo che la Società ne ha goduto, cre<strong>di</strong>amo<br />
opportuno rivolgerci con insistenza speciale ai Soci ed agli<br />
amici nostri, onde, con libri o con denaro, vengano in sussi<strong>di</strong>o<br />
della Biblioteca Sociale.<br />
Medagliere.<br />
Il Medagliere della Società ebbe quest'anno un incremento<br />
superiore a quello della biblioteca.<br />
I pezzi pervenuti in dono al nostro furono, nell'anno<br />
decorso, 216 e la Collezione oggi <strong>com</strong>prende:<br />
Monete: 2 in oro, 361 in argento, 1771 in rame e bronzo,<br />
363 in vetro.<br />
Medaglie e tessere: 5 in argento e 260 in bronzo, rame<br />
e piombo. — Totale: N. 2762 pezzi.<br />
<strong>Rivista</strong>.<br />
L'equilibrio fra i vari rami della <strong>numismatica</strong>, cui la nostra<br />
<strong>Rivista</strong> è de<strong>di</strong>cata, ci pare sia stato convenientemente mantenuto<br />
durante l'annata 1896. La <strong>numismatica</strong> classica e la<br />
me<strong>di</strong>oevale <strong>italiana</strong> si <strong>di</strong>visero equamente il campo, e l'una<br />
e l'altra non si limitarono ad osservazioni o stu<strong>di</strong> retrospet-<br />
tivi su materiali già noti , ma<br />
portarono in luce nuovi e inte-<br />
ressanti documenti, <strong>di</strong>mostrando <strong>com</strong>e, tanto nel campo della<br />
<strong>numismatica</strong> classica <strong>com</strong>e in quello dell'<strong>italiana</strong>, le ricerche<br />
non siano finite e la fonte non sia inari<strong>di</strong>ta; mentre chi ben<br />
cerca, trova sempre qualche cosa <strong>di</strong> nuovo e qualche angolo<br />
inesplorato.<br />
Quest'anno abbiamo potuto finalmente iniziare anche la<br />
richiesta ripubblicazione <strong>di</strong> alcune opere vecchie ormai introvabili,<br />
e l'abbiamo inaugurata con quelle <strong>di</strong> Carlo Kunz, che<br />
proseguiremo nell'anno corrente, ogni qual volta le memorie<br />
moderne ci consentiranno un po' <strong>di</strong> spazio. Le opere del Kunz<br />
si pubblicheranno nella loro originalità ed integrità; ma il<br />
vostro Consiglio <strong>di</strong> Redazione ha incaricato una Commissione<br />
la quale, alla fine della pubblicazione, aggiungerà un corredo<br />
<strong>di</strong> note atte a <strong>di</strong>mostrare i progressi della scienza dopo l'epoca<br />
in cui le rispettive memorie furono scritte, e a fare, in<br />
base a questi, le opportune rettifiche e aggiunte.<br />
Visto che non abbiamo una <strong>Rivista</strong> speciale de<strong>di</strong>cata<br />
alla Medaglistica e che questa è considerata quin<strong>di</strong> ancora<br />
una <strong>di</strong>pendenza della <strong>numismatica</strong>, resta sempre fra i deside-<br />
rati del Consiglio <strong>di</strong> Redazione che qualche amatore <strong>di</strong><br />
Medaglie moderne voglia assumersi la continuazione della
ATTI DELLA SOCIETÀ NUMISMATICA ITALIANA 269<br />
rubrica lasciata già interrotta dal Collega Coman<strong>di</strong>ni, proseguendo<br />
la pubblicazione delle medaglie italiane contemporanee.<br />
Chi vi si volesse sobbarcare, sarebbe benemerito della<br />
nostra <strong>Rivista</strong>.<br />
In ogni modo cre<strong>di</strong>amo poter affermare senza ostentazione<br />
che la <strong>Rivista</strong> si è mantenuta onorevolmente al livello<br />
che a poco a poco ha saputo acquistarsi, mercè l'intelligenza<br />
e la buona volontà dei nostri collaboratori, ai quali tributiamo<br />
pubblicamente i nostri vivi ringraziamenti. Certo non starebbe<br />
a noi il far qui le lo<strong>di</strong> della nostra pubblicazione; ma, colla<br />
stessa sincerità colla quale saremmo i primi a dare l'allarme<br />
se scorgessimo segni <strong>di</strong> decadenza, ci sia lecito <strong>di</strong>re che dall'<br />
interno <strong>com</strong>e dall'estero non abbiamo ricevuto che lo<strong>di</strong> ed<br />
incoraggiamenti.<br />
Concorsi.<br />
Nell'anno 1896 furono chiusi i due concorsi Papadopoli<br />
(n. 2) e Gnecchi (n. 3), dell'esito dei quali già avete avuto<br />
contezza nei resoconti delle sedute consigliari, I due lavori<br />
premiati del Conte Francesco Malaguzzi Valeri e del sig. Giuseppe<br />
Castellani ci offriranno materia per l'anno corrente e<br />
per buona parte dell'anno venturo.<br />
Nello scorso aprile venne ban<strong>di</strong>to un nuovo concorso<br />
(Gnecchi n. 4) per argomenti <strong>di</strong> <strong>numismatica</strong> classica, <strong>di</strong> cui<br />
pure conoscete i termini dal resoconto dell'ultima seduta del<br />
Consiglio. Possiamo già fin d'ora annunciare che anche questo<br />
Concorso raggiungerà bene il suo scopo, perchè già abbiamo<br />
<strong>di</strong>verse promesse <strong>di</strong> lavori classici tanto dall'Italia quanto<br />
dall'estero. Anzi, al tèsto primitivo del programma, in seguito<br />
ad una giusta osservazione d'un collega che fra le lingue vive<br />
non avrebbe potuto scrivere che il tedesco o l'inglese,<br />
abbiamo fatto una piccola variante, aggiungendo anche il<br />
latino alle lingue ammesse pel concorso. Difatti pare che il<br />
mondo scientifico, anziché semplificare, sia sulla via <strong>di</strong> <strong>com</strong>plicare<br />
e rendere sempre più <strong>di</strong>fficile l' intelligenza della<br />
scienza, adottando l'uso <strong>di</strong> pressoché tutte le lingue europee,<br />
<strong>di</strong> modo che lo stu<strong>di</strong>oso, prima <strong>di</strong> <strong>di</strong>ventare scienziato, si<br />
vede obbligato a <strong>di</strong>ventare poìiglotto e a consumare metà<br />
della sua vita nello stu<strong>di</strong>o delle lingue. Non sarebbe un progresso,<br />
in questo caso, il tornare all'antico?<br />
Bilancio.<br />
Ecco ora il Bilancio Consuntivo della scorsa annata 1896.
270<br />
atti della società <strong>numismatica</strong> <strong>italiana</strong><br />
Rimanenze attive al 31 <strong>di</strong>cembre 1895.<br />
Libretto Cassa <strong>di</strong> Risparmio L. 601 98<br />
Segretario (in Cassa) w 191 48<br />
Quote da riscuotere » 1006 —<br />
Tesoriere (in Cassa) » 203 50<br />
Entrate del 1896.<br />
Quote riscosse da soci ed abbonati . . . L. 2897 75<br />
Altri introiti „ 3^0<br />
Quote arretrate<br />
Offerta del Conte Comm. N. Papadopoli .<br />
» dei Cav. Uff. F. ed E. Gnecchi. .<br />
„<br />
»<br />
»<br />
400<br />
500 —<br />
500 —<br />
Interessi sul Libretto <strong>di</strong> Cassa <strong>di</strong> Risparmio » 22 33<br />
L. 2002 96<br />
L. 4740 08<br />
Residui passivi.<br />
Anticipazioni quote soci ed abbonati pel 1897 . . . L. 670 —<br />
Rimanenze passive al 31 <strong>di</strong>cembre 1895.<br />
Anticipazioni quote <strong>di</strong> soci ed abbonati 698 —<br />
Spese del 1896.<br />
Stampa ed accessori della <strong>Rivista</strong> .<br />
. . L. 3289 —<br />
Fotoincisioni ed eliotipie » 497 —<br />
Acquisto <strong>di</strong> uno scaffale . n 105 —<br />
Affitto locali n 375 —<br />
Onorario al Segretario » 300 —<br />
Spese per ufficio, posta, ecc » 104 32<br />
Rimanenze attive.<br />
Libretto Cassa <strong>di</strong> Risparmio L. 827 81<br />
Tesoriere (in Cassa) » 395 —<br />
Segretario (in Cassa) . . . ^ » 401 91<br />
Quote da riscuotere » 420 —<br />
L. 4670 32<br />
L. 2044 72<br />
L. 7413 04
ATTI DELLA SOCIETÀ NUMISMATICA ITALIANA 271<br />
Dimostrazione.<br />
Attività in principio <strong>di</strong> esercizio . . . . L. 2002 96<br />
Passività » » n .... » 608<br />
Attività in fine <strong>di</strong> esercizio L. 2044 72<br />
Passività »» w n „ 6^0 —<br />
L. 1304 96<br />
L- 1374 72<br />
Aumento del patrimonio L. 69 76<br />
Ren<strong>di</strong>te dell'anno L. ^-j^q 08<br />
bpese „ 4670 32<br />
Avanzo al 31 <strong>di</strong>cembre 1896 L. 69 76<br />
Da questa breve esposizione rileviamo con piacere che<br />
anche nel 1896 il nostro Bilancio è in pareggio e si chiude<br />
con un piccolo avanzo <strong>di</strong> L. 69.76, che va ad aumentare il<br />
patrimonio sociale. Neil' anno corrente poi, <strong>com</strong>e già si è<br />
detto, ci è lecito sperare un nuovo miglioramento nelle con-<br />
<strong>di</strong>zioni del nostro Bilancio, stante la <strong>di</strong>minuzione dell'affitto<br />
che otterremo col trasporto della nostra sede nel Castello<br />
Sforzesco.<br />
Ora ciò che sta in cima alle nòstre aspirazioni sarebbe<br />
<strong>di</strong> aumentare l'ancora scarso numero dei nostri Soci ; questo<br />
ci consentirebbe <strong>di</strong> arricchire a poco a poco la nostra Biblioteca,<br />
la quale è ancora in molte parti deficiente, e renderla<br />
pili utile a quegli stu<strong>di</strong>osi che vi ricorrono per le loro<br />
indagini.<br />
A raggiungere tale intento, abbiamo bisogno dell'aiuto<br />
e dell'appoggio <strong>di</strong> tutti i nostri Soci e facciamo grande assegnamento<br />
sul loro zelo e sulla loro propaganda.<br />
Il Conto Consuntivo 1896 viene approvato ad unanimità.<br />
Si passa alla nomina delle Cariche Sociali. Scadono<br />
dall' ufficio per anzianità i Sigg. Cav. Giuseppe Gavazzi e<br />
Ing. Emilio Motta. Ambedue sono rieletti. In seguito a che<br />
il Consiglio <strong>di</strong>rettivo, confermando le cariche del Presidente<br />
e dei Vicepresidenti, rimane così <strong>com</strong>posto:
272 ATTI DELLA SOCIETÀ NUMISMATICA ITALIANA<br />
Presidente Onorario.<br />
S. A. R. Il Principe <strong>di</strong> Napoli.<br />
Presidente.<br />
Conte Comm. Nicolò Papadopoli Senatore del Regno.<br />
Vice-Presidenti.<br />
Cav. Uff. Francesco Gnecchi.<br />
Cav. Uff. Ercole Gnecchi.<br />
Consiglieri :<br />
Ambrosoli Cav. Dott. Solone.<br />
Gavazzi Cav. Giuseppe.<br />
Motta Ing. Emilio.<br />
Ruggero Cav. Col. Giuseppe.<br />
Sambon Dott. Arturo.<br />
Visconti March. Carlo Ermes.<br />
La seduta è levata alle ore 17.<br />
Finito <strong>di</strong> stampare il 30 giugno 1897.<br />
Scotti Reno, Gerente responsabile.
Anno X- 1897. RIVISTA ITALIANA DI NUMISMATICA Pav. III.<br />
><br />
c5SB5<br />
Tito<br />
%'<br />
RESTITUZIONI DI BRONZO<br />
L.'i;ini/irino<br />
Trajano M. Aurelio e L. Vero Nerva<br />
Adriano<br />
RESTITUZIONI D'ARGENTO<br />
Trajano<br />
RESTITUZIONI D'ORO<br />
Francesco (ìnkcchi SULLE RESTITUZIONI l'ascicolo \.ì.<br />
\<br />
y
RIVISTA ITALIANA DI NUMISMATICA<br />
Anno X, 1897. Tav. IV.<br />
C. KUNZ. - Il Mnseo Bottacln
RIVISTA ITALIANA DI NUMISMATICA<br />
Anno X, 1897. Tav. V.<br />
C. KUNZ — Il Museo Bottacin.
FASCICOLO III,
LA CRONOLOGIA<br />
DELLE MONETE DI NERONE<br />
STABILITA SOPRA NUOVE RICERCHE ICONOGRAFICHE (l)<br />
I.<br />
Il TIPO DI Nerone sulle monete romane.<br />
Quantunque la serie monetale <strong>di</strong> Nerone non<br />
abbia una grande varietà <strong>di</strong> tipi, <strong>com</strong>e la serie dei<br />
Flavii e degli Antonini, è tuttavia <strong>di</strong> quelle, la cui<br />
cronologia più volte tentata, almeno in parte (2), non<br />
è ancor sicura. Ciò deriva principalmente dalla mancanza<br />
quasi assoluta dei dati cronologici, consistenti<br />
nelle salutazioni imperiali e nei numeri della tribunicia<br />
potestà s, ed anche dal succedersi <strong>di</strong> varii<br />
tentativi fatti per creare un or<strong>di</strong>namento stabile nella<br />
serie dei così detti bronzi, i quali dall'anno 15 a. C.<br />
non avevano avuto ciascuno una nota caratteristica.<br />
La zecca dell'impero funzionava da circa settant'anni<br />
e non ancora erasi trovato un segno costante e sicuro<br />
che pel variar <strong>di</strong> tipo rendesse riconoscibile e <strong>di</strong>stinto<br />
(i) Memoria letta alla R. Accademia d'Arch. <strong>di</strong> Napoli nella tornata<br />
del 16 febbraio 1897, la cui inserzione negli Atti fu approvata con unanimità<br />
<strong>di</strong> voti nella tornata del 9 marzo 1897. Nel Ren<strong>di</strong>conto delle tornate<br />
e dei lavori <strong>di</strong> detta Accademia fu pubblicato un sunto della presente<br />
memoria, non in tutto fedele al testo, che vede per la prima volta la<br />
luce nella nostra <strong>Rivista</strong>.<br />
(2) Geco, Intp. rom. num. Nero ; Eckhel, D. N. t. VI, Nero ; Cavedoni,<br />
Osservaz. sopra alcune med. imperiali negli Annali dell' Istit. <strong>di</strong><br />
corrisp. arch. 1851, p. 241-246; Kenner, Die ScheidemUnze des Kais. Nero<br />
nella Num. Zeitschr. 1878, p. 230-306.
276<br />
fcTfORE CABRICI<br />
il dupon<strong>di</strong>o dall'asse, né <strong>di</strong> quest'ultimo erano state<br />
coniate tutte le frazioni. Bontà <strong>di</strong> metallo, esattezza<br />
nei pesi, abbondanza <strong>di</strong> emissioni, ma incertezza e<br />
confusione ad un tempo.<br />
I primi anni dell'impero <strong>di</strong> Nerone partecipano<br />
<strong>di</strong> questi <strong>di</strong>fetti; poi subito si manifesta lo sforzo<br />
dello Stato per evitare una buona volta il crescente<br />
<strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ne: e qui riforme sopra riforme, per quattro<br />
o cinque volte <strong>di</strong> seguito. Se Augusto iniziò la mo-<br />
netazione dell'Impero, con Nerone fu in guisa rior-<br />
<strong>di</strong>nata, che nessun imperatore dopo <strong>di</strong> lui sentì il<br />
bisogno d'introdurre mo<strong>di</strong>ficazioni <strong>di</strong> sorta fino al<br />
terzo secolo d. Cr.<br />
Importa dunque grandemente allo stu<strong>di</strong>oso conoscere<br />
appieno questa serie monetale e seguirne<br />
tutte le pili lievi mo<strong>di</strong>ficazioni che gradatamente<br />
condussero ad un or<strong>di</strong>ne stabile. Poche monete d'oro<br />
e d'argento, pochissime <strong>di</strong> bronzo forniscono dati<br />
cronologici sicuri; le une e le altre costituiranno i<br />
capisal<strong>di</strong> della classificazione cronologica che noi ci<br />
proponiamo <strong>di</strong> fare.<br />
1 — 807 = 54 d. C.<br />
rB' — NERO CAESAR IMP • AVO. Testa <strong>di</strong> Nerone a d. ^<br />
^ — • PONTIF MAX TR • • P Corona <strong>di</strong> quercia, nel mezzo<br />
EX S C. Coh. (3) n. 192. A^<br />
2 — 809 = 56 d. C.<br />
^' — NERO • CAESAR •<br />
1^ - PONTIF •<br />
MAX<br />
• AVG<br />
• TR • P • Il • P • P Corona <strong>di</strong> quercia,<br />
IMP- Testa <strong>di</strong> N. a d. -<br />
nel mezzo EX S C. Coh. n. 204-5. ^- ^•<br />
^ - Sim. al prec. - 9/ — PONTIF • • MAX<br />
3 — 809 = 56 d. C.<br />
Corona <strong>di</strong> quercia, nel mezzo EX S C<br />
(3)<br />
del 1880.<br />
TR<br />
• P • III • P • P •<br />
Coh. n. 206-7. N. JR.<br />
I numeri del Cohen, che cito, sono quelli della seconda e<strong>di</strong>zione
LA CRONOLOGIA DELLE MONETE DI NERONE, ECC. 277<br />
4 — 810 = 57 d. C.<br />
^' — Sim. al n. 2. — 1^ - • PONTIF MAX<br />
P • P<br />
•<br />
TR •<br />
P •<br />
• Corona <strong>di</strong> quercia, nel mezzo EX S C.<br />
Coh. n. 208^. (Tav. I n. i). N. M.<br />
5 - 811 = 58 d. C.<br />
ilTl •<br />
ÌB' ^ Sim. al n. 2. — 9/ — • PONTIF • • MAX TR P • V • P • P •<br />
Corona <strong>di</strong> quercia, nel mezzo EX S C<br />
Coh. n. 210-11. (Tav. I n. 2). A^. M.<br />
6 — 812 = 59 d. C.<br />
^' - Sim. al n. 2. — '^ — • PONTIF MAX<br />
• • TR • P VI •<br />
P • P. Corona <strong>di</strong> quercia, nel mezzo EX S C<br />
7 — 813 = 60 d. C.<br />
Coh. n. 212. JR.<br />
;B' — Sình_ al n. 2. — 9; — PONTIF • • • MAX TR P • VI •<br />
• COS llll • P • P • Corona <strong>di</strong> quercia, nel mezzo EX S C<br />
Coh. n. 213-14. (Tav. I n. 3). A^ M.<br />
8 - 813 = 6q d. C.<br />
^^ - Sim. al n. 2. - 9/ — • PONTIF MAX<br />
COS •<br />
•<br />
TR •<br />
P • VH •<br />
llll • P • P • Corona <strong>di</strong> quercia, nel mezzo EX S C.<br />
Coh. n. 215-16. A^. M.<br />
9 — 813 = 60 d. C.<br />
^ — Sim. al n. 2. — 51 — PONTIF • • MAX TR • P • VM •<br />
COS llll P • • P Cerere stante a s., poggiata alla face,<br />
con spighe in mano; ai lati EX SC. Coh. n. 217-18. N. M.<br />
10 — 813 = 60 d. C.<br />
^ — Sim. al n. 2. — 91 — PONTIF • MAX • • TR P • VM-<br />
COS • llll • P • P • Marte, stante a s., poggiato all'asta e<br />
col parazonio nella destra, calcando varie armi; ai lati<br />
EX S C. Coh. n. 219-20. (Tav. I n. 4, 6). N. JR.<br />
11 — 813 = 60 d. C.<br />
;& - Sim. al n. 2. - ^f - • PONTIF • MAX • TR P • VII •<br />
• COS ilir • P • P • Roma stante a d., calcando varie armi<br />
e tenendo sulla gamba uno scudo rotondo, su cui scrive;<br />
ai lati EX S C Coh. n. 221-222. (Tav. I n. 5). N. M.
278 ETTORE CABRICI<br />
12 — 814 = 61 d. C.<br />
^ — Sim. al n. 2. — 9( - PONTIF • • MAX • TR P • VÌTl •<br />
• COS IMI • P • P • Tipo <strong>di</strong> Cerere, ai lati EX S C.<br />
Coh. n. 223-24. A^. iH.<br />
13 — 814 = 61 d. C.<br />
^' — Sim. al n. 2. — 9( - PONTIF • • MAX TR • P • VUl •<br />
COS •<br />
IMI • P • P<br />
14 — 814 = 61 d. C.<br />
• Tipo <strong>di</strong> Marte, ai lati EX S C.<br />
Coh. n. 225-26. N. , M..<br />
/B' - Sim. al n. 2. - J^ - • • PONTIF MAX TR • P • • Vm<br />
• COS illl • P • P • Tipo <strong>di</strong> Roma, ai lati EX S C<br />
15 ~ 815 = 62 d. C.<br />
Coh. n. 227. N..<br />
^ - Sim. al n. 2. - ]^ - PONTIF • • MAX TR • P • vUli •<br />
• COS Illl • P • • P Tipo <strong>di</strong> Cerere, ai lati EX S C.<br />
Coh. n. 228. A^<br />
16 — 815 = 62 d. C.<br />
^' - Sim. al n. 2. - 9( - • PONTIF MAX<br />
• • COS Illl P • P<br />
17 — 815 = 62 d. C.<br />
• TR • P • • Vim<br />
• Tipo <strong>di</strong> Marte, ai lati EX S C.<br />
Coh. n. 229. N.<br />
;& - Sim. al n. 2. — 9( - • • PONTIF MAX TR • P • VÌm •<br />
• • COS Illl P • P • Tipo <strong>di</strong> Roma, ai lati EX S C<br />
Coh. n. 230-31. A. JR.<br />
18 - 816 = 63 d. C.<br />
^'_3- Sim. al n. 2. - • PONTIF MAX • • TR P • X • • COS<br />
Illl • P • • P Tipo <strong>di</strong> Marte, ai lati EX S C<br />
19 — 816 = 63 d. C.<br />
Coh. n. 232-33. (Tav. I n. 7). A. Jiì.<br />
^ - Sim. al n. 2. — 5/ - PONTIF • MAX • • TR P • • X<br />
• COS IMI • P • P • Tipo <strong>di</strong> Roma, ai lati EX S C.<br />
Coh. n. 234-35.<br />
A'^. M,.<br />
20 — 817 = 64 d. C.<br />
^ - NERO CLAVD CAES AVG IMP TR POT XI P P. Busto<br />
<strong>di</strong> Nerone laureato a d. con lorica e paludamento. —
LA CRONOLOGIA DELLE MONETE DI NERONE, ECC. 879<br />
— —<br />
I<br />
^ - PACE P R TERRA MARIO PARTA lANVM CLVSIT.<br />
Il tempio <strong>di</strong> Giano, con la porta rivolta a d., adorna <strong>di</strong><br />
festone, ai lati S C.<br />
Sesterzio. Fiorelli, Cai. n. 4353.<br />
21 — 818 = 65 d. C,<br />
^ - NERO CAESAR AVO IMP TR POT XII P P. Busto <strong>di</strong><br />
N. laureato a d. con lorica e paludamento. — 9^ —<br />
Sim. al n. 20.<br />
Sesterzio. Fiorelli, Cai. n. 4354. (Tav. II n. 17).<br />
22 - 818 = 65 d. C. _<br />
.B' — IMP NERO CLAVD CAESAR AVG GERIVI PM TR P XII<br />
P P. Testa <strong>di</strong> N. laureata a d. — 9* — PACE P R<br />
TERRA MARIO PARTA lANVM CLVSIT. Il tempio <strong>di</strong> Giano<br />
con la porta rivolta a s., adorna <strong>di</strong> festone; ai lati S C.<br />
Sesterzio. Fiorelli, Cat. n. 4355.<br />
23 — 819 = 66 d. C.<br />
ÌB' - IMP NERO CLAVD CAESAR AVG GERM P M TR P<br />
XIII P P. Testa <strong>di</strong> N. laureata a. d. — 1^ — Sim. al. n. 22.<br />
Sesterzio. Coh. Nero n. 139.<br />
24 — 819 = 66 d. C.<br />
^ — IMP NERO CLAVD CAESAR AVO GERM P M TR P<br />
XIII P P. Testa <strong>di</strong> N. laureata a s. — 9^ — Sim. al n. 22.<br />
Sesterzio. Coh. Nero, n. 140. Parigi (Tav. Ili n. 7).<br />
25 — 819 = 66 d. C.<br />
^ - IMP NERO CLAVD CAESAR AVO OERM P M TR P<br />
XIII P P. Testa <strong>di</strong> N. a d. con corona ra<strong>di</strong>ata. — 9' —<br />
PACE P R VBIQ PARTA lANVM CLVSIT. Il tempio <strong>di</strong> Giano<br />
chiuso con la porta rivolta a s.; ai lati S C<br />
Dupon<strong>di</strong>o. Coh. Nero, n. 169.<br />
26 - 819 = 66 d. C.<br />
^ - IMP NERO CLAVD CAESAR AVO OERM P M TR P<br />
XIII P P. Testa <strong>di</strong> N. a d. con corona ra<strong>di</strong>ata. — ^^ —<br />
ROMA. Roma galeata seduta a s. sur una corazza e degli<br />
scu<strong>di</strong>, tenendo una corona e un'asta; ai lati S C<br />
Dupon<strong>di</strong>o. Coh. Nero, n. 283.<br />
—
28o ETTORE CABRICI<br />
27 — 819 = 66 d. C.<br />
;& - IMP NERO CLAVD CAESAR AVCr GERM P M TR P<br />
XIII P P. Busto <strong>di</strong> N. laureato a d., con l'egida. - 9/ -<br />
ROMA. Roma galeata seduta a s. su <strong>di</strong> una corazza, che<br />
stringendo l'asta si appoggia ad uno scudo ; ai pie<strong>di</strong><br />
ha <strong>di</strong>verse armi; ai lati S C.<br />
Sesterzio. Coh. Nero, n. 284. Parigi, [var. Fiorelli, Cat. n. 4356-57<br />
(Tav. Ili n. 2)].<br />
28 - 819 = 66 d. C.<br />
^ - IMP NERO CLAVD CAESAR AVG &ERM P M TR P<br />
XIII P P. Testa <strong>di</strong> N. ra<strong>di</strong>ata a d. - 9I - Sim. al 27.<br />
Dupon<strong>di</strong>o. Coh. Nero, n. 286. Parigi. (Tav. Ili n. 5).<br />
29 — 819 = 66 d. C.<br />
B' — IMP NERO CLAVD CAESAR AVG- GERM P M TR P<br />
XIII P P. Testa <strong>di</strong> N. laureata a d. - p — ROMA. Roma<br />
che, seduta a d. su <strong>di</strong> una lorica, tiene un'asta ed appoggia<br />
il braccio s. su <strong>di</strong> uno scudo; ai lati S C.<br />
Sesterzio. Coh. Nero, n. 287.<br />
30 — 819 = 66 d. C.<br />
3'_3 IMP NERO CLAVD CAESAR AVG GERM P M TR P<br />
XIII P P. Testa <strong>di</strong> N. laureata a destra. — p — ROMA.<br />
Roma galeata seduta a s. su varie armi, che stringendo<br />
l'asta tiene nella d. una piccola Vittoria alata che le porge<br />
un serto ; ai lati S C.<br />
Sesterzio. Fiorelli, Cat. n. 4358. (Tav. Ili n. 4).<br />
31 — 820 = 67 d. C.<br />
^ - NERO CAESAR AVG TR POT XIIII P P. Busto <strong>di</strong> N.<br />
laureato a d. con paludamento e lorica. — p — ROMA.<br />
Roma seduta a s. su <strong>di</strong> una corazza, avente in mano<br />
una Vittoria e un parazonio e poggiando il piede destro<br />
su <strong>di</strong> un elmo; ai lati S C.<br />
Sesterzio. Coh. Nero, n. 260.<br />
Le monete descritte abbracciano tutto il tempo<br />
deirimpero <strong>di</strong> Nerone, dal 54 ai primi mesi del 68,<br />
e ci dovrebbero fornire per conseguenza tutte le tras-
LA CRONOLOGIA DELLE MONETE DI NERONE, ECC. 281<br />
formazioni alle quali' andò soggetto il suo volto,<br />
dall'anno del suo elevamento al trono, quasi fino alla<br />
morte, ossia dall'età <strong>di</strong> se<strong>di</strong>ci anni a quella <strong>di</strong> trenta.<br />
Se confrontiamo le prime monete d'oro e d'argento<br />
con le ultime <strong>di</strong> bronzo, non possiamo non ammettere<br />
un passaggio notevole da un volto puerile a quello<br />
<strong>di</strong> uomo adulto, da un volto imberbe ad un volto<br />
virile. Ma è pur vero che le monete con la data dal<br />
54 al 63 sono esclusivamente <strong>di</strong> oro e d'argento e<br />
non ci forniscono neanche una sicura base <strong>di</strong> classifi-<br />
cazione, se vogliamo partire dai lineamenti del volto<br />
dell'imperatore, perchè hanno poca varietà; ed invece<br />
sul bronzo, dove il ritratto è più fedele, i dati cro-<br />
nologici <strong>com</strong>inciano dall'anno 64, un po' tar<strong>di</strong> veramente<br />
per la ricerca alla quale atten<strong>di</strong>amo. Se le due<br />
zecche avessero seguito sempre parallelamente lo<br />
sviluppo del tipo <strong>di</strong> Nerone, la serie dell'una potrebbe<br />
rischiarare la via colà dove l'altra ci vien meno, per<br />
modo che la serie d'oro e d'argento dal 54 al 63<br />
potrebbe aiutarci a classificare i bronzi <strong>di</strong> questi anni,<br />
sui quali non <strong>com</strong>pare mai la data; ma questa corrispondenza<br />
non vi è, il tipo <strong>di</strong> Nerone dell'una serie<br />
non trova un perfetto riscontro in quello dell'altra.<br />
Tuttavia la parte iconografica, <strong>com</strong>e mezzo <strong>di</strong> crono-<br />
logia, non è da trascurarsi in una monetazione così<br />
ricca <strong>di</strong> esemplari; e se da un lato <strong>di</strong>venta <strong>di</strong>fficile la<br />
ricerca, gioverà dall' altro a stabilire il metodo che<br />
potrebbe essere adottato per le serie <strong>di</strong> altri impera-<br />
tori, qualora la sola iconografia ci restasse per tentare<br />
una classificazione, <strong>com</strong>e nel caso presente.<br />
Alle monete <strong>di</strong> Nerone ha rivolta la sua attività<br />
un forte numismatico vivente, il D.' Friedrich<br />
Kenner (4), il quale ha preso <strong>com</strong>e principale scorta<br />
nel <strong>di</strong>fficile <strong>com</strong>pito <strong>di</strong> classificazione la leggenda del<br />
(4) Op. cit.<br />
36
282<br />
ETTORE CABRICI<br />
<strong>di</strong>ritto, senza trascurare però gli altri accessorii, <strong>com</strong>e<br />
il globetto, i segni del valore, la testa ra<strong>di</strong>ata o<br />
laureata, che hanno anche la loro importanza. Lo<br />
scritto del Kenner, assai pregevole per sottigliezza <strong>di</strong><br />
vedute, stabilisce le norme principali <strong>di</strong> una classifica-<br />
zione delle monete <strong>di</strong> Nerone. La parte iconografica<br />
è trattata in uno speciale capitolo, con uno sguardo<br />
largo e <strong>com</strong>prensivo, senza scendere ai particolari.<br />
Egli forma tre gruppi delle monete <strong>di</strong> bronzo, deri-<br />
vanti dalle tre maniere ond'è ritratta l'immagine <strong>di</strong><br />
Nerone.<br />
Una forma <strong>di</strong> ritratto, non molto scarsa, è facilmente<br />
riconoscibile dal capo esteso in larghezza e<br />
per lo più imberbe, coi lineamenti del viso fortemente<br />
impressi, che non appartengono in nessun modo<br />
all'età giovanile, bensì alla prima virilità, dopo s<strong>com</strong>parsa<br />
la lanuggine. Il rilievo è piatto, quin<strong>di</strong> anche<br />
un po' meno ricco <strong>di</strong> eff'etto; il profilo tuttavia assai<br />
vivace. La testa cosi incisa va <strong>di</strong> regola ac<strong>com</strong>pagnata<br />
con la piccola sfera posta all'estremità inferiore del<br />
collo. Questo tipo è rappresentato nelle nostre tavole<br />
dalle monete n. 16, 17, 18, 19 della tav. 1 e dalle<br />
monete n. i, 2, 3, 4 della tav. II.<br />
Un' altra specie <strong>di</strong> ritratto osservasi su <strong>di</strong> una<br />
serie assai più numerosa. Il capo è foggiato sopra<br />
una scala più piccola, è più alto il rilievo, il quale<br />
conferisce una finezza maravigliosa alle forme del<br />
volto. Il profilo è oltre ogni <strong>di</strong>re finissimo, l'accon-<br />
ciatura dei capelli manierata e artefatta, non più così<br />
naturale <strong>com</strong>e nei primi ritratti. Con un' intenzione<br />
palese è stato dato a questo capo un carattere gio-<br />
vanile, potrebbe <strong>di</strong>rsi apollineo, che qua e là certamente<br />
degenera nel manierato, nel molle; l'esecuzione<br />
è più accurata che negli antichi ritratti, la sfera<br />
ha ceduto il posto all'egida sul petto. I sesterzii n. 6,<br />
7, 8 della tav. II ci offrono questo ritratto.
LA CRONOLOGIA DELLE MONETE DI NERONE, ECC. 283<br />
Il terzo tipo, degli ultimi anni, ha le forme fiere,<br />
pronunziate, gli occhi incavati con espressione truce,<br />
le labbra sporgenti, il mento anch'esso sporgente, la<br />
barba tenuta con cura; i capelli minutamente delineati<br />
che scendono sulla nuca, <strong>com</strong>piono la selvaggia fi-<br />
gura. L'artista ha tentato <strong>di</strong> circondarla d'un' aureola<br />
<strong>di</strong> giovinezza, ma invece ci ha offerto un' immagine<br />
ricca <strong>di</strong> particolari che c'interessano. Ve<strong>di</strong> nella tav. Ili<br />
principalmente i n. 2, e2, 13, 15.<br />
Abbiamo creduto necessario <strong>com</strong>pen<strong>di</strong>are questa<br />
parte del lavoro del Kenner, perchè dovremo più<br />
volte riferirci ad essa, essendo la nostra classificazione<br />
fondata sullo stu<strong>di</strong>o della iconografia <strong>di</strong> Nerone.<br />
11 Kenner non poteva più felicemente aggruppare<br />
i tipi rispetto all'arte e rispetto alle apparenze dell'età;<br />
la sua osservazione, colà dove <strong>di</strong>ce che la figura <strong>di</strong><br />
Nerone sulle monete del secondo gruppo è alquanto<br />
abbeUita fino ad avere stu<strong>di</strong>atamente un non so che<br />
<strong>di</strong> apollineo, giunge opportuna a <strong>di</strong>leguare il dubbio<br />
che l'esame dei monumenti potrebbe ingenerare sul-<br />
l'anteriorità dei ritratti col globetto.<br />
Un particolare sfuggito agli occhi <strong>di</strong> tutt' i numismatici<br />
o, se osservato, non preso in quella con-<br />
siderazione che merita, è l'acconciatura dei capelli<br />
sulla fronte. 11 Bernoulli (s), pago delle conclusioni<br />
del Kenner, non curò neanche lui <strong>di</strong> esaminare le<br />
monete con quella scrupolosa osservazione che tanto<br />
lo <strong>di</strong>stingue nello stu<strong>di</strong>o dei monumenti.<br />
La singolarità della chioma <strong>di</strong> Nerone fu notata<br />
dal suo biografo Suetonio, il quale, parlando delle<br />
sue abitu<strong>di</strong>ni e del governo del corpo, ricorda che<br />
circa cultum habihimque adeo pudendus, ut <strong>com</strong>am<br />
semper in gradus formatam, peregrinatione achaica<br />
(5) Rómische Ikonographie, Nero, pag. 387-391.
284<br />
ETTORE CABRICI<br />
etiam pone verticem summiserit (6). Niente <strong>di</strong> più<br />
possibile per un uomo <strong>com</strong>e Nerone, fanatico <strong>di</strong><br />
apparire avvenente, anche sapendo <strong>di</strong> <strong>di</strong>ventare goffo<br />
e ri<strong>di</strong>colo.<br />
Negli ultimi anni della repubblica e nei primi<br />
dell'impero si usò <strong>di</strong> portare i capelli né lunghi né<br />
corti, senza <strong>di</strong>visione e senz' alcun abbigliamento,<br />
semplici e col loro naturale ripiego in avanti, leggermente<br />
abbandonati sulla fronte. Così è ritratto<br />
Augusto in tutt' i busti e le statue che si conoscono,<br />
così Tiberio e gli altri della famiglia Giulia, <strong>com</strong>e pure<br />
i loro contemporanei dei quali l'antichità ci ha tramandato<br />
i ritratti, così i Flavii sino agli Antonini,<br />
fatta eccezione <strong>di</strong> Nerone. Il giovane imperatore,<br />
corrotto e scioperato, aveva tutt' i <strong>di</strong>fetti dei suoi<br />
coetanei <strong>com</strong>pagni nelle capestrerie, dei quali parlano<br />
Ovi<strong>di</strong>o e Quintiliano (7). Varii busti <strong>di</strong> lui hanno i<br />
capeUi ravviati con molta ricercatezza. L'arte mone-<br />
tale <strong>com</strong>e fu fedele nel ritrarre le figure degli altri<br />
imperatori, andando <strong>di</strong> pari passo con l'arte plastica,<br />
così fu anche con Nerone. Se osserviamo infatti le<br />
teste e i busti che <strong>di</strong> lui si conservano, scorgeremo<br />
i capelli <strong>di</strong>segnati or in un modo or in un altro. E<br />
caratteristico quel sovrapporsi <strong>di</strong> riccioH dove più dove<br />
meno rilevati, da cui deriva quella chioma in gradns<br />
formatam, <strong>com</strong>e la chiama Suetonio. Ma per quanto<br />
prezioso sia questo passo dell' antico biografo e<br />
richiami il nostro stu<strong>di</strong>o su questa parte della icono-<br />
grafia <strong>di</strong> Nerone, pure il riscontro nei monumenti ci<br />
fornisce qualche particolare che Suetonio in fin dei<br />
conti non poteva rilevare; egU fa il ritratto <strong>di</strong> Nerone<br />
<strong>com</strong>e può farlo un biografo, e certe osservazioni che<br />
(6) Nero, 51. Tacito {Hist. II, 9) <strong>di</strong>ce in termini generali: Corpus<br />
insigne oculis <strong>com</strong>aque et torvitate vultus.<br />
(7) Cfr. OviD., Ars am. I, 507; III, 434. Quintil., Inst. orai. XII, io,<br />
47; I, 6, 44.
LA CRONOLOGIA DELLE MONETE DI NERONE, ECC. 285<br />
interessano oggi lo stu<strong>di</strong>oso d'iconografia non potevano<br />
e non possono interessare uno storico. L'esame<br />
<strong>di</strong> due sesterzii <strong>di</strong> Nerone varrà a chiarire quanto <strong>di</strong>co.<br />
Nell'esemplare n. 8 della tav. I abbiamo innanzi<br />
una bella testa <strong>di</strong> Nerone tra il giovanetto e l'adulto,<br />
con i capelli abbastanza lunghi, ripiegati in forma <strong>di</strong><br />
riccioli sulla nuca (proprietà <strong>com</strong>une a tutt' i Clau<strong>di</strong>i)<br />
aggiustati con una certa grazia sull'occipite e cadenti<br />
sulla fronte nella maniera naturale. La testa sugli<br />
esemplari n. 8 e i8 della tav. II è in tutto simile<br />
alla prima, se non che i capelli pettinati dal cocuzzolo<br />
alla fronte, in guisa da formare una gradazione ondulatoria,<br />
sulla fronte sono rivolti in su e dapprima<br />
rientranti, escono con l'estremità in fuori, circondandola<br />
a guisa <strong>di</strong> corona.<br />
La prima idea che ricorre alla mente è che<br />
questi due ritratti non sieno del medesimo anno e<br />
rappresentino due fasi, per così <strong>di</strong>re, della chioma<br />
<strong>di</strong> Nerone. Le monete <strong>di</strong> bronzo con i numeri <strong>di</strong><br />
carica, tutte degli ultimi anni (v. tav. II n. 17 e tav. Ili<br />
n. 2, 4, 5), potrebbero avvalorare la ipotesi, perchè<br />
hanno costantemente i capelli in su; ma un raro<br />
sesterzio <strong>di</strong> Parigi, unico a quanto pare, con la XIII<br />
potestas tribunicia, hai capelli lavorati alla prima<br />
foggia (v. tav. Ili n. 7). Dunque le due serie sono<br />
contemporanee, e una delle due sarà falsa e non<br />
rispondente al vero, perchè non possiamo ammettere,<br />
che Nerone si ravviasse i capelli ora in un modo ora<br />
nell'altro. Però la plastica, con la quale abbiamo detto<br />
essere d'accordo l'arte monetale, ci avverte, <strong>com</strong>e<br />
<strong>di</strong>cevamo poc'anzi, che le due specie <strong>di</strong> capigliatura<br />
esistettero: basti ricordare la famosa testa <strong>di</strong> bronzo<br />
della Biblioteca Vaticana W o quella della collezione<br />
(8) Bernoulli, Ikon., taf. XXIV.
286<br />
ETTORE CABRICI<br />
<strong>di</strong> Monaco (9). In tal caso possiamo piuttosto proporci<br />
<strong>di</strong> stu<strong>di</strong>are se le due serie siano in<strong>com</strong>inciate verso<br />
lo stesso tempo o se fra il principio dell'una e quello<br />
dell'altra intercedette qualche tempo. Qui possiamo<br />
ragionare per induzione. Una prova circa l'anterio-<br />
rità della prima pettinatura l'abbiamo nelle monete <strong>di</strong><br />
oro e d'argento con gli anni della tribunicia potestas.<br />
Su queste monete il capo dell'imperatore è<br />
tratteggiato sempre con i capelli in giù fino al 60<br />
(v. tav. I n. I, 2, 3); da questo anno fino al 63 i<br />
capelli sono <strong>di</strong>sposti intorno alla fronte con un appa-<br />
rente artifizio (v. tav. I n. 4, 5, 6, 7), finche non si<br />
perviene alla serie coi capelli in su. Perciò supponiamo<br />
che i bronzi con i capelli in giìi sieno stati i<br />
primi e che in seguito sia <strong>com</strong>parso 1' altro tipo,<br />
<strong>com</strong>inciato il quale, non fu sospesa la prima conia-<br />
zione, ma continuata con l'altra.<br />
Una sola cosa in questa monetazione non ci<br />
sappiamo spiegare, per soluzioni che abbiamo tentate,<br />
<strong>com</strong>e mai la serie con i capelli cadenti sulla fronte<br />
abbia sempre il capo dell'imperatore volto a sinistra,<br />
ed invece la serie coi capelli volti in su lo abbia<br />
sempre a destra. Singolarità tanto pili rilevante, in<br />
quanto, tranne questo particolare, entrambe le serie<br />
hanno molti lati <strong>com</strong>uni. La fisonomia dell'imperatore<br />
però non ha mai la stessa espressione in entrambe<br />
le serie. Evidentemente le mani che lavorarono i<br />
punzoni <strong>di</strong> una serie son <strong>di</strong>verse da quelle che lavoraron<br />
gli altri.<br />
Questo dualismo si può spiegare solo ammettendo<br />
che nella zecca <strong>di</strong> Roma vi siano state due<br />
scuole <strong>di</strong> artisti, seguenti ciascuna un unico tipo <strong>di</strong><br />
Nerone costantemente e fedelmente.<br />
Nell'arte monetale, a preferenza <strong>di</strong> ogn'altra arte.<br />
19) Id. taf. XXV.
LA CRONOLOGIA DELLE MONETE DI NERONE, ECC. 287<br />
certi tipi hanno esercitato una grande influenza sulle<br />
concezioni degli artisti successivi; tanto più nella<br />
zecca <strong>di</strong> Roma, che dobbiamo immaginare così numerosa<br />
d'artisti e quin<strong>di</strong> cosi produttiva <strong>di</strong> monete<br />
destinate a circolare per tutt' il mondo. In una serie<br />
<strong>di</strong> monete imperiali del medesimo imperatore, dello<br />
stesso anno, è <strong>di</strong>fficile trovarne due uscite dallo<br />
stesso conio, o, se il <strong>di</strong>ritto è uguale, non sarà così<br />
il rovescio. Delle zecche <strong>di</strong> Roma, del loro organamento<br />
interno , della <strong>di</strong>stribuzione dei carichi noi<br />
sappiamo assai poco, ma si deve ben credere che<br />
quella grande fabbrica <strong>di</strong> oricalco e <strong>di</strong> rame abbia<br />
avuto un numero considerevole d'artisti, non tutti<br />
certo dello stesso valore, ma chi più chi meno bravo,<br />
e che quelli i quali per età e per stu<strong>di</strong>i erano giu<strong>di</strong>cati<br />
migliori, regolassero gli artisti secondarii, creando i<br />
tipi che poi fedelmente erano riprodotti da questi con<br />
più o meno <strong>di</strong> <strong>com</strong>petenza. Così è che alcune monete<br />
non possono <strong>com</strong>petere con altre del medesimo anno<br />
per esattezza d'esecuzione e non rivelano una stessa<br />
mano d'artista.<br />
Nella serie monetale <strong>di</strong> Nerone <strong>di</strong>stinguiamo<br />
dunque tre tipi fondamentali : quello col globetto,<br />
quello con l'egida sul petto e i capelli in su ed un<br />
terzo tipo, spesso senz'egida né globetto, coi capelli<br />
rivolti in giù e la testa a sinistra. La classificazione<br />
generale potrebbe farsi coi seguenti criterii :<br />
Lasciando stare le monete d'oro e d'argento dei<br />
primi tre anni <strong>di</strong> regno le quali ci danno una testa<br />
<strong>di</strong> giovanetto, il tipo giovanile <strong>di</strong> Nerone dai 20 ai<br />
23 anni d'età ce lo forniscono le monete dello stesso<br />
metallo, degh anni 57, 58, 59, 60 (tav. I n. i, 2, 3):<br />
collo stretto, volto imberbe ed ovale, guancia ton-<br />
deggiante, chioma trascurata o almeno semplice e<br />
naturale <strong>com</strong>e quella d'Augusto, <strong>di</strong> Tiberio, <strong>di</strong> Cali-<br />
gola, <strong>di</strong> Clau<strong>di</strong>o, che scende sulla fronte. Nel 60 già
288 ETTORE CABRICI<br />
appare una leggiera mo<strong>di</strong>ficazione alla chioma; oltre<br />
ad avere quei caratteristici riccioli in gradus, i capelli<br />
della fronte non scendono più nella maniera naturale,<br />
ma sono <strong>di</strong>sposti a ciocche rivolte in su ed espresse<br />
dall'artista con una evidente <strong>di</strong>fficoltà (tav. I n. 4,5)^'°).<br />
Nel 60 appare dunque per la prima volta mo<strong>di</strong>ficata<br />
la chioma <strong>di</strong> Nerone in una serie non interrotta <strong>di</strong><br />
monete; il che è della più alta importanza, specie<br />
quando si osserva che in questo e nei successivi anni<br />
quella particolarità della chioma si cerca <strong>di</strong> riprodurla<br />
più fedelmente. Sopra un aureo dell'anno 60, benché<br />
un po' consumato, si <strong>di</strong>stinguono i capelli rivolti in su<br />
(tav. I, n. 6); ma un ritratto fedele, con quelle gra-<br />
dazioni <strong>di</strong> riccioli, <strong>di</strong>videnti la chioma in tre parti,<br />
l'abbiamo in un aureo del Museo <strong>di</strong> Napoli dell'anno<br />
63 (tav. I n. 7). I capeUi lunghi ed in su formano<br />
un rialzo che cinge la fronte d'ogn' intorno e danno<br />
al volto un'apparenza muHebre.<br />
Venendo ai bronzi, una serie monetale si <strong>di</strong>-<br />
stingue dalle altre per <strong>di</strong>verse particolarità <strong>di</strong> stile e<br />
per un accessorio notevole qual è un globetto collo-<br />
cato alla estremità del collo. Il n. 16 della tavola I<br />
è il prototipo <strong>di</strong> questi tipi. Carattere essenziale <strong>di</strong><br />
questa serie, oltre il globetto che basterebbe da solo<br />
a <strong>di</strong>stinguerla, è il poco rilievo. Quel che perde in<br />
altezza lo guadagna in ampiezza; il collo è largo, il<br />
contorno ben delineato, il volto sempre imberbe, i<br />
capelli eseguiti accuratamente, lo sguardo accighato.<br />
Non manca qualche immagine assai giovanile, dal<br />
collo stretto, <strong>com</strong>e quello del n. 18 tav. I.<br />
In questa serie appare per la prima volta il<br />
nuovo abbigliamento dei capelli <strong>di</strong> Nerone (tav. II<br />
n. I, 2, 3, 4). I riccioli della testa sono assai pro-<br />
(10) Un riscontro assai utile può farsi con la testa <strong>di</strong> Nerone che<br />
conservasi nel Museo Britannico (Bernoulli, Nero p. 398, fig. 59).
LA CRONOLOGIA DELLE MONETE DI NERONE, ECC. 289<br />
nunziati, così pure quelli della nuca e della fronte.<br />
Con l'apparire <strong>di</strong> questo tipo dai capelli in su non<br />
bisogna credere che quello col globetto e i capelli<br />
in giù sia stato abbandonato; per ritenere che sia<br />
durato ancora, abbiamo forti ragioni tratte dai tipi<br />
del rovescio ai quah si ac<strong>com</strong>pagna, <strong>com</strong>e vedremo<br />
nel Prospetto cronologico. Queste monete col glo-<br />
betto sono poco numerose e <strong>di</strong>mostrano che la<br />
coniazione loro fu scarsa e che durò pochi anni.<br />
Ma la serie piìi artistica e la più numerosa si<br />
manifesta con esemplari <strong>di</strong> una fattura squisita nei<br />
n.' 6, 7, 8, 9, IO, II, 13, 18 della tav. II. Il n. io<br />
rappresenta quanto <strong>di</strong> più perfetto è stata capace <strong>di</strong><br />
dare Tarte romana. L'incisore non poteva esser più<br />
felice nello stu<strong>di</strong>o dei particolari. Esso è il prodotto<br />
della creazione <strong>di</strong> un nuovo tipo che sarà copiato più<br />
o meno fedelmente tanto nei conii dell'oro e dell'argento<br />
quanto in quelli del bronzo. A ragione il Kenner<br />
vi vede un non so che <strong>di</strong> eroico, un non so che <strong>di</strong><br />
apollineo che traspare dall'insieme <strong>di</strong> esso. Invano<br />
adunque noi cercheremmo <strong>di</strong> classificare cronologicamente<br />
le monete <strong>di</strong> Nerone, se non tenessimo conto<br />
<strong>di</strong> questo abbellimento, <strong>di</strong> questa mo<strong>di</strong>ficazione che<br />
altera un poco le forme del suo volto e ci potrebbe<br />
far collocare queste monete nei primi anni del suo<br />
regno. Sui più antichi esemplari <strong>di</strong> questa nuova serie,<br />
che giunge fino al termine dell'impero <strong>di</strong> Nerone, la<br />
barba è appena accennata o talvolta non è accennata<br />
punto, ma in seguito è segnata con forti rilievi, <strong>com</strong>e<br />
nei n.' 8 e i8. Come nella serie precedente il globetto,<br />
così in questa è caratteristica l' egida sul petto.<br />
La nuova <strong>di</strong>sposizione dei capelli, già apparsa<br />
nella serie col globetto, ora <strong>di</strong>venta tipica. La testa è<br />
sempre rivolta a destra; lo sguardo fiero e gli occhi<br />
incavati, in questo tipo s<strong>com</strong>parvero per cedere il<br />
posto ad una serenità eroica. Una sobrietà <strong>di</strong> forme<br />
37
290 ETTORE CABRICI<br />
doveva appianare i <strong>di</strong>fetti e le sproporzioni naturali<br />
del volto del tiranno. Questo tipo lo chiameremo col<br />
Kenner tipo della Riforma, perchè si rannoda ad una<br />
serie <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficazioni intese ad un rior<strong>di</strong>namento<br />
generale della monetazione imperiale. È l'unico che<br />
troviamo nei sesterzii e dupon<strong>di</strong>i con gli anni della<br />
tribunicia potestas e perciò non può dubitarsi che<br />
sia l'ultimo apparso. Soltanto sugli esemplari ultimi<br />
r egida è quasi sempre s<strong>com</strong>parsa, il collo è assai<br />
largo, lo sguardo truce è caratteristico (tav. II n. 18<br />
e tav. Ili n. 1-8).<br />
Il famoso sesterzio che ha la Xll trib. pot. <strong>di</strong><br />
Nerone e il busto col paludamento, se ha la stessa<br />
fattura dei sopradescritti esemplari, ha però le fattezze<br />
del volto <strong>di</strong> gran lunga più giovanili che non appaiano<br />
sugli altri contemporanei (tav. II n. 17). Questo tipo è<br />
singolare per molte ragioni; prima perchè è l'unico,<br />
in tutta la serie, che abbia il busto così riccamente<br />
ornato, poi perchè non è un ritratto <strong>di</strong> Nerone rispondente<br />
a quelli delle altre monete contemporanee. Noi<br />
sospettiamo che l' artista abbia voluto riprodurre<br />
qualche statua <strong>di</strong> Nerone assai nota in Roma per<br />
la sua bellezza artistica.<br />
Per grande che sia stato lo sviluppo e l'influenza<br />
<strong>di</strong> questo nuovo tipo della moneta neroniana, è certo<br />
però che esso non fu il solo ad essere continuato.<br />
Il tipo primitivo dai capelli cadenti sulla fronte,<br />
sempre rivolto a sinistra, che abbiamo visto nella<br />
serie col globetto, lo troviamo durante il periodo<br />
della riforma. Esso è rappresentato dalla testa del<br />
sesterzio n. 8 tav. I.<br />
Conserva molto della fattura dei primi aurei: la<br />
guancia è tonda, gli occhi non incavati e senz'alcun<br />
aspetto truce, i capelli con riccioli cadenti sulla fronte<br />
ed artisticamente <strong>di</strong>sposti sulla nuca, sotto il nodo<br />
del lemnisco, spiegati a guisa <strong>di</strong> ventaglio. Di questa
LA CRONOLOGIA DELLE MONETE DI NERONE, ECC. 29I<br />
fattura non possiamo citare nessun altro sesterzio, ma<br />
possiamo bene citare un dupon<strong>di</strong>o riportato nella tav. I<br />
n. 9 e alcuni sesterzii, la cui <strong>di</strong>pendenza da questo è<br />
in<strong>di</strong>scutibile. Tali sono i sesterzii n. io, 1 1, 13 della tav. 1,<br />
ai quali va unito il dupon<strong>di</strong>o n. 12 della stessa tavola.<br />
Un asse coi capelli che ricordano assai da vicino<br />
quelli dell' aureo n. 7 della tav. I appartiene alla<br />
collezione Santangelo, ed è certamente dello stesso<br />
tempo (tav. I n. 14). L'artista <strong>di</strong> fronte alla <strong>di</strong>fficoltà<br />
<strong>di</strong> esprimere il rialzo dei capelli, ingegnosamente<br />
<strong>di</strong>spone le linee in modo da in<strong>di</strong>care che non sono<br />
i soliti capelli scendenti sulla fronte.<br />
I numerosi ritrovamenti <strong>di</strong> monete fatti a Pompei<br />
ci offrono un considerevole numero <strong>di</strong> esemplari col<br />
tipo della testa a sinistra dai capelli in giù, ma coi<br />
lineamenti <strong>di</strong> Nerone degli ultimi anni. Se si considera<br />
che il tipo col globetto è così raro nei trovamenti<br />
<strong>di</strong> Pompei, da essere pressoché sconosciuto e che<br />
il tipo della riforma abbonda notevolmente, potremo<br />
fin da ora tenere per indubitato che queste monete<br />
col capo a sin. abbiano avuto al loro apparire una<br />
scarsa coniazione, la quale <strong>di</strong>venne abbondante negli<br />
ultimi anni. Un esame superficiale <strong>di</strong> queste monete<br />
rinvenute a Pompei <strong>di</strong>ssipa ogni dubbio. Le forme<br />
del capo sono assai sviluppate, il collo taurino arriva<br />
a tale esagerazione, che quasi non si può <strong>di</strong>re dove<br />
in<strong>com</strong>inci, l'estremità del mento è sporgente, fino a<br />
trovarsi sulla linea del naso, lo sguardo feroce e gli<br />
occhi infossati (tav. Ili n. 11-15).<br />
Da una statistica delle monete <strong>di</strong> Nerone appar-<br />
tenenti alle pubbliche collezioni <strong>di</strong> Napoli, <strong>di</strong> Santangelo<br />
e a quella privata <strong>di</strong> Francesco Gnecchi, nonché<br />
ai depositi del Museo Nazionale formati <strong>di</strong> monete<br />
<strong>di</strong> provenienza pompejana, risulta che queste monete<br />
sono assai scarse rispetto a quelle della Riforma,<br />
perchè abbiamo avuto i seguenti risultati:
292<br />
ETTORE CABRICI<br />
Depositi del Museo Nazionale<br />
Sesterzii del i'^ tipo, cioè col globetto . . . . n. 5<br />
„ del 2° „ cioè con la testa rivolta a s. „ 36<br />
„ del 3° „ cioè della Riforma . . . „ 128<br />
Dupon<strong>di</strong>i del 1° tipo n. —<br />
del 2«<br />
„ „ 8<br />
del 3« „ „ 49<br />
Assi del 1° tipo n. 3<br />
« del 2° „ „ 16<br />
del 3° „ ,,162<br />
Totale: monete del 1° tipo 8; del 2° tipo 60; del 3° tipo 339.<br />
Medagliere inventariato dal Fiorelli<br />
Sesterzii del 1° tipo n.
LA CRONOLOGIA DELLE MONETE DI NERONE, ECC. 293<br />
Assi del 1° tipo n. 8<br />
„ del 2" „ „ i8<br />
del a'' „ „ 123<br />
Totale: monete del i° tipo 31; del 2° tipo 36; del 3° tipo 219.<br />
Medagliere Gnecchi<br />
Sesterzti del i" tipo n. io<br />
del 2° „ „ 14<br />
„ del 3° „ „ 28<br />
Dupondu del 1° tipo n. —<br />
„ del 2° „ „ 5<br />
del 3° „ „ II<br />
Assi del 1° tipo n. 13<br />
del 2°<br />
„ „ 8<br />
del 3° „ „ 18<br />
Totale: monete del 1° tipo 23; del 2"* tipo 27; del 3° tipo 57.<br />
La somma <strong>com</strong>plessiva delle monete <strong>di</strong> Nerone<br />
da noi stu<strong>di</strong>ate supera, <strong>com</strong>e si vede, il numero <strong>di</strong><br />
1000, del quale le monete del 2° tipo rappresentano<br />
assai meno della 5^ parte, laddove le monete <strong>di</strong> 3°<br />
tipo rappresentano le tre quarte parti; il resto è<br />
costituito dalle monete col globetto. Non dobbiamo<br />
noi dunque conchiudere che il 2° tipo fu assai poco<br />
coniato? Pili scarso ancora è il tipo col globetto;<br />
eppure durò dal 56 al 63, ben sette od otto anni.<br />
La ragione <strong>di</strong> tanta scarsezza cre<strong>di</strong>amo <strong>di</strong>penda dalle<br />
con<strong>di</strong>zioni economiche dell'Impero.<br />
La floridezza dello Stato con Augusto, Tiberio<br />
ed anche con Clau<strong>di</strong>o aveva accresciuto il <strong>com</strong>mercio,<br />
e una copia stragrande <strong>di</strong> moneta circolava nell'Italia<br />
e specialmente in Roma; tanto che coli' avvenimento<br />
<strong>di</strong> Nerone al trono non si sentì il bisogno <strong>di</strong> emettere<br />
altra moneta; quella che circolava era più che
294<br />
ETTORE CABRICI<br />
sufficiente. Perciò nei primi anni la zecca <strong>di</strong> Roma<br />
fu inerte e quando dopo un certo numero <strong>di</strong> anni,<br />
forse nel 56, si <strong>com</strong>inciò a coniare moneta <strong>di</strong> bronzo,<br />
non fu mestieri emetterne molta. Per questa ragione<br />
principalmente le monete del primo tipo sono scarse.<br />
II.<br />
Quando <strong>com</strong>incia il tipo della Riforma.<br />
La materia stessa ci trae adesso a determinare<br />
l'anno in cui <strong>com</strong>inciò il tipo della Riforma.<br />
Il tipo <strong>di</strong> Nerone dai capelli rivolti in su già lo<br />
abbiamo visto <strong>com</strong>parire nella serie col globetto e<br />
secondo noi rappresenta l'ultima e più perfetta fase<br />
<strong>di</strong> essa. Se non possiamo per ora in<strong>di</strong>care l'anno<br />
<strong>di</strong> tale <strong>com</strong>parizione , abbiamo almeno un dato<br />
cronologico importante nelle serie dell'oro e dell'ar-<br />
gento. Una spia sicura per l' apparizione <strong>di</strong> questo<br />
tipo nuovo è offerta dalle monete <strong>di</strong> città greche o<br />
<strong>di</strong> colonie romane, coniate sotto la dominazione <strong>di</strong><br />
Nerone e aventi l' in<strong>di</strong>cazione dell' anno della loro<br />
emissione.<br />
Queste zecche, cui nell'epoca imperiale era data<br />
facoltà <strong>di</strong> coniare moneta <strong>di</strong> bronzo con l'immagine<br />
dell'imperatore, si attenevano sempre al tipo delle<br />
monete uscenti dalla zecca <strong>di</strong> Roma e ne copiavano<br />
fedelmente alle volte il ritratto od il rovescio, e anche<br />
quando non segnavano l'anno della emissione, pure<br />
la <strong>di</strong>pendenza per questo rispetto era tale, da non<br />
lasciar dubbio <strong>di</strong> sorta. Il tipo della Vittoria gra<strong>di</strong>ente<br />
con corona e lungo ramo <strong>di</strong> palma, tanto frequente<br />
sui dupon<strong>di</strong>i <strong>di</strong> Nerone, il tipo del Citaredo, anch'esso
LA CRONOLOGIA DELLE MONETE DI NERONE, ECC. 295<br />
frequente, li ve<strong>di</strong>amo <strong>com</strong>parire fedelmente riprodotti<br />
l'uno sulle monete <strong>di</strong> Tessalonica e <strong>di</strong> Apollonoshieron<br />
(tav. V n. 2), l'altro su quelle <strong>di</strong> Perinto e <strong>di</strong> Patrasso,<br />
e sic<strong>com</strong>e vanno quasi sempre ac<strong>com</strong>pagnati dal tipo<br />
<strong>di</strong> Nerone della Riforma, possiamo sicuramente conchiudere<br />
che tali monete <strong>di</strong> zecca greca non sono<br />
anteriori alla prima emissione del tipo della Riforma.<br />
Questa induzione si fa con le monete senza data <strong>di</strong><br />
sorta; e per quelle con la data? Allora sì che avremo<br />
un dato cronologico in<strong>di</strong>scutibile.<br />
Questa maniera <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>are la serie imperiale<br />
greca può in molti casi fornirci una prova della più<br />
alta importanza storica in quelle serie imperiali romane,<br />
dove manca l'in<strong>di</strong>cazione delle cariche, e forse<br />
l'unico dato cronologico, sicurissimo per altro, quando<br />
saremmo per rinunziare alla classificazione.<br />
Abbiamo descritto nell'elenco che offriamo agli<br />
stu<strong>di</strong>osi in fine <strong>di</strong> questo capitolo, una gran parte <strong>di</strong><br />
quelle monete greche dell'età <strong>di</strong> Nerone aventi l'anno<br />
<strong>di</strong> loro emissione, in<strong>di</strong>cando sempre la maniera ond' è<br />
aggiustata la chioma <strong>di</strong> Nerone, cioè se con i capelli<br />
scendenti sulla fronte ovvero rivolti in su. Abbiamo<br />
<strong>com</strong>preso inoltre le monete senza dato cronologico,<br />
sulle quali l'immagine <strong>di</strong> Nerone è accoppiata con<br />
quella della madre Agrippina o <strong>di</strong> alcuna delle sue<br />
mogli. Tali monete se non ci forniscono una data<br />
certa, si possono bene circoscrivere in un determi-<br />
nato giro <strong>di</strong> anni e giovarci all'uopo.<br />
Notevole fra tutte è la ricca serie delle monete<br />
alessandrine, che dal 54 scende senza interruzione<br />
fino al 67 o 68. La testa <strong>di</strong> Nerone negli anni 54,<br />
56; Sii 58, 59, 60, 61, 62, è sempre ritratta allo<br />
stesso modo, coi capelli in giij ; nell'anno 63 si nota,<br />
ma non sempre, una deviazione dei capelli dalla<br />
or<strong>di</strong>naria <strong>di</strong>rezione con due o tre linee rivolte in su.<br />
Continua intanto la prima forma. Nel 64 abbiamo
296<br />
ETTORE CABRICI<br />
esemplari della prima forma ed esemplari coi capelli<br />
alquanto mo<strong>di</strong>ficati <strong>com</strong>e nel 63; e così negli anni<br />
successivi, fino a quando nell'anno 67 abbiamo quasi<br />
il tipo della Riforma.<br />
Ma Alessandria si tenne forse un po' troppo<br />
fedele all'antico ritratto <strong>di</strong> Nerone. Antiochia che fino<br />
a tutto il 63 aveva anch' essa conservato la forma<br />
stereotipata dei primi anni, nel 64 <strong>di</strong> botto passa al<br />
tipo nuovo che troviamo continuato nel 66. L'identico<br />
passaggio avviene nella sua serie senza data. Ma qui<br />
basta solo ricordarlo.<br />
Le colonie <strong>di</strong> Corinto e <strong>di</strong> Patras, <strong>com</strong>echè senza<br />
data, pure giovano alla ricerca nostra, perchè le<br />
loro monetine <strong>di</strong> bronzo con la leggenda ADVENT • AVGnon<br />
sono anteriori alla seconda metà dell' anno 66.<br />
Ebbene<br />
Riforma.<br />
queste hanno quasi sempre il tipo della<br />
Il tipo nuovo appare anche sulle belle monete<br />
<strong>di</strong> Caesarea Cappadociae nel 63 (tav. IV n. 3), su<br />
quelle <strong>di</strong> Gadara nel 65 (tav: V n. 7), <strong>di</strong> Caesarea<br />
Samariae (tav. V n. 8), <strong>di</strong> Augusta (tav. V n. 6), <strong>di</strong><br />
Sebaste (tav. V n. 11), <strong>di</strong> Nicaea, (MiUingen, Sylloge<br />
of ancient coins, ecc. PI. Ili n. 38) nell' anno 67 e<br />
nei primi mesi del 68.<br />
Ma sopra tutte ha una importanza sconfinata<br />
la bellissima moneta d'argento <strong>di</strong> Lao<strong>di</strong>cea <strong>di</strong> Siria,<br />
per l'anno della sua emissione che è il 63.<br />
Noi non presumiamo d'aver raccolto in questo<br />
catalogo, che segue, tutte le monete greche degli anni<br />
dell'impero <strong>di</strong> Nerone aventi un dato cronologico,<br />
ma cre<strong>di</strong>amo che bastino allo scopo <strong>di</strong> spiare in quale<br />
anno più o meno appaia il nuovo tipo <strong>di</strong> Nerone.<br />
Salvo il caso che nuove scoperte o monete a noi<br />
ignote esistenti in collezioni pubbliche e private, non<br />
ci smentiscano, si può ritenere che questo tipo faccia<br />
capolino sulle monete <strong>di</strong> Alessandria e <strong>di</strong> Caesarea
LA CRONOLOGIA DELLE MONETE DI NERONE, ECC. 297<br />
Cappadociae neir anno 63, su quelle <strong>di</strong> Antiochia,<br />
salvo mo<strong>di</strong>ficazione, nel 64. Ma V anno più antico<br />
della sua apparizione è il 63.<br />
Lo stu<strong>di</strong>o delle monete greche, conferma dunque<br />
il sospetto che il nuovo tipo della Riforma sia co-<br />
minciato nel 63. E <strong>di</strong>fatti, se si considera bene, varie<br />
altre prove in<strong>di</strong>rette concorrono alla medesima con-<br />
chiusione e a far presumere che nell'anno 63 il governo<br />
<strong>di</strong> Roma abbia cercato <strong>di</strong> regolare la monetazione<br />
in conformità delle con<strong>di</strong>zioni economiche<br />
dello Stato. Le monete d' oro conservavano ancora<br />
il peso me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> 7,60 che fu ridotto a 7,28; quelle<br />
d'argento dal peso me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> gr. 3,40 scesero a quello<br />
<strong>di</strong> gr. 3,18. In quest'anno cre<strong>di</strong>amo che sia stata<br />
<strong>di</strong>sciplinata la lega dell' oricalco, scaduto dopo Augusto,<br />
e fatta una revisione generale delle monete<br />
<strong>di</strong> bronzo, imprimendo su quelle <strong>di</strong> giusto peso e<br />
<strong>di</strong> buona lega la contromarca NCAPR. Fu <strong>com</strong>inciato<br />
a coniare l' asse d' oricalco, mentre prima questo<br />
nominale non si conosceva che <strong>di</strong> rame, e lo argomentiamo<br />
dal tipo <strong>di</strong> Nerone che è sempre quello<br />
della Riforma. Assi d'oricalco col primo o col secondo<br />
tipo non se ne conoscono. Questa è una vera riforma<br />
monetale e le nuove monete col nuovo tipo pigliano<br />
nome da essa.<br />
Anno 54.<br />
Alexandria (Bigi.) — NEPH KAAV KAI2 lEB .<br />
. . Testa <strong>di</strong><br />
Nerone a d. con corona ra<strong>di</strong>ata (capelli in giù).<br />
P — AYTOKPA. Aquila a s. con ramo <strong>di</strong> palma, poggiato<br />
all'ala; innanzi LA.<br />
Fiorelli, Cat. n. 9576-77.
298 ETTORE CABRICI<br />
Anno 56.<br />
Alexandria (Bigi.) — NER KAAY KAI . . . TEP AYTO. Testa<br />
<strong>di</strong> N. laur. a d. (capelli in giìi).<br />
9 - APPinniNA lEBAITH. Busto <strong>di</strong> Agrippina a d.;<br />
innanzi Lf.<br />
Fiorelli, Cai. n. 9608 — Gotha.<br />
- (Bigi.) - NEP KAAY KAIZ lEB TEP . . . Testa<br />
<strong>di</strong><br />
N. laur. a d. (capelli in giù).<br />
P — NEO ArAe AAIM. Serpente mitrato a d. che si erge<br />
sulla coda fra spighe e papaveri; innanzi Lf.<br />
Vienna.<br />
- (Bigi.) - NEP KAAY KAII 2EB TEP AYTO. Testa<br />
<strong>di</strong> N. laur. a d. (capelli in giù).<br />
^ — OKTAYIA lEBAITOY. Busto <strong>di</strong> Ottavia a d.; innanzi<br />
Lf.<br />
Gotha — Santang., Cat. n. 11809 (Tav. IV n. 7).<br />
Sidon (Br.) — Testa <strong>di</strong> N. laur. a d. ; innanzi al petto un astro<br />
(capelli in giù).<br />
]^ — IIAANOI GEAI. Europa sul toro, a d.; sopra SIP.<br />
Sanclem, t. II, tab. XV n. 52.<br />
Anno 57.<br />
Alexandria (Bigi.) — NEPXl ZEB TEP AY. Busto <strong>di</strong> N.<br />
a s. con corona rad. ed egida sull'omero; innanzi LA<br />
(capelli in giù).<br />
9^ — AnOAAriN. Busto laur. <strong>di</strong> Apollo a d. con<br />
la faretra sull'omero; innanzi una stella.<br />
Vienna.<br />
- (Bigi.) — . . . . KAAY KAII ZEBA TEP . . Testa<br />
<strong>di</strong> N. laur. a d. (capelli in giù).<br />
^ — OKTAOYI .... Busto <strong>di</strong> Ottavia a<br />
Vienna.<br />
d. ; innanzi<br />
_<br />
LA.
LA CRONOLOGIA DELLE MONETE DI NERONE, ECC. 299<br />
Alexandria (Bigi.) — NEPH KAAY KAIZ lEBA TEP AYTO.<br />
Testa <strong>di</strong> N. laur. a d. (capelli in giù).<br />
P — NEO A M. Serpente mitrato a d. che si erge<br />
sulla coda fra spighe e papaveri; a d. LA.<br />
Vienna — Santang. n. 11707.<br />
— (Bigi.) - KAIZ ZEB TER Testa <strong>di</strong><br />
N. laur. a d. (capelli in giij).<br />
91 — TER. Cerere in pie<strong>di</strong> a s., poggiata ad alta<br />
face e con le spighe in mano; innanzi LA.<br />
Fiorelli, Cut. n. 9578.<br />
Anno 58.<br />
Alexandria (Bigi.) — NEPfl KAAY KA Testa <strong>di</strong> N. laur.<br />
a d. (capelH in giij).<br />
5^ — AHMHTEP. Cerere in pie<strong>di</strong> a s., poggiata a lunga<br />
asta e con le spighe nella d. ; innanzi LE.<br />
Santang., Cat. n. J1708.<br />
- (Bigi.) - NEPriN KAAY KAIZ ZEBA TEP AYTO.<br />
Testa <strong>di</strong> N. laur. a d. (capelli in giìi).<br />
P — IPHNH. La Pace in pie<strong>di</strong> a d. col caduceo in una<br />
mano e nell'altra una galea; innanzi LE.<br />
Fiorelli, Cat. n. 9579.<br />
- (Bigi.) - NEPn KAAY KAI . . . AYTO. Testa <strong>di</strong><br />
N. laur. a d. (capelH in giù).<br />
^ — NEO A AAIM. Serpente mitrato a d. che si<br />
erge sulla coda fra spighe e papaveri; a d. LE.<br />
Fiorelli, Cat. n. 9580.<br />
- (Bigi.) - NEPAN KAA ZEBA TEP AYTO.<br />
Testa <strong>di</strong> N. laur. a d. (capelli in giù).<br />
^ — Donna seduta a s. con una patera nella d. ;<br />
avanti LE.<br />
Vienna.
300<br />
ETTORE GABRICI<br />
Anno 59.<br />
Alexandria (Bigi.) - NEPHN KAÀY KAIZ 2EB .... Testa <strong>di</strong><br />
N. laur. a d. (capelli in giù).<br />
^ — AHMHTEP. Tipo <strong>di</strong> Cerere; innanzi LS.<br />
Santang., Cai. n. 11709.<br />
Dal 54 AL 59.<br />
Creta (Arg.) - NERO CLAVD DIVI CLAVD F CAESAR AVO<br />
GERMANI. Testa <strong>di</strong> N. laur. a d. (capelli in giù).<br />
Ar* —<br />
^ — Testa d'Agrippina a d.; <strong>di</strong>etro ._, avanti KA; in<br />
corona d'alloro.<br />
Svoronos, Numism. de la Crete, pi. XXXII, n. 26 [variante n. 27].<br />
Anno 60.<br />
Antiochia ad Or. (Arg.) - NEPANOI KAIIAP Testa <strong>di</strong><br />
N. laur. a d. con egida sull'omero (capelli in giù).<br />
5^ — Aquila sopra un fulmine a s., con ali aperte; in-<br />
nanzi ramo <strong>di</strong> palma, a d. t^flHP.<br />
Fiorelli, Cat. n. 8876.<br />
Anno 61.<br />
Alexandria (Br.) - NEP KAAY KAI ... Testa <strong>di</strong> N, laur. a<br />
d. (capelli in giù).<br />
9I — AYTOKPAT. Busto del Genio <strong>di</strong> Alessandria a d.,<br />
con pelle <strong>di</strong> elefante sul capo; innanzi LH.<br />
Fiorelli, Cat. n. 9581.<br />
Antiochia (Arg.) - NEPHNOI KAI ... lEBAITOI. Testa <strong>di</strong><br />
N. laur. a d. con egida sull'omero (capelli in giù).<br />
9' — Aquila sul fulmine a s., con ali spiegate, avanti<br />
ramo <strong>di</strong> palma, <strong>di</strong>etro gp..<br />
Vienna.
LA CRONOLOGIA DELLE MONETE DI NERONE, ECC. 3OI<br />
Anno 62..<br />
Antiochia (Arg.) - NEPHNOI KA Testa <strong>di</strong> N. a d.<br />
laur. e con egida sull'omero (capelli in giù).<br />
^ — Aquila sul fulmine a s. con ali spiegate; in-<br />
nanzi un ramo <strong>di</strong> palma, <strong>di</strong>etro . ".<br />
Vienna — Gotha.<br />
Dal 53 AL 62.<br />
Cnossus (Br.) — NERO CLAV CÀES AVG IMP VOLVMNIO<br />
LVPIIHD II. Testa <strong>di</strong> N. a d. con uno scettro sulla<br />
spalla sinistra (capelli in giù).<br />
5/ - NERO CLAVD CAES AVO IMP ET OCTAVIA AVGVSTI.<br />
Teste <strong>di</strong> Nerone e Ottavia <strong>di</strong> fronte, delle quali l'una<br />
è sormontata dalla mezzaluna, l'altra da una stella.<br />
Santang. [Tav. V n. i]. Svoronos, Nutnism. de la Crete, pi. Vili<br />
n. 26 e 27. Questa moneta è stata falsamente attribuita a Corinto.<br />
Teos (Br.) — NEPHN THIflN. Tempio <strong>di</strong>stilo <strong>di</strong> fronte, entro'<br />
cui la testa giovanile <strong>di</strong> Nerone a d. (capelli in giù).<br />
9* — OKTAOYIAN. Busto <strong>di</strong> Ottavia a d. con <strong>di</strong>adema.<br />
Imhoof-BIumer [Tav. IV n. 6] — Gotha.<br />
Anno 63.<br />
Alexandria (Bigi.) - NEPH KAAY KAII lEB TEP. Testa <strong>di</strong><br />
N. a d. con corona rad. (capelli in giù).<br />
^ — .<br />
. . . KPA.<br />
capo; innanzi LI.<br />
Busto <strong>di</strong> Serapide a d. col mo<strong>di</strong>o sul<br />
Fiorelli, Cat. 9582 — Vienna.<br />
— (Bigi.) - NEPn KAAY KAII lEB TEP AY. Testa<br />
<strong>di</strong> N. a d. con corona rad. (capelli alquanto mo<strong>di</strong>ficati).<br />
9I — nonnAlA IEBAITH. Busto <strong>di</strong> Poppea a d. ; in-<br />
nanzi LI.<br />
Fiorelli, Cat. n. 9609-10 — Santang., Cat. n. 1181012 — Vienna<br />
[Tav. IV n. 8].
302 ETTORE CABRICI<br />
Antiochia ad Or. (Arg.) — NEPriN KAIZÀP lEBÀITOI. Testa<br />
<strong>di</strong> N. laur. a d. con egida sull'omero (capelli in giù).<br />
p — ETOYZ AlP • O. Aquila sopra un fulmine a d. con<br />
ali aperte; innanzi un ramo <strong>di</strong> palma.<br />
Fiorelli, Cat. 8877 [Tav. IV n. 1] — Vienna - Gotha.<br />
Caesarea Cappadociae (Arg.) — NERO CLAVDIVS CLAVD F<br />
CAESAR AVG GERM. Testa laur. <strong>di</strong> N. a d. (capelli in su).<br />
9* — ET I. Il monte Argeo, sulla cima del quale sta<br />
l'imperatore in pie<strong>di</strong>, tenendo un globo nella mano<br />
destra, la sinistra sull'asta.<br />
Parigi, Mionn. IV, p. 409, n. 17 [Tav. IV n. 3].<br />
Lao<strong>di</strong>caea Syriae (Arg.) — NEPHNOC CEBACTOY KAICAPOC.<br />
Testa laur. <strong>di</strong> N. a d., avanti le lettere Ol (capelli in su).<br />
^ — lOYAlEflN TAN KAI AAGAIKEHN. Testa velata e<br />
turrita <strong>di</strong> donna, a d.; <strong>di</strong>etro APIC, avanti AlP, nelFe-<br />
sergo ICA.<br />
Parigi, Mionn. V, pag. 248 n. 719, riprodotta nel Suppl. Vili, pi.<br />
XVI n. 3. [Tav. IV n. 11].<br />
Anno 64.<br />
Alexandria (Bigi.) — NEPH KAAY KAIZ ZEB TEP. Testa <strong>di</strong><br />
N. a d. con corona rad. (capelli in giù).<br />
P — AYTOKPA. Busto <strong>di</strong> Serapide a d., col mo<strong>di</strong>o sul<br />
capo; innanzi L lA.<br />
Fiorelli, Cat. n. 9583 — Santang., Cat. n. 1 1710-18 (Serapide ha il<br />
<strong>di</strong>adema).<br />
— (Bigi.) - NEPn KAAY KAIZ ZEB TEP. Busto <strong>di</strong> N.<br />
a d. con corona rad. ed egida sull'omero (capelli in giù).<br />
Ij^ — AYTOKPA. Aquila a s. con ramo <strong>di</strong> palma pog-<br />
giato sull'ala; innanzi L lA.<br />
Vienna [Tav. IV n. 9] — Fiorelli, Cat. n. 9584 e 9585; Santang.,<br />
Cat. n. 11719-30 (varianti).
LA CRONOLOGIA DELLE MONETE DI NERONE, ECC. 303<br />
Alexandria (Bigi.) — NEPfi KAAY KAII lEB TEP AY. Testa <strong>di</strong><br />
N. a d. con corona rad. (capelli alquanto mo<strong>di</strong>ficati).<br />
^ — nonnAIA IEBAITH. Busto <strong>di</strong> Poppea a d., innanzi<br />
LIA.<br />
Vienna -Gotha [Tav. IV n. io] — Santang., Cat. n. 11813-15.<br />
Antiochia ad Or. (Arg.) — NEPflN KAIZAP lEBAITOI. Testa<br />
<strong>di</strong> N. laur. a d. con egida sull'omero (capelli in su).<br />
^ — ETOYX BIP-I. Aquila sopra un fulmine a d., con<br />
ali aperte; innanzi ramo <strong>di</strong> palma.<br />
Fiorelli, Cat. n. 8879 [Tav. IV n. 2] — Vienna [Tav. IV n. 4].<br />
Caesarea Cappadociae (Arg.) — NERO CLAVDIVS CLAVD F<br />
CAESAR AVG- G-ERM. Testa laur. <strong>di</strong> N. a d. (capelli in su).<br />
5^ — ET lA. Il monte Argeo .... (<strong>com</strong>e sopra).<br />
Parigi, Miomu IV, p. 409 n. 17 [Tav. IV n. 5].<br />
Cabala (Br.) — Testa <strong>di</strong> N. laur. a d. (capelli in giù).<br />
p — TABAAEllN. Donna seduta a s., tenendo un papavero<br />
nella s., ai pie<strong>di</strong> una sfinge accoccolata; nel campo<br />
SQ MA; nell'esergo SE.<br />
Parigi, Mionn. V, p. 234 n. 629 [Tav. V n. 9].<br />
Anno 65.<br />
Alexandria (Bigi.) — NEPA KAAY KAII ZEB TEP. Testa <strong>di</strong> N.<br />
a d. con corona rad. ed egida sull'omero (capelli in glia).<br />
^ — AYTOKPA. Busto del Genio <strong>di</strong> Alessandria a d.<br />
con pelle <strong>di</strong> elefante sul capo; innanzi L IB.<br />
Fiorelli, Cat. n. 9586-88 — Vienna (2 esempi.) — Santang., Cat.<br />
n. 11731-67.<br />
Damascus (Br.) — .<br />
. . . Testa <strong>di</strong> N. laur. a. d., avanti lituo<br />
(capelli in giù).<br />
^ — AAMACKHNXIN ZOT. Donna turrita sedente sur una<br />
roccia e rivolta a s., avendo il braccio d. <strong>di</strong>steso e<br />
tenendo con la s. un cornucopia.<br />
Parigi, Mionn. V, p. 286 n. 34; De Saulcy, Numism. de la Terre<br />
Sainte, pi. II n. 5.
304<br />
ETTORE CABRICI<br />
Gadara (Br.) - NEPAN KAICAP. Testa <strong>di</strong> N. laur. a d. (ca-<br />
pelli in su).<br />
IJi — fÀAÀPA. Astarte in pie<strong>di</strong> a s. con corona in una<br />
mano e nell'altra il cornucopia; a s. ramo <strong>di</strong> palma,<br />
a d. astro, innanzi L AAP.<br />
Fiorelli, Cat. n. 9153 — Parigi (senza l'astro; De Saulcy, Num.<br />
de la T. S., pi. XV n. 2) [Tav. V n. 7].<br />
— (Br.) — NEPAN. Testa <strong>di</strong> N. laur. a d. (capelli in su).<br />
^ — FAAAPEflN LAAP. Due cornucopia <strong>di</strong>sposti a<br />
croce.<br />
Parigi, Mionn, V, pag. 323 n. 24; De Saulcy, Num. de la T. S.,<br />
pi. XV n. 3.<br />
Sidon (Br.) — Testa <strong>di</strong> N. laur. a s., avanti lituo (capelli<br />
in giù).<br />
^ — IlAnNOZ L EOP. Europa sul toro, a d.<br />
Parigi, Mionn. V p. 381 n. 308 — Lòbbecke (con la leggenda va-<br />
riata) — Sanclement. (variante, coi capelli in su, T. II, tab. XV, n. 53).<br />
Dal 62 AL 65.<br />
Ephesus (Br.) — NEPflN — HOnnAIA. Teste <strong>di</strong> N. e Poppea<br />
<strong>di</strong> fronte, l'una laureata, l'altra con <strong>di</strong>adema ; ai lati<br />
E— (capelli in giii).<br />
P — AOYIOAA ANGYnATn AIXMOKAHC. Busto <strong>di</strong> Roma<br />
turrita a d. ; ai lati Pfl— MH.<br />
Imhoof-Blumer [Tav. IV n. 13] — Parigi.<br />
Magnesia (Br.) — NEPANA HOnnAIAN C6BACT0YC. Teste<br />
sovrapposte <strong>di</strong> Nerone e Poppea a d. (capelli in giù).<br />
^ — 06AN PriMHN MAfNH CIH. Testa turrita <strong>di</strong> Roma<br />
a d.; nel campo il monogramma IaI-<br />
Parigi, Mionn. IV p. 73 n. 395 [Tav. V n. 12] — Imhoof-Blumer<br />
(variante).<br />
Thyatira Ly<strong>di</strong>ae (Br.)— NGPflN KAAYAIO KAICAPG C€BACTOC.<br />
Testa <strong>di</strong> N. laur. a d. (capelli in giù).<br />
^ - nonnAIAN C€BACTHN GYATIPHNAN. Busto <strong>di</strong><br />
Poppea a d.<br />
Imhoof-Blumer [Tav. V n. io].
lA CRONOLOGIA ULLLE M M 11<br />
Anno 66,<br />
Alexandria (Bigi.) - NERA K TER AY. Testa <strong>di</strong> N. a<br />
s. con corona ra<strong>di</strong>ata ed egida sull'omero; innanzi LIT<br />
(capelli in giù).<br />
P — AKTIOZ AnOAAaN. Busto <strong>di</strong> Apollo laur. a d. con<br />
faretra sulle spalle.<br />
Santang., Cat. n. 11797-99.<br />
- (Bigi.) - NEPn KAAY KAIZ 2EB .<br />
. . . Testa<br />
N. a d. con corona ra<strong>di</strong>ata (capelli in giù).<br />
<strong>di</strong><br />
5* — AYTOKPA. Busto <strong>di</strong> Serapide a d. col mo<strong>di</strong>o sul<br />
capo, innanzi L IP.<br />
Fiorelli, Cat. n. 9589.<br />
- (Bigi.) — NEPn KAAY KAIZ ZEB Testa <strong>di</strong><br />
N. a d. con corona ra<strong>di</strong>ata (capelli in giù),<br />
IJ( — AY .<br />
. . . Busto<br />
del Genio <strong>di</strong> Alessandria a d., con<br />
pelle <strong>di</strong> elefante,sul capo; innanzi LIT.<br />
Fiorelli, Cai. n. 9590.<br />
- (Br.) - .<br />
, . , KAIZ<br />
ZEB TEP. Testa <strong>di</strong> N. laur. a<br />
d. (capelli in giù).<br />
9 - AYTOKPA. Aquila a d., innanzi LIF.<br />
Fiorelli, Cat. n. 9591.<br />
- (Bigi.) - NEPn KAAY KAIZ ZEB TEP. Testa <strong>di</strong> N.<br />
a d. con corona rad. ed egida sull'omero (capelli in giù).<br />
P — AYTOKPA. Busto <strong>di</strong> Roma galeata a d.; innanzi Lir.<br />
Santang., Cat. n. 11792-95.<br />
- (Bigi.) - NEPn KAAY KAIZ ZEB TEP AY. Testa<br />
<strong>di</strong> N. a s. con corona rad. ed egida sull'omero; in-<br />
nanzi Lir (capelli in giù).<br />
^ - AIOZ OAYMniOY. Testa <strong>di</strong> Giove laur. a d.<br />
Fiorelli, Cat. n. 9593.<br />
- (Bigi.) — Legg. simile al preced. Testa <strong>di</strong> N. a<br />
s. con corona rad.; innanzi LIT (capelli in giù).<br />
^ — HPA APPEIA. Busto <strong>di</strong> Giunone velato e <strong>di</strong>ademato<br />
a d.<br />
Fiorelli, Cat. n, 9592.<br />
39
3o6 ETTORE CABRICI<br />
Alexandria (Bigi.) — Legg. simile al preced. Testa <strong>di</strong> N. a<br />
s. con corona rad. ed egida sull'omero; innanzi LIT<br />
(capelli in giij).<br />
P — OEOI IEBAZT02. Testa <strong>di</strong> Augusto a d. con corona<br />
ra<strong>di</strong>ata.<br />
Fiorelli, Cai. n. 960 e — Vienna — Santang., Cat. n. 11768-82.<br />
— (Bigi.) — Legg. e tipo simili al preced. (capelli<br />
in giù).<br />
^ — 2EBAIT04>OPOI. Nave a d. con vela spiegata e<br />
vessillo; sotto, due delfini.<br />
Fiorelli, Cat. n. 9594-95 — Santang., Cat. n. 11796 (variante).<br />
— (Bigi.) — Legg. e tipo simili al preced. (capelli<br />
in giù).<br />
^ — TIBEPIOZ KAIIAP. Testa <strong>di</strong> Tiberio laur. a d.<br />
Fiorelli, Cat. n. 9602-7 — Santang., Cat. n. 1x783-91.<br />
Antiochia (Br.) — IM NERO AVG. Testa <strong>di</strong> N. lau-<br />
reata a d. (capelli in su).<br />
P — EniilKEZTlIJOY ANTlI|OXEnN[|ET AIR in corona<br />
d'alloro.<br />
Imhoof-BIumer — Fiorelli, Cat. n. 8878 (variante); il Fiorelli legge<br />
ET Aip [Tav. IV n. 14].<br />
Anno 67.<br />
Alexandria (Bigi.) - NERA KAAY KAIZ . lEB<br />
TER AY. Testa<br />
<strong>di</strong> N., a s. con corona rad. ed egida sull'omero; in-<br />
nanzi L lA (capelli in giù).<br />
^ - AKTIOI AnOAAflN. Busto <strong>di</strong> Apollo laur. a d.<br />
con faretra sull'omero ; innanzi astro.<br />
Fiorelli, Cat. n. 9599 — Santang., Cat. n. 11800-02.<br />
— (Bigi.) - NERA KAAY KAIZ ZEB TER. Testa <strong>di</strong><br />
N. a d, con corona rad. ed egida sull'omero (capelli<br />
notevolmente mo<strong>di</strong>ficati).<br />
9' "" AYTOKRA. Aquila a s,, sopra un fulmine, avendo<br />
accanto un ramo <strong>di</strong> palma; innanzi L lA.<br />
Santang., Cat. n. 11808 [Tav. IV n. 12].
LA CRONOLOGIA DELLE MONETE L»I NERONE, ECC. 307<br />
Alexandria (Bigi.) - AY KAII ZEB TEP AY. Testa <strong>di</strong> N.<br />
a s. con corona rad. ed egida sull'omero; innanzi L lA.<br />
(capelli in g-iùì.<br />
^ — AIOI OAYMniOY. Testa <strong>di</strong> Giove laureata a d. ;<br />
innanzi astro.<br />
Fiorelli, Cat. n. 9596 — Santang., Cai. n. 11805-7.<br />
- (Bigi.) - NEPn KAAY KAII ZEB TER AY. Testa<br />
<strong>di</strong> N. a s. con corona rad. ed egida sull'omero; in-<br />
nanzi LIA (capelli in giù).<br />
9 - HPA APrEIA. Busto <strong>di</strong> Giunone velato con <strong>di</strong>adema,<br />
a d.; innanzi astro.<br />
Fiorelli, Cat. n. 9597 — Vienna (senza l'astro) — Santang., Cat.<br />
n. 11803-4.<br />
- (Bigi.) - NEPn K Testa <strong>di</strong> N. a s. con<br />
corona rad. ed egida sull'omero; innanzi L lA.<br />
^ — nOZEIAflN IZOMIOZ. Testa <strong>di</strong> Nettuno a d., con<br />
<strong>di</strong>adema e tridente sull'omero.<br />
Fiorelli, Cat. n. 9598.<br />
- (Bigi.) - NEPn KAA Testa <strong>di</strong> N. a s.<br />
con corona rad. ed egida sull'omero; innanzi L lA<br />
(capelli in giù).<br />
^ — nYOIOZ AnOAA .<br />
faretra sull'omero.<br />
Fiorelli, Cat. n. 9600.<br />
. Busto <strong>di</strong> Apollo laur. a d. con<br />
Ascalon (Br.) - CEBACTOC. Testa <strong>di</strong> N. laur. a d., avanti un<br />
tridente (capelli in giù).<br />
^ — ACKAAH. Astarte in pie<strong>di</strong> sur una prora <strong>di</strong> nave,<br />
con la destra sull'asta e tenendo nella s. l'acrostolium;<br />
innanzi vi è un tridente, <strong>di</strong>etro una colomba, sotto la<br />
quale AOP.<br />
Parigi, (2 esempi.) MiotDu V p. 528 n. 69.<br />
Angusta (Br.) - NEPriN. Testa <strong>di</strong> N. laur. a d. (capelli<br />
in su).<br />
P - AYrOYCTANAN 6T0YC HM. Busto <strong>di</strong> Bacco a d.<br />
con un tirso sulla spalla s., <strong>di</strong>etro il praefericulum.<br />
Parigi, Mioiiti. Ili p. 566 n. 145 [Tav. V n. 6J.
3o8 ETTORE CABRICI<br />
Cacsarea Samariae (Br.) - NEPCON CEBACTOC KAICAP.<br />
Testa laur. <strong>di</strong> N. a d. (capelli in su).<br />
IjK - KAICA ACT Astante turrita in pie<strong>di</strong><br />
a s., vestita d'una tunica succinta sui reni, col pie<br />
<strong>di</strong>ritto su d'una prora <strong>di</strong> nave, una testa umana nella<br />
mano d. e l'asta nella s., che in su ha la forma d'una<br />
croce, nel campo a s. LIA.<br />
Parigi, Mionn. V p. 486 n. i. [Tav. V n. 8], e n. 2 (variante) —<br />
De Saulc}', Nitm. de la T. S. pag. 115 (variante) — Lòbbecke.<br />
Sebaste (Br.) — .<br />
. . . ZA. Testa <strong>di</strong> N. laur. a d. (capelli in su).<br />
P — I-IEBAITHNOO. Astarte turrita che ha nella d. una<br />
testa umana, nella s. un'asta, nel campo a s. LIA.<br />
De Saulcy, Num. de la T. S. pi. XIV n. 7.<br />
Dal 66 al 67.<br />
Con'ntìms (Br.) - NERO CAESAR NQ- IMP. Testa <strong>di</strong> N. a s.<br />
con corona rad. (capelli in su).<br />
P — L R RISONE .... Nave a s. con stendardo; sopra<br />
ADVE A^G, sotto QVI CO .<br />
. .<br />
Atene [Tav. V n, 5] Sanclem. Num. sei. II p. 115 tab. XV fig. 57<br />
(con qualche variante) — Lòbbecke (3 esempi, con qualche<br />
variante).<br />
- (Br.) — NERO CAE AVG IMP. Testa laur. <strong>di</strong> N. a d.<br />
(capelli in su).<br />
1^ - P MEM OLEANDRO IIQ CO. Nerone stante su <strong>di</strong><br />
una bigoncia a s., levando la mano d. e sostenendo<br />
la toga con la s.; ai lati ADL A'G-.<br />
Atene [Tav. V n. 4] — Parigi, Coh. Nero, p. 304 n. 376.<br />
l\itras (Br.) — NERO CAESAR AVG- G-ERM. Testa <strong>di</strong> N. a s.<br />
con corona rad. (capelli in su).<br />
^ - ADVENTVS AVGVSTI. Galera a s., sopra C, sotto P.<br />
Gotha [Tav. V n. 3] — Lòbbecke, Imhoof-Blumer (varianti).<br />
(Br.) - NERO CAESAR AVG GERMA. Testa <strong>di</strong> N. a s.<br />
con corona rad. (capelli in su).<br />
5* — COL-A-A-PATR. Due insegne con in mezzo un'a-<br />
quila legionaria, appiè delle quali X e XIII.<br />
Arigoni, Numisni. quaed. II. tab. IIII.
LA CRONOLOGIA DFLLE MONETK DI NERONE, ECC. 309<br />
Anno 68.<br />
Sebaste (Br.) — Testa <strong>di</strong> N. laur. a d. (capelli in su).<br />
9 — I • IEBA2TH .... Astante o l'imperatore in pie<strong>di</strong>,<br />
vestito <strong>di</strong> tunica, portando sulla d. una testa umana,<br />
la s. poggiandola sull' asta e il pie <strong>di</strong>ritto su <strong>di</strong> un<br />
fiore o un frutto; avanti l|A.<br />
Parigi, Miotin. Suppl. Vili p. 357<br />
Dal 65 AL 68.<br />
n. 105 [Tav. V n. 11].<br />
Ni'caca Bithyniae (?) (Br.) — TIB NEPflNKAAYAlOI KAIIAP<br />
lEBAlTOI. Testa <strong>di</strong> N. a d. con corona ra<strong>di</strong>ata (ca-<br />
pelli in su).<br />
5I - MEZZAAEINA TYNH lEBAlTOY. Messalina seduta<br />
a destra.<br />
Cav. Lavy <strong>di</strong> Torino (v. Millingen, Sylloge 0/ ancient coins of<br />
Greek cities and Khigs PI. Ili n. 38).<br />
III.<br />
Vicende del dupon<strong>di</strong>o, dell'asse e del semis.<br />
Una rigorosa classificazione cronologica dei<br />
bronzi <strong>di</strong> Nerone, fatta col metodo esposto, ci apre<br />
la via ad una interessante ricerca intorno all' uso<br />
della corona laureata o ra<strong>di</strong>ata sui dupon<strong>di</strong>i, intorno<br />
ai segni del valore espressi nell'esergo del rovescio<br />
ed anche intorno all'emissione degli assi d'oricalco.<br />
Con questa ricerca vedremo quanti sforzi, quanti<br />
tentativi fece il Senato per giungere ad una esatta<br />
e pronta <strong>di</strong>stinzione dei nominali <strong>di</strong>versi.<br />
Fino a Nerone vi erano stati quattro imperatori,<br />
con ciascuno dei quali si erano coniati assi e dupon<strong>di</strong>i;
3IO<br />
ETTORE CABRICI<br />
ma quale norma vi era per <strong>di</strong>stinguerli imme<strong>di</strong>atamente<br />
negli scambi <strong>com</strong>merciali? Ciascun citta<strong>di</strong>no<br />
doveva affidarsi alla propria esperienza.<br />
È merito del Kenner se oggi siamo in grado<br />
<strong>di</strong> seguire tutte le vicende del dupon<strong>di</strong>o e dell'asse<br />
neroniano. Egli avverte che il bronzo non fu usato<br />
da principio per Tasse, pel semis e pel quadrans, ma<br />
quando già il rame era stato usato per questi nominali.<br />
Egli <strong>di</strong>ce che in principio vi fu l'asse <strong>di</strong> rame<br />
e il dupon<strong>di</strong>o con la corona d'alloro, senza segno<br />
<strong>di</strong> valore, <strong>di</strong> poi furono introdotti l'asse, il semis, il<br />
quadrans <strong>di</strong> bronzo, i primi due anch'essi con la corona<br />
laureata e senza segno del valore.<br />
Questi quattro nominali erano così a primo<br />
sguardo non altrimenti <strong>di</strong>stinguibili che per la grandezza<br />
del <strong>di</strong>sco metallico. Ma esso nella lavorazione<br />
veniva fuori con un margine irregolare, stante le con-<br />
<strong>di</strong>zioni della tecnica d'allora, e perciò la <strong>di</strong>stinguibi-<br />
lità dei nominali me<strong>di</strong>i ne scapitava <strong>di</strong> molto, spe-<br />
cialmente quando mancava la <strong>com</strong>o<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> poterli<br />
paragonare con altri nominali e giu<strong>di</strong>care dalla <strong>di</strong>fferenza<br />
<strong>di</strong> grandezza. Per modo che essendosi emessa<br />
una parte delle monete <strong>di</strong> bronzo, per le rimanenti<br />
emissioni si usò <strong>di</strong> mettere i segni del valore sui<br />
dupon<strong>di</strong>i, assi e semis.<br />
Un sufficiente rime<strong>di</strong>o contro la confusione dei<br />
nominali neppure si era escogitato coi segni del va-<br />
lore, perchè spessissimo il conio e il <strong>di</strong>sco metallico<br />
non si corrispondevano esattamente, ma il primo scivolava<br />
fuori del campo <strong>di</strong> questo; così che da una<br />
parte appariva un margine ampio, dalla parte opposta<br />
della medesima faccia mancava una parte della leggenda<br />
o del conio e questa parte mancante poteva es-<br />
sere il segmento col segno <strong>di</strong> valore. Si ricorse allora<br />
ad un espe<strong>di</strong>ente molto pratico : la <strong>di</strong>versa maniera<br />
<strong>com</strong>'era coronata la testa dell'imperatore servì quale
LA CRONOLOGIA DtLL^ MONETE DI NERONF, tCC. 3"<br />
segno della <strong>di</strong>fTerenza. 3i <strong>di</strong>stinsero il dupon<strong>di</strong>o e<br />
l'asse dal sesterzio e dal semis, perchè i due primi<br />
ebbero la corona ra<strong>di</strong>ata. Questo passaggio segna<br />
una terza e quarta fase della emissione delle nuove<br />
monete <strong>di</strong> bronzo, una delle quali porta ancora il<br />
segno del valore: l'altra lo ha smesso. Le osserva-<br />
zioni del Kenner si <strong>com</strong>pen<strong>di</strong>ano tutte nel seguente<br />
specchietto :
312<br />
ETIORE CABRICI<br />
<strong>di</strong> oricalco col segno <strong>di</strong> valore e la testa laureata<br />
sono tutti in<strong>di</strong>stintamente del tempo della Riforma,<br />
cioè hanno tutti la testa <strong>di</strong> Nerone <strong>com</strong>e quella dei<br />
numeri io e 13 della tavola li, e secondo i principii<br />
da noi stabiliti per la presente classificazione, relativi<br />
alla iconografia <strong>di</strong> Nerone, non possono mettersi accanto<br />
ai dupon<strong>di</strong>i con la testa laureata e il segno<br />
del valore che hanno tutti la testa <strong>di</strong> Nerone col<br />
globetto, anteriore, <strong>com</strong>e sappiamo, al tipo della riforma<br />
(V. tav. I, n. 16, 17 e tav. II, n. i). Perciò<br />
riteniamo che questi assi debbano scendere più giii<br />
nella scala cronologica ed esser messi accanto ai dupon<strong>di</strong>i<br />
con la testa ra<strong>di</strong>ata e agli assi d'oricalco anche<br />
con la testa ra<strong>di</strong>ata. Non pare che sia possibile<br />
determinare l'anteriorità delle due serie <strong>di</strong> assi d'o-<br />
ricalco; ve n'ha con la testa laureata e segno <strong>di</strong> va-<br />
lore o senza e con la testa ra<strong>di</strong>ata e segno <strong>di</strong> valore<br />
o senza. Al più si può ritenere col Kenner anteriore<br />
la serie col segno <strong>di</strong> valore e posteriore l'altra, essendo<br />
naturale che il nuovo asse <strong>di</strong> oricalco al suo<br />
apparire portasse un segno del suo valore e che dopo<br />
un certo tempo, quando si fu <strong>di</strong>ffuso nel <strong>com</strong>mercio<br />
e da tutti fu riconosciuto, non avesse più bisogno<br />
<strong>di</strong> quel segno.<br />
Esposte le ragioni <strong>di</strong> queste nostre <strong>di</strong>vergenze<br />
dalla classificazione che il Kenner stabilisce, rico-<br />
struiamo la serie dei dupon<strong>di</strong>i e degli assi neroniani<br />
nel seguente modo.<br />
Da principio la monetazione <strong>di</strong> Nerone non fu<br />
che una continuazione <strong>di</strong> quella <strong>di</strong> Clau<strong>di</strong>o con le<br />
necessarie varianti del tipo e della leggenda. Nella<br />
serie dei bronzi <strong>di</strong> Clau<strong>di</strong>o, il quale dette opera a<br />
riformare il peso delle monete, già apparisce un segno<br />
sicuro per l'asse, la testa nuda dell'imperatore (^^).<br />
(il) Ve<strong>di</strong> una mia preced. memoria " Contributo alla storia della vi.<br />
rom. da Augusto a Domis., pag. 22. Cfr. Kenner, op. cit., p. 234-235 „.
LA CRONOLOGIA DELLE MONETE DI NERONE, ECC. 313<br />
Continua tale <strong>di</strong>stintivo con Nerone nella serie<br />
col globetto (Tav. I, n. i6 e 17; Tav. II, n. i, 3),<br />
mentre veniva impressa sul dupon<strong>di</strong>o la testa lau-<br />
reata e coniato per la prima volta nell' epoca impe-<br />
riale il semis, anch'esso con la testa nuda (Tav. II,<br />
n. 4). Per le ragioni addotte dal Kenner, rimaneva<br />
<strong>di</strong>fficile la imme<strong>di</strong>ata <strong>di</strong>stinzione del dupon<strong>di</strong>o dal-<br />
l'asse negli scambii <strong>com</strong>merciali e si pensò allora <strong>di</strong><br />
segnare nell'esergo dei soli dupon<strong>di</strong>i il segno del loro<br />
valore, me<strong>di</strong>ante due lineette verticali. Non ancora<br />
abbiamo assi col segno <strong>di</strong> valore, <strong>com</strong>e crede il<br />
Kenner.<br />
In una terza grande emissione fu mo<strong>di</strong>ficato il<br />
dupon<strong>di</strong>o, ma questa volta in tal modo, che non si<br />
sentì più il bisogno <strong>di</strong> altra aggiunta fino allo s<strong>com</strong>-<br />
parire della moneta senatoria. Questa mo<strong>di</strong>ficazione,<br />
che si estese in parte all'asse, consisteva nell' imprimere<br />
la corona ra<strong>di</strong>ata sul capo dell' imperatore<br />
(Tav. I, n. 12 e Tav. II, n. 11). Si ba<strong>di</strong> però che<br />
la corona ra<strong>di</strong>ata sulle monete non ha, da Nerone<br />
in poi, un valore religioso <strong>com</strong>e quella sulla testa <strong>di</strong><br />
Augusto nei dupon<strong>di</strong>i coniati da Tiberio, da Clau<strong>di</strong>o<br />
e da altri suoi successori.<br />
Risoluta così la quistione degli assi e dei du-<br />
pon<strong>di</strong>i, piacque <strong>di</strong> estendere l'oricalco anche alla coniazione<br />
dell' asse (Tav. II, n. io, 13). Ecco una<br />
terza serie <strong>di</strong> monete la quale <strong>com</strong>prende il sesterzio,<br />
il dupon<strong>di</strong>o dalla testa ra<strong>di</strong>ata e segno <strong>di</strong> valore, il<br />
semis <strong>di</strong> oricalco col segno <strong>di</strong> valore anch' esso<br />
(Tav. II, n. 9), ed in ultimo il quadrans, anche col<br />
segno <strong>di</strong> valore.<br />
Pare al Kenner che con 1' emissione <strong>di</strong> questi<br />
nuovi assi cessi d'un tratto la emissione degli' assi<br />
<strong>di</strong> rame. In questo punto anche <strong>di</strong>scor<strong>di</strong>amo dall'opi-<br />
nione del chiaro numismatico, perchè fra gli assi <strong>di</strong><br />
rame ne troviamo alcuni col capo <strong>di</strong> Nerone simile a
3H<br />
ETTORE CABRICI<br />
quello <strong>di</strong> certi assi d' oricalco che van collocati in<br />
capo alla serie della Riforma.<br />
L* asse <strong>di</strong> oricalco non ebbe lunga durata; ben<br />
presto cedette il posto a quello <strong>di</strong> rame, la cui co-<br />
niazione fu ripigliata in maggiore abbondanza, (Tav.<br />
Ili, n. I, 3, II), dopo che Tasse <strong>di</strong> oricalco fu emesso<br />
per un certo tempo senza il segno <strong>di</strong> valore. Nel seguente<br />
specchietto abbiamo sott'occhio la nostra clas-<br />
sificazione:<br />
Dnpon<strong>di</strong>i
LA CRONOLOGIA DELLE MONETE DI NERONE, ECC. 315<br />
E aggiungiamo pure che questa nostra ricostruzione<br />
cronologica non è scevra <strong>di</strong> qualche eccezione, perchè<br />
ogni riforma prima <strong>di</strong> andare in vigore suol essere<br />
preceduta da qualche tentativo, specialmente in fatto<br />
<strong>di</strong> monete, la cui emissione fu così abbondante e<br />
svariata nell'impero romano. Chi trovi dunque qualche<br />
moneta, che non possa aver luogo nella serie pro-<br />
posta, dovrà supporre che costituisca una eccezione.<br />
Così l'asse <strong>di</strong> rame del n. 15 tav. I, col tipo della<br />
Riforma, ha la testa nuda, <strong>com</strong>e sugli assi col globetto.<br />
Questo asse lo collochiamo alla fine <strong>di</strong> questa serie.<br />
Il semis della tav. II, n. 3, che è <strong>di</strong> rame, quin<strong>di</strong><br />
anteriore al tipo della Riforma, ha la testa <strong>di</strong> Nerone<br />
che somiglia molto a quella della Riforma. Queste<br />
sono eccezioni le quali vogliamo noi stessi notare,<br />
per prevenire tutt'i dubbii possibili.<br />
IV.<br />
Monete d'oro e d'argento.<br />
Il punto più oscuro <strong>di</strong> tutta questa monetazione è<br />
costituito dalle monete d'oro e d'argento aventi gli anni<br />
della tribunicia potestà s. È fuori <strong>di</strong> dubbio che<br />
siano anteriori quelle rispondenti al peso <strong>di</strong> gr. 7.60 per<br />
l'oro, <strong>di</strong> gr. 3.70 per l'argento, perchè anteriori alla<br />
riduzione dell'anno 63 i^^). Non sarà inutile richiamare<br />
l'attenzione sul significato che si è creduto <strong>di</strong> dare<br />
alla leggenda EX S •<br />
C che leggesi sul rovescio <strong>di</strong><br />
questi aurei. L'EX S-C.non si riferirebbe a decreto<br />
del Senato or<strong>di</strong>nante la coniazione <strong>di</strong> tali monete<br />
(12) Cfr. Kennek, op. e, pag. 230.
3l6 ETTORE CABRICI<br />
d'oro e d'argento, ma alla deliberazione da esso presa<br />
<strong>di</strong> erigere statue all'imperatore, nell'anno 59, e che<br />
questi , per deferenza al Senato , abbia fatto imprimere<br />
sulle monete uscenti dalla sua zecca le imma-<br />
gini <strong>di</strong> dette statue ed aggiungervi il ricordo della<br />
deliberazione senatoriale. Questa spiegazione può an-<br />
dare per gli aurei e denari degli anni 60, 61, 62, 63,<br />
ma non per quelli dei primi anni dell' impero <strong>di</strong> Ne-<br />
rone, aventi un unico rovescio , la corona d' alloro.<br />
Può darsi però che qui siano monche le fonti letterarie<br />
e che il Senato, nell'anno 54, tra gli altri onori resi<br />
all' imperatore , gli abbia offerto anche una corona<br />
d'alloro.<br />
Non osiamo opporci alla <strong>com</strong>une interpretazione;<br />
soggiungiamo però che essa non è esauriente. Perchè<br />
mai tanta uniformità <strong>di</strong> tipi per un decennio intero?<br />
Perchè la testa dell'imperatore non è mai coronata?<br />
Perchè non una sola moneta è priva delle lettere<br />
EX S-C? Anche altre volte nell'epoca imperiale furono<br />
emesse monete con questa scritta, ma si hmitarono<br />
alla sola emissione <strong>di</strong> qualche anno.<br />
Tanta irregolarità sparirebbe, sol che si ammettesse<br />
che il Senato avesse, se non usurpato, almeno<br />
esteso l'alta sua sorveglianza sulla zecca dell'Impe-<br />
ratore e ciò per effetto <strong>di</strong> una tendenza ad estendere<br />
le proprie attribuzioni.<br />
Alla morte <strong>di</strong> Clau<strong>di</strong>o ve<strong>di</strong>amo apparire sulle<br />
monete il carpentum decretato dal Senato, e contemporaneamente<br />
la corona d'alloro; il primo tipo non<br />
fu ripetuto negli anni seguenti, ma fu ben ripetuto<br />
il secondo per lo spazio <strong>di</strong> sei anni, mutandosi solo il<br />
numero della tribunicia potestas e del consolato.<br />
Tutto questo ad arte, per non dare nell' occhio e<br />
non manifestare il fine a cui il Senato mirava con<br />
quel primo passo, che era la usurpazione del <strong>di</strong>ritto<br />
<strong>di</strong> monetare.
LA CRONOLOGIA UtLLE MONElt DI NERONE, ECC. 317<br />
11 Senato così non <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto, ma <strong>di</strong> fatto aveva<br />
raggiunto il suo scopo. Così ci spiegheremmo che i<br />
tipi dell'oro e dell'argento non furono mutati in questo<br />
periodo, perchè allora l'EX S • C, che richiamava la<br />
deliberazione senatoriale del 54, non avrebbe più si-<br />
gnificato e le intenzioni del Senato sarebbero state<br />
evidenti.<br />
La serie che fa seguito a questa ed è certo po-<br />
steriore all'anno 63, presenta molte e sostanziali <strong>di</strong>-<br />
vergenze, se la mettiamo a confronto con la prima.<br />
Questa ha sempre la testa nuda dell' imperatore, la<br />
leggenda del <strong>di</strong>ritto che <strong>com</strong>incia dalla destra della<br />
moneta, quella del rovescio costantemente con l'in-<br />
<strong>di</strong>cazione delle cariche, le lettere EX S • C e i quattro<br />
tipi della corona, <strong>di</strong> Marte, <strong>di</strong> Roma, del Valore;<br />
quella ha invece la testa laureata, la leggenda co-<br />
minciante da sinistra, i tipi del rovescio tutto <strong>di</strong>-<br />
versi da queUi <strong>di</strong> prima, mancanza assoluta delle<br />
cariche. La totale sparizione dei tipi della prima serie<br />
e delle lettere EX S • C non è accidentale, ma voluta,<br />
se no, qualcuno <strong>di</strong> quei tipi pur <strong>com</strong>parirebbe tal-<br />
volta nelle monete posteriori. Questa osservazione<br />
avvalora sempre più la nostra tesi <strong>di</strong>anzi esposta,<br />
ma non insisto.<br />
Piuttosto <strong>di</strong>remo che il Kenner si arresta a questa<br />
<strong>di</strong>stinzione delle monete d'oro e d'argento, e non<br />
tenta una classificazione pur che sia <strong>di</strong> quelle che<br />
non hanno data.<br />
Partendo sempre dai tratti coi quali è rappre-<br />
sentato il capo dell'imperatore, cre<strong>di</strong>amo che si possa<br />
stabilire una certa cronologia. Non tutte le monete<br />
<strong>di</strong> questa serie hanno il ritratto <strong>di</strong> Nerone eseguito<br />
allo stesso modo. Come per i bronzi abbiamo con-<br />
statato esservi un tipo che chiamiamo della Riforma,<br />
dalla cui perfezione vanno sempre più <strong>di</strong>scostandosi<br />
le monete posteriori, così nella serie dei metalli pre-
3i8<br />
ETTORE CABRICI<br />
ziosi vi è anche un tipo della Riforma che si mo<strong>di</strong>-<br />
fica a poco a poco, conservando però inalterati i<br />
tratti essenziali del volto <strong>di</strong> Nerone. Questo allontanamento<br />
consiste in un lento scemare del rilievo<br />
della testa, nel quale è riposta gran parte della bel-<br />
lezza dei conii della Riforma, proprio quello che<br />
notasi per i bronzi, e nell' esagerare le <strong>di</strong>mensioni<br />
del collo in larghezza.<br />
L'aureo riprodotto nella tav. II, n. 14 va collo-<br />
cato, secondo noi, in capo a questa serie, perchè le<br />
sue somiglianze coi n.' 5 e 7, tav. I della prima<br />
serie sono troppo evidenti e la fattura dei capelli è<br />
in<strong>di</strong>zio che esso è anteriore al tipo della Riforma.<br />
Questo invece è rappresentato nella sua forma piii<br />
bella sugli aurei che hanno al rovescio le leggende<br />
AVGVSTVS AVGVSTÀ, AVGVSTVS GERMANICVS, e il tipo<br />
del tempio <strong>di</strong> Giano <strong>di</strong> fronte ('s), (tav. II, n. 12, 15,<br />
16); e si può affermare con sufficiente certezza che<br />
questi tre tipi non si trovano accoppiati con la testa<br />
dell'imperatore, lavorata secondo la tecnica degli<br />
ultimi anni che è quella dei n.' 9 e io, tav. Ili, e per<br />
conseguenza possiamo assegnar loro una durata assai<br />
brieve, a <strong>com</strong>inciare dall'anno 63.<br />
V.<br />
Cronologia e spiegazione dei tipi del rovescio.<br />
Prima <strong>di</strong> venire alla luce il lavoro del Kenner<br />
credevasi generalmente che la zecca senatoria avesse<br />
coniato le prime monete <strong>di</strong> Nerone nei primi anni<br />
(13) Fiore! Il, Cai. n. 4457-58.
LA CRONOLOGIA DELLE MONETE DI NERONE, ECC. 319<br />
del SUO avvenimento al trono , anzi non erasi mai<br />
agitata una simile questione <strong>di</strong> cronologia, e qualcuno<br />
<strong>com</strong>e r Eckhel , il Me<strong>di</strong>obarbus, il Cavedani, ne<br />
aveva spiegato spora<strong>di</strong>camente alcuni tipi, attribuendo<br />
loro la data che più gli pareva sicura. 11 Kenner fu<br />
il primo a sostenere la tesi un po' ar<strong>di</strong>ta, che prima<br />
deir anno 64 non fossero uscite monete <strong>di</strong> Nerone<br />
dalla zecca senatoria. Le prove che egli adduce sono<br />
tutte negative. Le riassumo brevemente. " La totale<br />
mancanza d' immagini sul bronzo, corrispondenti nel-<br />
l'esecuzione a quelle degli aurei e dei denari con la<br />
data, costituisce per lui un importante, in<strong>di</strong>ce crono-<br />
logico in sostegno dell' ipotesi , che non fu battuta<br />
moneta spicciola prima dell'anno 64. Non gli paiono<br />
da trascurare due altre circostanze. L' una è la totale<br />
mancanza dei numeri delle cariche sulle monete <strong>di</strong><br />
bronzo fino all'anno 66, i quali sono sempre espressi<br />
sull'oro e sull'argento dal 54 al 63 : ora se il Senato<br />
avesse battuto moneta in quest' epoca, avrebbe imi-<br />
tato l'esempio dell' imperatore. L'altra circostanza è<br />
la usurpazione del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> coniare in bronzo , cui<br />
andò soggetto il Senato per opera <strong>di</strong> Nerone, desideroso<br />
<strong>di</strong> partecipare, <strong>com</strong>e <strong>di</strong>ce il Mommsen , dei<br />
vantaggi finanziarli derivanti dall'emissione delle mo-<br />
nete <strong>di</strong>visionali. La quale usurpazione coincide perfettamente<br />
con la riduzione <strong>di</strong> peso nelle monete<br />
d'oro e d'argento, <strong>com</strong>parsa solo dopo il 63. „<br />
La tesi del Kenner, accolta pienamente dal Ber-<br />
noulli, ci pare che <strong>di</strong>a luogo a serie obbiezioni.<br />
Innanzi tutto la serie monetale <strong>di</strong> Nerone non è<br />
tanto scarsa per varietà <strong>di</strong> tipi ne per abbondanza <strong>di</strong><br />
emissione e non oseremmo quin<strong>di</strong> ridurla nel breve<br />
termine <strong>di</strong> quattro anni e mezzo, a prescindere dal<br />
fatto veramente singolare che il Senato per <strong>di</strong>eci anni<br />
consecutivi avrebbe tenuta chiusa la zecca e che poi<br />
tutt' ad un tratto avrebbe emesso un cofisiderevol
320 ETTORE CABRICI<br />
numero <strong>di</strong> monete. La ragione <strong>di</strong> tutto questo non<br />
la sappiamo trovare né il Kenner si preoccupa <strong>di</strong><br />
trovarla. Forse avrebbe ragioni in suo favore, se il<br />
regno <strong>di</strong> Nerone fosse trascorso <strong>com</strong>e quello <strong>di</strong> tanti<br />
imperatori, senza quelle enormi spese che noi sap-<br />
piamo. Ma esso invece trascorse in continue largi-<br />
zioni ad una plebe inoperosa e viziata <strong>com</strong>e il suo<br />
capo, e quin<strong>di</strong> non pare possibile che la produzione<br />
delle monete si sia potuta interrompere durante un<br />
periodo così lungo.<br />
Ma il sostegno maggiore sul quale si regge l'i-<br />
potesi del Kenner è la seguente osservazione: il tipo<br />
<strong>di</strong> Nerone sulle monete d'oro e d'argento con la data<br />
è assai giovanile, laddove i tipi più antichi del bronzo<br />
non ci danno i tratti <strong>di</strong> una giovinezza così imma-<br />
tura, e per conseguenza devono essere posteriori ai<br />
primi. Fino a quando egli confronta i ritratti <strong>di</strong> Nerone<br />
dei primi aurei con queUi dei piij antichi bronzi<br />
si è d'accordo con lui, ma non così allorché intende<br />
includere nel confronto anche quei ritratti degli aurei<br />
coniati dal 57 in poi. L'aspetto più giovanile <strong>di</strong> Ne-<br />
rone su questi ultimi risulta dalla mancanza della corona<br />
d'alloro.<br />
Le monete greche le quali ci han fatto da scorta<br />
sicura quando trattavasi <strong>di</strong> stabilire l'anno della prima<br />
apparizione del tipo nuovo <strong>di</strong> Nerone, anche qui possiamo<br />
richiamarle a proposito. Come può il Kenner<br />
affermare poi che il tipo della Riforma sia apparso<br />
non prima del 65, quando esso lo troviamo già riprodotto<br />
nell'anno 63 sulla bellissima moneta <strong>di</strong> Lao<strong>di</strong>caea<br />
Syriae e su quella <strong>di</strong> Caesarea Cappadociae?<br />
Conviene risalire <strong>di</strong> qualche anno e collocarlo almeno<br />
nel 63, <strong>com</strong>e abbiamo sopra <strong>di</strong>mostrato.<br />
Tale considerazione rischiara <strong>di</strong> viva luce la<br />
oscura questione che stiamo <strong>di</strong>battendo e ci rende<br />
ar<strong>di</strong>ti a sostenere con più forte ragione la nostra tesi.
LA CRONOLOGIA DIXLE MONETE DI NERONE, ECC. 321<br />
che cioè la coniazione del bronzo sotto Nerone non<br />
<strong>com</strong>inci nell'anno 64, ma varii anni prima. Dunque<br />
tutte le monete col tipo che noi abbiamo detto essere<br />
anteriore a quello della Riforma sono anteriori al-<br />
l'anno 63.<br />
Ve<strong>di</strong>amo se è possibile stabilire fra queste una<br />
più rigorosa classificazione. Anzi tutto convien <strong>di</strong>re<br />
quando in<strong>com</strong>inciano. Attesa la loro scarsità in tutte<br />
le collezioni, non andremmo lungi dal vero assegnando<br />
alle prime emissioni l'anno 56 o 57. Anche<br />
noi riconosciamo che la moneta spicciola <strong>di</strong> Nerone<br />
non potè <strong>com</strong>inciare nel 55. È probabile che sia<br />
apparsa qualche anno dopo con la testa a sin. e col<br />
globetto e che abbia avuto la sua maggior <strong>di</strong>ffusione<br />
dal 60 al 63 con la testa a destra e i capelli in su.<br />
Il tipo della Riforma <strong>com</strong>inciato nel 63 con il busto<br />
a destra, avente l'egida sul petto, si mantenne inalterato<br />
pel corso degli anni 64, 65, 66. Verso il 66<br />
<strong>com</strong>incia a mancare l' egida, che s<strong>com</strong>pare quasi<br />
del tutto nel 67 e nei primi mesi del 68. In questi<br />
ultimi due anni il tipo con la testa a sinistra e i<br />
capelli cadenti sulla fronte, che era stato scarso fin<br />
dalla sua apparizione, si mostra con un buon numero<br />
<strong>di</strong> esemplari, tanto da superare la emissione<br />
dell'altro tipo.<br />
Noi dunque <strong>di</strong>scor<strong>di</strong>amo dal Kenner nell'assegnare<br />
l'anno alle prime emissioni <strong>di</strong> bronzi neroniani,<br />
anticipandole <strong>di</strong> sette od otto anni. Questo spostamento<br />
rende necessaria una <strong>di</strong>versa spiegazione dei<br />
tipi del rovescio. In ciò ve<strong>di</strong>amo <strong>com</strong>e vacilli l'i-<br />
potesi del Kenner, quando trattasi <strong>di</strong> certi tipi che<br />
egli non senza artificio riesce a classificare. Confinata<br />
negli ultimi cinque anni la serie non poco numerosa,<br />
è costretto a spiegarne i tipi con avvenimenti storici<br />
<strong>di</strong> quel breve giro <strong>di</strong> anni e spesso avviene che un<br />
rovescio <strong>di</strong> sesterzio, il quale troverebbe il suo na-<br />
41
322<br />
ETTORE CABRICI<br />
turale riscontro in avvenimenti anteriori all'anno 64,<br />
egli sia costretto a riferirlo ad altri posteriori.<br />
Anticipando invece <strong>di</strong> sette od otto anni il prin-<br />
cipio della coniazione neroniana, potremo benissimo<br />
collocare nei primi cinque anni tutti i tipi dei sesterzii,<br />
dupon<strong>di</strong>i, assi, semis, che in seguito furono riprodotti<br />
integralmente, salvo <strong>di</strong>vergenze negli accessorii, e può<br />
<strong>di</strong>rsi che dal 61 in poi non si sia fatto altro, se non<br />
ripeterli senza introdurre alcuna novità. Anche in<br />
questo trovasi un or<strong>di</strong>ne rigoroso, nello sforzo cioè<br />
<strong>di</strong> stabilire certi tipi monetali e non alterarli succes-<br />
sivamente e nell'evitare ancora che i tipi <strong>di</strong> un no-<br />
minale non invadessero il campo <strong>di</strong> quelli <strong>di</strong> un altro<br />
nominale: cosa che non sempre si osservò nelle<br />
monete imperiali. E troviamo pure la ragione della <strong>di</strong>-<br />
versità grande <strong>di</strong> opinioni circa l'anno della emissione<br />
<strong>di</strong> certe monete, <strong>com</strong>e a <strong>di</strong>re <strong>di</strong> quelle relative alla<br />
chiusura del tempio <strong>di</strong> Giano, accennata confusamente<br />
da Suetonio. Ma la classificazione che noi proponiamo,<br />
oltre a farci determinare con una certa sicurezza<br />
l'anno delle prime emissioni, ci avverte che alcuni<br />
rovesci cessarono negli ultimi anni <strong>di</strong> Nerone. Pei<br />
sesterzii si può affermare che dall'anno 65 in poi furono<br />
usati soltanto i tipi <strong>di</strong> Roma e <strong>di</strong> Giano.<br />
Ora è tempo <strong>di</strong> passare alla spiegazione dei tipi<br />
monetali che hanno bisogno <strong>di</strong> essere illustrati uno<br />
per uno; nel qual lavoro rimetteremo in luce le vec-<br />
chie opinioni dell' Eckhel e del Cavedoni con qualche<br />
lieve aggiunta.<br />
I rovesci con ADLOCVTIO COH •<br />
e DECVRSIO <strong>di</strong>ce<br />
il Kenner che ebbero la loro prima apparizione for-<br />
s' anche prima dell'anno 64, perchè relativi ad avvenimenti<br />
<strong>di</strong> epoca anteriore; ma non già <strong>com</strong>e moneta<br />
ufficiale, bensì <strong>com</strong>e medaglioni privi delle sigle S • C<br />
ed emessi dall' imperatore insieme con tante altre<br />
monete, tutte prive del segno dell'autorità senatoria.
LA CRONOLOGIA UliLLE MONETE DI NERONK, tCC. 323<br />
Secondo la classificazione che noi proponiamo ,<br />
il<br />
rovescio deir A <strong>di</strong>o e ut io appare ben presto col S-C<br />
sui sesterzii col globetto, e non può non appartenere<br />
ad una delle prime emissioni, perchè ci ricorda uno<br />
dei primi atti del giovinetto imperatore, dopo la<br />
uccisione <strong>di</strong> Clau<strong>di</strong>o. Tacito e Dione (^4) infatti ci<br />
narrano che il 13 ottobre dell' anno 54, Nerone si<br />
te condurre dentro gli alloggiamenti dei soldati, e<br />
fatta un'orazione, promise loro un donativo. Sul ro-<br />
vescio <strong>di</strong> questi sesterzii egli è rappresentato nell'atto<br />
che dal suggesto parla ai soldati.<br />
Il tipo della Decursio è anch'esso <strong>di</strong> data molto<br />
remota e insieme col precedente non può esser po-<br />
steriore all'anno 56 o 57. Esso ci ricorda l'esercita-<br />
zione per la quale Nerone aveva un grande trasporto<br />
nei primi anni della sua giovinezza (^5).<br />
Un poco posteriori ai precedenti sono i rovesci<br />
che ricordano i congiarii. I monumenti suppliscono<br />
alla mancanza <strong>di</strong> fonti letterarie. Tacito menziona un<br />
solo congiario <strong>di</strong>stribuito durante il secondo conso-<br />
lato <strong>di</strong> Nerone, che cade nell'anno 57<br />
(^6); quello ri-<br />
cordato da Suetonio (^7), quantunque senza in<strong>di</strong>cazione<br />
<strong>di</strong> data, è certo lo stesso del precedente i^^).<br />
Lo Schiller (^9) ammette anch' egli due congiarii<br />
per la in<strong>di</strong>scutibile testimonianza delle monete, ma<br />
colloca il primo nel 58, secondo i due passi <strong>di</strong> Ta-<br />
cito e <strong>di</strong> Suetonio, l'altro nel 65. Vuoisi però notare<br />
che la elargizione <strong>di</strong> quest'anno fu <strong>di</strong>stribuita ai soli<br />
pretoriani ed è quin<strong>di</strong> un donativum che non può<br />
confondersi con un congiarium. L' Eckhel per altro<br />
(14) Tac, Ann. XIT, 69; Dio, LXI, 3.<br />
(15) Dio, LXI, 6; Suet., Nero, 7; Tac, Ann., XIII, 3.<br />
(16) Tac, Ann. XIII, 31.<br />
(17) Suet., Nero, io.<br />
(18) Cfr. Marquardt, Róm. Siaa/sv., t. II, p. 134-135.<br />
(19) Schiller, Nero, p. 109, n. 2.
324<br />
ETTORE CABRICI<br />
già aveva notato che, oltre a quella del 58 e del 60,<br />
tutte le largizioni <strong>di</strong> Nerone furono fatte ai preto-<br />
riani (20).<br />
La moneta con la semplice in<strong>di</strong>cazione del congiario,<br />
appartenente alla collezione Gonzales, non<br />
l'abbiamo vista e la classifichiamo secondo la descri-<br />
zione che ne fa il Cohen; ma supponiamo che il globetto<br />
sotto al collo <strong>di</strong> Nerone gli sia sfuggito, È<br />
certamente la più antica <strong>di</strong> tutte, e fu battuta prima<br />
che fosse <strong>di</strong>stribuito il secondo congiario, perchè,<br />
facendo nostra un'arguta osservazione del Kenner, il<br />
Senato, dopo la <strong>di</strong>stribuzione del primo congiario,<br />
non poteva sapere se l' imperatore avrebbe o no <strong>di</strong>-<br />
stribuito altri congiarii dopo quello del 58 e non po-<br />
teva segnare a questo il numero d'or<strong>di</strong>ne. I rovesci<br />
col GONG- 1<br />
e GONG-<br />
• II, a giu<strong>di</strong>care dal tipo <strong>di</strong> Nerone,<br />
<strong>com</strong>inciano dopo l'anno 60; <strong>di</strong>fatti il sesterzio della<br />
tav. I, n. II, avente la testa a sin., è <strong>di</strong> quelli che<br />
collochiamo accanto al tipo della Riforma. Dopo il 60<br />
furono usate in<strong>di</strong>stintamente le due scritte. Ma ci<br />
preme <strong>di</strong> assodare che il secondo congiario è ricordato<br />
sulle monete col globetto, le quali non oltrepassano<br />
il 63, ed anche per questa ragione non possiamo<br />
prestar fede alla data che lo Schiller gli ascrive.<br />
Dunque la nostra <strong>di</strong>sposizione cronologica ci sug-<br />
gerisce un secondo congiario verso il 60, che l'Eckhel<br />
dà per indubitato sulla testimonianza <strong>di</strong> un passo <strong>di</strong><br />
Suetonio (^i)^ nella vita <strong>di</strong> Nerone, colà dove parlando<br />
dei lu<strong>di</strong> maximi, celebrati prò aeternitate imperli, aggiunge<br />
" sparsa et populo missilia omnium rerum<br />
per omnes <strong>di</strong>es: singula coti<strong>di</strong>e milia avium cuiusque<br />
generis, multiplex penus, tesserae frumentariae, vestis,<br />
aurum, argentum, gemmae, margaritae, tabulae pictae,<br />
(20) EcKHEL, D. N., V, p. 271.<br />
(21) Nero, II.
LA CRONOLOGIA DELLE MONETK DI NERONE, ECC. 325<br />
mancipia, iumenta atque etiam mansuetae ferae, no-<br />
vissime naves, insulae, agri. „ Non è qui il caso <strong>di</strong><br />
parlare del significato della parola congiarium , ma<br />
non sappiamo capire perchè non si voglia ritener que-<br />
sto per un congiario, quand'esso consisteva proprio<br />
nella <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> generi alimentari o <strong>di</strong> tesserae, in<br />
cambio delle quali il citta<strong>di</strong>no riceveva la somma o<br />
i viveri o gli oggetti ai quali acquistava <strong>di</strong>ritto. Quando<br />
tutte queste cose erano gettate in mezzo alla folla,<br />
prendevano nome <strong>di</strong> missilia, <strong>di</strong> cui si parla nel ci-<br />
tato passo <strong>di</strong> Suetonio (^2)^<br />
Un altro tipo allusivo alla liberalità dell* impe-<br />
ratore è quello dell'Annona Augusti che congiungiamo<br />
col precedente e non facciamo salire oltre il 58.<br />
Un altro rovescio <strong>di</strong> sesterzii, intorno al quale<br />
inutilmente il Kenner adopera tutte le sue più sottili<br />
argomentazioni per fissarne la emissione dopo Tanno<br />
64, è quello raffigurante l'Arco <strong>di</strong> trionfo.<br />
Nell'anno 58, dopo le vittorie <strong>di</strong> Corbulone<br />
contro gli Armeni, veniva decretata dal Senato la<br />
erezione <strong>di</strong> un arco trionfale e <strong>di</strong> statue in onore <strong>di</strong><br />
Nerone (23). Ma questo decreto non ebbe pronta ese-<br />
cuzione, <strong>com</strong>e <strong>di</strong>ce lo stesso Tacito, e l' arco fu co-<br />
struito non prima del 61 (24). Ma il Kenner non ascrive<br />
a quest'anno le monete con l'Arco. Egli ragiona così:<br />
la deliberazione senatoriale relativa a questo tipo<br />
(22)<br />
grafo del 354,<br />
Il non essere citato questo congiario fra gli altri nel Crono-<br />
il quale è imperfetto <strong>com</strong>e nota il Marquardt, ha fatto<br />
si che non venisse preso in considerazione questo passo <strong>di</strong> Suetonio,<br />
dove la <strong>di</strong>stribuzione al popolo non è chiamata col suo nome <strong>di</strong> congiarium,<br />
perciò il biografo dandone tutti i particolari credette superfluo<br />
aggiungere il nome. Questa nostra opinione, che è quella dell' Eckhel,<br />
trova favore anche per V occasione che avrebbe suggerito a Nerone<br />
l'idea del congiario, il quale soleva <strong>di</strong>stribuirsi nelle solenni occasioni<br />
<strong>com</strong>e quella delle Neronie.<br />
(23) Tac. Ann, XIII, 41.<br />
(24) Ann. XV, 18.
326<br />
ETTORE GABUICI<br />
non potè esser presa prima del febbraio 62. Nella<br />
primavera fu sconfitto Peto e la costruzione dell'Arco<br />
dovette essere sospesa; è quin<strong>di</strong> probabile che sia stata<br />
fatta nel 64, quando ambasciatori dei barbari si recarono<br />
a Roma per chieder pace, senza nulla ottenere.<br />
Intanto Corbulone invade l'Armenia e ne consegue<br />
poi la pace e la venuta <strong>di</strong> Tiridate a Roma<br />
nel 66. Così il Kenner trova modo <strong>di</strong> tirare quelle<br />
monete entro la orbita dei quattro ultimi anni, nei<br />
quali restringe tutta la serie monetale <strong>di</strong> Nerone. In<br />
verità tutto questo ritardo nella esecuzione <strong>di</strong> un de-<br />
creto del Senato ci par poco verisimile (25), tanto<br />
pili che il passo <strong>di</strong> Tacito non lascia il menomo<br />
dubbio che la erezione delle statue e dell'Arco sia<br />
stata fatta sollecitamente nello stesso anno (a. 61)<br />
" at Romae tropaea de Parthis arcusque me<strong>di</strong>o Ca-<br />
pitolini montis siSTEBANTUR decreta ab senatu integro<br />
adhuc bello (^6) ^^ j e ciò in<strong>di</strong>pendentemente dal fatto<br />
che i sesterzii con l'Arco trionfale appaiono ben presto<br />
nella nostra serie cronologica. Quin<strong>di</strong> attenendoci<br />
all'opinione dell'Eckhel, riconosceremo in esso l'Arco<br />
decretato a Nerone dal Senato nell'anno 58, per le<br />
vittorie <strong>di</strong> Corbulone, e che doveva esser pronto nel<br />
61 o al pili nel 62<br />
, epoca dell' emissione <strong>di</strong> questi<br />
sesterzii.<br />
La relazione che il Kenner crede <strong>di</strong> scorgere tra<br />
i tipi della Securitas e del Genio <strong>di</strong> Nerone da<br />
una parte, la Vittoria e Nerone citaredo dall'altra,<br />
non è da trascurarsi. Se non che mentr'egli riferisce<br />
i primi due all'anno 65, quando fu sventata la congiura<br />
<strong>di</strong> Pisone, noi li riferiamo al 59, nel quale anno<br />
(25) Il Bernoulli stesso, che accetta in tutto e per tutto le opinioni<br />
del Kenner, non può starsene con lui anche in questo ed afferma che<br />
queste monete non sono state ancora chiaramente classificate (Ber-<br />
noulli, Nero, p. 390).<br />
(26) Tac. Aniu XV, 18.
LA CRONOLOGIA DELLE MONETE DI NERONE, ECC. 327<br />
fu sventata la congiura della madre. L'altra coppia,<br />
che egli spiega <strong>com</strong>e allusiva alla sua abilità d' i-<br />
strione, la colloca nell'anno 64, quando cantò nel<br />
teatro <strong>di</strong> Napoli o nel 65 quando cantò a Roma,<br />
mentre celebravansi le seconde Neronie. Quei tipi per<br />
noi risalgono all'anno delle prime Neronie, quando<br />
l'imperatore, a giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> tutti, fu reputato merite-<br />
vole della corona a preferenza d'ogni altro concor-<br />
rente ''27) per il sonar della cetra.<br />
La Vittoria volante con lo scudo sul quale leggonsi<br />
le lettere S-P-Q-R* non v'è ragione <strong>di</strong> credere<br />
che ritragga i tratti <strong>di</strong> una statua. Essa con<br />
Nerone già <strong>com</strong>incia ad essere un tipo <strong>com</strong>une nella<br />
monetazione romana, uno <strong>di</strong> quei tipi cioè, pei quali<br />
non bisogna trovare una spiegazione speciale; in-<br />
fatti una identica figura <strong>di</strong> Vittoria già si trova sulle<br />
monete <strong>di</strong> Tiberio (^S).<br />
VI.<br />
Quando Nerone chiuse il tempio <strong>di</strong> Giano.<br />
Uno dei punti ancora oscuri nella cronologia <strong>di</strong><br />
Nerone è l'anno della chiusura del tempio <strong>di</strong> Giano,<br />
della quale Tacito e Dione non fanno il menomo<br />
accenno, e soltanto Suetonio la ricorda nella vita <strong>di</strong><br />
Nerone, dopo <strong>di</strong> aver parlato dell'arrivo <strong>di</strong> Tiridate<br />
in Roma, " Ob quae imperator consalutatus, laurea<br />
in Capitolium lata, Janum geminum clausit, tam nullo<br />
quam residuo bello » (^9). Questo passo è stato pun-<br />
(27) Dio. LXI, 21.<br />
(28) Cohen, p. 96, n. 242.<br />
(29) Nern^ 14 e<strong>di</strong>z. Roth 1886.
328<br />
ETTORE CABRICI<br />
teggiato in <strong>di</strong>versi mo<strong>di</strong> dagli e<strong>di</strong>tori <strong>di</strong> Suetonio,<br />
secondo l'opinione che seguono relativamente alla<br />
chiusura del tempio <strong>di</strong> Giano. Il Roth e tutti gli<br />
storici moderni son d'accordo nel collocare la chiu-<br />
sura del tempio <strong>di</strong> Giano neir anno 66, e perciò<br />
congiungono la frase Janum geminum clausit con la<br />
precedente, formandone un sol periodo e riconnettendo<br />
tutto il concetto alla venuta <strong>di</strong> Tiridate in Roma,<br />
che cade proprio nel 66.<br />
Cewitro questa punteggiatura ed interpretazione<br />
si scagliò il Mancini interpretando il tam nullo qiiam<br />
residuo bello nel senso che debba riferirsi a due momenti<br />
<strong>di</strong>versi dell' impero <strong>di</strong> Nerone, e sostenendo<br />
r opinione del Casaubono, che il tempio <strong>di</strong> Giano<br />
sia stato chiuso da Nerone due volte, una prima<br />
volta quando v' era solo qualche residuo <strong>di</strong> guerra<br />
nell'impero' e una seconda volta quando esso era in<br />
pace perfetta (30). Prima <strong>di</strong> determinare queste due<br />
epoche, egli ha bisogno <strong>di</strong> rifare la serie delle sa-<br />
lutazioni imperiali <strong>di</strong> Nerone ed infine conchiude che<br />
la prima chiusura può cadere tra il 56 e il 57, la<br />
seconda nel 64. Per questa interpretazione e per<br />
alcuni argomenti d'indole affatto <strong>numismatica</strong>, il Man-<br />
cini torna alla punteggiatura degli e<strong>di</strong>tori antichi <strong>di</strong><br />
Suetonio e propriamente alla lezione dell'antico testo<br />
erasmiano <strong>di</strong> Basilea dell' anno 1533 il quale così<br />
<strong>di</strong>spone le parole :<br />
XIII . . . . Ob<br />
rea in Capiiolium lata.<br />
quae imperator consalutatus , lau-<br />
XIV Janum geminum clausit tam nullo quam<br />
residuo bello.<br />
(30) Mancini, Stor. <strong>di</strong>Elvid. Pr., note ed emendazioni p. 128 " Laonde,<br />
io molto volentieri sarei per tradurre cotal passo: Nerone tenne chiuso<br />
il bifronte Giano, si nella pace che con residuo <strong>di</strong> guerra. „
LA CRONOLOGIA DELLE MONETE DI NERONE, ECC. 329<br />
Non sappiamo perchè i moderni e<strong>di</strong>tori <strong>di</strong> Sue-<br />
tonio si ostinino a mantertere la loro punteggiatura in<br />
questo punto, e <strong>com</strong>e gli storici, quali lo Schiller (3i)<br />
e il Duruy (32)^ sostengano la chiusura del tempio <strong>di</strong><br />
Giano essere avvenuta nel 66, quando essi sono<br />
contraddetti dalle monete, sulle quali il rovescio col<br />
tempio <strong>di</strong> Giano va congiunto con la leggenda del<br />
<strong>di</strong>ritto che segna la XII (aa) e anche la XI (a4) tribunicia<br />
potestas <strong>di</strong> Nerone, il che ci obbliga a collo-<br />
care tale chiusura, almeno nel 64, <strong>com</strong>e fa osser-<br />
vare il Mancini. Ma pur riconoscendo a lui il merito<br />
<strong>di</strong> avere pel primo contraddetto alla <strong>com</strong>une falsa<br />
opinione sulla chiusura del tempio <strong>di</strong> Giano, non<br />
sapremmo sostenere egualmente la duplice chiusura.<br />
Il Mancini vi è indotto prima dal passo <strong>di</strong> Suetonio,<br />
poi dai sesterzii con la XI, XII e XIII trib. pot. <strong>di</strong><br />
Nerone e crede che i sesterzii col tempio <strong>di</strong> Giano<br />
coniati dal 64 in poi abbiano l'in<strong>di</strong>cazione della trib.<br />
pot. <strong>di</strong> Nerone, affinchè potessero <strong>di</strong>stinguersi dai<br />
primi. La tesi del Mancini muove due obbiezioni. La<br />
prima se la fa egli stesso, col domandarsi, perchè<br />
mai nella leggenda attorno al tempio <strong>di</strong> Giano dei<br />
secon<strong>di</strong> sesterzii non sia stato messo V avverbio<br />
iterum (35). Un avvenimento <strong>di</strong> tanta importanza non<br />
poteva esser ricordato inesattamente, specie quando<br />
si osserva che nei Co'ngiarii non manca mai il numero<br />
d'or<strong>di</strong>ne. Se poi si voglia credere col Mancini che <strong>di</strong><br />
questa seconda apparizione siano segno i numeri della<br />
trib. potestas, doman<strong>di</strong>amo allora, che significato<br />
(31) Nero, pag. 204; e poi Gesch. der Róm. Kaisers., pag. 351.<br />
(32) Hist. des Rom. t. IV, p. 83.<br />
(33) FioRELLi, Cat. n. 4354, 4355- La correzione che Io Schiller propone<br />
al sesterzio del Cohen, n. 178 (v. Schiller, Nero, p. 204, n. i) è<br />
contraddetta da questi due sesterzi del medagliere <strong>di</strong> Napoli.<br />
(34) FioRELLi, Cat. n. 4353.<br />
(35) Op. cit., pag. 126.<br />
43
330<br />
ETTORE CABRICI<br />
avrebbe la XIII trib. pot. su quei sesterzi! e dupon<strong>di</strong>i<br />
dal tipo <strong>di</strong> Roma galeata sedente sugli scu<strong>di</strong>? (36)<br />
E inoltre se fosse così, i sesterzii degli anni 64-67<br />
col tempio <strong>di</strong> Giano dovrebbero aver tutti la trib.<br />
potestas, la quale invece è rarissima, e accanto a<br />
questi troviamo sesterzii senza data <strong>di</strong> sorta che per<br />
il tipo <strong>di</strong> Nerone vanno collocati indubbiamente fra<br />
le ultime emissioni (v. Prospetto).<br />
Per queste due ragioni non pare abbastanza<br />
giustificata una seconda chiusura, la quale potrebbe<br />
ancora reggere, solo per il testo <strong>di</strong> Suetonio (37). Ma<br />
anche sulla interpretazione <strong>di</strong> questo facciamo le nostre<br />
riserve. Se il clausit si traduce tenne chiuso, <strong>com</strong>e<br />
vuole il Mancini, non v'è bisogno <strong>di</strong> ammettere due<br />
chiusure. E qui ci sia lecito <strong>di</strong> fare osservare al<br />
Mancini che non bisognava tirar poi tanto il senso<br />
<strong>di</strong> clusit quando egli sta per le due chiusure: sarebbe<br />
stato meglio tradurre col semplice chiuse. Ma traducendo<br />
tenne chiuso, vien quasi ad essere esclusa Tidea<br />
della ripetizione <strong>di</strong> azione, e si viene ad ammettere<br />
implicitamente una sola chiusura. Se poi dopo la<br />
prima chiusura il tempio <strong>di</strong> Giano sia stato aperto<br />
un'altra volta per lo scoppio della guerra armena e<br />
la spe<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> Corbulone, a noi non è dato ricer-<br />
care. Non è improbabile che l'ambizione dell'impera-<br />
tore abbia continuato a tenerlo chiuso, per ostentare<br />
una calma apparente, a quel modo che il decreto<br />
del senato or<strong>di</strong>nante la erezione <strong>di</strong> un arco e <strong>di</strong><br />
(36) CoH., Nero^ n. 283, 284, 286 (dupon<strong>di</strong>o), 287; Fiorelli, Cat.<br />
n 4356-58.<br />
(37) La duplice leggenda che queste monete portano scritta sul<br />
rovescio (pace p . r , terra mariq, parta xanvm clvsit e pace p.r.<br />
VBiQ . PARTA . lANVM clvsit) potrebbe dar fondamento alla ipotesi della<br />
duplice chiusura. Ma a prescindere, che non trovo <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> signif.<br />
tra le due leggende, è a notarsi che la seconda trovasi solo sugli assi<br />
e sui dupon<strong>di</strong>i, i quali offrivano uno spazio assai piìi piccolo <strong>di</strong> quello<br />
dei sesterzii, ed essendo la prima leggenda troppo lunga, fu abbreviata.
LA CRONOLOGIA DELLE MONETE DI NERONE, ECC. 33 1<br />
Statue per la vittoria <strong>di</strong> Corbulone non fu revocato,<br />
ma rinviato, quando pervenne a Roma la novella<br />
della <strong>di</strong>sfatta <strong>di</strong> costui (38).<br />
Resta ora a determinare 1' anno <strong>di</strong> tale avvenimento.<br />
In questa ricerca solo le monete ci possono<br />
illuminare. Il tipo <strong>di</strong> Giano sui sesterzii appare molto<br />
per tempo nella serie col globetto ed è quin<strong>di</strong> da<br />
collocarsi prima del 60. E sic<strong>com</strong>e in questi primi<br />
sette anni non si godè vera pace, <strong>com</strong>e osserva il<br />
Mancini, se non dal 56 al 57, siamo lieti <strong>di</strong> poter<br />
accettare quest' anno che il Mancini segna per la<br />
prima chiusura.<br />
VII.<br />
Osservazioni Iconografiche.<br />
Il Bernoulli ragionando del ritratto <strong>di</strong> Nerone<br />
sulle monete, vi osserva delle variazioni stabili nel<br />
tipo, le quali non sembrano tutte convenzionali, ma<br />
alcune <strong>di</strong> esse corrispondono certamente alle variazioni<br />
deir originale (39). Di tutte le serie monetali, raggruppate<br />
secondo il rispetto dell'arte, le più fedeli sono quella<br />
col capo a sin. e globetto e le ultime monete dal<br />
tipo della Riforma. Le une e le altre ci danno le<br />
forme piene, gonfie, lo sguardo accigliato, il collo<br />
(38) Tac. Ann. XV, i8 " At Romae tropaea de Parthis arcusquc<br />
me<strong>di</strong>o Capitolini montis sistebantur, decreta ab senatu integro adhuc<br />
bello, neque tum omissa, dum adspectui consulitur, spreta conscientia. „<br />
(39) Bernoulli, Nero p. 388 " .... so zeigen sie in ihrer Aufeina<br />
iderfolge doch noch bestimmte typische Unterschiede, <strong>di</strong>e nicht alle<br />
conventioneller Natur zu sein scheinen, sondern von dcnen einige oifen-<br />
bar, den Wandlungen des Urbildès entsprechen. „
332 ETTORE CABRICI<br />
grosso e tutti quegli accessorii nei quali sono im-<br />
presse le tracce delle sue <strong>di</strong>ssolutezze. Il convenzionalismo<br />
si trova specialmente nel primo tipo della<br />
Riforma, tanto sulle monete col capo a sin. quanto<br />
su quelle col capo a d. Quel ritratto ci dà un tipo<br />
non più grossolano, anzi <strong>di</strong> forme giuste, tutto proporzionato,<br />
se ne togli le proporzioni del collo, che<br />
sono esagerate in lunghezza e in larghezza sulle<br />
monete <strong>di</strong> tutti gl'imperatori romani ; quel ritratto ci<br />
dà infine un Nerone abbellito. Avemmo agio <strong>di</strong> fare,<br />
quest' osservazione sull' asse d' oricalco della tav. II<br />
n. IO.<br />
Ma noi non vogliam <strong>di</strong>re <strong>di</strong> quel convenzionalismo<br />
che consiste nell' accrescere o <strong>di</strong>minuire le<br />
proporzioni, nell'abbellire l'originale; noi troviamo nel<br />
tipo vero della Riforma qualche cosa che per l'artista<br />
e per il romano dell' età <strong>di</strong> Nerone era il carattere<br />
essenziale <strong>di</strong> tutte le teste <strong>di</strong> Nerone, un particolare<br />
che da solo bastava a dare la somighanza del suo<br />
volto. L'arte monetale in tutte le epoche ha <strong>di</strong>mostrato<br />
<strong>di</strong> sdrucciolare facilmente in questo conven-<br />
zionalismo, specie nelle età <strong>di</strong> decadenza dell'arte.<br />
Gli artisti incisori dei conii, costretti a ripetere sempre<br />
lo stesso tipo per anni ed anni, facilmente davano<br />
importanza a qualche accessorio, il quale <strong>di</strong>ventava<br />
col tempo la caratteristica più spiccata del volto<br />
dell'imperatore. Delle due l'una: o Nerone portava<br />
<strong>di</strong> consueto i capelli rivolti in su <strong>com</strong>e appaiono su<br />
tutte le monete che hanno il capo a destra, o li portava<br />
rivolti in giù <strong>com</strong>e sono <strong>di</strong>segnati sulle monete<br />
col capo a s. Già questa stessa <strong>di</strong>visione, fondata<br />
sulla <strong>di</strong>rezione del capo, vale a provare il convenzionalismo,<br />
vale cioè a <strong>di</strong>mostrare che dati i due<br />
tipi fondamentali, essi furon seguiti costantemente,<br />
variando solo qualche accessorio. Tutto induce a far<br />
credere che il tipo dai capelli in su sia il conven-
LA CRONOLOGIA DELLE MONETE DI NERONE, ECC. 333<br />
zionale. Fra le teste in marmo <strong>di</strong> Nerone adulto, solo<br />
qualcuna potrebbe mettersi a confronto con la testa<br />
<strong>di</strong> Nerone sulle monete, e sono la testa della Biblioteca<br />
Vaticana (4°) e quella del Museo <strong>di</strong> Monaco (40. Ma<br />
l'arte plastica si mantenne estranea a questa esage-<br />
razione. Infatti non si può <strong>di</strong>re lo stesso pel busto del<br />
Louvre (42) o per la testa del British Museum, opera<br />
greca (43) ; i quali monumenti ci danno la vera acconciatura<br />
<strong>di</strong> capelli che provocò il tipo delle monete.<br />
Ivi riscontriamo nella chioma in generale una<br />
certa ondulazione, della quale parla Suetonio, e sulla<br />
fronte i capelli sono <strong>di</strong>sposti a ciocche formanti un<br />
rialzo attorno alla fronte ed assottigliantisi man mano,<br />
fino a toccare la fronte con la loro estremità. L'arte<br />
monetale un po' per le proporzioni troppo piccole, un<br />
po' perchè non si trovava nelle identiche con<strong>di</strong>zioni<br />
dell'arte plastica, essendo obbligata a riprodurre il<br />
tipo <strong>di</strong> profilo, non potè copiare fedelmente 1' origi-<br />
nale e creò il tipo che abbiamo visto e chiamato<br />
della Riforma. Se si osservano per altro gli aurei che<br />
vanno dal 62 al 63, <strong>com</strong>e il n. 4, tav. I e quello<br />
inserito dal Bernoulli nella tav. XXXV n. 16, si<br />
trovano i capelH a questa foggia <strong>di</strong>segnati (44).<br />
(40) Bernoulli, Nero taf. XXIII.<br />
(41) Id. taf. XXIV.<br />
(42) Id. taf. XXV.<br />
(43) Id. p. 393 fig. 59-<br />
(44) A questo proposito ci sia lecito uscire dal campo numismatico<br />
ed esprimere il nostro parere sul busto <strong>di</strong> Nerone del Louvre, riprodotto<br />
dal Bernoulli a p. 397 fig. 58. Il Bernoulli si domanda se è antico,<br />
notando ragionevolmente una grande somiglianza con la testa <strong>di</strong> bronzo<br />
del Vaticano. La capigliatura non mi sembra <strong>di</strong> Nerone; abbiamo busti<br />
<strong>di</strong> Nerone con i capelli così pettinati, ma sono tutti giovanili. Quello è<br />
un busto <strong>di</strong> Nerone adulto e quell'acconciatura del capo non si trova<br />
mai sui monumenti che lo rappresentano adulto. Tutto induce a far<br />
credere che sia opera moderna, fatta sull'originale del Vaticano.
PROSPETTO CRONOLOGICO
336
ONZI DI NERONE COL GLOBETTO.<br />
///> (SOO-Sr, — 810-03)<br />
TA<br />
337
338<br />
CLASSIFICAZIONE CRONOLOGICA DEI BRONZI DI NERO^
\ ENTI IL CAPO DELL'IMPERATORE A SINISTRA<br />
ll2l=08<br />
ATA ASSI (rame)<br />
Testa laitr. a s.<br />
(pel tipo <strong>di</strong> N. V. tav. Ili n. ii)<br />
Citaredo Coh. 196.<br />
Giano Coh. 172, 175. Fior.<br />
4503-07-<br />
PROVIDENT Coh. 255.<br />
Vittoria Coh. 289. Fior. 4673-<br />
82, 4684-85.<br />
339<br />
DATA SEMIS (oricalco)<br />
Testa laur. a s.<br />
Mensa agonistica. Fior. 4350-51.<br />
st., tranne rarissime eccezioni, <strong>com</strong>e quella della tav. Ili n. 8, non rimasero dopo il 64 che<br />
neri del Cohen, perchè essi possono essere tanto del 63 quanto del 67. Accanto al tipo <strong>di</strong><br />
piamo che non oltrepassa il 64. Piuttosto possiamo ascrivere agli ultimi anni (65-68) alcuni<br />
i quelli nel cui <strong>di</strong>ritto sta la leggenda imp nero clavd (clav<strong>di</strong>vs) caesar avg . germ . p . m .<br />
terzio anteriore al 64 o 65 che abbia questa leggenda nel <strong>di</strong>ritto.<br />
za il globetto sotto al collo. Il Fiorelli ne descrive due senza glob. (n. 4598-99), ma sugli<br />
endovi adunque in questa serie dupon<strong>di</strong>i con la testa laureata, si deve inferire che essa sia<br />
63. Alla stessa conclusione mena l'assenza <strong>di</strong> semt's <strong>di</strong> rame: due soli ne ho visti e sono <strong>di</strong>
340<br />
CLASSIFICAZIONE CRONOLOGICA DEI BRON
XERONE COL TIPO DELLA RIFORMA<br />
i|ri-cj»<br />
ta ASSI<br />
Testa rad. a d.<br />
(pel tipo <strong>di</strong> N. V. tav. II<br />
n- 13)<br />
Citaredo Coh. 191,<br />
203, 248. T<br />
Fior. 4699,<br />
4704- T<br />
„ Coh. 199,<br />
200, 201,<br />
241.<br />
GENIO AVGVSTl Coh.<br />
„<br />
108. T<br />
Fior. 4422-<br />
26. T<br />
„ Fior. 4421.<br />
oricalco<br />
Testa l. a d.<br />
(pel tipo <strong>di</strong> N. V. tav. II<br />
n. io).<br />
„ Coh. 202, 242.<br />
— Coh. 107. t Vittoria Coh. 288,<br />
Coh. loi.<br />
rame<br />
Testa l. a d.<br />
(pel tipo <strong>di</strong> N. V. tav. Ili<br />
n- I. 3)-<br />
Giano Coh. 132, 141,<br />
„<br />
„<br />
142, 163, 164,<br />
171, 176, 177.<br />
Fior. 4469-71,<br />
4479-83, 4484-<br />
94.<br />
297» 298, 301.<br />
Fior. 4650-66.<br />
341<br />
Data SEMIS<br />
Testa l. a d.<br />
(pel tipo <strong>di</strong> N. V. tav. II<br />
n. 9).<br />
Mensa agonistica<br />
Coh. 47, 58,59,<br />
61-64. s<br />
Fior. 4339-44,<br />
4346-51. s<br />
Coh. 49,60, 6j.<br />
Fior. 4345.<br />
ROMA Coh. 178, 332. S<br />
Fior. 4569-73,<br />
4575-77- s<br />
Coh. 189, 236.<br />
Fior. 4565-68,<br />
4574-
342 ETTORE CABRICI<br />
APPENDICE A.<br />
Nel Catalogo del Museo Nazion.ile <strong>di</strong> Napoli, <strong>com</strong>pilato dal Fiorelli,<br />
ricorrono alcune inesattezze tipografiche, da noi corrette nel <strong>com</strong>pilare<br />
il prospetto cronologico. Queste inesattezze sono parecchie e a noi preme<br />
farle notare, affinchè chi vorrà fare confronti col catalogo del Fiorelli<br />
non attribuisca ad errore nostro ciò che è una correzione fatta dopo<br />
uno stu<strong>di</strong>o accurato sui monumenti.<br />
ERRATA CORRIGE<br />
"• 4359 Testa <strong>di</strong> N. laur. a d.<br />
n. 4371-74 Testa <strong>di</strong> N. laur. a d.,<br />
sotto globetto.<br />
n. 4408 Testa <strong>di</strong> N. laur. a s.<br />
n. 4469-71 Testa <strong>di</strong> N. laur. a d.<br />
n. 4529-31 IMP . NERO CLAVD . CAESAR<br />
AVG . GER . P . M . TR . P .<br />
P .P<br />
n. 4549 Testa <strong>di</strong> N. laur. a s.,<br />
con egida sul petto,<br />
n. 4598-9 Testa <strong>di</strong> N. laur. a s.<br />
n. 4614-15 Testa <strong>di</strong> N. laur. a d.<br />
n. 4616 Testa <strong>di</strong> N. laur. a s.<br />
n. 4683 Testa <strong>di</strong> N. laur. a s.<br />
n. 4705 Testa nuda <strong>di</strong> N. a s.<br />
bJ Nerone citaredo, nel-<br />
l'esergo i.<br />
Testa <strong>di</strong> N. laur. a d. sotto globetto.<br />
Testa nuda <strong>di</strong> N. a d., sotto glo-<br />
betto.<br />
Busto <strong>di</strong> N. laur. a s. con egida<br />
sull'omero.<br />
Uno <strong>di</strong> questi tre esempi, ha la<br />
testa nuda.<br />
IMP . NERO CLAVD . CAESAR AVG . GER<br />
p . M . TR .p . xni . P .P<br />
Testa <strong>di</strong> N. laur. a s. con egida<br />
sull'omero.<br />
Testa <strong>di</strong> N. laur. a s., sotto globetto.<br />
Una <strong>di</strong> queste monete ha la corona<br />
ra<strong>di</strong>ata.<br />
Testa <strong>di</strong> N. laur. a s. sotto globetto<br />
(appena visibile).<br />
Testa <strong>di</strong> N. nuda a s.<br />
Testa nuda <strong>di</strong> N. a s., sotto globetto.<br />
F^ Nerone citaredo, senza segno <strong>di</strong><br />
valore nell'esergo.<br />
.
LA CRONOLOGIA DELLE MONETE DI NERONE, ECC. 343<br />
APPENDICE B.<br />
Peso <strong>di</strong> alcune monete d'oro e d'argento <strong>di</strong> Nerone.<br />
Fiorelli<br />
n. 4317-20<br />
n. 4321-22<br />
n- 4323<br />
n- 4324-25<br />
n. 4326-28<br />
n. 4329<br />
n. 4331-32<br />
n. 4352<br />
n. 4375-76<br />
n. 4380-84<br />
n. 4457-58<br />
n. 4578<br />
n. 4617<br />
n. 96<br />
n. 42<br />
n. 66<br />
n. 118<br />
n. 3T3<br />
Cohen<br />
a) Medagliere dì Napoli<br />
Oro<br />
gr. 7.64; 7.62; 7,61.<br />
gr. 7,62; 7,45.<br />
gr. 7>59-<br />
gr. 7,72: 7,71.<br />
gr. 7,67; 7,64.<br />
gr. 6,42.<br />
gr.<br />
gr.<br />
gr.<br />
gr.<br />
gr.<br />
gr.<br />
gr.<br />
7;73i<br />
7,47-<br />
7>32i<br />
7,67.<br />
7,30.<br />
7,27; 7>i9-<br />
7»33; 7,19.<br />
7»3i-<br />
7,22.<br />
gr. 7.60.<br />
gr. 7,19.<br />
gr. 7,25.<br />
Fiorelli<br />
"• 4330<br />
n. 4385<br />
n. 43^6<br />
n. 4619<br />
h) IVIedagliere Santangelo<br />
Oro<br />
gr. 7,43; 7.33; 7>'5;<br />
6,94.<br />
gr. 6,86.<br />
Cohen<br />
n. 312<br />
n. 97<br />
n. 7<br />
n. 352<br />
n. 32<br />
n. 314<br />
n. 119<br />
n. 258<br />
n. 67<br />
gr. 3,46.<br />
gr. 3,08.<br />
gr. 3,23.<br />
gr. 3,35-<br />
gr. 3,48.<br />
gr. 3,63.<br />
gr. 2,42.<br />
Argento<br />
Argento<br />
gr. 1,59 (sest.).<br />
gr. 1,57 (sest.).<br />
gr<br />
gr<br />
3>43; 3,37;<br />
3,29; 3,17.<br />
3,47; 3.33;<br />
2,87.<br />
3,27; 3,17-<br />
3,25.<br />
3.32;<br />
3.01
344<br />
ETTORE CABRICI<br />
DESCRIZIONE<br />
DELLE MONETE CONTENUTE NELLE TAVOLE<br />
Num. Data<br />
. .<br />
Tavola I.<br />
1. 810=57 — NERO . CAESAR . AVG . iMP . Testa Huda <strong>di</strong> Nerone a d.<br />
lO — PONTiF . MAX . TR . p . iiii P.P. CoFona <strong>di</strong> quercia, nel<br />
mezzo EX s . e<br />
7)62. Fiorelli, Cat. n. 4321.<br />
N S^-<br />
nuda <strong>di</strong> N. a d.<br />
2. 811=58 — NERO . CAESAR . AVG . iMP . Tcsta<br />
I^ — PONTIF . MAX . TR . p ."v<br />
mezzo EX s . e<br />
p . p . CoFona <strong>di</strong> quercia, nel<br />
N S^- 1>59- Fiorelli, Caf. n. 4323.<br />
3. 813=60 — NERO . CAESAR . AVG . iMP , Testa nuda <strong>di</strong> N. a d.<br />
I^ — PONTiF . MAX . TR . p . VI . cos . IMI .P.P. Corona <strong>di</strong><br />
quercia, nel mezzo ex s . e .<br />
jy Napoli (Depositi del Mas. Naz.)-<br />
4. 813=60 — NERO . CAESAR . AVG . IMP . Tcsta nuda <strong>di</strong> N. a d.<br />
.P.P. Marte in pie<strong>di</strong><br />
a s., poggiato all'asta e col parazonio in mano, calcando<br />
I^ — PONTIF . MAX . TR . p . VII . COS . UH<br />
varie armi; ai lati ex s . c .<br />
jy gr. 7,64. Fiorelli, Cai. n. 4326.<br />
5. 813=60 — nero . CAESAR . AVG . IMP . Testa nuda <strong>di</strong> N. a d.<br />
r^ — PONTIF . MAX . TR . p . vir. cos . ììTi .p .p . Roma in pie<strong>di</strong><br />
a d., col piede calcando varie armi e tenendo sulla gamba<br />
uno scudo rotondo su cui scrive; ai<br />
^ gr. 6,42.<br />
lati ex s . c .<br />
Fiorelli, Cat. n. 4329.<br />
6. 813=60 — NERO . CAESAR . AVG . IMP . Testa nuda <strong>di</strong> N. a d.<br />
I^ — PONTIF . MAX . TR . p . VII . COS . iiii .P.P. Sim. al n. 4.<br />
jy Fiorelli, Caf. n. 4326-28.<br />
7. 816=63 ~ NERO . CAESAR . AVG . IMP .<br />
IQ — PONTIF . MAX . TR . p ."x<br />
Testa nuda <strong>di</strong> N. a d.<br />
COS . lìTT p . p . Il Valore in pie<strong>di</strong><br />
a s. poggiato all'asta e con parazonio in mano, calcando<br />
una galea; ai lati ex s . c .<br />
N gr- 7>47- Fiorelli, Cat. n. 4352.<br />
8. — NERO CLAVD . CAESAR AVG . GER . P . M . TR . P . IMP .P.P.<br />
Testa <strong>di</strong> N. laureata a s.<br />
^ — PACE P . R . TERRA MARIQ . PARTA lANVM CLVSIT. Il tempio<br />
<strong>di</strong> Giano a d. con la porta chiusa ed ornata <strong>di</strong> festone, ai<br />
lati S.C. Sest. Fiorelli, Cat. n. 4497.
Num. Data<br />
LA CRONOLOGIA DELLE MONETE DI NERONE, ECC. 345<br />
9. — NERO CLAVDIVS CAESAR AVG .<br />
Testa <strong>di</strong> N. a s. con corona ra<strong>di</strong>ata.<br />
GER<br />
. P . M . TR . P . IMP .P.P.<br />
I^ — ROMA. Roma sedente a s. sopra una ìbrica e più scu<strong>di</strong><br />
calcando una galea, che con la sin. stringe il parazonio e<br />
tiene nella d. una corona d'alloro; ai lati s.c.<br />
Dup. Fiorelli, Cat. n. 4559.<br />
10. — NERO CLAVDIVS CAESAR AVG . GERM . P . M . TR . P. IMP .P.P.<br />
Testa <strong>di</strong> N. laur. a s. con egida sul petto.<br />
r) — DECVRSio. Nerone corrente a d. su veloce destriero con<br />
asta inclinata, seguito da un altro cavaliere che porta un<br />
vessillo; ai Iati s.c.<br />
5^5/. Napoli (Depositi del Mus. Naz.).<br />
11. — NERO CLAVDIVS CAESAR AVG . GERM . P . M . TR . P . (iMP .P.P.)<br />
Testa <strong>di</strong> N. laur. a s.<br />
R) — coNG.Ti DAT. POP. Nerone sedente a d. su <strong>di</strong> un sug-<br />
gesto, presso cui un magistrato in pie<strong>di</strong> e nel basso altre<br />
due figure virili, delle quali una porge all'altra una tessera<br />
che questa raccoglie nel seno della toga; nel fondo è un<br />
peristilio ed il simulacro <strong>di</strong> Pallade, nell'esergo s.c.<br />
12. — NERO CLAVD .<br />
CAESAR<br />
Sest. Fiorelli, Cat. n. 4401.<br />
AVG . GERM . P . M . TR . P . IMP .P.P.<br />
Testa <strong>di</strong> N. a s. con corona rad.<br />
I^ — VICTORIA AVGvsTi . La Vittoria alata gra<strong>di</strong>ente a s. con<br />
ramo <strong>di</strong> palma in una mano e nell'altra la corona d'alloro;<br />
13. — NERO CLAVD .<br />
ai lati s . e, nell'esergo Ti. Dup. Fiorelli, Cat. n. 4640.<br />
CAESAR<br />
AVG .<br />
GER<br />
. P . M .<br />
TR<br />
. P . IMP .P.P.<br />
Testa <strong>di</strong> N. laur. a s. con egida sull'omero.<br />
^ — ROMA. Roma sedente a s. sopra una lorica e più scu<strong>di</strong>,<br />
calcando una galea, che con la s. stringe il parazonio e<br />
14. — NERO CLAVD .<br />
sostiene con la d. la Vittoria che le porge una corona; ai<br />
lati s . e Sest. Fiorelli, Cat. n. 4549.<br />
CAESAR<br />
AVG . GER . P . M .<br />
TR<br />
. P . IMP .P.P.<br />
Testa <strong>di</strong> N. laur. a d.<br />
lANVM CLVsiT. Il tempio <strong>di</strong> Giauo<br />
a d. con la porta chiusa ed ornata <strong>di</strong> festone, ai lati s.c<br />
Asse. Santangelo.<br />
R) — PACE p . R . vBiQ . PARTA<br />
15. — NERO CLAVD . CAESAR AVG . GER . P . M . TR . P . IMP .P.P.<br />
Testa nuda <strong>di</strong> N. a d.<br />
I^ — PACE P . R . TERRA MARIQ . PARTA lANVM CLVSIT. Il tempio<br />
<strong>di</strong> Giano a d. con la porta chiusa e ornata <strong>di</strong> festone; ai<br />
lati S.C. Asse (rame). Fiorelli, Cat. n. 4469.<br />
16. — IMP . NERO CAESAR AVG . P . MAX . TR . P . P . P . TeSta <strong>di</strong> N.<br />
laur. a s. poggiante su <strong>di</strong> un globetto.<br />
4t
346<br />
Num. Data<br />
ETTORE CABRICI<br />
V^ — VICTORIA AVGVSTi . La Vittoria alata gra<strong>di</strong>ente a s. con<br />
ramo <strong>di</strong> palma in una mano e nell'altra la corona d'alloro;<br />
ai lati S.C. Dup. Fiorelli, Caf. n. 4628.<br />
17. — iMP . NERO CAESAR AVO . p . MAX .<br />
N. a s. poggiante su <strong>di</strong> un globetto.<br />
TR<br />
. p . p . p . Testa<br />
laur. <strong>di</strong><br />
I^ — VICTORIA AVGVSTi . La Vittoria alata, <strong>com</strong>e nel n. 12,<br />
ma senza segno <strong>di</strong> valore. Dup. Santangelo.<br />
18. — im(p.ne)ro CAESAR AVG . p . MAX .<br />
TR<br />
. p . p . p , Testa nuda<br />
<strong>di</strong> N. a s. poggiante su <strong>di</strong> un globetto ; avanti la contromarca<br />
VESPA .<br />
I^ — {gen)io avgvsti. Genio in pie<strong>di</strong> a s. innanzi ad un'ara<br />
accesa, avendo in mano la patera e il cornucopia; ai lati<br />
S.C. Asse (rame). Collez. Gnecchi.<br />
19. — NERO CLAVD . CAESAR AVG .<br />
GER<br />
. P . M .<br />
TR<br />
. P . IMP .P.P.<br />
Testa <strong>di</strong> N. laur. a s. poggiante su <strong>di</strong> un globetto.<br />
I^ — DECvRSio. Nerone a cavallo corrente a d., con asta<br />
inclinata, preceduto da un soldato a pie<strong>di</strong> che porta un'insegna<br />
e seguito da un altro; ai lati s.c.<br />
Tavola II,<br />
1. — NERO CLAVD . CAESAR AVG .<br />
, i^<br />
GER<br />
Sest. Fiorelli, Cai. n. 4409.<br />
. P . M . TR . P . IMP .P.P.<br />
Testa <strong>di</strong> N. laur. a d. poggiante sopra un globetto.<br />
— SECVRITAS AVGVSTI. La Sicurtà sedente a d. che poggiato<br />
il cubito al dossale del seggio, sostiene il capo con<br />
la mano ed ha nella s. un'asta; innanzi, ara accesa adorna<br />
<strong>di</strong> festoni, cui è addossata una face; ai lati s.c.<br />
Dup. Fiorelli, Caf. n. 4603-04.<br />
2. — NERO CLAVD . CAESAR AVG . GER . P . M . TR . P . IMP .P.P.<br />
Testa <strong>di</strong> N. laur. a d., poggiante su <strong>di</strong> un globetto.<br />
. TERRA MARIQ . PARTA lANVM CLVSIT. Il tCUipio<br />
<strong>di</strong> Giano a d., ecc.; ai lati s.c. Sesf. Imhoof-Blumer.<br />
I^ — PACE P . R<br />
3. — IMP . NERO CAESAR AVG . p . MAX . TR . p . p . p. Testa nuda <strong>di</strong><br />
N. a d., poggiante su <strong>di</strong> un globetto.<br />
f^ — ARA PAcis. Ara adorna <strong>di</strong> figure e palmette, ai lati s.c.<br />
Asse (rame). Fiorelli, Caf. n. 4371-72.<br />
4. — IMP . NERO CAESAR AVG . PONTiF. Testa nuda <strong>di</strong> N. a d.<br />
I^ — PONTiF . MAX . TR . POT<br />
.P.P. Roma sedente a s. sopra<br />
una lorica e piìi scu<strong>di</strong>, calcando una galea, che con la s.<br />
stringe il parazonio e tiene nella d. una corona <strong>di</strong> alloro;<br />
nell'esergo s.c. Asse (rame). Fiorelli, Caf. n. 4564.
Num. Dat.i<br />
LA CRONOLOGIA DELLE MONETE DI NERONE, ECC. 347<br />
5. — NERO CLAVDIVS CAESAR AVG . GERM . P . M . TR . P . IMP .P.P.<br />
Testa <strong>di</strong> N. laur. a d.<br />
^ — CERTAMEN QviNQ . ROM . CO . Mensa agonistica adorna <strong>di</strong><br />
due grifi, sopra cui vaso e corona; sotto un <strong>di</strong>sco.<br />
Semis (rame). Fiorelli, Cat. n. 4333.<br />
6. — NERO CLAVD . CAESAR AVG . GER . P . M . TR . P . IMP .P.P.<br />
Busto <strong>di</strong> N. laur. a d., con egida sul ]>etto.<br />
I^ — Arco <strong>di</strong> trionfo adorno <strong>di</strong> festone, sulla cui sommità è<br />
l'imperatore in quadriga fra la Pace e la Vittoria, con altre<br />
due figure sulla cornice <strong>di</strong> coronamento: <strong>di</strong> lato in una<br />
nicchia è Marte in pie<strong>di</strong> con asta e scudo, essendo pure<br />
l'attico ed il basamento ornati <strong>di</strong> figure; ai lati s.c.<br />
Sest. Fiorelli, Cat. n. 4695.<br />
7. — NERO CLAVDIVS CAESAR AVG. GERM . P . M . TR . P . IMP . P . P .<br />
Busto <strong>di</strong> N. laur. a d. con egida sul petto.<br />
.Rj — ANNONA AVGVSTi CERES. Cerere sedente a s. con face<br />
e spighe tra mani, innanzi a cui è l'Abbondanza in pie<strong>di</strong><br />
con cornucopia nella sin. e la d. poggiata sul fianco, presso<br />
<strong>di</strong> una base ornata <strong>di</strong> festone, su cui è il mo<strong>di</strong>o; nel fondo<br />
una nave, nell'es. s.c. Collez. Gnecchi.<br />
8. — NERO CLAVD . CAESAR AVG .<br />
GER<br />
. P . M .<br />
Busto <strong>di</strong> N. laur. a d. con egida sul petto.<br />
TR<br />
. P . IMP .P.P.<br />
I^ — ROMA. Roma galeata seduta a s. su <strong>di</strong>verse armi, che,<br />
tenendo il parazonio nella sinistra, sostiene colla destra<br />
un globo sormontato da una piccola Vittoria, che le porge<br />
una corona. Collez. Gnecchi.<br />
9- — NERO cAES . AVG . IMP . Tcsta <strong>di</strong> N. laur. a d.<br />
R) — TR . poT .p.p. Roma sedente a s. sopra una lorica e<br />
più scu<strong>di</strong> calcando una galea, che con la s. stringe il pa-<br />
10. — NERO CLAVD .<br />
razonio e tiene nella d. una corona d' alloro ; avanti s,<br />
nell'es. s.c. Semis (oricalco). Fiorelli, Cat. n. 4571.<br />
Testa <strong>di</strong> N. laur. a d.<br />
CAESAR<br />
AVG . GER . P . M . TR . P . IMP .P.P.<br />
R) — GENIO AVGVSTi. Gcnìo in pie<strong>di</strong> a s. innanzi ad un' ara<br />
accesa, avendo in mant) una patera e un cornucopia; ai<br />
lati s . e, nell'es. T. Asse (oricalco). Fiorelli, Cat. n. 4424-26.<br />
11. — NERO CLAVDIVS CAESAR AVG . GER . P . M .<br />
TR<br />
. P . IMP .P.P.<br />
Testa <strong>di</strong> N. a d. con corona ra<strong>di</strong>ata.<br />
^ — SEcvRiTAS AVGVSTL La Sicuptà (v. tav. II, n. i); nell'esergo<br />
ir.<br />
12. — NERO CAESAR AVGVSTvs. Tcsta <strong>di</strong> N. laur. a d.<br />
R) — PACE p . R .<br />
Terra<br />
mariq . parta ianvm clvsit. Porta<br />
chiusa del tempio <strong>di</strong> Giano. jy^ Fiorelli, Cat. n. 4457-58.
348<br />
Num. Data<br />
ETTORE CABRICI<br />
1-3. — NERO CLAVDivs cAKSAR AVG .<br />
con corona rad.<br />
GERMANic<br />
.<br />
Testa<br />
<strong>di</strong> N. a d.<br />
I^ — poNTiF . MAX . TR . POT . iMP .P.P. L'impcrat. in pie<strong>di</strong> a<br />
d. laureato ed in abito muliebre, ac<strong>com</strong>pagnando il suo<br />
canto alia lira; ai lati s . e, nell'esergo i.<br />
Asse (oricalco). Fiorelli, Cat n. 4699-700.<br />
14. — NERO CAESAR AVGVSTvs. Testa <strong>di</strong> N. laur. a d.<br />
E^ — CONCORDIA AVGvsTA. La Concor<strong>di</strong>a sedente a s. con<br />
patera in una mano e neiraltra il corno d'abbondanza.<br />
15. — NERO CAESAR, Testa <strong>di</strong> N. laur. a d.<br />
jy . Fiorelli, Cai. n. 4391.<br />
f^ — AVGVSTVS GERMANicvs. L'impcrat. in pie<strong>di</strong> con la testa<br />
ra<strong>di</strong>ata, avendo nella d. un ramo d'alloro e nella s. la<br />
Vittoria alata. A^<br />
• Fiorelli, Caf. n. 4382-84.<br />
16. — NERO CAESAR AVGVSTVS. Tcsta <strong>di</strong> N. laur. a d.<br />
I^ — VESTA. Tempio esastilo, nel cui mezzo il simulacro <strong>di</strong><br />
Vesta sedente, poggiata all'asta e con patera in mano.<br />
. ^ Fiorelli, Cai. n. 4617-18.<br />
17. 818=65 — NERO CAESAR AVG . IMP . TR .<br />
a d., con lorica e paludamento.<br />
POT .XII P.P. BuStO <strong>di</strong> N. laur.<br />
I^ — PACE P . R . TERRA MARIQ . PARTA lANVM CLVSIT. Il tempio<br />
<strong>di</strong> Giano a d., con la porta adorna <strong>di</strong> festone; ai lati se.<br />
Sesi. Imhoof-Blumer.<br />
18. — NERO CLAVD . CAESAR AVG . GER . P . M . TR . P . IMP .P.P.<br />
Busto laur. <strong>di</strong> N. a d. con egida sul petto.<br />
I^ — ANNONA AVGvsTi CERES. L'Annona e Cerere (v. tav. II,<br />
n. 7). Sesi. Imhoof-Blumer.<br />
Tavola III.<br />
1. — NERO CLAVD . CAESAR AVG . GER . P . M . TR . P . IMP .P.P.<br />
Testa <strong>di</strong> N. laur. a d.<br />
RJ — PACE P . R . TERRA MARIQ . PARTA lANVM CLVSIT. Il tempio<br />
<strong>di</strong> Giano a d.; ai lati s.c.<br />
Asse (rame). Fiorelli, Cai. n. 4469-71.<br />
2. 819=66 — IMP . NERO CLAVD . CAESAR AVG . GERM . P . M . TR . P . XIII P.P.<br />
Testa <strong>di</strong> N. laur. a d.<br />
I^ — ROMA. Roma galeata sedente a s., che stringendo<br />
l'asta, preme col braccio sin. lo scudo poggiato su varie<br />
armi ; ai lati s.c. Sesi. Fiorelli, Cai. n. 4356.
Niim. Data<br />
LA CRONOLOGIA DELLE MONETE DI NERONE, ECC. 349<br />
3. — NERO cAESAR AVG .<br />
GERM<br />
. iMP . Tcsta <strong>di</strong> N. laur. a d.<br />
I^ — PACE, ecc. ecc. Tempio <strong>di</strong> Giano a d.; sotto s.c.<br />
Asse (rame). Fiorelli, Cat. n. 4492-93.<br />
.]. 819=66 — Legg. e tipo <strong>com</strong>e nel n. 2 <strong>di</strong> questa tavola.<br />
i^ — ROMA. Roma galeata sedente a s. su varie armi, che<br />
stringendo l'asta, tiene nella d. una piccola Vittoria alata<br />
che le porge un serto; ai lati s.c.<br />
Sesf. Fiorelli, Cat. n. 4358.<br />
5. 8i9=66 — IMP . NERO CLAVD . CAESAR AVG . GERM . P . M . TR . P . XIII .P .P .<br />
Testa <strong>di</strong> N. a d. con corona rad.<br />
i^ — ROMA. Roma (v. il n. 2 <strong>di</strong> questa tavola); ai lati s.c.<br />
Dup. Parigi (Coh. n. 286),<br />
6. — IMP . NERO CLAVD . CAESAR AVG .<br />
Testa <strong>di</strong> N. laur. a d.<br />
GER<br />
.P.M.TR.P.P.P.<br />
i^ — PACE, ecc. ecc. 11 Tempio <strong>di</strong> Giano a d., ai lati s.c.<br />
7. 819=66 — IMP . NERO CLAVD . CAESAR AVG .<br />
8. . —<br />
Testa <strong>di</strong> N. laur. a s.<br />
GERM<br />
Sesf. Fiorelli, Caf. n. 4474.<br />
. P . M . TR . P . XIII P.P.<br />
i^ — PACE, ecc. ecc. Il tempio <strong>di</strong> Giano a s.; ai lati s.c.<br />
NERO CLAVD . CAESAR AVG .<br />
Testa laur. <strong>di</strong> N. a s.<br />
GER<br />
SesL Parigi (Coh. n. 140).<br />
. P . M . TR . P . IMP .P.P.<br />
i^ — Arco <strong>di</strong> trionfo (v. tav. II, n. 6); ai lati s.c.<br />
9. — NERO CAESAR AVGvsTvs. Testa <strong>di</strong> N. laur. a d.<br />
Collez. Gnecchi.<br />
i^ — SALvs. La Salute sedente a s., con patera in mano.<br />
Arg. Fiorelli, Cai. n. 4583-84.<br />
10. — NERO CAESAR AVGVSTVS. Tcsta <strong>di</strong> N. laur. a d.<br />
i^ — Legg. e tipo e. nel n. preced.<br />
^''^- gì". 3»37- Santangelo.<br />
11. — NERO CAESAR AVG . GERM . IMP . Testa lauT. <strong>di</strong> N. a s.<br />
i^ — Vittoria volante a s. che porta tra mani un clipeo, sul<br />
quale s . p . q . r . ; ai lati s.c.<br />
Asse (rame). Fiorelli, Cai. n. 4673<br />
12. — NERO CLAVDIVS CAESAR AVG . GER . P . M . TR . P . IMP . P . P<br />
Testa <strong>di</strong> N. laur. a s.<br />
Bj) — ROMA. Roma sedente a s. sopra una lorica e più scud<br />
calcando una galea, che con la sin. stringe il parazonio<br />
e sostiene con la d. la Vittoria che le porge una corona:<br />
ai lati S.C. SesL Fiorelli, Cai. n. 4542-43<br />
13. — NERO CLAVD . CAESAR AVG .<br />
GER<br />
. P . M . TR . P . IMP . P . P<br />
Testa <strong>di</strong> N. a s. con corona rad. (a sei raggi).
350<br />
Num. Data<br />
ETTORE CABRICI<br />
i^ — PACE p , R . VBiQ .PARTA lANVM cLvsiT. Il tempio <strong>di</strong> Giano<br />
14. — NERO CLAVD .<br />
a d. Dup. Santangelo.<br />
CAESAR<br />
AVO .<br />
Testa <strong>di</strong> N. laur. a s.<br />
GER<br />
. P . M . TR . P . IMP .P.P.<br />
bJ — ROMA. Roma (v. il n. 12 <strong>di</strong> questa tav.) ai lati s . e .<br />
Sest. (Depositi del Mus. Naz.).<br />
15. — NERO CLAVDIVS CAESAR AVO . GER . P . M . TR . P . IMP .P.P.<br />
pj •— ROMA. Roma (v. il n. 4 <strong>di</strong> questa tavola) ai lati s . e .<br />
Sest. (Depositi del Mus. Naz.).<br />
Tralascio <strong>di</strong> descrivere le monete delle tavole IV e V, perchè sa-<br />
rebbe una inutile ripetizione, essendo state già descritte nel capitolo II.<br />
Ettore Cabrici.
NUOVO CONTRIBUTO<br />
ALLA.<br />
NUMISMATICA PADOVANA<br />
Le monete <strong>di</strong> Padova repubblica e <strong>di</strong> Padova<br />
sotto la signoria dei Principi da Carrara furono ma-<br />
gistralmente illustrate da Giambatista Verci (0. Nella<br />
sua opera " Dissertazione sulle monete <strong>di</strong> Padova „ ^^\<br />
ha saputo presentarci non solo i tipi abbastanza fedelmente<br />
riprodotti <strong>di</strong> dette monete; ma anche, <strong>com</strong>pletandone<br />
in modo perfetto V illustrazione, ci ha<br />
recati taluni documenti che a queste si riferiscono.<br />
Io, <strong>di</strong>nanzi ad un lavoro così bene condotto, non<br />
ostante sia trascorso più <strong>di</strong> un secolo dalla pubbli-<br />
cazione, abbandonata l'idea che avevo concepita <strong>di</strong><br />
rifare <strong>di</strong> sana pianta la storia delle monete della<br />
nostra città, m'arrogai soltanto il meno faticoso ma<br />
pur non inutile <strong>com</strong>pito <strong>di</strong> riempiere quelle poche<br />
lacune, che nel suddetto lavoro si trovavano, e <strong>di</strong><br />
rettificare qualche abbaglio preso dallo stesso Verci<br />
nel giu<strong>di</strong>care una moneta spettante ad un' epoca<br />
piuttosto che ad un'altra.<br />
Ho creduto inoltre opportuno <strong>di</strong> riferire, riunendole<br />
in un sol capitolo, su quelle monete che Venezia<br />
battè per la terraferma, <strong>com</strong>presa quin<strong>di</strong> la città <strong>di</strong><br />
(i) II Verci rifece ed ampliò l'opera " De re nummarta Patavinorum „<br />
del Brunacci.<br />
(2) La detta <strong>di</strong>ssertazione si trova inserita nel Voi. Ili della Raccolta<br />
delle Zeixhe d'Italia dello Zanetti, dal quale venne sapientemente annotata,
352 LUIGI RIZZOLI<br />
Padova, od esclusivamente per questa. A tal uopo<br />
mi valsi delle eru<strong>di</strong>te opere del Lazari, del Padovan<br />
e deirOn. Senatore Papadopoli, dalle quali trassi e<br />
riportai notizie e documenti.<br />
Pur essendo <strong>di</strong> una mole relativamente piccola,<br />
questo stu<strong>di</strong>o mi ha condotto, per ottenere il fine<br />
desiderato, ad affrontare non lievi <strong>di</strong>fficoltà, che<br />
solo coU'aiuto <strong>di</strong> persona piii che mai esperta in tale<br />
materia (3) ho potuto superare.<br />
Pago adunque <strong>di</strong> avere in breve fatto <strong>com</strong>prendere<br />
il mio intento, senza perdere tempo e spazio<br />
in una lunga ed inutile prefazione, entro subito in<br />
argomento.<br />
PARTE PRIMA.<br />
Anzitutto il Verci ci presenta una monetuccia,<br />
che egli crede sia uno <strong>di</strong> quei denari piccoli, dei<br />
quali tanti documenti padovani fanno menzione. Ammette<br />
che essa sia <strong>di</strong> Padova repubblica e ne avva-<br />
lora l'asserzione citando i giu<strong>di</strong>zi del Muratori, del<br />
Brunacci e <strong>di</strong> Monsig. Gradenigo.<br />
Si dovrebbe adunque riportare al tempo che va<br />
dal 1256, anno che segna la cacciata degli Eccelini<br />
da Padova, al 1318, in cui Gia<strong>com</strong>o da Carrara è<br />
scelto dal popolo a tenere il principato nella stessa<br />
città (4).<br />
Senonchè la grafia delle lettere (tav. n. i), che,<br />
(3) Intendo alludere al benemerito conservatore del Museo Bottacin<br />
sig. Luigi Rizzoli,<br />
(4) A. Gloria, Quadro Storico-Cronologico <strong>di</strong> Padova. Padova, 1856.
NUOVO CONTRIBUTO ALLA NUMISMATICA PADOVANA 353<br />
nella maggior parte degli esemplari da me veduti,<br />
sono <strong>di</strong> un bel carattere gotico , la forma delle<br />
rosette, che alternano le lettere della iscrizione cir-<br />
colare del dritto : PADV, la mancanza <strong>di</strong> scodellatura,<br />
che presentano invece le monete che vanno sotto i<br />
numeri 2, 3, 4 e 5 nella tavola XX, inserita nella<br />
cit. opera dello Zanetti ed inoltre la somighanza<br />
in fatto d'arte che detta moneta ha con il sestino<br />
nero o sesino <strong>di</strong> Francesco il Giovane da Carrara,<br />
<strong>di</strong> cui più innanzi vorrò parlare, tutto insomma mi<br />
fa credere che essa spetti ad un tempo <strong>di</strong> molto posteriore<br />
a quello ritenuto dal Verci e precisamente<br />
al suddetto Francesco.<br />
Sorregge ancora la mia opinione, il carattere <strong>di</strong><br />
vera somiglianza che, le rosette, le lettere e la stessa<br />
fattura nel suo <strong>com</strong>plesso <strong>di</strong>, questa moneta, presen-<br />
tano con i denari piccoli, che io assegno a Francesco li,<br />
e con la tessera dello stesso signore (5).<br />
Devonsi quin<strong>di</strong> ritenere prime monete <strong>di</strong> Padova<br />
quelle scodellate, che occupano successivamente il<br />
secondo, il terzo, il quarto ed il quinto posto nella<br />
detta tavola XX, e che rappresentano i veri denari<br />
piccoli, ricordati nei documenti padovani.<br />
*<br />
* *<br />
Sotto i numeri 6, 7, 8, 9 e io della stessa ta-<br />
vola XX inserita nell'op. cit., si trovano 5 esem-<br />
plari <strong>di</strong> monete, che, per avere nel dritto l'insegna<br />
dell'aquila imperiale sveva, furono dette grossi aquilini.<br />
Di queste monete ne furono battute in Merano,<br />
che ce ne dà invero il prototipo (6), in Verona, in<br />
(5) Zanetti, Op. cit,, Voi. Ili, pag. 435, n. 6.<br />
(6) Perio<strong>di</strong>co <strong>di</strong> Numismatica e Sfragistica <strong>di</strong>retto dal March. Strozzi.<br />
Voi. II, pag. 85.<br />
45
354<br />
LUIGI RIZZOLI<br />
Mantova, in Parma, in Vicenza, in Treviso ed in<br />
Padova.<br />
I suddetti Aquilini, nel rovescio, tutti, meno quello<br />
<strong>di</strong> Merano, alla sinistra della crocetta, dalla quale<br />
principia l'iscrizione, hanno uno scudetto, posto fra<br />
trifogli, stellette, rosette, punti, etc, che molto pro-<br />
babilmente possono essere i segni dello zecchiere.<br />
Quelli <strong>di</strong> Padova poi, a <strong>di</strong>fferenza degli altri, hanno<br />
nel dritto la scritta: PADVA: REGIA (?).<br />
Importante è lo stabilire a chi appartenga l'arme,<br />
che trovasi nello scudetto dei nostri Aquilini.<br />
Lo Zanetti (^) ed il Gennari ammisero che fosse<br />
dell'ufficiale, che sovraintendeva alla zecca. Ma questa<br />
asserzione non deve essere, a mio avviso, accettata.<br />
Infatti nell'esaminare gli aquilini consimili delle<br />
città circonvicine e nel riscontrare in essi l'arme dei<br />
vicari imperiali, quale ad esempio degli Scahgeri in<br />
Verona, dei Trissino in Vicenza (9), dei Conti <strong>di</strong> Gorizia<br />
in Treviso, dei Gonzaga in Mantova, dei da Cor-<br />
reggio in Parma (^°), sono stato indotto a credere che<br />
anche Tarme posta nello scudetto degli aquilini padovani<br />
appartenga ai vicari imperiah per Federico III<br />
e per Enrico <strong>di</strong> Boemia.<br />
Per <strong>di</strong> più la mia opinione trova vahdo appoggio<br />
nell'arme delTaquilino segnato coi numeri 6, 7, 8 e 9<br />
nella piii volte cit. tav. XX, appartenendo ad Ulrico<br />
<strong>di</strong> Valdsee, primo vicario in Padova per Federico III<br />
dal 5 gennaio 1320 al 5 settembre 1321, che aveva<br />
per l'appunto quale insegna gentilizia <strong>di</strong> sua famiglia<br />
una fascia d' argento in campo nero, e così pure<br />
nell'arme <strong>di</strong> un raro aquilino, <strong>di</strong> cui un esemplare fa<br />
(7) Ab. Giuseppe Gennari, Sopra il titolo <strong>di</strong> Regia dato a Padova.<br />
Padova, 1795.<br />
(8) Zanetti, Op. cit., Voi. Ili, pag. 383, nota 3Ó3.<br />
(9) Gaetano Girolamo Macca, Trattato della Zecca Vicentina,<br />
pag. 116-130.<br />
(io) Period. Num. e Sfrag. cit., Voi. II, anno 1869, pag. 63.
NUOVO CONTRIBUTO ALLA NUMISMATICA PADOVANA 355<br />
parte della raccolta Bottacin e due altri <strong>di</strong> quella <strong>di</strong><br />
famiglia, arme che pare ci presenti una fascia incre-<br />
spata, che corrisponderebbe perfettamente a quella<br />
increspata d'argento in campo rosso <strong>di</strong> Engelmaro<br />
<strong>di</strong> Villandres, vice-capitano in Padova <strong>di</strong> Corrado d'O-<br />
venstein dalla seconda metà del 1323 al 3 settem-<br />
bre 1328. Ma non è così per gli altri aquilini, <strong>di</strong> cui<br />
uno si trova riprodotto nella medesima tavola al n. io,<br />
due altri sono ricordati dal Verci (^^K<br />
Il primo <strong>di</strong> questi porta uno scudo con cinque<br />
giglietti, il secondo invece un'arme, che sarebbe stata<br />
i^^nota anche al Brunacci, il terzo infine avrebbe avuto<br />
due scudetti, dei quali uno il Brunacci stesso chiama<br />
d'Austria, l'altro dei Savorgnani. Tutti questi, <strong>di</strong>co,<br />
mi mettono ad<strong>di</strong>rittura in un gravissimo imbarazzo,<br />
non corrispondendo le armi degli altri vicari e capitani<br />
imperiali in Padova, quella ad es. <strong>di</strong> Corrado<br />
d'Ovenstein, capitano <strong>di</strong> Enrico dal 5 novembre 1321<br />
al 24 luglio 1324 e dal 14 ottobre 1325 al 3 settembre<br />
1328 e quella <strong>di</strong> Ulrico <strong>di</strong> Falimberg, capitano<br />
<strong>di</strong> Enrico dal 24 luglio 1324 al 14 ottobre 1325, a<br />
quelle testé menzionate.<br />
Pure non volendo in alcun modo rinunziare alla<br />
mia credenza, che è anche quella del conservatore<br />
del Museo Bottacin, deciso <strong>di</strong> risolvere la questione<br />
nel senso da me espresso, non dubito ad ammettere<br />
che le armi che si scorgono nei detti scudetti, eccetto<br />
quelle spettanti ad Ulrico <strong>di</strong> Valdsee e a Engelmaro<br />
<strong>di</strong> Villandres, siano state erroneamente in-<br />
terpretate, tanto più che quei pochi esemplari che si<br />
conoscono sono <strong>di</strong>sgraziatamente così sciupati dal<br />
tempo ed in ispecial modo in quella parte dove cade<br />
lo scudetto, da non potersi con precisione stabilire<br />
quale arme veramente sia in essi rappresentata.<br />
(n) Zanetti, Op. cit., Voi. Ili, pag. 387.
356 LUIGI RIZZOLI<br />
Ad Jacopino che tenne il governo <strong>di</strong> Padova<br />
assieme al nipote Francesco I dal 1350 al 1355,<br />
anno in cui venne da questo relegato nella rocca <strong>di</strong><br />
Monselice (^2)^ il Verci attribuisce il carrarino, che nel<br />
rovescio ha la figura <strong>di</strong> S. Prosdocimo seduto, ed<br />
all'intorno * S * PSDOCIMVS *; nel dritto una croce<br />
ornata, tagliante tutta l'area, negli angoli superiori<br />
della quale si leggono le lettere I A e negli inferiori<br />
si vedono due piccoli carri, all'intorno: * CIVIT* PAD.<br />
Naturalmente <strong>com</strong>e le lettere I A possono signi-<br />
ficare Jacopino, non meno verosimilmente in<strong>di</strong>cano<br />
Jacopo II, anzi a questo io l'attribuisco, accoghendo<br />
le molte e buone ragioni, addotte dallo Zanetti in<br />
sua nota alla <strong>di</strong>ssertazione del Verci, ragioni che qui<br />
intendo riassumere. Anzitutto perchè Jacopino da<br />
solo non battè mai monete, e lo provano non solo<br />
la mancanza <strong>di</strong> queste, ma anche il sigillo apposto<br />
in fine <strong>di</strong> un documento spettante ad Jacopino e<br />
Francesco I (^s)^ nel quale non si trovano i nomi dei<br />
detti principi, ma il solo carro; in secondo luogo<br />
perchè la paleografia delle lettere, la grandezza della<br />
moneta, il <strong>com</strong>plesso della fattura ed il peso sentono<br />
più dell'arte degli aquilini, che non <strong>di</strong> quella più<br />
moderna dei carrarini <strong>di</strong> Francesco 1.<br />
Ciò che s'è detto per il carrarino devesi pure<br />
ripetere per il denaro piccolo, che il Verci ritiene <strong>di</strong><br />
(12) Andrea Gloria, Monumenti della Università <strong>di</strong> Padova. Voi. II<br />
1318-1405), pag. 21.<br />
(13) Zanetti, Op. cit., Voi. Ili, pag. 391, nota 367.<br />
1
NUOVO CONTRIBUTO ALLA NUMISMATICA PADOVANA 357<br />
Jacopino e che noi, collo Zanetti, assegneremo ad<br />
Jacopo li. Tale denaro ha nel dritto una stella grande<br />
<strong>di</strong> 6 raggi con all'intorno + PADVÀ, nel rovescio I ed<br />
all'intorno + CIVITAS.<br />
*<br />
* *<br />
Il defunto Sig. Carlo Kunz in una nota ad una<br />
sua memoria, intitolata: Monete ine<strong>di</strong>te <strong>di</strong> Trieste e<br />
Trento (h), fa cenno <strong>di</strong> una moneta che egli chiama<br />
denaretto e <strong>di</strong>ce simile a quelli <strong>di</strong> Ubertino, <strong>di</strong> Jacopo II<br />
e <strong>di</strong> Francesco I (^s).<br />
Tale moneta ha nel rovescio, in luogo della con-<br />
sueta iniziale del nome del principe, un piccolo carro,<br />
arme dei Carraresi (tav. n. 2). Ritiene che ne sia<br />
stato autore lo stesso Ubertino, " che poi in un<br />
simile conio, fatto più ar<strong>di</strong>to, fece inserire la iniziale<br />
V del suo nome. „<br />
Senonchè in una seconda sua memoria pubbli-<br />
cata due anni più tar<strong>di</strong> C^^), ritrattando tacitamente<br />
ciò che avea detto nell'Archeografo, viene ad ammettere<br />
che questo denaretto possa essere un " primo<br />
tentativo <strong>di</strong> moneta carrarese, e perciò spettante<br />
verosimilmente a Marsilio, secondo signore <strong>di</strong> questa<br />
città. „<br />
Io invece, basandomi su quel sigillo, che più<br />
sopra ho ricordato, appartenente ad Jacopino e Fran-<br />
cesco I, nel quale anziché i nomi dei detti signori si<br />
vede il solo carro e su due tessere pure <strong>di</strong> Jacopino<br />
e Francesco I, delle quali una riprodotta nella <strong>di</strong>s-<br />
(14) Archeografo Triestino. Voi. V, fase. I, anno 1867.<br />
(15) Questa raro pezzo era posseduto dallo stesso Kunz, che lo<br />
vendette poi al Sig. Sipilli <strong>di</strong> Trieste. Ora ci riesce oltremmodo <strong>di</strong>fficile<br />
ritrovarne la traccia.<br />
(i6) Period. Num. e Sfrag. cit., Voi. II, anno 1869, pag. 73.
358 LUIGI RIZZOLI<br />
sertazione del Verci (^7), un'altra posseduta dalla mia<br />
famiglia e che hanno in ambo i lati il solo carro,<br />
con<strong>di</strong>videndo l'opinione del conservatore del M. Bot-<br />
tacin, l'assegnerei a questi due principi, che insieme<br />
tennero il dominio <strong>di</strong> Padova dal 1350 al 1355.<br />
Accanto a questa moneta deve a ragione essere<br />
collocato un denaro piccolo ine<strong>di</strong>to, che si trova nella<br />
raccolta <strong>di</strong> cose padovane della mia famiglia.<br />
Probabilmente esso altro non è, che una prova<br />
<strong>di</strong> zecca, male riuscita, della stessa moneta teste<br />
illustrata (tav. n. 3).<br />
L'arte infatti, perfettamente somigliante, <strong>di</strong>mostra<br />
ad evidenza la contemporaneità della battitura delle<br />
due monete in parola.<br />
Comunque sia, questo denaro che <strong>di</strong>rettamente<br />
mi riporta al sigillo e alle tessere, spettanti al condominio<br />
<strong>di</strong> Jacopino e <strong>di</strong> Francesco il Vecchio, non<br />
dubito attribuirlo ai due principi suddetti.<br />
Ai primi tempi della signoria <strong>di</strong> Francesco il<br />
Vecchio, il Kunz t^^) assegnava una moneta, ignota<br />
allo stesso Verci, avente da un lato: una testa<br />
coi capelli ricciuti, rivolta a sinistra ed all'intorno<br />
+ £C5|iV5liT?A^S3, dall'altro: nell'area la lettera H ed<br />
all'intorno + ®P®A®D®V®A® (tav. n. 4).<br />
Il dotto numismatico ritenne ciò per la somiglianza,<br />
che detta moneta presentava con quella che<br />
occupa il primo posto nella presente <strong>di</strong>ssertazione.<br />
(17) Zanetti, Op. cit., Voi. Ili, pag. 435, n. 8.<br />
(i8) Period. Num. e Sfragi?. cit., Voi. II, pag. 81.
NUOVO CONTRIBUTO ALLA NUMISMATICA PADOVANA 359<br />
Il documento però dell'anno 1398, riportato dal<br />
Verci (^9), ci riferisce sulla coniazione <strong>di</strong> 20000 libbre<br />
" sextinorum nigrorum ad ligam oncie unius et<br />
quartorum duorum argenti fini, et ad contum seu<br />
numerum librarum sex prò qualibet marca paduana. „<br />
Orbene, avendo la moneta in parola una testa, che<br />
è precisamente quella <strong>di</strong> un negro e non essendosi<br />
ancora trovate monete corrispondenti a quelle nomi-<br />
nate nel documento, io sarei d'opinione <strong>di</strong> conside-<br />
rarla uno dei detti sestini neri, i quali per l'appunto<br />
avrebbero assunto questo nome non dalla qualità del<br />
metallo usato per la loro coniazione (^o), ma invece<br />
dalla testa del negro che ne occupa l'area del dritto.<br />
Conforta inoltre la mia opinione la perfetta somi-<br />
glianza che essi hanno coi denari piccoli e con la<br />
tessera <strong>di</strong> Francesco II, per cui, allo stesso modo che<br />
la prima moneta da me descritta, mi sento inclinato<br />
ad attribuirla al secondo anziché al primo Francesco.<br />
*<br />
* *<br />
Assai <strong>di</strong>fficile riesce l'illustrazione <strong>di</strong> una mone-<br />
tina, che ritengo possa essere un mezzo bagattino.<br />
Lo Zanetti stesso si <strong>di</strong>chiara incapace <strong>di</strong> classificarla<br />
e si rivolge agli eru<strong>di</strong>ti padovani per ottenere una<br />
esauriente spiegazione (2^).<br />
Da allora nessuno mai ha creduto <strong>di</strong> esporre<br />
un giu<strong>di</strong>zio qualsiasi intorno a questa moneta, sia<br />
per la mancanza <strong>di</strong> documenti ad essa riferentisi, sia<br />
per l'impossibilità <strong>di</strong> confronti in fatto d'arte.<br />
Io pure mi trovo sfornito <strong>di</strong> prove atten<strong>di</strong>bili<br />
per stabilire a chi appartenga o cosa voglia in<strong>di</strong>care<br />
(19) Zanetti, Op. cit., Voi. Ili, pag. 418-422.<br />
(20) Ivi, pag. 422, nota 490.<br />
(21) Ivi, pag. 483.
360 LUIGI RIZZOLI<br />
quello scudo con tre onde che si vede nel suo dritto (22)<br />
(tav. n. 5).<br />
Ma se per questa parte non ho trovato modo<br />
<strong>di</strong> dare una giusta interpretazione alla moneta, non<br />
mi è sfuggito un dato così importante, da decidermi<br />
ad ammettere e con molta probabilità 1' epoca alla<br />
quale essa deve spettare.<br />
Nel rovescio ha una rosa con all'intorno + CIVITAS.<br />
Ebbene questa rosa trova perfetto riscontro in quella<br />
d'una preziosa medaglia ^d'argento (^3), <strong>com</strong>unemente<br />
attribuita a Francesco il Vecchio, <strong>di</strong> cui un bellissimo<br />
esemplare esiste nel Museo Bottacin, medaglia che<br />
nel mezzo del rovescio ha il Padre Eterno ed all'in-<br />
• torno + • REX REGVM J DN<br />
S • DOMINAMTIVM<br />
®, nel dritto<br />
poi una sfera armillare, che farebbe pensare a quella<br />
esistente sopra il campanile dell'ateneo patavino, al<br />
quale più volte i Principi da Carrara aveano accordati<br />
privilegi (24) ed all'intorno + FRANCISCI • • DE CARÀRIA • J-e<br />
(tav. n. 14).<br />
Naturalmente per questa rosa, che non so pre-<br />
cisare se sia un segno dello zecchiere od un semplice<br />
riempitivo <strong>di</strong> spazio, veniamo accertati che detti pezzi<br />
furono contemporaneamente battuti, allorquando cioè<br />
era signore <strong>di</strong> Padova il vecchio Francesco.<br />
A chi <strong>di</strong>ligentemente prenda in esame i denari<br />
piccoli fino ad ora attribuiti a Francesco I, non deve<br />
(22) Un'antica famiglia padovana <strong>di</strong> nome Basili aveva per arme<br />
tre onde; ma con ciò nulla possiamo spiegare.<br />
(23) Appel Joseph, Miinzen und MedaiUen der iveltlichen Fiirsten und<br />
Herren aus dem Miitelalter iind der neiiern Zeit. Voi. Ili, parte I, pag. 236,<br />
n. 863, tav. pag. 640, Wien, 1824.<br />
Period. Num. e Sfrag. cit., Voi. I, 1868. Memoria del Friedlaender.<br />
(24) Giovanni Cittadella, Storia della Dominazione Carrarese in<br />
Padova. Voi. II, pag. 535 e seg.
NUOVO CONTRIBUTO ALLA NUMISMATICA PADOVANA 361<br />
sfuggire un'assai manifesta <strong>di</strong>versità, <strong>di</strong>pendente non<br />
dalla sola grandezza, sic<strong>com</strong>e fu notato dal Bru-<br />
nacci (25), ma ben anco dal genere della lavorazione.<br />
Alcuni <strong>di</strong> questi denari infatti, che si mostrano<br />
battuti in più volte per i segni <strong>di</strong>versi dello zecchiere<br />
e sono molto sottili e scodellati, sono tali da ricon-<br />
durci per il loro <strong>com</strong>plesso artistico a quelli piìi antichi<br />
<strong>di</strong> Ubertino da Carrara, nei quali la valentìa e la<br />
finezza dell'artista sono invero en<strong>com</strong>iabili (tav. n. 6).<br />
Altri invece sono <strong>di</strong> uno spessore e peso mag-<br />
giore, piani e mentre manifestano, posti a confronto coi<br />
primi, un'arte più rozza, forse perchè battuti in fretta<br />
ed in tempi fortunosi per la signoria carrarese, per<br />
contro si rivelano più moderni in ispecie per le rosette<br />
che stanno accanto alla crocetta del rovescio (tav. n. 7).<br />
Questi ultimi adunque ho creduto, fin da principio,<br />
<strong>di</strong> assegnarh a Francesco Novello, del quale non si<br />
conoscevano i denari piccoli, ma soltanto i documenti<br />
che ad essi si riferivano; quelli al primo Francesco.<br />
«<br />
* *<br />
Fatte queste brevi note sulla <strong>numismatica</strong> pa-<br />
dovana, m'interessa mettere alla conoscenza degli<br />
stu<strong>di</strong>osi una moneta <strong>di</strong> Francesco II da Carrara,<br />
della quale, per quanto mi consta, non esiste che un<br />
<strong>di</strong>segno, trovato fra le carte <strong>di</strong> famiglia.<br />
Detto <strong>di</strong>segno, finemente eseguito dal defunto<br />
mio zio Pietro Rizzoli (^^), ci dà l'impronta <strong>di</strong> un<br />
Carrarino da due sol<strong>di</strong>, avente da un lato : la figura<br />
(25) Zanetti, Op. cit., Voi. III.<br />
(26) Mi è sommamente grato ricordare il detto mio zio, appassionatissimo<br />
cultore della scienza delle monete, che imprese a raccogliere<br />
ed illustrare. Quale studente della facoltà <strong>di</strong> Matematica in questa R.<br />
Università, nel 1848 si arruolò nel Corpo Franco Universitario e fece le<br />
campagne <strong>di</strong> Vicenza, Treviso, Brondolo e Venezia. Morì <strong>di</strong> anni 22 il 14<br />
<strong>di</strong>cembre 1851 per infezione malarica, presa durante l'asse<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Venezia.<br />
46
362 LUIGI RIZZOLI<br />
<strong>di</strong> S. Antonio in pie<strong>di</strong>, con un ramoscello <strong>di</strong> gigli in<br />
una mano e il vangelo nell'altra, ed ai lati del santo<br />
•V N-, all'intorno: "SANTVSo ANTONI o; dall'altro:<br />
il carro fra le lettere F • ed l • », ed all'intorno : FRANGI SCI •<br />
DÈ-CARARIA- (tav. n. 8).<br />
Che tale moneta abbia esistito realmente e sia<br />
quin<strong>di</strong> andata a far parte <strong>di</strong> una qualche collezione<br />
<strong>numismatica</strong>, anzitutto lo prova il n. 1174 preceduto<br />
dalle lettere P. R. M., che si trova nell'angolo inferiore<br />
destro del cartoncino, sul quale è tracciato il <strong>di</strong>segno.<br />
Sia il numero, che le lettere, attestano che quel<br />
<strong>di</strong>segno venne tratto indubbiamente da un catalogo <strong>di</strong><br />
monete, nel quale la nostra aveva per l'appunto il n. 1 1 74.<br />
Nell'impossibilità <strong>di</strong> accertare tale cosa, mi ri-<br />
volgo fin d'ora alla cortesia ed eru<strong>di</strong>zione dei nu-<br />
mismatici per avere schiarimenti, atti a togliere ogni<br />
dubbio sulla esistenza del detto carrarino.<br />
Altre considerazioni poi, oltre le suaccennate,<br />
mi inducono ad ammettere la coniazione <strong>di</strong> questa<br />
moneta, malgrado sia, <strong>com</strong>e già <strong>di</strong>ssi, irreperibile.<br />
Molte delle monete battute dai Principi da Car-<br />
rara sono andate totalmente perdute, molte invece<br />
sono ridotte ad un numero così esiguo, da occupare,<br />
ben a ragione, un posto assai onorevole in quelle<br />
fortunate collezioni, che <strong>di</strong> esse trovansi in possesso.<br />
Per esempio del ducato d'oro <strong>di</strong> Francesco il Vecchio,<br />
oggi tanto ricercato, credo che soltanto tre esemplari<br />
si conoscano, dei quali uno presso il gabinetto nu-<br />
mismatico <strong>di</strong> Vienna, un secondo in Padova presso<br />
il Museo Bottacin, un terzo presso la nobile famiglia<br />
padovana dei Papafava (27).<br />
(27) A proposito della rarità <strong>di</strong> questa moneta, il Kunz riferisce che<br />
era peregrina fino dal tempo in cai fu battuta o poco dopo. Aggiunge<br />
ancora che, nella interessante tariffa del secolo XV, pubblicata dal dot-<br />
tissimo F. Ganurrini, si legge: " Fiorini <strong>di</strong> Padova con l'arme del Signore<br />
da un lato e dall'altro un Santo, trovansene pochi. „
NUOVO CONTRIBUTO ALLA NUMISMATICA PADOVANA 363<br />
Del mezzo ducato d'oro dello stesso principe,<br />
non si conosce poi alcun esemplare né alcun documento,<br />
nonostante molti cronisti padovani, e fra questi<br />
10 storico Gattari, parlino <strong>di</strong> tale moneta, <strong>di</strong> cui è<br />
fatta chiara ed esatta descrizione.<br />
Per non citare altre monete delle quali si fa<br />
menzione nei documenti e che gli eru<strong>di</strong>ti non seppero<br />
o non poterono ancora identificare, <strong>di</strong> un sol<strong>di</strong>no <strong>di</strong><br />
Francesco il Vecchio, del quale il Verci ci dà anche<br />
il <strong>di</strong>segno (^8), ora non si conosce alcun esemplare.<br />
Niente <strong>di</strong> più facile adunque, che anche il Carrarino<br />
colla figura <strong>di</strong> S. Antonio, del quale non<br />
esistono né documenti, ne esemplari, sia pur esso<br />
andato perduto. L'epoca della coniazione dovrassi<br />
riportare all' ultimo anno (1405) della dominazione<br />
Carrarese in Padova. In questo tempo ardeva sanguinosa<br />
la guerra tra Francesco Novello e la sere-<br />
nissima Repubblica. Le risorse finanziarie del principe<br />
da Carrara, causa l'infausta guerra, erano presso che<br />
esauste. 1 soldati non pagati, <strong>di</strong>fettavano anche <strong>di</strong><br />
viveri. Novello da Carrara, in sì grave contingenza,<br />
pensò <strong>di</strong> ricorrere ad un mezzo non mai fino allora<br />
tentato, quello <strong>di</strong> spogliare la basilica <strong>di</strong> S. Antonio,<br />
ricca d'ornamenti d'oro e d'argento <strong>di</strong> gran valore,<br />
ornamenti dei quali era stata donata dai vari principi<br />
da Carrara, che si succedettero nel dominio <strong>di</strong> Padova.<br />
11 valore <strong>com</strong>plessivo <strong>di</strong> questa prima spogliazione<br />
si fa risalire a ducati d'oro 1720 (^9).<br />
Senonchè dolente <strong>di</strong> aver saccheggiato il famoso<br />
tempio, quasi contemporaneamente alla detta spoglia-<br />
zione volle il Novello ri<strong>com</strong>pensarlo dei danni sofferti,<br />
concedendogli la Castal<strong>di</strong>a d'Anguillara, affittata al-<br />
(28) Zanetti, Op. cit., Voi. Ili, Tav. XXI, n. 22.<br />
(29) Bernardo Gonzati, La Basilica <strong>di</strong> S. Antonio <strong>di</strong> Padova. Voi. I,<br />
pag. 46-48.
364 LUIGI RIZZOLI<br />
lora per annue lire iioo <strong>di</strong> denari piccoli e un animale<br />
suino <strong>di</strong> 200 libbre (3°), a patto però che coi proventi<br />
venissero rifatti i calici, i tabernacoli, i vasellami ed<br />
altre opere d'orificeria, che per necessità <strong>di</strong> guerra<br />
avea dovuto sottrarre.<br />
Col continuare della guerra che, quanto più a<br />
lungo si protraeva, altrettanto più <strong>di</strong>sastrosa tornava<br />
ai Carraresi, <strong>di</strong> nuovo facevasi sentire il bisogno <strong>di</strong><br />
denaro, i citta<strong>di</strong>ni affamati domandavano pane e i<br />
soldati non pagati si rifiutavano <strong>di</strong> <strong>com</strong>battere. Fran-<br />
cesco Novello non esitò <strong>di</strong> mettere una seconda volta<br />
la mano spogliatrice nella basilica <strong>di</strong> S. Antonio,<br />
impadronendosi <strong>di</strong> 50 marche e mezzo d' argento<br />
dorato. Ma 27 giorni innanzi che Padova cadesse<br />
sotto il dominio della Veneta Repubblica, Francesco II<br />
volle ri<strong>com</strong>pensarla dei nuovi danni patiti e con atto<br />
notarile del 30 ottobre 1405 pagò 404 ducati d'oro,<br />
corrispondenti all'argento, <strong>di</strong> cui erasi antecedentemente<br />
insignorito (30.<br />
Da ciò facilmente si <strong>com</strong>prende <strong>com</strong>e Francesco<br />
Novello, coll'argento o la prima o la seconda volta<br />
sottratto dal tempio <strong>di</strong> S. Antonio, per il quale tanta<br />
venerazione nutriva, abbia potuto or<strong>di</strong>nare la battitura<br />
del carrarino coll'effigie del Santo, se si pensa ancora<br />
che i principi da Carrara sulle loro monete aveano<br />
soltanto l'impronta degli altri santi protettori della<br />
città, cioè Prosdocimo, Daniele e Giustina, i quali<br />
spettano all'era romana e non mai quella <strong>di</strong> S. An-<br />
tonio, <strong>di</strong> ben poco anteriore ad essi.<br />
Riguardo poi alla s<strong>com</strong>parsa <strong>di</strong> tale moneta si<br />
trova atten<strong>di</strong>bile spiegazione, se si tiene conto dello<br />
scarso numero <strong>di</strong> monete <strong>di</strong> questo genere^ che deve<br />
essere stato battuto, stante la ristrettezza del tempo.<br />
(30) Ivi, Voi. I, Documento XXVIII.<br />
(31) Ivi, Voi. I, Documento XXX.
NUOVO CONTRIBUTO ALLA NUMISMATICA PADOVANA 365<br />
che va dalle spogliazioni alla fine della guerra con<br />
la Repubblica Veneta. Anzi prova la fretta, con cui<br />
devono essere state coniate, la mancanza delle sigle<br />
Zo P, iniziali dei nomi degli incisori o zecchieri del<br />
Novello, corrispondenti a Zuanne degli Adenti e a<br />
Pietro dall' Oglio.<br />
Naturalmente questi pochi esemplari coniati o si<br />
resero irreperibili o furono, al tempo della conquista,<br />
<strong>di</strong>strutti dalla stessa Repubblica Veneta, fors'anco<br />
per togliere qualunque ricordo della passata ed o<strong>di</strong>ata<br />
dominazione Carrarese.<br />
PARTE SECONDA.<br />
Prima <strong>di</strong> entrare nella trattazione delle monete<br />
venete per Padova, merita che dagli stu<strong>di</strong>osi della<br />
<strong>numismatica</strong> sia fatta speciale considerazione <strong>di</strong> un<br />
importante documento, tratto dal Capitolare delle<br />
brocche, il quale <strong>di</strong>mostra le relazioni monetarie<br />
esistenti fra Venezia e Padova fin dall'anno 1378 (32).<br />
In quest'anno e precisamente nel 18 gennaio, essendo<br />
questa la data del documento, teneva la signoria <strong>di</strong><br />
Padova Francesco il Vecchio da Carrara ed era doge<br />
<strong>di</strong> Venezia Andrea Contarini. Per nulla amichevoli<br />
risultano dal documento dette relazioni fra le due<br />
vicine città, or<strong>di</strong>nandosi esphcitamente dai Veneziani,<br />
che fossero ban<strong>di</strong>te dai loro stati talune monete dei<br />
Carraresi, perchè non corrispondenti per il loro va-<br />
lore intrinseco a quello nominale.<br />
(32) Documento I.
366 LUIGI RIZZOLI<br />
È ben naturale adunque che Venezia, dopo la<br />
conquista della nostra città, ne abolisse le monete,<br />
che vi erano in circolazione e vi introducesse le<br />
proprie. Ma sia durante il principato <strong>di</strong> Michele Steno<br />
(1400-1413), sia durante quello <strong>di</strong> Tomaso Mocenigo<br />
(1414-1423) non ci è dato trovare documenti attestanti<br />
la sostituzione delle monete Padovane con quelle<br />
Veneziane, ne riferentisi alla coniazione <strong>di</strong> tipi speciali<br />
<strong>di</strong> monete per la nuova provincia soggetta.<br />
Dinanzi ad una mancanza <strong>di</strong> documenti sì dannosa<br />
per il nostro stu<strong>di</strong>o, non possiamo fare a meno<br />
<strong>di</strong> ritenere che Venezia, forse troppo intenta nel<br />
rior<strong>di</strong>nare l'amministrazione della nostra città, nella<br />
quale, ed è bene il notarlo, scorgiamo fin d'ora<br />
rispecchiate molte <strong>di</strong> quelle magistrature, caratteri-<br />
stiche della città dominatrice, non abbia pensato a<br />
regolarne con speciaH ducali anche la circolazione<br />
monetaria.<br />
Sotto il doge Francesco Foscari (1423-1457) con<br />
un decreto del senato in data 24 maggio 1442 si dà<br />
or<strong>di</strong>ne ai massari dell'argento <strong>di</strong> mandare a Padova,<br />
Treviso ed in altri luoghi della terraferma, nonché<br />
nel Friuli delle monete dette bagattini, fatti colla<br />
stessa lega determinata precedentemente e si stabi-<br />
Hsce il minimo <strong>di</strong> tali piccole monete {parvuli), che<br />
deve essere dato in pagamento per ogni ducato dal<br />
rettore delle provincie (33). Questo documento è il<br />
primo che, assieme a quello d'altre terre, ci presenta<br />
il nome <strong>di</strong> Padova.<br />
Il Lazari, nella sua opera sulle monete veneziane,<br />
credette erroneamente che il bagattino testé ricordato,<br />
fosse quello che da un lato porta la croce a braccia<br />
eguali, accantonata dalle quattro lettere F F D V e<br />
dall'altra il leone accosciato, che tiene il vangelo tra<br />
{33) Documento II.
NUOVO CONTRIBUTO ALLA NUMISMATICA PADOVANA 367<br />
le zampe anteriori (34), mentre invece, sic<strong>com</strong>e giu-<br />
stamente <strong>di</strong>mostrò TOn. Sen. Nicolò Papadopoli, è<br />
quello che fu battuto per Brescia e per la Lombar<strong>di</strong>a (35).<br />
In Padova avrebbe avuto corso, per il decreto<br />
ricordato, il bagattino che, nella tav. XV inserita<br />
nella cit. op. del Papadopoli, va sotto il n. 7.<br />
torno : +<br />
Nel dritto ha una croce in un cerchio ed all'in-<br />
FRAC-FOOVX, nel rovescio pure una croce<br />
in un cerchio ed all'intorno: + ^ MARCV (tav. n. 9).<br />
Esiste <strong>di</strong> questa moneta anche una variante, che ha<br />
l'iscrizione così concepita: nel<br />
nel rovescio: + w MARCVSw.<br />
dritto: + FRA- FO • DVX,<br />
Senonchè la grande copia <strong>di</strong> bagattini, che erano<br />
stati emessi e le numerose falsificazioni che se ne<br />
erano fatte, aveano generato, in ispecie nella nostra<br />
città, una perniciosa confusione. Il senato veneto<br />
costretto per ciò a provvedere, con una terminazione<br />
del 21 giugno 1446 (s^) or<strong>di</strong>na la coniazione <strong>di</strong> piccoli<br />
o denari <strong>di</strong> nuovo tipo, in sostituzione dei precedenti<br />
ed obbliga i possessori delle monete, <strong>di</strong>chiarate fuori<br />
corso, a presentarle agli ufficiali della zecca.<br />
Sebbene non sia espresso nel documento, è facile<br />
intendere, <strong>com</strong>e <strong>di</strong>ce il Papadopoli (37), che si tratta<br />
della sostituzione <strong>di</strong> quei piccoli scodellati, che si<br />
coniavano per Venezia e che aveano corso nel dogato<br />
e nei territori vicini <strong>di</strong> Padova e Treviso.<br />
I nuovi piccoli hanno nel dritto: una croce pa-<br />
• FO • DVX -, nel<br />
tente in un cerchio; all'intorno • FRA<br />
rovescio: un leone nimbato, senza ali, rampante a<br />
sinistra; nel campo: S-'M (tav. n. io).<br />
(34) Vincenzo Lazari, Le monete dei Posse<strong>di</strong>menti Veneziani <strong>di</strong> Oltremare<br />
e <strong>di</strong> Terraferma. Venezia, 1851, pag. 136-137.<br />
(35) Nicolò Papadopoli, Le Monete <strong>di</strong> Venezia, (dalle Origini a Cristoforo<br />
Moro). Venezia, 1893, pag. 260.<br />
(36) Documento III.<br />
(37) Nicolò Papadopoli, Op. cit., pag. 263.
368 LUIGI RIZZOLI<br />
Nel 18 <strong>di</strong>cembre del 1453 si decreta dal Senato<br />
la coniazione <strong>di</strong> quattrini da 4 piccoli l'uno, per un<br />
valore corrispondente a 20000 ducati (38).<br />
Tali quattrini, che dovevano servire a tutte le<br />
terre del dogato e quin<strong>di</strong> anche a Padova, eccettuata<br />
però Venezia, furono battuti più che tutto per for-<br />
nire una moneta <strong>com</strong>une a tutte le provincie e nello<br />
stesso tempo capace <strong>di</strong> sud<strong>di</strong>viderne esattamente le<br />
varie lire.<br />
Il quattrino accennato è quello che nel dritto<br />
ha una croce patente, colle braccia <strong>di</strong>vise longitu<strong>di</strong>-<br />
nalmente in<br />
SCARI<br />
tre <strong>com</strong>parti ed all'intorno :<br />
• • + • DVX;<br />
•<br />
FRA FOnel<br />
rovescio, un leone nimbato, rampante<br />
a sinistra, avente nella zampa destra anteriore la<br />
spada e all'intorno :<br />
• • + S • MARCVS VENETI • (tav. n. 11).<br />
Di questa moneta il Papadopoli riporta anche<br />
una variante, la quale ha nel dritto : la croce colle<br />
estremità ornate <strong>di</strong> ricci (39).<br />
Molto probabilmente questa variante può appartenere<br />
ad una coniazione posteriore <strong>di</strong> qualche tempo<br />
alla prima, determinata forse dalla pratica utilità, che<br />
l'uso <strong>di</strong> detti quattrini doveva arrecare alle varie provincie.<br />
Infatti per un documento, in data 16 marzo<br />
1456, riportato dal Papadopoli, e pertinente al Maggior<br />
Consiglio, si viene a sapere che alla zecca erano<br />
stati battuti quattrini et parvuli <strong>di</strong> <strong>di</strong>verso tipo in tempi<br />
<strong>di</strong>versi (4°). Così viene <strong>com</strong>provato quanto <strong>di</strong>ssi or<br />
ora, a proposito della variante.<br />
Del tempo del dogato <strong>di</strong> Francesco Foscari non<br />
mi consta abbiano ad esistere altri documenti che,<br />
pure per incidenza, parlino delle monete <strong>di</strong> Padova.<br />
Neppure del doge Pasquale Malipiero (1457-1462) ci<br />
(38) Documento IV.<br />
(39) Nicolò Papadopoli, Op. cit., pag. 272, n. 13 e tav. XV, n. io.<br />
(40) Ivi, Doc. XXXI, pag. 371.
NUOVO CONTRIBUTO ALLA NUMISMATICA PADOVANA 369<br />
ò dato rinvenire, se pur ve ne furono emanati, spe-<br />
ciali decreti riguardanti il sistema monetario della<br />
nostra città.<br />
Sotto il doge Cristoforo Moro (1462-1471), per<br />
decreto 3 settembre 1463, venne or<strong>di</strong>nata dal senato<br />
la battitura <strong>di</strong> piccoli copoluti per la somma <strong>di</strong> 3000<br />
marchi <strong>di</strong> quattrini <strong>di</strong> conio veneziano (4O.<br />
Queste monete chiamate copolute perchè alquanto<br />
scodellate (42)^ dovevano sostituire i precedenti bagat*<br />
tini, che si spendevano in Venezia, in Padova, ir<br />
Treviso ed in altri luoghi affine <strong>di</strong> abolire le nume><br />
rose falsificazioni, che <strong>di</strong> questi ultimi eransi fatte.<br />
I nuovi piccoli sciffati, che contrad<strong>di</strong>stinguono in<br />
modo assai evidente le monete piccole <strong>di</strong> Cristoforo<br />
Moro da quelle degli altri dogi, erano <strong>di</strong> rame mescolato<br />
con poco argento. Nel dritto aveano una<br />
croce patente, accantonata da quattro bisanti, alle<br />
estremità delle braccia altri quattro bisanti e fra le<br />
braccia della stessa croce: le lettere CMDV; nel ro-<br />
vescio: un leone accosciato, nimbato, col vangelo fra<br />
le zampe • • anteriori ed all'intorno + S<br />
M<br />
• VENETI •<br />
(tav. n. 12).<br />
Anche <strong>di</strong> questa moneta si fecero in breve numerose<br />
falsificazioni.<br />
Per due volte allora si tentò <strong>di</strong> ottenerne l'abo-<br />
lizione e la sostituzione con monete <strong>di</strong> puro rame,<br />
allo scopo <strong>di</strong> rendere infruttuose le contraff'azioni,<br />
ma per due volte le proposte vennero respinte.<br />
Qualche raro esemplare <strong>di</strong> piccoli gran<strong>di</strong> ^^"i), <strong>di</strong><br />
puro rame, che ancor oggi ci è dato conservare, te-<br />
stifica che assieme alle proposte, erano stati presentati<br />
alla votazione del senato, anche i tipi delle nuove<br />
(41) Documento V.<br />
(42) N. Papadopoli, Op. cit., pag. 285.<br />
(43) Erano chiamati piccoli gran<strong>di</strong> per <strong>di</strong>stinguerli dai piccoli fino<br />
allora in uso, che erano <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ametro minore.<br />
47
370 LUIGI RIZZOLI<br />
monete, che dovevano prendere il posto delle pre-<br />
cedenti (44).<br />
La storia delle monete veneziane per Padova,<br />
dal doge Cristoforo Moro ad Agostino Barbarigo,<br />
presenta una nuova deplorevole lacuna, alla quale<br />
non mi è possibile riparare.<br />
Essendo doge Agostino Barbarigo (1486-1501),<br />
venne presa dal consiglio dei <strong>di</strong>eci una determina-<br />
zione, nel 20 <strong>di</strong>cembre i486, colla quale, constatata<br />
la scarsezza <strong>di</strong> oboli sia in Venezia, che in Padova,<br />
se ne or<strong>di</strong>nava una nuova coniazione per la somma<br />
<strong>di</strong> 400 ducati, dei quaH una metà dovea sopperire<br />
ai bisogni <strong>di</strong> Venezia ed una metà a quelli <strong>di</strong> Padova<br />
(45). Dovevano però le dette città rimandare al-<br />
l'ufficio della zecca un numero <strong>di</strong> monete d'argento,<br />
corrispondente al valore delle monete piccole ricevute.<br />
Nel citato documento non si fa parola del tipo<br />
della moneta <strong>di</strong> cui volevasi la riconiazione. Esami-<br />
nate, nell'opera del Padovan (46)^ le monete battute<br />
da Agostino Barbarigo, ho trovato un bagattino colla<br />
testa <strong>di</strong> S. Marco ed una croce, ed un mezzo bagattino<br />
colle iniziali A-B-D-V, simile a quello del Moro.<br />
Con molta probabilità il documento può alludere<br />
ad uno <strong>di</strong> questi due tipi, dovendosi notare fin d'ora,<br />
sic<strong>com</strong>e anche sostiene il Papadopoli, che la moneta<br />
chiamata dal Padovan mezzo bagattino, altro non è<br />
che un vero e proprio bagattino, e che la <strong>di</strong>fferenza<br />
<strong>di</strong> grandezza <strong>di</strong>pende esclusivamente dalla <strong>di</strong>versa<br />
lega, con cui quelle monete furono battute.<br />
Nella impossibilità <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>care in questo caso<br />
categoricamente, mi rivolgo al sereno giu<strong>di</strong>zio degli<br />
stu<strong>di</strong>osi, onde ottenere una soluzione confacente e<br />
sopra tutto conforme alla verità.<br />
(44) Nicolò Papadopoli, Op. cit., pag. 284-286.<br />
(45) Documento VI.<br />
(46) Vincenzo Padovan, Le Monete dei Veneziani, Venezia, 1881.
NUOVO CONTRIBUTO ALLA NUMISMATICA PADOVANA 37I<br />
Nel 31 agosto 1491 il consiglio dei <strong>di</strong>eci emanò<br />
un nuovo decreto, col quale si stabiliva la coniazione<br />
<strong>di</strong> bagattini <strong>di</strong> puro rame per Padova ed il suo <strong>di</strong>-<br />
stretto, aventi da un lato l'imagine <strong>di</strong> S. Marco in<br />
forma <strong>di</strong> leone e dall'altro una croce (47).<br />
Vincenzo Lazari fu il primo ad identificare ed<br />
illustrare tali monete, phe a vero <strong>di</strong>re sono pur ora<br />
assai <strong>com</strong>uni. Nella interpretazione però delle sigle,<br />
che stanno fra le zampe del leone nel rovescio della<br />
moneta, incorse in errore, ammettendo che fossero<br />
le iniziali dei nomi dei podestà <strong>di</strong> Padova, mentre<br />
invece sono le iniziali dei massari o zecchieri soprain-<br />
tendenti alla coniazione (48).<br />
Infatti le iniziali ricordate dal Lazari: C. K, Z. -F.<br />
M, A. F, M. B, corrispondono perfettamente a quelle<br />
<strong>di</strong> Cristoforo Canal, Zan Francesco Miani, Alvise<br />
Foscarini e Marcantonio Bollani, massari all'argento<br />
sotto il doge Agostino Barbarigo.<br />
Le sigle Z. R, M. L, ricordate pure dal Lazari,<br />
alle quali non so trovare nomi <strong>di</strong> massari corrispon-<br />
denti, devono essere state erroneamente lette, tanto<br />
pili che nel Museo Correr, citato dal Lazari nelle sue<br />
memorie, e nel Museo Bottacin esse non si trovano.<br />
A meglio illustrare questo bagattino ne do la<br />
descrizione: nel dritto: croce patente^ accantonata da<br />
quattro bisanti; alle estremità della braccia altri quattro<br />
bisanti, il tutto in un cerchio ; all' intorno : X<br />
BARBADICO<br />
AVG •<br />
• DVX; nel rovescio : leone nimbato, alato,<br />
stante a destra, tiene colle zampe anteriori il vessillo;<br />
tra le zampe vi sono varie sigle ; all'intorno :<br />
• SANCTVS<br />
MARCVS • VENETI • (tav. n. 13).<br />
Bagattini <strong>di</strong> tipo eguale a questo ora descritto,<br />
ne furono battuti ancora altre volte, secondo risulta<br />
(47) Documento VII.<br />
(48) V. Lazari, Op. cit., pag. 137-138.
372<br />
LUIGI RIZZOLI<br />
da decreti del consìglio dei <strong>di</strong>eci del 27 novembre<br />
1494 e 19 <strong>di</strong>cembre 1498.<br />
Sotto il nome <strong>di</strong> bagattino o quattrino od obolo<br />
per Padova, Vincenzo Padovan, nella sua opera ci-<br />
tata (49), descrive una moneta, che per il suo tipo è<br />
assai somigliante al bagattino col S. Liberale, coniato<br />
per Treviso in forza della determinazione del con-<br />
siglio dei <strong>di</strong>eci in data 24 ottobre 1492, quando cioè<br />
era doge Agostino Barbarigo.<br />
Le notizie, che il Padovan riporta intorno al<br />
detto bagattino, non sono per nulla tratte da documenti.<br />
Egli venne informato dal Sig. G. M. Urbani<br />
de Gheltof, che asseriva <strong>di</strong> aver veduto il bagattino,<br />
da un <strong>di</strong>stinto raccoglitore <strong>di</strong> monete Italiane, il<br />
Sig. Walter Gow <strong>di</strong> Dublino (5
NUOVO CONTRIBUTO ALLA NUMISMATICA PADOVANA 373<br />
Per deliberazione presa dal Consiglio dei <strong>di</strong>eci<br />
nel 31 marzo 1503, sotto il doge Leonardo Loredan<br />
(1501-1521), si or<strong>di</strong>na la coniazione <strong>di</strong> oboli ad solitam<br />
stampam per la somma <strong>di</strong> 100 ducati, nell'intento <strong>di</strong><br />
favorire la città <strong>di</strong> Padova (50. H Lazari opina che<br />
tali oboli siano dello stesso tipo <strong>di</strong> quelli coniati da<br />
Agostino Barbarigo, colla croce da un lato e col<br />
leone dall'altro (52)^ ed io, nulla trovando a <strong>di</strong>re in<br />
proposito, m'associo pienamente a lui.<br />
Adunque soltanto per l'iscrizione circolare del<br />
dritto il bagattino <strong>di</strong> Leonardo Loredan varia da<br />
Fra<br />
quello già descritto <strong>di</strong> Agostino Barbarigo, avendo :<br />
LEO • • LAVREDAN • DVX<br />
le zampe anteriori e poste-<br />
riori del leone vi sono le sigle A. M, che corrispondono<br />
alle iniziali <strong>di</strong> Alvise Miani, massaro all'argento<br />
nel 1503 e non a quelle <strong>di</strong> Alvise Molin, podestà <strong>di</strong><br />
Padova, sic<strong>com</strong>e ritenne erroneamente il Lazari. Con<br />
questa moneta, che sarebbe stata l' ultima battuta<br />
espressamente per Padova, do termine a questa breve<br />
trattazione sulle monete venete per la nostra città.<br />
Dal doge Leonardo Loredan in poi, si deve<br />
credere che le monete speciali per le varie città siano<br />
state definitivamente abolite e sostituite dalle vere e<br />
proprie monete Veneziane, sia per porre fine alla<br />
confusione causata dall'uso nelle varie provincie delle<br />
<strong>di</strong>verse lire, sia per porre un freno maggiore alle<br />
numerose falsificazioni, che delle monete eransi fatte.<br />
Dal documento infatti, in data 12 ottobre 1519(53),<br />
riportante un decreto del consiglio dei <strong>di</strong>eci, si ar-<br />
guisce che venne determinata la soppressione dei ba-<br />
gattini <strong>di</strong> vario tipo, che circolavano nelle varie città<br />
<strong>di</strong> terraferma, <strong>com</strong>e Padova e Treviso, e in quelle<br />
(51) Documento Vili.<br />
(52) V. Lazari, Op. cit., pag. 137.<br />
(53) Documento IX.
374 LUIGI RIZZOLI<br />
del Levante, <strong>com</strong>e Zara, Spalato, Sebenico, Lesina,<br />
Antivari e Traù e la sostituizione <strong>di</strong> essi con un ba-<br />
gattino <strong>di</strong> tipo unico, avente da un lato : il leone <strong>di</strong><br />
S. Marco entro un quadrangolo, al <strong>di</strong> fuori del quale,<br />
nel mezzo dei lati, quattro rosette o stelline; dal-<br />
l'altro : il busto della Vergine col bambino ed all'in-<br />
• torno R • C • — • L • A • (Regina-coeli-laetare-alleluia) e<br />
sotto il busto: il segno o le sigle del massaro.<br />
In gran<strong>di</strong>ssima quantità si trovano anche ora<br />
tali monetine, che, messe in corso per tutte le terre<br />
soggette a Venezia, continuarono molto probabilmente<br />
ad essere battute per tutto il secolo XVII.<br />
Padova, Giugno iS^y.<br />
Luigi Rizzoli Junior.
NUOVO CONTRIBUTO ALI,A NUMISMATICA PADOVANA 375<br />
DOCUMENTO I.<br />
MCCCLXXVIII, DIE XVIII JaNUARII, IN RoGATIS,<br />
Cum in Padua fiat de novo quaedam moneta nova ad<br />
formam sol<strong>di</strong>norum nostrorum, quae moneta nova habet ab<br />
uno latere charium, et ab alia parte crucem, quae moneta<br />
nova est cum magna utilitate nostrorum inimicorum et damno<br />
terrae nostrae;<br />
Va<strong>di</strong>t pars, quod prae<strong>di</strong>cta moneta nova in totum sit<br />
bannita de Venetiis, et de omnibus terris, locis, et civitatibus<br />
Communis Venetiarum, et insuper prò bono et <strong>com</strong>modo<br />
nostrorum civium et fidelium qui ad praesens reperirent<br />
apud se de <strong>di</strong>ctis monetis, ut ex hoc non recipiant notabile<br />
damnum, or<strong>di</strong>netur, quod assignetur eis terminus per totum<br />
mensem praesentem; videlicet cuilibet qui haberet de eis,<br />
quod possit <strong>di</strong>ctas monetas usque. ad <strong>di</strong>ctum terminum portare<br />
ad officium monetae, ubi habebunt de qualibet marcha<br />
prae<strong>di</strong>ctarum solidos quatuordecim, existentibus ipsis mo-<br />
netis bonis de argento; et si essent de falsis, illas debeant<br />
incidere officiales nostri, et restituere illis quorum essent,<br />
sine aliqua poena. Elapso vero <strong>di</strong>cto termino, omnes quibus<br />
<strong>di</strong>ctae monetae novae factae in Padua, vel carrarini novi vel<br />
veteres reperti fuerint, tam falsi quam boni, debeant perdere<br />
prae<strong>di</strong>ctas omnes, et tantumdem prò poena: de qua poena<br />
non possit fieri gratia, donum. remissio, revocatio vel aliqua<br />
declaratio, aliquo modo vel ingenio, sub poena librarum mille<br />
prò quolibet ponente vel consentiente partem in contrarium.<br />
Et prae<strong>di</strong>cta stridentur publice in locis solitis, et <strong>com</strong>mittantur<br />
omnibus officialibus nostris quibus <strong>com</strong>missa sunt negotia<br />
argenti et monetarum, habentibus ipsis officialibus partem<br />
suam solitam de poenis, ut habent de aliis sui officii.
376 LUIGI RIZZOLI<br />
DOCUMENTO II.<br />
MCCCCXLII, DIE XXIIII MAH.<br />
Cum pri<strong>di</strong>e captum fuerit in isto Consilio, quod in cecha<br />
nostra argenti fiant de bagatinis prò Pergamo, Brixia, Verona<br />
et Vincentia, et nihil expressum sit de Padua, Tarvisio, et<br />
aliis terris nostris,<br />
Va<strong>di</strong>t pars, quod massarii nostri monete argenti mittere<br />
debeant Paduam, Tervisium, et ad alias terras nostras a<br />
parte terre et in Patriam Foriiulii, de bagatinis qui expen-<br />
duntur in <strong>di</strong>ctis locis, factis ad ligam, sicut captum est in<br />
isto Consilio. Et rectores nostri dari facere debeant soldos<br />
quinque prò ducato de camera de parvulis pre<strong>di</strong>ctis in<br />
omnibus solutionibus et subventionibus quas facient et fieri<br />
facient, sicut pri<strong>di</strong>e captum fuit de aliis terris nostris. Rectores<br />
vero Padue dari facere debeant in solutionibus que fient per<br />
cameram illam de parvulis pre<strong>di</strong>ctis illam partem que solita<br />
est dari, dummodo sit maior soldorum quinque prò ducato.<br />
Et non possint rectores sive camerarii omnium terrarum et<br />
locorum nostrorum dare in solutionibus pre<strong>di</strong>ctis alios baga-<br />
tinos sive parvulos, quam illos quos habebunt a massariis<br />
nostris monete argenti, sub pena contenta in parte furantium ;<br />
teneanturque rectores pre<strong>di</strong>cti, sub pena ducatorum quingen-<br />
torum, remittere de tempore in tempus in auro vel argento<br />
valorem <strong>di</strong>ctorum parvulorum quos recipient nostris massariis<br />
argenti. Et teneantur <strong>di</strong>cti massarii tenere <strong>com</strong>putum<br />
or<strong>di</strong>natum in uno quaterno separate de expensis et utilitatibus<br />
<strong>di</strong>ctorum bagatinorum. Et sub pena ducatorum ducentorum<br />
in bonis suis propriis teneantur <strong>di</strong>cti Massarii argenti portare<br />
nostris Gubernatoribus introituum pecunias que extrahentur<br />
de utilitate <strong>di</strong>ctorum bagatinorum prò solutione Illustris Co-<br />
mitis Francisci.<br />
Senato, Terra, reg. i, carte 67 tergo.
NUOVO CONTRIBUTO ALLA NUMISMATICA PADOVANA 377<br />
DOCUMENTO III.<br />
MCCCCXLVI, DIE XXI JUNII.<br />
Cum per hoc consilium sub <strong>di</strong>e VII mensis mail nuper<br />
elapsi facta fuerit certa provisio super facto parvulorum<br />
falsorum presentandorum et cetera, prout in ea latius conti-<br />
netur, que utilis fuit acque bona. Sed cum in civitatibus et<br />
terris nostris a parte terre propter magnam moltitu<strong>di</strong>nem<br />
parvulorum, et maxime in civitate nostra Padue, sit exorta<br />
maxima confusio in facto ipsorum parvulorum, adeo quod<br />
nedum utile, sed necessarium sit super ipsis parvulis facere<br />
talem provisionem quod unusquisque se valeat intelligere ;<br />
Va<strong>di</strong>t pars, quod in nomine Dei de novo fiat et fieri<br />
debeat una nova stampa et forma ipsorum parvulorum, sicut<br />
collegio melius videbitur, Sed quod ipsi parvuli de nov'<br />
stampan<strong>di</strong> sint illius lige etbonitatis cuius sunt parvuli stampe<br />
presentis et quod de cetero parvuli huius presentis stampe<br />
non fiant neque stampentur. Sed ut provideatur inconve-<br />
nientiis presentibus, ex nunc sit captum, quod omnes et<br />
singuli qui habent parvulos in hac civitate nostra, teneantur<br />
et debeant illos presentare officialibus nostre monete....<br />
Senato, Terra, reg. i, carte 195.<br />
DOCUMENTO IV.<br />
MCCCCLIII, DIE XVIII DECEMBRIS.<br />
Item quod ad offìcium Ceche nostre cuniari debeant, in<br />
quatrinis a parvulis quatuor prò quatrino, ducati XX millia,<br />
incipiendo <strong>di</strong>e primo januarii proximi; qui quatrini <strong>di</strong>spen-<br />
sentur in oninibus terris nostris, excepta hac civitate. Et ad<br />
hoc deputentur apotece quatuor. Verum post factam <strong>di</strong>ctam<br />
summam, non possint amplius fieri quatrini sine licentia et<br />
or<strong>di</strong>ne huius consilii.<br />
Senato, Terra, reg. 3, carte 92.<br />
48
378 LUIGI RIZZOLI<br />
DOCUMENTO V<br />
MCCCCLXm, DIE III, SEPTEMBRIS.<br />
Per la parte prexa i <strong>di</strong> preteriti in questo conseio, tra<br />
le altre cosse fo provisto che tutti, si qui chome altrove dove<br />
se spende bagatini, fosseno tegnu<strong>di</strong> portar tutti quelli i qual<br />
havesseno ala zecha et ai luogi da esser deputa<strong>di</strong>, azò che<br />
i boni bagatini fosseno cerni<strong>di</strong> dai falsi; et necessario sia<br />
che essa parte sia reformada; per tanto, l'andera parte.<br />
Che perchè ala cecha nostra se truova bona summa de<br />
quatrini cunia<strong>di</strong> del cunio nostro, ne i qual sono karati<br />
d'argento per marcha, <strong>com</strong>ò è la liga <strong>di</strong> nostri pizoli, da<br />
mo sia presco che per i nostri massari de la cecha sia tolto<br />
marche tre <strong>di</strong> quatrini sopra<strong>di</strong>cti, e quelli sia fondu<strong>di</strong> in tavole<br />
e de quelle sia fatto pizoli copoiu<strong>di</strong>; i qual pizoli, stampi<strong>di</strong><br />
che i serano, siano messi in casson e de quelli per algun<br />
modo non se possa cambiar, per far ne oro, né arzento, ma<br />
solo se debia dar a tuti quelli che porterà pizoli boni cunia<strong>di</strong><br />
del nostro cunio, e sia da<strong>di</strong> daner per daner. Né altramente<br />
possa insir de la cecha nostra. Et per più execution de questa<br />
nostra intention, da mo sia prexo che i nostri massari de la<br />
cecha non possa cambiar né far cambiar pizoli a oro né ad<br />
argento, soto pena de ducati V et privation del officio; e<br />
per il simel i soprastanti fondadori o fanti de quel officio,<br />
che savesse chel fosse sta cambiado pizoli a oro over argento<br />
per i nostri massari, e quelli non accusasse al officio <strong>di</strong> nostri<br />
avogadori de chomum, subito sia cassi del suo officio né<br />
mai più possa esser in officio algun de quella cecha.<br />
De le manifature del far <strong>di</strong> <strong>di</strong>cti pizoli, sia pagado <strong>di</strong><br />
pizoli, i qual pizoli che per i maistri de quella cecha i bavera<br />
habudo per sua manifatura, quelli fuor de la cecha possi<br />
cambiar per oro e per argento chon le con<strong>di</strong>cion infrascripte.<br />
E perchè el non se chunia più de marche III. quelli sia<br />
fondu<strong>di</strong> in tavole, e quelle sia consignade per pexo, chome<br />
se fa a i nostri massari de la cecha del argento, e quelle<br />
sia dade fuora a lavorar ala maistranza e lavorade. E perchè
NUOVO CONTRIBUTO ALLA NUMISMATICA PADOVANA 379<br />
nel lavorar <strong>di</strong> <strong>di</strong>ati pizoli ne va assai in cesare, quelle se possa<br />
refonder tante volte, quanto se salda el conto de le <strong>di</strong>ete<br />
marche III.'" <strong>di</strong> pizoli fatti, né piii per algun modo se possa<br />
fonder senza licentia de questo conscio, soto pena a quelli<br />
fondadori de ducati cento per un, et d'esser priva<strong>di</strong> del officio.<br />
Tutti siano tegnu<strong>di</strong> da questo dì in avanti, fino per tutto<br />
dì XV del presente, portar i pizoli de zascaduna sorta i<br />
haverano alla cecha qui in Veniexia. A Pa<strong>di</strong>ia veramente e<br />
a Treviso, ai luogi che sarano ordena<strong>di</strong>; a i qual tuti per i<br />
boni pizoli che sarano cerni<strong>di</strong> dai falsi, serano da<strong>di</strong> tanti<br />
pizoli copolu<strong>di</strong> quanti boni pizoli del nostro cunio passado i<br />
haverano presentado, i qual siano desfati, et de quei poi siano<br />
facti pizoli copolu<strong>di</strong> in quella somma che parerà a questo<br />
conscio. E i pizoli falsi similiter siano desfati, et la massa<br />
loro sia restituida a quelli de chi la sera.<br />
E passado el termine suprascripto, sì qui, chome in Padoa<br />
et ne i altri luogi nostri pre<strong>di</strong>cti, non se possi spender per<br />
algun muodo se non pizoli copolu<strong>di</strong> et del nostro cunio, soto<br />
pena de perder quelli; et oltra questo, per zascadun pizolo<br />
pizoli 6 per pena, segondo le lege nostre. E i prefati pizoli<br />
copolu<strong>di</strong> che de cetero se spenderano, non se possino spender<br />
se non a menudo, zoè da sol<strong>di</strong> 5 et da h in zoso, sotto pena<br />
de perder quelli et el dopiò più per pena. Né in manifature<br />
over altre merce<strong>di</strong> da esser paga<strong>di</strong> per zascadun modo, over<br />
ad imprestedo o altramente, <strong>di</strong>cti pizoli copolu<strong>di</strong> dar a spender<br />
se possino, so la pre<strong>di</strong>cta pena. E sia in libertà <strong>di</strong> chi torà<br />
questi pizoli retegnirli per soi, habiando anchora la pena<br />
ut supra.<br />
I banchieri sì de questa cita, chome de Padoa e d'altri<br />
luoghi nostri dove se spendeno pizoli, non possino tegnir ne<br />
i suoi banchi over altrove questi pizoli, sì in scanuzi <strong>com</strong>e<br />
altramente, né <strong>com</strong>prar né vender quelli, né dar ad impre-<br />
stedo, over de quelli far marchadantia per algun muodo, soto<br />
la pena et stricture dechiaride de sopra. E questa parte, qui<br />
et ne le altre terre et luogi pre<strong>di</strong>cti, debia esser publicada<br />
azò che la sia nota a tutti.<br />
De parte 84; — de non 6; — non sinceri ii.<br />
Senato, Terra, reg. 5, carte 70.
380 LUIGI RIZZOLI<br />
DOCUMENTO VI.<br />
MCCCCLXXXVI, DIE XX DECEMBRIS.<br />
Est magna in<strong>di</strong>gentia obolorum tam in hac urbe quam<br />
in civitate Pa<strong>di</strong>ie cum in<strong>com</strong>odo multo populi minuti desiderantis<br />
habere ex illis, Eapropter,<br />
Va<strong>di</strong>t pars, quod auctoritate huius consilii mandetur<br />
massariis nostris ceche argenti ut cu<strong>di</strong> faciant de presenti<br />
ducatos quadringentos parvulorum sive obolorum pre<strong>di</strong>ctorum<br />
quorum ducati ducenti sint prò hac civitate et alii ducati<br />
ducenti prout videbitur capitibus mittantur ad rectores nostros<br />
Padue <strong>di</strong>spensandos illi populo cum or<strong>di</strong>ne quod remittant<br />
alterotantas argenteas monetas ad officium ceche prefatum.<br />
(Cons. X., Misti, R. 23, e. 68).<br />
DOCUMENTO VII.<br />
MCCCCXCI, DIE ULTIMA AUGUSTI.<br />
Quia oratores fidelissime <strong>com</strong>munitatis nostre Padue; ad<br />
presentiam capitum huius consilii <strong>com</strong>parentes post declaratam<br />
necessitatem, et in<strong>com</strong>odum quam et quod patitur ille<br />
fidelissimus populus ob defectum obolorum , supplicarunt<br />
provideri de obolis, et de tali sorte obolorum qui non possint<br />
ab falsificatoribus viciari cum consequenti multiplicatione, cum<br />
damno postea <strong>di</strong>ctorum fidelium, Eapropter<br />
Va<strong>di</strong>t pars; quod auctoritate huius consilii, captum et<br />
deliberatum sit, quod in cecha nostra cu<strong>di</strong> debeant modo et<br />
in futurum bagatini sortis et qualitatis nunc huic Consilio<br />
ostense, que est valute duodecim ad marchetum, quia sunt<br />
ex ramine puro, expenden<strong>di</strong> in Padua et paduano territorio<br />
ad nationem pre<strong>di</strong>ctam duodecim ad marchetum, et fiant<br />
cum imagine Sancti Marci in forma leonis ab uno latere et<br />
cum una cruce ab altero, sicuti etiam concessum fuit Veronensibus.<br />
Et prò nunc mandetur cu<strong>di</strong> et mitti ad cameram<br />
nostram Padue ducatos ducentos cum or<strong>di</strong>ne et mandato ad<br />
illos rectores nostros, quod remittant ad capita et camerarium<br />
huius consilii alterotantas monetas auri vel argenti.<br />
(Cons. X, Misti, F. 5).
NUOVO CONTRIBUTO ALLA NUMISMATICA PADOVANA 381<br />
DODUMENTO Vili.<br />
M.D.III, DIE ULTIMA MARTII.<br />
Quod fidelissime <strong>com</strong>unitati nostre Padue: ita supplicanti<br />
prò opportunitatibus mentis pietatis Padue concedatur et ita<br />
mandetur camerario huius consilii: quod cu<strong>di</strong> facere debeat<br />
in cecha nostra ducatos centum obolorum ad solitam stampam,<br />
dantibus ipsis oratoribus, sicut se offerunt, ducatos centum<br />
ad incontrum.<br />
(Con. X, Misti, F. 15).<br />
DOCUMENTO IX.<br />
M.D.XIX, DIE XII OCTOBRIS.<br />
Battandosi sulla cecha nostra bagatini de rame Zalo, tuti<br />
de uno medemo peso et precio, per Padoa:T\:^N'\?>Q\ Zara.:<br />
Spalato: Sibinico: Liesna: Antivari et Trahu. Quali tuti sonno<br />
de <strong>di</strong>verse stampe, et per la <strong>di</strong>versità de stampe quelle se<br />
fano con grande spesa <strong>di</strong>spen<strong>di</strong>o et fatica, si <strong>com</strong>e bora està<br />
dechiarito : et essendo al tuto necessario proveder. Si per<br />
evitar la spesa: <strong>com</strong>e etiam per la <strong>com</strong>mo<strong>di</strong>ta de i populi. Pero<br />
Landara parte: che per auctorita de questo Conseio, tute<br />
octo <strong>di</strong>ete <strong>di</strong>verse stampe de bagatini che sonno de una<br />
medesima charata, peso: et precio, se debano batter et far<br />
de una sola stampa la qual sia da una banda San Marco in<br />
soldo e dalaltra la nostra Dona dela instessa grandeza, qualità<br />
et sorte se battevano in <strong>di</strong>eta Cecha et bora està monstrada<br />
a questo Conseio. Et azo la presente deliberation sortisca<br />
votivo effecto, sia preso: Che per el cassier de <strong>di</strong>cto conseio<br />
sia <strong>com</strong>prado rame Zalo per la summa de ducati cento. Qual<br />
rame sia posto in Cecha, et desso batudo li <strong>di</strong>cti ducati cento<br />
in tanti bagatini dela stampa soprascrita, et cussi habia ad<br />
continuar battendo ogni mese ducati cento et non pini per<br />
fina che altro sarà deliberato per questo Conseio. I qual<br />
ducati 100 romagnir debano al continuo in deposito in essa<br />
cecha nostra, azo che <strong>di</strong>cti bagatini possine sempre haverli<br />
senza <strong>di</strong>fficulta, ne obstaculo alcuno.<br />
(Cons. X, Misti, R. 43, e. 77).
DE L'UTILITÉ SCIENTIFIQUE<br />
DES COLLECTIONS<br />
DE MONNAIES ANCIENNES (0<br />
Notre grand moraliste La Bruyère, voulant railler la<br />
Curiosité, qui '" n'est pas un goùt pour ce qui est bon ou<br />
ce qui est beau, mais pour ce qui est rare, unique, pour ce<br />
qu'on a et ce que les autres n'ont point „, met en scène le<br />
curieux de médailles, Diognète: " Pensez-vous, <strong>di</strong>t-il, qu'il<br />
cherche à s'instruire par les médailles, et qu'il les regarde<br />
<strong>com</strong>me des preuves parlantes de certains faits et des monuments<br />
fixes et indubitables de l'ancienne histoire? rien moins.<br />
Vous croyez peut-étre que toute la peine qu'il se donne pour<br />
recouvrer une téte vient du plaisir qu'il se fait de ne voir<br />
pas une suite d'empereurs interrompue? c'est encore moins:<br />
Diognète sait, d'une médaille, le frust, le feloux et la fleur<br />
de coin; il a une tablette dont toutes les places sont garnies,<br />
à l'exception d'une seule: ce vide lui blesse la vue, et c'est<br />
précisément, et à la lettre, pour le remplir qu'il emploie son<br />
bien et sa vie. „<br />
Cette mordante satire emprunte encore un surcroìt<br />
d'ironie à la place qu'elle occupe dans le chapitre de La<br />
Mode, où le curieux de monnaies anciennes a son rang<br />
marqué entre le fleuriste " qui a pris racine au milieu de<br />
ses tulipes „, l'amateur de prunes et le collectionneur de<br />
papillons et de serins.<br />
La Bruyère, Messieurs, tout en fustigeant de la belle<br />
fa^on les frivoles antiquaires de son temps qui possédaient<br />
(i) Discorso pronunciato alla Seduta generale del Congresso della<br />
Società d.egli Scienziati, tenuta a Parigi il 24 aprile 1897 (N. d. R.)
384<br />
ERNESTO BABELON<br />
des médailliers pour étre à la mode, a donne, en deux mots,<br />
avec le bon sens qui caractérise le genie, la définition de ce<br />
que doivent étre les monnaies anciennes pour tout esprit<br />
sérieux et éclairé: " des preuves parlantes de certains faits,<br />
des monuments fixes et indubitables de l'ancienne histoire. „<br />
Ce n'est pas dans une assemblée d'elite <strong>com</strong>me la vótre,<br />
Messieurs, dans cette réunion solennelle des savants de la<br />
France entière, dans ce vaste amphithéàtre de la science,<br />
que la démonstration de cette vérité devrait étre présentée,"<br />
si je ne m'étais simplement propose pour but de me faire,<br />
en peu de mots, l'interprete de votre réponse au public, qui,<br />
d'or<strong>di</strong>naire, visite pour se <strong>di</strong>straire nos musées de province<br />
et qui voit, sans en bien <strong>com</strong>prendre l'utilité scientifique, les<br />
lépidoptères et les serins empaillés, parfois méme des herbiers<br />
où la tulipe est en honneur, còtoyer une vitrine plus humble,<br />
où quelques médailles, les unes frustes, les autres à fleur de<br />
coin, ont marqué leur silhouette au milieu d'un champ de<br />
poussière protectrice. Il est tenté de considérer cette sèrie<br />
numismatique <strong>com</strong>me un amas de petites curiosités, des spé-<br />
cimens d'un genre d'objets qu'il est bon d'avoir parce qu'il faut<br />
un peu de tout dans un musée bien <strong>com</strong>pris; des échantillons<br />
d'un rang à peine un peu plus relevé que les collections<br />
voisines d'ex libris, de timbres-poste ou de boutons d'uniformes.<br />
Ce qui, d'ailleurs, explique cette opinion d'une partie du<br />
public, c'est qu'il se rencontre encore aujourd'hui — avouonsle<br />
— parmi les amateurs de monnaies anciennes, pas mal<br />
de Diognètes, les uns, spéculateurs intéressés, les autres,<br />
ignorants autant que passionnés, à la merci des brocanteurs<br />
et des faussaires, — qui sont, en face de leur propre médaillier,<br />
<strong>com</strong>me Tamateur de livres qui ne lit jamais, ou <strong>com</strong>me<br />
un voyageur qui ne prendrait pas de notes au cours de ses<br />
pérégrinations. J'en connais qui, ne s'attachant qu'au petit<br />
coté de la numismatique, sont au <strong>com</strong>ble de la joie lorsqu'ils<br />
ont rencontre une incorrection dans une legende monétaire,<br />
ou bien une téte imperiale tournée à droite au lieu d'étre à<br />
gauche, pareils en cela au bibliophile transporté d'aise quand<br />
il a découvert, dans la bonne é<strong>di</strong>tion d'un vieux livre, les<br />
trois coquilles typographiques qui ne se trouvent pas dans<br />
la mauvaise.
DE l'utilité scientifique des collections, ecc. 385<br />
Et puis, un esprit superficiel est naturellement porte à<br />
assimiler les monnaies anciennes à celles qui circulent jour-<br />
nellement dans nos mains, et il ne saisit guère de quelle<br />
utilité seraient ces dernières pour écriie l'histoire contem-<br />
poraine.<br />
Nous verrons tout à l'heure, Messieurs, que cette assi-<br />
milation n'est pas entièrement conforme à la réalité; mais,<br />
si vous le voulez bien, acceptons-la provisoirement et plagons-<br />
nous, par rapport à notre numéraire circulant, dans la situation<br />
où nous nous trouvons, par exemple, vis-à-vis des monnaies<br />
que nous ont laissées les Romains et les Grecs.<br />
Transportons-nous par la pensée dans un avenir lointain;<br />
franchissons les siècles et supposons que, dans deux mille<br />
ans d'i ci, des savants cherchent à reconstituer l'histoire de<br />
notre civilisation. alors que le tempus edax rerum aura<br />
englouti nos monuments de tonte sorte, et qu'il ne resterà<br />
plus, de nos oeuvres de l'art et de l'intelligence, que des<br />
ruines, des débris et des tombeaux: voici tout à coup un<br />
numismate de ce temps — il y en aura toujours — entre<br />
les mains duquel tombe une pièce de / francs, au millèsime<br />
de 1878. Que lui apprendra cette monnaie? Il est aisé de<br />
démontrer qu'armé de la critique la plus rigoureuse, il en<br />
tirerà des éléments propres à enrichir le domaine de toutes<br />
les branches des sciences historiques et économiques.<br />
La legende République frangaise lui apprendra quelle est<br />
la forme actuelle de notre gouvernement, et s'il a déjà rangé<br />
dans son médaillier un nombre raisonnable de monnaies de<br />
notre XIX*" siècle, il constaterà que notre regime politique<br />
a changé souvent; il pourra mème préciser la durée de chaque<br />
regime, l'epoque de nos trop fréquentes révolutions.<br />
L'inscription du revers, Libertè, égalité, fraternité, lui<br />
in<strong>di</strong>quera quel est l'idéal social que nous poursuivons, et<br />
peut-étre que les lambeaux de littérature que sa perspicacité<br />
saura confionter avec cette devise lui donneront à presumer<br />
que nous avions bien encore quelque progrès à faire pour<br />
en atteindre la parfaite réalisation.<br />
Le type de l'Hercule debout entre la Justice et l'Equité,<br />
ressouvenir de la mythologie romaine, lui donnera quelque<br />
idée des tendances philosophiques de notre siècle, en lui<br />
49
386<br />
ERNESTO BABELON<br />
démontrant que nous préférons ces allégories paiennes aux<br />
emblèmes de notre propre religion ou de notre histoire<br />
nationale.<br />
Peut-étre s'étonnera-t-il que l'inscription Dieu protège la<br />
France ait été gravée sur la tranche, dans le voisinage de<br />
THercule; il pourra toutefois, après un <strong>com</strong>pliment mérité à<br />
la logique de notre entendement, en déduire le principe<br />
fondamental de nos conceptions religieuses et morales.<br />
La marque de valeur / francs lui fera connaitre notre<br />
système monétaire, s'il veut bien peser la pièce. En consultant<br />
son médaillier, il s'apercevra que la frappe de la pièce de<br />
/ francs est suspendue chez nous depuis 1878, ce qui lui<br />
servirà d'argument pour <strong>di</strong>sserter sur la question du mono-<br />
métallisme et du bimétallisme, qui, sans doute, ne sera pas<br />
encore épuisée.<br />
La suite des monnaies du XIX*^ siècle lui permettra de<br />
mieux <strong>com</strong>prendre la valeur réelle et relative des choses à<br />
notre epoque, d'interpréter avec plus d'assurance les <strong>com</strong>ptes<br />
et les marchés dont le texte aura réussi à se conserver<br />
jusqu'à lui. Pour l'histoire de notre droit public, il constaterà<br />
que la République frangaise ne donne pas à ses Présidents<br />
le droit d'effigie qu'ont eu nos souverains. Quel jugement<br />
portera-t-il sur la finesse et l'acuite de notre esprit s'il<br />
parvient à trouver la clef du rebus qui s'étale dans le champ<br />
de nos pièces d'or, sous l'image du coq gaulois?<br />
Je passe sous silence, Messieurs, bien d'autres considé-<br />
rations, et je vous laisse le soin de <strong>com</strong>pléter par vos propres<br />
réflexions tonte la portée historique que nos monnaies<br />
actuelles, ce banal instrument de nos échanges quoti<strong>di</strong>ens,<br />
si i)duvre <strong>com</strong>me invention et <strong>com</strong>me art, pourrait avoir<br />
dans un lointain avenir et dans une situation scientifique<br />
<strong>com</strong>parable à celle qui nous a été faite vis-à-vis de l'antiquité,<br />
par le temps et les révolutions des siècles.<br />
Avant que j'aie esquissé à voi d'oìseau cette rapide<br />
<strong>com</strong>paraison, vous aviez déjà, Messieurs, reconnu par votre<br />
propre expérience que les monnaies anciennes sont des<br />
témoins oculaires et officiels, appelés sans relàche à déposer,<br />
dans la vaste enquéte entreprise à des points de vue <strong>di</strong>vers,<br />
par l'ensemble des sciences historiques, sur le passe de
DE l'uTILITÉ SCIENTIFIQUE DES COLLECTIONS, ECC. 387<br />
l'humanité. Voilà la raison de la présence de ces témoins,<br />
de ces pièces à conviction dans nos musées; voilà pourquoi<br />
nous recherchons aujourd'hui la modeste drachme qui cir-<br />
culait de main en main sur l'agora, le moindre denier qu'on<br />
échangeait sur le forum ou dans les camps, — <strong>com</strong>me un<br />
document authentique, contemporain, le seul témoin, parfois.<br />
qui nous serve à préserver un événement historique de la<br />
profanation de Toubli.<br />
Nos n'.onnaies modernes sont fìxées pour une longue<br />
période d'années dans des types de convention qui ne<br />
changent guère; les mémes emblèmes et les mémes légendes<br />
se perpétuent aussi longtemps que dure un regime politique:<br />
on mo<strong>di</strong>fie seulement la date et les <strong>di</strong>fférents monétaires.<br />
Tout autres étaient les usages de l'antiquité qui, presque<br />
partout, a fait de sa monnaie non seulement un instrument<br />
pour les échanges, mais en méme temps une médaille <strong>com</strong>mémorative<br />
destinée à fixer dans la mémoire des peuples<br />
le souvenir des événements heureux de leurs annales. De<br />
là, dans les coins monétaires, des changements incessants,<br />
une pro<strong>di</strong>gieuse variété de types qui s'accroìt encore par la<br />
multiplicité des ateliers et par l'imperfection matérielle de<br />
l'outillage qui ne permettait pas de frapper un grand nombre<br />
de pièces avec les mémes matrices.<br />
Pour le monde grec seulement, nous connaissons pré-<br />
sentement cinq à six cents rois ou dynastes, et près de 1,400<br />
villes qui ont frappé monnaie dans ces con<strong>di</strong>tions d'inépuisable<br />
fécon<strong>di</strong>té et de renouvellement continu, et les produits d'un<br />
grand nombre de ces ateliers s'échelonnent chronologiquement<br />
depuis le VIP siècle avant notre ère jusqu'au IIP siècle<br />
après Jésus-Christ.<br />
A Rome, la <strong>di</strong>versité des types monétaires est non moins<br />
grande et non moins instructive. Plus de <strong>di</strong>x mille symboles<br />
<strong>di</strong>fférents ont été relevés sur les deniers que le triumvir<br />
monétaire Lucius Calpurnius Piso fit frapper dans une séule<br />
année, en 89 avant notre ère, et ses deux collègues dans<br />
les mémes fonctions n'ont pas fait graver un moins grand<br />
nombre de coins. Il fallait la coopération d'une véritable<br />
armée d'ouvriers pour monnayer les espèces nécessaires à<br />
la circulation generale; à tei point qu'un jour, sous le règne
388<br />
ERNESTO BABELON<br />
d'Aurélien, une rébellion ayant éclaté dans les ateliers de la<br />
Monnaie de Rome, les monétaires s'y trouvaient si nombreux,<br />
que la repression du désordre coùta la vie à sept mille soldats.<br />
Une ville <strong>com</strong>me Ephèse, par exemple, frappe monnaie<br />
durant l'espace de huit siècles et demi et produit plusieurs<br />
centaines de types monétaires <strong>di</strong>fférents. Si vous les <strong>di</strong>sposez<br />
dans l'ordre des temps, vous pourrez suivre pas à pas l'histoire<br />
de Tart dans la capitale de l'Ionie; vous assisterez à ses<br />
débuts, à son épanouissement, à sa décadence; vous contem-<br />
plerez, se déroulant sous vos yeux, l'imposante théorie des<br />
<strong>di</strong>eux honorés dans cette ville, l'Artémis éphésienne et ses<br />
symboles. Zeus Yetios, Apollon Hikésios, Apollon Embasios;<br />
des <strong>di</strong>vinités allégoriques <strong>com</strong>me le <strong>di</strong>eu du mont Pion, les<br />
<strong>di</strong>eux fleuves Kaystros, Kenchrios et Marnas; <strong>di</strong>fférents<br />
épisodes des légendes relatives à l'établissement des loniens<br />
en Asie Mineure; Coresos, un des fondateurs mythiques du<br />
tempie d'Artémis, et jusqu'à Héraclite, le philosophe de la<br />
mélancolie.<br />
Pour l'histoire politique, vous en suivrez toutes les<br />
phases par les monnaies qui montrent Ephèse subissant tour<br />
à tour la suprématie athénienne ou la domination des Perses,<br />
s'alliant avec Rhodes, Cnide et Samos, ballottée entra la<br />
tyrannie et la démocratie, frappant ensuite au nom d'A-<br />
lexandre, de Lysimaque, des Séleucides, des Ptolémées;<br />
prenant au gre de ses maìtres successifs les noms d'Arsinoé<br />
et d'Eury<strong>di</strong>cée, retournant à son nom d'Ephèse, ouvrant son<br />
atelier aux rois de Pergame, affirmant son alliance avec<br />
Mithridate, enfin accueillant dans son port la galère qui<br />
portait le proconsul romain. Un grand nombre de ces événements,<br />
dont le souvenir est consacré par les monnaies, ne<br />
sont connus, précisés ou datés que par elles.<br />
Dans l'ordre économique, nous voyons Ephèse adopter<br />
tour à tour, pour la taille de ses espèces, suivant les avantages<br />
de son <strong>com</strong>merce extérieur, le système phénicien, le système<br />
rho<strong>di</strong>en, le système attique; nous constatons des associations<br />
<strong>com</strong>merciales dont l'histoire, sans les monnaies, n'aurait nul<br />
souvenir: alliance d'Éphèse avec Aradus de Phénicie, avec<br />
Alexandrie d'Égypte, avec Cyzique, Smyrne, Mytilène, Pergame<br />
et vingt autres villes; sous nos yeux se forment et se
DE l'uTILITÉ SCIENTIFIQUE DES COLLECTIONS, ECC. 389<br />
dénouent, au gre des intéréts ou sous la pression des événe-<br />
ments, ces ligues hanséatiques, dont le moyen àge n'eut pas<br />
le secret, et dont l'histoire est encore à écrire.<br />
Et quant aux annales municipales d'Ephèse, les bases<br />
essentielles en sont constituées par la serie — qui s'accroìt<br />
chaque jour — des prytanes éponymes dont les noms, au<br />
nombre de près de quatre cents, ont été jusqu'ici relevés sur<br />
les monnaies.<br />
Éphèse, Messieurs, n'est pas une exception. Parcourez,<br />
<strong>com</strong>me Anacharsis, toutes les contrées du monde hellénique:<br />
partout, aussi bien qu'à Éphèse, — à Smyrne, Alexandrie,<br />
Antioche, Athènes, Corinthe, S3Tacuse, — enfin à Carthage<br />
et à Rome, vous trouverez dans les monnaies le reflet des<br />
<strong>com</strong>motions politiques, de l'histoire de l'art, de la vie muni-<br />
cipale, de l'activité <strong>com</strong>merciale, du rayonnement au dehors;<br />
de cette <strong>di</strong>versité d'institutions, d'usages, de tra<strong>di</strong>tions locales;<br />
de cette décentralisation, en un mot, qui est pour un peuple<br />
— l'histoire de la Grece le démontre avec éloquence — la<br />
meilleure con<strong>di</strong>tion du progrès social.<br />
Si Éphèse nous donne le nom de ses prytanes éponymes,<br />
dans d'autres villes, la monnaie est signée par le stratège,<br />
le grammateus, le boularque, l'éphore, le tamias, l'archiéreus,<br />
le stéphanophore ou surintendant des sacrifices, l'agonothète<br />
ou président des jeux publics, le théologos ou interprete des<br />
oracles, l'archiatre ou chef des médecins; il y a mème de^<br />
villes où les monnaies nous apprennent que les femmes<br />
pouvaient ètre investies des plus hautes fonctions publiques.<br />
Partout les <strong>di</strong>eux et les héros de chaque contrée vivent<br />
et s'agitent en des milliers d'épisodes. Jetez un regard sur<br />
la numismatique de la Créte: cinquante villes au moins de<br />
cette ile fameuse y sont représentées, et quelle variété de<br />
types mythologiques! La naissance de Zeus dans la grotte<br />
du mont Ida; Minos, le premier législateur; Thésée, le<br />
labyrinthe, le Minotauro, le géant Talos, précurseur des<br />
modernes Crétois, qui bran<strong>di</strong>t une pierre et fait trois fois par<br />
jour le tour de l'ile, pour empècher le vaisseau des Argo-<br />
nautes confédérés d'y aborder.<br />
Vous parlerai-je à présent des monnaies de la Thessalie,<br />
de la Béotie, de l'Argolide? Ces dernières, avec Héra et ses
390<br />
ERNESTO BABELON<br />
symboles, Apollon Lykios, le <strong>com</strong>bat de Danaos et de Gelanor<br />
pour la domination du Péloponèse; la touchante histoire de<br />
Cléobis et Biton traìnant eux-mémes le chariot sur lequel<br />
leur pieuse mère est assise pour se rendre au tempie d'Héra.<br />
En Arca<strong>di</strong>e, c'est Ulysse, arme d'un aviron, qui cherche<br />
l'homme mystérieux que lui a désigné Tirésias; à Syracuse,<br />
c'est la nymphe de la fontaine d'Ortygie qui a si <strong>di</strong>vinement<br />
inspiré à la fois les poètes et les artistes graveurs des coins<br />
monétaires. A Neapolis, à Terina, à Tarente, ce sont les<br />
sirènes Parthenopé, Ligea et le jeune Taras sauvé par un<br />
dauphin. Vous citerai-je enfin, à une autre extrémité du monde<br />
grec, le géant Ascos à Damas, les Tables ambrosiennes à<br />
Tyr, les <strong>di</strong>eux syriens aux formes si étranges, au eulte si<br />
monstrueux?<br />
N'est-il pas intéressant de retrouver en images, sur les<br />
monnaies d'une ville perdue de la Paphlagonie, Abonotheicos,<br />
le eulte du serpent qu'un imposteur du IP siècle de notre<br />
ère, Alexandre, avait réussi, à Faide de bons tours de ma-<br />
gicien, à introniser dans cette contrée? Vous vous souvenez<br />
des persécutions sanglantes que les rois de Syrie, surtout<br />
Antiochus IV Epiphane, firent endurer aux Juifs réfractaires,<br />
et les déportations qui s'ensuivirent. Des familles juives furent<br />
ainsi transplantées jusqu'à Apamée en Phrygie; elles finirent<br />
par s'ac<strong>com</strong>moder de cet exil où elles prospérèrent tant et<br />
si bien, que trois cents ans plus tard, au temps de Septime<br />
Sevère, elles y avaient acclimaté les tra<strong>di</strong>tions bibliques<br />
elles-mèmes: on racontait que l'arche de Noè s'était arrétée<br />
au plus haut sommet des montagnes voisines, et, pour que<br />
personne n'en pùt douter, des monnaies furent alors frappées,<br />
sur lesquelles on voit Noè et sa femme dans l'arche, et<br />
donnant à la colombe son libre essor.<br />
A peu près tout ce que nous savons des tribus de la<br />
Macédoine et de la Thrace avant Philippe — les Bisaltes,<br />
les Edones, les Odomantes, les Odryses, les Paeoniens —<br />
nous est révélé par leurs grandes et curieuses monnaies,<br />
d'un art si rude, si vigoureux, si expressif. Ailleurs, c'est le<br />
nom d'un fleuve, <strong>com</strong>me le Rheon, à Hipponium, ou celui<br />
d'un port, <strong>com</strong>me le Lacydon à Marseille, qui nous sont<br />
révélés, ou bien c'est le nom méme d'une ville et de son
DE l'uTILITÉ SCIENTIFIQUE DES COLLECTIONS, ECC. 39I<br />
emplacement. Une quinzaine, au moins, des rois de la Bac-<br />
triane ne nous sont connus qua par leurs espèces. La chro-<br />
nologie des rois de Sidon, de Byblos et des villes de l'ile<br />
de Chypre n'a pu étre constituée que par les monnaies.<br />
L'histoire des dynastes de la Cilicie, de la Pamphylie, de la<br />
Lycie, de la Carie, de la Cappadoce n'a pas de plus solide<br />
fondement que les monnaies, qui <strong>com</strong>plètent, éclairent le<br />
récit des auteurs et permettent de vérifier leurs assertions<br />
plus ou moins controversées.<br />
Vous vous rappelez que Thémistocle, convaincu de<br />
trahison, dut quitter la Grece et se réfugier sur le territoire<br />
de l'empire perse. Artaxerxès, <strong>di</strong>t Plutarque, accueillit avec<br />
empressement le general athénien, et, pour le ré<strong>com</strong>penser<br />
d'avoir deserte la cause hellénique, il lui donna trois villes<br />
d'Asie Mineure, qui lui fournirent Fune son pain, l'autre son<br />
vin, et la troisième sa viande. On pouvait attribuer à ce<br />
récit tra<strong>di</strong>tionnel un certain caractère légendaire qu'un<br />
historien austère eùt été tenté de répu<strong>di</strong>er: quelle ne fut pas<br />
la joie du numismate entre les mains duquel, il n'y a pas<br />
quarante ans, tomba une monnaie d'argent portant le nom<br />
de Thémistocle, et frappée à Magnèsie, Fune des villes<br />
données par le grand Roi à l'illustre fugitif?<br />
Cent vingt-trois ans avant notre ère, le roi de Syrie,<br />
Alexandre Zebina, assiégé dans Antioche et réduit aux<br />
expé<strong>di</strong>ents, prit le parti d'aliéner, pour payer les troupes<br />
qui lui restaient, le trésor du tempie de Zeus, et il alla<br />
jusqu'à enlever la Victoire en or massif que la statue colos-<br />
sale du <strong>di</strong>eu tenait sur sa main tendue en avant. Il essaya<br />
méme, raconte Justin, de justifier ce sacrilège par une<br />
raillerie, en <strong>di</strong>sant qu'il acceptait la Victoire que le <strong>di</strong>eu<br />
daignait lui offrir. Y avait-il dans ce récit quelque amplifi-<br />
cation anecdotique de la part de l'auteur latin? on pouvait<br />
le soup9onner jusqu'à l'epoque, tonte recente, oij il m'est<br />
parvenu un exemplaire de la monnaie d'or que Zebina fit<br />
Trapper; elle a pour type la statue méme de Zeus tenant la<br />
Victoire d'or sur sa main, et le caractère exceptionnel de<br />
cette pièce est encore mis en évidence par l'absence de tout<br />
monnayage d'or en Syrie, dans le siede qui précède ou celui<br />
qui suit le règne de Zebina.
392<br />
ERNESTO BABEI.ON<br />
Quand Mithridate, voulant chasser les Romains de l'O-<br />
rient, fit alliance avec Ephèse, avec Athènes, avec les Italiens<br />
méme, les révoltés de la guerre Sociale, il envoya des<br />
subsides en or à tous ses alliés pour les aider à faire leurs<br />
préparatifs de guerre; eh bien, nous possédons de rares<br />
pièces d'or d'Ephèse, d'Athènes et des insurgés italiotes, qui<br />
sont, dans nos médailliers, les irréfragables témoins du projet<br />
vaste et bar<strong>di</strong> qu'avait confu le genie du redoutable adversaire<br />
de Lucullus et de Pompée.<br />
A qui la reine Philistis de Syracuse doit-elle sa célébrité,<br />
sinon à ses monnaies, où elle nous apparatt gracieuse et<br />
voilée <strong>com</strong>me une Madone de la Renaissance? Que saurionsnous<br />
de la plupart des villes de la Sicile et de la Grande<br />
Grece avant Pyrrhus et les guerres puniques? Fort peu de<br />
chose, sans ces admirables séries monétaires qui racontent<br />
leur fondation, leurs légendes, leurs annales, les jeux publics<br />
qu'elles célébraient pério<strong>di</strong>quement <strong>com</strong>me nos Expositions<br />
universelles ou régionales; leur art enfin, si fécond dans ses<br />
conceptions, oìi toujours la gràce exquise s'allie à la noblesse<br />
de l'expression, à la pureté des lignes, à l'équilibre parfait<br />
de la <strong>com</strong>position.<br />
Comment parler <strong>di</strong>gnement devant vous, Messieurs, de<br />
ces médailles que vous connaissez tous, que les Grecs ont<br />
faites si belles, et qu'ils ont — mus par un sublime instinct<br />
d'immortalité — jetées à poignées, <strong>com</strong>me un solennel défì<br />
aux artistes de tous les àges futurs; de ces médailles dont<br />
le charme intraduisible émeut toujours, soit qu'on se contente<br />
des impressions fugitives et superficielles du <strong>di</strong>lettante, soit<br />
qu'il s'agisse des études approfon<strong>di</strong>es de l'éru<strong>di</strong>t. Ne vous<br />
semble-t-il pas, Messieurs, que la Grande Grece et la Sicile<br />
étaient alors le théàtre merveilleux d'un miracle qui ne s'est<br />
renouvelé qu'une fois dans les annales de l'humanité? C'est<br />
à l'epoque de la Renaissance, alors que chaque ville, chaque<br />
bourgade de l'Italie avait ses écoles d'artistes en tous genres<br />
et ses Mécènes, assistait à cette émulation d'ateliers, source<br />
du progrès, qui a fait éclore tant de chefs-d'oeuvre éternels!<br />
CEuvres d'art par elles-mémes, les monnaies antiques<br />
nous conservent l'image et le souvenir des autres oeuvres<br />
d'art, dans le domaine de la sculpture ou de l'architecture.
DE l'utilité scientifique des collectiOxNs, ecc. 393<br />
Les primitifs essais de la sculpture grecque, ces bornes plus<br />
ou moins grossièrement équarries. images des <strong>di</strong>eux dont<br />
on voyait encore, du temps de Pausanias, des échantillons<br />
tra<strong>di</strong>tionnellement conservés dans les plus vieux sanctuaires<br />
de la Grece, ces brutales et curieuses images, <strong>di</strong>s-je, nous<br />
les voyons reproduites sur les monnaies. A Byzance, Apol-<br />
lonie, Mégare, c'est un cippe allongé, la première image de<br />
TApoUon des carrefours; à Pergé, à lasos, c'est Artémis<br />
sous l'aspect d'une poupée enfantine affublée d'ornements.<br />
Voici venir, à présent, des représentants des <strong>di</strong>fférentes<br />
écoles. Le premier sculpteur de Fècole d'Egine, Smilis, avait<br />
exécuté pour l'Héraion de Samos une statue que nous<br />
montrent les monnaies de l'ile. Un tétradrachme athénien<br />
nous donne quelque idée de ce qu'était la fameuse statue<br />
d'Apollon, érigée à Délos par Tektaios et Angelion. L'Athena<br />
Chalcioecos de Gitiadas, l'Apollon Didyméen, oeuvre de Ca-<br />
nachos, le Zeus Ithomatas du chef de Fècole argienne,<br />
Ageladas; le groupe des Tyranoctones, exécutè en bronzo<br />
par Anténor, au lendemain de la chute des Pisistratides,<br />
figurent sur des monnaies qui suppléent aux description des<br />
auteurs et nous aident à restaurer et à identifier les débris<br />
de sculpture èpars dans nos musèes. Vous y retrouverez<br />
pareillement les plus renommèes des oeuvres de Myron, de<br />
Polyclète, de Calamis, de Phi<strong>di</strong>as, de Praxitèle, de Bryaxis.<br />
On a invoqué avec profit des types monétaires à l'appui des<br />
restitutions qui ont été tentèes de la Vènus de Milo; et,<br />
quand sont venus au Musée du Louvre les dèbris de la<br />
Victoire de Samothrace, ce sont les beaux tétradrachmes de<br />
Dèmètrius Poliorcète qui ont donne une certitude scientifique<br />
à Fassemblage de cet admirable morceau et en ont fixè<br />
rigoureusement la date.<br />
Que de monuments d'architecture seraient, sans les types<br />
monétaires qui les reproduisent, à la merci des restitutions<br />
fantaisistes de notre imagination! lei, nous voyons le tempie<br />
d'Aphro<strong>di</strong>te à Paphos, avec son pylòne, son parvis, son vaste<br />
pèribole entourè d'un portique, et, au fond du sanctuaire, le<br />
bètyle, image de la dèesse, autour duquel voltigent les<br />
colombes sacrèes; là, c'est le tempie non moins fameux du<br />
mont Garizim, rivai de celui de Jérusalem, sur les cendres<br />
50
394<br />
ERNESTO BABELON<br />
duquel les Samaritains de nos jours vont encore ac<strong>com</strong>plir<br />
leurs pieux pèlerinages.<br />
Voici le tempie rond de Mélicerte, à Corinthe; celili de<br />
Baal, à Eraèse; d'Astarté, à Byblos ; de Vénus, à Éryx, sur<br />
une montagne à pie, dont la base est entourée d'une muraille,<br />
<strong>com</strong>me une forteresse; voici une vue de l'Acropole d'Athènes,<br />
avec l'Athena Promachos et la grotte de Pan; une vue des<br />
ports de Side, de Corinthe, d'Ostie. Tous les monuments<br />
de Rome défilent sous nos yeux : les temples de Jupiter Ca-<br />
pitolin et de la Concorde, avec leur toit surmonté de statues;<br />
les temples de Janus, de Vesta, de Vénus; les basiliques<br />
Emilienne et Ulpienne. A Tarse, c'est le monument singulier<br />
appelé " Tombeau de Sardanapale „; à Lyon, c'est l'autel<br />
de Rome et d'Auguste; à Antioche, sur le Méandre, c'est<br />
un pont monumentai dont les piles sont surmontées de sta-<br />
tues; ailleurs ce sont des théàtres, des thermes, des viaducs,<br />
des arcs de triomplie, des forteresses. De quelque coté que<br />
nous tournions nos regards^ c'est <strong>com</strong>me un panorama gigan-<br />
tesque où les graveurs des coins monétaires ont rassemblé,<br />
pour nous en garder le souvenir, tous ces monuments où le<br />
temps et la barbarie devaient porter la sape et le marteau.<br />
Prenez en main la description de la Grece par Pausanias<br />
et rapprochez-en, chemin faisant, les médailles de chaque<br />
ville : vous jugerez <strong>com</strong>bien la narration s'éclaire et prend,<br />
dans cette illustration, une physionomie animée; <strong>com</strong>bien le<br />
langage des images, si petites qu'elles soient, parie mieux<br />
à notre intelligence que la description littéraire la plus fìdèle<br />
et la plus développée.<br />
Voulez-vous savoir ce qu'étaient les vaisseaux des An-<br />
ciens? c'est par centaines que les monnaies grecques et<br />
romaines vous en montrent les variétés et le gréement; vous<br />
y reconnaìtrez, parfois, jusqu'au céleuste assis à la poupe<br />
et battant des mains pour donner aux rameurs le rythme de<br />
leurs chants et la cadence de leurs mouvements. Un historien<br />
militaire désire-t-il se rendre <strong>com</strong>pte du changement de ta-<br />
ctique préconisé par l'Athénien Chabrias? quii regarde la<br />
monnaie du satrape Oronte à Clazomène, oia l'hoplite grec<br />
est figure un genou en terre, la lance en arrét et se couvrant<br />
de son bouclier. L'archer crétois, le frondeur baléare, le
DE l'utilité scientifique des collections, ecc. 395<br />
cavalier numide, le légionnaire romain, les chiens de guerre<br />
du roi des Arvernes, Bituit, les éléphants de Pyrrhus et<br />
d'Annihal forment cent variétés de types monétaires.<br />
Les modes vous intéressent-elles? Voulez-vous connai-<br />
tre les transformation de la coiflure féminine en Grece ou<br />
à Rome, et les suivre, pour ainsi <strong>di</strong>re à chaque printemps,<br />
<strong>com</strong>me dans un journal de modes parisien ? voyez, par<br />
exemple, les monnaies de Syracuse, ou celles des impéra-<br />
trices romaines, et vous serez émerveillés de l'infinie variété,<br />
de la science, de l'ingéniosité de ces é<strong>di</strong>fices capiilaires,<br />
toujours élégants, parfois artificiels, entremélés de perles et<br />
de pierreries, soutenus par des sphendonés, des résilles, des<br />
bandelettes, des <strong>di</strong>adèmes, et qui justifient si bien ce mot<br />
d'Ovide, qu'il serait plus aisé de <strong>com</strong>pter les feuilles d'un<br />
chène ou les abeilles de l'Hybla, que les variétés de coiffures<br />
imaginées par les raffinements de la coquetterie ; mais nous<br />
nous refuserons à croire — parce que les monnaies n'en<br />
<strong>di</strong>sent rien — cet autre poète latin qui accuse des matrones<br />
romaines de Trapper jusqu'au sang de malheureuses esclaves,<br />
pour une seule boucle mal agencée dans l'échafaudage de<br />
leur chignon.<br />
Citerai-je à présent des traits de mcEurs et de caractère,<br />
des jeux de mots, des scènes familières? Considérez, par<br />
exemple, la suite nombreuse des monnaies de la République<br />
romaine. Des magistrats s'exercent parfois au calembour ou<br />
au rèbus: Antistius Gragulus fait graver un geai sur ses<br />
coins monétaires; Malleolus y place un maillet; Furius Cras-<br />
sipes, un pied <strong>di</strong>fforme; Voconius Vitulus, un veau. C'était<br />
de l'esprit facile. Mais que <strong>di</strong>tes-vous de ces austères déma-<br />
gogues, de ces amis des Gracques, de Marius ou de Brutus,<br />
qui se forgent des titres de noblesse sur les deniers dont ils<br />
ont à surveiller l'émission, se targuent de descendre de rois<br />
ou méme de héros légendaires, Numa, Ancus Marcius, Philippe<br />
de Macédoine, Faustulus, uniquement parce que le nom<br />
qu'ils portent semble favoriser ces prétentions aristocratiques?<br />
Tous, ils voudraient avoir pour ami un Horace qui leur chante :<br />
Maecenas, atavis e<strong>di</strong>te regibus,
396<br />
ERNESTO BABELON<br />
et nous, nous penserons avec philosophie, en envisageant<br />
notre histoire contemporaine, que si quelque chose a changé<br />
dans le monde depuis deux mille ans, ce n'est pas, à coup<br />
sur, le eulte des ancètres, méme de ceux qu'on n'a pas.<br />
Après Sylla et pendant tout l'empire, quelle in<strong>com</strong>para-<br />
ble galene de portraits nous offrent les monnaies! Sans ces<br />
effigies, <strong>com</strong>ment aurait-on pu donner des noms aux statues<br />
de nos musées? Et quant aux revers, ils constituent, par<br />
leur variété et leur précision chronologique, les archives of-<br />
ficielles de l'histoire. Un régne <strong>com</strong>me celui d'Hadrien, par<br />
exemple, ne <strong>com</strong>pte pas moins de 2,500 revers monétaires<br />
<strong>di</strong>fférents, qui se répartissent en 1,600 pièces latines et 900<br />
pieces grecques. C'est donc une galene de 2,500 tableaux<br />
en miniature qui déroulent à nos regards les événements du<br />
règne, nous initient à la vie publique de l'empereur ; nous<br />
le font suivre, étape par étape, dans ses expé<strong>di</strong>tions et ses<br />
nombreux voyages, <strong>com</strong>plètent le récit des historiens, le<br />
rectifient au besoin, ou nous aident à le mieux <strong>com</strong>prendre.<br />
Tout aussi bien que Thistorie militaire, l'historie économique,<br />
administrative, juri<strong>di</strong>que mème, trouve ici son <strong>com</strong>pte<br />
de renseignements. Si Nerva rend moins tyrannique la per-<br />
ception de la taxe sur les Juifs, les monnaies nous l'appren-<br />
nent par leur legende: Fisci Judaici calumnia sublata; s'il<br />
lève l'impòt sur le transit des marchan<strong>di</strong>ses en Italie : Vehi-<br />
culatione lialice remissa, nous <strong>di</strong>sent les monnaies; s'il crée<br />
un magasin de subsistances pour le peuple, des deniers sont<br />
frappés avec la legende : Plebei iirbance frumento constituto.<br />
Antonin le Pieux fonde-t-il, en l'honneur da sa femme Fau-<br />
stine, une institution d'assistance publique : Puellos Fausti-<br />
niance, portent des pièces qui représentent l'empereur et<br />
l'impératrice accueillant des familles d'in<strong>di</strong>gents.<br />
Ce serait, Messieurs, passer en revue les fastes de l'hi-<br />
stoire romaine, année par année, que d'énumérer tous les<br />
revers monétaires; et <strong>com</strong>bien d'entre eux sont encore<br />
inexpliqués et attendent de votre perspicacité leur interpré-<br />
tation scientifique !<br />
Qui de vous, en sa qualité de membre d'une société<br />
savante, n'a eu à dechiffrer quelque bronze toute encrassé<br />
de rouille? Qui n'a eu à désillusionner quelque brave la-
DE l'utilité scientifique des collections, ecc. 397<br />
boreur qui avait ramasse dans son sillon une vieille pièce<br />
qu'il a prise pour le trésor dont parie La Fontaine? Ce ne<br />
sont pas toujours, loin de là, des pièces banales qu'on vous<br />
apporte ou que vous rencontrez chez le bijoutier, et il est bon<br />
d'y regarder de près.<br />
C'est ainsi, par exemple, que l'année dernière, un expert<br />
de Paris mettait en vente, à l'hotel Drouot, un aureiis ro-<br />
main, qu'on venalt de trouver en Égypte, et qui portait le<br />
nom de l'un des tyrans du IIP siede, Saturninus. Que nous<br />
apprenait cette pièce nouvelle? Les historiens nous <strong>di</strong>sent<br />
fort peu de chose su ce personnage, et l'on a méme suspecté<br />
leur véracité. Saturnin, raconte Vopiscus, était né dans les<br />
Gaules, au sein de cette nation agitée et toujours prète à<br />
changer ceux qui détiennent le pouvoir [gens homimim in-<br />
quietissima et avida semper vel facien<strong>di</strong> principis vel imperii)<br />
— nous avions dejà cette réputation au IIP siècle. — Auré-<br />
lien l'envoya défendre l'Orient contre les Parthes, mais en<br />
lui inter<strong>di</strong>sant expressément l'accès de l'Egypte où avaient<br />
eu lieu naguère des troubles dont un general ambitieux<br />
aurait pu profiter. La pièce d'or nouvelle, frappée en Égypte,<br />
nous est la preuve in<strong>di</strong>scutable que Saturnin enfreignit la<br />
défense qui lui était faite et se fit proclamer empereur à<br />
Alexandrie, — en dépit de l'assertion contraire de Vopiscus<br />
qui avait un intérèt personnel à venger la mémoire de Sa-<br />
turnin de l'accusation de rébellion. Voilà donc une médaille<br />
qui vient contróler et rectifier un historien romain, préciser<br />
un épisode des annales obscures du IIP siècle et, du méme<br />
coup, faire tomber les objections de l'hypercritisme allemand<br />
qui allait jusqu'à nier l'existence du tyran Saturninus.<br />
La numismatique gauloise, Messieurs, est peut-étre plus<br />
intéressante encore, puisqu'elle se rapporte aux origines de<br />
notre pays. Dans tous les cantons de la France, on recueille<br />
des spécimens du monnayage de nos ancétres. Si vos mu-<br />
sées en possèdent une suite assez nombreuse, placez-les,<br />
suivant les trouvailles, sur une carte géographique, et vous<br />
serez étonnés vous-mèmes des enseignements que <strong>com</strong>porte<br />
cette simple <strong>di</strong>sposition matérielle. Vous constaterez, par<br />
exemple, que les tribus de la région danubienne frappent
398<br />
ERNESTO BABELON<br />
des monnaies, qui ne sont que de grossières imitations des<br />
tétradrachmes de la Macédoine ou des statères d'or de Phi-<br />
lippe pére d'Alexandre; que ces imitations se propagent<br />
graduellement à travers le pays des Helvètes, des Séquanes,<br />
des Éduens, jusqu'aux Arvernes qui frappent les beaux sta-<br />
tères au nom de Vercingetorix. Vous aurez trace ainsi avec<br />
ces monnaies, sur la carte de la Gaule, <strong>com</strong>me une grande<br />
et large voie que je ne puis mieux <strong>com</strong>parer qu'à la Voie<br />
lactée au milieu de la carte du ciel : c'est le chemin suivi<br />
par le <strong>com</strong>merce, c'est la route des Gaulois au tempie de<br />
Delphes, c'est la ligne de <strong>com</strong>munication de la Gaule avec<br />
la Grece, c'est-à-<strong>di</strong>re avec l'un des deux grands foyers de<br />
la civilisation antique. Et jugez de quelle utilité scientifique<br />
peut ètre une pareille constatation pour éclairer des textes<br />
plus ou moins obscurs, ou expliquer certaines découvertes<br />
archéologiques! D'autres monnaies gauloises vous <strong>di</strong>ront le<br />
rayonnement du <strong>com</strong>merce des colonies grecques de Mas-<br />
silia, de Rhoda, d'Emporiae; elles vous donneront la plus<br />
riche nomenclature de noms gaulois qui existe; elles vous<br />
montreront les Romains s'insinuant lentement dans notre<br />
pays et s'y créant des alliés avant d'en faire la conquète.<br />
Vous savez de méme, Messieurs, tout le parti que la<br />
philologie et la géographie ont tire des 1,200 noms de lo-<br />
calités et des 2,400 noms de personnes qu'on a jusqu''ici<br />
relevés sur les monnaies mérovingiennes; plusieurs d'entre<br />
vous, enfin, ont puisé les plus utiles renseignements sur les<br />
origines de la féodalité dans la numismatique de l'epoque<br />
carolingienne. Sans doute, la numismatique du moyen àge<br />
ne saurait étre <strong>com</strong>parée à celle de l'antiquité, parce que les<br />
types monétaires s'immobilisent et que les documents écrits<br />
sont trop nombreux pour qu'on puisse espérer <strong>com</strong>bler des<br />
lacunes historiques par les monnaies. Aussi est-ce à un autre<br />
point de vue qu'il faut se piacer pour en tirer un parti scien-<br />
tifique. L'histoire monétaire a, par elle méme, son attrait et<br />
son importance; et puis n'est-il pas nécessaire à l'historien<br />
et à l'economiste, par exemple, de savoir exactement ce<br />
qu'étaient les variétés d'espèces monétaires qu'ils trouvent<br />
mentionnées dans les cextes: le parisis, le tournois, l'agnel,<br />
^
» DE l'uTILITÉ SCIENTIFIQUE DES COLLECTIONS, ECC. 399<br />
le florin, le frane, l'esterlin, le gros, la pougeoise, le ducat,<br />
le sequin, la pistole, le marabotin, pour ne citer qu'un bien<br />
petit nombre d'espèces, <strong>com</strong>parativement à toutes celles qui<br />
furent en usage, Combien de gens s'imaginent que les mon-<br />
naies d'or et d'argent de Philippe le Bel sont en metal altère,<br />
parce qu'il est de mode de donner à ce prince l'épithète de<br />
faux monnayeur!<br />
Mais voici, Messieurs, que nous touclions au seuil des<br />
temps modernes: le moment est venu de clore cette causerie<br />
un peu austère. Lorsque M. le Ministre de l'Instruction pu-<br />
blique, par une insigne et trop bienveillante faveur, me fit<br />
l'honneur, il y a quelques semaines, de me designer pour<br />
prendre la parole dans cette solennelle réunion, et voulut<br />
bien m'inviter à occuper cette place où m'ont précède tant<br />
d'hommes èminents ou illustres, je me suis demandè, non<br />
sans inquiètude, de quel sujet je pourrais vous entretenir.<br />
Au risque de paraìtre précher pour mon saint, j'ai pensè a<br />
faire de la numismatique le terrain neutre sur lequel toutes<br />
les Sociètès savantes ne refuseraient pas de se rencontrer<br />
et de se donner la main. Figure de second pian, la numi-<br />
smatique se plaìt à étre l'humble servante de toutes les<br />
branches des sciences historiques qui ont en vous leurs re-<br />
présentants les plus autorisès. En ce temps de recherches<br />
précises et de sevère critique, où chacun est force de s'enfoncer<br />
dans une spècialitè étroite, parce qu'il vaut mieux<br />
ètre profond sur un point que superficiel en toutes choses,<br />
une collection de monnaies anciennes est la source historique<br />
où chaque spécialiste est assuré de trouver quelque èlèment<br />
utile à ses recherches. Voilà pourquoi je souhaiterais de voir<br />
les sèries numismatiques se développer dans nos musèes de<br />
province: tout le monde y trouverait son profit: artistes et<br />
historiens, èru<strong>di</strong>ts et <strong>di</strong>lettantes, économistes, gèographes,<br />
philologues, moralistes; car ce microcosme des mèdailles —<br />
j'aurais voulu le dèmontrer plus amplement — est bien la<br />
plus <strong>com</strong>plète et la plus fidèle èvocation du passe que nous<br />
procurent les sciences historiques.<br />
N'avons-nous pas, Messieurs, tous tant que nous som.<br />
mes, pris plaisir, dans notre jeune àge, à feuilleter maintes
400<br />
ERNESTO BABELON<br />
et maintes fois quelqu'une de ces Bibles d'images qui, en<br />
nous ber9ant des plus délicieux récits, nous initiait à la culture<br />
intellectuelle et morale? Eh bien, Messieurs, je <strong>com</strong>pa-<br />
rerais volontiers un médaillier à une Bible d'images, et si<br />
l'Histoire, <strong>com</strong>e l'a définie Michelet d'un mot sublime, est<br />
une résurrection, une suite de médailles anciennes est la<br />
résurrection du passe par les images.<br />
Ernesto Babelon.
NUMISMATICA e MEDAGLISTICA<br />
DIALOGO.<br />
(i." Direttore della <strong>Rivista</strong> — 2° Abbonato).<br />
i.° Con questo tempaccio oggi non metteremo certamente<br />
il naso fuori dell'albergo. E la vera giornata per una<br />
delle nostre <strong>di</strong>scussioni numismatiche.<br />
2.° Ed io sono felicissimo d'avere un argomento d'attua-<br />
lità, sul quale desideravo appunto <strong>di</strong> fare quattro chiacchere<br />
con lei, quantunque, a <strong>di</strong>r vero, una certa esitazione me ne<br />
trattenne finora.<br />
i.° Non capisco l' esitazione, a meno che si tratti <strong>di</strong><br />
qualche granchio che io possa aver preso; ma via, parliamo<br />
pure con tutta franchezza; mi troverà sempre remissivo,<br />
quando mi avrà convinto d'aver avuto torto.<br />
2.° Ebbi il 2" fascicolo della <strong>Rivista</strong> il giorno prima <strong>di</strong><br />
lasciare l' Italia, e mi servì da buon <strong>com</strong>pagno <strong>di</strong> viaggio.<br />
Lo lessi da cima a fondo in ferrovia col solito interesse...;<br />
ma fra due punti dello stesso fascicolo, due punti nei quali<br />
l'autore è sempre il medesimo, mi parve notare una certa<br />
contrad<strong>di</strong>zione, ed è <strong>di</strong> questa che mi premeva parlare onde<br />
avere qualche schiarimento.<br />
i.° E sarei io l'accusato?<br />
2.° Ella fece la relazione sulF andamento morale della<br />
Società nell'adunanza del giugno scorso, e la recensione della<br />
nuova Gazette numismatique frangaise porta pure la sua firma.<br />
i.° Ciò è verissimo; ma senza qualche spiegazione....<br />
2.° Nella relazione della Società, ella deplorava <strong>com</strong>e<br />
non si sia ancora trovato chi continuasse l'illustrazione delle<br />
medaglie italiane, iniziata dal Coman<strong>di</strong>ni. Nella citata recen-<br />
sione invece, ella sembra rimproverare la nuova Gazzetta<br />
51
402 FRANCESCO GNECCHI<br />
perchè accoglie fraternamente sotto il medesimo tetto le<br />
monete e le medaglie, aggiungendo che queste ultime non<br />
debbono far parte della <strong>numismatica</strong>, e avrebbe desiderato<br />
che, invece <strong>di</strong> una Gazzetta <strong>numismatica</strong>, fosse sorta una<br />
Gazzetta medaglistica, la quale avrebbe avuto un campo a<br />
se, <strong>com</strong>pletamente libero e <strong>di</strong>fferente da quello <strong>di</strong> tutte le<br />
altre Riviste numismatiche. Ora mi pare che per lo meno ci<br />
siano due pesi e due misure.<br />
i.° La cosa espressa così crudamente <strong>com</strong>e ella ha fatto<br />
presenta certamente gli estremi della contrad<strong>di</strong>zione ; ma mi<br />
pare che in quanto <strong>di</strong>ssi una volta e scrissi l'altra, vi fossero<br />
dei correttivi, <strong>di</strong> cui bisogna tener conto. Parlando della<br />
nuova Gazzetta francese, <strong>di</strong>cevo che la medaglistica era stata<br />
finora accolta sotto le ali della <strong>numismatica</strong> pel solo motivo<br />
<strong>di</strong> non avere un terreno a sé, e che sarebbe perciò stato<br />
a desiderarsi che la nuova Gazzetta si fosse assunta <strong>di</strong> fornire<br />
appunto alla medaglistica questo campo proprio ed esclusivo,<br />
liberando così la Revue <strong>di</strong> un fardello eterogeneo. E questa<br />
rimane sempre la mia opinione. Se poi nella relazione ai Soci<br />
il nostro Consiglio (<strong>di</strong> cui io non ero che lo speaker) invitava<br />
alla continuazione dell'opera <strong>di</strong> Coman<strong>di</strong>ni nella <strong>Rivista</strong>,<br />
aggiungeva però anche il correttivo : " visto che non abbiamo<br />
ancora una <strong>Rivista</strong> speciale de<strong>di</strong>cata alla Medaglistica. „ E<br />
in ciò veramente non mi pare che ci sia contrad<strong>di</strong>zione.<br />
2.° E lasciamo pure la brutta parola. Scopo mio non<br />
era certamente quello <strong>di</strong> volerla cogliere in fallo; ma unicamente<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>scutere sulla maggiore o minore giustizia ed<br />
opportunità delFostracismo che ella vorrebbe, almeno teori-<br />
camente, infliggere alle medaglie. Alcune ragioni sono sommariamente<br />
accennate nella recensione; ma la questione non<br />
è approfon<strong>di</strong>ta.<br />
i.° Approfon<strong>di</strong>amola pure.<br />
2.° Sì, perchè fra la medaglistica e la <strong>numismatica</strong> io<br />
vedo tali e tanti punti <strong>di</strong> contatto, e <strong>di</strong>rò anzi tale parentela,<br />
che mi pare <strong>di</strong>fficile il non tenerne conto, e <strong>di</strong>fficilissimo il<br />
farne una <strong>di</strong>stinzione netta.<br />
i.° Certamente che vi sono punti <strong>di</strong> contatto, ma <strong>com</strong>e<br />
ve n'ha fra la <strong>numismatica</strong> e la storia, fra la <strong>numismatica</strong><br />
e l'archeologia, senza però che queste <strong>scienze</strong>, pure sus-
NUMISMATICA E MEDAGLISTICA 403<br />
si<strong>di</strong>andosi vicendevolmente , abbiano a confondersi l' una<br />
coir altra.<br />
2.° La parentela nel nostro caso speciale mi pare assai<br />
più stretta che non colla storia e coll'archeologia. Sorpas-<br />
sando alla forma esterna, che assimila nel modo più perfetto<br />
i monumenti che costituiscono l'oggetto della <strong>numismatica</strong> e<br />
della medaglistica, noi ve<strong>di</strong>amo <strong>com</strong>e ben sovente siano le<br />
stesse effigie, gli stessi stemmi, le stesse rappresentazioni, le<br />
stesse leggende che figurano sulle monete e sulle medaglie.<br />
Abbiamo <strong>di</strong> più che sovente, anzi il più delle volte, le medaglie<br />
sono coniate nelle zecche, e sono incise dai medesimi<br />
artisti che apprestano i conii delle monete.<br />
i,° Questi sono però sempre caratteri e motivi esteriori<br />
che, similissimi infatti nelle due serie <strong>di</strong> monumenti, hanno<br />
portato la confusione nelle idee; ma quando dai caratteri e<br />
dai motivi esteriori passiamo agli interiori, quando cioè,<br />
lasciando la forma, passiamo alla sostanza, non sarà <strong>di</strong>fficile<br />
scoprire l'abisso che separa le due serie. E, per mettere le<br />
cose a posto, in<strong>com</strong>inciamo, se non le <strong>di</strong>spiace, da una defi-<br />
nizione. Cosa inten<strong>di</strong>amo noi per moneta? Un pezzo <strong>di</strong> metallo<br />
d'oro, d'argento o <strong>di</strong> bronzo, fuso o coniato, in forma gene-<br />
ralmente d'un <strong>di</strong>sco, il quale porta un' impronta che gli con-<br />
ferisce carattere legale per le contrattazioni pubbliche o<br />
private. Questo è il punto interessante, questa è la sostanza,<br />
tutto il resto non è che forma. Ora, ammettendo pure tutte<br />
le somiglianze e le analogie possibili fra le monete e le<br />
medaglie, a queste ultime manca precisamente quel punto<br />
essenziale che costituisce la moneta, il carattere legale per<br />
le contrattazioni. Questo è 1' abisso, che separa 1' una cosa<br />
dall'altra. La Medaglia potrà essere considerata e stu<strong>di</strong>ata<br />
sotto il rapporto artistico, storico, iconografico, politico, so-<br />
ciale; ma non mai sotto l'aspetto economico, il quale per le<br />
monete non solo si aggiunge a tutti quelli citati, ma <strong>di</strong>venta<br />
l'unico in<strong>di</strong>spensabile, e ne forma il to be or not to be.<br />
2° Con queste poche parole ella ha nettamente tracciato<br />
il limite fra l'una cosa e l'altra, non c'è che <strong>di</strong>re; ma riesce<br />
appunto tanto più strano l'ammettere che esso non sia mai<br />
stato avvertito prima d'ora dai <strong>di</strong>rettori delle riviste numi-<br />
smatiche, che accolsero sempre gli stu<strong>di</strong>i <strong>di</strong> medaglistica e,
404 FRANCESCO GNECCHI<br />
dai conservatori <strong>di</strong> musei, i quali furono sempre ben felici <strong>di</strong><br />
accordare la più ampia ospitalità a questi poveri rejetti del<br />
giorno d' oggi.<br />
i.° Crederei <strong>di</strong> fare gran torto agli uni e agli altri<br />
accettando tale supposizione.<br />
2.° Eppure il fatto sussiste.<br />
i.° Ne io lo vorrò negare, solo lo spiego. Furono i<br />
caratteri esteriori, ossia le somiglianze della forma e, ag-<br />
giungiamo anche qualche inesattezza linguistica, che fecero<br />
ammettere in origine le medaglie nei gabinetti numismatici.<br />
L'esservi state collocate ab antiquo, fece sì che per forza<br />
d'inerzia si continuasse a conservarvele, ed anzi si tendesse<br />
continuamente ad accrescerne il numero : ed è così che le<br />
ve<strong>di</strong>amo ammesse dappertutto, <strong>com</strong>e ve<strong>di</strong>amo ammessi in<br />
tutte le riviste numismatiche stu<strong>di</strong>i <strong>di</strong> medaglistica, senza<br />
che i due fatti nulla tolgano alla sostanza della cosa, senza<br />
fare cioè che le medaglie non siano che intruse in quella<br />
che noi definiamo la scienza delle monete.... a meno che vi<br />
si volessero includere anche i bassorilievi, le statue e i mo-<br />
numenti in genere.<br />
2.° Questo poi sarebbe troppo.<br />
i.° Lo so bene, ma non ne sarebbe che una necessaria<br />
conseguenza. Infatti cos' è la medaglia?<br />
2.° Un pezzo <strong>di</strong> metallo monetiforme, fuso o coniato e<br />
destinato a ricordare un personaggio od un fatto.<br />
i.° La definizione non è certo esattissima; quantunque<br />
sia a un <strong>di</strong>presso quella che troviamo nei trattati, nei manuali<br />
o nei vocabolarii. Ma ci sono dei ma e dei se. In primo<br />
luogo, quantunque la parola Medaglia pare tragga la sua<br />
origine da Metallo, non mi pare che 1' essere <strong>di</strong> metallo ne<br />
sia una con<strong>di</strong>zione necessaria, dal momento che non ha per<br />
iscopo <strong>di</strong> servire per gli scambi. La moneta che ha tale<br />
scopo deve essere d'oro, d'argento o <strong>di</strong> bronzo....<br />
2." O <strong>di</strong> nichelio.<br />
i.° Vada anche pel nichelio, e aggiungiamovi pure anche<br />
il platino, se le fa piacere, intendendo tutti quei metalli che<br />
sono ammessi per lo scambio sotto l'egida <strong>di</strong> una pubblica<br />
impronta. Le medaglie, <strong>com</strong>e si possono fare <strong>di</strong> questi me-<br />
talli che chiameremo legali, si possono anche fare <strong>di</strong> piombo,
NUMISMATICA E MEDAGLISTICA 405<br />
<strong>di</strong> Stagno, d'alluminio o <strong>di</strong> qualunque altra lega ; e chi mi<br />
potrebbe proibire <strong>di</strong> farle con qualunque altra materia, per<br />
esempio colla lava del Vesuvio, visto che la materia non ha<br />
alcuna influenza sulla loro essenza, <strong>com</strong>e nessuna ne hanno<br />
il valore intrinseco, il peso o la <strong>di</strong>mensione? Ammesso ciò,<br />
se mi venisse il capriccio <strong>di</strong> fare una medaglia <strong>di</strong> ferro fuso<br />
del <strong>di</strong>ametro <strong>di</strong> un metro e del peso <strong>di</strong> un quintale o <strong>di</strong> una<br />
tonnellata, cesserebbe perciò d'essere una medaglia? No<br />
certamente. E non <strong>di</strong>amo noi il nome <strong>di</strong> medaglione — la<br />
quale parola infine non è che l'amplificativo <strong>di</strong> medaglia —<br />
a un basso rilievo <strong>di</strong> marmo o <strong>di</strong> bronzo che orna un monumento<br />
o alle terre cotte <strong>di</strong> Luca della Robbia, che ornano<br />
l'ospedale degli Innocenti a Firenze?<br />
2.° Adagio, adagio, che forse corriamo troppo. Quello<br />
che noi chiamiamo medaglione e che può essere <strong>di</strong> bronzo,<br />
<strong>di</strong> marmo o <strong>di</strong> terra cotta o <strong>di</strong> qualunque altra materia è<br />
ben <strong>di</strong>stinto dalla medaglia, prima <strong>di</strong> tutto per le <strong>di</strong>mensioni<br />
molto maggiori e poi per avere una sola faccia.<br />
i.° Le <strong>di</strong>mensioni d' una medaglia nessuno le ha mai<br />
determinate; e, quanto alle faccie, è proprio una con<strong>di</strong>zione<br />
necessaria della medaglia quelle d' averne due? Io mi per-<br />
metterei <strong>di</strong> porlo in dubbio.<br />
2.*^ Quando la medaglia, che sta in certe proporzioni, ha<br />
una sola faccia, prende il nome <strong>di</strong> placchetta.<br />
i.° E sta bene che prenda questo nome speciale, e poco<br />
italiano per giunta; ma cessa per questo d'essere una medaglia?<br />
Io crederei <strong>di</strong> no, tanto è vero che <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse me-<br />
daglie furono tirati esemplari col solo dritto e senza rovescio.<br />
In questo caso si tratta, se vogliamo, d' un oggetto o d' un<br />
esemplare in<strong>com</strong>pleto; ma sempre però <strong>di</strong> una medaglia.<br />
2,° Certo che le linee <strong>di</strong> demarcazione qui non si possono<br />
tracciare colla precisione e colla nettezza con cui si è tracciata<br />
quella fra la moneta e la medaglia. Ma, andando <strong>di</strong> questo<br />
passo, un basso rilievo che orna ad esempio la base <strong>di</strong> un<br />
monumento, qualunque ne sia la materia e la forma, cadrebbe<br />
nella categoria delle medaglie o almeno sarebbe un quid<br />
che dalla medaglia nettamente non si <strong>di</strong>stinguerebbe.<br />
i.° Ella segue logicamente il mio ragionamento, e della<br />
giustezza <strong>di</strong> questo, le posso fornire una prova fresca fresca.
406 FRANCESCO GNECCHI<br />
Nel secondo fascicolo della Gazette numismatique, giunto<br />
appena jeri, l'articolo d'onore è de<strong>di</strong>cato al Sig. Roty. Ora<br />
il Sig. Roty, essendo incisore, incise delle medaglie, delle<br />
placchette e degli oggetti artistici, <strong>com</strong>e ad esempio, un<br />
braccialetto. Ella probabilmente si sarebbe accontentata <strong>di</strong><br />
ospitare le medaglie in un perio<strong>di</strong>co numismatico.... Ebbene<br />
alle tavole VII, Vili e X sono riprodotte le placchette, e alla<br />
tavola X fa la sua apparizione anche il braccialetto.... E<br />
<strong>di</strong>fatti, perchè non lo si può considerare una placchetta <strong>com</strong>e<br />
le altre? E se, variate le <strong>di</strong>mensioni, lo stesso bassorilievo<br />
fosse il fregio <strong>di</strong> un camino, quali minori <strong>di</strong>ritti avrebbe alla<br />
sua illustrazione?... In breve, eccoci arrivati senza saperlo e<br />
più presto <strong>di</strong> quanto avrei immaginato, al busto, alla statua,<br />
al monumento..., ed anzi, ora che il braccialetto me ne sug-<br />
gerisce l'idea, <strong>di</strong>co anche: a qualunque oggetto <strong>di</strong> oreficeria<br />
artistica.<br />
2.° Decisamente la Gazzetta ci ha fornito un esempio<br />
pratico <strong>di</strong> quanto mi pareva un volo della sua fantasia. A<br />
me non era mai passato per la mente che alcuno potesse<br />
intendere d'ammettere bassorilievi, statue e monumenti nei<br />
gabinetti numismatici, e le relative illustrazioni nelle nostre<br />
riviste.... ma ormai vedo che ci siamo; e tanto più è neces-<br />
sario quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> porre un argine a tale <strong>di</strong>lagamento. Bisogne-<br />
rebbe trovare una definizione della medaglia, che ne circo-<br />
scrivesse ragionevolmente i limiti entro i quali essa potesse<br />
estendersi, senza degenerare.<br />
i.° È un problema molto <strong>di</strong>fficile; e temo che una defi-<br />
nizione rigorosamente precisa non si possa dare, non poten-<br />
dosi circoscrivere della medaglia che i confini dello scopo,<br />
mentre rimarranno sempre vaghi quelli della forma, della<br />
materia e delle <strong>di</strong>mensioni. — Ma, per arrivarci in qualche<br />
modo, non sarà male farne prima un po' <strong>di</strong> storia, e vedere<br />
cosa veramente la medaglia sia e quale ne sia stata l'origine.<br />
La medaglia era ignota agli antichi, i quali <strong>di</strong>fatti non avevano<br />
neppure la parola corrispondente. Quando la moneta era per<br />
sé stessa <strong>com</strong>memorativa, non si sentiva il bisogno <strong>di</strong> tale<br />
surrogato per <strong>com</strong>memorare persone o avvenimenti. Fu un'in-<br />
venzione me<strong>di</strong>oevale e tutta <strong>italiana</strong>, <strong>com</strong>e lo <strong>di</strong>nota il nome il<br />
quale poi passò in tutte le lingue. La parola medaglia venne
NUMISMATICA E MEDAGLISTICA 407<br />
inventata nel principio del quattrocento e nacque colla cosa<br />
stessa, quando i nostri artisti pittori o scultori inaugurarono<br />
il sistema <strong>di</strong> quei piccoli monumenti metallici che ci conser-<br />
varono nelle più pure forme dell'arte le effìgie <strong>di</strong> tanti perso-<br />
naggi eminenti, e salvarono dall'obblìo anche tanti nomi che<br />
certo senza <strong>di</strong> esse non sarebbero arrivati fino a noi.<br />
2.° Ars saeculorum victrix! E nessuna meraviglia se,<br />
anche nella medaglistica, l'arte operò tali pro<strong>di</strong>gi, <strong>com</strong>e li<br />
operò in tutte le altre sue manifestazioni.<br />
i.° Nessuno oggi conoscerebbe il nome <strong>di</strong> Fedro Inghi-<br />
rami senza il ritratto <strong>di</strong> Raffaello.<br />
2.° Né quello dell'oscuro segretario Marsuppini, senza il<br />
meraviglioso monumento <strong>di</strong> Desiderio da Settignano in Santa<br />
Croce! Fortunato chi si imbatte in un sommo artista!<br />
i.° Dato che sia una fortuna, il trascinare innanzi per<br />
secoli un nome, davanti al quale tutti abbiano a chiedere :<br />
Chi può mai esser stato costui? Per parte mia, francamente,<br />
alla fortuna del ritrovare il sommo artista preferisco l'eterno<br />
oblìo. Ma ritorniamo alle nostre medaglie. La forma più pra-<br />
tica per tali piccoli monumenti fu trovata la circolare, la ma-<br />
teria il metallo. Da qui la loro estrema somiglianza colle<br />
monete. Nel cinquecento, quando 1' arte del rinascimento si<br />
plasmava sulla romana e quasi la riproduceva ingentilendola,<br />
gli artisti trovarono che nella monetazione romana v' erano<br />
splen<strong>di</strong><strong>di</strong> esempii da imitare, e in molte medaglie i busti dei<br />
contemporanei si ornarono del paludamento romano; si fe-<br />
cero anche medaglie rappresentanti imperatori romani ed<br />
auguste, e molti rovesci furono pure più o meno fedelmente<br />
imitati. Si arrivò poi a fare anche delle medaglie riprodu-<br />
centi sesterzii e medaglioni romani, imitazioni a cui forse a<br />
torto noi <strong>di</strong>amo il nome <strong>di</strong> falsificazioni, mentre probabilmente<br />
non erano fatte per mistificare i raccoghtori <strong>com</strong>e si<br />
fece più tar<strong>di</strong> e <strong>com</strong>e si fa al giorno d' oggi, ma per sem-<br />
pHce gusto d'arte. Ciò però portò un nuovo e grande punto<br />
<strong>di</strong> contatto, <strong>di</strong> somiglianza.... e <strong>di</strong> confusione fra le monete e<br />
le medaglie. Le antiche monete erano <strong>di</strong>ventate le medaglie<br />
moderne ; e fu probabilmente allora che per la prima volta<br />
i bronzi romani, e, <strong>di</strong>etro a questi tutte le altre monete antiche,<br />
in<strong>com</strong>inciarono a chiamarsi medaglie, <strong>com</strong>e ve<strong>di</strong>amo
4o8 FRANCESCO GNECCHI<br />
spesso in antiche opere che parlano appunto <strong>di</strong> monete romane<br />
o antiche in genere.<br />
2.° GH italiani si sono poi corretti <strong>di</strong> questa inesattezza,<br />
che invece è restata nella lingua francese, la quale, pure<br />
possedendo la parola monnaie, usa assai piia volontieri l'altra<br />
mcdaille, per esprimere la moneta antica.<br />
i.° Il che prova <strong>com</strong>e, quando si adotta una parola d'altra<br />
lingua, generalmente la si adotta a sproposito. In progresso<br />
<strong>di</strong> tempo l'uso delle medaglie venne generalizzandosi, <strong>di</strong><br />
mano in mano che le monete si facevano meno <strong>com</strong>memorative<br />
; e nulla <strong>di</strong> più naturale che siano così largamente<br />
ammesse nell'uso oggidì che la <strong>com</strong>memorazione fu <strong>com</strong>ple-<br />
tamente abbandonata nelle nostre monete. E vero che anche<br />
oggi non manca qualche esempio <strong>di</strong> monete-medaglie, <strong>com</strong>e<br />
gli scu<strong>di</strong> dei tiri federali svizzeri, e altri pezzi occasionali per<br />
matrimonii principeschi, giubilei o simili avvenimenti; ma ciò<br />
non toglie nulla a quanto s' è detto. La moneta può avere<br />
talvolta carattere <strong>com</strong>memorativo, restando sempre nel più<br />
rigoroso campo numismatico; mentre al contrario la medaglia<br />
n'è sempre assolutamente estranea. Arrivando dunque finalmente<br />
a formulare una definizione della medaglia, e attenendomi<br />
piuttosto alla logica e all'uso che alla stretta precisione —<br />
perchè è troppo <strong>di</strong>fficile precisare ciò che per sé stesso manca<br />
<strong>di</strong> precisione — io <strong>di</strong>rei che la medaglia è " un piccolo monu-<br />
" mento per lo più metallico e generalmente monetiforme, fatto<br />
" a scopo <strong>di</strong> <strong>com</strong>memorare una persona o un avvenimento. „<br />
2.° E io accetto la definizione, tenendo però molto alla<br />
materia metallica e alla forma <strong>di</strong> moneta, appunto <strong>com</strong>e si<br />
intende nell' uso, per escludervi quelle amplificazioni che ci<br />
condussero fino alla statua e al monumento, e per attenerci<br />
il più strettamente possibile a quello che può essere argo-<br />
mento <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o nostro, perchè somigliante alle monete. E,<br />
venendo appunto a questo che le <strong>di</strong>vagazioni quasi ci facevano<br />
perdere <strong>di</strong> vista, se noi abbandoniamo queste povere<br />
medaglie, escludendole dai nostri medaglieri,... o, per essere<br />
più precisi, dai nostri monetieri, chi le raccoglierà? Se agli<br />
stu<strong>di</strong>i ad esse relativi noi chiu<strong>di</strong>amo le porte delle riviste<br />
numismatiche, dove potranno essi venire alla luce del sole,<br />
dal momento che vi sono ancora quelli che vi si interessano?
NUMISMATICA E MEDAGLISTICA 409<br />
1° Eccoci dunque all' opportunismo. Se ne fa tanto in<br />
politica, nulla vieta che possiamo farne un poco anche nella<br />
scienza; e per parte mia, <strong>com</strong>e ebbi già l'onore <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarare,<br />
sono <strong>di</strong>spostissimo ad accettarlo, almeno in via provvisoria,<br />
ed entro limiti piìi stretti <strong>di</strong> quelli della Gazette, pel solo<br />
motivo che per ora i medaglisti o sono troppo pochi o non<br />
sono ancora fra loro organizzati, e anche perchè troppo<br />
limitati sono ancora i cultori della <strong>numismatica</strong> e troppo pochi<br />
i lettori delle nostre riviste.<br />
2.° Pochi ma buoni, <strong>com</strong>e i versi del Torti.<br />
i.° Buoni finché si vuole, ma pochissimi. Così pochi <strong>com</strong>e<br />
ella forse non immagina.<br />
2.° Non aspiro certo al milione <strong>di</strong> lettori del Secolo. Mi<br />
accontento dei soci e degli abbonati.<br />
i.° Che! Denari e santità metà della metà. Per parte<br />
mia non credo <strong>di</strong> errare applicando il proverbio ai nostri<br />
lettori; e, scherzi a parte, non è <strong>di</strong>fficile provare che tale<br />
asserzione non è punto esagerata. Il numero dei soci e degli<br />
abbonati è per sé limitatissimo, sia per la nostra rivista che<br />
per le riviste estere, oscillando fra il 200 e il 300.<br />
2.° Solamente?<br />
i.° Sono pochi infatti; ma del resto è quasi ancora il<br />
caso <strong>di</strong> meravigliarci <strong>com</strong>e, in mezzo al turbinoso trambusto<br />
della vita febbrile che agita il secolo nostro, si trovi ancora<br />
chi si lascia allettare dallo stu<strong>di</strong>o dell'antico; che, per quanto<br />
le nostre sapienti e ingegnose elocubrazioni possano riuscire<br />
a far sprizzare qualche scintilla <strong>di</strong> nuova luce da monumenti<br />
coperti da una polvere venti o trenta volte secolare....<br />
^.^^ .... non riesciranno mai a scoprire il bacillo della peste<br />
bubbonica o il telegrafo senza fili !<br />
i.° E ciò spiega il piccolo numero dei nostri abbonati,<br />
i quali non sono però ancora i nostri lettori. Prima d'arrivare<br />
ai lettori quante falci<strong>di</strong>e è necessario <strong>di</strong> fare, in<strong>com</strong>inciando<br />
da quelli, che non vanno più in là dei frontispizio!<br />
2.^* Queste però non possono essere che eccezioni.<br />
i." E sperabile; ma del resto non é cosa da scandalezzarsene.<br />
Io stesso ricevo regolarmente più <strong>di</strong> un perio<strong>di</strong>co —<br />
non numismatico certamente — il quale non mi rappresenta<br />
che un inutile aumento <strong>di</strong> biblioteca, e <strong>di</strong> cui neppure mi<br />
52
4IO FRANCESCO GNECCHI<br />
curo <strong>di</strong> tagliare i fogli.... E s<strong>com</strong>metterei che ella pure non<br />
avrà potuto evitare qualche imposta sociale <strong>di</strong> questo genere.<br />
Ma, venendo ai lettori, sono ben pochi, fra questi, quelli che<br />
leggono tutto in confronto <strong>di</strong> quelli che si limitano a leggerne<br />
una piccola parte. La nostra scienza si <strong>di</strong>vide in molti rami,<br />
ognuno dei quali forma una specialità.<br />
2.° E quello del resto che avviene <strong>di</strong> ogni scienza a un<br />
certo punto del suo sviluppo. Fatta l'impostatura generale<br />
dell'e<strong>di</strong>ficio, bisogna scendere al <strong>com</strong>pimento dei particolari ;<br />
e air architetto che ha ideato le linee generah succedono i<br />
<strong>di</strong>versi artisti che ne <strong>com</strong>piono le <strong>di</strong>verse parti.<br />
i.° E <strong>com</strong>e un artista non bada che alla sua partita,<br />
non occupandosi del rimanente, così avviene degli specialisti<br />
della scienza.<br />
2.° Non tutti però sono specialisti.<br />
1° Lo sono quasi tutti o <strong>di</strong>ciamo ad<strong>di</strong>rittura tutti, chi<br />
per elezione e chi per forza. In Italia forse più che altrove;<br />
ma anche in tutti gli altri paesi, il maggior contingente degli<br />
scrittori <strong>di</strong> <strong>numismatica</strong> non è portato da persone che <strong>di</strong><br />
essa si occupino ex professo o che siano ufficialmente tito-<br />
late, ma da quelU che della <strong>numismatica</strong> fanno una occupazione<br />
aggradevole la quale viene in seconda linea, dopo<br />
gli affari, dopo l'amministrazione dei proprii beni o dopo<br />
l'adempimento <strong>di</strong> un'altra professione qualunque. A nessuna<br />
altra scienza forse il <strong>di</strong>lettantismo — preso nel buon senso<br />
della parola — porta un contributo così copioso. Gli stu<strong>di</strong>osi<br />
quin<strong>di</strong> non possono de<strong>di</strong>carvi che una porzione più o meno<br />
larga del proprio tempo e della propria intelligenza; e se<br />
vogliono riuscire a <strong>di</strong>re qualche cosa che valga la pena<br />
d'essere detta, non vi possono arrivare che de<strong>di</strong>candosi ad<br />
una specialità.<br />
2.'' Restano però i <strong>di</strong>rettori dei Musei, che non possiamo<br />
mettere in questo numero.<br />
i.** Le persone ufficialmente titolate e per cui la <strong>numismatica</strong><br />
è l'occupazione unica o principalissima, non sono<br />
che pochissime in tutti i paesi : una<br />
sola o forse due in Italia,<br />
dove il <strong>di</strong>rettore d' un gabinetto numismatico è talvolta un<br />
bibliotecario e bene spesso un archeologo, il quale deve<br />
necessariamente occuparsi <strong>di</strong> lapi<strong>di</strong> e <strong>di</strong> scolture antiche, <strong>di</strong>
NUMISMATICA E MEDAGLISTICA 41I<br />
vasi etruschi e <strong>di</strong> mummie egiziane, <strong>di</strong> bassorilievi assiri o<br />
babilonesi e <strong>di</strong> oggetti <strong>di</strong> scavo in genere.<br />
2.° Ma ben <strong>di</strong>versamente da quelli d'Italia sono orga-<br />
nizzati i gran<strong>di</strong> musei dell'estero. Invece <strong>di</strong> molti gabinetti<br />
<strong>di</strong>spersi, tutto è concentrato in uno solo e là v'è una <strong>di</strong>re-<br />
zione <strong>com</strong>posta <strong>di</strong> conservatori i quali non hanno altra cura<br />
all' infuori <strong>di</strong> quella delle monete loro affidate.<br />
i.° E là avviene per elezione quello che qui avviene per<br />
forza; o, se preferisce, anche là è la forza delle cose che<br />
conduce al medesimo risultato. Lo sviluppo della nostra<br />
scienza è giunto a tal punto che ci vorrebbe il cervello d'un<br />
genio per approfon<strong>di</strong>rla nel suo <strong>com</strong>plesso e in tutte le sue<br />
ramificazioni, mentre basta quello d'un uomo d'ingegno per<br />
approfon<strong>di</strong>rne una partita. Ella vedrà <strong>com</strong>e dappertutto in<br />
quei gran<strong>di</strong> centri scientifici, se si raggiunge un risultato<br />
collettivo assai elevato, ciò si deve unicamente alla specia-<br />
lizzazione. Così sono organizzate le <strong>di</strong>rezioni dei Gabinetti<br />
<strong>di</strong> Londra, Vienna, Parigi ed è a questo principio che si<br />
devono le splen<strong>di</strong>de pubblicazioni <strong>di</strong> alcuni fra questi, <strong>com</strong>e<br />
ad esempio quelle del Museo Britannico. Frammezzo a tutti<br />
questi specialisti — vede, lo sono veramente tutti — ammetto<br />
che vi siano alcuni pochi dei più intelligenti e dei più ap-<br />
passionati, i quali, <strong>com</strong>e contorno, <strong>com</strong>e stu<strong>di</strong>o d' ambiente<br />
generale e per le naturali relazioni che i <strong>di</strong>versi rami hanno<br />
fra loro, ricevendo supponiamo, un fascicolo <strong>di</strong> una rivista, lo<br />
leggeranno da capo a fondo, <strong>com</strong>e scorreranno tutte le pubbH-<br />
cazioni numismatiche che vengono alla luce, soffermandosi<br />
solo con maggior agio agli stu<strong>di</strong>i <strong>di</strong> propria pre<strong>di</strong>lezione ; ma<br />
il numero <strong>di</strong> gran lunga maggiore, la quasi totalità è <strong>di</strong> coloro,<br />
i quali, data un'occhiata al sommario.... corrono <strong>di</strong>rettamente<br />
all'articolo che si occupa della loro partita, leggono questo<br />
con più o meno interesse, e non si occupano d'altro, <strong>com</strong>e<br />
<strong>di</strong> roba che esce dal loro campo.<br />
2.*^ A questo modo certamente il numero dei lettori si<br />
va sempre più assottigliando.<br />
i.° In modo spaventoso. E <strong>di</strong>fatti, facendo un <strong>com</strong>puto<br />
approssimativo, io non conosco personalmente più <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci<br />
in<strong>di</strong>vidui che leggano integralmente la nostra <strong>Rivista</strong>, e non<br />
più <strong>di</strong> quin<strong>di</strong>ci che abbiano la bontà <strong>di</strong> leggere i miei articoli....
412 FRANCESCO GNECCHI<br />
<strong>di</strong>co i miei per <strong>di</strong>re quelli attinenti ad una data specialità.<br />
Fanno 25; per esser largo ne voglio aggiungere altri 25,<br />
che non ho il bene <strong>di</strong> conoscere, e sono cinquanta in tutto,<br />
coi quali arriviamo scarsamente a quella famosa metà della<br />
metà.... la quale credo che sia ancora superiore al vero,<br />
perchè mi ricordo d'aver letto in una novella <strong>di</strong> Coppée : On<br />
n'écrit qiie pour vingtcinque personnes, et encorelY. appunto,<br />
nel numero esiguo dei lettori e nell'intento d'aumentarlo,<br />
ammettendovi qualche altro ramo, che si deve ricercare la<br />
ragione principale per cui le riviste numismatiche ne hanno<br />
accolto sotto le proprie ali alcuni affatto estranei <strong>com</strong>e la<br />
medaglistica e talvolta anche la sfragistica o sigillografia, per<br />
la quale, oltre ai motivi addotti parlando delle medaglie, altri<br />
ve ne sarebbero <strong>di</strong> carattere particolare. Ma tutto è questione<br />
<strong>di</strong> tempo. Anche la <strong>numismatica</strong> visse lungamente sotto<br />
r egida dell' archeologia, quasi sua umile ancella, finché,<br />
cresciuto il numero de' suoi cultori, trovò mezzo d' emanciparsi<br />
e <strong>di</strong> stabihrsi <strong>com</strong>e scienza autonoma, con grande<br />
sod<strong>di</strong>sfazione del nostro Ambrosoli. Quando i tempi saranno<br />
maturi, anche alla medaglistica verrà fatto <strong>di</strong> trovarsi una<br />
propria sede; le medaglie emigreranno allora dai gabinetti<br />
numismatici, i medaglieri saranno una cosa <strong>di</strong>stinta dai<br />
monetieri e un perio<strong>di</strong>co medaglistico — quello che io avrei<br />
desiderato che fosse la nuova gazzetta francese — sorgerà<br />
accanto a quelli <strong>di</strong> <strong>numismatica</strong>.<br />
2." E i nostri posteri rideranno <strong>di</strong> noi!<br />
i.° Non rideranno se sapranno portarsi nell'ambiente in<br />
cui viviamo noi, se investigheranno le ragioni che ci hanno<br />
condotti a così fare, e sopratutto se sapranno che noi siamo<br />
i primi a riconoscere che la nostra condotta non è che d'op-<br />
portunità; Video meliora proboque, deteriora sequor. Certamente<br />
essi potranno <strong>di</strong>re: Noi siamo più avanti ! Ma noi<br />
<strong>di</strong>ciamo loro in anticipazione : Guai a chi viene dopo, se non<br />
è più avanti <strong>di</strong> chi l'ha preceduto!<br />
S. Maurizio d'Enga<strong>di</strong>na, Luglio i8gy.<br />
Francesco Gnecchi.
BIBLIOGRAFIA<br />
LIBRI NUOVI E PUBBLICAZIONI.<br />
R. lloivat, Combinaisons secrètes de lettres dans les marques<br />
monétaires de Vempire romain — Revue Numismatique 1897.<br />
Il sig. Mowat <strong>di</strong> Parigi, uno dei pili attivi e più arguti<br />
ricercatori nella <strong>numismatica</strong> romana, ha pubblicato nell'ul-<br />
timo fascicolo della Revue un articolo interessantissimo sulla<br />
<strong>com</strong>binazione segreta delle lettere nelle marche monetarie.<br />
Quelle lettere e quei simboli che per lunghi secoli rimasero,<br />
quali enigmi, chiusi affatto all'interpretazione e a cui per <strong>di</strong>r<br />
vero nessuna importanza <strong>di</strong>edero fino a poco tempo fa gli<br />
eru<strong>di</strong>ti, <strong>com</strong>e piccolezze, che non valeva la pena <strong>di</strong> rilevare,<br />
richiamarono da qualche tempo l'attenzione degli stu<strong>di</strong>osi e<br />
i risultati ne sono sorprendenti. Del lavoro <strong>di</strong> Mowat, che è<br />
il riassunto <strong>di</strong> quanto venne finora scoperto su questo argomento<br />
coir aggiunta <strong>di</strong> quanto scoperse egli stesso, io non<br />
intendo fare una recensione nel senso della parola; ma piut-<br />
tosto dare un sunto che certo potrà interessare chi non ha<br />
letto l'articolo, e l'invoglierà non solo a leggerlo, ma proba-<br />
bilmente anche a continuare le ricerche per proprio conto,<br />
il campo essendo ancora aperto e tutt'altro che esaurito. È<br />
questo uno dei casi che <strong>di</strong>mostra quanto anche le piccole,<br />
le minuscole ricerche possano essere feconde <strong>di</strong> nozioni<br />
storiche, quanto certe minuzie, a primo aspetto inconcludenti,<br />
possano acquistare interesse, giu<strong>di</strong>ziosamente riunite e sagacemente<br />
interpretate, quanto infine la scrupolosa esattezza<br />
sia necessaria in chi descrive una nuova moneta. Quante<br />
cose si saprebbero <strong>di</strong> più e meglio se i vecchi e talora anche<br />
i moderni scrittori fossero stati più esatti e più <strong>com</strong>pleti nelle<br />
loro descrizioni!<br />
Fu A. <strong>di</strong> Longpérier che nel 1886 <strong>di</strong>ede pel primo e
414<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
in<strong>di</strong>rettamente la sveglia a tali ricerche, continuate poi da<br />
Missong, da Kolb e da Mowat.<br />
La questione che Longpérier si propose <strong>di</strong> risolvere era<br />
<strong>di</strong> sapere se le <strong>di</strong>verse officine d' una zecca fabbricassero<br />
in<strong>di</strong>stintamente o no monete pei due Augusti e pei due Cesari<br />
della tetrarchia <strong>di</strong>ocleziana; e, dall'ispezione <strong>di</strong> un me<strong>di</strong>o<br />
bronzo (o foUis) <strong>com</strong>unissimo della zecca <strong>di</strong> Cartagine e <strong>di</strong><br />
un altro pure <strong>com</strong>unissimo della zecca <strong>di</strong> Roma, trovò che<br />
in ambedue la i^ officina coniava pel primo Augusto, la 2*<br />
pel secondo Augusto, la 3"^ pel primo Cesare, la 4^ pel secondo<br />
Cesare. Il bronzo scelto della zecca <strong>di</strong> Cartagine è quello<br />
che porta il rovescio dell'Africa colla leggenda: SALVIS AVGG<br />
ET CÀESS FEL KART. Le quattro officine <strong>di</strong> Cartagine sono<br />
contrad<strong>di</strong>stinte dalle lettere greche A B f A. Ora i bronzi<br />
<strong>di</strong> Diocleziano (1° Augusto) portano air esergo A (prima<br />
officina), quelli <strong>di</strong> Massimiano Erculeo (2° Augusto) B (seconda<br />
officina), quelH <strong>di</strong> Costanzo Cloro (i° Cesare) r (terza officina)<br />
e finalmente quelli <strong>di</strong> Galeno Massimiano (2° Cesare) A<br />
(quarta officina).<br />
Lo stesso avviene per le officine della zecca <strong>di</strong> Roma,<br />
le quali sono contrad<strong>di</strong>stinte dalle lettere romane P (prima)<br />
S (seconda) T (tertia) Q (quarta), talvolta precedute dalla<br />
lettera R in<strong>di</strong>cante Roma. Il bronzo scelto è quello dal ro-<br />
vescio: SACRA MON VRB AVGG ET CAESS NN, il quale ha<br />
i seguenti eserghi pei quattro regnanti:<br />
Diocleziano RP oppure P fulmine oppure R mezzaluna P<br />
Massimiano RS „ S clava „ R „ S<br />
Cloro RT „ T clava ,, R „ T<br />
Galerio RQ „ Q fulmine ,, R „ Q(0<br />
(i) A proposito <strong>di</strong> questo specchietto mi permetterò <strong>di</strong> correggere<br />
una trasposizione che è occorsa nell'Articolo originale (V. Revue Franfaise,<br />
pag. 71) dove è stampato : P foudre<br />
S massue<br />
T foudre<br />
Q massue<br />
e invece va rettificato, in base alle risultanze <strong>di</strong> quanto è detto prece-<br />
dentemente: P foudre<br />
S massue<br />
T massue<br />
Q foudre<br />
<strong>com</strong>e è qui sopra esposto.<br />
I
BIBLIOGRAFIA 415<br />
Anche qui le officine sono <strong>di</strong>stribuite <strong>com</strong>e a Cartagine,<br />
e il fulmine e la clava sono i simboli <strong>di</strong> Giove e <strong>di</strong> Ercole.<br />
Ora è noto che Diocleziano s'intitolava Giovio (lOVIVS), <strong>com</strong>e<br />
il suo Cesare, Galeno e Massimiano Erculeo (HERCVLIVS)<br />
<strong>com</strong>e il suo Cesare Costanzo Cloro.<br />
Con ciò Longpérier, senz' avvedersene, apriva la que-<br />
stione delle lettere segrete, che veniva stu<strong>di</strong>ata da altri<br />
eru<strong>di</strong>ti. Kolb, passando dalle lettere che si trovano all'esergo<br />
a quelle che occupano il campo della moneta, trovò che sui<br />
medesimi bronzi stu<strong>di</strong>ati da Longpérier, a sinistra del campo<br />
nel rovescio, si trovano talvolta le lettere H o I. Nessuno<br />
vi aveva fatto attenzione fino allora; ma egli osservò che<br />
la lettera H si trova sui bronzi <strong>di</strong> Massimiano e <strong>di</strong> Costanzo,<br />
la lettera I su quelle <strong>di</strong> Diocleziano e <strong>di</strong> Galeno. Evidentemente<br />
dunque le due lettere dovevano significare HERCVLIVS<br />
e lOVIVS, rimpiazzando i simboH della clava e del fulmine.<br />
Lo stesso Kolb, stu<strong>di</strong>ando dei piccoli bronzi (o antoni-<br />
niani) degli stessi tetrarchi e precisamente quelli colla leg-<br />
genda CONSERVÀTOR ÀVGG, <strong>di</strong> Diocleziano e Massimiano,<br />
coniati probabilmente a Ser<strong>di</strong>ca o a Siscia, trovò che le tre<br />
officine <strong>di</strong> quella zecca contrassegnano le loro monete nella<br />
seguente curiosa maniera: pei bronzi <strong>di</strong> Diocleziano<br />
la prima officina (A) ha la lettera |<br />
la seconda „ (B) „ „ O<br />
la terza „ (P) ha le lettere Bl<br />
che riunite danno lOBI. Per quelle <strong>di</strong> Massimiano:<br />
la prima officina (A) ha le lettere HP<br />
la seconda „ (B) „ „ KOY<br />
la terza „ (D „ „ Al<br />
che riunite danno HPKOYAI ossia i due appellativi <strong>di</strong> lOVI<br />
e HERCVLI, scritti alla foggia greca. Questa era indubbiamente<br />
una <strong>com</strong>binazione segreta <strong>di</strong> zecca e la parola <strong>di</strong> passo non<br />
poteva <strong>com</strong>pletarsi che riunendo le tre varietà d'una mede-<br />
sima moneta.<br />
Il Dott. Missong, il grande specialista delle monete <strong>di</strong><br />
Probo, classificando le monete delle sei officine <strong>di</strong> Tarragona<br />
e delle sette <strong>di</strong> Roma, trova la chiave <strong>di</strong> alcune lettere<br />
isolate che si trovano nel campo e ne forma la parola EQVITI<br />
o AEQVITI, scoprendo che le lettere sono collocate nell'or<strong>di</strong>ne
4l6 BIBLIOGRAFIA<br />
delle officine, ossia p. es. in quelle <strong>di</strong> Roma le monete della<br />
prima officina hanno nel campo la lettera A, quelle della<br />
seconda E, della terza Q e così via. Assai probabilmente<br />
Equitius o Aequitius era uno dei nomi dell'imperatore Probo,<br />
finora sconosciuto.<br />
Ed ora veniamo a quanto aggiunge il Mowat in questo<br />
campo <strong>di</strong> scoperte. Dopo d'aver confermata quella che <strong>di</strong>remo<br />
la legge <strong>di</strong> Longpérier con altre monete dei Tetrarchi, si<br />
ferma alle lettere HER e SEF che si incontrano sui me<strong>di</strong>i<br />
bronzi <strong>di</strong> Massimiano, Massenzio e Costantino portanti la<br />
leggenda CONSERVATOR AFRICAE SVAE. Queste non sono<br />
a serie <strong>com</strong>e le precedenti, ma si trovano l'una o l'altra su<br />
<strong>di</strong>versi esemplari della medesima moneta; alcune monete cioè<br />
portano la prima, altre simili la seconda. L'interpretazione<br />
della prfma è facile, HER, significa evidentemente HERCVLIVS,<br />
r altra offre maggiore <strong>di</strong>fficoltà. Potrebbero leggersi per<br />
SE(nioris) F(ortissimi); ma, tale interpretazione non potrebbe<br />
adattarsi che a Massimiano; ricordando invece la frase Ini-<br />
peratores semper Herculii del panegirista anonimo <strong>di</strong> Massimiano<br />
e <strong>di</strong> Costantino, le due sigle accoppiate si possono<br />
assai verosimilmente interpretare per HER(culii) SE(mper)<br />
F(elicissimi). I bronzi che portano queste lettere nel campo<br />
sono estremamente rari.<br />
L'autore volge poi il suo stu<strong>di</strong>o ai me<strong>di</strong>i bronzi <strong>di</strong> Co-<br />
stanzo II e <strong>di</strong> Costanzo Gallo che offrono la leggenda FEL<br />
TEMP REPARATIO seguita dalla cifra LXXII, cifra che si trova<br />
pure su alcuni soli<strong>di</strong> <strong>di</strong> Costantino Magno, Costanzo II e<br />
Costante, L'interpretazione della cifra LXXII (che sui denari<br />
d'oro ha assai probabilmente e, <strong>di</strong>remo quasi con certezza,<br />
il significato <strong>di</strong> valore, ossia la 72-^ parte d'una libbra romana),<br />
riesce assai <strong>di</strong>fficile pel bronzo, tanto piij che ivi è scritta<br />
non in linea orizzontale <strong>com</strong>e sull'oro, ma sotto la leggenda<br />
circolarmente e concentrica a questa.<br />
Il Sig. Mowat offre una nuova interpretazione, che ora<br />
vedremo, la quale viene in qualche modo a collegarsi con<br />
tre segni segreti che occupano il centro <strong>di</strong> questi bronzi.<br />
Alcuni <strong>di</strong> questi, e precisamente quelli della zecca d'Aquileja,<br />
hanno nella parte centrale un piccolo monogramma <strong>di</strong> Cristo,<br />
altri hanno un S, altri infine una corona. Disponendo questi
BIBLIOGRAFIA 4I7<br />
tre segni, nell'or<strong>di</strong>ne: monogramma, S, corona, e leggendo:<br />
Chr(isti) S(igno) Corona, l'autore vi vede il famoso motto <strong>di</strong><br />
Costantino HOC SIG-NO VINCES. E la interpretazione è validamente<br />
appoggiata dai fatti. Giova ricordare, chi volesse<br />
obbiettare che la visione <strong>di</strong> Costantino era anteriore <strong>di</strong><br />
quarant'anni, che la tra<strong>di</strong>zione racconta (Chronicon paschale)<br />
che l'anno 351 il giorno <strong>di</strong> Pentecoste una croce splendente<br />
apparve nel cielo a Gerusalemme, la quale fu vista anche in<br />
Pannonia da Costanzo II <strong>com</strong>battente contro Magnenzio sotto<br />
le mura <strong>di</strong> Mursa. Difatti la zecca <strong>di</strong> Siscia in Pannonia, sulle<br />
monete <strong>di</strong> Costanzo II, pose per la prima volta la leggenda<br />
HOC SIGNO VICTOR ERIS, mentre quella d'Aquileja s'accon-<br />
tentò d' accennare simbolicamente allo stesso fatto coi tre<br />
segni descritti. Bisogna confessare che la trovata è elegante<br />
ed ingegnosa.<br />
Quanto alla cifra LXXII, scartando l' idea <strong>di</strong> Sabatier<br />
ch'essa potesse in<strong>di</strong>care il peso <strong>com</strong>e sull'oro, l'autore,<br />
calcolando che dalla morte <strong>di</strong> Probo, (a. 282) a quella <strong>di</strong><br />
Magnenzio (a. 354) corrono appunto 72 anni, nei quali l'impero<br />
aveva sempre sofferto per le <strong>di</strong>visioni fra <strong>di</strong>versi augusti<br />
associati o rivali, e che la leggenda FEL TEMP REPARATIO<br />
accenna appunto a un ritorno del benessere pubblico rista-<br />
bilito col ristabilimento della monarchia, non sarebbe alieno<br />
dall' interpretarla appunto <strong>com</strong>e una data o per <strong>di</strong>r meglio<br />
il numero dei 70 anni, ed è perciò che considera questo<br />
numero LXXII <strong>com</strong>e faciente seguito alla leggenda.<br />
Se non possiamo accettare la cosa <strong>com</strong>e un fatto provato,<br />
accettiamolo almeno <strong>com</strong>e un ipotesi probabile.<br />
L'esposizione sommaria che ho fatta delle <strong>di</strong>verse inge-<br />
gnose interpretazioni, dovrebbe certamente incoraggiare i<br />
giovani stu<strong>di</strong>osi a proseguire tali ricerche, tanto più che<br />
nell'epoca cui ci riferiamo il materiale è abbondantissimo, e,<br />
salvo eccezioni, facile a procurarsi.<br />
Promontogno, luglio 189J.<br />
Francesco Gnecchi.<br />
53
4l8 BIBLIOGRAFIA<br />
Les Origines de la Monnaie consideréés au point de vue economique<br />
et historique p. M. Ernest Babelon Paris. Firmin Didot 1897.<br />
La scienza Numismatica ha sempre o quasi sempre avuto<br />
il torto <strong>di</strong> chiudersi in una specie d'esclusivismo, staccandosi<br />
dalla economia, colla quale invece è così intimamente colle-<br />
gata da riuscire senza <strong>di</strong> essa sterile e da perdere buona<br />
parte del suo interesse. E forse anzi questa una delle ragioni<br />
per cui da molti la <strong>numismatica</strong> viene considerata leggermente<br />
quale semplice curiosità, o <strong>di</strong>sconosciuta <strong>com</strong>e scienza<br />
o per lo meno valutata quale scienza secondaria, che non viene<br />
se non in seguito alla storia, all'archeologia e all'economia.<br />
I nostri vecchi autori, e parlo specialmente dei nostri<br />
italiani, ebbero sempre <strong>di</strong> mira la parte economica, anzi<br />
presso <strong>di</strong> loro questa ha generalmente il sopravvento. Col<br />
progresso del tempo invece, la parte economica, stu<strong>di</strong>ata a<br />
parte, da quelH che appunto si intitolano economisti, e che<br />
non esistevano in passato, venne sempre più trascurata dagli<br />
stu<strong>di</strong>osi <strong>di</strong> <strong>numismatica</strong>. Conseguenza <strong>di</strong> ciò fu che molte fra<br />
le opere numismatiche recenti risultarono monche e quin<strong>di</strong><br />
inefficaci, e da qui il <strong>di</strong>scre<strong>di</strong>to venuto alla nostra scienza.<br />
È allo scopo <strong>di</strong> mettere in evidenza gli stretti legami che<br />
corrono fra la <strong>numismatica</strong> e l' economia pubblica che il<br />
Sig. Babelon scrisse il suo recente volume " Les origines<br />
de la Monnaie „ onde persuadere i numismatici ad approfon-<br />
<strong>di</strong>rsi nell'economia e gli economisti a fare altrettanto colla<br />
<strong>numismatica</strong>. E dunque ad ambedue queste categorie <strong>di</strong><br />
stu<strong>di</strong>osi che il libro è de<strong>di</strong>cato. Tutti ne possono trarre<br />
profitto e a tutti si può rac<strong>com</strong>andarlo <strong>com</strong>e una lettura utile<br />
e nello stesso tempo facile e piacevole. Prendendo le mosse<br />
dal principio delle umane società ossia dai primi scambi, che<br />
ne sono uno dei necessarii elementi, 1' autore passa in ras-<br />
segna i primi rappresentativi del valore, venendo gradatamente<br />
alle forme meno imperfette del cambio coli' interme-<br />
<strong>di</strong>ario dei metalli, per giungere infine alla vera moneta, e<br />
questo fa oltre che per molti dei popoli antichi, gli Egizii,<br />
gli Assiri, i Greci, gli Italioti e così via, per alcuni dei popoli<br />
moderni che ancora si trovano neh' infanzia della civiltà. I
BIBLIOGRAFIA 4I9<br />
medesimi fenomeni si ripetono sempre, <strong>di</strong>mostrando che essi<br />
sono insiti nella natura delle cose e che, <strong>com</strong>e <strong>di</strong>ce il nostro<br />
proverbio, tutto il mondo è paese, e il vecchio proverbio<br />
romano: nil sub sole novi.<br />
L'autore <strong>di</strong>ce poi molte cose interessantissime circa<br />
l'abbondanza e i rapporti dei metalli nei <strong>di</strong>versi paesi e nelle<br />
<strong>di</strong>verse epoche, circa le miniere nell'antichità, circa il mono-<br />
metallismo e il bimetallismo e circa molte altre questioni<br />
che qui è inutile enumerare; ma per le quali chi si interessa<br />
all' argomento troverà un alimento sano e ben preparato<br />
neir eccellente libro del Sig. Babelon, il quale ebbe anche<br />
la felice idea <strong>di</strong> non voler dare alla scienza la veste pomposa<br />
e in<strong>com</strong>o<strong>di</strong>ssima <strong>di</strong> un formato in 4° <strong>com</strong>e fanno la più parte<br />
— e <strong>com</strong>e pur troppo fece anche chi sta lanciando la pietra....<br />
— ma <strong>di</strong> ammanirla modestamente nel formato più <strong>com</strong>odo<br />
<strong>di</strong> tutti i libri <strong>di</strong> lettura.<br />
F. G.
VARIETÀ<br />
Furto al Gabinetto Numismatico <strong>di</strong> Losanna. —<br />
Togliamo dalla Gazzeita <strong>di</strong> Losanna le seguenti notizie<br />
relative al gravissimo furto perpetrato il i° Agosto alla<br />
insigne collezione <strong>di</strong> Losanna, formata con tanta cura e tanta<br />
scienza dal <strong>com</strong>pianto Morel-Fatio.<br />
" I ladri dovevano avere perfetta conoscenza dei luoghi,<br />
ch'essi avevano certamente stu<strong>di</strong>ati a loro agio. Il modo con<br />
cui essi procedettero <strong>di</strong>mostra un piano accuratamente stu-<br />
<strong>di</strong>ato in anticipazione. Essi hanno dovuto penetrare pei locali<br />
superiori dell'e<strong>di</strong>ficio del Museo. Nulla era più facile. Alcuni<br />
operai vi lavorano da parecchi giorni a stabilirvi un deposito<br />
<strong>di</strong> duplicati per la biblioteca cantonale. Le porte erano quin<strong>di</strong><br />
aperte e l'an<strong>di</strong>rivieni <strong>di</strong> persone in abito d'operaio non doveva<br />
destare alcun sospetto. I solai sono vastissimi e pieni <strong>di</strong> risvolti<br />
e <strong>di</strong> nascon<strong>di</strong>gh. I ladri vi si sono nascosti durante la giornata<br />
e quando giu<strong>di</strong>carono che non c'era più nulla a temere, si<br />
posero all'opera. Penetrando per la canna <strong>di</strong> un camino —<br />
un camino largo e grande <strong>com</strong>e si usavano una volta —<br />
<strong>di</strong>scesero, sfondando una tela, nello stu<strong>di</strong>o del Sig. de Molin<br />
conservatore del Gabinetto. Il medagliere è nella stanza<br />
attigua. Essi fecero man bassa su quanto loro parve più<br />
prezioso, senza <strong>di</strong>menticare un piccolo cassetto portante la<br />
scritta " pezzi rari „ e poi se ne andarono per la medesima<br />
strada. Dai solai arrivarono alla torretta della biblioteca da<br />
dove <strong>di</strong>scesero a mezzo <strong>di</strong> una corda e presero il largo.<br />
L'inchiesta imme<strong>di</strong>atamente aperta dal giu<strong>di</strong>ce istruttore non<br />
ha dato finora alcun risultato sod<strong>di</strong>sfacente; ma molte persone<br />
furono già interrogate, e furono fatti parecchi arresti. Pro-<br />
babilmente si ha a che fare con operai che in epoca non<br />
lontana ebbero parte ai lavori nell'e<strong>di</strong>ficio del Museo,
432 VARIETÀ<br />
Furto al Gabinetto numismatico <strong>di</strong> Nìmes. — Da<br />
un giornale <strong>di</strong> Marsiglia togliamo i seguenti particolari sul<br />
furto al Gabinetto numismatico <strong>di</strong> Nimes, furto che fortunatamente<br />
non ebbe le <strong>di</strong>sastrose conseguenze <strong>di</strong> quello <strong>di</strong> Losanna.<br />
" 1 ladri penetrarono nella sala del Gabinetto dall'alto<br />
<strong>di</strong> una finestra, e una volta entrati, apersero tutte le vetrine<br />
e collocarono quanto poterono in due sacchi, lasciando però<br />
ancora molte monete e fra queste alcune rarissime — ciò<br />
che <strong>di</strong>mostra la loro poca intelligenza in materia — sparse<br />
sul pavimento. Verso le 5 del mattino alcuni passanti videro<br />
due persone scendere per una scala <strong>di</strong> corda, portando due<br />
sacchi; ma li presero per operai e non ne fecero caso. Fu<br />
invece assai sorpreso il custode del museo, quando poco<br />
dopo, recandosi al suo ufficio vide la scala <strong>di</strong> corda appesa<br />
alla finestra del museo. Chiese ai vicini e seppe che due<br />
in<strong>di</strong>vidui con due pesanti sacchi s'erano visti andare in <strong>di</strong>re-<br />
zione della Fontana. — La polizia tosto avvisata si mise in<br />
moto in quella <strong>di</strong>rezione e, seguendo le <strong>di</strong>verse in<strong>di</strong>cazioni,<br />
giunse a un terreno che sembrava appena smosso, e <strong>di</strong>fatti,<br />
dopo d'aver levato alcuni ciottoli trovarono i due sacchi ivi<br />
nascosti e contenenti tutte le monete rubate. „<br />
Il Museo <strong>di</strong> Nìmes dunque può essere felice questa volta<br />
d'essersela cavata con un semplice spavento e col <strong>di</strong>sturbo<br />
pel suo <strong>di</strong>rettore <strong>di</strong> una nuova classificazione delle sue serie<br />
numismatiche, ed è sperabile che l'incidente abbia a consi-<br />
gliare una più accurata sorveglianza per l'avvenire.<br />
Finito <strong>di</strong> stampare il 6 ottobre 1897.<br />
Scotti Reno, Gerente responsabile.<br />
La Direzione.
u<br />
RIVISTA ITAITANA DI NUMISMATICA<br />
'-9<br />
16 i8 17<br />
E. Gabrici LA CRONOLOGIA DELLE MONETE DI NERONE<br />
A^<br />
15<br />
Tav. 1.
RIVISTA ITALIANA DI NUMISMATICA<br />
17<br />
14<br />
rft\<br />
16<br />
ìA nRni^ninniA nniF uonfte ni Nerone<br />
15<br />
18<br />
13<br />
Tav. 11.
14<br />
RIVISTA ITALIANA DI NUMISMATICA<br />
E. Gahrici LA CRONOLOGIA DELLE MONETE DI NERONE<br />
13<br />
Tav. Ili,
.S97.<br />
RIVISTA ITALIANA DI NUMISMATICA<br />
:-i: .^<br />
^1<br />
:M' ''Mi ""'^<br />
^^'4^:<br />
i\ '^'^B<br />
mm ^^k<br />
E. GAnKici L\ CRONOLOGIA DELLE MONETE DI NERONE<br />
13<br />
Tav.
Anno 1897.<br />
.11. M. KASSAXl - MILANO.<br />
RIVISTA ITALIANA DI NUMISMATICA<br />
.,11<br />
#<br />
€>"#<br />
:^-<strong>di</strong><br />
U^<br />
A/yO/O CONTRIBUTO ALLA NUMISMATICA PADOVANA<br />
Luigi Rizzoli, Junior.<br />
Tav. VI.
FASCICOLO IV
LA ZECCA DI BOLOGNA<br />
AVVERTENZA.<br />
La zecca <strong>di</strong> Bologna, che conta sei secoli e mezzo <strong>di</strong><br />
vita e una produzione <strong>di</strong> oltre 1170 tipi <strong>di</strong> monete, non trovò<br />
fin qui chi si addossasse il pesante incarico <strong>di</strong> illustrarne,<br />
con un lavoro <strong>com</strong>pleto, la storia ed i prodotti. Solo vi si<br />
era accinto, sullo scorcio del secolo passato, Guidantonio<br />
Zanetti, l'illustratore delle monete italiane, con un' opera<br />
rimasta in<strong>com</strong>pleta fin dal principio, ma che, se continuata<br />
collo stesso metodo (e gli stu<strong>di</strong> del tempo se ne accontenta-<br />
vano) non avrebbe corrisposto alle giuste esigenze dell'oggi.<br />
L' illustrazione che presentiamo ai numismatici è fatta<br />
sulla guida dei moltissimi documenti che offrivano gli Archivi<br />
bolognesi e sull'esame dei medaglieri: dei primi, tutta la serie<br />
dei contratti <strong>di</strong> locazione dell'officina, dei patti cogli incisori<br />
dei conii, delle gride, dei decreti, delle lettere dell'ambascia-<br />
tore bolognese in Roma agli Assunti <strong>di</strong> Zecca. Gli stu<strong>di</strong>osi<br />
d'arte vi troveranno abbondanti notizie sugli incisori delle<br />
impronte, tra i quali il PVancia, il Magnani, il Menganti, i<br />
Provagli e su parecchie medaglie bolognesi, <strong>di</strong> cui non si<br />
conoscevan gh autori. Abbiamo cercato, vista la vastità<br />
dell'argomento, <strong>di</strong> essere chiari e concisi, anche nella forma,<br />
per non stancare il lettore. Perciò citeremo nel contesto del<br />
nostro scritto i soli documenti pili importanti limitandoci a<br />
riportare per intero nella parte seconda quelli più notevoli<br />
e che non potrebbero esser trascritti nella prima parte. Nella<br />
terza saranno descritti tutti i tipi e le varianti che ci fu dato<br />
conoscere delle monete bolognesi, or<strong>di</strong>nate secondo consi-
428<br />
FRANCESCO MALAGUZZI<br />
gliavano i documenti. Questa parte del nostro lavoro ci è<br />
stata grandemente facilitata per la cortese cooperazione del<br />
sig. cav. prof. Costantino Luppi che mise a nostra <strong>di</strong>sposi-<br />
zione le descrizioni delle monete e<strong>di</strong>te nelle <strong>di</strong>verse opere<br />
a stampa e che ringraziamo pubblicamente. Aiuto e <strong>com</strong>u-<br />
nicazioni <strong>di</strong> monete ine<strong>di</strong>te e <strong>di</strong> varianti ebbimo da <strong>di</strong>rettori<br />
<strong>di</strong> medaglieri pubblici e da raccoglitori privati, quali i si-<br />
gnori Francesco ed Ercole Gnecchi, prof. Edoardo Brizio,<br />
dott. Luigi Frati, prof. Solone Ambrosoli, dott. Arsenio<br />
Crespellani, prof. Carlo Malagola, ai quali ci professiamo<br />
gratissimi.<br />
Ci lusinghiamo <strong>di</strong> aver reso, colla presente monografia,<br />
un servigio alla scienza <strong>numismatica</strong>, colmando la lacuna<br />
forse pili grande che si lamentasse nella serie delle illustra-<br />
zioni delle zecche italiane, che tanta parte sono della nostra<br />
storia politica e artistica, e, in considerazione della <strong>di</strong>fficoltà<br />
e vastità dell'argomento, chie<strong>di</strong>amo venia per le mende nelle<br />
quah fossimo involontariamente incorsi.<br />
Bologna, Marzo 189J.<br />
F. Malaguzzi.
BIBLIOGRAFIA<br />
DELLA ZECCA E DELLA STORIA BOLOGNESE.<br />
Argelati Filippo. Ad<strong>di</strong>tiones ad nummos variarum Italiae urbium<br />
(De Monetis Italiae, etc. Tav. IX, i, 2, 6, 7 e 8).<br />
Beeldenaer of te figuer hook <strong>di</strong>enende op te nieuve ordonnantie<br />
vander munte, etc. Graven Saghe, 1608; in-4, pag. 21, 22, 25, io, 9 e 12.<br />
Bellini Vincenzo. De Monetis Italiae me<strong>di</strong>i aevi. Ferrara, 1775;<br />
in-4. Dissertatio I, pag. 8-15, n. 1-14; Diss. II, pag. 18, 26, n. 1-30; Diss.<br />
Ili, pag. 14-18, tav. Ili, I-IO e tav. IV n. 11-14; Diss. IV, pag. 16-19,<br />
tav. II, 9-12, e tav. Ili, n. i.<br />
pag. 115.<br />
n. 2 e pag. 115.<br />
Dell'antica lira ferrarese. Ferrara, 1750; in-4, pag. 16, n. i e 2;<br />
Della moneta <strong>di</strong> Ferrara. Ferrara, 1761; in-4, P^g- fo; pag- 16,<br />
Benaven Jean Michel. Le caissier italien. Lyon, 1787^ in-fol.;<br />
Voi. II, tav. XXXII-XLI.<br />
Berg. New milntz bueck. Miinchen, 1597; in-fol. Fol. LVIII.<br />
Billon d'aur et d'argent et de plusieurs royaumes, ducés. contés,<br />
seigneuries, pays et ville. Gand, 1552; in-12, pag. 34, 176, 39, 28, 41.<br />
Biondelli Bernar<strong>di</strong>no. Dichiarazione <strong>di</strong> sessantatre monete pon-<br />
tificie ine<strong>di</strong>te del R. Gabinetto numismatico <strong>di</strong> Milano. Milano, 1884;<br />
in-8, pag. IO-I2, n. 42-49.<br />
Boneville B. F. Traité des monnaies d'or et d'argent. Paris, 1806;<br />
in-fol., pag. 108, tav. I-III.<br />
Borghesi Bartolomeo. Primo Catalogo del Museo Bartolomeo<br />
Borghesi. Monete italiane. Roma, 1879; in-8 (autonoma d'oro: tav. I,<br />
203, dal CinagU erroneamente attribuito a Martino V).<br />
Bo8Ì O. Notizie documentali intorno la venuta e permanenza in<br />
Bologna dei Sommi Pontefici dall'anno 311 a' dì nostri raccolte e desunte<br />
da autorevoli cronache e documenti. Bologna, 1857; in-8.<br />
Archivio patrio <strong>di</strong> antiche e moderne rimembranze Felsinee<br />
da autentici ed originali documenti. Bologna, 1885; in-4 fol.<br />
Archivio patrio <strong>di</strong> antiche e moderne rimembranze Felsinee.<br />
Bologna, 1859; Tomi IV, in-8.<br />
Bruti Alessandro. Monete ine<strong>di</strong>te dei Romani Pontefici. {Bull,<br />
<strong>di</strong> num. it., An. IV, n. 6, pag. 43.48; n. 34, 41, 42, 46, 51, 56).<br />
Caire Pietro. Di una moneta <strong>di</strong> Pisa ed altra <strong>di</strong> Bologna trovata<br />
presso Novara in giugno 1873. Novara, in-8 fig.
43©<br />
FRANCESCO MALAGUZZI<br />
Capitoli Stabiliti col zecchiere Carlo degli Angeli per battere monete<br />
d' oro et d' argento et quattrini <strong>di</strong> rame schietto. X <strong>di</strong>e. 1613. (Nella<br />
Misceli. Ms. bologn., tom. VI, ce. 120 — Bibl. Cora, <strong>di</strong> Bologna).<br />
La medesima opera. Bologna, 1840; in-4.<br />
Capo Tommaso. Catalogo delle monete greche, romane, primitive,<br />
ecc., italiane, me<strong>di</strong>oevali e moderne possedute dal Dott. Tommaso<br />
Capo. Roma, 1891; in-4, P^g- 1^> ^' 808; tav. V, 22.<br />
Carli-Rubbi. Delle monete e dell'istituzione delle zecche in Italia.<br />
Mantova, 1754; Tomo i, tav. Ili, i, 2.<br />
Dell'origine e del <strong>com</strong>mercio della moneta. All'-ffo/a, 1751; in-4,<br />
pag. 193-195» tav. II, 6.<br />
Dell'origine e del <strong>com</strong>mercio della moneta e dell'istituzione<br />
delle zecche d' Italia dalla decadenza dell' Impero sino al secolo decimosettimo.<br />
All'Haja, 1751; in-4, pag- i93-<br />
Carte ou liste contenant le prix de chacun marq, once, esterlin et<br />
as etc. selon l'ordonnance de mars 1627, etc. Anvers, 1627; in-4, P^g- 25,<br />
28, 63, 206, 31, 63, 62.<br />
Catalogo <strong>di</strong> varie monete d'Italia (già possedute da Guido Zanetti,<br />
poste in ven<strong>di</strong>ta). Bologna^ i793; in-8, pag. 15.<br />
Cavedoni Celestino. Ragguaglio storico del ritrovamento <strong>di</strong> un<br />
ripostino <strong>di</strong> monete d' argento dei bassi tempi fatto a Rosola nella<br />
montagna modenese l'anno MDCCXLI. Modena, 1860; in-4, pag. 7-10 (Descrizione<br />
<strong>di</strong> 1042 monete, con grande varietà <strong>di</strong> piccoli segni accessorii).<br />
Cinagli Angelo. Le monete de' Papi descritte in tavole sinottiche.<br />
Fermo, 1848; in-fol. con 4 tav.<br />
Collezione <strong>di</strong> tavole monetarie <strong>di</strong> tutte le monete nobili, che servono<br />
attualmente al <strong>com</strong>mercio, coniate nelle principali zecche dell' Europa,<br />
dell'Asia, della Barbarla, etc. Venezia, 1796; in-fol. (Ve<strong>di</strong>: Bologna).<br />
Coopliede handboucxkin. Gand, 1546; in-12, pag. 7, 158, 28, 25, 972,<br />
17, 95-<br />
Damoreau. Traité des négociacions de banque et des monnaies<br />
étrangères. Paris, 1727; in-fol., tav. I, pag. 162, n. a.<br />
Darier Hugues. Tableau du titre, poids et valeur des <strong>di</strong>fferéntes<br />
monnaies d' or et d' argent, qui circulent dans le <strong>com</strong>merce, avec em-<br />
preintes. Genève, 1807; in-4, tav. XLIX, i e 5; XVII, 4.<br />
Déclaration du roy et nouveau reglement sur le faict des monoyes<br />
tant de Franca qu'étrangères. Paris, 1637 ; in-8, pag. 41, 44.<br />
Depoletti. Catalogo della Collezione Depoletti. Monete italiane<br />
me<strong>di</strong>oevali e moderne. Roma, 3882; in-8 (Mezzo scudo d'oro <strong>di</strong> Pio V,<br />
ine<strong>di</strong>to, tav. ann. 120).<br />
Due fac-simili <strong>di</strong> monete coniate in Russia da Aristotile Fioravanti<br />
meccanico ed ingegnere bolognese del secolo XV (Atti e mem. della<br />
R. Deputazione <strong>di</strong> Storia Patria per le Provincie dell' EmiUa. Nuova<br />
serie. Voi. I, 1877).<br />
Durai et l'roelich. Monnaies en or du Cabinet de Vienne. Vienne,<br />
1759; pag- i-5> 286, Suppl. I, 2 e 82.
LA ZECCA DI BOLOGNA 43<br />
Duval et Frùelìch. Monnaies en argent du Cabinet de Vienne.<br />
Vienne, 1769; in-fol., pag. 286, n. 2.<br />
E<strong>di</strong>ct du roi sur le faict et reglement general de ses monnaies.<br />
Paris, 1602; in-8, pag. 58.<br />
E<strong>di</strong>ct et reglement faict par le roi sur le cours et prix des monnaies<br />
tant de France qu'éstrangères. Paris, 1636; in-8, pag. 34.<br />
Frati Luigi. Della zecca <strong>di</strong> Bologna. Brevissimi cenni inseriti<br />
nell'albo presentato al Sommo Pontefice Pio IX dalla Città e provincia<br />
<strong>di</strong> Bologna. Bologna, 1858; in-8.<br />
Delle monete gettate al popolo nel solenne ingresso in Bologna<br />
<strong>di</strong> Giulio II (Atti e Mem. della R. Dep. <strong>di</strong> Storia Patria per la Romagna,<br />
III serie, voi. I, pag. 474 e seg.).<br />
Sull'erronea attribuzione al Francia delle monete gittate al<br />
popolo nel solenne ingresso in Bologna <strong>di</strong> Giulio II. Bologna, Garagnani,<br />
1896 ; con I tav.<br />
Di un ducato d' oro ine<strong>di</strong>to <strong>di</strong> Leone X coniato a Bologna e<br />
<strong>di</strong> altro consimile <strong>di</strong> Modena. Bologna, Zanichelli, 1896; con i tav.<br />
Friedlaender Giulio, Numismata me<strong>di</strong>i-evi ine<strong>di</strong>ta. Berolini, 1835;<br />
in-4, pag. 38 e 39.<br />
Die Miinzen des Kirchenstaates von J794 bis 1814 (Koehne-<br />
Zeitschrift, etc. 1841, tomo I, tav. VI, n. 4 e 5; tav. VII, n. i.<br />
Die italienischen Schaumiinzen des fiinfzehnten lahrhunderts<br />
(1430-1530). Berlin, 1882; in-fol., tav. XXXIV.<br />
Oaetani. Museum Mazzucchellianum. Venetiis, 1761-63; 2 voi. in-fol.,<br />
tav. CXCVII, IO, II.<br />
Gagarine. Une<strong>di</strong>rte pàbstliche Munzen (Koehne-Zeitschrift fiir<br />
Mtìnzkunde, tomo VI, pag. 27).<br />
Gentili <strong>di</strong> Rovellone Tarquinia. Due scu<strong>di</strong> d' oro ine<strong>di</strong>ti spet-<br />
tanti a Papa Pio IV {Bull, <strong>di</strong> num. e sfrag., voi. I, pag. 223).<br />
Giordani. Della moneta dei poveri. Bologna, 1840 {^Almanacco<br />
statistico bolognese. Anno IX, in-i6).<br />
Moneta bolognese <strong>di</strong> Giulio II. Bologna, 1841 [Alm. stai. boi.<br />
Anno XII, in- 16).<br />
Della venuta e <strong>di</strong>mora in Bologna del Sommo Pontefice Clemente<br />
VII per la coronazione <strong>di</strong> Carlo V imperatore, celebrata l'anno<br />
1530. Bologna, 1842; in-8 con tav.<br />
Le rare monete del Pontefice Giulio II gettate al popolo nel suo<br />
ingresso in Bologna l' anno 1506. Bologna, 1855 (Archivio patrio <strong>di</strong><br />
antiche e moderne rimembranze felsinee. Tomo II, in-8).<br />
Vita del conte e senatore Andrea Bentivoglio scritta da Giovanni<br />
Saba<strong>di</strong>no degli Arienti e pubblicato con note da Gaetano Giordani.<br />
Bologna, 1840; in-8 con tav.<br />
Gosza<strong>di</strong>ni Giovanni. Memorie per la vita <strong>di</strong> Giovanni II Bentivoglio.<br />
Bologna, 1839; in-8 con tav.<br />
Grùevius. Thesaurus antiquitatum et historiae Siciliae. Lugduni<br />
Batavorum, 1723; voi. III, in-fol., tav. CCXX, 36.<br />
1
43^ FRANCESCO MALAGUZZI<br />
Heiss AI0188. Descripcion general de las monedas hispano-cristianas<br />
desde la invasion de los Arabes. Paris, 1865-69; in-4, voi. II (Testoni<br />
<strong>di</strong> Carlo V da Heiss attribuiti a Napoli).<br />
Les médailleurs de la Renaissance. Paris, 1885; ^^^ '^v.<br />
Hoffmann. Alter und neuer Mùnz-schlùssel. Nikrnberg, 1692; in-4,<br />
tav. XV, VI bis, XIII, XIII bis, XV, XVII, VI, L bis.<br />
lluron E. Notice sur quelques monnaies tirées d'une petite col-<br />
lection {Rev.franf., 1856; pag. 190). (Una moneta <strong>di</strong> Giovanni Bentivoglio).<br />
Koehler I, D. Historische Mfinz-belustigung. Nùrnberg, 1729-65 ;<br />
in-4, tomo V, pag. 225-239.<br />
Illustrazione storica della Medaglia <strong>di</strong> Galeazzo Marescotti Calvi<br />
(dell' avv. Carlo Pancal<strong>di</strong>) ixéWAlm. statisi, bologn. per l' anno 1831.<br />
Bologna, Salvar<strong>di</strong>, in-8, tav. i.<br />
Lelevel. Numismatique de moyen àge. Atlas. Paris, 1835; ^^'^ ol^''»<br />
tav. XV, II.<br />
Liébe. Prodromi reformationis pia memoria recolendae, sive nummi<br />
Ludovici XII regis Gallorum epigraphe : perdam babylonis nomen, vel<br />
PERDAM BABYLONEM. Lipsiac, 1717 ; in-8, pag. 22.<br />
Litta Pompeo. Famiglie celebri italiane; 1819-1868, in-fol.<br />
Barbo <strong>di</strong> Venezia, n. i.<br />
Bentivoglio <strong>di</strong> Bologna, n.<br />
Condulmero <strong>di</strong> Venezia, n. 2, 8.<br />
Visconti, n. 22, 25 e 26.<br />
MacchiavelU Alessandro. De veteri bononeno argenti Bononiae.<br />
Bologna, 1721 ;<br />
in-4.<br />
Maggiora- Vergano. Un esperimento della zecca <strong>di</strong> Bologna {Riv.<br />
<strong>di</strong> num. it., tomo II).<br />
MazzuchelU L. Il monetario del <strong>com</strong>mercio. Milano, 1846; in-8.<br />
(Ve<strong>di</strong>: Romagna).<br />
Melloni. Atti e memorie degli uomini illustri in santità nati o morti<br />
in Bologna. Classe I, tomo I. Bologna, 1786; in-4.<br />
Muratori. De moneta sive jure cuden<strong>di</strong> nummos (Antiquit. me<strong>di</strong>i<br />
aevi, tomo II, Me<strong>di</strong>olani, 1739; in-fol., tav. XLIII, 1-6, io; X, 43; LV,<br />
14; XLIII, 7, 8; XLIV, 9, 11).<br />
Nipote (II) del Vesta Verde. Strenna popolare pel 1858 (Anno X<br />
e XI). Milano, in-i6, pag. 141.<br />
Nota delle Medaglie in argento derubate (nella ricca Collezione<br />
appartenente al sig. cav. avv. Luigi Salina). Bologna, 1834; in-fol. voi.<br />
Ordonnance sur les monnaies. Lyon, 1577 ; in-8, pag. 56, 70, 99.<br />
Ordonnances, statut et permission des espèces d'aur et d'argent<br />
ayant cours au pays par de9a. Gand, 1552; in-8, pag. 18, 20, 19, 31, 29, 56.<br />
Ordonnance sur les monnaies. Lyon, 1602; in-8, pag. 58.<br />
Ordonnance pour les changeurs. Anvers, 1633; in-fol., pag. 18, 21,<br />
56, 23, 55, 173.
LA ZECCA DI BOLOGNA 433<br />
Petavius. Antiquariae suppellectilis portiuncula (Sallengre : novus<br />
thesaurus antiquit, roman.Tom.II). Hagae Comi/um, i^ 18; in-fol., tav. Vili.<br />
Placcarci du rei nostre sire contenant deffence du cours de florins<br />
d'or d'Allemaigne et de quelques aultres espèces. Aiwers, 1627 ; in-4,<br />
pag. 35. 39. 36, 42, 41-<br />
Placcard du roy sur le reglement de ses monnoyes. Anvers, 1644;<br />
in-4, pag- 34) 3^, 28.<br />
Placcard et ordonnances sur le faict des monnaies. Anvers, 1706;<br />
in-4, Foglio X, verso, XIII, XII verso.<br />
JPromis Domenico. Monete e medaglie italiane. Torino, 1873; in-4,<br />
tav. 1, n. 4 e 5.<br />
Mossi. Catalogo della Collezione Rossi <strong>di</strong> Roma. Monete <strong>di</strong> zecche<br />
italiane me<strong>di</strong>oevali e moderne. Roma, 1880 ; in-8, tav. I, 377 ; II, 374,<br />
398, 411, 423, 471 e 603 ine<strong>di</strong>te.<br />
Collezione <strong>di</strong> monete italiane, me<strong>di</strong>oevali e moderne. Roma,<br />
1895; in-4, con 3 tav. (2° catalogo).<br />
Brevi cenni sul!' ine<strong>di</strong>to Scudo romano del sacco <strong>di</strong> Roma<br />
coniato dal re d'Aragona e <strong>di</strong> Sicilia, ecc. Roma, 1886; in-8, tav. ann. n. 3.<br />
Muspoli. Catalogo delle monete papali <strong>com</strong>ponenti la collezione<br />
<strong>di</strong> Alessandro dei Principi Ruspoli. Roma, 1885; in-8, tav. I, 103 ine<strong>di</strong>ta;<br />
II, 521.<br />
Schiassi Filippo. De moneta Bononiensi <strong>di</strong>ssertatio. Bononia,<br />
1839; in-4.<br />
Schweitzer Federico. Doppia d' oro per Bologna <strong>di</strong> Papa Innocenzo<br />
X {Notizie peregrine <strong>di</strong> num. e d'archeolog.) Decade IV.<br />
Doppia d' oro per Bologna <strong>di</strong> papa Gregorio XIV [Notizie<br />
pereg. <strong>di</strong> nmnism. e d'archeologia) Decade V.<br />
Sepilli F. Quattro monete pontificie ed una <strong>di</strong> Casa Savoia. Trieste,<br />
1859; in-4, tav. ann. n. i.<br />
Tariffa <strong>di</strong> Venezia, 1554; in-fol. nn. 3, 12, 26, 27 e 283, pag. 127.<br />
Tariffa <strong>di</strong> Venezia, 1564; in-fol. nn. 13 e 17.<br />
Sugana Domenico. Taddeo Pepoli eletto signore <strong>di</strong> Bologna. —<br />
Monete battute sotto il suo governo (Nozze Isolani-Tattini) 1864.<br />
Terzi Basilio. Osservazioni sopra alcune monete ine<strong>di</strong>te d'Italia.<br />
Padova, 1808; in-4, pag- 12; tav, I, n. 2.<br />
Tonini. La crazia ed il quattrino <strong>di</strong> Fer<strong>di</strong>nando De Me<strong>di</strong>ci Principe<br />
<strong>di</strong> Castiglione del Lago {Period. <strong>di</strong> num. e sfragist. dello Strozzi. Anno I,<br />
pag. 130, 445).<br />
Tresooroft schat van alle de specien figuren en sorten van gouden<br />
ende silveren munten. Antwerpen, 1580; in-8, pag. 16, 37, 81, 91, 93, 97,<br />
131, 443, 445, 127, 130.<br />
Trésor de numismatique et de glyptique. Paris, 1846; in-fol., tav.<br />
XXV, 15; XXVI, 2, 3 e 7; XXVII, 2.<br />
Vitalini Ortensio. Di alcune monete ine<strong>di</strong>te e non ancora segna-<br />
late {Bulletlino <strong>di</strong> num. e sfragist., voi. I, pag. 97 e 262).<br />
55
434<br />
FRANCESCO MALAGUZZI<br />
Vitalini Ortensio. Le monete dei papi giusta V or<strong>di</strong>ne seguito<br />
nelle tavole sinottiche del Dott. Angelo Cinagli con razionali criteri apprezzate.<br />
Camerino, 1882, in-8.<br />
Le monete battute nel pontificato <strong>di</strong> Pio IX e nell'interregno<br />
della Repubblica Romana. Supplemento alle monete dei papi del Dot-<br />
tore Angelo Cinagli. Camerino, 1892; in-fol., con una tav.<br />
Voerzeichniz und gepràge der groben und kleinen Munzsorten.<br />
Leipzig, 1574; in-4, pag. 86.<br />
Vettori. Il Fiorino d'oro antico illustrato. Firenze, 1738; in-4, P3g-^97><br />
tav. a pag. 15, n. 14; pag. 149 e 176.<br />
Manoscritti e stampati dello Zanetti presso la Biblioteca<br />
Municipale <strong>di</strong> Bologna:<br />
Delle Monete <strong>di</strong> Bologna. Trattato <strong>di</strong> Guidantonio Zanetti — Ms.<br />
cart., autogr., in-fol., <strong>di</strong> ce. 167, con altre non poche volanti intramezzatevi.<br />
(Sembra la prima <strong>com</strong>pilazione <strong>di</strong> questo lavoro).<br />
Delle Monete <strong>di</strong> Bologna. Trattato <strong>di</strong> Guidantonio Zanetti — Ms.<br />
cart., autogr., <strong>di</strong> ce. 81, più xi altre volanti. Da questa <strong>com</strong>pilazione<br />
sembra essere stata tratta, con non lievi mo<strong>di</strong>ficazioni e aggiunte, la<br />
seguente in miglior forma; per cui la parte in quella copiata vedesi<br />
in questa cassata con un tratto <strong>di</strong> penna lungo ogni facciata.<br />
Delle Monete <strong>di</strong> Bologna — Ms. cart., autogr., <strong>di</strong> pag. 137 e<strong>di</strong>to<br />
fino alla pag. 117, colle firme dei Revisori in fine, avendo esso servito<br />
per la stampa, che aveva intrapreso <strong>di</strong> quest' opera il tipografo Lelio<br />
dalla Volpe, e che rimase interrotta per la morte dell'Autore.<br />
Altro esemplare ms. autografo della suddetta porzione <strong>di</strong> questo<br />
Trattato, mancante però degli ultimi 14 documenti — Ms. cart., in-fol.,<br />
pp. 92, n.<br />
Delle Monete <strong>di</strong> Bologna. Trattato <strong>di</strong> Guidantonio Zanetti, voi.,<br />
in-fol., parte a stampa e parte ms. <strong>di</strong> ce. 285, <strong>com</strong>prese le bianche.<br />
Comincia con sei fogli stampati, più un foglio <strong>di</strong> bozze (pag. 1-72), poi<br />
segue manoscritto, parte <strong>di</strong> mano dell'Autore, parte d' altra mano. La<br />
<strong>com</strong>pilazione fino a Martino V è abbastanza ultimata; in<strong>di</strong> è poco più<br />
che abbozzata, riportando la semplice descrizione delle monete coi<br />
rispettivi <strong>di</strong>segni; ed è stata tratta dal voi. autografo descritto al n. 8381.<br />
Selva cronologica delle Notizie su la Zecca e Monete <strong>di</strong> Bologna<br />
— Ms. cart., in-fol., nel quale sono notate qua e là Memorie <strong>di</strong>sposte<br />
cronologicamente sulle Monete <strong>di</strong> Bologna.
LA ZECCA DI BOLOGNA 435<br />
Miscellanea <strong>di</strong> stampe e ms. risguardanti le Monete <strong>di</strong> Bologna e<br />
contiene i seguenti articoli:<br />
ce. IO.<br />
1. Ragguaglio della Moneta antica con la moderna, 1695 — Ms. in-fol.,<br />
2. Gli uguali Assaggi e Misure delle varie monete — Bologna, 1703,<br />
in-4, ce. 8.<br />
3. Notizie sopra il valore <strong>di</strong> Monete antiche — Ms. in-fol., ce. 8.<br />
4. Note delle Monete proprie <strong>di</strong> Bologna nell'a. 1715 — Ms. in-fol., voi.<br />
5. Instrumenti quattro <strong>di</strong> Zecca, i." del 1450, 2.° 1474, 3.° e 4." 1472.<br />
6. Ban<strong>di</strong> <strong>di</strong> Monete dall'a. 1555 al 26 maggio 1714 — In ff. vv. stampati.<br />
Sommario delli Ban<strong>di</strong> risguardanti le Monete <strong>di</strong> Bologna dall'anno<br />
1555 all'a. 1694 — Ms. cart., in-fol., ce. 20.<br />
Altra Copia del sudd. Sommario — Ms. cart., in-fol., ce. 20.<br />
Ban<strong>di</strong> sopra le Monete <strong>di</strong> Bologna dall'anno 1539 all'a. 1704 — Ms.<br />
cart., in-fol., ce. 150; parecchi d'essi Ban<strong>di</strong> sono stampati.<br />
Riformazioni, Ban<strong>di</strong> ed altre scritture risguardanti le Monete <strong>di</strong> Bologna<br />
dall'anno 1289 all'a. 1808 — Fogli miscellanei, parte ms., parte<br />
stampati.<br />
Memorie <strong>di</strong>verse in materia <strong>di</strong> Monete — Ms. cart., del sec. XVIII,<br />
ce. 176, <strong>com</strong>prese le bianche, in-fol.<br />
Informatione, etc. sopra il valore delle Monete Lire e delli Scu<strong>di</strong><br />
d'oro; e varii Instrumenti (i) — Ms. cart., in-fol., ce. 282, con qualche<br />
foglio stampato.<br />
Bononien. Locorum Montium super valore Monetarum Epitome,<br />
cum Summario, anno 1746 — Ms. cart., in-fol. , ce. 93, <strong>com</strong>prese le bianche.<br />
Descrizione <strong>di</strong> Monete <strong>di</strong> Bologna <strong>di</strong>sposte cronologicamente dal-<br />
l'anno 1191 al 1769 — Ms. cart., in-4, ce 60, con sei tavole volanti <strong>di</strong><br />
monete bolognesi preparate per l'opera dello Zanetti.<br />
Volumi quattro miscellanei ms. risguardanti le Monete segnatamente<br />
<strong>di</strong> Bologna, già spettanti a Guido Zanetti.<br />
I. Notizie risguardanti le Monete <strong>di</strong> Bologna quali si sono ricavate<br />
da <strong>di</strong>versi Manoscritti esistenti nella Senatoria Cancelleria e suo Archivio<br />
— Voi. in-fol., pp. 480.<br />
II. Notizie <strong>com</strong>e sopra ricavate da <strong>di</strong>verse Cronache — Voi. <strong>di</strong><br />
pp. 218. Vi sono unite; Diverse Notizie spettanti alle Monete battute<br />
nella Zecca <strong>di</strong> Bologna raccolte e scritte da Guido Zanetti (pp. 53); a<br />
cui fa seguito altro fascicolo <strong>di</strong> pp. 36, in cui sono riportati <strong>di</strong>segni a<br />
penna <strong>di</strong> Monete <strong>di</strong> Bologna colla rispettiva <strong>di</strong>chiarazione.<br />
III. Ban<strong>di</strong>, Notificazioni, E<strong>di</strong>tti pubblicati in Bologna, sopra le Monete<br />
— Voi. <strong>di</strong> pp. 244, n. 20 n. n.<br />
IV. Pesi, e bontà <strong>di</strong> monete, Ragguagli, Tariffe, e altre Scritture<br />
varie risguardante le monete — Voi. <strong>di</strong> pp. 331.<br />
Disegni a penna delle Monete coniate in Bologna dall'anno 1191<br />
al 1757 — Ms. cart., in-4, ce. 107.<br />
(i) Titolo nel dorso del volume ; appartenne un tempo all'Archivio del Monte Giulio,<br />
del quale porta segnato nel cartone il n. 67.
436<br />
FRANCESCO MALAGUZZI<br />
Per la storia bolognese, tanto collegata a quella della<br />
zecca, si vedano le seguenti opere presso la Biblioteca<br />
Comunale <strong>di</strong> Bologna:<br />
Breve ristretto dalli successi <strong>di</strong> Bologna cavato dagli Annali <strong>di</strong><br />
Giovati Francesco Negri, (dall'origine della città fino alla prima crociata)<br />
— Ms. cari., in-fol.^ del sec. XVIII, ce. 64, n. n.<br />
Cronica delle cose <strong>di</strong> Bologna — Ms. cari., in-fol., del sec. XVII,<br />
ce. 148, n. n.<br />
Caroli Sigonii, historiarum bononiensium libri sex ab initio civitatis<br />
ad annum MCCLVII nell'Opera omnia Caroli Sigonii e<strong>di</strong>ta a Philippe<br />
Argelato — Me<strong>di</strong>olani, i7J2-jyjj, tom. Ili, pag. i-jjo.<br />
Annali bolognesi; firni. Ludovico Vittorio Savioli — Bassano {s. t.),<br />
iy84-9S, voi. VI, in-4.<br />
Deca prima delle historie <strong>di</strong> Bologna <strong>di</strong> F. Leandro degli Alberti<br />
— Bologna, per Bartholomeo Bonardo, et Marcantonio- Grossi, 1J43, in-4.<br />
Deca seconda (<strong>di</strong> soli Libri V) delle historie <strong>di</strong> Bologna, del sudd.<br />
Autore — Vicenza, presso Giorgio Greco, JJ92, in-4.<br />
Petri Cantinelli bononiensis Chronicon faventinum (ab a. 1229 ad<br />
a. 1306); ne' Rerum Favent. Script.<br />
Io. Bened. Mittarelli — Venetiis, apud Modestum Faentium, 1771, in-<br />
foi., pag. 219-314.<br />
Sumario delle cose <strong>di</strong> Bologna seguite da s. Petronio nostro protettore<br />
l'anno 423 persino all'anno M e CCC, xxiiij: cavate dall'antico<br />
per me Giovan Vincendo Gandolfi bolognese l'anno M. D. L. xxxiiij —<br />
Ms. cari., in-4 P-, ce. 108.<br />
Descrittione <strong>di</strong> Bologna, nella quale si contiene tutto quello, che è<br />
successo nella città dall'anno 423 fino all'anno 1325 <strong>di</strong> nostra salute —<br />
Ms. cari., in-fol.., p., del sec XVI, ce. 44.<br />
La Bologna perlustrata <strong>di</strong> Antonio <strong>di</strong> Paolo Masini ampliata e<br />
ricorretta da L, A. S. {Luca Antonio Sgargi) — Bologna, per i tipi<br />
Gamberini e Parmeggiani, 1823-26 P. Il, voi. V, in-8.<br />
Cronica <strong>di</strong> Bologna d'incerto Autore (dall'anno noi sino all'anno<br />
1345) Ms. cari., in-fol., <strong>di</strong> mano del conte Carrati, pp. 133.<br />
Somma, over Cronica raccolta da <strong>di</strong>versi memoriali <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi citta-<br />
<strong>di</strong>ni notabili. Comincia dall'anno 600 e va fino al 1350 — Ms. cari, infoi..,<br />
del sec. XVIII, <strong>di</strong> ce, 12.<br />
Cronica anonima <strong>di</strong> Bologna dall'anno 1116 all'anno 1350 — Ms.<br />
cart., in-fol., del sec. XVIII, pp. iii.<br />
Cronica <strong>di</strong> Bologna, anonima (dall'origine della città ai 22 genn. /sSp)<br />
— Ms. cart., infoi., del sec. XVI, ce. 128 n.<br />
Alcune cose notabili <strong>di</strong> Bologna, (dall'anno 1131 al 1399) cavate da<br />
una cronica manoscritta, che si conserva presso M.Sebastiano Buonhomo<br />
per me Valerio Rinieri 1613 del mese <strong>di</strong> aprile — Ms., cari., in-fol, del<br />
sec. XVIII, pp. p.
LA ZECCA DI BOLOGNA 437<br />
Cronica <strong>di</strong> Bologna che <strong>com</strong>incia dall'anno 1116 e va fino al 26<br />
giugno 1402 — Ms. cari., in-/ol, p., del sec. XVIII, pp. 84.<br />
Frammento della Cronaca bolognese <strong>di</strong> Prete Giovanni (dal i <strong>di</strong>e.<br />
1407 al 27 maggio 1409) pubblicato da Corrado Ricci negli Atti e Mem.<br />
della Deputaz. stor. <strong>di</strong> Romagna, ser. Ili, voi. Ili, pag. gj-ioS.<br />
Cronica <strong>di</strong> Bologna d'ignoto autore, dall'anno 1378 sino al 16 giugno<br />
del 1410 — Ms. cari., in-fol., p., del sec. XVIII pp. 7/, ti. n.<br />
Cronica <strong>di</strong> l3ologna, dall'anno 892 al 1420 — Ms. cari., in-fol., del<br />
sec. XV, ce. 48.<br />
Croniche <strong>di</strong> Bologna (dall'origine all'anno 1423) — Fascicoletto ms.,<br />
in-fol. picc, del sec. XVI, ce. 8.<br />
Fragmenti <strong>di</strong> Bologna cavati dall'Archivio dell' Ill.mo sig. Camillo<br />
da Correggio (dall' anno 700 all' anno 1423) — Ms. cari., in-fol., del<br />
sec. XVIll^ pp. 17.<br />
Cronica, o sia Memoriale delle cose <strong>di</strong> Bologna dall' anno 1371 al<br />
1424 scritte da Pietro <strong>di</strong> Mattiolo Fabro bolognese rettore <strong>di</strong> S. Michele del<br />
mercato <strong>di</strong> mezzo — Ms. cari., in-fol. <strong>di</strong> pp. iji, <strong>di</strong> mano del conte Carrati.<br />
La stessa pubblicata da Corrado Ricci — Bologna, presso Gaetano<br />
Romagnoli, i88s, in-8, pp. XLI-406.<br />
Bologna secondo la cronica <strong>di</strong> Pietro <strong>di</strong> Mattiolo. Appunti,7?r. Cesare<br />
Albicini, negli Atti e Mem. della Deputaz. stor. <strong>di</strong> Romagna — Bologna,<br />
1884, ser. Ili, voi. II, pag. 4^1-306 : Continuazione, op. cit., ser. Ili, voi. HI,<br />
pag- 355-3là.<br />
Cronica, o sia Memoriale delle cose <strong>di</strong> Bologna dall' anno 1359 al<br />
1399.... scritta da Pietro Fabro bolognese — Ms. cari., in-fol., <strong>di</strong> mano<br />
del Calcati, ce. io.<br />
Cronica <strong>di</strong> Bologna de' Signori Bolognetti dalla Mercanzia, dall'anno<br />
1219 ai 12 <strong>di</strong>e. 1443 — Ms. cart., in-fol. p., <strong>di</strong> pp. 182, <strong>di</strong> mano del conte<br />
Carrati, che la trascrisse da altra copia nel ijój<br />
Il Governo Visconteo in Bologna (1438-1443), fir. Cesare Albicini;<br />
negli Atti e Mem. della Deputaz. stor. <strong>di</strong> Romagna — Bologna, 1884,<br />
ser. Ili, voi. II, pag. 311-362.<br />
Ristretto della seconda parte della Cronica manoscritta circa li<br />
successi <strong>di</strong> Bologna dall'anno 1403 sino all'anno 1450 — Ms. cart, in-fol.,<br />
p., del sec. XV11, <strong>di</strong> ce. jo. Seguono: Brevissimi cenni storici della città<br />
dall'origine <strong>di</strong> essa all'anno 1530, <strong>di</strong> ce. 15.<br />
Memoriale historicum rerum bononiensium ab anno domini 782 ad<br />
annum 1472, auctore Mattheo de Griffonibus — Ms. cart., in-fol., foggiato<br />
a vacchetta, del sec. XV, <strong>di</strong> ce. igj n. n.<br />
Libro <strong>di</strong> Nicolo <strong>di</strong> Ta<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Mamelini, in lo quale sono scritti alcuni<br />
suoi facti (dal 1436 al 1483) — Ms. cart., in-4, del sec. XV, ce. 18.<br />
Chronica gestorum et factorum memorabilium civitatis Bonpniae<br />
e<strong>di</strong>ta a F. Hieronimo de Bursellis bononiensi or<strong>di</strong>nis prae<strong>di</strong>catorum —<br />
Ms. cart., in-fol., <strong>di</strong> mano del co. Carrati, pp. 8j.<br />
Annales bononienses F. Hieronimo de Bursellis bononiensis or<strong>di</strong>nis<br />
prae<strong>di</strong>catorum ab anno MCDXVIII usque ad MCDLXXXXVII; nei Rer.<br />
Ital., Script, e<strong>di</strong>t. a Lud. Ant. Muratorio, tom. XXIII, col. 863-916.<br />
.
438<br />
FRANCESCO MALAGUZZI<br />
Fatti Storici accaduti nella città <strong>di</strong> Bologna, dall'anno 1393 all'anno<br />
1501. [Titolo <strong>di</strong> scrittura recente) — Voi. due cari, ms., in-fol., del sec.<br />
XVIII: il primo <strong>di</strong> ce. j^2, l'altro <strong>di</strong> ce. 2jo.<br />
Memorabilia occurrentia et utilia prò Ecclesia S. Mariae Magdalenae,<br />
stratae S. Donati, auctore Gaspare de Capite bobus (Codebò) rectore<br />
prae<strong>di</strong>ctae Ecclesiae, ab. a. 1471 ad anno 1504 — Ms. cari., in-fol. p.,<br />
<strong>di</strong> mano del co. Carrati, pp. 64.<br />
Diario <strong>di</strong> Gaspare <strong>di</strong> Filippo Na<strong>di</strong>.... (principia dall'anno 1418, e<br />
termina all'anno 1504) pubblicato a cura <strong>di</strong> Corrado Ricci e <strong>di</strong> Alberto<br />
Bacchi della Lega — Bologna, presso Romagnoli DaWAcqua, 1886, in-8,<br />
pp. XXII, 394-<br />
Della historia <strong>di</strong> Bologna.... del R. P. M. Cherubino Ghirardacci,<br />
bolognese. Parte prima — Bologna per Giovanni Rossi, ijcfó, in-fol.<br />
Parte seconda.... data in luce dal P. M. Aurelio Agostino Solimani —<br />
Bologna, per Gia<strong>com</strong>o Monti, lójj, infoi.<br />
Della parte terza esistono copie ms. in due volumi.<br />
Giovanni Gozza<strong>di</strong>ni. Di alcuni avvenimenti in Bologna e nell'Emilia<br />
dal 1506 al 151 1 e dei Car<strong>di</strong>nali Legati A. Ferrerio e F. Alidosi, negli<br />
Atti e Mem. della Deputaz. stor. per le prov. <strong>di</strong> Romagna — Bologna,<br />
1886, ser. III, tom. IV, pag. ój-ijó.<br />
voi. 9.<br />
Annali <strong>di</strong> Muzzi Salvatore della città <strong>di</strong> Bologna — Bologna, 1840,<br />
Id. Compen<strong>di</strong>o della storia <strong>di</strong> Bologna — Bologna, i86j, i voi.<br />
Antonii Bianchina, che si crede o dell' autore, o del padrone del<br />
libro; l'originale del quale.... fu da me Ubaldo Zanetti fatto copiare negli<br />
anni 174 1 e 1742 — Ms. cari., infoi., <strong>di</strong> ce. 443.<br />
Diario delle cose notabili successe in Bologna, <strong>com</strong>inciando dall'a.<br />
1401 insieme al 1513, scritto dal R. D. Antonio Dalle Anelle bolognese<br />
— Ms. cari., infoi., del sec. XVIII, pp. 14"].<br />
Diario delle cose <strong>di</strong> Bologna, ove sono varie istorie <strong>di</strong> Lombar<strong>di</strong>a<br />
<strong>di</strong> Girolamo Bolognini dal 1494 fino al 1513 — Ms. cari., in-fol., del<br />
sec. XVI, pp. 290, XXVII d' in<strong>di</strong>ce.<br />
Altra copia del suddetto Diario, avente il seguente titolo: Successi<br />
«giornalmente occorsi sì nella città <strong>di</strong> Bologna quanto per l'Italia e fuori<br />
ancora, dall'a. 1494 del mese <strong>di</strong> agosto sino ai 27 marzo 1513, descritti<br />
e raccolti fedelmente da Hieronimo <strong>di</strong> Bolognini — Ms. cari., in-fol.,<br />
<strong>di</strong> mano del Carrati, pp. 213.<br />
Cronaca <strong>di</strong> Bologna (<strong>di</strong> Friano Ubal<strong>di</strong>ni), dall'a. 1260 all'a. 1521 —<br />
Voi. due cari, ms., in-fol. <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi caratteri del sec. XVI, il primo ha<br />
pag. 88j, il secondo pp. 864.<br />
Historia <strong>di</strong> Bologna (<strong>di</strong> Fileno dalle Tuate) dall'anno CCCV sino<br />
all'anno MDXXI, con appen<strong>di</strong>ce dopo l'in<strong>di</strong>ce — Voi. due ms., in-fol., del<br />
Sec. XVII, il primo <strong>di</strong> pp. jj% l'altro <strong>di</strong> pag. 2// non <strong>com</strong>presi gli in<strong>di</strong>ci.<br />
Altra copia — Voi. due ms., infoi, il 1° <strong>di</strong> ce. 34^, il 2" <strong>di</strong> ce. 2pj;<br />
e molte altre cronache, <strong>com</strong>pen<strong>di</strong>, ecc.
• CAPITOLO I.<br />
Il <strong>di</strong>ploma <strong>di</strong> Enrico VI, ii febbraio 1191, che concede ai bolognesi <strong>di</strong><br />
batter moneta — Il denaro bolognese — Prime locazioni della zecca<br />
alle società dei mercanti e dei cambiatori — Patti tra Bologna ed<br />
altre città pel corso delle monete — Varii sistemi della moneta<br />
bolognese prima dei Pepoli — Taddeo Pepoli e la moneta pepolese<br />
— Giovanni e Gia<strong>com</strong>o Pepoli — Bologna sotto il governo visconteo<br />
e della Chiesa — Prima battitura del bolognino d'oro nel 1379 —<br />
Il luogo della zecca.<br />
È noto che, parlando dell'origine della zecca <strong>di</strong><br />
Bologna, alcuni storici la fanno risalire molto più<br />
ad<strong>di</strong>etro della data certa e ormai riconosciuta <strong>com</strong>e<br />
la sola atten<strong>di</strong>bile, e ricordano monete bolognesi,<br />
etrusche, romane, longobarde e carolingie e alcuni<br />
arrivano a stabilirne senz'altro le impronte. La critica<br />
moderna ha demolito, sull'esempio del Muratori, ad<br />
una ad una quelle facili asserzioni ed ha <strong>di</strong>mostrato<br />
che l'origine della zecca <strong>di</strong> Bologna, una delle piiì<br />
antiche d'Italia e delle più gloriose, rimonta al ii9i(^).<br />
Enrico VI imperatore, acquetate le lotte intestine <strong>di</strong><br />
Germania, venne in- Italia per esservi incoronato dal<br />
pontefice. A Bologna, accolto magnificamente et hono-<br />
ratamente dal popolo e dai magistrati, donava al<br />
vescovo il titolo <strong>di</strong> principe e alla città il ben noto<br />
privilegio, con <strong>di</strong>ploma ii febbraio 1191, <strong>di</strong> batter<br />
moneta (2). L' imperatore vi aveva però apposta una<br />
(i) Muratori, Antichità italiane II. 260 e<strong>di</strong>z. milanese MDCCCXXXVI.<br />
Egli (e sul suo esempio gli storici bolognesi) confutò il preteso <strong>di</strong>ploma<br />
<strong>di</strong> Desiderio su cui si appoggiavano le asserzioni antiche sull'esistenza<br />
<strong>di</strong> moneta bolognese longobarda.<br />
(2) V. doc. I in appen<strong>di</strong>ce. Fu già pubblicato dal Muratori, dall'AR-<br />
GELATi e da altri. Lo riportiamo dal Savioli, Annali bolognesi II. 167,<br />
doc. CCXCVIII, dopo averlo collazionato sulla lezione della copia del<br />
sec. XIII, nel Registro Nuovo, e. 14. v. presso il R. Archivio <strong>di</strong> Stato<br />
<strong>di</strong> Bologna — Sezione Comunale.
440<br />
FRANCESCO MALAGUZZI<br />
clausola: che la nuova moneta bolognese non fosse<br />
uguale air imperiale ne per la quantità, ne per la<br />
forma, ne pel valore (« hoc excepto quod moneta<br />
ipsorum nostris Imperialibus nec quantitate nec forma<br />
nec valentia debet adequar! „).<br />
Che il privilegio imperiale tornasse gra<strong>di</strong>to ai<br />
bolognesi perchè rappresentante il rime<strong>di</strong>o a una<br />
necessità, lo prova il fatto che si pensò subito ad<br />
approfittarne, esempio raro allora e anche più tar<strong>di</strong>.<br />
La cronaca GhiselH ci assicura che s'in<strong>com</strong>inciò col<br />
deputare Ugone, Uguccione degli Oseletti, Bualello<br />
Bualelli e Marco (o Mario) Carbonesi a <strong>di</strong>sporre,<br />
<strong>com</strong>e consoli, perchè la prima coniazione avvenisse<br />
tosto e regolarmente. E la prima coniazione infatti<br />
ebbe luogo nello stesso anno <strong>com</strong>e ci assicurano i<br />
documenti e il memoriale reggiano che ricorda espli-<br />
citamente: " eo anno fuit facta moneta Bononie (s) ».<br />
Il " denarium bononiense „ <strong>com</strong>pare la prima<br />
volta nelle carte il 28 lugho 1191, in una cessione<br />
enfiteutica, fatta dal monastero <strong>di</strong> Santa Maria <strong>di</strong><br />
Reno e <strong>di</strong> S. Salvatore ad un Attone <strong>di</strong> Verardo ed<br />
a Manno <strong>di</strong> terreno, a rogito <strong>di</strong> Tetacapra <strong>di</strong> Federico<br />
notaio (4). L'importante documento (5) ci mostra<br />
anche che correvano allora in Bologna nelle contrattazioni<br />
i denari veronesi, oltre le lire imperiali. Siam<br />
certi, da altre fonti, che oltre quelle servivano le<br />
monete <strong>di</strong> Lucca, e, se cre<strong>di</strong>amo al cronista Tolomeo<br />
(3) Nel Rerum it. scriptores, Voi. Vili. MCXCI.<br />
(4) Arch. cit. Demaniale. Busta -^ n. 21. S. Salvatore. — Avver-<br />
2473<br />
tiamo fin d' ora che tutti i documenti che richiameremo s' intendono<br />
tratti dall'Archivio <strong>di</strong> Stato <strong>di</strong> Bologna, quando non vi sia <strong>di</strong>versa<br />
in<strong>di</strong>cazione. Fino al 1512 appartengono alla Sezione Comunale: dopo<br />
quell'anno alla Pontificia.<br />
(5) Pubblicato dal prof. G. B. Salvioni, La moneta bolognese e la<br />
traduzione <strong>italiana</strong> del Savigny (Atti e Meni, della R. Deputaz. <strong>di</strong> Storia<br />
Patria per la Romagna, III Serie, Voi. XII) da cui scegliamo le notizie<br />
relative ai valori delle prime monete bolognesi.
LA ZECCA DI BOLOGNA 441<br />
<strong>di</strong> quella città, fin dal 1180 venivan stretti patti<br />
giurati fra il Comune <strong>di</strong> Lucca ed i Bolognesi : questi<br />
si sarebbero obbligati a spendere nei loro <strong>com</strong>merci<br />
la moneta lucchese, tanto nella città <strong>di</strong> Bologna che<br />
nel suo territorio (^^.<br />
La prima moneta coniata a Bologna fu dunque<br />
detta denaro bolognese: la prima denominazione fu<br />
scelta in omaggio al privilegio imperiale. È noto che<br />
appunto le monete imperiali chiamavansi denari. Solo<br />
in seguito, <strong>com</strong>e vedremo, quella moneta bolognese<br />
prese il nome <strong>di</strong> bolognino e l'esempio fu seguito<br />
dalle altre città, dopo che fu tolta l'uniformità dei<br />
denari, che era stata introdotta da Carlo Magno.<br />
Il denaro bolognese^ <strong>di</strong> cui rimangono numerosi<br />
esemplari, è una piccola moneta <strong>di</strong> lega, secondo<br />
l'uso <strong>di</strong> quei tempi (7), portante da un lato il nome<br />
dell'imperatore concedente il privilegio HENRICVS e<br />
nel campo le lettere I • P • R • T • {imperator) in croce:<br />
dall'altro lato il motto • BO NO • NI • e nel mezzo A.<br />
Questo tipo, con leggere varianti <strong>di</strong> punti e crocette,<br />
rimase sulle monete <strong>di</strong> Bologna fino al tempo dei<br />
Pepoli: non è facile <strong>di</strong>stinguere le più antiche dalle<br />
susseguenti, anche per mancanza <strong>di</strong> documenti che<br />
ci in<strong>di</strong>chino il loro peso legale e la lega stabilita.<br />
Però, per induzioni molto atten<strong>di</strong>bili essendoci noto<br />
il titolo e il peso della moneta bolognese del 1205<br />
par cosa molto verosimile che quel titolo e quel peso,<br />
(<strong>com</strong>e <strong>di</strong>mostrò il prof. Salvioni nel suo scritto veramente<br />
magistrale già citato) fossero gh stessi della<br />
moneta del 1191. È infatti inverosimile (e ciò è confermato<br />
da un documento) che si mutasse a così<br />
(6) Muratori, Annales Ptolomaei Lucensis nei Rerum it. script.,<br />
t. XI, col. 1272.<br />
(7) V. descrizione <strong>di</strong> queste <strong>com</strong>e delie monete che verremo ricordando,<br />
in Appen<strong>di</strong>ce.<br />
56
442<br />
FRANCESCO MALAGUZZI<br />
breve <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> tempo un sistema monetario da<br />
poco introdotto <strong>di</strong> pianta.<br />
Lo Zanetti (^) argomenta <strong>com</strong>e verosimile che<br />
il denaro bolognese <strong>di</strong> quel tempo equivalesse a -<br />
dell'imperiale perchè non dovendo esso, secondo il<br />
<strong>di</strong>ploma, essere uguale al denaro imperiale, non po-<br />
teva nemmeno rappresentarne la metà per non asso-<br />
migliarsi ai mezzani^ né il quarto per non confondersi<br />
colle medaglie (vere monete <strong>di</strong> cui non si hanno<br />
notizie e i mezzani i denari nuovi <strong>di</strong> Milano) (9). Ne<br />
sarebbe venuto <strong>di</strong> conseguenza che equivalessero a<br />
un terzo degli imperiali.<br />
Del I200, 14 maggio, abbiamo un atto importante<br />
per la tecnologia <strong>numismatica</strong>, con cui i consoli dei<br />
mercanti e dei cambiatori ricevono dai loro antecessori<br />
in ufficio gli utensili della zecca (1°). Riportiamo<br />
più avanti il documento con note illustrative ed<br />
osserviamo intanto che vi si rileva che i primi ad<br />
assumere Tofficina monetaria bolognese furono, (<strong>com</strong>e<br />
più tar<strong>di</strong> presso la repubblica fiorentina) le arti dei<br />
mercanti e dei cambiatori, le più consighate infatti<br />
per <strong>di</strong>rigere un ramo così geloso della pubblica<br />
amministrazione. Il locale della zecca era in quel<br />
tempo in una casa privata dei figU <strong>di</strong> certo Scannabecco<br />
e la stima degli oggetti della zecca, fin d'allora<br />
molto ben provvista, fu fatta a denari imperiah, sopra<br />
un'estimazione anteriore.<br />
Sei anni dopo, con patto datato del 1° febbraio,<br />
fra Bologna e Ferrara, i deputati ferraresi giuravano<br />
a nome della loro città <strong>di</strong> far osservare per un decennio<br />
i capitoli allora fissati: cioè che la moneta<br />
(8) Biblioteca Comunale <strong>di</strong> Bologna. Ms. 8384, v. bibliografia.<br />
(9) Sulle monete <strong>di</strong> Milano v. l'opera dei sigg. Gnecchi Francesco<br />
ed Ercole, Le monete <strong>di</strong> Milano da Carlo Magno a Vittorio Etnanuele.<br />
Milano, Dumolard, 1884.<br />
(io) V. doc. II.
LA ZECCA DI BOLOGNA 443<br />
bolognese, sull* esempio <strong>di</strong> quella <strong>di</strong> Bologna, fosse<br />
tale che per ogni libbra <strong>di</strong> peso non vi fosse meno<br />
d'once 2 e -^ d'ars^ento e once 9 - <strong>di</strong> rame e se ne<br />
ricavassero sol<strong>di</strong> 46 ^ o denari piccoli 558, che il<br />
peso da adoperare <strong>com</strong>e criterio delle successive mo-<br />
netazioni fosse quello <strong>di</strong> Bologna e che finalmente<br />
non si potessero introdurre variazioni nelle monete<br />
delle due città senza l'unanime loro consenso M.<br />
Frattanto il mercato bolognese era invaso da<br />
moneta parmigiana, per la legge della moneta peggiore,<br />
avendo la città <strong>di</strong> Parma addottato a base<br />
del proprio sistema la stessa lega dei denari <strong>di</strong> Bo-<br />
logna, ma in numero maggiore per ogni libbra (^2)<br />
Perciò i bolognesi sentirono il bisogno <strong>di</strong> allargare<br />
la loro lega monetaria e con patti del 19 settembre<br />
1209, vi abbracciavano anche Parma (^3). A questa<br />
lega tra Bologna, Ferrara e Parma aderì in seguito<br />
probabilmente anche Reggio, <strong>com</strong>e sembra dal con-<br />
tenuto della rubrica XXVI del libro VII degli Statuti<br />
<strong>di</strong> Bologna (h).<br />
Verso il 1216, la città in<strong>com</strong>inciava a risentirsi<br />
della mancanza <strong>di</strong> moneta propria, causa l' esporta-<br />
(11) Si avverta la debolezza della lega che risponde al 229 J", ma,<br />
nota il prof. Salvioni (op. cit.), quanto più tornava necessario coniare<br />
monete <strong>di</strong> poco valore, altrettanto era impossibile attenersi al sistema<br />
antico del metallo puro, perchè tali monete sarebbero sfuggite all'occhio<br />
ed alla mano. Né si poteva pensare al conio <strong>di</strong> moneta <strong>di</strong> rame: perchè<br />
il concetto della moneta non poteva allora esser chiaro, <strong>com</strong>e fu poi;<br />
perchè non si sarebbe saputo <strong>com</strong>e mantenere il ragguaglio fra la<br />
moneta maggiore più antica e le nuove spicciole; perchè finalmente<br />
quanto più si torna ad<strong>di</strong>etro nel tempo, tanto più la mente, non so <strong>di</strong>re<br />
se più rozza o meno scaltrita, esige <strong>di</strong> avere nella moneta un pegno<br />
del valore che rappresenta.<br />
(12) P. Ireneo Affò, Della zecca e moneta parmigiana illustrata,<br />
libri III (nel Voi. V, dello Zanetti, Nuova raccolta delle monete e zecche<br />
d'Italia. Bologna, Lelio della Volpe, 1775-1789).<br />
(13) Registro nuovo, e, 132 " De licentia bononie data a Ferrarla<br />
quod cum parmensibus monetam faciant. „<br />
(14) E<strong>di</strong>z. Frati, II, p. 35 e Salvioni, Op. cit.
444<br />
FRANCESCO MALAGUZZI<br />
zione che ne veniva fatta, con qualche vantaggio. A<br />
provvedere a una nuova coniazione il Comune, col<br />
mezzo <strong>di</strong> Viscontino Visconti podestà, dava in appalto<br />
la zecca, con atto 5 aprile 1216, alle stesse arti dei<br />
mercanti e dei cambiatori, che la tenevano (^s). H<br />
termine della locazione fu fissato a due anni e si<br />
stabih <strong>di</strong> conservare gli stessi pesi, bontà e lega<br />
precedenti. Il corrispettivo fu fissato in 85 lire <strong>di</strong><br />
bolognini (it. L. 633.07) in due rate da pagarsi anche<br />
se non si battesse moneta. Come osserva il Salvioni<br />
qui apparisce per la prima volta che si ricavava<br />
qualche vantaggio dal coniar moneta, ma quale non<br />
sappiamo; certamente non piccolo a giu<strong>di</strong>care dal<br />
<strong>com</strong>penso rilevante dell'appalto anche tenuto conto<br />
che v'era <strong>com</strong>preso il fitto degli utensili dell'officina.<br />
Le cose erano bene incamminate e allo scadere<br />
del termine della locazione, il contratto fu rinnovato<br />
colle due arti che però questa volta ne addossarono<br />
il carico ad un Aldobran<strong>di</strong>no de' Burigagni da Lucca<br />
del quale il Savioli pubblicò l'importante giuramento<br />
pel buon governo della zecca. Il zecchiere prometteva<br />
<strong>di</strong> conservare tutte le suppellettih dell' officina e <strong>di</strong><br />
non introdurre robe sue o d'altri " in summa moneta<br />
Bononie, nisi illam mobiUam que mihi designata erit<br />
a consulibus mercatorum et campsorum. Et monetam<br />
bon. bonam et legalem faciam et facere faciam et<br />
alligabo et alligare faciam et tres untias minus uno<br />
quarterio arzenti mittam seu mitti faciam et viiij<br />
uncias et unum q.uarterium de ramo mittam vel seu<br />
mittere faciam et xlviiij sol. et vj den. de denaris<br />
modenatis (sic) per libr. bon. ponderatam faciam<br />
secundum consuetu<strong>di</strong>nem monete facte tempore do-<br />
mini Vice<strong>com</strong>itis ohm potestatis Bononie „<br />
(15) V. doc. IV.<br />
(^^). Il<br />
(16) Savioli, Op. cit., Voi. II, P. II, p. 399, doc. CCCLXII dal Registro<br />
grosso, lib. I, p. 347.
LA ZECCA DI BOLOGNA 445<br />
Burignani giurava inoltre <strong>di</strong> sottostare agli or<strong>di</strong>ni dei<br />
soprastanti alla zecca. Questi pubblici uffiziali, <strong>com</strong>e<br />
nelle altre città, sorvegliavano a nome del Comune,<br />
sul buon andamento della zecca, stendendo i contratti<br />
<strong>di</strong> locazione, nominando gli assistenti e gli assaggia-<br />
tori (de' quali però troviam notizie più tar<strong>di</strong>) e sce-<br />
gliendo il locale della zecca.<br />
Di essi il Salvioni pubblicò il giuramento (^7).<br />
Questo documento è una interessante pittura dell'am-<br />
ministrazione, del regime interno, delle operazioni<br />
tecniche, del personale <strong>di</strong> una zecca me<strong>di</strong>oevale. Vi<br />
troviamo l'acquisto del cambium o metallo da monetare,<br />
assistiamo alla alligazione dei metalli, ve<strong>di</strong>amo<br />
formarsene i catii e trarsene i denari, in tondelli,<br />
nigri cioè ossidati dall'azione del fuoco: se ne vede<br />
sperimentare la perfetta uguaglianza, prima <strong>di</strong> imbian-<br />
chirli colla liscivia o con aci<strong>di</strong> per essere affiorati e<br />
coniati. L'operazione finiva con un altro riscontro,<br />
collo scarto dei denari reprobi, colla registrazione<br />
dei denari <strong>com</strong>piuti e legittimi che uscivano <strong>di</strong> zecca.<br />
Quest'ultima cautela era rac<strong>com</strong>andata in modo speciale<br />
ai maestri <strong>di</strong> zecca in tutti i contratti, <strong>com</strong>e<br />
vedremo. La parte metallurgica spettava a varie<br />
classi <strong>di</strong> operai fra i quali erano fun<strong>di</strong>tores, sazatores,<br />
incisores: il conio ai monetarii.<br />
Dopo aver accennato alle convenzioni 15 novembre<br />
1230 tra il Comune <strong>di</strong> Bologna e Bonsignore<br />
battitore <strong>di</strong> monete. Martino Grasso, Bonaventura<br />
Gonzaga da Verona, Buono da Vimercate ed altri,<br />
senza dati nuovi ^^^) e ad un primo accenno a mo-<br />
nete falsificate nel 1233<br />
del 1236.<br />
(^9), veniamo alla battitura<br />
(17) Op. cit. Lo riportiamo (V. doc. Ili) perchè <strong>di</strong> molto interesse<br />
per la nostra illustrazione.<br />
(18) Registro grosso, 1. 1, e. 500, r.° in Archivio <strong>di</strong> Stato <strong>di</strong> Bologna,<br />
(19) Registro grosso, e. 517, v.
446<br />
FRANCESCO MALAGUZZI<br />
In quest'anno, <strong>com</strong>e narra la cronaca Bolognetti:<br />
" messer Ubaldo Sordo fu podestà <strong>di</strong> Bologna et in<br />
quale anno li Bolognixi <strong>com</strong>enzano a batere la moneda<br />
grossa d'argento „ non bastando piii ai <strong>com</strong>-<br />
merci la moneta minuta battuta fino allora. La notizia<br />
è confermata dal Ghirardacci e da tutti gli storici<br />
bolognesi, che però non riuscirono, (<strong>com</strong>e non vi<br />
riuscimmo noi) a trovar notizie precise sul titolo e<br />
sul peso <strong>di</strong> questa moneta grossa. Se però cre<strong>di</strong>amo<br />
al Zanetti e alle esperienze da lui fatte, i bolognini<br />
grossi <strong>di</strong> quel tempo avrebbero pesato circa 32 grani:<br />
sic<strong>com</strong>e 240 erano i denari in una libbra, abbiamo<br />
7680 grani ossia troviamo rinnovata in Bologna<br />
quella perfetta rispondenza fra la unità ponderale ed<br />
il peso monetario che Carlomagno aveva, ai suoi<br />
tempi, sapientemente instaurata e che s'era smarrita<br />
nelle età successive. Quanto al titolo, Zanetti riferisce<br />
da un co<strong>di</strong>ce Magliabecchiano la notizia che nel pe-<br />
riodo 1250- 1254 " la libbra <strong>di</strong> bolognini tiene oncie<br />
d'argento X M. „<br />
Dal che il prof. Salvioni citato deduce che, se<br />
tutte queste induzioni sono esatte, si può ancora<br />
affermare che il terzo sistema monetario, che secondo<br />
le fonti del Savigny, data dal 1269, dovrebbe ripor-<br />
tarsi al 1236. Infatti se i bolognini grossi d'argento<br />
si coniavano con <strong>di</strong>eci oncie <strong>di</strong> fino e ne andavano<br />
240 per Hbbra, avremo oncie io = 6400 grani, da<br />
cui ~ = 26 ^ grani d'argento puro per ogni bolognino<br />
grosso, che rappresenta appunto il peso, <strong>com</strong>e<br />
vedremo, prefisso ad esso bolognino nel 1269.<br />
Anche su questo terzo sistema, ci convien seguire<br />
la dotta guida del Salvioni che ha trattato abbon-<br />
(20) Salvioni, Op. cit.
LA ZECCA DI BOLOGNA 447<br />
dantemente la parte <strong>di</strong> queste prime monetazioni,<br />
per quanto sotto un aspetto <strong>di</strong>verso dal nostro.<br />
Avverte egli che a proposito <strong>di</strong> questo terzo<br />
sistema, definito espressamente nel 1269, vi si nota<br />
una novità, che il titolo delle nostre monete viene<br />
ragguagliato alla lega dei grossi veneziani, e prima<br />
<strong>di</strong> descriverlo egli rammenta un episo<strong>di</strong>o che spiega<br />
questa innovazione, riferito e documentato dal Savioli,<br />
narrato anche dallo Zanetti, e che noi riassumeremo.<br />
Bisogna risalire al 1262, in cui venne per la<br />
prima volta podestà a Bologna Andrea Zeno vene-<br />
ziano. Già da qualche anno negli Statuti bolognesi<br />
esisteva una rubrica " De moneta facienda « ma nel<br />
1262 la rubrica fu mutata :<br />
« Quod potestas teneatur<br />
dare operam quod moneta grossa batetur » e vi si<br />
aggiunse questo periodo, sfuggito al Savioli e allo<br />
Zanetti: « Ad<strong>di</strong>mus huic statuto quod medalie menute<br />
ques sint medalie valimenti me<strong>di</strong>etatis unius denarii<br />
parvi battantur, et etiam bononini grossi aurei, qui<br />
sint quilibet bononinus aureus valimenti XX soldorum<br />
bononinorum et hec omnia sint precisa et precise<br />
debeant observari per Potestatem et angianos et<br />
consules, et si aliquis angianus sive consul poneret<br />
ad conscilium populi quod hoc fieri non deberet, vel<br />
concionaretur in conscilio <strong>com</strong>unis Bononie quod<br />
pre<strong>di</strong>cta non fierent vel quod <strong>di</strong>fiferetur, condempnetur<br />
per potestatem quilibet angianus sive consul in XXV<br />
libris bononinorum et bave condempnationem Potestas<br />
precise facere teneatur jnfra XV <strong>di</strong>es postquam<br />
contra hoc factum fuerit vel <strong>di</strong>ctum. „ Ma per allora<br />
non se ne fece nulla, cosicché, tornato due anni dopo<br />
Andrea Zeno podestà a Bologna, riprese Tidea <strong>di</strong><br />
quella coniazione. Chiamò da Venezia un Guido Megano<br />
(non " Megatio „ <strong>com</strong>e lesse il Savioli) coi<br />
fratelli Damiano e Pietro e creatolo zecchiere, con<br />
contratto 24 aprile 1264, gli impose una <strong>com</strong>plicata
448<br />
FRANCESCO MALAGUZZI<br />
monetazione <strong>di</strong> medagliole, denari piccoli e grossi,<br />
e bolognini d'oro. Ma il progetto abortì e questo<br />
episo<strong>di</strong>o non ha per noi altra importanza che storica.<br />
Il locatario della battitura progettata nel 1269<br />
fu cercato a Firenze nella persona <strong>di</strong> Betto Torna-<br />
quinci che, con contratto del febbraio 1269, che il<br />
lettore troverà in appen<strong>di</strong>ce (^i), si obbligava a batter<br />
monete d' argento in modo che da ogni oncia si<br />
dovessero ricavare d. 52 - <strong>di</strong> piccoli (colla tolleranza<br />
da piccoli, 49 - a 55 -J-): i grossi rispondevano al soldo<br />
dei piccoli dunque a grani 26 | , per modo che il<br />
soldo <strong>di</strong> grossi conteneva grani 320 o mezz'oncia,<br />
la libbra grossa grani 6400 o <strong>di</strong>eci once <strong>di</strong> fino.<br />
Anche questa volta la battitura non ebbe luogo<br />
a giu<strong>di</strong>care dal fatto che l'anno successivo la zecca<br />
fu affidata per un quinquennio a un Nicolò <strong>di</strong> Guglielmo<br />
bolognese. Nel 1284 nuova locazione ad<br />
Opizzino dei Laman<strong>di</strong>ni e a Matteo Culforato, ma<br />
non ne rimangono particolari: le notizie sono date<br />
così dai Memoriali dei notai Geremia Angelelli (1270)<br />
e Giovanni Barbarossa (1284) (22).<br />
Ed ora passiamo al quarto sistema della moneta<br />
bolognese, del 1289, ricordata anche dal Ghirar-<br />
dacci (23). Riassumiamo dalle lunghe provvigioni la<br />
parte che ci interessa. Sembra che i bolognesi sten-<br />
tassero a trovare un zecchiere, causa lo scarso profitto<br />
offerto, mentre cresceva il bisogno <strong>di</strong> moneta<br />
minuta il cui pregio era causa della sua esportazione<br />
al <strong>di</strong> fuori. È noto infatti che fin d'allora i bolognini<br />
avevano tal fama nei mercati che erano scelti e<br />
sparsi dovunque. Si bandì un invito che cadde a<br />
(21) V. doc. V.<br />
(22) Arch. cit. Cpm.<br />
(23) Historia dì Bologna. Bologna, Rossi, MDCV, i, 290.
LA ZECCA DI BOLOGNA 449<br />
vuoto;, cosichè il Comune nel novembre del 1289<br />
dovette affidare la zecca ai banchieri e ai mercanti.<br />
Quello che è notevole è che una <strong>com</strong>missione appo-<br />
sitamente scelta, suggerì una leggera riforma del<br />
sistema monetario, che fu accolta dal Consiglio quasi<br />
all' unanimità. I denari grossi si sarebbero coniati,<br />
<strong>com</strong>e pel passato, in ragione <strong>di</strong> 13 e 4 d. per libbra,<br />
ma dei piccoli ne sarebbero ricavati 53 per oncia,<br />
ossia 53 X 12 = 636 in luogo <strong>di</strong> 627 per libbra (24).<br />
A coniare bolognini grossi e piccoh fu chiamato<br />
nel 1291 un tal Gia<strong>com</strong>ino <strong>di</strong> Carlino maestro in<br />
quell'arte (Provvigioni F, e. 152, 153): egli, <strong>com</strong>e<br />
risulta da una memoria vista dallo Zanetti, fu della<br />
famiglia Truffi ed in origine era stato ban<strong>di</strong>to perchè<br />
seguace dei Lambertazzi.<br />
Nel 1295, 21 novembre nuova locazione della<br />
officina alla società dei cambiatori per sei anni per<br />
coniare bolognini grossi e piccoli (25) e l'anno dopo<br />
(24) Provvigioni, lett. H, e. 262, r. 272, r. e v.<br />
(25) 1295, 21 novembre, e. 64, v. Nella locazione della zecca al sindaco<br />
della società dei cambiatori è prescritto <strong>di</strong> coniare " ad sufìcentiam<br />
ita quod habundancia sit in civitate Bononie et <strong>di</strong>strictu de bononinis<br />
parvis et medaglolis scilicet quod due medagle valeant unum bononinum<br />
parvum bine ad sex annos proximos venturos monetam novam silicei<br />
de bononinis grossis et bononinis parvis erri boni argenti ponderis et<br />
lighe prout atenus in civitate Bononie fieri consuevit videlicet quod<br />
bononini grossi qui fieri debebunt sint et esse debeant ad decem ungias<br />
et terciam argenti veneti grossi vel erri boni et duas ungias minus<br />
terciam rammi et duodecim unzias bononinorum grossorum tali modo<br />
quod forciores minus sint ponderis tredecim soldorum et duorum bononenorum<br />
in marcha at flebiores non possint intrare plus quam tredecim<br />
soldos et sex denarios bononinorum in marcha ita quod <strong>com</strong>unales<br />
asendant tredecim soldos et quatuor denarios in marcha bon. scampita<br />
albos et rotundos. Ita quod bononini parvi qui fieri debebunt debeant<br />
fieri et esse ponderis duodecim unciarum bononinorum parvorum et<br />
due uncie et <strong>di</strong>mi<strong>di</strong>j quarterij argenti veneti grossi vel erri boni et<br />
novem ungiarum et trium quarteriorum et <strong>di</strong>mi<strong>di</strong>j rami et quod debeant<br />
asendere in uncia quinquaginta trium bononini parvi quod tali modo<br />
quod forciores non possint esse minus quinquaginta sex in unzia, ecc. „<br />
Memoriale <strong>di</strong> Bonifacio qd. Bonazunta da Savignano II semestre,<br />
1295, e. 64.<br />
57
450<br />
FRANCESCO MALAGUZZI<br />
cessione della zecca dai cambiatori ad un Andrea <strong>di</strong><br />
Bonino (Mem. <strong>di</strong> Gioannino <strong>di</strong> fra Deulay de Sala,<br />
I sem. 1296, 16 marzo). Dopo questo sembra non<br />
avvenissero mutamenti nella nostra moneta prima del<br />
governo dei Pepoli e il Ghirardacci e le scarse riformagioni<br />
<strong>di</strong> quel perìodo ci ricordano solamente<br />
che neir anno 1300, visti gli Statuti della città, si<br />
coniò altra moneta dal solito tipo e qualità (^6) ; che<br />
nel 1301 si bandì da Bologna la moneta imperiale<br />
perchè deficente <strong>di</strong> valore (^7); che nel 1305 fu ritirata<br />
dalla circolazione la moneta rasa e con essa se ne<br />
fabbricò altra (^S). finalmente che nel 1313 si battè<br />
ancora moneta (^9).<br />
La nomina <strong>di</strong> Taddeo Pepoli a signore della<br />
città, il 28 agosto 1337, fu salutata dal popolo <strong>com</strong>e<br />
il principio <strong>di</strong> un'era <strong>di</strong> pace per la città. Egh ricusò<br />
il titolo <strong>di</strong> " signore „, nome che suonava male in<br />
un <strong>com</strong>une che aveva tanto lottato per la libertà,<br />
preferì quello <strong>di</strong> capitano generale e datosi alle riforme<br />
che i nuovi tempi reclamavano, seppe presto<br />
conquistare buon nome presso il popolo (3°).<br />
Tra queste riforme ci interessa la nuova battitura<br />
<strong>di</strong> monete, <strong>di</strong> cui è fatto cenno in una provvigione<br />
del 20 febbraio 1338. La nuova moneta pepolese fu<br />
battuta a somiglianza degli agontani (corruzione <strong>di</strong><br />
" anconitani „) che equivalevano a due grossi l'uno<br />
o 23 denari ad Ancona e 24 a Bologna (31). Ne ri-<br />
(26) Provvigioni, lett. D, e. 14.<br />
(27) Ghirardacci, Op. cit. I, pag. 428 (dalle Riform. cit.).<br />
(28) id. Op, cit. I, pag. 563. V. i doc. e illustrazione nel<br />
recente scritto <strong>di</strong> G. B. Salvioni, Sul valore della lira bolognese, in<br />
Terza serie, Voi. XIV, fase. IV-VI degli Atti e M. d. R. Deput. <strong>di</strong> Storia<br />
patria per la Romagna.<br />
(29) Ghirardacci, Op. cit., I, pag. 563.<br />
(30) id. Op. cit.<br />
(31) Provvigioni <strong>di</strong> Taddeo Pepoli, 1338.
LA ZECCA DI BOLOGNA 45 1<br />
mangono prodotti: portano da un lato la leggenda<br />
TÀDEVS DE PEPVLIS all' ingiro e una croce greca nel<br />
mezzo (allusiva probabilmente all'impresa guelfa del<br />
Comune) e dall'altro lato la figura intera <strong>di</strong> S. Pietro<br />
nimbato colle parole all' ingiro S. P. (Petrus) DE<br />
BONONIA, allora venerato protettore della città. Di tal<br />
coniazione ci parla anche la cronaca Villola <strong>di</strong> quel<br />
secolo (32) e una grida dello stesso anno della batti-<br />
tura, che prescrisse che la nuova moneta non potesse<br />
spendersi che in città, <strong>com</strong>minando pene agli asportatori<br />
<strong>com</strong>e ai contraffatori (33); ma non sappiamo<br />
con precisione quale ne fosse il titolo ed il peso. Lo<br />
Zanetti assicura che le pepolesi da lui possedute<br />
pesavano 57 grani e quin<strong>di</strong>, da nuove, 58.<br />
Un documento visconteo del 1350 che prescrive<br />
che gli zecchieri milanesi dovessero battere bolognini<br />
grossi alla lega dei pepoleschi, coniati al tempo <strong>di</strong><br />
Taddeo, ammette <strong>com</strong>e grado <strong>di</strong> bontà oncie 9 e<br />
denari 22, ma lo Zanetti nei suoi saggi trovò invece<br />
IO, 14. Sopra alcune <strong>di</strong>versità <strong>di</strong> notizie relative al<br />
valore e alle leggende <strong>di</strong> questa moneta coniata da<br />
Taddeo non cre<strong>di</strong>amo necessario intrattenerci, essendo<br />
già stato notata da altri la loro poca atten<strong>di</strong>bilità,<br />
<strong>com</strong>provata dalla mancanza <strong>di</strong> altre monete pepolesi<br />
<strong>di</strong> quel periodo nelle collezioni italiane (34).<br />
Anche i figli <strong>di</strong> Taddeo Pepoh, Giovanni e Gia<strong>com</strong>o,<br />
subentrati al padre nel governo della città,<br />
coniarono nel 1349 nuovi bolognini col loro nome,<br />
che descriveremo a suo luogo, ed il Gherardacci ricorda<br />
inoltre che furono messi in circolazione sulla<br />
(32) Biblioteca Universitaria <strong>di</strong> Bologna.<br />
(33) Provvigioni cit.<br />
(34) Taddeo Pepoli eletto signore <strong>di</strong> Bologna. Moneta battuta sotto<br />
il suo governo. Domenico SuGA.NAper nozze Isolani. — Tattini. Bologna,<br />
R. Tip. 1864.
452<br />
FRANCESCO MALAGUZZI<br />
fine <strong>di</strong> queiranno e che con quelli furono <strong>di</strong>stribuite<br />
le mancie del Natale.<br />
L'anno susseguente i due figli <strong>di</strong> Taddeo, degeneri<br />
dal padre che aveva avuto a cuore la grandezza<br />
della città, vendevano Bologna all' arcivescovo <strong>di</strong><br />
Milano Giovanni Visconti, dando uno <strong>di</strong> quegli<br />
esempi <strong>di</strong> cui non è penuria nella storia del me<strong>di</strong>oevo.<br />
Sotto il nuovo dominio si coniarono bolognini grossi<br />
e piccoli.<br />
Da Milano l'arcivescovo mandava a Bologna i<br />
frateUi Maffiolo e Lorenzino de' Frotti per coniarvi<br />
monete, or<strong>di</strong>nando loro <strong>di</strong> provvedere l'argento e, nel<br />
caso, esonerandoli dal dazio. Radunatisi il 21 novem-<br />
bre gli Anziani, i Consoli e otto sapienti per quar-<br />
tiere chiamati dal Vicario, concordemente stabilirono<br />
che le nuove monete dovessero portar scritto, secondo<br />
l'or<strong>di</strong>ne dell'Arcivescovo nel <strong>di</strong>ritto la parola<br />
lOHES VICEC-OMES colle ultime quattro lettere nel-<br />
l'area <strong>di</strong>sposte in croce e nel rovescio il nome della<br />
città BO •<br />
NO<br />
• NI • e l'A finale nel campo , per seguire<br />
l'uso fino allora invalso nella zecca bolognese. La<br />
lega sarebbe stata la medesima dei pepolesi " zoè che<br />
la livra de l'ariento peso contegna unze <strong>di</strong>exe meno<br />
de dui d'argento fine almeno de liga de peso sieno<br />
vintidui bolognini grosi per onze e non plue, si che<br />
ne vadano ne la livra peso de romano bolognini<br />
doxento sexanta quattro e non plue, cum questa<br />
zunta che se gl'avignise che al deliberare la moneda<br />
se trovasero <strong>di</strong>nari uno e mezo de hga, meglo o peso<br />
ch'el pato sovrascripto, la Hvra a peso che la sia<br />
intera bona e fina „ (35).<br />
(35) V. Lodovico Frati, Documenti per la storia del governo visconteo<br />
in Bologna nel sec. XIV. (Arch. Storico Lombardo, Anno XVI,<br />
fase. Ili, 30 settembre 1889).
LA ZECCA DI BOLOGNA 45<br />
A far cessare del tutto l'ultimo ricordo della<br />
signoria dei Pepoli, un bando del 12 febbraio 1353,<br />
mentre era governatore pei Visconti, l'Oleggio, sta-<br />
bilì che entro otto giorni si spendessero o si portassero<br />
al banco <strong>di</strong> Ligo cambiatore (che ne avrebbe<br />
dato un fiorino d'oro <strong>di</strong> sol<strong>di</strong> 35, sebbene il ducato<br />
si spendesse per soli sol<strong>di</strong> 30)<br />
i bolognini grossi<br />
coniati da Taddeo che correvano per la città.<br />
Conseguenza <strong>di</strong> tal bando fu che nel susseguente<br />
anno 1351 si coniarono nuovi bolognini grossi, dello<br />
stesso tipo <strong>di</strong> quelli dell'anno precedente <strong>com</strong>e ci<br />
assicura una provvisione del 23 settembre: furono<br />
coniati dallo stesso zecchiere Maffiolo de' Frotti, della<br />
stessa lega dei precedenti, ma <strong>di</strong> soli ducento ses-<br />
santatre alla libbra " cum <strong>di</strong>mi<strong>di</strong>o. „ V'è ricordato<br />
che la officina era allora in capella <strong>di</strong> Santa Maria<br />
<strong>di</strong> Porta Ravennate (36).<br />
Il cronista Bartolomeo della Pugliola aveva at-<br />
tribuito all'Oleggio anche la coniazione <strong>di</strong> bolognini<br />
piccoli <strong>di</strong> cui v'era penuria in città perchè anche<br />
durante la signoria dei Pepoli non se n'eran battuti<br />
e aggiungeva che s'erano sparsi sul mercato nell'ot-<br />
tobre del 1351. Non si conosce alcun esemplare <strong>di</strong><br />
questo piccolo che dev'essere rarissimo. Il Zanetti<br />
ne possedette uno, ora perduto e ne dà la descri-<br />
zione. Aveva le stesse leggende del bolognino grosso<br />
visconteo sopra descritto con alcune stellette in luogo<br />
dei punti fra le lettere: non pesava che grammi io<br />
e forse doveva pesarne 11 appena uscito <strong>di</strong> zecca:<br />
sembrava contenere poco più <strong>di</strong> un'oncia e mezzo<br />
<strong>di</strong> fino per libbra e per conseguenza il suo valore,<br />
secondo il Zanetti, era <strong>di</strong> un denaro o sia bolognino<br />
piccolo, do<strong>di</strong>ci dei quali formavano il grosso.<br />
Non abbiamo notizie importanti della zecca bo-<br />
(36) Frati, ibid.
454<br />
FRANCESCO MALAGUZZI<br />
lognese sotto i successivi governi <strong>di</strong> Innocenzo VI<br />
(1352-1362), <strong>di</strong> Urbano V (1362-1372) del quale ci<br />
rimane un bolognino d' argento col suo nome e ritratto<br />
e <strong>di</strong> Gregorio XI (1372-1378) anche per mancanza<br />
<strong>di</strong> carte <strong>di</strong> quel tempo negli archivi pubblici.<br />
Importantissima invece è la innovazione creata<br />
nel 1379, ed attuata dopo il 1° gennaio dell'anno sus-<br />
seguente, sotto la signoria della Chiesa, cioè l'introduzione<br />
per la prima volta del fiorino d'oro. La nuova<br />
moneta fu chiamata bolognino d' oro, cosicché da al-<br />
lora il bolognino fu <strong>com</strong>pletamente introdotto nelle<br />
tre materie ormai adottate negli scambi : oro, argento<br />
e rame. Ne assunsero la coniazione Bernardo<br />
<strong>di</strong> Domenico Nardo e Zenobio <strong>di</strong> Paolo de Jaceto,<br />
fiorentini, e il nuovo bolognino fu battuto ad imita-<br />
zione del ducato veneziano (mantenutosi più fedele<br />
al tipo originario del fiorino <strong>di</strong> Firenze) e quin<strong>di</strong><br />
d'oro purissimo in ragione <strong>di</strong> 102 fiorini per Hbbra<br />
d'oro, ossia del peso <strong>di</strong> grani 75 gf per cadauno (^)<br />
che sono grammi metrici 3,5471. Il fiorino venne<br />
valutato a 34<br />
grossi d'argento, cioè a 2 s. io d. <strong>di</strong><br />
grossi, corrispondenti, secondo 1' ultimo ragguaglio<br />
del 1289, a 906 grani <strong>di</strong> puro argento : e si ricaverebbe<br />
per il : 1379: 75 90 = I : 12. 8, <strong>com</strong>e ragguaglio<br />
fra i due metalli (37). Bologna che, <strong>com</strong>e vedemmo,<br />
non aveva accolto molto tempo prima le proposte<br />
del podestà Andrea Zeno, ebbe così soltanto allora<br />
il fiorino quando questo era già stato accolto in molte<br />
parti d'Europa.<br />
Porta nel <strong>di</strong>ritto il motto BONOMIA DOCET (che fu<br />
introdotto per la prima volta a ricordare al mondo<br />
civile la gloria dello Stu<strong>di</strong>o) e il leone rampante collo<br />
(37) Salvioni, Op. cit.
LA ZECCA DI BOLOGNA 455<br />
stendardo dalla croce <strong>com</strong>unale (38) e nel rovescio il<br />
S. Pietro in pie<strong>di</strong> colle parole all'ingiro S. PETRVS<br />
APOSTOLVS. Ai bolognini d'argento fu lasciato il motto<br />
MATER STVDIORVM, <strong>com</strong>e si vedrà nelle descrizioni<br />
delle monete che riporteremo a suo luogo.<br />
In questo tempo però andavano <strong>di</strong>minuendo <strong>di</strong><br />
qualità i piccioli, dei quali se ne ricavavano 768 per<br />
libbra e l'argento essendo ridotto a grani 1226 j,<br />
ogni denaro non conteneva più <strong>di</strong> grani i ^ <strong>di</strong> fino :<br />
<strong>di</strong> qui il deprezzamento dei danni piccoli e la ne-<br />
cessità <strong>di</strong> una moneta spicciola più grossa nei quat-<br />
trini coniati, <strong>com</strong>e vedremo, nel 1404 e che equiva-<br />
levano a due soli dei nostri denari (39).<br />
Del 1385 ci rimane l'in<strong>di</strong>cazione precisa del luogo<br />
in cui era la zecca in un atto dell' 8 novembre, da<br />
cui risulta che presenti all'estrazione delle monete<br />
erano i rappresentanti del Comune, i cambiatori e<br />
una rappresentanza della società degli orefici <strong>com</strong>e<br />
interessata a conoscere il saggio delle monete co-<br />
niate: vi è detto che teneva l'officina Tommaso <strong>di</strong><br />
ser Gerardo de la Lana, cessionario <strong>di</strong> Rodolfo dei<br />
Sabatini e che l'officina era posta in capella sanda<br />
Teck de Portauova ossia circa nella località dell'attuale<br />
palazzo degli Anziani. Nel XIII secolo invece era<br />
stata presso (forse dentro) il palazzo del Podestà.<br />
Trovammo che, nel 1433 non era più nel luogo<br />
sopradetto. Vedremo che più tar<strong>di</strong> fu situata al pian<br />
terreno <strong>di</strong> una delle case Bentivoglio e che solamente<br />
verso la fine del XVI secolo fu costrutto espressamente<br />
il palazzo della zecca che rimane tuttora.<br />
Nel 1398 22 aprile, nuova provvigione per coniar<br />
(38) Si noti che la croce rossa in campo bianco è lo stemma del<br />
Comune e il motto libertas quello del Popolo. Nel sec. XIV in<strong>com</strong>inciarono<br />
ad essere uniti insieme.<br />
(39) Salvioni, Op. cit.
456<br />
FRANCESCO MALAGUZZI<br />
moneta d'ogni metallo in Bologna, ma senza nuovi<br />
particolari (4°).<br />
Così si chiude la serie delle notizie <strong>di</strong> questo<br />
periodo, <strong>di</strong> non poco interesse per il monetografo,<br />
che se non trova in quei primi prodotti la bellezza<br />
<strong>di</strong> quelH che seguirono, in <strong>com</strong>penso può stu<strong>di</strong>arne<br />
meglio la varietà ed assistere ai progressivi risultati<br />
a cui fin d'allora seppe arrivare quel ramo importante<br />
della pubblica amministrazione.<br />
(40) Provv. in capreto G 1394-1400, e. 18, 2* numerata.
CAPITOLO IL<br />
La zecca nei perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> Giovanni I Bentivoglio, dei Visconti, dei papi,<br />
<strong>di</strong> Sante Bentivoglio — Giovanni II Bentivoglio — Locazioni della<br />
zecca — L'incisore dei conii Antonio Magnani — La battitura<br />
del 1476 — Il corso delle monete a Bologna nel sec. XV — Il privilegio<br />
dell'imperatore Massimiliano a Gio. II <strong>di</strong> coniar moneta —<br />
Le zecche bentivolesche <strong>di</strong> Covo e Antignate — Falsificatori e<br />
tosatori <strong>di</strong> monete nel sec. XV.<br />
Il secolo XV è il più interessante per la nostra<br />
illustrazione, sia per L abbondanza delle notizie documentate,<br />
che per il fatto <strong>di</strong> essere il secolo aureo<br />
per la <strong>numismatica</strong>, <strong>com</strong>e per gli altri rami dell'arte<br />
<strong>italiana</strong>.<br />
Nel 1401, ai 27 <strong>di</strong> febbraio, Giovanni I Bentivoglio,<br />
appoggiato dai suoi, dopo un <strong>com</strong>battimento<br />
in piazza, aveva occupato il palazzo della Signoria<br />
<strong>di</strong> Bologna e si era fatto nominare magnifico e potente<br />
signore. Il periodo che seguì fu tra i più tristi della<br />
storia citta<strong>di</strong>na: Bologna, <strong>di</strong>visa in Scacchesi e Mal-<br />
traversi, non tollerò il nuovo giogo da cui la liberò,<br />
dopo un solo anno <strong>di</strong> signoria, l'esercito <strong>di</strong> Gianga-<br />
leazzo Visconti: questi ricuperò così la città tolta<br />
già alla sua casa dal car<strong>di</strong>nale Albornoz. Giovanni<br />
perdette, col potere, la vita, nella battaglia <strong>di</strong> Ca-<br />
salecchio.<br />
Del breve periodo del primo Bentivogho, si<br />
conosce un rarissimo bolognino d'oro e un denaro,<br />
mentre l'officina era affittata a un Antonio da Montone.<br />
Da un registro per le estrazioni delle monete,<br />
del 1401 e seguenti, rileviamo che <strong>di</strong> quei bolognini<br />
d'oro ne andavano 102 per ogni libbra <strong>di</strong> peso, secondo<br />
la lega bolognese, e <strong>di</strong> queUi d'argento ne<br />
andavano da prima lire 14 e sol<strong>di</strong> 9 per ogni libbra<br />
58
458<br />
FRANCESCO MALAGUZZI<br />
<strong>di</strong> peso e tenevano once 9, denari 22 <strong>di</strong> argento fino<br />
per libbra, mentre nel 1402 ne andavano lire 14 e<br />
sol<strong>di</strong> IO e tenevano (a detta degli assaggiatori) once<br />
IO <strong>di</strong> argento fino (0. Questa <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> peso nella<br />
stessa moneta a <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> un anno solo ci prova<br />
una volta <strong>di</strong> piiì quanto fosse imperfetta la tecnica<br />
della fabbricazione delle monete nel me<strong>di</strong>oevo, con<br />
gran fortuna de' tosatori e falsificatori. All'estrazione<br />
delle monete eran presenti i <strong>di</strong>fensori dell'avere e<br />
dei <strong>di</strong>ritti della Camera o uno da essi delegato, il<br />
<strong>di</strong>fensore della società del cambio della città, tre<br />
cambiatori, il rettore della società degli orefici con<br />
uno o pili membri della società, e uno de' soprastanti<br />
alla zecca. L'officina, in quel tempo, era ancora in una<br />
casa della parrocchia <strong>di</strong> Santa Tecla <strong>di</strong> Portanuova.<br />
Alla morte <strong>di</strong> Giangaleazzo Visconti la duchessa<br />
Caterina, vedendo sfasciarsi il suo stato, venne ad<br />
accor<strong>di</strong> e cedette la città alla chiesa (1403). A Innocenzo<br />
successo papa Gregorio XII, <strong>di</strong> casa Correr<br />
<strong>di</strong> Venezia (1406-1409), si coniarono nuove monete<br />
<strong>di</strong> rame. Ai io <strong>di</strong>cembre 1406 il Legato or<strong>di</strong>nava<br />
che, causa la riduzione successiva dei piccoli che<br />
reclamava una moneta spicciola più grossa, si co-<br />
niassero nuove monete da due denari, dette qviattrini<br />
(perchè a imitazione <strong>di</strong> queUi <strong>di</strong> Milano che ne valevano<br />
quattro), portanti l' imagine <strong>di</strong> S. Petronio<br />
da l'un lato e le chiavi decussate dall'altro.<br />
La scarsezza <strong>di</strong> documenti per questi primi<br />
decenni del secolo ci vieta <strong>di</strong> entrare in particolari<br />
sulle battiture precedenti al periodo <strong>di</strong> Eugenio IV."<br />
È noto che la storia citta<strong>di</strong>na bolognese <strong>di</strong> quel<br />
(i) Tutte le citazioni <strong>di</strong> documenti sottintendono per 1* avvenire<br />
l'in<strong>di</strong>cazione: Archivio <strong>di</strong> Stato <strong>di</strong> Bologna. Negli altri Archivi della re-<br />
gione, nei quali non mancammo <strong>di</strong> far ricerche, non trovammo quasi nulla.
LA ZECCA DI BOLOGNA 459<br />
tempo è piena <strong>di</strong> lotte intestine e vicende tristi.<br />
Sollevazione della plebe a mo' dei Ciompi (ii maggio<br />
141 1), deposizione dei magistrati e <strong>di</strong>struzione della<br />
fortezza <strong>di</strong> Galliera, rivincita e ritorno dei nobili,<br />
ricaduta la città sotto i pontefici (14 agosto 141 2).<br />
Nuove rivolte poco dopo ed elezione della città a<br />
repubblica, con a capo Antongaleazzo <strong>di</strong> Giovanni<br />
Bentivoglio (1420): rinacquero le vecchie fazioni sotto<br />
i nomi <strong>di</strong> bentivolesca e cannesca. Finalmente la<br />
città ricadde sotto la chiesa, governata allora da<br />
Martino V (Colonna 1417-1431). Del 2 ottobre 1412<br />
ci rimangono i capitoli relativi agli ufficiali deputati<br />
al cumulo delle monete dal Comune, approvati dal<br />
luogotenente del Legato (2). Al breve periodo <strong>di</strong> li-<br />
bertà appartengono probabimente alcuni bolognini<br />
d'argento, senza alcun segno <strong>di</strong> signoria, che descriveremo<br />
a suo luogo. Ai primi anni del governo <strong>di</strong><br />
Martino V vanno ascritte invece le monete d'argento<br />
col motto BONONIA MATER STVDIORVM e le chiavi de-<br />
cussate poste fra una colonna coronata e un leoncino,<br />
pubblicate dal BelHni.<br />
Eugenio IV (Condulmiero, 1431-1447) nel pe-<br />
riodo in cui tenne Bologna battè monete d'oro, d'ar-<br />
gento e <strong>di</strong> mistura: le prime fatte a mò <strong>di</strong> zecchini<br />
<strong>di</strong> Roma, le seconde, i grossoni, con S. Pietro e<br />
S. Paolo ben note. Di queste coniazioni rimangono<br />
esemplari e memoria in un bando (s) e i nomi dei<br />
(2) Comunale, Libro Fantaccini, e. 66 e 67.<br />
(3)<br />
" Per parte del Reveren<strong>di</strong>ssimo in Cristo padre e signore Monsignore<br />
misser Daniel per la Dio gratia Vescovo <strong>di</strong> Concor<strong>di</strong>a, Governadore<br />
de la cita contado e <strong>di</strong>stretto <strong>di</strong> Bologna per la Santa Romana<br />
ghiesia e per lo Santissimo in Cristo padre e signor nostro Misser<br />
Eugenio per la <strong>di</strong>vina providentia papa IV. Se fa noto e manifesto a<br />
tutte e zaschune persone che novamente se batte per ly condusedurj<br />
de la Cecha de Bologna Monede de Ariento a la liga de Bologna ly<br />
quali se chiamaran grosoni de papa ly quali hano da una parte la yma-
460<br />
FRANCESCO MALAGUZZI<br />
coniatori Vicizosco (?) e Tommaso Lodovici per una<br />
coniazione <strong>di</strong> L. 5000 in un mandato della Tesoreria<br />
(Giornali 1437 1° sem. 27 febb.).<br />
Nel maggio del 1438 altre sorprese nella <strong>di</strong>-<br />
sgraziata città. Favorito da molti citta<strong>di</strong>ni che preferivano<br />
la signoria del Visconti a quella troppo<br />
severa del legato, Francesco Piccinino entra in città<br />
colle truppe milanesi, saccheggia il palazzo pubblico<br />
mal <strong>di</strong>feso dalle scarse truppe del papa, s'impadro-<br />
nisce del Castello <strong>di</strong> Galliera e proclama la signoria<br />
del Visconti sopra il bolognese U).<br />
A questo tempo appartengono probabilmente<br />
alcune monete bolognesi d' argento e <strong>di</strong> mistura<br />
coir impresa viscontea da un lato.<br />
Le angherie e le violenze raddoppiarono sotto<br />
il nuovo governo e a desolare la città si aggiunsero<br />
le lotte, fino allora assopite ma non spente, delle<br />
fazioni. La parte bentivolesca, numerosissima, pose<br />
le sue speranze su Annibale, figlio naturale <strong>di</strong> Antongaleazzo<br />
e che militava allora sotto TAttendolo:<br />
questi venne e s'impadronì della città (1443). Ma i<br />
Canetoli, partigiani dei Visconti, insorti a ribellione,<br />
pugnalarono Annibale e misero a sacco la città. La<br />
vittoria rimase ai bentivoleschi che si elessero a capo<br />
Sante Bentivoglio, il quale prese il primato della città<br />
a 22 anni (1446). Questi fu uno dei mighori signori<br />
<strong>di</strong> Bologna :<br />
acquetò<br />
le fazioni e definì la lunga con-<br />
troversia col papato me<strong>di</strong>ante i capitoli approvati da<br />
Nicolò V e che fissarono il Hmite fra il potere pon-<br />
gine <strong>di</strong> misser Sam Petronio e de laltra parte le chiave cum larma del<br />
prefato santissimo nostro signore misser lo papa tra esse, e valeno e<br />
vole el <strong>di</strong>tto R.o padre misser lo governadore che se spendano e<br />
debiani spendere per zaschuno in la <strong>di</strong>tta cita, contado e <strong>di</strong>stretto de<br />
Bologna per <strong>di</strong>nari trenta de pizoli overo quindese quatrini de Bologna<br />
de moneda de <strong>di</strong>tti pizoli overo quatrini. Al nome de Dio e de Bo-<br />
logna. „ (Comunale, Uff." <strong>di</strong> zecca. Busta i.* Decreti).<br />
(4) S. Muzzi, Annali della città <strong>di</strong> Bologna. Bologna, 1842, Voi. IV.
LA ZECCA DI BOLOGNA 461<br />
tificio e le franchigie municipali (22 agosto 1447).<br />
La signoria <strong>di</strong> Sante, che durò 16 anni, nominalmente<br />
<strong>di</strong>pendeva dalla chiesa. Le monete <strong>di</strong> questo<br />
periodo fino al suo successore Giovanni II portarono<br />
quin<strong>di</strong> l'arma del pontefice e le sue insegne.<br />
A garantire il buon andamento dell'officina monetaria<br />
il legato pontificio si riservò per l'avvenire<br />
la nomina <strong>di</strong> un suo rappresentante che si trovasse<br />
presente all'estrazione delle monete d'oro, d'argento<br />
e <strong>di</strong> rame (s).<br />
Di un progetto <strong>di</strong> coniazione nel 1449 ci lasciò<br />
ricordo il Zanetti (ms. 6 — VI Istrumenti <strong>di</strong> Zecca)<br />
che trascrisse un atto del 24 ottobre <strong>di</strong> quell'anno<br />
che qui riassumiamo:<br />
I. 16 Riformatori, considerando il gran pregiu<strong>di</strong>zio per<br />
l'ommissione fatta in passato <strong>di</strong> batter moneta, massime per<br />
l'abuso grande d'essersi introdotte monete forestiere <strong>di</strong> lega<br />
inferiore ed a prezzi incongrui al loro intrinseco, deputarono<br />
soprastanti alla Zecca Nicolò Sanuti e Bartolomeo <strong>di</strong> Mino<br />
Rossi per anni cinque dal i gennaio 1450 coi patti e capitoli<br />
seguenti :<br />
Che nessuno fuori dei due detti potesse batter o far<br />
batter monete.<br />
Che la Camera fosse obbligata a pagare la pigione d'una<br />
casa atta alla Zecca.<br />
Che si deputasse un Guar<strong>di</strong>ano e il soprastante da salariarsi<br />
dalla Camera <strong>di</strong> Bologna che gli somministrasse anche<br />
il sale necessario a 20 sol<strong>di</strong> la corba.<br />
Che si dovessero battere bolognini alla lega usata cioè<br />
a oncie 9 o denari 22 e avere denari due <strong>di</strong> peso per libbra<br />
<strong>di</strong> tolleranza ; e i quattrini a once una e denari 22 e avere<br />
denari due per libbra <strong>di</strong> tolleranza. E che dei bolognini ne<br />
andassero alla libbra <strong>di</strong> peso L. 17.4 che sono all'oncia a<br />
ragione <strong>di</strong> sol<strong>di</strong> 28 ^ e avere sol<strong>di</strong> due <strong>di</strong> bolognini per libbra<br />
<strong>di</strong> peso <strong>di</strong> tolleranza. E che tutti i bolognini e quattrini dovessero<br />
essere <strong>di</strong> peso bene or<strong>di</strong>nati. E che <strong>di</strong> quattrini ne<br />
(5) Comunale, Partiti. Voi. I, e. 46, r.
462<br />
FRANCESCO MALAGUZZI<br />
dovesse andare alla libbra <strong>di</strong> peso L. 3.18 e avere sol<strong>di</strong> 2<br />
per libbra <strong>di</strong> peso <strong>di</strong> tolleranza.<br />
Che non si potesse estrarre dalla città o contado <strong>di</strong><br />
Bologna oro o argento in verga e monete forestiere, ecc.,<br />
che pel transito <strong>di</strong> argento in verga o monete forestiere occorresse<br />
il permesso dei due detti sovrastanti; che chi volesse<br />
mettere argento in Zecca pagasse per libbra lordo <strong>di</strong> peso<br />
sol<strong>di</strong> 12 <strong>di</strong> fattura e sol<strong>di</strong> 6 <strong>di</strong> affinatura, ecc.<br />
Che si battessero piccoli alla stampa usata e alla lega<br />
dei quattrini che ne andassero L. 3.ig, alla libbra <strong>di</strong> peso<br />
con denari 2 <strong>di</strong> tolleranza e sol<strong>di</strong> 2 <strong>di</strong> tolleranza per libbra.<br />
Che dopo due mesi da tal battitura si ban<strong>di</strong>sse la moneta<br />
forestiera che non fosse della bontà della bolognese. Che si<br />
pagasse il salario <strong>di</strong> L. 7 il mese a un garzone per stare<br />
continuamente sopra i maestri <strong>di</strong> Zecca. Che dei bolognini<br />
ne andassero all'oncia sol<strong>di</strong> 2g. I bolognini d'oro che si batteranno<br />
essendo <strong>di</strong> bontà, lega e peso dei due Veneziani<br />
<strong>com</strong>e tali si spendessero (Appr. 21 genn. 1450).<br />
E qui in<strong>com</strong>inciamo ad avere notizie degli inci-<br />
sori delle monete. Tra le denunzie dei forestieri che<br />
venivano a domiciliare a Bologna, sotto le date 4 marzo<br />
e 6 aprile 1451, troviamo i nomi <strong>di</strong> Pietro <strong>di</strong> Ber-<br />
tolino Maestri da Reggio, incisore <strong>di</strong> monete e <strong>di</strong><br />
Nicolò <strong>di</strong> Francesco Ferini da Firenze maestro <strong>di</strong><br />
Zecca e pratico anche della tecnica perchè è detto<br />
nel documento ch'egli venne a Bologna per lavorare<br />
in Zecca (6). Se però costoro furono realmente appli-<br />
cati subito all'officina, l'opera loro dev'essersi limitata<br />
a rac<strong>com</strong>odare vecchi ponzoni o tutt'al pili a rifare<br />
queUi per qualche moneta piccola, perchè del 1° periodo<br />
<strong>di</strong> Sante Bentivoglio non conosciamo moneta<br />
d'oro o d'argento e quelle attribuitegli da qualcuno<br />
sono invece del tempo <strong>di</strong> Giovanni II, <strong>com</strong>e ci assicurano<br />
i capitoh, che riporteremo a suo luogo. Nel 1455<br />
erano bensì maestri <strong>di</strong> Zecca un Benedetto <strong>di</strong> An-<br />
tonio del Montone e Bartolomeo Mino Rossi tra i<br />
(6) Arch. cit.
LA ZECCA DI BOLOGNA 463<br />
quali era insorta certa questione relativa a monete<br />
coniate (7), ma non è chiaro se si trattasse <strong>di</strong> conia-<br />
zioni recenti e dell' officina bolognese. Frattanto a<br />
Bologna avevano corso monete forestiere <strong>di</strong> ogni<br />
sorta e un bando del i" luglio 1459 prescriveva che<br />
non si potessero spendere i nuovi pecchioni dalla<br />
palma <strong>di</strong> Milano per più <strong>di</strong> otto quattrini 1' uno e i<br />
bolognini marchesani per piìi <strong>di</strong> cinque
464<br />
FRANCESCO MALAGUZZI<br />
cum litere intorno che <strong>di</strong>cano Sanctus petrus apostolus<br />
con doe arme pichole da i pie<strong>di</strong> zoe del populo e<br />
del legato. Et da laltro lato uno Lione dritto cum<br />
le ban<strong>di</strong>ere de la croxe overo cum larma del papa<br />
cum litere intorno che <strong>di</strong>cano Bononia docet. Su li<br />
quali ducatj siano arme- del papa et de monsignore e<br />
signi de li maestre de ceche (sic) posti in luogo dove<br />
<strong>di</strong>cano li soprastanti pre<strong>di</strong>ctj. „ Il peso sarebbe stato<br />
<strong>di</strong> 18 carati^: ne sarebbero andati alla libbra 103,<br />
la lega <strong>di</strong> 23 car. e ^|^; la mercede ai locatari era<br />
fissata in sol<strong>di</strong> 38 per ogni Hbbra <strong>di</strong> peso nel caso<br />
che qualche privato portasse oro in zecca.<br />
I bolognini piccoli d' argento dovevano esser<br />
stampati così: « da un lato li sia intorno scripto e<br />
stampato Bononia cum la <strong>di</strong>eta •<br />
• A<br />
in mezo et da<br />
laltro lato li sia intorno scripto docet et nel mezo li<br />
sia uno lione dricto cum la ban<strong>di</strong>era de la croxe<br />
nelle zampe denanzi » (e una nota in margine ag-<br />
giunge: « overo che da un lato <strong>di</strong>cha Bononia, e<br />
da laltro <strong>di</strong>cha mater stu<strong>di</strong>orum »). Ne sarebbero<br />
andati « a la unza <strong>di</strong> pexo al più bolognini 34 et<br />
ala libra <strong>di</strong> pexo bolognini trecento novantasie "<br />
alla lega <strong>di</strong> once nove e cinque sesti <strong>di</strong> argento fino<br />
per libbra <strong>di</strong> peso con un sesto <strong>di</strong> rime<strong>di</strong>o per libbra.<br />
I bolognini grossi d'argento dovevano « essere<br />
stampatj <strong>di</strong> queste insegne zoe da uno lato li debia<br />
essere scolpito Sam Petronio cum la città de Bologna<br />
in mano e de intorno li siano queste littere: Sanctus<br />
Petronius Bonon. epischopus cum duj circulj intorno.<br />
Et da laltro lado li debia essere uno lione cum la<br />
ban<strong>di</strong>era <strong>com</strong>ò ha el bolognino doro cum littere<br />
intorno che <strong>di</strong>cano Bononia mater stu<strong>di</strong>orum cum<br />
duj circulj <strong>di</strong>ntorno. » Tali grossi valevano quattro<br />
bolognini d'argento.<br />
I quattrini sarebbero stati alla lega <strong>di</strong> once una<br />
e denari 22 <strong>di</strong> argento fino per libbra <strong>di</strong> peso e
LA ZECCA DI BOLOGNA 465<br />
once IO e denari 2 <strong>di</strong> rame con rime<strong>di</strong>o <strong>di</strong> 2 denari<br />
d'argento fino per libbra (1°). Con tali impronte: « da<br />
un lado li sia sam Petronio a sedere cum duj circulj<br />
intorno cum littere che <strong>di</strong>cano Sanctus Petronhis et<br />
da laltro lado li debia essere le chiave in croxe cum<br />
duj circulj intorno a le <strong>di</strong>ete chiave cum littere che<br />
<strong>di</strong>cano de Bononia. »<br />
I denari piccoli sarebbero pure stati alla lega <strong>di</strong><br />
oncia una e denari 22 <strong>di</strong> argento fino per libbra <strong>di</strong><br />
peso e once io e denari 2 <strong>di</strong> rame con rime<strong>di</strong>o <strong>di</strong><br />
2 denari d' argento fino per libbra. Le impronte<br />
sarebbero state : « da uno lato li sia larma del<br />
<strong>com</strong>une de Bologna zoe larma cum la croxe e gigli<br />
cum duj circulj intorno la <strong>di</strong>eta arma cum littere che<br />
<strong>di</strong>cano Bononia et da laltro lato debia essere uno<br />
Lione dricto cum la ban<strong>di</strong>era del <strong>com</strong>une cum la<br />
croxe dentro et cum duj circulj intorno cum littere<br />
che <strong>di</strong>cano Bononia docet » (^0.<br />
II contratto <strong>di</strong> locazione prosegue prescrivendo<br />
l'obbligo pel Canonici <strong>di</strong> tenere un registro gelosamente<br />
custo<strong>di</strong>to per notarvi la quantità d' oro e<br />
argento che entrerebbe o sortirebbe dall'officina: <strong>di</strong><br />
pagare i garzoni : <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>re sotto chiave in una<br />
stanza sorvegliata da un custode i ponzoni: e stabi-<br />
lisce i particolari relativi al saggio delle monete,<br />
alle richieste dei privati, all'esenzione dai dazi da<br />
parte del locatario per introdurre in città oro e<br />
argento in materia prima, ecc. Poco dopo una grida<br />
stabiliva che si era fissato che i nuovi bolognini d'oro<br />
sarebbero del peso <strong>di</strong> 18 carati cum <strong>di</strong>mi<strong>di</strong>o e che<br />
i denari piccoli dovrebbero essere spesi e accettati<br />
(io) Da ogni libbra si ricavavano 4 lire ed 8 sol<strong>di</strong> al più cioè denari<br />
960 più 96 che sono 1056, ma non è espresso chiaramente che ognuno<br />
ne debba contenere 2 e quin<strong>di</strong> che il loro peso debba essere doppio<br />
dei denari piccoli <strong>di</strong> cui si parla dopo.<br />
(11) Zecca, loc. cit.
466 FRANCESCO MALAGUZZI<br />
dai dazieri, e dai gabellieri coli' aggio <strong>di</strong> 20 denari<br />
per libbra d'argento (^^K<br />
Il Canonici però non si attenne sempre alle<br />
con<strong>di</strong>zioni stabilite. Nel giugno dello stesso anno,<br />
appena in<strong>com</strong>inciata la battitura, gli assaggiatori<br />
riferivano che 83 libbre <strong>di</strong> denari piccoli erano stati<br />
trovati calanti, perchè alla lega <strong>di</strong> un'oncia e soli<br />
denari 19 e ^l. Per quella volta si permise che le<br />
monete sortissero ugualmente <strong>di</strong> zecca, nonostante<br />
ciò che era prescritto, ma si condannò il maestro <strong>di</strong><br />
zecca a pagare 40 sol<strong>di</strong> alla fabbrica <strong>di</strong> S. Petronio (^3).<br />
Questa coniazione dunque è uguale a quella del<br />
successivo 1464 e perciò abbiamo voluto intrattenerci<br />
nei particolari del contratto. Quanto ai prodotti delle<br />
due battiture, il lettore ne troverà le descrizioni in<br />
seguito.<br />
Sante BentivogHo moriva il 1° ottobre 1463 e<br />
veniva eletto a suo successore Giovanni II, figlio <strong>di</strong><br />
Annibale, che prese il titolo <strong>di</strong> Gonfaloniere <strong>di</strong> Giu-<br />
stizia, massima carica dello Stato (h). Solo in seguito<br />
Paolo II lo nominò presidente a vita dei Riformatori,<br />
(nei quali fin dal 1447, pe' famosi capitoli <strong>di</strong> Nicolò V<br />
era stata trasfusa tutta l'autorità del governo bolo-<br />
gnese, e il loro numero fu portato a 21, pur essi a<br />
vita, e <strong>di</strong>visi in due sezioni che governavano alternativamente<br />
per 6 mesi).<br />
Il periodo <strong>di</strong> Giovanni II, gran mecenate e che<br />
non trascurava occasione per atteggiarsi a padre<br />
della patria, (sull' esempio dei signori della vicina<br />
Ferrara, dalla quale chiamò artisti a schiere per far<br />
rifiorire in Bologna l'arte e specialmente la pittura,<br />
sulla quale sorse presto gigante Francesco Francia) è<br />
(12) Parmi, 5, e. 44, r.<br />
(13) Ibid., e. 34, r.<br />
(14) GoZZADINI, Op. Cit.
LA ZECCA DI BOLOGNA 467<br />
d'interesse speciale anche per noi e non fu consi-<br />
derato ancora sotto l'aspetto che ci siamo proposti.<br />
Troveremo <strong>di</strong> quel periodo una produzione <strong>di</strong> me-<br />
daglie e monete veramente eccezionale: cosichc pclla<br />
loro finezza e bellezza questi prodotti, sparsi nelle<br />
nostre collezioni, possono stare a confronto colle<br />
migliori cose del genere del rinascimento. L'abbondanza<br />
dei documenti e le notizie <strong>di</strong> nuovi incisori<br />
<strong>di</strong> questo periodo porgeranno quin<strong>di</strong>, lo speriamo,<br />
non piccola ragione <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfazione ai cultori degli<br />
stu<strong>di</strong> numismatici.<br />
Al principio della signoria <strong>di</strong> Giovanni II veni-<br />
vano pubblicate alcune gride : una<br />
contro quclH che<br />
portavano oro e argento non monetato fuori <strong>di</strong> Bo-<br />
logna: un'altra che prescriveva che si ban<strong>di</strong>ssero<br />
dagh scambi monete basse forestiere: una terza che<br />
or<strong>di</strong>nava che i fiorini del Reno non si potessero<br />
spendere ne ricevere per più <strong>di</strong> 42 bolognini purché<br />
<strong>di</strong> buon conio e <strong>di</strong> peso <strong>di</strong> 18 carati e - ('5).<br />
Il contratto <strong>di</strong> locazione della zecca del 4 aprile<br />
1464 per cinque anni ai mercanti citta<strong>di</strong>ni Paolo <strong>di</strong><br />
ser Marco de' Lupari e Giovanni <strong>di</strong> Bon<strong>com</strong>pagno<br />
Federici è stato pubblicato dall'Argelati e non <strong>di</strong>ffe-<br />
risce in sostanza da quello dell'anno precedente, <strong>di</strong><br />
cui ci siamo intrattenuti. È anch'esso in italiano,<br />
meno il proemio, il titolo dei primi capitoli e la<br />
sottoscrizione del cancelliere (^^). Le monete e le<br />
(15) Partiti, 17 aprile, 19 maggio, 24 maggio 1464 e Zecca B. i,<br />
(Decreti).<br />
(16) F. Argelati, De monetis Italie, t. IV. Importanti osservazioni<br />
nel campo economico da questo documento posto a raffronto con altri<br />
pure relativi alla zecca bolognese trasse il prof. G. Salvioni nel suo<br />
scritto citato La moneta bolognese e la traduzione <strong>italiana</strong> del Savigny<br />
(Atti e Memorie della R. Dep. <strong>di</strong> Storia Patria per la Romagna, IH serie,<br />
Voi. XII). Preziosissima vi è l'unita tavola della moneta bolognese dal<br />
iiQi al 1464 che cre<strong>di</strong>amo utile tener presente anche pe' nostri stu<strong>di</strong> e<br />
che riportiamo in appen<strong>di</strong>ce.
468<br />
FRANCESCO MALAGUZZ<br />
relative impronte rimasero le stesse stabilite l' anno<br />
prima. Seguirono altre gride d'indole varia: per<br />
limitare il valore dei pecchioni milanesi, in corso a<br />
Bologna, a otto quattrini l'uno: per <strong>com</strong>minare pene<br />
ai falsificatori e tosatori <strong>di</strong> monete, sempre numerosi<br />
qui, <strong>com</strong>e dovunque: per stabilire che le monete<br />
tosate si dovessero accettare per -| <strong>di</strong> meno del valore<br />
solito e che i ducali veneti fossero ridotti a sol<strong>di</strong> 57<br />
e i fiorini a 56 (11 ottobre 1470): i grossi fiorentini<br />
e i grossetti del cavallotto essendo stati riconosciuti<br />
<strong>di</strong> non giusto peso furono messi a soli 20 quattrini<br />
i primi e a nove i secon<strong>di</strong> (2 <strong>di</strong>cembre 1473).<br />
Allo scadere del termine fissato coi due locatari,<br />
il contratto, nel 1468, fu rinnovato coi medesimi (^7),<br />
ma per un termine minore, perchè il 2 novembre<br />
1472 si cedeva 1' officina a Lodovico Canonici che<br />
questa volta l'assumeva a nome dell' intera società<br />
degli orefici. Questi si affittarono la zecca per cinque<br />
anni e s'impegnarono a coniare alla solita stampa e<br />
lega per cento fibre <strong>di</strong> monete d'oro fino ogni anno<br />
e trecento d'argento: quanto alla moneta bassa ne<br />
avrebbero coniato quello che sarebbe ritenuto ne-<br />
cessario : avrebbero<br />
scelto il locale dell' officina in<br />
luogo pubblico e al soprastante avrebbero dato un<br />
soldo per ogni libbra <strong>di</strong> moneta d'oro coniata, e<br />
denari sei per ogni libbra d'argento, oltre la provvigione<br />
assegnatagli dal Comune : in caso <strong>di</strong> guerre,<br />
malattie contagiose o altre <strong>di</strong>sgrazie avrebbero, (secondo<br />
r uso) abbandonato la zecca e si sarebbe<br />
<strong>di</strong>chiarato sciolto il contratto. Questa ultima riserva<br />
trova la ragione nel fatto che in quei tempi una<br />
città colpita da uno <strong>di</strong> quei flageUi, allora tanto<br />
<strong>com</strong>uni, veniva a trovarsi isolata e abbandonata dalle<br />
popolazioni finitime e tanto più dalle classi <strong>com</strong>mer-<br />
(17) Alidosi, Operette, v. 3.
LA ZECCA DI BOLOGNA 469<br />
ciali e dai mercanti forestieri che apportavano il loro<br />
oro alle zecche per cambiarlo in moneta. Un foglio<br />
aggiunto a quello da cui riassumiamo i capitoli ac-<br />
cettati dagli orefici contiene alcune altre clausole<br />
d'indole generale, relative al maestro dei conii, che<br />
sarebbe stato homo sufficiente e pratico cum bone<br />
signrtade, agli assaggiatori, alla decisione da lasciarsi<br />
al rettore dell'arte degli orefici in casi <strong>di</strong> controversie<br />
sulle coniazioni, ecc. i^^K Quanto al <strong>com</strong>penso fu poi<br />
stabilito che i locatari avrebbero ricevuto sol<strong>di</strong> 22<br />
per ogni Hbbra <strong>di</strong> moneta d'oro coniata, sol<strong>di</strong> 11 per<br />
ogni libbra <strong>di</strong> moneta d'argento e <strong>di</strong> denari piccoli.<br />
Il Canonici, orefice bolognese della cappella <strong>di</strong><br />
S. Tomaso del Mercato, fu artista certamente <strong>di</strong><br />
valore perchè servì più volte il Comune e i privati<br />
in oggetti d'arte. Pochi anni dopo aver assunta la<br />
zecca, egH era scelto dagli Anziani per fabbricare un<br />
bronzo e un bacile d'argento da presentarsi a Gio-<br />
vanni della Rovere (^9). Ma è noto che la tecnica<br />
dell' incidere i ponzoni per fabbricar monete richie-<br />
deva una pratica <strong>di</strong>versa da quella dell'orefice, fosse<br />
anche medaglista: questi fondeva i suoi prodotti, il<br />
niagister cnneorimi incideva varii ponzoni dai quali<br />
ricavava l'intero conio e il lavoro era altrettanto<br />
geloso che <strong>di</strong>fficile (^o). Ciò spiega perchè anche<br />
questa volta il Comune affidò, con contratto 4 novembre<br />
1472 <strong>di</strong> cui rimane l'originale, la parte tecnica<br />
nell'officina monetaria ad Antonio <strong>di</strong> Battista Magnani<br />
che il documento chiama « virum habilem, aptum,<br />
idoneum, praticum, et expertum « nella coniazione<br />
(18) Zecca. B. 3. {Locazioni, ecc.) e Archivio Notarile <strong>di</strong> Bologna,<br />
rog. Curialti Matteo, filza i, n. 113.<br />
(19) Mandatorum, 19, e. 135, v.<br />
(20) Vedasi in appen<strong>di</strong>ce il doc. VII importante per conoscere la<br />
tecnica del coniar monete e dove sono enumerati tutti gli arnesi che<br />
a ciò occorrevano.
470<br />
FRANCESCO MALAGUZZI<br />
delle monete. Ce ne sarebbe d'avanzo per riconoscere<br />
a prima vista in questi l'artista che alcuni anni dopo<br />
fabbricava i bei conii dei bagattini per la zecca <strong>di</strong><br />
Reggio-Emilia insieme a Gia<strong>com</strong>o Martelli i^^\ se<br />
il fatto d'esser ricordato <strong>com</strong>e figlio <strong>di</strong> Marco in una<br />
lettera del Martelli ai sovrastanti reggiani, non ci<br />
lasciasse in dubbio. Il fatto <strong>di</strong> trovare che in entrambi<br />
i casi abbiamo presente un incisore <strong>di</strong> conii, e collo<br />
stesso nome e cognome ci lascia supporre che ci<br />
troviamo realmente <strong>di</strong> fronte alla stessa persona e che<br />
l'errore del patronimico possa ascriversi al Martelli.<br />
Senza insistere sulla questione ricorderemo che<br />
l'Antonio <strong>di</strong> Battista Magnani, ricordato nell'atto 4<br />
novembre 1473, aveva due fratelli, Matteo e Gia<strong>com</strong>o,<br />
che lo aiutavano nel lavoro. Per allora essi non<br />
rifabbricarono <strong>di</strong> pianta nuovi conii perchè per alcuni<br />
anni le impronte non furono mutate e si seguitò a<br />
battere colle solite <strong>di</strong> cui parlammo.<br />
Nel maggio del successivo anno 1474 i soprastanti<br />
alla zecca ricevevano dal Comune tremila Hre,<br />
da servire per l'acquisto della materia prima per la<br />
battitura iniziata ^^^).<br />
Ed ora veniamo al grande mutamento ideato nel<br />
regime monetario <strong>di</strong> Bologna nel 1476, il più notevole<br />
certamente in quel tempo, <strong>di</strong> cui e la mancanza fin<br />
qui <strong>di</strong> documenti e <strong>di</strong> alcuni prodotti, tra cui i doppi<br />
ducati d'oro allora per la prima volta or<strong>di</strong>nati, furon<br />
certo le ragioni principali del silenzio degli storici<br />
e degli stu<strong>di</strong>osi sull'argomento.<br />
Ne trovammo i lunghissimi e dettagliati capitoli<br />
in un fascicolo <strong>di</strong> 15 pagine <strong>di</strong> carattere minutis-<br />
simo: portano l'in<strong>di</strong>cazione sola dell'anno: 1476. Il<br />
(21) P. Malaguzzi-Valeri ,' La secca <strong>di</strong> Reggio Emilia. {<strong>Rivista</strong><br />
<strong>italiana</strong> <strong>di</strong> numistnatica. Anno VII, fase. II-III-IV, 1894).<br />
(22) Partiti, 7, e. 166, V.
LA ZECCA DI BOLOGNA 471<br />
fascicolo è del tempo, benché lo scritto non sia<br />
che una copia. Non vi è nominato il nuovo locatario<br />
perchè evidentemente il documento doveva avere<br />
carattere <strong>di</strong> perpetuità ed ha tutte le forme <strong>di</strong> un<br />
vero decreto destinato a rimanere. 11 fatto che alcuni<br />
prodotti <strong>di</strong> quella progettata monetazione non riman-<br />
gono, lascia sospettare che dessa non sia mai stata<br />
realmente effettuata e che il documento che abbiamo<br />
<strong>di</strong>nnanzi non rappresenti appunto altro che un pro-<br />
getto. Certo è che non molto tempo dopo si eseguì<br />
una <strong>di</strong>versa battitura <strong>di</strong> cui descriveremo i prodotti.<br />
Ad ogni modo cre<strong>di</strong>amo necessario esporre sommariamente<br />
nelle sue linee generali il progetto del 1476,<br />
<strong>di</strong> molto interesse per la storia della moneta nel<br />
quattrocento.<br />
I capitoli <strong>com</strong>prendevano la coniazione <strong>di</strong> bolo-<br />
gnini d'oro, doppi bolognini d'oro, bolognini d'argento^<br />
grossi da due bolognini d'argento, grassoni d'argento<br />
da sol<strong>di</strong> quattro, mezzani o mezzi bolognini da sei<br />
denari piccoli, piccoli e quattrini. I bolognini d'oro<br />
erano in tutto uguali ai precedenti della coniazione<br />
del 1463.<br />
I doppi bolognini d'oro o doppi ducati avrebbero<br />
portato da una parte le figure del S. Petronio se-<br />
duto colla città in mano e le parole sanctus Petro-<br />
nius de Bononia episcopus " cum duj circulj intorno<br />
cum la soa granadura de fuora „<br />
: e dall'altra parte<br />
il solito leone rampante collo stendardo <strong>com</strong>unale<br />
" in uno <strong>com</strong>paso „ e intorno il motto Bononia mater<br />
stu<strong>di</strong>orum " cum li soi doj circulj de intorno. „ Ne<br />
sarebbero andati " a lunza de pexo quatro e sete<br />
ventequatroeximi zoe 4 ^ a lunza de pexo e pixi<br />
trenta sete e ventinove cintotrieximi luno carati 37 -^<br />
et che ne vada a la libra de pexo cinquantauno e<br />
mezo de numero e che vagha luno ducatj duj doro<br />
da Bologna. „
472<br />
FRANCESCO MALAGUZZI<br />
I bolognini d'argento avrebbero avuto tali im-<br />
pronte: da un lato la. parola. Bonojna colla lettera A<br />
finale nel mezzo " cum duj circolj de intorno cum<br />
la soa granadura „ e dall' altro il leone rampante<br />
collo stendardo <strong>com</strong>unale e intorno il motto mater<br />
stu<strong>di</strong>orum. La lega era la solita <strong>di</strong> once nove e -5-<br />
<strong>di</strong> argento fino per libbra ma ne andavano " a lonza<br />
de pexo al più trenta trj bologninj et a la libra ne<br />
va da quatrocentotrentaduj al più. „<br />
I bolognini grossi dovevano avere da un lato il<br />
Santo a sedere e le parole Sanctus Petronius all'in-<br />
torno :<br />
dall'altro il leone rampante col vessillo entro<br />
uno <strong>com</strong>passo e il motto Bononia docet con due<br />
circoli e la granatura.<br />
La lega era la stessa dei bolognini piccoli " e<br />
che ne vada a lunza de peso desesete (17) e mezo<br />
e pixi luno caratj nove e uno setimo e che ne vada<br />
a la libra de pexo doxento <strong>di</strong>exe in fino in undexe<br />
al più de numero e vaglia luno bolognini duj d'ar-<br />
gento. „<br />
I grossoni d'argento da sol<strong>di</strong> quattro portavano :<br />
da un lato il S. Petronio seduto colla città in mano<br />
e intorno la frase Sanctus Petronius Bononia episcopus<br />
con due circoli e la granatura e dall' altro lato un<br />
leone rampante col vessillo <strong>com</strong>unale e il motto<br />
preferito Bononia mater stu<strong>di</strong>oriim con due circoli e<br />
la. granatura. La loro lega era la stessa dei bolo-<br />
gnini piccoli, avvertendosi " che ne vada a lunza<br />
de pexo otto e trj quarti e pixi luno caratj desedoto<br />
(18) e duj setimj, che ne vada a la libra <strong>di</strong> pexo<br />
centocinque de numero insino in centocinque e mezo<br />
al più, che vaglia luno bologninj quatro de ar-<br />
gento „ ecc.<br />
I mezzani da mezzo bolognino l'uno (6 denari<br />
piccoli) avrebbero avuto questa stampa; da un lato<br />
il Bononia coll'A finale nel mezzo <strong>com</strong>e nei bolognini
LA ZECCA DI BOLOGNA Ano<br />
descritti e dall'altro il solito leone rampante colla<br />
ban<strong>di</strong>era e intorno la parola docet con due circoli<br />
all'ingiro e la granatura. La lega era la stessa dei<br />
bolognini e ne andavano " a lunza de pexo al più<br />
setanta oto de numero e non più ma si .-. . . . (sic)<br />
e a la libra novecento trentasej mezanj de numero. „<br />
I piccoli avevano le stesse impronte <strong>di</strong> quelli<br />
della battitura del 1463 " a la lega de una onza e denari<br />
dodexe de argento fino per libra de peso e unza<br />
<strong>di</strong>exe <strong>di</strong> dodexe <strong>di</strong> ramo senza reme<strong>di</strong>o alcuno zoe<br />
che tiegna almeno unza una e mezo de argento fino<br />
per libra <strong>di</strong> pexo. „ Ne andavano alla libbra L. 4, s. 6.<br />
I quattrini avevano pure le stesse impronte <strong>di</strong><br />
quelli antichi " a la liga de unza una d. vinte per<br />
libra de argento fino zoe unza una e cinque sextj<br />
de argento fino per libra de peso e unze <strong>di</strong>exe e<br />
de. quatro de ramo. „ Ne andavano alla libbra L. 4,<br />
s. 19^ al più (23).<br />
Di tali monete non rimangono nelle principali<br />
collezioni quelle con impronte nuove, allora proget-<br />
tate: le altre sono <strong>com</strong>uni a quelle della coniazione<br />
del 1463. Per questo ci pare che il nostro sospetto<br />
che la coniazione progettata nel 1476 non abbia<br />
avuto luogo o almeno interamente, non manchi <strong>di</strong><br />
fondamento. Ne le notizie che stanno tra questa data<br />
e il 1489, epoca <strong>di</strong> nuova coniazione, accennano<br />
affatto alle nuove monete. Certo è invece che si<br />
continuava a stampare moneta bassa pei bisogni<br />
continui del <strong>com</strong>mercio, perchè un or<strong>di</strong>ne del 24<br />
<strong>di</strong>cembre 1479 stabiliva che si <strong>di</strong>struggessero i quat-<br />
trini ultimamente sortiti <strong>di</strong> zecca, perchè mal eseguiti<br />
e si rifacessero (24). Sappiamo inoltre che in quegli<br />
anni in Bologna correva molta moneta ferrarese (^5).<br />
(23) Zecca. B. 3.<br />
(24) Partiti, 19, e. 163, V.<br />
(25) Zecca. B. 2 {decreti^ 1484, ecc.).<br />
60
474<br />
FRANCESCO MALAGUZZI<br />
E qui <strong>di</strong>amo luogo a un' osservazione che vien<br />
naturale dall'esame dei documenti del tempo. In<br />
mezzo a tante <strong>di</strong>sposizioni sulle battiture delle monete<br />
e sul loro corso non troviamo nessun accenno a<br />
quella giuris<strong>di</strong>zione che la Chiesa si era riservata<br />
su tutti i rami della pubblica amministrazione, <strong>com</strong>presa<br />
l'officina monetaria, ramo importantissimo e<br />
fonte <strong>di</strong> lucro pei governi d'allora: giuri<strong>di</strong>zione che<br />
Giovanni Bentivoglio stesso aveva riconosciuto al<br />
principio della sua signoria. E la ragione va trovata<br />
nella storia interna della città stessa e nel carattere<br />
della signoria che il Bentivoglio, uomo astuto <strong>com</strong>e<br />
ce lo mostrano i documenti, aveva in suo pugno.<br />
Una tal signoria, potente più che non sembri, era<br />
basata sopra un partito estesissimo che riconosceva<br />
<strong>di</strong> fatto, mai <strong>di</strong> nome, nel suo capo un vero principe:<br />
la politica <strong>di</strong> questi consisteva nel conservare e ri-<br />
spettare in apparenza tutte quelle forme esterne <strong>di</strong><br />
libertà citta<strong>di</strong>na che poche provincie avevano allora:<br />
il gonfaloniere <strong>di</strong> giustizia, i se<strong>di</strong>ci Riformatori, <strong>di</strong>-<br />
venuti in seguito ventuno, il formulario <strong>di</strong> Hbertà, ecc.<br />
Egli non voleva essere che prior tra i magistrati, ma<br />
in realtà egli era tutto e quelli non erano che sue<br />
creature. Da tale indeterminatezza dei confini delle<br />
reciproche guarentigie derivò la forza <strong>di</strong> Giovanni II,<br />
che prima che l'invasione <strong>di</strong> Carlo Vili gli facesse<br />
perdere il solito sangue freddo e la chiaroveggenza,<br />
governò sapientemente e seppe entrare in tutti i ne-<br />
gozi importanti della penisola. Peccato che la per<strong>di</strong>ta<br />
dell' archivio bentivolesco costringa gli stu<strong>di</strong>osi a<br />
ricercare altrove la traccia <strong>di</strong> quel grande uomo <strong>di</strong><br />
stato e mecenate, sicché la sua figura non può sor-<br />
tirne così nitidamente scolpita <strong>com</strong>e si vorrebbe!<br />
Il potere della Curia romana su Bologna in quel<br />
tempo era quasi nullo: il legato non influiva per<br />
niente sulla pubblica amministrazione. È quin<strong>di</strong> natu-
LA ZECCA DI BOLOGNA<br />
rale che anche nelle cose relative alla zecca non vi<br />
fossero contestazioni <strong>di</strong> sorta, nessuno potendo ostare<br />
agli or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong>retti del consiglio <strong>di</strong> libertà condotto<br />
da Giovanni. Questi, fedele al suo proposito ed<br />
ossequente a parole al pontefice, aveva rinunciato<br />
persino a far riprodurre la propria immagine nelle<br />
monete, il che gli sarebbe riuscito facile e a noi<br />
certo più gra<strong>di</strong>to. Solamente più avanti, <strong>com</strong>e vedremo,<br />
si valse <strong>di</strong> quella facoltà eh' egli, ghibellino<br />
d'idee e d' inte<strong>di</strong>menti, ottenne facilmente dall'imperatore<br />
Massimiliano.<br />
475<br />
Nell'ottobre del 1489 i Riformatori, dopo aver<br />
deciso <strong>di</strong> far coniare monete d'oro, d'argento e <strong>di</strong><br />
rame, nominavano tre <strong>di</strong> loro per stabilire le moda-<br />
lità della nuova battitura. I capitoli furono presentati<br />
il 3 novembre, ma nemmeno questa volta, vi è ricor-<br />
dato il nome del nuovo appaltatore. L'officina fu<br />
ceduta per un triennio col patto che vi si coniassero<br />
trecento libbre d'argento <strong>di</strong> grossoni e grossetti,<br />
pagando alla Camera sol<strong>di</strong> due e denari due per<br />
ciascuna libbra: per l'oro (alla lega e stampe con-<br />
suete) cinque sol<strong>di</strong> per libbra <strong>di</strong> peso d'oro lavorato,<br />
per quattrini e denari piccoli tre sol<strong>di</strong> per libbra.<br />
L'appaltatore avrebbe poi sborsate L. 100 a Giovanni<br />
Bentivoglio per pigione della zecca, e avrebbe pre-<br />
sentate buone sicurtà (26). Le coniazioni si succedevano<br />
dunque, con frequenza: ciò trova spiegazione<br />
nello sviluppo anche <strong>com</strong>merciale che Bologna andava<br />
prendendo, favorita dalla sua posizione che<br />
accogheva lo sbocco degh scambi <strong>di</strong> quasi tutta<br />
l'alta Italia. Molte gride, l'una dopo T altra, rego-<br />
lavano il corso delle monete <strong>di</strong> Venezia, Milano,<br />
Firenze, Genova, Siena, Ferrara, Mantova, Lucca, e<br />
(26) Zecca. B. 3. {Affitti, ecc.).
476<br />
FRANCESCO MALAGUZZI<br />
vietavano ai forestieri <strong>di</strong> asportar Toro da Bologna (27).<br />
Ricor<strong>di</strong>amo qui le principali gride pubblicate in quel<br />
tempo sul corso delle monete forestiere a Bologna:<br />
una del 6 febbraio 1462 che regolava la valuta dei<br />
grossoni fiorentini e senesi e stabiliva che i pecchioni<br />
<strong>di</strong> Milano andassero in ragione <strong>di</strong> quaranta al ducato;<br />
un'altra del 4 <strong>di</strong>cembre 1473 che or<strong>di</strong>nava che per l'av-<br />
venire dei grossoni fiorentini e grossetti del cavalletto<br />
ne andassero uno per nove quattrini. Il 24 settembre<br />
si stabiHva tassativamente che le seguenti mo-<br />
1474<br />
nete non si accettassero negli scambi che pei se-<br />
guenti valori:<br />
" li Grossoni de Milano da larma cum la testa per bo-<br />
lognini sei et <strong>di</strong>nari duj luno zoe . . boi. 6. d. 2 luno<br />
"<br />
li Grossi de Sanato Ambruoso à cavallo per boi. quatro<br />
4. d. 6 luno<br />
et den. sei luno zoe .... boi.<br />
" li Grossi dalle Sechie per boi. duj et d. octo luno<br />
zoe boi. 2. d. 8 luno<br />
" li Grossi da Santo Ambruoso cum li armati per boi.<br />
duj et <strong>di</strong>narj sei luno zoe . . . boi. 2. d. 6 luno<br />
" le monede vechie de Lombar<strong>di</strong>a tose o non tose non<br />
vagliano et non siano se non per argento rotto<br />
" li Graici bonj per octo <strong>di</strong>narj luno zoe boi. o. d, 8 luno<br />
"<br />
li Grossi fiorentinj bonj et non tosj per boi. trj et<br />
<strong>di</strong>narj quatro boi. 3. d.<br />
"<br />
li Grossi ferraresi chiamati cavalitti per boi.<br />
d. octo luno zoe ..... boi.<br />
4 luno<br />
uno et<br />
i. d. 8 luno<br />
" li tronj venetiani bonj et non tosi per boi. nove<br />
zoe . . . . . . . . . boi. 9 luno<br />
" li mezi tronj et marcellj venetiani per boi. quatro et<br />
<strong>di</strong>narj sei luno zoe „ . . . boi. 4. d. 6 luno (28)<br />
C'interessa ricordarne una del 27 febbraio 1490<br />
che stabiliva che per l'avvenire 14 grossoni, un bolognino<br />
e tre denari piccoli equivalessero a un ducato<br />
(37) Zecca, B. i. {Decreti).<br />
(28) Zecca. B. i, {Decreti).
LA ZECCA DI BOLOGNA<br />
d'oro largo del valore <strong>di</strong> lire tre e sol<strong>di</strong> due e così<br />
s'intendesse <strong>di</strong> ventotto grossetti e un bolognino e<br />
tre denari piccoli, <strong>com</strong>e <strong>di</strong> cinquantasette bolognini e<br />
tre denari piccoli, purché tutte le monete fossero al<br />
conio bolognese e ogni ducato fosse del peso <strong>di</strong><br />
carati 246(29).<br />
Vedemmo che la zecca era stata data per tre<br />
anni a una nuova persona nel novembre 1489: ma<br />
per ragioni che ignoriamo, il contratto fu sciolto dopo<br />
un solo anno e l'ufficio, il 23 <strong>di</strong>cembre 1490, fu<br />
affidato per un triennio ad Ambrogio Serafini.<br />
477<br />
Questi si obbligava: a battere grossoni in ra-<br />
gione <strong>di</strong> III -^ o tutt'alpiìi 112 per ogni libbra <strong>di</strong><br />
peso, grossetti in ragione <strong>di</strong> 223 ~ o 224 al più per<br />
libbra <strong>di</strong> peso o ducati d'oro nel caso che fossero<br />
richiesti da qualche privato che portasse oro in zecca:<br />
<strong>di</strong> più quattrini e denari piccoli alla lega <strong>di</strong> once i -^<br />
per Hbbra <strong>di</strong> peso e ne andassero lir quattro e sol<strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>eci alla libbra: promettendo <strong>di</strong> battere col suo<br />
proprio argento detti grossoni e grossetti per una<br />
somma non minore <strong>di</strong> 500 lire: e lir cinquanta d'oro,<br />
<strong>di</strong> seguitare a pagare l'affitto del locale al Benti-<br />
vogHo, ecc. (30).<br />
A questa coniazione ne seguì un'altra nel 1494,<br />
<strong>di</strong> quarti <strong>di</strong> ducati: 31 <strong>di</strong> questi più due grossetti avevano<br />
il peso <strong>di</strong> una libbra: 115 grossi d'argento del<br />
valore <strong>di</strong> sol<strong>di</strong> 40 d'argento pesavano una libbra:<br />
così 460 bolognini: e si sarebbero dovuti coniare<br />
almeno ~ in bolognini della somma totale (30. Il loca-<br />
tario era <strong>di</strong> nuovo il Serafini, perchè i documenti ce<br />
lo ricordano ancora nel 1496.<br />
In questo tempo Giovanni II, in ri<strong>com</strong>pensa<br />
(29) Partiti II, e. IO, r. e Zecca. B. i, (decreti).<br />
(30) V. doc. Vili e IX.<br />
(31) Partiti II, e. 104, r. 13 febbr. 1494.
478<br />
FRANCESCO MALAGUZZI<br />
della sua lunga devozione e attaccamento alla causa<br />
dell'impero, riceveva dall'imperatore Massimiliano <strong>di</strong><br />
Germania favori e privilegi, sui quali conviene che<br />
c'intratteniamo un poco. Con privilegio del 19 otto-<br />
bre 1494 l'imperatore concedeva a Giovanni e al<br />
figlio <strong>di</strong> questi, Annibale, <strong>di</strong> essere annoverati fra i<br />
conti del sacro palazzo, dava loro facoltà <strong>di</strong> creare<br />
cavalieri, notai e giu<strong>di</strong>ci or<strong>di</strong>nari, <strong>di</strong> legittimare e<br />
nobilitare figli naturali (e Giovanni ne aveva parecchi),<br />
<strong>di</strong> aggiungere al proprio stemma l'aquila imperiale,<br />
<strong>di</strong> coronare d'alloro dottorale legisti, artisti, poeti e<br />
me<strong>di</strong>ci, e finalmente concedeva loro « facultatem<br />
cuden<strong>di</strong> seu cu<strong>di</strong> facien<strong>di</strong> monetas in civitate Bononiae<br />
stampe, cunei, nominisque vestri ubicumque locorum<br />
cum omnibus juribus, privilegis, praeminentijs,<br />
exemptionibus, praerogativis, immonitatibus, quibus<br />
aliis tales fabbricatores et magistri monetarij in Im-<br />
perialibus fabricis et cecchis vocentur et fruun-<br />
tur (32) „. Il Bentivoglio si valse tosto del privilegio<br />
e fece battere le note monete con effigie e insegne<br />
proprie. Il Gozza<strong>di</strong>ni aggiunge ch'egli nel 1497 fece<br />
fabbricare un palazzo destinato all'officina monetaria<br />
nel luogo medesimo ove sorge l'attuale fabbricato<br />
del 1578 circa. Ma nelle nostre ricerche non trovammo<br />
la riconferma <strong>di</strong> questa notizia: i contratti<br />
<strong>di</strong> appalto ricordano solamente che i maestri <strong>di</strong> zecca<br />
pagavano l'affitto della casa che occupavano al Ben-<br />
tivoglio e non è improbabile che l'officina fosse a<br />
poca <strong>di</strong>stanza dalla piazza, nelle cui vicinanze era<br />
stata per tanto tempo, fin dal secolo XIII.<br />
A quale artista appartengono le belle monete<br />
del periodo <strong>di</strong> Giovanni II?<br />
Son note le parole del Vasari nella biografia<br />
(32) G. Gozza<strong>di</strong>ni, Memorie per la vita <strong>di</strong> Giovanni II Bentivoglio,<br />
pag. 106, ecc. e doc. LXII, ivi.
LA ZECCA DI BOLOGNA<br />
del grande artista bolognese Francesco Raibolini<br />
detto il Frane 'a: " ma quello <strong>di</strong> che egli si <strong>di</strong>lettò<br />
sopramodo e in che fu eccellente fu il fare conij<br />
479<br />
per medaglie ; nel che fu ne' tempi suoi singularis-<br />
simo, <strong>com</strong>e si può vedere in alcune che ne fece<br />
dove è naturalissima la testa <strong>di</strong> papa Giulio II<br />
che stettono a paragone <strong>di</strong> quelle <strong>di</strong> Caradosso.<br />
Oltre che fece le medaglie del signor Giovanni Bentivoglio<br />
che par vivo.... Tenne continuamente, mentre<br />
che e' visse, la zecca <strong>di</strong> Bologna e fece le stampe<br />
<strong>di</strong> tutti i conj per quella, nel tempo che i Bentivogli<br />
reggevano, ecc. i^i) „.<br />
Solamente la scoperta <strong>di</strong> un documento che<br />
sembra assicurare che il Francia eseguì i conii a<br />
in<strong>com</strong>inciare dal 1508 e non prima, pose in dubbio<br />
l'asserzione del Vasari, troppo facile ad accettare<br />
senza vagliarle le notizie sentite <strong>di</strong>re su gli artisti<br />
che non erano più del suo tempo (3»). Riporteremo<br />
il documento parlando delle coniazioni del tempo <strong>di</strong><br />
Giulio II e frattanto aggiungiamo che alcune notizie<br />
che ricaviamo dai documenti venuti alla luce nelle<br />
nostre ricerche e che il fatto <strong>di</strong> non trovar mai<br />
ricordato il Francia nelle carte della zecca al tempo<br />
dei Bentivoglio sembrano confermare che almeno non<br />
tutte le monete bentivolesche si possono attribuire<br />
al Francia.<br />
Neil' anno in cui Giovanni II fece battere le<br />
nuove monete colla propria effigie, la zecca era affit-<br />
tata ad Ambrogio Serafini che la tenne fin verso il<br />
1497. Il locatario aveva probabilmente dato l'incarico<br />
al maestro dei conii, già a' suoi stipen<strong>di</strong>, <strong>di</strong> lavorare<br />
per la zecca finche durasse la locazione e se il Bentivogho<br />
avesse imposto il Raibolini, i mandati ne<br />
(33) Vasari, Vite. E<strong>di</strong>z. Milanesi. T. III.<br />
(34) L. Frati, Delle monete gettate al popolo^ ecc.
480 FRANCESCO MALAGUZZI<br />
farebbero cenno. Da un partito del 30 gennaio 1495<br />
appren<strong>di</strong>amo che l'orefice Pietro <strong>di</strong> Matteo dal Gambaro<br />
fu nominato ad cunium et ceccam per fare i saggi<br />
delle monete. Dovrebbesi ciò intendere nel senso<br />
che egU fabbricasse anche i conii? (35). Allo scadere<br />
poi del contratto col Serafini, nel 1498, la zecca<br />
bolognese fu ceduta per tre anni all'orefice Antonio<br />
Magnani, probabilmente fino allora incisore dei conii,<br />
già in tale ufficio molti anni prima che lasciò la sua<br />
iniziale in alcuni grossi <strong>di</strong> quei tempo e che anche<br />
per la zecca <strong>di</strong> Reggio aveva prestato l'opera sua,<br />
<strong>com</strong>e vedemmo. Il Magnani si obligò a coniare per<br />
l'avvenire i ducati d'oro alla lega <strong>di</strong> denari 23 e ^ almeno,<br />
in ragione <strong>di</strong> denari 24 per oncia <strong>di</strong> oro<br />
puro e del peso <strong>di</strong> carati 18 e ^ almeno (36). Ci<br />
rimane un ren<strong>di</strong>conto del 1495 da cui (oltre rile-<br />
varsi che dal Gennaio al 16 Maggio <strong>di</strong> quell'anno<br />
si erano coniate tante monete pel valore <strong>di</strong> du-<br />
cati 10200) risulta che le paghe dei principali operai<br />
della zecca erano le seguenti, per ogni libbra <strong>di</strong><br />
monete stampate :<br />
per l'assaggiatore (Pietro <strong>di</strong> Matteo del Gambaro) s. i<br />
per gli operai addetti alle stampe . . . s. 2<br />
per l'operaio che eseguiva la battitura . . s. i, d. 6<br />
per l'incisore o maestro da le stampe . . s. i (37).<br />
Dopo che il Magnani ebbe assunta la zecca non<br />
si trova più cenno del maestro incisore dei conii,<br />
perchè egli riunì in se le due .qualità <strong>di</strong> locatario e<br />
incisore, caso molto frequente allora e che nella<br />
stessa zecca Bolognese si ripetè dopo allora molte<br />
(35) Alcuni anni prima, dal 1461 in poi, un m.° Corre<strong>di</strong>no orelìce<br />
coniava le perline (tessere) per la <strong>di</strong>stribuzione delle farine ai poveri<br />
nel Natale (V. anche Mandali 19 <strong>di</strong>e. 1461, ecc.).<br />
(36) Partiti, 20 <strong>di</strong>e. 1498, 11, e. 167, r.<br />
(37) Zecca B. t. {Decreti, ecc.)
LA ZECCA DI BOLOGNA 481<br />
volte, <strong>com</strong>e vedremo. Per tuttociò ci par dunque<br />
giusto ritenere che almeno una parte delle belle monete<br />
bentivolesche, cioè quelle coniate dopo il T49S<br />
si debbano all'orefice Antonio Magnani, artista i cui<br />
noti prodotti della z,ecca reggiana per finezza e bel-<br />
lezza dei ritratti possono ben stare a pari colle -cose<br />
del Francia (38). Era del resto il tempo in cui quasi<br />
ogni orefice era grande artista e solo la mancanza <strong>di</strong><br />
notizie contribuì ad attribuire a pochi fortunati gran<br />
parte dell'opera d'altri contemporanei ignoti. Aggiungiamo<br />
che le nostre ricerche negli archivi bolognesi<br />
per appurare la paternità delle monete <strong>di</strong> Giovanni II<br />
non <strong>di</strong>edero che il risultato che abbiamo riferito,<br />
cosicché propen<strong>di</strong>amo a credere che se pure il Francia<br />
fabbricò i conii <strong>di</strong> alcune , forse quelle bellissime<br />
del 1494 col Maximiliani imperatoris munus, non dovette<br />
eseguirli nel locale della zecca, ma nel suo<br />
(38) Ad escludere che, <strong>com</strong>e qualcuno sarebbe <strong>di</strong>sposto a credere,<br />
quelle monete bentivolesche potessero ritenersi opera <strong>di</strong> Speran<strong>di</strong>o da<br />
Mantova vale (oltre i documenti) la considerazione che nel 1494, quando<br />
in<strong>com</strong>inciò quella battitura, Speran<strong>di</strong>o già da quattro anni non si trovava<br />
più a Bologna. L'ultimo suo lavoro in questa città fu la medaglia <strong>di</strong><br />
Catalano Casali eletto Protonotario nel 1490. Dopo quest' anno non<br />
troviamo più sue tracce colà. Nelle nostre ricerche trovammo il suo<br />
nome tra i poveri, cui il Comune faceva elemosina nel Natale, negli<br />
anni i486, 1487, 1488. Interessante è un documento che trovammo tra<br />
le Riformagioni del Comune, che riguarda Speran<strong>di</strong>o da Mantova e il<br />
Francia. Un Gia<strong>com</strong>o <strong>di</strong> Gillo, mercante <strong>di</strong> stoffe e velluti, si era fatto<br />
fare nel 1474 dal nostro Speran<strong>di</strong>o una medaglia portante da un lato<br />
l'effìgie propria e il motto lacobus Lilius bononiensis delitiarum specimen<br />
e dall'alti o una ninfa suonante la cetra " cum certis adminiculis „<br />
ornamentali e le parole effectu ut nomine poiest : opus Sperandei,<br />
MccccLxxiiij. Quattro anni dopo l'artista non era ancor stato pagato, ed<br />
essendo insorta questione sul prezzo fra i due, la cosa fu portata innanzi<br />
agli Anziani che chiamarono ad arbitro il Francia : questi, il 21 agosto<br />
1479, esaminò <strong>di</strong>ligentemente la medaglia " et consideratis que considerando<br />
fuerunt „ ne fissò il prezzo in tre ducati d' oro larghi. (Arch.<br />
<strong>di</strong> Stato <strong>di</strong> Bologna. Com. Riformagioni, 21 agosto 1479). La medaglia<br />
non è ricordata né dall'Armand, né dall' Heiss, né cre<strong>di</strong>amo se ne<br />
conosca alcun esemplare.<br />
61
483 FRANCESCO MALAGUZZI<br />
stu<strong>di</strong>o o nel palazzo Bentivoglio e per incarico <strong>di</strong>retto e<br />
privato <strong>di</strong> Giovanni. Di tutte queste splen<strong>di</strong>de monete,<br />
veri carnei, degni davvero del Caradosso, il lettore<br />
troverà le descrizioni più avanti.<br />
Ed ora due parole sulla questione delle tanto<br />
<strong>di</strong>scusse monetazioni che sarebbero state or<strong>di</strong>nate<br />
da Giovanni II in Lombar<strong>di</strong>a, ne' suoi feu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Antignate<br />
e Covo. La questione fu trattata in uno scritto<br />
inserto nel Perio<strong>di</strong>co <strong>di</strong> <strong>numismatica</strong> e sfragistica (Anno<br />
II, fase. Ili) dal valente numismatico cav. Damiano<br />
Muoni. Egli la esaminò <strong>di</strong>ligentemente, partendo da<br />
quanto avevano affermato il Muzzi, lo Schiassi, il<br />
Litta che principalmente ne scrissero, ma le sue ricerche<br />
in proposito non poterono approdare a nulla<br />
e finì coll'attenersi a quanto ne <strong>di</strong>sse lo Zanetti nel<br />
ms. da noi ricordato, della biblioteca <strong>com</strong>unale <strong>di</strong><br />
Bologna. Lo Zanetti, ripetendo vecchie affermazioni,<br />
scrisse infatti che il Bentivoglio « il 4 gennaio 1495,<br />
<strong>com</strong>inciò a stampare danaro facendosi fare i conii<br />
da Francesco RaiboHni, detto il Pranza, orefice e<br />
pittore celebre bolognese e non solamente ne' suoi<br />
castelli <strong>di</strong> Antignano e Covo, donatigli dal duca<br />
<strong>di</strong> Milano ; ma ezian<strong>di</strong>o <strong>com</strong>e vogliono alcuni, in<br />
casa sua propria. » — Quanto all' intervento del<br />
Francia abbiamo già detto ciò che ne pensiamo:<br />
aggiungeremo che, per tutto quanto risulta dai docu-<br />
menti, dubitiamo forte che monete <strong>di</strong> Giovanni II<br />
siano state battute altrove che a Bologna, dove la<br />
zecca aperta e la facilità <strong>di</strong> ottenere bei conii non<br />
consigliavano certo il Bentivoglio a valersi fuori del<br />
proprio stato <strong>di</strong> quel <strong>di</strong>ritto sovrano a cui, per ragioni<br />
politiche, egli teneva tanto.<br />
Con queste coniazioni si migliorarono talmente<br />
le impronte che riuscì in seguito <strong>di</strong>fficilissimo ai<br />
falsificatori e ai tosatori <strong>di</strong> monete imitarle o alterarle.
LA ZECCA DI BOLOGNA 4B3<br />
Infatti non si trova quasi più cenno <strong>di</strong> tale inconveniente<br />
nei documenti bolognesi posteriori al 1490. E<br />
ciò fu certamente <strong>di</strong> gran sollievo al governo e ai<br />
privati, fino allora afflitti da quella piaga, del resto<br />
<strong>com</strong>une a tutti gli stati d'Italia.<br />
E prima <strong>di</strong> abbandonare per sempre questo<br />
argomento <strong>di</strong>amo una scorsa alle notizie più salienti<br />
che vi si riferiscono. I ban<strong>di</strong> contro i falsificatori o<br />
tosatori <strong>di</strong> monete furon sempre numerosissimi nel<br />
Me<strong>di</strong>o Evo. Ma a Bologna il male fu più frequente<br />
o almeno più tollerato nel quattrocento: i provve-<br />
<strong>di</strong>menti per estirparlo restarono lettera morta finche<br />
nel 1472<br />
i Se<strong>di</strong>ci Riformatori decretarono il bando per<br />
quei malfattori, stabilendo inoltre che non si potesse<br />
far loro grazia se non si ottenessero per ciò in Consiglio<br />
almeno 11 voti bianchi sopra 16 (39). L'anno dopo<br />
si riformavano ancora le provvigioni <strong>di</strong>rette allo<br />
stesso scopo, tenendo sempre fermo il bando <strong>com</strong>e<br />
pena principale. Ma i falsificatori <strong>di</strong> monete trovavano<br />
proseliti in tutte le classi sociali : artisti, <strong>com</strong>mer-<br />
cianti, popolani, operai addetti all'officina. Non rifuggì<br />
dal ricorrere a questo mezzo ignominioso <strong>di</strong> lucro<br />
lo stesso Aristotile Fieravante, il celebre ingegnere<br />
ricercato da governi e da principi : nel Giugno<br />
del 1473, mentre era al servizio del papa, a Roma,<br />
fu arrestato, <strong>di</strong>etro denuncia <strong>di</strong> falsificazioni <strong>com</strong>messe<br />
tempo prima, e i Riformatori bolognesi sta-<br />
bilivano all' unanimità <strong>di</strong> privarlo dell' ufficio <strong>di</strong><br />
ingegnere del Comune e del relativo stipen<strong>di</strong>o (4°).<br />
Si pubbhcarono nuove pene <strong>di</strong> bando promettendo<br />
grossi premi in denaro ai denunciatori e a chi<br />
consegnasse alla giustizia i falsari (4^. I quali non<br />
si <strong>di</strong>edero per vinti e molti andarono altrove a fab-<br />
(39) Partiti, 7,<br />
e. 81. r.<br />
(40) Partiti, 7, e. 145, e. 167, V.<br />
(41) Ibid. e. 178, e segg.
484<br />
FRANCESCO MALAGUZZI<br />
bricar monete al conio bolognese: il 21 Aprile 1477<br />
gli Anziani scrivevano al Duca <strong>di</strong> Ferrara pregan-<br />
dolo <strong>di</strong> punire quelli che si trovavano nel suo stato (42).<br />
Non essendo sufficienti le pene in vigore vi si aggiunse<br />
la tortura e nel 1479 ^^ /^^
LA ZECCA DI BOLOGNA 485<br />
nuova locazione del 1502 in cui non è fatto il nome<br />
del zecchiere: da quelli rileviamo che si batterono<br />
ancora le solite monete d'oro, d'argento e <strong>di</strong> rame<br />
ai soliti conii e lega (46).<br />
Più importanti sono i capitoli della successiva<br />
locazione del 30 giugno 1506. L'officina fu affidata<br />
a Napoleone Malvasia per cinque anni : egli prometteva<br />
<strong>di</strong> battere ogni anno (oltre le somme <strong>com</strong>messe<br />
da privati) libbre 500 <strong>di</strong> quarti, grossoni, grossetti<br />
e bolognini alla lega consueta, e 50 d'oro; l'affitto<br />
dell'officina monetaria era portato a L. 120 annue,<br />
coi soliti obblighi <strong>di</strong> pagare operai, tagliatori, inci-<br />
sore, manovali, <strong>di</strong> tenere i registri in or<strong>di</strong>ne, ecc. (47).<br />
E quella fu l'ultima locazione del periodo ben-<br />
tivolesco.<br />
(46) Zecca B. 3 {Affitti, ecc.).<br />
(47) Partiti 12, e. 79, r. e Zecca B. 3 {A/fi[i, 1506).<br />
(Continua).
UN RIPOSTIGLIO<br />
DI MONETE DEL SECOLO XIII<br />
A Vigo <strong>di</strong> Cave<strong>di</strong>ne nel Trentino<br />
Negli ultimi giorni dello scorso marzo un con-<br />
ta<strong>di</strong>no scavando le terre <strong>di</strong> un suo campo, situato<br />
presso Vigo <strong>di</strong> Cave<strong>di</strong>ne i^), rinvenne una quantità<br />
<strong>di</strong> monete che, a quanto sembra, erano riposte in<br />
una borsa <strong>di</strong> pelle fra<strong>di</strong>cia e consunta, che andò tosto<br />
<strong>di</strong>strutta. Regalatene alcune a questa e quella persona<br />
del paese, cedette le altre ad un riven<strong>di</strong>tore <strong>di</strong> anti-<br />
caglie, dal quale ne feci l'acquisto. Il deposito era<br />
<strong>com</strong>posto <strong>di</strong> circa 450 grossi e sol<strong>di</strong>, la maggior<br />
parte <strong>di</strong> Trento, Verona e Bergamo, alcuni <strong>di</strong> Tortona,<br />
e pochi altri spettanti a Venezia, Brescia, Cremona,<br />
Como, Lo<strong>di</strong>, Tortona, Acqui ed Asti; i piccoli, poco<br />
pili <strong>di</strong> trenta, appartenevano a Trento, Verona, Ve-<br />
nezia, Mantova e Brescia.<br />
Fra questi pezzi, quasi tutti <strong>di</strong> ottima conserva-<br />
zione, non rinvenni alcun tipo, che non fosse noto;<br />
molte invece le varietà <strong>di</strong> conio <strong>di</strong> una stessa moneta,<br />
e qualcuna <strong>di</strong> queste fin' ora non avvertita.<br />
Come appare dalla descrizione del ripostiglio il<br />
pezzo <strong>di</strong> data piia recente è il grosso veneto del doge<br />
Ranieri Zeno (1253-1268), in due esemplari <strong>di</strong> conio<br />
freschissimo. Tutti gli altri, fatta eccezione dei due<br />
(i) Vigo è un piccolo villaggio in fondo alla valle <strong>di</strong> Cave<strong>di</strong>ne nel<br />
<strong>di</strong>stretto <strong>di</strong> Vezzano, presso Trento,
488<br />
GIORGIO CIANI<br />
piccoli veneti della fine del XII secolo, appartengono<br />
alla prima metà del secolo XIII, o <strong>di</strong> poco la oltrepassano,<br />
e sembra che non siano stati battuti dopo<br />
l'anno 1256, nel quale verosimilmente fu sotterrato<br />
il tesoretto (^).<br />
Narrano gli storici che in quell'anno il Trentino,<br />
e specialmente la Valsugana, fu devastato, e Trento<br />
stessa saccheggiata orribilmente dalle orde <strong>di</strong> Ezze-<br />
lino IV da Romano, e da quelle del suo alleato<br />
Mainardo I conte del Tirolo, i quali, sotto pretesto<br />
<strong>di</strong> <strong>com</strong>battere i guelfi ed il vescovo Egnone d'Ap-<br />
piano — che ambiva ricuperare l'amministrazione del<br />
vescovato, tenuta fino dal. 1235 dai podestà imperiali<br />
— agognavano estendere i confini dei territori loro<br />
soggetti, spacciandosi fautori e sostenitori del partito<br />
deir imperatore.<br />
È probabile che all'approssimarsi <strong>di</strong> quelle turbe<br />
sfrenate, avide <strong>di</strong> ricchezze, ed assetate <strong>di</strong> sangue,<br />
qualche citta<strong>di</strong>no per salvare la vita, abbia cercato<br />
scampo neir ultimo villaggio della remota valle <strong>di</strong><br />
Cave<strong>di</strong>ne e, nel momento del maggior pericolo, abbia<br />
affidato alla terra il tesoro gelosamente serbato, che<br />
la sorte non gli dovea far riavere.<br />
TRENTO (3).<br />
I. Grosso da 20 denari, o piccoli.<br />
.-B" — • + EPS • • TRIDENTI<br />
Busto<br />
mitrato <strong>di</strong> vescovo volto<br />
a sinistra, in atto <strong>di</strong> bene<strong>di</strong>re, e col pastorale. Circolo<br />
<strong>di</strong> punti interno ed esterno.<br />
(2) È da notarsi che questo ripostiglio non <strong>di</strong>ede monéta alcuna<br />
dei conti del Tirolo. Accenno al fatto che confermerebbe l'opinione <strong>di</strong><br />
coloro che ritengono Vaquilino della zecca <strong>di</strong> Merano esser stato battuto,<br />
o da Mainardo I (1254-1258) o dai suoi figli Mainardo II e Alberto II,<br />
durante il governo da loro esercitato in <strong>com</strong>une dal 1258-1271.<br />
(3) Nella descrizione delle monete <strong>com</strong>ponenti il ripostiglio <strong>com</strong>prendo<br />
anche quelle, che passate in altre mani, mi furono gentilmente<br />
oflferte in esame.
9( - + •<br />
UN RIPOSTIGLIO DI MONETE DEL SECOLO XIII, ECC. 489<br />
INPERATOR<br />
• Nel mezzo + F. Circoli <strong>di</strong> punti<br />
e. S. (Peso gr. 1.622, titolo 952 mill.) . . . . n. 22<br />
Simonis Petri Bartholomei, De tridentinarum, veronensium, mera-<br />
nensiumqite monetarum, ecc. Tridenti, 1749, tav.<br />
Varietà: Dopo INPERATOR,: (Peso gr. 1.59)<br />
. . . n. i<br />
Benedetto Giov anelli, Intorno all'antica zecca trentina, ecc. Trento,<br />
C. s.<br />
C. s.<br />
C. s.<br />
1812, pag. 34, fig.<br />
\ (Peso gr. 1.60) .<br />
® (Peso gr. 1.65) .<br />
® (Peso gr. 1.658).<br />
C. s. Con un punto sopra la croce ed uno sotto la F nel<br />
campo del rovescio (Peso gr. 1.63) . . . . n. i<br />
Benedetto Giovanelli, Alterthumliche Entdeckungen, ecc. Innsbruck,<br />
1839, pag. 13, n. 5 della tav.<br />
C. s. Punti nel campo <strong>com</strong>e nella precedente, ed una punta<br />
scendente verticalmente sopra la F. (Peso gr. 1.62). n. 3<br />
Le numerose varietà che si conoscono <strong>di</strong> questo<br />
grosso si possono facilmente <strong>di</strong>videre in due serie,<br />
assegnando alla prima quelle col busto del vescovo,<br />
ornato <strong>di</strong> tre, e più spesso <strong>di</strong> quattro perline, colla<br />
scritta INPERATOR, e che dal carattere generale mo-<br />
strano <strong>di</strong> essere le più antiche;<br />
alla seconda, quelle col busto fregiato <strong>di</strong> <strong>di</strong>verso<br />
ornamento, la iscrizione IMPERATOR, ed altre partico-<br />
larità che le in<strong>di</strong>cano <strong>di</strong> fattura più recente.<br />
«9<br />
2<br />
2<br />
25
490<br />
GIORGIO CIANI<br />
I grossi del nostro ripostiglio appartengono tutti<br />
alla prima specie, per cui sarebbe lecito arguire che<br />
quelli della seconda serie siano stati coniati dopo il<br />
1256, nel quale anno probabilmente fu sotterrato il<br />
piccolo tesoro, e spettino al vescovo Egnone d'Ap-<br />
piano (1248-1272) del quale si conoscono tre locazioni<br />
della zecca per la coniazione <strong>di</strong> grossi da 20 piccoli<br />
della lega dei grossi veronesi, fatte negli anni 1262,<br />
1269 e 1272.<br />
Gli autori che trattarono della zecca trentina<br />
sono concor<strong>di</strong> nell' assegnare i grossi colla F, in<strong>di</strong>-<br />
stintamente al vescovo Federico Vanga, ed ai suoi<br />
imme<strong>di</strong>ati successori Adelperto III <strong>di</strong> Ravenstein<br />
(1219-1223), Gerardo I cremonese (1223-1232), Aldrighetto<br />
<strong>di</strong> Campo (1232-1247) ed Egnone d'Appiano<br />
(1248-1273). Tale attribuzione è però sempre alquanto<br />
vaga ed incerta, né i documenti conosciuti giovano<br />
a recare maggior luce, che il più antico accenno alla<br />
moneta trentina non risale che al 1257. E un fatto<br />
però che la moneta così detta grossa si <strong>com</strong>inciò<br />
generalmente a battere nelle zecche d'Italia soltanto<br />
dopo il 1220, ai tempi <strong>di</strong> Federico IL Vi farebbe<br />
eccezione Milano per un grosso e un soldo attribuiti<br />
ad Enrico VI (1190-1197) e Venezia che verso il 1200<br />
coniava il suo primo matapan. Esiterei perciò ad<br />
ammettere che Trento nel coniare questa sorte <strong>di</strong><br />
moneta avanzasse altre e più importanti città dell' I-<br />
talia superiore. Di più è da notarsi che nelle carte<br />
trentine della prima metà del secolo XIII non trovasi<br />
menzionata la moneta <strong>di</strong> Trento, ma sempre quella<br />
<strong>di</strong> Verona, ed in conformità ai grossi veronesi erano<br />
battuti i grossi trentini, che quin<strong>di</strong> sono da ritenersi<br />
meno antichi <strong>di</strong> quelli, e non anteriori al 1220.<br />
È perciò che preferirei attribuire questi grossi del<br />
nostro ripostiglio al vescovo Aldrighetto <strong>di</strong> Campo<br />
(1232-1247) ed al suo successore Egnone d'Appiano
UN RIPOSTIGLIO DI MONETE DEL SECOLO XIII, ECC. 49I<br />
(1248-1273) nel periodo <strong>di</strong> tempo <strong>com</strong>preso fra il 1235<br />
ed il 1255, all'epoca in cui il vescovato era ammini-<br />
strato nel temporale dai podestà imperiali.<br />
^ — ¥ •<br />
^ — • +<br />
2. Soldo da 12 denari o piccoli.<br />
EPS<br />
• TRIDEN •<br />
interno ed esterno.<br />
IM^ATOR<br />
•<br />
F<br />
Nel campo T. Circolo <strong>di</strong> punti<br />
• Croce con stella a sei raggi ad i<br />
e 4, e punta rivolta verso l'interno ad i e 2. Circoli<br />
e. S. (Peso gr. 1.21, titolo 724 mill.) . . . . n. 26<br />
Varietà con una punta verticale scendente dall'alto sopra<br />
il T nel campo del <strong>di</strong>ritto (Peso gr. 1.25) . . n. 8<br />
Varietà con una punta a sinistra del T, volta dal basso<br />
all'alto (Peso gr. 1.20, titolo 724 mill.) . . . . n. 99<br />
B. GiovANELLi, Alterthumliche Entdeckungeu, ecc. Op. cit., pag. 16,<br />
tav. n. 7.<br />
Gazzoletti, Della zecca <strong>di</strong> Trenta. Trento, 1858, tav. I, n. 3, pag. 30.<br />
Il valore <strong>di</strong> questa moneta, tenuto conto del suo<br />
peso e dell'argento che contiene, risulterebbe corrispondente<br />
a 12 denari piccoli <strong>di</strong> Trento, o <strong>di</strong> Verona<br />
ossia ad un soldo.<br />
L'essere essa apparsa nel nostro ripostiglio in<br />
tanta quantità e con molti esemplari <strong>di</strong> ottima con-<br />
servazione, pare non giovi a confermare l'attribuzione<br />
fattane dal Giovanelli, e dal Gazzoletti al vescovo<br />
Salomone (1177-1183). È probabile che si riferisca a<br />
questa moneta la <strong>di</strong>sposizione dello statuto <strong>di</strong> Brescia<br />
dell'anno 1257, colla quale si ammettono fra gli altri<br />
anche i trentini grossi ad ligam veronensium /a<strong>di</strong>,<br />
ossia si concede libero corso al grosso da 20 denari.
492<br />
GIORGIO CIANI<br />
e si ban<strong>di</strong>sce questo soldo, che verosimilmente fu<br />
battuto negli ultimi anni del dominio dei podestà<br />
imperiali (1235- 1255). Anche <strong>di</strong> questa specie esiste<br />
una varietà, <strong>di</strong> stile più antico, col T del <strong>di</strong>ritto fra<br />
tre punti, e nel rovescio 2 stelle negli angoli supe-<br />
riori, e due punti in quelli inferiori della croce, che<br />
non rinvenni fra i 133 esemplari del ripostiglio.<br />
Questa varietà in esemplari perfetti raggiunge il peso<br />
<strong>di</strong> grammi 1.41, ed all' assaggio risultò <strong>di</strong> millesimi<br />
864, e perciò appartiene ad un' epoca anteriore a<br />
quelle precedentemente descritte.<br />
^ — EPS • • TRIDEN Nel campo T. Circolo <strong>di</strong> punti all'interno<br />
e all'esterno.<br />
^ — IN^ATOR ® • Croce. Circoli e. s. . . . n. 3<br />
Peso gr. 0.327, titolo 220 mill.<br />
3. Denaro o piccolo (concavo).<br />
Gazzoletti, Op. cit., tav. I, n. 5, pag. 31.<br />
Il denaro, o piccolo, <strong>di</strong> Trento era eguale in<br />
valore a quello <strong>di</strong> Verona. I tre esemplari del ripo-<br />
stiglio non portano l'iniziale <strong>di</strong>notante il nome dell'im-<br />
peratore che vedesi gu altri simih denari trentini, forse<br />
perchè emesso dopo la morte <strong>di</strong> Federico II (1250).<br />
VERONA.<br />
Grosso da 20 denari, o piccoli.<br />
^ — + CI + f I + CI + fi (FPIR). Croce oltrepassante un<br />
5!^<br />
circolo, fra le cui aste VE — RO — N — A. Circolo <strong>di</strong> punti<br />
interno ed esterno.<br />
— + ® VE ® RO ® NA ® (VE in nesso) Croce <strong>com</strong>e sopra<br />
fra le cui aste, CI— fi — CI — f=i. Circoli e. s. . n. 7<br />
Peso gr. 1.653, titolo 956 mill.
UN RIPOSTIGLIO DI MONETE DEL SECOLO XIII, ECC. 493<br />
Varietà: Con un'appen<strong>di</strong>ce sopra la croce nel <strong>di</strong>ritto, e sotto<br />
la croce nel rovescio n.<br />
^' -<br />
II
494<br />
GIORGIO CIANI<br />
certamente per <strong>di</strong>stinguerli da altri che doveano es-<br />
sere questi grossi. Probabilmente la loro coniazione<br />
risale al 1220 circa.<br />
5. Denaro o piccolo (concavo).<br />
^ — Ff-ID — lf — D (FRIP). Fra le braccia <strong>di</strong> una croce<br />
oltrepassante un cerchiello.<br />
1^ — VE ~ RO — N - A (VE in nesso) C. s, (Peso gr. 0.28) n. 1<br />
Zanetti, Op. cit., tom. IV, tav. IV, n. 20.<br />
VENEZIA.<br />
6. Denaro o piccolo (Peso gr. 0.28-0.30).<br />
Sebastiano Ziani (1172-1178) n. i<br />
Orio Malipiero (1178-1192) „ i<br />
N. Papadopoli, Le monete <strong>di</strong> Venezia. Venezia, 1893, tav. V, n. 2 e 3.<br />
7. Grosso (Peso gr. 2.18).<br />
Iacopo Tiepolo (1229-1249) n. 2<br />
Ranieri Zeno (1253-1268) ,,2<br />
N. Papadopoli, Op. cit., tav. V, n. 5 e 11.<br />
MANTOVA.<br />
8. Denaro o piccolo, concavo (Peso gr. 0.29). . . n. 9<br />
A. Partioli, La zecca <strong>di</strong> Mantova. Mantova, 1879. Parte I, tav. n. 7.<br />
BRESCIA.<br />
9. Denaro o piccolo, concavo (Peso gr. 0.24). . . n. 2<br />
Zanetti, Op. cit., tom IV, tav. VII, n. 4.<br />
10. Grosso (Peso gr. 1.95) „ i<br />
Zanetti, Op. cit., tom. IV, tav. VI, n. 6.<br />
CREMONA.<br />
ri. Soldo (Peso gr. 1.23) . . . . . . . n. i<br />
Descritto da C. Brambilla in Riv. It. <strong>di</strong> Num. Anno IV, f. IV, p. 432.<br />
1
12. Soldo?<br />
UN RIPOSTIGLIO DI MONETE DEL SECOLO XIII, ECC. 495<br />
BERGAMO.<br />
ViMERCATi-Sozzi, SulU monete della città <strong>di</strong> Bergamo. Bergamo, 1842,<br />
tav. I, n. 8.<br />
Varietà: Con + e vj nel campo del '^ (Peso gr. 1.35) . n. 8<br />
„ Con O a destra della crocetta del tempio nel I^ „ i<br />
Peso gr. 1.36.<br />
„ Con ^ dopo IMPRT, e • nel campo.<br />
Nel • P e ^ (Peso gr. 1.26) . . . . „ 8<br />
„ e. 1. p. con due punte salienti nei due archi <strong>di</strong><br />
mezzo del 5^ (Peso gr. 1.26) . . . . „ 8<br />
„<br />
„<br />
C. s. con due anelletti negli archi (Peso gr. 1.29)<br />
C. 1. p. mancante del<br />
„ 6<br />
• nel campo del ^ . „ 1<br />
Peso gr. 1.26.<br />
„ C. 1. p. mancante degli anelletti nel 1^ . . „ 1<br />
Peso gr. 1.29.<br />
„ C. 1. p. con "¥ a destra della crocetta nel 9/ „ i<br />
Peso gr. 1.27.<br />
„<br />
„<br />
13. Soldo?<br />
Con ®- dopo IMPRT.<br />
Nel P ®- e v!; (Peso gr. T.17). . . • ,, 5<br />
Con © dopo IMPRT.<br />
Nel :^ ®- e 4t<br />
COMO.<br />
S. Ambrosoli, Zecche italiane. Corno, 1881, tav. I e II, n. 15.<br />
Varietà: Con ^ nel campo del ^', e -® sopra la testa del-<br />
„<br />
l'aquila nel ^ (Peso gr. 1.39).<br />
Come il n. 17 delle tav. I e II<br />
. •<br />
dell'op. cit.<br />
. n. i<br />
mancante<br />
della stella nel campo del ^ (Peso gr. 1.22) „ i<br />
„ C. 1. p. con *-> nel campo del ^ (Peso gr. 1.20) „ i<br />
LODI.<br />
14. Soldo? (Peso gr. 1,32) n. I<br />
B. GiovANELLi, Intorno all'antica zecca trentina, Op. cit., pag. 85, fig.<br />
„<br />
I
496<br />
GIORGIO CIANI<br />
TORTONA.<br />
15. Grosso (Peso gr. 1.69) n. 8<br />
D. Promis, Monete del Piemonte ine<strong>di</strong>te, rare. Torino, 1852, pag. 31,<br />
tav. II, n. 8.<br />
16. Soldo (Peso gr. 1.05, consunta).<br />
^ — + INPE • • RA'TOR Nel campo f"r Circolo <strong>di</strong> punti<br />
interno ed esterno.<br />
P — + TER"DONA • Croce con anelletto nei due angoli<br />
superiori ; . . „ i<br />
Simile al n. 9 della tav. II. Promis, Op. cit.<br />
ACQUI.<br />
17. Soldo? (Peso gr. 1.315) . . . . . . n. 2<br />
E. Gnecchi, in Riv. It. <strong>di</strong> Num. Anno X, fase. I, 1897, pag. 24, fig.<br />
ASTI.<br />
18. Soldo? (Peso gr. 1.32.) n. 2<br />
D. Promis, Monete della zecca d'Asti. Torino, 1853, tav. I, n. 5,<br />
pag. 21.<br />
Trento, Agosto iSgj.<br />
Giorgio Ciani.
ANNOTAZIONI<br />
NUMISMATICHE ITALIANE<br />
III.<br />
DEZANA.<br />
i^ — + PERDI- D: G- RO VNGBOE- DAL •CROAZC''REX<br />
Busto corazzato a sin. con corona imperiale, scettro<br />
nella sin., e colla destra sulla impugnatura della spada.<br />
:pf - + NVMVS ® AR(t ® IMP ® COMITIS ® DECIANE ® ®<br />
Aquila spiegata, collo scudo dei Tizzoni in petto.<br />
Argento, peso gr. 27,96. — Cons. buona. Raccolta Principe <strong>di</strong> Napoli.<br />
Dal Promis abbiamo notizia <strong>di</strong> una deposizione<br />
deirassaggiatore Prevostino fatta nel 1585, relativa<br />
alle monete coniate prima <strong>di</strong> quell'anno in questa<br />
officina (i), nella quale son citati alcuni talleri <strong>di</strong><br />
denari 8 <strong>di</strong> fine {666), e del peso <strong>di</strong> den. 22,14 cor-<br />
rispondente a poco meno <strong>di</strong> gr. 29. A pag. 37,<br />
(i) Monete della Zecca <strong>di</strong> Dezana. Torino, 1863, a pag. 33.<br />
63
498<br />
GIUSEPPE RUGGERO<br />
ritornando su quel documento, troviamo che questi<br />
talleri avevano l'effigie <strong>di</strong> re ed imperatori, ma che<br />
il teste non ricordava bene quali fossero. L'illustre<br />
A. <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> non conoscere altre monete che possano<br />
corrispondere a quella descrizione, all'infuori <strong>di</strong><br />
quelle che portano il busto <strong>di</strong> un guerriero armato<br />
ed a capo scoperto, <strong>com</strong>e si trova sui talleri <strong>di</strong> Ca-<br />
sale <strong>di</strong> Messerano e Tassarolo, coU'aquila al rovescio.<br />
Ma la deposizione del teste precisava l'effigie in modo,<br />
da lasciar qualche dubbio sulla ipotesi del Promis.<br />
Il magnifico tallero, che ho <strong>di</strong>segnato dal calco<br />
che me ne ha favorito S. A. R. il Principe <strong>di</strong> Napoli,<br />
fortunato possessore <strong>di</strong> questo pezzo insigne, viene<br />
a colmare una lacuna, palesandosi anche nel peso,<br />
per una <strong>di</strong> quelle monete citate nel documento. D'altronde<br />
non è probabile che questa venisse coniata<br />
dopo <strong>di</strong> quell'anno, anzi nemmeno dopo del 1583,<br />
sia perchè ci allontaneremmo <strong>di</strong> troppo dall' epoca<br />
<strong>di</strong> Fer<strong>di</strong>nando I: sia perchè allora si coniavano già<br />
altri talleri coll'effigie del successore Massimiliano II,<br />
che rimangono ancora a noi sconosciuti (V. pag. 38,<br />
Op. cit.).<br />
Il dritto della moneta non ha nulla che riveli<br />
la zecca <strong>di</strong> origine, essendo, salvo qualche particolare<br />
insignificante, eguale a quello dei talleri unghe-<br />
resi dell'Imperatore, colla stessa leggenda <strong>di</strong> quelli.<br />
E questo era più che sufficiente per la circolazione<br />
della moneta fino a che non venisse scoperta la frode.<br />
Il rovescio invece, Imperiale per l'aquila, si mostra<br />
<strong>di</strong> Dezana allo stemma ed alla leggenda : particolari<br />
questi, sui quali non si fermava certamente l'atten-<br />
zione del pubblico, <strong>di</strong>giuno in gran parte <strong>di</strong> lettere<br />
e maggiormente <strong>di</strong> aral<strong>di</strong>ca.<br />
Non si è assaggiato il titolo, ma al semplice<br />
aspetto si <strong>di</strong>mostra non inferiore <strong>di</strong> certo, a quello<br />
in<strong>di</strong>cato sul documento più volte citato.
^^ — A L • D<br />
ANNOTAZIONI NUMISMATICflE ITALIANE 499<br />
MODENA OD URBINO?<br />
X • Bomba<br />
fatta a guisa <strong>di</strong> un monticello.<br />
9? — DI II MIDI<br />
II<br />
VM<br />
II<br />
Traccie<br />
accesa , sopra una base<br />
<strong>di</strong> una ghirlanda attorno.<br />
Lega bassissima, peso gr. 0,57. — Cons. me<strong>di</strong>ocre. Presso lo scrivente.<br />
La bomba <strong>di</strong> questa monetina, ci richiama alla<br />
mente per analogia due serie monetarie, quella <strong>di</strong><br />
Modena e quella <strong>di</strong> Urbino. Infatti, nella prima si<br />
coniarono quelle monete del Duca Cesare col titolo<br />
<strong>di</strong> Principe della Garfagnana, le quali portano una<br />
bomba eguale alla presente meno che nella base (2)-<br />
dalla seconda, uscirono certe monetine <strong>di</strong> Guidubaldo<br />
II portanti le granate a mano, oggetti guerreschi,<br />
che già prima dei Dalla Rovere si trovavano scol-<br />
piti negh ornati <strong>di</strong> quel palazzo Ducale (3).<br />
Prima <strong>di</strong> tutto devo avvertire il lettore, che la<br />
terza lettera al dritto è un po' <strong>di</strong>fettosa, e si presta<br />
egualmente bene tanto per una D <strong>com</strong>e per una P.<br />
Converrà tener conto <strong>di</strong> questo fatto per la interpre-<br />
tazione della leggenda nelle due ipotesi sopra ac-<br />
cennate.<br />
Nella prima, cioè per Modena, la moneta sarebbe<br />
coniata dal Duca Alfonso I, e si dovrebbe leggere,<br />
ALfonsus .<br />
.<br />
DuX Questa lezione troverebbe una<br />
giustificazione nel numero e nella posizione dei due<br />
(2) Ve<strong>di</strong> Promis, Monete <strong>di</strong> zecche Italiane ine<strong>di</strong>te, Memoria I. To-<br />
rino, 1867, al n. 26 — Crespellani, La Zecca <strong>di</strong> Modena. Modena, 1884,<br />
Tav. IX, n. 75.<br />
(3) Ve<strong>di</strong> Giuseppe Castellani, Quattrino ine<strong>di</strong>to, etc, in Riv. N. 11.<br />
Anno VII, pag. 91-97.
500<br />
GIUSEPPE RUGGERO<br />
punti: ma è strano quel DVX segnato colle sole<br />
lettere estreme, forse per non rompere la simmetria<br />
delle quattro lettere, e credendosi piij decisiva la<br />
X che non TV, per l'interpretazione della parola.<br />
Il valore della moneta non sconcorderebbe colle<br />
altre della serie Modenese, perchè data la <strong>di</strong>fferenza<br />
del titolo e del peso, tornerebbe per l'appunto alla<br />
metà del valore del quattrino. Sarebbe tuttavia que-<br />
sto, l'unico esempio in quella zecca, dell'uso <strong>di</strong> questo<br />
infimo spezzato.<br />
Passiamo ora alla seconda ipotesi, quella della<br />
pertinenza alla serie Urbinate. In questo caso leggeremo<br />
la terza lettera per una P, ed assegneremo<br />
la moneta all'epoca della spogliazione del Della Ro-<br />
vere, fatta da. Papa Leone X in favore del nipote,<br />
cioè al 15 16. Nel quale anno, Urbino prima e Pesaro<br />
poco dopo, aprirono le porte al condottiero delle<br />
schiere papaline Renzo <strong>di</strong> Cere, non avendo Fran-<br />
cesco Maria neppur tentato <strong>di</strong> opporre <strong>di</strong>fesa alcuna,<br />
anzi avendole abbandonate in tempo utile per la pro-<br />
pria salvezza. La moneta sarebbe stata coniata in<br />
quell'intervallo <strong>di</strong> tempo, trascorso tra l'occupazione<br />
del Ducato e la bolla papale contro firmata da tutti<br />
i Car<strong>di</strong>nali meno uno, che ne investiva Lorenzo de'<br />
Me<strong>di</strong>ci. Onde la leggenda dovrebbe interpretarsi,<br />
Auspice Leone .<br />
Papa<br />
X .<br />
In questa ipotesi, noi avremmo l'appoggio <strong>di</strong><br />
due in<strong>di</strong>zi favorevoh. La <strong>di</strong>sposizione della leggenda<br />
<strong>di</strong> più linee in mezzo ad una ghirlanda, foggia<br />
usitatissima in quelle zecche, è il primo. U altro ci<br />
vien dato dalla in<strong>di</strong>cazione del valore <strong>di</strong> mezzo quat-<br />
trino, che si trova pure, ma in italiano perchè <strong>di</strong><br />
epoca posteriore, sopra una monetina <strong>di</strong> Francesco<br />
Maria li (4); dunque è evidente, che quel valore era<br />
(4) Ve<strong>di</strong> Zanetti, Nuova raccolta, etc. Voi. I, pag. 136, n. 53.
ANNOTAZIONI NUMISMATICHE ITALIANE 501<br />
usato nella monetazione Urbinate. Confrontando il<br />
pezzo con i quattrini <strong>di</strong> quell'epoca, e specialmente<br />
con quelli <strong>di</strong> Lorenzo de' Me<strong>di</strong>ci coniati subito dopo,<br />
troviamo dal calcolo approssimativo del peso e della<br />
lega delle due monete, che l.'una è doppia dell'altra,<br />
e che il nostro mezzo quattrino corrisponde al picciolo.<br />
Nella speranza <strong>di</strong> qualche nuovo esemplare che<br />
tolga il dubbio circa la terza lettera, purché il <strong>di</strong>fetto<br />
non esista nel conio, ne aspetteremo la soluzione definitiva<br />
della questione tra le due ipotesi che ci tengono<br />
incerti. Meglio ancora, se prima d'allora altri più<br />
<strong>com</strong>petenti in materia, ne troverà una migliore.<br />
^ — SANT •<br />
CORREGGIO?<br />
ANTONIVS Busto mitrato e nimbato; ai lati S A<br />
9» — Aquila bicipite, con corona chiusa.<br />
(Juasi rame, peso gr. 0,93, — Cons. buona. Presso lo scrivente.<br />
Questa monetina non è ine<strong>di</strong>ta a rigor <strong>di</strong> ter-<br />
mini, avendone il Kunz fino dal 1869 constatata l'e-<br />
sistenza nella nota a pag. iii del volume II del<br />
Perio<strong>di</strong>co dello Strozzi. Al n. 8 tav. V dello stesso<br />
volume, egli pubblicava il <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> una consimile,<br />
che in luogo dell'intero nome del Santo ha l'abbre-<br />
viazione <strong>di</strong> SANCTVS •<br />
ANT,<br />
la quale si presta a doppia<br />
interpretazione. Ed è per questo che nella nota ci-<br />
tata, egli rilevava <strong>com</strong>e venisse spesso attribuito a<br />
Piacenza quel quattrino, fatto ad imitazione <strong>di</strong> ta-<br />
luni dell'Imperatore Carlo V per Milano, perchè nel<br />
Santo si voleva raffigurare S. Antonino sebbene<br />
sotto parvenze che non gli corrispondono. E, notata
502<br />
GIUSEPPE RUGGERO<br />
l'esistenza <strong>di</strong> altro esemplare con SAN •<br />
ANTONI VS che<br />
infirmava l'ipotesi dell'attribuzione a Piacenza, finiva<br />
coir invocare un ammaestramento su tale proposito.<br />
Comincierò dall'accentuar meglio la conclusione<br />
del Kunz, <strong>di</strong>cendo : che l'ipotesi accennata, già infir-<br />
mata dalle parvenze del busto, vien <strong>di</strong>strutta total-<br />
mente da questo esemplare con SAN •<br />
ANTONIVS.<br />
La<br />
zecca Piacentina non ha mai improntato questo Santo<br />
sulle sue monete, ne ha mai contraffatto moneta altrui.<br />
Non intendo risolvere la questione mancandoci<br />
gli elementi <strong>di</strong> prova. Ma non rinunzio a formulare<br />
una ipotesi che lascio alla <strong>di</strong>screzione del lettore fino<br />
a prova in contrario. Ma questi problemi numisma-<br />
tici non avranno mai una soluzione, se manchino i<br />
Kunz che li propongano, e gli altri che <strong>com</strong>incino a<br />
stu<strong>di</strong>arli.<br />
Le due iniziali furono il punto <strong>di</strong> partenza per<br />
il ragionamento, semplice <strong>di</strong> molto, ma non saprei<br />
se egualmente convincente. Volendo considerarle<br />
<strong>com</strong>e iniziali del nome del Santo, si avrebbe una<br />
ripetizione. Se si trattasse <strong>di</strong> moneta la cui origine<br />
fosse designata da una leggenda o da altri caratteri,<br />
questa ripetizione costituirebbe solamente un pleonasmo.<br />
Ma in questa nostra dove mancano assolutamente<br />
leggenda e caratteri relativi alla zecca, questa<br />
ripetizione mi pare veramente fuor <strong>di</strong> luogo e perciò<br />
inammessibile. hi massima, gli autori <strong>di</strong> contraffazioni<br />
hanno sempre lasciato sulla moneta, qualche traccia<br />
più o meno larvata relativa alla zecca. Ecco dunque<br />
i motivi per cui le due iniziali dovevano, secondo<br />
me, tener la chiave dell'enigma, e mi fermai alla<br />
zecca dei Correggeschi leggendovi Sirus Austriacus;<br />
pronto, beninteso, a fare onorevole ammenda in caso<br />
<strong>di</strong> prova contraria.<br />
GH altri caratteri della moneta, non presenterebbero<br />
in<strong>com</strong>patibilità. L'aquila bicipite è quasi Tu-
ANNOTAZIONI NUMISMATICHE ITALIANE 503<br />
nica usata sopra le <strong>di</strong>verse specie <strong>di</strong> monete <strong>di</strong><br />
Correggio, non trovandosi improntata quella ad una<br />
testa che eccezionalmente sui sesini e su qualche altra<br />
piccola moneta. Circa al Santo, non è questa la sola<br />
volta che S. Quirino avrebbe ceduto il posto ad<br />
altri (5). E non è poi così strano che il protettore della<br />
città, abituato a cangiare costume ed attributi quasi<br />
per ogni specie <strong>di</strong> moneta, ceda anche una volta il<br />
suo posto ad un nuovo Santo, messo \\ , perchè i<br />
Milanesi vi raffigurassero il loro Ambrogio. Si ca-<br />
pisce poi, che col nome <strong>di</strong> S. Quirino si correva<br />
rischio <strong>di</strong> fallir Tintento, facilitato invece da un nome<br />
che <strong>com</strong>inciasse per AM o almeno per AN. Notisi<br />
ancora, che S. Antonio aveva un culto speciale in<br />
Correggio, per un altare molto venerato nel Duomo.<br />
Dunque non si avrebbe nulla sin qui, in con-<br />
trario a quésta attribuzione, anzi parrebbe che ogni<br />
in<strong>di</strong>zio concorresse a confermarla. Né voglio trascu-<br />
rare quello del peso, il quale sebbene non costituisca<br />
mai da solo un argomento valido, pur tuttavia può<br />
concorrere alla prova in unione agli altri.<br />
Questa monetina pesa gr. 0,93 ed è quasi <strong>di</strong><br />
puro rame; avrebbe dunque presentato le con<strong>di</strong>zioni<br />
<strong>di</strong> un buon guadagno correndo frammista alle trilline<br />
<strong>di</strong> Carlo V (6), le quali al titolo <strong>di</strong> 60, pesavano<br />
gr. 1,160. Ora, si veda il documento portato dal<br />
Bigi (7) che prescrive per i sesini <strong>di</strong> Correggio il<br />
peso <strong>di</strong> grani 20 <strong>di</strong> libbra Bolognese, ed il titolo <strong>di</strong><br />
circa 120. La libbra Bolognese essendo eguale a<br />
gr. 361,851, <strong>di</strong>visibile in 12 oncie <strong>di</strong> 160 carati <strong>di</strong> 4<br />
grani, ne risulta che i sesini vengono a pesare gr. 0,94,<br />
(5) Ve<strong>di</strong> Q. Bigi, Di Camillo e Siro da Correggio e lor zecca.<br />
Modena, 1870; tav. Ili, n. 23 e tav. IX, n. 74 e 75 — Kunz, in Archeo-<br />
grafo triestino, Voi. Vili, n. 16 delle tavole.<br />
(6) Ve<strong>di</strong> Gnecchi, Le Monete <strong>di</strong> Milano, ivi 1884, tav. XXV, p. 14.<br />
(7) Op. cit, pag. 53.
504<br />
GIUSEPPE RUGGERO<br />
che è il peso della nostra monetina pila un centigrammo.<br />
Ecco dunque <strong>com</strong>e il contraffattore avrebbe<br />
creato in parte le prove a <strong>di</strong>mostrare che quella<br />
moneta gli apparteneva, sia per le iniziali che per<br />
il peso, ed era un vero sesino <strong>di</strong> Correggio; se poi<br />
qualcuno si fosse ingannato scambiandolo per una<br />
trillina <strong>di</strong> Carlo' V, quod erat in votis, tanto peggio<br />
per lui. Ed avrebbe potuto aggiungere che volendo<br />
contraffare trilline, avrebbe prese a modello quelle<br />
contemporanee dei Filippi, e non quelle più antiche,<br />
sebbene a quei tempi queste circolassero ancora.<br />
Avendo dovuto toccare la questione dei Santi<br />
menzionati sulle monete, non sarà male <strong>di</strong> consultare<br />
i principah elenchi che ne trattano, e che si trovano<br />
abitualmente tra le mani dei numismatici. Per non<br />
cercarne altri, basterà vedere il Tonini, il Muoni e<br />
TAmbrosoli. Nel primo (s), ricopiato poi nel vademecum<br />
del Bazzi e Santoni (9), non abbiamo che un<br />
solo S. Antonio, quello abbate, ma in <strong>com</strong>penso vien<br />
pro<strong>di</strong>gato a sei zecche, cioè Mirandola, Padova,<br />
Parma, Piacenza, Pesaro ed ai Lau<strong>di</strong>. Dunque questo<br />
elenco non si rac<strong>com</strong>anda per esattezza. Il Muoni (^o),<br />
non fa un elenco a parte, ma nota i Santi protettori<br />
per ogni zecca: egli non nomina che un solo S. An-<br />
tonio per Padova, ma nel supplemento a pag. 68,<br />
assegna S. Antonio abbate a Massa Lombarda. L'A.<br />
cita ingenuamente il Catalogo Rossi (") a proposito<br />
<strong>di</strong> una monetina portata in Massa Lombarda al<br />
n, 2193, senza avvedersi dell' errore: infatti nello<br />
stesso catalogo, la detta moneta è ripetuta al n. 3459<br />
in Pesaro, zecca alla quale vien data dal Zanetti,<br />
(8) Topografia delle Zecche Italiane. Firenze, 1869.<br />
(9) Vade-mecum del raccoglitore <strong>di</strong> monete ital., etc. Camerino, i886.<br />
(io) Elenco delle zecche d'Italia^ seconda e<strong>di</strong>zione in Gazzetta Nu-<br />
mismatica dell'ÀMBROSOLi, anno V, 1885.<br />
(11) Catalogo del Sambon per la Collezione Rossi. Roma, 1880.
ANNOTAZIONI NUMISMATICHE ITALIANE 505<br />
Voi. Ili, Tav. XXIV, n. 34. Finalmente V elenco<br />
deirAmbrosoli (^2) che è il più esatto <strong>di</strong> tutti, <strong>di</strong>stingue<br />
i <strong>di</strong>versi Santi che hanno il nome <strong>di</strong> Antonio. Non<br />
mette in Piacenza che il solo S. • Antonino che le<br />
spetta; ma assegna dubitativamente un S. Antonio<br />
a Dezana.<br />
In conclusione, questi elenchi sono una buonissima<br />
cosa massime per i principianti, quando son<br />
fatti e tenuti a corrente colla scorta delle monete o<br />
dei documenti; ma chi volesse poi tenerli per guida<br />
nella classificazione <strong>di</strong> monete nuove, correrebbe<br />
rischio <strong>di</strong> allontanarsi dal vero.<br />
Firenze, Ottobre 189J.<br />
Giuseppe Ruggero.<br />
(12) Manuale <strong>di</strong> Numismatica, Serie Hoepli, seconda e<strong>di</strong>zione. Mi-<br />
lano, 1895.<br />
64
IL RIPOSTIGLIO<br />
DI<br />
SAN MARTINO DEL PIZZOLANO<br />
Nello scorso anno, in un fondo <strong>di</strong> proprietà del Nob.<br />
Sig. Gio. Frigerio <strong>di</strong> Milano, a San Martino del Pizzolano<br />
(<strong>com</strong>une <strong>di</strong> Somaglia, circondario <strong>di</strong> Lo<strong>di</strong>), un conta<strong>di</strong>no nel<br />
lavorare una risaia spezzava coli' aratro un vaso <strong>di</strong> terra,<br />
che conteneva oltre un migliaio <strong>di</strong> monete <strong>di</strong> bronzo romane.<br />
Di queste, ho potuto esaminarne circa una metà; erano<br />
tutte, con una sola eccezione, gran bronzi imperiali o sesterzi,<br />
in generale ben conservati, appartenenti a 31 tra imperatori<br />
e auguste, e (prescindendo da due irriconoscibili) si <strong>di</strong>stri-<br />
buivano <strong>com</strong>e risulta dal succinto elenco che segue.<br />
Tito. — Gr. br. con rov. consunto. Esempi, i.<br />
Domiziano. — Gr. br. con rov. consunto. Es. 2.<br />
Nerva. — Gr. br., restit. d'Augusto. Es. i consunto.<br />
Traiano. — Gr. br. Armenia et mesopotamia in potestatem p r<br />
REDACTAE Es. I consunto. — SENATVS POPVLVSQVE ROMANVS La Pace o<br />
la Felicità stante a sin. Es. i consunto. — s p q r optimo principi Dace<br />
seduto a sin.; <strong>di</strong>nanzi, un trofeo. Es. i consunto. — s p q r optimo<br />
principi La Vittoria stante a dr. appende uno scudo su cui vie dac Es. i.<br />
— Arco <strong>di</strong> trionfo (?). Es. i consunto. — Gr. br. con rov. consunt. Es. 7.<br />
Adriano. — Gr. br. aeqvitas avg Es. 2. — cos ni II Valore stante<br />
a sin. Es. i consunto. — felicitati avg Nave a sin. Es. 2. — hilaritas<br />
p R Es. I. — PONT MAX ecc. La Pace o la Felicità stante a sin. con<br />
caduceo e cornucopia. Es. i. — salvs avg La Salute seduta a sin. Es. i.<br />
— Giove seduto a sin. Es. i consunto. — Nettuno stante a dr. Es. i<br />
consunto. — Adriano stante a sin. porge la mano a una figura ingi-<br />
nocchiata. Es. I. — Adriano stante a dr. ; <strong>di</strong>nanzi a lui, una figura<br />
muliebre. Es. 2 consunti. — La Speranza gra<strong>di</strong>ente a sin. Es. 3 consunti.<br />
— La Salute stante a sin. Es. i consunto. — Gr. br. con rov. consunto.<br />
Es. 37.
508 SOLONE AMBROSOLI<br />
Sabina. — Gr. br. concor<strong>di</strong>a Es. 2. — veneri genetrici (var. del<br />
N. 74, Coh. II e<strong>di</strong>z., perchè Sabina ha la capigliatura rialzata). Es. i. —<br />
Gr. br. con rov. in<strong>di</strong>stinto n Es. i. — Gr. br. con rov. consunto. Es. 3.<br />
Antonino Pio. — Gr. br. annona avg L'Abbondanza stante a dr.<br />
Es. I. — ANNONA AVG ecc. L'Abbondanza seduta a sin. Es. i. — apollini<br />
avgvsto Es. I consunto. — consecratio Rogo. Es. i. — cos mi L'Equità<br />
stante a sin. Es. 2. — felicitas avg Es. i. — indvlgentia avg cos mi<br />
Es. I consunto. — libertas cos mi La Libertà stante a sin. tiene un<br />
berretto e uno scettro. Es. i. — libertas cos mi La Libertà stante a<br />
dr. tiene un berretto nella dr. e protende la sin. Es. 4. — Me<strong>di</strong>o br.<br />
Stesso, tipo. Es. I. — Gr. br. pietati avg Es. i. — pietati avg cos mi<br />
Es. 2. — SALVS avg La Salute stante a sin. Es. 2. — tr fot cos ii<br />
Figura muliebre stante a dr., con due spighe e un canestro <strong>di</strong> frutta.<br />
Es. I. — TR POT XV ecc. Antonino seduto a sin., tiene un globo ed è<br />
coronato da una Vittoria volante. Es. 3. — tr pot xv cos mi La Fortuna<br />
stante a dr. coti timone e cornucopia. Es. i. — tr pot xix ecc. La<br />
Provvidenza stante a sin. Es. i. — tr pot xix ecc. La Pace stante a<br />
sin. Es. I. — tr pot xxi cos mi L'Abbondanza stante a dr. con timone<br />
e mo<strong>di</strong>o, poggia il piede su <strong>di</strong> una prora. Es. i. — tr pot xxii ecc. La<br />
Concor<strong>di</strong>a, stante <strong>di</strong> prospetto, guarda a sin. e tiene due insegne mi-<br />
litari. Es. I. — VOTA svscepta DEC III Es. I. — Antonino stante a sin.<br />
in abito militare, tiene un ramoscello nella dr. e un'asta nella sin. Es. i.<br />
— La Libertà stante a sin. tiene un berretto e uno scettro. Es. i con-<br />
sunto. — L'Abbondanza stante a sin. fra il mo<strong>di</strong>o e una nave. Es. i<br />
consunto. — La Salute stante a sin. Es. i consunto. — Figura muliebre<br />
seduta a sin. Es. 3 consunti. — La Lupa a dr., coi gemelli. Es. i. —<br />
La Lupa a sin., coi gemelli. Es. i. — Gr. br. con rov. consunto. Es. 15.<br />
Faustina sen. — Gr. br. aeternitas L'Eternità (o Faustina ?) seduta<br />
a sin. Es. i. — aeternitas L'Eternità (o la Fortuna?) stante a sin. Es. i.<br />
— ceres Cerere stante a sin. Es. i. — consecratio Vesta stante a sin.<br />
Es. 2. — ivNO Es. 3. — pietas La Pietà stante a sin. depone un grano<br />
d'incenso su <strong>di</strong> un candelabro. Es. i. — Gr. br. con rov. consunto. Es. 11.<br />
Marc'Aurelio. — Gr. br. consecratio Marc'Aurelio trasportato da<br />
un' aquila. Es. i. — consecratio Aquila sul globo. Es. 3. — felicitas<br />
AVG ecc. Es. I. — FIDES EXERCiTVVM Es. I. — iMP VI COS IH La Vittoria<br />
appende uno scudo su cui vie ger Es. 5. — imp vii cos iii La Fede<br />
militare stante a sin. Es. i. — imp viii Cumulo d'armi. Es. i. — primi<br />
decennales cos III Es. I. — s e Minerva stante a dr. imbracciando lo<br />
scudo e scagliando un giavellotto. Es. 2. — vota sol decenn cos ih<br />
Es. I. — Giove seduto a sin. Es. 3. — Minerva stante a dr., appoggiata<br />
allo scudo. Es. 2. — Minerva stante a sin., appoggiata allo scudo. Es. i.<br />
— Marc'Aurelio stante a sin. fra quattro insegne militari. Es. i. —<br />
Marc'Aurelio stante a sin. porge la mano a una figura inginocchiata.<br />
Es. I consunto. — La Fortuna seduta a sin. Es. i. — Il Valore stante<br />
a dr. Es. 2. — Il Valore seduto a dr. Es. i. — La Vittoria gra<strong>di</strong>ente<br />
a sin. Es. 4. — L'Equità seduta a sin. Es. i. — La Salute stante a<br />
sin. Es. 4. — La Provvidenza stante a sin. Es. 2. — L'Abbondanza
IL RIPOSTIGLIO DI SAN MARTINO DEL PIZZOLANO 509<br />
Stante a sin. Es. 2. — L'Allegrezza stante a sin. Es. i. — Roma stante<br />
a sin. Es. i. — Roma seduta a sin. Es. 2. — La Pietà stante a sin.,<br />
tiene due fanciulli sulle braccia e ne ha dallato due altri. Es. i. — La<br />
Pietà stante a sin., depone un grano d'incenso su <strong>di</strong> un'ara. Es. i. —<br />
Gr. br. con rov. consunto. Es. 14.<br />
Faustina jun. — Gr. br. aeternitas L' Eternità (o Cerere ?) stante<br />
<strong>di</strong> prospetto, guarda a sin. e tiene una fiaccola. Es. i. — consecratio<br />
Faustina trasportata da un'aquila. Es. i. — fecvnd .wgvstae Es. i. —<br />
FECVNDITAS Es. 8. — HILARITAS Es. I. — IVNONI LVCINAE Es. I. — IVNOHl<br />
REGINAE Es, 6. — MATRI MAGNAE Es. I. — VENERI GENETRICI Es. I. —<br />
VENVS Venere stante a sin. Es. i. — venvs felix Es. i. — Gr. br. con<br />
rov. consunto. Es. 6.<br />
Lucio Vero. — Gr. br. consecratio Es. i. — tr p ecc. Marte gra<strong>di</strong>ente<br />
a dr. Es. 2. — La Vittoria che colloca su <strong>di</strong> un tronco uno scudo in cui<br />
Vie PAR Es. 4.<br />
Lucilla. — Gr. br. ceres Es. i. — fecvn<strong>di</strong>tas La Fecon<strong>di</strong>tà (o Lu-<br />
cilla?) seduta a sin. Es. i. — ivno Es. i. — ivnoni lvcinae Es. i. — pietas<br />
Es. 7. — VENVS Venere stante a sin., tiene un pomo e uno scettro. Es. 5.<br />
Commodo. — Gr. br. ann avg ecc. Es. i. — fel pvblica ecc. Es. i.<br />
— FOR RED Es. 3. — FORT FELI Es. 4. GEN AVG FELIC eCC. Es. I. —<br />
HILARITAS ecc. (COS v) Es. I. — lOVI CONSERVATORI Es. I. — lOVI EXSVPER<br />
Es. I. — lovi ivvENi ecc. Es. 2. — lovi victori ecc. Es. 3. — -Italia<br />
(all'esergo), p m tr p ecc. Es. i. — libertas avg ecc. Es. 2. — matri<br />
DEVM CONSERV AVG Es. I. — NOBILITAS AVG eCC. Es. I. — PATER SENATVS<br />
Es. I. — p M tr p ecc. L' Equità stante a sin. Es. i. — p m tr p ecc.<br />
Commodo seduto a sin., tiene un globo nella dr. ed è coronato da una<br />
Vittoria volante. Es. i. — p m tr p ecc. Commodo seduto a sin. con<br />
ramoscello e scettro. Es. i. — p m tr p ecc. Commodo in quadriga a<br />
dr. Es. I. — p M TR p ecc. Roma seduta a sin. Es. i. — princ ivvent<br />
Es. I. — princ ivvent (var.). Es. i. — prov deor ecc. Es. i. — secvrit<br />
ORB Es. 2. — vicr brit Es. 2. — vota svscep ecc. Es. 2. — Giove stante<br />
a sin. tiene un globo sormontato da una Vittoria. Es. i. — Apollo<br />
Palatino. Es. i. — Minerva stante a sin., depone un grano d'incenso<br />
su <strong>di</strong> un'ara. Es. 4. — Minerva gra<strong>di</strong>ente a dr. Es. 2. — La Provvidenza<br />
stante a sin. Es. i. — La Vittoria gra<strong>di</strong>ente a dr. Es. i. — Roma stante<br />
a sin. Es. i. — Gr. br. con rov. consunto. Es. 23.<br />
Crispina. — Gr. br. concor<strong>di</strong>a Es. i. — laetitia Es. 2. — pv<strong>di</strong>citia<br />
Es. 2. — SALVS Es. 7. — VENVS FELIX Es. I.<br />
Di<strong>di</strong>o Giuliano. — Gr. br. p m tr p ecc. La Fortuna stante a sin.<br />
Es. 2 consunti.<br />
Settimio Severo. — Gr. br. <strong>di</strong>s avspicib tr p ii cos n pp Es. i. —<br />
<strong>di</strong>vi m pii f p m tr p III cos lì pp Settimio Severo, incoronato da Roma.<br />
Es. 2. — DIVI M PII f ecc. Roma seduta a sin. Es. 4. — p m tr p ecc.<br />
Marte gra<strong>di</strong>ente a dr. Es. 2. — vict avg ecc. Es. i. — La Liberalità.<br />
Es. I. — Gr. br. con rov. consunto. Es. 7.<br />
Giulia Domna. — Gr. br. mat avgg mat sen m patr Es. i. — venvs<br />
FELIX Es. I.
5IO SOLONE AMBROSOLI<br />
Caracalla. — Gr. br. p m tr p ecc. La Libertà. Es. i. — principi<br />
ivvENTVTis Es. I. — Gr. br. con busto giovanile e rov. consunto. Es. i.<br />
Giulia Mesa. — Gr. br. saecvli felicitas Es. i.<br />
Severo Alessandro. — Gr. br. aeqvitas avgvsti Es. i. — fides militvm<br />
Es. I. — lovi PROPVGNATORi Es. 2. — lovi VLTORi Giove scduto a sin.<br />
Es. 3. — IVSTITIA AVGVSTI Es. 2. — LIBERTAS AVGVSTI Es. I. — MARS<br />
VLTOR Es. 8. — PAX AVGVSTI Es. 2. — p M TR p ecc. Marte gra<strong>di</strong>ente<br />
a dr. Es. 7. — p m tr p ecc. Marte stante a sin. Es. 3. — p m tr p ecc.<br />
La Pace gra<strong>di</strong>ente a sin. con un ramoscello. Es. i. — p m tr p ecc.<br />
Romolo gra<strong>di</strong>ente a dr. Es. i. — p m tr p ecc. La Provvidenza stante<br />
a sin. con àncora e spighe. Es. i. — p m tr p ecc. Il Sole stante con<br />
un globo. Es. 2. — p M TR p ecc. Il Sole stante con un flagello. Es. 2.<br />
— p M TR p ecc. Il Sole gra<strong>di</strong>ente a sin. Es. 7. — p m tr p ecc. La<br />
Vittoria gra<strong>di</strong>ente a sin. Es. i. — p m tr p ecc. L'imperatore in quadriga<br />
a dr. Es. i. — p m tr p ecc. L'imperatore sacrificante. Es. i. — pontif<br />
MAX TR p ecc. L' imperatore stante a sin. Es. 3. — providentia avg<br />
Es. 13. — ROMAE AETERNAE Es. 5. — SPES PVBLICA Es. II. — VICTORIA<br />
AVGVSTI Es. 5. — viRTvs AVGVSTI Romolo gra<strong>di</strong>ente a dr. Es. i. —<br />
viRTVS AVGVSTI L'imperatore stante a sin. tiene un globo e un'asta.<br />
Es. I. — Gr. br. con rov. consunto. Es. 2.<br />
Giulia Mammea. — Gr. br. felicitas pvblica La Felicità stante,<br />
appoggiata a una colonna. Es. io. — felicitas pvblica La Felicità seduta<br />
a sin. Es. 6. — veneri felici Es. 5. — venvs felix Es. 2. — venvs<br />
vicTRix Es. 2. — vesta Es. 2.<br />
Massimino. — Gr. br. fides militvm Es. io. — liberalitas avg<br />
Es. I. — marti pacifero Es. i. — pax avgvsti Es. 7. — p m tr p ecc.<br />
L'imperatore stante. Es. 3. — providentia avgEs. 2. — salvs avgvsti<br />
es. 6. — victoria avg es. 4. — victoria germanica es. 5. — votis<br />
decennalibvs Es. i.<br />
Massimo. — Gr. br. pietas avg Es. i. — principi ivventvtis Es. 5.<br />
Balbino. — Gr. br. p m tr p ecc. Es. i. — providentia deorvm Es. i.<br />
Gor<strong>di</strong>ano Pio. — Gr. br. aeqvitas avg Es. 2. — aeternitati avg<br />
Es. 7. — concor<strong>di</strong>a avg Es. 2. — concor<strong>di</strong>a milit Es. i. — felicitas<br />
avg Es, I. — FELiciT tempor Es. i. — fides militvm La Fede militare<br />
stante. Es. 3. — fortvna redvx Es. 2. — lovi statori Es. 8. — laetitia<br />
AVG N Es. 8. — liberalitas avg II Es. 3. — libertas avg Es. 3. —<br />
MARS propvgnat Es. 3. — PAX AETERNA Es. I. — p M TR p ecc. L'impe-<br />
ratore sacrificante. Es. 2. — p m tr p ecc. L'imperatore gra<strong>di</strong>ente. Es. 5.<br />
— p M TR p ecc. L' imperatore seduto. Es. i. — p m tr p ecc. Figura<br />
seduta con ramoscello. Es. 7. — salvs avg Es. 2. — secvritas avg<br />
Es. 3. — secvritas perpetva Es. 2. — secvrit perpet Es. i. — Victoria<br />
aeterna La Vittoria stante. Es. i. — Victoria aeterna La Vittoria<br />
gra<strong>di</strong>ente. Es. i. — Victoria after Es. 3. — Victoria avg La Vittoria<br />
gra<strong>di</strong>ente a dr. Es. 2. — Victoria avg La Vittoria gra<strong>di</strong>ente a sin. Es. i.<br />
Filippo padre. — Gr. br. adventvs avgg Es. 3. — aeqvipas avgg<br />
Es. 3 — annona avgg Es. 2. — laet fvndata Es. i. — felicitas temp<br />
Es. I. — FIDES exercitvs Es. 2. — fides militvm Es. 2. — pax aeterna
IL RIPOSTIGLIO DI SAN MARTINO DEL PIZZOLANO 51I<br />
Es. 1. — p M TR p ecc. La Pace o la Felicità stante. Es. 2, - salvs<br />
AVG Es. I.<br />
OtaciUa. — Gr. br. concor<strong>di</strong>a avgg Es. r. — pietas avgvstae Es. i.<br />
Filippo figlio. — Cr. br. liberautas avgg ih Es. 2. — pax aeterma<br />
Es. I. — SAECVLARES AVGG Es. I.<br />
Traiano Decio. — Gr. br. pannoniae Es. i. — Victoria avg Es. i.<br />
Treboniano Gallo. — Gr. br. apoll salvtari Es. i. — ivnoni martiali<br />
Es. I. — pietas avgg Es. i.<br />
Volusiano. — Gr. br. ivnoni martiali Es. 1. — Gr. br. Dir,: [imp]<br />
CAE e viB voLvsiANo AVG Busto laureato e paludato dell' imp., a dr.<br />
Rov. : AETERNiTAS AVGG s c L'Eternità stante a sin., reggendo nella dr.<br />
un globo sormontato da una fenice, e rialzando con la sin. il lembo<br />
della veste. Es. i.<br />
Quest' ultima moneta è ine<strong>di</strong>ta, anche alla 2.-' ed. del<br />
Cohen; l'identico rovescio s'incontra sui sesterzi <strong>di</strong> Treboniano<br />
Gallo, anzi non è fra' più rari <strong>di</strong> quell'imperatore, ma<br />
sui bronzi <strong>di</strong> Volusiano non si era finora presentato.<br />
Sebbene quin<strong>di</strong> tra il mezzo migliaio <strong>di</strong> sesterzi da me<br />
esaminati del ripostiglio ve ne fossero alcuni che hanno vanto<br />
<strong>di</strong> maggiore o minore rarità (<strong>com</strong>e quelli <strong>di</strong> Di<strong>di</strong>o Giuliano,<br />
<strong>di</strong> Massimo, <strong>di</strong> Balbino, qualcuno <strong>di</strong> Giulia Domna, ecc.),<br />
questo <strong>di</strong> Volusiano col rovescio dell'Eternità è <strong>di</strong> gran lunga<br />
la moneta piii pregevole fra essi sotto il riguardo della<br />
scienza, perchè reca un nuovo per quanto modesto contri-<br />
buto alla Numismatica romana.<br />
Solone Ambrosoli.
BIBLIOGRAFIA<br />
LIBRI NUOVI E PUBBLICAZIONI.<br />
Meili (Julius). Das Brasilianische Geldwesen. i Theil. Die MUnzen<br />
der Colonie Brasilien 1645 bis 1822. Ziirich, 1897.<br />
In una splen<strong>di</strong><strong>di</strong>ssima e<strong>di</strong>zione pubblicata dall'Istituto<br />
poligrafico <strong>di</strong> Zurigo, il Signor Giulio Meili ci dà la prima<br />
parte dell'illustrazione delle monete brasiliane, <strong>com</strong>prendente<br />
le due epoche del Brasile colonia olandese dal 1624 al 1654<br />
e del Brasile colonia portoghese dal 1654 al 1822. L* opera<br />
sarà <strong>com</strong>pletata da un secondo volume col quale si arriverà<br />
fino all'epoca moderna, e allora il Brasile potrà vantare una<br />
stupenda<br />
monetaria.<br />
e perfetta illustrazione della propria produzione<br />
Questo primo volume <strong>com</strong>pilato dall'Autore col sussi<strong>di</strong>o<br />
della sua ricca collezione e <strong>di</strong> molti musei pubblici e privati<br />
dell'America e dell'Europa, è una monografia veramente<br />
<strong>com</strong>pleta ed esauriente in tutte le sue parti, e tale da accon-<br />
tentare non solo l'amatore che raccoglie per <strong>di</strong>letto senza<br />
voler approfon<strong>di</strong>re la materia, ma ben anche lo stu<strong>di</strong>oso il<br />
quale desidera conoscere il lato storico, economico, legisla-<br />
tivo, artistico, ecc. <strong>di</strong> questa serie <strong>di</strong> monete. I vari capitoli<br />
dell'opera sono <strong>di</strong>visi, <strong>com</strong>e segue :<br />
Serie dei Sovrani portoghesi. — Dissertazione sulla<br />
monetazione portoghese al Brasile (1500-1688). — Le monete<br />
ossi<strong>di</strong>onali degli Olandesi a Fernambuco, 1645-46 e 1654. —<br />
La fondazione della Zecca al Brasile, 1688-1694. — Contromarche<br />
portoghesi sugH scu<strong>di</strong> spagnuoli. — Introduzione<br />
della moneta coloniale nel Brasile, 1694. — Le monete <strong>di</strong><br />
Pietro II (1694-1706), — Le monete <strong>di</strong> Giovanni V (1706-50).<br />
— Le monete <strong>di</strong> Giuseppe I (1750-77). — Le monete <strong>di</strong> Donna<br />
Maria I (1777-1805). — Le monete <strong>di</strong> Giovanni VI, <strong>com</strong>e<br />
65
514<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
reggente (1805-18), e <strong>com</strong>e re (1818-22). — Valore delle<br />
monete più rare. — Collezioni straniere citate.<br />
A <strong>com</strong>plemento dell'opera, TAutore vi ha aggiunto 59<br />
magnifiche tavole in eliotipia, oltre a vari <strong>di</strong>segni intercalati<br />
nel testo. Questo primo Volume fa vivamente desiderare il<br />
secondo, e noi, congratulandocene vivamente col Sig. Meili,<br />
facciamo voto che tutti i paesi abbiano presto a possedere<br />
la loro storia monetaria così pregiata e <strong>com</strong>pleta <strong>com</strong>e questa<br />
del Brasile.<br />
E. G.<br />
Catalogo del medagliere genovese nella galleria Brignole Sale De<br />
Ferrari: vetrina C. Genova, stab. tip. fratelli Pagano, 1897, i^A P- 42.<br />
Galeno dott. Ang., Della ricerca delle pepiti d'oro e d'argento nelle<br />
sabbie del fiume Adda: nota preventiva. Lo<strong>di</strong>, tip. lit. Operaia, 1897,<br />
in-8, p. 31.<br />
Luzzatti prof. Giac, Cre<strong>di</strong>to capitalistico e moneta nazionale: note<br />
<strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o. Milano, Ulrico Hoepli e<strong>di</strong>t. (stab. tip. <strong>di</strong>tta F. Manini), 1897,<br />
in-8, p. X-205.<br />
Lorini Eteocle, La riforma monetaria in Russia : monografia fatta<br />
per incarico del ministero del tesoro. Torino, Ermanno Lòscher e<strong>di</strong>t.<br />
{Roma, tip. dell'Unione cooperativa e<strong>di</strong>trice), 1897, ifi"8. P- xv-2i2, con<br />
due prospetti.<br />
Catalogo delle monete rinvenute nel contado dell'Aquila e donate<br />
al museo civico dal dott. Giambattista Mancini nell' anno 1897. Aquila,<br />
tip. Sociale <strong>di</strong> A. Eliseo, 1897, in-8, p. 12.<br />
Ghersi ing. I., Leghe metalliche ed amalgame: alluminio, nichelio,<br />
metalli preziosi e imitazioni, bronzo, ottone, monete e medaglie, salda-<br />
ture. Milano, Ulrico Hoepli e<strong>di</strong>t. (tip. Lombar<strong>di</strong> <strong>di</strong> M. Bellinzaghi), 1898,<br />
in-r6 fig., p. xij-431.<br />
Garujf C. A., La monetazione <strong>di</strong> Federico II <strong>di</strong> Svevia, gli Augu-<br />
stali e la pubblicazione del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Melfi. (Estr. dalla <strong>Rivista</strong> <strong>italiana</strong><br />
per le <strong>scienze</strong> giuri<strong>di</strong>che). Torino, Bocca, 1897, •ri-8, pp. 15.<br />
Numismatique frangaise. Catalogue-guide illustre de l'amateur; 2"<br />
partie: Monnaies féodales et provinciales de France et de l'Orient latin.<br />
Paris, Serrare, 1897, '^^A PP- 179-<br />
Desnoyers, Monnaie au type de Louis XII. Orléans, Herluison, 1896,<br />
in-.8, pp. 15 fig.<br />
Chautard Jules, Jetons des princes de Bourbon de la première<br />
maison de Vendòme, suivis d'une note relative aux méreaux et aux<br />
sceaux de la collegiale de Saint-Georges de Vendòme. I. Vendòme, impr.<br />
Empaytaz, 1897, in-8, pp. 70.
BIBLIOGRAFIA<br />
515<br />
La Tour {Henri de), Catalogue des jetons de la Bibliothèque natio-<br />
naie. Rois et reines de France. Paris, Rollin et Feuardent, 1897, 'f»-®»<br />
pp. XLVI-510 et pi.<br />
Farcinet Charles, Mélanges de numismatique et d'histoire. V: Note<br />
sur un tiers de sou d'or (triens mcrovingien) trouvé en Vendée et<br />
frappé à Basniacum. Paris, Serrare, 1897, in-i6, pp. 13. (Extr. de la<br />
Revue du Bas Poitou).<br />
ProH Maurice, Essai sur l'histoire monétaire de Beauvais, à propos<br />
d'un denier de l'éveque Philippe de Dreux. Paris, 1897, in-8, pp. 22.<br />
(Extr. des Memoires de la Sociélé nationale des anliquaires de France,<br />
t. LVI).<br />
Houdard A., Le malentendu monétaire. Elude critique du monomé-<br />
tallisme-or et du bimétallisme à rapport Constant. Paris, Guillaumin,<br />
in-8, pp. 48.<br />
Gomel C, Histoire financière de l'Assemblée costiluante, voi. II,<br />
(1790-1791). Paris, Guillaumin, in-8, pp. 590.<br />
Chevallier Emile, La Monnaie de Paris en 1897. — Monnaies et<br />
médailles. Paris, Rousseau, in-8, pp. 107 et fig.<br />
Grimm Ed., Miinzen und Meda llen der Stadt Wisniar. Berlin, A.<br />
Weyl, 1897, in-8, pp. 111-73. [Estr., ma con aggiunte, dai Berliner Miìnsbldltei ].<br />
Giinter Heinrich, Das Milnzwesen in der Grafschaft Wurtemberg.<br />
Stuttgart, W. Kohlhammer, 1897, in-8, pp. iv-123.<br />
Joseph Paul u. Fellner Ed., Die Munzen von Frankfurt am Main.<br />
Frankfurt A. M., C. Jiigel, in-8, pp. jx-68i e 75 tav.<br />
Schwabe Ludw., Die kaiserlichen Decennalien und <strong>di</strong>e alexandrinischen<br />
Munzen. Tiibingen, I. I. Heckenhauer, in-4, pp. 51 ili.<br />
Ortler A. u. G., Vademecum fiir Miinzsammler. Leipzig, M. Rubi,<br />
1897, in-8, pp. Ill-ni e 20 tav.<br />
Kubitschek W., Rundschau iiber ein Quinquennium der antiken<br />
Numismatik (1890-94). Wien, Holder, in-8, pp. 108.<br />
Catalogue de médailles et jetons armoiriés appartenant à des<br />
familles nobles et aristocratiques, en vente aux prix marqués chez I.<br />
Schulman, numismate et antiquaire à Amersfoort. Amersfoort, A. 1.<br />
Michielsen, 1897, '^A PP- 22.<br />
Limburg-Stirum {CJe Th. de), Monnaies des <strong>com</strong>tes de Limburg-sur-<br />
la-Lenne. Bruxelles, Goemaere, in-8, pp. 68 et pi.<br />
Tobler-Meyer W., Die Milnz- und Medaillen-Sammlung des Herrn<br />
Hans Wunderly von Muralt in Ziirich. L Abth. Band 3: Die MQnzcn<br />
und Medaillen der Stàdte und Kantone Freiburg, Solothurn, Basel und<br />
Schaflfhausen, des Kts. Appenzell und der geistlichen MOnzherren auf
5l6 BIBLIOGRAFIA<br />
dem Boden der heutigen Schweiz. Zùrich, Komm. Verlag A. Muller,<br />
1897, in-8 gr., pp. xxv-476.<br />
Moskovskiì poublitchnyì i Roumlantsovskiì mouzei. Noumismatitcheskiì<br />
kabinet. IV: Katalog polskikh nionet. [Cabinet numismatique du<br />
musée Roumiautsov à Moscou. Monnaies polonaises]. Moscou, impr.<br />
Kharinsof, 1897, in-8, pp. 32.<br />
Schoenhof J,, A history of Money and Prices being an inquiry<br />
into their relations from the thirteenth century to the present time.<br />
Nevo-York, Putnam, in-8, 2 E<strong>di</strong>tion.<br />
Mar Alex, del., History of monetary systems. 2*^ rev. ed. Chicago,<br />
Kerr and C, in-8, pp. 444.<br />
E. M.<br />
PERIODICI. .<br />
Revue Numismatique, <strong>di</strong>rigée par A. de'Barthélemy, G. Schluni-<br />
berger, E. Babelon (Secrétaire de la Rédaction: J.-A. Blanchet).<br />
Paris, chez Rollin et Feuardent ; 4, rue de Louvois.<br />
Quatrième serie. — Tome premier. — Deuxième trimestre 1897.<br />
Reinach (Théod.), Apollon Derrònaios. — Mowat (/?.), Com-<br />
binaisons secrètes de lettres dans les marques monétaires de l'Em-<br />
pire romain (suite et fin). — Prou (M.), Recherches sur les origines<br />
de la monnaie tournois et de la monnaie parisis. — De La Tour<br />
(//.), Médailles modernes récemment acquises par le Cabinet de<br />
France (suite). — Blanchet (J.-A.), Bail de la Monnaie d'Henri-<br />
chemont, en 1635. — Germain (Z,.), Médaille de René de Maria,<br />
abbé de Saint-Mihiel. — De La Tour (//.), Payements faits à<br />
Jean Warin, graveur de jetons. — Chronique [Discorso del Sig.<br />
Babelon. — Cronologia dei re Indo-Sciti. — Premio <strong>di</strong> <strong>numismatica</strong>,<br />
conferito dall'Accad. delle Iscriz. e Belle Lettere al Sig. Blanchet.<br />
— Concorso Gnecchi per la Nusmismatica classica. — S. A. R. il<br />
Principe <strong>di</strong> Napoli, presidente onorano della Società Numism. Ital.<br />
— Statua dell' « Incisione in medaglie ». — Nuove monete russe]. —<br />
Necrologie [Iloffmann]. — Bulletin bibliographique. — Pério<strong>di</strong>ques.<br />
— Procès-verbaux de la Société Fran9aise de Numismatique, —<br />
3 tav.
Troisième trimestre 1897.<br />
BIBLIOGRAFIA 517<br />
Reinach (Thcod.), Un nouveau roi de Bithynie. — Babelon<br />
(E.), La collection Wad<strong>di</strong>ngton au Cabinet des Médailles : Inven-<br />
taire sommaire. — Rouvicr [D'' J.), Note sur un poids antique de<br />
Béryte. — Van Getmep (A. Rauge), Le ducat vénitien en Égypte.<br />
— Mély {F. de), Le « numisma Laetiense » de 1213. — Chronique.<br />
— Necrologie. — Bulletin bibliographique. — Procés-verbaux des<br />
séances de la Société Fran^aise de Numismatique (Interessante<br />
<strong>com</strong>unicazione del Sig. Blanchet a proposito <strong>di</strong> un vecchio <strong>di</strong>segno<br />
tedesco rappresentante un'officina con gli operai che stanno coniando<br />
monete]. — 3 tav.<br />
Gazette numismatique fran
5l8 BIBLIOGRAFIA<br />
— Il premio Allier de Hauteroche conferito al Sig. Blanchet. — Il<br />
premio Gnecchi per la Numismatica classica].<br />
1897. — 3"^ livraison.<br />
Mazerolle [F.), Jean Baptiste Maire (1787- 1859). Biographie et<br />
catalogne de ses oeuvres (Portrait, quatre planches en phototipie et<br />
vignette dans le texte). — Chevs d'Achon, Les mansois frappés en<br />
Norman<strong>di</strong>e par Henri V, roi d'Angleterre (Figure dans le texte).<br />
— O^ de Castellane, Les grands et petits blancs au K, à la croix<br />
cantonnée de Charles VII, frappés à Beauvais (Bianche en phototipie).<br />
— R. V. <strong>di</strong>i Cheylard, L'atelier delphinal de Fiégon (Dròme)<br />
(Carte dans le texte). — Serrure (R.), Ogier le Danois, pala<strong>di</strong>n de<br />
Charlemagne, sur un jeton du XIV^ siècle (Figure dans le texte).<br />
— Mazerolle (F.), Le journal historique de la Monnaie des Mé-<br />
dailles (1667-1726). — Mazerolle, Conipte rendu de l'ouvrage de<br />
M. RoNDOT, « Les graveurs de monnaies à Lyon du XIII^ au XVIIP<br />
siècle ». — Denise, Compte rendu du « Rapport au Ministre des<br />
finances (2*= année, 1897) » par M. de Foville, Directeur des Mon-<br />
naies et Médailles. — Mazerolle, Compte rendu du « Catalogne des<br />
jetons de la Bibl. Nat. « — Mazerolle, Chronique artistique [Medaglie<br />
fuse e coniate, dei primi mesi dell'anno corrente. Lavori <strong>di</strong> Cha-<br />
plain, Dupuis, Patey, Borrel, Alfeo Dubois, Enr. Dubois, Ippol.<br />
Lefebvre (che riportò il premio <strong>di</strong> Roma), Mouchon, Vernon, e<br />
Courdray (incisore in medaglie, allievo dell' « Ecole de Rome »). —<br />
Medaglie francesi all' Esposiz. Univ. <strong>di</strong> Bruxelles. — I medaglisti<br />
francesi contemporanei]. — Forrcr {L.), Correspondance anglaise<br />
[La morte del Sig. Montagu. — 11 catalogo delle monete greche<br />
del Museo Britannico. — Il libro del Sig. Hazlitt « The Coinage of<br />
the European Continent >». — La « Numismatic Circular » dei<br />
Sigg. Spink. — Altri perio<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> Numismatica. - La Società Numismatica<br />
<strong>di</strong> Londra. — Ripostigli (anche <strong>di</strong> monete romane). —<br />
Ven<strong>di</strong>te. — La famosa moneta detta « medaglia Juxon » (una prova<br />
<strong>di</strong> zecca d'un pezzo da 5 ghinee, offerta al vescovo Juxon da Carlo I,<br />
pochi momenti prima <strong>di</strong> morire; questa moneta unica raggiunse<br />
alla ven<strong>di</strong>ta Montagu il prezzo <strong>di</strong> 700 sterline, cioè piìi <strong>di</strong> 19,000<br />
franchi; fu acquistata dal Museo Britannico). — Il giubileo <strong>di</strong> <strong>di</strong>amante<br />
<strong>di</strong> S. M. la Regina Vittoria e le medaglie <strong>com</strong>memorative<br />
<strong>di</strong> quest'avvenimento. — Necrologie: Cochran-Patrick, l'autore dei<br />
« Records of the Coinage of Scotland » e del « Catalogne of the<br />
Medals of Scotland »»]. —<br />
Les pério<strong>di</strong>ques. — Nouvelles <strong>di</strong>verses<br />
[Il catalogo dei mss. della Bibl. <strong>di</strong> Besanzone, d'interesse anche<br />
numismatico. — L'assemblea generale annua della Soc. Svizzera<br />
<strong>di</strong> Num. — Pubblicazioni <strong>di</strong>verse. — Medaglia <strong>di</strong> Chaplain per la
BIBLIOGRAFIA 519<br />
visita dell'Imperatore e della Imperatrice <strong>di</strong> Russia. — II Museo<br />
della Zecca, <strong>di</strong> Parigi (apertura <strong>di</strong> nuove sale accessibili al pub-<br />
blico, con esposizione <strong>di</strong> medaglie da Luigi XVIII a Napoleone III,<br />
e <strong>di</strong> esemplari <strong>di</strong> medaglie contemporanee donate dagli artisti). —<br />
Falsificazioni <strong>di</strong> monete merovingie. — L'inaugurazione della nuova<br />
sede della Società Numismatica Italiana nel Castello Sforzesco <strong>di</strong><br />
Milano. — Incisori <strong>di</strong> medaglie e monete, officiali <strong>di</strong> Zecca, ecc.,<br />
<strong>com</strong>presi nell'elenco dei membri del <strong>com</strong>itato <strong>di</strong> ammissione per<br />
l'Esposizione Universale del 1900 (*). — Annuncio d' un progetto<br />
<strong>di</strong> legge per sostituire, in Francia, alle monete <strong>di</strong> bronzo da 5 e 10<br />
centesimi, monete <strong>di</strong> nichelio da cent. 20, io e 5].<br />
BuLLETiN DE NuMisM.ATiQUE. Pubblicato da Raimondo Serrure in<br />
Parigi. — Voi. IV, <strong>di</strong>sp. 5, giugno-luglio 1897.<br />
Serrure (R.), Jetons rares ou iné<strong>di</strong>ts. — Richard (Alfred),<br />
Notes sur une trouvaille de pièces de billon des XV^ et XVI«<br />
siècles. — Livres nouveiux. — Revue des Revues. — Lectures<br />
<strong>di</strong>verses [Proposta d' iniziativa parlamentare per la creazione <strong>di</strong><br />
una nuova moneta da '/g soldo ossia da 2 Va centesimi, <strong>com</strong>e quella<br />
che esiste già nel granducato del Lussemburgo (e, aggiungeremo,<br />
<strong>com</strong>e esisteva negli Stati Pontifici)]. — Livres en préparation [Il<br />
catalogo generale che il nostro collaboratore Sig. Dattari sta <strong>com</strong>pi-<br />
lando per le monete coniate ad Alessandria d'Egitto dagli impera-<br />
tori romani]. — Académies et Sociétés. — Les Musées [I furti <strong>di</strong><br />
Nìmes e <strong>di</strong> Losanna]. — Les nouvelles émissions. — Les ventes.<br />
Disp. 6, agosto-settembre 1897.<br />
Serrure (/?.), De l'authenticité des statères d'or de Panticapée.<br />
— Damare [D''), La nouvelle loi monétaire du Japon. — Serrure,<br />
Monnaies mérovingiennes fausses. — Livres nouveaux. — Revue<br />
des Revues. — Lectures <strong>di</strong>verses. — Académies et Sociétés. — Les<br />
Musées [L'acquisto della celebre collez. Wad<strong>di</strong>ngton. — Il lascito<br />
della biblioteca <strong>di</strong> Enr. Hoffmann alla bibliot. civica <strong>di</strong> Compiègne<br />
« en souvenir de l'accueil sympathique qu' il avait, au début de sa<br />
u carrière <strong>com</strong>merciale, regu des amateurs de cette ville »]. —<br />
Bonnet {Étnile), Les trouvailles. — i tav.<br />
Disp. 7, ottobre-novembre 1897.<br />
Engel {Arthur) et Serrure (/?.), Résumé de l'histoire monétaire<br />
moderne des Pays-Bas septentrionaux [È un capitolo della nuova<br />
(*) V. Notizie varie.
520<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
pubblicazione dei Sigg. Engel e Serrure : Traitc de Ntimismatique<br />
moderne, destinato a far séguito al loro Traile de Numismatique<br />
da moyen dge, <strong>di</strong> cui il primo voi. è <strong>com</strong>parso nel 1891, il secondo<br />
nel 1894, ed il terzo è pressoché ultimato], — Revue des Revues.<br />
— Lectures <strong>di</strong>verses [Un ripostiglio <strong>di</strong> monete me<strong>di</strong>oevali ad Atene].<br />
— Académies et Sociétés [La solenne inaugurazione della nuova<br />
sede della Soc. Num. Ital. nel Castello <strong>di</strong> Milano. — La manifestazione<br />
<strong>di</strong> simpatia al Sig. Cumont in Bruxelles]. — Le mouvement<br />
économique. — Les nouvelles émissions. — Les ventes,<br />
Revue Suisse de Numism.\tique, publiée par le Comité de la So-<br />
ciété Suisse de Numismatique, sous la <strong>di</strong>rection de Paul-Ch.<br />
Stroehlin. — Tome VII, première livraison. — Genève, 1897.<br />
Inthoof-Blumer {F.), Zur Miinzkunde Kleinasiens (Schluss). —<br />
Gnecchi (F.), Monetazione romana (prima parte) [Articolo <strong>di</strong> vol-<br />
garizzazione]. — Vallentin du Cheylard (R.), Du florin du poids<br />
de Piémont. — Haas {F.), Beitrage zu einer luzernischen Miinzge-<br />
schichte (erster Theil). — Raugé van Gennep (A.), Bibliographie<br />
numismatique des princes de la maison de Savoie. — Liebenau<br />
{Th. von), Ein Gutachten iiber <strong>di</strong>e Reform des Miinzwesens von<br />
1758. — Strcehlin (P.-Ch.), Médailles suisses nouvelles [anche italo-<br />
svizzere]. — Strahlin, Médailles étrangères nouvelles [anche ita-<br />
liane]. — Mélanges [Copiosissima cronaca internazionale]. — Trou-<br />
vailles. — Société Suisse de Numismatique: Extraits des procèsverbaux<br />
du Comité et de l'Assemblée generale. — Necrologie. —<br />
19 tav. [La XIX: Un atelier monétaire suisse à la fin du XV^ siéclej.<br />
Revue Belge de Numismatique, publiée sous les auspices de la<br />
Société Royale de Numismatique. Directeurs : MM. le V'^ B.<br />
de Jonghe, le C'^ Th. de Limburg-Stirum et A. de Witte. —<br />
Bruxelles,<br />
1897, troisième livraison.<br />
V^^ B. de Jonghe, Un denier frappé à Mayence par l'empereur<br />
Lothaire I, avant le traile de Verdun. — De PVitte {A.), Les jetons<br />
et les médailles d' inauguration frappés par ordre du gouvernement<br />
general aux Pays-Bas autrichiens (1717-1792) (Suite). — Lemaire (F.),<br />
Une conclusion. — Mubarek GItalib Bey, Quelques mots sur deux<br />
monnaies ilkhaniennes. — Tra<strong>di</strong>sci (C.-F.), Deux testons iné<strong>di</strong>ts<br />
de Sébastien de Monfaucon, évèque de Lausanne et prince du<br />
Saint-Empire. — Ter Gow [J.-E.), Des fausses monnaies (Suite).<br />
— Van Hende (E.), Pierre Lorthior, graveur des médailles du<br />
Roi. — Rouyier (/.), Le nom de Jesus employé <strong>com</strong>me type sur
BIBLIOGRAFIA 521<br />
les monuments numismatiques du XV^ siede (Suite et fin). — Ne-<br />
crologie [Phillips. Hoffmann.] — Mélanges [Ambrosoli, Vocabolarietto<br />
pei numismatici, cenno del Signor A. De Witte. — Concorso<br />
Gnecchi per il miglior lavoro <strong>di</strong> Numismatica classica che sarà<br />
stato pubblicato nella <strong>Rivista</strong> Ital. <strong>di</strong> Num. nel triennio 1897, 1898,<br />
1899]. — Société Royale de Numismatique : Extrait des procès-<br />
-verbaux. — 3 tav.<br />
1897, quatrième livraison.<br />
V'^ B. de Jonghe, Un cinquième d'écu de Philippe II frappé<br />
à Arras en 1582. - Daniels (P.), Le « civitat » de Jeanne de<br />
Merwede. — Trachsel (C.-F.), Les ducats d'or d'Aymon de Mont-<br />
faucon (1490-1517). — De Witte {A.), Les jetons et les médailles<br />
d'inauguration frappés par ordre du gouvernement general aux<br />
Pays-Bas autrichiens (1717-1792) [continuaz.]. — Rouyer {].),<br />
Médaille gravée de Marie de la Chàtre, dame de Chàteauneuf-sur-<br />
Cher, femme de Guillaume de l'Aubespine, maitre des requètes de<br />
l'hotel du Roi (1586). — Bamps (C), Note sur les sceaux des<br />
corporations de métiers de la ville de Hasselt, au XVI«= siècle. —<br />
Mélanges. — Société Royale de Numismatique : Extraits des procès-<br />
-verbaux. — 3 tav.<br />
La Gazette numismatique (Directeur-Rédacteur : Charles Dupriez).<br />
— Bruxelles, place de Brouckère, 26.<br />
N. 4, I
522<br />
N. 6, ler Mars 1897.<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
Beger {Paul), Les types des Monnaies brabangonnes au moyen<br />
àge, — O^ Le Bailly d'Inghiiem, Un Kerveguen. — De Witte<br />
(Alphonse), Le dernier jeton des gouverneurs du Namurois. —<br />
Dupriez {Charles), Le médailleur Roty. — Bibliographie [Capo-<br />
bianchi: Appunti per servire all'or<strong>di</strong>nam. delle mon. coniate dal<br />
Senato Rem. dal 1184 al 14J9]. — Nouvelles <strong>di</strong>verses [Scritti <strong>di</strong><br />
Kunz, ripubblicati nella <strong>Rivista</strong> It. <strong>di</strong> Num.]. — Trouvailles. —<br />
Vente Stiénon du Pré; février 1897. — Catalogue [Medaglie moderne,<br />
in ven<strong>di</strong>ta].<br />
N. 7,<br />
I^-" Avril 1897.<br />
Dupriez (Ch.), Grand bronze d'Antonin le Pieux frappé à<br />
Alexandrie d'Égypte. — Beger (P.), Les ateliers monétaires bra-<br />
bangons. — A^. //.^ Peter Flòtner. — Moraleda y Esteban {Juan),<br />
Contributions à la numismatique du quatrième centenaire de la<br />
découverte du Nouveau-monde. — Bibliographie. — Nouvelles<br />
<strong>di</strong>verses [Società Nuni. Italiana: Concorsi Papadopoli e GnecchiJ.<br />
— Trouvailles. — Ventes. — Necrologie. — Catalogue [Medaglie<br />
moderne, in ven<strong>di</strong>ta].<br />
N. 8, ^r Mai 1897.<br />
Lebrun, Numismatique antique : Samé<br />
de Céphalonie. — Corre-<br />
spondance: Lettre de M. le Marquis d^Anselme de Puisaye à M.<br />
Ch. Dupriez. — Dupriez {Ch.), La médaille de Fernand Cortes. —<br />
A'^. H., Médailleurs allemands du XVI^ siècle: Hans Krug, Louis<br />
Krug, Hans Schwartz. — Dupriez {Ch.), Jeton bruxellois au type<br />
de la grue. — Bibliographie. — Nouvelles <strong>di</strong>verses. — Trouvailles.<br />
— Ventes. — Catalogue de Médailles modernes, en vente aux prix<br />
marqués.<br />
2^ Année, N. i, I^r Octobre 1897.<br />
D. (C), Au lecteur [La Gazette si pubblicherà, d'ora in avanti,<br />
non più 8 volte ma bensì io all'anno, in fascicoli mensili, da ottobre<br />
a luglio <strong>com</strong>preso. Il prezzo rimane fissato in fr. 2,50 all'anno, per<br />
tutta l'Unione Postale]. — Z).*" Lebrun, Numismatique antique:<br />
Abdère. — Dupriez, Un nouveau sou d'or mérovingien. — Dupriez,<br />
Jeton iné<strong>di</strong>t d'un seigneur de Herstal. — Van den Broeck {Ed.),<br />
Un jeton satirique. — Bibliographie. — Nouvelles <strong>di</strong>verses [La<br />
Soc. Reale <strong>di</strong> Numism. del Belgio e la sua assemblea generale<br />
annua. Il Big. De Witte, nominato per acclamazione Segretario<br />
della Società, conservando provvisoriamente anche l'ufficio <strong>di</strong> Bi-
BIBLIOGRAFIA 523<br />
bliotecario. Medaglia-<strong>di</strong>ploma in oro offerta al Tesoriere Van den<br />
Broeck, che per la trentesimaterza ed ultima volta presentava alla<br />
Società il suo resoconto annuo sulle finanze sociali, — Medaglioni<br />
<strong>di</strong> Pasteur e <strong>di</strong> Edmondo de Goncourt. — Il « Club » Numismatico<br />
<strong>di</strong> Newport (Stati Uniti d'America)]. — Trouvailles. — Ventes. —<br />
Catal. de livres de numismatique, en vente aux prix marqués.<br />
N. 2, I*^"" Novembre 1897.<br />
De Witle {A), Notes sur les monnaies des États-Belgiques-<br />
Unis. — Diipriez (Ch.). Notre planche I: Médailles et décorations.<br />
— Bibliographie. — Nouvelles <strong>di</strong>verses. — Trouvailles. — Ventes.<br />
— Necrologie. — Catalogue de livres de numismatique, en vente<br />
aux prix marqués. — i tav.<br />
N. 3,<br />
I^*" Décembre 1897.<br />
F'^ B. de Jongìie, Un Demi-rixdaler de Christophe de Manderscheid,<br />
prince-abbé de Stavelot et de Malmédy (1546-1576). —<br />
C* Le Bailly d'Inghuem, Monnaies et Médailles à l'Exposition de<br />
Bruxelles 1897 [Curiose notizie intorno alle monete in<strong>di</strong>gene del<br />
Congo]. — Correspondance. — Bibliographie. — Novelles <strong>di</strong>verses.<br />
— Ventes. — Catal. de livres de numismatique, en vente aux prix<br />
marqués. — i tav.<br />
TlJDSCHRIFT VAN HET NeDERLANDSCH GeNOOTSCHAP VOOR MuNT- EN<br />
Penningkunde. — Amsterdam.<br />
5 anno (1897), fase. III.<br />
De Witte {A.), Le jeton dans les <strong>com</strong>ptes des maìtres des<br />
Monnaies du duché de Brabant aux XVII^ et XVIII^ siècles [Con-<br />
tinuazione]. — Snoeck {M. A), Bijdragen tot de Penningkunde van<br />
Noord-Brabant, - Mej. M. de Man, lets over en gildepenning van<br />
de scheepstimmerlieden te Zierikzee. — Zivierzina ( IV. K. F.),<br />
Beschrijving der Médailles sederi 23 November 1890 tot i Januari<br />
1897 geslagen aan de Kon. Fabriek van Zilverwerken, firma C. J.<br />
Begeer te Utrecht [Continuaz]. — Nijland M. C), Twee Sneeker<br />
magistraatspenningen. — Mededeeling aan de Leden omtrent 't<br />
verhandelde in de laarlijksche Vergadering van 16 Juni te Utrecht.<br />
— Inhoudsopgave der Tijdschriften <strong>di</strong>e het Genootschap in ruiling<br />
ontvangt. — Gemengde berichten (Troisch- of goudgewicht. —<br />
Varieteiten van Nederlandsche munten. — Een muntvervalscher<br />
gestraft. — Boekaankon<strong>di</strong>ging [Ambrosoli, « Vocabolarietto pei<br />
numismatici »]. — Prijsvraag voor en gedenkplaat ter gedachtenis<br />
aan H. M. Inhul<strong>di</strong>ging binnen Amsterdam in 1898. — i tav.
524<br />
Fase. IV, 1897.<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
De Witte, Le jeton etc. [Continuaz.] — Snoeck {M. A.), Bìjdragen<br />
tot de Penningkunde van Noord-Brabant [Contin.]. — V'^<br />
B. de Jonghe, Les monnaies frappées à Bois-le-Duc, par les archiducs<br />
Albert et Isabelle. — Zwierzina, Beschrijving der Medailles<br />
etc. [Contin.]. — Brumvis [C. IV.}, De Alkmaarsche Loterijpenning<br />
(1703). — Inhoudsopgave der Tijdschriften. — Gemengde berichten<br />
(Gildebrief van Tiel 1475. — AanvuUing Dirks « Ned, Pennirigen »).<br />
— Vergaderingen van het Genootschap (Notulen). — Jaarverslag<br />
1896 van den Secretaris. — J. van den Penningmeester. — J. van<br />
den Conservator. — J. v. de Commissie voor Redactie van 't Tijd<br />
schrift. — Ledenlijst, — Inhoudsopgave. — i tav.<br />
The Numismatic Chronicle and Journal of the Numismatic Society.<br />
— London.<br />
1897. — Part IL<br />
Wroth [W.], Greek Coins acquired by the British Museum in<br />
1896. — Boyd {C. IV.), A Find of Roman Denarii near Cambridge.<br />
— Whymper (E.), A Discovery of Roman Coins on the Summit<br />
of the Théodule Pass (Matterjoch). — Lord Grantley, On the<br />
North-Humbrian Coinage of A. D. 758-808. — Grueber {H. A), A<br />
Find of Coins at East Worlington. — Grueber, A Find of Coins<br />
at Cre<strong>di</strong>ton, N. Devon. — 5 tav.<br />
1897. — Part III.<br />
Seltman [E. J.), The Type known as « The Demos " on Coins<br />
of Rhegium. — Six {J. P.), Monnaies grecques, iné<strong>di</strong>tes et incer-<br />
taines. — Lawrence {L. A.), On some Coins of William I and IL<br />
— Lawrence, On a Hoard of Short- cross Pennies. — Notices of<br />
Recent Numismatic Publications. — Miscellanea. — 3 tav.<br />
MONATSBLATT DER NUMISMATISCHEN GeSELLSCHAFT IN WlEN.<br />
N. 168. Juli 1897.<br />
Kenner [Fr.), Zur Geschichte der Medaille [Continuazione] —<br />
MUnzenfunde. — Vermehrung der Milnzensammlung. — Bespre-<br />
chungen. — Numismatische Literatur. — Verschiedenes [Esposizione<br />
<strong>di</strong> medaglie e placchette <strong>di</strong> artisti austriaci, tenuta a Nuova York,<br />
nei locali del Grolier-Club, per iniziativa del Prof Oettinger e dei<br />
Sigg. Parish e D"" Storer].<br />
N. 169. August 1897.<br />
Kenner, Zur Geschichte der Medaille [Continuaz. e fine <strong>di</strong>
BIBLIOGRAFIA 535<br />
questa importante lettura, tenuta dal eh. Dott. Kenner nell'assemblea<br />
annuale della Società, il 27 genn. 1897]. — Mackl (M.), Hul<strong>di</strong>gungs-<br />
Medaillen dar Stende des Erzherzogthums Oesterreich ob der<br />
Enns. — Renner, Zur Frage der unterrichtlichen Verwendung der<br />
Miìnzkunde an den òsterreichischen Mittelschulen [Promemoria al<br />
Ministro della P. I. per introdurre la Numismatica nelle scuole<br />
austriache <strong>com</strong>e sussi<strong>di</strong>o della Storia, della Filologia ed eventual-<br />
mente anche <strong>di</strong> altre <strong>di</strong>scipline] — Munzenfunde. — Besprechungen,<br />
— Numism. Literatur. — Verschiedenes [Necro'. dell'eminente sto-<br />
rico austriaco Cons. Cav. Alfredo von Arneth, figlio del celebre<br />
numismatico Giuseppe Arneth. — Necrol. <strong>di</strong> Henry Phillips jr. e<br />
<strong>di</strong> Hoffmann. — Fondazione <strong>di</strong> una nuova zecca, a Perth nell'Australia<br />
Occidentale, in séguito alla scoperta <strong>di</strong> ricche miniere d'oro. Le<br />
zecche inglesi attualmente in attualità <strong>di</strong>ventano per ciò 6, cioè<br />
Londra, Bombay, Calcutta, Sidney, Melbourne, e Perth. — Meda-<br />
glia d'oro offerta al munifico mecenate americano, Sig. S. P. Avery,<br />
da vari anni presidente del Grolier-Club <strong>di</strong> N. York (società che<br />
ha per iscopo <strong>di</strong> promuovere le arti e le <strong>scienze</strong>), benemerito del<br />
Museo Metropolitano e della gran Biblioteca riunita Astor-Lenox-<br />
Tilden e d'altre istituzioni deW Imperiai City].<br />
N. 170. September 1897.<br />
Voetter {Otto), VI e IV auf romischen Miinzen des 3. Jahrhunderts.<br />
— Ernst, Der Todestag des Medailleurs Theodor van<br />
Berkel. Munzenfunde. — Besprechungen. — Num. Literatur. —<br />
Verschiedenes [Medaglie <strong>di</strong> S. Uberto, pei cacciatori].<br />
N. 171. October 1897.<br />
Markl {Moriz), Bóhmische Munzpragungen und deren Beizeichen<br />
unter der Regierung Fer<strong>di</strong>nand I. —Besprechungen. — Num.<br />
Literatur. — Verschiedenes [Nomina del Dott. Kenner a Membro ono-<br />
rario della Soc. Num. Bavarese. — Cenno necrol. del Sig. Davide<br />
Egger, il noto negoziante <strong>di</strong> monete a Budapest. — L'esposizione<br />
<strong>di</strong> medaglie fuse e placchette, tenuta a Vienna nel Museo austr.<br />
d'Arte e d'Industria. Il Sig. Renner conclude ironicamente osservando<br />
che la stampa quoti<strong>di</strong>ana, « beninteso », lasciò passare quasi<br />
inosservata questa bellissima esposizione. — Tre nuove medaglie<br />
officiali inglesi : la Royal Victor tan medal per coloro che si resero<br />
benemeriti verso la regina; la medaglia del DrummondCastle, co-<br />
niata per esprimere la gratitu<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> S. M. verso i pescatori ed<br />
altri abitanti dell'isola <strong>di</strong> Ushant che soccorsero il piroscafo nau-<br />
fragato D.-Castle; una medaglia militare <strong>di</strong> nuovo tipo per l'In<strong>di</strong>a.
526<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
Quest' ultima med. vien coniata a Calcutta, con conii preparati a<br />
Londra. — Medaglia-placchetta in onore del <strong>di</strong>stinto <strong>com</strong>positore<br />
Antonio Bruckner].<br />
N. 172. November 1897.<br />
Voetter (O.), Aus Siscia [Interessante <strong>com</strong>unicazione su certe<br />
cifre o lettere, <strong>di</strong> tipo orientale, che s'incontrano su monete del<br />
Basso Impero]. — Milnzenfunde. — Ordentliche Versammlung der<br />
numismatischen Gesellschaft am 27. October 1897. — Vermehrung<br />
der Miinzensammlung. — Besprechungen. — Num. Literatur. —<br />
Verschiedenes [Il dono al Sig. Giorgio Cumont. — L'inaugurazione<br />
della nuova sede della Società Numismatica Italiana nel Castello<br />
Sforzesco <strong>di</strong> JVIilano. — Elenco dei corsi <strong>di</strong> Numismatica che si terranno<br />
nell'inverno 1897-98 presso le Università tedesche (*). — La<br />
Coli. Wad<strong>di</strong>ngton acquistata per il Gabinetto Numism. <strong>di</strong> Parigi.<br />
A questo proposito, il Sig. Renner ricorda altri gran<strong>di</strong>osi acquisti<br />
fatti dal Governo francese, per più centinaia <strong>di</strong> migliaia <strong>di</strong> franchi,<br />
<strong>com</strong>e la CoUez. Saulcy (per 200,000 fr.), quella d'Amécourt (per<br />
180,000 fr.), ecc.].<br />
N. 173. December 1897.<br />
Scholz (J.), Ueber Contorniaten [Lettura tenuta nell'adunanza<br />
del 26 maggio 1897]. — Thalmayr {F.), Uebersicht der an den<br />
òsterreichischen Mittelschulen bestehenden Miinzensammlungen<br />
[Rassegna delle coUez. numismatiche esistenti presso le scuole<br />
secondarie austriache]. — Miinzenfunde [Perini {Q.), Ripostiglio <strong>di</strong><br />
monete me<strong>di</strong>oevali scoperto a Vigo-Cave<strong>di</strong>ne nel Trentino. Consi-<br />
steva in circa 350 monete d'argento, delle zecche <strong>di</strong> Trento, Verona,<br />
Venezia, Mantova, Brescia, Cremona, Bergamo, Como, Lo<strong>di</strong>, Tortona,<br />
Acqui, Asti, con grande predominio numerico delle monete veronesi<br />
e trentine]. — Ordentliche Versammlung der numism. Gesellschaft<br />
am 24. Nov. 1897. — Vermehrung der Miinzensammlung. — Besprechungen.<br />
— Num. Literatur. — « Prof. Dr. Alfred von Sallet<br />
[Necrologia]. — Theodor Mommsen's achtzigster Geburtstag. —<br />
Verschiedenes [« Berthold Willner », cenno necrol.].<br />
S. A.<br />
Bollettino <strong>di</strong> archeologia e storia dalmata, XX, 1" gennaio 1897 :<br />
Btilic' F., Tessera lusoria <strong>di</strong> Lissa.<br />
Bollettino della Commissione Archeologica <strong>com</strong>unale <strong>di</strong> Roma,<br />
(') V. Notizie varie.
BIBLIOGRAFIA 527<br />
anno XXV, fase.<br />
repubblicana.<br />
I: Serafini, L'arte nei ritratti della moneta romana<br />
Giornale <strong>di</strong> eru<strong>di</strong>zione, n. 21-22 e 23-24, voi. VI, Firenze 1897:<br />
Medaglia Arretinus, (Perchè l'Aretino fece coniare una medaglia in cui<br />
il suo nome venne scritto Arretinus?).<br />
<strong>Rivista</strong> Abruzzese, XI, 12, <strong>di</strong>cembre 1896: De Petra G., Tortoreto.<br />
Ripostiglio <strong>di</strong> monete fuse e battute.<br />
Giornale storico della letteratura <strong>italiana</strong>, XXX, i-a: Toynbee<br />
P., The coins denominatad Santelene by Dante (Conv. IV, II).<br />
Atti dell'Accademia <strong>di</strong> U<strong>di</strong>ne, serie III, voi. MI: Joppi Vincenzo,<br />
Medaglie friulane.<br />
Rassegna nazionale, i° giugno 1897: Rossi Aless., Le fasi attuali<br />
^^<br />
dell'argento.<br />
Archivio Trentino, anno XIII, fase. II, '- 1897<br />
Monumento a Dante<br />
in Trento [Con tav. delle medaglie <strong>com</strong>memorative]. — Un ripostiglio<br />
<strong>di</strong> monete del secolo XIII a Vigo <strong>di</strong> Cave<strong>di</strong>ne.<br />
Réforme économique, 18 luglio 1897: Circulation monétaire des<br />
principaux pays du monde. Les monnaies <strong>di</strong>visionnaires de l'union latine.<br />
M Jaurés et le bimétailisme. La question du bimétallisme en Angleterre.<br />
Revue du Bas-Poitou, 2 livr. 1897 • Farcinet C, Notes sur un tiers<br />
de sou d'or (triens mérovingien) trouvé en Vendée.<br />
Spectateur militaire, 1° mai, i et 15 juin 1897 • Boissonnet C, Les<br />
décorations, croix et médailles.<br />
Bulletin de la Société de l'histoire de Paris, livr. I, 1897 : Prou M.,<br />
Les monnaies de Bouchard, <strong>com</strong>te de Paris.<br />
Bulletin historique et scientifique de l'Auvergne, 1896, n. 9-10:<br />
Doitrif dJ, Notes numismatiques [pièce d'or frappée au nom de Théo-<br />
debert I" ou II, roi d'Austrasie].<br />
Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de<br />
l'Yonne, voi. LVI, 1896: Ed. de Luze, La collection Gariel: les monnaies<br />
des ducs de Bourgogne.<br />
Mélanges d'archeologie et d'histoire, fase. 2-3, 1897 : Fabre P., La<br />
pereeption du cens apostolique en France en 1291-1293 [con riferimenti<br />
curiosi sul valore delle monete].<br />
Sociologie catholique, mai 1897: Hérail G., L'adoption de l'étalon<br />
d'or au Japon.<br />
Science sociale, mai 1897: Babelon, De l'utilité scientifique des<br />
collections de monnaies anciennes.<br />
Mémoires de la Société des antiquaires du Centre, (Bourges), t. XXI:<br />
Kersers M. de, Bulletin numismatique, n. 19.<br />
Mémoires de la Société Académique d'agriculture, des sciences, arts<br />
et belles lettres du département de l'Aube (Troyes, 1896), voi. XXXIII,<br />
sèrie III: Lorin Le Cleri, Musée de Troyes. Numismatique. Monnaies<br />
gauloises. Catalogne descriptif et raisonné.
:28 BIBLIOGRAFIA<br />
CoSMOs, 26 giugno 1897 : Babelon E., De l'utilité scientifique des<br />
collcctions de monnaies anciennes.<br />
Frange illustrée, 12 giugno 1897 :<br />
Henri Harpignies.<br />
Giron A., Medaille d'honneur de<br />
Le Correspondant, io luglio 1897: Langlois A., La Monnaie de<br />
Paris en 1897.<br />
Revue generale internationale, scientifique, littéraire et artistique,<br />
mai 1897 : Raffalovich A., La question monétaire en Russie.<br />
BuLLETiN de correspondance hellénique, 1896 nov. : Reinach Th.,<br />
Observation sur le système monétaire delphique du IV" siècle.<br />
Revue deb 2 Monqes, 15 settembre 1897 : Lévy R. G., La hausse du<br />
blè et la baisse du metal argent.<br />
Journal deb economibtes, settembre 1897 : Apostol P., Un bimétal-<br />
liste russe.<br />
La Libertè, 21 settembre 1897: P. C. de Villedeuil, La Monnaie de<br />
Paris.<br />
Le Soleil, II settembre 1897: ThiébauU-Sisson, La Collection Wad-<br />
<strong>di</strong>ngton au Cabinet des médailles.<br />
Zeitschrift filr vaterlàn<strong>di</strong>sche Geschichte und Alterthumskunde, <strong>di</strong><br />
Westfalia, voi. LIV, 1896: Offenberg, Der Miinzmeister Peter Koeplin<br />
in Mùnster.<br />
Deutsche Rundschau, marzo 1897: Hiìbner Baron, Jacobo Zobel de<br />
Zangrónitz. [biografia del numismatico vissuto a Madrid ed a Manilla,<br />
1854-1896].<br />
Mittheilungen des Vereins fiir Geschichte und Alterthumskunde zu<br />
Kahla und Roda, Bd. V, Heft 2,<br />
von Orlamiinde.<br />
1896: Lommer, Die Munzen der Grafen<br />
Jahrbuchlr fiir Nationalókonomie und Statistik, III Folge, Bd. 13,<br />
Heft 5 : Fick Ludwig, Ueber <strong>di</strong>e Mòglichkeit eines Wertmasses.<br />
Zeitschrift fiir Social u. Wirthschaftsgeschichte, voi. V, fase. Ili,<br />
Weimar, 1897: Schaube A., Ein italienischer Coursbericht von der Messe<br />
von Troyes aus dem 13 Jahrhundert.<br />
Sitzungsberichte dell'Accademia delle <strong>scienze</strong> <strong>di</strong> Monaco, 1897,<br />
fase. II: Riggauer H., Ein unbekannter Numismatiker des 16. Jahrhun-<br />
derts. [Gio. Battista Fickler alla corte Bavarese],<br />
Anzeiger fur schweizerische Alterthumskunde, n. 2, 1897<br />
Werdmuller //., Die Schnabelthaler.<br />
Fribourg artibtique, fase. I, janvier 1897 : Max<br />
dailles de la bataille de Dreux et d'Anne d'Autriche.<br />
: Zeller-<br />
de Diesbacli, Mé-<br />
Die Schweiz, 1897, fase. 677<br />
schweizer. Schiltzen-vereins. Mit 19 Orig.-Abbldgn. — Die schweize-<br />
rischen Goldmiìnzen (mit io Stempelgravilren).<br />
: Pfenniger N., Die Ehrenmedaille des
The economic Journal, voi. VII, n. 25-26, 1897 '•<br />
BIBLIOGRAFIA 529<br />
Hughes,<br />
Crump and<br />
Johnson. The debasement of the coinage under Edward III.<br />
The English Historical Review, ottobre 1897 : The coinage of the<br />
Three Edwards.<br />
The Nation, 29 luglio 1897: The proposed monetary <strong>com</strong>mission.<br />
Annales du cercle archéologique d'Enghien, IV, livr. 4: Cumont<br />
G., La trouvaille numismatique de Saint-Pierre-Chapelle. — Decl'eve 1.,<br />
Biographie de Renier Chalon.<br />
Annales de la Société d'archeologie de Bruxelles, t. XI, livr. a:<br />
Ctimont G., Théodore van Berckel, graveur general de la monnaie de<br />
Bruxelles (XVIII siede).<br />
Annales de l'Institut archéologique du Luxembourg, 1897, t. XXXI,<br />
livr. I : Sibenaler J.-B., La numismatique luxembourgeoise et les origines<br />
d'Arlon.<br />
E. M.<br />
67
VARIETÀ<br />
Inaugurazione della nuova Sede<br />
DELLA SOCIETÀ NUMISMATICA ITALIANA<br />
NEL Castello <strong>di</strong> Milano.<br />
L'inaugurazione della nuova sede sociale, che doveva<br />
già riuscire solenne per l'intervento <strong>di</strong> S. A. R. il Principe<br />
<strong>di</strong> Napoli, nostro Presidente Onorario, lo fu doppiamente<br />
pel fatto che i Principi facevano il 19 ottobre scorso il primo<br />
loro ingresso ufficiale in Milano e vi erano ac<strong>com</strong>pagnati<br />
anche dai Sovrani. Una visita agli iniziati restauri del Ca-<br />
stello e l'inaugurazione dei locali a<strong>di</strong>biti alla Società Storica<br />
Lombarda e alla Società Numismatica Italiana furono gli<br />
argomenti che motivarono l'invito del Sindaco <strong>di</strong> Milano ai<br />
Principi. Perciò la narrazione della cerimonia che riguarda<br />
la nostra Società, sarà necessariamente collegata anche con<br />
qualche particolare non essenzialmente numismatico e noi<br />
chie<strong>di</strong>amo venia se la cronaca non sarà questa volta conte-<br />
nuta in quegli strettissimi limiti che per regola generale ci<br />
prefiggiamo nella nostra <strong>Rivista</strong>.<br />
La giornata era splen<strong>di</strong>da, quale si ad<strong>di</strong>ceva alla circo-<br />
stanza, tutta la città animata e imban<strong>di</strong>erata, e i cortili del Ca-<br />
stello, addobbati a festa, rigurgitavano <strong>di</strong> gente. Alle ore 15 V2,<br />
<strong>com</strong>e annunciato, arrivavano quasi contemporaneamente i<br />
Principi dal palazzo reale, e i Sovrani dalla villa <strong>di</strong> Monza, e<br />
scendevano alla porta del Castello. Accolti al suono della<br />
marcia reale e dell' inno montenegrino, ac<strong>com</strong>pagnati dalle<br />
autorità citta<strong>di</strong>ne e dalle presidenze delle due Società, e<br />
acclamati calorosamente dalla folla plaudente , entrarono<br />
ad<strong>di</strong>rittura nella sala riservata alla nostra Società e da questa
532<br />
VARIETÀ<br />
passarono nel salone <strong>com</strong>une delle adunanze, dove si doveva<br />
<strong>com</strong>piere la cerimonia inaugurale.<br />
Al banco presidenziale sedette il Sindaco e accanto a lui,<br />
da un lato il nob. Felice Calvi e Don Cesare Vignati rappresentanti<br />
la Società Storico-Lombarda, dall'altro i fratelli Gnecchi<br />
e il Dott. Ambrosoli rappresentanti la Società Numismatica.<br />
I Reali e i Principi sedevano <strong>di</strong> fronte, e <strong>di</strong>etro a loro un<br />
centinaio <strong>di</strong> signore e quelli fra gli invitati che poterono<br />
penetrare nella sala; mentre una folla enorme si accalcava<br />
nel cortile della Rocchetta.<br />
I <strong>di</strong>scorsi ebbero il merito d'essere brevi. Primo a parlare<br />
fu il Sindaco, che <strong>di</strong>ede il benvenuto agli augusti ospiti colle<br />
seguenti parole:<br />
Nel nome <strong>di</strong> Milano, che ho l'onore dì rappresentare, ringrazio<br />
S. M. il Re e l'amata nostra Regina per il favore fattoci colI'Augusta<br />
ed ambita loro presenza.<br />
Alle Vostre Altezze Reali il benvenuto nella nostra città e la<br />
conferma dell'intenso affetto che circonda l'Augusta Famiglia, nella<br />
quale la Giovane Sposa è entrata nuovo e desiderato raggio <strong>di</strong> sole.<br />
Qui dove ogni pietra parla della storia nostra; in queste pareti<br />
che hanno sfidato i secoli ed ora si ritornano allo splendore della<br />
architettura antica, l'anno scorso, alla Vostra Augusta presenza, si<br />
inaugurò il Museo del Risorgimento Nazionale; oggi si inse<strong>di</strong>ano,<br />
affratellate, le Società Storica Lombarda e Numismatica Italiana,<br />
della quale Vostra Altezza è degno presidente onorario, e si visiteranno<br />
le sale destinate ai civici Musei, ed a quella Scuola d'arte<br />
applicata all'industria che è la prima manifestazione del concetto<br />
nostro che le raccolte qua dentro non devono essere mute e sterili<br />
esposizioni <strong>di</strong> oggetti, ma costituire un ambiente <strong>di</strong> ricor<strong>di</strong> sacri e<br />
<strong>di</strong> stu<strong>di</strong> fecon<strong>di</strong>.<br />
Così il Museo artistico coll'annessa Scuola servono a far rivivere<br />
la classe <strong>di</strong> quegli artefici dai quali ebbero tanto decoro l'arte<br />
e l'industria <strong>italiana</strong> e tanto lustro la patria nostra, e nelle reliquie<br />
del Museo del Risorgimento, mentre ì Veterani trovano conforto<br />
ai loro vecchi giorni, i giovani si ritemprano ai più santi ideali,<br />
all'amore <strong>di</strong> patria, a quei sentimenti dì riconoscenza e <strong>di</strong> devozione<br />
che a chiunque pensa al passato e confida nell'avvenire strappano<br />
dal cuore il grido <strong>di</strong> Vtva Savoja.<br />
In<strong>di</strong> parlò il presidente della Società Storica, nob. Felice<br />
Calvi, il quale in un elegante <strong>di</strong>scorso, rievocò la meravi-<br />
gliosa corte <strong>di</strong> Lodovico il Moro, e intrattenne l'eletto u<strong>di</strong>torio<br />
intorno a Lodovico XII e a Carlo V, accennando poi effica-
VARIETÀ<br />
cernente alla buia notte della signoria spagnolesca. Riassunse<br />
infine a gran<strong>di</strong> tratti l'opera della benemerita Società da lui<br />
presieduta, e concluse eloquentemente:<br />
Milano si ingolfa sempre più nelle industrie, nei <strong>com</strong>merci, nei<br />
gran<strong>di</strong> affari; ma non dovrebbe trascurare ciò che eleva lo spirito<br />
umano e rende veramente duraturo e fecondo il progresso.<br />
533<br />
Venuta la volta della Società Numismatica, uno dei Vice-<br />
presidenti, il Cav. Francesco Gnecchi, prese così la parola :<br />
Maestà, Altezza Reale<br />
Quando il giorno ii aprile 1892 quella Società Numismatica,<br />
che da lungo tempo era nel desiderio degli stu<strong>di</strong>osi italiani, venne<br />
finalmente costituita, in testa ai nomi dei promotori già figurava<br />
l'augusto nome <strong>di</strong> V, A. R.<br />
La Società, per quanto ristretta <strong>di</strong> numero, <strong>com</strong>e sono per<br />
natura tutte le Società scientifiche de<strong>di</strong>cate all'investigazione del<br />
passato, percorse però la sua via con coraggio e con <strong>di</strong>gnità e<br />
s'acquistò onorevolmente il suo posto fra le consorelle dell'estero,<br />
talché, dopo cinque anni d'esistenza si fece ar<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> offrire a V.<br />
A. R. la Presidenza onoraria, e fu assai fiera <strong>di</strong> vederla graziosa»<br />
mente accettata.<br />
Era vivissimo desiderio dei soci <strong>di</strong> accogliere una volta almeno<br />
nella propria sede il loro Presidente onorario, ed oggi essi ascrivono<br />
a vera fortuna l'occasione che tanto opportunamente si presenta.<br />
— Sede più propria e più degna non si poteva immaginare<br />
per la nostra Società in Milano, che questa nell' antico Castello<br />
Sforzesco dalle cui mura spirano tante memorie in parte gloriose,<br />
in parte pur troppo dolorose, ma che pure tutte si collegano alla<br />
storia della città nostra e dell'Italia intera; memorie che noi veneriamo<br />
e stu<strong>di</strong>amo <strong>com</strong>pen<strong>di</strong>ate ed eternate nella splen<strong>di</strong>da serie<br />
delle monete coniate nella zecca milanese, una delle più varie e<br />
delle più ricche dell'Italia nostra.<br />
Di questi locali che il Municipio <strong>di</strong> Milano liberalmente ci<br />
offerse, non è peranco <strong>com</strong>piuto il restauro, nessuna adunanza vi<br />
ebbe luogo finora; pochi fra i nostri soci appena li hanno veduti,<br />
parecchi vi entrano oggi per la prima volta.<br />
Nessun miglior augurio era lecito desiderare per la nostra<br />
Società, che l' inaugurazione fattane oggi da V. A. R., nella quale<br />
si <strong>com</strong>penetrano due personalità, quali nessuna delle società con-<br />
sorelle nel suo presidente onorario può vantare, quella del Principe<br />
Ere<strong>di</strong>tario e quella dell'appassionato raccoglitore e del <strong>com</strong>peten-<br />
tissimo cultore della <strong>numismatica</strong>.<br />
E io sono felice — nell' assenza del nostro Presidente Conte<br />
Papadopoli — <strong>di</strong> ringraziare a nome <strong>di</strong> tutti i soci V. A. R. d'avere<br />
inaugurata la nostra nuova sede, l'Augusta Principessa d'averla<br />
,
534<br />
VARIETÀ<br />
rallegrata col suo sorriso, e le LL. MM. d'aver reso maggiormente<br />
solenne questo giorno col loro grazioso intervento.<br />
E chiudo le mie brevi parole invitando tutti ad acclamare in<br />
una sola volta alla scienza, alla patria, al Principe, alla Regina<br />
ed al Re.<br />
Chiuse il Dott. Solone Ambrosoli, Direttore del Gabi-<br />
netto Numismatico <strong>di</strong> Brera, col <strong>di</strong>scorso seguente:<br />
Maestà, Altezze Reali, Egregi signori,<br />
Il periodo storico al quale il Castello Sforzesco deve la sua<br />
ricostruzione e la sua caratteristica, — la seconda metà cioè del<br />
secolo XV, — coincide col periodo più splen<strong>di</strong>do per la <strong>numismatica</strong><br />
milanese.<br />
Con Francesco Sforza, infatti, in<strong>com</strong>incia a <strong>com</strong>parire il ritratto<br />
del principe sulle nostre monete.<br />
Con Galeazzo Maria, possiamo seguire la transizione dal Me<strong>di</strong>o<br />
Evo al Rinascimento, quella « evoluzione dell' arte » che Luca<br />
Beltrami ha magistralmente <strong>di</strong>mostrata per le sculture del Castello,<br />
e che nella <strong>numismatica</strong> qui si estrinseca me<strong>di</strong>ante l' impiego dei<br />
rinnovellati caratteri classici per le inscrizioni, talché le monete <strong>di</strong><br />
Galeazzo si potrebbero rior<strong>di</strong>nare cronologicamente in due serie, la<br />
prima a caratteri gotici, la seconda a caratteri romani. Ma già nella<br />
prima serie, per quanto ancora avvinta al passato nelle forme grafiche,<br />
la rappresentazione figurata si svincola dalle pastoie me<strong>di</strong>oevali:<br />
due monete <strong>di</strong> Galeazzo presentano un rovescio immaginoso<br />
e vivacemente tradotto dal bulino: Sant'Ambrogio che flagella un<br />
gruppo <strong>di</strong> guerrieri fuggenti; anzi, in una <strong>di</strong> queste monete, il<br />
, santo li insegue impetuosamente su <strong>di</strong> un focoso destriero.<br />
Con Bona <strong>di</strong> Savoia, e soprattutto con Giangaleazzo Maria Sforza<br />
e Lodovico il Moro, tocchiamo infine al colmo della perfezione;<br />
la moneta con la testa soavissima del duca giovinetto e con l'acci-<br />
gliata effigie del tutore essendo ad esempio un vero gioiello d'arte,<br />
paragonabile alle monete greche, e, per <strong>di</strong>rla con una frase manzo-<br />
niana, <strong>di</strong> <strong>di</strong>versa, ma non d'inferiore bellezza.<br />
A questa coincidenza <strong>di</strong> perio<strong>di</strong>, corrisponde una singolare<br />
coincidenza tra la decorazione del Castello e la <strong>numismatica</strong>; per<br />
cui gli stessi motivi artistici che incontriamo ad ogni istante sulle<br />
monete, si ripetono sugli affreschi delle sale, e principalmente nei<br />
bassorilievi delle targhe numerosissime che ornano le colonne, i<br />
leggiadri capitelli pensili e le serraglie delle vòlte del vasto e<strong>di</strong>ficio,<br />
del porticato medesimo ond'è ricinto il cortile <strong>di</strong> questa Rocchetta<br />
dove la Società Numismatica Italiana, <strong>di</strong> cui S. A. R. il Principe<br />
si è degnato <strong>di</strong> accettare la presidenza onoraria, ha oggi, — per<br />
cortese concessione del Municipio, — la fortuna d'inaugurare con<br />
la Vostra presenza la propria nuova sede.<br />
Mi sia quin<strong>di</strong> permessa una rapida rassegna dei bassorilievi.
VARIETÀ<br />
perchè si vegga sino a qual punto si estenda la coincidenza <strong>di</strong> cui<br />
ho parlato; e <strong>com</strong>e la nostra Società, anche per questo riguardo,<br />
sia pure secondario, possa <strong>com</strong>piacersi d' una sede così singolarmente<br />
adatta all' indole sua.<br />
Fra le targhe (d'interesse numismatico) del Castello, alcune<br />
recano stemmi od imprese che furono adottati dagli Sforza ma che<br />
risalgono ai Visconti: — la biscia, o sola, o inquartata con l'aquila;<br />
i tizzoni con le secchie, impresa già <strong>di</strong> Galeazzo II Visconti; la<br />
fascia annodata, impresa <strong>di</strong> Filippo Maria, il quale usò pure sulle<br />
sue monete, poggiata sullo scudo, quella corona col ramo <strong>di</strong> palma<br />
e col ramo d'alloro, che campeggia poi sola su qualche targa del<br />
Castello, <strong>com</strong>e campeggia poi sola sulle monete sforzesche. Anche<br />
lo scudo partito con la biscia e le tre aquile, eh' è lo stemma della<br />
contea <strong>di</strong> Pavia, figura già sulle monete <strong>di</strong> Filippo Maria Visconti.<br />
535<br />
Altre imprese invece sono schiettamente sforzesche, <strong>com</strong>e la<br />
elegante scopetta, il bizzarro leone col cimiero e le secchie, la<br />
graziosissima colomba nel fiammante, emblemi tutti che s'incontrano<br />
e qui e sulle monete degli Sforza,<br />
La targa col cane appiè d' un albero, quantunque non trovi<br />
riscontri nelle monete sforzesche, richiama tosto al numismatico una<br />
notissima medaglia <strong>di</strong> Francesco Sforza, opera del valente medaglista<br />
Gianfrancesco Enzola <strong>di</strong> Parma, nonché una rara moneta<br />
milanese <strong>di</strong> Filippo li <strong>di</strong> Spagna.<br />
E fra queste targhe dell'epoca sforzesca, infine, le LL. MM. e<br />
le LL. AA. RR. potranno osservarne <strong>di</strong>verse che recano un' insegna<br />
ben nota e familiare : lo scudo con la croce, sul quale poggia un<br />
elmo che ha per cimiero un teschio <strong>di</strong> leone alato. È la medesima<br />
insegna che occorre con tanta frequenza sulle monete <strong>di</strong> Savoia;<br />
ed essa ci ricorda quel motto misterioso che la attornia su <strong>di</strong> un<br />
antico suggello del Conte Verde, quel motto magico e profondo<br />
che Carlo Alberto adottava poi per il suo carteggio, e che egli,<br />
nel 1844, intendendo lo sguardo pensoso all' aurora del nostro ri-<br />
sorgimento, faceva incidere per una medaglia rimasta celebre, coi<br />
busti <strong>di</strong> Dante, Raffaello, Galileo e Cristoforo Colombo : — J'attends<br />
mon astre.<br />
E ora, ad Umberto I, al Re leale, — alla coltissima Regina<br />
d'Italia, — a S. A. R. il Principe <strong>di</strong> Napoli, valoroso fautore della<br />
<strong>numismatica</strong> e Presidente onorario della Società, — e al fiore gentile<br />
ch'egli ha trapiantato fra noi dall'opposta riva dell'Adriatico, i nostri<br />
omaggi e la nostra reverente riconoscenza.<br />
Vive acclamazioni ai Principi e ai Sovrani accolgono le<br />
ultime parole dell'Ambrosoli, <strong>com</strong>e avevano accolto prima i<br />
<strong>di</strong>scorsi precedenti. Lasciando allora le sale sociali il Sindaco<br />
invitò i Principi e i Sovrani a visitare le parti restaurate del<br />
Castello, la corte ducale, la loggetta <strong>di</strong> Galeazzo Maria
536<br />
VARIETÀ<br />
Sforza e i locali destinati ad accogliere il Museo Artistico<br />
Municipale, in uno dei quali era preparato un generoso<br />
asciolvere offerto dalla Città. Mentre il lungo corteo proce-<br />
deva, percorrendo le vastissime sale, il Principe si intrattenne<br />
continuamente e famigliarmente col Dott. Ambrosoli e coi<br />
fratelli Gnecchi, <strong>di</strong>scorrendo <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi argomenti sul tema<br />
dei <strong>com</strong>uni stu<strong>di</strong>i e accolse con favore e sod<strong>di</strong>sfazione la<br />
<strong>di</strong>manda da essi fatta, che S. A. R. la Principessa Elena,<br />
quale sua collaboratrice nei lavori numismatici, fosse iscritta<br />
nel novero dei soci (i).<br />
Alle ore 17<br />
i Sovrani e i Principi partivano per Monza<br />
acclamati <strong>com</strong>e all'arrivo, e la giornata resta così a segnarsi<br />
albo lapillo fra gli annali della nostra Società.<br />
Il " Corpus Numoruni italiooruni „ fu l'argomento<br />
principale <strong>di</strong> ripetuti e lunghi colloqui che S. A. R. il Principe<br />
<strong>di</strong> Napoli ebbe nello scorso ottobre a Milano e a Monza coi<br />
Direttori della <strong>Rivista</strong> e col Conservatore del R. Gabinetto<br />
Numismatico, e siamo felici <strong>di</strong> poter <strong>com</strong>unicare ai lettori<br />
della <strong>Rivista</strong> i progetti che occupano la mente del nostro<br />
Augusto Presidente onorario. Deplorando, quale raccoglitore<br />
<strong>di</strong> monete italiane, la mancanza <strong>di</strong> un catalogo ben redatto<br />
e abbastanza esteso, che possa servire <strong>di</strong> guida generale.<br />
S. A. R. aveva formata l'idea <strong>di</strong> pubblicare il catalogo della<br />
propria collezione, quando questa avesse raggiunti i 20000<br />
pezzi, dai quali ora è poco lontana, contandone 18000. In<br />
progresso <strong>di</strong> tempo però, visitando altre collezioni, e vedendo<br />
<strong>com</strong>e nella propria alcune serie fossero più o meno defi-<br />
cienti, venne nella persuasione che meglio sarebbe valso fare<br />
ad<strong>di</strong>rittura un Catalogo generale delle zecche italiane, prendendo<br />
la propria collezione <strong>com</strong>e punto <strong>di</strong> partenza, ma ag-<br />
giungendovi anche tutto quello che vi mancasse e che si<br />
potesse trovare nelle altre. L'opera andava naturalmente<br />
ingrossando e prendendo delle proporzioni gran<strong>di</strong>ose; ma<br />
non si arretrò per questo il proposito del Principe, il quale<br />
è deciso a mettersi al lungo e importante lavoro, malgrado<br />
tutte le <strong>di</strong>fficoltà che si presentano, alcune delle quali <strong>di</strong><br />
(i) Ve<strong>di</strong> Atti della Società, Seduta 9 Novembre 1897.
VARIETÀ<br />
somma importanza. Il lavoro sarà in<strong>com</strong>inciato colla <strong>com</strong>pi-<br />
lazione delle schede della privata collezione del Principe, le<br />
quali saranno poligrafate e <strong>com</strong>unicate ai principali gabinetti<br />
pubblici e privati. Non dubitiamo punto che tutti faranno a<br />
gara nel contribuire del loro meglio all'opera gigantesca che<br />
il nostro Augusto Presidente onorario sta per intraprendere<br />
e che non ha riscontro in nessun altro paese.<br />
Ma il Corpus Numorum italicorum non sarà solo una<br />
gloria per l'iniziatore e pel nostro paese; sarà anche un<br />
beneficio per la nostra Società e servirà ad assicurare la vita<br />
finanziaria della nostra <strong>Rivista</strong>, la quale, <strong>com</strong>e ognun sa, ora<br />
vive per appoggi privati che un giorno o l'altro potrebbero<br />
mancare. Tutto il ricavo dell'opera è generosamente off'erto<br />
dal Principe alla nostra Società, a nome della quale noi<br />
esprimiamo già fin d'ora i sensi della massima riconoscenza.<br />
La Direzione.<br />
Il Principe <strong>di</strong> Napoli a Brera, — Togliamo dalla<br />
" Ieri mattina, in forma<br />
Perseveranza del 27 ottobre u. s. : —<br />
privata, il Principe <strong>di</strong> Napoli si è recato a Brera per visitarvi<br />
il Gabinetto Numismatico. Ricevuto dal Conservatore dott.<br />
Solone Ambrosoli, s' intrattenne per due ore ad esaminare<br />
con vivissimo interesse e con rara <strong>com</strong>petenza la sezione<br />
delle monete me<strong>di</strong>oevali e moderne <strong>di</strong> zecche italiane, campo<br />
pre<strong>di</strong>letto de' suoi stu<strong>di</strong>i, manifestando la propria <strong>com</strong>piacenza<br />
nel veder riuniti nel nostro Medagliere tanti preziosi monu-<br />
menti della storia e dell'arte monetale. „<br />
537<br />
Dono al Gàb. JViim. <strong>di</strong> Milano. — Il noto incisore<br />
milanese Cav. Francesco Grazioli ha donato al R. Gabinetto<br />
Numismatico <strong>di</strong> Brera la raccolta dei conii e punzoni per<br />
medaglie, da lui incisi durante il lungo periodo della sua<br />
attività artistica, dal 1859 al 1896. I detti conii e punzoni<br />
sono collocati in due ben adatte vetrine, dono anch'esse<br />
del Cav. Grazioli.<br />
Concorso Grai^ioli, — Ricor<strong>di</strong>amo ai Sigg. Incisori <strong>di</strong><br />
medaglie, che nel p. v. anno 1898 si ripeterà il Concorso<br />
Grazioli presso la R. Accademia <strong>di</strong> Belle Arti in Milano,<br />
dalla cui Segreteria potranno avere le relative informazioni.<br />
68
538<br />
VARIETÀ<br />
Per V Esposizione Universale del 1900. — Nella<br />
Gazette numismatique francaise troviamo l'elenco degl'incisori<br />
<strong>di</strong> medaglie e monete, officiali <strong>di</strong> Zecca, ecc., designati a<br />
formar parte del <strong>com</strong>itato <strong>di</strong> ammissione per 1' Esposizione<br />
Universale. Cre<strong>di</strong>amo utile <strong>di</strong> riportarlo.<br />
Classe 4. (Insegnamento speciale artistico). — J.-C. Cha-<br />
plain, membro dell'Istituto, incisore in medaglie.<br />
Classe ij. (Strumenti <strong>di</strong> precisione, monete e medaglie).<br />
— A. de Foville, <strong>di</strong>rettore della Zecca; J. Boussingault,<br />
P. Charpentier, E. Collière e F. Hucher, capi <strong>di</strong> servizio<br />
della Zecca; Daniele Dupuis e P. Tasset, incisori in medaglie.<br />
Classe g3. (Oreficeria). — O. Roty, presidente dell' Ac-<br />
cademia delle Belle Arti, incisore in medaglie; E. Mazerolle,<br />
archivista della Zecca; H. de la Tour, bibliotecario al Ga-<br />
binetto Numismatico <strong>di</strong> Parigi.<br />
Classe g4. (Gioielleria). — L. Bottée, incisore in medaglie.<br />
Viaggio scientifico, — Gli scienziati tedeschi Dott. T.<br />
J. Haeberlin <strong>di</strong> Erancoforte e il Maggiore M. Bahrfeldt <strong>di</strong><br />
Breslavia percorsero T Italia dal 15 ottobre scorso al 15<br />
novembre visitando quante collezioni numismatiche fu loro<br />
possibile, pubbliche e private, e ciascuno nella propria spe-<br />
cialità, il primo nell'Aes grave italico, il secondo nelle mo-<br />
nete della repubblica romana, raccolsero buona messe <strong>di</strong><br />
materiale per nuovi stu<strong>di</strong>i, che in buona parte vedranno la<br />
luce per mezzo della nostra <strong>Rivista</strong>.<br />
Corsi <strong>di</strong> Nìimìsmntica, — In un perio<strong>di</strong>co viennese<br />
troviamo un elenco dei corsi <strong>di</strong> Numismatica che si terranno<br />
nell'inverno 1897-98 presso alcune Università tedesche. Cre<strong>di</strong>amo<br />
interessante <strong>di</strong> qui riportarlo.<br />
Jena, Prof, straord. Dott. B. Pick: Elementi <strong>di</strong> Mitologia dell'arte,<br />
desunti in particolare dalle monete.<br />
Monaco, Prof, onorario Dott. H. Riggauer: Numismatica greca.<br />
Graz, Prof, straord. Dott; F. Pichler: La monetazione ateniese.<br />
Gli stemmi degli Stati europei. Gli or<strong>di</strong>ni austriaci.<br />
Vienna, Prof, straord. Dott. Gugl. Kitbitschek : Corso elementare<br />
<strong>di</strong> Numismatica greca. Esercitazioni relative. — Lib. docente<br />
Dott. 5. Steinherz: Introduzione alla storia monetaria del Me<strong>di</strong>o Evo.
Milano<br />
Pavia<br />
Venezia<br />
Firenze<br />
VARIETÀ<br />
539<br />
Una <strong>di</strong>mostiraxlone a Gtorf/lo Cumont, — Per inizia-<br />
tiva <strong>di</strong> alcuni fra i membri della Società Reale Belga <strong>di</strong><br />
Numismatica da alcuni mesi era stata aperta una sottoscrizione<br />
internazionale per offrire un ricordo al Sig. Giorgio<br />
Cumont, avvocato, antico presidente della Società Archeolo-<br />
gica e antico Segretario della Società Numismatica , in<br />
benemerenza dei servigi da lui prestati alla scienza. —<br />
La manifestazione ebbe luogo martedì 27 ottobre- scorso a<br />
Bruxelles nella sala del Museo della Società Archeologica.<br />
11 Sig. de Bavay accolse l' avv. Cumont, con un <strong>di</strong>scorso<br />
d'attualità, e terminando gli offerse il bronzo d'arte, frutto<br />
della sottoscrizione e consistente in un San Giorgio. Un vino<br />
d'onore coronò la cerimonia.<br />
Il ripostiglio <strong>di</strong> Chignolo I*o. — Alla fine del settembre<br />
scorso, a Chignolo Po (Prov. <strong>di</strong> Pavia), in un fondo<br />
<strong>di</strong> proprietà del Sig. March. Luigi Cusani Gonfalonieri, durante<br />
i lavori agricoli fu scoperto un ripostiglio <strong>di</strong> monete me<strong>di</strong>o-<br />
evali, che fortunatamente potè essere raccolto nella sua quasi<br />
totalità per cura del Nob. Ing. Antonio Castiglione.<br />
11 tesoretto, poco numeroso <strong>di</strong> pezzi, ma, per <strong>com</strong>penso,<br />
<strong>di</strong> elettissima <strong>com</strong>posizione, constava quasi esclusivamente<br />
<strong>di</strong> monete d'oro, alcune fra le quali assai rare, <strong>com</strong>e si vedrà<br />
dal seguente elenco.<br />
• Galeazzo<br />
Galeazzo II Visconti<br />
Bernabò Visconti<br />
Giangaleazzo Visconti<br />
Dominazione viscontea<br />
II Visconti<br />
Bartolomeo Gradenigo<br />
Giovanni Dolfin<br />
- Andrea Contarini<br />
- Michele Morosini<br />
-Antonio Venier<br />
- Doge primo<br />
Doge quarto<br />
- Doge quinto<br />
- Doge ottavo<br />
Doge decimo<br />
Repubblica<br />
- Dominazione pontificia<br />
- Senatori anonimi<br />
Roma<br />
AYipone- Clemente VI<br />
- Boeiia Carlo IV imp. (I CODie IB dì B<br />
Unglieria - Sigismondo<br />
(1354-78)-
540<br />
VARIETÀ<br />
" Ambrosiana. „ — Sotto questo titolo, la Commissione<br />
degli stu<strong>di</strong>i per le feste del XV centenario dalla morte <strong>di</strong><br />
S. Ambrogio pubblicherà nel corr. mese <strong>di</strong> <strong>di</strong>cembre, coi<br />
tipi della nostra Casa e<strong>di</strong>trice L. F. Cogliati, una raccolta<br />
<strong>di</strong> scritti varii, che formeranno un grosso volume in-4°, <strong>di</strong><br />
circa 600 pag., e<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> lusso copiosamente illustrata, al<br />
prezzo <strong>di</strong> it. L. 20, Fra gli scritti in esso contenuti, non pochi<br />
sono d'indole storica, archeologica od artistica; il Dott. Am-<br />
brosoli ha poi contribuito al volume con una memoria <strong>di</strong><br />
nummografia milanese: L'ambrosmo d'oro {Ricerche storico-<br />
•numismatiche).<br />
Da Berlino ci giunge la dolorosa notizia della morte del<br />
Dott. Prof. ALFREDO von SALLET<br />
Direttore <strong>di</strong> quel R. Gabinetto Numismatico.<br />
Parleremo <strong>di</strong> lui nel prossimo fascicolo della <strong>Rivista</strong>.
ATTI<br />
DELLA<br />
SOCIETÀ NUMISMATICA ITALIANA<br />
Seduta del Consiglio 9 Novembre 1897.<br />
(Estratto dai Verbali).<br />
La seduta è tenuta per la prima volta nella nuova sede<br />
del Castello ed è aperta alle ore 9V2.<br />
I. Il Vice-Presidente Francesco Gnecchi prende la parola<br />
in questi termini:<br />
Dopo la cerimonia inaugurale <strong>di</strong> questa sede, che riuscì<br />
" oltremodo solenne e che qui non ripeterò a voi che tutti<br />
" ne foste testimonii e parte (0, ma per la quale ci resta un<br />
" debito <strong>di</strong> gratitu<strong>di</strong>ne verso il nostro Augusto Presidente<br />
" Onorario, ho 1' onore e il piacere <strong>di</strong> aprire la serie delle<br />
" nostre sedute nel nuovo locale coli' annuncio <strong>di</strong> due fatti<br />
" che renderanno memorabile per noi questa prima riunione.<br />
" — Per prima cosa vi annuncio che S. A. R. la Principessa<br />
" <strong>di</strong> Napoli ha graziosamente accettato <strong>di</strong> far parte della<br />
" nostra Società, e il suo Augusto nome figurerà d' ora<br />
" innanzi a capolista nell'elenco dei nostri Soci, occupando<br />
"<br />
il posto che già era devoluto al Principe prima che fosse<br />
" nostro Presidente Onorario. E tengo a <strong>di</strong>chiarare <strong>com</strong>e<br />
" tale nomina, tanto onorifica per la nostra società, non sia<br />
" stata motivata dalla eccelsa posizione sociale della nuova<br />
" iscritta, ma bensì dalle sue benemerenze numismatiche.<br />
" Mentre si passeggiava per le sale del Castello, il giorno<br />
" dell'inaugurazione, il Principe mi narrava <strong>com</strong>e la Princi-<br />
" pessa sia la fida e intelligente <strong>com</strong>pagna de' suoi stu<strong>di</strong>i<br />
(i) Ve<strong>di</strong> in questo stesso fascicolo Varietà pag. 531.
542<br />
ATTI DELLA SOCIETÀ NUMISMATICA ITALIANA<br />
" sulle monete italiane e <strong>com</strong>e stia anche formando una<br />
" propria collezione <strong>di</strong> monete degli Slavi. Io osai allora<br />
" chiedere a S. A. R. il permesso <strong>di</strong> iscriverla fra i nostri<br />
" Soci, e la <strong>di</strong>manda venne accolta colla massima cor<strong>di</strong>alità. „<br />
Un vivo applauso dei convenuti accoglie queste parole<br />
e viene incaricata la Presidenza <strong>di</strong> un voto <strong>di</strong> ringraziamento<br />
e <strong>di</strong> devozione a S. A. R. la Principessa <strong>di</strong> Napoli.<br />
Continuando il <strong>di</strong>scorso relativamente ai colloqui avuti<br />
col Principe, il Vice-Presidente viene al secondo fatto, del<br />
quale oggi si mette per così <strong>di</strong>re simbolicamente la prima<br />
pietra, annunciando cioè la decisione del Principe <strong>di</strong> accin-<br />
gersi all'opera colossale <strong>di</strong> un Corpus Numorum italicoriim (O.<br />
Né occorre accennare con quale ammirazione e favore venne<br />
accolta da tutti i convenuti la lieta novella, e con quanta<br />
riconoscenza l'offerta del principe <strong>di</strong> devolverne l'introito a<br />
favore della Società.<br />
IL Si propone e si approva ad unanimità il passaggio<br />
del Cav. V. Padoa <strong>di</strong> Firenze dalla categoria <strong>di</strong> Socio corri-<br />
spondente a quella <strong>di</strong> Socio effettivo. Viene nominato Socio<br />
corrispondente il Sig. Francesco Nuvolari <strong>di</strong> Castel d'Ario.<br />
III. Si passa alla <strong>com</strong>posizione del IV fascicolo, già in<br />
corso <strong>di</strong> stampa.<br />
IV. Vengono prese alcune <strong>di</strong>sposizioni d'or<strong>di</strong>ne interno e<br />
si stabilisce una tessera d'ingresso pei Soci nella nuova sede.<br />
Prima <strong>di</strong> levare la seduta, rammentandosi che dopo<br />
domani ricorre il genetliaco <strong>di</strong> S. A. R., il Consiglio incarica<br />
la Presidenza <strong>di</strong> mandare i più cor<strong>di</strong>ali e rispettosi auguri<br />
all'Augusto Presidente Onorario.<br />
La seduta è levata alle ore n 74.<br />
Seduta del Consiglio 25 Novembre 1897.<br />
{Estratto dai Verbali).<br />
La seduta è aperta alle ore 9 nel locale del Castello.<br />
I. Il Vice-Presidente, Cav. Francesco Gnecchi, apre la<br />
seduta consegnando i ritratti <strong>di</strong> S. A. R. il Principe <strong>di</strong> Napoli<br />
(i) Ve<strong>di</strong> in questo stesso fascicolo Varietà pag. 536.
ATTI DELLA SOCIETÀ NUMISMATICA ITALIANA 543<br />
e <strong>di</strong> S. A. R. la Principessa <strong>di</strong> Napoli, graziosamente offerti<br />
alla Società dai Principi stessi, colle loro firme.<br />
I Consiglieri votano un ringraziamento incaricandone la<br />
Presidenza, e i ritratti vengono collocati nel posto d'onore.<br />
II. Il Cav. Prof. Luppi, in seguito ad accor<strong>di</strong> presi fra la<br />
Presidenza della Società e il Presidente Onorario, dovendo<br />
recarsi a Napoli onde coa<strong>di</strong>uvare S. A. R. nella <strong>com</strong>pilazione<br />
delle schede pel Corpus numorum, rassegna le proprie <strong>di</strong>mis-<br />
sioni da Segretario della Società.<br />
II Consiglio, riconoscendo nel Prof. Luppi tutte le ne-<br />
cessarie attitu<strong>di</strong>ni pel lavoro che andrà ad assumere, allo<br />
scopo <strong>di</strong> favorire V importantissima opera del Principe, si<br />
priva (per quanto con rammarico) del suo Segretario e ne<br />
accetta le <strong>di</strong>missioni, ringraziandolo dei servigi resi alla So-<br />
cietà dalla sua fondazione fino ad oggi.<br />
III. Vengono nominati a voti unanimi e onorariamente il<br />
Cav. Giuseppe Gavazzi a Segretario e il Cav. Dott. Solone<br />
Ambrosoli a Bibliotecario della Società. — A Segretario<br />
effettivo viene nominato il Signor A. M. Cornelio.<br />
IV. Si dà <strong>com</strong>unicazione dei seguenti doni pervenuti<br />
alla Società:<br />
Bordeaux Paul <strong>di</strong> Neuilly.<br />
La sua pubblicazione: L'Adjonction au domaine royal de la Cha-<br />
tellerie de Dun. Parigi, 1897.<br />
Capobianchi Cav. Prof. Vincenzo.<br />
La sua pubblicazione: Appunti per servire all'or<strong>di</strong>namento delle<br />
monete coniate dal Senato <strong>di</strong> Roma. Roma, 1896.<br />
La Mantia Comm. Vito <strong>di</strong> Palermo.<br />
La sua pubblicazione: I Privilegi <strong>di</strong> Messina (1129-1816). Note<br />
storiche con documenti ine<strong>di</strong>ti. Palermo, 1897.<br />
Lambros Paolo <strong>di</strong> Atene.<br />
On a Coin of Hierapytna in Crete, hitherto wrongly attributed.<br />
Londra, 1897.<br />
Luppi Cav. Prof. Costantino.<br />
Revue de la numismatique belge. 4^ Serie <strong>com</strong>pleta. Dall'anno 1863<br />
all'anno 1868, e il primo volume della 5=» Serie, cioè dell'anno<br />
1869. (Sette annate). — Cohen Henri, Description des médailles
544 -^TTI DELLA SOCIETÀ NUMISMATICA ITALIANA<br />
romaines <strong>com</strong>posant la Collection de M. I. Gréau. Paris, i86q;<br />
voi. in-8 con 7 tav. — S. Quintino Giulio, Notizia ed osservazioni<br />
sopra alcune monete battute in Pavia da Ardoino mar-<br />
chese d'Ivrea e re d'Italia e dall'avo <strong>di</strong> lui il re Berengario li.<br />
Con aggiunto: Della parte dovuta agli italiani nello stu<strong>di</strong>o<br />
delle monete battute nel corso dei secoli XIII e XIV, ecc.<br />
Torino, 1842; in-4 con una tav. — 5. Quintino Giulio, Descrizione<br />
delle medaglie imperiali alessandrine ine<strong>di</strong>te del R. Museo<br />
egiziano <strong>di</strong> Torino. In-4 con una tavola. — Sanclemente, De<br />
Trallensi-Tulliano tetradrachmo Musei Theupoli. Milano, 1806;<br />
in-4 fig- — Gazzoletti Ant., Della zecca <strong>di</strong> Trento. Trento, 1858;<br />
in-8 con 2 tav. — Biondelli Bern., Bellinzona e le sue monete<br />
e<strong>di</strong>te ed ine<strong>di</strong>te. Milano, 1879; in-8 fig. — Stancovich Can. Pietro,<br />
Deposito <strong>di</strong> monete ungheresi, carraresi, e veneziane scoperto<br />
nell'Istria. Barbana, 1831 ; in-8 con una tav. — Bianconi Ge-<br />
rolamo, Catalogus numorum veterum urbium, populorum, et<br />
regum qui apud. CI. V. Max. Angelellium patriclum bononiensem<br />
adservantur, adjectis nonnuUis illustrationibus. Bologna, 1827;<br />
in-8 con 2 tav. — Mussagli Dom., Monnaies de Lucques<br />
pendant la domination des Francs aux Vili et IX siècles. Paris,<br />
1861; in-8 con tav. — Massagli Dom., Monnaies frappées a<br />
Lucques sous les empereurs de Germanie et les rois d' Italie<br />
dans les X, XI, et XII siècles. Paris, 1863; in-8 con una tav.<br />
— Massagli Dom., Monnaies de Lucques, de la réforme monetaire<br />
de Frédéric II, et des types adoptés à Lucques pendant<br />
le XIII siede. Paris, 1864; in-8. — Santarelli Ant., Notizia <strong>di</strong><br />
un ripostiglio <strong>di</strong> denari consolari trovato a Pieve-Quinta nel<br />
Forlivese. Forlì, 1879; in-8. — Riccio Gennaro, Le monete<br />
attribuite alla zecca dell'antica città <strong>di</strong> Lucerla. Napoli, 1846;<br />
in-4 con 3 tav. — Riccio Gennaro, Secondo supplemento al<br />
catalogo delle antiche monete consolari e <strong>di</strong> famiglie romane.<br />
— Porro Giulio, Moneta battuta in Viterbo da Cesare Vico.<br />
Asti, T840; in-8 con i tav. — Sestini Dom., Lettere e <strong>di</strong>ssertazioni<br />
numismatiche. In-4 fig. — Salinas Antonino, Il Museo<br />
nazionale <strong>di</strong> Palermo e il suo avvenire. Palermo, 1873; in-8.<br />
— Maggiora- Vergano, Una moneta ine<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> Acqui. Asti,<br />
1877; in-8 con una tav. — Tini Tommaso, Storia della moneta.<br />
Foligno, 1^5; con 5 tav. — Carli-Rubbi Gianrinaldo, Delle<br />
monete e dell'istituzione delle zecche d'Italia. Mantova, 1754;<br />
voi. 4 in-8 con 9 tav. — Fraccia Gio., Antiche monete siciliane<br />
pubblicate pel primo dal Cav. Gio. Fraccia. Roma, 1889; in-8<br />
con T tav. — Fraccia Gio., Antiche monete siciliane ine<strong>di</strong>te o<br />
per qualsiasi particolarità nuove del Real Museo <strong>di</strong> Palermo.
ATTI DIÌLLA SOCIETÀ NUMISMATICA ITALIANA<br />
545<br />
Palermo, 1865; in-4. - Bertolotti Gius., Illustrazione <strong>di</strong> un<br />
denaro d'argento ine<strong>di</strong>to <strong>di</strong> Rodolfo <strong>di</strong> Borgogna re d'Italia<br />
coniato in Milano circa il 922-925. Milafio, in-8 con i tav. —<br />
Adriani G. B., Delle monete maomettane del Dottore Krehl.<br />
Torino, 1857; in-8. — Gozza<strong>di</strong>ni, Solenne inaugurazione del<br />
Museo civico <strong>di</strong> Bologna. Bologna, 1881 ; in-8. — Repossi Luigi,<br />
Milano e la sua zecca. Torirto, 1877; in-8. - Schiarimenti sopr^i<br />
alcune monete venete. Venezia, 1848; in-8. — Morbio Carlo,<br />
Monografia storica delle zecche italiane. Asti, 1868; in-8. —<br />
Morbio Carlo, Delle monete battute da Carlo Magno in Italia.<br />
Asti, 1866; in-8 con i tav. — Castiglioni Ottavio, Mémoire<br />
géographique et numismatique sur la partie orientale de la<br />
Barbarie appelée Afrikia par les arabes. Milano, 1826; in-8. —<br />
Millin L., Lettre sur les monnoies qu'on attribue à la Reine<br />
Brunehaut et sur quelques pièces de Théodebert. In-8 fig. —<br />
Gratino Gio., Delle genealogie del Duca d'Amalfi Marino figlio<br />
<strong>di</strong> Luciano, nipote <strong>di</strong> Purcaro e de' Duchi Sergio e Mansone.<br />
Pisa, 1860; in-4 ^g- — Morrona Alessandro, Pisa illustrata<br />
nelle arti del <strong>di</strong>segno. Livorno, 1812; voi. 3 in-8 picc. con molte<br />
tav. <strong>di</strong> monumenti ed anche <strong>di</strong> monete. — Patin Carlo, Intro-<br />
ducilo ad historiam numismatum. Amsterdam, 1683; in-i6 fig.<br />
— Spanhemio, luliani imp. Caesares. Gota, 1736; in-i6 con 4<br />
tav. <strong>di</strong> monete. — Orlan<strong>di</strong>ni G., Catalogo <strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> mo-<br />
nete dei dogi veneti, con illustrazioni storico-monetografiche,<br />
ecc. Portogruaro, 1855: in-i6. — Monal<strong>di</strong>ni Ant., Istituzione<br />
antiquaria <strong>numismatica</strong>. Roma, 1772; in-8 con 3 tav. — Rome<br />
De Ulsle, Metrologie ou table pour servir à l'intelligence des<br />
poids et mesures des anciens et principalement à déterminer<br />
la valeur des monnaies grecques et romaines. Paris, 1789; in-4.<br />
Engelmann, Miinz-Cabinet. Saxe. Mulhouse, 1835; con io tav.<br />
— Tavole stampate a Stutgard nel Wiirtemberg rappresentanti<br />
le svanziche che col 15 novembre 1858 vennero messe fuori<br />
<strong>di</strong> corso nella Germania. Con 16 tav. — Nissar<strong>di</strong> Filippo,<br />
Intorno ai ripostigli <strong>di</strong> bronzi <strong>di</strong> Abini e <strong>di</strong> Ferraxi Nioi in<br />
Sardegna, ecc. Cagliari, 1884; opuscoli in-8. — Baart De la<br />
Faille, Cabinet numismatique. Groningue, 1869; in 8 fig. —<br />
Della Cella Paolo, Viaggio <strong>di</strong> Tripoli <strong>di</strong> Barberia alle frontiere<br />
dell'Egitto, fatto nel 1817. Genova, 1819; in-8 con tav. e una<br />
<strong>di</strong> monete. — Caronni, Ragguaglio <strong>di</strong> alcuni monumenti <strong>di</strong><br />
antichità e d'arti raccolti negli ultimi viaggi da un <strong>di</strong>lettante,<br />
ecc. Milano, 1806; in-8 con molte tav. la più parte <strong>di</strong> monete.<br />
— Leonar<strong>di</strong> Michel'Angelo, Lettere scritte al nobile ed ingenuo<br />
cavaliere il Sig. Giuseppe Avogadro. Novara; in-8 con i tav.<br />
69
546 ATTI DELLA SOCIETÀ NUMISMATICA ITALIANA<br />
sulla moneta piacentina. — Ayrmanno Crisi. Fed., Dissertati©<br />
de nummis Ateulae regi Attilae male attributis. Gissa, 1738;<br />
in-8. — Aliés F., Traile <strong>com</strong>paratif des monnaies, poids et<br />
mesures, ecc. Marseille, 1832; in-8, — Tableau de valeur des<br />
monnaies des principaux états du monde. Paris, 1817; in-8 con<br />
16 tav. — Patente sovrana del i novembre 1823 portante il<br />
nuovo sistema <strong>di</strong> monetazione nel regno Lombardo-Veneto.<br />
Milano; in-8 con tav. — Bergmann Joseph, Medaiilen auf<br />
beriihmte und ansgezeichnete Mànner des Kaiserthums Oester-<br />
reich vom XVI bis zum XIX lahrhunderte. Wien, 1840 ; in-4<br />
voi. 2 (mancante <strong>di</strong> 2 <strong>di</strong>spense) con moltissime tav. <strong>di</strong> medaglie.<br />
— Rossi Guglielmo, L' adorazione del sole desunta da una<br />
moneta <strong>di</strong> Costantino il Grande. Milano, 1880; in-8. — Ecluse<br />
[Charles de L'), Monnaies de tous les pays de monde. Paris,<br />
1887; in-8 fig. — Pizzi Francesco, Numismata collecta. In<br />
occasione delle nozze <strong>di</strong> Fortunato Turina con Donna Carolina<br />
Cavalcabò dei marchesi <strong>di</strong> Viadana. Cremona, 1877; in-4. —<br />
Paciau<strong>di</strong> Paolo Maria, Medaglie rappresentanti i più gloriosi<br />
avvenimenti del magistero <strong>di</strong> S. A. E. Fra D. Emmanuele Pinto.<br />
(Molto raro) con 22 tav. incise. — Muoni Damiano, Famiglia<br />
Labus. Milano, 1875; in-fol. con ritratto. — Collezione <strong>di</strong> tavole<br />
monetarie <strong>di</strong> tutte le monete nobili coniate nelle principali zecche<br />
dell'Europa, dell'Asia e della Barbarla, con il loro titolo, peso<br />
e valore, ecc. Venezia, 1796; un centinaio <strong>di</strong> tav. incise. —<br />
Bizot, Histoire métallique de la Republique de Hollande. Paris,<br />
1687; in-fol. con moltissime tav. — Neumann loseph, Beschreibung<br />
der bekannsteten Kupfermiinzen. Prag, 1856; in-8. Gli 8 fasci-<br />
coli <strong>com</strong>ponenti il primo volume, colla descrizione <strong>di</strong> tutte le<br />
monete degli stati europei, con molte tav. incise. — Mantovani G.,<br />
Museo Opitergino. Bergamo, 1874 ; in-8 fig. — Cartier E., Tables<br />
generales et raisonnées par ordre de matières des XX volumes<br />
de la I''^ Serie de la Revue numismatique. Paris, 1856; un voi.<br />
in-8. — Scotti Ang., Illustrazione <strong>di</strong> un vaso italo-greco del<br />
museo <strong>di</strong> Monsignor Arcivescovo <strong>di</strong> Taranto. Napoli, 181 1 ;<br />
in-4 CO" ^^^- anche <strong>di</strong> monete. — Del Monte Saverio, Le monete<br />
della Repubblica romana. Genova, 1869; in-8. — Betti Salvatore,<br />
Intorno la moneta gallica <strong>di</strong> Tatino. Dissertazione. Roma, in-4.<br />
Padoa Cav. Vittorio <strong>di</strong> Firenze.<br />
Monete e Medaglie relative al risorgimento Italiano. N. 12 in argento,<br />
20 in bronzo, 4 in piombo o stagno.<br />
Puschi Cav. Prof. Alberto <strong>di</strong> Trieste.<br />
Atti del Museo Civico <strong>di</strong> Antichità in Trieste. N. 2. Trieste, 1897.
ATTI DELLA SOCIETÀ NUMISMATICA ITALIANA 547<br />
"Witte (De) Alphonse <strong>di</strong> Bruxelles.<br />
La sua pubblicazione : Notes sur les monnaies des Ètats-Belgiques*<br />
unis. Bruxelles, 1897.<br />
VI. Il Consiglio, considerando l'importanza dei doni del<br />
Cav. Vittorio Padoa, in monete e medaglie e del Professore<br />
Cav. Luppi in libri (v. lista d'oggi e liste precedenti) proclama<br />
il Sig. Cav. Vittorio Padoa e il Prof. Cav. Costantino Luppi<br />
Benemeriti della Società.<br />
VII. Vengono presentate le Tessere <strong>di</strong> riconoscimento<br />
da <strong>di</strong>stribuirsi ai Soci per l'accesso alla sede sociale, le quali<br />
furono gratuitamente eseguite e gentilmente offerte dalla<br />
Ditta M. Bassani e C.<br />
Vili. Dopo varie <strong>di</strong>scussioni d'or<strong>di</strong>ne interno, relative<br />
all'arredamento e all'ammobigliamento della sala, la seduta<br />
è levata all-e ore 11.
COLLABORATORI DELLA RIVISTA<br />
NELL'ANNO 1897<br />
Memorie e Dissertazioni.<br />
Agostini Agostino<br />
Ambrosoli Solone<br />
Babelon Ernesto<br />
Ciani Giorgio<br />
Frati Luigi<br />
Cabrici Ettore<br />
Gnecchi Ercole<br />
Gnecchi Francesco<br />
t Kunz Carlo<br />
Malaguzzi Valeri Francesco<br />
Papadopoli Nicolò<br />
Ricci Serafino<br />
Rizzoli Luigi junior<br />
Ruggero Ciuseppe<br />
Vitalini Ortensio<br />
Cronaca.<br />
Ambrosoli Solone<br />
Gnecchi Francesco<br />
Motta Emilio
ELENCO DEI MEMBRI<br />
DELLA<br />
SOCIETÀ NUMISMATICA ITALIANA<br />
E DEGLI<br />
ASSOCIATI ALLA RIVISTA<br />
PER l'anno 1897<br />
SOCI EFFETTIVI (*).<br />
1. *S. A. R. Il Principe <strong>di</strong> Napoli.<br />
2. S. A. R. La Principessa <strong>di</strong> Napoli.<br />
3. *Ambrosoli Dott. Cav. Solone — Milano.<br />
4. *Arcari Dott. Cav. Francesco — Cremona.<br />
5.<br />
Averara Avv, Manifesto — Lo<strong>di</strong>.<br />
6.*fBalIarati Magg. Cav. Amedeo — Sacconago.<br />
7. Bellicorti (De) Ing. I. — S. Stefano d'Egitto.<br />
8. *Bertol<strong>di</strong> Cav. Antonio — Venezia.<br />
9. 'Castellani Rag. Giuseppe — Santarcangelo {Romagna).<br />
10. *Ciani Dott. Giorgio — Trento.<br />
11. Dattari Giovanni — Cairo (Egitto).<br />
12. Dessi Vincenzo — Sassari.<br />
13. *Fasella Comm. Carlo — Milano.<br />
14. 'Fiorasi Cap. Gaetano — Piacenza.<br />
15. 'Gavazzi Cav. Giuseppe — Milano.<br />
16. *Gnecchi Cav. uff. Ercole — Milano.<br />
17. *Gnecchi Cav. uff. Francesco — Milano.<br />
18. Kirsch Dott. Jacopo — Monaco.<br />
19. *Johnson Cav. Federico — Milano.<br />
20. Lazara (De) Conte Antonio — Padova.<br />
21. *Marazzani Visconti Terzi Conte Lodovico — Piacenza.<br />
22. Marietti Dott. Antonio — Milano.<br />
(•) I nomi segnati con asterisco sono quelli dei Soci Fondatori.
552 ELENCO DEI MEMBRI DELLA SOCIETÀ, ECC.<br />
23. 'Marietti Dott. Comm. Giovanni — Parma.<br />
24. Mattoi Edoardo — Milano.<br />
25. *Miari Conte Fulcio Luigi — Venezia.<br />
26. *Milani Prof. Cav. Luigi Adriano — Firenze.<br />
27. *Motta Ing. Emilio — Milano.<br />
28. Nervegna Giuseppe — Brin<strong>di</strong>si.<br />
29. Padoa Cav. Vittorio — Firenze.<br />
30. *Papadopoli Conte Comm. Nicolò — Venezia.<br />
31. Ponti Cesare — Milano.<br />
32. Puschi Prof. Cav. Alberto — Trieste.<br />
33.<br />
*Ratti Dott. Luigi — Milano.<br />
34. Rizzoli Luigi — Padova.<br />
35. 'Ruggero Cav. Col. Giuseppe - Firenze.<br />
36. *Salinas Comm. Prof. Antonino — Palermo.<br />
37. Savini Paolo — Milano.<br />
38. Seletti Avv. Cav. Emilio — Milano.<br />
39. *Sessa Rodolfo — Milano.<br />
40. *Sormani Andreani Conte Lorenzo — Milano.<br />
41. *Tatti Ing. Paolo — Milano.<br />
42. Traversa Francesco — Bra.<br />
43. 'Visconti Ermes March. Carlo — Milano.<br />
, 8.<br />
SOCI CORRISPONDENTI.<br />
1. Adriani Prof. Comm. G. B. — Cherasco.<br />
2. Annoni Antonio — Milano.<br />
3. Baj occhi F. — Massaua.<br />
4. Balli Emilio — Locamo.<br />
5. Bartolo (Di) Prof. Francesco — Catania.<br />
6. Cahn E. Adolfo — Francoforte sul Meno.<br />
7.<br />
Canessa Cesare — Napoli.<br />
Caucich Guido — Firenze.<br />
9. Cavalli Gustavo — Skófde (Svezia).<br />
10. Clerici Ing. Carlo — Milano.<br />
11. Crespellani Cav. Avv. Arsenio — Modena.<br />
12. Cumont Georges — Bruxelles.<br />
13. De' Ciccio Mario — Palermo.<br />
14. Dell'Acqua Dott. Girolamo — Pavia.<br />
15. Di Palma Prof. Francesco — Sant'Elia a Pianisi.
ELENCO DEI MEMBRI DELLA SOCIETÀ, ECC. 553<br />
16. Foa Alessandro — Torino.<br />
17. Car<strong>di</strong>ni Prof. Cal<strong>di</strong>no — Ferrara.<br />
18. Ceigy Dott. Alfredo — Basilea.<br />
19. Hess Adolfo — Francoforte s. M.<br />
20. Lamberti Policarpo — Savona.<br />
21. Lambros C. Paolo — Atene.<br />
22. Lanzoni Ciuseppe — Mantova.<br />
23. Leone Cav. Camillo — Vercelli.<br />
24. *|-Mantegazza Avv. Cav. Carlo — Voghera.<br />
25. Mantovani Dott. Ciuseppe — Pavia.<br />
26. Mariani Prof. Cav. Mariano — Pavia.<br />
27. Morchio Cav. Ciuseppe — Venezia.<br />
28. *Morsolin abate Prof. Bernardo — Vicenza.<br />
29. Nuvolari Francesco — Castel d'Ario.<br />
30. Oettinger Prof. S. — Nuova York.<br />
31. Osio Magg. Cen. Comm. Egi<strong>di</strong>o — U<strong>di</strong>ne.<br />
32. Paulucci Panciatichi Marchesa M.°' — Firenze.<br />
33. Perini Quintilio — Rovereto.<br />
34. Pischedda Avv. Elìsio — Oristano.<br />
35. Righi Ing. Cirillo — Bologna.<br />
36. Rocca Cia<strong>com</strong>o — Taranto.<br />
37. *Romussi Dott. Carlo — Milano.<br />
38. *Santoni Can. Prof. Milziade — Camerino.<br />
39. Savo Doimo — Spalato.<br />
40. Schott Ettore — Trieste.<br />
41. Serrure Raymond — Parigi.<br />
42. Società Svizzera <strong>di</strong> Numismatica — Ginevra.<br />
43. Spigar<strong>di</strong> Arturo — Firenze.<br />
44. Spink Samuele — Londra.<br />
45.*fStefani Comm. Federico — Venezia.<br />
46. Stroehlin Paolo — Ginevra.<br />
47. Valton Prospero — Parigi.<br />
48. Varelli Giovanni — Napoli.<br />
49. Vigano Gaetano — Desio.<br />
50. Vitalini Cav. Ortensio — Roma.<br />
51. Witte (De) Cav. Alfonso — Bruxelles.<br />
52. Zitelli Pietro — Scio.<br />
70
554 ELÈNCO t)EI MEMBRI DELLA SOCIETÀ, ECC.<br />
BENEMERITI DELLA SOCIETÀ.<br />
S. A. R. Il Principe <strong>di</strong> Napoli.<br />
Ambrosoli Dott. Cav, Solone.<br />
Cuttica de Cassine Marchesa Maura.<br />
Dattari Giovanni.<br />
Gnecchi Cav. uff. Ercole.<br />
Gnecchi Cav. uff. Francesco.<br />
-|- Gnecchi Comm. Ing, Giuseppe.<br />
Johnson Cav. Federico.<br />
Luppi Prof. Cav. Costantino.<br />
Osnago Enrico.<br />
Padoa Cav. Vittorio.<br />
Papadopoli Conte Comm. Nicolò.<br />
ASSOCIATI ALLA RIVISTA.<br />
American Journal of Archeology — Nuova York.<br />
American Journal of Numismatics. — Boston.<br />
Annales de la Société d'Archeologie. — Bruxelles.<br />
Annuaire de Numismatique. — Parigi.<br />
Archivio della Società romana <strong>di</strong> storia patria. — Roma.<br />
Archivio storico italiano. — Firenze.<br />
Archivio storico Lombardo. — Milano.<br />
Archivio storico Napoletano. — Napoli.<br />
Archivio Veneto. — Venezia.<br />
Bagatti Valsecchi nob. cav. Fausto. — Milano.<br />
Bahrfeldt Max. — Breslavia.<br />
Bari. — Maseo Provinciale.<br />
Bartoli Avveduti avv, Giulio. — Roma.<br />
Bartolini cav. Luigi — Trevi.<br />
Beltrami architetto <strong>com</strong>m. Luca. — Milano.<br />
Bignarai cav. Giulio. — Roma.<br />
Bocca Fratelli. — Torino (copie 2).<br />
Bollettino <strong>di</strong> Archeologia e Storia. — Spalato.
ELENCO DEI MEMBRI DELLA SOCIETÀ, ECC. 555<br />
Bologna. — Biblioteca Municipale.<br />
Bosso Dott, Giuseppe. — Crescentino.<br />
Briganti cav. Bellino. — Ostino.<br />
Brockhaus F. A. — Lipsia (copie 2).<br />
Cagliari. — Regio Museo <strong>di</strong> Antichità.<br />
Camozzi Verteva conte <strong>com</strong>m. G. B. — Bergamo.<br />
Camuccini barone G. A. — Roma.<br />
Capobianchi cav. prof. Vincenzo. — Roma.<br />
Carpinoni Michele. — Brescia.<br />
Casanova Francesco. — Torino.<br />
Ceppaglia cap. cav. Federico. — Perugia.<br />
Cerrato Giacinto. — Torino.<br />
Cini avv. Tito. — Montevarchi.<br />
Clausen Carlo. — Torino (copie 8).<br />
Como. — Biblioteca Comunale.<br />
n — Museo Civico.<br />
Da Celleno P. Gius. Giacinto. — Damanhur (Egitto).<br />
Dutilh G. D. J. — Cairo.<br />
Engel Dott. Arturo. — Parigi.<br />
Firenze. — Biblioteca Marucelliana.<br />
Fermenti Giuseppe. — Milano.<br />
Furchheim Federico. — Napoli.<br />
Gaggino S. e C. — Singapore.<br />
Garovaglio cav. dott. Alfonso. — Milano.<br />
Genova. — Biblioteca Civica.<br />
Hamburger L. e L. — Francoforte sul Meno.<br />
Hierseman Cari. — Lipsia (copie 3).<br />
Hoepli <strong>com</strong>m. Ulrico. — Milano.<br />
Knight Carlo. — Napoli.<br />
Loescher Ermanno. — Roma.<br />
Lussemburgo. — Istituto Gran Ducale.<br />
Mantova. — Biblioteca Comunale.<br />
Marignoli marchese <strong>com</strong>m. Filippo. — Roma.<br />
Marsiglia. — Biblioteca Civica.<br />
Milano. — Municipio.<br />
» — R. Gabinetto Numismatico <strong>di</strong> Brera.<br />
w — Biblioteca Ambrosiana.<br />
n — Circolo Alessandro Manzoni.<br />
Modena. R. Biblioteca Estense,<br />
Napoli. — R. Musei <strong>di</strong> Antichità.<br />
Numismatic Chronicle. — Londra.<br />
Numismatische Zeitschrift. — Vienna.<br />
Nutt Davide. — Londra (copie 2).
556 ELENCO DEI MEMBRI DELLA SOCIETÀ, ECC.<br />
Osnago Enrico. — Milano.<br />
Parazzoli Antonio. — Cairo.<br />
Parma. — R. Museo <strong>di</strong> Anticiiità.<br />
Pavia. — Biblioteca Civica Bonetta.<br />
Peelman Giulio e C. — Parigi.<br />
Pesaro. — Biblioteca Oliveriana.<br />
Piacenza. — Biblioteca Passerini-Lan<strong>di</strong>.<br />
Reggio Calabria — Museo Civico.<br />
Revue francaise de Numismatique. — Parigi.<br />
Rivani Giuseppe. — Ferrara.<br />
Rizzini dott, cav. Prospero. — Brescia.<br />
Roma. — R. Accademia dei Lincei.<br />
" — Direzione della R. Zecca.<br />
n — Biblioteca della Camera dei Deputati.<br />
Sangiorgi G. — Roma.<br />
Scarpa dott. Ettore. — Treviso.<br />
Schoor (van) Carlo. — Bruxelles.<br />
Sertnian E. J, — Londra.<br />
Smithsonian Institution. — Washington.<br />
Società Neerlandese <strong>di</strong> Numismatica. — AmsterJain.<br />
Société R. de Numismatique. — Bruxelles.<br />
Stettiner cav. Pietro. — Roma.<br />
Tolstoy conte Giovanni. — Pietroburgo.<br />
Torino. — R. Biblioteca Nazionale.<br />
» — R. Museo <strong>di</strong> Antichità.<br />
Torrequadra conte Rogadeo. — Bitonto.<br />
Trento. — Biblioteca Comunale.<br />
TrUbner K. J. — Strasburgo.<br />
Varese. — Museo Patrio.<br />
Van Trigt G. A. — Bruxelles.<br />
Varisco sac. Achille. — Monza.<br />
Venezia. — Ateneo Veneto.<br />
» — R. Biblioteca Marciana.<br />
" — Museo Civico.<br />
" — Ufficio regionale per la conservazione dei monumenti.<br />
Verona. — Biblioteca Comunale.<br />
Vienna. — Gabinetto Num. <strong>di</strong> Antichità della Casa Imperiale.<br />
Virzì Ignazio. — Palermo.<br />
Volterra. — Museo e Biblioteca Guarnacci.<br />
Zeitschrift fiir Numismatik. — Berlino.
INDICE METODICO<br />
DELL'ANNO 1897<br />
NUMISMATICA ANTICA.<br />
(Memorie e Dissertazioni).<br />
Appunti <strong>di</strong> Numismatica romana. Francesco Gnecchi:<br />
XLI. Gli ultimi dupon<strong>di</strong>i e le prime monete <strong>di</strong> bronzo<br />
degli Imper. Diocleziano e Massimiano Erculeo (fig.) Pag. n<br />
XLII. Bronzo ine<strong>di</strong>to <strong>di</strong> Massimiano Erculeo (fig.). . » 17<br />
XLIII. Un ripostiglio miserabile. . . . . . » 19<br />
XLIV. Sulle Restituzioni (con tav.) . . . . . »> 123<br />
Contributi alla storia del ripostiglio consolare <strong>di</strong> Palazzo<br />
Canavese. Serafino Ricci »» 179<br />
La cronologia delle monete <strong>di</strong> Nerone (con 5 tav.). Ettore<br />
Cabrici . . » 275<br />
De l'utilité scientifique des collections de monnaies an-<br />
ciennes. Ernest Babelon . . . . . . » 383<br />
(Varietà).<br />
Concorso Gnecchi <strong>di</strong> Numismatica classica . . . Pag. 259<br />
Il Corpus numorum italicorum » 536<br />
Il ripostiglio <strong>di</strong> San Martino del Pizzolano. Solone Am-<br />
brosoli » 507<br />
NUMISMATICA MEDIOEVALE E MODERNA.<br />
(Memorie e Dissertazioni).<br />
Appunti <strong>di</strong> Numismatica <strong>italiana</strong>. Ercole Gnecchi:<br />
XVI. Il ripostiglio <strong>di</strong> Cavriana (fig.) P(ig. 23<br />
Mirandola. Monete ine<strong>di</strong>te o corrette (fig.). Giorgio Ciani » 33
558 INDICE METODICO DELL'aNNO 1897<br />
Ducatene ine<strong>di</strong>to <strong>di</strong> Alberico I Cibo, Principe <strong>di</strong> Massa<br />
(fìg.). O. Vitalini Pag- 47<br />
Sull'erronea attribuzione al Francia delle monete gettate<br />
al popolo nel solenne ingresso in Bologna <strong>di</strong> Giulio II<br />
per la cacciata <strong>di</strong> Gio. II Benti voglio (con tav.). Luigi<br />
Frati .......... w<br />
49<br />
Un nuovo grosso ine<strong>di</strong>to <strong>di</strong> Gio. Antonio Falletti, Conte<br />
<strong>di</strong> Benevello (fig.). O. Vitalini "63<br />
Miscellanea Numismatica (con tav.). Carlo Kunz . . » 71<br />
Illustrazione <strong>di</strong> una moneta <strong>di</strong> Fabriano (fig.). Carlo Kunz. » loi<br />
Ancora <strong>di</strong> una moneta <strong>di</strong> Fabriano (fig.). Carlo Kunz . •» 105<br />
Lo zecchino <strong>di</strong> Porcia (fig.). Solone Ambrosoli . . n 159<br />
Il privilegio <strong>di</strong> zecca accordato dall' imperatore Massimi-<br />
liano II a Ferrante Gonzaga, I Marchese <strong>di</strong> Castiglione<br />
delle Stiviere. A. Agostini » 175<br />
Il Museo Bottacin annesso alla civica biblioteca e museo<br />
<strong>di</strong> Padova (con tav.). Carlo Kunz .... » 199<br />
Nuovo contributo alla Numismatica Padovana (con tav.).<br />
Luigi Rizzoli "351<br />
La Zecca <strong>di</strong> Bologna. Francesco Malaguzzi ...» 427<br />
Un ripostiglio <strong>di</strong> monete del secolo XIII a Vigo <strong>di</strong> Cave-<br />
<strong>di</strong>ne. Giorgio Ciani >» 487<br />
Annotazioni numismatiche italiane. Giuseppe Ruggero:<br />
III. Dezana — Modena od Urbino — Correggio . . »> 497<br />
Il ripostiglio <strong>di</strong> Chignolo Po " 539<br />
(Varietà).<br />
Ven<strong>di</strong>ta della Collezione Sambon Pc^g- 109<br />
Ven<strong>di</strong>ta Sambon » 261<br />
Le riviste<br />
BIBLIOGRAFIA.<br />
numismatiche francesi (F. G.) .... Pag. 233<br />
Bahrfeldt M., Nachtrage und Berichtigungen zur Miinzkunde<br />
der Ròmischen Republik im Anschluss an<br />
Babelon's Verzeichmiss der Consular-Munzen (F. G.) » 236<br />
Misios P. A., 2T0tj(^eia tvì? 'A^j^xixq No{;.icry.aTt)c?i; xtoi<br />
Fevixà npo>,ìY(5{xeva 'rii; NofXKjjxaxoXoY^ai; toO 'ExxeXiou.<br />
MeràfppafTì? (S. A.) » 239
INDICE METODICO DELl'aNNO 1897 559<br />
Vasconcellos (J. Lette de), Elencho das Li^óes de Numisma-<br />
tica dadas na Bibliotheca Nacional de Lisboa (S. A.) Pag. 239<br />
Brandt F. H., Erster Medailleur an der kóniglichen<br />
Miinze und Professor der Gewerbe-Academie zu<br />
Berlin (S. A.) . . ...<br />
.<br />
. . » 241<br />
Forster A. imd Schmid R., Die Munzen der freien<br />
Reichsstadt Augsburg {S-. A.) . , . . . » 242<br />
Mowat R., Combinaisons sècretes des lettres dans les<br />
marques monétaires de l'empire romain (F. G.) . " 413<br />
Babelon Ernest, Les Origines de la Monnaie considerées<br />
au point de vue économique et historique (F. G.) . n 418<br />
Meili J., Das Brasilianische Geldwesen. Ziirich, 1897 . » 513<br />
Pubblicazioni <strong>di</strong>verse Pag. 243, 514<br />
(Perio<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> Numismatica).<br />
Revue Num. fran9aise, pag. 245, 516.<br />
Gazette Num. fran^aise, pag. 247, 517.<br />
BuUetin de Numismatique, pag. 248, 519.<br />
Revue suisse de Num., pag. 249, 520.<br />
Revue belge de Num., pag. 250, 520.<br />
Circulaire Num. universelle, pag. 250.<br />
Tijdschrift van het Nederlandsch Genootschap, pag. 251, 523.<br />
Zeitschrift fiir Numismatik, pag. 251.<br />
Numismatische Zeitschrift, pag. 252.<br />
Monatsblatt der Num. Gesellschaft in Wien, pag. 252, 524.<br />
Numismatic Chronicle, pag. 253, 524.<br />
Monthly Numismatic Circular, pag. 254.<br />
American Journal of Numismatics, pag. 255.<br />
Gazette Numismatique (Bruxelles), pag. 521.<br />
Articoli <strong>di</strong> Numismatica in Perio<strong>di</strong>ci <strong>di</strong>versi, pag. 255, 526.<br />
NECROLOGIE<br />
Hoffmann H. (F. G.) Pag. 231<br />
MISCELLÀNEA<br />
Premio <strong>di</strong> Numismatica . . . ... . Pag. 260<br />
Medaglia pontificia <strong>com</strong>memorativa . . . . . » 260<br />
Dell'utilità scientifica delle collezioni <strong>di</strong> monete antiche . » 261<br />
Numismatica e Medaglistica {Francesco Gnecchi) . . » 401
560 INDICE METODICO DELl'aNNO 1897<br />
Furto al Gabinetto numismatico <strong>di</strong> Losanna<br />
Furto al Gabinetto numismatico <strong>di</strong> Nìmes<br />
Inaugurazione della nuova Sede della Società Numisma<br />
tica Italiana nel Castello <strong>di</strong> Milano<br />
Il Principe <strong>di</strong> Napoli a Brera .<br />
Dono al Gabinetto Numismatico <strong>di</strong> Milano<br />
Concorso Grazioli ....<br />
Per l'Esposizione Universale del 1900<br />
Viaggio scientifico ....<br />
Corsi <strong>di</strong> Numismatica<br />
Una <strong>di</strong>mostrazione a Giorgio Cumont<br />
Ambrosiana .....<br />
Collaboratori della <strong>Rivista</strong> nell'anno 1897<br />
Elenco dei Membri della Società Numismatica Italiana<br />
e degli Associati alla <strong>Rivista</strong> pel 1897<br />
Pag
TAVOLE
CJ<br />
9<br />
R6<br />
v.lO<br />
<strong>Rivista</strong> <strong>italiana</strong> <strong>di</strong> <strong>numismatica</strong><br />
e <strong>scienze</strong> <strong>affini</strong><br />
PLEASE DO NOT REMOVE<br />
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET<br />
UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY