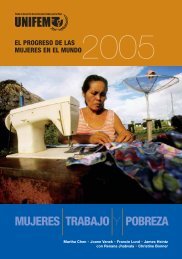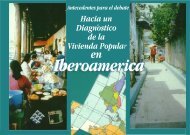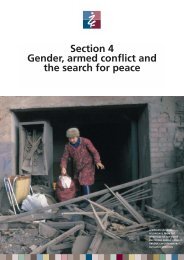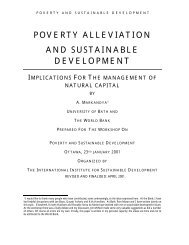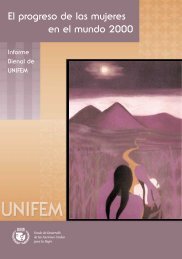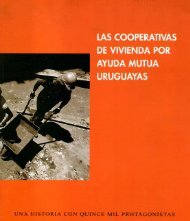Principi, culture e pratiche di giustizia sociale Ota de ... - HDRNet
Principi, culture e pratiche di giustizia sociale Ota de ... - HDRNet
Principi, culture e pratiche di giustizia sociale Ota de ... - HDRNet
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Principi</strong>, <strong>culture</strong> e <strong>pratiche</strong> <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong> <strong>sociale</strong><br />
<strong>Ota</strong> <strong>de</strong> Leonar<strong>di</strong>s<br />
Il mondo <strong>de</strong>l welfare è per intero – dai principi normativi fissati in leggi fino alle più minute<br />
<strong>pratiche</strong> quoti<strong>di</strong>ane nei servizi – un territorio ad alta <strong>de</strong>nsità normativa, costituito com’è <strong>di</strong> regole,<br />
precetti, valori, norme; <strong>di</strong> classificazioni, certificazioni, e valutazioni; <strong>di</strong> istituzioni, <strong>di</strong> scelte ed<br />
azioni in materia <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong> <strong>sociale</strong>. I sistemi <strong>di</strong> welfare, infatti, si occupano <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong> <strong>sociale</strong>.<br />
Del resto, basta per richiamalo ricordare la storia <strong>de</strong>llo sviluppo <strong>de</strong>l welfare state, che è storia <strong>di</strong><br />
conflitti e <strong>di</strong> compromessi su questioni <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong>, cioè su questioni <strong>di</strong> scelta pubblica su quale<br />
società consi<strong>de</strong>riamo migliore. Oggi, tuttavia, nelle elaborazioni che accompagnano le<br />
trasformazioni <strong>de</strong>l welfare le questioni <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong> tendono a restare in ombra, implicite. Si lavora<br />
per lo più su altri temi, e con vocabolari <strong>di</strong>versi da quelli nei quali si tematizzano queste questioni.<br />
Si ragiona con il vocabolario <strong>de</strong>l rapporto tra costi e benefici, o con quello <strong>de</strong>ll’efficacia, per<br />
esempio lavorando sulla coerenza tra domanda e offerta <strong>di</strong> servizi; si parla <strong>di</strong> bisogni, poco –quasi<br />
nulla – si <strong>di</strong>ce a proposito <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti. L’equità, spesso richiamata (per esempio l’equità<br />
intergenerazionale) è riconoscibile come un principio <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong>, ma esso resta come tale soltanto<br />
evocato e poco tematizzato nelle sue implicazioni problematiche, come vedremo.<br />
Scopo <strong>di</strong> questo scritto è ren<strong>de</strong>re invece esplicite le questioni <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong> che sono in gioco nelle<br />
trasformazioni in corso, invitare ad adottare un certo sguardo per poterle mettere sotto osservazione<br />
e perché entrino nel <strong>di</strong>scorso, sia scientifico che <strong>di</strong> policy, sul welfare. Ritengo infatti che i sistemi<br />
<strong>di</strong> welfare, comunque <strong>di</strong>segnati e praticati, esercitino un’influenza enorme sugli assetti <strong>di</strong> base <strong>de</strong>lla<br />
società che abitiamo. Quella <strong>de</strong>nsità normativa <strong>de</strong>l welfare più sopra evocata sprigiona una forza<br />
generativa da cui quegli assetti <strong>di</strong> base prendono forma e caratteri <strong>di</strong> necessità, <strong>di</strong> vincolo, o <strong>di</strong><br />
mondo comune riconosciuto e con<strong>di</strong>viso: è la forza <strong>de</strong>l legame <strong>sociale</strong>. E’ dunque meglio, quando si<br />
tratti <strong>di</strong> welfare, sapere ciò che si sta facendo (per ripren<strong>de</strong>re un vecchio adagio, tornato in auge nei<br />
<strong>di</strong>scorsi sull’appren<strong>di</strong>mento collettivo e la riflessività); ciò che si sta facendo, in particolare, in<br />
materia <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong> <strong>sociale</strong>.
Beni comuni, tra cui gli spazi pubblici.<br />
Parlando <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong> <strong>sociale</strong>, bisogna per prima cosa richiamare alla memoria il welfare state, che<br />
cosa ha significato in quella che per una volta mi permetto <strong>di</strong> chiamare, durkheimianamente, la<br />
coscienza collettiva: ha significato la possibilità, la sfida, <strong>di</strong> costruire una “società migliore”. Da<br />
costruire, beninteso, non da lasciare <strong>de</strong>rivare da altri progetti, il mercato e l’intrapresa privata, come<br />
sottoprodotti virtuosi. Il parametro principale su cui valutare è quello <strong>de</strong>ll’eguaglianza : esso misura<br />
<strong>di</strong>suguaglianze. Il welfare state tratta, per ridurle, <strong>di</strong>suguaglianze. Anzitutto la <strong>di</strong>suguaglianza <strong>di</strong> cui<br />
soffre la con<strong>di</strong>zione lavorativa, che non riguarda scale <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to e <strong>di</strong>sparità <strong>di</strong>stributive, bensì<br />
riguarda il potere <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre <strong>de</strong>lla ricchezza <strong>sociale</strong> che questa con<strong>di</strong>zione genera. Le<br />
<strong>di</strong>suguaglianze hanno la loro matrice nello sfruttamento, nella contrad<strong>di</strong>zione tra produzione <strong>sociale</strong><br />
<strong>di</strong> ricchezza e appropriazione privata, quella centrale in Marx (v. Boltanski, Chiappello, 1999, 6°<br />
cap.). Il welfare state si sviluppa da quest’alveo, che è l’alveo in fondo <strong>de</strong>lla gran<strong>de</strong> stagione<br />
social<strong>de</strong>mocratica, con l’i<strong>de</strong>a forza <strong>di</strong> una socializzazione <strong>de</strong>lla ricchezza socialmente prodotta, <strong>di</strong><br />
una sua trasformazione in beni comuni, almeno quanto basta perché una società possa governare i<br />
mo<strong>di</strong> in cui si riproduce 1 . Di quest’alveo –l’alveo <strong>de</strong>l movimento operaio - ci sono tracce vistose<br />
nell’egemonia <strong>de</strong>l riferimento al lavoro e ai lavoratori (il cosid<strong>de</strong>tto stampo lavoristico <strong>de</strong>l welfare)<br />
con tutti i suoi limiti, ma anche con l’ancoraggio ai <strong>di</strong>ritti fondati su conquiste. Il vocabolario <strong>de</strong>i<br />
<strong>di</strong>ritti ha un peso importante nella tematizzazione <strong>de</strong>gli obiettivi <strong>de</strong>lle politiche sociali da costruire e<br />
da implementare. Il principio <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong> che fa da parametro obbligato è quello <strong>de</strong>lla<br />
re<strong>di</strong>stribuzione. Ma re<strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> che cosa? Certo, <strong>di</strong> beni. Certo si tratta <strong>di</strong> ri<strong>di</strong>stribuire beni<br />
per compensare i costi sociali subiti dalla partecipazione attiva alla produzione <strong>de</strong>l benessere,<br />
compensazione per lo sfruttamento appunto. Ma si tratta anche <strong>di</strong> ri<strong>di</strong>stribuire poteri <strong>di</strong> scelta e <strong>di</strong><br />
azione circa la <strong>de</strong>stinazione <strong>de</strong>i beni in questione. Non si può negare che lo sviluppo <strong>de</strong>l welfare<br />
state abbia aperto spazi <strong>di</strong> rafforzamento e allargamento <strong>de</strong>lla <strong>de</strong>mocrazia, e che si sia intrecciato<br />
con le vicen<strong>de</strong> <strong>di</strong> quest’ultima, configurandosi nei <strong>di</strong>scorsi come uno spazio <strong>di</strong> costruzione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti<br />
(i ben noti <strong>di</strong>ritti sociali). In coerenza con quell’alveo originario, nel quale la questione era come<br />
ren<strong>de</strong>re <strong>sociale</strong>, con<strong>di</strong>visa collettivamente, l’opera <strong>di</strong> riproduzione <strong>de</strong>lla società stessa, lo sviluppo<br />
<strong>de</strong>l welfare state è consistito nella creazione <strong>di</strong> materie e <strong>di</strong> spazi <strong>di</strong> <strong>di</strong>scussione circa le scelte e le<br />
azioni sulle con<strong>di</strong>zioni che riproducono la società (v. Montebugnoli, in questo volume). Un’opera<br />
1 Castel parla in proposito <strong>di</strong> “proprietà <strong>sociale</strong>”, riferendosi al fatto che proprio la socializzazione <strong>di</strong> alcuni beni operata<br />
dal welfare ha consentito il pieno <strong>di</strong>spiegarsi <strong>de</strong>ll’in<strong>di</strong>vidualità: per <strong>di</strong>fferenza rispetto alla ten<strong>de</strong>nza attuale nella quale<br />
2
eminentemente politica, che agisce appunto sul terreno <strong>de</strong>lle scelte collettive, su problemi e su beni<br />
comuni.<br />
Se si rileggono i classici <strong>de</strong>lla teoria fondativa <strong>de</strong>l welfare –tipicamente Titmuss e Marshall – si<br />
ve<strong>de</strong> bene che questo era il tenore <strong>de</strong>lle questioni in gioco. Politiche e servizi costruiti nel welfare<br />
state <strong>di</strong>stribuivano risorse ai singoli (beni o prestazioni) non in ragione <strong>de</strong>i loro bisogni ma in<br />
quanto titolari <strong>de</strong>l <strong>di</strong>ritto, universalistico, <strong>di</strong> fruire <strong>di</strong> alcune con<strong>di</strong>zioni comuni <strong>di</strong> riproduzione<br />
<strong>sociale</strong>. Diritti <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>nanza. Cure sanitarie, scolarizzazione, sicurezze da rischi <strong>de</strong>lla vita: sono<br />
tematizzati come beni sociali, non <strong>de</strong>i singoli, ma <strong>di</strong> collettività: beni comuni. Come tali oggetto <strong>di</strong><br />
messa a tema, <strong>di</strong> elaborazioni contrastanti e <strong>di</strong>scussioni, e <strong>di</strong> <strong>de</strong>liberazioni pubbliche. E’ la loro<br />
natura <strong>di</strong> beni comuni, non la posizione <strong>de</strong>i <strong>de</strong>stinatari, che ne giustifica l’erogazione.<br />
Questo, in <strong>de</strong>finitiva, mi pare importante ricordare, <strong>de</strong>lla storia <strong>de</strong>l welfare state. Essa è una storia <strong>di</strong><br />
conflitti e <strong>di</strong> cambiamenti sociali e istituzionali che hanno messo a tema questioni <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong><br />
(<strong>sociale</strong>: ma è pleonastico) e che hanno creato spazi per <strong>di</strong>scutere e <strong>de</strong>liberare pubblicamente su<br />
queste questioni. Questioni <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong> applicate ai processi <strong>di</strong> riproduzione <strong>de</strong>lla società, e alla<br />
<strong>de</strong>stinazione <strong>di</strong> ricchezza per questa riproduzione.<br />
Questioni <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong> nei welfare mix.<br />
Questo promemoria relativo al welfare state e al principale terreno <strong>de</strong>l suo sviluppo non è<br />
finalizzato ad aprire un ragionamento sulla sua storia, le sue evoluzioni e la sua crisi, ma serve qui<br />
soltanto a richiamare le premesse per riflettere sui principi <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong> implicati nelle attuali<br />
trasformazioni <strong>de</strong>l welfare, nelle configurazioni che oggi assumono le politiche e le <strong>pratiche</strong> nelle<br />
materie sociali. E per domandarsi se in quest’ambito, e come, si creano spazi e mo<strong>di</strong> per metterli a<br />
tema, <strong>di</strong>scutere e <strong>de</strong>liberare.<br />
Come sappiamo sulla spinta <strong>de</strong>lle i<strong>de</strong>ologie neoliberiste che hanno messo in <strong>di</strong>scussione<br />
l’impalcatura storica <strong>de</strong>i welfare state in tutti i paesi occi<strong>de</strong>ntali, e che hanno introdotto misure <strong>di</strong><br />
privatizzazione, i sistemi <strong>di</strong> welfare si sono andati orientando verso arrangiamenti istituzionali che<br />
in vario modo combinano pubblico e privato. Più precisamente, la formula che si generalizza, in<br />
particolare in Europa, è quella <strong>de</strong>i cosid<strong>de</strong>tti welfare mix, cioè una combinazione variabile <strong>di</strong><br />
intervento pubblico, mercato e solidarietà <strong>sociale</strong> che va a costituire “regimi <strong>di</strong> welfare”. Non mi<br />
proprio dalla <strong>de</strong>privazione <strong>sociale</strong>, dalla per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> proprietà sociali, pren<strong>de</strong> forma “l’in<strong>di</strong>viduo per <strong>di</strong>fetto” (Castel,<br />
3
soffermo ad analizzare questa formula (v. <strong>de</strong> Leonar<strong>di</strong>s, 1998), mi limito ad evi<strong>de</strong>nziarne i due più<br />
importanti elementi <strong>di</strong> novità: la fine <strong>de</strong>l monopolio <strong>de</strong>ll’autorità pubblica, che <strong>de</strong>lega una parte<br />
significativa <strong>de</strong>lle proprie competenze ad altre organizzazioni non pubbliche, ad attori economici,<br />
associazioni <strong>de</strong>lla società civile, volontariato o beneficenza privata; e la centralità complementare<br />
che vi assumono questi altri attori, in <strong>de</strong>finitiva il terzo settore, con gli argomenti <strong>de</strong>lla restituzione<br />
alla società civile <strong>di</strong> capacità e responsabilità <strong>di</strong> auto-organizzazione.<br />
Già solo la fine <strong>de</strong>l monopolio <strong>de</strong>ll’autorità pubblica sul trattamento <strong>di</strong> materie, problemi e beni<br />
collettivi, apre il genere <strong>di</strong> quesiti che <strong>di</strong>cevamo, cioè se e come altrimenti queste vengono trattate<br />
come questioni pubbliche, come tali implicanti scelte <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong>. Nelle politiche e nelle <strong>pratiche</strong><br />
che variamente combinano i tre settori nel campo <strong>de</strong>l welfare, queste ultime non sono tematizzate<br />
come tali. O almeno non è in questi termini che se ne parla. In questo campo tendono a prevalere<br />
argomenti e vocabolari che riguardano altre questioni e portano altre argomentazioni, ad esempio <strong>di</strong><br />
natura morale o economica.<br />
Certo, la costruzione <strong>di</strong> questa formula si accompagna a un <strong>di</strong>scorso carico <strong>di</strong> impliciti normativi, <strong>di</strong><br />
ricette, <strong>di</strong> valori portati come ban<strong>di</strong>ere, <strong>di</strong> valutazioni e <strong>di</strong> giustificazioni 2 , che tuttavia non<br />
sembrano dar luogo a <strong>di</strong>scussioni ed elaborazioni in materia <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong>, e che soprattutto non<br />
s’interrogano granché su chi abbia titolo a parlarne e in quali se<strong>di</strong>. Certo, le questioni <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong>,<br />
compresa quest’ultima, hanno una gran<strong>de</strong> fioritura in se<strong>de</strong> filosofica, nelle teorie <strong>de</strong>lla <strong>giustizia</strong> –<br />
<strong>di</strong>ciamo a partire da e intorno a Rawls- e tuttavia ciò che si <strong>di</strong>batte in questa se<strong>de</strong> non sembra avere<br />
rapporti con ciò che formicola nel campo <strong>de</strong>l welfare. Sembrano mancare spazi nei quali entrino in<br />
rapporto quesiti <strong>de</strong>l tipo “che cos’è una società giusta?” con quesiti <strong>de</strong>l tipo “come <strong>de</strong>ve funzionare<br />
un dato servizio <strong>sociale</strong>?”. Ho l’impressione per esempio che, almeno in Italia, sia venuta meno la<br />
messa in connessione che tra questi livelli <strong>di</strong> <strong>di</strong>scorso riuscivano a fare i movimenti sociali <strong>di</strong><br />
protesta 3 , e che il ri<strong>di</strong>mensionamento <strong>de</strong>l peso <strong>de</strong>ll’autorità pubblica ne abbia anche in<strong>de</strong>bolito la<br />
funzione pubblica <strong>di</strong> ren<strong>de</strong>re visibili e argomentabili i nessi tra principi e <strong>pratiche</strong> <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong>.<br />
Sembra insomma che si siano ridotti gli spazi <strong>de</strong>lla politica, l’opera <strong>di</strong> traduzione nei due sensi <strong>di</strong><br />
particolare e generale.<br />
Haroche, 2001).<br />
2 La nozione <strong>di</strong> “giustificazione”, e l’approccio analitico che da essa si sviluppa –e che richiamerò spesso nella mia<br />
argomentazione - si <strong>de</strong>vono a Boltanski e Thévenot (1991).<br />
3 Il movimento femminista e quello per il riconoscimento <strong>de</strong>llo statuto pieno <strong>di</strong> persona ai malati<br />
mentali, con la relativa dotazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti fondamentali, sono quelli <strong>di</strong> cui ho potuto riconoscere<br />
questa funzione, e sono quelli dai quali io traggo le argomentazioni che sto sviluppando.<br />
4
Malgrado questo, o forse per questo, bisogna esplorare connessioni implicite e metterle a tema. La<br />
stesso tenore retorico <strong>de</strong>lle argomentazioni, che ho avuto modo <strong>di</strong> segnalare altrove, dovrebbe<br />
mettere sull’avviso: nei valori sban<strong>di</strong>erati è all’opera una sorta <strong>di</strong> marketing morale, carico <strong>di</strong><br />
normatività (e nelle ricette tecniche si annidano scelte politiche, scelte <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong>, come vedremo).<br />
Lavorerò perciò sulle retoriche, e in particolare su alcune nozioni ricorrenti che tendono ad essere<br />
enunciate e utilizzate come parole d’or<strong>di</strong>ne: per farne emergere gli impliciti normativi, le questioni<br />
<strong>di</strong> <strong>giustizia</strong> che incorporano e <strong>di</strong> cui sarebbe bene <strong>di</strong>scutere.<br />
<strong>Principi</strong> controversi<br />
Precisiamo però ancora un poco il campo <strong>di</strong> analisi. La mia attenzione è limitata alle configurazioni<br />
che i sistemi <strong>di</strong> welfare hanno assunto in Europa, in particolare attraverso le politiche sociali<br />
europee. Sussi<strong>di</strong>arietà, solidarietà, coesione <strong>sociale</strong>, attivazione: queste parole d’or<strong>di</strong>ne sono<br />
ricavate dal vocabolario europeo –quello <strong>de</strong>i programmi europei nelle materie sociali- ma ne<br />
esaminerò i mo<strong>di</strong> in cui entrano in circolo nelle misure e nelle <strong>pratiche</strong>. Malgrado l’apparente<br />
consenso che suscitano, ciascuna <strong>di</strong> esse rinvia a principi <strong>di</strong>versi <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong> ed è perciò un<br />
potenziale terreno <strong>di</strong> controversie. Esaminerò brevemente le prime tre parole d’or<strong>di</strong>ne –senza<br />
illustrarle e senza portare documentazione - per soffermarmi <strong>di</strong> più sull’ultima, la più nuova.<br />
La nozione <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà è stata una <strong>de</strong>lle prime ad acquisire il sapore imperativo <strong>di</strong> una ricetta<br />
nelle <strong>di</strong>scussioni sulla crisi e sulla ristrutturazione <strong>de</strong>l welfare. Come spiega Montebugnoli (v. in<br />
questo volume) in Italia essa ha origine dal vocabolario cattolico che serve ad esprimere il sospetto<br />
<strong>de</strong>ll’ingerenza <strong>de</strong>llo Stato in materie che pertengono alla morale, alla coscienza, ai doveri, e alle<br />
prove <strong>de</strong>lla vita con cui si misura il buon cristiano. Il principio <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà suona dunque in<br />
questo caso così: nelle questioni che la famiglia, e per estensione la società civile, sono in grado <strong>di</strong><br />
gestirsi da sé lo Stato non <strong>de</strong>ve interferire; lo Stato intervenga soltanto a supporto, in forma appunto<br />
sussi<strong>di</strong>aria. Ma il principio <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà lo troviamo <strong>de</strong>clinato anche in altro modo e con un<br />
<strong>di</strong>verso vocabolario. In particolare nei proclami e nei programmi <strong>de</strong>lla costruzione <strong>sociale</strong> e politica<br />
<strong>de</strong>ll’europa: qui si parla <strong>di</strong> relazioni <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà tra istituzioni, tra livelli <strong>di</strong> governo. Il livello<br />
superiore –per esempio il governo regionale rispetto a quello locale – interviene solo dove e per<br />
quanto l’inferiore non basta a se stesso. Si intuisce facilmente che tra questi due significati<br />
<strong>de</strong>ll’imperativo <strong>de</strong>lla sussi<strong>di</strong>arietà, per quanto per certi versi contigui e nelle argomentazioni<br />
mescolati, passa una <strong>di</strong>fferenza importante in fatto <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong>. Nel suo primo significato la nozione<br />
5
<strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà sottinten<strong>de</strong> una <strong>di</strong>slocazione <strong>de</strong>i problemi e <strong>de</strong>lle azioni per affrontarli (siano essi <strong>di</strong><br />
salute, <strong>di</strong> educazione, <strong>di</strong> assistenza, eccetera) nella sfera privata <strong>de</strong>lla famiglia e <strong>de</strong>lle relazioni <strong>di</strong><br />
prossimità, con le questioni <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong> implicate in questi problemi e in queste azioni consegnate<br />
alla sfera <strong>de</strong>lla morale e <strong>de</strong>lla coscienza. La responsabilità <strong>di</strong> partecipare al bene comune (al<br />
singolare) viene interpretata e in<strong>di</strong>cata in forma <strong>di</strong> precetti morali. Nel suo secondo significato la<br />
nozione <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà <strong>de</strong>signa una architettura istituzionale, senza implicazioni morali così intese<br />
ma con implicazioni in termini <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong>: essa chie<strong>de</strong> al governo locale <strong>di</strong> responsabilizzarsi<br />
rispetto alla costruzione e alla tenuta <strong>di</strong> una collettività concreta in grado <strong>di</strong> sostenere da sé i propri<br />
problemi. E chiama per questo in causa, in verticale, anche gli altri livelli <strong>di</strong> governo. A livello<br />
locale la sussi<strong>di</strong>arietà così intesa si può anche espan<strong>de</strong>re in orizzontale, in quanto il governo locale<br />
è chiamato a promuovere e valorizzare le capacità <strong>di</strong> autorganizazione <strong>de</strong>lla società civile, ma per<br />
l’appunto governandole. I problemi e le azioni per affrontarli che riguardano il campo <strong>de</strong>l welfare<br />
chiamano comunque in causa la res publica.<br />
Questa sorta <strong>di</strong> doppiezza la possiamo riconoscere anche nella nozione <strong>di</strong> solidarietà. Non è il caso<br />
<strong>di</strong> richiamarne la storia, nel pensiero sociologico e nelle lotte <strong>de</strong>l movimento operaio (v. <strong>de</strong><br />
Leonar<strong>di</strong>s, 1999) ma esplorarne gli usi attuali. Questa nozione è entrata alla gran<strong>de</strong> nelle retoriche<br />
che celebrano le virtù <strong>de</strong>i mix, o più propriamente <strong>de</strong>l terzo settore. Anche nel lessico <strong>de</strong>lle politiche<br />
sociali europee. Essa è un argomento sempre presente nei <strong>di</strong>scorsi che giustificano la centralità <strong>di</strong><br />
quest’ultimo nei mix: è la risorsa principale che portano nelle politiche sociali il volontariato, le<br />
imprese non-profit e in genere l’associazionismo. Essa è una risorsa <strong>di</strong> natura normativa, beninteso,<br />
che alimenta il tessuto morale <strong>de</strong>lla società, richiamando implicitamente una qualche concezione<br />
<strong>de</strong>l bene, o <strong>de</strong>l giusto. Ma essa funziona come tale in due mo<strong>di</strong> <strong>di</strong>versi, compresenti nello stesso<br />
terzo settore. Nel suo significato più ovvio e <strong>di</strong>rei <strong>de</strong>cisamente prevalente in quest’ambito, la<br />
solidarietà <strong>de</strong>signa un impegno morale <strong>di</strong> natura personale, affine al precetto <strong>de</strong>ll’ “amore per il<br />
prossimo” <strong>di</strong> stampo religioso su due aspetti importanti: essa è un fatto <strong>di</strong> coscienza; essa configura<br />
i legami sociali come legami <strong>di</strong> prossimità, legami personali. E in tal modo risucchia le questioni <strong>di</strong><br />
<strong>giustizia</strong> implicate nel welfare, per cominciare nelle relazioni <strong>di</strong> aiuto e <strong>di</strong> cura, tutte <strong>de</strong>ntro il frame<br />
<strong>de</strong>l privato, <strong>de</strong>lla morale personale e <strong>de</strong>ll’intimità. La valenza pubblica, e politica <strong>di</strong> queste<br />
questioni viene ignorata. Quest’ultima riemerge invece in una <strong>di</strong>versa sfumatura <strong>di</strong> significato <strong>de</strong>lla<br />
solidarietà là dove, sempre nell’ambito <strong>de</strong>l terzo settore, essa <strong>de</strong>signa ciò che dovrebbe<br />
caratterizzare un tessuto <strong>sociale</strong> (non una qualità morale <strong>de</strong>i singoli). Certo, a mettere in gioco la<br />
solidarietà sono comunque prioritariamente gli attori <strong>de</strong>l terzo settore, ma in quanto operino per<br />
6
creare e per alimentare un tessuto <strong>sociale</strong> solidale. Se anche sono in gioco virtù morali <strong>de</strong>i singoli,<br />
la solidarietà si esprime qui sul terreno <strong>de</strong>i legami societari, non interpersonali, nel riconoscimento<br />
<strong>di</strong> questi legami come beni comuni (al plurale).<br />
Ci ritornerò, ma intanto in questa interpretazione solidarietà <strong>di</strong>venta sinonimo <strong>di</strong> coesione <strong>sociale</strong>,<br />
in modo esplicito nel lessico europeo. Vale la pena soffermarsi brevemente anche su questa parola<br />
d’or<strong>di</strong>ne. Vale la pena anzitutto esaminare gli effetti che la sua introduzione produce su <strong>di</strong> un’altra<br />
nozione contigua, che ha costituito un riferimento normativo centrale, e problematico, nello<br />
sviluppo <strong>de</strong>l welfare state, quella <strong>di</strong> integrazione <strong>sociale</strong>. Il richiamo al principio normativo <strong>de</strong>lla<br />
coesione <strong>sociale</strong>, come un obiettivo centrale <strong>de</strong>lle politiche sociali, sposta il fuoco <strong>de</strong>ll’attenzione<br />
(e <strong>de</strong>l giu<strong>di</strong>zio) dal piano <strong>de</strong>ll’integrazione <strong>de</strong>l singolo in<strong>di</strong>viduo, o <strong>di</strong> quella specifica categoria<br />
<strong>sociale</strong>, al piano <strong>de</strong>lla creazione <strong>di</strong> un tessuto <strong>sociale</strong> integrante. Il regime <strong>di</strong> giustificazione che<br />
viene attivato non è messo alla prova sul singolo e sulla possibilità <strong>di</strong> integrarlo nella società data -<br />
e data come la norma - è messo piuttosto sulla tenuta <strong>de</strong>i legami sociali, sulla capacità <strong>de</strong>l tessuto<br />
<strong>sociale</strong> <strong>di</strong> reggere, <strong>di</strong> accogliere singolarità <strong>di</strong>verse e anche incoerenti, <strong>di</strong> supportare e sopportare.<br />
Sennonché c’è un alone semantico attorno al vocabolo “coesione <strong>sociale</strong>” , da cui anche queste<br />
buone intenzioni non riescono a liberarsi <strong>de</strong>l tutto: certe assonanze con “or<strong>di</strong>ne <strong>sociale</strong>”, “controllo<br />
<strong>sociale</strong>”, “consenso”, e con il corollario <strong>de</strong>ll’assenza <strong>de</strong>i conflitti. Un parola coerente con regimi <strong>di</strong><br />
giustificazione <strong>di</strong> tipo comunitario, nei quali il conflitto ha comunque una valenza negativa,<br />
qualcosa che non ci dovrebbe essere, se non nella versione <strong>de</strong>potenziata e spesso moralmente<br />
dubbia <strong>de</strong>l conflitto allocativo tra interessi contrastanti. In entrambe le versioni la coesione <strong>sociale</strong><br />
è richiamata come obiettivo <strong>di</strong> interventi su squilibri sociali. Ma nella prima versione questi<br />
squilibri sociali sono <strong>di</strong> carattere societario –segnalano una “società fuori squadra”, come <strong>di</strong>rebbe<br />
Bagnasco (2002) – e chiamano in causa <strong>di</strong>suguaglianze. Nella seconda versione gli squilibri sociali<br />
sono invece richiamati come una minaccia, un potenziale <strong>di</strong> <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ne <strong>sociale</strong>, e possono entrare<br />
come argomentazioni giustificative in orientamenti <strong>di</strong> policy <strong>di</strong> tipo espulsivo, invece che integrante<br />
(come ten<strong>de</strong> ad acca<strong>de</strong>re nelle politiche che trattano i flussi migratori in termini <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico,<br />
e con intenti securitari).<br />
Il posto <strong>de</strong>i <strong>de</strong>stinatari<br />
Ora soffermiamoci a esaminare più in <strong>de</strong>ttaglio un’ultima parola d’or<strong>di</strong>ne, la più nuova come<br />
<strong>di</strong>cevo. Quella <strong>di</strong> attivazione (o sue varianti) che ricorre <strong>di</strong> continuo negli obiettivi e nelle procedure<br />
7
<strong>de</strong>i programmi sociali europei e nelle politiche che per l’appunto si <strong>de</strong>finiscono “attive”. In estrema<br />
sintesi questa parola d’or<strong>di</strong>ne in<strong>di</strong>ca che le politiche (sociali in senso lato) <strong>de</strong>vono essere orientate<br />
ad attivare e coinvolgere “i <strong>di</strong>retti interessati” <strong>di</strong> quelle politiche. Ma questa in<strong>di</strong>cazione viene<br />
<strong>de</strong>clinata in mo<strong>di</strong> <strong>di</strong>versi nel <strong>di</strong>segno e nell’implementazione <strong>de</strong>lle politiche, e con implicazioni<br />
<strong>di</strong>verse, se non <strong>de</strong>cisamente contrastanti in termini <strong>di</strong> criteri <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong>.<br />
In una certa versione il principio <strong>di</strong> attivazione pren<strong>de</strong> forma attorno al problema <strong>de</strong>lla povertà e<br />
alle politiche <strong>di</strong> contrasto alla povertà che come è noto hanno assunto un gran<strong>de</strong> peso nel <strong>di</strong>scorso<br />
sul welfare. La povertà è il tema chiave attorno a cui s’intrecciano <strong>di</strong>scorsi pubblici, politici o<br />
esperti, e <strong>di</strong> senso comune, sulle politiche sociali. Una consistente letteratura <strong>di</strong> ricerca <strong>di</strong>mostra la<br />
rilevanza attuale <strong>de</strong>l problema. Ma la centralità <strong>de</strong>l tema <strong>de</strong>lla povertà rinvia a dati tanto quanto<br />
rinvia a mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>de</strong>finirli, classificarli e interpretarli, come viene <strong>de</strong>l resto riconosciuto dalla ricerca<br />
più avvertita in merito: “piuttosto che stu<strong>di</strong>are la povertà o l’esclusione <strong>sociale</strong> come status o<br />
con<strong>di</strong>zioni ‘oggettive’, autoevi<strong>de</strong>nti, sembra più fruttuoso analizzare come esse siano interpretate,<br />
riconosciute e socialmente <strong>de</strong>finite –ad esempio come povertà ‘meritevole’ o ‘non meritevole’-<br />
all’interno <strong>di</strong> una data società” (Garcia e Saraceno, 1999, pag.11).<br />
Qui la figura centrale è quella <strong>de</strong>l povero ma abile (al lavoro) -il cosid<strong>de</strong>tto able-bo<strong>di</strong>ed poor,<br />
persona la cui con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> bisogno resta associata a capacità <strong>di</strong> svolgere una vita attiva, dunque <strong>di</strong><br />
lavorare e procurarsi un red<strong>di</strong>to- e le politiche relative sono quelle <strong>di</strong> sostegno al red<strong>di</strong>to e <strong>di</strong><br />
inserimento lavorativo 4 . E’ in quest’ambito che si parla <strong>di</strong> attivazione, <strong>di</strong> coinvolgimento <strong>de</strong>gli<br />
interessati negli interventi sui loro problemi. Le misure <strong>de</strong>vono attivare i <strong>di</strong>retti interessati nel senso<br />
<strong>di</strong> promuoverne l’autonomia, la self-reliance, la responsabilità. Per esempio esse richiedono un<br />
qualche tipo <strong>di</strong> contratto che li impegni ad una <strong>di</strong>sponibilità al lavoro in cambio <strong>de</strong>lla concessione <strong>di</strong><br />
un sostegno al red<strong>di</strong>to. Oppure prevedono tipologie <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong> (“poco generosi” o “a <strong>di</strong> breve<br />
durata”) che incentivino all’in<strong>di</strong>pen<strong>de</strong>nza in negativo, scoraggiando cioè la <strong>di</strong>pen<strong>de</strong>nza<br />
dall’assistenza. Certo si tratta <strong>di</strong> scelte tecniche guidate da obiettivi <strong>di</strong> efficienza ed efficacia <strong>de</strong>lle<br />
misure, ma già da queste poche battute è evi<strong>de</strong>nte la <strong>de</strong>nsità normativa che esse contengono e<br />
trasmettono. L’attivazione è un principio normativo in quanto si misura sulla responsabilizzazione<br />
(un significato che ritroviamo anche nella parola d’or<strong>di</strong>ne affine <strong>de</strong>ll’empowerment). E implica un<br />
giu<strong>di</strong>zio che si esercita sul <strong>di</strong>retto interessato alla misura: un giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> meritevolezza. La<br />
posizione è espressa in modo limpido – e con eloquenza quasi militante – da Schmidtz in un testo<br />
4 Il più recente testo che, presentando i risultati <strong>di</strong> una importante ricerca europea sul tema, fa anche il punto sullo stato<br />
<strong>de</strong>l <strong>di</strong>battito è Saraceno (2002). Riprendo qui alcune <strong>de</strong>lle argomentazioni sviluppate in <strong>de</strong> Leonar<strong>di</strong>s (2000). V. anche<br />
Bosco, Negri (1997)<br />
8
fondamentale sull’argomento (Goo<strong>di</strong>n e Schmidtz, 1998). Schmidtz ripropone gli argomenti centrali<br />
<strong>de</strong>llo schieramento neoliberale che negli ultimi <strong>de</strong>cenni ha criticato il welfare state sostenendone il<br />
ri<strong>di</strong>mensionamento, e una ra<strong>di</strong>cale revisione <strong>de</strong>i presupposti <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong> su cui si basa. Come<br />
segnala il titolo <strong>de</strong>l suo contributo, al centro c’è la questione <strong>de</strong>lla responsabilità in<strong>di</strong>viduale, o<br />
meglio la re-internalizzazione <strong>de</strong>lla responsabilità che il welfare state aveva esternalizzato nella<br />
government responsibility, e nelle politiche re<strong>di</strong>stributive. La società è una shared venture che<br />
richie<strong>de</strong> per “<strong>di</strong>ventare migliore” il contributo <strong>di</strong> ciascuno. Questa prospettiva pone come cruciale<br />
un problema <strong>di</strong> equità, tra chi da un lato contribuisce a questa social venture, al progresso <strong>sociale</strong>, e<br />
chi invece preten<strong>de</strong> <strong>di</strong> go<strong>de</strong>rne i benefici senza avervi partecipato, come i beneficiari <strong>de</strong>l welfare.<br />
L’abile povero merita un aiuto pubblico se si mostra <strong>di</strong>sponibile a responsabilizzarsi, accettando un<br />
lavoro. Un lavoro purché sia, inteso come un obbligo –non come un <strong>di</strong>ritto, come una con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong><br />
base per la piena appartenenza alla vita <strong>sociale</strong>.<br />
Anche nelle politiche europee <strong>di</strong> sostegno al red<strong>di</strong>to si avverte l’influenza <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>llo <strong>de</strong>l welfare-<br />
to-work applicato negli Stati Uniti, in particolare nelle misure che ne subor<strong>di</strong>nano la concessione<br />
non soltanto all’accertamento <strong>di</strong> uno stato <strong>di</strong> bisogno, ma anche alla valutazione <strong>de</strong>lla capacità <strong>de</strong>l<br />
can<strong>di</strong>dato a responsabilizzarsi rispetto a questo stato, cioè ad una valutazione morale.<br />
Una ten<strong>de</strong>nza analoga si esprime anche nelle politiche per la famiglia. In Italia, la crescente<br />
attenzione alla tenuta morale <strong>de</strong>lla famiglia, e il ricorso al parametro <strong>de</strong>l “superiore interesse <strong>de</strong>l<br />
minore” per misurare questa tenuta –in termini dunque <strong>di</strong> responsabilità genitoriale- tendono ad<br />
alimentare un orientamento sanzionatore e misure <strong>di</strong> tipo punitivo nei confronti <strong>de</strong>lle famiglie più<br />
<strong>de</strong>private, e <strong>de</strong>lle donne in particolare, sottoposte alla minaccia <strong>di</strong> un provve<strong>di</strong>mento giu<strong>di</strong>ziario <strong>di</strong><br />
sottrazione <strong>de</strong>i figli. Naturalmente <strong>di</strong> questo orientamento fanno soprattutto le spese le madri sole<br />
con figli minori a carico: “le reti <strong>di</strong> servizi che si occupano <strong>di</strong> minori spesso tendono a rinforzare<br />
vicen<strong>de</strong>volmente un doppio messaggio e un circolo perverso: la scarsità <strong>di</strong> risorse economiche e<br />
relazionali <strong>de</strong>lla madre sola ren<strong>de</strong> suo figlio particolarmente meritevole <strong>di</strong> sostegno, tuttavia il<br />
permanere in queste stesse <strong>di</strong>fficoltà ren<strong>de</strong> la madre sola particolarmente a richio <strong>di</strong><br />
stigmatizzazione come cattiva madre e quin<strong>di</strong> eleggibile per possibili provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> separazione<br />
dal figlio” (Bimbi, 1999, pag. 255; v. anche Pitch, 1998).<br />
Il principio <strong>di</strong> attivazione in questa versione, inteso cioè come responsabilizzazione, si giustifica<br />
sulla base <strong>de</strong>ll’imperativo <strong>di</strong> scoraggiare la <strong>di</strong>pen<strong>de</strong>nza dal welfare, essendo questa letta in chiave<br />
morale e giu<strong>di</strong>cata moralmente riprovevole. E’ all’opera quello che Goo<strong>di</strong>n, nella sua <strong>di</strong>scussione<br />
con Schmidtz, <strong>de</strong>finisce un processo <strong>di</strong> “moralizzazione <strong>de</strong>lla <strong>di</strong>pen<strong>de</strong>nza”. L’i<strong>de</strong>ntificazione <strong>di</strong><br />
9
con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> bisogno che richiedono un aiuto <strong>sociale</strong> implica un giu<strong>di</strong>zio morale sui can<strong>di</strong>dati a<br />
questo aiuto. Questo giu<strong>di</strong>zio è guidato dal sospetto che la <strong>di</strong>pen<strong>de</strong>nza sia volontaria, espressione <strong>di</strong><br />
atteggiamenti irresponsabili e opportunistici, in <strong>de</strong>finitiva <strong>di</strong> <strong>di</strong>fetti morali. E a loro volta le misure<br />
– quelle che subor<strong>di</strong>nano l’erogazione <strong>di</strong> un sussi<strong>di</strong>o ad un giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> meritevolezza, che<br />
incentivano all’in<strong>di</strong>pen<strong>de</strong>nza dal welfare seguendo la logica <strong>de</strong>lla less eligibility (sussi<strong>di</strong> micragnosi<br />
e <strong>di</strong> breve durata)- sono guidate da un intento moralizzatore 5 . E la responsabilità assume i caratteri<br />
<strong>de</strong>lla blame responsibility, <strong>de</strong>ll’imputazione <strong>di</strong> colpa. Questo è il registro nel quale viene<br />
riconosciuto al <strong>de</strong>stinatario <strong>de</strong>lle politiche lo statuto <strong>di</strong> soggetto morale, responsabile <strong>de</strong>lle proprie<br />
azioni: questa persona è costantemente “in prova”, sotto il profilo morale. Ed è costantemente in<br />
bilico sulla china <strong>de</strong>ll’immiserimento, sotto il profilo materiale: l’ “in<strong>di</strong>pen<strong>de</strong>nza dal welfare” così<br />
intesa, e il raggiungimento <strong>di</strong> una con<strong>di</strong>zione lavorativa, è così misera che viceversa conferma uno<br />
stato <strong>di</strong> povertà. Si tratta spesso soltanto <strong>di</strong> una reimmersione <strong>de</strong>lla persona in una con<strong>di</strong>zione al <strong>di</strong><br />
sotto <strong>de</strong>lla “soglia <strong>di</strong> povertà”, a al <strong>di</strong> sotto <strong>de</strong>lla soglia <strong>di</strong> visibilità pubblica 6 .<br />
E’ il caso <strong>di</strong> aggiungere a questo proposito che, come <strong>di</strong>mostra la letteratura critica sulle<br />
realizzazioni <strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>llo welfare-to-work negli Stati Uniti (oltre a Goo<strong>di</strong>n, cit. v. anche Mead,<br />
1997), il principio <strong>di</strong> moralizzazione e la relativa stigmatizzazione <strong>de</strong>lla <strong>di</strong>pen<strong>de</strong>nza incorrono nella<br />
classica trappola <strong>de</strong>ll’ingiunzione paradossale (sii responsabile, altrimenti… ) che nega ciò che<br />
vorrebbe far esistere. Le intenzioni <strong>di</strong>chiarate <strong>di</strong> superare il carattere paternalistico <strong>de</strong>l welfare state<br />
e la <strong>di</strong>pen<strong>de</strong>nza che esso crea, producono un effetto paradossale: un’autorità che applica giu<strong>di</strong>zi <strong>di</strong><br />
meritevolezza, con il potere <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuire premi e punizioni, ancora più letteralmente paternalistica<br />
<strong>de</strong>l vecchio welfare state. Essa è un’autorità che sorveglia il comportamento <strong>de</strong>i propri sud<strong>di</strong>ti,<br />
potenzialmente irresponsabili, che li tratta come sospetti o li infantilizza come minus habens morali,<br />
e che li <strong>de</strong>priva <strong>de</strong>llo statuto pieno <strong>di</strong> attore <strong>sociale</strong>, con ciò alimentando una relazione <strong>di</strong><br />
asservimento.<br />
Questa interpretazione <strong>de</strong>l principio <strong>di</strong> attivazione che pren<strong>de</strong> forma nelle politiche contro la<br />
povertà, in particolare la povertà associata ad abilità, non affronta –anzi lascia fuori dal <strong>di</strong>scorso- il<br />
5 Oltretutto, questo intento che si giustifica con il rischio che si crei <strong>di</strong>pen<strong>de</strong>nza, non sembra avere riscontri empirici. La<br />
ricerca europea Esopo (v. Saraceno 2002) <strong>di</strong>mostra che la permanenza nello stato <strong>di</strong> assistito è un fenomeno limitato,<br />
che <strong>di</strong>pen<strong>de</strong> da fattori sociali in<strong>di</strong>pen<strong>de</strong>nti dalle intenzioni <strong>de</strong>lla persona sotto esame, e che la scarsità <strong>de</strong>ll’aiuto e la sua<br />
breve durata non sono affatto associati ad un’efficace opera <strong>di</strong> uscita dalla <strong>di</strong>pen<strong>de</strong>nza (e che semmai questa è facilitata<br />
al contrario da aiuti “generosi” e non selettivi).<br />
6 Questo esito è messo in luce nelle ricerche sulle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> povertà <strong>de</strong>i lavoratori a basso red<strong>di</strong>to negli Stati Uniti<br />
(v. per es. Newman, 1999, e più <strong>di</strong> recente l’inchiesta <strong>di</strong> Barbara Erenreich, 2002) e sulla contiguità tra questo tipo <strong>di</strong><br />
10
gran<strong>de</strong> nodo <strong>de</strong>lle <strong>di</strong>sabilità, cruciale nel campo <strong>de</strong>l welfare. Disabilità fisiche o mentali, e più in<br />
generale con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> svantaggio <strong>sociale</strong> più o meno grave, <strong>di</strong> <strong>de</strong>privazione e vulnerabilità.<br />
Quando il principio <strong>di</strong> attivazione si applica su <strong>di</strong>sabilità così intese la sua interpretazione cambia. E<br />
cambiano i criteri <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong> che entrano in gioco nelle politiche e nelle <strong>pratiche</strong>. Il principio<br />
<strong>di</strong>venta più esigente, e meno imme<strong>di</strong>ato: non è evi<strong>de</strong>nte infatti che cosa voglia <strong>di</strong>re che i <strong>di</strong>retti<br />
interessati (in questo caso non abili) partecipano alle misure che li riguardano, né come questo si<br />
possa perseguire.<br />
Detto in sintesi nel confronto con <strong>di</strong>sabilità e svantaggi sociali il principio <strong>di</strong> attivazione richie<strong>de</strong><br />
politiche che attivino, che promuovano le capacità <strong>di</strong> scelta e <strong>di</strong> azione. Attivazione come<br />
capacitazione. Qui <strong>de</strong>lineo le coor<strong>di</strong>nate <strong>di</strong> questa seconda interpretazione <strong>de</strong>l principio <strong>di</strong><br />
attivazione limitandomi a rappresentarne alcune manifestazioni.<br />
Al livello molto concreto, quello <strong>de</strong>i terminali operativi <strong>di</strong> un sistema <strong>di</strong> welfare, il principio <strong>di</strong><br />
attivazione si esprime nelle argomentazioni che vengono addotte per <strong>de</strong>finire il modo <strong>di</strong> lavorare <strong>di</strong><br />
quei servizi che intervengono su un qualche tipo, anche grave, <strong>di</strong> svantaggio <strong>sociale</strong> operando una<br />
ri<strong>de</strong>finizione <strong>de</strong>l proprio compito: “noi –viene puntualizzato- non interveniamo su carenze,<br />
<strong>di</strong>sabilità, han<strong>di</strong>cap, incapacità <strong>di</strong> qualche tipo, per curarle in qualche modo, per provare a porvi<br />
rime<strong>di</strong>o. Non lavoriamo sull’invali<strong>di</strong>tà, ma sulla validazione. Noi qui lavoriamo sulle capacità <strong>de</strong>lle<br />
persone –le loro esperienze e competenze, le loro risorse <strong>di</strong> persone e soprattutto le loro capacità <strong>di</strong><br />
scegliere e <strong>di</strong> agire- e lavoriamo a farle emergere, a <strong>di</strong>spiegarle e potenziarle facendo in modo che<br />
esse possano essere messe all’opera, utilizzate (perché le capacità si danno, e crescono, solo nel loro<br />
uso)” (<strong>de</strong> Leonar<strong>di</strong>s, Mauri, Rotelli, 1994). Questo principio è stato un motore importante <strong>di</strong> certi<br />
sistemi locali <strong>di</strong> servizi organizzati come “impresa <strong>sociale</strong>”. Ne ho dato ampiamente conto altrove<br />
e non entro nel merito. Essi rientrano tra quei programmi europei (tipo Equal) che negli obiettivi <strong>di</strong><br />
sostegno al lavoro e <strong>di</strong> inserimento lavorativo ospitano anche “soggetti svantaggiati”. Il principio <strong>di</strong><br />
attivazione che in questi programmi viene comunque richiamato ammette questa seconda<br />
interpretazione, che si misura sulle <strong>di</strong>sabilità: l’attivazione intesa some promozione <strong>di</strong> capacità <strong>de</strong>gli<br />
interessati, anzitutto le capacità <strong>di</strong> scelta e <strong>di</strong> azione.<br />
E’ forse il caso <strong>di</strong> aggiungere che in questa <strong>di</strong>versa prospettiva la questione <strong>de</strong>lla <strong>di</strong>pen<strong>de</strong>nza dal<br />
welfare viene <strong>de</strong>finita e trattata in modo rovesciato. Anzitutto essa <strong>di</strong>ce qualcosa non sulla persona e<br />
il suo statuto morale, ma sulle politiche e sui servizi che le implementano; la <strong>di</strong>pen<strong>de</strong>nza va cioè<br />
lavoratori e i welfare recipients (v. la ricerca sulla povertà urbana condotta a Chicago da W.J.Wilson, 1996). L’efficacia<br />
11
imputata alle politiche e ai servizi ed è conseguente ai processi <strong>di</strong> invalidazione – che confermano e<br />
rafforzano <strong>di</strong>sabilità e <strong>de</strong>privazioni (v. Bifulco, 1999). E pertanto essa <strong>de</strong>ve essere contrastata<br />
smontando le logiche e le <strong>pratiche</strong> istituzionali che invalidano, che cronicizzano legami <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>pen<strong>de</strong>nza, e viceversa costruendo con<strong>di</strong>zioni, come <strong>di</strong>cevo, <strong>di</strong> validazione.<br />
Anche sul terreno <strong>de</strong>lle misure <strong>di</strong> contrasto alla povertà troviamo tracce <strong>di</strong> questa seconda<br />
interpretazione <strong>de</strong>l principio <strong>di</strong> attivazione. Ne seguo solo una, quella che emerge dalla storia <strong>de</strong>lla<br />
signora I <strong>de</strong>lla città te<strong>de</strong>sca <strong>di</strong> Halle sintetizzata in Kazepov et al (2002, pag. 159): “la signora I ha<br />
55 anni ed è madre <strong>di</strong> 5 figli. E’ entrata nello schema <strong>de</strong>l red<strong>di</strong>to minimo in conseguenza<br />
<strong>de</strong>ll’accumulazione <strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> eventi critici, tra cui la separazione dal suo secondo partner e<br />
l’uscita forzata dal lavoro… .Ha lavorato per [complessivi] 29 anni… E’ <strong>di</strong>pen<strong>de</strong>nte da misure <strong>di</strong><br />
supporto al red<strong>di</strong>to da 5 anni, e sostiene che l’aiuto <strong>de</strong>ll’assistenza <strong>sociale</strong> ha migliorato<br />
<strong>de</strong>cisamente le sue con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> vita. E’ attivamente coinvolta in networks familiari e <strong>di</strong><br />
vicinato… e gestisce la sua vita quoti<strong>di</strong>ana senza la speranza <strong>di</strong> poter fare a meno <strong>de</strong>ll’assistenza<br />
data la sua età e la sua bassa qualificazione professionale, ma senza sentirsi per questo isolata o<br />
stigmatizzata”. Questo caso esemplifica una situazione nella quale la <strong>di</strong>pen<strong>de</strong>nza dall’assistenza si<br />
coniuga con una buona integrazione nel contesto <strong>sociale</strong> e una piena padronanza <strong>de</strong>lla propria vita,<br />
con esiti <strong>di</strong> validazione. Il sostegno al red<strong>di</strong>to si configura in questo caso come una compensazione<br />
<strong>di</strong> svantaggi sociali che permette alla signora <strong>di</strong> realizzare ciò che sa e vuole fare nella sua vita e nel<br />
suo contesto <strong>di</strong> vita; un aiuto che – ben <strong>di</strong>versamente da un premio <strong>di</strong> buona condotta – viene<br />
praticato e riconosciuto come un <strong>di</strong>ritto, come basic income,un red<strong>di</strong>to <strong>di</strong> base incon<strong>di</strong>zionato.<br />
Questa interpretazione <strong>de</strong>l principio <strong>di</strong> attivazione la si può riconoscere infine anche nell’i<strong>de</strong>a <strong>de</strong>lla<br />
partecipazione <strong>de</strong>gli interessati ad interventi <strong>di</strong> trasformazione e riqualificazione <strong>di</strong> contesti<br />
<strong>de</strong>gradati <strong>di</strong> vita. Partecipazione, più precisamente, al <strong>di</strong>segno e alla messa in opera <strong>di</strong> questi<br />
programmi, dunque alla <strong>de</strong>finizione <strong>de</strong>gli obiettivi e <strong>de</strong>i mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> proce<strong>de</strong>re. Se ne trovano esempi<br />
nell’ambito <strong>de</strong>lle politiche abitative e <strong>de</strong>i progetti <strong>di</strong> riqualificazione <strong>di</strong> quartieri “problematici”<br />
(europei, tipo Urban) 7 . In questo caso va notato che gli interessati –socialmente svantaggiati – sono<br />
coinvolti come attori <strong>de</strong>i progetti, interlocutori competenti a <strong>de</strong>finire i problemi e a scegliere le<br />
<strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>llo welfare-to-work è messa in <strong>di</strong>scussione anche da Solow, 1998.<br />
7 Sull’argomento v. anche il contributo <strong>di</strong> Montebugnoli su questo volume. Un’interessante analisi <strong>di</strong> caso in Bricocoli,<br />
2002. Nella letteratura attorno a questo tipo <strong>di</strong> programmi il tema <strong>de</strong>lla partecipazione viene sviluppato nel quadro <strong>de</strong>lle<br />
questioni <strong>de</strong>lla governance urbana, e affrontato in rapporto alle trasformazioni <strong>de</strong>lla <strong>de</strong>mocrazia (rinvio in proposito a<br />
Bifulco, De Leonar<strong>di</strong>s, 2002).<br />
12
soluzioni, con il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> “voce” e gli spazi per farla sentire. In questo caso dunque l’attivazione,<br />
che a partire da svantaggi sociali si misura sulle capacità attivate, compren<strong>de</strong> nel compito normativo<br />
<strong>de</strong>lle politiche, nei criteri <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong> che le guidano, la promozione <strong>di</strong> capacità <strong>di</strong> scelta e <strong>di</strong> azione<br />
sul terreno politico, pubblico, <strong>de</strong>lla <strong>di</strong>scussione e <strong>de</strong>liberazione su materie d’interesse collettivo.<br />
Si può riconoscere che il principio <strong>di</strong> attivazione, così inteso, incorpora e socializza alcune<br />
in<strong>di</strong>cazioni normative <strong>di</strong> fondo provenienti da quelle teorie filosofiche <strong>de</strong>lla <strong>giustizia</strong> che si<br />
misurano con le <strong>di</strong>suguaglianze, e con le <strong>di</strong>suguaglianze intese come ingiustizie, in particolare<br />
affrontandole a partire da “quelli che stanno peggio”. L’eguaglianza è un parametro centrale <strong>de</strong>lla<br />
<strong>giustizia</strong> <strong>sociale</strong>, che dunque impone alle politiche <strong>di</strong> perseguire la re<strong>di</strong>stribuzione. Le <strong>di</strong>sabilità,<br />
sottratte ad registro naturalizzante <strong>de</strong>l <strong>de</strong>stino, tengono aperte tensioni e contrad<strong>di</strong>zioni sui temi<br />
<strong>de</strong>lla <strong>giustizia</strong>: anzitutto, “eguaglianza <strong>di</strong> che cosa?” (v. Sen, 1986 e 1982). Come coniugare<br />
l’accesso eguale a beni sociali primari con la fondamentale <strong>di</strong>versità <strong>de</strong>gli esseri umani? E<br />
re<strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> che cosa? Facendo leva sulle <strong>di</strong>sabilità l’intento critico è quello <strong>di</strong> sorvegliare il<br />
rischio <strong>di</strong> instaurare barriere (soglie) nella partecipazione al gioco <strong>de</strong>ll’eguaglianza (e <strong>de</strong>lla<br />
<strong>di</strong>fferenza), e la complementare resistenza, come osserva Antonella Besussi (1999, pag. 52) a<br />
“guardare il gioco proprio dal punto <strong>di</strong> vista <strong>di</strong> quelli che non hanno potuto giocare, gli scarti, i non<br />
adatti”, e ad assumerlo come “un punto <strong>di</strong> vista davvero ospitale per la <strong>giustizia</strong>”. E la ricerca si<br />
rivolge a superare la prospettiva <strong>de</strong>lla re<strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> beni sociali primari: ci sono “<strong>di</strong>fferenze”<br />
non congruenti, non commensurabili con quei beni, scarti e alterità incolmabili, che spostano le<br />
questioni <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong> sul terreno <strong>di</strong> chi e come partecipa a <strong>de</strong>finire che cosa e come ri<strong>di</strong>stribuire. Il<br />
principio <strong>di</strong> attivazione in<strong>di</strong>ca un passaggio importante nell’evoluzione <strong>di</strong> queste teorie, uno<br />
spostamento <strong>de</strong>l terreno su cui si applicano criteri <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong> “dai beni alle capacità”, dai beni a<br />
ciò che i beni consentono alle persone <strong>di</strong> essere e fare. L’approccio <strong>de</strong>lle basic capabilities <strong>di</strong><br />
Amartya Sen qui evocato rappresenta una formulazione, a mio parere rigorosa ed a<strong>de</strong>guatamente<br />
complessa, <strong>di</strong> questa concezione <strong>de</strong>lla <strong>giustizia</strong> implicata nel principio <strong>di</strong> attivazione.<br />
Che cosa è in gioco?<br />
Intorno al principio <strong>di</strong> attivazione si gioca una partita complessa in termini <strong>di</strong> scelte <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong> che<br />
riguardano - certo - il campo <strong>de</strong>l welfare, ma che più in generare influenzano fortemente alcuni<br />
caratteri costitutivi <strong>de</strong>l legame <strong>sociale</strong>. Le due interpretazioni <strong>de</strong>lineano i contorni <strong>di</strong> due<br />
13
contrastanti mo<strong>de</strong>lli normativi <strong>di</strong> welfare, entrambi attivi nelle trasformazioni in atto. Vi si<br />
contrappongono un para<strong>di</strong>gma <strong>di</strong>stributivo e un para<strong>di</strong>gma re<strong>di</strong>stributivo. Il primo assume il criterio<br />
normativo <strong>de</strong>ll’equità e orienta le politiche a <strong>di</strong>stribuire beni in base a un principio contributivo 8 . Il<br />
legame <strong>de</strong>l singolo con la società essendo trattato con la contabilità <strong>de</strong>l dare-avere. Il secondo<br />
para<strong>di</strong>gma assume il criterio normativo <strong>de</strong>ll’eguaglianza ed è rivolto a ri<strong>di</strong>stribuire opportunità per<br />
compensare svantaggi socialmente prodotti, secondo un principio compensativo. Il mo<strong>de</strong>llo che si<br />
rifà al para<strong>di</strong>gma <strong>di</strong>stributivo è selettivo – classifica e compie esercizi <strong>di</strong> misurazione, certifica stati<br />
<strong>di</strong> bisogno e su questo crea soglie, e lavora con ciò a creare uno spartiacque tra inclusione ed<br />
esclusione- mentre il mo<strong>de</strong>llo re<strong>di</strong>stributivo è universalistico, essendo certi beni (compresi quelli<br />
<strong>di</strong>stribuiti dal welfare) accessibili a tutti perché sono beni sociali, sono riconosciuti come beni<br />
comuni da una data collettività.<br />
Il posto <strong>de</strong>i <strong>de</strong>stinatari <strong>de</strong>lle politiche è molto <strong>di</strong>verso nei due mo<strong>de</strong>lli: portatori <strong>di</strong> bisogni o titolari<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti, <strong>de</strong>stinatari <strong>di</strong> misure <strong>di</strong>stributive nella posizione <strong>di</strong> chie<strong>de</strong>re e <strong>di</strong> esser valutati, o viceversa<br />
attori, nella posizione <strong>di</strong> esercitare le loro capacità <strong>di</strong> scelta e <strong>di</strong> azione sullo stesso terreno <strong>de</strong>lla<br />
<strong>de</strong>finizione <strong>di</strong> tali <strong>di</strong>ritti e <strong>de</strong>i beni comuni che essi trattano. Perché la titolarità <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto<br />
presuppone per <strong>de</strong>finizione la possibilità <strong>di</strong> concepirsi, ed essere riconosciuti come autori <strong>di</strong> quel<br />
<strong>di</strong>ritto 9 .<br />
In <strong>de</strong>finitiva, nel primo <strong>de</strong>i due mo<strong>de</strong>lli l’equilibrio tra contributi e benefici, tra dare e avere,<br />
<strong>di</strong>venta l’unico gioco ammesso al vaglio <strong>di</strong> consi<strong>de</strong>razioni <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong>, con l’esclusione <strong>di</strong><br />
consi<strong>de</strong>razioni che invece riguardano, a monte, poteri e libertà esercitate nel <strong>de</strong>liberare a che gioco<br />
giochiamo, e le <strong>di</strong>suguaglianze che vi si annidano. Viceversa, se si tratta <strong>di</strong> ri<strong>di</strong>stribuire emergono<br />
motivi e forme <strong>di</strong> conflitto sui fini, non sui mezzi, non riducibili cioè allo stampo <strong>de</strong>l conflitto<br />
allocativo, <strong>di</strong>stributivo.<br />
Il primo è un welfare <strong>de</strong>lla moralizzazione, dove le questioni <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong> sono soggettivate, trattate<br />
con il vocabolario <strong>de</strong>lla responsabilità personale e tradotte in giu<strong>di</strong>zi morali; il secondo è un<br />
welfare politico, che tematizza la natura politica <strong>de</strong>lle questioni <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong> e <strong>de</strong>gli ambiti <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>scussione, conflitto e <strong>de</strong>liberazione in merito; un welfare che dunque fa <strong>de</strong>lle questioni <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong><br />
materia <strong>di</strong> res pubblica. E’ in questo senso un welfare pubblico (ben al <strong>di</strong> là <strong>de</strong>ll’equazione<br />
8 Su alcuni elementi portanti <strong>di</strong> questo para<strong>di</strong>gma v. Garcia, Saraceno, 1999 e, nell’ambito <strong>de</strong>i contributi <strong>de</strong>lla teoria<br />
femminista al <strong>di</strong>battito sulla <strong>giustizia</strong> v. Young, 1990, in particolare cap. 1.<br />
9 V. Habermas, 1994. E’ però opportuno segnalare che un rischio simile corre anche un orientamento che, nel trattare la<br />
re<strong>di</strong>stribuzione come compensazione, ten<strong>de</strong> a trattare i beneficiari <strong>de</strong>l welfare come vittime. Anche in questo caso si<br />
rischia <strong>di</strong> confinali nello stato <strong>di</strong> <strong>de</strong>stinatari passivi e <strong>di</strong> confermare una relazione asimmetrica e a senso unico tra chi dà<br />
e chi riceve, tra chi ha il potere su risorse da (re)<strong>di</strong>stribuire e chi ha o non ha titolo (in questo caso il risarcimento, non<br />
la meritevolezza) per ottenerle.<br />
14
pubblico=statuale), mentre il primo è privatistico. Esso è privatistico non solo o tanto perché poggia<br />
sulla cosid<strong>de</strong>tta privatizzazione <strong>de</strong>ll’offerta <strong>di</strong> servizi e sui richiami alla benevolenza privata, ma<br />
perché <strong>de</strong>politicizza le materie - i problemi e i beni - <strong>de</strong>l welfare, sottraendole alla visibilità<br />
pubblica, al campo <strong>de</strong>lle scelte collettive su questioni comuni 10 . Beni e problemi tendono ad essere<br />
trattati con il registro argomentativo <strong>de</strong>gli affari privati. I problemi, per esempio la povertà: essa<br />
ten<strong>de</strong> ad essere trattata come <strong>di</strong>sgrazia, evento <strong>de</strong>lla vita, caso sfortunato, <strong>de</strong>stino… o come colpa e<br />
punizione, una questione <strong>di</strong> responsabilità personale –con<strong>di</strong>zione in tutti i casi estranea a questioni<br />
<strong>di</strong> <strong>giustizia</strong>, o in questo caso <strong>di</strong> in<strong>giustizia</strong>, <strong>sociale</strong>. Quanto ai beni sociali materia <strong>de</strong>lle politiche -<br />
la scolarizzazione, la salute, la sicurezza da rischi – essi tendono ad esser trattati come beni privati,<br />
in due forme complementari. Come beni oggetto <strong>di</strong> scelte libere <strong>di</strong> privati citta<strong>di</strong>ni, oggetto <strong>di</strong><br />
domanda e offerta, <strong>de</strong>finiti e valutati con logiche affini a quella <strong>de</strong>l mercato, <strong>de</strong>gli interessi,<br />
<strong>de</strong>ll’impresa e <strong>de</strong>lla sod<strong>di</strong>sfazione <strong>de</strong>l cliente. Ovvero come beni morali. In proposito - per non<br />
tornare alla responsabilità, e relativi richiami alla coscienza - si pensi alle tanto spesso evocate<br />
risorse <strong>di</strong> solidarietà e impegno volontario intese appunto come risorse morali. I legami <strong>di</strong> aiuto e <strong>di</strong><br />
cura che s’instaurano utilizzando queste risorse morali sono legami personali, legami asimmetrici <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>pen<strong>de</strong>nza personale 11 .<br />
Raccomandazioni<br />
Prima <strong>di</strong> chiu<strong>de</strong>re vorrei raccomandare alla riflessione in corso sulle trasformazioni <strong>de</strong>l welfare<br />
alcune consi<strong>de</strong>razioni.<br />
Bisogna mettere osservazione i criteri <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong> che si trovano sotto traccia nelle <strong>pratiche</strong>, nelle<br />
<strong>culture</strong>, nelle organizzazioni, nelle interazioni, nelle norme, nel <strong>di</strong>segno <strong>de</strong>lle misure… Risalire la<br />
traccia, <strong>de</strong>costruendo le argomentazioni tecniche, professionali, o gestionali <strong>de</strong>lle scelte <strong>di</strong> policy<br />
per farne emergere il succo normativo. E osservare da vicino che cosa queste scelte, concretamente<br />
praticate, generano in forma <strong>di</strong> parametri <strong>di</strong> valutazione e norme <strong>di</strong> comportamento, <strong>de</strong>finizioni <strong>di</strong><br />
ciò che è bene e ciò che è male, a chi spetta cosa, che cosa è importante e che cosa, o chi, vale meno<br />
<strong>di</strong> niente. Con le relative conseguenze in termini <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong> e in<strong>giustizia</strong> <strong>sociale</strong>. Questo è quello<br />
che si fa quoti<strong>di</strong>anamente e incessantemente nel mondo <strong>de</strong>l welfare.<br />
10 Sulla tematizzazione e sulla critica <strong>di</strong> questa ten<strong>de</strong>nza in termini <strong>di</strong> teoria <strong>de</strong>lla <strong>giustizia</strong> v. Mouffe (1988).<br />
11 Ho analizzato la sindrome <strong>de</strong>l privatismo che si alimenta sulle trasformazioni <strong>de</strong>l welfare in De Leonar<strong>di</strong>s, 1998. Qui<br />
mi sono limitata ad alcuni cenni.<br />
15
Bisogna far emergere questa <strong>de</strong>nsità normativa per poter tematizzare le questioni <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong> che vi<br />
sono implicate. Nella riflessione sia teorica che <strong>di</strong> policy sui sistemi <strong>di</strong> welfare – che sono sistemi <strong>di</strong><br />
<strong>giustizia</strong> <strong>sociale</strong>- queste questioni sono imprescin<strong>di</strong>bili. Quali che siano i criteri <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong> adottati,<br />
è importante che essi siano resi visibili e giustificati. Perché un presupposto cruciale affinché vi sia<br />
<strong>giustizia</strong>, perché la si persegua, è la sua <strong>di</strong>scutibilità. Che vi siano –ai <strong>di</strong>versi livelli – spazi e mo<strong>di</strong><br />
per mettere a tema questioni <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong>; che vi siano vocabolari per <strong>de</strong>co<strong>di</strong>ficare scelte e<br />
prestazioni tecniche nelle loro implicazioni normative. E che vi siano attori, molteplici, che<br />
partecipano all’elaborazione collettiva su queste questioni. O più precisamente che chiunque,<br />
nessuno escluso, possa in principio parteciparvi. Credo che un punto <strong>di</strong> osservazione sotto questo<br />
profilo importante, un punto cui prestare attenzione, siano i conflitti. Se vi siano arene e temi <strong>di</strong><br />
conflitto, nel welfare; <strong>di</strong> che natura siano i conflitti –se allocativi o politici; se e come vi siano<br />
tematizzate questioni normative, e principi <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong>; chi ne siano gli attori, e se vi abbiano voce,<br />
e semmai quale, i <strong>di</strong>retti interessati; se nel crogiuolo <strong>de</strong>i conflitti si sviluppano processi <strong>di</strong><br />
institution buil<strong>di</strong>ng, e semmai <strong>di</strong> quale natura e con quali esiti.<br />
Ho l’impressione che il mo<strong>de</strong>llo <strong>di</strong> welfare orientato in senso moralizzatore, privatistico e<br />
<strong>de</strong>politicizzato ricavi una sua forza dallo scarso peso che hanno le questioni <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong> negli<br />
argomenti giustificativi <strong>di</strong> politiche, misure e <strong>pratiche</strong>, la povertà <strong>di</strong> spazi e <strong>di</strong> vocabolari per<br />
mettere a tema queste questioni e <strong>di</strong>scuterne. Ho per esempio l’impressione che l’egemonia <strong>di</strong> un<br />
frame “economicista”, e i relativi vocabolari e argomenti, contribuisca gran<strong>de</strong>mente alla messa tra<br />
parentesi <strong>di</strong> questioni <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong>, benché esse siano certamente implicate anche nelle scelte e nelle<br />
azioni in cui questo frame si esplica (basti pensare – per ripren<strong>de</strong>re un punto - a quel che veicolano i<br />
criteri <strong>di</strong> efficacia <strong>de</strong>lle misure antipovertà misurati sul problema <strong>de</strong>lla <strong>di</strong>pen<strong>de</strong>nza dal welfare, ai<br />
criteri <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong> che per questa via si veicolano). E ho l’impressione complementare che le<br />
questioni <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong> restino altrettanto opache anche nel frame <strong>de</strong>lla solidarietà intesa come<br />
obbligo morale (non politico, pubblico, societario), nel quale quesiti <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong> si presentano in<br />
forma <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zi morali, una forma in cui dunque la natura problematica <strong>de</strong>lle questioni <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong><br />
è già neutralizzata.<br />
In entrambi questi casi non si <strong>di</strong>scute <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong> ma si giu<strong>di</strong>ca (in forma <strong>di</strong> valutazioni economiche<br />
o <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zi morali). E l’autorità giu<strong>di</strong>cante è comunque sottratta al vaglio <strong>di</strong> questioni <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong>.<br />
Bisogna dunque mettere sotto osservazione –questa è l’ultima consi<strong>de</strong>razione che raccomando alla<br />
riflessione – queste zone <strong>di</strong> opacità in materia <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong> poiché suscettibili <strong>di</strong> alimentare un<br />
welfare che non assolve il suo compito <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong> <strong>sociale</strong>, in quanto anzitutto non rispetta il criterio<br />
16
fondamentale <strong>de</strong>lla sua propria <strong>di</strong>scutibilità. L’in<strong>di</strong>cazione –normativa- che ne <strong>di</strong>scen<strong>de</strong> è dunque<br />
quella <strong>di</strong> perseguire un welfare che abbia sotto questo profilo alcuni caratteri <strong>di</strong> base. Che sia in<br />
qualche modo attrezzato a perseguire questo <strong>di</strong>fficile criterio, la sua propria <strong>di</strong>scutibilità. Che sia<br />
perciò in grado <strong>di</strong> alimentare spazi pubblici, in quanto spazi <strong>di</strong> <strong>di</strong>scussione su scelte <strong>di</strong> <strong>giustizia</strong>. E<br />
che riproduca, non importa con che formula, i caratteri <strong>di</strong> welfare pubbico, politico, più sopra<br />
<strong>de</strong>lineati. Il che implica - lo enuncio come un inciso, ma l’argomento sarebbe pertinente - un<br />
grado <strong>di</strong> riflessività <strong>de</strong>lle istituzioni (Donolo,1998; v. anche De Leonar<strong>di</strong>s, 2001).<br />
17
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI<br />
Bagnasco, A. (2002) “Distretti e città in società fuorisquadra”, in Cafagna, Crepax Bologna, Il<br />
Mulino.<br />
Besussi, A. (1999) “Togliere l’etichetta. Una <strong>di</strong>fesa eccentrica <strong>de</strong>ll’azione positiva” in B.Beccalli, a<br />
cura <strong>di</strong>, Donne in quota, Milano, Feltrinelli.<br />
Bifulco, L. (1999) “Culture amministrative e <strong>di</strong>pen<strong>de</strong>nze inventate”, Animazione Sociale, n. 10.<br />
Bifulco, L., O. <strong>de</strong> Leonar<strong>di</strong>s (2002) “Partecipazione/partnership”, in S. Arnolfi, a cura <strong>di</strong>,<br />
Bimbi, F. (1999) “Madri sole in Italia. Esclusione <strong>sociale</strong> e povertà in una prospettiva <strong>di</strong> genere”, in<br />
Mingione, op. cit., pp. 251-272.<br />
Boltanski, L., L. Thévenot (1991) De la justification. Les économies <strong>de</strong> la gran<strong>de</strong>ur, Paris,<br />
Gallimard.<br />
Boltanski,L., E.Chiappello (1999) Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard<br />
Bosco, N., N. Negri (1997) “L’abile povero tra <strong>di</strong>ritti e obbligazioni”, Animazione <strong>sociale</strong>, 6/7, pp.<br />
31-67.<br />
Bricocoli, M. (2002) “””, L’Assistenza Sociale<br />
Castel, R., C. Haroche (2001), Propriété privée, propriété <strong>sociale</strong>, propriété <strong>de</strong> soi. Entretiens sur<br />
la construction <strong>de</strong> l’in<strong>di</strong>vidu mo<strong>de</strong>rne, Paris, Fayard<br />
De Leonar<strong>di</strong>s, O. (1998) In un <strong>di</strong>verso welfare. Sogni e incubi, Milano, Feltrinelli.<br />
De Leonar<strong>di</strong>s, O. (1999) Solidarietà, in : Dizionario <strong>de</strong>l terzo settore<br />
De Leonar<strong>di</strong>s, O. (2000) « Povero abile povero. Il tema <strong>de</strong>lla povertà e le <strong>culture</strong> <strong>de</strong>lla <strong>giustizia</strong>”,<br />
Filosofia e Questioni pubbliche, 2.<br />
De Leonar<strong>di</strong>s, O. (2001) Le istituzioni. Come e perché parlarne, Roma, Carocci.<br />
De Leonar<strong>di</strong>s, O., D. Mauri, F. Rotelli (1994) L’impresa <strong>sociale</strong>, Milano, Anabasi.<br />
Donolo, C. (1997) L’intelligenza <strong>de</strong>lle istituzioni, Milano, Feltrinelli.<br />
Garcia, M., Y.Kazepov (2002) “Why Some People are more Likely to be on Social Assistance than<br />
Others”, in Saraceno, a cura <strong>di</strong>, op. cit.<br />
Garcia. M., C. Saraceno (1999) “Introduction”, in C. Saraceno, ed., Op.cit.<br />
Goo<strong>di</strong>n, R., D. Schmidtz, (1998) Social Welfare and In<strong>di</strong>vidual Responsibility, Cambridge,<br />
Cambridge University Press.<br />
Habermas, J. (1994) “Lotte per il riconoscimento nello stato <strong>de</strong>mocratico <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto”, Ragion<br />
Pratica, n. 3, pp. 132-165.<br />
18
Mead, L. (1997), ed., The New Paternalism: Supervisory Approaches to Poverty, Brookings<br />
Institute.<br />
Mouffe, C. (1998), “Rawls: Political Philosophy without Politics, in D. Rasmussen, ed.,<br />
Universalism versus Communitarianism. Contemporary Debates in Ethics, Cambridge, Mass., The<br />
MIT Press.<br />
Newman, K. (1999) No Shame in My Game: The Worker Poor in the Inner City, New York, A.<br />
Knopf & The Russell Sage Foundation.<br />
Pitch, T. (1998) Un <strong>di</strong>ritto per due, Milano, Il Saggiatore.<br />
Saraceno, C. (1999), ed., “Esopo. Evaluation of Social Policies at the Local Urban Level: Income<br />
Support for the Able Bo<strong>di</strong>ed”, Rapporto <strong>di</strong> ricerca non pubblicato.<br />
Saraceno, C., a cura <strong>di</strong> (2002) Social Assitance Dynamics in Europe, Bristol, The Polity Press.<br />
Sen, A. (1982) “Rights and Agency”, Philosophy and Public Affairs, n. 1.<br />
Sen, A. (1986) Scelta, benessere, equità, Bologna, Il Mulino.<br />
Solow, R. (1998) Work and Welfare, in A. Gutman (ed.) The Tanner Lectures, University Center<br />
for Human Values.<br />
Wilson, W.J. (1996) When Work Disappears: The World of the New Urban Poor, New York, A.<br />
Knopf & The Russell Sage Foundation.<br />
Young, I. (1990) Justice and the Politics of <strong>di</strong>fference, Princeton.<br />
19