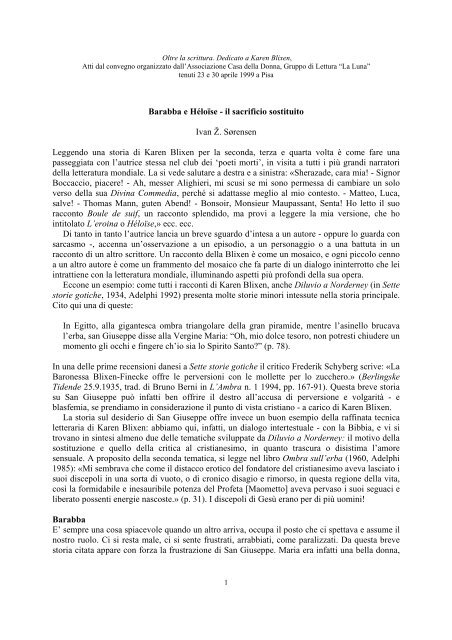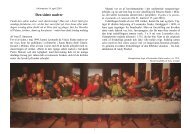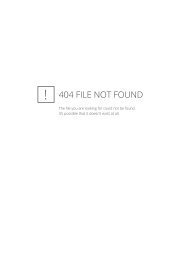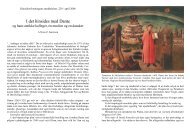Barabba e Héloïse - il sacrificio sostituito Ivan Ž. Sørensen ... - Ivan Z
Barabba e Héloïse - il sacrificio sostituito Ivan Ž. Sørensen ... - Ivan Z
Barabba e Héloïse - il sacrificio sostituito Ivan Ž. Sørensen ... - Ivan Z
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Oltre la scrittura. Dedicato a Karen Blixen,<br />
Atti dal convegno organizzato dall’Associazione Casa della Donna, Gruppo di Lettura “La Luna”<br />
tenuti 23 e 30 apr<strong>il</strong>e 1999 a Pisa<br />
<strong>Barabba</strong> e <strong>Héloïse</strong> - <strong>il</strong> <strong>sacrificio</strong> <strong>sostituito</strong><br />
<strong>Ivan</strong> <strong>Ž</strong>. <strong>Sørensen</strong><br />
Leggendo una storia di Karen Blixen per la seconda, terza e quarta volta è come fare una<br />
passeggiata con l’autrice stessa nel club dei ‘poeti morti’, in visita a tutti i più grandi narratori<br />
della letteratura mondiale. La si vede salutare a destra e a sinistra: «Sherazade, cara mia! - Signor<br />
Boccaccio, piacere! - Ah, messer Alighieri, mi scusi se mi sono permessa di cambiare un solo<br />
verso della sua Divina Commedia, perché si adattasse meglio al mio contesto. - Matteo, Luca,<br />
salve! - Thomas Mann, guten Abend! - Bonsoir, Monsieur Maupassant, Senta! Ho letto <strong>il</strong> suo<br />
racconto Boule de suif, un racconto splendido, ma provi a leggere la mia versione, che ho<br />
intitolato L’eroina o <strong>Héloïse</strong>,» ecc. ecc.<br />
Di tanto in tanto l’autrice lancia un breve sguardo d’intesa a un autore - oppure lo guarda con<br />
sarcasmo -, accenna un’osservazione a un episodio, a un personaggio o a una battuta in un<br />
racconto di un altro scrittore. Un racconto della Blixen è come un mosaico, e ogni piccolo cenno<br />
a un altro autore è come un frammento del mosaico che fa parte di un dialogo ininterrotto che lei<br />
intrattiene con la letteratura mondiale, <strong>il</strong>luminando aspetti più profondi della sua opera.<br />
Eccone un esempio: come tutti i racconti di Karen Blixen, anche D<strong>il</strong>uvio a Norderney (in Sette<br />
storie gotiche, 1934, Adelphi 1992) presenta molte storie minori intessute nella storia principale.<br />
Cito qui una di queste:<br />
In Egitto, alla gigantesca ombra triangolare della gran piramide, mentre l’asinello brucava<br />
l’erba, san Giuseppe disse alla Vergine Maria: “Oh, mio dolce tesoro, non potresti chiudere un<br />
momento gli occhi e fingere ch’io sia lo Spirito Santo?” (p. 78).<br />
In una delle prime recensioni danesi a Sette storie gotiche <strong>il</strong> critico Frederik Schyberg scrive: «La<br />
Baronessa Blixen-Finecke offre le perversioni con le mollette per lo zucchero.» (Berlingske<br />
Tidende 25.9.1935, trad. di Bruno Berni in L’Ambra n. 1 1994, pp. 167-91). Questa breve storia<br />
su San Giuseppe può infatti ben offrire <strong>il</strong> destro all’accusa di perversione e volgarità - e<br />
blasfemia, se prendiamo in considerazione <strong>il</strong> punto di vista cristiano - a carico di Karen Blixen.<br />
La storia sul desiderio di San Giuseppe offre invece un buon esempio della raffinata tecnica<br />
letteraria di Karen Blixen: abbiamo qui, infatti, un dialogo intertestuale - con la Bibbia, e vi si<br />
trovano in sintesi almeno due delle tematiche sv<strong>il</strong>uppate da D<strong>il</strong>uvio a Norderney: <strong>il</strong> motivo della<br />
sostituzione e quello della critica al cristianesimo, in quanto trascura o disistima l’amore<br />
sensuale. A proposito della seconda tematica, si legge nel libro Ombra sull’erba (1960, Adelphi<br />
1985): «Mi sembrava che come <strong>il</strong> distacco erotico del fondatore del cristianesimo aveva lasciato i<br />
suoi discepoli in una sorta di vuoto, o di cronico disagio e rimorso, in questa regione della vita,<br />
così la formidab<strong>il</strong>e e inesaurib<strong>il</strong>e potenza del Profeta [Maometto] aveva pervaso i suoi seguaci e<br />
liberato possenti energie nascoste.» (p. 31). I discepoli di Gesù erano per di più uomini!<br />
<strong>Barabba</strong><br />
E’ sempre una cosa spiacevole quando un altro arriva, occupa <strong>il</strong> posto che ci spettava e assume <strong>il</strong><br />
nostro ruolo. Ci si resta male, ci si sente frustrati, arrabbiati, come paralizzati. Da questa breve<br />
storia citata appare con forza la frustrazione di San Giuseppe. Maria era infatti una bella donna,<br />
1
Oltre la scrittura. Dedicato a Karen Blixen,<br />
Atti dal convegno organizzato dall’Associazione Casa della Donna, Gruppo di Lettura “La Luna”<br />
tenuti 23 e 30 apr<strong>il</strong>e 1999 a Pisa<br />
ma non fu lui a godere di lei <strong>il</strong> 25 marzo, <strong>il</strong> giorno dell’Annunciazione. Lo Spirito Santo - o si<br />
trattava forse dell’arcangelo Gabriele? - assume <strong>il</strong> posto di San Giuseppe, si offre - e Maria<br />
accetta, com’è noto. Secondo Karen Blixen però, quando San Giuseppe, Maria e <strong>il</strong> piccolo Gesù<br />
tornano dall’Egitto, egli prova a ritrovare <strong>il</strong> suo ruolo di marito e soprattutto di uomo. Quella che<br />
sembra una piccola battuta di spirito, in un senso più profondo riguarda un problema di identità,<br />
in questo caso di identità masch<strong>il</strong>e.<br />
Ancora peggiore è <strong>il</strong> caso in cui <strong>il</strong> sostituto non solo si offre, ma si sacrifica per qualcuno. E<br />
per di più senza essere invitato! Questo è l’argomento della storia Il vino del Tetrarca (inserita<br />
nel racconto Deluvio a Norderney), che potrebbe essere interpretata come <strong>il</strong> proto-racconto del<br />
‘<strong>sacrificio</strong> <strong>sostituito</strong>’, <strong>il</strong> nucleo della dottrina cristiana dell’espiazione: Gesù si sacrifica per i<br />
nostri peccati. “Questo è <strong>il</strong> mio sangue,” dice Gesù durante l’ultima Cena, “che è stato sparso per<br />
molti per <strong>il</strong> perdono dei peccati.” (Matteo 26, 28).<br />
Molti sono stati - e sono - sicuramente grati che Gesù sia morto per i nostri peccati, che ci<br />
abbia salvato e che abbia preso la colpa su di sé. Cosa sarebbe accaduto però se un uomo - come<br />
<strong>Barabba</strong> - avesse voluto rendere conto delle proprie azioni? Quest’uomo avrebbe potuto<br />
rispondere con uno dei motti della Blixen: Je responderay, che implica: «risponderò di ciò che<br />
dico o faccio; risponderò dell’impressione che faccio. Sarò responsab<strong>il</strong>e.» (Mit livs mottoer, in:<br />
Karen Blixen, Essays, Gyldendal 1965, p. 15.)<br />
Ma <strong>Barabba</strong> non ne ebbe l’occasione. Nel cristianesimo Gesù è crocifisso al suo posto. E un<br />
uomo orgoglioso e leale - come <strong>Barabba</strong> - non può sopportarlo. «Aveva impressa in viso una<br />
tristezza mortale» (p. 70).<br />
La storia Il vino del tetrarca è in sostanza un dialogo fra Pietro e <strong>Barabba</strong> che si svolge poco<br />
dopo la crocifissione di Gesù. Come narratrice la Blixen è veramente maligna verso i suoi<br />
personaggi: <strong>il</strong> loro è un dialogo fra sordi davvero bizzarro, e lei si rivolge al lettore sparlando alle<br />
loro spalle.<br />
Il fatto è che Pietro è triste perché Gesù è morto, e per di più soffre anche per averlo rinnegato:<br />
«“Sì, sì, sì” fu lesto a rispondere Pietro» alla domanda di <strong>Barabba</strong> se conoscesse Gesù (p. 69). Ma<br />
pochi giorni prima aveva risposto: «No, no, no!» E dice a <strong>Barabba</strong>: «“Bene hai fatto a rischiar la<br />
vita per <strong>il</strong> tuo amico”. E sospirò profondamente.» (p. 72). Pietro non aveva rischiato la vita per <strong>il</strong><br />
suo amico! In compenso, adesso si sta concentrando su quelli che dovevano diventare i dogmi<br />
cristiani: la resurrezione, l’imitazione di Cristo, ecc.<br />
Con questo racconto Karen Blixen ha preso Søren Kierkegaard sulla parola. Lui scrive: «Che<br />
situazione tremenda dovette essere per l’Apostolo Pietro nei giorni della Morte di Cristo - e<br />
Pietro l’aveva rinnegato - di trovarsi separati a quel modo. [...] Sarebbe ut<strong>il</strong>e esporre Pietro sotto<br />
quest’aspetto.» (Diario 1848, Vol. V, Morcelliana 1981, X 1 A 173). E la Blixen lo fa, ma nel<br />
suo modo obliquo, mettendo <strong>Barabba</strong> nel centro.<br />
<strong>Barabba</strong> è presentato nel racconto come un personaggio fiero, dignitoso, coraggioso e<br />
magnifico. «Hai forse saputo da qualcuno ch’io son della razza che fugge davanti al pericolo?»<br />
chiede a Pietro, che naturalmente esita di fronte alla domanda (p. 72). Al contrario di Pietro, i<br />
problemi di <strong>Barabba</strong> sono molto più concreti: <strong>il</strong> vino non gli piace più! «In questi giorni, ho<br />
assaggiato parecchi vini, e tutti m’avevano un cattivo sapore. Non so che cosa sia accaduto al<br />
vino, a Gerusalemme; non ha più profumo né corpo. Io credo che la colpa sia del terremoto di<br />
venerdì; ha fatto andare male tutto quanto <strong>il</strong> vino. [...] E ora, non so proprio che farci”» (p. 70).<br />
Adesso vorrebbe provare un buon vino, per esempio quello che hanno bevuto al festino giovedì<br />
sera - con “una sostanza molto speciale”! -, o quello del Tetrarca.<br />
2
Oltre la scrittura. Dedicato a Karen Blixen,<br />
Atti dal convegno organizzato dall’Associazione Casa della Donna, Gruppo di Lettura “La Luna”<br />
tenuti 23 e 30 apr<strong>il</strong>e 1999 a Pisa<br />
Pietro prova a consolare <strong>Barabba</strong>: «“Amico,” disse poi, “nella vita ci sono altre cose che<br />
danno piacere, oltre al vino del Tetrarca.”» Pietro qui pensa alla vita eterna - vita che <strong>Barabba</strong>,<br />
naturalmente, non ‘conosce’. «“Sì, lo so,” rispose <strong>il</strong> forestiero “ma... e se anche quelle cose<br />
subissero la medesima sorte? A casa, ho due belle mogli che mi aspettano, e poco prima di questi<br />
fatti avevo comperato una vergine di dodici anni. [...] Se volessi, potrei sollazzarmi con quelle<br />
donne. Ma <strong>il</strong> terremoto può aver nuociuto anche a loro, sì che non abbiano più né profumo né<br />
corpo - e che mi resta da fare, allora?”» (p. 73). I due uomini assolutamente non si comprendono.<br />
Paradossalmente, nel dialogo sulla croce emergono i contrasti tra le astrazioni di Pietro e <strong>il</strong><br />
mondo concreto di <strong>Barabba</strong>. «“Figlio mio,” disse [Pietro] con gravità e dolcezza “prendi la tua<br />
croce e segu<strong>il</strong>o. [...] Egli ti aiuterà a portarla”». Pietro pensa ovviamente all’imitazione di Cristo.<br />
Di nuovo <strong>Barabba</strong> prende alla lettera quanto Pietro gli dice, e da uomo forte e fiero, rimane<br />
offeso e sconvolto: «“Aiuto? E chi mai vuole un aiuto per portare una di quelle croci che<br />
fabbricano oggigiorno i falegnami di Gerusalemme? [...] Io, la mia croce l’avrei portata assai<br />
meglio di loro [si riferisce ai due ladri di lato a Gesù]. Credi che non avrei saputo resistere più di<br />
sei ore?”» Agli occhi di <strong>Barabba</strong> quel Gesù è semplicemente un buono a nulla! (p. 73-4).<br />
Si può non essere d’accordo con la Blixen, ma in ogni caso porta avanti <strong>il</strong> proprio punto di<br />
vista in maniera elegante, vale a dire: che <strong>il</strong> cristianesimo e più precisamente la dottrina<br />
dell’espiazione, è l’iniziale guastatore della piacevolezza della vita umana. Il racconto Il vino del<br />
Tetrarca lo mostra concretamente nel fatto che Gesù, occupando <strong>il</strong> posto di <strong>Barabba</strong>, mina la sua<br />
identità, la sua fierezza e la sua dignità. Così <strong>Barabba</strong> finisce nell’insensatezza, nel tedio -<br />
nel’horror vacui. In modo metaforico, e nella consapevolezza di <strong>Barabba</strong>, si trova la causa nel<br />
fatto che <strong>il</strong> terremoto di venerdì ha distrutto <strong>il</strong> vino - e forse le donne. La prospettiva più ampia in<br />
questa interpretazione della dottrina della riconc<strong>il</strong>iazione è naturalmente che <strong>il</strong> cristianesimo,<br />
nell’accezione più profonda, ci rende miseri! Come si vede anche nel racconto Il pesce (in<br />
Racconti d’inverno 1942, Adelphi, 1993. Il titolo danese è Heloïse), dove a Gesù sono state<br />
attribuite le parole seguenti: «Ho insegnato a quella povera e stolta creatura come si fa ad essere<br />
ingiuriati e perseguitati; [...] gli ho affidato la sua salvezza» (p. 243).<br />
<strong>Héloïse</strong><br />
Il racconto L’eroina (in Racconti d’inverno) è da una parte una risposta in forma dialogica a Il<br />
vino del Tetrarca - con la protagonista <strong>Héloïse</strong> in un ruolo all’opposto di Gesù -, da un’altra parte<br />
un ‘contro-racconto’ alla prima novella di Guy de Maupassant Boule de suif (1880, Einaudi 1997,<br />
pp. 7-40).<br />
La novella di Maupassant si svolge all’inizio della guerra franco-prussiana del 1870. Una<br />
compagnia di viaggiatori è in difficoltà, e una prostituta - «piccola, rotonda dappertutto, polposa,<br />
[...] ciò nonostante appetitosa e desiderata» (p. 14) - viene costretta a sacrificare <strong>il</strong> suo corpo, fare<br />
l’amore con l’ufficiale tedesco, perché i suoi onorati compagni di viaggio possano attraversare<br />
<strong>il</strong>lesi la Francia occupata. Come ringraziamento, ella riceve solo <strong>il</strong> loro disprezzo. E’ un racconto<br />
solidamente borghese sulla morale borghese, e anche nella sua ottica critica - l’ipocrisia e la<br />
constatazione che l’irriconoscenza è la ricompensa dei poveri - non si eleva dal contesto<br />
borghese.<br />
La situazione è quasi identica nel racconto della Blixen, ma questa volta <strong>il</strong> punto di vista è<br />
quello del giovane inglese Frederick Lamond, che - guarda caso - sta scrivendo «un libro sulla<br />
dottrina dell’espiazione» (p. 79). Un altro personaggio, <strong>il</strong> vecchio Padre Lamarque, da giovane<br />
aveva invece scritto «un trattato sul rinnegamento di Pietro» (p. 81).<br />
3
Oltre la scrittura. Dedicato a Karen Blixen,<br />
Atti dal convegno organizzato dall’Associazione Casa della Donna, Gruppo di Lettura “La Luna”<br />
tenuti 23 e 30 apr<strong>il</strong>e 1999 a Pisa<br />
Della compagnia fanno inoltre parte due anziane suore, una vedova (in danese: grassotella e<br />
dagli occhi neri) che gestiva un albergo in una città di provincia (come la ‘Boule de suif’!), un<br />
ricco viticultore, e un viaggiatore di commercio (p. 81) - una compagnia molto sim<strong>il</strong>e a quella di<br />
Maupassant. A loro si aggiunge <strong>Héloïse</strong>. Tutti quanti sono bloccati dai tedeschi nella città di<br />
frontiere Saarburg e rischiano di essere fuc<strong>il</strong>ati, in quanto Frederick e Padre Lamarque vengono<br />
accusati di spionaggio dai tedeschi, con un riferimento a un versetto in Isaia. L’ufficiale tedesco<br />
si offre però di fargli proseguire <strong>il</strong> viaggio, a una condizione: dice a <strong>Héloïse</strong>: «per avere i<br />
salvacondotti, dovrete venire vestita come la dea Venere» (p. 87). L’ufficiale tedesco e <strong>Héloïse</strong> si<br />
confrontano in una scena molto tesa - una faida antica, pensa Frederick. Invece di sacrificarsi<br />
immediatamente per i suoi compagni di viaggio, <strong>Héloïse</strong> gli offre un’alternativa, replicando al<br />
soldato tedesco: «La propria salvezza, per ciascuno di loro, è più importante della mia. Che siano<br />
loro a decidere se vogliono comprarla al prezzo da voi proposto.» (p. 88). E’ questo <strong>il</strong> punto<br />
centrale del racconto - e della tematica del ‘<strong>sacrificio</strong> <strong>sostituito</strong>’.<br />
Tutti quanti dissero di no, ad eccezione della vedova che non era presente - aveva «<strong>il</strong> mal di<br />
stomaco per la paura» (p. 97) - e a Frederick che «non disse nulla» (p. 89). Dopo un po’<br />
cominciano a pensare che saranno fuc<strong>il</strong>ati; invece l’ufficiale tedesco manda loro i salvacondotti e<br />
un gran mazzo di rose a <strong>Héloïse</strong> con la dedica: A un’eroina.<br />
Quando viene definita un’eroina, è - a un livello nel racconto - perché offre ai suoi compagni<br />
di viaggio, ai suoi prossimi, la possib<strong>il</strong>ità di scegliere; di scegliere, cioè, se se la sentono, miseri,<br />
di lasciar sacrificare un altro per loro, oppure di accettare <strong>il</strong> proprio destino.<br />
La perdita di identità dell’uomo moderno<br />
Sette anni più tardi Frederick incontra <strong>Héloïse</strong> a Parigi. La vede danzare nuda nello spettacolo La<br />
vendetta di Diana. Dopo lo spettacolo si parlano. Laddove, però, <strong>il</strong> dialogo tra <strong>Héloïse</strong> e<br />
l’ufficiale tedesco era intenso e vibrante, la conversazione con Frederick è contrassegnata da<br />
un’ironia pungente. Frederick non capisce, ma capiscono i lettori attenti.<br />
<strong>Héloïse</strong> parla dell’ufficiale tedesco: «Era un giovane onesto. Sapeva veramente desiderare una<br />
cosa. Molti uomini non ne sono capaci» (p. 97). Abbiamo qui un concentrato della<br />
rappresentazione che la Blixen dà dell’uomo, di un certo tipo di uomo del suo tempo, toccato<br />
dalla civ<strong>il</strong>tà moderna. Molti uomini non sono capaci di desiderare una cosa - specialmente una<br />
donna! Vengono definiti impotenti. I racconti della Blixen sono pieni di uomini impotenti, dove<br />
l’impotenza è espressione della perdita di identità dell’uomo moderno. Talvolta ci sono però<br />
uomini che sono bravi - anche a letto -, spesso personaggi secondari, spesso soldati o marinai, per<br />
esempio <strong>il</strong> marinaio de La storia immortale (in Capricci del destino, 1958, it. 1966) o <strong>il</strong> mozzo de<br />
Il racconto del mozzo (in Racconti d’inverno). Lo è anche <strong>Barabba</strong> - e lo sarebbe anche <strong>il</strong> povero<br />
Giuseppe. Le loro possib<strong>il</strong>ità di sv<strong>il</strong>uppo sessuale tuttavia vengono bloccate e la loro identità è<br />
minata nel ‘racconto cristiano’.<br />
<strong>Héloïse</strong> prosegue così nella sua battuta: «“Molti uomini non ne sono capaci. [...] Voi” disse<br />
“Voi non eravate come gli altri.”» (p. 96). Significa che Frederick non era come gli altri della<br />
compagnia che dissero di no, mentre lui non diceva nulla. Dall’altro lato egli è veramente come<br />
gli uomini che non sono capaci di desiderare una donna. «“Voi avreste potuto esortarmi, in tutta<br />
semplicità, a salvare la mia vita nel modo che voleva lui, senza dare in seguito nessuna<br />
importanza all’episodio. Me ne sono accorta subito. E poi, in quel fiacre, quando abbiamo fatto <strong>il</strong><br />
viaggio insieme sino alla frontiera, e voi non avete detto una sola parola, ne sono stata certa.”»<br />
Questa replica di <strong>Héloïse</strong> è equivoca e scabrosa: a un primo livello parla del <strong>sacrificio</strong> di lei, a un<br />
4
Oltre la scrittura. Dedicato a Karen Blixen,<br />
Atti dal convegno organizzato dall’Associazione Casa della Donna, Gruppo di Lettura “La Luna”<br />
tenuti 23 e 30 apr<strong>il</strong>e 1999 a Pisa<br />
altro rivela che allora avrebbero potuto fare l’amore. «“Sì,” disse [Frederick] lentamente “se l’aveste<br />
proposto voi stessa, di vostra spontanea volontà.” Ed <strong>Héloïse</strong> si mise a ridere.» (pp. 96-7).<br />
Perché ride <strong>Héloïse</strong>? - e sarà probab<strong>il</strong>mente una risata molto ironica. Perché lei stessa infatti lo<br />
propose quella volta nel fiacre. «Tutt’a un tratto lei gli prese la mano» (p. 91), era scritto a questo<br />
punto nel racconto. Poi la scena è tagliata. Non successe niente nella fiacre. E <strong>il</strong> racconto si<br />
chiude con la battuta di <strong>Héloïse</strong>: «“Quanto vorrei, mio caro amico,” ella disse, “che voi mi aveste<br />
vista allora”» (p. 98), così come l’ha appena vista - nuda.<br />
La differenza fra l’ufficiale tedesco e Frederick è espressa anche da uno dei più cari<br />
riferimenti intertestuali di Karen Blixen: i dipinti di Tiziano e Veronese. All’inizio del racconto si<br />
sente come Frederick, nell’Altes Museum di Berlino, gode delle «opere profane dei grandi<br />
maestri» (p. 80). Quando vede <strong>Héloïse</strong> pensa che «ella aveva tutte le grazie delle dee di Tiziano e<br />
del Veronese. I suoi lunghi e morbidi riccioli avevano la stessa pallida sfumatura dorata delle loro<br />
chiome. [...] Talvolta Frederick sbrigliava l’immaginazione, e allora la vedeva negli<br />
atteggiamenti abbandonati delle dee - ma sì, vestita come Venere. Ma queste sue fantasie erano<br />
candide e impersonali.» (pp. 82-83). E’ chiaro che le fantasie del soldato tedesco non sono<br />
‘candide’, quando richiede di vedere <strong>Héloïse</strong> vestita come la dea Venere - lui sa desiderare una<br />
donna! Lui non ha paura, come Frederick, di offenderla. Sia <strong>il</strong> tedesco che <strong>Héloïse</strong> cambiano<br />
colore, arrossano e impallidiscono (p. 87-89) - come fanno sempre i personaggi della Blixen,<br />
quando si rendono conto, interamente o parzialmente, di un nesso, di un mosaico, della loro<br />
natura interna o del piano di Dio. Qui si vede in funzione <strong>il</strong> concetto di anagnoris in Aristotele,<br />
che implica ‘un cambiamento che porta da l’ignoranza a conoscenza’ (Om digtekunsten,<br />
Gyldendal 1970, capitolo 11-12) ovvero quello di metamorfosi in Ovidio. Per l’innocente e casto<br />
Frederick, assolutamente incolore, al contrario «quella sentenza era una deformazione delle<br />
incantevoli fantasie alle quali si era abbandonato lui stesso quando pensava a <strong>Héloïse</strong>.» (p. 87).<br />
Quali sono allora i dipinti che Frederick ha goduto all’Altes Museum di Berlino? Fra gli altri<br />
Venere con organista e Amorino di Tiziano, dove l’organista si volge dall’organo, dall’arte, verso<br />
la nuda Venere. La questione è se la guarda in un modo scomposto e bramoso - oppure se la vede<br />
solo come una musa. Frederick si immagina che sia nella stessa situazione come l’organista, ma<br />
guardava la <strong>Héloïse</strong> senza desiderare - non diceva e non faceva niente - talvolta quando aveva la<br />
possib<strong>il</strong>ità: «e tuttavia, al pari di una musa, gli sedeva accanto come su un trono. [...] In lei c’era<br />
una così squisita, semplice vivezza quale non aveva mai trovato in nessun libro al mondo.» (p.<br />
91).<br />
<strong>Héloïse</strong> non conosce i dipinti che Frederick ha visto, ma è comunque la stessa situazione che<br />
lei desiderava nel fiacre, con un sguardo bramoso da parte di Frederick, ben inteso. «La bellezza<br />
della donna si crea nell’occhio dell’uomo,» dice la Madamigella Malin in D<strong>il</strong>uvio a Norderney<br />
(p. 55), e la Bibbia le attesta che «chiunque consideri una donna con concupiscenza ha già<br />
commesso adulterio con essa nel proprio cuore.» (p. 27).<br />
<strong>Héloïse</strong> vuole essere vista - sia come «una bimba», «una contadinella» che come una donna -<br />
dopo che l’ufficiale tedesco, con <strong>il</strong> suo sguardo, scatenò la sua passione. Frederick invece la vede<br />
solo come una musa ed un’eroina elevata.<br />
Il fatto che <strong>Héloïse</strong> sia (diventata) una donna che vuole e agogna di essere desiderata, emerge<br />
dai riferimento intertestuale alla persona storica dalla quale ha ricavato <strong>il</strong> suo nome d’arte,<br />
<strong>Héloïse</strong> (ca. 1100-64), l’allieva e l’amante del teologo francese Pietro Abelardo (1079-1142).<br />
Quando la <strong>Héloïse</strong> rimane incinta si sposano, ma i parenti di lei catturano e castrano Abelardo.<br />
Dopo che <strong>il</strong> loro rapporto é stato interrotto così tragicamente, finiscono ognuno nel proprio<br />
5
Oltre la scrittura. Dedicato a Karen Blixen,<br />
Atti dal convegno organizzato dall’Associazione Casa della Donna, Gruppo di Lettura “La Luna”<br />
tenuti 23 e 30 apr<strong>il</strong>e 1999 a Pisa<br />
monastero, <strong>Héloïse</strong> come una venerab<strong>il</strong>e badessa. In una lettera <strong>Héloïse</strong> gli scrive:<br />
Quei piaceri ai quale entrambi ci dedicammo totalmente quando eravamo amanti furono tanto<br />
dolci per me che non posso dispiacermene, né essi possono svanire dalla mia memoria,<br />
nemmeno un poco. [...] Sospiro per ciò che non ho potuto avere, invece di dolermi per ciò che<br />
ho commesso. Ciò che facemmo, i luoghi e i momenti in cui lo facemmo, tutto questo è così<br />
infisso nel mio animo, insieme alla tua immagine, che ancora adesso mi comporto come se<br />
fossi con te. Nemmeno dormendo questi ricordi mi danno tregua. A volte un movimento del<br />
mio corpo, o una parola inaspettata, che non riesco a trattenere, rivelano i pensieri del mio<br />
animo. (Lettere di Abelardo e Eloisa, BUR 1996, pp. 229-31).<br />
Così sono anche i sogni della <strong>Héloïse</strong> blixiana, anche se lei non ha nessun ‘piacere dolce’ insieme<br />
con Frederick a rammentare. Con grande rincrescimento <strong>Héloïse</strong> doveva costatare che Frederick<br />
non era ab<strong>il</strong>e a guardarla in questo modo - con desiderio. Non sarà perché ha paura di essere<br />
colpito dal desiderio della donna - di cui non ha la più pallida idea. Solo, al loro commiato, ha<br />
«quel senso quasi soffocante di perdita o di privazione» (p. 92) [nell’edizione danese la citazione<br />
continua: «di qualcosa donde proprio la sua vita dipendeva»]. Soffra dunque, come tanti<br />
personaggi masch<strong>il</strong>i della Blixen, dalla, diciamo, ‘sindrome di Gesù’, quel ‘distacco erotico’<br />
(vedi la citazione sopra da Ombra sull’erba).<br />
Da giovane Karen Blixen studiava storia dell’arte, e visitava tante gallerie dell’arte. La galleria<br />
dei dipinti che ha davanti agli occhi, nel processo di scrittura, include anche i quadri di Tiziano e<br />
Veronese su Venere e Adone, creati sui Metamorfosi di Ovidio. Il mito racconta della dea Venere<br />
che, innamorata, seduce <strong>il</strong> bell’Adone sotto un pioppo (X, 555-9, vedi <strong>il</strong> dipinto di Veronese<br />
Venere e Adone). Gli sconsiglia di dare la caccia agli animali selvatici, specialmente <strong>il</strong> cinghiale,<br />
ma lui preferisce la caccia piuttosto che l’amore (sul dipinto di Tiziano Venere e Adone si vede<br />
come Venere tenta, invano, di trattenere Adone, che sta volgendosi dall’amore terreno), e alla<br />
fine un cinghiale inf<strong>il</strong>za con le zanne <strong>il</strong> suo ventre, e Adone muore. La metamorfosi di Adone<br />
avviene per volere di Venere che, cospargendo <strong>il</strong> suo sangue, origina l’anemone (X, 709-39).<br />
Dopo l’episodio a Saarburg Frederick ha scritto un libro «sui misteri dell’Adone egiziano» (p.<br />
94), un dio di fecondità che continuamente muore e rinasce. Tiziano interpretava, come era<br />
comune nel suo tempo, <strong>il</strong> mito di Venere e Adone in modo cristiano come ‘la risurrezione’.<br />
Un altro riferimento nel racconto L’eroina è quello a Atteone e Diana. Il cacciatore Atteone è<br />
condotto dal caso a scoprire la dea Diana e le sue ninfe nude in un lago fra i boschi. Nella sua<br />
fantasticheria Frederick immagina la <strong>Héloïse</strong> «fra le luminose colonne di marmo, sotto le fronde<br />
profumate, davanti all’abbagliante mare [in danese: lago] azzurro e alle nuvole argentee e rosee<br />
che aveva ammirato nei dipinti. Forse aveva un fanciullo negro al suo servizio.» (p. 83). Si tratta<br />
di una descrizione precisissima del dipinto Diana e Atteone di Tiziano. Della fonte narrativa<br />
ovidiana Adone viene tramuto - come vendetta dalla casta Diana - in cervo e sbranato dai suoi<br />
stessi cani, nonostante che provi a convincerle di essere Atteone (III, 143-252). Nel dipinto La<br />
morte di Atteone di Tiziano si vede anche la Diana che scaglia una freccia su Adone. Frederick<br />
prova apparentemente - attraverso i suoi studi - di trovare se stesso, ma non riesce neanche a dire:<br />
«sono Frederick».<br />
Quando Frederick la rivede a Parigi, <strong>Héloïse</strong> balla nuda nello spettacolo La vendetta di Diana.<br />
Perché questo spettacolo? Nel racconto accadano due metamorfosi con <strong>Héloïse</strong>, uno quando lo<br />
sguardo dell’ufficiale tedesco la tramuta nel Venere appassionata, l’altro quando viene<br />
6
Oltre la scrittura. Dedicato a Karen Blixen,<br />
Atti dal convegno organizzato dall’Associazione Casa della Donna, Gruppo di Lettura “La Luna”<br />
tenuti 23 e 30 apr<strong>il</strong>e 1999 a Pisa<br />
trasformata in Diana. E’ proprio Frederick - con <strong>il</strong> suo modo di guardarla, come musa ed eroina -<br />
che la mette in questo ruolo, fin dall’inizio l’ha identificata con Diana (del dipinto di Tiziano). La<br />
sua apparizione come danzatrice nuda e come la casta e vendicativa Diana è una risposta alla<br />
perdita della sua femmin<strong>il</strong>ità, inflitto dall’uomo che amava, Frederick, colui che né l’aveva vista<br />
né aveva capito la sua sessualità, una sessualità che lei aveva appena riconosciuta. Questo nesso<br />
sorge nel racconto - dietro le spalle dei personaggi - attraverso la voce narrante e le referenze<br />
intertestuali a Ovidio, Tiziano e la <strong>Héloïse</strong> storica. Il risposto, cioè la vendetta - miticamente nella<br />
forma del destino crudele di Adone e Atteone, <strong>il</strong> loro sbranamento - è <strong>il</strong> simbolo del laceramento<br />
interno che colpisce l’uomo perplesso.<br />
Il <strong>sacrificio</strong> <strong>sostituito</strong><br />
Negli occhi di Frederick <strong>Héloïse</strong> è un’eroina, un fatto che a sua volta le creano problemi fatali<br />
come donna! Anche a un altro livello è, infatti, un’eroina, un esempio, perché non si sacrifica.<br />
Lasciati a se stessi - senza esempio - i suoi compagni di viaggio se la sarebbero passata male, ma<br />
<strong>Héloïse</strong> gli offre la possib<strong>il</strong>ità di conservare la loro fierezza e la loro dignità - due parole centrali<br />
nell’opera di Karen Blixen e nella sua concezione della vita. I compagni di viaggio di <strong>Héloïse</strong><br />
hanno avuto in dono la possib<strong>il</strong>ità di fare come lei, l’esempio, cioè di farsi carichi del proprio<br />
destino, di morire coraggiosamente se necessario.<br />
Il dotto teologo Frederick però non lo capisce.<br />
Con riferimento alla risposta negativa della compagnia di viaggio Frederick chiede: «“Perché<br />
ci eravamo comportati così bene?”. “Vi eravate comportati bene, non è forse vero?” disse lei<br />
sorridendogli» (p. 96). Lui non capisce l’ironia - talvolta si comportava in modo passivo, né<br />
diceva di no né di sì. Gli altri, in vece, capivano, almeno Padre Lamarque che morì per la<br />
Comune parigina, «ha compiuto imprese leggendarie; era un eroe!» (p. 95). Imitava l’esempio.<br />
In D<strong>il</strong>uvio a Norderney <strong>il</strong> racconto Il vino del Tetrarca viene presentato come un racconto che<br />
deve «dimostrare che esistono cose peggiori della perdizione» (p. 69), nel testo danese viene<br />
specificato: morte e perdizione, e queste ‘cose peggiori’ sono proprio <strong>il</strong> ‘<strong>sacrificio</strong> <strong>sostituito</strong>’, la<br />
morte di Gesù sulla croce per colpa nostra, la dottrina dell’espiazione.<br />
In realtà nella storia della chiesa cristiana esistono due interpretazioni della dottrina<br />
dell’espiazione. Non é un caso, che proprio Abelardo - l’amante della <strong>Héloïse</strong> storica - sia<br />
l’autore della dottrina soggettiva dell’espiazione. Il punto centrale in questa disciplina è che Gesù<br />
non è una vittima sostituita - come nella dottrina oggettiva dell’espiazione - egli è un maestro, un<br />
modello, un esempio per i seguaci. Seguendo l’esempio di Gesù l’animo umano, cattivo e<br />
peccaminoso, si trasforma in obbedienza alla volontà di Dio, o, con le parole della Blixen: <strong>il</strong><br />
progetto di Dio! (Vedi Johannes Rosendahl: Karen Blixen (1957), Gyldendal 1968, s. 77 e sgg.)<br />
Quando nel racconto l’Eroina, con riferimento a Isaia, si parla delle trasgressioni del mio<br />
popolo (p. 84), ciò significa che ci si rifiuta di seguire <strong>il</strong> progetto di Dio, di chinarsi davanti alla<br />
propria sorte. Vuol dire che si deve seguire la propria natura. Questo è ciò che ‘molti uomini’ non<br />
sono capaci di fare. Il versetto di Isaia è del seguente tenore: «chi si affligge per la sua sorte? Sì,<br />
fu eliminato dalla terra dei viventi, per l’iniquità del mio popolo fu percosso a morte» (Is. 53,8).<br />
Quella che ‘fu eliminata dalla terra dei viventi’ è <strong>Héloïse</strong>, la donna.<br />
Anche se Abelardo era perseguitato - sia per la sua storia d’amore che per la sua dottrina, San<br />
Bernardo per esempio lo bollò come eretico - tuttavia la sua dottrina ha lasciato diverse tracce,<br />
anche tra i riformatori presso i quali <strong>il</strong> suo pensiero assunse <strong>il</strong> nome di “unitarismo” o<br />
7
Oltre la scrittura. Dedicato a Karen Blixen,<br />
Atti dal convegno organizzato dall’Associazione Casa della Donna, Gruppo di Lettura “La Luna”<br />
tenuti 23 e 30 apr<strong>il</strong>e 1999 a Pisa<br />
“socinianismo”, dal riformatore italiano Fausto Sozzini, morto in Polonia nel 1604.<br />
A questo proposito vale menzionare che la famiglia della madre di Karen Blixen, le donne<br />
Westenholz erano per l’appunto unitariane. La zia materna ‘Moster Bess’, con la quale Karen<br />
tenne una vivace corrispondenza, era addirittura tra gli unitariani fondatori, nel 1900, della Libera<br />
società di chiesa - e nel 1908, per una sentenza della Corte Suprema, venne esclusa dalla chiesa<br />
danese a causa delle sue opinioni unitariane. (ibid., p. 68 e sgg.).<br />
La Blixen ha molti punti di contatto con gli unitariani, anche se <strong>il</strong> punto di partenza e le<br />
conclusioni furono diversi. In primis vale la pena di mettere in luce la dottrina soggettiva della<br />
riconc<strong>il</strong>iazione; <strong>il</strong> concetto che «Dio e <strong>il</strong> Diavolo sono uno» (Karen Blixen, La mia Africa 1937,<br />
Feltrinelli 1985, p. 23); <strong>il</strong> rifiuto del peccato originale, della trinità e del dualismo; l’assenza della<br />
natura divina di Gesù, lui è un esempio. Quanto all’ultimo punto si tratta del principio<br />
dell’esempio eroico, non della figura di Cristo di per sé, e soprattutto non di Gesù come un uomo!<br />
Tali opinioni si sono formate anche dalle esperienze che la Blixen fece in Africa, soprattutto<br />
dall’incontro con musulmani e massai. Qui trovò la persona fiera, la quale, seguendo la sua<br />
vocazione e la sua natura, è l’ideale della Blixen. In realtà non si tratta tanto di una questione di<br />
appartenenza ad un sesso o a una classe - anche se nei testi della Blixen si trovano persone fiere<br />
più spesso tra le donne che tra gli uomini, più spesso nell’aristocrazia e nelle classi più povere<br />
che nella borghesia - e più spesso nel passato che nel presente. Ma anche se <strong>il</strong> suo sguardo è<br />
rivolto al passato, le sue tematiche sono attuali, moderne, e pongono le domande centrali della<br />
nostra epoca: Chi sono io? Chi sei tu? E come si diventa taluno?<br />
I racconti della Blixen muovono un’aspra critica alla cultura cristiana e alla civ<strong>il</strong>tà moderna,<br />
ma lei non era un teologo o un f<strong>il</strong>osofo, e non scriveva letteratura realistica (come per esempio<br />
Maupassant), bensì racconti con modelli. Il suo dialogo con la letteratura mondiale, tutti i<br />
riferimenti intertestuali nel suo racconto fanno parte della formazione di un modello, che forse ha<br />
proprio la forma della cicogna della Mia Africa (p. 199). Ma la cicogna è - sempre - un racconto.<br />
8