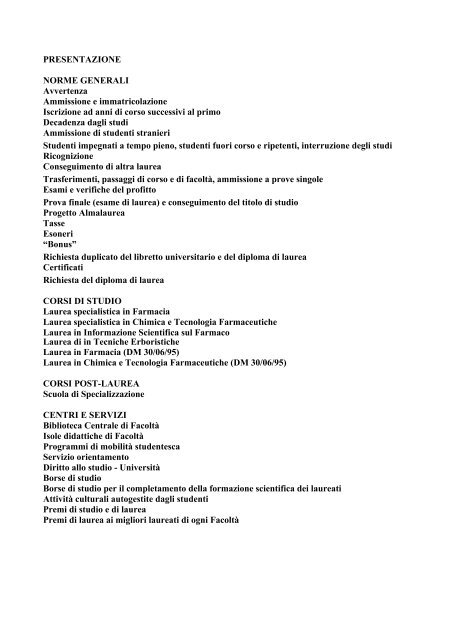formato pdf - Università degli Studi di Bari
formato pdf - Università degli Studi di Bari
formato pdf - Università degli Studi di Bari
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
PRESENTAZIONE<br />
NORME GENERALI<br />
Avvertenza<br />
Ammissione e immatricolazione<br />
Iscrizione ad anni <strong>di</strong> corso successivi al primo<br />
Decadenza dagli stu<strong>di</strong><br />
Ammissione <strong>di</strong> studenti stranieri<br />
Studenti impegnati a tempo pieno, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione <strong>degli</strong> stu<strong>di</strong><br />
Ricognizione<br />
Conseguimento <strong>di</strong> altra laurea<br />
Trasferimenti, passaggi <strong>di</strong> corso e <strong>di</strong> facoltà, ammissione a prove singole<br />
Esami e verifiche del profitto<br />
Prova finale (esame <strong>di</strong> laurea) e conseguimento del titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o<br />
Progetto Almalaurea<br />
Tasse<br />
Esoneri<br />
“Bonus”<br />
Richiesta duplicato del libretto universitario e del <strong>di</strong>ploma <strong>di</strong> laurea<br />
Certificati<br />
Richiesta del <strong>di</strong>ploma <strong>di</strong> laurea<br />
CORSI DI STUDIO<br />
Laurea specialistica in Farmacia<br />
Laurea specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche<br />
Laurea in Informazione Scientifica sul Farmaco<br />
Laurea <strong>di</strong> in Tecniche Erboristiche<br />
Laurea in Farmacia (DM 30/06/95)<br />
Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (DM 30/06/95)<br />
CORSI POST-LAUREA<br />
Scuola <strong>di</strong> Specializzazione<br />
CENTRI E SERVIZI<br />
Biblioteca Centrale <strong>di</strong> Facoltà<br />
Isole <strong>di</strong>dattiche <strong>di</strong> Facoltà<br />
Programmi <strong>di</strong> mobilità studentesca<br />
Servizio orientamento<br />
Diritto allo stu<strong>di</strong>o - <strong>Università</strong><br />
Borse <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o<br />
Borse <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o per il completamento della formazione scientifica dei laureati<br />
Attività culturali autogestite dagli studenti<br />
Premi <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o e <strong>di</strong> laurea<br />
Premi <strong>di</strong> laurea ai migliori laureati <strong>di</strong> ogni Facoltà
Provvidenze agli studenti<br />
Attività part-time<br />
Ente per il Diritto allo <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o Universitario (EDISU)<br />
Servizi a favore <strong>degli</strong> studenti <strong>di</strong>sabili<br />
Cinema e teatro<br />
Centro linguistico <strong>di</strong> Ateneo<br />
Servizio <strong>di</strong> consultazione psicologica<br />
Centro inter<strong>di</strong>partimentale per il Teatro, le Arti visive, la Musica, il Cinema (CUTAMC)<br />
Coro e orchestra dell’Ateneo barese “Harmonia”<br />
Centro Universitario Sportivo (CUS)<br />
La Cappella dell’<strong>Università</strong><br />
Segreterie studenti remote<br />
PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO<br />
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN FARMACIA<br />
Biologia animale e Biologia vegetale<br />
Chimica generale ed inorganica<br />
Fisica con elementi <strong>di</strong> Matematica<br />
Anatomia umana<br />
Chimica analitica con esercitazioni numeriche e <strong>di</strong> laboratorio (A-H)<br />
Chimica analitica con esercitazioni numeriche e <strong>di</strong> laboratorio (I-Z)<br />
Chimica organica (A-H)<br />
Chimica organica (I-Z)<br />
Microbiologia ed Igiene<br />
Biochimica<br />
Farmacognosia con elementi <strong>di</strong> Botanica farmaceutica<br />
Fisiologia generale<br />
Chimica farmaceutica e Tossicologia I<br />
Farmacologia e Farmacoterapia<br />
Analisi dei me<strong>di</strong>cinali I (A)<br />
Analisi dei me<strong>di</strong>cinali I (B)<br />
Biochimica applicata<br />
Patologia generale<br />
Analisi dei me<strong>di</strong>cinali II (A)<br />
Analisi dei me<strong>di</strong>cinali II (B)<br />
Tecnologia farmaceutica (A-H)<br />
Tecnologia farmaceutica (I-Z)<br />
Chimica farmaceutica e Tossicologia II<br />
Farmacologia e Tossicologia<br />
Tecnologia, Socioeconomia e Legislazione farmaceutiche<br />
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE<br />
Chimica generale ed inorganica<br />
Fisica<br />
Matematica<br />
Anatomia umana, Patologia generale e Terminologia me<strong>di</strong>ca<br />
Biologia animale e Microbiologia<br />
Chimica analitica e Complementi <strong>di</strong> Chimica<br />
Biologia vegetale e Farmacognosia<br />
Chimica fisica<br />
Chimica organica I
Analisi dei me<strong>di</strong>cinali (A)<br />
Analisi dei me<strong>di</strong>cinali (B)<br />
Biochimica applicata<br />
Fisiologia generale<br />
Analisi dei Farmaci I<br />
Chimica organica II<br />
Farmacologia e Farmacoterapia<br />
Biochimica<br />
Chimica farmaceutica e Tossicologia I<br />
Meto<strong>di</strong> fisici in Chimica organica<br />
Chimica farmaceutica e Tossicologia II<br />
Impianti dell’industria farmaceutica e Tecnologia farmaceutica<br />
Tecnologia, Socioeconomia e Legislazione farmaceutiche<br />
Analisi dei Farmaci II (A)<br />
Analisi dei Farmaci II (B)<br />
Chimica farmaceutica applicata<br />
Farmacologia e Tossicologia<br />
CORSO DI LAUREA IN INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO<br />
Biologia vegetale ed animale<br />
Chimica generale ed inorganica<br />
Fisica con elementi <strong>di</strong> Matematica<br />
Anatomia umana<br />
Chimica organica<br />
Microbiologia ed Igiene<br />
Biochimica<br />
Fisiologia generale<br />
Patologia generale<br />
Chimica farmaceutica e Tossicologia I<br />
Farmacologia e Farmacoterapia<br />
Chimica farmaceutica e Tossicologia II<br />
Farmacologia e Tossicologia<br />
Tecnologia, Socioeconomia e Legislazione farmaceutiche<br />
CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ERBORISTICHE<br />
Biologia vegetale ed animale<br />
Chimica generale ed inorganica e Chimica organica<br />
Farmacognosia con elementi <strong>di</strong> Botanica farmaceutica<br />
Chimica analitica ed esercitazioni numeriche e <strong>di</strong> laboratorio<br />
Biochimica e Biochimica vegetale<br />
Fisiologia<br />
Microbiologia ed Igiene<br />
Agrotecniche delle colture officinali e Tecnologie <strong>di</strong> trasformazione ed utilizzazione delle<br />
specie officinali<br />
Chimica farmaceutica e Farmacologia generale<br />
Analisi <strong>di</strong> principi attivi <strong>di</strong> natura erboristica e laboratorio <strong>di</strong> estrattiva<br />
Saggi e dosaggi farmacologici<br />
Prodotti cosmetici e <strong>di</strong>etetici <strong>di</strong> origine vegetale<br />
Tecnologia farmaceutica e Legislazione erboristica
PREMESSA<br />
La Facoltà <strong>di</strong> Farmacia è la struttura nella quale si svolgono i Corsi <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o per il conseguimento<br />
delle lauree della Classe 24 e delle Lauree specialistiche della Classe 14S, nonché le altre attività<br />
<strong>di</strong>dattiche e formative previste dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento Didattico d’Ateneo<br />
(RDA) secondo quanto previsto dal DM 509 del 1999 e reso attivo a partire dall’a.a. 2001-2002.<br />
La Facoltà <strong>di</strong> Farmacia conferisce i seguenti titoli:<br />
Classe 14S “Farmacia e farmacia industriale”<br />
Laurea specialistica in:<br />
Farmacia;<br />
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.<br />
Classe 24 “Scienze e tecnologie farmaceutiche"<br />
Laurea in:<br />
Informazione Scientifica sul Farmaco;<br />
Tecniche Erboristiche.<br />
Le due Lauree specialistiche in Farmacia e CTF, istituite con il DM 509 del 1999, hanno le<br />
medesime attribuzioni giuri<strong>di</strong>che e professionali riservate ai laureati dei curricula istituiti con i<br />
precedenti or<strong>di</strong>namenti, DPR 1988 e DM 1995.<br />
I Corsi <strong>di</strong> laurea specialistici sono riconosciuti per svolgere attività professionale a livello europeo<br />
e, in accordo con le <strong>di</strong>rettive UE, hanno la durata <strong>di</strong> cinque anni. Il numero delle annualità e <strong>degli</strong><br />
esami è <strong>di</strong> 19,5 per il Corso <strong>di</strong> laurea in Farmacia e <strong>di</strong> 24 per il Corso <strong>di</strong> laurea in Chimica e<br />
Tecnologia Farmaceutiche. Gli insegnamenti e i loro contenuti programmatici hanno subìto <strong>di</strong><br />
recente un sostanziale rinnovamento nell’intento <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensionarli meglio alle esigenze delle future<br />
professioni. Entrambi i Corsi <strong>di</strong> laurea prevedono, come completamento del curriculum <strong>di</strong> stu<strong>di</strong><br />
universitari, un periodo <strong>di</strong> tirocinio da compiersi presso una farmacia pubblica o privata. Per<br />
l’abilitazione all’esercizio della professione è previsto un esame <strong>di</strong> stato da compiersi dopo la<br />
laurea. Il Corso <strong>di</strong> laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche prevede, come esame finale <strong>di</strong><br />
laurea, la <strong>di</strong>scussione <strong>di</strong> una tesi sperimentale, per il Corso <strong>di</strong> laurea in Farmacia questa può avere<br />
anche carattere compilativo.<br />
Il titolo accademico conseguito in questi due Corsi <strong>di</strong> laurea specialistici prevede, in accordo con la<br />
normativa UE, sbocchi occupazionali che, oltre al settore del farmaco, interessano cosmetica,<br />
fitoterapia, <strong>di</strong>etetica, tossicologia ed ambiente. Nel settore più vicino al farmaco assumono<br />
particolare rilevanza le seguenti attività: ricerca, produzione, controllo, <strong>di</strong>stribuzione, informazione<br />
ed utilizzazione. Le prime tre attività costituiscono settore preferenziale, anche se non esclusivo,<br />
dei laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, mentre le altre sono maggiormente coerenti<br />
con la preparazione culturale dei laureati in Farmacia. I laureati della classe 14S possono iscriversi<br />
all’Or<strong>di</strong>ne professionale dei Farmacisti o dei Chimici.<br />
Dei due Corsi <strong>di</strong> laurea triennali della classe 24, Informazione Scientifica sul Farmaco e Tecniche<br />
Erboristiche, il primo si articola in 14 annualità, cui consegue identico numero <strong>di</strong> esami, il secondo<br />
ne contempla 13. Entrambi i corsi vedono la loro ultimazione con la <strong>di</strong>ssertazione scritta <strong>di</strong> un<br />
argomento che costituisce l’esame finale <strong>di</strong> laurea.<br />
La nuova normativa prevede che, per conseguire la Laurea, è necessario aver ottenuto un<br />
determinato numero <strong>di</strong> “cre<strong>di</strong>ti” che è pari a 180 nella laurea triennale e a 300 in quella<br />
quinquennale. Considerato che un cre<strong>di</strong>to corrisponde a 25 ore <strong>di</strong> attività culturale, il numero <strong>di</strong><br />
cre<strong>di</strong>ti totali per ottenere la Laurea quantifica l’impegno globale dello studente per raggiungere tale<br />
obiettivo. Parte <strong>di</strong> questi cre<strong>di</strong>ti caratterizzano l’impegno devoluto a quegli insegnamenti che si<br />
concludono con un esame, altri invece vengono utilizzati per attività culturali <strong>di</strong>verse come
<strong>di</strong>dattica libera, tirocinio, stage, conoscenze linguistiche ed informatiche, lavoro <strong>di</strong> tesi e<br />
quant’altro le commissioni <strong>di</strong>dattiche annualmente programmeranno.<br />
Nell’ambito della Facoltà, inoltre, è da molti anni attivata una Scuola <strong>di</strong> Specializzazione in<br />
Farmacia Ospedaliera della durata <strong>di</strong> tre anni, il cui accesso avviene previo concorso. Il Diploma<br />
conseguito costituisce il requisito obbligatorio per accedere ai concorsi per le farmacie <strong>degli</strong><br />
ospedali.<br />
I Corsi <strong>di</strong> laurea della Facoltà sono organizzati con <strong>di</strong>dattica semestrale.<br />
Le lezioni si terranno nei seguenti perio<strong>di</strong>:<br />
- I Semestre: dal lunedì successivo al 15 settembre al venerdì successivo al 15 <strong>di</strong>cembre<br />
- II Semestre: dal lunedì successivo al 1 marzo al venerdì successivo al 10 giugno.<br />
Tutti i Corsi <strong>di</strong> laurea della Facoltà prevedono la frequenza obbligatoria.<br />
Gli esami <strong>di</strong> profitto si terranno nei perio<strong>di</strong> in cui non è presente l’attività <strong>di</strong>dattica (4 appelli nel<br />
periodo invernale, 5 appelli nel periodo estivo: le date relative saranno fissate in apposito<br />
calendario).<br />
Per le Lauree specialistiche gli esami del terzo e del quarto anno possono essere sostenuti solo dopo<br />
aver superato gli esami del primo e secondo anno, rispettivamente.<br />
IL PRESIDE<br />
Prof. Vincenzo Tortorella
Avvertenza<br />
Secondo quanto previsto dal DPR 28 <strong>di</strong>cembre 2000 n. 445 (TU delle <strong>di</strong>sposizioni legislative e<br />
regolamentari in materia <strong>di</strong> documentazione amministrativa), si avvertono gli studenti e tutte le<br />
categorie <strong>di</strong> utenti universitari, comprese nei paragrafi della presente sezione e nelle successive<br />
(laureati, dottori <strong>di</strong> ricerca, etc.), che tutti i certificati richiesti in allegato per l’espletamento delle<br />
pratiche amministrative e/o <strong>di</strong> segreteria, con esclusione dei certificati me<strong>di</strong>co-sanitari, possono<br />
essere sostituiti da idonea autocertificazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.<br />
AMMISSIONE E IMMATRICOLAZIONE<br />
(dall’1 agosto al 5 novembre 2003)<br />
Per iscriversi all’<strong>Università</strong> è necessario aver conseguito un <strong>di</strong>ploma <strong>di</strong> scuola me<strong>di</strong>a superiore <strong>di</strong><br />
durata quinquennale.<br />
Coloro che siano in possesso <strong>di</strong> <strong>di</strong>ploma <strong>di</strong> durata quadriennale potranno iscriversi se abbiano<br />
superato l’anno integrativo; in mancanza, i competenti Organi della Facoltà prescelta<br />
in<strong>di</strong>vidueranno gli eventuali debiti formativi da recuperare.<br />
Chi sia fornito <strong>di</strong> una laurea, <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ploma rilasciato da una scuola <strong>di</strong>retta a fini speciali, o <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>ploma ISEF, può iscriversi a qualsiasi Facoltà (questa norma non è valida per i <strong>di</strong>plomati in<br />
Vigilanza Scolastica).<br />
Per immatricolarsi ai Corsi <strong>di</strong> laurea a numero programmato, lo studente dovrà sostenere una prova<br />
<strong>di</strong> ammissione, svolta secondo modalità e termini a tal fine stabiliti.<br />
Lo studente non può mai iscriversi contemporaneamente a due Corsi <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o. Se la<br />
contemporaneità venisse comunque rilevata, lo studente decade dal Corso <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o cui si è iscritto<br />
successivamente alla prima iscrizione.<br />
Per potersi immatricolare, lo studente deve:<br />
a) munirsi dell’apposita modulistica pre<strong>di</strong>sposta dall’<strong>Università</strong> in <strong>di</strong>stribuzione presso l’Ufficio<br />
Stampati dell’Ateneo barese, le Segreterie delle Facoltà decentrate e le Segreterie remote,<br />
comprendente il modulo <strong>di</strong> conto corrente postale relativo alla tassa <strong>di</strong> immatricolazione;<br />
b) allegare quanto segue:<br />
• due fotografie identiche <strong>formato</strong> tessera, <strong>di</strong> cui una autenticata in bollo da un funzionario<br />
dell’<strong>Università</strong> a ciò incaricato, ovvero da un Ufficio comunale o da un notaio;<br />
• attestazione del versamento della tassa <strong>di</strong> immatricolazione <strong>di</strong> 170,00 Euro (causale I 2004); (lo<br />
studente portatore <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap non inferiore al 66% è tenuto al solo versamento <strong>di</strong> 10,33 Euro per<br />
bollo virtuale);<br />
• attestazione del versamento della tassa regionale a favore dell’EDISU (Ente per il Diritto allo<br />
<strong>Stu<strong>di</strong></strong>o Universitario) <strong>di</strong> 77,47 Euro sul c/c 860700 (sono esonerati dal pagamento della tassa<br />
regionale gli studenti portatori <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap non inferiore al 66%);<br />
• eventuale attestazione <strong>di</strong> versamento dell’indennità <strong>di</strong> mora qualora ci si immatricoli, previa<br />
autorizzazione del Rettore, oltre i termini stabiliti;<br />
• fotocopia <strong>di</strong> un documento <strong>di</strong> riconoscimento in corso <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà;<br />
• certificato <strong>di</strong> vaccinazione antitubercolare rilasciato da un centro antitubercolare regionale (solo<br />
per coloro che si immatricolano alla Facoltà <strong>di</strong> Me<strong>di</strong>cina e Chirurgia);<br />
• gli studenti portatori <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap devono altresì allegare certificazione rilasciata ai sensi della<br />
normativa vigente, attestante la con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> portatore <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap con la relativa percentuale <strong>di</strong><br />
invali<strong>di</strong>tà. Per i componenti del nucleo familiare portatori <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap allegare la medesima<br />
certificazione;<br />
• copia autenticata del permesso <strong>di</strong> soggiorno relativo all’anno 2003 (solo per studenti stranieri<br />
non comunitari non soggiornanti in Italia).
Gli studenti provenienti da paesi in via <strong>di</strong> sviluppo, per ottenere la prevista riduzione <strong>di</strong> tasse e<br />
contributi, devono allegare idonea documentazione rilasciata dall’Autorità <strong>di</strong>plomatica italiana del<br />
paese <strong>di</strong> provenienza, attestante le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>sagio economico.<br />
Il modulo <strong>di</strong> immatricolazione e i relativi allegati dovranno essere consegnati presso i seguenti punti<br />
<strong>di</strong> raccolta:<br />
• Segreteria Studenti della Facoltà a cui ci si immatricola;<br />
• Segreterie remote.<br />
L’<strong>Università</strong> provvederà ad inviare a domicilio il libretto universitario e i successivi moduli <strong>di</strong><br />
versamento personalizzati.<br />
ISCRIZIONE AD ANNI DI CORSO SUCCESSIVI AL PRIMO<br />
(dall’1 agosto al 5 novembre 2003)<br />
Per l’iscrizione agli anni <strong>di</strong> corso successivi al primo, lo studente dovrà presentare domanda su<br />
apposito modulo pre<strong>di</strong>sposto dall’<strong>Università</strong>, in <strong>di</strong>stribuzione presso l’Ufficio Stampati dell’Ateneo<br />
e le Segreterie remote, allegando i seguenti documenti:<br />
• attestazioni <strong>di</strong> frequenza, ove necessarie;<br />
• fotocopia attestazione dei versamenti della prima rata d’iscrizione all’anno accademico 2003-2004<br />
(causale I –170,00 Euro) e della seconda rata relativa all’anno precedente (causale II), (lo studente<br />
portatore <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap non inferiore al 66% è tenuto al solo versamento <strong>di</strong> 10,33 Euro per bollo<br />
virtuale). Tali bollettini <strong>di</strong> versamento vengono inviati per posta dall’<strong>Università</strong>;<br />
• attestazione del versamento della tassa regionale a favore dell’EDISU (Ente per il Diritto allo<br />
<strong>Stu<strong>di</strong></strong>o Universitario) <strong>di</strong> 77,47 Euro sul c/c 860700 (sono esonerati dal pagamento della tassa<br />
regionale gli studenti portatori <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap non inferiore al 66%);<br />
• copia autenticata del permesso <strong>di</strong> soggiorno relativo all’anno 2003 (solo per studenti stranieri non<br />
comunitari non soggiornanti in Italia);<br />
• eventuale ricevuta <strong>di</strong> versamento dell’indennità <strong>di</strong> mora qualora ci si iscriva, previa autorizzazione<br />
del Rettore, oltre i termini stabiliti;<br />
• fotocopia <strong>di</strong> un documento <strong>di</strong> riconoscimento in corso <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà;<br />
• gli studenti portatori <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap devono altresì allegare certificazione rilasciata ai sensi della<br />
normativa vigente, attestante la con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> portatore <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap con la relativa percentuale <strong>di</strong><br />
invali<strong>di</strong>tà. Per i componenti del nucleo familiare portatori <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap allegare la medesima<br />
certificazione.<br />
Gli studenti provenienti da paesi in via <strong>di</strong> sviluppo, per ottenere la prevista riduzione <strong>di</strong> tasse e<br />
contributi, devono allegare idonea documentazione rilasciata dall’Autorità <strong>di</strong>plomatica italiana del<br />
paese <strong>di</strong> provenienza, attestante le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>sagio economico.<br />
I centri <strong>di</strong> raccolta dei suddetti documenti sono:<br />
• Segreteria Studenti della Facoltà a cui si è iscritti;<br />
• Segreterie remote.<br />
DECADENZA DAGLI STUDI<br />
Non è previsto l’istituto della decadenza dalla qualità <strong>di</strong> studente dopo otto anni <strong>di</strong> inattività<br />
scolastica; pertanto, è consentito presentare istanza <strong>di</strong> iscrizione, previa ricognizione della carriera,<br />
con riferimento agli esami già superati, nonché alle frequenze acquisite, e previo versamento delle<br />
tasse e dei contributi dovuti, purché non sia intervenuto atto formale <strong>di</strong> cessazione dagli stu<strong>di</strong>.
AMMISSIONE DI STUDENTI STRANIERI<br />
Gli studenti stranieri sono ammessi all’<strong>Università</strong> dopo aver superato specifiche prove <strong>di</strong><br />
ammissione, e per gli extracomunitari entro il limite <strong>di</strong> posti messi a <strong>di</strong>sposizione (gli studenti<br />
comunitari e categorie parificate non gravano sui posti <strong>di</strong>sponibili).<br />
Si riportano <strong>di</strong> seguito le norme contenute nella Circolare MIUR dell’8/5/2003, sottolineando,<br />
tuttavia, che le scadenze previste devono, fino a <strong>di</strong>versa <strong>di</strong>sposizione, intendersi aggiornate all’anno<br />
2003.<br />
Gli studenti extracomunitari non residenti in Italia devono presentare la domanda <strong>di</strong> preiscrizione<br />
alla Rappresentanza italiana con giuris<strong>di</strong>zione sul territorio nel quale risiedono, la quale provvederà<br />
all’autenticazione della firma e della fotografia, entro il 7 giugno 2003 (Modello A).<br />
Si precisa che nella domanda si deve in<strong>di</strong>care un solo corso <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o e l’<strong>Università</strong> presso la quale<br />
ci si intende iscrivere.<br />
Al Modello A, redatto in originale e duplice copia, dovranno essere allegati i seguenti documenti:<br />
a) titolo finale <strong>degli</strong> stu<strong>di</strong> secondari in originale, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti <strong>di</strong><br />
legge;<br />
b) certificato attestante il superamento dell’eventuale prova <strong>di</strong> idoneità accademica che fosse<br />
prevista per l’accesso all’<strong>Università</strong> del paese <strong>di</strong> provenienza (es.: Vestibular in Brasile,<br />
Selectividad in Spagna, Prova de Afericao o Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior in<br />
Portogallo, etc.). Non è richiesto tuttavia il superamento <strong>di</strong> esami in loco che si configurino<br />
esclusivamente come “concorsi” per la definizione dei vincitori dei posti programmati in singoli<br />
corsi o facoltà a numero chiuso;<br />
c) certificato attestante gli stu<strong>di</strong> accademici parziali già compiuti, qualora il titolo <strong>degli</strong> stu<strong>di</strong><br />
secondari sia stato conseguito al termine <strong>di</strong> un periodo inferiore ai 12 anni <strong>di</strong> scolarità e, pertanto,<br />
rientri nella categoria <strong>di</strong> cui alla Circolare ministeriale dell’8/5/2003 o si richieda abbreviazione <strong>di</strong><br />
corso (in quest’ultimo caso, il certificato dovrà specificare gli esami superati ed essere corredato da<br />
documentazione ufficiale circa i programmi <strong>degli</strong> esami stessi), ovvero titolo post-secondario<br />
conseguito in un Istituto Superiore non universitario.<br />
Relativamente a quanto in<strong>di</strong>cato nei punti a), b) e c), i can<strong>di</strong>dati devono esibire alla Rappresentanza<br />
<strong>di</strong>plomatico-consolare italiana i titoli <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o già legalizzati dalle competenti Autorità del paese<br />
che li ha rilasciati, ove previsto dalle norme locali. Per i paesi che hanno aderito alla Convenzione<br />
dell’Aja del 15/10/1961, i documenti dovranno essere muniti del timbro “Apostille” previsto da tale<br />
Convenzione e apposto a cura delle competenti Autorità locali.<br />
d) eventuali certificati <strong>di</strong> competenza in lingua italiana rilasciati da una delle seguenti Istituzioni<br />
universitarie: III <strong>Università</strong> <strong>degli</strong> <strong>Stu<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> Roma, <strong>Università</strong> per Stranieri <strong>di</strong> Perugia e <strong>Università</strong> per<br />
Stranieri <strong>di</strong> Siena, o attestati <strong>di</strong> frequenza rilasciati da altre <strong>Università</strong> che abbiano istituito corsi ai<br />
sensi dell’articolo 46, comma 3, del DPR 31 agosto 1999, n. 394, anche in convenzione con altre<br />
istituzioni formative, enti locali e regioni. Tali certificazioni, sulla base delle autonome decisioni dei<br />
singoli Atenei, possono costituire titolo utile per l’esonero dalla prova <strong>di</strong> conoscenza della lingua<br />
italiana <strong>di</strong> cui alla Circolare ministeriale dell’8/5/2003 ovvero per l’attribuzione <strong>di</strong> punteggio<br />
supplementare ai fini dell’inserimento nelle graduatorie <strong>degli</strong> idonei (nel caso <strong>di</strong> certificazioni<br />
corrispondenti ai livelli <strong>di</strong> competenza più elevati). Gli studenti interessati possono rivolgersi<br />
<strong>di</strong>rettamente alle predette <strong>Università</strong> ovvero agli Istituti Italiani <strong>di</strong> Cultura all’estero, al fine <strong>di</strong><br />
conoscere le modalità per ottenere tali certificazioni.<br />
e) due fotografie (<strong>di</strong> cui una verrà autenticata dalla Rappresentanza italiana competente per<br />
territorio).<br />
Tutti i documenti redatti in lingua straniera vanno corredati <strong>di</strong> traduzione ufficiale in lingua italiana<br />
(la traduzione dovrà essere fatta eseguire a cura <strong>degli</strong> interessati e, nel caso <strong>di</strong> traduzioni rilasciate<br />
da traduttori locali, sarà confermata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio, alla<br />
quale i can<strong>di</strong>dati possono rivolgersi per ogni informazione. I can<strong>di</strong>dati che si trovino
temporaneamente in Italia possono rivolgersi al Tribunale <strong>di</strong> zona ovvero a traduttori ufficiali o<br />
giurati, o anche alle rappresentanze <strong>di</strong>plomatico-consolari, operanti in Italia, del paese ove il<br />
documento è stato rilasciato).<br />
La Rappresentanza italiana restituirà agli interessati i titoli <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o originali muniti <strong>di</strong><br />
legalizzazione consolare - salvo il caso <strong>di</strong> esonero da tale atto in virtù <strong>di</strong> accor<strong>di</strong> e convenzioni<br />
internazionali - e <strong>di</strong> “<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> valore in loco”, inoltrando all’<strong>Università</strong> prescelta dal<br />
can<strong>di</strong>dato fotocopia autenticata <strong>degli</strong> stessi.<br />
Entro otto giorni dal loro ingresso in Italia i can<strong>di</strong>dati devono presentarsi alla Questura della città in<br />
cui intendono stabilire la propria <strong>di</strong>mora, al fine <strong>di</strong> ottenere il rilascio del permesso <strong>di</strong> soggiorno per<br />
motivi <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o. Gli studenti stranieri, successivamente all’immatricolazione ad un corso<br />
universitario per l’a.a. 2003-2004, devono richiedere al Questore della Provincia in cui si trovano il<br />
rinnovo del permesso <strong>di</strong> soggiorno per l’intero anno 2004, almeno 30 giorni prima della scadenza.<br />
I can<strong>di</strong>dati si presentano alle prove d’esame presso l’<strong>Università</strong> prescelta muniti del passaporto con<br />
lo specifico visto d’ingresso per “stu<strong>di</strong>o” e del permesso <strong>di</strong> soggiorno.<br />
Le prove si svolgeranno il giorno 3 settembre 2003 come segue:<br />
• studenti delle Facoltà scientifiche (Agraria, Farmacia, Me<strong>di</strong>cina e Chirurgia, Scienze MMFFNN,<br />
Scienze Biotecnologiche, Me<strong>di</strong>cina Veterinaria): Aula VI (piano terra) della Facoltà <strong>di</strong> Farmacia,<br />
Campus Universitario, Via Orabona n. 4, <strong>Bari</strong>;<br />
• studenti delle Facoltà morali (Economia, Giurisprudenza, Lettere e Filosofia, Lingue e Letterature<br />
straniere, Scienze della Formazione, Scienze Politiche): Aula I (piano terra) della Facoltà <strong>di</strong><br />
Economia, via Camillo Rosalba, 53, <strong>Bari</strong>.<br />
Entro quin<strong>di</strong>ci giorni dallo svolgimento delle prove <strong>di</strong> ammissione, saranno affisse le graduatorie.<br />
Gli ammessi dovranno presentare le domande <strong>di</strong> immatricolazione presso le Segreterie del Corso<br />
universitario prescelto.<br />
I can<strong>di</strong>dati comunitari ovunque residenti e quelli extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia,<br />
possono accedere alla formazione universitaria in Italia senza limitazioni <strong>di</strong> “contingente”,<br />
presentando domanda <strong>di</strong> iscrizione <strong>di</strong>rettamente all’<strong>Università</strong> prescelta (Mod. B), purché abbiano<br />
conseguito un titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o valido e superino:<br />
a) la prova <strong>di</strong> conoscenza della lingua italiana e la contestuale prova <strong>di</strong> cultura generale;<br />
b) l’eventuale prova <strong>di</strong> ammissione, se trattasi <strong>di</strong> Corso <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o a numero programmato.<br />
Per informazioni rivolgersi a:<br />
Segreteria Generale Studenti (Palazzo Ateneo), tel. 0805714512; fax 0805714658; e-mail: segr.gen.stud@area-segrstudenti.uniba.it<br />
STUDENTI IMPEGNATI A TEMPO PIENO,<br />
STUDENTI FUORI CORSO E RIPETENTI,<br />
INTERRUZIONE DEGLI STUDI<br />
1. I Regolamenti <strong>di</strong>dattici <strong>di</strong> ogni Corso <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> (escluso il Dottorato <strong>di</strong> Ricerca) possono prevedere<br />
specifiche forme <strong>di</strong> attribuzione dei cre<strong>di</strong>ti formativi universitari per studenti lavoratori o comunque<br />
impossibilitati, per comprovate ragioni personali, economiche o sociali, alla frequenza a tempo<br />
pieno delle attività <strong>di</strong>dattiche. La qualità <strong>di</strong> studente a tempo parziale dovrà essere annotata dalla<br />
Segreteria studenti sul libretto personale dello studente.<br />
2. Lo studente si considera fuori corso quando, avendo frequentato le attività formative previste<br />
dall’Or<strong>di</strong>namento del suo Corso, non abbia superato gli esami e le altre prove <strong>di</strong> verifica previsti per<br />
ciascun anno <strong>di</strong> corso e/o per l’intero curriculum e non abbia acquisito entro la durata normale del<br />
Corso medesimo il numero <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti necessario al conseguimento del titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o.<br />
3. Lo studente fuori corso non ha obblighi <strong>di</strong> frequenza, ma deve superare le prove mancanti alla<br />
propria carriera universitaria entro termini determinati, su proposta del Collegio <strong>di</strong>dattico
interessato, dal Consiglio <strong>di</strong> Classe. In caso contrario, le attività formative <strong>di</strong> cui egli ha usufruito<br />
possono essere considerate non più attuali e dei cre<strong>di</strong>ti acquisiti si può verificare l’obsolescenza. Il<br />
Collegio <strong>di</strong>dattico provvede in tali casi a determinare i nuovi obblighi formativi per il<br />
conseguimento del titolo. Il trasferimento dello studente fuori corso non è subor<strong>di</strong>nato alla<br />
sussistenza <strong>di</strong> gravi e comprovati motivi, come richiesto dalla normativa previgente.<br />
4. Si considera studente ripetente lo studente che entro la durata normale del Corso non abbia<br />
ottenuto il riconoscimento della frequenza, ove richiesto, per tutte le attività formative previste<br />
dall’Or<strong>di</strong>namento <strong>di</strong>dattico.<br />
5. Lo studente che non abbia acquisito attestati <strong>di</strong> frequenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>scipline <strong>di</strong> anni precedenti, può a<br />
sua richiesta iscriversi come ripetente dell’ultimo anno frequentato avendo come obbligo la<br />
frequenza dei soli corsi non frequentati.<br />
6. Il Manifesto annuale deliberato dal Senato Accademico può prevedere su decisione del Consiglio<br />
<strong>di</strong> Amministrazione una <strong>di</strong>fferenziazione nel pagamento delle tasse dovute dagli studenti ripetenti e<br />
fuori corso.<br />
7. Agli iscritti a Corsi <strong>di</strong> Specializzazione o a Master, che siano ammessi a frequentare un Corso <strong>di</strong><br />
Dottorato <strong>di</strong> Ricerca, sia presso la stessa, sia presso altra <strong>Università</strong>, si applicano le normative<br />
vigenti (art. 8 della Legge 30 novembre 1989, n. 398).<br />
RICOGNIZIONE<br />
(Ripresa <strong>degli</strong> stu<strong>di</strong> dopo abbandono temporaneo)<br />
Può accadere che lo studente, senza voler necessariamente rinunciare agli stu<strong>di</strong>, si trovi nella<br />
con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> interromperli per qualche anno. In questo caso, l’interessato, quando decide <strong>di</strong><br />
riprendere gli stu<strong>di</strong>, si può rivolgere alla Segreteria che gli fornisce i moduli <strong>di</strong> conto corrente per<br />
effettuare i versamenti delle tasse arretrate, relative agli anni accademici <strong>di</strong> inattività.<br />
Per ciascun anno <strong>di</strong> interruzione lo studente è tenuto a pagare soltanto la speciale tassa <strong>di</strong><br />
ricognizione <strong>di</strong> 50,00 Euro e non altri contributi. Si fa presente che se lo studente effettua la<br />
ricognizione, non può sostenere esami prima della sessione estiva del nuovo anno (2003-2004).<br />
Se si desidera sostenere esami prima <strong>di</strong> tale data occorre iscriversi per l’a.a. 2002-2003 in qualità <strong>di</strong><br />
fuori corso pagando le previste tasse.<br />
CONSEGUIMENTO DI ALTRA LAUREA<br />
Chi è in possesso <strong>di</strong> Laurea o <strong>di</strong> Laurea specialistica e intende conseguire un ulteriore titolo <strong>di</strong><br />
stu<strong>di</strong>o del medesimo livello può chiedere al Preside <strong>di</strong> Facoltà l’iscrizione ad un anno <strong>di</strong> Corso<br />
successivo al primo. Tali domande verranno valutate dal Consiglio <strong>di</strong>dattico interessato, che<br />
suggerirà al Consiglio <strong>di</strong> Classe le eventuali delibere in proposito.<br />
TRASFERIMENTI, PASSAGGI DI CORSO E DI FACOLTÀ,<br />
AMMISSIONE A PROVE SINGOLE<br />
1. Le domande <strong>di</strong> trasferimento presso l’<strong>Università</strong> <strong>di</strong> studenti provenienti da altra <strong>Università</strong> e le<br />
domande <strong>di</strong> passaggio <strong>di</strong> Corso <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> sono subor<strong>di</strong>nate ad approvazione da parte del Consiglio <strong>di</strong><br />
Classe <strong>di</strong> destinazione, che valuta, sentito il parere del Consiglio <strong>di</strong>dattico interessato, l’eventuale<br />
riconoscimento totale o parziale della carriera <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o fino a quel momento seguita, con la<br />
convalida <strong>di</strong> esami sostenuti e cre<strong>di</strong>ti acquisiti, e in<strong>di</strong>ca l’anno <strong>di</strong> Corso al quale lo studente viene<br />
iscritto e l’eventuale debito formativo da assolvere. Quando un Corso viene totalmente riconosciuto,<br />
il numero <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti attribuito è pari a quello previsto per quel Corso nella struttura <strong>di</strong>dattica in cui lo
studente si trasferisce, in<strong>di</strong>pendentemente dal suo valore nella struttura <strong>di</strong> provenienza. Gli<br />
adempimenti per il riconoscimento parziale possono essere fissati nei Regolamenti <strong>di</strong>dattici <strong>di</strong><br />
Facoltà.<br />
2. Nelle more dell’approvazione della richiesta <strong>di</strong> trasferimento, gli studenti sono ammessi a<br />
frequentare i corsi e a sostenere i relativi esami che saranno convalidati soltanto quando il<br />
trasferimento sarà stato accettato. Il trasferimento verso un Corso <strong>di</strong> laurea per il quale non è<br />
prescritta la prova <strong>di</strong> ammissione, richiesto da uno studente iscritto al primo anno <strong>di</strong> corso è<br />
<strong>di</strong>sposto automaticamente; nel caso in cui l’iscrizione al Corso richiede prova <strong>di</strong> ammissione, il<br />
trasferimento sarà possibile soltanto dopo il superamento <strong>di</strong> tale prova.<br />
3. In relazione alla quantità <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti riconosciuti ai sensi del comma 1, la durata del Corso <strong>di</strong> stu<strong>di</strong><br />
può essere abbreviata dal Consiglio <strong>di</strong> Classe e, su parere del Consiglio <strong>di</strong> Corso <strong>di</strong> <strong>Stu<strong>di</strong></strong>, secondo<br />
criteri stabiliti dai Regolamenti <strong>di</strong>dattici. Il riconoscimento da parte dell’<strong>Università</strong> <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti<br />
acquisiti presso altre <strong>Università</strong> italiane o straniere può essere determinato in forme automatiche da<br />
apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico; tali convenzioni potranno altresì prevedere<br />
la sostituzione <strong>di</strong>retta, all’interno dei curricula in<strong>di</strong>viduali, <strong>di</strong> attività formative impartite<br />
nell’<strong>Università</strong> e richieste dagli Or<strong>di</strong>namenti <strong>di</strong>dattici con attività formative impartite presso altre<br />
<strong>Università</strong> italiane o straniere.<br />
4. I citta<strong>di</strong>ni italiani, anche se già in possesso <strong>di</strong> un titolo <strong>di</strong> Laurea o <strong>di</strong> Laurea specialistica, e gli<br />
studenti iscritti a Corsi <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o presso <strong>Università</strong> straniere, possono iscriversi, <strong>di</strong>etro il pagamento<br />
<strong>di</strong> contributi stabiliti dagli Organi accademici competenti, a singoli corsi <strong>di</strong> insegnamento attivati<br />
presso i Corsi <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> ogni livello presenti nell’<strong>Università</strong>, nonché essere autorizzati a sostenere<br />
le relative prove d’esame e ad averne dalla Segreteria Studenti regolare attestazione utilizzabile per<br />
scopi professionali o concorsuali, per i quali sia richiesto un aggiornamento culturale e scientifico o<br />
un particolare perfezionamento delle competenze acquisite.<br />
ESAMI E VERIFICHE DEL PROFITTO<br />
A seconda della tipologia e della durata <strong>degli</strong> insegnamenti impartiti, i Regolamenti <strong>di</strong>dattici<br />
stabiliscono il tipo <strong>di</strong> prove <strong>di</strong> verifica che determinano per gli studenti il superamento del corso e<br />
l’acquisizione dei cre<strong>di</strong>ti assegnati. Tali prove potranno consistere in esami (orali o scritti), la cui<br />
votazione viene espressa in trentesimi, o nel superamento <strong>di</strong> altre prove <strong>di</strong> verifica (prove orali o<br />
scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.) anche in itinere appositamente stu<strong>di</strong>ate dal<br />
Consiglio <strong>di</strong>dattico competente allo scopo <strong>di</strong> valutare il conseguimento <strong>degli</strong> obiettivi formativi<br />
previsti per ciascun insegnamento.<br />
PROVA FINALE (ESAME DI LAUREA)<br />
E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI STUDIO<br />
Per accedere alla prova finale lo studente deve aver acquisito, sostenendo le relative prove, il<br />
quantitativo <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti universitari previsto dal relativo Regolamento <strong>di</strong>dattico.<br />
Per essere ammesso all’esame <strong>di</strong> laurea lo studente deve presentare apposita domanda alla<br />
Segreteria Studenti del proprio Corso <strong>di</strong> laurea allegando un versamento <strong>di</strong> 51,65 Euro (sul c/c 8706<br />
intestato all’<strong>Università</strong> <strong>degli</strong> <strong>Stu<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>Bari</strong>), rispettando i seguenti termini:<br />
- per la sessione estiva dal 21 al 30 aprile <strong>di</strong> ogni anno;<br />
- per la sessione autunnale dall’1 al 10 settembre <strong>di</strong> ogni anno (per la Facoltà <strong>di</strong> Giurisprudenza i<br />
termini <strong>di</strong> presentazione sono dal 21 al 31 agosto).<br />
- per la sessione straor<strong>di</strong>naria dall’1 al 10 <strong>di</strong>cembre <strong>di</strong> ogni anno.<br />
Ciascuna Facoltà, inoltre, segue proprie norme per la presentazione del modulo tesi, della tesi, per il<br />
numero <strong>di</strong> copie da presentare, per altre certificazioni, etc.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alle Segreterie Studenti.<br />
PROGETTO ALMALAUREA<br />
Allo scopo <strong>di</strong> facilitare ai propri laureati l’ingresso nel mondo del lavoro, l’<strong>Università</strong> <strong>degli</strong> <strong>Stu<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong><br />
<strong>Bari</strong> ha aderito al Consorzio AlmaLaurea, che ha istituito una banca dati consultata da Enti<br />
(pubblici e privati) e da aziende (italiane ed estere) per la selezione <strong>di</strong> personale da avviare al<br />
mondo del lavoro.<br />
Per avvalersi dell’iniziativa in parola, ogni laureando inserisce i propri dati in un questionario<br />
elettronico. Nel rispetto della privacy, dopo il conseguimento del titolo accademico, il curriculum<br />
personale è reso consultabile per favorire l’avviamento al lavoro e la selezione <strong>di</strong> personale<br />
qualificato.<br />
AlmaLaurea è visibile su internet: www.almalaurea.it<br />
TASSE<br />
L’importo della prima rata, per l’a.a. 2003-2004 è <strong>di</strong> 170,00 Euro (comprensivi <strong>di</strong> bollo virtuale). Il<br />
versamento dovrà essere effettuato entro il 5 novembre 2003, ad eccezione dei <strong>di</strong>versi termini <strong>di</strong><br />
scadenza previsti per i Corsi <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o a numero programmato.<br />
Sono tenuti al pagamento della prima rata anche gli studenti aspiranti al beneficio dell’esonero<br />
totale; in caso <strong>di</strong> ottenimento dello stesso, l’importo sarà rimborsato.<br />
Dovranno versare la sola prima rata <strong>di</strong> iscrizione:<br />
• gli studenti stranieri provenienti da <strong>Università</strong> estere che intendono frequentare presso l’<strong>Università</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Bari</strong> uno o più corsi singoli <strong>di</strong> cui all’art. 13 del Regolamento Studenti;<br />
• gli studenti che presentano istanza <strong>di</strong> trasferimento presso altra sede oltre il 5 novembre 2003,<br />
unitamente alla tassa <strong>di</strong> trasferimento, pari a 51,65. Euro.<br />
Gli studenti che ritengano <strong>di</strong> conseguire la laurea o il <strong>di</strong>ploma entro il 30 aprile 2004 possono non<br />
pagare la prima rata d’iscrizione. Nel caso in cui, entro tale data, non venga conseguita la laurea o il<br />
<strong>di</strong>ploma e non sia stata pagata la prima rata d’iscrizione, è dovuto il pagamento della prima rata,<br />
maggiorato della penale prevista.<br />
La seconda rata per l’a.a. 2003-2004, per un importo massimo ipotizzabile <strong>di</strong> 464,81, Euro deve<br />
essere versata con scadenza 31 maggio 2004, anche in caso <strong>di</strong> mancata ricezione dei bollettini.<br />
In caso <strong>di</strong> ritardo nel pagamento, è stabilita una indennità <strong>di</strong> mora pari a 15,49 Euro se il<br />
versamento è eseguito entro quarantacinque giorni dalla data <strong>di</strong> scadenza, <strong>di</strong> 36,15 Euro se eseguito<br />
dal quarantaseiesimo giorno in poi.<br />
Gli studenti stranieri, citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> Stati extracomunitari, provenienti da paesi in via <strong>di</strong> sviluppo, in<br />
con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>sagio economico accertato con documentazione rilasciata dalle Autorità Consolari<br />
Italiane, devono versare un importo complessivo pari a 247,47 Euro comprensive <strong>di</strong> bollo virtuale<br />
(prima rata <strong>di</strong> 170,00 Euro, tassa regionale annuale per il <strong>di</strong>ritto agli stu<strong>di</strong> universitari <strong>di</strong> 77,47<br />
Euro).<br />
Gli studenti delle Scuole <strong>di</strong> specializzazione beneficiari <strong>di</strong> una borsa <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o e gli studenti delle<br />
Scuole <strong>di</strong>rette a fini speciali sono tenuti a versare gli stessi importi previsti per i corsi <strong>di</strong> laurea e <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>ploma.<br />
Gli specializzan<strong>di</strong> non borsisti beneficiano <strong>di</strong> un abbattimento pari al 50%, purché non percepiscano<br />
red<strong>di</strong>ti da lavoro autonomo e/o <strong>di</strong>pendente e versino il saldo in un’unica soluzione.<br />
ESONERI
Sono esonerati totalmente da tasse e contributi gli studenti beneficiari delle borse <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o EDISU e<br />
<strong>di</strong> eventuali prestiti d’onore (erogati ai sensi dell’art. 16 L. 390/91); gli studenti idonei, non<br />
beneficiari per scarsità <strong>di</strong> risorse; gli studenti in situazione <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap con un’invali<strong>di</strong>tà<br />
riconosciuta pari o superiore al 66%; gli studenti stranieri beneficiari <strong>di</strong> borsa <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o del Governo<br />
italiano.<br />
Ulteriori forme <strong>di</strong> esonero sono previste per:<br />
- studenti portatori <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap con invali<strong>di</strong>tà riconosciuta dal 45% al 65% (riduzione del 50%<br />
dell’importo totale);<br />
- studenti che si laureano entro i termini legali senza iscrizioni fuori corso (esonero totale da<br />
tasse e contributi dell’ultimo anno).<br />
Gli aspiranti al beneficio dell’esonero, totale o parziale, dal pagamento delle tasse e dai contributi<br />
universitari, sono tenuti alla presentazione <strong>di</strong> un’apposita domanda da consegnarsi esclusivamente<br />
ai competenti uffici dell’EDISU.<br />
Ai fini del controllo sui dati forniti dagli studenti beneficiari dell’esonero tasse, l’<strong>Università</strong>,<br />
l’EDISU e l’Amministrazione finanziaria procedono allo scambio delle informazioni in loro<br />
possesso. I casi <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione mendace saranno perseguiti con denuncia all’Autorità giu<strong>di</strong>ziaria,<br />
ferma restando la revoca imme<strong>di</strong>ata del beneficio dell’esonero e il recupero delle somme dovute,<br />
nonché l’adozione <strong>di</strong> misure <strong>di</strong>sciplinari, compresa l’esclusione fino a tre anni dall’<strong>Università</strong>.<br />
“BONUS”<br />
Il vigente Regolamento tasse e contributi al punto 1.3.2 prevede che gli studenti che superano entro<br />
il 30 settembre il numero <strong>di</strong> esami del piano <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> statutario previsto dalla Facoltà per gli anni<br />
precedenti quello <strong>di</strong> iscrizione (n.e.s. uguale n.e.p.), senza iscrizioni fuori corso, ripetenze o<br />
ricognizioni, con una me<strong>di</strong>a non inferiore a 29/30, ottengono (<strong>di</strong>etro presentazione <strong>di</strong> apposita<br />
istanza da inoltrare entro il 31 ottobre <strong>di</strong> ciascun anno) come bonus un premio <strong>di</strong> 258,23 Euro da<br />
potersi utilizzare esclusivamente per l’acquisto <strong>di</strong> libri.<br />
Per informazioni rivolgersi a:<br />
Segreteria Generale, Settore I, Area Segreterie Studenti (Palazzo Ateneo, I piano ingresso da Via Nicolai); lun.-ven.<br />
dalle 10,00 alle 12,00, mar.-gio. dalle 15,00 alle 17,00; tel. 0805714512-4831.<br />
RICHIESTA DUPLICATO DEL LIBRETTO UNIVERSITARIO<br />
E DEL DIPLOMA DI LAUREA<br />
Lo studente che richieda il duplicato del proprio libretto per smarrimento o deterioramento deve<br />
presentare domanda in carta libera a cui allegare:<br />
• due fotografie identiche;<br />
• libretto deteriorato o autocertificazione <strong>di</strong> smarrimento, ai sensi della normativa vigente;<br />
• marca da bollo da 10,33 Euro;<br />
• ricevuta <strong>di</strong> versamento <strong>di</strong> 5,16 Euro su c/c 8706 intestato all’<strong>Università</strong> <strong>degli</strong> <strong>Stu<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>Bari</strong>.<br />
Chi, in possesso <strong>di</strong> un titolo accademico conseguito presso l’<strong>Università</strong> <strong>di</strong> <strong>Bari</strong>, <strong>di</strong>chiara lo<br />
smarrimento del proprio <strong>di</strong>ploma, deve presentare richiesta <strong>di</strong> duplicato in bollo da 10,33 Euro<br />
in<strong>di</strong>rizzata al Magnifico Rettore, allegando la denuncia <strong>di</strong> smarrimento effettuata presso le<br />
Autorità competenti e la ricevuta <strong>di</strong> versamento <strong>di</strong> 51,65 Euro su c/c 8706 intestato<br />
all’<strong>Università</strong> <strong>degli</strong> <strong>Stu<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>Bari</strong>.<br />
CERTIFICATI
I certificati possono essere richiesti <strong>di</strong>rettamente agli sportelli della propria Segreteria, compilando<br />
un apposito modulo da ritirare presso l’Ufficio Stampati (per le se<strong>di</strong> decentrate la <strong>di</strong>stribuzione<br />
<strong>degli</strong> stampati è a cura della Segreteria Studenti).<br />
Per le certificazioni in bollo occorre munire preventivamente la richiesta <strong>di</strong> una marca da bollo da<br />
10,33 Euro e allegare ad essa tante marche per quanti certificati si intende richiedere. Inoltre, si<br />
ricorda che, per ottenere il rilascio <strong>di</strong> certificati, lo studente deve essere in regola con il pagamento<br />
delle tasse.<br />
Coloro che hanno perso lo status <strong>di</strong> studente (es. laureati, rinunciatari, etc.) dovranno, inoltre,<br />
effettuare un versamento sul c/c 8706 (<strong>Università</strong> <strong>degli</strong> <strong>Stu<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>Bari</strong>) <strong>di</strong> 2,00 Euro per ogni<br />
certificato richiesto.<br />
RICHIESTA DEL DIPLOMA DI LAUREA<br />
Per richiedere il <strong>di</strong>ploma <strong>di</strong> laurea, occorre presentare domanda in bollo da 10,33 Euro<br />
in<strong>di</strong>rizzata al Magnifico Rettore, e presentarsi al momento del ritiro muniti <strong>di</strong> un valido<br />
documento <strong>di</strong> identità. Il <strong>di</strong>ploma può, infatti, essere consegnato solo alla persona interessata o<br />
eventualmente ad altra persona munita <strong>di</strong> delega conforme a quanto previsto dalla normativa<br />
vigente.
LAUREA SPECIALISTICA IN FARMACIA<br />
Or<strong>di</strong>namento <strong>di</strong>dattico DM 509 del 3/11/99<br />
Classe 14S “Farmacia e farmacia industriale”<br />
Obiettivi formativi specifici<br />
- Fornire conoscenza della metodologia dell’indagine scientifica, applicata in particolare alle<br />
tematiche del settore;<br />
- fornire conoscenze multi<strong>di</strong>sciplinari fondamentali per la comprensione del farmaco, della sua<br />
struttura ed attività in rapporto alla loro interazione con le biomolecole a livello cellulare e<br />
sistemico, nonché per le necessarie attività <strong>di</strong> preparazione e controllo dei me<strong>di</strong>camenti;<br />
- fornire conoscenze chimiche e biologiche integrate con quelle <strong>di</strong> farmacoeconomia e quelle<br />
riguardanti le leggi nazionali e comunitarie che regolano le varie attività del settore, proprio della<br />
figura professionale che, nell’ambito dei me<strong>di</strong>cinali e dei prodotti per la salute in genere, può<br />
garantire i requisiti <strong>di</strong> sicurezza, qualità ed efficacia, richiesti dalle normative dell’OMS e dalle<br />
<strong>di</strong>rettive nazionali europee;<br />
- fornire conoscenze utili all’espletamento professionale del servizio farmaceutico nell’ambito del<br />
Servizio Sanitario Nazionale, nonché ad interagire con le altre professioni sanitarie;<br />
- fornire una buona padronanza del metodo scientifico <strong>di</strong> indagine;<br />
- fornire conoscenza <strong>di</strong> almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano, con riferimento<br />
anche ai lessici <strong>di</strong>sciplinari.<br />
Sbocchi professionali<br />
Il laureato nel presente Corso, con il conseguimento della Laurea specialistica e della relativa<br />
abilitazione professionale, svolge ai sensi della <strong>di</strong>rettiva 85/432/CEE la professione <strong>di</strong> farmacista<br />
ed è autorizzato almeno all’esercizio delle seguenti attività professionali:<br />
- preparazione, controllo, immagazzinamento e <strong>di</strong>stribuzione dei me<strong>di</strong>cinali nelle farmacie aperte al<br />
pubblico;<br />
- preparazione, controllo, immagazzinamento e <strong>di</strong>stribuzione dei me<strong>di</strong>cinali negli ospedali<br />
(farmacie ospedaliere);<br />
- <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> in<strong>formato</strong>ri scientifici e consigli nel settore dei me<strong>di</strong>cinali;<br />
- immagazzinamento, conservazione e <strong>di</strong>stribuzione dei me<strong>di</strong>cinali nella fase <strong>di</strong> commercio<br />
all’ingrosso;<br />
- preparazione della forma farmaceutica dei me<strong>di</strong>cinali;<br />
- fabbricazione e controllo dei me<strong>di</strong>cinali;<br />
- controllo dei me<strong>di</strong>cinali in laboratorio <strong>di</strong> controllo;<br />
Tali attività rientrano nel campo minimo comune coor<strong>di</strong>nato da detta <strong>di</strong>rettiva; il percorso<br />
formativo potrà considerare anche altre attività professionali svolte dall’Unione Europea nel campo<br />
del farmaco, al fine <strong>di</strong> consentire pari opportunità occupazionali in ambito europeo.<br />
PIANO DI STUDI<br />
I Anno<br />
Insegnamenti CFU<br />
Biologia animale e vegetale 10<br />
Chimica generale ed inorganica 11<br />
Fisica con elementi <strong>di</strong> matematica 10<br />
Anatomia umana 10<br />
Chimica analitica con esercitazioni numeriche e <strong>di</strong><br />
laboratorio<br />
10
II Anno<br />
Insegnamenti CFU<br />
Chimica organica 11<br />
Microbiologia ed igiene 11<br />
Biochimica 11<br />
Farmacognosia co elementi <strong>di</strong> botanica farmaceutica 10<br />
Fisiologia generale 11<br />
III Anno<br />
Insegnamenti CFU<br />
Chimica farmaceutica e tossicologica I 11<br />
Farmacologia e farmacoterapia 11<br />
Analisi dei me<strong>di</strong>cinali I 13<br />
Biochimica applicata 6<br />
Patologia generale 10<br />
IV Anno<br />
Insegnamenti CFU<br />
Analisi dei me<strong>di</strong>cinali II 13<br />
Tecnologia farmaceutica 13<br />
Chimica farmaceutica e tossicologica II 11<br />
Farmacologia e tossicologia 11<br />
Tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche 11<br />
V Anno<br />
Insegnamenti CFU<br />
Corsi a scelta e Profili professionali integrativi (a) 28<br />
Tesi compilativa (b) 15<br />
Conoscenze linguistiche (c) 6<br />
Conoscenze informatiche (d) 6<br />
Tirocinio professionale in farmacia (e) 30<br />
(a) Vedere appresso le in<strong>di</strong>cazioni pre<strong>di</strong>sposte dalla Facoltà.<br />
(b) Per la tesi sperimentale, per la quale vengono assegnati 30 cre<strong>di</strong>ti, i 15 mancanti vengono<br />
prelevati da: “Corsi a scelta”.<br />
(c) Le conoscenze linguistiche verranno accertate attraverso un colloquio.<br />
(d) Le conoscenze informatiche verranno verificate attraverso una prova pratica; se questa non<br />
risultasse sufficiente sarà necessario seguire un breve corso pre<strong>di</strong>sposto dalla Facoltà.<br />
(e) Il tirocinio professionale <strong>di</strong> sei mesi deve avvenire presso una farmacia aperta al pubblico o in<br />
un ospedale, sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico stesso. Il compimento del semestre <strong>di</strong><br />
pratica professionale deve risultare da un attestato del titolare o del <strong>di</strong>rettore della farmacia<br />
frequentata. Detto tirocinio deve essere effettuato a tempo pieno per un numero <strong>di</strong> ore pari a 36<br />
settimanali (Direttiva CEE 85/432). Tutte le farmacie del territorio nazionale sono autorizzate ad<br />
accettare laurean<strong>di</strong> in Farmacia per il compimento della prescritta pratica farmaceutica semestrale.<br />
La richiesta <strong>di</strong> tesi (compilativa o sperimentale) potrà essere presentata nei seguenti perio<strong>di</strong> dopo<br />
aver superato un numero <strong>di</strong> esami <strong>di</strong> almeno 16 annualità:
- tesi compilative: nella prima metà dei mesi <strong>di</strong> febbraio e ottobre;<br />
- tesi sperimentali: nella prima metà dei mesi <strong>di</strong> marzo e luglio.<br />
Per la tesi sperimentale è obbligatoria la frequenza, <strong>di</strong> un laboratorio scientifico della Facoltà, per<br />
un periodo <strong>di</strong> sei mesi.<br />
PROFILI PROFESSIONALI INTEGRATIVI<br />
A. Nutraceutico, B. Cosmeceutico, C. Gestionale, D. Officinale, E. Fitoterapeutico, F. Clinico<br />
analitico, G. Clinico terapeutico, H. Pharmaceutical care, I. Controllo <strong>di</strong> qualità, L. Sintetico<br />
preparativo, M. Industriale farmaceutico, N. Metodologie computerizzate nella ricerca<br />
farmaceutica, O. Tecnologico, P. Biologia molecolare, Q. Preparazione dell’esame <strong>di</strong> stato per<br />
farmacista, R. Preparazione dell’esame <strong>di</strong> stato per chimico.<br />
Su questi corsi la frequenza non è obbligatoria; una prova finale <strong>di</strong> idoneità sarà realizzata<br />
attraverso la risoluzione <strong>di</strong> quesiti a risposta multipla.<br />
Nel caso vengano scelti altri corsi <strong>di</strong> insegnamento istituzionali impartiti nella Facoltà <strong>di</strong> Farmacia<br />
o in altre Facoltà dell’Ateneo, la frequenza e la verifica del profitto saranno in accordo con quelle<br />
della struttura che ha fornito il servizio.
LAUREA SPECIALISTICA IN<br />
CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE<br />
Or<strong>di</strong>namento <strong>di</strong>dattico DM 509 del 3/11/99<br />
Classe 14S “Farmacia e farmacia industriale”<br />
Obiettivi formativi specifici<br />
- Fornire conoscenza della metodologia dell’indagine scientifica, applicata in particolare alle<br />
tematiche del settore;<br />
- fornire conoscenze multi<strong>di</strong>sciplinari fondamentali per la comprensione del farmaco, della sua<br />
struttura ed attività in rapporto alla loro interazione con le biomolecole a livello cellulare e<br />
sistemico, nonché per le necessarie attività <strong>di</strong> preparazione e controllo dei me<strong>di</strong>camenti;<br />
- fornire conoscenze chimiche e biologiche integrate con quelle <strong>di</strong> farmacoeconomia e quelle<br />
riguardanti le leggi nazionali e comunitarie che regolano le varie attività del settore, proprio della<br />
figura professionale che, nell’ambito dei me<strong>di</strong>cinali e dei prodotti per la salute in genere, può<br />
garantire i requisiti <strong>di</strong> sicurezza, qualità ed efficacia, richiesti dalle normative dell’OMS e dalle<br />
<strong>di</strong>rettive nazionali europee;<br />
- fornire conoscenze utili all’espletamento professionale del servizio farmaceutico nell’ambito del<br />
Servizio Sanitario Nazionale, nonché ad interagire con le altre professioni sanitarie;<br />
- fornire una buona padronanza del metodo scientifico <strong>di</strong> indagine;<br />
- fornire conoscenza <strong>di</strong> almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano, con riferimento<br />
anche ai lessici <strong>di</strong>sciplinari.<br />
Sbocchi professionali<br />
Il laureato nel presente Corso, con il conseguimento della laurea specialistica e della relativa<br />
abilitazione professionale, svolge ai sensi della <strong>di</strong>rettiva 85/432/CEE la professione <strong>di</strong> farmacista<br />
ed è autorizzato almeno all’esercizio delle seguenti attività professionali:<br />
- preparazione della forma farmaceutica dei me<strong>di</strong>cinali;<br />
- fabbricazione e controllo dei me<strong>di</strong>cinali;<br />
- controllo dei me<strong>di</strong>cinali in laboratorio <strong>di</strong> controllo;<br />
- immagazzinamento, conservazione e <strong>di</strong>stribuzione dei me<strong>di</strong>cinali nella fase <strong>di</strong> commercio<br />
all’ingrosso;<br />
- preparazione, controllo, immagazzinamento e <strong>di</strong>stribuzione dei me<strong>di</strong>cinali nelle farmacie aperte al<br />
pubblico;<br />
- preparazione, controllo, immagazzinamento e <strong>di</strong>stribuzione dei me<strong>di</strong>cinali negli ospedali<br />
(farmacie ospedaliere)<br />
- <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> in<strong>formato</strong>ri scientifici e consigli nel settore dei me<strong>di</strong>cinali.<br />
Tali attività rientrano nel campo minimo comune coor<strong>di</strong>nato da detta <strong>di</strong>rettiva; il percorso<br />
formativo potrà considerare anche altre attività professionali svolte dall’Unione Europea nel campo<br />
del Farmaco, al fine <strong>di</strong> consentire pari opportunità occupazionali in ambito europeo.<br />
PIANO DI STUDI<br />
I Anno<br />
Insegnamenti CFU<br />
Chimica generale ed inorganica 8<br />
Fisica 7<br />
Matematica 6<br />
Anatomia umana, patologia generale e terminologia<br />
me<strong>di</strong>ca<br />
8
Biologia animale e microbiologia 9<br />
Chimica analitica e complementi <strong>di</strong> chimica 8<br />
II Anno<br />
Insegnamenti CFU<br />
Biologia vegetale e farmacognosia 8<br />
Chimica fisica 8<br />
Chimica organica I 8<br />
Analisi dei me<strong>di</strong>cinali 10<br />
Biochimica 8<br />
Fisiologia generale 8<br />
III Anno<br />
Insegnamenti CFU<br />
Analisi dei farmaci I 10<br />
Chimica organica II 8<br />
Farmacologia e farmacoterapia 8<br />
Biochimica applicata 9<br />
Chimica farmaceutica e tossicologica I 8<br />
Meto<strong>di</strong> fisici in chimica organica 8<br />
IV Anno<br />
Insegnamenti CFU<br />
Chimica farmaceutica e tossicologica II 8<br />
Impianti dell’industria farmaceutica e tecnologie<br />
farmaceutiche<br />
10<br />
Tecnologia, socioeconomia e legislazione<br />
farmaceutiche<br />
10<br />
Analisi dei farmaci II 10<br />
Chimica farmaceutica applicata 8<br />
Farmacologia e tossicologia 8<br />
V Anno<br />
Insegnamenti CFU<br />
Corsi a scelta e Profili professionali integrativi (a) 24<br />
Tesi sperimentale (b) 30<br />
Conoscenze linguistiche (c) 9<br />
Conoscenze informatiche (d) 6<br />
Tirocinio professionale in farmacia (e) 30<br />
(a) Vedere appresso il quadro pre<strong>di</strong>sposto dalla Facoltà.<br />
(b) La richiesta <strong>di</strong> tesi potrà essere presentata nei perio<strong>di</strong> 1-10 marzo, 10-20 giugno, 10-20<br />
settembre <strong>di</strong> ciascun anno dopo aver superato un numero <strong>di</strong> esami <strong>di</strong> almeno 20 annualità. Per lo<br />
svolgimento della tesi è obbligatoria la frequenza <strong>di</strong> un laboratorio scientifico preferibilmente della<br />
Facoltà, per un periodo <strong>di</strong> sei mesi.<br />
(c) Le conoscenze linguistiche verranno accertate attraverso un colloquio.
(d) Le conoscenze informatiche verranno verificate attraverso una prova pratica; se questa non<br />
risultasse sufficiente sarà necessario seguire un breve corso pre<strong>di</strong>sposto dalla Facoltà.<br />
(e) Il tirocinio professionale <strong>di</strong> sei mesi deve avvenire presso una farmacia aperta al pubblico o in<br />
un ospedale, sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico stesso. Il compimento del semestre <strong>di</strong><br />
pratica professionale deve risultare da un attestato del titolare o del <strong>di</strong>rettore della farmacia<br />
frequentata. Detto tirocinio deve essere effettuato a tempo pieno per un numero <strong>di</strong> ore pari a 36<br />
settimanali (Direttiva CEE 85/432). Tutte le farmacie del territorio nazionale sono autorizzate ad<br />
accettare laurean<strong>di</strong> in Farmacia per il compimento della prescritta pratica farmaceutica semestrale.<br />
PROFILI PROFESSIONALI INTEGRATIVI<br />
A. Nutraceutico, B. Cosmeceutico, C. Gestionale, D. Officinale, E. Fitoterapeutico, F. Clinico<br />
analitico, G. Clinico terapeutico, H. Pharmaceutical care, I. Controllo <strong>di</strong> qualità, L. Sintetico<br />
preparativo, M. Industriale farmaceutico, N. Metodologie computerizzate nella ricerca<br />
farmaceutica, O. Tecnologico, P. Biologia molecolare, Q. Preparazione dell’esame <strong>di</strong> stato per<br />
farmacista, R. Preparazione dell’esame <strong>di</strong> stato per chimico.<br />
Su questi corsi la frequenza non è obbligatoria; una prova finale <strong>di</strong> idoneità sarà realizzata<br />
attraverso la risoluzione <strong>di</strong> quesiti a risposta multipla.<br />
Nel caso vengano scelti altri corsi <strong>di</strong> insegnamento istituzionali impartiti nella Facoltà <strong>di</strong> Farmacia<br />
o in altre Facoltà dell’Ateneo, la frequenza e la verifica del profitto saranno in accordo con quelle<br />
della struttura che ha fornito il servizio.
LAUREA IN<br />
INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO<br />
Or<strong>di</strong>namento <strong>di</strong>dattico DM 509 del 3/11/99<br />
Classe 24 “Scienze e tecnologie farmaceutiche”<br />
Obiettivi formativi specifici<br />
- Fornire la preparazione adeguata per svolgere attività <strong>di</strong> informazione scientifica nel settore dei<br />
farmaci e delle specialità me<strong>di</strong>cinali, oltreché dei <strong>di</strong>spositivi e presi<strong>di</strong> me<strong>di</strong>co-chirurgici per uso sia<br />
umano, che veterinario;<br />
- fornire adeguate competenze in merito alla composizione, alla forma farmaceutica, alle<br />
caratteristiche tecnologiche, ai mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> impiego, alla posologia ottimale, all’efficacia terapeutica e<br />
alle controin<strong>di</strong>cazioni;<br />
- fornire conoscenze scientifiche e normative, in ambito nazionale ed europeo, al fine <strong>di</strong> un corretto<br />
impiego dei farmaci.<br />
Sbocchi professionali<br />
I laureati svolgeranno attività professionali relativamente all’informazione scientifica del farmaco e<br />
dei prodotti della salute.<br />
Prova finale<br />
La prova finale consiste in una tesi compilativa secondo le modalità in<strong>di</strong>cate dalle strutture<br />
<strong>di</strong>dattiche.<br />
PIANO DI STUDI<br />
I Anno<br />
Insegnamenti CFU<br />
Biologia animale e vegetale 10<br />
Chimica generale ed inorganica 11<br />
Fisica con elementi <strong>di</strong> matematica 10<br />
Anatomia umana 11<br />
Corsi a scelta e seminari 8<br />
II Anno<br />
Insegnamenti CFU<br />
Chimica organica 11<br />
Microbiologia ed igiene 10<br />
Biochimica 11<br />
Fisiologia generale 11<br />
Patologia generale 10<br />
III Anno<br />
Insegnamenti CFU<br />
Chimica farmaceutica e tossicologica I 11<br />
Farmacologia e farmacoterapia 11<br />
Chimica farmaceutica e tossicologica II 11<br />
Farmacologia e tossicologia 11<br />
Tecnologia, socioeconomia e legislazione<br />
farmaceutiche<br />
11
Corsi a scelta e seminari (a) 5<br />
Tesi compilativa (b) 4<br />
Conoscenze linguistiche (c) 5<br />
Attività pratiche, tirocini, stage, attività informatiche (d) 8<br />
(a) La Facoltà offrirà uno spettro <strong>di</strong> lezioni, conferenze e seminari, tra i quali lo studente potrà<br />
scegliere quelli da seguire. Su questi la frequenza non è obbligatoria; il controllo sarà operato<br />
attraverso tesine, colloqui, prove prelaurea, etc.<br />
Nel caso vengano scelti altri corsi <strong>di</strong> insegnamento istituzionali impartiti nella Facoltà <strong>di</strong> Farmacia<br />
o in altre Facoltà dell’Ateneo, la frequenza e la verifica del profitto saranno in accordo con quelle<br />
della struttura che ha fornito il servizio.<br />
(b) La richiesta <strong>di</strong> tesi potrà essere presentata nella prima metà dei mesi febbraio ed ottobre, dopo<br />
aver superato un numero <strong>di</strong> esami <strong>di</strong> almeno 11 annualità.<br />
(c) Le conoscenze linguistiche verranno accertate attraverso un colloquio<br />
(d) Le conoscenze informatiche verranno verificate attraverso una prova pratica; se questa non<br />
risultasse sufficiente sarà necessario seguire un breve corso pre<strong>di</strong>sposto dalla Facoltà.
LAUREA IN<br />
TECNICHE ERBORISTICHE<br />
Or<strong>di</strong>namento <strong>di</strong>dattico DM 509 del 3/11/99<br />
Classe 24 “Scienze e tecnologie farmaceutiche”<br />
Obiettivi formativi specifici<br />
- Fornire le conoscenze attinenti alle attività <strong>di</strong> raccolta, lavorazione, trasformazione,<br />
confezionamento e commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio <strong>di</strong> piante, loro parti e derivati,<br />
destinati ad uso erboristico nei vari impieghi industriali;<br />
- fornire la conoscenza delle droghe vegetali, dei principi farmacologicamente attivi in esse<br />
contenuti, il loro impiego, la loro stabilità, le tecniche <strong>di</strong> lavorazione;<br />
- fornire la conoscenza necessaria al controllo della qualità dei prodotti erboristici.<br />
Sbocchi professionali<br />
I laureati svolgeranno attività professionali relativamente alla trasformazione e al confezionamento<br />
<strong>di</strong> parti <strong>di</strong> piante e loro derivati, per uso erboristico, garantendone la qualità secondo quanto<br />
<strong>di</strong>sposto dalle norme vigenti.<br />
Prova finale<br />
La prova finale consiste in una tesi compilativa secondo le modalità in<strong>di</strong>cate dalle strutture<br />
<strong>di</strong>dattiche.<br />
PIANO DI STUDI<br />
I Anno<br />
Insegnamenti CFU<br />
Biologia animale e vegetale 10<br />
Chimica generale ed inorganica e chimica organica 10<br />
Farmacognosia con elementi <strong>di</strong> botanica farmaceutica 12<br />
Chimica analitica con esercitazioni numeriche e <strong>di</strong><br />
laboratorio<br />
10<br />
Biochimica e biochimica vegetale 10<br />
II Anno<br />
Insegnamento CFU<br />
Fisiologia 10<br />
Microbiologia ed igiene 10<br />
Agrotecniche delle colture officinali e tecnologie <strong>di</strong> 10<br />
trasformazione etc.<br />
Chimica farmaceutica e farmacologia generale 11<br />
Corsi a scelta e seminari (a) 12<br />
III Anno<br />
Insegnamento CFU<br />
Analisi <strong>di</strong> principi attivi <strong>di</strong> natura erboristica e<br />
laboratorio <strong>di</strong> estrattiva<br />
11<br />
Saggi e dosaggi farmacologici e farmacognostici 10<br />
Prodotti cosmetici e <strong>di</strong>etetici <strong>di</strong> origine vegetale 10
Tecnologia farmaceutica e legislazione erboristiche 12<br />
Corsi a scelta e seminari 10<br />
Tesi compilativa 6<br />
Conoscenze linguistiche 3<br />
Attività pratiche, tirocini, stage, conoscenze<br />
informatiche<br />
13<br />
(a) La Facoltà offrirà uno spettro <strong>di</strong> lezioni, conferenze e seminari, tra i quali lo studente potrà<br />
scegliere quelli da seguire. Su questi la frequenza non è obbligatoria; il controllo sarà operato<br />
attraverso tesine, colloqui, prove prelaurea, etc.<br />
Nel caso vengano scelti altri corsi <strong>di</strong> insegnamento istituzionali impartiti nella Facoltà <strong>di</strong> Farmacia<br />
o in altre facoltà dell’Ateneo, la frequenza e la verifica del profitto saranno in accordo con quelle<br />
della struttura che ha fornito il servizio.<br />
(b) La richiesta <strong>di</strong> tesi potrà essere presentata nella prima metà dei mesi febbraio ed ottobre, dopo<br />
aver superato un numero <strong>di</strong> esami <strong>di</strong> almeno 11 annualità.<br />
(c) Le conoscenze linguistiche verranno accertate attraverso un colloquio.<br />
(d) Le conoscenze informatiche verranno verificate attraverso una prova pratica; se questa non<br />
risultasse sufficiente sarà necessario seguire un breve corso pre<strong>di</strong>sposto dalla Facoltà.
LAUREA IN FARMACIA<br />
Or<strong>di</strong>namento <strong>di</strong>dattico - Tabella XXVII del DM 30/6/95<br />
La durata del Corso <strong>di</strong> laurea in Farmacia è fissata in cinque anni, all’interno dei quali si devono<br />
seguire con frequenza obbligatoria insegnamenti teorici e pratici corrispondenti a ventidue<br />
annualità e prevede, come completamento del curriculum <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> universitari, un periodo <strong>di</strong><br />
tirocinio da compiersi presso una farmacia aperta al pubblico o ospedaliera.<br />
Tirocinio professionale. Il tirocinio professionale <strong>di</strong> sei mesi, da compiersi prima della laurea e<br />
successivamente al terzo anno <strong>di</strong> corso, deve avvenire presso una farmacia aperta al pubblico o in<br />
un ospedale, sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico stesso.<br />
Il compimento del semestre <strong>di</strong> pratica professionale deve risultare da un attestato del titolare o del<br />
<strong>di</strong>rettore della farmacia frequentata.<br />
Detto tirocinio deve essere effettuato a tempo pieno per un numero <strong>di</strong> ore pari a 36 settimanali<br />
(Direttiva CEE 85/432). Tutte le farmacie del territorio nazionale sono autorizzate ad accettare<br />
laurean<strong>di</strong> in Farmacia per il compimento della prescritta pratica farmaceutica semestrale.<br />
Lingua straniera. Lo studente dovrà <strong>di</strong>mostrare entro il terzo anno la conoscenza pratica e la<br />
comprensione <strong>di</strong> almeno una lingua straniera <strong>di</strong> rilevanza scientifica. Presso questo Corso <strong>di</strong> laurea<br />
la lingua straniera attivata è l’inglese. Il non conseguimento <strong>di</strong> tale idoneità non permette <strong>di</strong><br />
sostenere gli esami dal quarto anno in poi.<br />
Esame <strong>di</strong> laurea. Per essere ammesso all’esame <strong>di</strong> laurea lo studente deve avere superato gli esami<br />
<strong>di</strong> profitto <strong>di</strong> tutti gli insegnamenti del corso ed aver effettuato il tirocinio professionale.<br />
La richiesta <strong>di</strong> tesi (compilativa o sperimentale) potrà essere presentata nei seguenti perio<strong>di</strong> dopo<br />
aver superato un numero <strong>di</strong> esami <strong>di</strong> almeno 18 annualità:<br />
- tesi compilative: nella prima metà dei mesi <strong>di</strong> febbraio e ottobre;<br />
- tesi sperimentali: nella prima metà dei mesi <strong>di</strong> marzo e luglio.<br />
Per la tesi sperimentale è obbligatoria la frequenza, per un anno accademico, <strong>di</strong> un laboratorio<br />
scientifico preferibilmente della Facoltà.<br />
IV Anno<br />
VII Semestre<br />
- Chimica farmaceutica e tossicologica II<br />
- Farmacologia e tossicologia<br />
PIANO DI STUDI<br />
Il primo, secondo e terzo anno sono <strong>di</strong>sattivati<br />
VIII Semestre<br />
- Analisi dei me<strong>di</strong>cinali II<br />
- Prodotti <strong>di</strong>etetici con elementi <strong>di</strong> scienza dell’alimentazione (c.i.)<br />
- Tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche.<br />
V Anno<br />
IX Semestre<br />
- Prodotti cosmetici con elementi <strong>di</strong> fisiologia e biochimica della cute (c.i.)<br />
- Organizzazione aziendale ed elementi <strong>di</strong> farmacoeconomia (c.i.).<br />
Propedeuticità
Gli esami del terzo, quarto e quinto anno possono essere sostenuti solo dopo aver superato tutti gli<br />
esami del primo, secondo e terzo anno rispettivamente.<br />
Norme transitorie<br />
Secondo quanto previsto dal comma 2 art. 13, del DM 3/11/1999, le università <strong>di</strong>sciplinano la<br />
facoltà per gli studenti <strong>di</strong> optare per l’iscrizione a corsi <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o con i nuovi or<strong>di</strong>namenti.<br />
Le norme transitorie relative sono reperibili nei verbali dei Consigli <strong>di</strong> Facoltà del 28/9/2001 e del<br />
27/3/2002.
LAUREA IN<br />
CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE<br />
Or<strong>di</strong>namento <strong>di</strong>dattico - Tabella XXVII bis del DM 30/6/95<br />
La durata del Corso <strong>di</strong> laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche è fissata in cinque anni<br />
all’interno dei quali si devono seguire, con frequenza obbligatoria, insegnamenti teorici e pratici<br />
corrispondenti a ventotto annualità, articolati in un quadriennio <strong>di</strong> base, ed un ultimo anno <strong>di</strong><br />
in<strong>di</strong>rizzo <strong>di</strong> specializzazione professionale.<br />
Lingua straniera. Lo studente dovrà <strong>di</strong>mostrare entro il terzo anno la conoscenza pratica e la<br />
comprensione <strong>di</strong> almeno una lingua straniera <strong>di</strong> rilevanza scientifica. Presso questo Corso <strong>di</strong> laurea<br />
la lingua straniera attivata è l’inglese. Il non conseguimento <strong>di</strong> tale idoneità non permette <strong>di</strong><br />
sostenere gli esami dal quarto anno in poi.<br />
Esame <strong>di</strong> laurea. L’esame <strong>di</strong> laurea consiste nella <strong>di</strong>scussione <strong>di</strong> una tesi sperimentale, su<br />
argomento concordato con un docente della Facoltà in una delle <strong>di</strong>scipline comprese nel curriculum<br />
dello studente. Per il lavoro <strong>di</strong> tesi lo studente dovrà frequentare, obbligatoriamente per un anno<br />
accademico, un laboratorio scientifico preferibilmente della Facoltà.<br />
La richiesta <strong>di</strong> tesi potrà essere presentata nei perio<strong>di</strong> 1-10 marzo, 10-20 giugno, 10-20 settembre <strong>di</strong><br />
ciascun anno dopo aver superato un numero <strong>di</strong> esami <strong>di</strong> almeno 22 annualità.<br />
Tirocinio professionale. Il tirocinio pratico professionale <strong>di</strong> sei mesi per l’iscrizione all’Albo<br />
professionale deve essere svolto dopo il conseguimento della laurea presso una farmacia aperta al<br />
pubblico o in una farmacia ospedaliera sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell’ospedale<br />
stesso.<br />
Il compimento del semestre <strong>di</strong> pratica professionale deve risultare da un attestato del titolare o del<br />
<strong>di</strong>rettore della farmacia frequentata.<br />
Detto tirocinio deve essere effettuato a tempo pieno per un numero <strong>di</strong> ore pari a 36 settimanali<br />
(Direttiva CEE 85/432). Tutte le farmacie del territorio nazionale sono autorizzate ad accettare<br />
laurean<strong>di</strong> in Farmacia per il compimento della prescritta pratica farmaceutica semestrale.<br />
PIANO DI STUDI<br />
Il primo, secondo e terzo anno sono <strong>di</strong>sattivati<br />
IV Anno<br />
VII Semestre<br />
- Analisi dei farmaci II<br />
- Chimica farmaceutica e tossicologica II<br />
- Tecnologia, socioeconomia e legislazione farmaceutiche<br />
VIII Semestre<br />
- Chimica farmaceutica applicata<br />
- Impianti dell’industria farmaceutica e tecnologie farmaceutiche<br />
- Farmacologia e tossicologia.<br />
V Anno<br />
IX Semestre<br />
quattro annualità <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo.<br />
I In<strong>di</strong>rizzo<br />
Chimica biofarmaceutica (semestrale)
Chimica <strong>degli</strong> alimenti (semestrale)<br />
Analisi dei farmaci e loro metaboliti nei liqui<strong>di</strong> biologici (semestrale)<br />
Chimica bioinorganica (semestrale)<br />
Chimica delle sostanze organiche naturali (semestrale)<br />
Prodotti cosmetici (semestrale)<br />
Chimica farmaceutica superiore<br />
II In<strong>di</strong>rizzo<br />
Biochimica sistematica umana<br />
Enzimologia (semestrale)<br />
Basi <strong>di</strong> dati e sistemi informativi (semestrale)<br />
Elementi <strong>di</strong> statistica me<strong>di</strong>ca (semestrale)<br />
Scienza dell’alimentazione (semestrale)<br />
Fisiologia e biochimica della cute (semestrale)<br />
Chimica analitica clinica (semestrale)<br />
Propedeuticità<br />
Gli esami del terzo, quarto e quinto anno possono essere sostenuti solo dopo aver superato tutti gli<br />
esami del primo, secondo e terzo anno, rispettivamente.<br />
Norme transitorie<br />
Secondo quanto previsto dal comma 2 art. 13, del D.M. 3/11/1999, le università <strong>di</strong>sciplinano la<br />
facoltà per gli studenti <strong>di</strong> optare per l’iscrizione a corsi <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o con i nuovi or<strong>di</strong>namenti.<br />
Le norme transitorie relative sono reperibili nei verbali dei Consigli <strong>di</strong> Facoltà del 28/9/2001 e del<br />
27/3/2002.
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE<br />
FARMACIA OSPEDALIERA<br />
Presidente: prof. Marcello Ferappi<br />
Durata del corso: 3 anni; 6 posti per anno<br />
Titoli <strong>di</strong> ammissione: laurea in Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e abilitazione alla<br />
professione <strong>di</strong> farmacista.
Direttore: prof. Vincenzo Tortorella<br />
Coor<strong>di</strong>natore: dott. Vincenzo Patano<br />
Campus - Via Orabona, 4 - 70125 <strong>Bari</strong><br />
Tel. 080/5442807 fax 080/5442490<br />
Orario: lun.-ven. 9,00-18,45.<br />
e-mail: bibliofarm@farmacia.uniba.it<br />
Posti a sedere: 60<br />
Cataloghi supportati da schede informatizzate<br />
Monografie: 4.000<br />
Perio<strong>di</strong>ci: 330, <strong>di</strong> cui 120 in corso.<br />
BIBLIOTECA CENTRALE DI FACOLTÁ<br />
ISOLE DIDATTICHE DI FACOLTÁ<br />
Aula 4 (piano terra) Tel. 080/5442496<br />
Polo Linguistico (seminterrato) Tel. 080/5443164.<br />
PROGRAMMI DI MOBILITÀ STUDENTESCA<br />
Lo studente universitario ha la possibilità <strong>di</strong> frequentare un periodo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> presso una <strong>Università</strong><br />
straniera. È una opportunità offerta dall’Unione Europea (UE), che promuove e finanzia con<br />
contributi integrativi una serie <strong>di</strong> programmi <strong>di</strong> cooperazione e <strong>di</strong> scambio tra gli Atenei. Questi<br />
Programmi hanno lo scopo <strong>di</strong> favorire la mobilità <strong>degli</strong> studenti universitari e prevedono l’utilizzo<br />
<strong>di</strong> una borsa <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o, garantendo il riconoscimento accademico del periodo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o svolto<br />
all’estero. L’<strong>Università</strong> <strong>di</strong> <strong>Bari</strong> aderisce attualmente ai seguenti Programmi:<br />
Socrates/Erasmus, Leonardo da Vinci, Tempus.<br />
Presso la Facoltà <strong>di</strong> Farmacia è attivato il Programma Erasmus <strong>di</strong> cui il coor<strong>di</strong>natore è: prof.<br />
Pinarosa Avato (Dip. Farmaco-Chimico) Tel. 080/5442757.<br />
Per informazioni rivolgersi a:<br />
Area Relazioni Internazionali e Cooperazioni per la Ricerca e la Formazione, Settore IV,<br />
Programmi Internazionali <strong>di</strong> Mobilità e Cooperazione, Piazza Umberto, I - 70121 <strong>Bari</strong> (Italia),<br />
tel. +39 0805714516-4561, fax +39 0805714463, e-mail: francesco.tritto@relint.uniba.it.<br />
SERVIZIO ORIENTAMENTO<br />
L’<strong>Università</strong> <strong>di</strong> <strong>Bari</strong> per il potenziamento e il miglioramento del servizio <strong>di</strong> orientamento ai suoi<br />
studenti ha messo in atto il Progetto “Mentore”, un progetto ambizioso cofinanziato dall’Unione<br />
Europea, che articola il Servizio <strong>di</strong> Orientamento e Tutorato, gestito da uno staff centrale in accordo<br />
con le singole Facoltà, in una serie <strong>di</strong> iniziative volte a fornire agli studenti:<br />
- Orientamento in entrata (realizzazione <strong>di</strong> incontri e seminari per docenti e studenti presso le<br />
scuole; sportello <strong>di</strong> counseling; sportello “Donna”).<br />
- Orientamento in itinere (sostegno agli studenti neoiscritti nelle scelte curriculari, nella valutazione<br />
e nella risoluzione dei propri debiti formativi; servizi per gli studenti <strong>di</strong>sabili; azioni <strong>di</strong> sostegno<br />
<strong>di</strong>dattico da parte <strong>di</strong> studenti seniors o neolaureati e teletutoraggio; ateliers specializzati su tecniche<br />
e metodologie per lo stu<strong>di</strong>o; informazioni, analisi e consigli per riorentare la scelta del corso <strong>di</strong><br />
laurea, previa rilevazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà e suggerimenti derivanti dai dati generali <strong>di</strong> monitoraggio sui
possibili sbocchi lavorativi; sistema informativo in internet per agevolare l’incrocio dei profili<br />
professionali dei laurean<strong>di</strong>/laureati con le richieste delle aziende, e per l’attivazione <strong>di</strong> stage e<br />
tirocini formativi.<br />
- Orientamento in uscita (seminari per la ricerca attiva del lavoro con la presentazione <strong>di</strong> casi<br />
concreti e testimonianze; job placement ovvero attivazione <strong>di</strong> laboratori <strong>di</strong> orientamento e<br />
counseling in<strong>di</strong>viduale per in<strong>di</strong>viduare le potenzialità personali e i percorsi <strong>di</strong> autoimpren<strong>di</strong>torialità;<br />
job meeting ovvero organizzazione <strong>di</strong> incontri frontali con le realtà produttive ed economiche<br />
territoriali).<br />
Il Comitato scientifico del Progetto “Mentore” è composto da:<br />
Prof. DAMMACCO Francesco, Coor<strong>di</strong>natore, e dai seguenti docenti, referenti per ciascuna Facoltà:<br />
- Prof. ANCONA Giovanni, Facoltà <strong>di</strong> Scienze Politiche,<br />
tel. 0805049097, e-mail: g.ancona@lex.uniba.it<br />
- Prof. BALDASSARRE Vito Antonio, Facoltà <strong>di</strong> Scienze della Formazione,<br />
tel. 0805714547, e-mail: va.baldassarre@sc-edu.uniba.it<br />
- Prof. BRUNO Andrea, Facoltà <strong>di</strong> Lingue e Letterature Straniere,<br />
tel. 0805714825, e-mail: a.bruno@lingue.uniba.it<br />
- Prof. CROVACE Antonio, Facoltà <strong>di</strong> Me<strong>di</strong>cina Veterinaria,<br />
tel. 0805443817, e-mail: a.crovace@veterinaria.uniba.it<br />
- Prof. DI GIANDOMENICO Mauro, Facoltà <strong>di</strong> Lettere e Filosofia,<br />
tel. 0805714162, e-mail: <strong>di</strong>giandomenico@filosofia.uniba.it<br />
- Prof. FRANCHINI Carlo, Facoltà <strong>di</strong> Farmacia,<br />
tel. 0805442743, e-mail: cfranc@farmchim.uniba.it<br />
- Prof. GALLITELLI Donato, Facoltà <strong>di</strong> Scienze Biotecnologiche,<br />
tel. 0805443071, e-mail: gallitel@agr.uniba.it<br />
- Prof. GAROFALO Mario Giovanni, Facoltà <strong>di</strong> Giurisprudenza,<br />
tel. 0805717265, e-mail: mg.garofalo@lex.uniba.it<br />
- Prof. MININNO Antonio, Facoltà <strong>di</strong> Economia,<br />
tel. 0805049060, e-mail: a.mininno@dgm.uniba.it<br />
- Prof. PICCIARELLI Vittorio, Facoltà <strong>di</strong> Scienze MMFFNN,<br />
tel. 0805443152, e-mail: picciarelli@fisica.uniba.it<br />
- Prof. SAVINO Vito Nicola, Facoltà <strong>di</strong> Agraria,<br />
tel. 0805443069, e-mail: savino@agr.uniba.it<br />
- Prof. TURSI Alfredo, Facoltà <strong>di</strong> Me<strong>di</strong>cina e Chirurgia,<br />
tel. 0805478872, e-mail: a.tursi@allergy.uniba.it<br />
- Dott. RUTIGLIANI Pasqua, Responsabile Amministrativa del Progetto, Palazzo Ateneo, Piazza<br />
Umberto I, <strong>Bari</strong>; tel. 0805714681; e-mail: p.rutigliani@<strong>di</strong>ramm.it.<br />
- Dott. DE SANTIS Giorgio, Responsabile Amministrativo del Progetto, Palazzo Ateneo, Piazza<br />
Umberto I, <strong>Bari</strong>; tel. 0805714205; e-mail: g.desantis@<strong>di</strong>ramm.uniba.it.<br />
DIRITTO ALLO STUDIO – UNIVERSITÀ<br />
L’<strong>Università</strong> in collaborazione con l’EDISU, realizza interventi per il <strong>di</strong>ritto allo stu<strong>di</strong>o destinati a<br />
tutti gli studenti, italiani e stranieri e <strong>di</strong>retti a rimuovere gli ostacoli <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne economico e sociale e<br />
si pone come istituzione aperta alle problematiche che emergono dai processi <strong>di</strong> trasformazione e<br />
<strong>di</strong> sviluppo, organizzando attività <strong>di</strong> formazione e <strong>di</strong> promozione culturale. Promuove, inoltre, ogni<br />
forma <strong>di</strong> utile collaborazione con soggetti pubblici e privati, in particolare con quelli preposti al<br />
<strong>di</strong>ritto allo stu<strong>di</strong>o; cura l’informazione circa le possibilità offerte per lo stu<strong>di</strong>o e la formazione<br />
presso altre <strong>Università</strong> o enti, con particolare attenzione ai Programmi comunitari; pubblicizza gli<br />
interventi <strong>di</strong> sua competenza in materia <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto agli stu<strong>di</strong> universitari. In virtù <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>ritto, gli<br />
studenti <strong>di</strong> nazionalità straniera fruiscono <strong>degli</strong> stessi servizi e provvidenze <strong>di</strong> quelli italiani, nei
mo<strong>di</strong> e nelle forme stabiliti per questi ultimi, e quin<strong>di</strong> per concorso, purché esistano trattati o<br />
accor<strong>di</strong> internazionali bilaterali o multilaterali <strong>di</strong> reciprocità tra la Repubblica italiana e gli stati <strong>di</strong><br />
origine <strong>degli</strong> studenti, a patto che non ci siano <strong>di</strong>verse <strong>di</strong>sposizioni previste nell’ambito dei<br />
programmi in favore <strong>di</strong> paesi in via <strong>di</strong> sviluppo. Infine, l’<strong>Università</strong> per la realizzazione <strong>degli</strong><br />
interventi a favore <strong>degli</strong> studenti, concede contributi per:<br />
- attività part- time;<br />
- borse <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o per studenti in sede e fuori sede;<br />
- provvidenze agli studenti;<br />
- premi <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o e <strong>di</strong> laurea per studenti e laureati italiani e stranieri;<br />
- attività <strong>di</strong> supporto per <strong>di</strong>sabili;<br />
- attività culturali autogestite <strong>degli</strong> studenti.<br />
Per informazioni rivolgersi a:<br />
Dipartimento per gli Studenti e la Formazione Post-Laurea, Area Diritto allo <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o, Settore I; tel.<br />
0805714279; fax 0805714178; e-mail: a.volpe@area.<strong>di</strong>rstud.uniba.it.<br />
BORSE DI STUDIO<br />
L’<strong>Università</strong> <strong>di</strong> <strong>Bari</strong> conferisce borse <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o annuali prioritariamente agli studenti, regolarmente<br />
iscritti e risultati idonei non vincitori delle borse <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o concesse dall’EDISU-<strong>Università</strong> <strong>degli</strong><br />
<strong>Stu<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>Bari</strong>.<br />
Il Consiglio <strong>di</strong> Amministrazione determina, anno per anno, la somma complessiva da destinare al<br />
finanziamento delle borse <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o.<br />
L’importo <strong>di</strong> ciascuna borsa è <strong>di</strong> misura pari alla quota in contanti erogata per le borse <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o<br />
concesse dall’EDISU.<br />
Le borse <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o vengono assegnate secondo i criteri stabiliti dal relativo regolamento.<br />
La domanda <strong>di</strong> partecipazione al concorso per le borse <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o, in<strong>di</strong>rizzata a EDISU-<strong>Università</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>Bari</strong> dovrà essere redatta sul modulo pre<strong>di</strong>sposto dall’EDISU barrando la casella riportata nel<br />
frontespizio dello stesso modulo in cui si chiede <strong>di</strong> partecipare al concorso per le borse <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o<br />
offerte dall’<strong>Università</strong> <strong>di</strong> <strong>Bari</strong>. La stessa dovrà essere consegnata all’Ente per il Diritto allo <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o<br />
Universitario, Via Einstein 39 - 70124 <strong>Bari</strong>, nei termini <strong>di</strong>sposti dal bando dello stesso Ente.<br />
Per informazioni rivolgersi a:<br />
Dipartimento per gli Studenti e la Formazione Post-Laurea - Area Diritto allo <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o - Settore II, Ufficio<br />
Borse e Premi <strong>di</strong> <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o (Palazzo Ateneo, I piano, ingresso da Via Crisanzio); lun.-ven. dalle 10,00 alle<br />
12,00, mar. e gio. dalle 15,00 alle 17,00; tel. 0805714848 Sig.ra Stano, oppure tel. 0805714481-4583-4143,<br />
fax 0805714848; e-mail: g.mastrolonardo@area.<strong>di</strong>rstud.uniba.it. Oppure consultare il sito internet<br />
www.uniba.it.<br />
BORSE DI STUDIO PER IL COMPLETAMENTO<br />
DELLA FORMAZIONE SCIENTIFICA DEI LAUREATI<br />
L’<strong>Università</strong> <strong>di</strong> <strong>Bari</strong>, utilizzando fon<strong>di</strong> rivenienti da donazioni, accor<strong>di</strong> con enti e attività<br />
commissionate, istituisce borse <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o in favore <strong>di</strong> giovani laureati, per il completamento della<br />
loro formazione scientifica, secondo i criteri stabiliti da apposito regolamento.<br />
Le borse <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o sono conferite a seguito <strong>di</strong> concorso pubblico per titoli ed esami, ban<strong>di</strong>to con<br />
decreto rettorale, secondo la graduatoria <strong>di</strong> merito, formulata dalla Commissione giu<strong>di</strong>catrice.<br />
Le domande <strong>di</strong> ammissione al concorso, redatte in carta libera, in<strong>di</strong>rizzate al Magnifico Rettore<br />
dell’<strong>Università</strong> <strong>degli</strong> <strong>Stu<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>Bari</strong> - Dipartimento per gli Studenti e la Formazione Post-Laurea,<br />
Area Diritto allo <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o, Settore II, P.zza Umberto I n. 1, 70100 <strong>Bari</strong>, vanno spe<strong>di</strong>te a mezzo
accomandata postale con avviso <strong>di</strong> ricevimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data <strong>di</strong><br />
emanazione del relativo bando. Per il rispetto del termine predetto farà fede la data del timbro<br />
dell’ufficio postale accettante la raccomandata.<br />
È prevista, inoltre, la possibilità dell’erogazione <strong>di</strong> Prestiti d’Onore a favore <strong>di</strong> studenti <strong>di</strong> master in<br />
Italia o all’Estero, ovvero eventualmente <strong>di</strong> Lauree specialistiche ai sensi del nuovo or<strong>di</strong>namento<br />
universitario italiano.<br />
Importo massimo in<strong>di</strong>viduale: € 50.000.<br />
Forma tecnica: apertura <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to in conto corrente con durata massima 24 mesi, da trasformarsi in<br />
cre<strong>di</strong>to personale con durata massima <strong>di</strong> 5 anni ovvero 7 anni, a scelta del cliente;<br />
Rimborsi: con perio<strong>di</strong>cità a scelta del cliente, mensile, trimestrale, o semestrale;<br />
Requisiti:<br />
• attestato <strong>di</strong> ammissione al Master o alla Laurea specialistica;<br />
• curriculum vitae;<br />
• eventuale attestazione del datore <strong>di</strong> lavoro (se applicabile);<br />
Delibera: entro 15 giorni dalla richiesta, con erogazione della somma all’inizio dell’anno<br />
accademico, ovvero all’effettuazione dello stage;<br />
Tasso:<br />
- apertura <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to: Euribor a 3 mesi maggiorato <strong>di</strong> uno spread del 3%;<br />
- cre<strong>di</strong>to personale: Euribor a 3 mesi maggiorato <strong>di</strong> uno spread dell’1% in caso <strong>di</strong> rimborso in 5<br />
anni, ovvero del 3% in caso <strong>di</strong> rimborso in 7 anni;<br />
Con<strong>di</strong>zione accessoria: contributo liberale al Trust “Post-Graduate Education” pari almeno al 3%<br />
del finanziamento accordato;<br />
Obblighi: impegno a domiciliare l’accre<strong>di</strong>to dello stipen<strong>di</strong>o presso le succursali <strong>di</strong> Banca Ar<strong>di</strong>ti<br />
Galati.<br />
Per informazioni rivolgersi a:<br />
Dipartimento per gli Studenti e la Formazione Post-Laurea - Area Diritto allo <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o - Settore II, Ufficio<br />
Borse e Premi <strong>di</strong> <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o (Palazzo Ateneo, I piano, ingresso da Via Crisanzio); lun.-ven. dalle 10,00 alle<br />
12,00, mar. e gio. dalle 15,00 alle 17,00; tel. 0805714583 Sig.ra Pellecchia, oppure tel. 0805714481-4143;<br />
fax 0805714848; e-mail: g.mastrolonardo@area.<strong>di</strong>rstud.uniba.it. Oppure consultare il sito internet<br />
www.uniba.it.<br />
Per informazioni relative ai Prestiti d’Onore rivolgersi a:<br />
Dott. Loredana Napolitano, Dipartimento <strong>di</strong> <strong>Stu<strong>di</strong></strong> Aziendali e Giusprivatistici, Facoltà <strong>di</strong> Economia, tel.<br />
0805049001, cell. 3383425157; Dott. Giuseppe DiNoi, tel. 0805234545, cell. 3297398682; e-mail:<br />
giuseppe.<strong>di</strong>noi@bag.it; Dott. Giorgio De Donno, tel. 0832698303, cell. 3296885111; e-mail:<br />
giorgio.dedonno@bag.it.<br />
ATTIVITÀ CULTURALI AUTOGESTITE DAGLI STUDENTI<br />
Annualmente l’<strong>Università</strong> <strong>di</strong> <strong>Bari</strong> assegna dei fon<strong>di</strong> per le attività culturali <strong>degli</strong> studenti. Le<br />
richieste <strong>di</strong> finanziamento, che comunque non devono avere fini <strong>di</strong> lucro, possono essere avanzate<br />
da:<br />
a) liste studentesche che hanno rappresentanze nel Senato Accademico, nel Consiglio <strong>di</strong><br />
Amministrazione e nei Consigli <strong>di</strong> Facoltà;<br />
b) associazioni studentesche universitarie regolarmente costituite con atto notarile, che abbiano<br />
come associati almeno 50 studenti in corso o fuori corso da non più <strong>di</strong> un anno;<br />
c) altri gruppi <strong>di</strong> studenti universitari costituitisi per la realizzazione <strong>di</strong> una specifica iniziativa<br />
culturale, composti da almeno cinquanta studenti regolarmente iscritti e in corso o fuori<br />
corso da non più <strong>di</strong> un anno.
Nell’ipotesi a) è necessario in<strong>di</strong>care in quale organo collegiale la lista è rappresentata ed il nome del<br />
suo rappresentante;<br />
Nell’ipotesi b) è necessario allegare l’atto costitutivo e l’elenco <strong>di</strong> almeno cinquanta associati che<br />
siano studenti regolarmente iscritti presso l’<strong>Università</strong> <strong>di</strong> <strong>Bari</strong> in corso o fuori corso da non più <strong>di</strong><br />
un anno, con il relativo numero <strong>di</strong> matricola o <strong>di</strong> plico.<br />
Nell’ipotesi c) l’adesione <strong>di</strong> almeno cinquanta studenti, regolarmente iscritti presso l’<strong>Università</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>Bari</strong>, in corso o fuori corso da non più <strong>di</strong> un anno, deve essere attestata dall’elenco <strong>di</strong> firme con il<br />
relativo numero <strong>di</strong> matricola o <strong>di</strong> plico.<br />
Le richieste, che devono essere presentate al Settore II - Borse e premi <strong>di</strong> <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o - Area Diritto allo<br />
<strong>Stu<strong>di</strong></strong>o, Dipartimento Studenti e Formazione Post-Laurea, entro i termini fissati dal bando,<br />
preferibilmente redatte in modo organico, comprensive <strong>di</strong> tutte le iniziative da realizzare dalla stessa<br />
lista, associazione o gruppo, elencate in or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> priorità e con un unico responsabile (e supplente),<br />
dovranno contenere:<br />
1 - La descrizione dettagliata <strong>di</strong> ciascuna iniziativa per cui si chiede il contributo con l’in<strong>di</strong>cazione<br />
<strong>di</strong>:<br />
- tempi e luoghi <strong>di</strong> realizzazione;<br />
- nomi <strong>di</strong> eventuali relatori partecipanti con prova <strong>di</strong> accettazione <strong>degli</strong> stessi ad intervenire;<br />
- eventuali coofinanziatori;<br />
- forme <strong>di</strong> pubblicità intese a promuovere la partecipazione del maggior numero <strong>di</strong> studenti.<br />
2 - Il preventivo <strong>di</strong> spesa dettagliato <strong>di</strong> ciascuna iniziativa.<br />
3 - La designazione <strong>di</strong> uno studente delegato e <strong>di</strong> un supplente, regolarmente iscritti, con rispettive<br />
firme, in<strong>di</strong>rizzi e recapiti telefonici, quali responsabili nei confronti dell’<strong>Università</strong> <strong>di</strong> <strong>Bari</strong> e dei<br />
terzi per tutto quanto attiene alla regolare attuazione delle iniziative.<br />
4 - L’in<strong>di</strong>cazione delle priorità nel caso in cui nello stesso progetto vengano presentate più<br />
iniziative.<br />
Coloro che nell’anno accademico precedente hanno beneficiato dei finanziamenti, contestualmente<br />
alla nuova richiesta, dovranno presentare una relazione illustrativa delle iniziative svolte e delle<br />
forme <strong>di</strong> pubblicità adottate. La mancata presentazione della relazione illustrativa, comporta<br />
l’esclusione dal concorso.<br />
L’inosservanza delle con<strong>di</strong>zioni sopra richieste comporta l’esclusione dalla partecipazione al<br />
concorso.<br />
I fon<strong>di</strong> assegnati dovranno risultare regolarmente impegnati entro il 31 <strong>di</strong>cembre <strong>di</strong> ogni anno<br />
accademico e spesi entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo. In caso contrario, saranno<br />
considerati economia <strong>di</strong> Bilancio in sede <strong>di</strong> redazione del Conto Consuntivo ai sensi dell’art. 16 del<br />
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza, la Contabilità dell’<strong>Università</strong> <strong>degli</strong> <strong>Stu<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>Bari</strong>.<br />
Per informazioni rivolgersi a:<br />
Dipartimento per gli Studenti e la Formazione Post-Laurea - Area Diritto allo <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o - Settore II, Ufficio<br />
Borse e Premi <strong>di</strong> <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o (Palazzo Ateneo, I piano, ingresso da Via Crisanzio); lun.-ven. dalle 10,00 alle 12,00<br />
mar. e gio. dalle 15,00 alle 17,00; tel. 0805714143 Sig.ra Incantalupo, oppure tel. 0805714481-4583; fax<br />
0805714848, e-mail: g.mastrolonardo@area<strong>di</strong>rstud.uniba.it. Oppure consultare il sito internet www.uniba.it.<br />
PREMI DI STUDIO E DI LAUREA<br />
L’<strong>Università</strong> <strong>di</strong> <strong>Bari</strong> conferisce premi <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o e <strong>di</strong> laurea destinati a studenti e a giovani laureati,<br />
secondo criteri stabiliti dal regolamento.<br />
La domanda <strong>di</strong> ammissione al concorso, redatta in carta libera, in<strong>di</strong>rizzata al Rettore dell’<strong>Università</strong><br />
<strong>degli</strong> <strong>Stu<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>Bari</strong>, va spe<strong>di</strong>ta a mezzo raccomandata postale con avviso <strong>di</strong> ricevimento ovvero<br />
consegnata a mano all’Ufficio Borse e Premi <strong>di</strong> <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o dell’Area Diritto allo <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o - Dipartimento<br />
per gli Studenti e la Formazione Post-Laurea, al Palazzo Ateneo, entro e non oltre trenta giorni dalla
data <strong>di</strong> emanazione del bando. Nel caso <strong>di</strong> spe<strong>di</strong>zione, farà fede il timbro a data dell’ufficio postale<br />
accettante la raccomandata.<br />
Per informazioni rivolgersi a:<br />
Dipartimento per gli Studenti e la Formazione Post-Laurea - Area Diritto allo <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o - Settore II, Ufficio<br />
Borse e Premi <strong>di</strong> <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o (Palazzo Ateneo, I piano, ingresso da Via Crisanzio); lun.-ven. dalle 10,00 alle 12,00<br />
mar. e gio. dalle 15,00 alle 17,00; tel. 0805714143 Sig.ra Incantalupo, oppure tel. 0805714481-4583; fax<br />
0805714848; e-mail: g.mastrolonardo@area.<strong>di</strong>rstud.uniba.it. Oppure consultare il sito internet www.uniba.it.<br />
PREMI DI LAUREA AI MIGLIORI LAUREATI DI OGNI FACOLTÀ<br />
L’<strong>Università</strong> <strong>degli</strong> <strong>Stu<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>Bari</strong>, ogni anno accademico, assegna un premio <strong>di</strong> laurea ai migliori<br />
laureati <strong>di</strong> ogni Facoltà.<br />
Il premio è costituito dalla menzione solenne, dalla consegna del sigillo <strong>di</strong> bronzo dell’<strong>Università</strong> da<br />
parte del Rettore e della pergamena <strong>di</strong> laurea da parte del Preside della Facoltà, durante la cerimonia<br />
<strong>di</strong> inaugurazione dell’anno accademico.<br />
La selezione è effettuata d’ufficio fra tutti i laureati dell’anno accademico precedente quello<br />
dell’inaugurazione, secondo criteri stabiliti dal regolamento.<br />
Per informazioni rivolgersi a:<br />
Dipartimento per gli Studenti e la Formazione Post-Laurea - Area Diritto allo <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o - Settore II, Ufficio<br />
Borse e Premi <strong>di</strong> <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o (Palazzo Ateneo, I piano, ingresso da Via Crisanzio); lun.-ven. dalle 10,00 alle<br />
12,00, mar. e gio. dalle 15,00 alle 17,00; tel. 0805714143 Sig.ra Incantalupo, tel. oppure 0805714481-4583;<br />
fax 0805714848; e-mail: g.mastrolonardo@area<strong>di</strong>rstud.uniba.it. Oppure consultare il sito internet<br />
www.uniba.it.<br />
PROVVIDENZE AGLI STUDENTI<br />
L’<strong>Università</strong> <strong>di</strong> <strong>Bari</strong> ha istituito un apposito capitolo <strong>di</strong> spesa, denominato “Provvidenze agli<br />
studenti ivi compresi i portatori <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap”, finalizzato alla concessione <strong>di</strong> un sussi<strong>di</strong>o<br />
straor<strong>di</strong>nario agli studenti universitari che versino in con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> grave <strong>di</strong>sagio economico o<br />
portatori <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap.<br />
Il sussi<strong>di</strong>o è destinato prioritariamente a quegli studenti che, a causa <strong>di</strong> eventi eccezionali, abbiano<br />
subito un grave <strong>di</strong>sagio economico familiare in corso d’anno.<br />
La domanda, redatta su modulo pre<strong>di</strong>sposto dall’<strong>Università</strong> con allegati i seguenti documenti e/o<br />
autocertificazioni in carta libera:<br />
- curriculum stu<strong>di</strong>orum con in<strong>di</strong>cazione dell’anno <strong>di</strong> corso e <strong>degli</strong> esami sostenuti e superati<br />
(fotocopia del libretto universitario);<br />
- stato <strong>di</strong> famiglia;<br />
- fotocopia del co<strong>di</strong>ce fiscale;<br />
- fotocopia della <strong>di</strong>chiarazione del red<strong>di</strong>to <strong>di</strong> ciascun componente il nucleo familiare;<br />
- certificato <strong>di</strong> residenza;<br />
- <strong>di</strong>chiarazione relativa alla citta<strong>di</strong>nanza per gli studenti stranieri;<br />
- eventuale altra documentazione che attesti lo stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>sagio economico del nucleo familiare;<br />
- certificato attestante la con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> portatore <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap (L. 188/71) e la sua percentuale;<br />
deve essere presentata all’Ufficio Borse e Premi <strong>di</strong> <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o - Settore II - Area Diritto allo <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o -<br />
Dipartimento per gli Studenti e la Formazione Post-Laurea, entro i seguenti termini <strong>di</strong> scadenza: 28<br />
febbraio, 30 giugno e 31 ottobre <strong>di</strong> ogni anno.
Il sussi<strong>di</strong>o non può essere richiesto da chi già in possesso <strong>di</strong> un titolo accademico e non è<br />
cumulabile con altri finanziamenti conferiti a qualsiasi altro titolo. Il sussi<strong>di</strong>o, una volta ottenuto,<br />
non esonera dal pagamento <strong>di</strong> tasse e contributi.<br />
Per informazioni rivolgersi a:<br />
Dipartimento per gli Studenti e la Formazione Post-laurea - Area Diritto allo <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o - Settore II, Ufficio<br />
Borse e Premi <strong>di</strong> <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o (Palazzo Ateneo, I piano, ingresso da Via Crisanzio); lun-ven. dalle 10,00 alle 12,00,<br />
mar. e gio. dalle 15,00 alle 17,00; tel. 0805714583 Sig.ra Pellecchia, oppure tel. 0805714481-4143; fax<br />
0805714848; e-mail: g.mastrolonardo@area.<strong>di</strong>rstud.uniba.it. Oppure consultare il sito internet www.uniba.it.<br />
ATTIVITÀ PART-TIME<br />
L’<strong>Università</strong> <strong>di</strong> <strong>Bari</strong> offre ogni anno ai propri studenti attività <strong>di</strong> collaborazione da prestare a tempo<br />
parziale presso le proprie strutture per l’ammontare <strong>di</strong> 150 ore per ciascuno studente. Per poter<br />
partecipare alle suddette forme <strong>di</strong> collaborazione gli studenti dovranno essere già regolarmente<br />
iscritti, alla data <strong>di</strong> scadenza per la partecipazione al concorso, all’anno accademico 2003-2004.<br />
Potranno accedere al concorso gli studenti iscritti dal secondo anno in corso al primo fuori corso, e<br />
quelli iscritti alle lauree specialistiche, a partire dall’anno <strong>di</strong> immatricolazione, con esclusione dei<br />
fuori corso, che abbiano superato entro il 30 settembre 2003 almeno i 2/5 <strong>degli</strong> esami previsti dal<br />
piano <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> prescelto, con riferimento agli anni precedenti o, se iscritti a corsi del nuovo<br />
or<strong>di</strong>namento, che abbiano acquisito entro il 30 settembre 2003 almeno i 2/5 dei cre<strong>di</strong>ti previsti dal<br />
piano <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>, con riferimento agli anni precedenti. Sono esclusi gli studenti già in possesso <strong>di</strong><br />
laurea. La domanda <strong>di</strong> partecipazione va presentata su apposito modulo in <strong>di</strong>stribuzione presso<br />
l’ufficio collaborazioni studentesche dell’Area Diritto allo <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o, entro 30 giorni dalla data <strong>di</strong><br />
pubblicazione del bando <strong>di</strong> concorso. Unitamente alla domanda va presentata un’auto certificazione<br />
relativa alla con<strong>di</strong>zione economica complessiva del proprio nucleo familiare riferita all’anno 2002,<br />
nonché la composizione del nucleo stesso. Saranno esclusi coloro i quali <strong>di</strong>chiareranno una<br />
con<strong>di</strong>zione economica normalizzata superiore a quella stabilita dal bando <strong>di</strong> concorso. Il Consiglio<br />
<strong>di</strong> Amministrazione determina anno per anno l’importo del compenso orario. Avranno la<br />
precedenza gli studenti idonei non vincitori delle borse <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o erogate dall’EDISU, sempre che<br />
abbiano fatto domanda <strong>di</strong> partecipazione al concorso per l’attività a tempo parziale. Allo scopo <strong>di</strong><br />
attuare una più <strong>di</strong>ffusa ed equa <strong>di</strong>stribuzione delle risorse, il beneficio dell’attività a tempo parziale<br />
non è esteso, invece, agli studenti già beneficiari <strong>di</strong> borse <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o. Nel caso <strong>di</strong> eventuali posti<br />
residui si formulerà un’ulteriore graduatoria riservata agli studenti che abbiano presentato domanda<br />
soltanto per il concorso per l’attività a tempo parziale.<br />
Gli studenti part-time per l’a.a. 2002-2003 sono stati complessivamente 2560. Ciascuno studente ha<br />
percepito al netto 930 Euro.<br />
Per informazioni rivolgersi a:<br />
Ufficio Collaborazioni Studentesche, Settore III, Area Diritto allo <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o (Palazzo Ateneo, I piano, ingresso<br />
da Via Nicolai); lun.-ven. dalle 10,00 alle 12,00, mar. e gio. dalle 15,00 alle 17,00; tel. 0805714631-4332-<br />
4270; e-mail: uff.collab.stud@area-segr-studenti.uniba.it.<br />
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (EDISU)<br />
L’EDISU è l’Ente della Regione Puglia per il <strong>di</strong>ritto allo stu<strong>di</strong>o universitario che attua gli interventi<br />
<strong>di</strong>retti a rimuovere gli ostacoli <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne economico e sociale per consentire agli studenti più capaci<br />
e meritevoli, privi <strong>di</strong> mezzi, <strong>di</strong> raggiungere i gra<strong>di</strong> più alti <strong>degli</strong> stu<strong>di</strong>. I destinatari <strong>degli</strong> interventi<br />
sono gli iscritti ad un qualsiasi corso <strong>di</strong> laurea dell’<strong>Università</strong> <strong>di</strong> <strong>Bari</strong>.<br />
L’EDISU offre i seguenti servizi:
- erogazione borse <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o;<br />
- servizi abitativi;<br />
- servizio ristorazione;<br />
- facilitazioni <strong>di</strong> trasporto;<br />
- servizio librario;<br />
- servizi speciali per gli studenti portatori <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap;<br />
- interventi per attività culturali, ricreative, turistiche e sportive.<br />
Alloggi<br />
L’EDISU mette a <strong>di</strong>sposizione circa 800 posti letto ripartiti nei seguenti alloggi:<br />
- Residenza Universitaria “Renato Dell’Andro”, Via C. Rosalba 55, <strong>Bari</strong>, tel. 0805438622 (420<br />
posti, <strong>di</strong> cui 10 riservati a portatori <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap);<br />
- Collegio “D. Fresa”, Via Colaianni, <strong>Bari</strong>, tel. 0805439999 (120 posti + 5 posti per portatori <strong>di</strong><br />
han<strong>di</strong>cap);<br />
- Collegio “Benedetto Petrone”, Via Salvemini 2/h, <strong>Bari</strong>, tel. 0805439401 (180 posti);<br />
- Residenza Universitaria, Via Caldarola trav. 24, <strong>Bari</strong>, tel. 0805580443 (82 posti).<br />
L’EDISU, al fine <strong>di</strong> consentire agli studenti non beneficiari <strong>di</strong> posto alloggio <strong>di</strong> reperire sul mercato<br />
alloggi rispondenti alle specifiche esigenze <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o a prezzi contenuti e con contratto chiaro, ha<br />
firmato un Protocollo d’Intesa con il Comune <strong>di</strong> <strong>Bari</strong> ed altre Associazioni. Per informazioni a<br />
riguardo è stato attivato il numero verde 800-637979.<br />
Mense<br />
- Residenza Universitaria “Renato Dell’Andro”, Via C. Rosalba 55, <strong>Bari</strong> (nei pressi della Facoltà <strong>di</strong><br />
Economia), tel. 0805042636;<br />
- Casa dello Studente, Via Murat 2, <strong>Bari</strong>, tel. 0805439053;<br />
- Mensa <strong>di</strong> Me<strong>di</strong>cina, Via Garrone 64, <strong>Bari</strong>, tel. 0805617585;<br />
- Mensa <strong>di</strong> Me<strong>di</strong>cina Veterinaria c/o la Facoltà, Valenzano<br />
- Collegio Universitario Maschile, Via Amendola 165, <strong>Bari</strong>, tel. 0805538055;<br />
- C/o Economia Aziendale, Via Lago Maggiore 1, Taranto.<br />
Le mense universitarie sono aperte dal lunedì al sabato, dalle ore 12,00 alle ore 14,30 e dalle ore<br />
19,00 alle ore 20,30. Nei giorni festivi le mense funzionano a turno.<br />
Servizi<br />
- Servizio <strong>di</strong> trasporto garantito dalla Ditta Miccolis da Largo Ciaia alla Facoltà <strong>di</strong> Veterinaria<br />
(Valenzano); intera rete <strong>Bari</strong> in convenzione <strong>Università</strong>/Amtab con fermate de<strong>di</strong>cate al Campus e<br />
Facoltà <strong>di</strong> Economia e Commercio (abbonamento mensile 5,25 Euro);<br />
- Servizio <strong>di</strong> prestito librario presso la sede centrale dell’Ente;<br />
- Centro Turistico Culturale per ogni attività;<br />
- CUS <strong>Bari</strong> per attività sportive e impianti sportivi “R.D.A.”;<br />
- Ampia informativa sul Diritto allo <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o presso la sede centrale dell’Ente.<br />
Per informazioni rivolgersi a:<br />
Dipartimento per gli Studenti e la Formazione Post-Laurea, Area Diritto allo <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o, Settore I, Palazzo Ateneo (atrio <strong>di</strong><br />
Via Nicolai), lun.-ven. dalle ore 10,00 alle ore 12,00; mar. e gio. dalle ore 15,00 alle ore 17,00; tel. 080/5714279, fax<br />
080/5714178; e-mail: a.volpe@area-<strong>di</strong>rstud.uniba.it.
EDISU, Via Einstein 39, tel. 080/5438011; fax 080/5576028, numero verde 800-637979; e-mail:<br />
e<strong>di</strong>su_università@tin.it; lun.-ven. dalle ore 9,00 alle ore 12,00; mar. e gio. dalle ore 15,00 alle ore 17,00.<br />
SERVIZI A FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI<br />
L’<strong>Università</strong>, in applicazione della legge n. 17/99 in materia <strong>di</strong> assistenza, integrazione sociale e<br />
<strong>di</strong>ritti delle persone <strong>di</strong>sabili, ha avviato una serie <strong>di</strong> iniziative intese a garantire agli studenti <strong>di</strong>sabili<br />
servizi e sussi<strong>di</strong> tecnici e <strong>di</strong>dattici specifici, in relazione all’han<strong>di</strong>cap posseduto, che assicurino<br />
l’effettivo esercizio del <strong>di</strong>ritto allo stu<strong>di</strong>o.<br />
Di recente sono stati avviati i seguenti servizi:<br />
- allestimento <strong>di</strong> un sito Internet de<strong>di</strong>cato agli studenti <strong>di</strong>sabili all’interno del quale sono consultabili<br />
informazioni sulle attività, sui servizi, etc.: www.uniba.it/<strong>di</strong>sabilita/index.htm;<br />
- allestimento <strong>di</strong> 5 isole <strong>di</strong>dattiche, attrezzate con ausili informatici, specifici per le tre tipologie <strong>di</strong><br />
han<strong>di</strong>cap (visiva, u<strong>di</strong>tiva, motoria), ubicate nei principali plessi universitari (Economia, Campus,<br />
Ateneo, Facoltà <strong>di</strong> Scienze della Formazione – Via De Rossi 233, Scienze Giuri<strong>di</strong>che sede <strong>di</strong><br />
Taranto);<br />
- allestimento della sala Accoglienza nel Palazzo Ateneo;<br />
- <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> computer da affidare in comodato d’uso gratuito per la utilizzazione a domicilio.<br />
Inoltre, per gli studenti <strong>di</strong>sabili che vogliono partecipare ai programmi <strong>di</strong> mobilitazione all’estero<br />
sono previsti dei contributi finanziari aggiuntivi, così come è prevista una quota aggiuntiva da<br />
destinare alle attività culturali autogestite.<br />
La gestione dei servizi a favore dei <strong>di</strong>sabili è affidata all’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico.<br />
Per informazioni rivolgersi a:<br />
Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, Palazzo Ateneo (Atrio <strong>di</strong> Piazza Umberto), lun.-ven. dalle 9,30 alle<br />
13,00 e dalle 16,00 alle 18,00; tel. 0805714488-4413, 800-883046 (linea verde); fax 0805714830.<br />
CINEMA E TEATRO<br />
L’<strong>Università</strong> <strong>di</strong> <strong>Bari</strong> ha inteso de<strong>di</strong>care ancora più attenzione alle iniziative volte a migliorare la<br />
qualità della vita dello studente, anche rispetto alla permanenza in città, dando concreta attuazione a<br />
quanto recita lo Statuto, tra i principi generali, all’art. 10: “L’università favorisce le attività<br />
culturali, ricreative e sociali <strong>di</strong> tutte le componenti universitarie”.<br />
A tal fine, è stato stipulato un Accordo, con la delegazione dell’AGIS/ANEC <strong>di</strong> Puglia e Basilicata<br />
e con le Amministrazioni provinciali <strong>di</strong> <strong>Bari</strong>, Taranto e Brin<strong>di</strong>si, che consente agli studenti<br />
universitari <strong>di</strong> poter accedere agli spettacoli cinematografici usufruendo <strong>di</strong> una consistente<br />
riduzione sul costo dei biglietti d’ingresso.<br />
Lo studente, esibendo una foto tessera, un documento <strong>di</strong> identità ed una certificazione attestante la<br />
sua posizione <strong>di</strong> studente univarsitario regolarmente iscritto, ha <strong>di</strong>ritto, previo versamento <strong>di</strong> 2 Euro<br />
nelle casse dell’<strong>Università</strong>, al rilascio <strong>di</strong> una showcard (<strong>di</strong> <strong>formato</strong> simile alla carta <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to,<br />
strettamente personale, fornita <strong>di</strong> foto e <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà triennale), con cui ottenere i ticket da presentare<br />
ai botteghini delle sale cinematografiche delle città <strong>di</strong> <strong>Bari</strong>, Brin<strong>di</strong>si e Taranto e dei Comuni delle<br />
rispettive province: ciò gli consente <strong>di</strong> acquistare il biglietto al prezzo <strong>di</strong> 2 Euro (per tutti gli<br />
spettacoli giornalieri, dal lunedì al venerdì e per il primo spettacolo del sabato).<br />
Tale possibilità è consentita anche agli specializzan<strong>di</strong> e ai dottoran<strong>di</strong>.<br />
Per informazioni rivolgersi a:<br />
Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, Palazzo Ateneo (Atrio <strong>di</strong> Piazza Umberto), lun.-ven. dalle 9,30 alle<br />
13,00 e dalle 16,00 alle 18,00; tel. 0805714488-4413, 800-883046 (linea verde), fax 0805714830.<br />
CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO
Il Centro Linguistico d’Ateneo (CLA) è una “comunità virtuale”, il cui obiettivo primario è<br />
l’insegnamento della comunicazione linguistica con gli altri citta<strong>di</strong>ni del mondo, nonché<br />
l’inserimento dei destinatari delle attività formative nella realtà economico-produttiva locale,<br />
nazionale ed europea. Il CLA si compone <strong>di</strong> un Polo Centrale, presso la Facoltà <strong>di</strong> Lingue e<br />
Letterature Straniere e <strong>di</strong> 10 Poli a struttura modulare, con piena autonomia <strong>di</strong> servizi e<br />
collegamento in rete.<br />
Le attività del CLA comprendono:<br />
a) formazione linguistica per gli studenti, personale docente e tecnico-amministrativo<br />
dell’<strong>Università</strong>;<br />
b) formazione per la <strong>di</strong>dattica linguistica multime<strong>di</strong>ale;<br />
c) formazione linguistica informatica;<br />
d) formazione informatica <strong>di</strong> base.<br />
Il Centro Linguistico d’Ateneo <strong>di</strong>spone <strong>di</strong> 33 aule, per un totale <strong>di</strong> 596 postazioni.<br />
Ciascun Polo del CLA si compone <strong>di</strong> più laboratori:<br />
- 1 aula multime<strong>di</strong>ale, 1 aula self-access (Polo della Facoltà <strong>di</strong> Agraria);<br />
- 1 aula multime<strong>di</strong>ale, 2 laboratori analogici, 1 aula self-access (Polo della Facoltà <strong>di</strong> Economia);<br />
- 1 aula multime<strong>di</strong>ale, 1 aula self-access (Polo della Facoltà <strong>di</strong> Farmacia);<br />
- 1 aula multime<strong>di</strong>ale, 2 laboratori analogici, 1 aula self-access (Polo della Facoltà <strong>di</strong><br />
Giurisprudenza/Scienze Politiche);<br />
- 1 aula multime<strong>di</strong>ale, 1 laboratorio analogico, 1 aula self-access (Polo della Facoltà <strong>di</strong> Lettere);<br />
- 2 aule multime<strong>di</strong>ali, 2 laboratori analogici, 1 aula self-access, 1 biblioteca multime<strong>di</strong>ale (Polo<br />
Centrale della Facoltà <strong>di</strong> Lingue e Letterature Straniere);<br />
- 1 aula multime<strong>di</strong>ale, 1 aula self-access (Polo della Facoltà <strong>di</strong> Me<strong>di</strong>cina e Chirurgia);<br />
- 1 aula multime<strong>di</strong>ale, 1 aula self-access (Polo della Facoltà <strong>di</strong> Me<strong>di</strong>cina Veterinaria);<br />
- 1 aula multime<strong>di</strong>ale, 1 laboratorio analogico, 1 aula self-access (Polo della Facoltà <strong>di</strong> Scienze<br />
MMFFNN);<br />
- 1 aula multime<strong>di</strong>ale, 1 laboratorio analogico, 1 aula self-access (Polo della Facoltà <strong>di</strong> Scienze<br />
della Formazione);<br />
- 1 aula multime<strong>di</strong>ale, 1 aula self-access (Polo della sede gemmata <strong>di</strong> Taranto).<br />
Direttore: prof. Giovanni Dotoli, Or<strong>di</strong>nario <strong>di</strong> Lingua e Letteratura Francese.<br />
Sede: Facoltà <strong>di</strong> Lingue e Letterature Straniere, via Garruba n. 6/b (I piano); tel. 0805717521; fax<br />
0805717538; e-mail: centro.linguistico@lingue.uniba.it.<br />
SERVIZIO DI CONSULTAZIONE PSICOLOGICA<br />
Presso il Dipartimento <strong>di</strong> Psicologia è istituito il Servizio <strong>di</strong> Consultazione Psicologica per gli<br />
studenti dell’<strong>Università</strong> <strong>di</strong> <strong>Bari</strong>.<br />
Il Servizio svolge attività <strong>di</strong> counseling, a orientamento psico<strong>di</strong>namico, con l’obiettivo <strong>di</strong> fornire<br />
agli studenti in <strong>di</strong>fficoltà psicologica un primo momento <strong>di</strong> confronto e chiarificazione che aiuti a<br />
farsi carico dei problemi e delle iniziative necessarie per affrontarli.<br />
Agli studenti interessati è data la possibilità <strong>di</strong> effettuare un ciclo <strong>di</strong> cooloqui in<strong>di</strong>viduali –<br />
solamente cinque, a cadenza settimanale, sempre con lo stesso psicologo – o <strong>di</strong> partecipare a<br />
workshops esperienziali <strong>di</strong> gruppo, a cadenza mensile.<br />
Il Servizio si articola nel seguente modo:<br />
• accettazione delle richieste, attraverso la segreteria, aperta il martedì e il giovedì dalle ore 11,30<br />
alle ore 13,00 presso la sede <strong>di</strong> via G. Petroni, 15/f (VII piano) - <strong>Bari</strong>, tel./fax 0805561228;
• attività <strong>di</strong> consultazione: gli operatori impegnati in questa fase sono psicologi accomunati da un<br />
percorso formativo abbastanza omogeneo ad orientamento psico<strong>di</strong>namico.<br />
Il Servizio è gratuito. Per comunicazioni è <strong>di</strong>sponibile la casella <strong>di</strong> posta elettronica:<br />
consultorio@psico.uniba.it.<br />
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER IL TEATRO,<br />
LE ARTI VISIVE, LA MUSICA, IL CINEMA (CUTAMC)<br />
Per iniziativa della Commissione Cultura dell’<strong>Università</strong> <strong>di</strong> <strong>Bari</strong> è stato istituito nel 1995 il Centro<br />
Universitario per il Teatro, le Arti Visive, la Musica, il Cinema (CUTAMC), da quest’anno<br />
tras<strong>formato</strong>si in Centro Inter<strong>di</strong>partimentale <strong>di</strong> Ricerca per il Teatro, le Arti Visive, la Musica, il<br />
Cinema.<br />
Il Centro ha le seguenti finalità:<br />
• promozione, sviluppo e <strong>di</strong>ffusione <strong>degli</strong> stu<strong>di</strong> e delle ricerche, in campo artistico relativo alle arti<br />
visive, musicali, teatrali, cinematografiche;<br />
• acquisizione <strong>di</strong> materiali documentari, scientifici, librari, <strong>di</strong> interesse specifico e costituzione <strong>di</strong><br />
laboratori con particolare riferimento agli ambiti su menzionati;<br />
• or<strong>di</strong>namento dei suddetti materiali in biblioteca specialistica <strong>di</strong> consultazione e <strong>di</strong> archivio<br />
multime<strong>di</strong>ale;<br />
• promozione ed organizzazione <strong>di</strong> convegni, conferenze, seminari, manifestazioni,<br />
rappresentazioni, esposizioni documentarie, artistiche e bibliografiche e scambi <strong>di</strong> esperienze anche<br />
internazionali nei <strong>di</strong>versi settori previsti dal Centro;<br />
• formazione <strong>di</strong> gruppi studenteschi attraverso laboratori, mostre e spettacoli che coinvolgono<br />
l’<strong>Università</strong> e/o il territorio.<br />
Il Centro può costituirsi come e<strong>di</strong>tore <strong>di</strong> collane <strong>di</strong> testi, materiali e stu<strong>di</strong> e come organizzatore <strong>di</strong><br />
manifestazioni e produzioni culturali.<br />
È stato attivato dall’a.a. 2001-2002 un laboratorio teatrale, <strong>di</strong> cui è coor<strong>di</strong>natore il prof. F.<br />
Fiorentino. Tale laboratorio si conclude con una rappresentazione pubblica <strong>di</strong>versa per ogni anno. Il<br />
laboratorio si svolge nella sede del CUTAMC, ed è riservato a 15 studenti dell’Ateneo barese scelti<br />
a seguito <strong>di</strong> concorso. Inoltre, è attivata una rassegna cinematografica <strong>di</strong> carattere storico e<br />
retrospettivo intitolata Sentieri del Cinema con la collaborazione dell’Associazione culturale <strong>Bari</strong><br />
Film & Video e con argomenti specifici e <strong>di</strong>versi ogni anno.<br />
La sezione musicale è preposta anche alla ideazione-organizzazione <strong>di</strong> manifestazioni a tema su<br />
particolari aspetti della storia della musica colta ed extra-colta.<br />
Direttore: prof. Francesco Tateo<br />
Presidente onorario: prof. Ernesto Quagliariello<br />
Giunta: proff. Raffaele Cavalluzzi, Grazia Distaso, Erina Siciliani, Giovanna Zaccaro<br />
Sede: CUTAMC, pal. S. Giacomo, Strada S. Giacomo (Borgo Antico, nei pressi della Cattedrale), tel.<br />
0805714621 o 0805243270.<br />
CORO E ORCHESTRA DELL’ATENEO BARESE “HARMONIA”<br />
L’Associazione Harmonia, Coro e Orchestra dell’Ateneo barese costituitasi ufficialmente nel 1989<br />
svolge un’intensa attività musicale all’interno dell’<strong>Università</strong> e della comunità locale.<br />
Interesse principale dell’Associazione è la <strong>di</strong>ffusione della pratica musicale e corale tra i giovani e,<br />
in particolare, tra gli studenti universitari attraverso il lavoro svolto dai gruppi strumentali e vocali<br />
che hanno promosso nell’ambito della comunità accademica una sempre maggior sensibilizzazione<br />
a forme profondamente educative in campo umano e culturale.
L’idea, infatti, è quella <strong>di</strong> far tesoro dell’esperienza culturale <strong>di</strong> altri paesi europei, dove in ogni<br />
or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> scuola esiste la pratica musicale d’insieme, strumentale e corale, vissuta come momento<br />
aggregante ed educativo.<br />
Nutrita da questa idea, Harmonia ha compiuto passi decisivi per instaurare nell’Ateneo barese<br />
un’attiva tra<strong>di</strong>zione musicale: con oltre 200 tra concerti e seminari in collaborazione con i<br />
Dipartimenti <strong>di</strong> Italianistica, Lingue e Tra<strong>di</strong>zioni culturali europee, frequenti collaborazioni<br />
<strong>di</strong>dattiche e artistiche con il Conservatorio <strong>di</strong> <strong>Bari</strong> e Monopoli, corsi <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione corale e <strong>di</strong> vocalità<br />
e canto.<br />
Di grande rilievo anche gli scambi con altre realtà musicali e universitarie all’estero.<br />
Il Coro Polifonico dell’Associazione Harmonia (repertorio a cappella e concertante dal Barocco al<br />
‘900) è aperto a:<br />
• coloro che hanno già qualche esperienza corale o musicale, e comunque aventi i seguenti requisiti:<br />
buona intonazione, passione per il canto orale, <strong>di</strong>sponibilità per due prove settimanali serali;<br />
• coloro che provengono dal Coro Propedeutico <strong>di</strong> Harmonia il quale è aperto a tutti i principianti,<br />
con la durata <strong>di</strong> un anno (un incontro settimanale). Il programma prevede: teoria musicale, lettura<br />
musicale cantata, principi <strong>di</strong> vocalità, momenti <strong>di</strong> ascolto guidato, facile repertorio corale a più voci,<br />
vita <strong>di</strong> gruppo e nell’Associazione.<br />
Il Direttore del Coro Polifonico è Antonella Arnese (tel./fax 0809911411; cell. 3397947411).<br />
Il Direttore del Coro Propedeutico è Francesco Abbrescia (tel. 0805013427, cell. 3393810251).<br />
È al suo quinto anno invece, la Scuola Popolare <strong>di</strong> Musica, nata in seno al CUTAMC, è confluita<br />
dall’anno 2000 nell’Associazione Harmonia. Ha come finalità lo stu<strong>di</strong>o della musica e <strong>degli</strong><br />
strumenti a fiato ed è in<strong>di</strong>rizzato a principianti e non. L’ensemble <strong>di</strong> fiati “Improbabilband” della<br />
Scuola ha già partecipato al Festival International de Mousique Universitarie <strong>di</strong> Belfort in Francia<br />
(maggio 2001) e ad una tournèe <strong>di</strong> Harmonia presso le <strong>Università</strong> della Polonia nel maggio 2002.<br />
Organizza anche per il prossimo anno accademico, corsi <strong>di</strong>: oboe, clarinetto, flauto, tromba,<br />
trombone sassofono, corno, canto, musica d’insieme e improvvisazione, solfeggio e lettura della<br />
musica. Il Direttore della Scuola è il Maestro Franco Angiolo. Per informazioni sulla Scuola<br />
rivolgersi al numero <strong>di</strong> cellulare 3384646156.<br />
L’Orchestra <strong>degli</strong> Studenti Universitari, costituitasi nel gennaio 2002, è riservata ad allievi del<br />
Conservatorio – studenti universitari – strumentisti ad arco e a fiato, al fine <strong>di</strong> poter realizzare<br />
un’orchestra stabile e dare l’opportunità agli studenti musicisti <strong>di</strong> fare l’esperienza della musica<br />
d’insieme nell’ambito dell’Associazione, specializzandosi in primo luogo nella prassi esecutiva<br />
della musica barocca<br />
Maestro Sabino Manzo (tel. 0805304490; cell. 3393347692).<br />
Sede: c/o CUTAMC, pal. S. Giacomo, Strada S. Giacomo (Borgo Antico, nei pressi della Cattedrale);<br />
www.harmoniaonline.org.<br />
CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO (CUS)<br />
Il Centro Universitario Sportivo (CUS) incentiva la politica sportiva nell’ambito universitario nel<br />
quadro della formazione globale dello studente. Il Centro, oltre alla gestione e alla manutenzione<br />
<strong>degli</strong> impianti sportivi, promuove corsi <strong>di</strong> iniziazione o perfezionamento nelle varie <strong>di</strong>scipline<br />
sportive e partecipa alle attività agonistiche a carattere universitario e federale.<br />
Modalità <strong>di</strong> iscrizione<br />
Possono essere ammessi a frequentare gli impianti sportivi del CUS e ad usufruire dei relativi<br />
servizi gli studenti regolarmente iscritti all’<strong>Università</strong> <strong>di</strong> <strong>Bari</strong> che richiedano il tesseramento al<br />
CUS, con la seguente documentazione: certificato attestante la propria posizione universitaria
(libretto con timbro aggiornato, ricevuta <strong>di</strong> versamento, etc.), documento d’identità personale, una<br />
foto <strong>formato</strong> tessera, certificato <strong>di</strong> sana e robusta costituzione, quota ad anno solare <strong>di</strong> 10 Euro.<br />
A seguito <strong>di</strong> tali adempimenti, lo studente riceverà un tesserino con foto plastificato che dovrà<br />
esibire al personale <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a all’ingresso. Il CUS provvederà alla relativa copertura assicurativa<br />
presso una Compagnia Assicuratrice <strong>di</strong> sua fiducia. Fatta eccezione per i provve<strong>di</strong>menti previsti dal<br />
regolamento della Compagnia <strong>di</strong> Assicurazione, il CUS è sollevato da ogni responsabilità derivante<br />
da eventuali incidenti sia in mare, che in terra.<br />
L’affiliazione decorre dal 1 gennaio al 31 <strong>di</strong>cembre dell’anno solare. Nell’uso <strong>degli</strong> impianti e nello<br />
svolgimento delle attività programmate gli studenti sono tenuti ad osservare la necessaria <strong>di</strong>sciplina,<br />
attenendosi alle istruzioni dei tecnici e del personale del CUS. In particolare, essi sono tenuti al<br />
massimo rispetto <strong>degli</strong> ambienti, nonché <strong>degli</strong> orari e delle modalità <strong>di</strong> svolgimento delle <strong>di</strong>verse<br />
attività. Coloro che si rendano responsabili <strong>di</strong> infrazioni o che arrechino danno alle cose o alle<br />
persone saranno segnalati all’Autorità accademica per eventuali provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong>sciplinari.<br />
Uso libero <strong>degli</strong> impianti<br />
A tutti gli studenti affiliati è consentito, sotto la propria responsabilità, il libero uso dei seguenti<br />
impianti:<br />
- piscina coperta: 1 ottobre/15 giugno - ore 10,00-16,00 (escluso il lunedì) e ore 10,00-13,00 (giorni<br />
festivi);<br />
- piscina scoperta: 15 giugno/15 settembre - ore 10,00-17,00 (escluso il lunedì) e ore 10,00-13,00<br />
(giorni festivi);<br />
- palazzetto dello sport e pista <strong>di</strong> pattinaggio: 1 gennaio/31 <strong>di</strong>cembre (escluso il mese <strong>di</strong> agosto), ore<br />
10,00-13,00 (giorni feriali e festivi, escluso il lunedì);<br />
- campi da tennis: 1 gennaio/31 <strong>di</strong>cembre (escluso il mese <strong>di</strong> agosto), ore 10,00 sino al tramonto<br />
(escluso il lunedì);<br />
- campo <strong>di</strong> calcio a 5: 1 gennaio/31 <strong>di</strong>cembre (escluso il mese <strong>di</strong> agosto), ore 10,00-21,30 (esclusi il<br />
lunedì e il pomeriggio dei giorni festivi);<br />
- campo <strong>di</strong> calcio a 11: 1 gennaio/31 <strong>di</strong>cembre (escluso il mese <strong>di</strong> agosto), ore 10,00 sino al<br />
tramonto (esclusi il lunedì e il pomeriggio dei giorni festivi);<br />
- pista <strong>di</strong> atletica leggera: 1 gennaio/31 <strong>di</strong>cembre (escluso il mese <strong>di</strong> agosto), ore 10,00 sino al<br />
tramonto (esclusi il lunedì e il pomeriggio dei giorni festivi).<br />
Per l’uso dei campi da tennis, <strong>di</strong> calcio e calcetto, nonché della palestra per car<strong>di</strong>o-fitness e<br />
muscolazione, oltre la prenotazione, sarà dovuto un <strong>di</strong>ritto orario agevolato. Per la piscina coperta e<br />
scoperta non è necessario prenotarsi.<br />
Ogni studente ha <strong>di</strong>ritto ad usufruire <strong>degli</strong> spogliatoi con le relative docce ad acqua fredda e calda,<br />
nonché dei servizi igienici, nel massimo rispetto del decoro, dell’igiene e della tutela <strong>degli</strong> ambienti<br />
e delle suppellettili. Ciascuno studente è tenuto a frequentare gli impianti con propri indumenti<br />
idonei alla relativa salvaguar<strong>di</strong>a delle attrezzature ed alla sicurezza delle persone. Il CUS potrà<br />
fornire indumenti ed attrezzi soltanto agli studenti ammessi a partecipare alle attività federali.<br />
Corsi <strong>di</strong> iniziazione alla pratica sportiva<br />
Su richiesta <strong>di</strong> almeno trenta studenti, il CUS organizza, dal 1 novembre al 30 aprile <strong>di</strong> ciascun<br />
anno, dei corsi <strong>di</strong> iniziazione alle seguenti <strong>di</strong>scipline: atletica leggera, pallacanestro, pattinaggio. I<br />
suddetti corsi avranno durata trimestrale e saranno concordati con gli studenti interessati in base ai<br />
propri impegni <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o. La frequenza è gratuita.<br />
Attività universitaria<br />
Il CUS organizza annualmente, su richiesta <strong>di</strong> almeno trenta studenti interessati, tornei interfacoltà<br />
nelle seguenti <strong>di</strong>scipline: atletica leggera, calcio a 11, calcio a 5, nuoto, pallacanestro, tennis. Gli<br />
studenti particolarmente versati nelle <strong>di</strong>scipline predette potranno partecipare, per i colori del CUS e
ad insindacabile giu<strong>di</strong>zio dei tecnici designati dal medesimo, ai Campionati Nazionali Universitari<br />
organizzati annualmente dal CUSI.<br />
Attività federale<br />
Gli studenti che <strong>di</strong>mostrino, ad insindacabile giu<strong>di</strong>zio dei tecnici designati dal CUS, il necessario<br />
livello <strong>di</strong> attitu<strong>di</strong>ne ed impegno potranno essere ammessi a partecipare, a cura e spese del<br />
medesimo, all’attività agonistica organizzata dalle seguenti Federazioni Nazionali facenti capo al<br />
CONI a cui il CUS è affiliato: atletica leggera, canoa, canottaggio, lotta greco-romana e stile libero,<br />
nuoto, pallacanestro e pattinaggio.<br />
Corsi speciali <strong>di</strong> istruzione<br />
Il CUS organizza presso il proprio Centro Fitness corsi <strong>di</strong> car<strong>di</strong>o-fitness, muscolazione, aerobica,<br />
step, ginnastica tonificante e allenamenti personalizzati <strong>di</strong> durata mensile e trimestrale dal 1 ottobre<br />
al 30 giugno (lun.-mer.-ven. dalle 10,00 alle 22,00, mar.-gio dalle 12,00 alle 22,00, sab. dalle 10,00<br />
alle 19,00). Inoltre, organizza corsi <strong>di</strong> nuoto nelle varie specialità natatorie, <strong>di</strong> durata trimestrale con<br />
frequenza settimanale dal 1 ottobre al 30 giugno. Per la partecipazione a tali corsi gli studenti<br />
godranno <strong>di</strong> particolari agevolazioni.<br />
Per informazioni rivolgersi a:<br />
Segreteria CUS, Lungomare Starita, 1/a-b; tel. 0805341779; fax 0805344865 (lun.-ven. 10,00-12,00, 17,00-<br />
19,00; sab. 10,00-12,00).<br />
Sportello del CUS, sito nel cortile del Palazzo Ateneo, Piazza Umberto 1 (mar. e gio., dalle 10,00 alle 12,00);<br />
sito web: www.cusbari.it; e-mail: info@cusbari.it.<br />
LA CAPPELLA DELL’UNIVERSITÀ<br />
La Cappella dell’<strong>Università</strong>, sita all’interno del cortile <strong>di</strong> Piazza Umberto I dell’Ateneo barese, è un<br />
servizio dell’<strong>Università</strong> a favore delle persone che vi stu<strong>di</strong>ano e vi lavorano. Sua finalità è integrare<br />
ciò che l’<strong>Università</strong> offre sul piano accademico, attraverso una serie <strong>di</strong> iniziative specifiche su piani<br />
complementari, in particolare su quello esistenziale.<br />
La Cappella è aperta continuativamente dalle 8,00 alle 20,00 allo scopo <strong>di</strong>:<br />
- offrire uno spazio <strong>di</strong> silenzio;<br />
- offrire un servizio <strong>di</strong> accoglienza in risposta ai bisogni materiali <strong>degli</strong> studenti, soprattutto fuorisede;<br />
- offrire una possibilità <strong>di</strong> confronto su problemi personali con l’aiuto <strong>di</strong> un sacerdote, una suora o<br />
una laica;<br />
- offrire un luogo dove si <strong>di</strong>battono i temi <strong>di</strong> fondo dell’esistere o le maggiori problematiche del<br />
momento, attraverso conferenze, tavole rotonde, gruppi <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o, anche con esponenti <strong>di</strong> religioni<br />
non cristiane e del pensiero cosiddetto laico;<br />
- offrire ai cattolici la celebrazione dell’Eucaristia (dal lunedì al venerdì, ore 8,00 e 12,30) e del<br />
sacramento della Riconciliazione;<br />
- offrire un servizio <strong>di</strong> evangelizzazione e <strong>di</strong> catechesi (letture bibliche, gruppi <strong>di</strong> preghiera e <strong>di</strong><br />
con<strong>di</strong>visione, etc.);<br />
- offrire cammini <strong>di</strong> gruppo.<br />
I Padri gesuiti, presenti in Cappella dal lunedì al venerdì, sono: Padre Stefano Titta e Padre Franco<br />
Annichiarico.<br />
Si può contattarli al seguente in<strong>di</strong>rizzo:<br />
Comunità Padri Gesuiti, Piazza Diaz 11, 70121 <strong>Bari</strong>; tel. 0805559434; telefax 0805524381: e-mail:<br />
gesuiti.bari@gesuiti.it, web: www.gesuiti.it.
Acquaviva delle Fonti<br />
Piazza Garibal<strong>di</strong> – tel. 080761134<br />
Alberobello<br />
Piazza del Popolo, 1 – tel. 0804322280<br />
Andria<br />
Piazza Umberto I – tel. 0883290340<br />
Barletta<br />
Via Libertà, 5 – tel. 0883349427<br />
SEGRETERIE STUDENTI REMOTE<br />
Bitonto<br />
Via Dossetti c/o Ufficio Polizia Municipale - tel. 0803751014<br />
Canosa<br />
Piazza Martiri XXIII Marzo – tel. 0883615707<br />
Cassano Murge<br />
Piazza Aldo Moro, 10 – tel. 080764333<br />
Castellana Grotte<br />
Via Michele Latorre, 10/I – tel. 0804900249<br />
Cerignola (FG)<br />
Piazza Cesare Battisti – tel. 0885421113<br />
Corigliano Calabro (CS)<br />
Via Aldo Moro – tel. 098383851<br />
Fasano<br />
Via del Balì, 18 – tel. 0804394191<br />
Melfi (PZ)<br />
Piazza Pasquale Festa Campanile – tel. 0972251111<br />
Molfetta<br />
Palazzo Giovene, P.zza Municipio – tel. 0803349052<br />
Noci<br />
Via Giambattista Sansonetti – tel. 0804948225<br />
Palo del Colle<br />
Viale della Resistenza – tel. 080627623<br />
Ruvo <strong>di</strong> Puglia<br />
Via Alcide de Gasperi, 26 – tel. 0803612539
Santeramo in Colle<br />
Via Armando Diaz, 3 – tel. 0803037763<br />
Trani<br />
Via Tenente Morrico, 2 – tel. 0883581211<br />
Valenzano<br />
Via Gabriele D’Annunzio, 2 – tel. 0804671833 o 4607218
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN FARMACIA<br />
BIOLOGIA ANIMALE E BIOLOGIA VEGETALE<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Farmacia)<br />
Attività formativa: A (<strong>di</strong> base);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare BIO/13; cre<strong>di</strong>ti formativi: 10<br />
I Anno, I Semestre<br />
prof. Italo Stipani<br />
Finalità del Corso<br />
La Biologia animale e vegetale ha lo scopo <strong>di</strong> fornire agli studenti le conoscenze <strong>di</strong> base che regolano la<br />
materia vivente e gli organismi viventi (animali e vegetali) e rappresenta un utile substrato per le altre<br />
materie biologiche del loro Corso <strong>di</strong> laurea.<br />
Contenuto del Corso<br />
Introduzione alla Biologia come scienza sperimentale. Caratteristiche <strong>degli</strong> organismi viventi.<br />
Classificazione regni. Teoria cellulare. Procarioti ed eucarioti. Virus e batteri. Evoluzione della specie. La<br />
selezione naturale e l’adattamento. Ere<strong>di</strong>tarietà Lamarckiana e Darwiniana. Meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o delle cellule.<br />
Microscopia ottica e microscopia elettronica. Le membrane biologiche. Trasporto attraverso le membrane.<br />
Proteine strutturali e proteine <strong>di</strong> adesione. Il citoscheletro. Fibra muscolare. Sarcomero. Actina e miosina.<br />
Meccanismo molecolare della contrazione. Reticolo endoplasmatico liscio e rugoso. Involucro nucleare.<br />
Complesso del poro nucleare. Apparato del Golgi. Gli organelli cellulari. Il genoma <strong>degli</strong> organelli. Il<br />
Nucleo. Cromatina. Organizzazione della cromatina. I singoli filamenti <strong>di</strong> DNA: i geni. Istoni e proteine nonistoniche.<br />
Formazione dei nucleosomi. Cromosomi. Ciclo cellulare. Mitosi. Ribosomi. Il nucleolo. Co<strong>di</strong>ce<br />
genetico, codon e anticodon. Cenni sulla sintesi proteica. La riproduzione: asessuata e sessuata. I benefici del<br />
sesso: cellule somatiche e germinali. Meiosi: descrizione generale, Differenze fra meiosi e mitosi. La<br />
ricombinazione del patrimonio genetico. Crossing/over. Gametogenesi: cellula uovo e spermatozoo. La<br />
fecondazione. Processo acrosomiale. La cellula vegetale. I plasti<strong>di</strong>. I vacuoli e il turgore cellulare. La parete<br />
cellulare: funzione e formazione. Organizzazione della pianta: fusto, ra<strong>di</strong>ce e foglia. I principali tessuti della<br />
pianta. Tessuto epidermico. Tessuto vascolare. Xilema e Floema. Tessuto fondamentale. Cenni <strong>di</strong> anatomia<br />
della pianta. Angiosperme e gimnosperme. Il fiore. Il frutto. Il seme. Riproduzione nelle angiosperme.<br />
Cloroplasti. Differenze con i mitocondri. Principali componenti: la clorofilla e i fotosistemi. Le reazioni alla<br />
luce: la fotosintesi e la formazione <strong>di</strong> ossigeno. Schema Z. Le reazioni al buio e la fissazione dell’anidride<br />
carbonica. Sintetica descrizione del Ciclo <strong>di</strong> Calvin-Benson. Cenni <strong>di</strong> Genetica. Fenotipo/genotipo.<br />
Dominante/recessivo. Le leggi <strong>di</strong> Mendel. Genetica umana: determinazione del sesso; ere<strong>di</strong>tà legata al sesso.<br />
Il cariotipo umano normale. Mappe genetiche. Malattie genetiche (sindrome <strong>di</strong> Down). Gruppi sanguigni<br />
dell’uomo. Tassonomia. Nomenclatura linneana. I cinque regni <strong>degli</strong> esseri viventi: principali classificazioni.<br />
Cenni <strong>di</strong> Ecologia. Concetto <strong>di</strong> ecosistema. Habitat. Nicchia ecologica. Fattori ambientali. Ambienti<br />
biologici. Comportamento. Catena alimentare. Pirami<strong>di</strong> ecologiche.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso è articolato in lezioni in aula per almeno 5 ore settimanali per un totale <strong>di</strong> 60/65 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica<br />
frontale con l’ausilio <strong>di</strong> supporti informatici.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in una prova orale.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento e materiale <strong>di</strong>dattico:<br />
SOLOMON ET ALII, Biologia, (voll. I e II), E<strong>di</strong>SES.<br />
PURVES ET ALII, Biologia, Zanichelli.<br />
S.L. WOLFE, Biologia molecolare e cellulare, E<strong>di</strong>SES.<br />
P.H. RAVEN, G.B. JOHNSON, Biologia, (voll. I e II), E<strong>di</strong>SES.<br />
Tutto il materiale <strong>di</strong>dattico delle lezioni è riportato su supporto elettronico ed è messo a <strong>di</strong>sposizione <strong>degli</strong><br />
studenti per la consultazione nei computer dell’aula <strong>di</strong>dattica.<br />
Orari <strong>di</strong> ricevimento: mar., mer., ore 9-10; gio., ore 17-19.
CHIMICA GENERALE ED INORGANICA<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Farmacia)<br />
Attività formativa: A (<strong>di</strong> base);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare CHIM/03; cre<strong>di</strong>ti formativi: 11<br />
I Anno, I Semestre<br />
proff. Carlo Fragale e Concetta Pacifico<br />
Finalità del Corso<br />
Il Corso intende potenziare negli studenti le capacità <strong>di</strong> analisi della fenomenologia quoti<strong>di</strong>ana e formare la<br />
piattaforma culturale necessaria alla comprensione delle <strong>di</strong>scipline successive.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
Elementi <strong>di</strong> matematica usuale. Funzioni e grafici. La Teoria Atomica: Dalle leggi ponderali al principio <strong>di</strong><br />
Avogadro. Atomo e particelle subatomiche. Isotopi. Massa atomica. La mole. Nomenclatura. Formule<br />
chimiche. Numero <strong>di</strong> ossidazione. Equazioni chimiche e bilanciamento. Reagente limitante. Struttura<br />
dell’atomo: Natura della luce e spettri. Modelli atomici. Numeri quantici. Orbitali. Aufbau e sistema<br />
perio<strong>di</strong>co. Il legame chimico: Legame metallico, ionico, covalente, covalente polare. Elettronegatività.<br />
Formule <strong>di</strong> Lewis. Geometria molecolare. Teoria dell’orbitale molecolare. Forze secondarie <strong>di</strong> legame.<br />
Legame a idrogeno. I gas: comportamento ideale ed equazione <strong>di</strong> stato. Modello cinetico. Comportamento<br />
dei gas reali e liquefazione. Soli<strong>di</strong> cristallini ed amorfi. Struttura e proprietà. Allotropia. Stati <strong>di</strong><br />
aggregazione. Fasi. Sistemi omogenei ed eterogenei. Cambiamenti <strong>di</strong> stato. Diagrammi <strong>di</strong> fase. Le soluzioni:<br />
Unità <strong>di</strong> concentrazione. Elettroliti e non elettroliti. Legge <strong>di</strong> Raoult e proprietà colligative. Osmosi.<br />
Distillazione. Le reazioni chimiche (tipologia e riscontri): Reazioni acido-base (Arrhenius, Bronsted, Lewis),<br />
redox, <strong>di</strong> precipitazione. Titolazioni. Trasformazioni ed energia. Calorimetria. Legge <strong>di</strong> Hess. Spontaneità <strong>di</strong><br />
una trasformazione ed equilibrio. L’equilibrio chimico: Legge <strong>di</strong> azione <strong>di</strong> massa. Costante <strong>di</strong> equilibrio.<br />
L’equilibrio mobile. Equilibri eterogenei. Solubilità. Ripartizione. La legge <strong>di</strong> Henry. Equilibri in soluzione:<br />
Gli equilibri acido-base: Auto-ionizzazione dell’acqua. Il pH. Soluzioni <strong>di</strong> aci<strong>di</strong> e basi forti. Aci<strong>di</strong> e basi<br />
deboli. Grado <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssociazione e pH. Idrolisi. Soluzioni tampone. In<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> pH. Aci<strong>di</strong> poliprotici. Anfoliti.<br />
Titolazioni acido-base. Elettrochimica: Celle galvaniche e celle elettrolitiche. L’equazione <strong>di</strong> Nernst. Pile<br />
commerciali. Le leggi <strong>di</strong> Faraday. Corrosione. Elementi <strong>di</strong> chimica inorganica: Il comportamento <strong>degli</strong><br />
elementi e la Tavola Perio<strong>di</strong>ca. Processo soda-cloro, ammoniaca, acido solforico, alluminio, soda Solvay.<br />
L’atmosfera. Le acque. Il carsismo come fenomeno territoriale pugliese. Cenni <strong>di</strong> cinetica chimica:<br />
Meccanismi <strong>di</strong> reazione e catalisi. Ra<strong>di</strong>oattività. Reazioni nucleari. Datazione con 14 C.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso, articolato in lezioni ed esercitazioni in aula, per almeno sette ore settimanali con un totale <strong>di</strong> circa<br />
ottanta ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica frontale.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in una prima prova scritta contenente problemi numerici e quesiti a carattere descrittivo. La<br />
successiva prova orale, alla quale si accede dopo il superamento della prova scritta, verte essenzialmente<br />
sugli argomenti trattati nella prima prova.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento e materiale <strong>di</strong>dattico:<br />
G. BANDOLI, A. DOLMELLA, G. NATILE, Chimica <strong>di</strong> base, E<strong>di</strong>SES.<br />
SACCO ET ALII, Chimica Generale ed Inorganica, Ambrosiana.<br />
NOBILE ET ALII, La chimica <strong>di</strong> base attraverso gli esercizi, Ambrosiana.<br />
Appunti Power Point nei computer dell’aula <strong>di</strong>dattica.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: lun., mar., gio., ore 11,30-13.
FISICA CON ELEMENTI DI MATEMATICA<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Farmacia)<br />
Attività formativa: A (<strong>di</strong> base);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare FIS/01; cre<strong>di</strong>ti formativi: 10<br />
I Anno, I Semestre<br />
prof. Roberto Bellotti<br />
Finalità del Corso<br />
Il Corso è svolto tenendo presente che esso fa parte del primo gruppo <strong>di</strong> materie affrontate da studenti neo<br />
maturati o <strong>di</strong>plomati. Gli obiettivi del Corso possono essere così sintetizzati:<br />
- applicazione dello strumento matematico per la comprensione e modellizzazione <strong>di</strong> fenomeni naturali, in<br />
particolare fisici;<br />
- comprensione delle leggi fisiche elementari (meccanica, termo<strong>di</strong>namica ed elettromagnetismo classico)<br />
attraverso un approccio fenomenologico;<br />
- comprensione “operativa” delle leggi fisiche attraverso lo sviluppo della attitu<strong>di</strong>ne al “problem solving”.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
Grandezze fisiche e unità <strong>di</strong> misura. Cinematica uni<strong>di</strong>mensionale. Calcolo vettoriale. Cinematica nello<br />
spazio. Leggi della <strong>di</strong>namica. Dinamica dei sistemi <strong>di</strong> punti materiali. Lavoro ed energia. Meccanica dei<br />
flui<strong>di</strong>. Termo<strong>di</strong>namica. Elettromagnetismo.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso, articolato in lezioni ed esercitazioni in aula, per almeno 5 ore settimanali con un totale <strong>di</strong> circa 60<br />
ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica frontale.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in una prima prova scritta nella quale si dovranno risolvere cinque problemi numerici,<br />
relativi al programma svolto.<br />
La successiva prova orale, alla quale si accede dopo il superamento della prova scritta, verte essenzialmente<br />
sugli argomenti trattati durante il Corso.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento e materiale <strong>di</strong>dattico:<br />
HALLIDAY, RESNICK, WALKER, Fondamenti <strong>di</strong> Fisica, Ambrosiana.<br />
GIANCOLI, Fisica, Ambrosiana.<br />
RAGOZZINO, GIORDANO, MILANO, Fondamenti <strong>di</strong> Fisica, E<strong>di</strong>SES.<br />
CAPITELLI, CELIBERTO, LONGO, Termo<strong>di</strong>namica e Cinetica Chimica, Adriatica.<br />
Le prove scritte d’esame sono inserite nei computer dell’aula <strong>di</strong>dattica e <strong>di</strong>sponibile, in <strong>formato</strong> “.doc” sul<br />
sito web www.robertobellotti.com, nella sezione de<strong>di</strong>cata agli studenti della Facoltà <strong>di</strong> Farmacia.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: mar., ore 10,30-12,30; gio., ore 10,30-12,30.
ANATOMIA UMANA<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Farmacia)<br />
Attività formativa: A (<strong>di</strong> base);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare BIO/16; cre<strong>di</strong>ti formativi: 10<br />
I Anno, II Semestre<br />
Svolto nel precedente a.a. da:<br />
prof. Lorenzo Bosco<br />
Finalità del Corso<br />
Il Corso è finalizzato allo stu<strong>di</strong>o dell’Anatomia dei sistemi e <strong>degli</strong> organi.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
La terminologia anatomica. I piani anatomici. Generalità sugli organi e sugli apparati.<br />
Apparato emolinfopoietico<br />
Il midollo osseo e le sue se<strong>di</strong>. Il sangue. I principali collettori linfatici. Il timo. La milza. I linfono<strong>di</strong>.<br />
Apparato car<strong>di</strong>ocircolatorio<br />
Il me<strong>di</strong>astino ed il suo contenuto. Il cuore ed il pericar<strong>di</strong>o. La grande e la piccola circolazione. Le arterie e le<br />
vene della circolazione polmonare. La vascolarizzazione e l’innervazione del cuore. L’aorta e le sue<br />
collaterali (generalità). Le vene cave ed i loro affluenti (generalità).<br />
Apparato respiratorio<br />
Il naso. Il faringe. Il laringe. La trachea. I bronchi. I polmoni. Le pleure.<br />
Apparato <strong>di</strong>gerente<br />
La cavità buccale e le ghiandole salivari. L’istmo delle fauci e l’orofaringe. L’esofago. Lo stomaco.<br />
L’intestino tenue. L’intestino crasso. Il pancreas. Il fegato.<br />
Apparato urinario<br />
Il rene. La pelvi renale e gli ureteri. La vescica. L’uretra.<br />
Apparato genitale maschile<br />
Il pene. Lo scroto. I testicoli. Le vie spermatiche. Le vescichette seminali.<br />
Il sistema nervoso<br />
Generalità sul sistema nervoso. Le meningi. Il midollo spinale. Il tronco encefalico (bulbo, ponte,<br />
mesencefalo). Il cervelletto. Il cervello (generalità). Il telencefalo. Il <strong>di</strong>encefalo. Il cervello nel controllo del<br />
comportamento. I nervi cranici. Le vie motrici. Le vie sensitive. L’occhio (generalità). L’orecchio<br />
(generalità). Il sistema nervoso centrale: plesso cervicale, plesso brachiale, plesso lombare, plesso sacrale. Il<br />
sistema nervoso autonomo: ortosimpatico, parasimpatico.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso, prevede 5 ore settimanali con un totale <strong>di</strong> almeno 60 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica frontale.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in una prova scritta nella quale si dovrà rispondere in maniera concisa a quesiti <strong>di</strong> carattere<br />
generale e in una successiva prova orale che riguarderà sia gli argomenti trattati nella prova scritta, sia gli<br />
altri argomenti del programma.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento e materiale <strong>di</strong>dattico:<br />
J.B. WALTER, Patologia generale e fisiopatologia, Napoli, E<strong>di</strong>SES.<br />
A. STEVENS, J. LOWE, Patologia, Milano, Ambrosiana.<br />
JUNQUEIRA, CARNEIRO, KELLY, Compen<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Istologia, Piccin, 1991.<br />
BARR, Anatomia del sistema nervoso, McGraw-Hill, 1992.<br />
BUCCIANTE, Anatomia umana, Piccin, 1986.<br />
NETTER, Atlante <strong>di</strong> Anatomia umana, Masson, 2001.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: sab., ore 12-13.
CHIMICA ANALITICA CON ESERCITAZIONI NUMERICHE E DI LABORATORIO (Corso A-H)<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Farmacia)<br />
Attività formativa: C (affini o integrativi);<br />
settori <strong>di</strong>sciplinari CHIM/01 e CHIM/08; cre<strong>di</strong>ti formativi: 10<br />
I Anno, II Semestre<br />
prof. Antonia Reho<br />
Finalità del Corso<br />
Obiettivo del Corso è quello <strong>di</strong> fornire una conoscenza <strong>di</strong> base della Chimica analitica.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
1) Concentrazione <strong>di</strong> una soluzione. Molarità. Molalità. Normalità. Parti per milione. Concentrazione<br />
percentuale.<br />
2) Equilibrio chimico. Fattori che influenzano la costante <strong>di</strong> equilibrio.<br />
3) Equilibri acido-base. Forza <strong>degli</strong> aci<strong>di</strong> e delle basi. Soluzione <strong>di</strong> aci<strong>di</strong> e basi forti.<br />
4) Aci<strong>di</strong> monobasici e basi monoacide. Soluzioni contenenti un acido debole. Soluzioni contenenti una base<br />
debole. Soluzioni tampone.<br />
5) Aci<strong>di</strong> polibasici e basi poliacide. Soluzioni contenenti un acido poliprotico. Composizione <strong>di</strong> una<br />
soluzione contenente un acido poliprotico in funzione del pH. Soluzioni contenenti una base poliacide.<br />
Soluzioni <strong>di</strong> anfoliti. Soluzioni contenenti una coppia coniugata acido-base.<br />
6) Miscele acido-base. Miscele <strong>di</strong> aci<strong>di</strong>. Miscele <strong>di</strong> basi. Miscele <strong>di</strong> aci<strong>di</strong> e <strong>di</strong> basi.<br />
7) Equilibri <strong>di</strong> precipitazione. Fattori che influenzano la solubilità <strong>degli</strong> elettroliti. Solubilità e prodotti <strong>di</strong><br />
solubilità. Effetto dello ione comune. Precipitazione selettiva.<br />
8) Equilibri <strong>di</strong> complessamento. Effetto del pH sugli equilibri <strong>di</strong> complessamento.<br />
9) Effetto <strong>di</strong> equilibri competitivi sulla solubilità dei precipitati. Effetto del pH sulla solubilità. Effetto del<br />
complessamento sulla solubilità.<br />
10) Equilibri <strong>di</strong> ripartizione. Effetto del pH sull’estrazione <strong>di</strong> aci<strong>di</strong> deboli e basi deboli. Coefficiente <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>stribuzione e curva <strong>di</strong> estrazione. Estrazione <strong>di</strong> chelati.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso prevede lezioni per 6 ore settimanali <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica frontale.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
Due prove esonerative o in alternativa una prova scritta finale danno l’accesso all’esame orale.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento:<br />
FREISER, FERNANDO, Gli equilibri ionici nella chimica analitica, Piccin.<br />
HARRIS, Chimica analitica quantitativa, Zanichelli.<br />
SKOOG, WEST, HOLLER, Fondamenti <strong>di</strong> chimica analitica, Piccin.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: mer. e gio., ore 9,30-11,30.
CHIMICA ANALITICA CON ESERCITAZIONI NUMERICHE E DI LABORATORIO (I-Z)<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Farmacia)<br />
Attività formativa: C (affini o integrativi);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare: CHIM/01 CHIM/08; cre<strong>di</strong>ti formativi: 10<br />
I Anno, II Semestre<br />
proff. Adriana Ottolino e Clau<strong>di</strong>o Vetuschi<br />
Finalità del Corso<br />
Il Corso è finalizzato a fornire allo studente le in<strong>di</strong>spensabili conoscenze <strong>di</strong> base <strong>degli</strong> equilibri chimici in<br />
soluzione. È trattato lo stu<strong>di</strong>o delle composizioni <strong>di</strong> miscele acquose nelle quali esistano equilibri <strong>di</strong><br />
solubilità, equilibri implicanti mo<strong>di</strong>ficazione <strong>di</strong> pH e reazioni <strong>di</strong> ossido-riduzione. Questi ultimi sono stu<strong>di</strong>ati<br />
nelle celle galvaniche ed elettrolitiche.<br />
Contenuto del Corso<br />
Tipi <strong>di</strong> formule e unità <strong>di</strong> concentrazione. L’equilibrio chimico. Soluzioni acquose <strong>di</strong> elettroliti.<br />
Dissociazione e forza <strong>di</strong> aci<strong>di</strong> e basi. Aci<strong>di</strong> e basi coniugati. Effetto livellante del mezzo.<br />
Reazioni <strong>di</strong> precipitazione. Solubilità, prodotto <strong>di</strong> solubilità ed effetto dello ione comune. Precipitazione<br />
frazionata e separazioni quantitative. Separazioni <strong>di</strong> solfuri con H2S gas a pH controllato. Quadro generale.<br />
Separazione <strong>di</strong> Pb ++ e Hg ++ con I - , <strong>di</strong> Ba ++ e Ca ++ con SO4 -- , <strong>di</strong> Mg ++ e Fe +++ con OH -. Dissoluzioni del<br />
precipitato per formazione <strong>di</strong> complessi. Curve <strong>di</strong> titolazione <strong>di</strong> precipitazione: effetto della concentrazione<br />
dei reagenti e della solubilità del prodotto. Titolazioni argentimetriche. Calcoli <strong>di</strong> pAg e pCl. Attività ionica.<br />
Forza ionica, Debye-Hückel, e coefficienti <strong>di</strong> attività. Effetto della forza ionica sulla solubilità dei sali.<br />
Effetto sale.<br />
Equilibri acido-base. Aci<strong>di</strong> e basi forti e deboli, mono e poliprotici. Calcoli e regole <strong>di</strong> approssimazione.<br />
Aci<strong>di</strong> solfidrico e carbonico. Idrolisi, costante e grado <strong>di</strong> idrolisi. Tamponi, proprietà. Teoria <strong>degli</strong> in<strong>di</strong>catori<br />
acido-base. Titolazione <strong>di</strong> acido forte e <strong>di</strong> acido debole con basi forti. Curve <strong>di</strong> titolazione. Dipendenza<br />
dell’andamento della curva dalle concentrazioni dei reagenti.<br />
Ossido-riduzioni. Principali reazioni redox e regole <strong>di</strong> bilanciamento. Celle galvaniche ed elettrolitiche.<br />
Potenziali standard. Spontaneità <strong>di</strong> una reazione. Equazione <strong>di</strong> Nernst. Potenziali elettro<strong>di</strong>ci, anodo e catodo,<br />
convenzioni dei segni. Semielementi in cui uno ione redox fa parte <strong>di</strong> un equilibrio <strong>di</strong>verso. Determinazioni<br />
galvanometriche <strong>di</strong> Kps, <strong>di</strong> costanti <strong>di</strong> equilibrio <strong>di</strong> reazioni redox, <strong>di</strong> costanti <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssociazioni. Schema <strong>di</strong><br />
pHmetro. Elettro<strong>di</strong> <strong>di</strong> riferimento: Standard ad Idrogeno, a vetro, meccanismo della permeabilità della<br />
membrana, a calomelano, <strong>di</strong> Ag/AgCl, a Chinidrone. Elettro<strong>di</strong> ionoselettivi, a membrana e con enzima<br />
immobilizzato (per determinazione <strong>di</strong> glucosio, urea, proteine, O2, CO2, NH3, CO). Meto<strong>di</strong> elettroanalitici.<br />
Titolazioni potenziometriche. Schema <strong>di</strong> misurazione potenziometrica.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso è organizzato, per lezioni <strong>di</strong> almeno 5 ore settimanali con un totale <strong>di</strong> circa 60 lezioni. Durante il<br />
Corso possono essere svolte prove scritte esonerative dell’esame, o integrabili dal solo colloquio.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in una prova scritta nella quale sarà richiesta la soluzione <strong>di</strong> problemi assolutamente<br />
analoghi a quelli trattati a lezione. Si richiedono risposte precise e scritte in maniera leggibile. La prova orale<br />
per coloro che hanno mostrato un livello accettabile <strong>di</strong> preparazione, consente l’approfon<strong>di</strong>mento <strong>degli</strong><br />
argomenti della prova scritta e comunque <strong>degli</strong> argomenti sviluppati nel Corso.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento:<br />
SKOOG WEST, Chimica analitica, 2. ed., E<strong>di</strong>SES.<br />
G.D. CHRISTIAN, Chimica analitica, Piccin, 1986.<br />
F. FRIESER, Gli equilibri ionici nella Chimica analitica, Piccin.<br />
D.G. HARRIS, Chimica analitica quantitativa, Zanichelli.
CHIMICA ORGANICA (Corso A-H)<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Farmacia)<br />
Attività formativa: C (affini o integrativi);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare: CHIM/06; cre<strong>di</strong>ti formativi: 11<br />
II Anno, I Semestre<br />
Svolto nel precedente a.a. da:<br />
proff. Leonardo Di Nunno e Saverio Florio<br />
Finalità del Corso<br />
Lo scopo del presente Corso è mettere in luce i principi fondamentali della Chimica organica, i suoi aspetti<br />
applicativi e le connessioni che essa ha con la vita <strong>di</strong> tutti i giorni e con i processi biologici.<br />
Contenuti del Corso per argomenti<br />
Alcani e Cicloalcani: struttura, nomenclatura, isomeria, conformazioni e reazioni. Alcheni e Alchini:<br />
struttura, nomenclatura, isomeria e reazioni <strong>di</strong> ad<strong>di</strong>zione elettrofila. Terpeni: struttura e presenza in natura.<br />
Chiralità e stereoisomeria: sistemi D,L e R,S; risoluzione ottica <strong>di</strong> enantiomeri. Alogenuri alchilici:<br />
nomenclatura. Sostituzione nucleofila alifatica: meccanismi SN1, SN2, SNi; β-eliminazioni: meccanismi E1,<br />
E2, E1CB. Aci<strong>di</strong>tà e basicità. Alcooli, Eteri, Epossi<strong>di</strong> e Tioli: nomenclatura e reattività. Benzene e suoi<br />
derivati: nomenclatura, aromaticità e reazioni <strong>di</strong> sostituzioni elettrofila aromatica. Fenoli: struttura,<br />
nomenclatura, aci<strong>di</strong>tà. Sistemi Eterocicli pentatomici, esatomici e sistemi condensati corrispondenti:<br />
nomenclatura e reattività. Ammine: nomenclatura e basicità. Immine e Enammine. Aldei<strong>di</strong> e Chetoni:<br />
nomenclatura, ad<strong>di</strong>zioni nucleofile. Tautomeria cheto-enolica. Aci<strong>di</strong> carbossilici e loro derivati funzionali:<br />
nomenclatura; reazione <strong>di</strong> esterificazione e interconversione <strong>di</strong> gruppi funzionali. Anioni enolato: reazione<br />
aldolica e condensazione <strong>di</strong> Claisen. Carboidrati: struttura, nomenclatura, stereochimica e reattività dei<br />
principali monosaccari<strong>di</strong>; mutarotazione; formazione <strong>di</strong> glicosi<strong>di</strong>; <strong>di</strong>saccari<strong>di</strong> e polisaccari<strong>di</strong>. Lipi<strong>di</strong>:<br />
trigliceri<strong>di</strong>; saponi e detergenti; prostaglan<strong>di</strong>ne; steroi<strong>di</strong>; fosfolipi<strong>di</strong>. Amminoaci<strong>di</strong>: struttura, chiralità e punto<br />
isoelettrico. Polipepti<strong>di</strong> e proteine. Nucleosi<strong>di</strong>, nucleoti<strong>di</strong> e aci<strong>di</strong> nucleici: generalità.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso è articolato in lezioni ed esercitazioni in aula per 6 ore settimanali per un totale <strong>di</strong> almeno 60 ore <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>dattica frontale.<br />
Esame finale<br />
L’esame consiste in un colloquio orale in cui lo studente è invitato a <strong>di</strong>mostrare <strong>di</strong> essere in possesso delle<br />
conoscenze teoriche <strong>di</strong> base della Chimica organica. Si chiede inoltre <strong>di</strong> risolvere alcuni semplici esercizi<br />
relativi alla reattività e alle trasformazioni dei più comuni gruppi funzionali.<br />
Testi consigliati:<br />
W.H. BROWN, Chimica organica, Napoli, E<strong>di</strong>SES.<br />
W.H. BROWN, B.L. IVERSON, S.A. IVERSON, Guida alla soluzione dei problemi <strong>di</strong> Chimica organica,<br />
Napoli, E<strong>di</strong>SES, 1997.<br />
M.A. FOX, J.K. WHITESELL, Chimica Organica, Bologna, Zanichelli, 1997.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: prof. Di Nunno lun., mer., ore 15,30-17,30; mar., ore 9,30-10,30; prof. Florio lun.,<br />
11,30-13,30; mar., mer., 11-13.
CHIMICA ORGANICA (Corso I-Z)<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Farmacia)<br />
Attività formativa: C (affini o integrativi);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare: CHIM/06; cre<strong>di</strong>ti formativi: 11<br />
II Anno, I Semestre<br />
prof. Vito Capriati<br />
www.farmchim.uniba.it/chimica_organica/C.V.Capriati.html<br />
Finalità del Corso<br />
Lo scopo del presente Corso annuale è mettere in luce i principi fondamentali della Chimica organica, i suoi<br />
aspetti applicativi e le connessioni che questa ha con la vita <strong>di</strong> tutti i giorni e con i processi biologici.<br />
Contenuti del Corso per argomenti<br />
Alcani e Cicloalcani: struttura, nomenclatura, isomeria, conformazioni e reazioni. Alcheni e Alchini:<br />
struttura, nomenclatura e reazioni <strong>di</strong> ad<strong>di</strong>zione elettrofila. Terpeni: struttura e presenza in natura. Chiralità e<br />
Stereoisomeria: sistemi D,L e R,S; risoluzione ottica <strong>di</strong> enantiomeri. Alogenuri alchilici: nomenclatura;<br />
sostituzione nucleofila alifatica: meccanismi SN1 e SN2; β-eliminazioni: meccanismi E1 e E2. Aci<strong>di</strong>tà e<br />
basicità. Alcooli, Eteri, Epossi<strong>di</strong> e Tioli: nomenclatura e reattività. Benzene e suoi derivati: nomenclatura,<br />
aromaticità e reazioni <strong>di</strong> sostituzioni elettrofila aromatica. Fenoli: struttura, nomenclatura, aci<strong>di</strong>tà. Sistemi<br />
Eterocicli pentatomici, esatomici e sistemi condensati corrispondenti: nomenclatura e reattività. Ammine:<br />
nomenclatura e basicità; immine e enammine. Aldei<strong>di</strong> e Chetoni: nomenclatura; ad<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> nucleofili con<br />
centro reattivo sul carbonio, sull’ossigeno, sull’azoto. Tautomeria cheto-enolica. Aci<strong>di</strong> carbossilici e loro<br />
derivati funzionali: nomenclatura; reazione <strong>di</strong> esterificazione e interconversione <strong>di</strong> gruppi funzionali. Anioni<br />
enolato: reazione aldolica e condensazione <strong>di</strong> Claisen. Carboidrati: struttura, nomenclatura, stereochimica e<br />
reattività dei principali monosaccari<strong>di</strong>; mutarotazione; formazione <strong>di</strong> glicosi<strong>di</strong>; <strong>di</strong>saccari<strong>di</strong> e polisaccari<strong>di</strong>.<br />
Lipi<strong>di</strong>: trigliceri<strong>di</strong>; saponi e detergenti; prostaglan<strong>di</strong>ne; steroi<strong>di</strong>; fosfolipi<strong>di</strong>. Amminoaci<strong>di</strong>: struttura, chiralità<br />
e punto isoelettrico. Polipepti<strong>di</strong> e proteine. Nucleosi<strong>di</strong>, nucleoti<strong>di</strong> e aci<strong>di</strong> nucleici: generalità.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso è articolato in lezioni ed esercitazioni in aula per 6 ore settimanali per un totale <strong>di</strong> almeno 60 ore <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>dattica frontale.<br />
Esame finale<br />
L’esame consiste in un colloquio orale <strong>di</strong> circa 30 min. in cui lo studente è invitato a <strong>di</strong>mostrare <strong>di</strong> essere in<br />
possesso delle conoscenze teoriche <strong>di</strong> base della chimica organica. Si chiede, inoltre, <strong>di</strong> risolvere alcuni<br />
semplici esercizi relativi alla reattività e alle trasformazioni dei più comuni gruppi funzionali.<br />
Siti web <strong>di</strong> utile consultazione:<br />
www.cem.msu.edu/~parrill/ (materiale educativo per la chimica organica);<br />
www.chempensoftware.com/organicreactions.htm (reazioni organiche classiche);<br />
www.chem.qmul.ac.uk/iupac/ (nomenclatura IUPAC); www.organicworldwide.net/tutorial.html (tutorial in<br />
chimica organica).<br />
Testi consigliati:<br />
W.H. BROWN, Introduzione alla Chimica organica, Napoli, E<strong>di</strong>SES, 2001.<br />
W.H. BROWN, C.S. FOOTE, Chimica organica, Napoli, E<strong>di</strong>SES, 1999.<br />
W.H. BROWN, B.L. IVERSON, S.A. IVERSON, Guida alla soluzione dei problemi <strong>di</strong> Chimica organica,<br />
Napoli, E<strong>di</strong>SES, 1997.<br />
H. HART, L.E. CRAINE, D.J. HART, Chimica organica, Bologna, Zanichelli, 2003.<br />
R. MACOMBER, Chimica organica, Bologna, Zanichelli, 2001.<br />
M.A. Fox, J.K. WHITESELL, Chimica organica, Bologna, Zanichelli, 1997.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: lun., mar., mer., ore 14,30-16,30.
MICROBIOLOGIA ED IGIENE<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Farmacia)<br />
Attività formativa: C (affini o integrativi);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare: MED/42 e MED/07; cre<strong>di</strong>ti formativi: 11<br />
II Anno, I Semestre<br />
prof. Danila De Vito<br />
Finalità del Corso<br />
Il Corso si propone <strong>di</strong> fornire allo studente conoscenze e competenze relative alla prevenzione delle malattie<br />
e alla promozione della salute, all’organizzazione sanitaria. Esso intende perciò avviare lo studente alla<br />
conoscenza dei determinanti <strong>di</strong> malattia e dei sistemi <strong>di</strong> sorveglianza sanitaria; alla comprensione dei<br />
meccanismi <strong>di</strong> insorgenza e <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffusione delle malattie e del loro impatto sulle comunità; all’appren<strong>di</strong>mento<br />
dei principi e delle strategie della me<strong>di</strong>cina preventiva e della promozione della salute.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
Generalità sui microrganismi. Principi <strong>di</strong> immunologia. Allergia ed ipersensibilità. Classificazione dei<br />
batteri. Gram-negativi. Gram-negativi anaerobi. Gram-positivi. Miceti. Flora batterica normale nell’uomo.<br />
Virus: proprietà generali. Classificazione dei virus. Batteriofagi. Protozoi patogeni per l’uomo. Storia,<br />
significato e scopi dell’Igiene. Organizzazione Sanitaria Nazionale. I servizi sanitari: l’Ospedale. Me<strong>di</strong>cina<br />
preventiva ed educazione sanitaria. Epidemiologia descrittiva. Epidemiologia analitica. Epidemiologia<br />
sperimentale. Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive. I fenomeni immunitari. Notifica;<br />
contumacia; accertamenti <strong>di</strong> laboratorio; chemio-antibiotico profilassi. Vaccinazioni obbligatorie e<br />
facoltative e loro calendario; preparazioni vaccinali. La sieroprofilassi: sieri eterologhi, omologhi,<br />
iperimmuni, specifici e gammaglobuline.<br />
Disinfezione. Influenza, epatiti da virus, morbillo, tubercolosi, tifo addominale, brucellosi, colera,<br />
toxoplasmosi. Igiene dell’ambiente fisico: meccanismi <strong>di</strong> termoregolazione, parametri fisici del microclima e<br />
loro rilevamento. Lo smaltimento dei liquami domestici. Lo smaltimento dei rifiuti soli<strong>di</strong>. Igiene <strong>degli</strong><br />
alimenti: tossinfezioni alimentari: da Stafilococco, Salmonelle, Bacillo botulino. Latte come veicolo <strong>di</strong><br />
malattie. La bonifica del latte. L’acqua potabile: fonti <strong>di</strong> approvvigionamento idrico, criteri <strong>di</strong> potabilità,<br />
potabilizzazione delle acque.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso articolato in lezioni frontali in aula per 5 ore settimanali con un totale <strong>di</strong> 60 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica frontale.<br />
Il Corso è sud<strong>di</strong>viso in moduli monotematici.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in una prova orale sugli argomenti relativi al programma in allegato.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento e materiale <strong>di</strong>dattico:<br />
POLI, COCUZZA, NICOLETTI, Microbiologia Me<strong>di</strong>ca, UTET, 1993.<br />
BARBUTI, BELELLI, FARA, GIAMMANCO, Igiene e Me<strong>di</strong>cina preventiva, Bologna, Monduzzi, 2003.<br />
CHECCACCI, MELONI, PELISSERO, Igiene, Milano, Ambrosiana, 1992.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: mer., ore 10-11.
BIOCHIMICA<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Farmacia)<br />
Attività formativa: A (<strong>di</strong> base);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare BIO/10; cre<strong>di</strong>ti formativi: 11<br />
II Anno, II Semestre<br />
prof. Fer<strong>di</strong>nando Palmieri<br />
Finalità del Corso<br />
Il Corso <strong>di</strong> Biochimica ha l’obiettivo <strong>di</strong> fornire agli studenti le conoscenze sulla struttura e funzione delle<br />
principali classi <strong>di</strong> molecole biologiche e sulle loro trasformazioni nella <strong>di</strong>namica cellulare, sulla regolazione<br />
dei processi metabolici e sui meccanismi <strong>di</strong> conservazione e trasmissione dell’informazione genica. Oggetto<br />
<strong>di</strong> questo Corso sono anche le principali meto<strong>di</strong>che sperimentali <strong>di</strong> interesse biochimico.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
La cellula ed i suoi compartimenti. Zuccheri. Lipi<strong>di</strong>. Nucleoti<strong>di</strong>. Amminoaci<strong>di</strong>. Legame pepti<strong>di</strong>co e pepti<strong>di</strong>.<br />
Proteine: proprietà e funzioni. Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine.<br />
Denaturazione e rinaturazione delle proteine. Purificazione e criteri <strong>di</strong> purezza. Relazioni tra struttura<br />
tri<strong>di</strong>mensionale e attività biologica delle proteine. Mioglobina ed emoglobina. Enzimi: struttura, funzione,<br />
classificazione e specificità. Cofattori. Coenzimi. Cinetica enzimatica. Inibizione enzimatica. Meccanismo<br />
d’azione <strong>degli</strong> enzimi. Isoenzimi e ribozimi. Sistemi multienzimatici ed enzimi allosterici. Regolazione<br />
dell’attività enzimatica. Struttura e funzione delle membrane biologiche. Trasportatori, pompe e canali<br />
ionici. Recettori ormonali e meccanismi <strong>di</strong> trasduzione dei segnali. Principi <strong>di</strong> termo<strong>di</strong>namica e principi <strong>di</strong><br />
bioenergetica. Energia libera. Composti “ad alta energia”. Reazioni eso- ed endoergoniche. Processi<br />
d’accoppiamento. Le vie metaboliche e la loro regolazione. Glicolisi. Catabolismo <strong>di</strong> esosi <strong>di</strong>versi dal<br />
glucosio. Fermentazione alcolica e lattica. Gluconeogenesi. Degradazione e biosintesi del glicogeno. Via dei<br />
pentosi fosfato. Degradazione dei lipi<strong>di</strong> β-ossidazione <strong>degli</strong> aci<strong>di</strong> grassi. Ciclo <strong>di</strong> Krebs. Catena <strong>di</strong> trasporto<br />
<strong>degli</strong> elettroni e fosforilazione ossidativa. Corpi chetonici. Sintesi <strong>degli</strong> aci<strong>di</strong> grassi, dei trigliceri<strong>di</strong> dei<br />
fosfoglicerolipi<strong>di</strong> e <strong>degli</strong> sfingolipi<strong>di</strong>. Biosintesi del colesterolo. Metabolismo <strong>degli</strong> amminoaci<strong>di</strong>.<br />
Metabolismo delle basi puriniche e pirimi<strong>di</strong>niche. Sintesi dell’urea. Metabolismo dell’eme. Ormoni e<br />
meccanismi d’azione. Aci<strong>di</strong> nucleici e informazione genetica. DNA: struttura e proprietà. Geni e cromosomi.<br />
Replicazione del DNA. Struttura e funzione dell’RNA messaggero, dell’RNA ribosomiale e dell’RNA<br />
transfer. Sintesi <strong>di</strong> RNA DNA-<strong>di</strong>pendente. Maturazione dell’RNA. Sintesi <strong>di</strong> DNA RNA-<strong>di</strong>pendente. Co<strong>di</strong>ce<br />
genetico. Ribosomi: struttura e funzione. Attivazione <strong>degli</strong> amminoaci<strong>di</strong>. Biosintesi delle proteine.<br />
Mo<strong>di</strong>ficazioni post-traduzionali delle proteine. Tecniche biochimiche: spettrofotometria, centrifugazione,<br />
cromatografia, tecniche isotopiche, dosaggi enzimatici.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso è articolato in lezioni in aula per almeno 5 ore settimanali, con un totale <strong>di</strong> circa 60 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica<br />
frontale ed esercitazioni in laboratorio.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in una prima prova scritta nella quale si dovrà rispondere a 20 quesiti a risposta multipla<br />
giustificando la risposta scelta e ad una domanda a risposta aperta. La successiva prova orale, alla quale si<br />
accede dopo il superamento della prova scritta, verte essenzialmente sugli argomenti trattati nella prima<br />
prova.<br />
Testo <strong>di</strong> riferimento:<br />
NELSON, COX, I principi <strong>di</strong> Biochimica <strong>di</strong> Lehninger, Zanichelli.<br />
Testi <strong>di</strong> consultazione:<br />
STREYER, Biochimica, Zanichelli.<br />
MATHEWS, VAN HOLDE, Biochimica, Ambrosiana.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: mar., ore 9,30-10,30; ven., ore 8,30-9,30.
FARMACOGNOSIA CON ELEMENTI<br />
DI BOTANICA FARMACEUTICA<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Farmacia)<br />
Attività formativa: B (caratterizzante);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare BIO/15; cre<strong>di</strong>ti formativi: 10<br />
II Anno, II Semestre<br />
prof. Pinarosa Avato<br />
Finalità del Corso<br />
Il Corso è rivolto principalmente allo stu<strong>di</strong>o delle droghe vegetali e <strong>di</strong> farmaci <strong>di</strong> origine naturale da esse<br />
derivati. Particolare rilievo viene dato alle droghe vegetali iscritte nella Farmacopea Nazionale ed in quella<br />
Europea. Vengono trattati l’aspetto botanico della fonte vegetale e le caratteristiche farmacognostiche della<br />
droga.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
1.0 Cellula vegetale.<br />
2.0 Organografia.<br />
3.0 Selezione del materiale vegetale e conservazione delle droghe.<br />
4.0 Preparazione <strong>degli</strong> estratti.<br />
5.0 Classificazione chimica dei principi attivi.<br />
5.0 Monografie <strong>di</strong> piante me<strong>di</strong>cinali e droghe selezionate.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso è articolato in lezioni. Eventuali seminari integrativi potranno essere organizzati durante l’anno. A<br />
richiesta <strong>degli</strong> studenti potranno essere organizzate delle esercitazioni per l’osservazione <strong>di</strong> preparazioni<br />
istologiche da piante me<strong>di</strong>cinali.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in una prova orale.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento e materiale <strong>di</strong>dattico:<br />
Elementi <strong>di</strong> Botanica Farmaceutica:<br />
E. MAUGINI, Botanica Farmaceutica, ult. ed., Piccin.<br />
A. BRUNI, M. NICOLETTI, Biologia vegetale, Japarde, 1993.<br />
Atlante <strong>di</strong> Anatomia vegetale.<br />
Farmacognosia:<br />
TREASE AND EVANS, Farmacognosia, trad. it. <strong>di</strong> Nicoletti M. e Serafini M., Piccin, 1995.<br />
A. BRUNI, Farmacognosia generale ed applicata, Piccin, 1999.<br />
G. FASSINA, E. RAGAZZI, Lezioni <strong>di</strong> Farmacognosia Droghe Vegetali, Padova, Cedam, 1995.<br />
G. FASSINA, P. DORIGO, Lezioni <strong>di</strong> Farmacognosia Droghe Animali ed Enzimi, Padova, Cedam, 1992.<br />
Tutto il materiale <strong>di</strong>dattico usato nelle lezioni sarà riportato su supporto elettronico.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: mar., mer., giov., ore 15-17.
FISIOLOGIA GENERALE<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Farmacia)<br />
Attività formativa: C (affini o integrativi);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare BIO/ 09; cre<strong>di</strong>ti formativi: 11<br />
IΙ Anno, IΙ Semestre<br />
prof. Enrico Gallucci<br />
Finalità del Corso<br />
Il Corso <strong>di</strong> Fisiologia generale viene svolto spiegando le funzioni vitali <strong>degli</strong> animali e dell’uomo. Analizza<br />
come gli organismi viventi mantengano l’omeostasi del mezzo interno a livello molecolare, cellulare e<br />
tissutale al variare dell’ambiente circostante. I meccanismi fondamentali delle funzioni biologiche vengono<br />
affrontati considerando i principi fisico-chimici alla loro base.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
Processi <strong>di</strong> trasporto attraverso le membrane biologiche. Diffusione passiva. Il potenziale <strong>di</strong> flusso.<br />
Diffusione <strong>degli</strong> elettroliti. Trasporto attivo. I neuroni e le cellule gliali. Potenziale <strong>di</strong> membrana e sua<br />
genesi. Potenziale d’azione o impulso nervoso. Conduzione dell’impulso nervoso nelle fibre mieliche e<br />
amieliche. Proprietà generali dei sistemi sensoriali. Recettori: classificazione e proprietà generali. Sistema<br />
nervoso centrale. Cenni anatomici. Funzioni della corteccia motoria e dei gangli della base. Connessioni<br />
afferenti alla corteccia motoria. Vie efferenti: piramidale ed extrapiramidale. Funzioni del sistema limbico.<br />
Funzioni ipotalamiche. Sistema ipotalamo-ipofisi. Sistema nervoso vegetativo. Controllo spinale della<br />
motilità. Riflessi motori spinali: caratteristiche. Tono posturale. Controllo bulbo-pontino della motilità.<br />
Cervelletto: controllo cerebellare dei movimenti. Sistema muscolare. Contrazione del muscolo scheletrico<br />
liscio e car<strong>di</strong>aco. Sistema car<strong>di</strong>ovascolare. Attività elettrica del cuore. Conduzione delle fibre car<strong>di</strong>ache.<br />
Eccitazione naturale del cuore ECG. La pompa car<strong>di</strong>aca. Il ciclo car<strong>di</strong>aco. Gettata car<strong>di</strong>aca e sua regolazione.<br />
Il controllo del cuore. Emo<strong>di</strong>namica. Funzione del sistema renale per funzioni. Sistema gastrointestinale.<br />
Funzione del sistema respiratorio. Sistema endocrino.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso, articolato in lezioni ed esercitazioni in aula, è sud<strong>di</strong>viso in una parte generale <strong>di</strong> base in cui viene<br />
stu<strong>di</strong>ata la biofisica, l’elettrofisiologia, le funzioni dei sistemi <strong>di</strong> trasporto e <strong>di</strong> comunicazioni nelle<br />
membrane biologiche. Una parte speciale riguardante il funzionamento dei vari organi e loro integrazione nel<br />
contesto del funzionamento dell’organismo. Il docente della <strong>di</strong>sciplina, svolge 5 ore settimanali con un totale<br />
<strong>di</strong> circa 60 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica frontale.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in una prima prova scritta in cui agli studenti vengono posti <strong>di</strong>eci quesiti a risposta multipla<br />
(test) e una domanda finale a cui si dovrà dare una risposta esauriente e concisa. La successiva prova orale,<br />
alla quale si accede dopo il superamento della prova scritta, verte essenzialmente sugli argomenti trattati<br />
nella prima prova.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento e materiale <strong>di</strong>dattico:<br />
R.M. BERNE, M.N. LEVY, Fisiologia generale, Ambrosiana.<br />
D.U. SILVERTHORN, Fisiologia, Ambrosiana.<br />
G. MONTICELLI, G. ESPOSITO, Fenomeni <strong>di</strong> trasporto ed elettrici, in membrane biologiche, Milano, Ermes.<br />
Il materiale <strong>di</strong>dattico riguardante alcuni argomenti usato nelle lezioni e nelle esercitazioni sarà riportato su<br />
supporto elettronico e inserito nei computer dell’aula <strong>di</strong>dattica, a <strong>di</strong>sposizione <strong>degli</strong> studenti.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: mer., ore 10,30-11,30; ven., ore 10,30-11,30.
CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA I<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Farmacia)<br />
Attività formativa: B (caratterizzante);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare: CHIM/08; cre<strong>di</strong>ti formativi: 11<br />
III Anno, I Semestre<br />
proff. Carlo Franchini e Vincenzo Tortorella<br />
Finalità del Corso<br />
Il Corso è svolto tenendo in particolare considerazione la possibilità <strong>di</strong> correlare l’attività <strong>di</strong> ciascuna classe<br />
<strong>di</strong> farmaci alle caratteristiche chimiche della molecola. Eventuali aspetti <strong>di</strong> tipo sintetico e/o relativi a<br />
particolari meccanismi d’azione, saranno trattati soltanto nella misura in cui riescono a razionalizzare il<br />
comportamento del principio attivo a livello biologico.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
1.0 Presupposti della ricerca e della produzione <strong>di</strong> farmaci. 2.0 La nomenclatura dei farmaci. 3.0 Meccanismi<br />
molecolari dell’azione dei farmaci: le relazioni attività-struttura. 3.1 Mo<strong>di</strong>ficazioni chimiche che influenzano<br />
le fasi farmacocinetiche. 3.1.1 Ruolo delle caratteristiche chimico-fisiche del principio attivi. 3.1.2 Le<br />
reazioni metaboliche. 3.2 Mo<strong>di</strong>ficazioni chimiche che influenzano le fasi farmaco<strong>di</strong>namiche. 3.2.1<br />
Interazioni tra farmaco e sito attivo. 3.2.2 Forma spaziale della molecola e attività dei farmaci. 4.0 Le curve<br />
dose-risposta ed il meccanismo <strong>di</strong> azione dei farmaci. 5.0 I neurotrasmettitori fisiologici ed il loro ruolo sul<br />
sistema nervoso periferico e su quello centrale. 6.0 Struttura, attività ed effetti collaterali <strong>di</strong> principi attivi su.<br />
6.1 Sistema colinergico. 6.2 Sistema adrenergico. 6.3 Sistema dopaminergico. 6.4 Sistema<br />
serotoninergico.6.5 Sistema istaminergico. 6.6 Sistema oppioide. 7.0 Struttura, attività ed effetti collaterali <strong>di</strong><br />
farmaci attivi su sistemi enzimatici e canali ionici. 7.1 Antinfiammatori non steroidei; 7.2 Antipertensivi; 7.3<br />
Anestetici locali. 8.0 Anestetici generali, ipnotici e sedativi. Classificazione dei principi attivi e delle<br />
specialità me<strong>di</strong>cinali secondo il sistema ATC.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso, articolato in lezioni ed esercitazioni in aula, è sud<strong>di</strong>viso in moduli monotematici svolti e coor<strong>di</strong>nati<br />
dai due docenti della <strong>di</strong>sciplina, per almeno 5 ore settimanali con un totale <strong>di</strong> circa 60 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica<br />
frontale.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in una prima prova scritta nella quale si dovrà rispondere in maniera concisa su cinque<br />
quesiti <strong>di</strong> carattere generale a risposta multipla, giustificando sia la risposta esatta che le motivazioni che<br />
rendono non corrette le altre risposte in<strong>di</strong>cate. Si dovrà, inoltre, rispondere a 15 quesiti a risposta multipla e<br />
relativi al programma svolto. La successiva prova orale, alla quale si accede dopo il superamento della prova<br />
scritta, verte essenzialmente sugli argomenti trattati nella prima prova.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento e materiale <strong>di</strong>dattico:<br />
E. SCHROEDER, C. RUFER, R. SCHMIECHEN, Chimica farmaceutica, (voll. I e II), Napoli, E<strong>di</strong>SES, 1991.<br />
WERMUTH, Le applicazioni della Chimica farmaceutica, Napoli, E<strong>di</strong>SES, 2001.<br />
V. TORTORELLA, La farmacia ed il concorso, Napoli, E<strong>di</strong>SES, 1997.<br />
FOYE, LEMKE, WILLIAMS, Principi <strong>di</strong> Chimica farmaceutica, Piccin, 1998.<br />
Tutto il materiale <strong>di</strong>dattico usato nelle lezioni è inserito nei computer dell’aula <strong>di</strong>dattica, a <strong>di</strong>sposizione <strong>degli</strong><br />
studenti. Sarà fornita anche una copia cartacea del materiale utilizzato durante lezioni ed esercitazioni, che<br />
gli studenti potranno duplicare a loro spese.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: prof. Franchini lun., mar., mer., ore 17-19; prof. Tortorella lun., 10,30-11,30; gio.,<br />
11,30-12,30; ven., 9-10.
FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Farmacia)<br />
Attività formativa: B (caratterizzante);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare BIO/14; cre<strong>di</strong>ti formativi: 11<br />
III Anno, I Semestre<br />
proff. Diana Conte e Annamaria De Luca<br />
Finalità del Corso<br />
Fornire allo studente competenze riguardanti i principi generali dei meccanismi dell’azione dei farmaci,<br />
nonché le classi <strong>di</strong> agenti farmacologici utilizzati a scopi terapeutici.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
Farmacologia generale. Recettori fisiologici e altri bersagli dell’azione dei farmaci; Sistemi <strong>di</strong> trasduzione<br />
del segnale; Concetti <strong>di</strong> desensitizzazione recettoriale. Curve dose-risposta, Affinità, attività intrinseca,<br />
potenza ed efficacia; Agonismo, antagonismo, agonismo parziale ed inverso. Farmacocinetica:<br />
somministrazione; assorbimento, <strong>di</strong>stribuzione, metabolismo ed escrezione dei farmaci; Posologia.<br />
Farmacogenomica. II parte: Farmacologia e Farmacoterapia I. Farmacologia del sistema nervoso autonomo e<br />
periferico: Neurotrasmettitori e recettori. Farmacologia dei sistemi <strong>di</strong> regolazione del tono muscolare (NO,<br />
endoteline, bra<strong>di</strong>chinine, prostaglan<strong>di</strong>ne, canali ionici e recettori) e della trasmissione nervosa periferica<br />
(anticolinesterasici. Curari. Anestetici locali). Farmacologia dei processi infiammatori: La cascata dell’acido<br />
arachidonico e gli eicosanoi<strong>di</strong>. Antiinfiammatori non steroidei e glucocorticoi<strong>di</strong>. Inibitori della<br />
lipoossigenasi. Antagonisti dei leucotrieni. Istamina e gli inibitori dei recettori H 1. Farmaci attivi su cuore,<br />
circolo e apparato respiratorio: Omeostasi car<strong>di</strong>ovascolare. Antiipertensivi; Diuretici; Farmaci utilizzati nello<br />
scompenso car<strong>di</strong>aco; Antianginosi ed Antiaritmici; Antiaggreganti, anticoagulanti e fibrinolitici. Trattamento<br />
delle <strong>di</strong>slipidemie. Farmaci bronco<strong>di</strong>latatori; Mucolitici e antitussivi. Farmacologia del Sistema Nervoso<br />
Centrale: Vie <strong>di</strong> neurotrasmissione centrale e me<strong>di</strong>atori; bersagli farmacologici nel SNC. Farmaci utilizzati<br />
in affezioni psichiatriche: antidepressivi; ansiolitici; neurolettici. Terapia del morbo <strong>di</strong> Parkinson, malattia <strong>di</strong><br />
Alzheimer ed epilessie. Anestetici generali. Neurofarmacologia del dolore acuto e cronico; La morfina e i<br />
suoi derivati; Cure palliative. Aspetti regolatori inerenti alla prescrizione e all’uso dei farmaci.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso, articolato in lezioni ed esercitazioni in aula è sud<strong>di</strong>viso in moduli monotematici svolti e coor<strong>di</strong>nati<br />
dai docenti, per almeno 5 ore settimanali con un totale <strong>di</strong> circa 60 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica frontale.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in una prova orale nella quale si dovrà rispondere in maniera precisa a quesiti relativi agli<br />
argomenti del programma svolto.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento e materiale <strong>di</strong>dattico:<br />
PAOLETTI, NICOSIA, CLEMENTI, FUMAGALLI, Farmacologia generale e molecolare, UTET.<br />
RANG, DALE, RITTER, Farmacologia, Ambrosiana<br />
GOODMAN & GILMAN, Le basi farmacologiche della terapia, 9. ed., McGraw-Hill.<br />
Il materiale <strong>di</strong>dattico usato nelle lezioni ed esercitazioni sarà riportato, quando possibile, su supporto<br />
elettronico e inserito nei computer dell’aula <strong>di</strong>dattica, a <strong>di</strong>sposizione <strong>degli</strong> studenti.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: prof.ssa D. Conte ven., ore 9-11; prof.ssa A. De Luca lun. e mer., ore 9,30-12.
ANALISI DEI MEDICINALI I (Corso A)<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Farmacia)<br />
Attività formativa: B (caratterizzante);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare CHIM/08; cre<strong>di</strong>ti formativi: 13<br />
III Anno, II Semestre<br />
prof. Nicolino De Laurentis<br />
Finalità del Corso<br />
In<strong>di</strong>rizza alle cognizioni teoriche fondamentali per l’esecuzione sperimentale <strong>di</strong> alcuni dosaggi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cinali<br />
secondo la FU.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
Generalità. Norme <strong>di</strong> primo intervento. Normative sulle specialità me<strong>di</strong>cinali: Ministero SP, Divisioni,<br />
Servizi. Farmacopea Ufficiale: Determinazioni Analitiche. Norme <strong>di</strong> buona Fabbricazione delle Specialità<br />
Me<strong>di</strong>cinali e Controllo <strong>di</strong> Qualità. Analisi Statistica dei Dati. Bilancia Analitica. Analisi gravimetrica.<br />
Dosaggi Gravimetrici secondo la FU. Titolazioni <strong>di</strong> precipitaione: Argentometria, Precipitimetria. Analisi<br />
Volumetrica. Microanalisi. Titolazioni <strong>di</strong> neutralizzazione. Aci<strong>di</strong>metria e Alcalimetria: Dosaggi aci<strong>di</strong>metrici<br />
della FU. Titolazioni in Solventi non Acquosi. Titolazione con Formazione <strong>di</strong> Complessi Solubili:<br />
Complessometria. Titolazione Redox. Io<strong>di</strong>metria. Bromometria. Permanganometria. Cerimetria. Teoria delle<br />
Titolazioni Redox. Potenziometria. Elettrolisi. Coulumbometria. Voltammetria. Conduttimetria.<br />
Spettrofotometria. Fluorimetria. Spettroscopia Atomica.<br />
Eercitazioni <strong>di</strong> laboratorio<br />
Saggi della FU in Gravimetria. Aci<strong>di</strong>metria. Alcalimetria. Titolazione in Solventi non Acquosi.<br />
Complessometria. Argentometria. Permanganometria. Cerimetria. Iodometria. Conduttimetria.<br />
Potenziometria. Spettrofotometria. Spettrofluorimetria.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso è articolato in lezioni teoriche <strong>di</strong> almeno 5 ore settimanali per un totale <strong>di</strong> 60 e <strong>di</strong> esercitazioni<br />
pratiche in<strong>di</strong>viduali <strong>di</strong> laboratorio <strong>di</strong> 4 ore circa ciascuna.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in una prima prova scritta nella quale si dovrà rispondere su sei/sette esercizi <strong>di</strong> cui tre<br />
sono <strong>di</strong> calcoli stechiometrici relativi ai dosaggi <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cinali e gli altri su domande <strong>di</strong> carattere generale<br />
riguardante la parte teorica del Corso.<br />
La successiva prova orale, alla quale si accede dopo il superamento della prova scritta, verte essenzialmente<br />
sugli argomenti inerenti il corso teorico.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento e materiale <strong>di</strong>dattico:<br />
C. PORRETTA, Analisi quantitativa dei composti farmaceutici, CISU.<br />
SKOOG, WEST, Chimica Analitica, E<strong>di</strong>SES.<br />
NOVELLINO, Analisi chimico-farmaceutica quantitativa, Fratelli Conte.<br />
Farmacopea Ufficiale, 11. ed.<br />
Appunti dalle lezioni.<br />
Tutto il materiale <strong>di</strong>dattico usato nelle lezioni e nelle esercitazioni sarà riportato su supporto elettronico e<br />
inserito nei computer dell’aula <strong>di</strong>dattica, a <strong>di</strong>sposizione <strong>degli</strong> studenti con largo anticipo. Sarà fornita anche<br />
una copia cartacea del materiale utilizzato durante lezioni ed esercitazioni, che gli studenti potranno<br />
duplicare a loro spese.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: prof. De Laurentis mar. e gio., dalle 8,30-10,30.
ANALISI DEI MEDICINALI I (Corso B)<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Farmacia)<br />
Attività formativa: B (caratterizzante);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare CHIM/08; cre<strong>di</strong>ti formativi: 13<br />
III Anno, II Semestre<br />
prof. Antonio Carrieri<br />
Finalità del Corso<br />
Gli argomenti del Corso riguardano i principi fondamentali e i meto<strong>di</strong> maggiormente utilizzati per la<br />
identificazione qualitativa e la determinazione quantitativa <strong>di</strong> analiti <strong>di</strong> interesse farmaceutico e<br />
farmacologico. Più in dettaglio, sono descritte le <strong>di</strong>verse tecniche volumetriche e strumentali particolarmente<br />
utili nell’ambito della chimica analitica. Il Corso inoltre comprende anche una breve trattazione sui meto<strong>di</strong><br />
statistici.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
1. Aspetti generali<br />
2. Analisi qualitativa<br />
3. Analisi quantitativa<br />
3.1 Misura della massa<br />
3.2 Meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> analisi basati su titolazione<br />
3.2.1 Titolazione <strong>di</strong> neutralizzazione<br />
3.2.2 Titolazione <strong>di</strong> precipitazione<br />
3.2.3 Titolazione <strong>di</strong> complessazione<br />
3.2.4 Titolazione <strong>di</strong> ossidoriduzione<br />
4. Analisi strumentale<br />
4.1 Meto<strong>di</strong> elettroanalitici<br />
4.1.1 Potenziometria<br />
4.1.2 Voltammetria<br />
4.1.3 Amperometria<br />
4.1.4 Polarografia<br />
4.1.5 Conduttimetria<br />
5. Meto<strong>di</strong> spettroscopici <strong>di</strong> analisi<br />
5.1 Spettroscopia <strong>di</strong> assorbimento<br />
6. Errore sperimentale e valutazione dei dati analitici.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso, articolato in lezioni ed esercitazioni in laboratorio a posto singolo e in aula, si articola in almeno 5<br />
ore settimanali con un totale <strong>di</strong> circa 60 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica frontale.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in una prima prova scritta e una successiva prova orale.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento e materiale <strong>di</strong>dattico:<br />
SKOOG, WEST, HOLLER, Fondamenti <strong>di</strong> Chimica Analitica: Introduzione, Napoli, E<strong>di</strong>SES.<br />
HARRIS, Chimica Analitica Quantitativa, Bologna, Zanichelli.<br />
Tutto il materiale <strong>di</strong>dattico, in <strong>formato</strong> elettronico e cartaceo, sarà a <strong>di</strong>sposizione <strong>degli</strong> studenti, che ne<br />
potranno richiedere eventualmente anche l’invio per posta elettronica, previo contatto con il docente.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: lun., ore 10,30-12,30; mer., ore 16,30-17,30.
BIOCHIMICA APPLICATA<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Farmacia)<br />
Attività formativa: B (caratterizzante);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare BIO/10; cre<strong>di</strong>ti formativi: 6<br />
III Anno, II Semestre<br />
prof. Italo Stipani<br />
Finalità del Corso<br />
Il Corso <strong>di</strong> Biochimica applicata si prefigge l’approfon<strong>di</strong>mento della Biochimica tenendo presente in<br />
particolare le interrelazioni metaboliche tra i principali organi e tessuti sia in con<strong>di</strong>zioni fisiologiche che<br />
patologiche. Sono trattate le principali patologie con riferimento alle moderne tecnologie <strong>di</strong> produzione dei<br />
farmaci.<br />
Contenuto del Corso<br />
Biochimica dei vari tessuti: fegato, muscolo scheletrico, cuore, cervello, rene e tessuto a<strong>di</strong>poso.<br />
Interrelazioni metaboliche. Basi biochimiche e genetiche delle malattie. Classificazione delle malattie<br />
genetiche. Test <strong>di</strong>agnostici <strong>di</strong> laboratorio <strong>di</strong> malattie genetiche: dosaggi <strong>di</strong> attività enzimatiche, Southern<br />
blotting, marcatura con sonde <strong>di</strong> DNA, PCR e sue applicazioni in <strong>di</strong>agnostica. Metabolismo gluci<strong>di</strong>co.<br />
Meccanismi <strong>di</strong> regolazione della glicemia. Patologie del metabolismo dei carboidrati. Iperglicemie e <strong>di</strong>abete.<br />
Insulina: sintesi, compartimentazione, secrezione. Ipoglicemia. Glucagone e altri ormoni iperglicemizzanti.<br />
Ciclo <strong>di</strong>giuno-alimentazione. Meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> determinazione della glicemia: curve <strong>di</strong> tolleranza al glucosio.<br />
Glicogenosi, intolleranza al fruttosio, galattosemia. Ormoni, secon<strong>di</strong> messaggeri e neurotrasmettitori.<br />
Metabolismo lipi<strong>di</strong>co. Lipoproteine plasmatiche (chilomicroni, VLDL, IDL, LDL, HDL). Recettore per le<br />
LDL. Determinazione delle lipoproteine. Patologie del metabolismo delle lipoproteine. Colesterolemia e suo<br />
significato clinico. Colesterolo e malattie car<strong>di</strong>ovascolari. Proteine plasmatiche: analisi elettroforetica e<br />
variazioni delle proteine plasmatiche, significato clinico. Metabolismo azotato: azoto totale e azoto non<br />
proteico, significato clinico. Patologie del ciclo dell’urea. Il sangue: funzioni e composizione. Fasi principali<br />
dell’emostasi e patologie correlate. Emofilia. Biochimica delle emopatie. Emoglobinopatie. Principali<br />
anemie: anemia falciforme, talassemie, etc. Bilirubina e bilinogeni. Biochimica <strong>degli</strong> itteri. Enzimi<br />
plasmatici e loro origine. Enzimi nella <strong>di</strong>agnostica clinica (epatiti, infarto, etc.). Biochimica <strong>degli</strong> agenti<br />
xenobiotici (ad<strong>di</strong>tivi alimentari, contaminanti dei cibi, farmaci, etc.). Detossificazione epatica. Citocromo P-<br />
450 e sue isoforme. Metabolismo dell’etanolo: influenza dell’etilismo sui metabolismi e danni provocati.<br />
Tecniche immunologiche. Tecnologie del DNA ricombinante. Clonaggio. Ingegnerizzazione del DNA.<br />
Espressione <strong>di</strong> proteine ricombinanti. Produzione <strong>di</strong> farmaci e vaccini me<strong>di</strong>ante biotecnologie. Organismi<br />
geneticamente mo<strong>di</strong>ficati. Alimenti e nutrienti. Basi biochimiche della <strong>di</strong>eta e della <strong>di</strong>etoterapia.<br />
Alimentazione in con<strong>di</strong>zioni fisiologiche e patologiche. Alimentazione nella prevenzione <strong>di</strong> malattie.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso è articolato in lezioni in aula per 3 ore settimanali (per un totale <strong>di</strong> 30/35 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica frontale)<br />
con l’ausilio <strong>di</strong> supporti informatici.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in una prova orale.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento e materiale <strong>di</strong>dattico:<br />
CALDARERA, Biochimica sistematica umana, 2. ed., Clueb.<br />
KAPALAN, DELPECH, Biologia molecolare e me<strong>di</strong>cina, Gnocchi.<br />
WILSON, Biochimica applicata, Cortina.<br />
Tutto il materiale <strong>di</strong>dattico delle lezioni è riportato su supporto elettronico e messo a <strong>di</strong>sposizione <strong>degli</strong><br />
studenti nell’aula <strong>di</strong>dattica per la consultazione.<br />
Orari <strong>di</strong> ricevimento: mar., ore 9-10; mer., ore 9-10; gio., ore 17-19.
PATOLOGIA GENERALE<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Farmacia)<br />
Attività formativa: C (affini o integrativi);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare MED/04; cre<strong>di</strong>ti formativi: 10<br />
III Anno, II Semestre<br />
Svolto nel precedente a.a. da:<br />
prof. Na<strong>di</strong>a Pasquetto<br />
Finalità del Corso<br />
Il Corso è svolto con l’intento <strong>di</strong> delucidare le più frequenti patologie, nonché quelle che hanno destato<br />
l’apprensione generale.<br />
A tal fine, il Corso è correlato <strong>di</strong> elementi <strong>di</strong> terminologia me<strong>di</strong>ca e <strong>di</strong> una serie numerosa <strong>di</strong> <strong>di</strong>apositive<br />
riguardanti i vari temi trattati.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
Eziologia generale<br />
Ere<strong>di</strong>tà in patologia<br />
Infiammazione o flogosi<br />
Immunità<br />
Immunopatologia<br />
Processi regressivi e progressivi<br />
Degenerazioni cellulari<br />
Oncologia<br />
Fisiopatologia <strong>degli</strong> idrati <strong>di</strong> carbonio<br />
Fisiopatologia delle purine e delle pirimi<strong>di</strong>ne<br />
Fisiopatologia del sangue<br />
Fisiopatologia dell’apparato car<strong>di</strong>o-vascolare<br />
Fisiopatologia della circolazione e dei vasi<br />
Fisiopatologia renale<br />
Fisiopatologia del fegato.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso, articolato in lezioni monotematiche, comprende un impegno <strong>di</strong> 5 ore settimanali per un totale <strong>di</strong><br />
circa 60 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica frontale.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in una prova orale riguardante, almeno, due argomenti del programma.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento:<br />
I. COVELLI, L. FRATI, G. ROSSI, G. VECCHIO, Patologia generale, 5. ed., Napoli, Florio, 1998.<br />
I. COVELLI, L. FRATI, Fisiopatologia generale, 5. ed., Napoli, Florio, 2001.<br />
Per il solo argomento “Ere<strong>di</strong>tà in patologia”:<br />
M.U. DIANZANI, Istituzioni <strong>di</strong> patologia generale, Torino, USES.<br />
Per il solo argomento “Processi regressivi e progressivi”:<br />
G.M. PONTIERI “Patologia generale” Padova, Piccin.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: per appuntamento, mancando il docente <strong>di</strong> un suo stu<strong>di</strong>o.
ANALISI DEI MEDICINALI II (Corso A)<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Farmacia)<br />
Attività formativa: B (caratterizzante);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare CHIM/08; cre<strong>di</strong>ti formativi: 13<br />
IV Anno, I Semestre<br />
prof. Saverio Cellamare<br />
Finalità del Corso<br />
Il Corso si pone l’obiettivo <strong>di</strong> fornire agli studenti le tecniche chimico-fisiche e spettroscopiche per l’analisi<br />
dei me<strong>di</strong>cinali riportati nella farmacopea italiana ed europea. Particolare attenzione sarà data alla<br />
identificazione e caratterizzazione dei principi attivi, eccipienti ed impurezze che spesso sono<br />
contemporaneamente presenti in una specialità me<strong>di</strong>cinale.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
1.0 Introduzione. 1.1 Farmacopea e controllo <strong>di</strong> qualità <strong>di</strong> specialità me<strong>di</strong>cinali. 2.0 Analisi Organica<br />
Qualitativa 2.1 Sicurezza e prevenzione infortuni in laboratorio. 2.2 Punto <strong>di</strong> fusione: aspetti teorici e<br />
determinazione pratica. 2.3 Solubilità: aspetti teorici del processo <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssoluzione, relazioni strutturali<br />
solvente-soluto, determinazione pratica. 2.4 Proprietà e costanti fisiche <strong>di</strong> composti <strong>di</strong> interesse<br />
farmaceutico: Farmacopea Italiana ed Europea, The Merck Index, CRC Handbook of Chemistry and Physics.<br />
2.5 Reazioni <strong>di</strong> riconoscimento dei principali gruppi funzionali. 2.6 Elementi <strong>di</strong> analisi organica qualitativa.<br />
2.7 Reazioni <strong>di</strong> riconoscimento <strong>di</strong> alcune classi <strong>di</strong> sostanze riportate nella Farmacopea: Alcaloi<strong>di</strong>,<br />
Barbiturici, Benzoati, Citrati, Lattati, Salicilati, Tartrati, Xantine. 3.0 Tecniche <strong>di</strong> Separazione e <strong>di</strong><br />
Purificazione 3.1 Distillazione: semplice, frazionata, azeotropica, sotto vuoto, in corrente <strong>di</strong> vapore. 3.2<br />
Estrazione con solventi: generalità e criteri <strong>di</strong> scelta del solvente. 3.2.1 Estrazione solido-liquido e liquidoliquido.<br />
3.2.2 Distribuzione in controcorrente. 3.2.3 Separazione <strong>di</strong> miscele per mezzo <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>menti<br />
estrattivi. 3.3 Cromatografia: generalità e meccanismi <strong>di</strong> separazione. 3.3.1 Serie eluotrope. 3.3.2 Teoria <strong>di</strong><br />
base del processo cromatografico e definizione <strong>di</strong>: ritenzione, selettività, efficienza, risoluzione. 3.3.3<br />
Applicazioni dei principi teorici generali ai <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> cromatografia. 3.3.4 Cromatografia su strato sottile<br />
(TLC). 3.3.5 Cromatografia liquida ad elevate prestazioni (HPLC). 3.3.6 Gas-cromatografia. 4.0 Analisi<br />
Spettroscopica. 4.1 Aspetti generali.<br />
4.2 Spettroscopia UV-Vis e IR: principi e applicazioni, interpretazione <strong>di</strong> spettri. 4.3 Spettroscopia <strong>di</strong><br />
risonanza magnetica nucleare: principi, schermo elettronico, spostamento chimico e campo magnetico;<br />
accoppiamento spin-spin e costanti <strong>di</strong> accoppiamento; interpretazione <strong>di</strong> spettri del primo e secondo or<strong>di</strong>ne;<br />
protoni legati ad eteroatomi e scambio con D2O. 4.4 Spettrometria <strong>di</strong> massa: principi e applicazioni, peso<br />
molecolare, frammentazione.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso, articolato in lezioni, esercitazioni in aula ed esercitazioni pratiche <strong>di</strong> laboratorio, è sud<strong>di</strong>viso in<br />
moduli monotematici svolti per almeno 5 ore settimanali per un totale <strong>di</strong> circa 120 ore <strong>di</strong> cui 60 ore <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>dattica frontale e altrettante ore <strong>di</strong> esercitazioni pratiche <strong>di</strong> laboratorio.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in un colloquio in cui lo studente dovrà rispondere ad almeno tre domande sugli argomenti<br />
in<strong>di</strong>cati nel “contenuto del Corso”.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento:<br />
COZZI, PROTTI, RUARO, Analisi chimica moderni meto<strong>di</strong> strumentali, Bologna, Zanichelli.<br />
CONNORS, Textbook of Pharmaceutical Analysis, New York, A. Wiley, Interscience Publication,<br />
Farmacopea Ufficiale Italiana. SILVERSTEIN, WEBSTER, Identificazione spettroscopica <strong>di</strong> composti organici,<br />
Milano, Ambrosiana.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: mar., ore 10,30-11,30; gio., 10,30-12,30; ven., ore 10,30-12,30.
ANALISI DEI MEDICINALI II (Corso B)<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Farmacia)<br />
Attività formativa: B (caratterizzante);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare CHIM/08; cre<strong>di</strong>ti formativi: 13<br />
IV Anno, I Semestre<br />
prof. Antonio Scilimati<br />
Finalità del Corso<br />
Il Corso si pone l’obiettivo <strong>di</strong> fornire agli studenti le tecniche chimico-fisiche e spettroscopiche per l’analisi<br />
dei me<strong>di</strong>cinali riportati nella farmacopea italiana ed europea. Particolare attenzione sarà data alla<br />
identificazione e caratterizzazione dei principi attivi, eccipienti ed impurezze che spesso sono<br />
contemporaneamente presenti in una specialità me<strong>di</strong>cinale.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
1.0 Introduzione. 1.1 Farmacopea e controllo <strong>di</strong> qualità <strong>di</strong> specialità me<strong>di</strong>cinali. 2.0 Analisi Organica<br />
Qualitativa. 2.1 Sicurezza e prevenzione infortuni in laboratorio. 2.2 Punto <strong>di</strong> fusione: aspetti teorici e<br />
determinazione pratica. 2.3 Solubilità: aspetti teorici del processo <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssoluzione, relazioni strutturali<br />
solvente-soluto, determinazione pratica. 2.4 Proprietà e costanti fisiche <strong>di</strong> composti <strong>di</strong> interesse<br />
farmaceutico: Farmacopea Italiana ed Europea, The Merck Index, CRC Handbook of Chemistry and Physics.<br />
2.5 Reazioni <strong>di</strong> riconoscimento dei principali gruppi funzionali. 2.6 Elementi <strong>di</strong> analisi organica qualitativa.<br />
2.7 Reazioni <strong>di</strong> riconoscimento <strong>di</strong> alcune classi <strong>di</strong> sostanze riportate nella Farmacopea: Alcaloi<strong>di</strong>,<br />
Barbiturici, Benzoati, Citrati, Lattati, Salicilati, Tartrati, Xantine. 3.0 Tecniche <strong>di</strong> Separazione e <strong>di</strong><br />
Purificazione. 3.1 Distillazione: semplice, frazionata, azeotropica, sotto vuoto, in corrente <strong>di</strong> vapore. 3.2<br />
Estrazione con solventi: generalità e criteri <strong>di</strong> scelta del solvente. 3.2.1 Estrazione solido-liquido e liquidoliquido.<br />
3.2.2 Distribuzione in controcorrente. 3.2.3 Separazione <strong>di</strong> miscele per mezzo <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>menti<br />
estrattivi. 3.3 Cromatografia: generalità e meccanismi <strong>di</strong> separazione. 3.3.1 Serie eluotrope. 3.3.2 Teoria <strong>di</strong><br />
base del processo cromatografico e definizione <strong>di</strong>: ritenzione, selettività, efficienza, risoluzione. 3.3.3<br />
Applicazioni dei principi teorici generali ai <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> cromatografia. 3.3.4 Cromatografia su strato sottile<br />
(TLC). 3.3.5 Cromatografia liquida ad elevate prestazioni (HPLC). 3.3.6 Gas-cromatografia. 4.0 Analisi<br />
Spettroscopica. 4.1 Aspetti generali.<br />
4.2 Spettroscopia UV-Vis e IR: principi e applicazioni, interpretazione <strong>di</strong> spettri. 4.3 Spettroscopia <strong>di</strong><br />
risonanza magnetica nucleare: principi, schermo elettronico, spostamento chimico e campo magnetico;<br />
accoppiamento spin-spin e costanti <strong>di</strong> accoppiamento; interpretazione <strong>di</strong> spettri del primo e secondo or<strong>di</strong>ne;<br />
protoni legati ad eteroatomi e scambio con D2O. 4.4 Spettrometria <strong>di</strong> massa: principi e applicazioni, peso<br />
molecolare, frammentazione.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso, articolato in lezioni, esercitazioni in aula ed esercitazioni pratiche <strong>di</strong> laboratorio, è sud<strong>di</strong>viso in<br />
moduli monotematici svolti per almeno 5 ore settimanali per un totale <strong>di</strong> circa 120 ore <strong>di</strong> cui 60 ore <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>dattica frontale e altrettante ore <strong>di</strong> esercitazioni pratiche <strong>di</strong> laboratorio.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in un colloquio in cui lo studente dovrà rispondere ad almeno tre domande sugli argomenti<br />
in<strong>di</strong>cati nel “contenuto del Corso”.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento:<br />
COZZI, PROTTI, RUARO, Analisi chimica moderni meto<strong>di</strong> strumentali, Bologna, Zanichelli.<br />
CONNORS, Textbook of Pharmaceutical Analysis, New York, A. Wiley, Interscience Publication,<br />
Farmacopea Ufficiale Italiana.<br />
SILVERSTEIN, WEBSTER, Identificazione spettroscopica <strong>di</strong> composti organici, Milano, Ambrosiana.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: mar., ore 10,30-11,30; gio., ore 16,30-17,30; ven., ore 16,30-17,30.
TECNOLOGIA FARMACEUTICA (Corso A-H)<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Farmacia)<br />
Attività formativa B (caratterizzante);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare CHIM/09; cre<strong>di</strong>ti formativi: 13<br />
IV Anno, I Semestre<br />
prof. Gaetano Liso<br />
Finalità del Corso<br />
Conoscenza delle forme farmaceutiche e della normativa riguardante la <strong>di</strong>spensazione del me<strong>di</strong>camento.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
Farmacopee. Preparazioni magistrali, officinali e norme per la <strong>di</strong>spensazione dei me<strong>di</strong>camenti.<br />
Composizione e proprietà dei contenitori e <strong>degli</strong> eccipienti più comunemente utilizzati per le varie forme<br />
farmaceutiche. Polveri per uso orale e per la preparazione <strong>di</strong> liqui<strong>di</strong> per uso orale, Polveri per uso topico.<br />
Polveri per preparazioni iniettabili o infusioni endovenose. Polveri nasali, auricolari o per inalazione.<br />
Polveri per soluzioni e sospensioni rettali. Saggi tecnologici della FU. Granulati. Granulazione a secco o ad<br />
umido e relative apparecchiature. Controlli tecnologici. G. effervescenti, rivestiti, gastroresistenti, a rilascio<br />
mo<strong>di</strong>ficato e relativi saggi FU. Capsule. Capsule dure e cps molli. Tecniche <strong>di</strong> produzione. Cps<br />
gastroresistenti, a rilascio mo<strong>di</strong>ficato. Saggi FU.<br />
Microcapsule e nanocapsule. Compresse. Compattazione <strong>di</strong> polveri o granulati. Parametri relativi al processo<br />
<strong>di</strong> compressione e proprietà del compatto. Cprs con rivestimento zuccherino o rivestite con film<br />
gastrosolubile o gastroresistente.<br />
Tipi <strong>di</strong> compresse e relativi saggi FU. Soluzioni acquose. Cosolventi e sostanze idrotrope. Processi <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>ffusione e <strong>di</strong>ssoluzione. Osmolarità ed isotonicità delle soluzioni. Preservazione dall’inquinamento<br />
microbico, correzione del gusto e stabilizzazione delle soluzioni. Liqui<strong>di</strong> per uso orale e Liqui<strong>di</strong> per<br />
applicazione cutanea. Soluzioni non acquose: elisir, alcoliti, alcolati, gliceriti, oleoliti. Massa della goccia e<br />
contagocce FU. Estratti. Tinture. Infusi e Decotti. Dispersioni colloidali. Colloi<strong>di</strong> liofili, liofobi e <strong>di</strong><br />
associazione. Proprietà elettriche ed ottiche delle <strong>di</strong>spersioni colloidali. Flui<strong>di</strong> newtoniani e non newtoniani.<br />
Viscosità <strong>di</strong> sol idrofili. Applicazioni farmaceutiche dei sistemi colloidali. Emulsioni semplici e multiple.<br />
Scelta del tensioattivo e calcolo della quantità minima richiesta. Microemulsioni. Sospensioni. Sciroppi<br />
semplice o me<strong>di</strong>cato. Preparazioni farmaceutiche pressurizzate. Preparazioni per inalazione. Stabilità delle<br />
forme farmaceutiche. Determinazione della velocità <strong>di</strong> decomposizione dei farmaci. Periodo <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà della<br />
f. farm. e sua valutazione me<strong>di</strong>ante prove <strong>di</strong> decomposizione accelerata (equazione <strong>di</strong> Arrhenius).<br />
Preparazioni semisolide per uso topico: Unguenti, creme, geli e paste. Basi per pomate del Codex FOFI.<br />
Cerotti transdermici. Preparazioni rettali, vaginali e uretrali. Sterilizzazione <strong>di</strong> forme farmaceutiche e<br />
materiali per me<strong>di</strong>cazione. Preparazioni parenterali e p. oftalmiche.<br />
Elementi <strong>di</strong> biofarmaceutica. Processi farmacocinetici <strong>di</strong> assorbimento ed eliminazione. Bio<strong>di</strong>sponibilità e<br />
bioequivalenza <strong>di</strong> f.f. farm. Fattori influenzanti la bio<strong>di</strong>sponibilità del p. attivo presente nella f. farm. Cenni<br />
sulle f.f. farm. a rilascio mo<strong>di</strong>ficato.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso si articola in 60 ore <strong>di</strong> lezioni e 40 ore <strong>di</strong> esercitazioni pratiche. Queste ultime prevalentemente<br />
relative a modalità <strong>di</strong> preparazione e <strong>di</strong>spensazione <strong>di</strong> galenici magistrali.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
Una prova scritta ed una successivo prova orale.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento:<br />
M. AMOROSA, Principi <strong>di</strong> tecnica farmaceutici, Bologna, Tinarelli.<br />
A.T. FLORENCE & D. ATTWOOD, Le basi chimico-fisiche della tecnologia farmaceutica, Napoli, E<strong>di</strong>SES.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: mer., ore 16,30-17,30; gio. e ven., ore 12-13.
TECNOLOGIA FARMACEUTICA (Corso I-Z)<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Farmacia)<br />
Attività formativa B (caratterizzante);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare Chim/09; cre<strong>di</strong>ti formativi: 13<br />
IV Anno, I Semestre<br />
prof. Sabino Ottolino<br />
Finalità del Corso<br />
Riguardano la caratterizzazione, la pre-formulazione, la preparazione ed il controllo delle forme<br />
farmaceutiche, nonché dei me<strong>di</strong>cinali e la loro gestione.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
Norme e metrologia della galenica. Forme farmaceutiche convenzionali, loro formulazione e produzione.<br />
Saggi e proce<strong>di</strong>menti tecnologici prescritti in FU. Principali eccipienti, veicoli ed a<strong>di</strong>uvanti: loro funzione e<br />
struttura. Meccanismi <strong>di</strong> cessione dei farmaci. Bio<strong>di</strong>sponibilità e bioequivalenza. Fondamentali parametri<br />
chimico-fisici e fenomeni fisici che regolano e governano i vari sistemi farmaceutici allo stato <strong>di</strong> polveri,<br />
soli<strong>di</strong>, liqui<strong>di</strong> e semisoli<strong>di</strong> mono e multi-fase. Fondamentali processi <strong>di</strong> produzione e relative<br />
apparecchiature. Sterilità e meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> sterilizzazione. Requisiti microbiologici ed agenti preservanti.<br />
Classificazione amministrativa dei me<strong>di</strong>cinali (DL.vo 178/91). Classificazione nella fornitura (DL.vo<br />
539/92). Gestione professionale <strong>di</strong> stupefacenti e sostanze velenose. Le norme <strong>di</strong> Farmacopea. FF <strong>di</strong><br />
dosaggio programmate: polveri, granulati, capsule e compresse, gomme da masticare, liqui<strong>di</strong>, bastoncini,<br />
preparazioni semisolide topiche, preparazioni auricolari, nasali, oftalmiche, rettali e vaginali, preparazioni<br />
pressurizzate, inalazioni ed irrigazioni, preparati fitofarmaceutici.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso si articola in 60 ore <strong>di</strong> lezioni e 40 ore <strong>di</strong> esercitazioni pratiche. Queste ultime relative alla <strong>di</strong><br />
preparazione e spe<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> galenici, prevalentemente del Codex FOFI.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame orale comprende test <strong>di</strong> autocontrollo culturale, risolutivi dei più comuni problemi tecnicofarmaceutici.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento:<br />
M. AMOROSA, Tecnica farmaceutica, Bologna, Tinarelli.<br />
M. BETTIOL, Preparazioni galeniche, Milano, Tecniche Nuove.<br />
H. ANSEL ET ALII, Pharmaceutical dosage forms, USA, Williams.<br />
FLORENCE, Basi chimico-fisiche della tecnologia farmaceutica, Napoli, E<strong>di</strong>SES.<br />
Royal Ph. Soc. of G. Britain; The Codex, London, Ph Press.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: mar., ore 11-12,30 o per appuntamento.
CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA II<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Farmacia)<br />
Attività formativa: B (caratterizzante);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare CHIM/08; cre<strong>di</strong>ti formativi: 11<br />
IV Anno, II Semestre<br />
proff. Marcello Ferappi e Francesco Campagna<br />
Finalità del Corso<br />
Il Corso viene svolto tenendo in particolare considerazione la <strong>di</strong>fferenza tra farmaci organotropi ed eziotropi.<br />
Per tutti i farmaci vengono trattati proprietà, biogenesi, aspetti farmacocinetici, meccanismo d’azione,<br />
attività ed effetti collaterali, correlando sempre tali fattori alle caratteristiche chimiche delle molecole. Tutte<br />
le classi <strong>di</strong> farmaci sono tenute aggiornate in considerazione <strong>degli</strong> ultimi traguar<strong>di</strong> terapeutici.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
1.0 Ormoni. 1.1 Ormoni <strong>di</strong> natura pepti<strong>di</strong>ca: ormoni ipotalamici ed ipofisari, ormoni ghiandolari e tissutali.<br />
1.2 Biogenesi del colesterolo, ipocolesterolemici. 1.3 Ormoni steroi<strong>di</strong>ci: ormoni sessuali, androgeni,<br />
estrogeni, progestinici, anticoncezionali, ormoni corticosurrenali: mineralcorticoi<strong>di</strong>, glicocorticoi<strong>di</strong>. 2.0<br />
Eicosanoi<strong>di</strong>. 2.1 Cascata dell’acido arachidonico: prostaglan<strong>di</strong>ne, prostacicline, trombossani, leucotrieni. 3.0<br />
Farmaci ed alimenti. 3.1 Vitamine e provitamine. 3.2 Vitamine liposolubili. 3.3 Vitamina C. 3.3 Complesso<br />
B e attività coenzimatica. 3.4 Fattori folinici. 4.0 Chemioterapici. 4.1 Sulfami<strong>di</strong>ci 4.2 Chinolonici. 4.3<br />
Antiprotozoari. 4.4 Antimicobattrici. 4.4.1 Antitubercolari. 4.4.2 Antilebbra. 4.5 Antielmintici. 4.6<br />
Antimicotici. 4.7 Antivirali. 4.8 Antitumorali. 4.8.1 Cell cycle phase. 4.8.2 Antimetaboliti pirimi<strong>di</strong>nici e<br />
purinici. 4.8.3 Antifolici. 4.8.4 Agenti alchilanti. 4.8.5 Antibiotici antiblastici. 4.8.6 Altri antitumorali. 5.0<br />
Antibiotici. 5.1 Antibiogramma. 5.2 Spettro d’azione. 5.3 Attacco ai vari recettori. 5.4 Tossicità. 5.5<br />
Cicloserina. 5.6 Beta lammine. 5.6.1 Parete cellulare, biosintesi del peptidoglicano, reattività elettrofila<br />
acilante. 5.6.2 Penicilline naturali, biosintetiche, semisintetiche. 5.6.3 Cefalosporine. 5.6.4 Inibitori delle<br />
lattamasi. 5.6.5 Monobattami. 5.6.6 Carbapenemi. 5.7 Glicopepti<strong>di</strong>. 5.8 Polipepti<strong>di</strong>ci. 5.9 Macroli<strong>di</strong>. 5.10<br />
Macroli<strong>di</strong> polienici. 5.11 Tetracicline. 5.12 Amminoglicosi<strong>di</strong>ci. 5.13 Streptomicine. 5.14 Amfenicoli.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso è sud<strong>di</strong>viso in moduli monotematici, si articola in lezioni ed esercitazioni per almeno 5 ore<br />
settimanali con un totale <strong>di</strong> circa 60 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica frontale.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
La prova d’esame consiste in un colloquio su almeno tre argomenti presenti nel programma, eventualmente<br />
preceduto da una prova scritta.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento e materiale <strong>di</strong>dattico:<br />
E. SCHROEDER, C. RUFER, R. SCHMIECHEN, Chimica farmaceutica, (voll. I e II) Napoli, E<strong>di</strong>SES, 1991.<br />
C. WERMUTH, Le applicazioni della chimica farmaceutica, Napoli E<strong>di</strong>SES, 2001.<br />
FOYE, LEMKE, WILLIAMS, Principi <strong>di</strong> Chimica farmaceutica, Piccin, 1998.<br />
Tutto il materiale <strong>di</strong>dattico sarà riportato su supporto elettronico e inserito nei computer dell’aula <strong>di</strong>dattica.<br />
Ne sarà fornita anche una copia cartacea.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: mar., ore 10,30-11,30; mer., ore 16,30-18,30; gio., ore 10,30-11,30.
FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Farmacia)<br />
Attività formativa: B (caratterizzante);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare BIO/14; cre<strong>di</strong>ti formativi: 11<br />
IV Anno, II Semestre<br />
prof. Diana Conte<br />
Finalità del Corso<br />
Fornire allo studente competenze riguardanti la conoscenza dell’azione dei farmaci e <strong>degli</strong> aspetti<br />
tossicologici legati al loro impiego in terapia e i danni causati da agenti tossici <strong>di</strong> varia natura.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
I parte. Farmacologia e Farmacoterapia II<br />
Farmaci e Sistema immunitario. Corticosteroi<strong>di</strong>: glucocorticoi<strong>di</strong> e mineralcorticoi<strong>di</strong>. Farmacologia del<br />
sistema endocrino. Farmacologia della sterilità e della contraccezione orale. Farmaci delle malattie<br />
<strong>di</strong>smetaboliche: <strong>di</strong>smetabolismo gluci<strong>di</strong>co e proti<strong>di</strong>co. Interventi farmacologici sulla motilità uterina:<br />
uterotonici e uterolitici. Farmacologia del sistema gastroenterico. Vitamine.<br />
II parte. Chemioterapici e antibiotici.<br />
Resistenza batterica: acquisizione e trasferimento. Antibiotici beta-lattamici, Aminoglicosi<strong>di</strong> e chinolonici,<br />
Macroli<strong>di</strong>, Lincosami<strong>di</strong>, Tetracilcine e Cloramfenicolo. Sulfami<strong>di</strong>ci e Nitroimidazoli. Antitubercolari,<br />
Antimicotici, Antivirali (Epatite, Herpes, AIDS, SARS, Ebola, etc.). Antielmintici, Antiprotozoari,<br />
trattamento delle Ectoparassitosi. Farmaci antineoplastici.<br />
III parte. Tossicologia.<br />
Tossicologia generale. Valutazione del rischio. Mutagenesi, cancerogenesi, teratogenesi. Tossicologia<br />
sistemica. Tossicità d’organo. Interazioni tra farmaci. Farmacologia delle tossico<strong>di</strong>pendenze. Tossicità da<br />
inquinanti ambientali: pestici<strong>di</strong> e aereoinquinanti. Tossicologia alimentare e nutrizionale. Lo sviluppo <strong>di</strong> un<br />
farmaco e farmacovigilanza.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso, articolato in lezioni ed esercitazioni in aula è sud<strong>di</strong>viso in moduli monotematici svolti e coor<strong>di</strong>nati<br />
dallo stesso docente, per almeno 5 ore settimanali con un totale <strong>di</strong> circa 60 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica frontale.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in una prova orale nella quale si dovrà rispondere in maniera precisa a quesiti relativi agli<br />
argomenti del programma svolto.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento e materiale <strong>di</strong>dattico:<br />
GREIM, DEML, Tossicologia, Zanichelli.<br />
RANG, DALE, RITTER, Farmacologia, Ambrosiana.<br />
PAOLETTI, NICOSIA, CLEMENTI, FUMAGALLI, Tossicologia generale e molecolare, UTET.<br />
GOODMAN & GILMAN, Le basi farmacologiche della terapia, 9. ed. McGraw-Hill.<br />
Il materiale <strong>di</strong>dattico usato nelle lezioni ed esercitazioni quando possibile sarà riportato su supporto<br />
elettronico e inserito nei computer dell’aula <strong>di</strong>dattica, a <strong>di</strong>sposizione <strong>degli</strong> studenti. Sarà fornita copia<br />
cartacea del materiale usato durante lezioni ed esercitazioni, solo come guida ad integrazione ai testi sotto<br />
consigliati.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: ven., ore 9-11.
TECNOLOGIA, SOCIOECONOMIA<br />
E LEGISLAZIONE FARMACEUTICHE<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Farmacia)<br />
Attività formativa: B (caratterizzante);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare CHIM/09 cre<strong>di</strong>ti formativi: 11<br />
IV Anno, II Semestre<br />
prof. Nicola Maggi<br />
Finalità del Corso<br />
Il Corso è orientato alla trattazione <strong>degli</strong> aspetti tecnologici importanti ai fini della preparazione galenica <strong>di</strong><br />
qualità. Inoltre, approfon<strong>di</strong>sce tematiche normative e socioeconomiche <strong>di</strong> interesse preminente in campo<br />
professionale.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
Percorso <strong>di</strong> sviluppo <strong>di</strong> un nuovo farmaco, dalla sua scoperta sino alla introduzione in mercato. Vie <strong>di</strong><br />
somministrazione dei farmaci e modalità <strong>di</strong> assorbimento; richiami <strong>di</strong> farmacocinetica. <strong>Stu<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong><br />
preformulazione: proprietà fisiche e chimico-fisiche del farmaco, <strong>di</strong> rilevanza nell’allestimento delle varie<br />
forme farmaceutiche.<br />
Progettazione e messa a punto della forma <strong>di</strong> dosaggio <strong>di</strong> un farmaco.<br />
Forme farmaceutiche parenterali: classificazione e requisiti. Modalità preparative <strong>degli</strong> iniettabili. Operazioni<br />
sterili e tecniche <strong>di</strong> sterilizzazione.<br />
Forme farmaceutiche orali liquide: qualità microbiologica e agenti conservanti. Forme farmaceutiche solide<br />
orali: criteri <strong>di</strong> formulazione <strong>di</strong> capsule e compresse, aspetti biofarmaceutici e funzioni dei principali<br />
eccipienti e coformulanti. Forme a rilascio mo<strong>di</strong>ficato per via parenterale, orale, oftalmica, intrauterina e<br />
transdermica. Forme farmaceutiche pressurizzate per uso topico e inalatorio.<br />
Stabilità e stabilizzazione dei farmaci: meccanismi <strong>di</strong> degradazione, modelli sperimentali <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o.<br />
Controllo <strong>di</strong> qualità: concetti generali applicati alla produzione farmaceutica. Norme <strong>di</strong> Buona Fabbricazione.<br />
Norme <strong>di</strong> Buona Preparazione. Controlli <strong>di</strong> qualità delle principali forme farmaceutiche, con riferimento alla<br />
FU.<br />
Introduzione alla Farmacoeconomia: trend demografici e spesa farmaceutica. Modelli <strong>di</strong> analisi<br />
farmacoeconomica; minimizzazione dei costi. Me<strong>di</strong>cinali generici: esigenze farmacoeconomiche, aspetti<br />
tecnologici, biofarmaceutici e legislativi. Me<strong>di</strong>cinali orfani: aspetti farmacoeconomici e legislativi. Procedure<br />
<strong>di</strong> autorizzazione all’immissione in commercio dei me<strong>di</strong>cinali. Presentazione del me<strong>di</strong>cinale e foglio<br />
illustrativo.<br />
Farmacoepidemiologia e Farmacovigilanza. Me<strong>di</strong>cinali omeopatici: cenni storici, aspetti tecnici e normativi.<br />
Servizio Sanitario Nazionale e sua organizzazione. Normative <strong>di</strong> sicurezza nell’esercizio professionale.<br />
Adempimenti e problemi relativi allo smaltimento dei materiali <strong>di</strong> scarto in farmacia.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso si articola in lezioni, per almeno 5 ore settimanali con un totale <strong>di</strong> circa 70 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica frontale.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in una prova orale.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento e materiale <strong>di</strong>dattico:<br />
M. AMOROSA, Principi <strong>di</strong> Tecnica Farmaceutica, Bologna, Tinarelli.<br />
A.T. FLORENCE, D. ATWOOD, Le Basi chimico-fisiche della tecnologia farmaceutica, Napoli, E<strong>di</strong>SES.<br />
G.M. MARCHETTI, P. MINGHETTI, Legislazione Farmaceutica, Ambrosiana.<br />
RECCHIA, G. DE CARLI, Introduzione alla Farmacoeconomia, OEMF. R.J. BONK, Pharmacoeconomics in<br />
Perspective, Pharmaceutical Products Press.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: lun., ore 10-11; mar. e gio., ore 9,30-10,30.
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN CHIMICA E<br />
TECNOLOGIA FARMACEUTICHE<br />
CHIMICA GENERALE ED INORGANICA<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche)<br />
Attività formativa: A (<strong>di</strong> base);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare CHIM/03; cre<strong>di</strong>ti formativi: 8<br />
I Anno, I Semestre<br />
proff. Luciana Maresca e Giovanni Natile<br />
Finalità del Corso<br />
Il Corso intende formare negli studenti la base culturale adatta al successivo approfon<strong>di</strong>mento delle<br />
<strong>di</strong>scipline <strong>di</strong> ambito chimico e a potenziare le capacità logiche nell’approccio ai temi scientifici. Il<br />
programma è completato da un excursus attraverso le principali reazioni della Chimica inorganica.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
1. La Teoria Atomica: Le prime leggi (Lavoisier, Proust, Dal ton, etc.). Teoria atomica <strong>di</strong> Dalton. Particelle<br />
subatomiche. La mole.<br />
2. Dall’atomo alla composizione molecolare: Nomenclatura e formule chimiche. Bilanciamento delle<br />
equazioni chimiche.<br />
3. Sistema perio<strong>di</strong>co e struttura dell’atomo: Struttura atomica. Connfigurazioni elettroniche. Costruzione del<br />
sistema perio<strong>di</strong>co.<br />
4. Legame chimico e struttura molecolare: Formule <strong>di</strong> Lewis. Geometria molecolare (teoria VSEPR).<br />
Polarità delle molecole. Legame ionico e covalente. Legame covalente polare. Teoria del legame <strong>di</strong> valenza.<br />
Teoria dell’orbitale molecolare (cenni).<br />
5. I gas: Proprietà generali. Le leggi dei gas. Equazione generale <strong>di</strong> stato dei gas. La teoria cinetica dei gas<br />
ideali. I gas reali.<br />
6. I soli<strong>di</strong>: Legame chimico e struttura. Principali proprietà.<br />
7. Stati condensati e transizioni <strong>di</strong> fase: Importanza e natura dei legami intermolecolari.Transizione <strong>di</strong> fase.<br />
8. Le soluzioni: Formazione, concentrazione e tensione <strong>di</strong> vapore. Legge <strong>di</strong> Raoult. Proprietà colligative.<br />
9. Le reazioni chimiche: Reazioni acido-base. Reazioni ossido-riduttive. Reazioni <strong>di</strong> precipitazione.<br />
Titolazioni.<br />
10. Termo<strong>di</strong>namica: Cenni <strong>di</strong> termo<strong>di</strong>namica chimica. Reazioni spontanee. Equilibrio chimico e fattori che<br />
lo influenzano.<br />
11. Equilibrio chimico in soluzione: Gli equilibri acido-base. Auto-ionizzazione dell’acqua. Il pH. Aci<strong>di</strong> e<br />
basi forti; aci<strong>di</strong> e basi deboli. Il grado <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssociazione ed il pH. Reazioni <strong>di</strong> idrolisi. Aci<strong>di</strong> poliprotici e basi<br />
poliacide. Anfoliti. Soluzioni tampone. In<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> pH. Equilibrio chimico e titolazioni acido-base.<br />
Equilibri <strong>di</strong> solubilità.<br />
12. Elettrochimica: Celle galvaniche. Legge <strong>di</strong> Nernst. Elettrochimica e termo<strong>di</strong>namica. Elettrolisi: aspetti<br />
quantitativi e applicativi.<br />
13. Elementi <strong>di</strong> Chimica inorganica: Idruri, ossi<strong>di</strong> e loro proprietà. Formule e nomi IUPAC e d’uso comune<br />
dei composti binari e ternari <strong>degli</strong> elementi dei gruppi principali. Principali caratteristiche <strong>degli</strong> elementi dei<br />
gruppi della tavola perio<strong>di</strong>ca.<br />
14. Cenni <strong>di</strong> Cinetica chimica.<br />
15. Ra<strong>di</strong>oattività: Cenni.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso, lezioni ed esercitazioni in aula, con 7 ore settimanali (circa 80 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica frontale), è<br />
sdoppiato: A (G. Natile); B (L. Maresca).<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
La prova d’esame consiste in un elaborato scritto (5 quesiti, alcuni richiedono dei calcoli numerici; tempo<br />
concesso per lo svolgimento: 4 ore). La prova scritta può essere esaustiva della prova d’esame.<br />
Testi consigliati:<br />
G. BANDOLI, A. DOLMELLA, G. NATILE, Chimica <strong>di</strong> base, E<strong>di</strong>SES.
Orario <strong>di</strong> ricevimento: prof.ssa L. Maresca lun., mer., ore 14-16; mar., ore 10-12; prof. G. Natile lun., mar.,<br />
ore 14-16; ven., ore 11-13.
FISICA<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche)<br />
Attività formativa: B (caratterizzante);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare FIS01; cre<strong>di</strong>ti formativi: 7<br />
I Anno, I Semestre<br />
prof. Mauro De Palma<br />
Finalità del Corso<br />
Il Corso è svolto con lo scopo <strong>di</strong> presentare i concetti fondamentali della Fisica classica, adottando un<br />
formalismo matematico non complicato. Maggiore risalto è dato ai principi che sono alla base <strong>di</strong> metodologie<br />
e tecnologie <strong>di</strong> interesse chimico-biologico. Al fine <strong>di</strong> condurre lo studente a riscontrare nella pratica i<br />
concetti fisici espressi nella teoria, per ogni argomento trattato vengono proposte e risolte numericamente<br />
semplici situazioni fisiche.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
Introduzione: grandezze fisiche, vettori.<br />
Cinematica: cinematica del punto, cinematica rotazionale.<br />
Dinamica del punto materiale: le tre leggi del moto, il lavoro <strong>di</strong> una forza, energia cinetica, energia<br />
potenziale, conservazione dell’energia meccanica.<br />
Dinamica dei sistemi principio <strong>di</strong> conservazione della quantità <strong>di</strong> moto, conservazione del momento della<br />
quantità <strong>di</strong> moto, equazione del moto rotatorio intorno ad un asse.<br />
Statica: con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> equilibrio.<br />
Idrostatica: leggi fondamentali, tensione superficiale.<br />
Idro<strong>di</strong>namica: concetti generali sul moto dei flui<strong>di</strong>, viscosità.<br />
Termologia: temperatura e concetto <strong>di</strong> calore.<br />
Termo<strong>di</strong>namica: I e II principio, applicazioni.<br />
Elettrostatica: legge <strong>di</strong> Coulomb, teorema <strong>di</strong> Gauss, potenziale elettrostatico, concetto <strong>di</strong> capacità e<br />
condensatori.<br />
Corrente elettrica: corrente elettrica e legge <strong>di</strong> Ohm.<br />
Magnetismo: forza <strong>di</strong> Lorentz, teorema <strong>di</strong> Ampere.<br />
Elettromagnetismo: induzione, le equazioni <strong>di</strong> Maxwell.<br />
Fenomeni ondulatori: concetto e proprietà generali, potenza ed intensità, onde elastiche, onde<br />
elettromagnetiche.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso, articolato in lezioni ed esercitazioni in aula, è sud<strong>di</strong>viso in moduli monotematici; per almeno 5 ore<br />
<strong>di</strong> lezione e 2 ore <strong>di</strong> esercitazioni settimanali per un totale <strong>di</strong> circa 70 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica frontale.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in una prima prova scritta nella quale si dovranno risolvere numericamente cinque problemi<br />
che richiedono l’in<strong>di</strong>viduazione e l’applicazione <strong>di</strong> una delle leggi della Fisica.<br />
La successiva prova orale, alla quale si accede dopo il superamento della prova scritta, verte essenzialmente<br />
sulla <strong>di</strong>scussione <strong>di</strong> argomenti non trattati nella prima prova.<br />
Testo <strong>di</strong> riferimento:<br />
D. HALLIDAY, Fondamenti <strong>di</strong> Fisica, 5. ed., Ambrosiana.<br />
Testi <strong>di</strong> consultazione:<br />
D.C. GIANCOLI, Fisica, Ambrosiana.<br />
R. SERWAY, Principi <strong>di</strong> Fisica, E<strong>di</strong>SES.<br />
Materiale <strong>di</strong>dattico:<br />
Il Corso si basa sui testi <strong>di</strong> riferimento. Per gli argomenti non presenti sui testi e/o trattati in modo <strong>di</strong>verso, il<br />
materiale <strong>di</strong>dattico usato nelle lezioni è a <strong>di</strong>sposizione <strong>degli</strong> studenti al sito<br />
www.ba.infn.it/~depalma/schemi.htm. I problemi delle prove scritte, i suggerimenti per la loro soluzione ed i<br />
risultati numerici sono proposti al sito www.ba.infn.it/~depalma/ctf.html.
Orario <strong>di</strong> ricevimento: Si articola su 2 ore per 2 giorni la settimana da sincronizzare con l’orario delle lezioni.<br />
MATEMATICA<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche)<br />
Attività formativa A (<strong>di</strong> base);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare MAT/05; cre<strong>di</strong>ti formativi: 6<br />
I Anno, I Semestre<br />
Svolto nel precedente a.a. da:<br />
prof. Enrico Jannelli<br />
Finalità del Corso<br />
Il Corso ha lo scopo <strong>di</strong> fornire il linguaggio matematico e gli strumenti matematici <strong>di</strong> base in<strong>di</strong>spensabili per<br />
la formazione <strong>di</strong> un qualsiasi laureato <strong>di</strong> area scientifica, e in particolare <strong>di</strong> un laureato in Chimica e<br />
Teconologia farmaceutiche.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
Insiemi e numeri reali.<br />
Relazioni e funzioni.<br />
Limiti.<br />
Limiti <strong>di</strong> successioni. Teoremi e operazioni sui limiti. Forme indeterminate. Teoremi <strong>di</strong> confronto. Alcuni<br />
limiti notevoli. Successioni monotone. Il numero e. Limiti <strong>di</strong> funzioni. Intorni. Punti <strong>di</strong> accumulazione.<br />
Principio <strong>di</strong> soppressione <strong>degli</strong> infinitesimi <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne superiore e <strong>degli</strong> infiniti <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne inferiore.<br />
Funzioni continue.<br />
Teoremi sulle funzioni continue: teorema della permanenza del segno, teorema dell’esistenza <strong>degli</strong> zeri,<br />
teorema dell’esistenza dei valori interme<strong>di</strong>, teorema <strong>di</strong> Bolzano-Weierstrass, teorema <strong>di</strong> Weierstrass,<br />
continuità della funzione inversa.<br />
Calcolo <strong>di</strong>fferenziale.<br />
Operazioni sulle derivate. Teoremi fondamentali del calcolo <strong>di</strong>fferenziale: Rolle, Lagrange, Cauchy, De<br />
L’Hopital. Criterio <strong>di</strong> monotonia. Criterio <strong>di</strong> convessità. Formula <strong>di</strong> Taylor con resto <strong>di</strong> Peano. <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o del<br />
grafico <strong>di</strong> una funzione.<br />
L’integrale <strong>di</strong> Riemann.<br />
Teorema della me<strong>di</strong>a integrale. Teorema fondamentale e formula fondamentale del calcolo integrale.<br />
Primitive. L’integrale indefinito. Meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> integrazione.<br />
Alcuni cenni su equazioni <strong>di</strong>fferenziali.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso, articolato in lezioni ed esercitazioni in aula, prevede 5 ore <strong>di</strong> lezione e 2 ore <strong>di</strong> esercitazioni<br />
settimanali, per un totale <strong>di</strong> circa 80 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica frontale.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in una prova scritta, comprendente uno o più esercizi analoghi a quelli svolti durante le<br />
esercitazioni, e riguardanti gli argomenti più significativi del Corso, e in una prova orale, alla quale si accede<br />
previo superamento della prova scritta, consistente nell’esposizione e nella <strong>di</strong>mostrazione <strong>di</strong> teoremi scelti<br />
tra quelli esposti durante le lezioni.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento e materiale <strong>di</strong>dattico:<br />
P. MARCELLINI & C. SBORDONE, Calcolo, Napoli, Liguori.<br />
P. MARCELLINI & C. SBORDONE, Esercizi <strong>di</strong> istituzioni <strong>di</strong> Matematica, (vol. I, parte I e II), Napoli, Liguori.<br />
A. ALVINO, L. CARBONE & G. TROMBETTI, Esercitazioni <strong>di</strong> Matematica, (vol. I, parte I e II), Napoli,<br />
Liguori.<br />
Si vedano, inoltre, le <strong>di</strong>spense del prof. Enrico Jannelli.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: mar., ore 11-13. In altri giorni, previo appuntamento.
ANATOMIA UMANA, PATOLOGIA GENERALE<br />
E TERMINOLOGIA MEDICA<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche)<br />
Attività formativa: A (<strong>di</strong> base) e C (affini o integrativi);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare: BIO/16 e MED/04; cre<strong>di</strong>ti formativi: 8<br />
I Anno, II Semestre<br />
prof. Mauro Coluccia<br />
Finalità del Corso<br />
Il Corso è finalizzato allo stu<strong>di</strong>o dell’Anatomia dei sistemi e <strong>degli</strong> organi, allo stu<strong>di</strong>o dei meccanismi <strong>di</strong> base<br />
delle principali malattie, e alla comprensione dei principi-guida dei proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong>agnostici e terapeutici.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
1. Introduzione alla Patologia generale: cause, meccanismi, effetti, e manifestazioni della malattia. 1.1.<br />
Danno e morte cellulare. 1.2. La risposta dei tessuti al danno: infiammazione acuta e cronica. 1.3. Le<br />
neoplasie.<br />
2. Anatomia dell’apparato car<strong>di</strong>o-vascolare: cuore, vasi sanguigni e linfatici, sangue.<br />
3. Patologia dell’apparato car<strong>di</strong>ovascolare: infarto, aterosclerosi, anemie.<br />
4. Anatomia dell’apparato respiratorio: vie aeree superiori, inferiori, e polmoni.<br />
5. Patologia dell’apparato respiratorio: <strong>di</strong>spnea, malattie infettive, insufficienza respiratoria.<br />
6. Anatomia del sistema <strong>di</strong>gerente: faringe, esofago, stomaco, intestino tenue, intestino crasso, fegato, vie<br />
biliari e cistifellea, pancreas.<br />
7. Patologia del sistema <strong>di</strong>gerente: malattie dello stomaco, malattie dell’intestino tenue e dell’intestino<br />
crasso, malattie del fegato.<br />
8. Anatomia dell’apparato urogenitale: rene, pelvi renale, uretere, vescica; organi dell’apparato genitale<br />
maschile e femminile.<br />
9. Patologia del rene e delle vie urinarie: sindrome nefritica, sindrome nefrosica, principali malattie renali.<br />
10. Anatomia del sistema nervoso: sistema nervoso centrale e periferico, organi <strong>di</strong> senso.<br />
11. Patologia del sistema nervoso: malattie cerebro-vascolari; malattie degenerative; malattie<br />
demielinizzanti.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso prevede 5 ore settimanali con un totale <strong>di</strong> almeno 60 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica frontale.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in una prova scritta nella quale si dovrà rispondere in maniera concisa a 3-5 quesiti <strong>di</strong><br />
carattere generale, e in una successiva prova orale che riguarderà sia gli argomenti trattati nella prova scritta,<br />
sia gli altri argomenti del programma.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento e materiale <strong>di</strong>dattico:<br />
G.M. PONTIERI, Patologia e Fisiopatologia generale, Piccin.<br />
F. CELOTTI, Patologia generale e Fisiopatologia, Napoli, E<strong>di</strong>SES.<br />
J.B. WALTER, Patologia generale e Fisiopatologia, Napoli, E<strong>di</strong>SES.<br />
A. STEVENS, J. LOWE, Patologia, Milano, Ambrosiana.<br />
KHALE, LEONHARD, PLATZER, Anatomia umana, Milano, Ambrosiana.<br />
Tutto il materiale <strong>di</strong>dattico sia su supporto elettronico, che cartaceo, usato nelle lezioni sarà reso <strong>di</strong>sponibile<br />
agli studenti.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: mar., mer., ore 15-16,30.
BIOLOGIA ANIMALE E MICROBIOLOGIA<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche)<br />
Attività formativa: C (affini o integrativi);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare MED/07; cre<strong>di</strong>ti formativi: 9<br />
I Anno, II Semestre<br />
prof. Cesare Vitali<br />
Finalità del Corso<br />
La struttura della vita al livello cellulare e biomolecolare. Il mondo microbico e la microbiologia clinica. Le<br />
<strong>di</strong>fese immunitarie. Prevenzione e terapia antimicrobica. L’obiettivo è fornire una conoscenza delle due<br />
<strong>di</strong>scipline biologiche <strong>di</strong> base volta ad affrontare successive materie caratterizzanti del Corso <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
Biologia animale. Sistema binomiale <strong>di</strong> classificazione, il flusso <strong>di</strong> energia; organismi autotrofi ed eterotrofi.<br />
L’organizzazione della vita: la cellula; cellule procariotiche, cellule eucariotiche, struttura (nucleo cellulare,<br />
organuli citoplasmatici, citoscheletro). Le membrane biologiche, fagocitosi ed endocitosi. Cromosomi,<br />
mitosi e meiosi: l’informazione genetica, ciclo cellulare eucariotico. DNA, RNA, sintesi proteica. Virus e<br />
batteri: i virus come agenti infettivi. Struttura, riproduzione e metabolismo batterico. I patogeni. I batteri nei<br />
processi industriali. Sistema circolatorio dei vertebrati. Il sistema linfatico, immunità umorale e cellulome<strong>di</strong>ata,<br />
fagocitosi. Antigeni, anticorpi, vaccini e vaccinazioni. I sieri immuni, fenomeni <strong>di</strong> ipersensibilità,<br />
l’AIDS.<br />
Microbiologia. Generalità sui microrganismi: eucarioti e procarioti, virus, loro <strong>di</strong>stribuzione in natura.<br />
Microscopio ottico e principi <strong>di</strong> microscopia elettronica. Allestimento <strong>di</strong> preparati per l’esame<br />
batterioscopico. Tecniche colturali, semina e identificazione. Morfologia, struttura e funzione della cellula<br />
batterica. La spora batterica. Tecniche <strong>di</strong> coltivazione. Agenti fisici e chimici nel controllo dei<br />
microrganismi. Chemioterapia antimicrobica. Genetica batterica. Applicazione delle biotecnologie<br />
innovative in farmacologia e me<strong>di</strong>cina. Tecnica del DNA ricombinante. Mutazioni. Biosonde molecolari.<br />
Amplificazione <strong>di</strong> sequenze <strong>di</strong> DNA. Interazione ospite-parassita. Fattori <strong>di</strong> colonizzazione. Esotossine ed<br />
endotossine. Le <strong>di</strong>fese dell’ospite con sistemi non specifici. Generi batterici. Generalità dei virus. Virus della<br />
rosolia, virus delle epatiti A, B, C.<br />
Organizzazione del Corso<br />
I due Corsi integrati sono articolati in lezioni ed esercitazioni per almeno 5 ore settimanali per un totale <strong>di</strong><br />
circa 70 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica frontale.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame prevede una prima prova scritta (facoltativa) nella quale si dovrà rispondere a non meno <strong>di</strong> 100<br />
quesiti a risposta multipla relativi al programma svolto nella prima metà del corso <strong>di</strong> lezioni, integrato da 2<br />
quesiti sui quali si dovrà rispondere in maniera concisa. Alla successiva prova orale si accede con il cre<strong>di</strong>to<br />
derivante dalla valutazione della prova a quiz; nel caso lo studente non abbia superato o non abbia effettuato<br />
l’esame scritto dovrà sostenere l’esame su tutti gli argomenti dei due moduli <strong>di</strong>dattici.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento e materiale <strong>di</strong>dattico:<br />
G. POLI, G. COCUZZA, G. NICOLETTI, M. CLEMENTI, Microbiologia me<strong>di</strong>ca, 2. ed., Torino, UTET.<br />
E.P. SOLOMON, L.R. BERG, D.W. MARTIN, Fondamenti <strong>di</strong> Biologia, 2. ed., Napoli, E<strong>di</strong>SES.<br />
Tutto il materiale <strong>di</strong>dattico usato nelle lezioni e nelle esercitazioni sarà riportato su supporto elettronico e<br />
inserito nei computer dell’aula <strong>di</strong>dattica, a <strong>di</strong>sposizione <strong>degli</strong> studenti con largo anticipo. Sarà fornita anche<br />
una copia cartacea del materiale utilizzato durante lezioni ed esercitazioni, che gli studenti potranno<br />
duplicare a loro spese.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: lun., mar., mer., ore 12-14; ven., ore 11-14.<br />
CHIMICA ANALITICA E COMPLEMENTI DI CHIMICA<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche)<br />
Attività formativa: C (affini o integrativi);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare: CHIM/01 e CHIM/03; cre<strong>di</strong>ti formativi: 8
I Anno, II Semestre<br />
Svolto nel precedente a.a. da:<br />
proff. Carlo Franchini e Carlo Fragale<br />
Finalità del Corso<br />
Avviare alla <strong>di</strong>scussione articolata <strong>degli</strong> equilibri in soluzione, finalizzata alle tematiche analitiche<br />
farmaceutiche; completamento delle nozioni <strong>di</strong> base <strong>di</strong> Chimica generale ed inorganica con riferimenti alle<br />
problematiche ambientali.<br />
Contenuto del Corso<br />
Modulo <strong>di</strong> Complementi <strong>di</strong> Chimica<br />
Cinetica chimica: velocità <strong>di</strong> reazione e or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> reazione. Tempo <strong>di</strong> <strong>di</strong>mezzamento. Datazione con 14 C.<br />
Energia <strong>di</strong> attivazione. Meccanismi <strong>di</strong> reazione. Catalisi omogenea ed eterogenea. Diagrammi <strong>di</strong> stato:<br />
trasformazioni <strong>di</strong> fase, analisi e lettura dei <strong>di</strong>agrammi <strong>di</strong> stato più ricorrenti. Complessi: operazioni <strong>di</strong><br />
simmetria, orbitali atomici e molecolari. Proprietà dei complessi dei metalli <strong>di</strong> transizione. Elettrochimica:<br />
potenziali redox, equazione <strong>di</strong> Nernst. Dipendenza del potenziale redox dal pH. Diagrammi potenziale-pH:<br />
costruzione e lettura. Equilibri eterogenei: equilibri <strong>di</strong> ripartizione, liquido-liquido e liquido-gas (legge <strong>di</strong><br />
Henry). Cenni <strong>di</strong> problematiche ambientali: Formazione ed evoluzione <strong>di</strong> sostanze inquinanti nella atmosfera<br />
e nelle acque. COD e BOD.<br />
Modulo <strong>di</strong> Chimica analitica<br />
Nozioni <strong>di</strong> base in Chimica analitica: la Chimica analitica applicata al dosaggio dei farmaci. Unità <strong>di</strong> misura<br />
ed espressione della concentrazione: concetto <strong>di</strong> mole e definizione <strong>di</strong> soluzione, molarità, molalità,<br />
normalità; composizione percentuale p/p, p/v, v/v, v/p, e loro interconversione. Equilibrio chimico: bilancio<br />
<strong>di</strong> carica, bilancio <strong>di</strong> massa, con<strong>di</strong>zione protonica. Concetto <strong>di</strong> pH e suo calcolo nelle soluzioni <strong>di</strong> vari<br />
elettroliti: soluzioni tampone e loro caratteristiche; pH <strong>di</strong> soluzioni molto <strong>di</strong>luite; solubilità e prodotto <strong>di</strong><br />
solubilità; fattori che influenzano la solubilità; effetto dello ione a comune; influenza del pH; equilibri <strong>di</strong><br />
complessazione; effetto sale e forza ionica del sistema.<br />
Cenni sull’analisi statistica dei dati: uso dei logaritmi; cifre significative e arrotondamento; espressione<br />
corretta del dato analitico, concetto <strong>di</strong> precisione e accuratezza; errori sistematici ed errori casuali; concetti <strong>di</strong><br />
me<strong>di</strong>a e me<strong>di</strong>ana; deviazione standard, errore standard.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso è articolato in due moduli svolti e coor<strong>di</strong>nati dai due docenti della <strong>di</strong>sciplina, per almeno 5 ore<br />
settimanali con un totale <strong>di</strong> circa 60 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica frontale.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in una prova scritta nella quale si dovrà rispondere a semplici quesiti inerenti gli argomenti<br />
svolti durante il Corso. La successiva prova orale, alla quale si accede dopo il superamento della prova<br />
scritta, verte essenzialmente sugli argomenti trattati nella prima prova.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento e materiale <strong>di</strong>dattico:<br />
D.C. HARRIS, Chimica Analitica Quantitativa, Zanichelli. D. SKOOG, D. WEST, Chimica Analitica, E<strong>di</strong>SES.<br />
OXTOBY, NACHTRIEB, FREEMAN, Chimica, E<strong>di</strong>SES. FREISER & FERNANDO, Gli equilibri ionici nella<br />
Chimica analitica, Piccin. SACCO, Chimica, Ambrosiana.<br />
Tutto il materiale <strong>di</strong>dattico usato nelle lezioni e nelle esercitazioni è a <strong>di</strong>sposizione <strong>degli</strong> studenti con largo<br />
anticipo.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: prof. C. Fragale lun., mar., gio., ore 11,30-13; prof. C. Franchini lun., mar., mer., ore<br />
17-19.<br />
BIOLOGIA VEGETALE E FARMACOGNOSIA<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche)<br />
Attività formativa: B (caratterizzante);
settore <strong>di</strong>sciplinare BIO/14; cre<strong>di</strong>ti formativi: 8<br />
II Anno, I Semestre<br />
Svolto nel precedente a.a. da:<br />
prof. Domenico Tricarico<br />
Finalità del Corso<br />
Il Corso ha lo scopo <strong>di</strong> fornire informazioni integrate che riguardano la morfogenesi delle droghe <strong>di</strong> piante<br />
me<strong>di</strong>cinali e preparazione, caratteristiche delle sostanze naturali presenti nelle droghe, le proprietà<br />
farmacologiche ed usi.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
Modulo <strong>di</strong> Biologia Vegetale<br />
1.0 Citologia e organuli cellulari.<br />
2.0 Proteine, aci<strong>di</strong> nucleici, zuccheri, aci<strong>di</strong> grassi, cellulosa, amido.<br />
3.0 Reazioni cataboliche ed anaboliche; fotosintesi; vie biosintetiche <strong>di</strong> flavonoi<strong>di</strong>, alcaloi<strong>di</strong>, terpeni,<br />
antrachinoni, <strong>di</strong>gitalici, tannini, aci<strong>di</strong> grassi, oligosaccari<strong>di</strong> e polisaccari<strong>di</strong>.<br />
4.0 Classificazione delle piante.<br />
5.0 Struttura della pianta: ra<strong>di</strong>ce, fusto e foglie.<br />
Modulo <strong>di</strong> Farmacognosia<br />
6.0 Concetto <strong>di</strong> droga, farmaci <strong>di</strong> origine naturale, concetto <strong>di</strong> fitocomplesso e <strong>di</strong> me<strong>di</strong>camento.<br />
7.0 Fattori che influenzano la produzione delle droghe, meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> produzione <strong>di</strong> droghe.<br />
8.0 Controllo <strong>di</strong> qualità (test biologici e chimici), analisi <strong>di</strong> estratti, preparazioni officinali.<br />
9.0 Proprietà <strong>degli</strong> alcaloi<strong>di</strong>: tropanici, xantinici, tassoli, indolici, benzilisochinolinici e fenantrenici,<br />
imidazolici, piperi<strong>di</strong>nici, purinici; terpenoi<strong>di</strong>; glicosi<strong>di</strong>: antocianici, tannici, flavonici, glucosinati e<br />
solforati, fenolici, cianogenetici, antrachinonici, steroidei, saponinici, cumarinici; carboidrati; grassi ed<br />
olii volatili.<br />
10.0 Piante me<strong>di</strong>cinali e droghe car<strong>di</strong>ovascolari: <strong>di</strong>gitale, china, strofanto, scilla, segale cornuta, rauwolfia,<br />
caffè, tè, ergot, cacao, efedra, tabacco, aglio, ginkgo, veratro, mirtillo; <strong>di</strong>uretiche: caffè, tè, cacao;<br />
antipiretiche ed analgesiche: oppio, capsico, salice; gastroenteriche: liquirizia, camomilla, senna,<br />
frangula, rabarbaro, aloe, ricino, agar, psillio, crusca, castagno, oppio, atropa, physostigma, pilocarpina,<br />
amanita; ad azione sul sistema nervoso: coca, oppio, noce vomica, tabacco, curaro, efedra, cannabis,<br />
melissa, valeriana, passiflora, luppolo, lavanda, atropa, strychnos, cinnamonum camphora, ipperico,<br />
ginseng; balsamiche: pino, eucalipto, timo, lavanda, menta; epatoprotettori: cardo, carciofo;<br />
antitumorali: taxus, catharantus roseus, vinca, podofillum; antinfiammatorie e antisettiche: echinacee,<br />
salice, cinnamonum camphora, colchicum.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Prevede 5 ore settimanali <strong>di</strong> lezioni teoriche organizzate in due moduli: il modulo <strong>di</strong> Biologia vegetale ed il<br />
modulo <strong>di</strong> Farmacognosia.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
Consiste in una prova orale che verte sugli argomenti trattati nei due moduli.<br />
Testi consigliati:<br />
BRUNI, NICOLETTI, Biologia vegetale, Japadre.<br />
TREASE AND EVANS, Farmacognosia, Piccin.<br />
BRUNI, Farmacognosia generale e applicata, Piccin.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: mar., mer., gio., ore 15,30-16,30.
CHIMICA FISICA<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche)<br />
Attività formativa: C (affini o integrativi);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare CHIM/02; cre<strong>di</strong>ti formativi: 8<br />
II Anno, I Semestre<br />
Svolto nel precedente a.a. da:<br />
prof. Francesco Naso<br />
Finalità del Corso<br />
Il Corso è svolto con l’obiettivo <strong>di</strong> fornire all’allievo le basi chimico-fisiche <strong>di</strong> supporto all’appren<strong>di</strong>mento<br />
delle altre <strong>di</strong>scipline (Chimica organica, Chimica farmaceutica, Chimica biologica, etc.) che verranno<br />
incontrate lungo tutto il percorso formativo. I temi privilegiati nella trattazione del Corso, integrati<br />
comunque da vari altri argomenti, sono essenzialmente rappresentati da Termo<strong>di</strong>namica e Cinetica chimica.<br />
Contenuti del Corso<br />
1.0 Le proprietà dei gas.<br />
2.0 Termo<strong>di</strong>namica chimica. 2.1 Le leggi della termo<strong>di</strong>namica: Primo principio della termo<strong>di</strong>namica.<br />
Entalpia. Termochimica. Secondo principio della termo<strong>di</strong>namica ed entropia. Entropie assolute e terzo<br />
principio. Ciclo <strong>di</strong> Carnot. Funzioni energia libera e lavoro massimo. Equazione <strong>di</strong> Gibbs-Helmholtz. 2.2<br />
Cambiamenti <strong>di</strong> stato: Potenziale chimico. Regola delle fasi. Sistemi ad un componente. Equazione <strong>di</strong><br />
Clausius-Clapeyron. 2.3 Soluzioni ed equilibri <strong>di</strong> fase: Soluzioni ideali. Legge <strong>di</strong> Raoult. Abbassamento<br />
del punto <strong>di</strong> congelamento ed innalzamento del punto <strong>di</strong> ebollizione. Pressione osmotica. Effetto della<br />
temperatura sulla solubilità <strong>di</strong> un solido. Soluzioni <strong>di</strong> gas in liqui<strong>di</strong>. Legge <strong>di</strong> Henry. Miscele <strong>di</strong> due<br />
liqui<strong>di</strong>. Distillazione frazionata. Liqui<strong>di</strong> parzialmente miscibili ed immiscibili. Distillazione in corrente<br />
<strong>di</strong> vapore. Distribuzione soluto in due liqui<strong>di</strong> immiscibili. Sistemi gas-solido. Sistemi solido-liquido.<br />
Diagrammi con eutettico. Analisi termica. Formazione <strong>di</strong> composti con punto <strong>di</strong> fusione congruente o<br />
incongruente. Soluzioni solide. Sistemi a tre componenti. 2.4 Termo<strong>di</strong>namica ed equilibrio chimico:<br />
Energia libera standard e costanti <strong>di</strong> equilibrio. Equilibri in sistemi non ideali. Fugacità ed attività. 2.5<br />
Elettrochimica: Elettrolisi e sue leggi. Celle galvaniche. Potenziale all'elettrodo ed equazione <strong>di</strong> Nerst.<br />
Calcolo della costante <strong>di</strong> equilibrio in reazioni <strong>di</strong> ossido- riduzione. Misura pH.<br />
3.0 Cinetica chimica: Velocità <strong>di</strong> reazione. Reazioni <strong>di</strong> I, II e III or<strong>di</strong>ne. Pseudo-or<strong>di</strong>ne. Equazione <strong>di</strong><br />
Arrhenius. Teoria delle reazioni unimolecolari e bimolecolari in fase gassosa. Teoria dello stato <strong>di</strong><br />
transizione. Entalpia ed entropia <strong>di</strong> attivazione. Reazioni complesse (parallele; consecutive; reversibili).<br />
Catalisi omogenea. Catalisi acida e basica. Equazione <strong>di</strong> Brønsted. Funzione <strong>di</strong> aci<strong>di</strong>tà Ho. Effetto sale<br />
primario. Catalisi eterogenea. Catalisi enzimatica.<br />
4.0 Aspetti generali relativi alle proprietà dei liqui<strong>di</strong> e dei soli<strong>di</strong>.<br />
5.0 Sistemi <strong>di</strong>spersi: Colloi<strong>di</strong>. Micelle. Emulsioni.<br />
6.0 Il legame chimico: Teoria del legame <strong>di</strong> valenza. Orbitali molecolari. Applicazioni del metodo LCAO.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso è organizzato in lezioni ed in esercitazioni in aula. L’impegno orario settimanale è <strong>di</strong> 5 ore <strong>di</strong><br />
lezione e <strong>di</strong> 1 ora <strong>di</strong> esercitazione per un totale <strong>di</strong> circa 70 ore <strong>di</strong> attività <strong>di</strong>dattica frontale.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame è costituito da una prova orale che ha come obiettivo principale quello <strong>di</strong> valutare la capacità <strong>degli</strong><br />
studenti <strong>di</strong> calcolare ed applicare le funzioni termo<strong>di</strong>namiche ed i parametri cinetici relativi ai processi<br />
chimici.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento:<br />
P.W. ATKINS, Elementi <strong>di</strong> Chimica fisica, Bologna, Zanichelli, 1994. A. GAVEZZOTTI, Principi <strong>di</strong> Chimica<br />
fisica, Milano, Ambrosiana, 1993. M. CAPITELLI, R. CELIBERTO, S. LONGO, Fondamenti <strong>di</strong> Chimica:<br />
Termo<strong>di</strong>namica e Cinetica chimica, 2. ed., Adriatica, 2001.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: lun., ore 11-13; mar., ore 12-13; gio., 10-12.<br />
CHIMICA ORGANICA I<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche)<br />
Attività formativa: A (<strong>di</strong> base);
settore <strong>di</strong>sciplinare CHIM/06; cre<strong>di</strong>ti formativi: 8<br />
II Anno, I Semestre<br />
prof. Leonardo Di Nunno<br />
Finalità del Corso<br />
Il Corso è svolto tenendo in particolare considerazione le caratteristiche <strong>di</strong> base dell’insegnamento e le<br />
finalità del Corso <strong>di</strong> laurea al quale si riferisce. Una particolare attenzione è rivolta alla comprensione, oltre<br />
che <strong>di</strong> tutti gli aspetti concernenti la struttura e la stereochimica delle molecole organiche, anche dei più<br />
significativi meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> sintesi e dei più importanti meccanismi <strong>di</strong> reazione.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
Descrizione generale dell’atomo: struttura elettronica. Proprietà atomiche. Definizione <strong>di</strong> legame. Tipi <strong>di</strong><br />
legame. La costituzione <strong>di</strong> alcune piccole molecole. Strutture <strong>di</strong> Lewis e carica formale. Alcune proprietà dei<br />
legami covalenti. Teoria della repulsione delle coppie <strong>di</strong> legame del guscio <strong>di</strong> valenza. Ibridazione. Aci<strong>di</strong> e<br />
basi <strong>di</strong> Lewis: il legame covalente coor<strong>di</strong>nato. La risonanza. Gruppi funzionali più comuni. Alcani: struttura,<br />
nomenclatura, reattività, sintesi. Stereoisomeria nei derivati alchilici. Centro chirale (stereocentro):<br />
definizione, rappresentazioni. Configurazione relativa ed assoluta. Composti con più centri chirali. Sintesi <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>astereoisomeri me<strong>di</strong>ante alogenazione ra<strong>di</strong>calica. Risoluzione ottica. Classificazione <strong>degli</strong> isomeri.<br />
Alogenuri alchilici. La reazione SN2 e SN1. I carbocationi. Nucleofilo, elettrofilo: definizione.<br />
Classificazione delle reazioni <strong>di</strong> eliminazione. Reazioni E2 ed El. Reazioni ElcB. I reattivi <strong>di</strong> Grignard ed<br />
altri composti organometallici. Sistemi ciclici: nomenclatura, la forma <strong>degli</strong> anelli, forme <strong>di</strong> tensione.<br />
Ciclobutano, ciclopentano, cicloesano. Isomeria nei derivati dei cicloalcani. Sistemi policiclici ad anelli<br />
condensati, isolati, a ponte. Relazione fra struttura <strong>degli</strong> anelli e reattività. Stereochimica nei sistemi ciclici.<br />
Alcheni: nomenclatura, isomeria. Stabilità relativa <strong>degli</strong> alcheni isomeri. Riduzione dei doppi legami.<br />
Ad<strong>di</strong>zioni elettrofile ai doppi legami. Reazioni <strong>di</strong> ad<strong>di</strong>zione ra<strong>di</strong>calica. Polimerizzazione <strong>degli</strong> alcheni.<br />
Ossidazione dei doppi legami. Carbeni: loro struttura e reazioni con alcheni. Alchini: nomenclatura, aci<strong>di</strong>tà<br />
<strong>degli</strong> alchini terminali, sintesi e reattività. Alcooli: proprietà fisiche, nomenclatura, sintesi e reattività. Eteri,<br />
epossi<strong>di</strong> e <strong>di</strong>oli: sintesi e reattività. Sintesi organica. Programmazione <strong>di</strong> una sintesi (analisi retrosintetica).<br />
Sintesi asimmetrica. Dieni. Aromaticità. Il benzene. Gli annuleni e la regola <strong>di</strong> Huckel. Ioni aromatici.<br />
Idrocarburi aromatici polinucleari. Sostituzione elettrofila aromatica. Sostituzione nucleofila aromatica.<br />
Aldei<strong>di</strong> e chetoni: nomenclatura, sintesi e reattività. Aci<strong>di</strong> carbossilici e loro derivati. Ammine e composti<br />
arilici azotati: nomenclatura. Proprietà delle ammine. Sintesi delle ammine. Reazioni delle ammine. Sali <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>azonio. Fenoli: proprietà, sintesi e reazioni. Chinoni.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso, articolato in lezioni ed esercitazioni in aula è svolto per almeno 6 ore settimanali con un totale <strong>di</strong><br />
almeno 60 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica frontale.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in una prova orale su tutti gli argomenti trattati, generalmente su 3 <strong>di</strong>stinti quesiti. L’esame<br />
include, oltre alla trattazione <strong>degli</strong> argomenti, anche lo svolgimento <strong>di</strong> opportuni esercizi connessi con gli<br />
stessi argomenti.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento:<br />
W.H. BROWN, C.S. FOOTE, Chimica organica, Napoli, E<strong>di</strong>SES.<br />
R.T. MORRISON, R.N. BOYD, Chimica organica, Milano, CEA.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: lun., mer., ore 15,30-17,30; mar., 9,30-11,30.<br />
ANALISI DEI MEDICINALI (Corso A)<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche)<br />
Attività formativa: A (<strong>di</strong> base);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare: CHIM/08; cre<strong>di</strong>ti formativi: 10<br />
II Anno, II Semestre<br />
prof. Giovanni Lentini
Finalità del Corso<br />
Iniziazione all’arte <strong>di</strong> riconoscere le <strong>di</strong>verse sostanze e <strong>di</strong> determinare i loro costituenti (W. Ostwald, 1894)<br />
con particolare enfasi sull’analisi qualitativa <strong>degli</strong> xenobiotici inorganici, sia per la parte teorica sia per la<br />
parte <strong>di</strong> laboratorio. Esercizi <strong>di</strong> problem solving atti ad interessare lo studente e a svilupparne l’attitu<strong>di</strong>ne al<br />
processo induttivo-deduttivo.<br />
Contenuti del Corso per argomenti<br />
Principi chimici fondamentali dell’analisi qualitativa. Reazioni specifiche ed analisi sistematica. I gruppi<br />
analitici dei cationi.<br />
Generalità sulle operazioni <strong>di</strong> laboratorio. Apparecchiature per l’analisi. Il bunsen: caratteristiche della<br />
fiamma. Precipitazione e separazione <strong>di</strong> un precipitato: filtrazione e centrifugazione. La centrifuga. Solubilità<br />
<strong>di</strong> un solido e <strong>di</strong>pendenza da fattori chimico-fisici. Riconoscimento dei principali ioni inorganici.<br />
Analisi dei cationi. Via secca. Spettri <strong>di</strong> emissione: riconoscimento <strong>degli</strong> ioni Li + , Na + , K + , Ca 2+ , Sr 2+ , Ba 2+ ,<br />
Cu 2+ . Analisi allo stato fuso: perle al borace ed alcalino ossidanti. Analisi in soluzione. Sud<strong>di</strong>visione in<br />
gruppi analitici e precipitazione, separazione ed identificazione <strong>degli</strong> ioni Ag + , Pb 2+ , Hg2 2+ As 3+/5+ , Sb 3+/5+ ,<br />
Hg 2+ , Bi 3+ , Cd 2+ , Cu 2+ , Al 3+ , Fe 2+ , Cr 3+ , Mn 2+ , Zn 2+ , Co 2+ , Ni 2+ , NH4 + .<br />
Analisi <strong>degli</strong> anioni. Via secca: (CHOHCO2)2 2– , CO3 2– , CH3CO2 2– , S 2– , SO3 2– . La soluzione alcalina.<br />
Riconoscimento dei più comuni anioni: S2O3 2– SO4 2– , AsO4 3– , Cl – , Br – , I – , NO2 – , NO3 – , C2O4 2– .<br />
Equilibri contemporanei e calcolo della costante <strong>di</strong> equilibrio. Interconversione. Fattori che influenzano la<br />
solubilità: effetto ione a comune, pH, complessazione, precipitazione frazionata.<br />
Distribuzione delle specie <strong>di</strong> un acido debole in funzione del pH.<br />
Idrossi<strong>di</strong> anfoteri. Concetti <strong>di</strong> sicurezza: sistemi <strong>di</strong> sicurezza in un laboratorio chimico. Incen<strong>di</strong> e sistemi<br />
antincen<strong>di</strong>o. Estintori, maschere.<br />
Elementi <strong>di</strong> tossicologia: campi tossicologici, scopi, stu<strong>di</strong>o quali e quantitativo dell’effetto tossico <strong>di</strong> una<br />
sostanza chimica (vie <strong>di</strong> esposizione, relazione, dose, effetto, test <strong>di</strong> tossicità acuta, subacuta e cronica,<br />
valutazione del rischio, valori limite). Effetti combinati delle sostanze chimiche: determinazione e controllo<br />
dei danni provocati all’organismo. Aspetti farmaceutici e tossicologici dei metalli: trattamento delle<br />
intossicazioni da metalli, agenti chelanti. Proprietà, usi, sali usati in terapia, attività farmacologica e<br />
tossicologica, preparati farmaceutici in commercio, effetti collaterali, in<strong>di</strong>cazioni terapeutiche <strong>di</strong>: Ag, Pb,<br />
Hg, Bi, As, Cd, Cu, Zn, Co, Ni, Al, Cr, Fe, Na, Ca, Mg, Li, Sb, Mn, K. Gas tossici. Fibre minerali.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Lezioni, esercitazioni in aula e in laboratorio per un totale <strong>di</strong> 90 ore.<br />
Esame finale<br />
Colloquio orale con <strong>di</strong>scussione delle prove pratiche eseguite in laboratorio e risoluzione numerica <strong>di</strong><br />
problemi ed esercizi.<br />
Testi consigliati:<br />
A. ARANEO, Chimica Analitica Qualitativa, Milano, Ambrosiana, 1993.<br />
D.C. HARRIS, Chimica Analitica Quantitativa, Bologna, Zanichelli, 1991.<br />
D.C. HARRIS, Elementi <strong>di</strong> Chimica Analitica, Bologna, Zanichelli, 1999.<br />
T.R. HOGNESS, W.C. JOHNSON, A.R. ARMSTRONG, Analisi Qualitativa ed Equilibrio Chimico, Padova,<br />
Piccin, 1972.<br />
J. EMSLEY, Prodotti Chimici: Guida per il Consumatore, Bologna, Zanichelli, 2000.<br />
Orari <strong>di</strong> ricevimento: lun. e ven., ore 9,30-12,30.<br />
ANALISI DEI MEDICINALI (Corso B)<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche)<br />
Attività formativa: A (<strong>di</strong> base);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare: CHIM/08; cre<strong>di</strong>ti formativi: 10<br />
I Anno, II Semestre<br />
Svolto nel precedente a.a. da:<br />
prof. Filomena Corbo
Finalità del Corso<br />
Iniziazione all’arte <strong>di</strong> riconoscere le <strong>di</strong>verse sostanze e <strong>di</strong> determinare i loro costituenti (W. Ostwald, 1894)<br />
con particolare enfasi sull’analisi qualitativa <strong>degli</strong> xenobiotici inorganici, sia per la parte teorica sia per la<br />
parte <strong>di</strong> laboratorio. Esercizi <strong>di</strong> problem solving atti ad interessare lo studente e a svilupparne l’attitu<strong>di</strong>ne al<br />
processo induttivo-deduttivo.<br />
Contenuti del Corso per argomenti<br />
Principi chimici fondamentali dell’analisi qualitativa. Reazioni specifiche ed analisi sistematica. I gruppi<br />
analitici dei cationi.<br />
Generalità sulle operazioni <strong>di</strong> laboratorio. Apparecchiature per l’analisi. Il bunsen: caratteristiche della<br />
fiamma. Precipitazione e separazione <strong>di</strong> un precipitato: filtrazione e centrifugazione. La centrifuga. Solubilità<br />
<strong>di</strong> un solido e <strong>di</strong>pendenza da fattori chimico-fisici. Riconoscimento dei principali ioni inorganici.<br />
Analisi dei cationi. Via secca. Spettri <strong>di</strong> emissione: riconoscimento <strong>degli</strong> ioni Li + , Na + , K + , Ca 2+ , Sr 2+ , Ba 2+ ,<br />
Cu 2+ . Analisi allo stato fuso: perle al borace ed alcalino ossidanti. Analisi in soluzione. Sud<strong>di</strong>visione in<br />
gruppi analitici e precipitazione, separazione ed identificazione <strong>degli</strong> ioni Ag + , Pb 2+ , Hg2 2+ As 3+/5+ , Sb 3+/5+ ,<br />
Hg 2+ , Bi 3+ , Cd 2+ , Cu 2+ , Al 3+ , Fe 2+ , Cr 3+ , Mn 2+ , Zn 2+ , Co 2+ , Ni 2+ , NH4 + .<br />
Analisi <strong>degli</strong> anioni. Via secca: (CHOHCO2)2 2– , CO3 2– , CH3CO2 2– , S 2– , SO3 2– . La soluzione alcalina.<br />
Riconoscimento dei più comuni anioni: S2O3 2– SO4 2– , AsO4 3– , Cl – , Br – , I – , NO2 – , NO3 – , C2O4 2– .<br />
Equilibri contemporanei e calcolo della costante <strong>di</strong> equilibrio. Interconversione. Fattori che influenzano la<br />
solubilità: effetto ione a comune, pH, complessazione, precipitazione frazionata.<br />
Distribuzione delle specie <strong>di</strong> un acido debole in funzione del pH.<br />
Idrossi<strong>di</strong> anfoteri. Concetti <strong>di</strong> sicurezza: sistemi <strong>di</strong> sicurezza in un laboratorio chimico. Incen<strong>di</strong> e sistemi<br />
antincen<strong>di</strong>o. Estintori, maschere.<br />
Elementi <strong>di</strong> tossicologia: campi tossicologici, scopi, stu<strong>di</strong>o quali e quantitativo dell’effetto tossico <strong>di</strong> una<br />
sostanza chimica (vie <strong>di</strong> esposizione, relazione, dose, effetto, test <strong>di</strong> tossicità acuta, subacuta e cronica,<br />
valutazione del rischio, valori limite). Effetti combinati delle sostanze chimiche: determinazione e controllo<br />
dei danni provocati all’organismo. Aspetti farmaceutici e tossicologici dei metalli: trattamento delle<br />
intossicazioni da metalli, agenti chelanti. Proprietà, usi, sali usati in terapia, attività farmacologica e<br />
tossicologica, preparati farmaceutici in commercio, effetti collaterali, in<strong>di</strong>cazioni terapeutiche <strong>di</strong>: Ag, Pb,<br />
Hg, Bi, As, Cd, Cu, Zn, Co, Ni, Al, Cr, Fe, Na, Ca, Mg, Li, Sb, Mn, K. Gas tossici. Fibre minerali.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Lezioni, esercitazioni in aula e in laboratorio per un totale <strong>di</strong> 90 ore.<br />
Esame finale<br />
Colloquio orale con <strong>di</strong>scussione delle prove pratiche eseguite in laboratorio e risoluzione numerica <strong>di</strong><br />
problemi ed esercizi.<br />
Testi consigliati:<br />
A. ARANEO, Chimica Analitica Qualitativa, Milano, Ambrosiana, 1993.<br />
D.C. HARRIS, Chimica Analitica Quantitativa, Bologna, Zanichelli, 1991.<br />
D.C. HARRIS, Elementi <strong>di</strong> Chimica Analitica, Bologna, Zanichelli, 1999.<br />
T.R. HOGNESS, W.C. JOHNSON, A.R. ARMSTRONG, Analisi Qualitativa ed Equilibrio Chimico, Padova,<br />
Piccin, 1972.<br />
J. EMSLEY, Prodotti Chimici: Guida per il Consumatore, Bologna, Zanichelli, 2000.<br />
Orari <strong>di</strong> ricevimento: lun., mar., gio., ore 10-11.<br />
BIOCHIMICA APPLICATA<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche)<br />
Attività formativa: B (caratterizzante);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare BIO/10; cre<strong>di</strong>ti formativi: 9<br />
III Anno, II Semestre<br />
prof. Vito Iacobazzi
Finalità del Corso<br />
Il Corso intende fornire una conoscenza sugli aspetti applicativi della Biochimica, della Biologia molecolare<br />
e dell’Immunochimica con particolare riferimento agli aspetti chimico-farmaceutici.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
Specificità biochimiche <strong>di</strong> organi e tessuti e loro interrelazioni. Metabolismo dei tessuti in con<strong>di</strong>zioni<br />
fisiologiche <strong>di</strong>verse. Basi biochimiche delle più comuni patologie metaboliche e genetiche. Glicemia e<br />
<strong>di</strong>abete. Ormoni coinvolti nel controllo della glicemia. Trasportatori del glucosio. Colesterolemia e<br />
ipercolesterolemia. Fosfolipi<strong>di</strong> e trigliceri<strong>di</strong> plasmatici. Alterazioni del metabolismo dell’azoto. Secon<strong>di</strong><br />
messaggeri. Biochimica del sangue e alterazioni. Enzimi nella <strong>di</strong>agnostica clinica. Biochimica e metabolismo<br />
<strong>di</strong> sostanze estranee all’organismo (farmaci, ad<strong>di</strong>tivi, inquinanti ambientali, etc.). <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o delle proteine:<br />
determinazione N- e C- terminale, sequenza, purificazione. Gel elettroforesi. DNA ricombinante. Enzimi <strong>di</strong><br />
restrizione. Mappe <strong>di</strong> restrizione. Separazione <strong>di</strong> frammenti. Blotting (Southern, Northern blots). Ibridazione.<br />
Marcatura <strong>di</strong> sonde <strong>di</strong> DNA. Diagnosi <strong>di</strong> malattie genetiche e analisi <strong>di</strong> DNA. Sequenziamento del DNA.<br />
PCR: principio e applicazioni. Clonaggio. Vettori <strong>di</strong> clonaggio. DNA ligasi. Sintesi <strong>di</strong> cDNA. Librerie <strong>di</strong><br />
cDNA e genomiche. Isolamento <strong>di</strong> geni clonati. Cellule procariotiche, lieviti, funghi e cellule umane: meto<strong>di</strong><br />
<strong>di</strong> coltura. Selezione <strong>di</strong> ceppi. Vettori <strong>di</strong> espressione. Espressione <strong>di</strong> proteine. Geni reporter. Identificazione e<br />
stu<strong>di</strong>o delle sequenze regolatrici. Mutazione sito specifica. Caratterizzazione delle proteine ricombinanti.<br />
Proteine <strong>di</strong> fusione. Biochimica e Biologia molecolare industriale. Biochimica delle cellule cancerose.<br />
Oncogeni: meccanismi <strong>di</strong> attivazione.<br />
Sistema immunitario e risposte immunitarie. Linfociti B e linfociti T. Selezione clonale. Antigeni e<br />
determinanti antigenici. Specificità e memoria immunologica. Anticorpi monoclonali. Struttura e classi <strong>di</strong><br />
anticorpi. Recettori per le cellule T. Proteine MHC: struttura e funzioni. Cellule T helper e T citotossiche.<br />
Attivazione delle cellule T helper. Proteine CD. Interleuchine. Patologie del sistema immunitario. Tecniche<br />
immunologiche: ELISA, RIA, chemiluminescenza. Impiego <strong>di</strong> Ab monoclonali in <strong>di</strong>agnostica e nella terapia.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso è articolato in lezioni ed esercitazioni <strong>di</strong>mostrative <strong>di</strong> Biologia molecolare in laboratorio. Si svolge<br />
per almeno 5 ore settimanali con un totale <strong>di</strong> circa 60 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica frontale.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in una prova orale sugli argomenti del Corso e del laboratorio.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento e materiale <strong>di</strong>dattico:<br />
CALDARERA, Biochimica sistematica umana, Clueb.<br />
WATSON, DNA ricombinante, Zanichelli.<br />
WILSON, Biochimica applicata, Cortina.<br />
ALBERTS, Biologia molecolare della cellula (cap.: Sistema immunitario), Zanichelli.<br />
GLICK, PASTERNAK, Biotecnologia molecolare, Zanichelli.<br />
Tutto il materiale <strong>di</strong>dattico usato nelle lezioni e nelle esercitazioni sarà riportato su supporto elettronico e<br />
inserito nei computer dell’aula <strong>di</strong>dattica, a <strong>di</strong>sposizione <strong>degli</strong> studenti con largo anticipo.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: mer., ore 10-12; gio., ore 16-18.
FISIOLOGIA GENERALE<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche)<br />
Attività formativa: C (affini o integrativi);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare BIO/09; cre<strong>di</strong>ti formativi: 8<br />
II Anno, II Semestre<br />
prof. Vito Scalera<br />
Finalità del Corso<br />
Conoscenza dei processi (biofisici, funzionali) delle membrane biologiche. <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o delle funzioni<br />
specializzate delle singole cellule. Conoscenza dei meccanismi <strong>di</strong> omeostasi a livello molecolare, cellulare e<br />
tessutale. <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o delle funzioni integrate <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi organi ed apparati e dei meccanismi <strong>di</strong> regolazione e<br />
controllo.<br />
Contenuto del Corso per argomenti (per maggiori dettagli):<br />
www.biologia.uniba.it/dfga/<strong>di</strong>dattica/pro_farmaceu.html)<br />
Membrane cellulari ed epiteliali. Trasporti per esocitosi ed endocitosi. Diffusione: libera e in membrane<br />
biologiche. Osmosi: Legge <strong>di</strong> Vant’Hoff. Coefficiente <strong>di</strong> riflessione. Flusso <strong>di</strong> acqua (<strong>di</strong>ffusionale e <strong>di</strong><br />
massa). Trascinamento <strong>di</strong> soluti. Trasporto facilitato ed attivo. Legge <strong>di</strong> Nernst e <strong>di</strong> Nernst-Planck. Legge <strong>di</strong><br />
Hodgkin-Katz. Potenziale <strong>di</strong> membrana. Trasporto attraverso canali. Selettività dei canali <strong>di</strong> membrana.<br />
Canali <strong>di</strong>pendenti da voltaggio, sostanze chimiche e da stimoli meccanici. Proprietà e caratteristiche dei<br />
neuroni. Comunicazione elettrica: Potenziali locali e <strong>di</strong> d’azione. Legge delle conduttanze. Proprietà passive<br />
e conduzione nelle fibre nervose. Accomodazione e refrattarietà. Sinapsi: elettriche e chimiche. Sinapsi<br />
neuromuscolare. Neurotrasmettitori e neuromodulatori. Neuroni centrali e co<strong>di</strong>ficazione. Recettori sensoriali:<br />
Tipi <strong>di</strong> recettori e loro funzioni. Classificazione e proprietà generali. Stimolo adeguato. Processo <strong>di</strong><br />
traduzione, co<strong>di</strong>ficazione e adattamento. Propriocettori. Recettori labirintici e cocleari. Funzione<br />
dell’orecchio me<strong>di</strong>o e interno. Fotorecettori. Adattamento alla luce e al buio. Riflessi monosinaptici e<br />
polisinaptici. Riflesso mioatico e ten<strong>di</strong>neo. Sistema nervoso autonomo. Me<strong>di</strong>atori chimici pre e postgangliari.<br />
Recettori adrenergici e colinergici. Muscolo: striato, car<strong>di</strong>aco e liscio. Struttura, citologia ed<br />
innervazione dei <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> muscolo. Contrazione muscolare e tono nei <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> muscolo. Muscolo<br />
car<strong>di</strong>aco. Struttura anatomica. Manifestazioni elettriche del cuore. Proprietà meccaniche: basi molecolari<br />
della contrazione, accoppiamento eccitazione contrazione. Ciclo car<strong>di</strong>aco. Forza e lavoro del cuore.<br />
Extrasistole. Regolazione dell’attività car<strong>di</strong>aca: Intrinseca ed estrinseca. Sistema circolatorio. Caratteristiche<br />
del piccolo e del grande circolo. Emo<strong>di</strong>namica. Determinanti della pressione arteriosa. Meccanismi <strong>di</strong><br />
controllo a breve, me<strong>di</strong>o e lungo termine. Sistema respiratorio. Funzioni delle vie aeree e <strong>degli</strong> alveoli.<br />
Ventilazione. Diffusione dei gas respiratori. Trasporto dell’O2 e della CO2. Controllo della ventilazione.<br />
Sistema renale. Compartimenti idrici dell’organismo. Struttura e funzione del rene. Filtrazione,<br />
riassorbimento e secrezioni tubulari. Clearance. Trasporto massimo e soglia renale <strong>di</strong> escrezione.<br />
Meccanismo renale <strong>di</strong> concentrazione e <strong>di</strong>luizione dell’urina. Fattori che regolano la <strong>di</strong>uresi. Equilibrio<br />
acido-base dell’organismo. Apparato gastro-intestinale. Secrezioni. Controllo della motilità e delle<br />
secrezioni. Digestione dei carboidrati dei lipi<strong>di</strong> e delle proteine. Processi <strong>di</strong> assorbimento nell’intestino tenue<br />
e crasso. Sistema endocrino. Meccanismi <strong>di</strong> traduzione dei segnali ormonali: secon<strong>di</strong> messaggeri e vie <strong>di</strong><br />
trasduzione. Ormoni ipofisari. Controllo ipotalamo-ipofisario della secrezione ormonale. Controllo della<br />
calcemia e glicemia.<br />
Organizzazione del Corso ed esame finale<br />
Il Corso è articolato in lezioni ed esercitazioni in aula (circa 60 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica frontale). L’esame consiste in<br />
una prova orale.<br />
Testi consigliati:<br />
R.M. BERNE, M.N. LEVY, Fisiologia, CEA.<br />
SILVERTHORN, Fisiologia, CEA.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: mer., gio., ore 16-17,30.<br />
ANALISI DEI FARMACI I<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche)
Attività formativa: B (caratterizzante);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare CHIM/08; cre<strong>di</strong>ti formativi: 10<br />
III Anno, I Semestre<br />
proff. Carla Cellucci e Fulvio Loio<strong>di</strong>ce<br />
Finalità del Corso<br />
Il Corso si prefigge <strong>di</strong> guidare lo studente nella complessa e <strong>di</strong>versificata analisi, sotto il profilo quantitativo,<br />
<strong>di</strong> sostanze <strong>di</strong> interesse farmaceutico; esso abbraccia un campo poliedrico che porta lo studente dalla mera<br />
operazione matematica alla valutazione personale delle problematiche connesse all’analisi e alla valutazione<br />
statistica dei dati finali.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
Bilancia analitica, elettronica. Incertezze nelle misure strumentali. Errori in un’analisi: sistematici, casuali e<br />
trattamento <strong>degli</strong> stessi. Rappresentazione dei dati. Valori caratteristici, valori <strong>di</strong> tendenza centrale, in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong><br />
precisione (deviazione, me<strong>di</strong>a, range, deviazione standard, varianza, intervallo interquantile). Espressioni <strong>di</strong><br />
concentrazione: Molarità, Normalità, Concentrazioni percentuali, Parti per milione. Volumetrica <strong>di</strong><br />
neutralizzazione. Teoria dell’in<strong>di</strong>catore. Curve <strong>di</strong> titolazione: acido forte/base forte, acido debole/base forte e<br />
specie inverse. Titolazioni <strong>di</strong> miscele <strong>di</strong> aci<strong>di</strong> e <strong>di</strong> basi. Errore associato all’in<strong>di</strong>catore nelle titolazioni.<br />
Volumetrica <strong>di</strong> precipitazione. In<strong>di</strong>catori nelle titolazioni <strong>di</strong> precipitazione. Meto<strong>di</strong>che <strong>di</strong> Mohr, Volhard,<br />
Fajans. Curve <strong>di</strong> titolazione, calcoli relativi. Volumetrica <strong>di</strong> complessazione. In<strong>di</strong>catori nelle titolazioni<br />
complessometriche. Curve <strong>di</strong> titolazione, calcoli relativi. Importanza del pH nelle titolazioni<br />
complessometriche. Costante con<strong>di</strong>zionale. Titolazioni <strong>di</strong>rette, in<strong>di</strong>rette e <strong>di</strong> spostamento. Volumetrica <strong>di</strong><br />
ossido/riduzione. In<strong>di</strong>catori. Curve <strong>di</strong> titolazione, calcoli relativi. Uso <strong>di</strong> titolanti ossidanti e riducenti<br />
(permanganato, io<strong>di</strong>o, bromo). Potenziometria. Elettro<strong>di</strong> <strong>di</strong> riferimento. Elettro<strong>di</strong> in<strong>di</strong>catori: metallici, a<br />
membrana liquida, a membrana cristallina, a vetro. Misure potenziometriche <strong>di</strong>rette e in<strong>di</strong>rette.<br />
Conduttometria. Misure conduttimetriche <strong>di</strong>rette. Titolazioni conduttimetriche. Voltammmetria. Polarografia<br />
classica, ad impulsi, ad impulso <strong>di</strong>fferenziale. Titolazioni amperometriche e biamperometriche.<br />
Spettrofotometria. Trasmittanza e Assorbanza. Legge <strong>di</strong> Lambert-Beer. Misure spettrofotometriche <strong>di</strong>rette.<br />
Analisi <strong>di</strong> miscele. Analisi in derivata. Titolazioni spettrofotometriche. Spettrofotometri a singolo e doppio<br />
raggio. Fluorimetria. Principi. Strumentazione. Applicazioni.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso è sud<strong>di</strong>viso in moduli monotematici svolti e coor<strong>di</strong>nati dai due docenti della <strong>di</strong>sciplina ed è<br />
articolato in almeno 5 ore settimanali <strong>di</strong> teoria ed altrettante <strong>di</strong> esercitazioni <strong>di</strong> laboratorio per un totale <strong>di</strong><br />
circa 120 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica frontale.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in una prova scritta <strong>di</strong> tipo numerico volta ad accertare la capacità, da parte dello studente,<br />
<strong>di</strong> risoluzione dei problemi inerenti le <strong>di</strong>verse meto<strong>di</strong>che analitiche. La suddetta prova scritta è preliminare<br />
ed integrativa al colloquio orale.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento e materiale <strong>di</strong>dattico:<br />
D.A. SKOOG, D.M. WEST, F.J. HOLLER, Fondamenti <strong>di</strong> Chimica analitica, Napoli, E<strong>di</strong>SES, 1998.<br />
R. COZZI, P. PROTTI, T. RUARO, Analisi Chimica strumentale, Bologna, Zanichelli, 1997.<br />
Parte del materiale <strong>di</strong>dattico è <strong>di</strong>sponibile nei computer dell’aula <strong>di</strong>dattica.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: lun., mar., mer., ore 11-12.
CHIMICA ORGANICA II<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche)<br />
Attività formativa: A (<strong>di</strong> base);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare: CHIM/06; cre<strong>di</strong>ti formativi: 8<br />
III Anno, I Semestre<br />
prof. Saverio Florio<br />
Finalità del Corso<br />
Vengono approfon<strong>di</strong>ti alcuni concetti fondamentali già sviluppati nel Corso <strong>di</strong> Organica I e stu<strong>di</strong>ate nuove<br />
reazioni organiche. Particolare attenzione viene rivolta alla sintesi organica seguendo l’approccio della<br />
retrosintesi. Oggetto <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o sono anche alcune categorie <strong>di</strong> prodotti naturali quali amminoaci<strong>di</strong>, pepti<strong>di</strong>,<br />
carboidrati, nucleosi<strong>di</strong> e nucleoti<strong>di</strong>, composti eterociclici dei quali si stu<strong>di</strong>ano sia la sintesi che la reattività.<br />
Contenuti del Corso per argomenti<br />
Sintesi Organica: sintesi <strong>di</strong> vari tipi <strong>di</strong> molecole organiche seguendo l’approccio della retrosintesi: significato<br />
<strong>di</strong> sintone, <strong>di</strong>sconnessione e trasformazione <strong>di</strong> gruppi funzionali. Meto<strong>di</strong> per ottenere molecole otticamente<br />
pure: risoluzione ottica e risoluzione cinetica, sintesi asimmetrica: <strong>di</strong>astereo ed enantioselezione. Sintesi<br />
organiche me<strong>di</strong>ate da complessi <strong>di</strong> metalli <strong>di</strong> transizione.<br />
Amminoaci<strong>di</strong>: struttura, sintesi e reazioni. Pepti<strong>di</strong>: sintesi ed analisi.<br />
Carboidrati: monosaccari<strong>di</strong> (classificazione, struttura e trasformazioni); oligo e polisaccari<strong>di</strong>.<br />
Composti Eterociclici: vie generali <strong>di</strong> sintesi e reattività. Composti eterociclici <strong>di</strong> varie <strong>di</strong>mensioni, aromatici<br />
e non aromatici. Basi puriniche e pirimi<strong>di</strong>niche. Nucleosi<strong>di</strong> e nucleoti<strong>di</strong>.<br />
Reazioni pericicliche: reazioni elettrocicliche, <strong>di</strong> cicload<strong>di</strong>zione e <strong>di</strong> riassestamento sigmatropiche.<br />
Derivati organici dello zolfo, del fosforo e del silicio: reattività, sintesi e trasformazioni.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso è articolato in lezioni ed esercitazioni in aula svolte dal docente della <strong>di</strong>sciplina per 5 ore settimanali<br />
per un totale <strong>di</strong> 60 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica frontale più 10 ore <strong>di</strong> esercitazioni.<br />
Esame finale<br />
L’esame consiste in un colloquio orale su tutti gli argomenti trattati, generalmente su tre <strong>di</strong>stinte domande.<br />
L’esame comprende, oltre alla trattazione <strong>degli</strong> argomenti, anche la risoluzione <strong>di</strong> alcuni esempi <strong>di</strong> sintesi.<br />
Testi consigliati:<br />
CLAYDEN, GREEVES, WARREN, WOTHERS, Organic chemistry, UK, Oxford University Press.<br />
CLAYDEN, GREEVES, WARREN, WOTHERS, Solutions manual to accompany, organic chemistry, UK, Oxford<br />
University Press.<br />
G. PROCTER, Sintesi asimmetrica, Napoli, E<strong>di</strong>SES.<br />
W.H. BROWN, Introduzione alla Chimica organica, Napoli, E<strong>di</strong>SES, 2001.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: lun., mar. e mer., ore 16,30-18,30.<br />
FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche)
Attività formativa: B (caratterizzante);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare BIO/14; cre<strong>di</strong>ti formativi: 8<br />
III Anno, I Semestre<br />
proff. Diana Conte e Annamaria De Luca<br />
Finalità del Corso<br />
Fornire allo studente competenze riguardanti i principi generali dei meccanismi dell’azione dei farmaci,<br />
nonché le classi <strong>di</strong> agenti farmacologici utilizzati a scopi terapeutici.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
I parte: Farmacologia generale. Recettori fisiologici e altri bersagli dell’azione dei farmaci; Sistemi <strong>di</strong><br />
trasduzione del segnale; Desensitizzazione recettoriale. Curve dose-risposta, Affinità, attività intrinseca,<br />
potenza ed efficacia; Agonismo, antagonismo, agonismo parziale ed inverso. Farmacocinetica:<br />
somministrazione, assorbimento, <strong>di</strong>stribuzione, metabolismo ed escrezione dei farmaci; Posologia.<br />
Farmacogenomica.<br />
II parte: Farmacologia e Farmacoterapia I. Farmacologia del sistema nervoso autonomo e periferico:<br />
Neurotrasmettitori e recettori. Farmacologia dei sistemi <strong>di</strong> regolazione del tono muscolare (NO, endoteline,<br />
bra<strong>di</strong>chinine, prostaglan<strong>di</strong>ne, canali ionici e recettori) e della trasmissione nervosa periferica<br />
(anticolinesterasici. Curari. Anestetici locali). Farmacologia dei processi infiammatori: La cascata dell’acido<br />
arachidonico e gli eicosanoi<strong>di</strong>. Antiinfiammatori non steroidei e glucocorticoi<strong>di</strong>. Inibitori della<br />
lipoossigenasi. Antagonisti dei leucotrieni. Istamina e gli inibitori dei recettori H 1. Farmaci attivi su cuore,<br />
circolo e apparato respiratorio: Omeostasi car<strong>di</strong>ovascolare. Antiipertensivi; Diuretici; Farmaci utilizzati nello<br />
scompenso car<strong>di</strong>aco; Antianginosi ed Antiaritmici; Antiaggreganti, anticoagulanti e fibrinolitici. Trattamento<br />
delle <strong>di</strong>slipidemie. Farmaci bronco<strong>di</strong>latatori; Mucolitici e antitussivi. Farmacologia del Sistema Nervoso<br />
Centrale: Vie <strong>di</strong> neurotrasmissione centrale e me<strong>di</strong>atori; bersagli farmacologici nel SNC. Farmaci utilizzati<br />
in affezioni psichiatriche: antidepressivi; ansiolitici; neurolettici. Terapia del morbo <strong>di</strong> Parkinson, malattia <strong>di</strong><br />
Alzheimer ed epilessie. Anestetici generali. Neurofarmacologia del dolore acuto e cronico; La morfina e i<br />
suoi derivati; Cure palliative. Aspetti regolatori inerenti alla prescrizione e all’uso dei farmaci.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso, articolato in lezioni ed esercitazioni in aula è sud<strong>di</strong>viso in moduli monotematici svolti e coor<strong>di</strong>nati<br />
dai docenti, per almeno 5 ore settimanali con un totale <strong>di</strong> circa 60 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica frontale.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in una prova orale nella quale si dovrà rispondere in maniera precisa a quesiti relativi agli<br />
argomenti del programma svolto.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento e materiale <strong>di</strong>dattico:<br />
PAOLETTI, NICOSIA, CLEMENTI, FUMAGALLI, Farmacologia generale e molecolare, UTET.<br />
RANG, DALE, RITTER, Farmacologia, Ambrosiana.<br />
GOODMAN & GILMAN, Le basi farmacologiche della terapia, 9. ed., McGraw-Hill.<br />
Il materiale <strong>di</strong>dattico usato nelle lezioni ed esercitazioni sarà riportato, quando possibile, su supporto<br />
elettronico e inserito nei computer dell’aula <strong>di</strong>dattica, a <strong>di</strong>sposizione <strong>degli</strong> studenti.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: prof.ssa D. Conte ven., ore 9-11; prof.ssa A. De Luca lun. e mer., ore 9,30-12.
BIOCHIMICA<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche)<br />
Attività formativa: A (<strong>di</strong> base);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare BIO/10; cre<strong>di</strong>ti formativi: 8<br />
II Anno, IV Semestre<br />
prof. Girolamo Prezioso<br />
Finalità del Corso<br />
Il Corso è finalizzato allo stu<strong>di</strong>o dei processi chimici che hanno luogo negli organismi viventi, sulla base<br />
delle conoscenze <strong>di</strong> Biologia e dei principi della Chimica, Chimica fisica, Chimica organica già acquisiti<br />
dallo studente. Esso è organizzato in una parte descrittiva delle principali biomolecole, in cui viene messo in<br />
evidenza il rapporto tra struttura e funzione, ed una parte in cui sono analizzati i processi metabolici<br />
fondamentali <strong>di</strong> un organismo vivente, le loro correlazioni e regolazioni reciproche, la loro organizzazione in<br />
compartimenti cellulari, tessuti ed organi.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
1. L’organismo vivente: rapporti con l’ambiente, catabolismo, anabolismo. La cellula. Duplicazione e<br />
<strong>di</strong>fferenziazione. Compartimentazione. L’acqua come solvente polare. Zuccheri. Lipi<strong>di</strong>. Nucleoti<strong>di</strong>.<br />
Amminoaci<strong>di</strong>. 2. Strutture delle proteine. Denaturazione e rinaturazione. Interazioni proteina-proteina.<br />
Biomembrane. Interazioni tra proteine e glici<strong>di</strong>, lipi<strong>di</strong>, aci<strong>di</strong> nucleici. Funzioni delle proteine. Cofattori.<br />
Interazioni proteina-substrato. La mioglobina. Proteine oligomeriche e cooperatività. L’emoglobina. Modello<br />
<strong>di</strong> Monod e Changeaux, modello sequenziale. 3. Gli enzimi. Meccanismi catalitici. Specificità. Attività<br />
enzimatica. Cinetica enzimatica. Equazione <strong>di</strong> Michaelis-Menten. Reazioni a due substrati. Inibitori delle<br />
reazioni enzimatiche. Enzimi oligomerici. Cooperatività e cinetiche sigmoi<strong>di</strong>. Effettori allosterici.<br />
Classificazione <strong>degli</strong> enzimi. Cofattori e coenzimi. L’energia libera e le altre funzioni termo<strong>di</strong>namiche nei<br />
processi metabolici. Reazioni eso- ed endoergoniche. Processi accoppiati. Le vie metaboliche. Attività delle<br />
vie metaboliche e sua regolazione. Correlazione tra le vie metaboliche. Ruolo dell’ATP. 4. Glicolisi. Via<br />
anaerobica e via aerobica. Degradazione e biosintesi del glicogeno. Degradazione <strong>di</strong> altri esosi. Via dei<br />
pentosi-fosfati. Degradazione dei lipi<strong>di</strong>. β-ossidazione <strong>degli</strong> aci<strong>di</strong> grassi. Ciclo <strong>di</strong> Krebs. Catena respiratoria e<br />
fosforilazione ossidativa. Corpi chetonici. Degradazione delle proteine e <strong>degli</strong> amminoaci<strong>di</strong>. 5.<br />
Gluconeogenesi, fotosintesi. Biosintesi <strong>degli</strong> aci<strong>di</strong> grassi, dei trigliceri<strong>di</strong>, dei fosfogliceri<strong>di</strong>, <strong>degli</strong> sfingolipi<strong>di</strong>.<br />
Biosintesi del colesterolo. Biosintesi <strong>degli</strong> amminoaci<strong>di</strong>, dell’eme, dei nucleoti<strong>di</strong>. 6. Struttura e funzioni del<br />
DNA. I geni. Il DNA procariotico ed eucariotico. RNA messaggero, RNA ribosomiale ed RNA transfer:<br />
struttura e funzioni. Biosintesi <strong>degli</strong> RNA. Maturazione <strong>degli</strong> RNA. Replicazione del DNA. Attivazione<br />
<strong>degli</strong> amminoaci<strong>di</strong>. I ribosomi: struttura e funzione. Il processo <strong>di</strong> biosintesi delle proteine. Mo<strong>di</strong>ficazioni<br />
post-traduzionali. 7. Tecniche biochimiche: Spettrofotometria. Cromatografia. Elettroforesi. Centrifugazione.<br />
Ra<strong>di</strong>oisotopi.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso è articolato in lezioni ed esercitazioni per almeno 5 ore settimanali ed un totale <strong>di</strong> almeno 60 ore.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in una prova orale in cui lo studente <strong>di</strong>mostri <strong>di</strong> essere in grado <strong>di</strong> <strong>di</strong>scutere dei vari processi<br />
biochimici sod<strong>di</strong>sfacendo alle finalità in<strong>di</strong>cate per il Corso.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento:<br />
MATHEUS, VAN HOLDE, Biochimica, Ambrosiana.<br />
LEHENINGER, NELSON, COX, Principi <strong>di</strong> Biochimica, Zanichelli.<br />
Testi <strong>di</strong> consultazione:<br />
VOET, VOET, Biochimica, Zanichelli.<br />
STREYER, Biochimica, Zanichelli.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: lun., mar., mer., ore 11,30-12,30.<br />
CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA I<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche)
Attività formativa: B (caratterizzante);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare CHIM/08; cre<strong>di</strong>ti formativi: 8<br />
III Anno, II Semestre<br />
proff. Francesco Berar<strong>di</strong> e Roberto Perrone<br />
Finalità del Corso<br />
Nel Corso viene dato risalto ad aspetti prettamente chimici come i meccanismi molecolari, le proprietà<br />
chimico-fisiche che li influenzano ed alcuni proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> sintesi, il tutto finalizzato alla conoscenza delle<br />
motivazioni, dei criteri e delle metodologie utili per la progettazione e lo sviluppo, tramite strategie <strong>di</strong><br />
ottimizzazione, <strong>di</strong> nuovi farmaci.<br />
Propedeu<strong>di</strong>cità sostanziali<br />
L’appren<strong>di</strong>mento della <strong>di</strong>sciplina sarà facilitato da conoscenze <strong>di</strong> base in Chimica organica, Anatomia e<br />
Fisiologia.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
Progettazione (motivazioni, criteri e metodologie), e sviluppo (strategie <strong>di</strong> ottimizzazione) <strong>di</strong> nuovi farmaci.<br />
Nomenclatura dei prodotti d’interesse farmaceutico e regole IUPAC per strutture complesse.<br />
Biotrasformazione dei farmaci: meccanismi delle reazioni, influenza dei fattori sterici ed elettronici. Effetti<br />
secondari e tossicità <strong>di</strong> farmaci e loro metaboliti: meccanismi molecolari. Le fasi della Farmacocinetica e le<br />
proprietà chimico-fisiche che la influenzano. La Farmaco<strong>di</strong>namica: <strong>di</strong>verse teorie sull’interazione tra<br />
farmaco e recettore. Proprietà chimico-fisiche che influenzano l’interazione recettoriale. Misura dell’affinità<br />
recettoriale e relazioni tra struttura ed affinità. Attività intrinseca dei farmaci: curve dose-risposta e relazione<br />
tra struttura e attività. Le <strong>di</strong>verse famiglie e tipologie <strong>di</strong> recettori e loro sottotipi. Sistemi <strong>di</strong> trasduzione del<br />
segnale conseguenti all’interazione tra farmaco e recettore. Ligan<strong>di</strong> endogeni ed esogeni, ra<strong>di</strong>oligan<strong>di</strong> e<br />
farmaci. Sistemi enzimatici quali target nell’azione dei farmaci, inibitori enzimatici reversibili ed irreversibili<br />
<strong>di</strong>: Acetilcolinesterasi, Monoaminossidasi, Catecol-O-metiltransferasi, Dopa decarbossilasi, COX, COX-1,<br />
COX-2, ACE. Ligan<strong>di</strong> e farmaci del SNA e SNC: sistema muscarinico, nicotinico, adrenergico,<br />
dopaminergico, seroto-ninergico, istaminergico, oppioide, gabaergico, glutammaergico. Ligan<strong>di</strong> e farmaci<br />
attivi su canali ionici. Meccanismi aspecifici d’azione dei farmaci. Vie <strong>di</strong> sintesi industriali <strong>di</strong> fondamentali<br />
strutture d’interesse farmaceutico.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso, articolato in lezioni ed esercitazioni in aula, è sud<strong>di</strong>viso in moduli monotematici svolti e coor<strong>di</strong>nati<br />
dai due docenti della <strong>di</strong>sciplina, per almeno 5 ore settimanali con un totale <strong>di</strong> circa 60 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica<br />
frontale.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame esclusivamente orale consiste nel <strong>di</strong>segnare la struttura <strong>di</strong> un farmaco del quale viene dettato il<br />
nome chimico secondo la nomenclatura IUPAC e nell’ identificarne l’appartenenza ad una classe; è richiesto<br />
un commento dal punto <strong>di</strong> vista farmacocinetico e farmaco<strong>di</strong>namico con eventuali risvolti <strong>di</strong> tipo<br />
tossicologico o <strong>di</strong> Chimica farmaceutica generale. L’esame si conclude con la <strong>di</strong>scussione su altre classi <strong>di</strong><br />
farmaci trattati nel programma.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento e materiale <strong>di</strong>dattico:<br />
C.G. WERMUTH, Le applicazioni della Chimica farmaceutica, Napoli, E<strong>di</strong>SES, 2000. C. MELCHIORRE, I<br />
recettori dei neurotrasmettitori, Bologna, Clueb, 1996. W.O. FOYE ET ALII, Principles of me<strong>di</strong>cinal<br />
chemistry, Filadelfia, Lippincott et alii, 2002.<br />
Una copia cartacea del materiale utilizzato durante lezioni ed esercitazioni sarà messa a <strong>di</strong>sposizione <strong>degli</strong><br />
studenti i quali la potranno duplicare a loro spese.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: prof. Berar<strong>di</strong> mar., ore 12,30-13,30; mer., ore 18-19; gio., ore 17-18; prof. Perrone<br />
lun., ore 12-13; gio., ore 12-13.<br />
METODI FISICI IN CHIMICA ORGANICA<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche)<br />
Attività formativa: C (affini o integrativi);
settore <strong>di</strong>sciplinare CHIM/06; cre<strong>di</strong>ti formativi: 8<br />
III Anno, II Semestre<br />
Svolto nel precedente a.a. da:<br />
proff. Giuseppe Carbonara e Vincenzo Tortorella<br />
Finalità del Corso<br />
Il Corso sarà svolto tenendo in particolare considerazione la possibilità <strong>di</strong> ricavare il massimo delle<br />
informazioni strutturali partendo dai <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> spettri.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
1.0 Spettro elettromagnetico e sue interazioni con la materia: cenni teorici.<br />
2.0 Spettroscopia <strong>di</strong> risonanza magnetica nucleare: parte generale.<br />
2.1 Con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> risonanza dei nuclei; spostamento chimico (chemical shift); misura del chemical shift.<br />
2.2 La strumentazione: spettrometri CW ed FT.<br />
3.0 Spettroscopia <strong>di</strong> risonanza magnetica nucleare: il protone.<br />
3.1 La costante <strong>di</strong> schermaggio; influenza dei gruppi elettronici della molecola sulla costante <strong>di</strong> schermaggio;<br />
equivalenza chimica dei nuclei; accoppiamento <strong>di</strong> spin; definizione dei sistemi <strong>di</strong> spin; spettri <strong>di</strong> primo<br />
or<strong>di</strong>ne e <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne superiore; semplificazione <strong>di</strong> spettri.<br />
4.0 Spettroscopia <strong>di</strong> risonanza magnetica nucleare: il 13 C.<br />
4.1 La costante <strong>di</strong> schermaggio; influenza dei gruppi elettronici della molecola sulla costante <strong>di</strong> schermaggio;<br />
regole semiempiriche per l’in<strong>di</strong>viduazione dei <strong>di</strong>versi carboni; semplificazione <strong>di</strong> spettri.<br />
5.0 Spettroscopia <strong>di</strong> risonanza magnetica nucleare bi<strong>di</strong>mensionale.<br />
5.1 Cosy, Hetcor, Noesy.<br />
6.0 Spettroscopia infrarossa.<br />
6.1 Transizioni vibrazionali e caratteristiche strutturali ad esse correlate; apparecchiature; preparazione dei<br />
campioni; regole e tabelle per l’in<strong>di</strong>viduazione delle <strong>di</strong>verse porzioni molecolari.<br />
7.0 Spettroscopia ultravioletta e visibile.<br />
7.1 Transizioni elettroniche e caratteristiche strutturali ad esse correlate; apparecchiature; preparazione dei<br />
campioni; regole semiempiriche per l’in<strong>di</strong>viduazione dei <strong>di</strong>versi cromofori.<br />
8.0 Spettrometria <strong>di</strong> massa.<br />
8.1 Processi <strong>di</strong> ionizzazione; strumentazione; aspetto generale dello spettro; tipi principali <strong>di</strong><br />
frammentazione; schemi caratteristici <strong>di</strong> frammentazione delle principali classi <strong>di</strong> composti organici.<br />
9.0 Interpretazione <strong>di</strong> dati spettroscopici.<br />
9.1 Dai dati spettroscopici alle strutture chimiche.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Prevede 5 ore settimanali <strong>di</strong> lezioni teoriche, organizzate in moduli e 3 ore settimanali <strong>di</strong> esercitazioni<br />
pratiche.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
Consiste in una prova scritta nella quale si dovranno ipotizzare due strutture molecolari incognite partendo<br />
dai loro spettri; il superamento <strong>di</strong> tale prova ammette alla prova orale che verte sugli argomenti trattati nella<br />
prova scritta.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento:<br />
M. HESSE, H. MEIER, B. ZEEH, Meto<strong>di</strong> spettroscopici nella Chimica organica, Napoli, E<strong>di</strong>SES, 1996.<br />
R.M. SILVERSTEIN, F.X. WEBSTER, Identificazione spettroscopica <strong>di</strong> composti organici, Milano, CEA, 1999.<br />
E. PRETSH, P. BÜHLMANN, C. AFFOLTER, Structure determination of organic compounds. Tables of spectral<br />
data, Berlin, Springer-Verlag, 2000.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: prof. Carbonara mar., mer., gio., ore 16,30-18,30; prof. Tortorella lun., ore 10,30-<br />
11,30; gio., ore 11,30-12,30; ven., ore 9-10.
CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA II<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche)<br />
Attività formativa: B (caratterizzante);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare: CHIM/08; cre<strong>di</strong>ti formativi 8<br />
IV Anno, I Semestre<br />
proff. Cosimo Altomare e Angelo Carotti<br />
Finalità del Corso<br />
Classi <strong>di</strong> farmaci, aggiornate in considerazione dei più recenti traguar<strong>di</strong> terapeutici, vengono trattate con<br />
particolare riferimento a: strategie innovative <strong>di</strong> progettazione, ricerca e sviluppo; metodologie sintetiche ed<br />
estrattive industriali; meccanismo d’azione su basi molecolari; mappatura dei siti <strong>di</strong> legame dei farmaci,<br />
modelli farmacoforici e relazioni quantitative struttura-attività (QSAR).<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
1.0 Antibiotici. 1.1 Inibitori della biosintesi del peptidoglicano. 1.1.1 Cicloserina e fosfomicina. 1.1.2 Betalattamine:<br />
penicilline; cefalosporine; inibitori delle beta-lattamasi; tienamicine; monobattami. 1.1.3<br />
Antibiotici glicopepti<strong>di</strong>ci. 1.2 Inibitori della sintesi proteica: tetracicline; macroli<strong>di</strong>; amminoglicosi<strong>di</strong>. 1.3<br />
Rifamicine. 1.4 Amfenicoli. 1.5 Polipepti<strong>di</strong>ci. 2.0 Chemioterapici. 2.1 Antielmintici e antiprotozoari. 2.2<br />
Antimalarici. 2.3 Antiflagellati. 2.4 Antimicrobici. 2.4.1 Sulfami<strong>di</strong>ci. 2.4.2 Ossacine. 2.5 Antimicotici. 2.5.1<br />
Macroli<strong>di</strong> polienici. 2.5.2 Derivati azolici. 2.6 Antimicobatterici. 2.7 Antivirali. 2.7.1 Agenti antiherpetici.<br />
2.7.2 Amanti<strong>di</strong>ne. 2.7.3 Farmaci anti-HIV. 2.7.4 Interferone. 2.8 Anti-neoplastici. 2.6.1 Alchilanti. 2.6.2<br />
Antimetaboliti. 2.6.3 Intercalanti. 2.6.4 Antimitotici. 3.0 Ormoni e antagonisti <strong>degli</strong> ormoni. 3.1 Ormoni da<br />
singolo amminoacido: ormoni tiroidei, melatonina. 3.2 Ormoni pepti<strong>di</strong>ci. 3.2.1 Ormoni ipotalamici e<br />
ipofisari (ACTH). 3.2.2 Ormoni neuroipofisari. 3.2.3 Paratormone e calcitonina. 3.2.4 Ormoni pancreatici:<br />
insulina e glucagone. 3.2.5 Ormoni della mucosa gastrica e duodenale. 3.2.6 Sistema renina-tensina: inibitori<br />
dell’ACE e antagonisti dell’angiotensina II. 3.2.7 Ormoni timici e farmaci immunomodulatori. 3.3 Ormoni<br />
steroidei. 3.3.1 Androgeni e anabolizzanti. 3.3.2 Estrogeni e antiestrogeni. 3.3.6 Progestativi e contraccettivi<br />
orali. 3.3.7 Corticosurrenali: glicocorticoi<strong>di</strong> e mineralcorticoi<strong>di</strong>. 4.0 Autacoi<strong>di</strong>. 4.1 Prostaglan<strong>di</strong>ne. 4.2<br />
Prostacicline. 4.3 Trombossani. 4.4 Leucotrieni. 5.0 Vitamine. 5.1 Vitamine liposolubili: A, D, E, K. 5.2<br />
Vitamine idrosolubili: complesso B; vitamina C; vitamina P. 6.0 Anticoagulanti e antitrombotici. 6.1<br />
Eparine. 6.2 Anticoagulanti orali. 6.3 Inibitori <strong>di</strong> trombina e fattore Xa. 6.4 Antiaggreganti piastrinici.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso si articola in lezioni e seminari, per almeno 6 ore settimanali con un totale <strong>di</strong> circa 70 ore <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>dattica frontale.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
La prova d’esame consiste in un colloquio sugli argomenti in programma, eventualmente preceduto da una<br />
prova scritta.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento e materiale <strong>di</strong>dattico:<br />
C. WERMUTH, Le applicazioni della Chimica farmaceutica, Napoli, E<strong>di</strong>SES, 2001.<br />
C.G. ALBERTI, L. VILLA, Chimica farmaceutica, (vol. II), Chemioterapici, Antibiotici, Milano, OEMF.<br />
FOYE, LEMKE, WILLIAMS, Principi <strong>di</strong> Chimica farmaceutica, Padova Piccin, 1998.<br />
È inoltre <strong>di</strong>sponibile il materiale <strong>di</strong>dattico utilizzato nel Corso, in copia cartacea e/o su supporto elettronico.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: lun., ore 10,30-12,30; mer., ore 16,30-18,30; ven., ore 10,30-11,30.
IMPIANTI DELL’INDUSTRIA FARMACEUTICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche)<br />
Attività formativa: B (caratterizzante);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare CHIM 09; cre<strong>di</strong>ti formativi: 10<br />
IV Anno, I Semestre<br />
prof. Andrea Latrofa<br />
Finalità del Corso<br />
Il Corso ha come obiettivo l’acquisizione da parte dello studente delle conoscenze correlate con<br />
l’impiantistica industriale e le tecnologie farmaceutiche coinvolte nella produzione e nel confezionamento<br />
dei me<strong>di</strong>cinali.<br />
Contenuto del Corso<br />
Nozioni generali inerenti l’Industria Farmaceutica (IF), dati statistici sulla produzione del farmaco in Italia e<br />
nel mondo. Principali caratteristiche dell’IF, contesto operativo, prodotti del settore, struttura della domanda<br />
e dell’offerta dei farmaci; intervento pubblico nel settore. Organizzazione <strong>di</strong> un’IF: organigramma, centro<br />
elaborazione dati, documentazione <strong>di</strong> stabilimento, costo unitario <strong>di</strong> produzione, logistica industriale, fasi ed<br />
azioni sperimentali dello sviluppo <strong>di</strong> farmaci. Norme per la produzione industriale <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cinali a livello<br />
Nazionale (D.Lvo 29/5/91 n. 178 e D.Lvo 18/02/97 n. 446): autorizzazione alla produzione (AP) e<br />
all’immissione in commercio (AIC) <strong>di</strong> una specialità me<strong>di</strong>cinale (SM), AIC a livello Europeo. Norme per la<br />
buona fabbricazione e per il controllo <strong>di</strong> qualità dei me<strong>di</strong>camenti (NBF e CQM); NBF <strong>di</strong> Soluzioni<br />
Parenterali <strong>di</strong> Grande Volume (LVPs). Tipicità dell’IF, organizzazione delle unità tecniche produttive,<br />
servizi tecnici centralizzati: Vapore e centrale termica, Acqua; Energia elettrica; Gas maggiormente usati,<br />
Aria compressa, Linee <strong>di</strong> vuoto, Centrale frigorifera, Sistemi antincen<strong>di</strong>o ed antideflagrazione, Sistemi <strong>di</strong><br />
abbattimento dei fumi e delle polveri, Scarichi e Rifiuti <strong>di</strong> un’IF. Locali <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> un’IF: ventilati,<br />
con<strong>di</strong>zionati, deumi<strong>di</strong>ficati, sterili. Prodotti sterili e limite <strong>di</strong> assicurazione <strong>di</strong> sterilità (LAS) secondo la FUI,<br />
sterilizzazione <strong>di</strong> prodotti e presi<strong>di</strong> farmaceutici con meto<strong>di</strong> fisici e con meto<strong>di</strong> chimici. Materiali in uso<br />
nell’IF per impianti e per confezionamento: vetro, acciaio, alluminio, materie plastiche, elastomeri. Acqua<br />
per uso farmaceutico, demineralizzazione dell’acqua con meto<strong>di</strong> chimici, con meto<strong>di</strong> fisici, con processi a<br />
membrana. Tecnologia produttiva e controllo qualità delle <strong>di</strong>verse FF. FF liquide e preparati iniettabili.<br />
Liofilizzazione ed Essiccamento per Spray-drying delle soluzioni, essiccamento dei materiali soli<strong>di</strong>.<br />
Operazioni inerenti le FF solide: macinazione, setacciatura, miscelazione, granulazione. Compresse,<br />
Capsule. Sistemi <strong>di</strong> trasporto dei materiali soli<strong>di</strong>. Estrazione <strong>di</strong> principi attivi d’interesse farmaceutico:<br />
estrazione solido-liquido e liquido-liquido. Evaporazione, trasmissione del calore tra due flui<strong>di</strong> in movimento<br />
(legge <strong>di</strong> Fourier), scambiatori <strong>di</strong> calore. FF fluido-solide. Confezionamento delle FF solide. Simboli e sigle<br />
per schemi e <strong>di</strong>segni <strong>di</strong> impianti industriali. Decreto legislativo n. 626 del 19/9/94.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso è impostato in lezioni per 5 ore settimanali e per un totale non inferiore a 60 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica frontale.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame, della durata non inferiore a 20 minuti, consiste in un colloquio inerente il programma svolto<br />
durante il Corso.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento:<br />
G.C. CESCHEL, Impianti per l’Industria Farmaceutica, Bologna, Esculapio.<br />
S.M. LAVAGNA Impianti e tecnologie per le forme farmaceutiche iniettabili, Trend-E<strong>di</strong>zioni Multime<strong>di</strong>ali.<br />
L. LACHMAN, The theory and practice of industrial pharmacy, Philadelphia, Lea & Febiger.<br />
Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana, XI E<strong>di</strong>zione, Istituto Superiore Sanità.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: mar., gio., ore 10-12.<br />
TECNOLOGIA, SOCIOECONOMIA<br />
E LEGISLAZIONE FARMACEUTICHE<br />
Attività formativa: B (caratterizzante);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare CHIM/09; cre<strong>di</strong>ti formativi: 10<br />
IV Anno, I Semestre<br />
prof. Massimo Franco
Finalità del Corso<br />
Il Corso ha lo scopo <strong>di</strong> fornire le basi teoriche e metodologiche necessarie per la trasformazione <strong>di</strong> un<br />
principio attivo in un me<strong>di</strong>camento. Nel contempo vengono fornite le basi per il controllo della forma<br />
farmaceutica finita e principi basilari <strong>di</strong> Socioeconomia e Legislazione Farmaceutica.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
L’evoluzione del farmaco. Aspetti normativi ed impatto sociale. La regolamentazione nella produzione del<br />
farmaco. La Farmacopea Ufficiale Italiana. I co<strong>di</strong>ci e le farmacopee sovranazionali. Aspetti generali e<br />
valutazioni etiche, sociali ed economiche nella progettazione, sviluppo e produzione del farmaco e delle<br />
forme farmaceutiche. Aspetti brevettuali e legislativi. Le norme <strong>di</strong> Buona Fabbricazione. La<br />
preformulazione e la formulazione farmaceutica. Requisiti generali delle forme farmaceutiche e problemi<br />
connessi alla stabilità ed alla conservazione. Caratterizzazione e proprietà delle polveri. La preparazione<br />
delle forme farmaceutiche solide (capsule, compresse, confetti), dalla preparazione dei prototipi alla messa a<br />
punto definitiva. I sistemi multiparticellari. La microincapsulazione. Le forme farmaceutiche semisolide<br />
(creme, unguenti, paste, gel). I tensioattivi, le emulsioni, le sospensioni. Le preparazioni iniettabili:<br />
caratteristiche formulative e requisiti <strong>di</strong> preparazione. La sterilizzazione. I prodotti liofilizzati. I colliri.<br />
Preparazioni per somministrazione oftalmica, nasale, polmonare. I suppositori. I sistemi terapeutici a<br />
rilascio controllato. Controlli tecnologici delle forme farmaceutiche e requisiti richiesti dalle <strong>di</strong>fferenti<br />
farmacopee. Organizzazione Sanitaria Nazionale, il Servizio Sanitario. Norme legislative che regolano la<br />
produzione, la <strong>di</strong>stribuzione e la <strong>di</strong>spensazione dei farmaci. Or<strong>di</strong>ne professionale, etica e deontologia nel<br />
settore del farmaco.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso è articolato in lezioni per almeno 5 ore settimanali con un totale <strong>di</strong> circa 60 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica frontale.<br />
Inoltre vi sono esercitazioni a posto singolo che riguardano la preparazione <strong>di</strong> forme farmaceutiche e i loro<br />
controlli con particolare riguardo a quelli tecnologici della Farmacopea Ufficiale, nonché la tariffazione<br />
delle preparazioni magistrali. Ogni studente è impegnato per circa 30 ore <strong>di</strong> esercitazione.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in una prima prova scritta nella quale si dovrà rispondere in maniera concisa su alcuni<br />
quesiti <strong>di</strong> carattere generale effettuando calcoli <strong>di</strong> natura chimico fisica. La successiva prova orale, alla<br />
quale si accede dopo il superamento della prova scritta, verte essenzialmente su altri argomenti teorici<br />
trattati.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento:<br />
M. AMOROSA, Principi <strong>di</strong> Tecnica Farmaceutica, Bologna, Tinarelli, 1995.<br />
MARTIN, Physical Pharmacy, Philadelphia, Lea and Fabiger, 1994.<br />
A.T. FLORENCE, D. ATWOOD, Le basi chimico fisiche della Tecnologia Farmaceutica, Napoli, E<strong>di</strong>SES,<br />
2002.<br />
BUNKER, RHODES, Modern Pharmaceutics, Dakker, 1992.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: lun., mar., ore 11-13; gio., ore 17-19.
ANALISI DEI FARMACI II (Corso A)<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche)<br />
Attività formativa: B (caratterizzante);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare CHIM/08; cre<strong>di</strong>ti formativi: 10<br />
IV Anno, I Semestre<br />
prof. Savina Ferorelli<br />
Finalità del Corso<br />
Il Corso si propone l’obiettivo <strong>di</strong> illustrare le tecniche che consentono sia l’analisi <strong>di</strong> sostanze iscritte nella<br />
Farmacopea Ufficiale Italiana sia <strong>di</strong> composti che hanno potenziale impiego come farmaci. Poiché per essere<br />
sottoposte all’analisi queste sostanze devono presentarsi pure, ampio spazio è de<strong>di</strong>cato alle tecniche <strong>di</strong><br />
purificazione strumentali e non.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
1.0 Identificazione <strong>di</strong> molecole organiche e allo stato puro.<br />
2.0 Caratterizzazione <strong>di</strong> sostanze organiche e <strong>di</strong> interesse farmaceutico con costanti fisiche: punto <strong>di</strong> fusione,<br />
punto <strong>di</strong> ebollizione, in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> rifrazione, densità, potere rotatorio, <strong>di</strong>croismo circolare.<br />
3.0 Determinazione della solubilità in <strong>di</strong>versi solventi.<br />
4.0 Identificazione <strong>di</strong> sostanze riportate in Farmacopea.<br />
5.0 Meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> purificazione: sublimazione, cristallizzazione, estrazione, <strong>di</strong>stillazione.<br />
6.0 Meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> purificazione cromatografici: TLC, Cromatografia su colonna, Gas-cromatografia,<br />
Cromatografia a scambio ionico, HPLC, Gel filtrazione cromatografica, elettroforesi capillare.<br />
7.0 Analisi qualitativa e quantitativa in gas-cromatografia.<br />
8.0 Introduzione al bin<strong>di</strong>ng con ra<strong>di</strong>oligan<strong>di</strong>.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso è articolato in lezioni in aula ed esercitazioni in laboratorio svolte e coor<strong>di</strong>nate dai docenti della<br />
<strong>di</strong>sciplina. Le lezioni in aula comprendono almeno 5 ore settimanali con un totale <strong>di</strong> circa 60 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica<br />
frontale. Le esercitazioni in laboratorio comprendono almeno 12 ore settimanali per circa 100 ore<br />
complessive.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in una prova orale che verte su tutti gli argomenti del programma svolto.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento e materiale <strong>di</strong>dattico:<br />
R. COZZI, P. PROTTI, T. RUARO, Analisi Chimica strumentale, vol. C Meto<strong>di</strong> cromatografici, Zanichelli.<br />
G. LUCENTE, V. TORTORELLA, Guida all’analisi dei composti <strong>di</strong> interesse farmaceutico, Bulzoni.<br />
ESPOSITO, IAVARONE, TROGOLO, Analisi organica qualitativa, Roma, La Goliar<strong>di</strong>ca E<strong>di</strong>trice Universitaria.<br />
Tutto il materiale <strong>di</strong>dattico usato nelle lezioni e nelle esercitazioni sarà a <strong>di</strong>sposizione <strong>degli</strong> studenti che lo<br />
potranno duplicare a loro spese.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: mar., ore 17-18; gio., ore 10-11.
ANALISI DEI FARMACI II (Corso B)<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche)<br />
Attività formativa: B (caratterizzante);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare CHIM/08; cre<strong>di</strong>ti formativi: 10<br />
IV Anno, II Semestre<br />
prof. Marcello Leopoldo<br />
Finalità del Corso<br />
Il Corso si propone l’obiettivo <strong>di</strong> illustrare le tecniche che consentono sia l’analisi <strong>di</strong> sostanze iscritte nella<br />
Farmacopea Ufficiale Italiana sia <strong>di</strong> composti che hanno potenziale impiego come farmaci. Poiché per essere<br />
sottoposte all’analisi queste sostanze devono presentarsi pure, ampio spazio è de<strong>di</strong>cato alle tecniche <strong>di</strong><br />
purificazione strumentali e non.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
1.0 Identificazione <strong>di</strong> molecole organiche e allo stato puro.<br />
2.0 Caratterizzazione <strong>di</strong> sostanze organiche e <strong>di</strong> interesse farmaceutico con costanti fisiche: punto <strong>di</strong> fusione,<br />
punto <strong>di</strong> ebollizione, in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> rifrazione, densità, potere rotatorio, <strong>di</strong>croismo circolare.<br />
3.0 Determinazione della solubilità in <strong>di</strong>versi solventi.<br />
4.0 Identificazione <strong>di</strong> sostanze riportate in Farmacopea.<br />
5.0 Meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> purificazione: sublimazione, cristallizzazione, estrazione, <strong>di</strong>stillazione.<br />
6.0 Meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> purificazione cromatografici: TLC, Cromatografia su colonna, Gas-cromatografia,<br />
Cromatografia a scambio ionico, HPLC, Gel filtrazione cromatografica, elettroforesi capillare.<br />
7.0 Analisi qualitativa e quantitativa in gas-cromatografia.<br />
8.0 Introduzione al bin<strong>di</strong>ng con ra<strong>di</strong>oligan<strong>di</strong>.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso è articolato in lezioni in aula ed esercitazioni in laboratorio svolte e coor<strong>di</strong>nate dai docenti della<br />
<strong>di</strong>sciplina. Le lezioni in aula comprendono almeno 5 ore settimanali con un totale <strong>di</strong> circa 60 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica<br />
frontale. Le esercitazioni in laboratorio comprendono almeno 12 ore settimanali per circa 100 ore<br />
complessive.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in una prova orale che verte su tutti gli argomenti del programma svolto.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento e materiale <strong>di</strong>dattico:<br />
R. COZZI, P. PROTTI, T. RUARO, Analisi Chimica strumentale, vol. C Meto<strong>di</strong> cromatografici, Zanichelli.<br />
G. LUCENTE, V. TORTORELLA, Guida all’analisi dei composti <strong>di</strong> interesse farmaceutico, Bulzoni.<br />
ESPOSITO, IAVARONE, TROGOLO, Analisi organica qualitativa, Roma, La Goliar<strong>di</strong>ca E<strong>di</strong>trice Universitaria.<br />
Tutto il materiale <strong>di</strong>dattico usato nelle lezioni e nelle esercitazioni sarà a <strong>di</strong>sposizione <strong>degli</strong> studenti che lo<br />
potranno duplicare a loro spese.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: mer., ore 12-13; gio., ore 17-18.
CHIMICA FARMACEUTICA APPLICATA<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche)<br />
Attività formativa: B (caratterizzante);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare CHIM/09; cre<strong>di</strong>ti formativi: 8<br />
IV Anno, II Semestre<br />
prof. Giuseppe Trapani<br />
Finalità del Corso<br />
Il Corso ha lo scopo <strong>di</strong> fornire le basi teoriche e metodologiche necessarie alla soluzione coor<strong>di</strong>nata dei<br />
problemi chimico-fisici, tecnologici e biologici relativi alla trasformazione <strong>di</strong> un principio attivo in un<br />
me<strong>di</strong>camento. Nel contempo vengono fornite le basi per la progettazione <strong>di</strong> un sistema terapeutico a rilascio<br />
mo<strong>di</strong>ficato.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
Dall’idea terapeutica alla realizzazione <strong>di</strong> un prodotto farmaceutico.<br />
<strong>Stu<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> preformulazione nello sviluppo del farmaco. Proprietà chimico-fisiche. Principi <strong>di</strong> fisica<br />
farmaceutica e biofarmaceutica. Solubilità. Lipofilia. Costante <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssociazione. Caratterizzazione fisica dello<br />
stato solido. Diffusione e velocità <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssoluzione. Nozioni <strong>di</strong> farmacocinetica necessarie per la<br />
comprensione dei parametri <strong>di</strong> bio<strong>di</strong>sponibilità assoluta e relativa, <strong>di</strong> bioequivalenza dei prodotti<br />
farmaceutici, e per il rilascio mo<strong>di</strong>ficato. Metabolismo, assorbimento. Biofarmaceutica. Bio<strong>di</strong>sponibilità e<br />
bioequivalenza.<br />
Meto<strong>di</strong> per con<strong>di</strong>zionare il rilascio o veicolare e <strong>di</strong>rezionare i farmaci.<br />
Ruolo dei polimeri nel rilascio mo<strong>di</strong>ficato <strong>di</strong> farmaci. Polimeri biodegradabili, bioero<strong>di</strong>bili, biocompatibili e<br />
bioadesivi. Polimeri come carriers <strong>di</strong> farmaci. Drug delivery systems a rilascio mo<strong>di</strong>ficato. Pompe osmotiche.<br />
Cinetiche <strong>di</strong> rilascio. Profarmaci. Complessazione nel rilascio mo<strong>di</strong>ficato. Dispersioni solide. Rilascio<br />
sitospecifico <strong>di</strong> farmaci drug targeting. Vettori (carriers): microparticelle, nanoparticelle e nanocapsule.<br />
Liposomi convenzionali. Liposomi pegilati. Meccanismo <strong>di</strong> captazione <strong>di</strong> vettori: passivo, attivo e fisico.<br />
Anticorpi monoclonali con targeting cellulari. Strategie <strong>di</strong> legame agli anticorpi monoclonali. Coniugati<br />
carriers-farmaco. Profarmaci polimerici nel targeting. Immunoliposomi. Terapia genica. Approccio chimico<br />
al drug targeting. Barriera ematoencefalica. Chemical delivery systems (CDS). Approccio ADEPT, GDEPT e<br />
SATE/DTE. Rilascio a livello polmonare. Rilascio a livello del colon. Vie <strong>di</strong> somministrazione e<br />
bio<strong>di</strong>sponibilità. Stabilità e stabilizzazione <strong>di</strong> farmaci e forme farmaceutiche. Degradazione chimica, fisica e<br />
Sicurezza dei farmaci. In<strong>di</strong>ce terapeutico, soft drugs.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso, articolato in lezioni ed esercitazioni in aula, per almeno 5 ore settimanali con un totale <strong>di</strong> circa 60<br />
ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica frontale.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in una prima prova scritta nella quale si dovrà rispondere in maniera concisa su sei quesiti<br />
<strong>di</strong> carattere generale effettuando calcoli <strong>di</strong> natura chimico fisica. La successiva prova orale, alla quale si<br />
accede dopo il superamento della prova scritta, verte essenzialmente su altri argomenti teorici trattati.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento:<br />
MARTIN, Physical Pharmacy, Philadelphia, Lea and Fabiger, 1994.<br />
A.T. FLORENCE, D. ATWOOD, Le basi chimico fisiche della Tecnologia Farmaceutica, Napoli, E<strong>di</strong>SES, 2002.<br />
BUNKER, RHODES, Modern Pharmaceutics, Dakker, 1992.<br />
C. WERMUTH, Le applicazioni della chimica farmaceutica, Napoli, E<strong>di</strong>SES, 2001.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: mer., ore 9,30-11,30; giov., ore 10,30-13.
FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche)<br />
Attività formativa: B (caratterizzante);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare BIO/14; cre<strong>di</strong>ti formativi: 8<br />
IV Anno, II Semestre<br />
prof. Marcello Diego Lograno<br />
Finalità del Corso<br />
Il Corso delle lezioni offre allo studente la possibilità <strong>di</strong> conoscere i principali interventi terapeutici nelle<br />
<strong>di</strong>fferenti patologie, nonché le <strong>di</strong>fferenti categorie <strong>di</strong> farmaci utilizzati, le loro caratteristiche<br />
farmaco<strong>di</strong>namiche e farmacocinetiche. Inoltre, si vuol far comprendere gli aspetti tossicologici dei farmaci<br />
nel provocare effetti sistemici acuti, subacuti e cronici, la tossicologia delle sostanze xenobiotiche <strong>di</strong> “abuso”<br />
e i loro effetti interattivi.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
1.0 Farmacologia e Farmacoterapia.<br />
Farmaci del sistema immunitario, Farmaci corticosteroi<strong>di</strong>.<br />
Farmacologia del sistema endocrino, Contraccettivi orali.<br />
Farmaci delle patologie <strong>di</strong>smetaboliche. Farmaci attivi sulla sfera uterina. Farmaci del sistema gastroenterico.<br />
Vitamine liposolubili e idrosolubili e loro applicazioni.<br />
2.0 Chemioterapici e antibiotici.<br />
Aspetti generali del trattamento chemioterapico delle infezioni.<br />
Antibiotici beta-lattamici, Aminoglicosi<strong>di</strong> Chinolonici.<br />
Macroli<strong>di</strong>, Lincosami<strong>di</strong>, Tetracicline e Cloramfenicolo.<br />
Sulfami<strong>di</strong>ci e Nitroimidazoli, Antimicobatteri, Antimicotici, Antivirali, Antielmintici, antiprotozoari e<br />
antiectoparassiti, Farmaci antineoplastici.<br />
3.0 Tossicologia.<br />
Tossicologia generale, Valutazione del rischio, Mutagenesi.<br />
Cancerogenesi, Teratogenesi, Tossicologia sistemica <strong>degli</strong> apparati, Farmacologia delle tossico<strong>di</strong>pendenze.<br />
Tossicologia alimentare e ambientale.<br />
4.0 Lo sviluppo <strong>di</strong> un farmaco.<br />
Sviluppo preclinico, clinico, aspetti etici della sperimentazione, farmacovigilanza.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso, articolato in lezioni frontali in aula, è sud<strong>di</strong>viso in moduli monotematici svolto e coor<strong>di</strong>nato dallo<br />
stesso docente, per almeno 5 ore settimanali e un totale <strong>di</strong> circa 60 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica.<br />
Esame finale <strong>di</strong> verifica e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in una prova orale nella quale il can<strong>di</strong>dato dovrà <strong>di</strong>mostrare <strong>di</strong> aver acquisito una<br />
preparazione approfon<strong>di</strong>ta dei vari meccanismi <strong>di</strong>namici e cinetici e tossicologici dei farmaci. Il can<strong>di</strong>dato<br />
dovrà conoscere, inoltre, i principi generali <strong>di</strong> tossicologia e <strong>di</strong> chemioterapia<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento:<br />
GOODMAN & GILMAN, Le basi farmacologiche della terapia, 9. ed. it., McGraw-Hill.<br />
PAOLETTI, NICOSIA, CLEMENTI, FUMAGALLI, Tossicologia generale e molecolare, UTET.<br />
RANG, DALE, RITTER, Farmacologia, Ambrosiana.<br />
CASARET, DOULL’S, Tossicologia, Klassen Lmsi Ed.ne.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: lun., ore 10-12 e 16-18.
CORSO DI LAUREA IN INFORMAZIONE SCIENTIFICA SUL FARMACO<br />
BIOLOGIA VEGETALE ED ANIMALE<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea in Informazione Scientifica sul Farmaco)<br />
Attività formativa: A (<strong>di</strong> base);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare BIO/13; cre<strong>di</strong>ti formativi: 10<br />
I Anno, I Semestre<br />
prof. Italo Stipani<br />
Finalità del Corso<br />
La Biologia animale e vegetale ha lo scopo <strong>di</strong> fornire agli studenti le conoscenze <strong>di</strong> base che regolano la<br />
materia vivente e gli organismi viventi (animali e vegetali) e rappresenta un utile substrato per le altre<br />
materie biologiche del loro Corso <strong>di</strong> laurea.<br />
Contenuto del Corso<br />
Introduzione alla Biologia come scienza sperimentale. Caratteristiche <strong>degli</strong> organismi viventi.<br />
Classificazione regni. Teoria cellulare. Procarioti ed eucarioti. Virus e batteri. Evoluzione della specie. La<br />
selezione naturale e l’adattamento. Ere<strong>di</strong>tarietà Lamarckiana e Darwiniana. Meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o delle cellule.<br />
Microscopia ottica e microscopia elettronica. Le membrane biologiche. Trasporto attraverso le membrane.<br />
Proteine strutturali e proteine <strong>di</strong> adesione. Il citoscheletro. Fibra muscolare. Sarcomero. Actina e miosina.<br />
Meccanismo molecolare della contrazione. Reticolo endoplasmatico liscio e rugoso. Involucro nucleare.<br />
Complesso del poro nucleare. Apparato del Golgi. Gli organelli cellulari. Il genoma <strong>degli</strong> organelli. Il<br />
Nucleo. Cromatina. Organizzazione della cromatina. I singoli filamenti <strong>di</strong> DNA: i geni. Istoni e proteine nonistoniche.<br />
Formazione dei nucleosomi. Cromosomi. Ciclo cellulare. Mitosi. Ribosomi. Il nucleolo. Co<strong>di</strong>ce<br />
genetico, codon e anticodon. Cenni sulla sintesi proteica. La riproduzione: asessuata e sessuata. I benefici del<br />
sesso: cellule somatiche e germinali. Meiosi: descrizione generale. Differenze fra meiosi e mitosi. La<br />
ricombinazione del patrimonio genetico. Crossing/over. Gametogenesi: cellula uovo e spermatozoo. La<br />
fecondazione. Processo acrosomiale. La cellula vegetale. I plasti<strong>di</strong>. I vacuoli e il turgore cellulare. La parete<br />
cellulare: funzione e formazione. Organizzazione della pianta: fusto, ra<strong>di</strong>ce e foglia. I principali tessuti della<br />
pianta. Tessuto epidermico. Tessuto vascolare. Xilema e Floema. Tessuto fondamentale. Cenni <strong>di</strong> anatomia<br />
della pianta. Angiosperme e gimnosperme. Il fiore. Il frutto. Il seme. Riproduzione nelle angiosperme.<br />
Cloroplasti. Differenze con i mitocondri. Principali componenti: la clorofilla e i fotosistemi. Le reazioni alla<br />
luce: la fotosintesi e la formazione <strong>di</strong> ossigeno. Schema Z. Le reazioni al buio e la fissazione dell’anidride<br />
carbonica. Sintetica descrizione del Ciclo <strong>di</strong> Calvin-Benson. Cenni <strong>di</strong> Genetica. Fenotipo/genotipo.<br />
Dominante/recessivo. Le leggi <strong>di</strong> Mendel. Genetica umana: determinazione del sesso; ere<strong>di</strong>tà legata al sesso.<br />
Il cariotipo umano normale. Mappe genetiche. Malattie genetiche (sindrome <strong>di</strong> Down). Gruppi sanguigni<br />
dell’uomo. Tassonomia. Nomenclatura linneana. I cinque regni <strong>degli</strong> esseri viventi: principali classificazioni.<br />
Cenni <strong>di</strong> Ecologia. Concetto <strong>di</strong> ecosistema. Habitat. Nicchia ecologica. Fattori ambientali. Ambienti<br />
biologici. Comportamento. Catena alimentare. Pirami<strong>di</strong> ecologiche.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso è articolato in lezioni in aula per almeno 5 ore settimanali per un totale <strong>di</strong> 60/65 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica<br />
frontale con l’ausilio <strong>di</strong> supporti informatici.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame finale consiste in una prova orale.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento e materiale <strong>di</strong>dattico:<br />
SOLOMON ET ALII, Biologia, E<strong>di</strong>SES, (voll. I e II).<br />
PURVES ET ALII, Biologia, Zanichelli.<br />
S.L. WOLFE, Biologia molecolare e cellulare, E<strong>di</strong>SES.<br />
P.H. RAVEN, G.B. JOHNSON, Biologia, E<strong>di</strong>SES, (voll. I e II).<br />
Tutto il materiale <strong>di</strong>dattico delle lezioni è riportato su supporto elettronico ed è messo a <strong>di</strong>sposizione <strong>degli</strong><br />
studenti per la consultazione nei computer dell’aula <strong>di</strong>dattica.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: mar., mer., ore 9-10; gio., ore 17-19.<br />
CHIMICA GENERALE ED INORGANICA
(Corso <strong>di</strong> laurea in Informazione Scientifica sul Farmaco)<br />
Attività formativa: A (<strong>di</strong> base);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare CHIM/03; cre<strong>di</strong>ti formativi: 11<br />
I Anno, I Semestre<br />
proff. Carlo Fragale e Concetta Pacifico<br />
Finalità del Corso<br />
Il Corso intende potenziare negli studenti le capacità <strong>di</strong> analisi della fenomenologia quoti<strong>di</strong>ana e formare la<br />
piattaforma culturale necessaria alla comprensione delle <strong>di</strong>scipline successive.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
Elementi <strong>di</strong> Matematica usuale. Funzioni e grafici. La Teoria Atomica: Dalle leggi ponderali al principio <strong>di</strong><br />
Avogadro. Atomo e particelle subatomiche. Isotopi. Massa atomica. La mole. Nomenclatura. Formule<br />
chimiche. Numero <strong>di</strong> ossidazione. Equazioni chimiche e bilanciamento. Reagente limitante. Struttura<br />
dell'atomo: Natura della luce e spettri. Modelli atomici. Numeri quantici. Orbitali. Aufbau e sistema<br />
perio<strong>di</strong>co. Il legame chimico: Legame metallico, ionico, covalente, covalente polare. Elettronegatività.<br />
Formule <strong>di</strong> Lewis. Geometria molecolare. Teoria dell’orbitale molecolare. Forze secondarie <strong>di</strong> legame.<br />
Legame a idrogeno. I gas: Comportamento ideale ed equazione <strong>di</strong> stato. Modello cinetico. Comportamento<br />
dei gas reali e liquefazione. Soli<strong>di</strong> cristallini ed amorfi. Struttura e proprietà. Allotropia. Stati <strong>di</strong><br />
aggregazione. Fasi. Sistemi omogenei ed eterogenei. Cambiamenti <strong>di</strong> stato. Diagrammi <strong>di</strong> fase. Le soluzioni:<br />
Unità <strong>di</strong> concentrazione. Elettroliti e non elettroliti. Legge <strong>di</strong> Raoult e proprietà colligative. Osmosi.<br />
Distillazione. Le reazioni chimiche (tipologia e riscontri): Reazioni acido-base (Arrhenius, Bronsted, Lewis),<br />
redox, <strong>di</strong> precipitazione. Titolazioni. Trasformazioni ed energia. Calorimetria. Legge <strong>di</strong> Hess. Spontaneità <strong>di</strong><br />
una trasformazione ed equilibrio. L’equilibrio chimico: Legge <strong>di</strong> azione <strong>di</strong> massa. Costante <strong>di</strong> equilibrio.<br />
L’equilibrio mobile. Equilibri eterogenei. Solubilità. Ripartizione. La legge <strong>di</strong> Henry. Equilibri in soluzione:<br />
Gli equilibri acido-base: Auto-ionizzazione dell’acqua. Il pH. Soluzioni <strong>di</strong> aci<strong>di</strong> e basi forti. Aci<strong>di</strong> e basi<br />
deboli. Grado <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssociazione e pH. Idrolisi. Soluzioni tampone. In<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> pH. Aci<strong>di</strong> poliprotici. Anfoliti.<br />
Titolazioni acido-base. Elettrochimica: Celle galvaniche e celle elettrolitiche. L’equazione <strong>di</strong> Nernst. Pile<br />
commerciali. Le leggi <strong>di</strong> Faraday. Corrosione. Elementi <strong>di</strong> Chimica inorganica: Il comportamento <strong>degli</strong><br />
elementi e la Tavola Perio<strong>di</strong>ca. Processo soda-cloro, ammoniaca, acido solforico, alluminio, soda Solvay.<br />
L’atmosfera. Le acque. Il carsismo come fenomeno territoriale pugliese. Cenni <strong>di</strong> cinetica chimica:<br />
Meccanismi <strong>di</strong> reazione e catalisi. Ra<strong>di</strong>oattività. Reazioni nucleari. Datazione con 14 C.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso, articolato in lezioni ed esercitazioni in aula, per almeno 7 ore settimanali con un totale <strong>di</strong> circa 80<br />
ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica frontale.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in una prima prova scritta contenente problemi numerici e quesiti a carattere descrittivo. La<br />
successiva prova orale, alla quale si accede dopo il superamento della prova scritta, verte essenzialmente<br />
sugli argomenti trattati nella prima prova.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento e materiale <strong>di</strong>dattico:<br />
G. BANDOLI, A. DOLMELLA, G. NATILE, Chimica <strong>di</strong> base, E<strong>di</strong>SES.<br />
SACCO ET ALII, Chimica Generale ed Inorganica, Ambrosiana.<br />
NOBILE ET ALII, La chimica <strong>di</strong> base attraverso gli esercizi, Ambrosiana.<br />
Appunti Power Point nei computer dell’aula <strong>di</strong>dattica.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: lun., mar., gio., ore 11,30-13.
FISICA CON ELEMENTI DI MATEMATICA<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea in Informazione Scientifica sul Farmaco)<br />
Attività formativa: A (<strong>di</strong> base);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare FIS/01; cre<strong>di</strong>ti formativi: 10<br />
I Anno, I Semestre<br />
prof. Roberto Bellotti<br />
Finalità del Corso<br />
Il Corso è svolto tenendo in considerazione che esso fa parte del primo gruppo <strong>di</strong> materie affrontate da<br />
studenti neo maturati o <strong>di</strong>plomati. Gli obiettivi del Corso possono essere così sintetizzati:<br />
- Applicazione dello strumento matematico per la comprensione e modellizzazione <strong>di</strong> fenomeni naturali, in<br />
particolare fisici;<br />
- Comprensione delle leggi fisiche elementari (meccanica, termo<strong>di</strong>namica ed elettromagnetismo classico)<br />
attraverso un approccio fenomenologico;<br />
- Comprensione “operativa” delle leggi fisiche attraverso lo sviluppo della attitu<strong>di</strong>ne al “problem solving”.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
Grandezze fisiche e unità <strong>di</strong> misura.<br />
Cinematica uni<strong>di</strong>mensionale.<br />
Calcolo vettoriale.<br />
Cinematica nello spazio.<br />
Leggi della <strong>di</strong>namica.<br />
Dinamica dei sistemi <strong>di</strong> punti materiali.<br />
Lavoro ed energia.<br />
Meccanica dei flui<strong>di</strong>.<br />
Termo<strong>di</strong>namica.<br />
Elettromagnetismo.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso, articolato in lezioni ed esercitazioni in aula, per almeno 5 ore settimanali con un totale <strong>di</strong> circa 60<br />
ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica frontale.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in una prima prova scritta nella quale si dovranno risolvere cinque problemi numerici,<br />
relativi al programma svolto.<br />
La successiva prova orale, alla quale si accede dopo il superamento della prova scritta, verte essenzialmente<br />
sugli argomenti trattati durante il Corso.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento e materiale <strong>di</strong>dattico:<br />
HALLIDAY, RESNICK, WALKER, Fondamenti <strong>di</strong> Fisica, Ambrosiana.<br />
GIANCOLI, Fisica, Ambrosiana.<br />
RAGOZZINO, GIORDANO, MILANO, Fondamenti <strong>di</strong> Fisica, E<strong>di</strong>SES.<br />
CAPITELLI, CELIBERTO, LONGO, Termo<strong>di</strong>namica e Cinetica Chimica, Adriatica.<br />
Le prove scritte d’esame sono inserite nei computer dell’aula <strong>di</strong>dattica e <strong>di</strong>sponibile, in <strong>formato</strong> “.doc” sul<br />
sito web www.robertobellotti.com, nella sezione de<strong>di</strong>cata agli studenti della Facoltà <strong>di</strong> Farmacia.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: mar. e gio., ore 10,30-12,30.
ANATOMIA UMANA<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea in Informazione Scientifica sul Farmaco)<br />
Attività formativa: A (<strong>di</strong> base);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare BIO/16; cre<strong>di</strong>ti formativi: 11<br />
I Anno, II Semestre<br />
prof. Lorenzo Bosco<br />
Finalità del Corso<br />
Il Corso è finalizzato allo stu<strong>di</strong>o dell’Anatomia dei sistemi e <strong>degli</strong> organi.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
La terminologia anatomica. I piani anatomici. Generalità sugli organi e sugli apparati.<br />
Apparato emolinfopoietico:<br />
Il midollo osseo e le sue se<strong>di</strong>. Il sangue. I principali collettori linfatici. Il timo. La milza. I linfono<strong>di</strong>.<br />
Apparato car<strong>di</strong>ocircolatorio:<br />
Il me<strong>di</strong>astino ed il suo contenuto. Il cuore ed il pericar<strong>di</strong>o. La grande e la piccola circolazione. Le arterie e le<br />
vene della circolazione polmonare. La vascolarizzazione e l’innervazione del cuore. L’aorta e le sue<br />
collaterali (generalità). Le vene cave ed i loro affluenti (generalità).<br />
Apparato respiratorio:<br />
Il naso. Il faringe. Il laringe. La trachea. I bronchi. I polmoni. Le pleure.<br />
Apparato <strong>di</strong>gerente:<br />
La cavità buccale e le ghiandole salivari. L’istmo delle fauci e l’orofaringe. L’esofago. Lo stomaco.<br />
L’intestino tenue. L’intestino crasso. Il pancreas. Il fegato.<br />
Apparato urinario:<br />
Il rene. La pelvi renale e gli ureteri. La vescica. L’uretra.<br />
Apparato genitale maschile:<br />
Il pene. Lo scroto. I testicoli. Le vie spermatiche. Le vescichette seminali.<br />
Il sistema nervoso:<br />
Generalità sul sistema nervoso. Le meningi. Il midollo spinale. Il tronco encefalico (bulbo, ponte,<br />
mesencefalo). Il cervelletto. Il cervello (generalità). Il telencefalo. Il <strong>di</strong>encefalo. Il cervello nel controllo del<br />
comportamento. I nervi cranici. Le vie motrici. Le vie sensitive. L’occhio (generalità). L’orecchio<br />
(generalità). Il sistema nervoso centrale: plesso cervicale, plesso brachiale, plesso lombare, plesso sacrale. Il<br />
sistema nervoso autonomo: ortosimpatico, parasimpatico.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso, prevede 5 ore settimanali con un totale <strong>di</strong> almeno 60 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica frontale.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in una prova scritta nella quale si dovrà rispondere in maniera concisa a quesiti <strong>di</strong> carattere<br />
generale e in una successiva prova orale che riguarderà sia gli argomenti trattati nella prova scritta, sia gli<br />
altri argomenti del programma.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento e materiale <strong>di</strong>dattico:<br />
J.B. WALTER, Patologia generale e fisiopatologia, Napoli, E<strong>di</strong>SES,<br />
A. STEVENS, J. LOWE, Patologia, Milano, Ambrosiana.<br />
JUNQUEIRA, CARNEIRO, KELLY, Compen<strong>di</strong>o <strong>di</strong> istologia, Piccin, 1991.<br />
BARR, Anatomia del sistema nervoso, McGraw-Hill, 1992.<br />
BUCCIANTE, Anatomia umana, Piccin, 1986.<br />
NETTER, Atlante <strong>di</strong> anatomia umana, Masson, 2001.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: sab., ore 12-13.
CHIMICA ORGANICA<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea in Informazione Scientifica sul Farmaco)<br />
Attività formativa: C (affini o integrativi);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare: CHIM/06; cre<strong>di</strong>ti formativi: 11<br />
II Anno, I Semestre<br />
prof. Vito Capriati<br />
www.farmchim.uniba.it/chimica_organica/C.V.Capriati.html<br />
Finalità del Corso<br />
Lo scopo del presente Corso annuale è <strong>di</strong> mettere in luce i principi fondamentali della Chimica organica, i<br />
suoi aspetti applicativi e le connessioni che questa ha con la vita <strong>di</strong> tutti i giorni e con i processi biologici.<br />
Contenuti del Corso per argomenti<br />
Alcani e Cicloalcani: struttura, nomenclatura, isomeria, conformazioni e reazioni. Alcheni e Alchini:<br />
struttura, nomenclatura e reazioni <strong>di</strong> ad<strong>di</strong>zione elettrofila. Terpeni: struttura e presenza in natura. Chiralità e<br />
Stereoisomeria: sistema R,S; risoluzione ottica <strong>di</strong> enantiomeri. Alogenuri alchilici: nomenclatura;<br />
sostituzione nucleofila alifatica: meccanismi SN1 e SN2; β-eliminazioni: meccanismi E1 e E2. Aci<strong>di</strong>tà e<br />
basicità. Alcooli, Eteri, Epossi<strong>di</strong> e Tioli: nomenclatura e reattività. Benzene e suoi derivati: nomenclatura,<br />
aromaticità e reazioni <strong>di</strong> sostituzioni elettrofila aromatica. Fenoli: struttura, nomenclatura, aci<strong>di</strong>tà. Sistemi<br />
Eterocicli pentatomici, esatomici e sistemi condensati corrispondenti: nomenclatura e reattività. Ammine:<br />
nomenclatura e basicità; immine e enammine. Aldei<strong>di</strong> e Chetoni: nomenclatura; ad<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> nucleofili con<br />
centro reattivo sul carbonio, sull’ossigeno, sull’azoto. Tautomeria cheto-enolica. Aci<strong>di</strong> carbossilici e loro<br />
derivati funzionali: nomenclatura; reazione <strong>di</strong> esterificazione e interconversione <strong>di</strong> gruppi funzionali. Anioni<br />
enolato: reazione aldolica e condensazione <strong>di</strong> Claisen. Carboidrati: struttura, nomenclatura, stereochimica e<br />
reattività dei principali monosaccari<strong>di</strong>; mutarotazione; formazione <strong>di</strong> glicosi<strong>di</strong>; <strong>di</strong>saccari<strong>di</strong> e polisaccari<strong>di</strong>.<br />
Lipi<strong>di</strong>: trigliceri<strong>di</strong>; saponi e detergenti; prostaglan<strong>di</strong>ne; steroi<strong>di</strong>; fosfolipi<strong>di</strong>. Amminoaci<strong>di</strong>: struttura, chiralità<br />
e punto isoelettrico. Polipepti<strong>di</strong> e proteine. Nucleosi<strong>di</strong>, nucleoti<strong>di</strong> e aci<strong>di</strong> nucleici: generalità.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso è articolato in lezioni ed esercitazioni in aula per 7 ore settimanali per un totale <strong>di</strong> 60 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica<br />
frontale.<br />
Esame finale<br />
L’esame finale consiste in un colloquio orale <strong>di</strong> circa 30 min. in cui lo studente è invitato a <strong>di</strong>mostrare <strong>di</strong><br />
essere in possesso delle conoscenze teoriche <strong>di</strong> base della chimica organica. Si chiede inoltre <strong>di</strong> risolvere<br />
alcuni semplici esercizi relativi alla reattività e alle trasformazioni dei più comuni gruppi funzionali.<br />
Siti web <strong>di</strong> utile consultazione<br />
www.cem.msu.edu/~parrill/ (materiale educativo per la chimica organica);<br />
www.chempensoftware.com/organicreactions.htm (reazioni organiche classiche);<br />
www.chem.qmul.ac.uk/iupac/ (nomenclatura IUPAC); www.organicworldwide.net/tutorial.html (tutorial in<br />
chimica organica).<br />
Testi consigliati:<br />
W.H. BROWN, Introduzione alla Chimica organica, Napoli, E<strong>di</strong>SES, 2001.<br />
W.H. BROWN, C.S. FOOTE, Chimica organica, Napoli, E<strong>di</strong>SES, 1999.<br />
W.H. BROWN, B.L. IVERSON, S.A. IVERSON, Guida alla soluzione dei problemi <strong>di</strong> Chimica organica, Napoli,<br />
E<strong>di</strong>SES, 1997.<br />
HAROLD, HART, L. E. CRAINE, D.J. HART, Chimica organica, Zanichelli, Bologna, 2003.<br />
R. MACOMBER, Chimica organica, Bologna, Zanichelli, 2001.<br />
M.A. FOX, J.K. WHITESELL, Chimica Organica, Bologna, Zanichelli, 1997.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: lun., mar., mer., ore 14,30-16,30.
MICROBIOLOGIA ED IGIENE<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea in Informazione Scientifica sul Farmaco)<br />
Attività formativa: C (affini o integrativi);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare: MED/42 e MED/07; cre<strong>di</strong>ti formativi: 10<br />
II Anno, I Semestre<br />
prof. Danila De Vito<br />
Finalità del Corso<br />
Il Corso si propone <strong>di</strong> fornire allo studente conoscenze e competenze relative alla prevenzione delle malattie<br />
e alla promozione della salute, all’organizzazione sanitaria. Esso intende perciò avviare lo studente alla<br />
conoscenza dei determinanti <strong>di</strong> malattia e dei sistemi <strong>di</strong> sorveglianza sanitaria; alla comprensione dei<br />
meccanismi <strong>di</strong> insorgenza e <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffusione delle malattie e del loro impatto sulle comunità; all’appren<strong>di</strong>mento<br />
dei principi e delle strategie della me<strong>di</strong>cina preventiva e della promozione della salute.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
Generalità sui microrganismi. Principi <strong>di</strong> immunologia. Allergia ed ipersensibilità. Classificazione dei<br />
batteri. Gram-negativi. Gram-negativi anaerobi. Gram-positivi. Miceti. Flora batterica normale nell’uomo.<br />
Virus: proprietà generali. Classificazione dei virus. Batteriofagi. Protozoi patogeni per l’uomo. Storia,<br />
significato e scopi dell’Igiene. Organizzazione Sanitaria Nazionale. I servizi sanitari: l’Ospedale. Me<strong>di</strong>cina<br />
preventiva ed educazione sanitaria. Epidemiologia descrittiva. Epidemiologia analitica. Epidemiologia<br />
sperimentale. Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive. I fenomeni immunitari. Notifica;<br />
contumacia; accertamenti <strong>di</strong> laboratorio; chemio-antibiotico profilassi. Vaccinazioni obbligatorie e<br />
facoltative e loro calendario; preparazioni vaccinali. La sieroprofilassi: sieri eterologhi, omologhi,<br />
iperimmuni, specifici e gammaglobuline.<br />
Disinfezione. Influenza, epatiti da virus, morbillo, tubercolosi, tifo addominale, brucellosi, colera,<br />
toxoplasmosi. Igiene dell’ambiente fisico: meccanismi <strong>di</strong> termoregolazione, parametri fisici del microclima e<br />
loro rilevamento. Lo smaltimento dei liquami domestici. Lo smaltimento dei rifiuti soli<strong>di</strong>. Igiene <strong>degli</strong><br />
alimenti: tossinfezioni alimentari: da Stafilococco, Salmonelle, Bacillo botulino. Latte come veicolo <strong>di</strong><br />
malattie. La bonifica del latte. L’acqua potabile: fonti <strong>di</strong> approvvigionamento idrico, criteri <strong>di</strong> potabilità,<br />
potabilizzazione delle acque.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso articolato in lezioni frontali in aula per 5 ore settimanali con un totale <strong>di</strong> 60 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica frontale.<br />
Il Corso è sud<strong>di</strong>viso in moduli monotematici.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in una prova orale sugli argomenti relativi al programma in allegato.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento e materiale <strong>di</strong>dattico:<br />
POLI, COCUZZA, NICOLETTI, Microbiologia Me<strong>di</strong>ca, UTET, 1993. BARBUTI, BELELLI, FARA, GIAMMANCO,<br />
Igiene e Me<strong>di</strong>cina Preventiva, Bologna, Monduzzi, 2003.<br />
CHECCACCI, MELONI, PELISSERO, Igiene, Milano, Ambrosiana, 1992.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: mer., ore 10-11.
BIOCHIMICA<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea in Informazione Scientifica sul Farmaco)<br />
Attività formativa: A (<strong>di</strong> base);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare BIO/10; cre<strong>di</strong>ti formativi: 11<br />
II Anno, II Semestre<br />
prof. Fer<strong>di</strong>nando Palmieri<br />
Finalità del Corso<br />
Il Corso <strong>di</strong> Biochimica ha l’obiettivo <strong>di</strong> fornire agli studenti le conoscenze sulla struttura e funzione delle<br />
principali classi <strong>di</strong> molecole biologiche e sulle loro trasformazioni nella <strong>di</strong>namica cellulare, sulla regolazione<br />
dei processi metabolici e sui meccanismi <strong>di</strong> conservazione e trasmissione dell’informazione genica. Oggetto<br />
<strong>di</strong> questo Corso sono anche le principali meto<strong>di</strong>che sperimentali <strong>di</strong> interesse biochimico.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
La cellula ed i suoi compartimenti. Zuccheri. Lipi<strong>di</strong>. Nucleoti<strong>di</strong>. Amminoaci<strong>di</strong>. Legame pepti<strong>di</strong>co e pepti<strong>di</strong>.<br />
Proteine: proprietà e funzioni. Struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria delle proteine.<br />
Denaturazione e rinaturazione delle proteine. Purificazione e criteri <strong>di</strong> purezza. Relazioni tra struttura<br />
tri<strong>di</strong>mensionale e attività biologica delle proteine. Mioglobina ed emoglobina. Enzimi: struttura, funzione,<br />
classificazione e specificità. Cofattori. Coenzimi. Cinetica enzimatica. Inibizione enzimatica. Meccanismo<br />
d’azione <strong>degli</strong> enzimi. Isoenzimi e ribozimi. Sistemi multienzimatici ed enzimi allosterici. Regolazione<br />
dell’attività enzimatica. Struttura e funzione delle membrane biologiche. Trasportatori, pompe e canali<br />
ionici. Recettori ormonali e meccanismi <strong>di</strong> trasduzione dei segnali. Principi <strong>di</strong> termo<strong>di</strong>namica e principi <strong>di</strong><br />
bioenergetica. Energia libera. Composti “ad alta energia”. Reazioni eso- ed endoergoniche. Processi<br />
d’accoppiamento. Le vie metaboliche e la loro regolazione. Glicolisi. Catabolismo <strong>di</strong> esosi <strong>di</strong>versi dal<br />
glucosio. Fermentazione alcolica e lattica. Gluconeogenesi. Degradazione e biosintesi del glicogeno. Via dei<br />
pentosi fosfato. Degradazione dei lipi<strong>di</strong>. β-ossidazione <strong>degli</strong> aci<strong>di</strong> grassi. Ciclo <strong>di</strong> Krebs. Catena <strong>di</strong> trasporto<br />
<strong>degli</strong> elettroni e fosforilazione ossidativa. Corpi chetonici. Sintesi <strong>degli</strong> aci<strong>di</strong> grassi, dei trigliceri<strong>di</strong> dei<br />
fosfoglicerolipi<strong>di</strong> e <strong>degli</strong> sfingolipi<strong>di</strong>. Biosintesi del colesterolo. Metabolismo <strong>degli</strong> amminoaci<strong>di</strong>.<br />
Metabolismo delle basi puriniche e pirimi<strong>di</strong>niche. Sintesi dell’urea. Metabolismo dell’eme. Ormoni e<br />
meccanismi d’azione. Aci<strong>di</strong> nucleici e informazione genetica. DNA: struttura e proprietà. Geni e cromosomi.<br />
Replicazione del DNA. Struttura e funzione dell’RNA messaggero, dell’RNA ribosomiale e dell’RNA<br />
transfer. Sintesi <strong>di</strong> RNA DNA-<strong>di</strong>pendente. Maturazione dell’RNA. Sintesi <strong>di</strong> DNA RNA-<strong>di</strong>pendente. Co<strong>di</strong>ce<br />
genetico. Ribosomi: struttura e funzione. Attivazione <strong>degli</strong> amminoaci<strong>di</strong>. Biosintesi delle proteine.<br />
Mo<strong>di</strong>ficazioni post-traduzionali delle proteine. Tecniche biochimiche: spettrofotometria, centrifugazione,<br />
cromatografia, tecniche isotopiche, dosaggi enzimatici.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso è articolato in lezioni in aula per almeno 5 ore settimanali, con un totale <strong>di</strong> circa 60 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica<br />
frontale ed esercitazioni in laboratorio.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in una prima prova scritta nella quale si dovrà rispondere a 20 quesiti a risposta multipla<br />
giustificando la risposta scelta e ad una domanda a risposta aperta. La successiva prova orale, alla quale si<br />
accede dopo il superamento della prova scritta, verte essenzialmente sugli argomenti trattati nella prima<br />
prova.<br />
Testo <strong>di</strong> riferimento:<br />
NELSON, COX, I principi <strong>di</strong> Biochimica <strong>di</strong> Lehninger, Zanichelli.<br />
Testi <strong>di</strong> consultazione:<br />
STREYER, Biochimica, Zanichelli.<br />
MATHEWS, VAN HOLDE, Biochimica, Ambrosiana.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: mar., ore 9,30-10,30; ven., ore 8,30-9,30.
FISIOLOGIA GENERALE<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea in Informazione Scientifica sul Farmaco)<br />
Attività formativa: C (affini o integrativi);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare BIO/ 09; cre<strong>di</strong>ti formativi: 11<br />
II Anno, II Semestre<br />
prof. Enrico Gallucci<br />
Finalità del Corso<br />
Il Corso <strong>di</strong> Fisiologia generale viene svolto spiegando le funzioni vitali <strong>degli</strong> animali e dell’uomo. Analizza<br />
come gli organismi viventi mantengano l’omeostasi del mezzo interno a livello molecolare, cellulare e<br />
tissutale al variare dell’ambiente circostante. I meccanismi fondamentali delle funzioni biologiche vengono<br />
affrontati considerando i principi fisico-chimici alla loro base.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
Processi <strong>di</strong> trasporto attraverso le membrane biologiche. Diffusione passiva. Il potenziale <strong>di</strong> flusso.<br />
Diffusione <strong>degli</strong> elettroliti. Trasporto attivo. I neuroni e le cellule gliali. Potenziale <strong>di</strong> membrana e sua<br />
genesi. Potenziale d’azione o impulso nervoso. Conduzione dell’impulso nervoso nelle fibre mieliche e<br />
amieliche. Proprieta' generali dei sistemi sensoriali. Recettori: classificazione e proprietà generali. Sistema<br />
nervoso centrale. Cenni anatomici. Funzioni della corteccia motoria e dei gangli della base. Connessioni<br />
afferenti alla corteccia motoria. Vie efferenti: piramidale ed extrapiramidale. Funzioni del sistema limbico.<br />
Funzioni ipotalamiche. Sistema ipotalamo-ipofisi. Sistema nervoso vegetativo. Controllo spinale della<br />
motilità. Riflessi motori spinali: caratteristiche. Tono posturale. Controllo bulbo-pontino della motilità.<br />
Cervelletto: controllo cerebellare dei movimenti. Sistema muscolare. Contrazione del muscolo scheletrico<br />
liscio e car<strong>di</strong>aco. Sistema car<strong>di</strong>ovascolare. Attività elettrica del cuore. Conduzione delle fibre car<strong>di</strong>ache.<br />
Eccitazione naturale del cuore ECG. La pompa car<strong>di</strong>aca. Il ciclo car<strong>di</strong>aco. Gettata car<strong>di</strong>aca e sua regolazione.<br />
Il controllo del cuore. Emo<strong>di</strong>namica. Funzione del sistema renale per funzioni. Sistema gastrointestinale.<br />
Funzione del sistema respiratorio. Sistema endocrino.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso, articolato in lezioni ed esercitazioni in aula, è sud<strong>di</strong>viso in una parte generale <strong>di</strong> base in cui viene<br />
stu<strong>di</strong>ata la biofisica, l’elettrofisiologia, le funzioni dei sistemi <strong>di</strong> trasporto e <strong>di</strong> comunicazioni nelle<br />
membrane biologiche. Una parte speciale riguardante il funzionamento dei vari organi e loro integrazione nel<br />
contesto del funzionamento dell’organismo. Il docente della <strong>di</strong>sciplina, svolge 5 ore settimanali con un totale<br />
<strong>di</strong> circa 60 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica frontale.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in una prima prova scritta in cui agli studenti vengono posti <strong>di</strong>eci quesiti a risposta multipla<br />
(test) e una domanda finale cui si dovrà dare una risposta esauriente e concisa. La successiva prova orale,<br />
alla quale si accede dopo il superamento della prova scritta, verte essenzialmente sugli argomenti trattati<br />
nella prima prova.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento e materiale <strong>di</strong>dattico:<br />
R.M. BERNE, M.N. LEVY, Fisiologia generale, Ambrosiana.<br />
D.U. SILVERTHORN, Fisiologia, Ambrosiana.<br />
G. MONTICELLI, G. ESPOSITO, Fenomeni <strong>di</strong> trasporto ed elettrici, in membrane biologiche, Milano, Ermes.<br />
Il materiale <strong>di</strong>dattico riguardante alcuni argomenti usato nelle lezioni e nelle esercitazioni sarà riportato su<br />
supporto elettronico e inserito nei computer dell’aula <strong>di</strong>dattica, a <strong>di</strong>sposizione <strong>degli</strong> studenti.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: mer. e ven., ore 10,30-11,30.
PATOLOGIA GENERALE<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea in Informazione Scientifica sul Farmaco)<br />
Attività formativa: C (affini o integrativi);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare MED/04; cre<strong>di</strong>ti formativi: 10<br />
II Anno, II Semestre<br />
prof. Na<strong>di</strong>a Pasquetto<br />
Finalità del Corso<br />
Il Corso è svolto con l’intento <strong>di</strong> delucidare le più frequenti patologie, nonché quelle che hanno destato<br />
l’apprensione generale.<br />
A tal fine, il Corso è correlato <strong>di</strong> elementi <strong>di</strong> terminologia me<strong>di</strong>ca e <strong>di</strong> una serie numerosa <strong>di</strong> <strong>di</strong>apositive<br />
riguardanti i vari temi trattati.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
Eziologia generale.<br />
Ere<strong>di</strong>tà in patologia.<br />
Infiammazione o flogosi.<br />
Immunità.<br />
Immunopatologia.<br />
Processi regressivi e progressivi.<br />
Degenerazioni cellulari.<br />
Oncologia.<br />
Fisiopatologia <strong>degli</strong> idrati <strong>di</strong> carbonio.<br />
Fisiopatologia delle purine e delle pirimi<strong>di</strong>ne.<br />
Fisiopatologia del sangue.<br />
Fisiopatologia dell’apparato car<strong>di</strong>o-vascolare.<br />
Fisiopatologia della circolazione e dei vasi.<br />
Fisiopatologia renale.<br />
Fisiopatologia del fegato.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso, articolato in lezioni monotematiche, comprende un impegno <strong>di</strong> 5 ore settimanali per un totale <strong>di</strong><br />
circa 60 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica frontale.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in una prova orale riguardante, almeno, due argomenti del programma.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento:<br />
I. COVELLI, L. FRATI, G. ROSSI, G. VECCHIO, Patologia generale, 5. ed., Napoli, Florio, 1998.<br />
I. COVELLI, L. FRATI, Fisiopatologia generale, 5. ed., Napoli, Florio, 2001.<br />
Per il solo argomento “Ere<strong>di</strong>tà in patologia”:<br />
M.U. DIANZANI, Istituzioni <strong>di</strong> patologia generale, Torino, Uses.<br />
Per il solo argomento “Processi regressivi e progressivi”:<br />
G. M. PONTIERI, Patologia generale, Padova, Piccin.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: per appuntamento, mancando il docente <strong>di</strong> un suo stu<strong>di</strong>o.
CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA I<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea in Informazione Scientifica sul Farmaco)<br />
Attività formativa: B (caratterizzante);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare: CHIM/08; cre<strong>di</strong>ti formativi: 11<br />
III Anno, I Semestre<br />
proff. Carlo Franchini e Vincenzo Tortorella<br />
Finalità del Corso<br />
Il Corso è svolto tenendo in particolare considerazione la possibilità <strong>di</strong> correlare l’attività <strong>di</strong> ciascuna classe<br />
<strong>di</strong> farmaci alle caratteristiche chimiche della molecola. Eventuali aspetti <strong>di</strong> tipo sintetico e/o relativi a<br />
particolari meccanismi d’azione, saranno trattati soltanto nella misura in cui riescono a razionalizzare il<br />
comportamento del principio attivo a livello biologico.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
1.0 Presupposti della ricerca e della produzione <strong>di</strong> farmaci. 2.0 La nomenclatura dei farmaci. 3.0 Meccanismi<br />
molecolari dell’azione dei farmaci: le relazioni attività-struttura. 3.1 Mo<strong>di</strong>ficazioni chimiche che influenzano<br />
le fasi farmacocinetiche. 3.1.1 Ruolo delle caratteristiche chimico-fisiche del principio attivi. 3.1.2 Le<br />
reazioni metaboliche. 3.2 Mo<strong>di</strong>ficazioni chimiche che influenzano le fasi farmaco<strong>di</strong>namiche. 3.2.1<br />
Interazioni tra farmaco e sito attivo. 3.2.2 Forma spaziale della molecola e attività dei farmaci. 4.0 Le curve<br />
dose-risposta ed il meccanismo <strong>di</strong> azione dei farmaci. 5.0 I neurotrasmettitori fisiologici ed il loro ruolo sul<br />
sistema nervoso periferico e su quello centrale. 6.0 Struttura, attività ed effetti collaterali <strong>di</strong> principi attivi su.<br />
6.1 Sistema colinergico. 6.2 Sistema adrenergico. 6.3 Sistema dopaminergico. 6.4 Sistema serotoninergico.<br />
6.5 Sistema istaminergico. 6.6 Sistema oppioide. 7.0 Struttura, attività ed effetti collaterali <strong>di</strong> farmaci attivi<br />
su sistemi enzimatici e canali ionici. 7.1 Antinfiammatori non steroidei; 7.2 Antipertensivi; 7.3 Anestetici<br />
locali. 8.0 Anestetici generali, ipnotici e sedativi. Classificazione dei principi attivi e delle specialità<br />
me<strong>di</strong>cinali secondo il sistema ATC.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso, articolato in lezioni ed esercitazioni in aula, è sud<strong>di</strong>viso in moduli monotematici svolti e coor<strong>di</strong>nati<br />
dai due docenti della <strong>di</strong>sciplina, per almeno 5 ore settimanali con un totale <strong>di</strong> circa 60 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica<br />
frontale.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in una prima prova scritta nella quale si dovrà rispondere in maniera concisa su cinque<br />
quesiti <strong>di</strong> carattere generale a risposta multipla, giustificando sia la risposta esatta sia le motivazioni che<br />
rendono non corrette le altre risposte in<strong>di</strong>cate. Si dovrà, inoltre, rispondere a 15 quesiti a risposta multipla e<br />
relativi al programma svolto. La successiva prova orale, alla quale si accede dopo il superamento della prova<br />
scritta, verte essenzialmente sugli argomenti trattati nella prima prova.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento e materiale <strong>di</strong>dattico:<br />
E. SCHROEDER, C. RUFER, R. SCHMIECHEN, Chimica farmaceutica, (voll. I e II), Napoli, E<strong>di</strong>SES, c1991.<br />
WERMUTH, Le applicazioni della chimica farmaceutica, Napoli, E<strong>di</strong>SES, 2001.<br />
V. TORTORELLA, La farmacia ed il concorso, Napoli, E<strong>di</strong>SES, 1997.<br />
FOYE, LEMKE, WILLIAMS, Principi <strong>di</strong> Chimica farmaceutica, Piccin, 1998.<br />
Tutto il materiale <strong>di</strong>dattico usato nelle lezioni è inserito nei computer dell’aula <strong>di</strong>dattica, a <strong>di</strong>sposizione <strong>degli</strong><br />
studenti. Sarà fornita anche una copia cartacea del materiale utilizzato durante lezioni ed esercitazioni, che<br />
gli studenti potranno duplicare a loro spese.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: prof. Franchini, lun., mar., mer., ore 17-19; prof. Tortorella, lun., ore 10,30-11,30;<br />
gio., ore 11,30-12,30; ven., ore 9-10.
FARMACOLOGIA E FARMACOTERAPIA<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea in Informazione Scientifica sul Farmaco)<br />
Attività formativa: B (caratterizzante);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare BIO/14;cre<strong>di</strong>ti formativi: 11<br />
III Anno, I Semestre<br />
proff. Diana Conte e Annamaria De Luca<br />
Finalità del Corso<br />
Fornire allo studente competenze riguardanti i principi generali dei meccanismi dell’azione dei farmaci,<br />
nonché le classi <strong>di</strong> agenti farmacologici utilizzati a scopi terapeutici.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
Parte prima. Farmacologia generale. Recettori fisiologici e altri bersagli dell’azione dei farmaci; Sistemi <strong>di</strong><br />
trasduzione del segnale; Concetti <strong>di</strong> desensitizzazione recettoriale. Curve dose-risposta, Affinità, attività<br />
intrinseca, potenza ed efficacia; Agonismo, antagonismo, agonismo parziale ed inverso. Farmacocinetica:<br />
somministrazione; assorbimento, <strong>di</strong>stribuzione, metabolismo ed escrezione dei farmaci; Posologia.<br />
Farmacogenomica.<br />
Parte seconda. Farmacologia e Farmacoterapia I. Farmacologia del sistema nervoso autonomo e periferico:<br />
Neurotrasmettitori e recettori. Farmacologia dei sistemi <strong>di</strong> regolazione del tono muscolare (NO, endoteline,<br />
bra<strong>di</strong>chinine, prostaglan<strong>di</strong>ne, canali ionici e recettori) e della trasmissione nervosa periferica<br />
(anticolinesterasici. Curari. Anestetici locali). Farmacologia dei processi infiammatori: La cascata dell’acido<br />
arachidonico e gli eicosanoi<strong>di</strong>. Antiinfiammatori non steroidei e glucocorticoi<strong>di</strong>. Inibitori della<br />
lipoossigenasi. Antagonisti dei leucotrieni. Istamina e gli inibitori dei recettori H 1. Farmaci attivi su cuore,<br />
circolo e apparato respiratorio: Omeostasi car<strong>di</strong>ovascolare. Antiipertensivi; Diuretici; Farmaci utilizzati nello<br />
scompenso car<strong>di</strong>aco; Antianginosi ed Antiaritmici; Antiaggreganti, anticoagulanti e fibrinolitici. Trattamento<br />
delle <strong>di</strong>slipidemie. Farmaci bronco<strong>di</strong>latatori; Mucolitici e antitussivi. Farmacologia del Sistema Nervoso<br />
Centrale: vie <strong>di</strong> neurotrasmissione centrale e me<strong>di</strong>atori; bersagli farmacologici nel SNC. Farmaci utilizzati in<br />
affezioni psichiatriche: antidepressivi; ansiolitici; neurolettici. Terapia del morbo <strong>di</strong> Parkinson, malattia <strong>di</strong><br />
Alzheimer ed epilessie. Anestetici generali. Neurofarmacologia del dolore acuto e cronico; la morfina e i<br />
suoi derivati; cure palliative. Aspetti regolatori inerenti alla prescrizione e all’uso dei farmaci<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso, articolato in lezioni ed esercitazioni in aula è sud<strong>di</strong>viso in moduli monotematici svolti e coor<strong>di</strong>nati<br />
dai docenti, per almeno 5 ore settimanali con un totale <strong>di</strong> circa 60 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica frontale.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in una prova orale nella quale si dovrà rispondere in maniera precisa a quesiti relativi agli<br />
argomenti del programma svolto.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento e materiale <strong>di</strong>dattico:<br />
PAOLETTI, NICOSIA, CLEMENTI, FUMAGALLI, Farmacologia generale e molecolare, UTET.<br />
RANG, DALE, RITTER, Farmacologia, Ambrosiana.<br />
GOODMAN & GILMAN, Le basi farmacologiche della terapia, 9. ed., McGraw-Hill.<br />
Il materiale <strong>di</strong>dattico usato nelle lezioni ed esercitazioni sarà riportato, quando possibile, su supporto<br />
elettronico e inserito nei computer dell’aula <strong>di</strong>dattica, a <strong>di</strong>sposizione <strong>degli</strong> studenti.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: prof.ssa D. Conte, ven., ore 9-11; prof.ssa A. De Luca: lun. e mer., ore 9,30-12.
CHIMICA FARMACEUTICA E TOSSICOLOGICA II<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea in Informazione Scientifica sul Farmaco)<br />
Attività formativa: B (caratterizzante);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare CHIM/08; cre<strong>di</strong>ti formativi: 11<br />
III Anno, II Semestre<br />
proff. Marcello Ferappi e Francesco Campagna<br />
Finalità del Corso<br />
Il Corso viene svolto tenendo in particolare considerazione la <strong>di</strong>fferenza tra farmaci organotropi ed eziotropi.<br />
Per tutti i farmaci vengono trattati proprietà, biogenesi, aspetti farmacocinetici, meccanismo d’azione,<br />
attività ed effetti collaterali, correlando sempre tali fattori alle caratteristiche chimiche delle molecole. Tutte<br />
le classi <strong>di</strong> farmaci sono tenute aggiornate in considerazione <strong>degli</strong> ultimi traguar<strong>di</strong> terapeutici.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
1.0 Ormoni 1.1 Ormoni <strong>di</strong> natura pepti<strong>di</strong>ca: ormoni ipotalamici ed ipofisari, ormoni ghiandolari e tissutali<br />
1.2 Biogenesi del colesterolo, ipocolesterolemici 1.3 Ormoni steroi<strong>di</strong>ci: ormoni sessuali, androgeni,<br />
estrogeni, progestinici, anticoncezionali, ormoni corticosurrenali: mineralcorticoi<strong>di</strong>, glicocorticoi<strong>di</strong> 2.0<br />
Eicosanoi<strong>di</strong> 2.1 Cascata dell’acido arachidonico: prostaglan<strong>di</strong>ne, prostacicline, trombossani, leucotrieni 3.0<br />
Farmaci ed alimenti 3.1 Vitamine e provitamine 3.2 Vitamine liposolubili 3.3 Vitamina C 3.3 Complesso B e<br />
attività coenzimatica 3.4 Fattori folinici 4.0 Chemioterapici 4.1 Sulfami<strong>di</strong>ci 4.2 Chinolonici 4.3<br />
Antiprotozoari 4.4 Antimicobattrici 4.4.1 Antitubercolari 4.4.2 Antilebbra 4.5 Antielmintici 4.6 Antimicotici<br />
4.7 Antivirali 4.8 Antitumorali 4.8.1 Cell cycle phase 4.8.2 Antimetaboliti pirimi<strong>di</strong>nici e purinici 4.8.3<br />
Antifolici 4.8.4 Agenti alchilanti 4.8.5 Antibiotici antiblastici 4.8.6 Altri antitumorali 5.0 Antibiotici 5.1<br />
Antibiogramma 5.2 Spettro d’azione 5.3 Attacco ai vari recettori 5.4 Tossicità 5.5 Cicloserina 5.6 Beta<br />
lammine 5.6.1 Parete cellulare, biosintesi del peptidoglicano, reattività elettrofila acilante 5.6.2 Penicilline<br />
naturali, biosintetiche, semisintetiche 5.6.3 Cefalosporine 5.6.4 Inibitori delle lattamasi 5.6.5 Monobattami<br />
5.6.6 Carbapenemi 5.7 Glicopepti<strong>di</strong> 5.8 Polipepti<strong>di</strong>ci 5.9 Macroli<strong>di</strong> 5.10 Macroli<strong>di</strong> polienici 5.11<br />
Tetracicline 5.12 Amminoglicosi<strong>di</strong>ci 5.13 Streptomicine 5.14 Amfenicoli.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso è sud<strong>di</strong>viso in moduli monotematici, si articola in lezioni ed esercitazioni per almeno 5 ore<br />
settimanali con un totale <strong>di</strong> circa 70 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica frontale.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
La prova d’esame consiste in un colloquio su almeno tre argomenti presenti nel programma, eventualmente<br />
preceduto da una prova scritta.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento e materiale <strong>di</strong>dattico:<br />
E. SCHROEDER, C. RUFER, R. SCHMIECHEN, Chimica farmaceutica, (voll I e II), Napoli, E<strong>di</strong>SES, 1991.<br />
C. WERMUTH, Le applicazioni della chimica farmaceutica, Napoli, E<strong>di</strong>SES, 2001.<br />
FOYE, LEMKE, WILLIAMS, Principi <strong>di</strong> Chimica farmaceutica, Piccin, 1998.<br />
Tutto il materiale <strong>di</strong>dattico sarà riportato su supporto elettronico e inserito nei computer dell’aula <strong>di</strong>dattica.<br />
Ne sarà fornita anche una copia cartacea.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: mar., ore 10,30-11,30; mer., ore 16,30-18,30; gio., ore 10,30-11,30.
FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea in Informazione Scientifica sul Farmaco)<br />
Attività formativa: B (caratterizzante);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare BIO/14; cre<strong>di</strong>ti formativi: 11<br />
III Anno, II Semestre<br />
prof. Diana Conte<br />
Finalità del Corso<br />
Fornire allo studente competenze riguardanti la conoscenza dell’azione dei farmaci e <strong>degli</strong> aspetti<br />
tossicologici legati al loro impiego in terapia e i danni causati da agenti tossici <strong>di</strong> varia natura.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
Parte prima. Farmacologia e Farmacoterapia II.<br />
Farmaci e Sistema immunitario. Corticosteroi<strong>di</strong>: glucocorticoi<strong>di</strong> e mineralcorticoi<strong>di</strong>. Farmacologia del<br />
sistema endocrino. Farmacologia della sterilità e della contraccezione orale. Farmaci delle malattie<br />
<strong>di</strong>smetaboliche: <strong>di</strong>smetabolismo gluci<strong>di</strong>co e proti<strong>di</strong>co. Interventi farmacologici sulla motilità uterina:<br />
uterotonici e uterolitici. Farmacologia del sistema gastroenterico. Vitamine.<br />
Parte seconda. Chemioterapici e antibiotici.<br />
Resistenza batterica: acquisizione e trasferimento. Antibiotici beta-lattamici, Aminoglicosi<strong>di</strong> e chinolonici,<br />
Macroli<strong>di</strong>, Lincosami<strong>di</strong>, Tetracilcine e Cloramfenicolo. Sulfami<strong>di</strong>ci e Nitroimidazoli. Antitubercolari,<br />
Antimicotici, Antivirali (Epatite, Herpes, AIDS, SARS, Ebola, etc.). Antielmintici, Antiprotozoari,<br />
trattamento delle Ectoparassitosi. Farmaci antineoplastici.<br />
Parte terza. Tossicologia.<br />
Tossicologia generale. Valutazione del rischio. Mutagenesi, cancerogenesi, teratogenesi. Tossicologia<br />
sistemica. Tossicità d’organo. Interazioni tra farmaci. Farmacologia delle tossico<strong>di</strong>pendenze. Tossicità da<br />
inquinanti ambientali: pestici<strong>di</strong> e aereoinquinanti. Tossicologia alimentare e nutrizionale. Lo sviluppo <strong>di</strong> un<br />
farmaco e farmacovigilanza.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso, articolato in lezioni ed esercitazioni in aula è sud<strong>di</strong>viso in moduli monotematici svolti e coor<strong>di</strong>nati<br />
dallo stesso docente, per almeno 5 ore settimanali con un totale <strong>di</strong> circa 60 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica frontale.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in una prova orale nella quale si dovrà rispondere in maniera precisa a quesiti relativi agli<br />
argomenti del programma svolto.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento e materiale <strong>di</strong>dattico:<br />
GREIM, DEML, Tossicologia, Zanichelli.<br />
RANG, DALE, RITTER, Farmacologia, Ambrosiana.<br />
PAOLETTI, NICOSIA, CLEMENTI, FUMAGALLI, Tossicologia generale e molecolare, UTET.<br />
GOODMAN & GILMAN, Le basi farmacologiche della terapia, 9. ed., McGraw-Hill.<br />
Il materiale <strong>di</strong>dattico usato nelle lezioni ed esercitazioni quando possibile sarà riportato su supporto<br />
elettronico e inserito nei computer dell’aula <strong>di</strong>dattica, a <strong>di</strong>sposizione <strong>degli</strong> studenti. Sarà fornita copia<br />
cartacea del materiale usato durante lezioni ed esercitazioni, solo come guida ad integrazione ai testi sotto<br />
consigliati.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: ven., ore 9-11.
TECNOLOGIA, SOCIOECONOMIA<br />
E LEGISLAZIONE FARMACEUTICHE<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea in Informazione Scientifica sul Farmaco)<br />
Attività formativa: B (caratterizzante);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare CHIM/09 cre<strong>di</strong>ti formativi: 11<br />
III Anno, II Semestre<br />
prof. Nicola Maggi<br />
Finalità del Corso<br />
Il Corso è orientato alla trattazione <strong>degli</strong> aspetti tecnologici importanti ai fini della preparazione galenica <strong>di</strong><br />
qualità. Inoltre, approfon<strong>di</strong>sce tematiche normative e socioeconomiche <strong>di</strong> interesse preminente in campo<br />
professionale.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
Percorso <strong>di</strong> sviluppo <strong>di</strong> un nuovo farmaco, dalla sua scoperta sino alla introduzione in mercato. Vie <strong>di</strong><br />
somministrazione dei farmaci e modalità <strong>di</strong> assorbimento; richiami <strong>di</strong> farmacocinetica. <strong>Stu<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong><br />
preformulazione: proprietà fisiche e chimico-fisiche del farmaco, <strong>di</strong> rilevanza nello allestimento delle varie<br />
forme farmaceutiche.<br />
Progettazione e messa a punto della forma <strong>di</strong> dosaggio <strong>di</strong> un farmaco.<br />
Forme farmaceutiche parenterali: classificazione e requisiti. Modalità preparative <strong>degli</strong> iniettabili. Operazioni<br />
sterili e tecniche <strong>di</strong> sterilizzazione.<br />
Forme farmaceutiche orali liquide: qualità microbiologica e agenti conservanti. Forme farmaceutiche solide<br />
orali: criteri <strong>di</strong> formulazione <strong>di</strong> capsule e compresse, aspetti biofarmaceutici e funzioni dei principali<br />
eccipienti e coformulanti. Forme a rilascio mo<strong>di</strong>ficato per via parenterale, orale, oftalmica, intrauterina e<br />
transdermica. Forme farmaceutiche pressurizzate per uso topico e inalatorio.<br />
Stabilità e stabilizzazione dei farmaci: meccanismi <strong>di</strong> degradazione, modelli sperimentali <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o.<br />
Controllo <strong>di</strong> qualità: concetti generali applicati alla produzione farmaceutica. Norme <strong>di</strong> Buona Fabbricazione.<br />
Norme <strong>di</strong> Buona Preparazione. Controlli <strong>di</strong> qualità delle principali forme farmaceutiche, con riferimento alla<br />
FU.<br />
Introduzione alla Farmacoeconomia: trend demografici e spesa farmaceutica. Modelli <strong>di</strong> analisi<br />
farmacoeconomica; minimizzazione dei costi. Me<strong>di</strong>cinali generici: esigenze farmacoeconomiche, aspetti<br />
tecnologici, biofarmaceutici e legislativi. Me<strong>di</strong>cinali orfani: aspetti farmacoeconomici e legislativi. Procedure<br />
<strong>di</strong> autorizzazione all’immissione in commercio dei me<strong>di</strong>cinali. Presentazione del me<strong>di</strong>cinale e foglio<br />
illustrativo.<br />
Farmacoepidemiologia e Farmacovigilanza. Me<strong>di</strong>cinali omeopatici: cenni storici, aspetti tecnici e normativi.<br />
Servizio Sanitario Nazionale e sua organizzazione. Normative <strong>di</strong> sicurezza nell’esercizio professionale.<br />
Adempimenti e problemi relativi allo smaltimento dei materiali <strong>di</strong> scarto in farmacia.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso si articola in lezioni, per almeno 5 ore settimanali con un totale <strong>di</strong> circa 70 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica frontale.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame finale consiste in una prova orale.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento e materiale <strong>di</strong>dattico:<br />
M. AMOROSA, Principi <strong>di</strong> Tecnica Farmaceutica, Tinarelli.<br />
A.T. FLORENCE, D. ATWOOD, Le Basi chimico-fisiche della tecnologia farmaceutica, E<strong>di</strong>SES.<br />
G.M. MARCHETTI, P. MINGHETTI, Legislazione Farmaceutica, Ambrosiana.<br />
RECCHIA, G. DE CARLI, Introduzione alla Farmacoeconomia, OEMF.<br />
R.J. BONK, Pharmacoeconomics in Perspective, Pharmaceutical Products Press.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: lun., ore 10-11; mar., e gio., ore 9,30-10,30.
CORSO DI LAUREA IN TECNICHE ERBORISTICHE<br />
BIOLOGIA VEGETALE ED ANIMALE<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea in Tecniche Erboristiche)<br />
Attività formativa: A (<strong>di</strong> base);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare BIO/13; cre<strong>di</strong>ti formativi: 10<br />
I Anno, I Semestre<br />
prof. Italo Stipani<br />
Finalità del Corso<br />
La Biologia animale e vegetale ha lo scopo <strong>di</strong> fornire agli studenti le conoscenze <strong>di</strong> base che regolano la<br />
materia vivente e gli organismi viventi (animali e vegetali) e rappresenta un utile substrato per le altre<br />
materie biologiche del loro Corso <strong>di</strong> laurea.<br />
Contenuto del Corso<br />
Introduzione alla Biologia come scienza sperimentale. Caratteristiche <strong>degli</strong> organismi viventi.<br />
Classificazione regni. Teoria cellulare. Procarioti ed eucarioti. Virus e batteri. Evoluzione della specie. La<br />
selezione naturale e l’adattamento. Ere<strong>di</strong>tarietà Lamarckiana e Darwiniana. Meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o delle cellule.<br />
Microscopia ottica e microscopia elettronica. Le membrane biologiche. Trasporto attraverso le membrane.<br />
Proteine strutturali e proteine <strong>di</strong> adesione. Il citoscheletro. Fibra muscolare. Sarcomero. Actina e miosina.<br />
Meccanismo molecolare della contrazione. Reticolo endoplasmatico liscio e rugoso. Involucro nucleare.<br />
Complesso del poro nucleare. Apparato del Golgi. Gli organelli cellulari. Il genoma <strong>degli</strong> organelli. Il<br />
Nucleo. Cromatina. Organizzazione della cromatina. I singoli filamenti <strong>di</strong> DNA: i geni. Istoni e proteine nonistoniche.<br />
Formazione dei nucleosomi. Cromosomi. Ciclo cellulare. Mitosi. Ribosomi. Il nucleolo. Co<strong>di</strong>ce<br />
genetico, codon e anticodon. Cenni sulla sintesi proteica. La riproduzione: asessuata e sessuata. I benefici del<br />
sesso: cellule somatiche e germinali. Meiosi: descrizione generale, <strong>di</strong>fferenze fra meiosi e mitosi. La<br />
ricombinazione del patrimonio genetico. Crossing/over. Gametogenesi: cellula uovo e spermatozoo. La<br />
fecondazione. Processo acrosomiale. La cellula vegetale. I plasti<strong>di</strong>. I vacuoli e il turgore cellulare. La parete<br />
cellulare: funzione e formazione. Organizzazione della pianta: fusto, ra<strong>di</strong>ce e foglia. I principali tessuti della<br />
pianta. Tessuto epidermico. Tessuto vascolare. Xilema e Floema. Tessuto fondamentale. Cenni <strong>di</strong> anatomia<br />
della pianta. Angiosperme e gimnosperme. Il fiore. Il frutto. Il seme. Riproduzione nelle angiosperme.<br />
Cloroplasti. Differenze con i mitocondri. Principali componenti: la clorofilla e i fotosistemi. Le reazioni alla<br />
luce: la fotosintesi e la formazione <strong>di</strong> ossigeno. Schema Z. Le reazioni al buio e la fissazione dell’anidride<br />
carbonica. Sintetica descrizione del Ciclo <strong>di</strong> Calvin-Benson. Cenni <strong>di</strong> Genetica. Fenotipo/genotipo.<br />
Dominante/recessivo. Le leggi <strong>di</strong> Mendel. Genetica umana: determinazione del sesso; ere<strong>di</strong>tà legata al sesso.<br />
Il cariotipo umano normale. Mappe genetiche. Malattie genetiche (sindrome <strong>di</strong> Down). Gruppi sanguigni<br />
dell’uomo. Tassonomia. Nomenclatura linneana. I cinque regni <strong>degli</strong> esseri viventi: principali classificazioni.<br />
Cenni <strong>di</strong> Ecologia. Concetto <strong>di</strong> ecosistema. Habitat. Nicchia ecologica. Fattori ambientali. Ambienti<br />
biologici. Comportamento. Catena alimentare. Pirami<strong>di</strong> ecologiche.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso è articolato in lezioni in aula per almeno 5 ore settimanali per un totale <strong>di</strong> 60/65 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica<br />
frontale con l’ausilio <strong>di</strong> supporti informatici.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in una prova orale.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento e materiale <strong>di</strong>dattico:<br />
SOLOMON ET ALII, Biologia, E<strong>di</strong>SES, (vol. I e II). PURVES ET ALII, Biologia, Zanichelli. S.L. WOLFE,<br />
Biologia molecolare e cellulare, E<strong>di</strong>SES. P.H. RAVEN, G.B. JOHNSON, Biologia, E<strong>di</strong>SES, (vol. I e II).<br />
Tutto il materiale <strong>di</strong>dattico delle lezioni è riportato su supporto elettronico ed è messo a <strong>di</strong>sposizione <strong>degli</strong><br />
studenti per la consultazione nei computer dell’aula <strong>di</strong>dattica.<br />
Orari <strong>di</strong> ricevimento: mar., mer., ore 9-10; gio., ore 17-19.
CHIMICA GENERALE ED INORGANICA<br />
E CHIMICA ORGANICA<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea in Tecniche Erboristiche)<br />
Attività formativa: C (integrativa);<br />
settori <strong>di</strong>sciplinari: CHIM/03, CHIM/06; cre<strong>di</strong>ti formativi: 10<br />
I Anno, I Semestre<br />
Svolto nel precedente a.a. da:<br />
proff. Concetta Pacifico e Vito Capriati<br />
Finalità del Corso<br />
Lo scopo del Corso è mettere in luce i principi fondamentali delle due <strong>di</strong>scipline e gli aspetti applicativi<br />
nell’attività pratica quoti<strong>di</strong>ana.<br />
Contenuti del Corso per argomenti<br />
Chimica generale ed inorganica: Stati <strong>di</strong> aggregazione. Fasi. Sistemi omogenei e eterogenei. Sostanze,<br />
composti, elementi. Atomi, molecole, simboli atomici e formule chimiche. La struttura dell’atomo. Numero<br />
atomico. Numero <strong>di</strong> massa. Mole. Massa molare. Composizione percentuale. Formula empirica.<br />
Bilanciamento <strong>di</strong> equazioni chimiche. La tavola perio<strong>di</strong>ca. La valenza. Numeri quantici. Orbitali atomici.<br />
Principio <strong>di</strong> Aufbau. Principio <strong>di</strong> esclusione <strong>di</strong> Pauli. Regola <strong>di</strong> Hund. Proprietà perio<strong>di</strong>che <strong>degli</strong> elementi.<br />
Energia <strong>di</strong> legame. Il legame ionico e covalente. Le strutture <strong>di</strong> Lewis. Geometria delle molecole. Teoria<br />
dell’Orbitale Molecolare. Legami sigma e pigreco. Allotropi. Orbitali molecolari localizzati. Orbitali ibri<strong>di</strong>.<br />
Risonanza. Or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> legame. Polarità <strong>di</strong> un legame. Molecole polari. Legami chimici intermolecolari.<br />
Entalpia <strong>di</strong> reazioni. Temperatura critica. Proprietà delle soluzioni. Unità <strong>di</strong> misura delle concentrazioni.<br />
Legge <strong>di</strong> Henry. Legge <strong>di</strong> Raoult. Proprietà colligative. Distillazione. Miscele reali. Principio <strong>di</strong> Le<br />
Chatelier. Elettroliti forti e deboli. Definizioni <strong>di</strong> acido e <strong>di</strong> base. Prodotto ionico dell’acqua. Aci<strong>di</strong> e basi in<br />
soluzione acquosa <strong>di</strong>luita. Costante <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssociazione <strong>degli</strong> aci<strong>di</strong> e delle basi. Titolazioni. In<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> pH.<br />
Soluzioni tampone.<br />
Chimica organica: Il legame chimico. Alcani e cicloalcani. Isomeria conformazionale e geometrica. Alcheni<br />
e Alchini: reazioni <strong>di</strong> ad<strong>di</strong>zione elettrofila; ad<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> idrogeno. Concetto <strong>di</strong> aci<strong>di</strong>tà e basicità. I composti<br />
aromatici: nomenclatura e risonanza; sostituzione elettrofila aromatica. Stereoisomeria: la chiralità e gli<br />
enantiomeri; centri stereogenici; la configurazione e la convenzione RS; attività ottica; composti meso e<br />
<strong>di</strong>astereoisomeri. I composti organici alogenati: generalità sulla sostituzione nucleofila alifatica e sulla<br />
eliminazione. Alcoli, Fenoli e Tioli. Eteri ed Epossi<strong>di</strong>. Ammine. Aldei<strong>di</strong> e Chetoni: reazioni <strong>di</strong> ad<strong>di</strong>zione<br />
nucleofila; tautomeria; condensazione aldolica. Aci<strong>di</strong> carbossilici e i loro derivati. Composti eterociclici.<br />
Lipi<strong>di</strong> e detergenti. Carboidrati: monosaccari<strong>di</strong>: anomeria e mutaroratazione; <strong>di</strong>saccari<strong>di</strong> e polisaccari<strong>di</strong>;<br />
acido ascorbico (vitamina C). Amminoaci<strong>di</strong>: proprietà acido-base; chiralità; punto isoelettrico. Pepti<strong>di</strong> e<br />
proteine: il legame pepti<strong>di</strong>co; struttura primaria e secondaria.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso è articolato in lezioni ed esercitazioni in aula per 6 ore settimanali per un totale <strong>di</strong> 60 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica<br />
frontale.<br />
Esame finale<br />
L’esame, svolto congiuntamente, consiste in un colloquio orale in cui lo studente è invitato a <strong>di</strong>mostrare <strong>di</strong><br />
essere in possesso delle conoscenze teoriche <strong>di</strong> base delle due <strong>di</strong>scipline.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento:<br />
G. BANDOLI, A. DOLMELLA, G. NATILE, Chimica <strong>di</strong> base, E<strong>di</strong>SES.<br />
W.H. BROWN, Introduzione alla Chimica organica, Napoli, E<strong>di</strong>SES, 2001.<br />
H. HART, L.E. CRAINE, D.J. HART, Chimica organica, Bologna, Zanichelli, 2003.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: prof.ssa C. Pacifico lun., mar., gio., ore 11,30-13,30; prof. V. Capriati lun., mar.,<br />
mer., 14,30-16,30.
FARMACOGNOSIA CON ELEMENTI DI<br />
BOTANICA FARMACEUTICA<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea in Tecniche Erboristiche)<br />
Attività formativa: A (<strong>di</strong> base);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare BIO/15; cre<strong>di</strong>ti formativi: 12<br />
I Anno, II Semestre<br />
prof. Pinarosa Avato<br />
Finalità del Corso<br />
Il Corso è rivolto principalmente allo stu<strong>di</strong>o delle droghe vegetali e <strong>di</strong> farmaci <strong>di</strong> origine naturale da esse<br />
derivati. Particolare rilievo viene dato alle droghe vegetali officinali <strong>di</strong> uso fitoterapico maggiore impiego nel<br />
settore propriamente erboristico oltre che a quelle ammesse dalla Farmacopea nazionale. Vengono trattati<br />
l’aspetto botanico della fonte vegetale e le caratteristiche farmacognostiche della droga.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
1. Cellula vegetale<br />
2. Organografia<br />
3. Selezione del materiale vegetale e conservazione delle droghe<br />
4. Preparazione <strong>degli</strong> estratti<br />
5. Classificazione chimica dei principi attivi<br />
5. Monografie <strong>di</strong> piante me<strong>di</strong>cinali e droghe selezionate.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso è articolato in lezioni. Seminari integrativi e stage <strong>di</strong> approfon<strong>di</strong>mento presso aziende o laboratori<br />
fitoterapici potranno essere organizzati durante l’anno. Sono organizzate delle esercitazioni in aula per il<br />
riconoscimento macroscopico <strong>di</strong> droghe vegetali e per l’osservazione <strong>di</strong> preparazioni istologiche da piante<br />
me<strong>di</strong>cinali.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in una prova orale.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento e materiale <strong>di</strong>dattico:<br />
Elementi <strong>di</strong> Botanica Farmaceutica:<br />
E. MAUGINI, Botanica Farmaceutica, ult. ed., Piccin.<br />
A. BRUNI, M. NICOLETTI, Biologia vegetale, Japarde, 1993.<br />
Atlante <strong>di</strong> Anatomia vegetale.<br />
Farmacognosia:<br />
TREASE AND EVANS, Farmacognosia, Trad. it. <strong>di</strong> M. Nicoletti e M. Serafini, Piccin, 1995.<br />
A. BRUNI, Farmacognosia generale ed applicata, Piccin, 1999.<br />
G. FASSINA, E. RAGAZZI, Lezioni <strong>di</strong> Farmacognosia Droghe Vegetali, Padova, Cedam, 1995.<br />
G. FASSINA, P. DORIGO, Lezioni <strong>di</strong> Farmacognosia Droghe Animali ed Enzimi, Padova, Cedam, 1992.<br />
Tutto il materiale <strong>di</strong>dattico usato nelle lezioni sarà riportato su supporto elettronico.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: mar., mer., gio., ore 15-17.
CHIMICA ANALITICA ED ESERCITAZIONI<br />
NUMERICHE E DI LABORATORIO<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea in Tecniche Erboristiche)<br />
Attività formativa.: A (<strong>di</strong> base) e C (affini o integrativi);<br />
settori <strong>di</strong>sciplinari CHIM/01 e MAT/04; cre<strong>di</strong>ti formativi: 10<br />
I Anno, II Semestre<br />
Svolto nel precedente a.a. da:<br />
prof. Fausta Palluotto<br />
Finalità del Corso<br />
Il Corso si propone <strong>di</strong> fornire le conoscenze necessarie alla valutazione quali-quantitativa delle droghe<br />
vegetali, alla stabilità dei prodotti erboristici e ai meto<strong>di</strong> per effettuarne il controllo <strong>di</strong> qualità.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
1.0 Introduzione alla Chimica analitica<br />
2.0 Richiami introduttivi <strong>di</strong> Matematica<br />
3.0 Valutazione statistica dei dati analitici<br />
4.0 Attrezzature <strong>di</strong> laboratorio<br />
5.0 Sicurezza in laboratorio<br />
6.0 Sistemi omogenei ed eterogenei. 6.1 Soluzioni, sospensioni, emulsioni. 6.2 Mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> esprimere la conc.<br />
delle soluzioni: % p/p, % p/v; % v/v, ppm, molarità, normalità, molalità. 6.3 Metodo della croce. 6.4<br />
Diluizioni omeopatiche.<br />
7.0 Equilibri acido-base. 7.1 Prodotto ionico dell’acqua e pH. 7.2 pH <strong>di</strong> aci<strong>di</strong> e basi forti. 7.3 pH <strong>di</strong> aci<strong>di</strong> e<br />
basi deboli. 7.4 pH <strong>di</strong> aci<strong>di</strong> poliprotici. 7.5 Soluzioni tampone. 7.6 In<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> pH. 7.7 Anfoliti.<br />
8.0 Equilibri <strong>di</strong> ossidoriduzione<br />
9.0 Equilibri <strong>di</strong> precipitazione<br />
10.0 Analisi volumetrica. 10.1 Titolazioni acido-base. 10.2 Titolazioni con il metodo della<br />
precipitazione. 10.3 Titolazioni con il metodo redox. 10.4 Tecniche estrattive. 10.5 Cromatografia<br />
11.0 Meto<strong>di</strong> spettroscopici <strong>di</strong> analisi<br />
12.1 UV-Vis 13.2 IR. 13.3 1 H-NMR.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso si articola in lezioni frontali (5 ore settimanali per un totale <strong>di</strong> 60 ore), arricchite da esercitazioni<br />
numeriche (1 ora settimanale per un totale <strong>di</strong> 12 ore) ed esercitazioni <strong>di</strong> laboratorio (2 ore settimanali per un<br />
totale <strong>di</strong> 24 ore).<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame si realizza attraverso un colloquio sugli argomenti trattati.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento e materiale <strong>di</strong>dattico:<br />
SKOOG, WEST, HOLLER, Chimica Analitica: una introduzione, Napoli, E<strong>di</strong>SES.<br />
F.W. FIFIELD, D. KEALEY, Chimica Analitica, teoria e pratica, Bologna, Zanichelli.<br />
D.C. HARRIS, Elementi <strong>di</strong> Chimica Analitica, Bologna, Zanichelli.<br />
SILVERSTEIN, WEBSTER, Identificazione spettroscopica <strong>di</strong> composti organici, Milano, Ambrosiana.<br />
Il materiale <strong>di</strong>dattico sarà riportato su supporto elettronico e inserito nei computer dell’aula <strong>di</strong>dattica, a<br />
<strong>di</strong>sposizione <strong>degli</strong> studenti con largo anticipo. Sarà fornita anche una copia cartacea che gli studenti potranno<br />
duplicare a loro spese.<br />
Orario delle lezioni ed esercitazioni:<br />
Sarà <strong>di</strong>sponibile negli albi della Facoltà prima dell’inizio delle lezioni.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: lun., ore 9,30-11; mer., ore 16-17,30.
BIOCHIMICA E BIOCHIMICA VEGETALE<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea in Tecniche Erboristiche)<br />
Attività formativa: B (caratterizzante);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare BIO/10 e BIO/04; cre<strong>di</strong>ti formativi: 10<br />
I Anno, II Semestre<br />
Svolto nel precedente a.a. da:<br />
proff. Giuseppe Fiermonte e Annalisa De Palma<br />
Finalità del Corso<br />
Il Corso ha l’obiettivo <strong>di</strong> fornire agli studenti le principali conoscenze sulla struttura e funzione delle più<br />
importanti molecole biologiche e sui processi metabolici fondamentali per la vita <strong>di</strong> un organismo vivente. In<br />
particolare, sono approfon<strong>di</strong>ti alcuni aspetti del metabolismo vegetale che stanno alla base della crescita e<br />
dello sviluppo della pianta.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
La cellula e le sue unità <strong>di</strong> struttura. Polisaccari<strong>di</strong> <strong>di</strong> riserva e strutturali. Lipi<strong>di</strong> <strong>di</strong> riserva e lipi<strong>di</strong><br />
impermeabilizzanti. Amminoaci<strong>di</strong>. Proteine: struttura e funzioni. Relazioni tra struttura tri<strong>di</strong>mensionale e<br />
attività biologica delle proteine. Vitamine e coenzimi. Enzimi: struttura, funzione e specificità. Cinetica<br />
enzimatica. Regolazione dell’attività enzimatica. Strutture e funzioni delle membrane biologiche. Principi <strong>di</strong><br />
termo<strong>di</strong>namica e bioenergetica. Concetti generali del metabolismo. Glicolisi. Fermentazione alcolica e<br />
lattica. Gluconeogenesi. Via dei pentosi fosfato. Biosintesi e degradazione <strong>degli</strong> aci<strong>di</strong> grassi e dei lipi<strong>di</strong>.<br />
Ciclo dell’acido gliossilico. Biosintesi e degradazione <strong>degli</strong> amminoaci<strong>di</strong>. Ciclo <strong>degli</strong> aci<strong>di</strong> tricarbossilici.<br />
Catena <strong>di</strong> trasporto <strong>degli</strong> elettroni e fosforilazione ossidativa. Fase luminosa della fotosintesi. I pigmenti<br />
fotosintetici. I complessi molecolari per la raccolta della luce (LHC) e i fotosistemi. Trasferimento <strong>di</strong><br />
elettroni e fotofosforilazione. Fase oscura della fotosintesi. Fissazione dell’anidride carbonica. Il ciclo <strong>di</strong><br />
Calvin. Fotorespirazione. Regolazione e fattori che influenzano la fotosintesi. Le piante C4 e le piante CAM.<br />
Aci<strong>di</strong> nucleici e informazione genetica. DNA e RNA: struttura e proprietà. Geni e cromosomi. Duplicazione<br />
e trascrizione del DNA. Co<strong>di</strong>ce genetico. Biosintesi proteica. Regolazione dell’espessione genica e della<br />
sintesi proteica.<br />
Metabolismo dell’azoto. Fissazione biologica, assimilazione e trasferimento dell’azoto. Assorbimento e<br />
assimilazione <strong>di</strong> altri elementi nutritivi minerali. Metaboliti secondari. Ormoni vegetali e regolatori <strong>di</strong><br />
crescita. Fitocromo: struttura e proprietà biochimiche. Risposte della pianta indotte dal fitocromo. Risposta<br />
biochimica agli stress ambientali <strong>di</strong> natura biotica e <strong>di</strong> natura abiotica.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso è articolato in lezioni in aula per almeno 5 ore settimanali con un totale <strong>di</strong> circa 60 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica<br />
frontale.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in una prova orale sugli argomenti del programma svolto.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento e materiale <strong>di</strong>dattico:<br />
LEHNINGER, NELSON, COX, Introduzione alla Biochimica <strong>di</strong> Lehninger, Zanichelli.<br />
BUCHANAN, GRUISSEM, Biochimica e Biologia molecolare delle piante, Zanichelli.<br />
Tutto il materiale <strong>di</strong>dattico usato nelle lezioni sarà riportato su supporto elettronico, inserito nei computer<br />
dell’aula <strong>di</strong>dattica e sarà a <strong>di</strong>sposizione <strong>degli</strong> studenti.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: prof. G. Fiermonte lun., mar., mer., ore 16-18; prof.ssa A. De Palma lun., mar., mer.,<br />
gio., ven., ore 10-12.
FISIOLOGIA<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea in Tecniche Erboristiche)<br />
Attività formativa: C (affini o integrativi);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare BIO/09; cre<strong>di</strong>ti formativi: 10<br />
II Anno, I Semestre<br />
Svolto nel precedente a.a. da:<br />
prof. Valentina Stipani<br />
Finalità del Corso<br />
Il Corso <strong>di</strong> Fisiologia generale viene svolto spiegando le funzioni vitali <strong>degli</strong> animali e dell’uomo. Analizza<br />
come gli organismi viventi mantengano l’omeostasi del mezzo interno a livello molecolare, cellulare e<br />
tissutale al variare dell’ambiente circostante. I meccanismi fondamentali delle funzioni biologiche vengono<br />
affrontati considerando i principi fisico-chimici alla loro base.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
Processi <strong>di</strong> trasporto attraverso le membrane biologiche. Diffusione passiva. Il potenziale <strong>di</strong> flusso.<br />
Diffusione <strong>degli</strong> elettroliti. Trasporto attivo. I neuroni e le cellule gliali. Potenziale <strong>di</strong> membrana e sua<br />
genesi. Potenziale d’azione o impulso nervoso. Conduzione dell’impulso nervoso nelle fibre mieliche e<br />
amieliche. Proprietà generali dei sistemi sensoriali. Recettori: classificazione e proprietà generali. Sistema<br />
nervoso centrale. Cenni anatomici. Funzioni della corteccia motoria e dei gangli della base. Connessioni<br />
afferenti alla corteccia motoria. Vie efferenti: piramidale ed extrapiramidale. Funzioni del sistema limbico.<br />
Funzioni ipotalamiche. Sistema ipotalamo-ipofisi. Sistema nervoso vegetativo. Controllo spinale della<br />
motilità. Riflessi motori spinali: caratteristiche. Tono posturale. Controllo bulbo-pontino della motilità.<br />
Cervelletto: controllo cerebellare dei movimenti. Sistema muscolare. Contrazione del muscolo scheletrico<br />
liscio e car<strong>di</strong>aco. Sistema car<strong>di</strong>ovascolare. Attività elettrica del cuore. Conduzione delle fibre car<strong>di</strong>ache.<br />
Eccitazione naturale del cuore ECG. La pompa car<strong>di</strong>aca. Il ciclo car<strong>di</strong>aco. Gettata car<strong>di</strong>aca e sua regolazione.<br />
Il controllo del cuore. Emo<strong>di</strong>namica. Funzione del sistema renale per funzioni. Sistema gastrointestinale.<br />
Funzione del sistema respiratorio. Sistema endocrino.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso, articolato in lezioni ed esercitazioni in aula, è sud<strong>di</strong>viso in una parte generale <strong>di</strong> base in cui viene<br />
stu<strong>di</strong>ata la biofisica, l’elettrofisiologia, le funzioni dei sistemi <strong>di</strong> trasporto e <strong>di</strong> comunicazioni nelle<br />
membrane biologiche. Una parte speciale riguardante il funzionamento dei vari organi e loro integrazione nel<br />
contesto del funzionamento dell’organismo. Il docente della <strong>di</strong>sciplina, svolge 5 ore settimanali con un totale<br />
<strong>di</strong> circa 60 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica frontale.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in una prima prova scritta in cui agli studenti vengono posti <strong>di</strong>eci quesiti a risposta multipla<br />
(tests) e una domanda finale a cui si dovrà dare una risposta esauriente e concisa. La successiva prova orale,<br />
alla quale si accede dopo il superamento della prova scritta, verte essenzialmente sugli argomenti trattati<br />
nella prima prova.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento e materiale <strong>di</strong>dattico:<br />
L.S. COSTANZO, Fisiologia, E<strong>di</strong>SES.<br />
R.M. BERNE, M.N. LEVY, Fisiologia generale, Ambrosiana.<br />
D.U. SILVERTHORN, Fisiologia, Ambrosiana.<br />
G. MONTICELLI, G. ESPOSITO, Fenomeni <strong>di</strong> trasporto ed elettrici, in membrane biologiche, Milano, Ermes.<br />
Il materiale <strong>di</strong>dattico riguardante alcuni argomenti usato nelle lezioni e nelle esercitazioni sarà riportato su<br />
supporto elettronico e inserito nei computer dell’aula <strong>di</strong>dattica, a <strong>di</strong>sposizione <strong>degli</strong> studenti.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: mer., ore 10,30-11,30; ven., ore 10,30-11,30.
MICROBIOLOGIA ED IGIENE<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea in Tecniche Erboristiche)<br />
Attività formativa: C (affini o integrativi);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare: MED/42 e MED/07; cre<strong>di</strong>ti formativi: 10<br />
II Anno, I Semestre<br />
prof. Danila De Vito<br />
Finalità del Corso<br />
Il Corso si propone <strong>di</strong> fornire allo studente conoscenze e competenze relative alla prevenzione delle malattie<br />
e alla promozione della salute, all’organizzazione sanitaria. Esso intende perciò avviare lo studente alla<br />
conoscenza dei determinanti <strong>di</strong> malattia e dei sistemi <strong>di</strong> sorveglianza sanitaria; alla comprensione dei<br />
meccanismi <strong>di</strong> insorgenza e <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffusione delle malattie e del loro impatto sulle comunità; all’appren<strong>di</strong>mento<br />
dei principi e delle strategie della me<strong>di</strong>cina preventiva e della promozione della salute.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
Generalità sui microrganismi. Principi <strong>di</strong> immunologia. Allergia ed ipersensibilità. Classificazione dei<br />
batteri. Gram-negativi. Gram-negativi anaerobi. Gram-positivi. Miceti. Flora batterica normale nell’uomo.<br />
Virus: proprietà generali. Classificazione dei virus. Batteriofagi. Protozoi patogeni per l’uomo. Storia,<br />
significato e scopi dell’Igiene. Organizzazione Sanitaria Nazionale. I servizi sanitari: l’Ospedale. Me<strong>di</strong>cina<br />
preventiva ed educazione sanitaria. Epidemiologia descrittiva. Epidemiologia analitica. Epidemiologia<br />
sperimentale. Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive. I fenomeni immunitari. Notifica;<br />
contumacia; accertamenti <strong>di</strong> laboratorio; chemio-antibiotico profilassi. Vaccinazioni obbligatorie e<br />
facoltative e loro calendario; preparazioni vaccinali. La sieroprofilassi: sieri eterologhi, omologhi,<br />
iperimmuni, specifici e gammaglobuline.<br />
Disinfezione. Influenza, epatiti da virus, morbillo, tubercolosi, tifo addominale, brucellosi, colera,<br />
toxoplasmosi. Igiene dell’ambiente fisico: meccanismi <strong>di</strong> termoregolazione, parametri fisici del microclima e<br />
loro rilevamento. Lo smaltimento dei liquami domestici. Lo smaltimento dei rifiuti soli<strong>di</strong>. Igiene <strong>degli</strong><br />
alimenti: tossinfezioni alimentari da Stafilococco, Salmonelle, Bacillo botulino. Latte come veicolo <strong>di</strong><br />
malattie. La bonifica del latte. L’acqua potabile: fonti <strong>di</strong> approvvigionamento idrico, criteri <strong>di</strong> potabilità,<br />
potabilizzazione delle acque.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso articolato in lezioni frontali in aula per 5 ore settimanali con un totale <strong>di</strong> 60 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica frontale.<br />
Il Corso è sud<strong>di</strong>viso in moduli monotematici.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in una prova orale sugli argomenti relativi al programma <strong>di</strong> esame.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento e materiale <strong>di</strong>dattico:<br />
POLI, COCUZZA, NICOLETTI, Microbiologia Me<strong>di</strong>ca, UTET, 1993. BARBUTI, BELELLI, FARA, GIAMMANCO,<br />
Igiene e Me<strong>di</strong>cina Preventiva, Bologna, Monduzzi, 2003.<br />
CHECCACCI, MELONI, PELISSERO, Igiene, Milano, Ambrosiana, 1992.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: prof.ssa D. Devito mer., ore 10-11.
AGROTECNICHE DELLE COLTURE OFFICINALI E TECNOLOGIE DI TRASFORMAZIONE<br />
ED<br />
UTILIZZAZIONE DELLE SPECIE OFFICINALI<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea in Tecniche Erboristiche)<br />
Attività formativa: C (affini o integrativi);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare AGR/02; cre<strong>di</strong>ti formativi: 10<br />
II Anno, II Semestre<br />
Svolto nel precedente a.a. da:<br />
proff. Vittorio Marzi e Giuseppe De Mastro<br />
Finalità del Corso<br />
Il Corso è mirato all’approfon<strong>di</strong>mento delle tematiche relative alla fase produttiva in campo e <strong>di</strong> prima<br />
trasformazione aziendale delle piante officinali con particolare attenzione agli aspetti della qualità, sicurezza<br />
e tracciabilità delle produzioni erboristiche in tutte le fasi dell’intera filiera.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
Parte generale. Definizioni <strong>di</strong> pianta aromatica e me<strong>di</strong>cinale. Le piante officinali come fonte <strong>di</strong> materie<br />
prime: settori d’impiego e <strong>di</strong>versificazione nell’impiego dei prodotti ottenibili. Il mercato delle piante<br />
officinali: specie coltivate, paesi produttori, import-export, domanda, offerta, prezzi. Realtà produttive,<br />
esperienze e progetti <strong>di</strong> ricerca. Organizzazione della filiera produttiva e rapporto fra modelli e tipologie<br />
aziendale: criteri <strong>di</strong> scelta delle specie, in<strong>di</strong>rizzo produttivo, investimenti, itinerari tecnici. Caratterizzazione<br />
<strong>degli</strong> ambienti <strong>di</strong> coltivazione: clima e caratteristiche pedologiche. Scelta del materiale <strong>di</strong> propagazione,<br />
valorizzazione delle popolazioni allo stato spontaneo e trasferimento in coltivazione. Trattamenti <strong>di</strong> post<br />
raccolta, meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> essiccazione, <strong>di</strong>stillazione e tecniche <strong>di</strong> estrazione, conservazione e confezionamento.<br />
Parte speciale. Borrago officinalis L., Arctiun lappa L., Tarassacum officinalis L., Artemisia spp.,<br />
Chamomilla recutita Rausch., Anthemis nobilis L., Cichorium intybus L., Achillea millefolium L., Arnica<br />
montana L., Calendula officinalis L., Sylibum marianum (L.) Gaertn., Helichrrysum italicum G. Don.,<br />
Tannacetum balsamita L., Isatis tinctoria L., Genziana lutea L., Hypericum perforatum L., Iris pallida Lam.,<br />
Crocus sativus L., Salvia spp., Melissa officinalis L., Menta x piperita L., Hyssopus officinalis L., Lavandula<br />
spp., Origanum spp., Ocimum basilicum L., Satureja spp., Rosmarinus officinalis L., Thymus vulgaris L.,<br />
Melilotus officinalis Lam., Glycyrrhizia glabra L., Lotus corniculatus L., Galega officinalis L., Malva<br />
sylvestris L., Althea officinalis L., Myrtus communis L., Eschscholtia californica Cham, Passiflora incarnata<br />
L., Plantago spp., Rheum spp., Digitalis lanata Ehrhart., Atropa belladonna L., Angelica spp., Foeniculum<br />
vulgare Miller, Carum carvi L., Coriandrum sativum L., Anthriscus cerefolium Hoffm., Anethum graveolens<br />
L., Pimpinella anisum L., Valeriana officinalis L., Lippia citriodora L.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso, articolato in lezioni ed esercitazioni in laboratorio ed in campo, è sud<strong>di</strong>viso in moduli monotematici<br />
svolti e coor<strong>di</strong>nati dai due docenti della <strong>di</strong>sciplina.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
Prova orale sugli argomenti trattati durante il Corso.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento e materiale <strong>di</strong>dattico:<br />
P. CATIZONE, G. TODERI, M. MAROTTI, P. TETENY, Coltivazioni delle piante me<strong>di</strong>cinali e aromatiche, Bologna,<br />
Pàtron, 1986.<br />
Tutto il materiale <strong>di</strong>dattico usato nelle lezioni e nelle esercitazioni sarà riportato su supporto elettronico e inserito nei<br />
computer dell’aula <strong>di</strong>dattica, a <strong>di</strong>sposizione <strong>degli</strong> studenti con largo anticipo.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: lun., mar., mer., ore 17-19.
CHIMICA FARMACEUTICA<br />
E FARMACOLOGIA GENERALE<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea in Tecniche Erboristiche)<br />
Attività formativa: B (caratterizzante);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare: CHIM/08 e BIO/14; cre<strong>di</strong>ti formativi: 11<br />
II Anno, II Semestre<br />
Svolto nel precedente a.a. da:<br />
proff. Giovanni Lentini e Annamaria De Luca<br />
Finalità del Corso<br />
Fornire allo studente competenze riguardanti i principi generali della struttura e dei meccanismi d’azione dei<br />
farmaci ed in particolare dei principi attivi <strong>di</strong> origine vegetale, nonché nozioni riguardanti le basi <strong>di</strong><br />
farmacoterapia e <strong>di</strong> interazione tra farmaci, alimenti e sostanze naturali.<br />
Contenuti del Corso per argomenti<br />
Farmacologia generale.<br />
Farmaci naturali e <strong>di</strong> sintesi. Bersagli dell’azione dei farmaci; Recettori e sistemi <strong>di</strong> trasduzione del segnale;<br />
Concetti <strong>di</strong> down- e up-regulation, desensitizzazione, tolleranza, <strong>di</strong>pendenza, resistenza e tachifilassi.<br />
Quantificazione dell’azione dei farmaci: affinità, attività intrinseca, efficacia e potenza. Farmaci agonisti,<br />
antagonisti, agonisti parziali ed inversi. Farmacocinetica: Vie <strong>di</strong> somministrazione; assorbimento,<br />
<strong>di</strong>stribuzione, metabolismo ed escrezione dei farmaci; posologia ed intervalli terapeutici; Variabilità<br />
in<strong>di</strong>viduale ai farmaci. Interazioni farmacocinetiche e farmaco<strong>di</strong>namiche tra xenobiotici: Principi <strong>di</strong><br />
tossicologia. Basi <strong>di</strong> Farmacoterapia; Farmacologia <strong>di</strong>: Sistema nervoso periferico e centrale, autacoi<strong>di</strong> ed<br />
ormoni, processi immunologici e infiammatori. Basi <strong>di</strong> terapia antiinfettiva ed antitumorale.<br />
Chimica Farmaceutica.<br />
Definizioni e obiettivi. Classificazioni dei Farmaci. Importanza dell’osservazione clinica nella scoperta dei<br />
farmaci. Nomenclatura dei Farmaci. Sperimentazione dei Farmaci. Ambiguità, rischio e aspettative nell’uso<br />
dei farmaci. Interazioni tra farmaci convenzionali e rime<strong>di</strong> fitoterapici: principi guida per uso e<br />
<strong>di</strong>spensazione <strong>di</strong> rime<strong>di</strong> fitoterapici; interazioni tra rime<strong>di</strong> fitoterapici e farmaci convenzionali. Farmaci<br />
convenzionali <strong>di</strong> origine vegetale: origine e ruolo dei metaboliti secondari; tappe dell’approccio basato sui<br />
prodotti naturali; vantaggi e svantaggi; esempi. Organizzazione e funzioni del SNC. Organizzazione e<br />
funzioni del SNP. Agenti farmaco<strong>di</strong>namici.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Lezioni ed esercitazioni in aula sud<strong>di</strong>vise in moduli monotematici svolti e coor<strong>di</strong>nati dai docenti, per almeno<br />
5 ore settimanali con un totale <strong>di</strong> circa 60 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica frontale.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in una prova orale sugli argomenti del programma svolto.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento e materiale <strong>di</strong>dattico:<br />
PAOLETTI, NICOSIA, CLEMENTI, FUMAGALLI, Farmacologia generale e molecolare, UTET.<br />
RANG, DALE, RITTER, Farmacologia, Ambrosiana.<br />
C. E G. WERMUTH, Le Applicazioni della Chimica Farmaceutica, E<strong>di</strong>SES.<br />
J. EMSLEY, Prodotti Chimici: Guida per il Consumatore, Zanichelli.<br />
Il materiale <strong>di</strong>dattico usato nelle lezioni ed esercitazioni sarà riportato, quando possibile, su supporto<br />
elettronico e inserito nei computer dell’aula <strong>di</strong>dattica, a <strong>di</strong>sposizione <strong>degli</strong> studenti. Sarà fornita copia<br />
cartacea del materiale usato durante lezioni ed esercitazioni, solo come guida ed integrazione ai testi sotto<br />
consigliati.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: prof.ssa A. De Luca lun. e mer., ore 9,30-12; prof. G. Lentini lun. e ven., ore 9,30-<br />
12,30.
ANALISI DI PRINCIPI ATTIVI DI NATURA ERBORISTICA<br />
E LABORATORIO DI ESTRATTIVA<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea in Tecniche Erboristiche)<br />
Attività formativa: B (caratterizzante);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare BIO/15; cre<strong>di</strong>ti formativi: 10<br />
III Anno, I Semestre<br />
Svolto nel precedente a.a. da:<br />
prof. Marcello Ferappi<br />
Finalità del Corso<br />
Il percorso <strong>di</strong>dattico punta a fornire una adeguata esperienza teorico-sperimentale con riferimento agli<br />
aspetti organizzativi pratici, alle apparecchiature estrattive, al controllo analitico delle procedure <strong>di</strong><br />
estrazione e <strong>di</strong> purificazione e della concentrazione dei principi attivi ricavati dal materiale grezzo <strong>di</strong><br />
partenza.<br />
Ciò premesso e tenendo presente la particolare identità culturale, acquisita nello stu<strong>di</strong>o delle <strong>di</strong>scipline<br />
chimiche <strong>di</strong> base e i fini per i quali tale insegnamento è stato inserito nel curriculum <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>, si ritiene che,<br />
pur prendendo le mosse da una ormai provata tra<strong>di</strong>zione, si debbano operare quei <strong>di</strong>mensionamenti sia per<br />
estensione che per profon<strong>di</strong>tà, che portino all’essenziale la parte teorica a favore <strong>di</strong> una più costruttiva<br />
elaborazione sperimentale.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
1.0 Differenze tra farmaci <strong>di</strong> sintesi e fitoterapici; il fitocomplesso.<br />
2.0 Principi attivi e sostanze secondarie presenti nella pianta fresca e secca.<br />
3.0 Estratti, fitoderivati, fitopreparati.<br />
4.0 Controlli su materie prime e su prodotti finali.<br />
5.0 Apparecchiature <strong>di</strong> laboratorio. 5.1 Resistenza <strong>di</strong> materiali ad agenti chimici e fisici. 5.2 Fonti <strong>di</strong> calore e<br />
mezzi refrigeranti.<br />
6.0 Distillazione. 6.1 Semplice. 6.2 Frazionata. 6.3 A pressione ridotta. 6.4 In corrente <strong>di</strong> vapore.<br />
7.0 Rifrattometria.<br />
8.0 Polarimetria.<br />
9.0 Cromatografia: assorbimento e ripartizione. 9.1 Tecniche cromatografiche: su colonna, su carta, su strato<br />
sottile, a scambio ionico, gascromatografia, HPLC.<br />
10.0 Processi <strong>di</strong> estrazione: macerazione, percolazione, <strong>di</strong>gestione, infusione, decozione, solventi <strong>di</strong><br />
estrazione. 10.1 Alcaloi<strong>di</strong>. 10.2 Steroli e steroi<strong>di</strong>. 10.3 Glucosi<strong>di</strong>. 10.4 Vitamine liposolubili.<br />
11.0 Forme farmaceutiche da piante fresche.<br />
12.0 Parte monografica: aglio, calendula, camomilla, cardo mariano, genziana, iberico, luppolo. passiflora,<br />
tarassaco, valeriana.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso, sud<strong>di</strong>viso in moduli monotematici, si articola in lezioni per almeno 5 ore settimanali con un totale<br />
<strong>di</strong> circa 60 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica frontale. Questa viene arricchita da selezionate esercitazioni <strong>di</strong> laboratorio per<br />
rendere più acquisibili gli approcci teorici, specie per quegli argomenti che meglio si prestano a evidenze<br />
<strong>di</strong>mostrative e che conducano ad una più utile ricaduta sulla futura professione. Le esercitazioni si svolgono<br />
nella II parte del Corso, per 2 settimane, tutti i giorni, dalle 15 alle 19.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
La prova <strong>di</strong> esame si realizza attraverso un colloquio sugli argomenti trattati e sulla valutazione delle prove<br />
<strong>di</strong> laboratorio eseguite durante il Corso.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento e materiale <strong>di</strong>dattico:<br />
B. PELLE, Il manuale del fitopreparatore, Milano, <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o E<strong>di</strong>zioni SAS. M. ROSSI, Tinture madri in<br />
fitoterapia, Milano, <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o E<strong>di</strong>zioni SAS. D.L. PAVIA, G.M. LAMPMAN, G.S. KRIZ, Il laboratorio <strong>di</strong><br />
Chimica organica, Milano, Sorbona. R. LONGO, Monografie tedesche, Milano, <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o E<strong>di</strong>zioni SAS.<br />
Tutto il materiale <strong>di</strong>dattico, riportato su supporto elettronico, viene inserito nei computer dell’aula <strong>di</strong>dattica.<br />
Sarà fornita anche una copia cartacea.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: mar., gio., ore 11-12; 17-19.
SAGGI E DOSAGGI FARMACOLOGICI<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea in Tecniche Erboristiche)<br />
Attività formativa: B (caratterizzante);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare BIO/14; cre<strong>di</strong>ti formativi: 10<br />
III Anno, I Semestre<br />
Svolto nel precedente a.a. da:<br />
prof. Marcello Diego Lograno<br />
Finalità del Corso<br />
Lo studente dovrà acquisire nozioni riguardanti le principali meto<strong>di</strong>che e i saggi in vitro e in vivo utili<br />
all’identificazione dell’attività biologica <strong>di</strong> principi attivi <strong>di</strong> interesse terapeutico estratti dal mondo vegetale,<br />
animale e minerale, nonché ricavati da sintesi chimica.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
1.0 Linee guida per la valutazione dell’attività biologica delle piante <strong>di</strong> interesse erboristico.<br />
2.0 Criteri <strong>di</strong> selezione <strong>di</strong> alcune piante officinali: Principio basato sulla presenza <strong>di</strong> specifici costituenti.<br />
3.0 Modelli animali in Farmacologia per saggi in vitro e in vivo. Concetto <strong>di</strong> stabulazione. L’uso<br />
dell’animale da laboratorio in Farmacologia.<br />
4.0 <strong>Stu<strong>di</strong></strong>o delle colture cellulari e loro applicazioni nella saggistica e sperimentazione farmacologica.<br />
5.0 La buona pratica <strong>di</strong> laboratorio in Farmacologia. Il protocollo sperimentale, standar<strong>di</strong>zzazione e<br />
riproducibilità <strong>di</strong> un saggio biologico.<br />
6.0 Cenni <strong>di</strong> Biometria e Analisi statistica dei dati sperimentali. Concetto <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a, Deviazione ed errore<br />
standard t-Student, Analisi della varianza.<br />
7.0 Rappresentazione grafica dei dati sperimentali: curve dose-risposta.<br />
8.0 Saggi su organi isolati (metodo funzionale). Ileo <strong>di</strong> cavia, Arteria aorta <strong>di</strong> ratto, tratto <strong>di</strong>scendente. Utero<br />
<strong>di</strong> ratta, Trachea <strong>di</strong> ratto.<br />
9.0 Saggi <strong>di</strong> bin<strong>di</strong>ng (metodo biochimico).<br />
10.0 Saggi <strong>di</strong> elettro-farmacologia per la caratterizzazione <strong>di</strong> recettori canale.<br />
11.0 Meto<strong>di</strong> in vivo per lo stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS).<br />
12.0 Meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o dei farmaci della sfera uterina.<br />
13.0 Meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o dei farmaci della sfera gastro-enterica.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso, articolato in lezioni frontali in aula, è sud<strong>di</strong>viso in moduli monotematici svolto e coor<strong>di</strong>nato dal<br />
docente incaricato della <strong>di</strong>sciplina, per almeno 5 ore settimanali con un totale <strong>di</strong> circa 60 ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica.<br />
Esame finale <strong>di</strong> verifica e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame consiste in una prova orale nella quale il can<strong>di</strong>dato dovrà <strong>di</strong>mostrare <strong>di</strong> aver acquisito una<br />
preparazione approfon<strong>di</strong>ta sulle meto<strong>di</strong>che <strong>di</strong> saggistica farmacologica <strong>di</strong> base e applicata e su alcuni<br />
parametri <strong>di</strong> Statistica sperimentale.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento:<br />
PAOLETTI, NICOSIA, CLEMENTI, FUMAGALLI, Tossicologia generale e molecolare, UTET.<br />
DOLARA, FRANCONI, MUGELLI, Farmacologia e tossicologia sperimentale, Pitagora.<br />
Supplemento della FU, Droghe vegetali e preparazioni, 9. ed.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: lun., ore 10-12.
PRODOTTI COSMETICI E DIETETICI<br />
DI ORIGINE VEGETALE<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea in Tecniche Erboristiche)<br />
Attività formativa: B (caratterizzante) C (affini o integrativi);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare CHIM /09 e CHIM/010; cre<strong>di</strong>ti formativi: 10<br />
III Anno, II Semestre<br />
Svolto nel precedente a.a. da:<br />
proff. Savina Ferorelli e Francesco Berar<strong>di</strong><br />
Finalità del Corso<br />
Il Corso ha lo scopo <strong>di</strong> fornire informazioni <strong>di</strong> base sulla Chimica e sul meccanismo d’azione <strong>di</strong> molecole <strong>di</strong><br />
derivazione vegetale da utilizzare in prodotti cosmetici e <strong>di</strong>etetici.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
Prodotti cosmetici: Significato e uso del prodotto cosmetico. Cenni sulla Legislazione Cosmetica. Eccipienti<br />
lipofili anidri: oli, burri e cere <strong>di</strong> derivazione vegetale. Autoossidazione <strong>degli</strong> oli e antiossidanti naturali.<br />
Eccipienti idrofili. Inquinamento microbico e uso <strong>di</strong> antimicrobici. Chelanti. Emulsiologia e preparazioni <strong>di</strong><br />
emulsioni. Gel. Odori corporei e loro attenuazione con principi attivi <strong>di</strong> derivazione vegetale. Prodotti solari<br />
ed uso <strong>di</strong> derivati vegetali ad azione filtrante le ra<strong>di</strong>azioni U.V.<br />
Prodotti <strong>di</strong>etetici: Significato e obiettivi del prodotto <strong>di</strong>etetico. Normative attuali sui prodotti <strong>di</strong>etetici e sugli<br />
integratori alimentari. Standard nutrizionali e fabbisogni energetici particolari. Integrazione alimentare.<br />
Composizione <strong>degli</strong> alimenti e principi alimentari. Latti vegetali e mo<strong>di</strong>ficati con prodotti vegetali. Dietetici<br />
a base gluci<strong>di</strong>ca: derivati da scissione dell’amido, fecole, manioca, tapioca. Prodotti per celiaci e per<br />
<strong>di</strong>abetici. Edulcoranti vegetali e semisintetici. Fibre <strong>di</strong>etetiche solubili e insolubili, prodotti a base <strong>di</strong> fibra.<br />
Proteine vegetali e loro impiego nei prodotti <strong>di</strong>etetici. Dietetici a base lipi<strong>di</strong>ca: oli vegetali e fosfolipi<strong>di</strong>.<br />
Antiossidanti vegetali.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso è sud<strong>di</strong>viso in due moduli svolti per almeno 5 ore settimanali con un totale <strong>di</strong> circa 60 ore <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>dattica frontale (sud<strong>di</strong>vise in 30 per modulo).<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
L’esame si svolge in un unico colloquio orale.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento e materiale <strong>di</strong>dattico:<br />
PROSERPIO, Chimica e tecnica cosmetica, Milano, Sepem.<br />
PROSERPIO, Piante oleaginose, mucillaginose e colorate per uso alimentare, farmaceutico, erboristico,<br />
cosmetico e industriale, Milano, Sepem.<br />
CECCHETTI, MILANESI, Scienza dell’alimentazione, Milano, Ambrosiana, 1994.<br />
GIULIANO, STEIN, Quaderni <strong>di</strong> Chimica <strong>degli</strong> alimenti. Alimenti <strong>di</strong>etetici, Roma, Bulzoni, 1988.<br />
CAPPELLI, VANNUCCHI, Chimica <strong>degli</strong> alimenti, Bologna, Zanichelli, 2000.<br />
Parte del materiale <strong>di</strong>dattico usato nelle lezioni sarà riportato su supporto elettronico e inserito nei computer<br />
dell’aula <strong>di</strong>dattica<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: prof. Berar<strong>di</strong> mar., ore 12,30-13,30; mer., ore 18-19; gio., ore 17-18; prof.ssa<br />
Ferorelli mar., 17-18; gio., ore 10-11.
TECNOLOGIA FARMACEUTICA E LEGISLAZIONE ERBORISTICA<br />
(Corso <strong>di</strong> laurea in Tecniche Erboristiche)<br />
Attività formativa: B (caratterizzante);<br />
settore <strong>di</strong>sciplinare CHIM/09; cre<strong>di</strong>ti formativi: 12<br />
III Anno, II Semestre<br />
Svolto nel precedente a.a. da:<br />
prof. Massimo Franco<br />
Finalità del Corso<br />
Il Corso si propone <strong>di</strong> far acquisire allo studente le conoscenze tecnologico-farmaceutiche e legislative <strong>di</strong><br />
base per il conseguimento del livello formativo richiesto dall’area professionale <strong>di</strong> tecnico erborista.<br />
Contenuto del Corso per argomenti<br />
Definizione <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cinale e prodotto erboristico. Farmaco e forma farmaceutica, eccipienti, coa<strong>di</strong>uvanti.<br />
Principali vie <strong>di</strong> somministrazione.<br />
Operazioni farmaceutiche generali: polverizzazione, setacciatura, analisi granulometrica, densità vera ed<br />
apparente, porosità, caratteristiche <strong>di</strong> scorrimento, mescolamento, essiccamento <strong>di</strong> prodotti soli<strong>di</strong> e liqui<strong>di</strong>.<br />
Definizione, caratteristiche e controlli <strong>di</strong> forme farmaceutiche solide (polveri, granulati, compresse, confetti,<br />
capsule rigide e molli) e liquide (soluzioni, emulsioni, sospensioni, sciroppi).<br />
Preparazioni semisolide per uso dermatologico. Omeopatici.<br />
Droghe vegetali e preparati ottenibili da droghe vegetali (droghe in polvere, essenze, idrolati, alcoolati,<br />
tinture ed estratti, infusi e decotti). Meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> soluzione estrattiva (infusione, decozione, macerazione,<br />
<strong>di</strong>gestione, percolazione). Aspetti normativi riguardanti il settore erboristico. Farmacopea Ufficiale della<br />
Repubblica Italiana XI e<strong>di</strong>zione, Farmacopea Europea. Organizzazione sanitaria italiana. Professioni<br />
sanitarie ausiliarie e arti sanitarie.<br />
Organizzazione del Corso<br />
Il Corso, impostato in lezioni frontali in aula per almeno cinque ore settimanali e per un totale <strong>di</strong> circa<br />
sessanta ore <strong>di</strong> <strong>di</strong>dattica, è sud<strong>di</strong>viso in moduli sviluppati da un docente della <strong>di</strong>sciplina. La <strong>di</strong>dattica frontale<br />
potrà essere integrata con alcune esercitazioni <strong>di</strong> laboratorio.<br />
Esame finale e modalità <strong>di</strong> svolgimento<br />
La prova <strong>di</strong> esame consisterà in un colloquio che verterà sull’intero programma svolto. L’esame potrà<br />
svolgersi durante le sessioni ufficiali previa prenotazione almeno tre giorni prima della data stabilita.<br />
Testi <strong>di</strong> riferimento:<br />
M. AMOROSA, Principi <strong>di</strong> tecnica farmaceutica, Tinarelli, 1995.<br />
F. PAPASSO, G. GRANDOLINI, Fitofarmacia Impiego razionale delle droghe vegetali, 2. ed, Sprinter, 1999.<br />
F. BETTIOL, Manuale delle preparazioni galeniche, Milano, Tecniche Nuove, 1995.<br />
M. MARCHETTI, M. MINGHETTI, Legislazione Farmaceutica, 3. ed., CEA, 2002.<br />
Orario <strong>di</strong> ricevimento: lun., mar., ore 11-13, gio., ore 17-19.