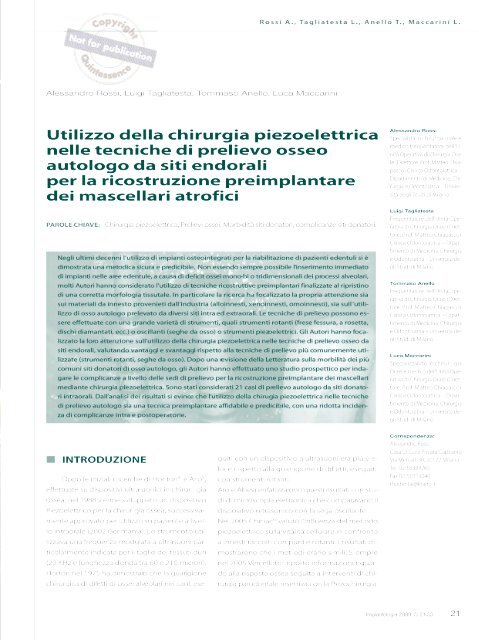Download - Studio Dentistico Dr. Luigi Tagliatesta
Download - Studio Dentistico Dr. Luigi Tagliatesta
Download - Studio Dentistico Dr. Luigi Tagliatesta
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Rossi A., <strong>Tagliatesta</strong> L., Anello T., Maccarini L.<br />
22<br />
Implantologia 2009; 3: 21-33<br />
Infine alcuni lavori scientifici condotti su animali 8<br />
sembrano dimostrare che, nei dif etti creati con<br />
un dispositivo a ultrasuoni, l’osso rigenera in modo<br />
simile o addirittura migliore di quelli con difetti<br />
creati con strumenti rotanti.<br />
Gli Autori hanno f ocalizzato la lor o attenzione sull’utilizzo<br />
della chirurgia piezoelettrica nelle tecniche<br />
di prelievo osseo da siti endorali, valutando vantaggi<br />
e svantaggi rispetto alle tecniche tradizionali.<br />
Obiettivo dunque di quest o articolo è di mostrar e<br />
come l’utilizzo della chirurgia piezoelettrica nei prelievi<br />
autologhi endorali possa rappresentare una valida<br />
alternativa alle tecniche tradizionali di prelievo.<br />
Prima di entrare nello specifico della tecnica chirurgica<br />
e di valutar e i r isultati ottenuti, verranno<br />
analizzati i pr incipali siti donat ori intraorali con<br />
particolare attenzione alle indicazioni per ogni sito<br />
di prelievo e alle rispettive tecniche chirurgiche.<br />
SITI DONATORI INTRA-ORALI<br />
Con le attuali t ecniche di chirur gia preimplantare<br />
è possibile eff ettuare riabilitazioni implantoprotesiche<br />
anche in pazienti affetti da gravi<br />
atrofie dei mascellari9-25 .<br />
Nonostante siano stati proposti diversi materiali alloplastici,<br />
rivelatisi efficaci prevalentemente nei difetti<br />
minori, l’osso autologo rimane il materiale di riferimento<br />
sia per le g randi sia per le piccole r icostruzioni<br />
preimplantari, in virtù delle sue proprietà<br />
osteogenetiche, osteoinduttive e osteoconduttive.<br />
I siti donatori di osso autologo possono essere suddivisi<br />
in 2 gruppi principali: intraorali ed extraorali.<br />
In par ticolare i siti donat ori intraorali di più fr equente<br />
utilizzo sono:<br />
• ramo e corpo della mandibola;<br />
• sinfisi mentoniera;<br />
• tuber mascellare.<br />
La scelta del sit o donatore è legata pr incipalmente<br />
a tre fattori:<br />
1. la quantità di t essuto osseo necessar io per la<br />
correzione del difetto;<br />
2. la qualità dell’osso (corticale o spongioso);<br />
3. il rapporto costi biologici/benefici ottenuti cui<br />
sottoporre il paziente.<br />
Per scegliere il sito donatore è necessar io prima<br />
conoscere quali siano i volumi medi di alcuni tipi<br />
di difetti ossei da ricostruire:<br />
• ricostruzione di difetti associati a monoedentulia:<br />
1-3 ml;<br />
• ricostruzione di difetti associati ad assenza di 2-3<br />
elementi dentari: 4-9 ml;<br />
• rialzo del seno mascellare monolaterale: 5-10 ml;<br />
• rialzo del seno mascellare in caso di seno molto<br />
pneumatizzato: 10-15 ml;<br />
• ricostruzioni complesse nelle edentulie t otali<br />
associate a gravi atrofie: >30 ml.<br />
Altro parametro di indubbia importanza per il successo<br />
delle r icostruzioni preimplantari con osso<br />
autologo risulta essere la conoscenza e il r ispetto<br />
dei tempi di attecchimento dei singoli tipi di innesti<br />
autologhi. I tempi di attesa per la rivascolarizzazione<br />
e sostituzione del trapianto osseo, a parità di<br />
condizioni, locali del letto ricevente e sistemiche di<br />
salute del pazient e, dipendono dalla quantità di<br />
osso corticale presente. Quanto maggiore sarà lo<br />
strato di osso corticale, tanto più lenta sarà la rivascolarizzazione.<br />
D ’altra par te però, quanto maggiore<br />
è la componente corticale dell’innesto, tanto<br />
maggiore è il mantenimento del volume osseo;<br />
infatti innesti pr evalentemente spugnosi presentano<br />
un più alto grado di riassorbimento.<br />
È importante che qualsiasi genere di innesto, sia<br />
corticale che spugnoso, venga stimolato precocemente,<br />
compatibilmente con i tempi di attecchimento,<br />
dal carico funzionale trasmesso all’osso<br />
dagli impianti osteointegrati per non andare incontro<br />
a riassorbimento26,27 .<br />
I tempi di attesa tra innesto e inserimento di impianti<br />
osteointegrati possono esser e così schematizzati<br />
in base al sito di prelievo:<br />
• ramo mandibolare: 4-6 mesi;<br />
• sinfisi mentoniera: 4-6 mesi;<br />
• tuber mascellare: 2-4 mesi.<br />
A dispetto degli indubbi vantaggi dell’osso autologo,<br />
non devono tuttavia essere trascurati i possibili<br />
svantaggi legati sia al costo biologico sia alla<br />
morbilità del prelievo osseo.<br />
SITI DONATORI INTRAORALI<br />
I siti di prelievo intraorali maggiormente utilizzati<br />
e documentati nella Letteratura scientifica<br />
sono: il ramo mandibolare, la sinfisi mentoniera e<br />
il tuber mascellare.<br />
Non verrà analizzato il tuber mascellare come sede<br />
di pr elievo in quant o da questa sede non è<br />
possibile prelevare osso autologo in blocco e inoltre<br />
nel nostro studio non è stat o considerato alcun<br />
prelievo eseguito in questa sede.
PRELIEVO OSSEO DAL RAMO<br />
MANDIBOLARE<br />
Rossi A., <strong>Tagliatesta</strong> L., Anello T., Maccarini L.<br />
In passato rappresentava un’alternativa al<br />
le, rendono il prelievo osseo dal ramo mandibolare<br />
una soluzione ben accettata dai pazienti.<br />
Dal punto di vista chirurgico il prelievo dal ramo<br />
mandibolare richiede una tecnica più complessa<br />
prelievo osseo dalla sinfisi ment oniera; attual- rispetto al prelievo osseo dalla sinfisi mentoniera.<br />
mente il pr elievo dal ramo mandibolar e va pr o- Le maggiori complicanze a carico di questa sede<br />
gressivamente sostituendo quello dal mento co- di prelievo possono essere così riassunte:<br />
me sede donatrice intraorale per la ricostruzione • lesione del nervo alveolare inferiore;<br />
di atrofie del processo alveolare, sia per la continua • lesione del nervo linguale;<br />
evoluzione delle tecniche chirurgiche di prelievo • lesione dell'arteria facciale;<br />
sia per il decorso post operatorio spesso caratte- • lesione dell'arteria alveolare inferiore;<br />
rizzato da una ridotta morbilità.<br />
• lesione dell'arteria miloioidea;<br />
La zona di prelievo è compresa tra primo molare e • lesioni degli apici dei molar i eventualmente<br />
ramo mandibolare in cor rispondenza della linea presenti;<br />
obliqua esterna, mantenendosi sempre sul v er- • frattura della mandibola;<br />
sante vestibolare della porzione posteriore del cor- • infezione;<br />
po mandibolare e del ramo. Può essere eseguito in • deiscenza della ferita chirurgica.<br />
anestesia locale, salvo quando la complessità del- La prevenzione delle rarissime complicanze di quela<br />
procedura chirurgica ricostruttiva richieda temsto tipo di prelievo osseo intraorale si attua con:<br />
pi operatori molto lunghi e nei casi di r idotta col- 1. una chirurgia basata sulla perfetta conoscenza<br />
laborazione/apertura della bocca del pazient e. I l dell'anatomia;<br />
prelievo può essere eseguito o tramite l’utilizzo di 2. una manualità chirurgica improntata al rispet-<br />
frese fessura e a rosetta o tramite seghe oscillanti, to dei tessuti interessati al prelievo e a quelli li-<br />
oppure tramite chirurgia piezoelettrica: le fasi osteomitrofi alla sede chirurgica;<br />
tomiche finali vengono spesso eseguite con l’ausi- 3. un rigoroso scollamento periostale, soprattutlio<br />
di scalpelli curvi e dritti. Quando la quantità di osto sul versante linguale;<br />
so necessaria è ridotta, come nei casi di GBR, si pos- 4. l'esatta localizzazione preoperatoria del decorsono<br />
utilizzare le frese di carotazione.<br />
so del canale mandibolare;<br />
È un prelievo osseo di tipo corticale (sempre mo- 5. il controllo del sanguinamento con un attento<br />
nocorticale) con una limitata possibilità di prelie- utilizzo della diatermocoagulazione;<br />
vo di osso spongioso, per la presenza del canale<br />
mandibolare.<br />
Le caratteristiche dell’osso sono simili a quelle del-<br />
6. la perfetta sutura del campo operatorio.<br />
la sinfisi mentoniera, con una cor ticale maggior- PRELIEVO OSSEO DALLA SINFISI<br />
mente rappresentata e r endono il pr elievo difficilmente<br />
modellabile nella forma e nelle dimen-<br />
MENTONIERA<br />
sioni: inoltre la compattezza della corticale non si La sinfisi mentoniera rappresenta la sede più<br />
presta facilmente alla sua r iduzione a osso par ti- frequente per il prelievo osseo intraorale nella ricolato,<br />
pertanto l’osso prelevato da questo sito ricostruzione di dif etti ossei a scopo implantar e,<br />
sulta poco idoneo all ’utilizzo di t ecniche rico- anche se negli ultimi anni il pr elievo dall’area restruttive<br />
del seno mascellare.<br />
tromolare/ramo mandibolare sembra raccogliere<br />
Con questo tipo di prelievo è possibile ottenere fi- un gradimento sempre maggiore, come sede inno<br />
a 10 ml di osso corticale per lato, particolarmente traorale di prelievo osseo, in considerazione della<br />
adatto a ricostruzioni crestali orizzontali e verticali. minor frequenza di complicanze postoperatorie.<br />
La quasi assenza di complicanze neurologiche, un Il mento è una sede che consente, in pazienti che<br />
eccellente decorso postoperatorio, la vicinanza tra conservano la pr opria dentizione, l’asportazione<br />
sede di pr elievo e sit o ricevente, l ’ottima qualità anche di 10 ml di osso prevalentemente cortica-<br />
dell’osso di tipo membranoso con una spessa corle di tipo membranoso tra i due forami mentonieri<br />
ticale, la buona quantità prelevabile e la possibili- e al di sotto degli apici dentari, ovvero nello spatà<br />
di esecuzione dell’intervento in anestesia loca- zio compreso tra i due canini.<br />
Implantologia 2009; 3: 21-33<br />
23
Rossi A., <strong>Tagliatesta</strong> L., Anello T., Maccarini L.<br />
24<br />
Implantologia 2009; 3: 21-33<br />
In questi pazienti però, il prelievo può comportare<br />
fastidiose parestesie dentali nel decorso post operatorio<br />
transitorie o permanenti.<br />
Nei pazienti che hanno perso il gruppo incisale inferiore<br />
è possibile appr ofondire il prelievo corticale<br />
con la r imozione della spongiosa presente,<br />
facendo però attenzione a non intaccare la corticale<br />
linguale. Infatti, a ridosso della corticale linguale<br />
decorrono i vasi sottomentonieri, sottolinguali<br />
e le loro anastomosi che, se lesionati, possono<br />
provocare emor ragie anche impor tanti e<br />
difficilmente gestibili. Inoltre un prelievo bicorticale<br />
espone al rischio di una netta riduzione del<br />
potenziale rigenerativo del tessuto osseo locale<br />
per occupazione dello spazio vuoto che residua<br />
al prelievo da parte di tessuto connettivo.<br />
Dopo il prelievo monocorticale invece si ha una<br />
rigenerazione ossea molt o più rapida tant o da<br />
rendere possibile un ulteriore prelievo anche dopo<br />
12 mesi.<br />
Il prelievo osseo dalla sinfisi mentoniera trova indicazione<br />
soprattutto nella ricostruzione di difetti<br />
verticali a sella o per il r ialzo di un seno mascellare<br />
dopo riduzione in osso particolato.<br />
La facile accessibilità chirurgica, la vicinanza al sito<br />
ricevente, l’ottima qualità dell’osso, la possibilità<br />
di esecuzione in anestesia locale e l’assenza di<br />
cicatrici cutanee rendono il prelievo osseo dalla<br />
sinfisi mentoniera un int ervento facilmente accettato<br />
dai pazienti che necessitano di piccoli interventi<br />
ricostruttivi delle ossa mascellari a scopo<br />
implantologico. Il prelievo dalla super ficie vestibolare<br />
della sinfisi mentoniera è condotto in una<br />
zona compresa tra i f orami mentonieri in senso<br />
mesio-distale e tra gli apici del gruppo incisivo inferiore<br />
e il margine inferiore del corpo mandibolare<br />
in senso corono-caudale, mantenendo sempre<br />
un margine di sicurezza di almeno 5 mm dagli<br />
apici dentari, per prevenire la lesione dei fasci<br />
vascolonervosi pulpari con conseguente devitalizzazione<br />
degli elementi stessi e di 2 mm dal bordo<br />
inferiore della mandibola per evitar e alterazioni<br />
del profilo del volto.<br />
L’intervento è quasi sempre attuabile in anestesia<br />
locale, salvo quando la complessità della pr ocedura<br />
chirurgica ricostruttiva renda prevedibili<br />
tempi operatori molto lunghi e nei casi di r idotta<br />
collaborazione/aper tura della bocca del paziente.<br />
Previa incisione longitudinale nel fornice<br />
con mantenimento delle inserzioni superiori dei<br />
muscoli mentali e scheletrizzazione della sinfisi, il<br />
prelievo viene eseguito tramite l’utilizzo di frese<br />
fessura e a r osetta (o tramit e seghe oscillanti o<br />
chirurgia piezoelettrica) e con l’ausilio di scalpelli<br />
curvi e dritti. L’emostasi viene ottenuta tramite<br />
garze di cellulosa ossidata e, solo nei casi di sanguinamento<br />
persistente, si ricorre all’uso di cera<br />
da osso in quantità minima. D opo un’accurata<br />
sutura a punti staccati, riassorbibile sui capi muscolari<br />
riposizionati e non riassorbibile sulla mucosa<br />
orale, la z ona è posta in leggera compr essione<br />
e al pazient e viene prescritta una dieta liquida/morbida<br />
per la prima settimana postoperatoria,<br />
l’utilizzo di collutorio a base di clorexidina<br />
0,12% oltre a una terapia farmacologica antibiotica<br />
e analgesica.<br />
Le più comuni complicanze di questo tipo di prelievo<br />
osseo possono essere rappresentate da:<br />
• lesione diretta del nervo incisivo;<br />
• lesione diretta del nervo mentoniero;<br />
• emorragia da lesione dell’arteria sottomentoniera;<br />
• emorragia da lesione dell’arteria sottolinguale<br />
in caso di penetrazione nel pavimento orale;<br />
• ptosi del mento;<br />
• infezione o deiscenza della ferita.<br />
La corretta prevenzione delle complicanze si attua<br />
con:<br />
1. una condotta chirur gica improntata alla perfetta<br />
conoscenza dell’anatomia;<br />
2. un’adeguata manualità chirurgica che rispetti<br />
i tessuti interessati al prelievo e quelli contigui<br />
alla sede chirurgica;<br />
3. uno scollamento periostale che non deve mai<br />
raggiungere o superar e il mar gine inferiore<br />
della mandibola;<br />
4. il controllo del sanguinamento mediante l’utilizzo<br />
di cellulosa ossidata e rigenerata o spugne<br />
di collagene;<br />
5. l’uso mirato ai soli punti di evident e sanguinamento<br />
di cera da osso;<br />
6. una sutura attenta dei diversi piani chirurgici<br />
ed il riposizionamento corretto delle strutture<br />
muscolari e della mucosa.<br />
Se il chirurgo orale attua un ’adeguata condotta<br />
terapeutica, la comparsa delle più g ravi complicanze<br />
è assai rara.
■ MATERIALI E METODI<br />
Nel biennio 2007-2008 sono stati trattati 16<br />
pazienti (9 maschi e 7 f emmine), sottoposti a 21<br />
prelievi ossei, per difetti mascellari e mandibolari di<br />
vario tipo ed entità; sono stati eseguiti 20 prelievi dal<br />
ramo mandibolare e un prelievo dalla sinfisi mentoniera<br />
in un paziente privo degli incisivi inferiori.<br />
Sono state utilizzate le seguenti tecniche chirurgiche<br />
ricostruttive:<br />
1. rigenerazione ossea guidata con membrane<br />
non riassorbibili (2 casi con bone chips e membrana<br />
rinforzata in titanio WTR9® Goretex);<br />
2. innesti di apposizione (19 casi di cui 7 or izzontali,<br />
14 verticali e 3 combinati) e 12 grandi<br />
rialzi del seno mascellare, di cui 11 in associazione<br />
a innesti verticali, 1 in associazione a innesti<br />
orizzontali e 2 in associazione a innesti<br />
verticali e orizzontali.<br />
L’osso prelevato è stato utilizzato in blocco in 20<br />
casi, mentre in due casi l ’innesto è stato trasformato<br />
in chip mediante trita osso. In alcuni casi la<br />
ricostruzione è stata eseguita g razie all’ausilio di<br />
materiali di sintesi (Bio-Oss®Geistlich, Microchips<br />
e Membrana Tutodent® Tutogen, Butterfly) e di<br />
barriere riassorbibili (Biogide® Geistlich) e non riassorbibili<br />
(Tr9w® Goretex) (Tab. 1).<br />
In 7 casi l’accesso all’area di prelievo è stato eseguito<br />
senza soluzione di continuo conl ’accesso all’area<br />
da ricostruire e/o rigenerare. Tale parametro risulta<br />
di particolare rilievo poiché ha influenzato le risposte<br />
dei pazienti al questionario consegnato loro per<br />
consentire la raccolta dati utilizzati in questo studio.<br />
I criteri di inclusione stabiliti sono stati:<br />
• assenza di pat ologie orali e sist emiche controindicanti<br />
l’esecuzione dell’intervento chirurgico;<br />
• presenza di difetti ossei verticali e/o orizzontali<br />
in creste alveolari completamente o par zialmente<br />
edentule e/o pr esenza di pneumatizzazione<br />
del seno mascellare.<br />
I criteri di esclusione sono stati i seguenti:<br />
• abuso di alcool o tabacco;<br />
• patologie renali o epatiche gravi;<br />
• storia di radioterapia nel distretto cervico-facciale;<br />
• chemioterapia antiblastica in corso;<br />
• diabete non compensato;<br />
• malattia parodontale a carico della dentatura<br />
residua;<br />
• patologie a car ico delle mucose (e .g. lichen<br />
planus) nelle zone da trattare;<br />
Rossi A., <strong>Tagliatesta</strong> L., Anello T., Maccarini L.<br />
Tabella 1 Tabella riassume tutte le caratteristiche dei pazienti trattati.<br />
Paziente Nascita Sesso Prelievo Materiale eterologo Sede prelievo Tipo ricostruzione Anestesia Data ricostro Complicanze Complicanze<br />
sito donatore sito ricevente<br />
1 1953 F Lato dx bo+bg Ramo Onlay orizzontale Sed 10-2007 no no<br />
1 1953 F Lato sx bo+bg Ramo Onlay orizzontale Sed 10-2007 no no<br />
2 1949 M Lato dx bo+bg Ramo Onlay verticale Sed 10-2007 no no<br />
3 1936 F monol bo+bg Ramo Onlay verticale Gen 04-2007 no no<br />
4 1958 F Lato sx bo+bg Ramo Onlay verticale+sl Gen 09-2007 no no<br />
4 1958 F Lato dx bo+bg Ramo Onlay orizzontale+sl Gen 09-2007 no no<br />
5 1949 F Lato dx Bo+bg Ramo Onlay verticale+ sl Sed 04-2007 no esposizione<br />
6 1938 F Lato dx Ramo Onlay verti+orizz+ sl Gen 05-2007 no no<br />
6 1938 F Lato sx Ramo Onlay verticale+ sl Gen 05-2007 no no<br />
7 1939 F Lato dx bo+bg Ramo Onlay verticale+ sl Gen 01-2007 no no<br />
7 1939 F Lato sx bo+bg Ramo Onlay verti+orizz+ sl Gen 01-2007 no no<br />
8 1930 M Lato dx bo+bg Ramo Onlay verticale +sl Loc 02-2007 no no<br />
9 1981 M Lato dx Membr+chips+tutodent Ramo Onlay verticale +orizzontale Loc 03-2007 no no<br />
10 1978 M Lato dx TR9W Ramo GBR+ membr titanio Loc 03-2008 no no<br />
11 1948 M Lato dx bg Ramo Onlay verticale Loc 06-2007 no Parestesia<br />
12 1939 M Lato dx bo+bg Ramo Onlay verticale+ sl Loc 12-2007 no no<br />
13 1941 F Lato dx Bo+bg Ramo Onlay verticale+ sl Sed 01-2008 no no<br />
13 1941 F Lato sx Bo+bg Ramo Onlay verticale+ sl Sed 01-2008 no no<br />
14 1977 M TR9W sinfisi GBR+ membr titanio Sed 11-2007 no rimozione membrana<br />
15 1938 M Lato sx bo+bg Ramo Onlay verticale+sl gen 05-2007 no no<br />
16 1948 M Lato sx Ramo Onlay orizzontale Sed 02-2007 no no<br />
Legenda: bo = bioss; bg = biogide; sl = sinuslift.<br />
• igiene orale insufficiente;<br />
• insufficiente collaborazione da par te del paziente.<br />
Tutti gli interventi sono stati effettuati presso strutture<br />
pr ivate site in M ilano. Tutti i pazienti sono<br />
stati trattati dalla medesima èquipe e con la medesima<br />
tecnica chirurgica.<br />
Implantologia 2009; 3: 21-33<br />
25
Rossi A., <strong>Tagliatesta</strong> L., Anello T., Maccarini L.<br />
26<br />
Implantologia 2009; 3: 21-33<br />
TECNICA CHIRURGICA<br />
I pazienti sono stati trattati in anest esia ge-<br />
nerale o in sedoanalgesia venosa o in anestesia locale<br />
a seconda del tipo di pr elievo e soprattutto<br />
del tipo di ricostruzione preimplantare necessaria.<br />
I pazienti trattati in anest esia locale hanno r icevuto<br />
sia l’anestesia tronculare al nervo alveolare<br />
inferiore e linguale, sia l’anestesia loco-regionale<br />
al nervo buccale (4% ar ticaina/1:100,000 epinefrina,<br />
ultracaina forte, Aventis Pharma).<br />
Pazienti trattati in anestesia generale e in sedazione<br />
endovenosa hanno r icevuto unicamente l ’anestesia<br />
locoregionale sia sul versante vestibolare<br />
sia sul versante linguale della mandibola. Una singola<br />
dose per via endovenosa di penicillina (2 gr.<br />
Amoxicillina + Acido clavulanico) è stata somministrata<br />
ai pazienti pre-operatoriamente.<br />
Un antibiotico di copertura è stato prescritto per<br />
via orale per i 5 g iorni successivi all ’intervento.<br />
Tutti i pazienti hanno seguito lo stesso protocollo<br />
antisettico (clorexidina 012% - 3 volte al dì per<br />
10 giorni) e antidolorifico (Nimesulide 100 mg - 2<br />
volte al dì per 3 giorni).<br />
Per accedere alla zona del ramo mandibolar e, è<br />
stata fatta un’incisione distale al secondo molare<br />
sul lato vestibolare nella z ona posteriore della<br />
stessa.<br />
In tutti i casi in cui l’area di prelievo non era attigua<br />
all’area di innesto il lembo di accesso è sempre<br />
stato paramarginale a livello della linea obliqua<br />
esterna, con scar ico posteriore a liv ello del<br />
processo coronoide. L’osteotomia è stata eff ettuata<br />
con il dispositivo chirurgico Piezoelettrico,<br />
(Piezosurgery® Mectron) mediante l’utilizzo di inserti<br />
dedicati (OT7, OP1, OT8R e OT8L ®Mectron).<br />
Dopo aver tracciato i contorni del prelievo osseo<br />
attraverso la par ete cor ticale, il blocco è stat o<br />
sempre rimosso mediante scalpello, senza usare<br />
il martello.<br />
Per prevenire e/o r idurre il sanguinament o postoperatorio<br />
e l’ematoma postoperatorio il difetto<br />
è stato ricoperto mediante una garza di cellulosa<br />
ossidata ( Tabotamp®). Il lembo d ’accesso è<br />
stato chiuso mediant e punti di sutura staccati<br />
non riassorbilili.<br />
Viene mostrato un caso clinico esemplificativ o<br />
(Figg. 1-21).<br />
È stato applicato un impacco di ghiaccio nelle 8<br />
ore succesive all’intervento e applicato un protocollo<br />
postoperatorio standardizzato e r igoroso<br />
per ogni paziente.<br />
Tutti i pazienti sono stati monitorati con il medesimo<br />
follow-up: a distanza di 10 g iorni è stata rimossa<br />
la sutura ed eseguit o un controllo radiografico<br />
(radiografia endorale o ortopantomografia).<br />
Successivamente tutti i pazienti sono stati clinicamente<br />
valutati a 4 - 12 - 20 settimane dall’intervento<br />
chirurgico.<br />
Per ogni innesto prelevato si sono registrati i seguenti<br />
parametri: dimensione e f orma degli innesti,<br />
le complicanz e postoperatorie, l ’attecchimento<br />
o il riassorbimento degli innesti d’osso.<br />
La dimensione degli innesti è stata misurata in seguito<br />
alla rimozione dal sito donatore con il principio<br />
d’Archimede.<br />
La morfologia di ciascun innesto è stata grossolanamente<br />
definita corticale o corticospongiosa.<br />
Le complicazioni postoperatorie al sito donatore<br />
e al sito ricevente sono state registrate durante la<br />
fase di guar igione. Le car telle cliniche e i questionari<br />
sottoposti ai pazienti al completamento<br />
dell’intervento chirurgico di pr elievo e innest o<br />
hanno consentito di registrare l’evenienza di complicanze<br />
postchirurgiche a breve e lungo termine<br />
a livello di ciascun sito donatore. Inoltre, sono state<br />
raccolte informazioni riguardanti il disagio del<br />
paziente e l’accettabilità della procedura chirurgica.<br />
Complicanze al sito donatore quali ematomi,<br />
sanguinamento e dolore sono state considerate<br />
complicanze lievi; al contrario deiscenze, infezioni<br />
e alt erazioni della sensibilità, sono stat e<br />
considerate complicanze severe.<br />
Atteso il periodo di integrazione dell’innesto (minimo<br />
5 mesi), al momento dell’inserimento degli<br />
impianti, è stat o valutato il successo della r icostruzione<br />
ossea sia v erificando l’avvenuto attecchimento<br />
dell’innesto sia misurando il r iassorbimento<br />
osseo dell’innesto rispetto alla testa della<br />
vite di fissazione. La stabiltà dell’innesto è stata valutata<br />
dopo la rimozione delle viti di fissazione.<br />
Tutti gli impianti sono stati inser iti dopo un periodo<br />
di attesa minimo di 5 mesi dall’innesto.<br />
I siti implantar i ideali sono stati det erminati mediante<br />
una mascherina diagnostica preoperatoria,<br />
utilizzata successivamente come mascher ina chirurgica<br />
per il posizionament o implantare. La r icostruzione<br />
è stata considerata pienament e soddisfacente<br />
se accompagnata dal posizionamento dell’impianto<br />
in posizione protesicamente corretta.<br />
Durante la preparazione dei siti implantari è stata<br />
valutata la qualita dell’osso secondo la classificazione<br />
di Misch. Sono stati inseriti 57 impianti<br />
(19 A stra® Astratech, 30 Straumann® Strau-
Rossi A., <strong>Tagliatesta</strong> L., Anello T., Maccarini L.<br />
Fig. 1 Visione intraorale della zona sia di prelievo sia di innesto.<br />
Figg. 2,3 Ceratura diagnostica che evidenzia il deficit osseo da correggere: visione frontale e laterale.<br />
Fig. 4 La visione tomografica simil panoramica evidenzia il deficit osseo presente a livello del quarto quadrante.<br />
Fig. 5 Le scansioni tomografiche evidenziano la zona di prelievo.<br />
Fig. 6 Le scansioni t omografiche evidenziano la<br />
zona di innesto.<br />
Implantologia 2009; 3: 21-33<br />
27
Rossi A., <strong>Tagliatesta</strong> L., Anello T., Maccarini L.<br />
28<br />
Implantologia 2009; 3: 21-33<br />
Fig. 7 Lembo di accesso e scollamento a tutto spessore. Fig. 8 Fase osteotomica con strumenti piezoelettrici.<br />
Fig. 9 Disegno finale del segmento osteotomizzato. Fig. 10 Mediante scalpello dir itto l’ostectomia viene completata<br />
e l’innesto prelevato.<br />
Fig. 11 Visione dell’area di prelievo. Fig. 12 Protezione dell’area di prelievo con cellulosa ossidata<br />
(Tabotamp® Johnson & Johnson.<br />
Fig. 13 Sutura del lembo di accesso mediante punti staccati<br />
riassorbibili.<br />
Fig. 14 Radiografia di controllo successiva al prelievo e alla<br />
ricostruzione.
Rossi A., <strong>Tagliatesta</strong> L., Anello T., Maccarini L.<br />
Fig. 15 L’immagine intraorale evidenzia la correzione del deficit<br />
osseo a distanza di mesi mesi dall’intervento chirurgico.<br />
Figg. 16,17 Preparazione dei siti implantari: la visione laterale (16) evidenzia la buona vascolarizzazione dell’innesto, mentre<br />
la visione occlusale (17) evidenzia la buona correzzione del deficit osseo orizzontale.<br />
Fig. 18 Radiografia di controllo eseguita dopo l’inserimento degli impianti.<br />
Figg. 19,20 Riabilitazione protesica definitiva: visione laterale e occlusale (Protesi<br />
<strong>Dr</strong>. D. Lops, Odt F. Arnone).<br />
Fig. 21 Radiografia di controllo finale.<br />
Implantologia 2009; 3: 21-33<br />
29
Rossi A., <strong>Tagliatesta</strong> L., Anello T., Maccarini L.<br />
30<br />
Implantologia 2009; 3: 21-33<br />
mann, 8 3i®Implant Innovations): 8 impianti sono<br />
stati fatti guar ire in maniera non sommersa<br />
(one-stage surgery).<br />
I tempi per la riabilitazione protesica sono stati variabili<br />
in quanto a seconda del tipo di ricostruzione,<br />
del tipo di macro e micro struttura implantare<br />
e del tipo di trattamento di superficie si sono attesi<br />
tempi differenti (8-24 setimane). La r iabilitazione<br />
protesica finale è stata eseguita mediante ponti o<br />
corone singole cementate o avvitate (Tab. 2).<br />
■ RISULTATI<br />
La chirurgia Piezoelettrica si è dimostrata precisa,<br />
pulita, con un taglio dolce dell’osso corticale e<br />
un’eccellente visibilità del sito chirurgico. Il tempo<br />
necessario per il prelievo d’osso è stato valutato in<br />
maniera sistematica dall’inizio delle fasi osteotomiche<br />
(con strumento piezoelettrico) fino al distacco<br />
completo del prelievo osseo. Il tempo di prelievo è<br />
stato in media di 13 minuti, (range 9-19 min).<br />
La grandezza ottenuta dall’innesto andava da un<br />
minimo di 2,4 cm3 a un massimo di 7,1 cm3 . L’altezza<br />
media dell’innesto è stata di 8 mm, la lunghezza<br />
di 13 e lo spessore di 2,3 mm.<br />
L’integrazione degli innesti è a vvenuta con successo<br />
in tutti i siti ricostruiti. Tutti gli innesti d’osso<br />
hanno fornito sufficiente osso per il successi-<br />
vo inserimento degli impianti in posizione pr otesicamente<br />
guidata.<br />
In un caso l’esposizione e l’infezione di una membrana<br />
rinforzata in titanio, causata da un trauma<br />
dentale, ha richiesto la rimozione della membrana<br />
stessa 11 settimane dopo l’intervento. In un altro<br />
caso si è v erificata una piccola deiscenza in<br />
corrispondenza delll’innesto osseo, ma questa si<br />
è chiusa alcuni giorni dopo mediante l’ausilio di<br />
antisettici topici.<br />
Infine, un pazient e ha r iferito l’alterazione della<br />
sensibilità (parestesia) a liv ello del ment o e del<br />
labbro associata a dolor e prolungato mandibolare.<br />
Con ogni probabilità tali complicanze sono<br />
da attribuirsi non al prelievo (eseguito con ampi<br />
margini di sicurezza rispetto alle strutture nervose),<br />
ma alla ricostruzione ossea estesa, eseguita in<br />
continuità con la zona di prelievo, dove sono state<br />
eseguite incisioni di rilascio del lembo mucoso<br />
molto vicine al f orame mentoniero con conseguenti<br />
stiramenti e/o lesioni delle terminazioni<br />
nervose del nervo mentale. L’alterata sensibilità<br />
si è risolta dopo 13 settimane dall’intervento.<br />
La riabilitazione su impianti è stata completata<br />
mediante protesi fisse avvitate o cementate.<br />
La percentuale di successo degli impianti è stata<br />
del 95% (1 impianto non congruo con i parametri<br />
di Albrektsson e Zarb), mentre la percentuale di sopravvivenza<br />
è stata del 100% (f ollow-up minimo<br />
dalla data di inserimento degli impianti di 6 mesi).<br />
Tabella 2 Dati relativi alle riabilitazioni impianto-supportate.<br />
Paziente Numero Tipo Impianto sede Dimensioni Data Carico Follow-up (01/ 2009)<br />
impianti Impianto impianto protesico dall’inserimento impianto<br />
1 6 Tissue Level ® Straumann 33 35 36 43 45 46 4.1x10 03-2008 06-2008 10<br />
2 3 Bone Level ® Straumann 24 25 26 4.1x12 03-2008 09-2008 10<br />
3 1 Bone Level ® Straumann 45 4. 1x12 09-2007 11-2007 16<br />
3 1 Bone Level ® Straumann 46 4.1x10 09-2007 11-2007 16<br />
4 4 Bone Level ® Straumann 25 26 14 16 4.1x12 03-2008 07-2008 10<br />
4 1 Bone Level ® Straumann 23 4. 1x12 03-2008 07-2008 10<br />
5 2 Osseospeed ® Astratech 14 16 4x13 11-2007 04-2008 14<br />
6 8 Osseospeed ® Astratech 16 15 13 11 21 23 25 26 4.5x13 09-2007 01-2008 16<br />
7 4 Osseospeed ® Astratech 16 15 13 23 25 26 4.5x13 06-2007 12-2007 19<br />
8 2 Tissue Level ® Straumann 23 25 26 4.1x12 07-2007 12-2007 18<br />
9 1 Tissue Level ® Straumann 13 4.1x12 09-200 7 02-2008 16<br />
10 2 Bone Level ® Straumann 21 22 4.1x12 07-2008 01-2009 6<br />
11 2 Osseospeed ® Astratech 45 46 4.5x11 12-2007 02-2008 15<br />
12 3 Bone Level ® Straumann 15 17 4.1x10 05-2008 09-2008 8<br />
12 1 Bone Level ® Straumann 16 4.1x12 05-2008 09-2008 8<br />
13 6 3i 33 35 36 43 45 46 3.75x11 07-2008 10-2008 6<br />
14 2 3i 32 41 3.3x13 07-2008 01-2009 6<br />
15 3 Tissue Level ® Straumann 23 25 26 4.1x12 11-2007 05-2008 14<br />
16 1 Tissue Level ® Straumann 24 4.1x12 06-2007 11-2007 19<br />
Totale:56 Impianti di cui<br />
19 Astra-Tech; 8 3i; 29 ITI
Per quanto riguarda la soddisfazione del paziente,<br />
non è stato necessario chiedere un giudizio estetico<br />
sulla cicatr ice residua a liv ello della z ona di<br />
prelievo in quanto trattandosi di un sito donatore<br />
intraorale posteriore, non vi sono implicazioni di<br />
carattere estetico. Il giudizio generale sull ’accettabilità<br />
della procedura chirurgica, in una scala da<br />
1 a 10 (1 = pessimo; 10 = ottimo), è risultato essere<br />
in media 9,1 (in un range compr eso da 5 a 10); il<br />
91,9% dei pazienti ha vissuto l’esperienza meglio<br />
di quanto si aspettasse , l ’8,1% di essi ha in vece<br />
giudicato l’esperienza più traumatica del previsto.<br />
Ciò nonostante il 97% dei pazienti si sott oporrebbe<br />
nuovamente alla procedura se si tr ovasse<br />
nelle stesse condizioni di necessità, mentre il 3%<br />
non ripeterebbe l’intervento. Il 91% dei pazienti<br />
non ha avvertito alcuna sintomatologia di rilievo<br />
nel decorso postoperatorio e negli altri casi al dolore<br />
è stata attribuita un’intensità media pari a 3,5<br />
(da 2 a 9). Il 18% dei pazienti ha avvertito un maggior<br />
disagio a livello del sito ricevente, il 6% a livello<br />
del sito di prelievo, il 42% non ha saputo effettuare<br />
distinzione tra i due siti perché spesso contigui<br />
e il 34% dei pazienti non ha riferito disagio in nessuno<br />
dei due siti.<br />
Dai dati raccolti, la morbilità di questa sede di prelievo<br />
risulta essere bassa (4,5%), e inferiore all’incidenza<br />
globale di tutti i prelievi intraorali riportati<br />
in altri studi, da cui è emersa una percentuale globale<br />
di complicanze del 7,7%, con incidenze che<br />
spaziano dallo 0% (9, 37, 38) al 20,8% 28-32 .<br />
Da un punt o di vista qualitativ o, l ’utilizzo della<br />
chirugia piezoelettrica sembra r idurre la pr evalenza<br />
di complicanze neurologiche: non si sono<br />
verificate lesioni permanenti a carico del nervo alveolare<br />
inferiore in nessun paziente. Viene riportata<br />
una tabella riassuntiva di tutte le complicanze<br />
sia riferite dai pazienti sia rilevate durante i follow-up<br />
clinici (Tab. 3).<br />
■ DISCUSSIONE<br />
Il ramo mandibolare è un sito donatore che,<br />
oltre a essere caratterizzato da una modesta morbilità,<br />
presenta un’incidenza quasi nulla di sequele<br />
severamente invalidanti per il paziente, salvo nei<br />
casi di gravi errori da parte dell’operatore durante<br />
la pr ocedura chirurgica (esempio: r ecisione<br />
dell’arteria facciale o di altre strutture anatomiche<br />
rilevanti).<br />
Rossi A., <strong>Tagliatesta</strong> L., Anello T., Maccarini L.<br />
Il principale vantaggio di questa sede di prelievo osseo<br />
endorale è la disponibilità di un discreto quantitativo<br />
(fino a 10 ml per lat o in rapporto all’estensione<br />
del prelievo) di osso corticale di origine membranosa,<br />
di ottima qualità e soggetto ad un minor<br />
riassorbimento a livello del sito di innesto.<br />
Le caratteristiche dell’osso, con una corticale maggiormente<br />
rappresentata e una limitatà possibilità<br />
di prelievo di osso spong ioso, rendono il prelievo<br />
più difficilment e modellabile nella f orma e<br />
meno facilmente riducibile a osso particolato. Anche<br />
la ridotta morbilità, la contiguità del sito donatore<br />
con il sito ricevente e la possibilità di eseguire<br />
l’intervento in anestesia locale, rendono questa<br />
sede di prelievo preferibile rispetto ad altre.<br />
Tuttavia va sottolineato che, come per tutti i siti<br />
intraorali, la quantità di osso prelevabile non sempre<br />
è sufficiente a colmare difetti ossei estesi; inoltre<br />
il prelievo dal ramo è gravato da una maggior<br />
complessità tecnica rispetto al prelievo dal mento<br />
ed espone il paziente a un maggior rischio di<br />
fratture patologiche della mandibola, in particolar<br />
modo se il pr elievo è molt o esteso. È sicuramente<br />
indispensabile, come per la maggior parte<br />
delle procedure chirurgiche di prelievo osseo,<br />
che l’operatore sia dotato di ottima manualità ed<br />
esperienza.<br />
La chirurgia piezoelettrica risulta essere una tecnica<br />
innovativa ed efficiente.<br />
Le proprietà fisiche e meccaniche della tecnologia<br />
piezoelettrica hanno diversi vantaggi clinici:<br />
Tabella 3<br />
Complicanze Numer o complicanze<br />
dolore prolungato 1<br />
gonfiore prolungato 0<br />
sanguinamento 0<br />
infezione 1<br />
deiscenza 1<br />
trisma 0<br />
frattura mandibolare 0<br />
lesioni nervose 1<br />
transitorie 1<br />
n. alveolare inferiore 1<br />
n. buccale 0<br />
n. linguale 0<br />
permanenti 0<br />
n. alveolare inferiore 0<br />
n. buccale 0<br />
n. linguale 0<br />
disturbi fz orali prolungati 0<br />
danni molari inferiori 0<br />
alterazioni estetiche 0<br />
Totale 4<br />
Implantologia 2009; 3: 21-33<br />
31
Rossi A., <strong>Tagliatesta</strong> L., Anello T., Maccarini L.<br />
32<br />
Implantologia 2009; 3: 21-33<br />
• taglio preciso e micrometrico;<br />
• selettività di taglio per i tessuti mineralizzati;<br />
• migliore visione intraoperatoria dovuta all’effetto<br />
di cavitazione.<br />
Inoltre in un recente studio di Schierano8 , si è dimostrato<br />
come la chirur gia piezoeletrica possa<br />
migliorare le prime fasi di guarigione a livello osseo<br />
in quant o stimola l ’attivazione e il r ichiamo<br />
delle proteine ossee morfogenetiche e, simultaneamente,<br />
riduce la liberazione dei mediat ori<br />
dell’infiammazione. Utilizzando questo tipo di<br />
tecnologia nel nostr o studio la fr equenza delle<br />
complicanze riportate è comparabile a quelle riportate<br />
in Letteratura.<br />
I volumi di osso pr elevati risultano analoghi a<br />
quelli prelevati con altri strumenti; inoltre la presenza<br />
di inserti ultrasonici di varie forme consente<br />
di eseguire tutte le linee osteotomiche senza<br />
particolari difficoltà.<br />
L’utilizzo della chirurgia piezoelettrica per le fasi di<br />
prelievo ha mostrato indubbi vantaggi sia per il<br />
paziente sia per l’operatore.<br />
A differenza degli strumenti tradizionali, r otanti<br />
(frese, dischi) o oscillanti (seghe da osso), nessun<br />
paziente ha r iferito nel questionar io par ticolari<br />
disagi legati al prelievo, mentre nelle altre tecniche<br />
è stat o sottolineato come alcune manovr e<br />
chirurgiche possano essere poco piacevoli (strumenti<br />
rumorosi, uso del martello, ecc.).<br />
Per l’operatore invece i vantagg i maggiori sono<br />
rappresentati dal fatto che gli strumenti piez oelettrici<br />
non possono leder e strutture nobili quali<br />
nervi e/o vasi sanguigni, riducendo quindi le possibili<br />
complicanze sia intra che postoperatorie. Bisogna<br />
tuttavia sottolineare che, anche se si utilizzano<br />
strumenti piezoelettrici per le fasi ost eotomiche,<br />
il distacco dell’osso prelevato dalla sua sede<br />
è sempr e stato eseguito mediante scalpelli<br />
dritti e/o curvi; essendo quest’ultima fase quella in<br />
cui più comunement e si det erminano danni iatrogeni<br />
al nervo alveolare si deduce come gli strumenti<br />
piezoelettrici non possano tutelare da possibili<br />
danni neurologici transitori o permanenti.<br />
Inoltre, i t empi operatori per eseguir e i pr elievi<br />
con la piezochirurgia sono considervolmente più<br />
lunghi rispetto ai tempi impiegati con strumenti<br />
tradizionali (seghe e frese rotanti) come già sottolineato<br />
da altri Autori33 .<br />
Infine, anche questo tipo di strumenti deve essere<br />
utilizzato con le dovute cautele in quanto, come<br />
dimostrato in L etteratura34 , un aument o della<br />
pressione di lavoro al fine di aumentare la velocità<br />
di taglio può pr ovocare la trasf ormazione della<br />
energia di vibrazione in energia termica con conseguente<br />
danno tissutale.<br />
■ CONCLUSIONI<br />
Una variabile che può influenzare la scelta di<br />
un sito donatore di osso autologo rispetto a un altro,<br />
compatibilmente con la quantità/qualità di<br />
osso necessaria per la correzione del difetto, è la<br />
morbilità da cui ciascuna sede di prelievo è gravata.<br />
Questa dipende pr incipalmente dall’entità<br />
del prelievo eseguito e dalla t ecnica chirurgica<br />
utilizzata e dal tipo di strumento utilizzato.<br />
È principalmente questo l’aspetto che abbiamo voluto<br />
approfondire con il nostro studio e dai risultati<br />
ottenuti è possibile affermare che l’utilizzo della chirurgia<br />
piezoeletrica nelle tecniche di prelievo autologo<br />
endorale possa essere considerata una valida<br />
alternativa alle tecniche di prelievo tradizionali.<br />
■ BIBLIOGRAFIA<br />
1. Albrektsson T, Zarb G, Worthington P, Eriksson AR. The<br />
long-term efficac y of curr ently used dental implants: a<br />
review and proposed criteria of success. Int J Oral Maxillofac<br />
Implants. 1986 Summer;1(1):11-25.<br />
2. van Steenberghe D, Quirynen M, DeKeyser C. Osseointegrated<br />
implants ad modum Br ånemark in the or al rehabilitation<br />
of patients with advanc ed periodontal br eakdown.<br />
J Parodontol. 1990;1(1):45-54.<br />
3. Lindquist LW, Carlsson GE, Jemt T. A prospective 15-year<br />
follow-up study of mandibular fixed prostheses supported<br />
by osseointegrated implants. Clinical results and marginal<br />
bone loss. Clin Oral Implants Res. 1996 Dec;7(4):329-<br />
36. Clin Oral Implants Res 1997 Aug;8(4):342.<br />
4. Horton JE, Tarpley TM, Wood LD. The healing of surgical<br />
defects in alveolar bone produced with ultrasonic instrumentation,<br />
chisel and rotary byr. Oral Surg Oral Med Oral<br />
Pahtol 1975; 39:536-546.<br />
4a. Horton JE, Tarpley TM Jr, Jacoway JR. Clinical Applications<br />
of Ultrasonic Instrumentation in the Surgical Removal of<br />
Bone. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1981; 51:236-242.<br />
5. Aro H, Kallioniemi H, Aho AJ, Kellokumpu-Lehtinen P. Ultrasonic<br />
device in bone cutting. A histological and scanning<br />
alectron microsopical study. Acta Or thop Scand<br />
1981, 52:5-10.<br />
6. Chirac G, Herten M, Schwarz F, Rothamel D, Becker J. Autogenous<br />
bone chips: influenc e of a new piez oelectric<br />
device (piezosurgery) on chip morphology , cell viability<br />
and differentiation. J Clin Periodontol 2005;9:994-999.<br />
7. Vercellotti T, Nevins ML, K im DM, Nevins M, Wada K ,<br />
Schenk RK, Fiorellini JP. Osseous Response following Resective<br />
Therapy with a Piezosurgery®. Int J Periodontics Restorative<br />
Dent. 2005; 25(6): 543-549.
8. Schierano G, Martinasso G, Peirone B, Navone R, Manzel-<br />
la C, Muzio G, Russo C, Canuto RA, Preti G. Cytokines and<br />
Growth Factors Involved in the Osseointegration of Oral<br />
Titanium I mplants Positioned using P iezoelectric Bone<br />
Surgery Versus a <strong>Dr</strong>ill Technique: A Pilot Study in Minipigs.<br />
Journal of Periodontology, 2007;78(4):716-722.<br />
9. Adell R, Eriksson B, Lekholm U, Branemark PI, Jemt T. Longterm<br />
follow-up study of osseointegrated implants in the<br />
treatment of totally edentulous jaws. Int J Oral Maxillofac<br />
Implants. 1990 Winter;5(4):347-59.<br />
10. Isaksson S, Alberius P. Maxillary alveolar ridge augmentation<br />
with onlay bone-grafts and immediate endosseous<br />
implants. J Craniomaxillofac Surg. 1992 Jan;20(1):2-7.<br />
11. Lew D, Hinkle RM, Unhold GP, Shroyer JV 3rd, Stutes RD.<br />
Reconstruction of the severely atrophic edentulous mandible<br />
by means of autogenous bone grafts and simultaneous<br />
placement of osseointegrated implants. J Oral Maxillofac<br />
Surg. 1991 Mar;49(3):228-33.<br />
12. Donovan MG, Dickerson NC, Hanson L J, Gustafson RB.<br />
Maxillary and mandibular r econstruction using calvarial<br />
bone grafts and Branemark implants: a pr eliminary report.<br />
J Oral Maxillofac Surg. 1994 Jun;52(6):588-94.<br />
13. Williamson RA. Rehabilitation of the resorbed maxilla and<br />
mandible using autogenous bone grafts and osseointegrated<br />
implants. Int J Oral Maxillofac Implants. 1996 Jul-<br />
Aug;11(4):476-88.<br />
14. van Steenberghe D, Naert I, Bossuyt M, De M ars G, C alberson<br />
L, Ghyselen J, Branemark PI. The rehabilitation of<br />
the severely resorbed maxilla by simultaneous placement<br />
of autogenous bone grafts and implants: a 10- year evaluation.<br />
Clin Oral Investig. 1997 Sep;1(3):102-8.<br />
15. Lundgren S, Nystrom E, Nilson H, Gunne J, Lindhagen O.<br />
Bone grafting to the maxillary sinuses, nasal floor and anterior<br />
maxilla in the atrophic edentulous maxilla. A t wostage<br />
t echnique. I nt J Oral M axillofac Sur g. 1997<br />
Dec;26(6):428-34.<br />
16. Schliephake H, Neukam FW, Wichmann M. Survival analysis<br />
of endosseous implants in bone g rafts used f or the<br />
treatment of severe alveolar ridge atrophy. J Oral Maxillofac<br />
Surg. 1997 Nov;55(11):1227-33; discussion 1233-4.<br />
17. Misch CM. Comparison of intraoral donor sites for onlay<br />
grafting prior to implant placement. Int J Oral Maxillofac<br />
Implants. 1997 Nov-Dec;12(6):767-76.<br />
18. Lekholm U, Wannfors K, Isaksson S, Adielsson B. Oral implants<br />
in c ombination with bone g rafts. A 3- year retrospective<br />
multicenter study using the Branemark implant<br />
system. Int J Oral Maxillofac Surg. 1999 Jun;28(3):181-7.<br />
19. Becktor JP, Eckert SE, Isaksson S, Keller EE. The influence of<br />
mandibular dentition on implant failur es in bone -grafted<br />
edentulous maxillae . I nt J Or al Maxillofac I mplants.<br />
2002 Jan-Feb;17(1):69-77.<br />
20. Becktor JP, Isaksson S, Sennerby L. Survival analysis of endosseous<br />
implants in grafted and nongrafted edentulous maxillae.<br />
Int J Oral Maxillofac Implants. 2004 Jan-Feb;19(1):107-15.<br />
21. Nystrom E, Lundgren S, Gunne J, Nilson H. Interpositional<br />
bone grafting and Le Fort I osteotomy for reconstruction<br />
of the atr ophic edentulous maxilla. A t wo-stage technique.<br />
Int J Oral Maxillofac Surg. 1997 Dec;26(6):423-7.<br />
22. Nystrom E, Ahlqvist J, Gunne J, Kahnberg KE. 10-year followup<br />
of onlay bone grafts and implants in severely resorbed<br />
maxillae. Int J Oral Maxillofac Surg. 2004 Apr;33(3):258-62.<br />
Rossi A., <strong>Tagliatesta</strong> L., Anello T., Maccarini L.<br />
23. Chiapasco M, Romeo E, Vogel G. Tridimensional reconstruction<br />
of knife-edge edentulous maxillae by sinus elevation,<br />
onlay grafts, and sagittal osteotomy of the anterior<br />
maxilla: preliminary surgical and prosthetic results. Int J<br />
Oral Maxillofac Implants. 1998 May-Jun;13(3):394-9.<br />
24. Chiapasco M, Abati S, Romeo E, Vogel G. Clinical outcome of<br />
autogenous bone blocks or guided bone regeneration with<br />
e-PTFE membranes for the reconstruction of narrow edentulous<br />
ridges. Clin Oral Implants Res. 1999 Aug;10(4):278-88.<br />
25. Jemt T, Lekholm U. Measurements of buccal tissue volumes<br />
at single-implant restorations after local bone grafting<br />
in maxillas: a 3-year clinical prospective study case series.<br />
Clin Implant Dent Relat Res. 2003;5(2):63-70.<br />
26. Shelton DW. Critical review of preprosthetic surgery. Current<br />
Advances in Oral Surgery. 1977; vol.2:359-384.<br />
27. Cawood JI, Howell RA. A classification of the edentulous<br />
jaws. Int J Oral Maxillofac Surg. 1988 Aug;17(4):232-6.<br />
28. Cordaro L, Amade DS, Cordaro M. Clinical results of alveolar<br />
ridge augmentation with mandibular block bone grafts<br />
in par tially edentulous patients prior t o implant plac ement.<br />
Clin Oral Implants Res. 2002 Feb;13(1):103-11.<br />
29. Nkenke E, R adespiel-Troger M, Wiltfang J, Schultze-Mosgau<br />
S, Winkler G, Neukam FW. Morbidity of harvesting of<br />
retromolar bone grafts: a prospective study. Clin Oral Implants<br />
Res. 2002 Oct;13(5):514-21.<br />
30. Clavero J, Lundgren S. Ramus or chin grafts for maxillary<br />
sinus inlay and local onlay augmentation: comparison of<br />
donor site morbidity and complications. Clin Implant Dent<br />
Relat Res. 2003;5(3):154-60.<br />
31. Silva FM, Cortez AL, Moreira RW, Mazzonetto R. Complications<br />
of intraoral donor site for bone grafting prior to implant<br />
placement. Implant Dent. 2006 Dec;15(4):420-6.<br />
32. Chiapasco M, Rossi A, Sportelli S, Di Leo F, Boisco M. Complicanze<br />
dei siti donatori di prelievo osseo per la ricostruzione<br />
preimplantare dei mascellari atrofici. Dossier Dental<br />
Cadmos, 2008 Oct;76(8).<br />
33. Schlee M, Steigmann M, Bratu E, Garg AK. Piezosurgery: basics<br />
and possibilities. Implant Dent. 2006 Dec;15(4):334-40.<br />
34. Robiony M, Polini F, Costa F, Vercellotti T, Politi M. Piezoelectric<br />
Bone Cutting in multipiece maxillary osteotomies.<br />
Technical Note. J Oral Maxillofac Surg. 2004; 62: 759-761.<br />
Implantologia 2009; 3: 21-33<br />
33