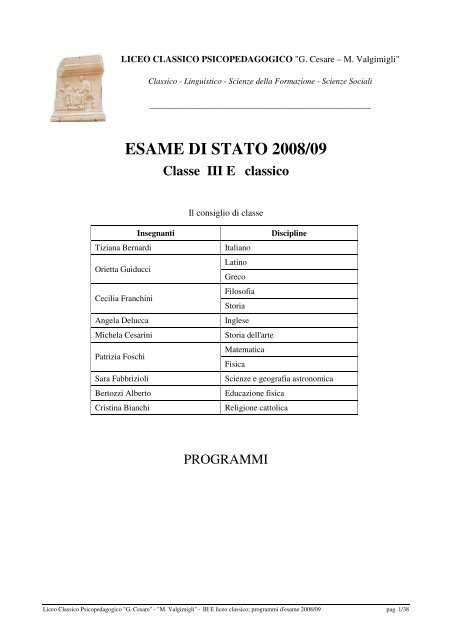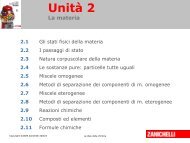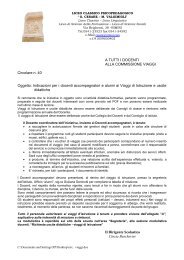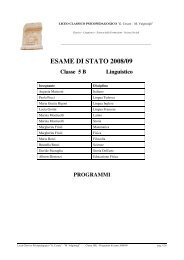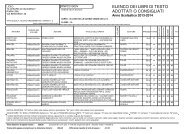esame di stato 2008/09 - Liceo Classico Psicopedagogico Cesare ...
esame di stato 2008/09 - Liceo Classico Psicopedagogico Cesare ...
esame di stato 2008/09 - Liceo Classico Psicopedagogico Cesare ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
LICEO CLASSICO PSICOPEDAGOGICO "G. <strong>Cesare</strong> – M. Valgimigli"<br />
<strong>Classico</strong> - Linguistico - Scienze della Formazione - Scienze Sociali<br />
_____________________________________________________<br />
ESAME DI STATO <strong>2008</strong>/<strong>09</strong><br />
Classe III E classico<br />
Il consiglio <strong>di</strong> classe<br />
Insegnanti Discipline<br />
Tiziana Bernar<strong>di</strong> Italiano<br />
Orietta Guiducci<br />
Cecilia Franchini<br />
Latino<br />
Greco<br />
Filosofia<br />
Storia<br />
Angela Delucca Inglese<br />
Michela Cesarini Storia dell'arte<br />
Patrizia Foschi<br />
Matematica<br />
Fisica<br />
Sara Fabbrizioli Scienze e geografia astronomica<br />
Bertozzi Alberto Educazione fisica<br />
Cristina Bianchi Religione cattolica<br />
PROGRAMMI<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 1/38
ITALIANO<br />
Testi utilizzati: R.Luperini, P.Castal<strong>di</strong>, L.Marchiani, V.Tinacci, La scrittura e l’interpretazione. Gli autori<br />
italiani, il canone europeo, la scrittura delle donne, gli intrecci interculturali e tematici, E<strong>di</strong>zione arancione,<br />
voll. 2 (t.II) 3 (t. I e II), Palombo e<strong>di</strong>tore, 2004.<br />
A.M.Chiavacci Leonar<strong>di</strong> ( a cura <strong>di</strong>), Dante Alighieri, Comme<strong>di</strong>a, Para<strong>di</strong>so, Zanichelli, 2001.<br />
Autori ed argomenti Letture compiute metodologia<br />
I Promessi sposi <strong>di</strong> A.Manzoni<br />
Le redazioni, la struttura, i temi.<br />
Storia della colonna infame<br />
G. Leopar<strong>di</strong><br />
La modernità <strong>di</strong> Leopar<strong>di</strong>; la vita; la<br />
ricerca del vero, il problema<br />
dell’infelicità, la poetica.<br />
Lo Zibaldone <strong>di</strong> pensieri<br />
Le Operette morali<br />
I Canti: composizione, struttura,<br />
titolo.<br />
Fermo e Lucia, tomo II, cap. V (la storia <strong>di</strong><br />
Egi<strong>di</strong>o e <strong>di</strong> Gertrude) a confronto coi capp.<br />
IX-X dei Promessi sposi<br />
Promessi sposi, capp.V-VI,( il <strong>di</strong>alogo fra<br />
padre Cristoforo e don Rodrigo)<br />
“ , cap. XXVIII ( il governo e<br />
la moltitu<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> fronte alla carestia)<br />
Ib., cap. XXIX ( la storia vista dal basso:<br />
don Abbon<strong>di</strong>o e la guerra)<br />
Ib., cap. XXXVIII (la conclusione)<br />
Letture critiche: I. Calvino, I Promessi<br />
sposi: il romanzo dei rapporti <strong>di</strong> forza;<br />
G.Bal<strong>di</strong>, I promessi sposi: progetto <strong>di</strong><br />
società e mito; E.Raimon<strong>di</strong>, Il romanzo<br />
senza i<strong>di</strong>llio per le parti antologizzate nel<br />
testo in adozione.<br />
L’introduzione<br />
Zibaldone 50-1, 353-6,<br />
4417-8, 1559-62, 4175-71025-6,4288-9.<br />
Coro <strong>di</strong> morti nello stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Federico<br />
Ruysch;<br />
Dialogo <strong>di</strong> Plotino e Porfirio;<br />
Dialogo della Natura e <strong>di</strong> un Islandese.<br />
Ultimo canto <strong>di</strong> Saffo<br />
L’infinito<br />
A Silvia<br />
Canto notturno <strong>di</strong> un pastore errante<br />
dell’Asia<br />
La quiete dopo la tempesta<br />
Il sabato del villaggio<br />
Il pensiero dominante<br />
A se stesso<br />
Lezione frontale<br />
Rilettura in<strong>di</strong>viduale<br />
L&C<br />
L&C<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 2/38<br />
L&C<br />
L&C<br />
L&C<br />
Lezione frontale<br />
L&C<br />
Lezioni frontali<br />
L&C<br />
L&C<br />
L&C<br />
L&C<br />
Lezione frontale<br />
L&C<br />
L&C<br />
L&C<br />
L&C<br />
L&C<br />
L&C<br />
L&C<br />
L&C
La seconda metà dell’Ottocento: un<br />
quadro introduttivo alla situazione<br />
storico-culturale e alle poetiche<br />
dominanti, naturalismo e<br />
simbolismo<br />
Il romanzo e la novella in Italia<br />
nella seconda metà dell’Ottocento.<br />
Presentazione sintetica della<br />
narrativa degli scapigliati, della<br />
narrativa pedagogica e dei veristi<br />
siciliani.<br />
G.Verga La rivoluzione stilistica e<br />
tematica. La vita e le opere.<br />
L’adesione al verismo e il ciclo dei<br />
“Vinti”<br />
Le novelle<br />
I Malavoglia. Il progetto letterario;<br />
la poetica; una ricostruzione<br />
intellettuale; il sistema dei<br />
personaggi; unità <strong>di</strong> co<strong>di</strong>ce<br />
espressivo e duplicità <strong>di</strong> toni; il<br />
cronotopo dell’i<strong>di</strong>llio familiare; il<br />
<strong>di</strong>scorso in<strong>di</strong>retto libero, la<br />
regressione, lo straniamento.<br />
Mastro don Gesualdo<br />
Simbolismo e decadentismo<br />
C.Baudelaire I fiori del male<br />
A.Rimbaud<br />
La ginestra o il fiore del deserto.<br />
C.Baudelaire, Per<strong>di</strong>ta dell’aureola in Poesie<br />
e prose, Mondatori, 1973, p.403<br />
Da L’amante <strong>di</strong> Gramigna De<strong>di</strong>catoria a<br />
Salvatore Farina<br />
Rosso Malpelo<br />
La lupa<br />
Libertà<br />
La roba<br />
La prefazione ai Malavoglia<br />
I Malavoglia, cap.I<br />
Ib. capp.II, III, V,VII, XV ( passi<br />
antologizzati)<br />
La giornata <strong>di</strong> Mastro don Gesualdo<br />
La morte <strong>di</strong> Mastro don Gesualdo<br />
Letture critiche: L.Spitzer, L’originalità<br />
della narrazione nei “Malavoglia” in<br />
“Belfagor”, XI,!,1956; G.Tellini, Il<br />
romanzo italiano dell’Ottocento e<br />
Novecento; G.Mazzacurati, Parallele e<br />
meri<strong>di</strong>ane:l’autore e il coro all’ombra del<br />
nespolo, in Stagioni dell’apocalisse. Verga,<br />
Pirandello, Svevo, Torino, Einau<strong>di</strong>, 1998,<br />
pp. 17-35 (in fotocopia)<br />
Revisione ed approfon<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> temi<br />
prima appena accennati<br />
Corrispondenze<br />
Le vocali<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 3/38<br />
L&C<br />
Lezione frontale<br />
L&C<br />
Lezione frontale<br />
Lezione frontale<br />
L&C<br />
L&C<br />
L&C<br />
L&C<br />
L&C<br />
L&C<br />
Lezione frontale<br />
L&C<br />
Rilettura in<strong>di</strong>viduale<br />
L&C<br />
Lettura in<strong>di</strong>viduale<br />
<strong>di</strong>scussa in classe<br />
L&C<br />
L&C<br />
Lezione frontale<br />
L&C<br />
L&C
G.Pascoli<br />
La vita: tra il “nido” e la poesia.<br />
La poetica del fanciullino.<br />
Myricae<br />
Il simbolismo impressionistico<br />
I Canti <strong>di</strong> Castelvecchio<br />
I Poemetti: tendenza narrativa e<br />
sperimentazione linguistica<br />
G. D’Annunzio.<br />
La vita. L’ideologia e la poetica.<br />
Il romanzo: Il Piacere<br />
Il trionfo della morte<br />
Il fuoco<br />
Notturno<br />
La poesia. Le Lau<strong>di</strong>: struttura e<br />
organizzazione interna. I temi.<br />
Alcione<br />
La tendenza dell’avanguar<strong>di</strong>a in<br />
Italia tra gli Anni Dieci e Venti: i<br />
crepuscolari.<br />
Palazzeschi tra crepuscolarismo e<br />
futurismo<br />
L.Pirandello.<br />
La vita, la formazione, le varie fasi<br />
dell’attività artistica.<br />
La poetica dell’umorismo<br />
Quaderni <strong>di</strong> Serafino da Gubbio<br />
Uno nessuno centomila<br />
Il fu Mattia Pascal: la<br />
struttura e i temi<br />
Il fanciullino<br />
Lavandare<br />
Temporale<br />
Il lampo<br />
X Agosto<br />
L’assiuolo<br />
Il gelsomino notturno<br />
Italy ( frammento)<br />
Digitale purpurea<br />
Letture critiche: da G.Contini, “Il<br />
linguaggio <strong>di</strong> Pascoli” in Varianti e altra<br />
linguistica, Einau<strong>di</strong>, 1970, pp.241-243<br />
Andrea Sperelli (da Il Piacere, I,2)<br />
La conclusione (da Il Piacere, IV,3)<br />
La sera fiesolana<br />
La pioggia nel pineto<br />
Meriggio<br />
Le stirpi canore<br />
G.Gozzano, La signorina felicita ovvero la<br />
Felicità (solo le parti iniziali )<br />
M.Moretti, Piove ( in fotocopia)<br />
Chi sono?<br />
Lasciatemi <strong>di</strong>vertire<br />
Da Il fu Mattia Pascal “Lo strappo nel cielo<br />
<strong>di</strong> carta” (cap.XII)<br />
L’Umorismo, p.II, cap. II ( <strong>di</strong>fferenza fra<br />
umorismo e comicità: la vecchia<br />
imbellettata)<br />
Il furto ( Libro IV, cap. VI)<br />
Adriano Meis e la sua ombra (cap. XV)<br />
Mi vi<strong>di</strong> in quell’istante attore <strong>di</strong> una<br />
trage<strong>di</strong>a (cap.V)<br />
L’ultima pagina del romanzo (cap. XVIII)<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 4/38<br />
L&C<br />
Lezione frontale<br />
L&C<br />
Lezione frontale<br />
L&C<br />
L&C<br />
L&C<br />
L&C<br />
L&C<br />
L&C<br />
L&C L&C<br />
Lezione frontale<br />
L&C<br />
Lezione frontale<br />
L&C<br />
Lezione frontale<br />
L&C L&C L&C<br />
L&C<br />
Lezione frontale<br />
L&C<br />
L&C<br />
Lezione frontale<br />
L&C<br />
L&C<br />
Lezione frontale<br />
Lezione frontale<br />
L&C<br />
L&C<br />
Lezione frontale<br />
L&C<br />
Lezione frontale<br />
Rilettura in<strong>di</strong>viduale<br />
del romanzo<br />
Confronto in classe<br />
sui passi in<strong>di</strong>cati<br />
Lezione frontale<br />
L&C<br />
L&C
Novelle per un anno<br />
Il teatro<br />
I miti teatrali: I Giganti della<br />
montagna<br />
I. Svevo.<br />
La vita , la cultura e la poetica.<br />
Caratteri dei romanzi sveviani<br />
La coscienza <strong>di</strong> Zeno. Struttura e<br />
temi<br />
G.Ungaretti e la religione della<br />
parola.<br />
L’Allegria<br />
Sentimento del tempo<br />
Il dolore<br />
U. Saba: Il Canzoniere<br />
E. Montale<br />
Centralità <strong>di</strong> Montale nella poesia<br />
del Novecento.<br />
La vita e le opere<br />
Ossi <strong>di</strong> seppia<br />
Poetica, temi e scelte stilistiche del<br />
secondo Montale: Occasioni<br />
Le altre fasi della poesia <strong>di</strong> Montale<br />
da Bufera a Diarii passando per la<br />
svolta <strong>di</strong> Satura<br />
Il treno ha fischiato.. (L’uomo solo)<br />
Tu ri<strong>di</strong> (Tutt’e tre)<br />
C’è qualcuno che ride (Una giornata)<br />
Io sono colei che mi si crede (Così è se vi<br />
pare)<br />
L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico<br />
e la scena finale (da Sei personaggi in<br />
cerca d’autore)<br />
da Senilità: Inettitu<strong>di</strong>ne e senilità (cap.I)<br />
Lo schiaffo del padre<br />
L’ad<strong>di</strong>o a Carla<br />
La vita è una malattia<br />
Letture critiche: A. Leone De Castris , La<br />
conclusione del romanzo in Il<br />
Decadentismo italiano, Laterza, 1989<br />
[1974],pp. 127-129<br />
In memoria<br />
Commiato<br />
Mattina<br />
Soldati<br />
I fiumi<br />
Veglia<br />
Caino<br />
Non gridate più<br />
A mia moglie<br />
Città vecchia<br />
Amai<br />
I limoni<br />
Non chiederci la parola<br />
Spesso il male <strong>di</strong> vivere ho incontrato<br />
Non recidere, forbice, quel volto<br />
Il sogno del prigioniero (La bufera)<br />
Ho sceso, dandoti il braccio almeno un<br />
milione <strong>di</strong> scale (Satura)<br />
L&C<br />
L&C<br />
Lezione frontale<br />
L&C<br />
Rilettura in<strong>di</strong>viduale<br />
e <strong>di</strong>scussione in<br />
classe<br />
Lezione frontale<br />
Lezione frontale<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 5/38<br />
L&C<br />
Lezione frontale<br />
Rilettura in<strong>di</strong>viduale<br />
e <strong>di</strong>scussione in<br />
classe<br />
sui passi in<strong>di</strong>cati<br />
Lezione frontale<br />
L&C<br />
L&C<br />
L&C<br />
L&C<br />
L&C<br />
L&C<br />
L&C<br />
L&C<br />
Lezione frontale<br />
L&C<br />
L&C<br />
L&C<br />
Lezione frontale<br />
L&C<br />
L&C<br />
L&C<br />
Lezione frontale<br />
L&C<br />
Lezione frontale<br />
L&C<br />
L&C<br />
L&C<br />
L&C
L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili<br />
(Satura)<br />
Si deve preferire (Diarii)<br />
Letture critiche: S.Solmi, Scrittori negli<br />
anni, in Montale, Ossi <strong>di</strong> seppia,<br />
Mondatori, 2003, pp. 264-268;<br />
L.Blascucci, Gli oggetti <strong>di</strong> Montale,<br />
Mulino, 202, pp. 49 e 58-60 ( fotocopie)<br />
DANTE, Divina Comme<strong>di</strong>a, Para<strong>di</strong>so. Sono stati letti e commentati i seguenti canti : I, III, VI, XI, XV,<br />
XVII, XXX, XXXIII.<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 6/38
LATINO<br />
Testi utilizzati:<br />
G. Pontiggia – M. C. Gran<strong>di</strong>, Letteratura latina, voll. II - III, Principato.<br />
L. Suar<strong>di</strong> (a cura <strong>di</strong>), Tacito, Passi scelti, Principato.<br />
P. Martino (a cura <strong>di</strong>), L. Anneo Seneca. Antologia <strong>di</strong> passi tratti dagli scritti filosofici e<br />
dall’Apokolokyntosis, D’Anna.<br />
L’età augustea Obiettivi:<br />
Analizzare l’elegia erotica latina<br />
Considerarla in relazione ai modelli greci <strong>di</strong><br />
riferimento<br />
Operare un confronto tra i poeti elegiaci del<br />
canone<br />
Tibullo e il Corpus Tibullianum<br />
Elegiae I, 1 (“La vita ideale”)<br />
Elegiae I, 3 (“Sulle rive dell’Egeo”)<br />
Elegiae I, 5 (“Il tra<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> Delia”)<br />
Properzio:<br />
dalle elegie amorose alla poesia<br />
eziologica d argomento romano<br />
Elegiae I, 1 (“L’elegia proemiale”)<br />
Elegiae I, 3 (“Cinzia dormiente”)<br />
Elegiae I, 11 (“Cinzia tra gli ozi <strong>di</strong> Baia”)<br />
Elegiae III, 25 (“L’elegia del <strong>di</strong>sci<strong>di</strong>um”)<br />
Elegiae IV, 4 (“Un esempio <strong>di</strong> poesia<br />
eziologica: la leggenda <strong>di</strong> Tarpea”)<br />
Elegiae IV, 7 (“Il fantasma <strong>di</strong> Cinzia”)<br />
Ovi<strong>di</strong>o<br />
in sintesi i contenuti <strong>di</strong>:<br />
Amores, Heroides, Ars amatoria, Me<strong>di</strong>camina<br />
faciei femineae, Reme<strong>di</strong>a amoris, Metamorfosi,<br />
Fasti<br />
Amores I, 3 (“Ritratto del poeta elegiaco”)<br />
Amores I, 5 (“La donna del poeta elegiaco”)<br />
Amores II, 1 (“Il pubblico del poeta elegiaco”)<br />
Ars amatoria I, 89-134 (“Luoghi <strong>di</strong> caccia<br />
amorosa: il teatro”)<br />
Ars amatoria III, 103-128 (“Al mio stile <strong>di</strong> vita<br />
questa è l’epoca adatta”)<br />
Tristia, IV, 10 (“Lettera ai posteri: la mia vita”)<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
La poesia “classica” <strong>di</strong> Tibullo.<br />
Analisi contenutistica dei brani letti.<br />
Eventuale confronto tra i medesimi e quelli degli<br />
altri poeti elegiaci.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Analisi contenutistica dei brani letti.<br />
I temi: eros, poesia e mito.<br />
Eventuale confronto tra i medesimi e quelli degli<br />
altri poeti elegiaci.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Analisi contenutistica dei brani letti.<br />
Eventuale confronto tra i medesimi e quelli degli<br />
altri poeti elegiaci.<br />
L’età <strong>di</strong> Tiberio Obiettivi:<br />
in<strong>di</strong>viduare le linee portanti del <strong>di</strong>battito<br />
letterario in relazione al potere imperiale<br />
riconoscere le caratteristiche della storio-grafia<br />
del consenso e del <strong>di</strong>ssenso<br />
Velleio Patercolo<br />
Historiae, II, 127-128 (Elogio <strong>di</strong> Seiano, homo<br />
novus)<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Confronto tra l’impostazione storiografica<br />
filoimperiale <strong>di</strong> Patercolo e quella <strong>di</strong> Valerio<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 7/38
Valerio Massimo<br />
Factorum et <strong>di</strong>ctorum memorabilium libri, praef.<br />
(“Ragioni dell’opera e de<strong>di</strong>ca a Tiberio”)<br />
Factorum et <strong>di</strong>ctorum memorabilium libri V, 3, 4<br />
(“Clamoroso esempio <strong>di</strong> ingratitu<strong>di</strong>ne”)<br />
Curzio Rufo<br />
Historiae Alexandri Magni, IV, 7, 5-31 (“In<br />
viaggio verso l’oracolo <strong>di</strong> Giove Ammone”)<br />
Fedro<br />
Fabulae I, 1; II, 5, V, 10 (“Lupus et agnus, Tiberius<br />
Caesar ad Atriensem, Canis et sus et venator”)<br />
Massimo e Curzio Rufo.<br />
Le testimonianze <strong>di</strong> Seneca e Tacito sulla figura<br />
dello storico Cremuzio Cordo (cfr. Seneca,<br />
Consolatio ad Marciam 20, 4-7, Tacito, Annali IV,<br />
34-35)<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Il fine moralistico degli exempla.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
La ricerca dell’effetto e la tensione narrativa<br />
funzionali al ritratto storico del protagonista.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Volontà <strong>di</strong> conferire alla favola una misura e una<br />
regola ben precise, ottemperando al precetto<br />
oraziano del miscere utile dulci.<br />
Riconoscimento <strong>di</strong> un rassegnato pessimismo e <strong>di</strong><br />
una morale rinunciataria.<br />
Il concetto <strong>di</strong> varietas: l’autore attinge anche al<br />
mondo della cronaca e dell’attualità.<br />
L’età <strong>di</strong> Nerone Obiettivi:<br />
confrontare la posizione degli intellettuali nei<br />
confronti del potere<br />
cogliere le novità dei singoli autori in or<strong>di</strong>ne allo<br />
sperimentalismo linguistico e stilistico.<br />
Seneca<br />
In italiano:<br />
Consolatio ad Marciam, 19, 3 – 20, 3 (“Solo la<br />
morte ci rende liberi”)<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
La consolatio come genere letterario in relazione ai<br />
modelli precedenti.<br />
Il tema della morte.<br />
Riconoscimento delle scelte espressive e stilistiche<br />
che l’autore perfezionerà nelle opere successive,<br />
nonché dei nuclei concettuali che saranno al centro<br />
della sua riflessione filosofica.<br />
Consolatio ad Polybium, 7 (“Elogio <strong>di</strong> Clau<strong>di</strong>o”) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Un esempio <strong>di</strong> opportunismo politico.<br />
Apokolokyntosis, 5-7, 1 (“Clau<strong>di</strong>o sale in cielo”) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
L’opera come esilarante <strong>di</strong>vertissment letterario.<br />
Importanza dell’opera come unico esempio in<br />
forma pressoché integrale <strong>di</strong> satira menippea.<br />
Uso spregiu<strong>di</strong>cato e paro<strong>di</strong>stico dei materiali<br />
De ira III, 17-19 (“ Esempi <strong>di</strong> ferocia bestiale:<br />
Alessandro, Silla, Catilina ,Caligola”)<br />
letterari sia greci che latini.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Riflessione sugli orrori e la ferocia dei politici che<br />
hanno preceduto il principe.<br />
De ira III, 36 (“L’<strong>esame</strong> <strong>di</strong> coscienza”) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Descrizione della pratica quoti<strong>di</strong>ana dell’<strong>esame</strong> <strong>di</strong><br />
coscienza.<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 8/38
Epistulae morales ad Lucilium 2 (“Le letture”) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Non conta leggere molto ma in modo utile e<br />
concentrato.<br />
Epistulae morales ad Lucilium 8, 1-7 (“La libertà<br />
del saggio”)<br />
Medea, vv. 116-178<br />
Thyestes, vv. 920-1068<br />
Epistulae morales ad Lucilium, 108, 1-7; 13-29<br />
(“L’epoca della mia prima giovinezza: gli stu<strong>di</strong><br />
filosofici”)<br />
Epistulae morales ad Lucilium, 47, 1-6, 15-21<br />
In latino:<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Riflessione sul concetto <strong>di</strong> libertà nel passaggio<br />
dalla repubblica all’impero.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Il teatro come scenario <strong>di</strong> un inconciliabile <strong>di</strong>ssi<strong>di</strong>o<br />
tra ratio e furor.<br />
Il mito come simbolo <strong>di</strong> una vita morale lacerata da<br />
violenti impulsi irrazionali.<br />
I tratti salienti <strong>di</strong> uno stile virtuosistico e baroccheggiante.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Il problema degli schiavi, uomini come gli altri.<br />
Consolatio ad Marciam 1, 2-4 (“Il coraggio <strong>di</strong> Marcia”. Attraverso l’esaltazione della figura <strong>di</strong> Marcia<br />
Seneca si <strong>di</strong>chiara dalla parte della libertas senatoria, augurandosi che il nuovo regime <strong>di</strong> Caligola si<br />
lasci alle spalle il regime del <strong>di</strong>spotismo).<br />
De ira I, 6,1 e 3-5 (“Il potere e il castigo”. Seneca delinea, per chi ha responsabilità <strong>di</strong> governo, una<br />
funzione precipua <strong>di</strong> sapiente e <strong>di</strong> educatore che deve rifuggire dagli eccessi e relegare la punizione<br />
fra i rime<strong>di</strong> ultimi.<br />
De ira II, 8 (“Una società <strong>di</strong> gla<strong>di</strong>atori e <strong>di</strong> belve”. Rappresentazione della folla, tema ricorrente in<br />
Seneca: la moltitu<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> persone <strong>di</strong> provenienze e ceti <strong>di</strong>versi che si addensa per le strade <strong>di</strong> Roma<br />
suscita nel filosofo sentimenti <strong>di</strong> sgomento e talvolta <strong>di</strong> commiserazione.)<br />
Consolatio ad Helviam matrem 6, 1-6. (“L’istinto del viaggio e del mutamento ”. L’esilio è presentato<br />
come una mera mutazione <strong>di</strong> luogo, quale variante della generale tensione umana verso il movimento<br />
e il cambiamento <strong>di</strong> se<strong>di</strong>).<br />
De brevitate vitae 1 (“La brevità della vita”. La vita <strong>di</strong> cui <strong>di</strong>sponiamo non è breve ma lunga, se non la<br />
sprechiamo).<br />
De Clementia I, 1, 1-4 (“La coscienza del potere”. La similitu<strong>di</strong>ne dello specchio. Seneca porge a Nerone<br />
uno specchio per fargli osservare riflessa la propria immagine naturale, ossia la spontanea attitu<strong>di</strong>ne a<br />
governare con clemenza).<br />
Epistulae morales ad Lucilium 1,1 (“Alla ricerca del tempo”. La via per la liberazione dell’in<strong>di</strong>viduo<br />
passa necessariamente attraverso la riconquista del tempo).<br />
Epistulae morales ad Lucilium 7, 1-5 (“Via dalla pazza folla”. La folla va evitata: è come un virus<br />
contagioso).<br />
Epistulae morales ad Lucilium 16, 1-5 (“Philosophandum est”. La filosofia è l’unico mezzo che può<br />
aiutare a sopportare stoicamente le ostilità del fato e della fortuna).<br />
Epistulae morales ad Lucilium 24, 19-21 (“La nostra morte quoti<strong>di</strong>ana”. La vita ci è stata data con la<br />
con<strong>di</strong>zione della morte; noi avanziamo contro <strong>di</strong> essa).<br />
Letture critiche:<br />
A. TRAINA, Lo stile “drammatico” del filosofo Seneca, Bologna, 1995 5 (fotocopie: “Linguaggio<br />
dell’interiorità”, “Linguaggio della pre<strong>di</strong>cazione”).<br />
Lucano<br />
Pharsalia, I, vv. 129-157 (“La quercia e il Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 9/38
fulmine”) Potenza espressiva e visionaria nei due ritratti<br />
antitetici <strong>di</strong> <strong>Cesare</strong> e Pompeo.<br />
Pharsalia, VI, vv. 719-830 (“Macabro rito <strong>di</strong> Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
negromanzia”)<br />
Consapevole rovesciamento dell’epos virgiliano:<br />
confronto tra la scena <strong>di</strong><br />
… della maga Eritto e la<br />
Pharsalia vii, 786-846 (“<strong>Cesare</strong> contempla il<br />
catabasi <strong>di</strong> Enea nel VI libro dell’Eneide.<br />
Esempio <strong>di</strong> “iperrealismo o surrealismo visionario”.<br />
Esempio <strong>di</strong> scrittura turgida e barocca, all’insegna<br />
della petulantia espressiva.<br />
Stile: fosche tinte barocche e sistematica forzatura<br />
del limite espressivo.<br />
La figura <strong>di</strong> <strong>Cesare</strong> trionfante giganteggia sullo<br />
campo <strong>di</strong> Farsalo dopo la strage”)<br />
sfondo <strong>di</strong> un apocalittico quadro <strong>di</strong> morte e <strong>di</strong><br />
orrore.<br />
Pharsalia IX, 378-410 (“La virtù <strong>di</strong> Catone”. Catone torna dopo l’ultima comparsa nel I libro.<br />
<strong>Cesare</strong> parla ai soldati non ponendo come obiettivo<br />
del loro agire il successo e neppure la<br />
sopravvivenza: “unica salvezza/ è morire a fronte<br />
alta”.<br />
Persio<br />
Choliambi (“Una <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> poetica”) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Poesia aspra che affonda le sue ra<strong>di</strong>ci nel reale.<br />
Saturae III , 60-118 (“Malattie del corpo e malattie Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
dell’animo”)<br />
Il poeta esorta un giovane vizioso a cambiare vita.<br />
Saturae V, 1-51 (“Elogio del maestro Anneo Lettura in traduzione e contestualizzazione<br />
Cornuto”)<br />
Saturae VI, 1-33 (“Sulla spiaggia <strong>di</strong> Luni,<br />
d’inverno”)<br />
Petronio<br />
Satyricon, 1-4 (“Una <strong>di</strong>sputa de causis corruptae<br />
eloquentia”)<br />
Satyricon, 32-34 (Cena Trimalchionis: l’ingresso <strong>di</strong><br />
Trimalchione)<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Un ulteriore punto <strong>di</strong> vista su uno dei temi più<br />
<strong>di</strong>battuti della letteratura latina del I sec. d.C., la<br />
decadenza dell’oratoria.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
La figura del liberto arricchito, indagata dall’autore<br />
con intento derisorio, ma anche con superiore<br />
<strong>di</strong>stacco.<br />
Satyricon, 61-64 (“Il lupo mannaro e altre storie”) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Esempi <strong>di</strong> novelle all’interno dell’opera, caratterizzate<br />
dalla presenza <strong>di</strong> elementi magici e irrazionali:<br />
La novella del lupo mannaro confronto con<br />
Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, VIII, 80-<br />
84<br />
La novella del manichino <strong>di</strong> paglia realismo<br />
beffardo, gusto del pittoresco, curiosità per i<br />
Satyricon 75-78 (“Cena Trimalchionis: conclusione<br />
e fuga”)<br />
Satyricon 110, 6-113, 2 (“La novella della matrona<br />
<strong>di</strong> Efeso”)<br />
fenomeni misteriosi.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Non la virtù ma il denaro regge le sorti del mondo.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Lo stesso Eumolpo intrattiene i presenti al<br />
banchetto con una novella piccante, <strong>di</strong> tono leggero<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 10/38
e scanzonato.<br />
Altro inserto novellistico all’interno dell’opera: la<br />
no-vella della matrona <strong>di</strong> Efeso.<br />
Esempio <strong>di</strong> fabula milesia.<br />
Assenza <strong>di</strong> ogni commento moralistico.<br />
Analisi della struttura della novella che si sviluppa<br />
per gra<strong>di</strong> fino al capovolgimento della situazione<br />
iniziale.<br />
Satyricon 116 (“La città rovesciata: Crotone”) Esempio <strong>di</strong> un mondo alla rovescia dove tutti i<br />
valori tra<strong>di</strong>zionali e consueti appaiono capovolti.<br />
Satyricon 118 (“ Contro l’epica storica”) Eumolpo a Crotone prende posizione contro l’epica<br />
storica contemporanea perché non racconta fatti<br />
Satyricon 132, 15 (“Un’ambigua <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong><br />
poetica”)<br />
reali.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Un epigramma pronunciato da Encolpio che ci<br />
offre una chiave <strong>di</strong> lettura dell’opera: il narratore<br />
<strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> voler descrivere il mondo qual è<br />
ricorrendo ad un linguaggio semplice e alla buona.<br />
Satyricon 141 (“Una suasoria antropofagica”) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
L’età dei Flavi Obiettivi:<br />
in<strong>di</strong>viduare lo sviluppo dell’ideologia del “buon<br />
burocrate” all’interno <strong>di</strong> una visio-ne non<br />
problematica della realtà<br />
riconoscere le ragioni dell’impossibilità <strong>di</strong> un<br />
completo ritorno al classicismo.<br />
Stazio<br />
Silvae, V, 4 (“L’invocazione al Sonno”) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Il motivo autobiografico filtrato attraverso eleganti<br />
figurazioni mitologiche.<br />
Tebaide, XI, 518-595 (“Il duello mortale tra<br />
Eteocle e Polinice”)<br />
Plinio il Vecchio<br />
Naturalis historia,<br />
- VII, 21-32 passim (“Miracula naturae: le<br />
popolazioni dell’In<strong>di</strong>a”)<br />
- VII, 188-190 (“Varie <strong>di</strong>cerie sui Mani”)<br />
- VIII, 80-84 (“Notizie sui lupi”)<br />
Quintiliano<br />
Institutio oratoria, I, 2, 17-29 (“Vantaggi della<br />
scuola pubblica e gradualità<br />
dell’appren<strong>di</strong>mento”)<br />
Institutio oratoria, I, 8, 1-5 (“Il valore formativo<br />
delle letture”)<br />
Ricorso ad immagini concettose e insolite.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Il poema <strong>di</strong> Stazio come singolare punto <strong>di</strong><br />
convergenza tra la tra<strong>di</strong>zione omerico-virgiliana e<br />
la più recente esperienza poetica <strong>di</strong> Seneca e<br />
Lucano.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Gusto per la narrazione fantastica e orientamento<br />
favoloso dell’esposizione.<br />
La natura come magazzino <strong>di</strong> pro<strong>di</strong>gi che si<br />
prestano ad una ricezione spettacolare.<br />
Significato rituale della licantropia e confronto con<br />
la novella <strong>di</strong> Petronio.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
L’importanza della famiglia e della scuola nella<br />
formazione del vir bonus peritus <strong>di</strong>cen<strong>di</strong>.<br />
Attenzione per la psicologia dell’età evolutiva.<br />
L’«ottimismo educativo» quintilianeo: tutti possono<br />
apprendere.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Le buone letture educano ai valori più alti dello<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 11/38
Institutio oratoria, X, 1, 125-131 (“Lo stile<br />
corruttore <strong>di</strong> Seneca”)<br />
spirito umano.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Polemica contro l’irrequieta scrittura <strong>di</strong> Seneca:<br />
reazione classicista al gusto asiano dell’età<br />
neroniana.<br />
L’ideale stilistico <strong>di</strong> Quintiliano è Cicerone, nel<br />
quale ritrova il nesso vitale tra soli<strong>di</strong>tà<br />
dell’espressione e moralità del costume.<br />
Lo stile: paradossalmente è lontano dall’euritmia<br />
ciceroniana, mentre risente dell’inevitabile<br />
evoluzione linguistica operata proprio da Seneca.<br />
Marziale<br />
Epigrammata, I, 4; IV, 49; VIII, 3; X, 4 (la poetica) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Testi programmatici.<br />
Polemica contro l’epos mitologico e la trage<strong>di</strong>a.<br />
Una poesia che sapit hominem e che ritrae la realtà<br />
nelle sue molteplici prospettive.<br />
Analogie e <strong>di</strong>fferenze con la satira.<br />
Epigrammata, I, 10; I, 47; II, 38; VIII, 10; X, 8, X,<br />
91 (Epigrammi satirici)<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Concretezza dell’osservazione ed effetto a sorpresa.<br />
Schema-base bipartito dell’epigramma <strong>di</strong> Marziale:<br />
momento descrittivo-rappresentativo<br />
¢ Ò finale con funzione<br />
conoscitiva e liberatoria.<br />
Epigrammata, V, 34 e 37 (Epigrammi funebri) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Esempio <strong>di</strong> epice<strong>di</strong>o.<br />
Varietà <strong>di</strong> toni della poesia <strong>di</strong> Marziale.<br />
Analisi linguistica: <strong>di</strong>minutivi e termini attinenti<br />
alla sfera affettiva contrapposti a vocaboli che<br />
evocano oscure realtà funebri.<br />
Epigrammata, I 7; I, 32 (“Marziale e Catullo”) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Celebrazione del modello: Catullo.<br />
Epigrammata XII, 18 (“La vita a Bilbili”) Descrizione della vita nella città natale spagnola.<br />
Epigrammata IV, 18 (“Nuov spettacoli: il pugnale Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
<strong>di</strong> ghiaccio”).<br />
Mancanza <strong>di</strong> commozione nella narrazione.<br />
Liber de spectaculis 4(“Spettacoli: la sfilata dei Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
delatori”)<br />
Tito non sfrutta più i delatori.<br />
Liber de spectaculis 7 (“Spettacoli: un cruento<br />
pantomimo”)<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
L’età <strong>di</strong> Traiano e <strong>di</strong> Adriano Obiettivi:<br />
-cogliere nei <strong>di</strong>versi atteggiamenti degli intellettuali<br />
l’ambiguità <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio nei confronti dell’età loro<br />
contemporanea<br />
-confrontare le <strong>di</strong>verse posizioni storiografiche<br />
Giovenale<br />
Satira, I, vv. 1-87; 147-171 (Una satira<br />
programmatica: facit in<strong>di</strong>gnatio versum)<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
La poetica: rifiuto delle recitationes, rifiuto<br />
dell’epos e della mitologia, la scelta dei modelli.<br />
Unico argomento possibile per la poesia è la realtà<br />
vista nei suoi aspetti più degradati.<br />
L’in<strong>di</strong>gnatio come stimolo alla poesia.<br />
Differenze rispetto alla satira <strong>di</strong> Lucilio e <strong>di</strong> Orazio.<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 12/38
Satira, III, vv. 232-267 (La ridda infernale nelle<br />
strade <strong>di</strong> Roma)<br />
Satira, VI, vv. 434-473 (Ritratti <strong>di</strong> donne: la<br />
letterata saccente e la donna che si fa bella)<br />
Tacito<br />
Dialogus de oratoribus, 36 (“L’antica fiamma<br />
dell’eloquenza”)<br />
Dialogus de oratoribus, 28-29 (“L’educazione dei<br />
figli”)<br />
Riflessioni sullo stile: tono declamatorio, icasticità<br />
delle rappresentazioni, condensazione espressiva<br />
delle sententiae.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Il degrado sociale e la corruzione dei costumi che<br />
affliggono la città.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Posizione misogina all’interno della generale<br />
denun-cia contro la corruzione morale e sociale<br />
dell’epoca.<br />
Non descrizione obiettiva, ma iperbolica<br />
deformazione dei dati desunti dall’esperienza reale.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Problemi <strong>di</strong> attribuzione dell’opera.<br />
Il problema della decadenza dell’oratoria<br />
(confronto con Seneca il Vecchio, Velleio<br />
Patercolo, Petronio, Quintiliano)<br />
Ciceronianismo dello stile.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
La vera educazione era quella del passato.<br />
Agricola, 33-34 (“La risposta <strong>di</strong> Agricola”) Lettura in traduzione e contestualizzazione<br />
Historiae, III, 83 (“Il degrado morale del popolo<br />
romano”)<br />
Annales, IV, 32-33 (“Infelicità dello storico<br />
moderno”)<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Profondo pessimismo <strong>di</strong> fronte all’irreversibile<br />
degrado morale e istituzionale che interessa Roma.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Complesso <strong>stato</strong> d’animo dell’autore <strong>di</strong>nanzi alla<br />
propria materia.<br />
Il genere storiografico è mutato col mutare della<br />
situazione politica.<br />
Annales XIV, 3-10 (“Il matrici<strong>di</strong>o”) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Descrizione della morte d Agrippina.<br />
Annales XVI, 18-19 (“Ritratto <strong>di</strong> Petronio”) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Annales XV, 62-64 (“La morte <strong>di</strong> Seneca nel<br />
Descrizione della morte <strong>di</strong> Petronio.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
racconto <strong>di</strong> Tacito”)<br />
In latino.<br />
Descrizione della morte <strong>di</strong> Seneca.<br />
Lettura, traduzione, commento e analisi grammaticale-retorica dei seguenti passi in latino:<br />
Agricola, 1-3 (“Proemio”)<br />
Traduzione e analisi sintattica.<br />
Agricola, 30-32 (“Il <strong>di</strong>scorso <strong>di</strong> Calgàco”) Di ogni singolo passo si sono sottolineati gli<br />
Germania, 1 (“I confini della Germania”)<br />
elementi peculiari sia a livello contenutistico.<br />
Germania, 18-20 (“Il matrimonio, la famiglia, i L’impianto “tragico” della storiografia <strong>di</strong> Tacito.<br />
figli”)<br />
L’analisi psicologica dei personaggi.<br />
Germania, 37 (“La libertà dei Germani”)<br />
Le descrizioni paesaggistiche funzionali alla descri-<br />
Historiae, I, 1-2 (“Proemio”)<br />
zione degli eventi e degli stati d’animo.<br />
Historiae, II, 38 (“La fine della libertas”)<br />
Annales, I, 1 (“Proemio”)<br />
Critica alla corruzione <strong>di</strong>ffusa a Roma.<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 13/38
Plinio il Giovane<br />
Panegyricus Traiano imperatori, 64 (Elogio <strong>di</strong><br />
Traiano, il migliore degli imperatori possibili)<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Il significato del termine “panegirico”.<br />
L’interesse letterario e storico dell’opera.<br />
Il rapporto tra la retorica e il potere (confronto con<br />
Quintiliano).<br />
L’antitesi tra il recente passato (regno <strong>di</strong><br />
Domiziano) e il presente (regno <strong>di</strong> Traiano)<br />
corrisponde all’anti-tesi tra necessitas e libertas.<br />
Lo stile dell’opera: molteplicità <strong>di</strong> posizioni<br />
critiche.<br />
Epistulae, VIII, 8 (Le fonti del Clitumno) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Topica descrizione <strong>di</strong> un locus amoenus descrito<br />
Epistulae, IX, 36 (Dalla villa in Tuscis: la mia<br />
giornata-tipo)<br />
Epistulae, X, 96-97 (Carteggio Plinio-Traiano: la<br />
questione dei cristiani)<br />
con efficace evidentia.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
La giornata <strong>di</strong> Plinio “un gran signore, privilegiato,<br />
accomodante, amico <strong>di</strong> tutti e, probabilmente, <strong>di</strong><br />
nessuno” (Luca Canali).<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Importanza del documento per comprendere<br />
l’atteggiamento dell’impero nei confronti del<br />
problema “cristiani”.<br />
Importanza del documento per conoscere alcuni<br />
aspetti della vita liturgica dei cristiani del II secolo.<br />
La risposta <strong>di</strong> Traiano: la logica del sistema<br />
ammini-strativo.<br />
Epistulae, VI, 4-20 Vita e morte dello zio Plinio il Vecchio.<br />
Epistulae, III, 21 Ricordo <strong>di</strong> Marziale.<br />
Apuleio: cenni sul romanzo Metamorfosi ovvero<br />
L’asino d’oro<br />
Autori Cristiani<br />
Sant’Agostino<br />
Le Confessioni, XI, 14 e 20 (“Natura del tempo”;<br />
“Quanti sono i tempi?”)<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Il tempo come creazione <strong>di</strong>vina.<br />
Le tre <strong>di</strong>mensioni del tempo.<br />
Le Confessioni, VI, 8 (“Alipio nell’anfiteatro”) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Collegamenti con Seneca ed il suo rapporto con la<br />
folla.<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 14/38
GRECO<br />
Testi utilizzati:<br />
Guidorizzi, La letteratura greca, voll. II-III Einau<strong>di</strong> scuola<br />
G.A. <strong>Cesare</strong>o (a cura <strong>di</strong>), Euripide, Ifigenia in Aulide , Società e<strong>di</strong>trice Dante Alighieri<br />
G. Schiassi (a cura <strong>di</strong>), Platone, Menesseno, Società e<strong>di</strong>trice Dante Alighieri<br />
Il teatro Obiettivi:<br />
V secolo:<br />
riconoscere la valenza culturale, politica e<br />
religiosa del teatro tragico e comico<br />
in<strong>di</strong>viduare l’analoga valenza catartica del<br />
pathos tragico e del riso comico<br />
in<strong>di</strong>viduare le caratteristiche portanti della<br />
drammaturgia <strong>di</strong> Euripide e gli elementi <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>fferenziazione rispetto ad Eschilo ed a<br />
Sofocle.<br />
IV secolo:<br />
analizzare il mutamento delle forme teatrali in<br />
rapporto alle mutate con<strong>di</strong>zioni politiche<br />
V SECOLO<br />
La trage<strong>di</strong>a: Eschilo<br />
Letture in italiano:<br />
Persiani, vv. 353-432 (La battaglia <strong>di</strong> Salamina) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
La ·Ásij del Messaggero: versi d straor<strong>di</strong>naria<br />
Sette contro Tebe, vv. 39-68 (Uno scudo pieno <strong>di</strong><br />
sangue)<br />
intensità narrativa.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Prologo: Eteocle esorta i concitta<strong>di</strong>ni a combattere<br />
per la loro città.<br />
Analisi del contrasto tra due mon<strong>di</strong>: quello greco e<br />
quello barbaro.<br />
Sette contro Tebe, vv. 631-719 (La settima porta) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Cuore della trage<strong>di</strong>a: <strong>di</strong>alogo tra il messaggero ed il<br />
re Eteocle. Alla settima porta troverà compimento<br />
Supplici, vv. 866-949 (Gli Egiziani tentano <strong>di</strong><br />
rapire le Danai<strong>di</strong>)<br />
Prometeo incatenato, vv. 1-105 (Prologo:<br />
Prometeo incatenato alla rupe)<br />
Prometeo incatenato, vv. 436-506 (La sapienza <strong>di</strong><br />
Prometeo)<br />
la sciagura della famiglia.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Tipica scena teatrale eschilea, ambientata ad Argo,<br />
in cui si condensa la tensione drammatica della<br />
trage<strong>di</strong>a.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Scena iniziale della trage<strong>di</strong>a: entrano in scena<br />
quattro personaggi (è necessario il terzo attore).<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Nell’auto<strong>di</strong>fesa <strong>di</strong> Prometeo affiora un problema<br />
centrale del secolo V a. C.: l’idea del progresso.<br />
Agamennone, vv. 1-39 (Prologo notturno) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
L’inquietu<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> un’atmosfera notturna e cupa.<br />
Monologo della guar<strong>di</strong>a che sul tetto della reggia<br />
attende la comparsa del segnale <strong>di</strong> fuoco che<br />
Agamennone, vv. 855-974 (Clitemnestra<br />
accoglie Agamennone)<br />
Agamennone, vv. 1372-1447 (La morte <strong>di</strong><br />
Agamennone)<br />
comunica la caduta <strong>di</strong> Troia.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Il personaggio <strong>di</strong> Clitemnestra, la “padrona della<br />
soglia”, accoglie lo sposo Agamennone <strong>di</strong> ritorno<br />
da Troia.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Scena <strong>di</strong> straor<strong>di</strong>naria tensione psicologica.<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 15/38
Coefore, vv. 124-305 (Il riconoscimento tra<br />
La regina ossessiva descrive il massacro del marito.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Oreste ed Elettra)<br />
Esempio <strong>di</strong> riconoscimento tragico che avrà<br />
successivi sviluppi.<br />
Coefore, vv. 875-929 (La vendetta: Oreste Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
uccide la madre)<br />
Oreste lacerato da due opposte pulsioni sceglie <strong>di</strong><br />
compiere la vendetta uccidendo sua madre.<br />
Eumeni<strong>di</strong>, vv. 94-197 (Lo spettro <strong>di</strong><br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Clitemnestra)<br />
Scena allucinata e spettrale: la potenza<br />
Eumeni<strong>di</strong>, vv. 681-753 (Il processo <strong>di</strong> Oreste)<br />
drammaturgi-ca del teatro eschileo.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Il pentimento ed il ravve<strong>di</strong>mento morale non<br />
occupano alcuno spazio nella vicenda.<br />
Sofocle<br />
Letture in italiano:<br />
Aiace, vv. 815-851 (Il suici<strong>di</strong>o <strong>di</strong> Aiace) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
La caratterizzazione dei personaggi.<br />
L’eroe <strong>di</strong> fronte al <strong>di</strong>lemma tragico.<br />
La solitu<strong>di</strong>ne degli eroi sofoclei: Aiace muore<br />
senza perdonare.<br />
Antigone, vv. 384-525 (Antigone sfida Creonte) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Contrapposizione tra le leggi degli dèi e leggi degli<br />
uomini.<br />
La paradossale contrapposizione tra grandezza<br />
Antigone, vv. 332-375; 781-800 (Due canti<br />
corali: il progresso umano e la forza<br />
dell’amore)<br />
Trachinie, vv. 531-625 (La gelosia <strong>di</strong> Deianira)<br />
Trachinie, vv. 756-812 (Eracle preso nella<br />
veste avvelenata)<br />
morale e colpa sociale.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
La fiducia nel progresso e nelle potenzialità<br />
dell’uomo.<br />
Il senso del limite.<br />
La forza irresistibile <strong>di</strong> Afro<strong>di</strong>te.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
L’uomo è per Deianira, ambiguamente, oggetto <strong>di</strong><br />
pulsione erotica ed insieme un’energia che la turba<br />
e la inibisce.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Deianira tace, annientata, incapace <strong>di</strong> <strong>di</strong>re una sola<br />
parola e intanto prende coscienza ( ¥rti manq£nw)<br />
<strong>di</strong> come il suo mondo stia crollando<br />
E<strong>di</strong>po re, vv. 1-77 (Prologo) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
La peste e le sue arcane motivazioni.<br />
E<strong>di</strong>po re, vv. 216-275: 316-462 (E<strong>di</strong>po e<br />
Tiresia)<br />
La figura <strong>di</strong> E<strong>di</strong>po: da buon re a tiranno.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
In concetto <strong>di</strong> ironia tragica.<br />
La contrapposizione tra vista e cecità fisica e<br />
spiritua-le.<br />
E<strong>di</strong>po re, vv. 697-847 (Il sospetto) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
E<strong>di</strong>po cessa <strong>di</strong> essere tÚrannoj ed inizia a scavare<br />
E<strong>di</strong>po re, vv. 1110-1222 (E<strong>di</strong>po comprende il<br />
suo passato)<br />
dentro il proprio passato.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Tutto ormai si è compiuto. Resta da raggiungere il<br />
momento fondamentale del processo psicologico<br />
dell’eroe sofocleo: il momento della conoscenza.<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 16/38
Elettra vv. 516-6<strong>09</strong> (Elettra e Clitemnestra)<br />
Filottete, vv. 26-69; 219-284 (L’antro del<br />
selvaggio)<br />
E<strong>di</strong>po a Colono, vv. 668-719 (L’elogio <strong>di</strong><br />
Colono)<br />
E<strong>di</strong>po a Colono, vv. 1579-1666 (La morte <strong>di</strong><br />
E<strong>di</strong>po)<br />
Euripide<br />
Letture in italiano:<br />
Alcesti, vv. 244-392 (La morte <strong>di</strong> Alcesti)<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Elettra è isolata sulla scena: ciò è segno esterno <strong>di</strong><br />
una profonda esclusione dalla realtà in cui è<br />
condannata a vivere.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
L’azione si apre subito in me<strong>di</strong>as res: si cercano le<br />
tracce <strong>di</strong> un uomo su un’isola, luogo <strong>di</strong> estrema<br />
miseria e degrado.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Brano <strong>di</strong> grande respiro poetico, cantato dal coro,<br />
espressione della potenza immaginativa ancora viva<br />
in un poeta ormai anziano.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
La tomba <strong>di</strong> E<strong>di</strong>po è la terra.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
La celebrazione delle virtù <strong>di</strong> Alcesti in confronto<br />
con la viltà dei genitori <strong>di</strong> Admeto.<br />
Alcesti, vv. 747-849 (Eracle mangione) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Eracle come personaggio a metà tra trage<strong>di</strong>a e<br />
Medea, vv. 446-626 (Medea e Giasone)<br />
Medea, vv. 1021-1080 (Il monologo <strong>di</strong> Medea)<br />
Ippolito, vv. 1-57 (Il prologo <strong>di</strong>vino)<br />
Ippolito, vv. 311-430 (Fedra confessa il suo<br />
amore)<br />
comme<strong>di</strong>a.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
L’emarginazione sociale <strong>di</strong> Medea.<br />
Il confronto tra i due antagonisti.<br />
Il conflitto tra furor e ratio.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
La rappresentazione euripidea della <strong>di</strong>vinità.<br />
La misoginia <strong>di</strong> Ippolito.<br />
Amore vince ogni cosa.<br />
Troiane, vv. 511-567 (La notte fatale <strong>di</strong> Troia) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Il punto <strong>di</strong> vista delle donne, che, secondo<br />
l’opinione comune greca, erano solite reagire agli<br />
Troiane, vv. 860-1059 (L’agone tra Elena ed<br />
Ecuba)<br />
Elena, vv. 483-647 (L’incontro e il<br />
riconoscimento fra Elena e Menelao)<br />
eventi in maniera scomposta ed irrazionale.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
L’agone risente degli influssi della retorica <strong>di</strong><br />
stampo sofistico.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
La realtà è svilita: a Troia si è combattuto per anni<br />
per un simulacro.<br />
Eracle, vv. 922- 1015 (La follia <strong>di</strong> Eracle) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Eracle uccide la sua famiglia pensando <strong>di</strong> uccidere<br />
Euristeo, suo persecutore.<br />
Ione, vv. 1106-1228 (Un tentato<br />
avvelenamento)<br />
La fragilità della mente umana.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Creusa intende avvelenare Ione, ma viene scoperta.<br />
La tÚch è il motore degli avvenimenti, ma in ogni<br />
caso pone gli uomini davanti alla limitatezza della<br />
loro autonomia.<br />
Baccanti, vv. 434-518 (Le baccanti sui monti) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 17/38
Baccanti, vv. 912-970 (La follia <strong>di</strong> Penteo)<br />
Baccanti, vv. 1043-1152 (Le baccanti fanno a<br />
pezzi Penteo)<br />
L’attrazione verso il mondo irrazionale dei riti<br />
<strong>di</strong>onisiaci.<br />
Il mena<strong>di</strong>smo e la sua valenza sociale.<br />
Penteo e Dioniso: due antagonisti speculari.<br />
Penteo: modello della fragilità umana.<br />
Euripide, Ifigenia in Aulide<br />
Letture in greco: Traduzione, analisi sintattica e stilistica. Scansione<br />
metrica in trimetri giambici.<br />
Datazione e collegamenti con il contesto socioculturale<br />
in cui la trage<strong>di</strong>a si sviluppa.<br />
Prologo, VV 1-49 Anapesti lirici.<br />
La scena è in Aulide, nell’accampamento greco,<br />
davanti alla tenda <strong>di</strong> Agamennone.<br />
Prologo, vv. 115-163 Anapesti lirici.<br />
Menelao or<strong>di</strong>na al vecchio servo <strong>di</strong> andare ad Argo<br />
a recapitare a Clitemnestra una lettera in cui le<br />
chiede <strong>di</strong> non fare partire la figlia; legge poi al<br />
servo il contenuto della lettera<br />
I Episo<strong>di</strong>o, vv. 334-401 Tetrametri trocaici catalettici.<br />
Agamennone esce dalla tenda, attirato dal violento<br />
alterco tra Menelao che ha intercettato la lettera, e il<br />
servo. I due fratelli si scontrano.<br />
I Episo<strong>di</strong>o, vv. 440-488; 506-542 Trimetri giambici.<br />
Un messo è entrato per annunciare ad Agamennone<br />
l’arrivo della moglie Clitemnestra con la figlia<br />
Ifigenia ed il piccolo Oreste.<br />
II Episo<strong>di</strong>o, vv. 633- 680 Sticomitia in trimetri giambici.<br />
Preannunciata da un servo, è arrivata in scena<br />
Clitemnestra su un carro, con Ifigenia ed il piccolo<br />
Oreste; ella ha dato or<strong>di</strong>ne ai servi <strong>di</strong> portare nella<br />
tenda i doni dotali, ha chiesto alle donne <strong>di</strong> aiutarla<br />
a scendere, ha fatto svegliare dal sonno Oreste ed<br />
ha esortato Ifigenia a salutare il padre.<br />
III Episo<strong>di</strong>o, vv. 819-854 Disticomitia in trimetri giambici.<br />
E’ entrato in scena Achille, con l’intento <strong>di</strong><br />
sollecitare Agamennone alla partenza. Clitemnestra<br />
esce dalla tenda per fargli la festa.<br />
IV Episo<strong>di</strong>o, vv. 1211-1275 In scena vi sono Agamennone, Clitemnestra,<br />
Ifigenia ed il piccolo Oreste. Agamennone è <strong>stato</strong><br />
costretto ad ammettere la verità.<br />
Preambolo <strong>di</strong> gusto forense recitato da I., che<br />
<strong>di</strong>mostra <strong>di</strong> amare fortemente la vita.<br />
Ricordo <strong>di</strong> scene d’affetto commoventi tra padre e<br />
figlia.<br />
V Episo<strong>di</strong>o, vv. 1368-1400 Tetrametri trocaici catalettici.<br />
Achille si presenta in scena <strong>di</strong>cendo che l’esercito<br />
pretende il sacrificio della ragazza, ma che lui è<br />
risoluto a <strong>di</strong>fenderla ad ogni costo.<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 18/38
Letture critiche:<br />
Per il testo letto in lingua greca:<br />
G. Paduano, Il nostro Euripide, Sansoni, 1984<br />
M. Pohlenz, La trage<strong>di</strong>a greca, trad. italiana<br />
Paideia 1978 2<br />
F. Ferrari, Introduzione ad Ifigenia in Aulide ed<br />
Ifigenia in Tauride, BUR<br />
Per la trage<strong>di</strong>a in generale:<br />
M. Pohlenz, La trage<strong>di</strong>a greca , trad. italiana<br />
Paideia 1978 2<br />
M. Morani-G. Regoliosi, Cultura classica e<br />
ricerca del <strong>di</strong>vino (<strong>di</strong> fronte alla trage<strong>di</strong>a<br />
greca), Il Cerchio, 2002<br />
C. Moeller, Saggezza greca e paradosso<br />
cristiano, Morcelliana, 2003 9<br />
Il dramma satiresco<br />
Eschilo, Diktyoulkoì<br />
Sofocle, Ichneutaì<br />
Euripide., Ciclope<br />
Caratteri e funzione teatrale in relazione alla<br />
trage<strong>di</strong>a.<br />
Trame sintetiche.<br />
La comme<strong>di</strong>a ¢ … .<br />
Notizie generali sulla comme<strong>di</strong>a antica Le origini:.<br />
Il contesto temporale: gli agoni drammatici<br />
ateniesi.<br />
La struttura.<br />
Il costume, la maschera, il coro.<br />
Catarsi tragica e riso comico.<br />
Libertà compositiva e attualità delle tematiche.<br />
La „ ¾„dšae l’Ñnomast… ‹ <br />
L’elemento fantastico e surreale.<br />
Aristofane<br />
Acarnesi, vv. 61-173 (Truffe in assemblea)<br />
vv. 395-479 (Euripide ex machina)<br />
Vv. 628-718 (Parabasi)<br />
Cavalieri, vv. 763-870 (Come imbrogliare il<br />
popolo)<br />
Nuvole, vv. 133-262 (Strepsiade entra nel<br />
pensatoio)<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Ritratto dei politici: imbroglioni e corrotti.<br />
Euripide viene pesantemente bersagliato da A.<br />
Si rompe la quarta parete che separa attori e<br />
pubblico: il poeta <strong>di</strong>ce ciò che desidera al pubblico.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Critica rivolta alla vita assembleare e alle tecniche<br />
persuasive.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Critica accesa alla sofistica.<br />
vv. 889-1104 (i due <strong>di</strong>scorsi )<br />
Pace, vv. 1-153 (Trigeo dà la scalata al cielo) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Due sfere linguistiche in contrasto.<br />
Le gioie della pace: la <strong>di</strong>gnità morale del lavoro.<br />
Uccelli, vv. 1-48 (In cerca <strong>di</strong> un luogo dove<br />
vivere)<br />
vv. 1565-1690 (Gli dei vengono a<br />
patti con gli uccelli)<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Prologo.<br />
Fuga dalla città <strong>di</strong> Atene per rifugiarsi in una<br />
<strong>di</strong>mensione utopica.<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 19/38
Lisistrata, vv. 845-953 (Scene <strong>di</strong> seduzione) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Ripresa del motivo del paraklaus…quron.<br />
Rane, vv. 830-870; 1197-1247 (La contesa tra<br />
Eschilo ed Euripide)<br />
Donne in assemblea, vv. 57-1<strong>09</strong> (Prove<br />
generali)<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Il motivo della crisi della trage<strong>di</strong>a dopo la morte <strong>di</strong><br />
Euripide e <strong>di</strong> Sofocle.<br />
Il viaggio nell’oltretomba rappresentato con<br />
un’effi-cace “scenografia verbale”.<br />
L’al<strong>di</strong>là come paese capovolto, simboleggiante<br />
Atene stessa.<br />
La paro<strong>di</strong>a tragica.<br />
L’agone tra Eschilo e Euripide<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Preparativi del colpo <strong>di</strong> <strong>stato</strong>.<br />
Tematica del travestimento sessuale come<br />
espe<strong>di</strong>ente finalizzato a penetrare in un luogo <strong>di</strong><br />
esclusivo appannaggio maschile.<br />
La comme<strong>di</strong>a š <br />
Notizie generali sulla comme<strong>di</strong>a nuova La nuova situazione storica: il tramonto<br />
dell’autono-mia della polis, l’ampliamento degli<br />
orizzonti geografici e culturali.<br />
Il mutamento delle coor<strong>di</strong>nate fondamentali<br />
dell’im-maginario collettivo.<br />
Lo scar<strong>di</strong>namento dei valori tra<strong>di</strong>zionali.<br />
Gli effetti della nuova situazione storico-sociale sul<br />
teatro comico: i mutamenti tematici e<br />
drammaturgici.<br />
Menandro<br />
Dyscolos, vv. 1-188 (I turbamenti <strong>di</strong><br />
Cnemone)<br />
vv. 710-747 (Monologo <strong>di</strong><br />
Cnemone)<br />
La ragazza tosata, vv. 1-76<br />
(Il prologo <strong>di</strong> Ignoranza)<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Analisi della struttura: riduzione del coro a<br />
intermez-zo, <strong>di</strong>visione in atti, rispetto delle<br />
convenzioni teatrali (unità <strong>di</strong> tempo, <strong>di</strong> luogo e <strong>di</strong><br />
spazio).<br />
Analisi della tematica in rapporto al mutamento del<br />
pubblico.<br />
La caratterizzazione psicologica <strong>di</strong> Cnemone,<br />
perso-naggio non totalmente negativo.<br />
Il messaggio conclusivo <strong>di</strong> solidarietà.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Prologo informativo recitato da un concetto astratto<br />
personificato).<br />
L’inganno è svelato.<br />
vv. 217-300<br />
(verso lo scioglimento dell’intreccio)<br />
L’arbitrato, Atto I, vv. 1-35 (Il prologo) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Atto II, vv. 42-206<br />
I vari passaggi per giungere al riconoscimento<br />
(La scena dell’arbitrato) finale e alla verità.<br />
Atto III, vv. 266-406<br />
La caratterizzazione psicologica dei personaggi in<br />
(Il mistero dell’anello) funzione della costruzione della trama.<br />
Atto V, vv. 704-774<br />
Il messaggio <strong>di</strong> filantropia e solidarietà.<br />
(Il lieto fine)<br />
La ragazza <strong>di</strong> Samo, vv. 1-5 (Il prologo) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Prologo non espositivo affidato ad uno dei<br />
protagonisti dell’azione comica, Moschione.<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 20/38
Platone: la funzione civica <strong>di</strong> un <strong>di</strong>scorso <strong>di</strong><br />
parata<br />
Letture in greco:<br />
Menesseno, 234c-235c<br />
Menesseno, 235d-236d<br />
Menesseno 236d-237b<br />
Menesseno 237b-238b<br />
Menesseno 246d-247c<br />
Traduzione, analisi sintattica e stilistica.<br />
Ambientazione.<br />
Datazione guerra <strong>di</strong> Corinto.<br />
Limiti dell’epitafio tra<strong>di</strong>zionale.<br />
Confronto con Gorgia.<br />
Socrate promette <strong>di</strong> recitare l’epitafio appreso da<br />
Aspasia.<br />
Critica alla falsa improvvisazione dei retori.<br />
I tre fini dell’epitafio: lode, consolazione,<br />
esortazione.<br />
Dal trenos all’epitafio.<br />
I precedenti: Pericle e Gorgia.<br />
Il contemporaneo epitafio <strong>di</strong> Lisia<br />
Lode degli Ateniesi: sono nobili perché nati da una<br />
nobile terra.<br />
Consolazione ai figli: tutto dovete orientare<br />
all’aretè.<br />
La “rivoluzione” dell’Ellenismo Obiettivi:<br />
verificare i cambiamenti indotti nelle tematiche,<br />
nello stile e nella concezione<br />
dell’arte dalla “rivoluzione” politica prodottasi<br />
con la fine della polis e dal<br />
passaggio dalla comunicazione orale a<br />
quella scritta.<br />
Callimaco<br />
Aitia, I, 1-38 (Prologo contro i Telchini)<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Gli elementi fondamentali e innovativi della poetica<br />
callimachea.<br />
Aitia, III, (Aconzio e Ci<strong>di</strong>ppe) Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
La polemica contro il poema epico tra<strong>di</strong>zionale.<br />
Il gusto delle leggende eziologiche.<br />
Realismo descrittivo: gusto dei dettagli<br />
impressioni-stici tratti dalla vita quoti<strong>di</strong>ana.<br />
L’interesse eziologico.<br />
La varietà dei temi.<br />
Il gusto dell’eru<strong>di</strong>zione mitologica e dell’arte<br />
Inno per i lavacri <strong>di</strong> Pallade, vv. 53-142<br />
Epigrammi, Ant. Pal., V, 6, 23; VII, 525, 80;<br />
IX, 507, XII, 43<br />
allusiva.<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
Esempio <strong>di</strong> inno drammatico.<br />
Il gusto della variante insolita ed eru<strong>di</strong>ta del mito.<br />
La poikil…a<br />
Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
I filoni principali degli epigrammi callimachei.<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 21/38
Teocrito<br />
I<strong>di</strong>lli, VII, vv.1-41 (Le Talisie) Programmatica poetica della verità.<br />
Il realismo teocriteo.<br />
Il mimo<br />
Eroda e i suoi mimiambi<br />
Il maestro <strong>di</strong> scuola<br />
Un piccolo quadro <strong>di</strong> vita quoti<strong>di</strong>ana: un ragazzino<br />
è represso da un apparato educativo arcigno e<br />
ossessivo e dall’invadenza della madre.<br />
Apollonio Ro<strong>di</strong>o e l’epica <strong>di</strong>dascalica Lettura in traduzione e contestualizzazione.<br />
La scelta dell’argomento.<br />
Compromesso tra l’antica tra<strong>di</strong>zione epica e le<br />
nuove esigenze della poesia ellenistica.<br />
Il narratore epico da entità invisibile si fa funzione<br />
esplicita.<br />
Interpretazioni controverse dell’opera: fallimento<br />
del-lo statuto eroico o consapevole realizzazione <strong>di</strong><br />
uno statuto antieroico? (Paduano).<br />
Argonautiche, III, 1278-1313; 1354-1398<br />
(Giasone “eroico”)<br />
Antologia Palatina<br />
Il romanzo <strong>di</strong> età ellenistica: cenni<br />
La ¢mhcan…a<strong>di</strong> Giasone.<br />
Formazione della raccolta.<br />
Evoluzione dell’epigramma.<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 22/38
FILOSOFIA<br />
IMMANUEL KANT – Vita e Opere. Il Criticismo kantiano. La Critica della Ragion Pura- La<br />
“Rivoluzione Copernicana”. Il concetto kantiano <strong>di</strong> Trascendentali. Estetica e Analitica . Le categorie; L’<br />
Io penso. Fenomeno e Noumeno. La Dialettica trascendentale. Le Idee. La Critica della Ragion Pratica- Il<br />
concetto e gli scopi. La Legge Morale come imperativo categorico. L’essenza dell’imperativo categorico. Le<br />
Formule. Principio dell’ autonomia morale. Il Bene morale e la sua <strong>di</strong>mensione universale. L’inno al dovere.<br />
I Postulati. II Primato della Ragion Pratica. La Critica del Giu<strong>di</strong>zio- Giu<strong>di</strong>zio determinante e giu<strong>di</strong>zio<br />
riflettente Giu<strong>di</strong>zio estetico e giu<strong>di</strong>zio teleologico. Bello e Sublime.<br />
Letture Critica della Ragion Pura: l Giu<strong>di</strong>zi Sintetici a Priori , La Rivoluzione Copernicana operata in<br />
ambito filosofico da Kant , L’unità sintetica originaria dell’appercezione pura a priori: l’Io penso. Critica<br />
della Ragion Pratica La pura forma come carattere essenziale della legge morale Noi conosciamo <strong>di</strong><br />
essere liberi partendo dalla legge morale, Devi dunque puoi. Critica del Giu<strong>di</strong>zio: Differenze tra Bello e<br />
Sublime<br />
IL MOVIMENTO ROMANTICO E LA FORMAZIONE DELL’IDEALISMO<br />
Genesi e Caratteri essenziali del Romanticismo. Lo Sturm und Drang. Il Romanticismo. Il termine, luoghi e<br />
tempi. La cifra spirituale dell’uomo romantico. Idee fondamentali del Romanticismo. I Fondatori della<br />
Scuola Romantica. Il Circolo dei Romantici e la Rivista Athenaeum. La <strong>di</strong>ffusione del Romanticismo.<br />
FONDAZIONE E ASSOLUTIZZAZIONE SPECULATIVA DELL’IDEALISMO<br />
JOHANN GOTTLIEB FICHTE – Vita e Opere. L’ Illuminante Lettura <strong>di</strong> Kant. L’Idealismo fichtiano . La<br />
Dottrina della Scienza. Problemi Morali. Fondazione Idealistica dell’ Etica. Significato e funzione del <strong>di</strong>ritto<br />
e dello Stato. Il ruolo storico della Nazione Tedesca.<br />
Letture Prima Introduzione alla dottrina della Scienza – Un Manifesto dell’ Idealismo: che cos’è<br />
l’Idealismo e perché un uomo lo sceglie - L’oggetto dell’ Idealismo è l’ “Io in sè”, L’interesse <strong>di</strong> fondo dell’<br />
idealista sta nell’amore per la libertà, l’esperienza come prodotto dell’attività <strong>di</strong> un pensiero libero, ma<br />
conforme a leggi, Per la filosofia idealistica non c’è altra realtà che l’intelligenza dalla cui realtà derivano<br />
tutte le cose<br />
FREDRICH WILHELM JOSEPH SCHELLING - Vita e Opere. Il punto <strong>di</strong> partenza: l’ Idealismo<br />
fichtiano. L’Unità <strong>di</strong> Spirito e Natura. La Filosofia della Natura. L’Idealismo trascendentale e l’Idealismo<br />
Estetico.Idealrealismo<br />
Letture Sistema dell’ Idealismo Trascendentale: La Necessità della Filosofia della Natura Il Vero<br />
organo della Filosofia: l’ Arte<br />
GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL – Vita e Opere. I Capisal<strong>di</strong> del pensiero hegeliano. Il Saper<br />
reale. La critica a Fichte e critica a Schelling. La nuova concezione hegeliana dello Spirito come Infinito. La<br />
Dialettica come legge suprema del reale. La Struttura tria<strong>di</strong>ca del processo <strong>di</strong>alettico. Lo Speculativo.<br />
Significato e finalità della “Fenomenologia dello Spirito”. Le tappe dell’ itinerario fenomenologico (sintesi).<br />
La figura <strong>di</strong> Padrone-Servo. La Logica. La Filosofia della Natura. La Filosofia dello Spirito. Lo Spirito ( Idea<br />
in sé e per sé ). La Natura dello Stato. La Natura della Storia e la filosofia della Storia. Lo Spirito Assoluto:<br />
Arte, Religione e Filosofia<br />
Letture Fenomenologia dello Spirito:La Natura del Sapere Scientifico e l’ Assoluto come Spirito -<br />
L’elemento e la figura vera della verità. Concetto e il sistema scientifico, L’Assoluto come soggetto e come<br />
risultato. Il Ruolo della Fenomenologia dello Spirito – La fenomenologia dello spirito è l’elevazione fino alla<br />
scienza Enciclope<strong>di</strong>a delle Scienze Filosofiche in compen<strong>di</strong>o: Le Articolazioni dell’elemento logico e la<br />
Dialettica. La Concezione hegeliana della Natura – Esteriorità come determinazione fondamentale della<br />
Natura, Sul carattere <strong>di</strong>vino della Natura. Lo Spirito nei suoi tre momenti<br />
DESTRA E SINISTRA HEGELIANA – Problemi<br />
LA SINISTRA HEGELIANA<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 23/38
LUDWIG FEUERBACH - Vita e Opere. La Riduzione della Teologia ad Antropologia. L’”Umanesimo <strong>di</strong><br />
Feuerbach”<br />
Letture L’Essenza del Cristianesimo: La Teologia è antropologia<br />
KARL MARX - Vita e Opere. Marx critico: <strong>di</strong> Hegel, della sinistra hegeliana, degli economisti classici,<br />
del Socialismo utopistico, <strong>di</strong> Proudhon. I limiti <strong>di</strong> Feuerbach. I temi: L’alienazione del lavoro, il<br />
materialismo storico, il Materialismo <strong>di</strong>alettico, La lotta <strong>di</strong> Classe. Il Plusvalore. L’avvento del Comunismo e<br />
i passaggi necessari. La Dittatura del Proletariato.<br />
Letture Per la Critica della Filosofia del Diritto <strong>di</strong> Hegel: La Religione è oppio del popolo K. MARX –<br />
F. ENGELS L’Ideologia Tedesca: Il Materialismo storico. Le Idee della Classe dominante sono sempre le<br />
Idee dominanti.<br />
K. MARX – F. ENGELS Il Manifesto Lettura Integrale<br />
K. MARX Miseria della Filosofia: La Struttura economica determina la struttura ideologica Il Capitale Il<br />
Materialismo <strong>di</strong>alettico<br />
I GRANDI CONTESTATORI DEL SISTEMA HEGELIANO<br />
ARTHUR SCHOPENAUER Vita e Opere . Il Mondo come rappresentazione. Il Mondo come Volontà. Il<br />
Dolore e la Noia. Liberazione e Redenzione : Arte e Ascesi. La Noluntas<br />
Letture Il Mondo come Volontà e Rappresentazione: Il Mondo è una mia Rappresentazione La Vita <strong>di</strong><br />
ogni singolo è sempre una trage<strong>di</strong>a La Base <strong>di</strong> ogni volere è bisogno, mancanza, ossia dolore<br />
SOREN KIERKEGAARD Vita e Opere. L’Opera <strong>di</strong> Kierkegaard “poeta cristiano” e i suoi temi <strong>di</strong> fondo.<br />
La Categoria del Singolo. Cristo: irruzione dell’ eterno nel tempo. Possibilità, angoscia e <strong>di</strong>sperazione.<br />
Contro la scienza e lo scientismo. K. Contro la Teologia scientifica<br />
Letture Aut - Aut: Sta<strong>di</strong>o Estetico Sta<strong>di</strong> sul Cammino della Vita: Sta<strong>di</strong>o Etico Timore e Tremore: Sta<strong>di</strong>o<br />
Religioso Diario: Il Singolo<br />
POSITIVISMO – Lineamenti generali - Sintesi<br />
CHARLES DARWIN Vita e Opere. La selezione naturale. Confronto Teorie Lamarck – Darwin. La teoria<br />
evoluzionistica.<br />
Letture L’origine delle specie La Selezione naturale<br />
HERBERT SPENCER L’ Evoluzionismo come metafisica. Il ruolo della Scienza, la <strong>di</strong>mensione misteriosa<br />
Ottimismo e progresso. Complementarietà <strong>di</strong> Scienza e religione.<br />
Letture I Primi Principi Non c’è antagonismo tra scienza e religione<br />
AUGUSTE COMTE e il Positivismo Sociologico – La Legge dei tre sta<strong>di</strong>. La dottrina della scienza. La<br />
Sociologia come fisica sociale. La classificazione delle scienze. La religione dell’umanità<br />
Letture Corso <strong>di</strong> filosofia positiva La Legge dei tre sta<strong>di</strong>; La costruzione della sociologia come fisica<br />
sociale<br />
LA FILOSOFIA DALL’OTTOCENTO AL NOVECENTO<br />
FRIEDRICH NIETZSCHE – Vita e Opere. Dionisiaco, Apollineo e Problema Socrate . La Concezione<br />
della Storia. Il Prospettivismo. Il Distacco da Schopenhauer e Wagner. La Morte <strong>di</strong> Dio. L’Anticristo. La<br />
Genealogia della morale. Il Nichilismo. L’Eterno Ritorno e l’Amor Fati. Necessità e Volontà. Il Superuomo.<br />
Letture La Nascita della Trage<strong>di</strong>a - Lettura integrale<br />
La Gaia Scienza: L’Annuncio della Morte <strong>di</strong> Dio Al<strong>di</strong>là del Bene e del Male: La morale dei signori e la<br />
morale degli schiavi<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 24/38
HENRI BERGSON – Vita e Opere. L’originalità dello Spiritualismo <strong>di</strong> Bergson. Il Tempo spazializzato e il<br />
Tempo durata. Durata e Libertà. Materia e memoria. Slancio vitale ed evoluzione creatrice<br />
Letture Saggio sui dati imme<strong>di</strong>ati della coscienza: In che cosa consiste la durata reale<br />
L’ Evoluzione Creatrice Slancio vitale e adattamento all’ ambiente<br />
LA PSICOANALISI<br />
SIGMUND FREUD e la PSICOANALISI. FREUD – Vita e Opere. Dall’ Ipnotismo alla Psicoanalisi.<br />
Inconscio, rimozione, censura e interpretazione dei sogni. Il concetto <strong>di</strong> libido. La sessualità infantile. Il<br />
complesso <strong>di</strong> E<strong>di</strong>po. Tecniche terapeutiche. La teoria del Transfert. La struttura dell’apparato psichico: Es,<br />
Ego, Super-Ego. Lotta tra Eros e Thanatos<br />
Letture La mia vita e la psicanalisi La Scoperta della “rimozione” e dell’ “Inconscio”<br />
Libro <strong>di</strong> Testo G. REALE- D. ANTISERI Storia della Filosofia vol. 2 La Scuola; Storia della Filosofia<br />
vol. 3 La Scuola<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 25/38
STORIA<br />
SOCIETA’ BORGHESE E MOVIMENTO OPERAIO - La borghesia europea. Ottimismo borghese<br />
e cultura positiva. Lo sviluppo economico. La rivoluzione dei trasporti. La città moderna. Il proletariato<br />
urbano e il movimento operaio dopo il ’48. In collegamento a filosofia: Marx e Il Socialismo Scientifico e la<br />
Teoria del valore-lavoro. Bakunin e il Comunismo Anarchico. l’Internazionale dei Lavoratori. Il mondo<br />
cattolico <strong>di</strong> fronte alla società borghese.<br />
Letture K. MARX – F. ENGELS, Il Manifesto del Partito Comunista Lettura integrale<br />
I PROBLEMI DELL’ UNIFICAZIONE - L’ Italia nel 1861. La classe <strong>di</strong>rigente: Destra e Sinistra. Lo<br />
Stato accentrato, Il Mezzogiorno, il Brigantaggio. La politica economica: i costi dell’unificazione nazionale.<br />
Il completamento dell’ unità: la III Guerra d’ In<strong>di</strong>pendenza e la Presa <strong>di</strong> Roma.<br />
Letture G. CANDELORO Storia dell’ Italia moderna vol. V Le cause del Brigantaggio<br />
L’ EUROPA DELLE GRANDI POTENZE – La lotta per l’egemonia continentale. La Francia del II<br />
Impero. La Guerra <strong>di</strong> Crimea. Il declino dell’ Impero asburgico e l’ ascesa della Prussia. La Guerra Franco-<br />
Prussiana e l’ unificazione tedesca. Le conseguenze della guerra: La Comune <strong>di</strong> Parigi e il revanscismo. La<br />
svolta del 1870 e l’equilibrio bismarckiano. La Germania imperiale. La Terza Repubblica in Francia. L’<br />
Inghilterra vittoriana. La Russia <strong>di</strong> Alessandro II<br />
E. ANCHIERI Antologia storico-<strong>di</strong>plomatica La Triplice Alleanza<br />
IMPERIALISMO E COLONIALISMO – La febbre coloniale. Colonizzatori e colonizzati. L’espansione<br />
in Asia. La spartizione dell’ Africa. Il Sud Africa e la Guerra anglo-boera.<br />
Letture G. CARROCCI L’ Età dell’ Imperialismo Una definizione dell’ Imperialismo<br />
V.I. LENIN L ‘Imperialismo fase suprema del Capitalismo pp. Scelte<br />
E. J. HOBSBAWM L’ Età degli Imperi Una spiegazione del Colonialismo<br />
J. R. KIPLING The White Man’s Burden ( Il fardello dell’ uomo bianco )<br />
LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE - Il Capitalismo a una svolta: concentrazioni,<br />
protezionismo, imperialismo. La crisi agraria e le sue conseguenze. Scienza e tecnologia. Le nuove industrie.<br />
Motori a scoppio e elettricità.<br />
VERSO LA SOCIETA’ DI MASSA – Che cos’è la società <strong>di</strong> massa. Sviluppo industriale e<br />
razionalizzazione produttiva. Istruzione e formazione. Suffragio universale, partiti <strong>di</strong> massa, sindacati. La<br />
questione femminile. I Partiti Socialisti e la II Internazionale. I Cattolici e la Rerum Novarum<br />
Letture H. FORD La mia vita e la mia opera – Catena <strong>di</strong> montaggio e <strong>di</strong>sciplina sociale<br />
L’ ITALIA GIOLITTIANA – Precedenti: La crisi <strong>di</strong> fine secolo – La svolta liberale. Decollo industriale e<br />
progresso civile. La questione meri<strong>di</strong>onale. I governi Giolitti e le riforme. Il Giolittismo e i suoi critici. La<br />
politica estera, il nazionalismo, la guerra <strong>di</strong> Libia. La crisi del sistema giolittiano.<br />
Letture Discorsi parlamentari Il governo e le classi lavoratrici<br />
LA PRIMA GUERRA MONDIALE – Le cause. Dall’ attentato a Sarajevo alla guerra europea. Dalla<br />
guerra <strong>di</strong> movimento alla guerra <strong>di</strong> usura. L’ Italia dalla neutralità all’intervento. La grande strage (1915-<br />
’16). La guerra nelle trincee. La svolta del ’17. L’Italia e il <strong>di</strong>sastro <strong>di</strong> Caporetto. L’ultimo anno <strong>di</strong> guerra. I<br />
trattati <strong>di</strong> pace e la nuova carta d’ Europa. - V. Approfon<strong>di</strong>menti 1 -<br />
Letture E. ANTICHIERI Antologia storico-<strong>di</strong>plomatica “I 14 punti”<strong>di</strong> Wilson<br />
LA RIVOLUZIONE RUSSA – LA Rivoluzione russa. Da febbraio ad ottobre. La Rivoluzione d’Ottobre.<br />
Dittatura e guerra civile. La III Internazionale. Dal Comunismo <strong>di</strong> Guerra alla Nep<br />
Letture V.I. Lenin Le Tesi <strong>di</strong> Aprile<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 26/38
IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO – I problemi del dopoguerra. La<br />
vittoria mutilata e l’impresa fiumana. Le agitazioni sociali e le elezioni del ’19. Il Biennio rosso. Giolitti, il<br />
trattato <strong>di</strong> Rapallo; l’occupazione delle fabbriche e la nascita del PCI. Il fascismo agrario e le elezioni del’21.<br />
L’agonia dello <strong>stato</strong> liberale. La marcia su Roma. Verso lo Stato autoritario. Il delitto Matteotti e l’Aventino.<br />
La <strong>di</strong>ttatura a viso aperto.<br />
Letture A. TASCA Nascita e avvento del Fascismo Lo squadrismo fascista e la sconfitta socialista<br />
L’ ITALIA FASCISTA - Il totalitarismo imperfetto. Il regime e il Paese. Cultura Scuola Comunicazioni <strong>di</strong><br />
massa. Il Fascismo e l’economia: la battaglia del grano e “ quota novanta”. Il Fascismo e la grande crisi: lo<br />
Stato impren<strong>di</strong>tore. L’Imperialismo fascista e l’impresa <strong>di</strong> Etiopia<br />
ECONOMIA E SOCIETA’NEGLI ANNI TRENTA – Crisi e trasformazione Dall’ euforia del I<br />
dopoguerra alla Grande Depressione. Il crack del 1929. La crisi in Europa, in particolare in Germania. La<br />
risposta americana alla crisi: Roosevelt e il New Deal. Il nuovo ruolo dello Stato. Le Teorie <strong>di</strong> Keynes. I<br />
nuovi consumi<br />
Letture J.M. KEYNES Teoria generale dell’ occupazione La fine del “laissez-faire”<br />
IL CONTAGIO AUTORITARIO – La crisi dei regimi liberali in Europa; Il caso della Spagna la reazione<br />
del Fronte Popolare; Il colpo <strong>di</strong> Stato del generale Franco La Guerra <strong>di</strong> Spagna<br />
L’ ETA’ DEI TOTALITARISMI – La Crisi della Repubblica <strong>di</strong> Weimar e l’avvento del Nazismo. IL<br />
NAZISMO consolidamento del potere <strong>di</strong> Hitler. Il Terzo Reich. Repressione e consenso nel regime nazista:<br />
L’Europa verso la catastrofe. Politica estera <strong>di</strong> Hitler e politica dell’ appeasement in Inghilterra e in<br />
Europa. La conferenza <strong>di</strong> Monaco. L’ Antisemitismo – v. Approfon<strong>di</strong>menti 2 -<br />
Letture H. ARENDT Le origini del totalitarismo pagine scelte<br />
C. J. FRIEDRICH Z. K. BRZEZINSKJ Dittatura totalitaria e autocrazia I Caratteri del Totalitarismo<br />
A. HITLER Mein Kampf Un manifesto dell’antisemitismo<br />
LA SECONDA GUERRA MONDIALE – Le origini e le responsabilità. La <strong>di</strong>struzione della Polonia e<br />
l’offensiva al Nord. L’attacco a Occidente e la caduta della Francia. L’intervento dell’ Italia. La Battaglia d’<br />
Inghilterra. Il fallimento della guerra italiana: i Balcani e il Nord Africa. L’attacco all’ Unione<br />
Sovietica. L’aggressione giapponese e il coinvolgimento degli Stati Uniti. L’apogeo dell’espansione<br />
nazista in Europa.<br />
La persecuzione degli Ebrei e la “soluzione finale”. La Battaglia <strong>di</strong> Stalingrado. 1942-1943: la svolta della<br />
guerra e la “grande alleanza”. Lo Sbarco degli Alleati in Italia. La caduta del Fascismo e l’8 Settembre.<br />
Resistenza e lotta politica in Italia. Le vittorie sovietiche e lo sbarco in Norman<strong>di</strong>a. La fine del Terzo Reich.<br />
La sconfitta del Giappone e la bomba atomica.<br />
Letture T. HARA Lettera da Hiroshima<br />
G. BOCCA Storia dell’ Italia Partigiana Alle Origini della Resistenza Italiana<br />
Bella Ciao Testo della canzone ( Anonimo )<br />
IL MONDO DIVISO Le conseguenze della seconda guerra mon<strong>di</strong>ale. Le Nazioni Unite e il nuovo or<strong>di</strong>ne<br />
economico. La fine della “grande alleanza”. La guerra fredda e la <strong>di</strong>visione dell’ Europa.<br />
Letture Statuto Nazioni Unite articoli 1, 2; Dichiarazione dei Diritti dell’uomo articoli 1, 2, 3, 4, 5<br />
D. YERGIN La pace in frantumi Il blocco <strong>di</strong> Berlino<br />
L’ ITALIA REPUBBLICANA – Dalla liberazione alla Repubblica. La Costituzione repubblicana. Le<br />
elezioni del ’48 e la sconfitta delle sinistre. La ricostruzione economica. Il trattato <strong>di</strong> pace e le scelte<br />
internazionali. I governi De Gasperi e la politica centrista. Il Miracolo economico. Le trasformazioni sociali.<br />
Il ’68 e l’autunno caldo. La crisi del centro-sinistra. Terrorismo e solidarietà nazionale. V. Approfon<strong>di</strong>menti<br />
3<br />
Letture La Costituzione Italiana articoli: 1 – 2 – 3 - 7 – 8 -11 – 13 - 21 – 27 -49<br />
V. CASTRONOVO L’ Industria italiana dall’ Ottocento ad oggi Il miracolo economico<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 27/38
APPROFONDIMENTI<br />
1 - Visita Guidata alla Mostra “ La Grande Guerra” a cura del Associazione ARIES e del Comune <strong>di</strong><br />
Rimini Visione del Film La Grande Guerra - Mario Monicelli - Italia 1959<br />
23 ott. 20<strong>09</strong><br />
2 - Laboratorio sulle Leggi Razziali in Italia a cura della Dott.ssa Francesca Panozzo per l’Istituto Storico<br />
della Resistenza. 13 genn. 20<strong>09</strong> Letture e Analisi dei Documenti<br />
Regio Decreto-Legge 17 nov.1938 Provve<strong>di</strong>menti per la <strong>di</strong>fesa della razza italiana<br />
Manifesto degli Scienziati Razzisti in “La Difesa della razza” 5 ago. 1938<br />
Regio Decreto-Legge 5 Sett. 1938 Provve<strong>di</strong>menti per la <strong>di</strong>fesa della razza nella scuola fascista<br />
Scheda personale <strong>di</strong> censimento degli Ebrei in Italia 19 nov.1938 + Alcune schede compilate<br />
Circolari ai Capi d’Istituto, Ispettori Scolastici, Direttori Didattici 1) Dell’ 11 ago. 1938 Oggetto: Rivista<br />
“La <strong>di</strong>fesa della razza”- Diffusione 2)Del 26 ago. 1938 Oggetto: Divieto <strong>di</strong> adozione nella scuola <strong>di</strong> libri <strong>di</strong><br />
testo <strong>di</strong> autori <strong>di</strong> razza ebraica 3) Del 15 nov. 1938 Oggetto: Alunni <strong>di</strong> razza ebraica<br />
Incontro con un testimone della persecuzione degli Ebrei in Italia: <strong>Cesare</strong> Finzi ( Giornata della<br />
Memoria ) a cura dell’ Istituto Storico della Resistenza e del Comune <strong>di</strong> Rimini 27 genn. 20<strong>09</strong><br />
3 - “Tra violenza ed utopia- Riflettendo sugli anni ‘70”- Ciclo <strong>di</strong> Incontri a cura dell’ Istituto Storico della<br />
Resistenza<br />
CINZIA VENTUROLI ( Direttrice CEDOST ) “La Strage <strong>di</strong> Bologna a partire dalle persone”<br />
12 nov. <strong>2008</strong><br />
EMILIANO VISCONTI( Esperto musica pop) “Musica e politica negli anni ‘70”<br />
2 <strong>di</strong>c. <strong>2008</strong><br />
RAIMONDO CATANZARO ( Sociologo – Docente Università <strong>di</strong> Bologna ) “Vecchie e nuove Brigate<br />
Rosse”<br />
17 febb20<strong>09</strong><br />
“ ’70 VolteSud” Spettacolo Teatrale <strong>di</strong> Salvatore Arena e Massimo Barilla sui Moti <strong>di</strong> Reggio Calabria ‘70<br />
23 genn. 20<strong>09</strong><br />
La Resistenza Visione del film “Il Partigiano Johnny” Guido Chiesa Italia 2000<br />
24 apr. 20<strong>09</strong><br />
Libro <strong>di</strong> Testo A. GIARDINA G. SABBATUCCI V. VIDOTTO Profili Storici vol. 2; Profili Storici vol. 3<br />
Laterza<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 28/38
THE ROMANTIC AGE<br />
Revision of the Romantic poets:<br />
William Wordsworth<br />
from the Preface to Lyrical Ballads<br />
A Certain Colouring of Imagination<br />
from Lyrical Ballads<br />
We are Seven<br />
from Poems in Two Vplumes<br />
Daffo<strong>di</strong>ls<br />
from Sonnets<br />
Composed upon Westminster Abbey<br />
Samuel Coleridge<br />
from the Preface to Lyrical Ballads<br />
Poetry and Imagination<br />
from the Rime of the Ancient Mariner<br />
Part I<br />
Part III<br />
George Gordon Byron<br />
from Don Juan<br />
Search, then the Room<br />
Percy Bysshe Shelley<br />
Ode to the West Wind<br />
John Keats<br />
Ode on a Grecian Urn<br />
THE GOTHIC NOVEL<br />
Mary Shelley<br />
Lettura integrale <strong>di</strong> Frankenstein<br />
THE ROMANTIC NOVEL<br />
Jane Austen<br />
from Sense and Sensibility<br />
He was rich and she was handsome<br />
Willoughby turns Marian down<br />
from Pride and Preju<strong>di</strong>ce<br />
Darcy’s proposal<br />
Elisabeth’s self-realisation<br />
Edgar Alan Poe<br />
The black cat<br />
LINGUA INGLESE<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 29/38
THE VICTORIAN AGE<br />
The Historical context<br />
Queen Victoria’s accession to the throne<br />
The later years of Queen Victoria’s reign<br />
The British Empire<br />
The social context<br />
A nation of town dwellers<br />
The world picture<br />
The Victorian compromise<br />
An American insight<br />
From the Civil War to the Frontier<br />
The literary context<br />
Aestheticism and Decadence<br />
The rebirth of Theatre<br />
Authors and texts<br />
Charles Dickens<br />
from David Copperfield<br />
The first days at school<br />
Murdstone and Grinsby’s warehouse<br />
The Bronte Sisters<br />
Emily Bronte<br />
from Wuthering Weights<br />
Back to Wuthering Weights<br />
I am Heathcliff<br />
Oscar Wilde<br />
from the Picture of Dorian Gray<br />
The Picture<br />
Dorian’s death<br />
from the Importance of being Earnest<br />
Deceits, tea and muffins<br />
George Bernard Shaw<br />
from Mrs Warren’s profession<br />
Mother and daughter<br />
THE MODERN AGE<br />
The historical context<br />
From Edward VII to World War I<br />
Britain at war<br />
The Twenties and Thirties<br />
World War II<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 30/38
The social context<br />
The Edwar<strong>di</strong>ans<br />
Between the wars<br />
The world picture<br />
The age of anxiety<br />
The literary context<br />
Revolt and experimentation<br />
The <strong>di</strong>vided consciousness<br />
A new realism<br />
The interior monologue<br />
Authors and texts<br />
The War Poets<br />
R. Brooke<br />
The Sol<strong>di</strong>er<br />
S. Sassoon<br />
Glory of Women<br />
Wystan Hugh Auden<br />
Refugees Blues<br />
James Joyce<br />
from Dubliners<br />
Eveline<br />
The Dead<br />
Virginia Woolf<br />
from Mrs Dalloway<br />
The Party<br />
from To the Lighthouse<br />
1 chapter<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 31/38
Il GOTICO INTERNAZIONALE<br />
Pisanello: affresco <strong>di</strong> San Giorgio e medaglie;<br />
STORIA DELL’ARTE<br />
Il Rinascimento (XV secolo)<br />
Il Rinascimento a Firenze (prima metà del XV secolo)<br />
-Il concorso per la Porta del Battistero (formelle <strong>di</strong> Ghiberti e Brunelleschi)<br />
- Filippo Brunelleschi: Cupola del Duomo <strong>di</strong> Firenze, Spedale degli Innocenti, Basilica <strong>di</strong> San Lorenzo,<br />
Sacrestia vecchia.<br />
- Donatello: San Giorgio, David, Cantoria del Duomo <strong>di</strong> Firenze.<br />
- Masaccio: Affreschi della Cappella Brancacci, Trinità <strong>di</strong> S. M. Novella, Sant’Anna Metterza;<br />
-Luca della Robbia: terracotte invetriate degli Innocenti e cantoria in marmo;<br />
- Leon Battista Alberti: Facciata della Chiesa <strong>di</strong> Santa Maria Novella e Palazzo Ruccellai; riflessioni sulla<br />
figura dell’intellettuale artista e sulla tipologia del palazzo fiorentino.<br />
- Sandro Botticelli: Nascita <strong>di</strong> Venere, Primavera, Compianto sul corpo <strong>di</strong> Cristo.<br />
Il Rinascimento in altri centri italiani (seconda metà del XV secolo)<br />
PADOVA:<br />
Statua equestre <strong>di</strong> Gattamelata ed Altare <strong>di</strong> Sant’Antonio a Padova <strong>di</strong> Donatello<br />
-Piero della Francesca e la <strong>di</strong>ffusione dell'arte prospettica: affresco <strong>di</strong> Rimini, Battesimo <strong>di</strong> Cristo, Storie<br />
della vera croce <strong>di</strong> Arezzo, Flagellazione, Ritratti dei duchi <strong>di</strong> Urbino, Pala dei Montefeltro.<br />
-La pittura ad olio: tecnica ed analisi del <strong>di</strong>pinto <strong>di</strong> Jan van Eyck (Coniugi Arnolfini).<br />
- RIMINI:<br />
Il Tempio Malatestiano: Leon Battista Alberti, Matteo de Pasti, Agostino <strong>di</strong> Duccio.<br />
MANTOVA:<br />
le chiese <strong>di</strong> Sant'Andrea e <strong>di</strong> San Sebastiano <strong>di</strong> Leon Battista Alberti;<br />
la Camera degli sposi <strong>di</strong> Andrea Mantegna ed altre opere (Pala <strong>di</strong> San Zeno, Cristo morto).<br />
URBINO:<br />
Il Palazzo Ducale (struttura architettonica e stu<strong>di</strong>olo <strong>di</strong> Federico da Montefeltro).<br />
-L’influsso della pittura fiamminga e l’opera <strong>di</strong> Antonello da Messina (San Girolamo nello stu<strong>di</strong>o, San<br />
Sebastiano).<br />
VENEZIA: l'opera <strong>di</strong> Giovanni Bellini (Pala <strong>di</strong> San Zaccaria, Ritratto del Doge Loredan, Pala <strong>di</strong> Pesaro).<br />
IL RINASCIMENTO MATURO (XVI SECOLO)<br />
La grande stagione della pittura veneta<br />
-Giorgione: La Pala <strong>di</strong> Castelfranco, Tempesta, Venere;<br />
-Tiziano: Assunta e Venere <strong>di</strong> Urbino, L’uomo col guanto.<br />
La maniera moderna<br />
Introduzione: l’importanze delle “Vite de’ più eccellenti architetti, pittori e scultori italiani” <strong>di</strong> Giorgio<br />
Vasari<br />
Leonardo da Vinci: l’attività grafica, Adorazione dei Magi, Battaglia <strong>di</strong> Anghiari, Dama con<br />
l’ermellino, Vergine delle rocce, Ultima cena, Gioconda.<br />
-Raffaello Sanzio: Sposalizio della Vergine, Ritratto <strong>di</strong> Maddalena Strozzi, Stanze vaticane, Leone<br />
X con due car<strong>di</strong>nali, Trasfigurazione.<br />
- Michelangelo Buonarroti: Pietà <strong>di</strong> San Pietro, David, Mosé, Prigioni, Tondo Doni, affreschi<br />
della Cappella Sistina (volta e Giu<strong>di</strong>zio Universale), Biblioteca Laurenziana e Sacrestia Nuova (S.Lorenzo,<br />
Firenze), Cupola <strong>di</strong> S.Pietro e Piazza del Campidoglio (Roma)<br />
- Il Manierismo: caratteri generali, Deposizione <strong>di</strong> Pontormo, Fontana del Nettuno e Ratto delle Sabine <strong>di</strong><br />
Giambologna, Perseo <strong>di</strong> Benvenuto Cellini.<br />
IL SEICENTO E IL SETTECENTO<br />
Il classicismo bolognese<br />
-L’Accademia degli Incamminati;<br />
-Il Mangiafagioli e la Volta <strong>di</strong> Palazzo Farnese <strong>di</strong> Annibale Carraci;<br />
Il naturalismo<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 32/38
-Michelangelo Merisi da Caravaggio: Ragazzo morso da un ramarro, Medusa, David con la testa <strong>di</strong> Golia,<br />
Canestra <strong>di</strong> frutta, Vocazione <strong>di</strong> San Matteo, Morte della Vergine;<br />
Il Barocco<br />
-Gian Lorenzo Bernini Apollo e Dafne, Ratto <strong>di</strong> Proserpina, Baldacchino <strong>di</strong> San Pietro, Estasi <strong>di</strong> Santa<br />
Teresa, Piazza San Pietro, Fontana dei fiumi in Piazza Navona;<br />
-Francesco Borromini: San Carlo alle Quattro fontane<br />
Cenni all’architettura Rococò: la Palazzina <strong>di</strong> Stupinigi <strong>di</strong> Juvarra e la Reggia <strong>di</strong> Caserta del Vanvitelli;<br />
Il Neoclassicimo:<br />
-Antonio Canova: Amore e Psiche, Paolina Borghese, Ebe, Il monumento a Maria Cristina d’Austria;<br />
L’OTTOCENTO<br />
Le correnti pittoriche ottocentesche attraverso le opere <strong>di</strong> importanti maestri:<br />
Il romanticismo (Turner e Friederich), L’impressionismo (E. Manet, C. Monet, E. Degas, A.<br />
Renoir) Il Post-impressionismo (P. Cézanne,P. Gauguin, Vincent Van Gogh).<br />
*IL NOVECENTO<br />
Breve excursus sulle avanguar<strong>di</strong>e del primo Novecento<br />
l’espressionismo (fauvismo francese), il cubismo (P. Picasso, G. Braque), il futurismo (U. Boccioni e<br />
G. Severini), l’astrattismo (V. Kan<strong>di</strong>nskji), il surrealismo (S. Dalì e R. Magritte).<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 33/38
MATEMATICA<br />
TRIGONOMETRIA<br />
Funzioni goniometriche e loro rappresentazione grafica; relazioni fondamentali tra seno, coseno e tangente <strong>di</strong><br />
uno stesso arco; archi associati, archi complementari, supplementari, esplementari. Valori delle funzioni<br />
goniometriche per archi particolari.<br />
Formule <strong>di</strong> ad<strong>di</strong>zione, sottrazione, duplicazione. Formule parametriche per il seno e il coseno (in funzione<br />
della tangente <strong>di</strong> x/2).Equazioni goniometriche.<br />
Teoremi sui triangoli rettangoli; teorema dell’area del triangolo, teorema dei seni, teorema del coseno (tutti i<br />
teoremi senza <strong>di</strong>mostrazione).<br />
Applicazione dei teoremi stu<strong>di</strong>ati a semplici problemi <strong>di</strong> geometria piana.<br />
ANALISI MATEMATICA<br />
Definizione <strong>di</strong> funzione, funzioni perio<strong>di</strong>che, funzioni pari o <strong>di</strong>spari, funzioni composte, funzioni monotone.<br />
Limite finito per una funzione in un punto, limite infinito per una funzione in un punto, limite destro e limite<br />
sinistro, definizione <strong>di</strong> limite per una funzione all’infinito;<br />
teorema dell’unicità del limite,teorema della permanenza del segno, teorema del confronto (senza<br />
<strong>di</strong>mostrazione ) .<br />
Due limiti notevoli, operazioni sui limiti.<br />
Definizione <strong>di</strong> funzione continua.<br />
Teoremi sulle funzioni continue: teorema <strong>di</strong> esistenza degli zeri, teorema <strong>di</strong> Bolzano-Weierstrass (senza<br />
<strong>di</strong>mostrazione);<br />
Calcolo <strong>di</strong> limiti e forme indeterminate.<br />
Punti <strong>di</strong> <strong>di</strong>scontinuità <strong>di</strong> prima, <strong>di</strong> seconda e <strong>di</strong> terza specie.<br />
Definizione <strong>di</strong> derivata, derivate fondamentali, calcolo <strong>di</strong> derivate: derivata del prodotto <strong>di</strong> una costante per<br />
una funzione, della somma <strong>di</strong> funzioni,del prodotto <strong>di</strong> funzioni, della potenza <strong>di</strong> una funzione,del quoziente<br />
<strong>di</strong> due funzioni; derivata della funzione composta , derivata <strong>di</strong> una funzione esponenziale , logaritmica , delle<br />
funzioni goniometriche senx, cosx, tgx.<br />
Derivate <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne superiore al primo, teorema <strong>di</strong> Lagrange, teorema <strong>di</strong> Rolle, regola <strong>di</strong> De L’Hospital (senza<br />
<strong>di</strong>mostrazione).<br />
Massimi, minimi e flessi delle funzioni, ricerca <strong>di</strong> massimi, minimi, flessi orizzontali me<strong>di</strong>ante lo stu<strong>di</strong>o del<br />
segno della derivata prima; stu<strong>di</strong>o del segno della derivata seconda e ricerca <strong>di</strong> flessi a tangente obliqua.<br />
Asintoto orizzontale, asintoto verticale, asintoto obliquo.<br />
Stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> funzione per funzioni polinomiali intere e fratte, irrazionali, esponenziali, logaritmiche.<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 34/38
FISICA<br />
TERMOLOGIA E TERMODINAMICA<br />
Definizione operativa <strong>di</strong> temperatura e scala termometrica Celsius , <strong>di</strong>latazione dei soli<strong>di</strong> dei liqui<strong>di</strong> e dei gas<br />
, comportamento anomalo dell’acqua.<br />
Sistemi termo<strong>di</strong>namici e gas perfetti.<br />
Prima e seconda legge <strong>di</strong> Gay-Lussac , legge <strong>di</strong> Boyle , equazione <strong>di</strong> <strong>stato</strong> dei gas perfetti, temperatura<br />
assoluta .<br />
Teoria cinetica dei gas, relazione tra temperatura assoluta ed energia cinetica me<strong>di</strong>a (senza <strong>di</strong>mostrazione) .<br />
L’esperimento <strong>di</strong> Joule,capacità termica e calore specifico, propagazione del calore: conduzione,<br />
convezione, irraggiamento.<br />
Sistema termo<strong>di</strong>namico,equilibrio termo<strong>di</strong>namico,principio zero della termo<strong>di</strong>namica,trasformazioni<br />
termo<strong>di</strong>namiche(isobare,isocore,isoterme,a<strong>di</strong>abatiche), lavoro in una trasformazione , energia interna e primo<br />
principio della termo<strong>di</strong>namica , applicazioni del primo principio alle trasformazioni stu<strong>di</strong>ate.<br />
Enunciati <strong>di</strong> Clausius e Kelvin del secondo principio della termo<strong>di</strong>namica, ren<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> una macchina termica,<br />
trasformazioni reversibili e trasformazioni irreversibili, teorema <strong>di</strong> Carnot (senza <strong>di</strong>mostrazione), ciclo <strong>di</strong> Carnot,<br />
ren<strong>di</strong>mento delle macchine termiche che lavorano tra due temperature.<br />
La <strong>di</strong>suguaglianza <strong>di</strong> Clausius, concetto <strong>di</strong> entropia,entropia <strong>di</strong> un sistema isolato, terzo principio della<br />
termo<strong>di</strong>namica .<br />
ELETTROSTATICA E CORRENTI ELETTRICHE<br />
Fenomeni <strong>di</strong> elettricità statica , interazione tra corpi elettrizzati , elettrizzazione per strofinio, contatto,<br />
induzione , elettroscopio , conduttori ed isolanti , la carica elettrica, legge <strong>di</strong> Coulomb.<br />
Definizione <strong>di</strong> campo elettrico e sua rappresentazione , flusso del campo elettrico e teorema <strong>di</strong> Gauss.<br />
Applicazioni del teorema <strong>di</strong> Gauss: <strong>di</strong>stribuzione della carica sulla superficie <strong>di</strong> un conduttore e campo<br />
elettrico <strong>di</strong> una sfera cava.<br />
Energia potenziale elettrica , definizione <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> potenziale elettrico, potenziale <strong>di</strong> una carica<br />
puntiforme , superfici equipotenziali, , circuitazione del campo elettrostatico.<br />
Equilibrio elettrostatico, campo elettrico e potenziale <strong>di</strong> un conduttore in equilibrio elettrostatico, capacità<br />
<strong>di</strong> un conduttore, capacità <strong>di</strong> un condensatore piano.<br />
Definizione <strong>di</strong> corrente elettrica e sua unità <strong>di</strong> misura , prima legge <strong>di</strong> Ohm, resistenze in serie e in parallelo<br />
,condensatori in serie ed in parallelo, potenza elettrica, seconda legge <strong>di</strong> Ohm, effetto Joule.<br />
CAMPO MAGNETICO<br />
Il campo magnetico e le linee <strong>di</strong> campo.<br />
Esperienza <strong>di</strong> Oersted, esperienza <strong>di</strong> Faraday, esperienza <strong>di</strong> Ampère.<br />
Forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso da corrente, campo magnetico generato da un<br />
filo percorso da corrente.<br />
Campo magnetico <strong>di</strong> una spira e <strong>di</strong> un solenoide (solo linee <strong>di</strong> forza). Il motore elettrico.<br />
La forza <strong>di</strong> Lorentz, il flusso del campo magnetico, la circuitazione del campo magnetico.<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 35/38
SCIENZE E GEOGRAFIA ASTRONOMICA<br />
Astronomia<br />
- Teoria del Big Bang. La Terra inserita nello spazio. L’Unità <strong>di</strong> misura astronomica e l’anno-luce. La<br />
sfera celeste e le costellazioni. Gli elementi <strong>di</strong> riferimento sulla sfera celeste. Coor<strong>di</strong>nate astronomiche.<br />
Movimenti apparenti degli astri sulla sfera celeste.<br />
- La luminosità delle stelle e le classi <strong>di</strong> magnitu<strong>di</strong>ne. Colore e temperatura delle stelle. L’analisi<br />
spettrale della luce stellare. Effetto Doppler. Volume e massa stellare. Il <strong>di</strong>agramma H-R. Nascita, vita<br />
e morte <strong>di</strong> una stella.<br />
- Le galassie dell’Universo. Galassie in movimento. La Via Lattea. Il red shift delle galassie e la<br />
scoperta dell’espansione dell’Universo.<br />
- Il Sistema Solare. Origine del S.S.. Corpi in movimento uniti dalla forza <strong>di</strong> gravità. Le tre leggi <strong>di</strong><br />
Keplero. Le principali caratteristiche dei pianeti terrestri e gioviani. Asteroi<strong>di</strong>, comete, meteore e<br />
meteoriti.<br />
Il pianeta Terra<br />
- Forma, <strong>di</strong>mensione e proprietà fisiche della Terra. Il moto <strong>di</strong> rotazione e le sue conseguenze:<br />
alternarsi del dì e della notte, moto apparente della sfera celeste, la forza centrifuga e le variazione<br />
dell’accelerazione <strong>di</strong> gravità, la forza <strong>di</strong> Coriolis. Prova della rotazione: esperienza <strong>di</strong> Guglielmini.<br />
Movimento <strong>di</strong> rivoluzione. Conseguenze: giorno solare e giorno sidereo. Movimento apparente del Sole<br />
sullo sfondo dello Zo<strong>di</strong>aco. La prova <strong>di</strong> rivoluzione terrestre: l’aberrazione stellare. Le stagioni<br />
astronomiche<br />
- Il satellite della Terra: Luna<br />
Caratteristiche fisiche generali della Luna. Le quattro ipotesi sull’origine della Luna. La superficie<br />
lunare (mari, altopiani, crateri). I moti lunari: rotazione, rivoluzione e traslazione. Le fasi lunari. Le<br />
eclissi.<br />
L’orientamento. I punti car<strong>di</strong>nali. Coor<strong>di</strong>nate polari. Latitu<strong>di</strong>ne e longitu<strong>di</strong>ne. La misura del tempo:<br />
giorno civile e sidereo. L’ora vera e fusi orari. Linea del cambio <strong>di</strong> data.<br />
La Terra solida<br />
- Caratteristiche generali della litosfera.<br />
- I minerali. Struttura cristallina e amorfa. La cella elementare. Scala <strong>di</strong> Mohs. Proprietà dei minerali.<br />
Classificazione in base alla composizione (ossi<strong>di</strong>, solfuri, alogenuri, solfati, fosfati, carbonati, silicati. I<br />
silicati: tetraedro, classificazione.<br />
- Le rocce. Concetto <strong>di</strong> roccia e litotipo, struttura e tessitura.<br />
Rocce magmatiche. Dai magmi alle rocce ignee. Composizione. Classificazione.<br />
Rocce se<strong>di</strong>mentarie. Processo se<strong>di</strong>mentario. Struttura, tessitura e classificazione delle rocce<br />
se<strong>di</strong>mentarie: r. detritiche, r. <strong>di</strong> deposito chimico, r. organogene.<br />
Rocce metamorfiche. Processo metamorfico. Tipi <strong>di</strong> metamorfismo.<br />
La <strong>di</strong>namica endogena<br />
- Struttura interna della Terra: crosta, mantello, nucleo.<br />
- Teoria della deriva dei continenti. Tettonica delle placche. Margini <strong>di</strong> placca attivi: convergenti,<br />
<strong>di</strong>vergenti, conservativi; margini passivi. Fondali oceanici. Teoria dell’espansione dei fondali oceanici.<br />
Ciclo <strong>di</strong> Wilson. Punti cal<strong>di</strong>. Tettonica delle zolle associata alle attività sismica e vulcanica.<br />
- Fenomeni vulcanici. Magmi, vulcani e plutoni.<br />
Caratteristiche dei magmi. I prodotti del vulcanismo (lave e piroclasti). Forme degli e<strong>di</strong>fici vulcanici.<br />
Eruzioni <strong>di</strong> tipo esplosive e <strong>di</strong> tipo effusivo.<br />
- Terremoti. Origine. Teoria del rimbalzo elastico. Le onde sismiche profonde e superficiali. Concetti<br />
d’intensità e magnitudo. Gli effetti dei terremoti sul suolo, acque, costruzioni e uomo. Distribuzione dei<br />
terremoti. Il rischio sismico.<br />
Atmosfera e Idrosfera<br />
- Composizione e sud<strong>di</strong>visione in strati dell’atmosfera. Temperatura e pressione atmosferica, i venti.<br />
Circolazione dell’aria. L’acqua nell’aria: umi<strong>di</strong>tà, nubi e nebbie, precipitazioni atmosferiche. Il tempo<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 36/38
atmosferico: masse e fronti d’aria, cicloni, le previsioni del tempo.<br />
- I serbatoi dell’idrosfera e il ciclo dell’acqua. Mari e oceani: il livello del mare, caratteristiche fisicochimiche<br />
e biologiche dell’acqua. I movimenti del mare: le onde, le maree, le correnti superficiali e<br />
profonde.<br />
- Le acque continentali. Le acque sotterranee: falde e sorgenti. Le acque <strong>di</strong> superficie: acque incanalate,<br />
l’acqua dei fiumi. I laghi: evoluzione, caratteristiche fisico-chimiche e biologiche, classificazione. I<br />
ghiacciai: formazione, movimento, struttura e classificazione.<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 37/38
EDUCAZIONE FISICA<br />
OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA<br />
Potenziamento fisiologico. Miglioramento delle gran<strong>di</strong> funzioni organiche e delle qualità fisiche.<br />
Rielaborazione degli schemi motori: accomodamento psico-fisico e psico-motorio. Consolidamento del<br />
carattere, sviluppo della socialità. Conoscenza e pratica delle attività sportive come mezzo <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa della<br />
salute e come veicolo <strong>di</strong> socializzazione. Informazioni sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli<br />
infortuni.<br />
OBIETTIVI RAGGIUNTI:<br />
Gli obbiettivi sono stati completamente raggiunti, improntando le attività in base alle esigenze motorie delle<br />
ragazze , molte delle quali non svolgono attività fisica organizzata, per cui gli esercizi più usati sono stati<br />
quelli a corpo libero , con l’uso <strong>di</strong> piccoli attrezzi(palloni, elastici e piccoli pesi)) e con l’ausilio della musica<br />
(aerobica);il tutto consente una partecipazione globale da parte <strong>di</strong> tutte le alunne. Particolare attenzione è<br />
stata rivolta ai giochi sportivi come elementi <strong>di</strong> socializzazione e collaborazione fra le allieve.<br />
METODI E MEZZI:<br />
Si utilizzerà il metodo globale soprattutto nelle attività <strong>di</strong> approccio, ove non si pretenderà l’acquisizione <strong>di</strong><br />
una capacità tecnica particolarmente fine; si userà il metodo analitico per quei compiti ove sarà necessario<br />
acquistare una capacità psico-motoria che permetta la padronanza dei movimenti più <strong>di</strong>fficoltosi. Si<br />
proporranno situazioni motorie che portino le allieve alla comprensione ed alla scoperta <strong>di</strong> se stesse, del<br />
proprio corpo e delle proprie capacità, in modo che l’appren<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>venti padronanza mentale del singolo,<br />
quin<strong>di</strong> conquista e non semplice riproduzione <strong>di</strong> esperienze già note. Con questi meto<strong>di</strong> ci si propone <strong>di</strong> far<br />
acquisire alle allieve un transfer motorio positivo.<br />
STRUMENTI DI VERIFICA:<br />
Le verifiche terranno conto dei risultati raggiunti in relazione ai punti <strong>di</strong> partenza, tali risultati saranno<br />
ovviamente influenzati dall’impegno personale, dalla costanza nell‘applicazione, dalla capacità <strong>di</strong><br />
appren<strong>di</strong>mento e dalle caratteristiche antropometriche delle ragazze.<br />
CRITERI PER LA VALUTAZIONE:<br />
Viene valutata la conoscenza delle varie <strong>di</strong>scipline sportive, la partecipazione, la costanza dell’applicazione;<br />
il senso <strong>di</strong> responsabilità nel lavoro in palestra.<br />
CONTENUTI DISCIPLINARI:<br />
Lavoro in aerobia ed anaerobia.<br />
Lavoro sulla trasmissione neuro-muscolare.<br />
Esercizi <strong>di</strong> mobilizzazione articolare e allungamento muscolare.<br />
Esercizi <strong>di</strong> trofismo muscolare a carico naturale e con sovraccarico.<br />
Esercizi <strong>di</strong> rilassamento neuro-muscolare.<br />
Lavoro <strong>di</strong> abilità psico-motoria<br />
Giochi ed attività sportiva: conoscenza delle regole <strong>di</strong> gioco, fondamentali in<strong>di</strong>viduali collettivi con o senza<br />
palla del basket, pallavolo, pallamano, baseball,calcetto, badminton e atletica leggera.<br />
Esercitazioni atte ad affinare la tecnica <strong>di</strong> movimento e la tattica nelle varie situazioni motorie, con l’intento<br />
<strong>di</strong> raggiungere quei meccanismi neuro muscolari utili ad arricchire il proprio bagaglio psico-motorio.<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> <strong>Psicopedagogico</strong> "G. <strong>Cesare</strong>" - "M. Valgimigli" - III E liceo classico; programmi d'<strong>esame</strong> <strong>2008</strong>/<strong>09</strong> pag. 38/38