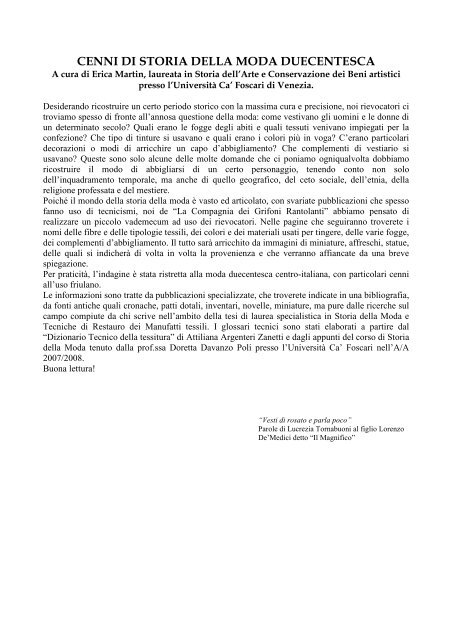Cenni di storia della moda duecentesca - Grifoni Rantolanti
Cenni di storia della moda duecentesca - Grifoni Rantolanti
Cenni di storia della moda duecentesca - Grifoni Rantolanti
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
CENNI DI STORIA DELLA MODA DUECENTESCA<br />
A cura <strong>di</strong> Erica Martin, laureata in Storia dell’Arte e Conservazione dei Beni artistici<br />
presso l’Università Ca’ Foscari <strong>di</strong> Venezia.<br />
Desiderando ricostruire un certo periodo storico con la massima cura e precisione, noi rievocatori ci<br />
troviamo spesso <strong>di</strong> fronte all’annosa questione <strong>della</strong> <strong>moda</strong>: come vestivano gli uomini e le donne <strong>di</strong><br />
un determinato secolo? Quali erano le fogge degli abiti e quali tessuti venivano impiegati per la<br />
confezione? Che tipo <strong>di</strong> tinture si usavano e quali erano i colori più in voga? C’erano particolari<br />
decorazioni o mo<strong>di</strong> <strong>di</strong> arricchire un capo d’abbigliamento? Che complementi <strong>di</strong> vestiario si<br />
usavano? Queste sono solo alcune delle molte domande che ci poniamo ogniqualvolta dobbiamo<br />
ricostruire il modo <strong>di</strong> abbigliarsi <strong>di</strong> un certo personaggio, tenendo conto non solo<br />
dell’inquadramento temporale, ma anche <strong>di</strong> quello geografico, del ceto sociale, dell’etnia, <strong>della</strong><br />
religione professata e del mestiere.<br />
Poiché il mondo <strong>della</strong> <strong>storia</strong> <strong>della</strong> <strong>moda</strong> è vasto ed articolato, con svariate pubblicazioni che spesso<br />
fanno uso <strong>di</strong> tecnicismi, noi de “La Compagnia dei <strong>Grifoni</strong> <strong>Rantolanti</strong>” abbiamo pensato <strong>di</strong><br />
realizzare un piccolo vademecum ad uso dei rievocatori. Nelle pagine che seguiranno troverete i<br />
nomi delle fibre e delle tipologie tessili, dei colori e dei materiali usati per tingere, delle varie fogge,<br />
dei complementi d’abbigliamento. Il tutto sarà arricchito da immagini <strong>di</strong> miniature, affreschi, statue,<br />
delle quali si in<strong>di</strong>cherà <strong>di</strong> volta in volta la provenienza e che verranno affiancate da una breve<br />
spiegazione.<br />
Per praticità, l’indagine è stata ristretta alla <strong>moda</strong> <strong>duecentesca</strong> centro-italiana, con particolari cenni<br />
all’uso friulano.<br />
Le informazioni sono tratte da pubblicazioni specializzate, che troverete in<strong>di</strong>cate in una bibliografia,<br />
da fonti antiche quali cronache, patti dotali, inventari, novelle, miniature, ma pure dalle ricerche sul<br />
campo compiute da chi scrive nell’ambito <strong>della</strong> tesi <strong>di</strong> laurea specialistica in Storia <strong>della</strong> Moda e<br />
Tecniche <strong>di</strong> Restauro dei Manufatti tessili. I glossari tecnici sono stati elaborati a partire dal<br />
“Dizionario Tecnico <strong>della</strong> tessitura” <strong>di</strong> Attiliana Argenteri Zanetti e dagli appunti del corso <strong>di</strong> Storia<br />
<strong>della</strong> Moda tenuto dalla prof.ssa Doretta Davanzo Poli presso l’Università Ca’ Foscari nell’A/A<br />
2007/2008.<br />
Buona lettura!<br />
“Vesti <strong>di</strong> rosato e parla poco”<br />
Parole <strong>di</strong> Lucrezia Tornabuoni al figlio Lorenzo<br />
De’Me<strong>di</strong>ci detto “Il Magnifico”
1- LA TESSITURA<br />
Si definisce “tessitura” la tecnica in base alla quale le fibre tessili vengono intrecciate me<strong>di</strong>ante<br />
giochi anche complessi, ottenendo drappi da impiegare tanto per la confezione <strong>di</strong> abiti quanto per<br />
l’arredamento. Le fibre tessili possono essere <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi tipi:<br />
VEGETALI<br />
Lino<br />
Cotone<br />
Canapa<br />
Altre: Juta, Ramiè, Agave, Ortica, Ginestra, Gelsomino, Rafia, Paglia.<br />
ANIMALI<br />
Lana<br />
Seta<br />
Bisso: detto anche “seta marina”, è costituito dai filamenti, lunghi circa 30 cm, che fuoriescono dal<br />
“piede” <strong>di</strong> una grande conchiglia bivalve che vive nel Me<strong>di</strong>terraneo. Il suo aspetto è <strong>di</strong> fili<br />
luminosissimi <strong>di</strong> color fulvo. Era usato nel passato sino all’alto me<strong>di</strong>oevo, poi scomparve per<br />
l’estrema laboriosità nel ricavarne filati per tessere. Resistette fino al 1300 per formare l’accia,<br />
ossia l’anima, dell’oro filato. A Firenze la sua presenza è attestata sino al 1400 circa.<br />
MINERALI<br />
Oro: poteva venir lavorato ad uso tessile in due <strong>di</strong>versi mo<strong>di</strong>: si definisce “ciprense” quell’oro che,<br />
messo in forma <strong>di</strong> pepita tra due stati <strong>di</strong> cuoio, veniva battuto sino a ridurlo in una foglia<br />
sottilissima la quale, fissata a bu<strong>della</strong> animali trattate come pergamena e tagliata a listarelle, veniva<br />
poi impiegata in tessitura, avvolgendola su anime <strong>di</strong> seta o bisso. Tale era la forma <strong>di</strong> utilizzo<br />
dell’oro nel campo dell’abbigliamento preferita dai bizantini. Si parla <strong>di</strong> oro “filato” quando il<br />
metallo prezioso, ridotto a stato lamellare, viene avvolto su filo <strong>di</strong> seta; si <strong>di</strong>ce “tirato”, invece,<br />
quell’oro al quale si conferiva un aspetto <strong>di</strong> filo tubolare facendo passare la massa del metallo<br />
attraverso minuscoli buchi, fuori dai quali veniva, appunto, tirato me<strong>di</strong>ante apposite pinze. Era<br />
questa la tipologia in voga a Venezia fino al Cinquecento e che rimase in uso in Oriente sino al<br />
secolo successivo. Di tra<strong>di</strong>zione cinese e giapponese è invece l’oro “cartaceo”, realizzato coprendo<br />
con una foglia <strong>di</strong> metallo prezioso <strong>della</strong> carta serica forte e riducendo il tutto in fettucce sottilissime;<br />
una variante persiana <strong>di</strong> questo tipo <strong>di</strong> lavorazione prevede striscioline <strong>di</strong> cuoio molto sottile in<br />
luogo <strong>della</strong> carta.<br />
Argento e Rame: potevano subire trattamenti analoghi all’oro, venendo battuti in foglia e ridotti a<br />
striscioline, avvolti attorno ad anime <strong>di</strong> seta o tirati a formare filo metallico. Il rame poteva venire<br />
dorato.<br />
Le fibre venivano intrecciate, ossia tessute, me<strong>di</strong>ante la tecnologia del telaio. Impiegato sin dalla<br />
notte dei tempi, poteva essere costruito secondo due tipologie:<br />
VERTICALE: da un palo fissato orizzontalmente pendevano (tesi me<strong>di</strong>ante appositi pesetti <strong>di</strong><br />
pietra o metallo) i fili dell’or<strong>di</strong>to, ossia quelli longitu<strong>di</strong>nali su cui poi si innestava<br />
perpen<strong>di</strong>colarmente la trama, formando il tessuto; quest’ultima veniva inserita me<strong>di</strong>ante una spola<br />
e poi compattata con un pettine. Tale tipo <strong>di</strong> telaio sopravvisse a lungo nelle case private, come<br />
strumento che le donne del popolo adoperavano per realizzare i semplici tessuti con cui vestire la<br />
famiglia.<br />
ORIZZONTALE: i fili <strong>di</strong> or<strong>di</strong>to erano tesi tra due pali detti subbi e passavano attraverso delle<br />
cornici <strong>di</strong> legno chiamate licci: in un telaio a due licci (ne esistevano <strong>di</strong> ancor più complessi, con<br />
più licci) uno conteneva i fili pari, l’altro quelli <strong>di</strong>spari e venivano alzati alternativamente per far<br />
1
passare la spola con il filo <strong>di</strong> trama, detta anche navetta; la trama poi veniva compattata me<strong>di</strong>ante<br />
una cassa battente basculante chiamata pettine. I telai avevano una <strong>di</strong>mensione definita, per cui i<br />
tessuti non superavano una certa altezza: è questa la misura che si prende da un bordo del tessuto<br />
(cimosa) all’altro.<br />
I tessuti così ottenuti erano <strong>di</strong>visi in due categorie principali: semplici e operati.<br />
TESSUTI SEMPLICI<br />
Si utilizzavano una singola trama e un or<strong>di</strong>to, intrecciandoli con tecniche non complesse; si<br />
ottenevano così la tela (se realizzata in lino, lana, cotone o altre fibre) o taffetas (se realizzata in<br />
seta), la <strong>di</strong>agonale e il raso. Venivano realizzati con telaio a due licci.<br />
TESSUTI OPERATI<br />
Si realizzavano me<strong>di</strong>ante più trame ed or<strong>di</strong>ti, intrecciandoli con giochi anche molto complessi<br />
grazie allo speciale telaio detto al tiro (introdotto in Italia dagli Arabi tra il X e l’XI secolo), fornito<br />
<strong>di</strong> lacci che venivano tirati per muovere i vari or<strong>di</strong>ti. Otteniamo così il lampasso (che comprendeva<br />
le tipologie dello sciamito, del <strong>di</strong>aspro e del broccatello), il damasco e il velluto; tutte queste<br />
tipologie potevano essere broccate, essendo la broccatura un’aggiunta che si poteva fare a<br />
qualunque tessuto.<br />
L’effetto d’opera (cioè il complesso intreccio tra fili) consentiva <strong>di</strong> realizzare <strong>di</strong>segni e decorazioni<br />
<strong>di</strong>rettamente intessuti nel drappo, anziché applicati o ricamati: era questo il modo più costoso ed<br />
elegante <strong>di</strong> impreziosire i tessuti nell’Italia del XIII secolo.<br />
Forniamo ora un piccolo glossario dei termini tecnici <strong>della</strong> tessitura:<br />
ORDITO: insieme dei fili longitu<strong>di</strong>nali che costituiscono un tessuto.<br />
TRAMA: filo che si intreccia perpen<strong>di</strong>colarmente all’or<strong>di</strong>to, formando il tessuto.<br />
PUNTO DI LEGATURA: punto nel quale un filo <strong>di</strong> or<strong>di</strong>to passa sopra un filo <strong>di</strong> trama.<br />
ARMATURA: modo col quale i fili dell’or<strong>di</strong>to <strong>di</strong> intrecciano con quelli <strong>di</strong> trama; le armature base<br />
sono tre: tela o taffetas, <strong>di</strong>agonale, raso.<br />
RAPPORTO DI ARMATURA: numero dei fili <strong>di</strong> or<strong>di</strong>to e trama che formano il ciclo <strong>di</strong> intreccio <strong>di</strong><br />
una qualsiasi armatura.<br />
CIMOSA: stretto bordo longitu<strong>di</strong>nale ai due lati del tessuto; il suo colore, l’armatura o il materiale<br />
<strong>di</strong> cui è composto possono essere <strong>di</strong>versi da quelli del tessuto.<br />
ALTEZZA: la larghezza <strong>della</strong> pezza <strong>di</strong> tessuto, misurata da una cimosa all’altra.<br />
NAVETTA: oggetto <strong>di</strong> forma allungata, con un alloggiamento cavo al centro per contenere la spola<br />
col filato; con tale strumento si fa passare la trama attraverso l’apertura creata dai fili <strong>di</strong> or<strong>di</strong>to, detta<br />
bocca o passo.<br />
COLPO: un passaggio <strong>della</strong> navetta attraverso il passo.<br />
SLEGATURA: passaggio <strong>di</strong> un filo <strong>di</strong> or<strong>di</strong>to sopra più colpi consecutivi <strong>di</strong> trama o <strong>di</strong> un colpo <strong>di</strong><br />
trama sopra più fili consecutivi <strong>di</strong> or<strong>di</strong>to.<br />
LICCIO: insieme <strong>di</strong> maglie che sono tenute tese tra due listelli <strong>di</strong> legno o in una cornice dello stesso<br />
materiale, entro le quali passano i fili <strong>di</strong> or<strong>di</strong>to che vengono alzati o abbassati per far passare la<br />
navetta, formando il “passo”.<br />
TELAIO A LICCI: telaio per la realizzazione <strong>di</strong> tessuti uniti semplici o piccolo-operati.<br />
TELAIO AL TIRO: telaio per l’esecuzione dei tessuti operati.<br />
MAGLIONE: anello sospeso all’estremità <strong>di</strong> un’arcata, munito <strong>di</strong> uno o più fori nei quali passano i<br />
fili <strong>di</strong> or<strong>di</strong>to per realizzare i decori del tessuto operato.<br />
CORPO DEI LICCI O DEI MAGLIONI: insieme dei licci o dei maglioni che manovrano i fili <strong>di</strong><br />
or<strong>di</strong>to per costruire il tessuto.<br />
ARCATA: corda fine che collega, nel telaio al tiro, il maglione alla corda del ramo.<br />
2
RAMO: insieme <strong>di</strong> corde poste orizzontalmente in alto sopra il telaio che sostengono le arcate nel<br />
telaio al tiro; inizialmente alle corde del ramo erano sospesi i lacci, occhielli che riunivano le corde<br />
scelte al fine <strong>di</strong> sollevare i fili <strong>di</strong> or<strong>di</strong>to per ottenere l’opera. Poi alle corde del ramo è collegato il<br />
tiratoio, posto verticalmente.<br />
CAMPO O CAMMINO: insieme delle arcate e dei maglioni del telaio che concorrono alla<br />
formazione dei <strong>di</strong>segni secondo un or<strong>di</strong>ne determinato.<br />
FONDO: intreccio principale del tessuto che fa da base agli effetti <strong>di</strong> <strong>di</strong>segno delle stoffe operate; è<br />
formato da un or<strong>di</strong>to e una trama, che sono detti, appunto, “<strong>di</strong> fondo”.<br />
TRAMA LANCIATA: trama supplementare (la quale, cioè, non fa parte del fondo) che definisce<br />
l’opera, ossia il <strong>di</strong>segno, ed è così detta perché lanciata da una cimosa all’altra. Viene legata al<br />
dritto, in <strong>di</strong>agonale o taffetas, dall’or<strong>di</strong>to <strong>di</strong> fondo (liage repris) o da un or<strong>di</strong>to supplementare detto<br />
“<strong>di</strong> legatura”. Quando non deve comparire al dritto per creare affetti <strong>di</strong> opera, passa al rovescio e<br />
può rimanere slegata o essere legata al fondo come al dritto.<br />
TRAMA BROCCATA: trama supplementare che crea i decori dell’opera limitando il suo intervento<br />
alle sole zone del <strong>di</strong>segno; viene inserita con piccole navette dette “spolini”. Può essere legata al<br />
dritto nei medesimi mo<strong>di</strong> <strong>della</strong> trama lanciata, o rimanere slegata.<br />
TRAMA LISERÉE: effetto ottenuto slegando in alcune aree la trama <strong>di</strong> fondo.<br />
TIPOLOGIE TESSILI SEMPLICI<br />
Tessuti formati da un solo or<strong>di</strong>to e da una trama.<br />
TELA O TAFFETAS: tessuto ad armatura semplice in cui il rapporto <strong>di</strong> armatura è 2 fili <strong>di</strong> or<strong>di</strong>to e<br />
2 <strong>di</strong> trama: tutti i fili <strong>di</strong> or<strong>di</strong>to <strong>di</strong>spari si sollevano al passaggio delle trame <strong>di</strong>spari e tutti i fili pari al<br />
passaggio delle trame pari. L’aspetto dell’armatura è identico su entrambe le facce del tessuto. Si<br />
<strong>di</strong>ce “tela” quando è realizzata con filati <strong>di</strong> lino, cotone, lana o altro, mentre “taffetas” se è <strong>di</strong> seta.<br />
CANGIANTE: tessuto, <strong>di</strong> solito taffetas, che ha la trama e l’or<strong>di</strong>to <strong>di</strong> colori <strong>di</strong>versi e crea perciò<br />
riflessi <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse tonalità al mutare <strong>della</strong> luce.<br />
CANNELLATO: armatura derivata dal taffetas; appare con coste orizzontali, formate dalle<br />
slegature <strong>di</strong> or<strong>di</strong>to su più colpi <strong>di</strong> trama inseriti nello stesso passo. I vari tipi <strong>di</strong> cannellato si<br />
definiscono in base al numero dei colpi introdotti per realizzare ciascuna delle coste orizzontali;<br />
quello <strong>di</strong> due colpi è detto “Gros de Tours”.<br />
CANNELLATO SEMPLICE: cannellato con un or<strong>di</strong>to supplementare, detto “<strong>di</strong> pelo”, che slega su<br />
più colpi <strong>di</strong> trama, formando le coste orizzontali sull’armatura <strong>di</strong> fondo a taffetas.<br />
CANNETILLÉ: variante del cannellato semplice, ma con le coste orizzontali interrotte ed alternate<br />
a formare una superficie a scacchiera.<br />
DIAGONALE, O SAIA, O SPINA: armatura semplice caratterizzata da nervature oblique che<br />
possono andare verso destra (viene in<strong>di</strong>cato con S) o verso sinistra (in<strong>di</strong>cato con Z) rispetto ai punti<br />
<strong>di</strong> legatura. Tale armatura presenta su una faccia, detta “faccia or<strong>di</strong>to”, una prevalenza delle<br />
slegature dei fili <strong>di</strong> or<strong>di</strong>to e sul lato opposto, detto “faccia trama”, una prevalenza delle slegature <strong>di</strong><br />
trama. Il tessuto <strong>di</strong>agonale è definito dal numero <strong>di</strong> slegature e legature <strong>di</strong> or<strong>di</strong>to nel rapporto <strong>di</strong><br />
armatura: si in<strong>di</strong>ca prima sotto quanti colpi <strong>di</strong> trama slega un filo <strong>di</strong> or<strong>di</strong>to e poi su quanti colpi lega.<br />
RASO: armatura semplice in cui i punti <strong>di</strong> legatura sono organizzati in modo da risultare nascosti<br />
dalle slegature dei fili <strong>di</strong> or<strong>di</strong>to a<strong>di</strong>acenti, formando così sulla faccia or<strong>di</strong>to una superficie lucida e<br />
uniforme e sulla faccia trama un effetto opaco, grazie alla prevalenza delle slegature <strong>di</strong> trama. I vari<br />
tipi <strong>di</strong> raso si in<strong>di</strong>cano con il numero dei fili che compongono il rapporto d’armatura e con quanti<br />
colpi <strong>di</strong> trama si sposta una legatura <strong>di</strong> un filo <strong>di</strong> or<strong>di</strong>to rispetto al filo <strong>di</strong> or<strong>di</strong>to precedente<br />
(contando sulla faccia or<strong>di</strong>to) oppure rispetto al filo <strong>di</strong> or<strong>di</strong>to seguente (contando sulla faccia<br />
trama); tale spostamento è definito “scoccamento”.<br />
3
TIPOLOGIE TESSILI OPERATE<br />
Tessuti decorati con <strong>di</strong>segni, definiti “opera”, ottenuti dall’intreccio <strong>di</strong> più or<strong>di</strong>ti con più trame.<br />
BROCCATELLO: tessuto operato <strong>della</strong> famiglia dei lampassi; in questo tipo <strong>di</strong> tessuto abbiamo<br />
<strong>di</strong>segni ottenuti con la faccia or<strong>di</strong>to del raso a rilievo, grazie all’utilizzo <strong>della</strong> trama <strong>di</strong> fondo in lino,<br />
mentre il fondo stesso è ricoperto da una trama lanciata in seta legata da un or<strong>di</strong>to supplementare.<br />
DAMASCO: tessuto operato che presenta un effetto <strong>di</strong> fondo e uno <strong>di</strong> <strong>di</strong>segno prodotti dalla faccia<br />
or<strong>di</strong>to e dalla faccia trama <strong>di</strong> un’armatura raso; in questo modo il tessuto risulta “double face”: da<br />
un lato, fondo lucido e decorazione opaca, dall’altro, decorazione lucida su sfondo opaco. In<br />
generale il damasco è monocromo, ma se ne trovano anche <strong>di</strong> bicromi, con or<strong>di</strong>to e trama <strong>di</strong> due<br />
<strong>di</strong>versi colori. E’ <strong>di</strong> antichissima origine orientale.<br />
LAMPASSO: tessuto operato derivante dallo sciamito; presenta un or<strong>di</strong>to e una trama <strong>di</strong> fondo che<br />
lavorano con armatura semplice: <strong>di</strong>agonale, raso o taffetas, più un or<strong>di</strong>to <strong>di</strong> legatura che lega le<br />
trame lanciate o broccate con un altro intreccio, in genere <strong>di</strong>agonale o taffetas. Può avere effetti<br />
d’or<strong>di</strong>to e <strong>di</strong> trama; mette in rilievo il <strong>di</strong>segno rispetto al fondo grazie alle <strong>di</strong>versità <strong>di</strong> armature<br />
impiegate. Presenta, cioè, due sistemi <strong>di</strong> or<strong>di</strong>to e almeno due serie <strong>di</strong> trame; un or<strong>di</strong>to e una trama<br />
formano l’intreccio <strong>di</strong> fondo, gli altri si legano a formare il decoro. La sua origine è cinese.<br />
SCIAMITO: tessuto a due o più trame legate in <strong>di</strong>agonale da un or<strong>di</strong>to <strong>di</strong> legatura, mentre l’or<strong>di</strong>to<br />
<strong>di</strong> fondo non lavora, fungendo unicamente da separatore delle trame che eseguono l’opera al dritto<br />
dalle trame che passano al rovescio quando non sono necessarie per definire i decori. La superficie<br />
è uniforme e il contorno del <strong>di</strong>segno è dato dalla contrapposizione dei colori del fondo e <strong>di</strong> quelli<br />
dell’opera o, per gli sciamiti monocromi, dagli stessi elementi del <strong>di</strong>segno.<br />
Tra le tipologie operate è compreso anche il velluto, non in uso nel Duecento, bensì a partire dal<br />
Trecento; abbiamo pensato comunque <strong>di</strong> fornire qualche nota tecnica anche su questo tessuto, per<br />
chi fosse interessato.<br />
VELLUTO: tessuto con due or<strong>di</strong>ti; uno <strong>di</strong> fondo, che intrecciandosi alla trama <strong>di</strong> fondo forma<br />
l’armatura <strong>di</strong> base, e uno “<strong>di</strong> pelo”, usato per la costruzione <strong>della</strong> superficie vellutata, la quale<br />
risulta, appunto, pelosa. Si esegue inserendo, ogni due o più colpi <strong>di</strong> trama <strong>di</strong> fondo, un ferro da<br />
velluto sul quale vengono poi abbassati i fili dell’or<strong>di</strong>to <strong>di</strong> pelo. Vi sono velluti uniti, ossia semplici,<br />
la cui superficie si presenta omogenea, e velluti operati, vale a <strong>di</strong>re arricchiti con effetti <strong>di</strong> opera.<br />
VELLUTO (CORPO DEL): tale termine in<strong>di</strong>ca l’or<strong>di</strong>to <strong>di</strong> pelo <strong>di</strong> un velluto operato; in un velluto a<br />
più colori vi sono <strong>di</strong>versi corpi.<br />
2-LA TINTURA E L’USO DEI COLORI<br />
Si forniscono qui <strong>di</strong> seguito i nomi dei materiali in uso durante il Duecento per tingere le stoffe, un<br />
piccolo glossario sui colori e una tabella sinottica dei significati che i <strong>di</strong>versi colori potevano<br />
assumere nella società me<strong>di</strong>evale.<br />
Porpora: ottenuta dal Murex, un mollusco marino grazie al quale si poteva tingere in colori che<br />
variavano dal violaceo all’azzurro cupo, passando per il bruno e il livido, a seconda <strong>della</strong> zona<br />
me<strong>di</strong>terranea dove il Murice era stato pescato. Ogni singola conchiglia dava una goccia <strong>di</strong> colore,<br />
per cui ne servivano migliaia per ricavare la quantità necessaria a tingere una tunica: <strong>di</strong> qui il prezzo<br />
elevatissimo <strong>della</strong> Porpora e il suo significato <strong>di</strong> <strong>di</strong>gnità regale.<br />
Indaco: estratto da una pianta chiamata In<strong>di</strong>goforu e importato dal Marocco, serviva a dare il colore<br />
azzurro.<br />
Scotano: da questa pianta si ottenevano il verde, il blu e il giallo.<br />
Galla: tale escrescenza presente sui rami <strong>di</strong> quercia dava il nero e il grigio.<br />
4
Grana: da un insetto parassita <strong>della</strong> quercia, chiamato coccus ilicis, si poteva trarre una tintura<br />
rossa chiamata “grana” per il fatto che l’insetto <strong>di</strong>sseccato appariva come un granello. Il processo<br />
consisteva nel far fermentare i piccoli insetti nell’urina, ottenendo un colore molto vivo e ricercato,<br />
quin<strong>di</strong> costoso.<br />
Kermes o chermes, termine arabo in<strong>di</strong>cante una tintura rossa, da cui nasce il “cremisi”.<br />
Verzino (o barzi, berzi, verzi), detto anche lignum brasile o braxile in quanto avente il colore <strong>della</strong><br />
bragia: era un legno proveniente dall’In<strong>di</strong>a o dall’Asia tropicale, per la precisione la corteccia <strong>di</strong><br />
Cesalpina Sappam e Cesalpina Cristia: i panni tinti con questo si <strong>di</strong>cevano berziliati e davano un<br />
rosso meno pregiato del kermes. Questo legno serviva anche per ricavare il vermiglio, il paonazzo<br />
e lo zaffiorato, laddove quest’ultimo colore in<strong>di</strong>cava una tinta interme<strong>di</strong>a fra giallo e rosso.<br />
Robbia (o garanza), ovvero la Rubia tinctorum, da secoli coltivata in Europa, ma importata pure<br />
dall’Oriente; questo perché la parte <strong>della</strong> pianta che dava la tintura era la ra<strong>di</strong>ce, per cui ogni<br />
raccolto <strong>di</strong> Robbia, che avveniva una volta l’anno e a due anni dalla semina, doveva essere<br />
sra<strong>di</strong>cato; <strong>di</strong> qui il fatto che la produzione interna non fosse sufficiente a colmare la richiesta. Dava<br />
anch’essa un colore rosso.<br />
Lacca: molto pregiata ma <strong>di</strong> scarso uso, altra tintura rossa <strong>di</strong> origine asiatica: era questa una resina<br />
emessa dai rami <strong>di</strong> alcune piante <strong>della</strong> famiglia delle euforbiacee a causa dell’azione <strong>di</strong> certi<br />
parassiti, che facevano “piangere” l’arbusto.<br />
Oricello: ulteriore maniera per ottenere il rosso, era già usato in Italia nel XII secolo: si trattava <strong>di</strong><br />
una sostanza <strong>di</strong> colore rosso violaceo estratta da un lichene definito “rocella tintoria”, lo stesso dal<br />
quale si ottiene il tornasole.<br />
Guado: altro modo, oltre all’indaco, <strong>di</strong> realizzare l’azzurro; si tratta <strong>di</strong> una sostanza estratta dalle<br />
foglie <strong>di</strong> una pianta, la Isatis tintoria, che forniva ben quattro-cinque raccolti all’anno. Le zone <strong>di</strong><br />
maggior produzione nell’Italia del XIII secolo erano il Chianti, la parte alta <strong>della</strong> val <strong>di</strong> Chiana, la<br />
valle del Tevere, la zona che si estendeva da Piacenza sino ad Alessandria.<br />
COLORE SIGNIFICATO<br />
Bianco Fede, in aral<strong>di</strong>ca detto “argento”,<br />
significa purezza o passione<br />
d’amore<br />
Rosso Carità, nobiltà, regalità, vendetta<br />
(in aral<strong>di</strong>ca), passione, amore,<br />
potere<br />
Verde Speranza, lutto se scuro, ardore<br />
(in aral<strong>di</strong>ca), rinascita<br />
Giallo In aral<strong>di</strong>ca detto “oro”, significa<br />
ricchezza e onori; se acceso,<br />
infamia e invi<strong>di</strong>a<br />
Nero Lutto, fermezza, perseveranza; in<br />
aral<strong>di</strong>ca in<strong>di</strong>ca malinconia<br />
Azzurro Purezza; in aral<strong>di</strong>ca il turchino<br />
significa magnanimità<br />
Blu Lutto o vedovanza se scuro<br />
Grigio Umiltà<br />
Bruno Umiltà<br />
Rovano (colore misto tra il nero Lutto o vedovanza se scuro<br />
e il rosso)<br />
Morello (color violetto) Lutto o vedovanza se scuro<br />
Oro Sentimento<br />
Viola Lutto<br />
5
I nomi dei colori in<strong>di</strong>cati qui <strong>di</strong> seguito si rifanno all’uso e alla lingua veneta.<br />
ALESSANDRINO: color azzurro con riflessi metallici.<br />
AMAREO: color amaranto.<br />
ARMELIN: color albicocca.<br />
BAVELIN: color <strong>della</strong> bavella, cioè del cascame <strong>di</strong> seta, i filamenti tolti dal bozzolo prima <strong>di</strong><br />
cominciare a trarne la seta.<br />
BERETINO: color marrone scuro tendente al grigio topo.<br />
BERTAMOREA: panno <strong>di</strong> color bruno tendente al viola.<br />
BIAVO, BLAVO: color celeste, azzurrognolo.<br />
BIAVETTO: blavus azzurro, ossia colore lilla.<br />
BIGELLO: tendente al grigio.<br />
BIOIO: panno <strong>di</strong> color Blavo o Biavo, cioè azzurro chiaro, molto usato dai veneti.<br />
BIONDO: colore giallo-bianco o giallo dorato.<br />
BLÒ: azzurro, paonazzo.<br />
CANNELLINO: color <strong>di</strong> cannella, <strong>di</strong> solito citato fra i paonazzi.<br />
CILESTRO: variante chiara del bioio.<br />
CREMESE: cremisi, rosso (dal chermes); sinonimo <strong>di</strong> vermiglio, è il colore veneziano nobile.<br />
FESTICHINO: color verde pistacchio.<br />
GREDELIN: o griselin, deriva dal francese gris-de-lin e in<strong>di</strong>ca il color lilla.<br />
INCARNÀ: color rosa carne.<br />
LACCA: color rosso lacca.<br />
LATADO: color del latte.<br />
LATESIN: colore bianco celestino.<br />
LIONATO: colore del leone ovvero fulvo, tinta ruggine.<br />
MAVÌ: colore celeste cupo.<br />
MORELLO: color violetto.<br />
MOSCO: color muschio.<br />
NARANZIN: color arancio.<br />
OBRIACO: forse panno rosso vivo.<br />
PAVONAZO, PAONAZZO: colore violetto, nero-azzurro o blu pavone.<br />
PAZIENZA: colore scuro.<br />
PERSEGHIN: del colore <strong>della</strong> pesca.<br />
PERSO: panno blavo bruno.<br />
ROAN, ROVANO: color nero rossigno.<br />
RUOSA SECHA: colore rosaceo.<br />
SCARLATTO: color rosso cremisi. In realtà questo termine, derivante dal persiano scarlat,<br />
in<strong>di</strong>cava in origine qualsiasi colore nella sua gradazione più intensa; si poteva parlare <strong>di</strong> bianco<br />
scarlatto, ad esempio, per in<strong>di</strong>care un bianco particolarmente brillante e vivido.<br />
SGUARDO: color rosso acceso, vermiglio.<br />
TANNÉ: color castano fulvo.<br />
VERDELLO: panno verde.<br />
VERMIGLIONE: rosso scuro.<br />
VINÀ, VINADO: color rosso, la stessa tinta del vino.<br />
6
3- LA MODA<br />
Qui <strong>di</strong> seguito forniamo un glossario dei nomi <strong>di</strong> abiti e accessori del vestiario, seguito da brevi<br />
spiegazioni illustrate me<strong>di</strong>ante miniature. La trattazione si riferisce in generale alla <strong>moda</strong> del nord e<br />
centro Italia, considerando però il più ampio contesto centroeuropeo e approfondendo talvolta con<br />
cenni dell’uso friulano; saranno quin<strong>di</strong> impiegate risorse iconografiche pertinenti tanto all’ampia<br />
area <strong>di</strong> cultura franco-germanica, quanto all’Italia del centro-nord e alle terre del Patriarcato<br />
d’Aquileia. Questa scelta è motivata dal fatto che il costume italiano in generale e friulano in<br />
particolare hanno subito, a causa delle conquiste e delle invasioni o grazie alla presenza pacifica sul<br />
territorio, l’influenza degli usi vestimentari e tessili <strong>di</strong> numerose culture e vari popoli: i francesi, le<br />
genti germanico-magiare, i normanni, gli arabi hanno lasciato il loro segno in decorazioni, fogge,<br />
tecniche tessitorie o tintorie.<br />
Si deve considerare, inoltre, il fatto che durante il Duecento i traffici commerciali a livello<br />
continentale erano molto sviluppati: in Italia si lavoravano lane pregiate fatte venire apposta<br />
dall’Inghilterra, che esportava anche i migliori ricami d’Europa, chiamati opus anglicanum; a<br />
Venezia, Lucca e Palermo fiorì una produzione <strong>di</strong> sete operate <strong>di</strong> derivazione orientale grazie ai<br />
contatti coi popoli del Vicino Oriente, dai quali venivano comunque importati tanto materie prime<br />
(cotone, seta, allume) quanto prodotti lavorati; in Friuli la presenza <strong>di</strong> una nobiltà <strong>di</strong> ceppo<br />
germanico favorì il <strong>di</strong>ffondersi <strong>di</strong> costumi “alla tedesca”, ma la vicinanza con Venezia, porta<br />
d’Oriente, influenzò anche il gusto per i tessuti operati e ad<strong>di</strong>rittura, verso i primi del Trecento, la<br />
passione per i drappi decorati alla <strong>moda</strong> cinese.<br />
Naturalmente questo intervento non ha la pretesa <strong>di</strong> illustrare un panorama così ampio e articolato<br />
come quello appena descritto, ma semplicemente <strong>di</strong> fornire al lettore le informazioni principali<br />
riguardo alla <strong>moda</strong> <strong>duecentesca</strong>; altri interventi affronteranno <strong>di</strong> volta in volta con approfon<strong>di</strong>menti<br />
le singole questioni.<br />
NOMI DEI TESSUTI, DEGLI INDUMENTI E DEI COMPLEMENTI DI VESTIARIO<br />
I termini impiegati in questo breve glossario sono sempre quelli dell’uso veneto nei secoli XIII e<br />
XIV.<br />
AGNINA: lana d’agnello<br />
ALBAGIO: tessuto grossolano <strong>di</strong> lana non tinta<br />
AMUER: moire, tessuto con armatura in taffetas o gros dall’effetto marezzato. Detto anche<br />
amoerro o marizzo.<br />
ARAZZO: tessuto che presenta un unico or<strong>di</strong>to e più trame <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi colori, ciascuna delle quali<br />
interviene solo dove lo richiede il <strong>di</strong>segno, coprendo comunque l’or<strong>di</strong>to. Di solito l’armatura è tela.<br />
ARMELIN: pelliccia <strong>di</strong> ermellino, ma anche color albicocca.<br />
AURIFRISIA: fregio, passamaneria intessuta d’oro.<br />
BAIADERA: tessuto che presenta fasce orizzontali prodotte dall’accostamento <strong>di</strong> armature <strong>di</strong>verse.<br />
BAIETTA: panno <strong>di</strong> lana.<br />
BALDACHIN: tessuto <strong>di</strong> seta originario <strong>della</strong> città <strong>di</strong> Baghdad.<br />
BALZANA: guarnizione all’estremità inferiore delle vesti.<br />
BANCHAL: cassapanca, ma anche drappo che la ricopre.<br />
BANDA: striscia <strong>di</strong> tessuto colorato in<strong>di</strong>cante l’appartenenza a un esercito, un partito, un casato.<br />
BARBOLE: lembi <strong>di</strong> cuffia.<br />
BASSETTE: pelli <strong>di</strong> agnellino ucciso appena nato.<br />
BATISTA: tela <strong>di</strong> lino sottile e semitrasparente, <strong>di</strong> alta qualità, <strong>di</strong> provenienza fiamminga.<br />
BASTON: tela <strong>di</strong> lino fabbricata nella regione francese <strong>della</strong> Piccar<strong>di</strong>a; è sinonimo <strong>di</strong> tela batista o<br />
rensa (da Reims).<br />
7
BAVELIN: color <strong>della</strong> bavella, cioè del cascame <strong>di</strong> seta, i filamenti tolti dal bozzolo prima <strong>di</strong><br />
cominciare a trarne la seta. E’ una seta <strong>di</strong> qualità più scadente.<br />
BECCHETTO: parte finale allungata <strong>di</strong> copricapo maschile.<br />
BELVEDER: tessuto <strong>di</strong> seta.<br />
BERCANDO: tessuto <strong>di</strong> cotone, fustagno, pignolato.<br />
BERGAMON: panno <strong>di</strong> lana.<br />
BIGELLO: panno <strong>di</strong> lana grossolana tendente al grigio.<br />
BINDELLI: fettucce <strong>di</strong> seta, nastri.<br />
BIOIO: panno <strong>di</strong> color blavo o biavo, cioè azzurro chiaro, molto usato dai veneti.<br />
BISAZZA: bisaccia.<br />
BOMBASO: cotone.<br />
BOTANA: tela <strong>di</strong> cotone assai resistente usata per le vele.<br />
BRAZZO: unità <strong>di</strong> misura per la tela, corrispondente a quattro palmi o quarte, cioè, a Venezia 63,8<br />
cm per la seta e 68,2 cm per la lana.<br />
BROCCA: bottone, spilla; tessuto operato per broccature.<br />
BRUNETTA: panno <strong>di</strong> bassa qualità <strong>di</strong> color bruno ( bruno in<strong>di</strong>cava la tonalità scura <strong>di</strong> un qualsiasi<br />
colore).<br />
BULGARO: cuoio <strong>di</strong> provenienza bulgara.<br />
CALÇARIOS: scarpe.<br />
CALCETTI: calzetti.<br />
CALLICOLE: decorazioni tonde.<br />
CAMAURO: cuffietta maschile <strong>di</strong> tela <strong>di</strong> lino <strong>di</strong> foggia cupoliforme con cordelle laterali da<br />
allacciare sotto la gola.<br />
CAMORA, GAMURRA: veste femminile; tunica con maniche.<br />
CAMOCATO: tessuto <strong>di</strong> seta molto lucente, proveniente da Cina e In<strong>di</strong>a.<br />
CAMOZZA: pelle scamosciata.<br />
CAMPAGI: calzature.<br />
CANZANTE: cangiante; detto così un tessuto <strong>di</strong> seta con trama <strong>di</strong> un colore e or<strong>di</strong>to <strong>di</strong> un altro.<br />
CAPIGLIARA: acconciatura femminile arricchita da posticci e nastri.<br />
CAPPA: mantello a ruota con cappuccio.<br />
CARNIZE: tela rada <strong>di</strong> lino.<br />
CAMBELOTTO: detto anche ciambellotto, cammellotto o zambellotto, è un tessuto in uso già a<br />
metà Duecento, una lana beige ricoperta <strong>di</strong> un leggero pelo. E’ chiamato così perché in origine pare<br />
fosse fatto <strong>di</strong> pelo <strong>di</strong> cammello.<br />
CAMBRADA: tela finissima <strong>di</strong> lino, solitamente bianca, originaria <strong>di</strong> Cambrai; del genere <strong>della</strong><br />
batista.<br />
CAMBRAGIO: tela molto fine vicina o coincidente con la batista.<br />
CANEVAZZA: canovaccio, ossia panno <strong>di</strong> lino (pannolino) grosso e ruvido, ma anche broccato<br />
tessuto d’oro e argento.<br />
CANUTIGLIA: strisciolina d’oro e argento che, attorcigliata, è usata nei ricami.<br />
CAPICCIOLA: tessuto con trama <strong>di</strong> stame o bavelle e or<strong>di</strong>to <strong>di</strong> seta cotta.<br />
CASTORETO: tela con or<strong>di</strong>to <strong>di</strong> seta e trama <strong>di</strong> lana.<br />
CENDAL, ZENDADO: detto anche zendale, era un tessuto grandemente in voga sin dal IX secolo e<br />
rimase in uso sino al XVII; poteva essere <strong>di</strong> molte varietà, somigliava ai foulard e al taffetas. Se ne<br />
facevano vesti sacre quanto abiti comuni.<br />
CENTONE: rozzo panno pesante; schiavina <strong>di</strong> più pezzi.<br />
CHATASAMITO: copia <strong>di</strong> sciamito, quasi sciamito.<br />
CHERMONESE: pare che il nome in<strong>di</strong>chi un tessuto fabbricato a Cremona, o che derivi da<br />
chermes.<br />
8
CHINÉ: tessuto decorato da un <strong>di</strong>segno a contorni sfumati, ottenuto tingendo, prima <strong>della</strong> tessitura,<br />
i fili <strong>di</strong> or<strong>di</strong>to a piccoli gruppi, in colori <strong>di</strong>versi e me<strong>di</strong>ante tintura per riserva, vale a <strong>di</strong>re coprendo<br />
(“riservando”) le zone che non si vogliono tingere.<br />
CINGOLO: cintura <strong>di</strong> corda.<br />
CIOPPA: sopravveste maschile pesante, con maniche, foderata <strong>di</strong> pelliccia.<br />
CIROTECHE: guanti.<br />
CLAMIDE: mantello a ruota allacciato da fibbia sulla spalla.<br />
COA: coda, ovvero strascico.<br />
COAZZONE: lunghissima treccia <strong>di</strong> capelli: è una <strong>moda</strong> originaria del Nord Europa.<br />
COGOLA: cocolla, tunica; veste monacale.<br />
CORDOVANO: cuoio finissimo, originario <strong>della</strong> città spagnola <strong>di</strong> Cordova.<br />
CORTELLATO: frastagliato, abito sul quale sono stati praticati dei tagli ornamentali.<br />
COSCIALIA: mutande: dette anche “tibialia” o “femoralia”.<br />
COSTANZA: tela bianca <strong>di</strong> lino proveniente dalla città <strong>di</strong> Costanza.<br />
COTTA: veste lunga con maniche strette, <strong>di</strong> uso sia maschile che femminile.<br />
CROSINA, CROSNA: sopravveste o mantello foderato <strong>di</strong> pelliccia.<br />
CUCULLO: corta mantellina con cappuccio.<br />
CUOIETTO: detto anche “coletto”, è un farsetto <strong>di</strong> cuoio per lo più senza maniche.<br />
DALMATICA: veste liturgica aperta ai fianchi, con maniche larghe; deve il suo nome alla sua<br />
origine dalmata.<br />
DESTAGGIO: intaglio, lavoro traforato o frastagliato.<br />
DIASPRO: termine in uso solo durante il secolo XIII per in<strong>di</strong>care certi tessuti preziosi. Deriva dal<br />
greco e significa “due volte bianco”, poiché presentava un <strong>di</strong>segno monocromatico che si staccava<br />
dal fondo per contrasto tra superficie lucida e opaca.<br />
DIMITO: termine derivante dal greco e che significa “a filo doppio”; guarnello o tessuto <strong>di</strong> cotone<br />
puro o misto con altra fibra.<br />
DIVISA: stemma aral<strong>di</strong>co.<br />
DIVISATO: tessuto a strisce verticali.<br />
DOBLONE: tessuto doppio, forse <strong>di</strong> cotone.<br />
DOSSI: dorsi del vaio.<br />
DRAPO: tessuto <strong>di</strong> pura seta.<br />
DURANTE: una specie <strong>di</strong> panno rinforzato.<br />
FACCIOLO: detto anche fazzuolo, faziol; è un velo da testa, in genere <strong>di</strong> seta.<br />
FALDA: lembo <strong>di</strong> veste, tesa <strong>di</strong> cappello o parte inferiore <strong>di</strong> casacca.<br />
FARSETTO: indumento per il busto maschile, chiuso e regolato con legacci; bustino o corpetto<br />
femminile.<br />
FELPA: tessuto <strong>di</strong> cotone grosso e peloso.<br />
FELTRO: stoffa non tessuta, ma ottenuta pressando peli o fibre animali.<br />
FERANDINA: stoffa leggera <strong>di</strong> lana e seta.<br />
FIGURADO: operato, ossia che presenta <strong>di</strong>segni e figure realizzati me<strong>di</strong>ante effetti <strong>di</strong> trama.<br />
FILLO: lino.<br />
FOGGIA: parte larga del cappuccio in uso nei secoli XIV-XV.<br />
FRAPPE: frastagliature degli orli <strong>della</strong> veste; frangiature.<br />
FORBIZADO: sforbiciato,tagliato, trinciato, accoltellato. Già nel Duecento era in uso la “veste<br />
accoltellata”, abito sul quale erano stati praticati tagli, in genere verticali; era spesso <strong>di</strong>stintiva dei<br />
personaggi bizzarri, come i giullari.<br />
FUSTAGNO: tessuto operato <strong>di</strong> cotone bianco, nel quale i <strong>di</strong>segni sono in genere geometrici e<br />
ottenuti per slegature <strong>di</strong> trama. Può però in<strong>di</strong>care qualsiasi tessuto <strong>di</strong> cotone o panno misto <strong>di</strong> lana e<br />
cotone, <strong>di</strong> me<strong>di</strong>o peso e poco prezzo.<br />
GARBO: panno fatto con lana proveniente dalla città araba <strong>di</strong> Garbo.<br />
GARZA: tela molto rada, molle e irregolare, originaria <strong>della</strong> città <strong>di</strong> Gaza.<br />
9
GHERONE: tassello triangolare <strong>di</strong> stoffa inserito per ampliare la veste.<br />
GIURIN: tipo <strong>di</strong> tessuto per fodere.<br />
GIUSTACUORE: farsetto o copribusto.<br />
GONNELLA: veste lunga tanto maschile quanto femminile, con maniche e strascico.<br />
GRISETTA: stoffa leggera <strong>di</strong> lana o mista <strong>di</strong> lana e seta.<br />
GRISO: o len<strong>di</strong>nella, era il panno grosso e <strong>di</strong> poco pregio usato da alcuni monaci e dagli eremiti;<br />
era adottato anche per le vesti degli schiavi forzati e degli operai.<br />
GRISOFERRO: panno ruvido <strong>di</strong> lana.<br />
GROGRANO: dal francese gros-grain, che in<strong>di</strong>ca la grana grossa, è un tessuto pesante a corde<br />
rilevate.<br />
GROS: drappo <strong>di</strong> seta in cui la trama è inserita doppia ad ogni passo; noti il gros de Tours o quello<br />
<strong>di</strong> Napoli.<br />
GUARNACCA: sopravveste con aperture laterali per le braccia, <strong>di</strong> uso sia maschile che femminile.<br />
GUARNELLO: lunga tunica femminile cinta in vita, veste da casa o da lavoro; così chiamata è una<br />
stoffa mista <strong>di</strong> cotone, lino, canapa.<br />
INTERCULAS, INTERULAS: mutande.<br />
LAMA, LAMETTA: tessuto <strong>di</strong> seta laminato, ossia con una trama lanciata d’oro o argento filati o<br />
lamellari.<br />
LATESIN:tipo <strong>di</strong> seta o colore bianco celestino.<br />
LATTIZI: pelli <strong>di</strong> agnellini da latte.<br />
LISCI: belletti, trucchi.<br />
LUPO CERVIERO: lince.<br />
MAGIETA: piccola maglia o anellino metallico.<br />
MANGANO: macchina formata da due cilindri orizzontali che sostengono una cassa <strong>di</strong> legno piena<br />
<strong>di</strong> pesi, attorno ai quali veniva avvolto il tessuto, che, così compresso, acquistava in lucentezza.<br />
MANOPOLE: guanti.<br />
MANTELLO: drappo da avvolgere attorno al corpo sopra gli abiti, a scopo <strong>di</strong> proteggersi dalle<br />
intemperie. Non ha una forma precisa.<br />
MANTO: mantello o tipo <strong>di</strong> tessuto <strong>di</strong> seta.<br />
MAREZZATO O MOIRÉ: presenta effetti decorativi ad onde, secondo i riflessi <strong>della</strong> luce; sono<br />
ottenuti piegando e poi schiacciando tessuti ad armature a coste trasversali, <strong>di</strong> solito del tipo gros. Il<br />
proce<strong>di</strong>mento avviene spostando la trama con appositi arnesi lignei e fissando poi il tutto me<strong>di</strong>ante<br />
la calandra, una pressa fortemente riscaldata.<br />
MASPILLI: bottoni.<br />
MAZZOCCHIO: cerchio imbottito che si cala sulla fronte per fissare il sottostante berretto o<br />
cappuccio.<br />
MEÇANELLO: tessuto misto <strong>di</strong> lana e lino.<br />
MESCOLATO: tessuto con fili <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi colori.<br />
MEZZALANA: tessuto <strong>di</strong> poco prezzo misto <strong>di</strong> lana, canapa o lino.<br />
MOZZETTA: corta mantellina, a volte rivestita <strong>di</strong> pelliccia.<br />
MUNEGHINA: tela ruvida <strong>di</strong> lino o canapa tessuta nei conventi.<br />
NASICCIO: drappo <strong>di</strong> seta intessuto d’oro, <strong>di</strong> origine cinese, così chiamato da Marco Polo.<br />
ORARIO: panno <strong>di</strong> lino per avvolgere il viso.<br />
ORMESIN: tessuto <strong>di</strong> seta che deve il suo nome all’isola <strong>di</strong> Ormuz, situata all’entrata del golfo<br />
Persico.<br />
OSTEA: detta anche hostea, è un tipo <strong>di</strong> tessuto.<br />
PADOVANELLA: panno <strong>di</strong> lana prodotto tanto in Italia quanto in Spagna.<br />
PASSETTI: cinghiette, cinturini.<br />
PATERNOSTRI: grani, ciondoli sferici, bossoli.<br />
PATITOS: zoccoli.<br />
10
PAVION: tessuto <strong>di</strong> stamigna a fili ra<strong>di</strong> e uguali tanto <strong>di</strong> trama quanto <strong>di</strong> or<strong>di</strong>to; era usato per le<br />
cortine dei letti o dei tabernacoli (da qui il termine “pa<strong>di</strong>glione”).<br />
PENULA: veste liturgica <strong>di</strong> forma circolare con apertura centrale per far passare il capo.<br />
PEROLO: ciondolo, pendente o bottone a forma <strong>di</strong> pera.<br />
PIANELE: calzature senza tacco.<br />
PIGNOLATO: panno misto grezzo con la superficie a piccoli no<strong>di</strong>, detti pinoli.<br />
POLANA: flanella.<br />
PONTO MORESCO: punto saraceno, puncetto a no<strong>di</strong>.<br />
POSTA: fascia <strong>di</strong> seta che si cinge in vita o attorno ad alcuni copricapo.<br />
PURGO: magistratura incaricata <strong>di</strong> verificare che i vari tessuti <strong>di</strong> lana fossero stati realizzati col<br />
numero <strong>di</strong> fili <strong>di</strong> or<strong>di</strong>to regolamentare per ciascuna tipologia.<br />
QUARTATO: <strong>di</strong>viso in quattro parti.<br />
RASSA: rascia.<br />
RAZZESE: panno proveniente da Arras.<br />
RAZZO: arazzo, dalla città <strong>di</strong> Arras.<br />
REFE: filo <strong>di</strong> lino.<br />
RESTAGNO: telette con oro e argento tirati.<br />
RIGADIN: tessuto ad armatura tela costituito da lana legata a intervalli regolari da gruppi <strong>di</strong> fili <strong>di</strong><br />
seta.<br />
RIGADINI TEDESCHI: tessuti misti <strong>di</strong> lino e cotone.<br />
ROMAGNOLO: panno <strong>di</strong> poco prezzo proveniente dalla Romagna.<br />
SACHOZA: borsa.<br />
SAIA: armatura semplice; tessuto <strong>di</strong> lana secca con or<strong>di</strong>to e trama <strong>di</strong> stame ad intreccio <strong>di</strong>agonale<br />
(anche in lino).<br />
SAIO: veste maschile o tonaca monacale.<br />
SARABULLE, ZARABULLE: mutande <strong>di</strong> ridotte <strong>di</strong>mensioni, una sorta <strong>di</strong> slip ante litteram.<br />
SARANGONA: tessuto <strong>di</strong> lana <strong>di</strong> origine turca.<br />
SARANTASIMO: tessuto <strong>di</strong> azze ( ricor<strong>di</strong>amo che l’accia, o azza, è il filo <strong>di</strong> lino, cotone e seta, o<br />
sinonimo <strong>di</strong> anima) e lana.<br />
SAZO: assaggio, ossia controllo <strong>della</strong> qualità delle stoffe effettuato da personale specializzato.<br />
SCAPOLARE: tipico degli or<strong>di</strong>ni monastici, è un lungo rettangolo <strong>di</strong> stoffa con apertura laterale,<br />
che cade sul petto e sulla schiena e rimane aperto ai lati.<br />
SCARLATTO: sargia o color rosso cremisi, oppure panno pregiato <strong>di</strong> colore acceso.<br />
SCHIAVINA: detto anche stiavina, è un tessuto <strong>di</strong> lana ruvido usato spesso per far coperte, ma<br />
in<strong>di</strong>cava anche un corto mantello con cappuccio usato dai marinai. Il nome è deriva dal fatto che il<br />
tipo <strong>di</strong> tessuto era originario <strong>della</strong> Schiavonia, l’o<strong>di</strong>erna Dalmazia.<br />
SCHIETO: semplice, ossia <strong>di</strong> un solo colore.<br />
SCHILLATO, SGHIRATTO: scoiattolo.<br />
SCIAMITO: stoffa <strong>di</strong> seta pesante.<br />
SCOTO: tessuto spinato <strong>di</strong> lana proveniente dalla Scozia.<br />
SIVIGLIA: tessuto <strong>di</strong> seta proveniente dell’omonima città spagnola, che con Cordoba e Toledo fu<br />
una delle capitali <strong>della</strong> seta nella Spagna dei secoli XII e XIII .<br />
SOATTO: tipo <strong>di</strong> cuoio leggero.<br />
SOGGOLO: fascia da avvolgere attorno al viso, passando sotto il mento. Acconciatura che copre<br />
capo e collo.<br />
SOTTANA: veste lunga da portare sotto gli altri indumenti.<br />
SPALIERE: arazzi o stoffe con le quali venivano rivestiti stalli o schienali <strong>di</strong> se<strong>di</strong>li lignei.<br />
STAME: filo <strong>di</strong> lana pettinata più attorto del solito, usato per l’or<strong>di</strong>to.<br />
STAMETTO: panni <strong>di</strong> lana molto pelosi e ispi<strong>di</strong>; tessuto a foggia <strong>di</strong> fascia stretta, da ciascun lato<br />
del quale la trama tagliata e sfilacciata sopravanza i fili <strong>di</strong> or<strong>di</strong>to che la tengono unita.<br />
11
STAMIGNA: tessuto <strong>di</strong> lana o lino a trama larga, impiegato per il confezionamento <strong>di</strong> camicie; si<br />
sa che già esisteva alla fiera <strong>di</strong> Troyes nel XIV secolo. Tessuto <strong>di</strong> lana sottile e resistente.<br />
STANFORTINO: tessuto dall’or<strong>di</strong>to (stame) rinforzato.<br />
TINTILANA: realizzato con lana tinta prima <strong>della</strong> filatura.<br />
TRUFALDA: tipo <strong>di</strong> tessuto.<br />
VAIO, VARO: vaio, animaletto dalla pelliccia pregiata simile allo scoiattolo.<br />
VALENZANA: stoffa leggera <strong>di</strong> lana pettinata.<br />
VANTIS: guanti.<br />
VARNAZA: guarnacca.<br />
VERGATO: a righe orizzontali o verticali.<br />
ZEBELIN: zibellino.<br />
ZENDADO, CENDATO: stoffa <strong>di</strong> seta leggera, usata solitamente per foderare.<br />
ZETANO, ZETANINO: tessuto originario <strong>della</strong> città cinese <strong>di</strong> Zayton, famosa per le sue seterie. E’<br />
un raso.<br />
ZUPON, ZIPON: giubbone, farsetto maschile da indossare sopra la camicia.<br />
ESEMPI DI ABBIGLIAMENTO DUECENTESCO<br />
Figura 1: conta<strong>di</strong>ni al lavoro, Bibbia Maciejowski, particolare <strong>di</strong> pagina miniata, sec. XIII, John Pierpont<br />
Morgan Library, New York<br />
Grazie alla figura qui sopra abbiamo la possibilità <strong>di</strong> capire quali fossero gli indumenti intimi<br />
portati dagli uomini del Duecento: il conta<strong>di</strong>no seminudo, infatti, calza un paio <strong>di</strong> brache, sorta <strong>di</strong><br />
pantaloni corti <strong>di</strong> lino (o <strong>di</strong> tessuto misto per i meno abbienti) sostenuti in vita da un’allacciatura a<br />
coulisse e dotati <strong>di</strong> due spacchi sulle cosce grazie ai quali la braca poteva essere rialzata, legandola<br />
al cordone in vita me<strong>di</strong>ante appositi laccetti. E’ infatti ciò che ha fatto il nostro conta<strong>di</strong>no: notiamo<br />
il cordoncino <strong>della</strong> vita che scende ad allacciarsi con la cor<strong>della</strong> fissata in fondo allo spacco <strong>della</strong><br />
braca; in questo modo chi lavora può avere più agio nei movimenti. L’uomo più a destra, oltre a<br />
12
sollevare le brache, ha rimborsato attorno alla vita la camisia, indumento <strong>di</strong> lino o tessuto misto, in<br />
genere bianco, da portare sciolto e lungo almeno fino alle ginocchia. Per le donne, il medesimo<br />
indumento è detto sotano.<br />
Gli uomini del popolo portavano solamente le brache come intimo, mentre i più ricchi potevano<br />
permettersi le sarabullas (o sararbulle, zorabulle), veri e propri slippini in lino chiusi a coulisse e<br />
resi aderenti grazie al taglio e alle cuciture, da portare sotto alle brache.<br />
Il trebbiatore vestito <strong>di</strong> blu ci mostra altri due capi che concorrevano a realizzare l’abbigliamento<br />
base <strong>di</strong> un uomo del XIII secolo: agganciate in vita alle brache porta infatti le calzebrache, antenate<br />
dei nostri pantaloni; erano <strong>di</strong>vise (da qui il nostro uso <strong>di</strong> <strong>di</strong>re “un paio <strong>di</strong> braghe”), realizzate in<br />
genere in panno <strong>di</strong> lana e a volte rivestite internamente <strong>di</strong> tela sottile <strong>di</strong> lino o <strong>di</strong> altro tessuto.<br />
Dotate <strong>di</strong> cordelle, potevano essere –appunto- legate in vita, ma si potevano anche portare scese e<br />
fissate attorno al ginocchio per maggior praticità. Il nostro uomo indossa anche la gonnella (o<br />
tunica): è un indumento lungo almeno fino alle ginocchia (sino alle caviglie per ricchi e nobili),<br />
attillato al busto e più abbondante al <strong>di</strong> sotto <strong>della</strong> vita, con maniche tubolari e scollo solitamente<br />
circolare (ma ne esistevano anche quadri o a “V”) con un’apertura sul davanti per essere infilato più<br />
co<strong>moda</strong>mente dalla testa; è stretta attorno alla vita da una cintura chiamata cingulum (se <strong>di</strong> corda) o<br />
corrigia (se <strong>di</strong> cuoio). Notiamo che la gonnella in questione si apre davanti a portafoglio e ci lascia<br />
vedere una foderatura interna, probabilmente in tela <strong>di</strong> lino o tessuto misto; tanto la fodera quanto<br />
questo tipo <strong>di</strong> apertura erano opzionali, esistendo anche gonnelle non foderate (per chi non se lo<br />
poteva permettere) e senza taglio anteriore, essendo quest’ultimo più che altro ricavato sulle<br />
gonnelle da lavoro. Notiamo anche come ai polsi delle maniche sia stato praticato un taglio<br />
longitu<strong>di</strong>nale per facilitare l’uscita <strong>della</strong> mano e come siano rivoltati all’in<strong>di</strong>etro per maggior<br />
praticità.<br />
La gonnella poteva in<strong>di</strong>care, in base ad alcuni particolari, la ricchezza e il rango sociale <strong>di</strong> chi la<br />
indossava: se un lavoratore la portava corta al ginocchio, a volte aperta a portafoglio, con tagli alle<br />
maniche e allo scollo, realizzata in tessuti poco costosi come quelli misti o le lane <strong>di</strong> scarsa qualità,<br />
un ricco e nobile signore la indossava in ottima lana, lino finissimo o seta, con foderatura in tela<br />
fine, attillatissima al busto ed estremamente abbondante al <strong>di</strong> sotto, lunga fino alle caviglie e chiusa<br />
attorno allo scollo e ai polsi da bottoni detti maspilli, pomelli o peroli. Per rendere la gonnella larga<br />
sotto i fianchi si faceva uso <strong>di</strong> gheroni, ovvero triangoli <strong>di</strong> stoffa cuciti l’uno accanto all’altro;<br />
naturalmente un indumento ricco poteva anche essere ingentilito da passamanerie, ricami (detti acu<br />
pictura o ars plumaria), applicazioni <strong>di</strong> perle, gemme, pietre preziose, liste (ovvero fasce) intessute<br />
d’oro; poteva essere realizzato in tessuto operato e tinto in colori vivaci. Per il Duecento, il non plus<br />
ultra dell’eleganza era la gonnella in seta operata con motivi circolari detti rotae, orbicula,<br />
compaxis o rotellas, tinta in colori molto brillanti, arricchita da bottoni in avorio, argento, oro e<br />
decorata da liste d’oro allo scollo, ai polsi e al bordo inferiore, oppure da fasce arricchite <strong>di</strong> perle e<br />
preziosi.<br />
Oltre alla gonnella esisteva anche un abito da lavoro chiamato guarnello, che prendeva il suo nome<br />
dal tessuto <strong>di</strong> cotone col quale era realizzato; se la gonnella poteva essere un capo “<strong>di</strong> tutti i giorni”<br />
quanto <strong>di</strong> lusso, il guarnello, portato da ambo i sessi, era un indumento de<strong>di</strong>cato unicamente al<br />
lavoro, fosse esso in casa o nei campi.<br />
Ma torniamo ai nostri trebbiatori: tutti portano in testa un copricapo bianco, probabilmente in tela <strong>di</strong><br />
lino, detto generalmente cofia o camauro; era usato unicamente dal sesso maschile e poteva venire<br />
indossato da solo oppure sotto un altro copricapo, fosse esso un cappello, un cappuccio o una<br />
berretta. Dall’analisi <strong>di</strong> varie miniature ed affreschi si evince come non tutti portassero la cofia:<br />
nelle miniature <strong>della</strong> Bibbia Maciejowski ricorre spesso, ma per esempio nel Salterio <strong>di</strong> Santa<br />
Elisabetta non la porta praticamente nessuno; si pensa dunque che il suo uso <strong>di</strong>pendesse dalle<br />
abitu<strong>di</strong>ni locali e dalla situazione.<br />
Ai pie<strong>di</strong> quasi tutti i conta<strong>di</strong>ni –salvo quello scalzo- calzano bassi stivaletti con un’allacciatura<br />
attorno alla caviglia; le calzature, chiamate caligas (scarpe basse) o stivalli (scarpe alte alla<br />
caviglia), erano realizzate in pelle e cuoio, chiuse sul davanti o sul lato me<strong>di</strong>ante lacci oppure<br />
13
fibbie, laddove queste ultime erano molto chic, soprattutto se poste lateralmente. La pelle poteva<br />
essere in tinta naturale oppure colorata: si hanno scarpe delle <strong>di</strong>verse tonalità del marrone, nere, ma<br />
anche (per i ricchi) rosse, bianche o realizzate in stoffa ricamata e colorata. Non era strettamente<br />
necessario per gli uomini del tempo indossare scarpe: potevano infatti portare le calze solate,<br />
calzebrache al piede delle quali era stata fissata una suola <strong>di</strong> cuoio; i conta<strong>di</strong>ni e i popolani<br />
potevano portare zoccoli <strong>di</strong> legno o ciocie <strong>di</strong> corda, mentre i più sfortunati andavano scalzi. Non<br />
esisteva lo stivale come è concepito in epoca moderna, alto fino al ginocchio.<br />
In definitiva, l’abbigliamento base dell’uomo duecentesco era costituito da:<br />
• Brache<br />
• Calzebrache<br />
• Camisia<br />
• Gonnella o guarnello<br />
• Caligas o stivalli<br />
• Cofia/camauro<br />
• Cingulum/corrigia<br />
In realtà il vero e proprio “completo”, così come lo concepiamo oggi, era detto roba e composto da:<br />
• Gonnella<br />
• Guarnacca<br />
• Mantello o pelle<br />
Laddove la gonnella è l’equivalente <strong>della</strong> nostra camicia, la guarnacca <strong>della</strong> giacca che usiamo<br />
portare abbinata coi pantaloni e il mantello del cappotto; naturalmente erano sottointesi l’intimo, le<br />
scarpe e i copricapo. Analizzeremo in seguito il mantello e la guarnacca; ora osserviamo qualche<br />
altra miniatura.<br />
Figura 2: popolano al lavoro, Salterio <strong>di</strong> Santa Elisabetta, particolare <strong>di</strong> pagina miniata, sec. XIII, Museo<br />
Archeologico Nazionale, Cividale del Friuli<br />
L’uomo <strong>di</strong> figura 2 indossa una gonnella rossa con scollo quadro e maniche a tubo, percorsa da una<br />
sottile profilatura bianca agli orli; è corta al ginocchio e leggermente rimborsata in vita,<br />
nascondendo la cintura. Il popolano porta anche calze solate color turchino; in testa non ha<br />
copricapo e i capelli sono regolati corti, a caschetto.<br />
14
Figura 3: conta<strong>di</strong>no intento al lavoro, Salterio <strong>di</strong> Santa Elisabetta, particolare <strong>di</strong> pagina miniata, sec. XIII,<br />
Museo Archeologico Nazionale, Cividale del Friuli<br />
Sempre gonnella rossa profilata <strong>di</strong> bianco, con scollo quadro e maniche tubolari per quest’altro<br />
popolano; qui però si notano bene lo sbuffo delle brache e la calzabraca scura agganciata in vita,<br />
forse solata o forse abbinata a stivaletti <strong>di</strong> pelle.<br />
Figura 4: mietitore, Salterio <strong>di</strong> Santa Elisabetta, particolare <strong>di</strong> pagina miniata, sec. XIII, Museo Archeologico<br />
Nazionale, Cividale del Friuli<br />
15
Ancora gonnella identica alle due precedenti, scarpe <strong>di</strong> pelle nera allacciate alla caviglia,<br />
calzebrache turchine; qui, però, l’interesse è suscitato dal copricapo, un cappello a tesa larga<br />
probabilmente in feltro e dotato <strong>di</strong> apposita cor<strong>della</strong> da passare sotto al mento per tenerlo ben<br />
assestato in capo. Nell’Italia del Duecento si usavano tanto cappelli in feltro o paglia, quanto<br />
berrette in feltro, panno <strong>di</strong> lana, seta; esistevano anche berrette in lana fatte a maglia con una<br />
tecnica ad ago (non esistevano i nostri ferri da maglia) chiamata Nadelbinde o Nälbil<strong>di</strong>ng. Molto<br />
usati anche i cappucci, in genere in lana foderata <strong>di</strong> tela, seta o pelliccia.<br />
Figura 5: carnefice intento a decapitare un uomo, Salterio <strong>di</strong> Santa Elisabetta, particolare <strong>di</strong> pagina miniata, sec.<br />
XIII, Museo Archeologico Nazionale, Cividale del Friuli<br />
Anche qui ricorre la gonnella rossa con scollo quadro e maniche tubolari, ora sollevata e rimborsata<br />
per avere più agio, lasciando vedere le brache e le calze solate. Interessante è il nodo <strong>della</strong> cintura<br />
<strong>di</strong> pelle che fissa alla vita dell’uomo il fodero <strong>della</strong> spada; le cinture potevano essere più o meno<br />
alte, dotate <strong>di</strong> fibbia metallica o -come in questo caso- allacciate me<strong>di</strong>ante stringhe passanti in<br />
occhielli. Le cinture più ricche erano in genere sottili e avevano un lunghissimo capo pendente che<br />
terminava in un puntalino prezioso, abbinato con una bella fibbia e magari con borchiette decorative<br />
applicate lungo tutta la lunghezza <strong>della</strong> cinta; si potevano anche avere leggiadre cinture <strong>di</strong> stoffa,<br />
realizzate me<strong>di</strong>ante una speciale tecnica <strong>di</strong> tessitura chiamata “a tavolette” o “a cartoni”, utile per<br />
ottenere bordure o passamanerie; per i nobili e i sovrani la stoffa poteva essere anche ornata da<br />
pietre preziose, applicazioni d’oro o d’argento, gemme o perle.<br />
Il nostro carnefice bran<strong>di</strong>sce una spada a una mano, arma tipica del Duecento: le tecniche<br />
principali <strong>di</strong> combattimento in<strong>di</strong>viduale erano infatti spada a una mano e scudo oppure spada e<br />
boccoliere, essendo quest’ultimo una protezione metallica circolare dotata <strong>di</strong> umboncino, atta a<br />
proteggere la mano armata; per il corpo a corpo si usavano anche la daga (tipo <strong>di</strong> arma corta a<br />
pugnale), mentre nelle battaglie frequentissimo era l’uso <strong>di</strong> lance, picche e armi in asta; si<br />
impiegavano anche archi e balestre.<br />
Il venerabile vecchio che sta subendo il martirio porta sulle spalle un manto azzurro in tessuto<br />
operato con un motivo molto frequente in periodo me<strong>di</strong>evale: le tre sfere sono dette “cintamani” ed<br />
originano in zona persiano-sassanide; si <strong>di</strong>ffondono in Europa a partire dal VII secolo circa e<br />
16
imangono in voga fino al Trecento. Il cintamani rappresenta le sfere celesti e viene in genere<br />
realizzato ad opera, ossia <strong>di</strong>rettamente intessuto nei drappi.<br />
Figura 6: allegoria dell’inverno, Salterio <strong>di</strong> Santa Elisabetta, particolare <strong>di</strong> pagina miniata, sec. XIII, Museo<br />
Archeologico Nazionale, Cividale del Friuli<br />
Ecco un altro mantello: questo in particolare è una pelle, ossia un vello animale conciato ed<br />
impiegato per <strong>di</strong>fendersi dai rigori invernali. In questo caso il fatto che l’uomo porti il pelo al <strong>di</strong><br />
fuori rappresenta un’eccezione: è solo nel XIX secolo, infatti, che le pellicce si cominciano a<br />
portare col vello all’esterno, mentre durante i secoli passati era posto all’interno. Le pellicce erano<br />
portate da tutte le classi sociali, <strong>di</strong>stinguendosi in base alla qualità: i popolani indossavano pelli<br />
grezze <strong>di</strong> capra, montone o simili, pesanti e con basso potere <strong>di</strong> scaldare; i ricchi foderavano<br />
mantelli, vesti, sopravvesti, scarpe e berrette con pellicce leggere, ma dall’elevato potere <strong>di</strong> scaldare<br />
come il vaio (scoiattolo argentato), l’ermellino, la martora, lo zibellino, la lince (chiamata “lupo<br />
cerviero”). In uso erano anche le pelli <strong>di</strong> coniglio, volpe, gatto selvatico; curiosa era la voga dei<br />
lattizzi, ovvero delle pelli <strong>di</strong> agnellino appena nato, considerate pregiate e delicate.<br />
Notiamo che il vecchio rappresentato nella miniatura calza dei bassi stivalli in pelle nera, con un<br />
piccolo risvolto.<br />
17
Figura 7: giovane uomo con cappuccio, particolare <strong>di</strong> pagina miniata, Bibbia Maciejowski, sec. XIII, John<br />
Pierpont Morgan Library, New York<br />
Il giovane <strong>di</strong> figura 7 indossa un cappuccio molto comune nel Duecento e chiamato cocolla (cogola,<br />
bardococolla), <strong>di</strong>scendente del romano cucullus; come si può vedere, non copre solo la testa ma<br />
anche le spalle, grazie a una falda a mantellina che scende sul busto. Solitamente la cocolla era in<br />
lana, foderata all’interno <strong>di</strong> tela fine o, per i ricchi, <strong>di</strong> pelliccia pregiata; poteva avere una piccola<br />
apertura alla gola dotata <strong>di</strong> maspilli, per facilitare l’atto d’infilarla.<br />
L’uomo rappresentato dalla miniatura ostenta un’acconciatura molto in voga: capelli arricciati col<br />
ferro caldo, pettinati all’in<strong>di</strong>etro e tagliati sotto le orecchie, frangia corta con ricciolini.<br />
18
Figura 8: uomini intenti al duello, particolare <strong>di</strong> pagina miniata, Codex Manesse, secc. XIII-XIV, Heidelberg,<br />
Biblioteca dell’Università<br />
I due giovini signori che qui duellano quasi con leggiadria portano gonnelle abbastanza lunghe, ma<br />
aperte a portafoglio e rialzate in vita, con scollo circolare e maniche a tubo, calzebrache dai vivaci<br />
colori e calighe, ovvero scarpe basse; notiamo che uno porta le calzature in pelle nera, allacciate<br />
lateralmente, mentre l’altro ha scarpe probabilmente realizzate in tessuto decorato con ricami o<br />
effetto d’opera. Entrambi calzano guanti in morbida pelle bianca, dalla manopola svasata,<br />
leggermente appuntita; queste cirotecas (così erano chiamate all’epoca) erano considerate il<br />
massimo dell’eleganza e portate da nobili e da alti ecclesiastici. Altri tipi <strong>di</strong> cirotecas potevano<br />
essere quelli in pelle <strong>di</strong> vari colori, morbida o più resistente (tipici quelli in pelle <strong>di</strong> camoscio),<br />
quelli in stoffa ricamata o ingentilita da applicazioni <strong>di</strong> metalli preziosi, perle, gemme. I sovrani<br />
indossavano lussuosissimi guanti in seta ricamata; ricchi erano anche i guanti rivestiti internamente<br />
<strong>di</strong> pelliccia.<br />
Il guerriero a sinistra ha in capo la cofia e un cappuccio <strong>di</strong> panno con bordo rinforzato;<br />
probabilmente si tratta <strong>di</strong> un cappuccio a gote, chiamato così perché <strong>di</strong> solito è indossato a coprire<br />
completamente il capo e il collo, con il bordo rinforzato a trapuntatura (detto mazzocchio) che<br />
incornicia il volto, una punta più o meno lunga (chiamata becchetto) a pendere <strong>di</strong>etro la testa e una<br />
corta falda (la foggia) a coprire la gola, senza tuttavia scendere sulle spalle. Il nostro duellante<br />
probabilmente lo porta nella maniera alternativa, vale a <strong>di</strong>re con il mazzocchio calcato sul cranio, il<br />
becchetto a pendere su un’orecchia e la foggia sull’altra.<br />
Il guerriero a destra ostenta invece la tipica acconciatura maschile del periodo: capelli tagliati poco<br />
sotto le orecchie, arricciati e resi bombati col ferro caldo, più corta frangetta bombata (in Francia<br />
detta dorelot) sulla fronte. In capo ha un serto <strong>di</strong> foglie e fiori: questa non è una stranezza per<br />
19
l’epoca, perché tanto gli uomini quanto le donne amavano circondarsi il capo <strong>di</strong> coroncine <strong>di</strong> fiori o<br />
cerchietti preziosi.<br />
I due uomini impugnano nella destra una spada a una mano con pomo a <strong>di</strong>sco e nella sinistra un<br />
boccoliere, usato per proteggere dai colpi le <strong>di</strong>ta <strong>della</strong> mano armata.<br />
Nella miniatura compaiono anche tre fanciulle <strong>di</strong> alto rango, che ostentano tre <strong>di</strong>fferenti<br />
acconciature alla <strong>moda</strong>: quella più a sinistra porta il capo scoperto (tipico delle nubili), i capelli<br />
sciolti e forse ondulati col ferro caldo, nonché una coroncina; quella centrale ha un pannicello (un<br />
fazzoletto decorato con leggiadri ricami o liste colorate) posato sulla chioma e quella all’estrema<br />
destra porta invece la glympa, acconciatura molto frequentata dalle donne sposate, che si riteneva<br />
dovessero coprire il capo con un velo. La glympa è composta <strong>di</strong> due veli, uno che passa sotto il<br />
mento formando un soggolo ed è fermato in cima al capo da alcuni spilli e uno che scende dal capo,<br />
coprendolo e fluendo sulle spalle.<br />
Il velo, imposto alle donne maritate dalla chiesa, doveva teoricamente essere semplice, magari in<br />
lino bianco, privo <strong>di</strong> ornamenti e tinte vivaci; le donne, invece, trovarono il modo <strong>di</strong> farlo <strong>di</strong>venire<br />
un prezioso elemento d’eleganza: le signore portavano veli <strong>di</strong> seta tanto leggera da essere<br />
trasparente, oppure li listavano d’oro, li impreziosivano con ricami e li facevano tingere in bei<br />
colori.<br />
Per quanto riguarda la <strong>moda</strong> femminile, ve<strong>di</strong>amo ora alcune miniature.<br />
Figura 9: nobiluomo e signora, particolare <strong>di</strong> pagina miniata, Codex Manesse, secc. XIII-XIV, Heidelberg,<br />
Biblioteca dell’Università<br />
La bionda e graziosa fanciulla <strong>di</strong> figura 9 indossa una gonnella <strong>di</strong> color rosato, attillata al busto e<br />
molto abbondante al <strong>di</strong> sotto <strong>della</strong> vita, con scollo ovale e maniche tubolari; la snellezza del punto<br />
vita è sottolineata da una lunga corrigia (detta anche zona), probabilmente in pelle, decorata da<br />
borchiette ornamentali. I polsi <strong>della</strong> veste sono decorati, così come lo scollo; il tessuto fluisce fino a<br />
terra, accumulandosi sui pie<strong>di</strong>: probabilmente questa gonnella è stata scampanata inserendo gheroni<br />
20
<strong>di</strong> stoffa a partire dai fianchi, in modo da ampliarne notevolmente la circonferenza con uno sciupio<br />
<strong>di</strong> tessuto che significava ricchezza. Un abito così largo e abbondante impacciava anche il<br />
cammino, comunicando l’idea che chi lo indossava fosse tanto abbiente da permettersi <strong>di</strong> non<br />
camminare spesso, avendo portantine e carrozze a propria <strong>di</strong>sposizione; un <strong>di</strong>scorso analogo si può<br />
fare anche per altre costrizioni <strong>della</strong> <strong>moda</strong>, quali per esempio il busto molto attillato <strong>di</strong> certi abiti,<br />
che irrigi<strong>di</strong>va i movimenti, le maniche estremamente ampie oppure i graziosi zoccoletti con suola <strong>di</strong><br />
legno e passanti <strong>di</strong> pelle chiamati patitos, che i nobili e i ricchi <strong>di</strong> entrambi i sessi calzavano sopra le<br />
scarpe: questi rendevano lo spostarsi un atto <strong>di</strong>fficoltoso, lasciando sottintendere, come prima detto,<br />
che chi li portava non camminasse spesso. I patitos più eleganti erano in legno bianco, con passanti<br />
<strong>di</strong> pelle morbida pure bianca.<br />
Notiamo come ci sia ben poca <strong>di</strong>fferenza tra l’abbigliamento maschile e quello femminile: entrambi<br />
indossano abiti lunghi (l’uomo lo porta fino alle caviglie, la donna a coprire le scarpe), stretti al<br />
busto e abbondanti sotto, con maniche tubolari e scollo ovale; l’uomo ha lo scollo chiuso da bottoni<br />
e indossa una cintura analoga a quella <strong>della</strong> donna; entrambi hanno il capo cinto da una coroncina<br />
preziosa. Durante tutto l’alto me<strong>di</strong>oevo e fino al Duecento non vi sarà grande <strong>di</strong>stinzione tra i sessi<br />
nel modo <strong>di</strong> vestire, o non perlomeno nelle classi abbienti: i popolani si <strong>di</strong>stinguevano invece dalle<br />
loro mogli perché portavano gonnelle corte al ginocchio, comode per lavorare, ma la <strong>di</strong>fferenza si<br />
fermava qui. Perché si crei un <strong>di</strong>scrimine tra <strong>moda</strong> maschile e femminile dobbiamo aspettare la<br />
metà del Trecento, quando le vesti degli uomini (soprattutto quelle dei ricchi) si faranno sempre più<br />
corte ed attillate, laddove quelle delle signore resteranno fluenti.<br />
La donna in rosa porta quasi sicuramente sotto la gonnella un indumento intimo analogo alla<br />
camisia che indossa l’uomo: bianca, in tela fine <strong>di</strong> lino e portata sciolta, è forse solo un poco più<br />
lunga e si chiama sotano; per quanto riguarda l’intimo, le donne stringevano il seno con una fascia<br />
<strong>di</strong> stoffa che poteva servire a tenerlo fermo, ma anche a comprimerlo o a tenerlo alto per farlo<br />
risaltare; un equivalente alle sarabullas maschili potevano essere le interulas o interculas, antenate<br />
delle mutande portate pare solo dalle donne più agiate. Sembra che le popolane, e le conta<strong>di</strong>ne in<br />
particolare, si servissero del sotano per creare una sorta <strong>di</strong> “pannolone” protettivo secondo questo<br />
proce<strong>di</strong>mento: l’orlo posteriore <strong>della</strong> veste veniva fatto passare in mezzo alle gambe, rialzato e<br />
rimborsato in vita me<strong>di</strong>ante una cintura; pare che questo trucco fosse usato anche dagli uomini,<br />
inserendo la falda <strong>della</strong> veste nel cordone <strong>di</strong> chiusura delle brache. Le donne non portavano<br />
calzebrache, ma calze in tela alte fino al ginocchio e sostenute grazie a un cinturino.<br />
La signora intenta a giocare a scacchi nella miniatura che segue indossa sopra la gonnella una<br />
ampia guarnacca: era questa l’equivalente <strong>della</strong> sopravveste maschile, poiché anche per le donne<br />
valeva il completo chiamato roba e costituito <strong>di</strong> gonnella, guarnacca e mantello. Notiamo che la<br />
guarnacca in questione ha maniche corte e svasate che lasciano vedere quelle attillate <strong>della</strong><br />
gonnella, e che è foderata internamente <strong>di</strong> tessuto fine; lo scollo è ovale e poco profondo, l’abito<br />
viene portato sciolto, senza cintura. Dalla guarnacca emerge la punta <strong>di</strong> una scarpina nera: le donne<br />
indossavano caligas <strong>di</strong> pelle in vari colori, allacciate con stringhe o fibbie, ma anche scarpine in<br />
stoffa ricamata o decorata; gli stivalli erano in genere d’appannaggio maschile, anche se non<br />
sempre. Una voga tipica del XII e del XIV secolo (meno esagerata invece nel Duecento) era quella<br />
delle pigaches (termine del XII secolo) o poulaines (termine trecentesco): erano calzature dalla<br />
punta acuta, a volte talmente lunga che veniva tenuta sollevata me<strong>di</strong>ante un laccio che la ancorava<br />
alla caviglia.<br />
Per le popolane vi erano scarpe <strong>di</strong> pelle, zoccoli <strong>di</strong> legno o sandali.<br />
La donna intenta al gioco degli scacchi ha i capelli bion<strong>di</strong> e crespi come <strong>di</strong> rito, coperti solo da un<br />
corto velo can<strong>di</strong>do; il suo compagno calza il cappuccio a gote, in questo caso rivestito internamente<br />
<strong>di</strong> pelliccia pregiata, e porta un’ampia guarnacca senza maniche sopra la gonnella verde; ha scarpe<br />
in tessuto ricamato od operato.<br />
21
Figura 10: coppia <strong>di</strong> nobili che gioca a scacchi e musici, particolare <strong>di</strong> pagina miniata, Codex Manesse, secc.<br />
XIII-XIV, Heidelberg, Biblioteca dell’Università<br />
I musicisti, rappresentati più in piccolo, hanno gonnelle colorate e ornate da <strong>di</strong>versi giochi <strong>di</strong> colore:<br />
i due a sinistra le portano vergate, ossia attraversate da righe <strong>di</strong> colore <strong>di</strong>verso; quello a destra ne<br />
indossa una addogate, vale a <strong>di</strong>re a larghe fasce <strong>di</strong> colori contrastanti. Il percussionista al centro ha<br />
gonnella verde e cappuccio rosso gettato in<strong>di</strong>etro sulle spalle.<br />
A figura 11 ve<strong>di</strong>amo una giovane signora intenta a scegliere cinture e borsette da un ven<strong>di</strong>tore<br />
ambulante; non esistendo ancora le tasche, donne e uomini portavano borse in pelle o in tessuto,<br />
spesso a tracolla per gli uomini, anche appese in cintura per le donne; era uso che le fanciulle<br />
ricamassero belle borsette <strong>di</strong> stoffa, magari ornate da frange e nappine o applicazioni preziose, da<br />
regalare ai loro innamorati.<br />
La bella nobildonna indossa una fluente guarnacca smanicata, tenendone un lembo sollevato in un<br />
gesto che si vede frequentemente nelle miniature: era infatti un vezzo <strong>di</strong> <strong>moda</strong> per far vedere il<br />
sottostante tessuto <strong>della</strong> gonnella e, magari, intravedere la fodera preziosa (in seta, tessuto finissimo<br />
<strong>di</strong> lino o pelliccia) <strong>della</strong> guarnacca. La fanciulla è probabilmente nubile, perché porta la chioma<br />
scoperta e sciolta, ingentilita dalla celebre e frequentatissima acconciatura con ben<strong>della</strong> (soggolo <strong>di</strong><br />
stoffa) e corona, laddove quest’ultima può essere liscia, arricciata come nella miniatura o rivestita <strong>di</strong><br />
stoffe colorate, ricamate o impreziosite da applicazioni. Di solito l’anima <strong>della</strong> corona è in feltro<br />
rigido o cuoio.<br />
22
Figura 11: nobildonna e ven<strong>di</strong>tore ambulante, particolare <strong>di</strong> pagina miniata, Codex Manesse, secc. XIII-XIV,<br />
Heidelberg, Biblioteca dell’Università<br />
Un particolare elegante concesso solo alle donne <strong>di</strong> rango o comunque ben fornite <strong>di</strong> mezzi<br />
economici è quello che si nota nella figura 12: maniche a tubo che al polso <strong>di</strong>vengono larghissime e<br />
pendenti, intralciando i movimenti delle braccia. Quella delle maniche ampie e cadenti era una<br />
<strong>moda</strong> <strong>di</strong>ffusissima nel corso del XII secolo, poi quasi svanita nell’Italia del Duecento salvo alcune<br />
eccezioni: il Friuli, dove la <strong>moda</strong> seguiva l’uso germanico, Venezia, che sempre si <strong>di</strong>stingueva dal<br />
resto <strong>della</strong> penisola per le molteplici influenze culturali derivanti dai suoi contatti con popoli<br />
<strong>di</strong>versi, e la Puglia, terra dei normanni che seguivano l’uso nor<strong>di</strong>co delle maniche ampie. La<br />
miniatura qui analizzata appartiene a un salterio realizzato in Turingia e poi portato in Friuli già nel<br />
corso del XIII secolo, seguendo proprio uno spostamento <strong>di</strong> nobili germanici con posse<strong>di</strong>menti nelle<br />
terre patriarcali; la fanciulla rappresentata è dunque un esempio <strong>di</strong> donna nobile e ricca, che ostenta<br />
una gonnella con tessuto abbondantissimo sotto la vita, tanto che le si impila sui pie<strong>di</strong> e si<br />
abbandona sul pavimento. Lo scollo <strong>della</strong> veste pare quadro o “a V”, il busto è attillato e<br />
sottolineato da una corrigia, la chioma bionda sciolta e libera da veli come si conviene alle nubili.<br />
23
Figura 12: figura astrologica <strong>della</strong> Vergine, Salterio <strong>di</strong> Santa Elisabetta, particolare <strong>di</strong> pagina miniata, sec. XIII,<br />
Museo Archeologico Nazionale, Cividale del Friuli<br />
Un bell’esempio <strong>di</strong> roba femminile intesa come set completo <strong>di</strong> abiti lo abbiamo a figura 13, nella<br />
quale due donne ben vestite operano atti <strong>di</strong> devozione e carità: entrambe indossano una gonnella<br />
dalle maniche a tubo e i polsini ornati, sopra la quale portano una sopravveste ampia e abbondante<br />
dalle maniche larghe e pendenti, stretta in vita da una cintura che risulta nascosta da un rimborso.<br />
Questo tipo <strong>di</strong> veste <strong>di</strong> sopra segue, come nel caso <strong>della</strong> fanciulla in bianco, l’uso germanico.<br />
In capo le due donne portano veli colorati e quella <strong>di</strong> sinistra lascia anche vedere,<br />
nell’inginocchiarsi, un paio <strong>di</strong> calighe <strong>di</strong> cuoio marrone.<br />
24
Figura 13: pie donne, Salterio <strong>di</strong> Santa Elisabetta, particolare <strong>di</strong> pagina miniata, sec. XIII, Museo Archeologico<br />
Nazionale, Cividale del Friuli<br />
Ben abbigliate sono anche le donne <strong>di</strong> figura 14, colte mentre danzano al suono del tamburo <strong>di</strong> una<br />
loro compagna: indossano lunghissime gonnelle con le maniche a tubo e scollo ovale, con busto<br />
attillato e molto abbondanti al <strong>di</strong> sotto <strong>della</strong> vita; una ha un breve taglio allo scollo <strong>della</strong> veste,<br />
tenuto chiuso da una spilla circolare, e una lunga corrigia dal capo pendente. Entrambe portano in<br />
capo un velo can<strong>di</strong>do e calzano scarpe <strong>di</strong> pelle nera, così come entrambe portano mantelli –<br />
probabilmente in lana- foderati internamente in tessuto più fine; questi ultimi appaiono lunghi, ampi<br />
e senza cappuccio. Il mantello era un capo d’abbigliamento usato da entrambi i sessi e confezionato<br />
in <strong>di</strong>verse maniere: semplice rettangolo <strong>di</strong> stoffa da avvolgersi attorno alla persona per i meno<br />
abbienti, a mezza ruota o a ruota completa per i più benestanti, foderato internamente <strong>di</strong> lino, seta o<br />
pellicce più o meno pregiate, con o senza cappuccio, decorato o meno da ricami e liste (anche<br />
dorate), realizzato in tessuto unito oppure in preziosi drappi operati. Poteva arrivare fino ai pie<strong>di</strong>,<br />
come essere più corto; i mantelli per cavalcare, per esempio, raggiungevano appena il ginocchio.<br />
Solitamente il manto veniva chiuso con stringhe e lacci oppure con spille e fibule; in quest’ultimo<br />
caso, se la spilla appare appuntata sulla spalla destra si parla <strong>di</strong> allacciatura a clamide, se invece<br />
chiude il mantello sul petto, l’allacciatura è detta a piviale.<br />
25
Figura 14: donne danzanti e suonatrice <strong>di</strong> tamburo, particolare <strong>di</strong> pagina miniata, Bibbia Maciejowski, sec. XIII,<br />
John Pierpont Morgan Library, New York<br />
Le tre giovani che danzano a figura 15 indossano gonnelle analoghe, <strong>di</strong>stinte solo dal colore: strette<br />
al busto e cinte ai fianchi da una corrigia sottile, abbondanti al <strong>di</strong> sotto <strong>della</strong> vita grazie all’aggiunta<br />
<strong>di</strong> gheroni, tanto lunghe da accumularsi sui pie<strong>di</strong>; hanno scollo ovale chiuso da spille <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse<br />
forme, maniche tubolari. Le tre giovani donne hanno il capo scoperto, con i capelli ben pettinati e<br />
trattenuti soltanto sulla fronte da una sottile coroncina; come abbiamo detto, il fatto <strong>di</strong> portare i<br />
capelli sciolti o acconciati, ma comunque senza velo, era tipico delle nubili. É vero, anche le<br />
meretrici andavano solitamente in giro a chioma sciolta e senza velo, ma ciò si abbinava a specifici<br />
capi d’abbigliamento o segni <strong>di</strong> riconoscimento che ne in<strong>di</strong>cassero il mestiere: un cappuccio giallo<br />
(colore, questo, dell’infamia) o –in alcuni casi- vermiglio, con un sonaglio da falcone a pendere dal<br />
becchetto, un abito <strong>di</strong> color giallo, l’assenza <strong>di</strong> alcuni ornamenti e <strong>di</strong> certi tessuti consentiti solo alle<br />
donne “per bene” o, al contrario, l’esenzione dalle restrizioni suntuarie, applicate solo alle signore<br />
rispettabili.<br />
Accanto alle fanciulle vi è un musico il cui abito è per noi <strong>di</strong> notevole interesse: si tratta infatti <strong>di</strong><br />
una gonnella <strong>di</strong>visata, ossia bipartita in colori contrastanti nel senso longitu<strong>di</strong>nale, e accoltellata,<br />
vale a <strong>di</strong>re con l’orlo percorso da lunghi tagli. Quella delle vesti accoltellate, sforbiciate,<br />
stratagliate è una voga che si svilupperà molto nel corso dei secoli, raggiungendo il suo apice nel<br />
Cinquecento; nel XIII secolo è riservata prevalentemente agli in<strong>di</strong>vidui un po’ fuori dal comune<br />
quali i giullari e i musici. Notiamo che il nostro suonatore indossa anche calzebrache scure e scarpe<br />
basse in pelle nera, chiuse sul davanti del piede.<br />
26
Figura 15: suonatori e fanciulle danzanti, particolare <strong>di</strong> pagina miniata, Bibbia Maciejowski, sec. XIII, John<br />
Pierpont Morgan Library, New York<br />
Un altro esempio <strong>di</strong> abbigliamento femminile e dei suonatori lo abbiamo alla figura seguente, dove<br />
ritroviamo le fanciulle con le loro lunghe gonnelle e un musico dalla veste <strong>di</strong>visata in blu e<br />
marrone, nonché accoltellata; risulta accoltellata anche la camisia bianca che l’uomo porta sotto la<br />
sua estrosa gonnella. Notiamo come la ragazza in blu abbia sollevato l’orlo <strong>della</strong> veste, infilandone<br />
un lembo nella cintura, per aver più agio nei movimenti.<br />
Figura 16: David porta agli israeliti la testa <strong>di</strong> Golia, particolare <strong>di</strong> pagina miniata, Bibbia Maciejowski, sec.<br />
XIII, John Pierpont Morgan Library, New York<br />
27
Figura 17: nobile fanciulla, particolare <strong>di</strong> pagina miniata, Bibbia Maciejowski, sec. XIII, John Pierpont Morgan<br />
Library, New York<br />
Un ultimo esempio <strong>di</strong> abbigliamento femminile è questa bella giovane in rosso: la sua ricca<br />
gonnella, la corrigia lunghissima, la vezzosa borsetta in stoffa ricamata e ingentilita da nappine, il<br />
grande mantello foderato <strong>di</strong> pance <strong>di</strong> vaio, la linda corona con ben<strong>della</strong>, denunciano la sua<br />
con<strong>di</strong>zione signorile: è una fanciulla nobile che esprime il proprio rango attraverso lo sciupio <strong>di</strong><br />
tessuto, la pelliccia pregiata, gli accessori <strong>di</strong> classe. Notiamo il forte contrasto con la servitrice che<br />
la affianca, la quale indossa un semplice guarnello bianco, l’abito <strong>di</strong> chi lavora.<br />
28
Il nostro breve viaggio nella <strong>moda</strong> del Duecento termina qui. Speriamo <strong>di</strong> aver fornito ai lettori<br />
qualche utile spunto per avvicinarsi al vasto e complesso mondo del costume antico, o <strong>di</strong> aver<br />
stimolato un po’ la loro curiosità. Ci sarebbe molto altro da <strong>di</strong>re sull’abbigliamento duecentesco<br />
italiano, ma farlo in questa sede significherebbe scrivere centinaia <strong>di</strong> pagine: questo scritto è stato<br />
invece concepito come un vademecum, per cui la brevità è essenziale. Per coloro che desiderassero<br />
approfon<strong>di</strong>re, forniamo una bibliografia contenente una scelta <strong>di</strong> alcuni tra i tanti testi e<strong>di</strong>ti<br />
sull’argomento.<br />
29
BIBLIOGRAFIA<br />
1854<br />
BINI, Telesforo, I lucchesi a Venezia, Lucca, Reale Accademia lucchese, 1854, t. XV<br />
1880<br />
DEMAY, Germain, Le costume au moyen Age d’après les sceaux, Paris, Publications D. Dumoulin<br />
et C., 1880<br />
1892<br />
VILLEMONT, Marie (De), Histoire de la coiffure féminine, Paris, Librairie Renouard, 1892<br />
1898<br />
MERKEL, Carlo, Come vestivano gli uomini del «Decameron», Roma, s.e., 1898<br />
1905-1914<br />
MONTICOLO, Giovanni-BESTA, Enrico, I capitolari delle arti veneziane, voll. 3, Roma, Istituto<br />
Storico Italiano, 1905-1914<br />
1922<br />
SANGIORGI, Giorgio, Contributi allo stu<strong>di</strong>o dell’arte tessile, Milano-Roma, Bestetti e Tuminelli,<br />
1922<br />
1925<br />
BRENNI, Luigi, La tessitura serica attraverso i secoli, Como, Ostinelli, 1925<br />
GENONI, Rosa, La <strong>storia</strong> <strong>della</strong> <strong>moda</strong> attraverso i secoli, Bergamo, Istituto Italiano Arti Grafiche,<br />
1925<br />
1927<br />
BEVILACQUA, Alberto, Le stoffe seriche, in «Istituto veneto per le piccole industrie e per il<br />
lavoro», Venezia, 1927<br />
BRENNI, Luigi, Le seterie italiane, Milano, Ferrari, 1927<br />
PARDUCCI, Amos, Costumi ornati. Stu<strong>di</strong> sugli insegnamenti <strong>di</strong> cortigiania me<strong>di</strong>evali, Bologna,<br />
Zanichelli, 1927<br />
1928<br />
PODREIDER, Fanny, Storia dei tessuti d’arte in Italia, Bergamo, Istituto italiano <strong>di</strong> Arti grafiche,<br />
1928<br />
1934<br />
PASCHINI, Pio, Storia del Friuli, U<strong>di</strong>ne, Arti Grafiche Friulane, 1934 (2003)<br />
1942<br />
RUPPERT, Jacques, Le costume. L’antiquité et le Moyen Age, Paris, Flammarion, 1942<br />
1951<br />
AA.VV., Actes du Ier congrès international d’histoire du costume, Venezia, Centro Internazionale<br />
delle Arti e del Costume, 1951<br />
POST, Paul, La naissance du costume masculin moderne au XIV siècle, in Actes du Ier congrès<br />
international d’histoire du costume, Venezia, Centro Internazionale delle Arti e del Costume, 1951<br />
1952<br />
EVANS, Joan, Dress in me<strong>di</strong>eval France, Oxford, Clarendon Press, 1952<br />
1959<br />
GAUTIER, Léon, La Chevalerie, Paris, Arthaud, 1959<br />
HANSEN, Henry Harald, Storia del costume, Torino, Einau<strong>di</strong>, 1959<br />
VOLPE, Gioacchino-VOLPICELLI, Andrea-DELLA CORTE, Adalberto, La vita me<strong>di</strong>evale<br />
italiana nella miniatura, Roma, 1959<br />
1960<br />
BOURDARIAS, Jules-Desire, Histoire du costume. Du Moyen-Âge à la Reinassance, Cannes, Éd.<br />
De l’École moderne Française, 1960<br />
CECCHELLI, Carlo, La vita <strong>di</strong> Roma nel Me<strong>di</strong>oevo. Le arti minori e il costume, Roma, Fratelli<br />
Palombi E<strong>di</strong>tori, 1960<br />
30
1963<br />
KOHLER, Karl, A history of costume, New York, Dover Publications, 1963<br />
1964-69<br />
LEVI PISETZKY, Rosita, Storia del costume in Italia, voll. 5, Milano, Istituto E<strong>di</strong>toriale Italiano,<br />
1964-69<br />
PISTOLESE, Rosana, La <strong>moda</strong> nella <strong>storia</strong> del costume, Bologna, Cappelli, 1964 (1991)<br />
1965<br />
BOUCHER, François, Histoire du costume en Occident, Paris, s.e., 1965<br />
BULLOUGH, Donald, The age of Charlemagne, London, Elek Books Limited, 1965<br />
CONTINI, Mila, La <strong>moda</strong> nei secoli, Milano, s.e., 1965<br />
CORSON, Richard, Fashion in hair. The first five thousands years, London, P. Awen, 1965<br />
DOMPÉ, Giovanna, Piccola <strong>storia</strong> dell’Abbigliamento, Torino, Loescher, 1965<br />
1966<br />
KYBALOVÁ, Ludmila, HERBEROVA, Olga, LAMAROVÁ, Milena, Enciclope<strong>di</strong>a illustrata del<br />
costume, La Spezia, Fratelli Melita, 1966 Praga (1988)<br />
VISCARDI, Antonio-BARNI, Gianluigi, Società e costume. L’Italia nell’età comunale, vol. IV,<br />
Torino, UTET, 1966<br />
1967<br />
DEVOTI, Donata, Dell’arte e del commercio <strong>della</strong> seta in Lucca, in Mostra del costume e sete<br />
lucchesi, Lucca, 1967<br />
1968<br />
Toesca, Pietro, ( a cura <strong>di</strong>), Miniature italiane <strong>della</strong> fondazione Giorgio Cini, Vicenza, Neri Pozza,<br />
1968<br />
BRUNELLO, Franco, L’arte <strong>della</strong> tintura nella <strong>storia</strong> dell’umanità, Vicenza, Neri Pozza, 1968<br />
1970<br />
BARTHES, Roland, Sistema <strong>della</strong> <strong>moda</strong>, Torino, Einau<strong>di</strong>, 1970<br />
SACCHETTI, Franco, Il Trecentonovelle, a cura <strong>di</strong> Emilio Faccioli, Torino, Einau<strong>di</strong>, 1970<br />
1971<br />
CREMONESI, Arduino, L’epoca patriarcale (1077-1420), in Enciclope<strong>di</strong>a monografica del Friuli<br />
Venezia Giulia, III, 1 La <strong>storia</strong> e la cultura, U<strong>di</strong>ne, Istituto per l’enciclope<strong>di</strong>a monografica del Friuli,<br />
1971<br />
1972<br />
PAVON, Massimo, Forme e tecniche nell’arte tessile, Treviso, Canova, 1972<br />
1974<br />
DEVOTI, Donata, L’arte del tessuto in Europa, Milano, Bramante, 1974 (1996)<br />
1976<br />
FRANCESCATO Grazia-SALIMBENI Fulvio, Storia, lingua e società in Friuli, U<strong>di</strong>ne, 1976<br />
1978<br />
LEVI PISETZKY, Rosita, Il costume e la <strong>moda</strong> nella società italiana, Torino, Einau<strong>di</strong>, 1978 (1995)<br />
1979<br />
GUIOTTO, Mario, La chiesa abbaziale <strong>di</strong> S. Maria <strong>di</strong> Summaga, Venezia, Tipografia commerciale,<br />
1979, estratto da Ateneo Veneto, anno XVII, vol. 17-12, Gennaio-Dicembre 1979<br />
1980<br />
CECCHETTI, Bartolomeo, La vita dei veneziani nel 1300. Le vesti, Bologna, Forni, 1980<br />
1981<br />
BUTAZZI, Grazietta, Moda arte società, Milano, Fabbri, 1981<br />
GREVENBROCH, Giovanni, Gli abiti de’ veneziani <strong>di</strong> quasi ogni età […], a cura <strong>di</strong> G. Mariacher,<br />
voll. 4, Venezia, Filippi, 1981<br />
DAVANZO POLI, Doretta, I tessuti <strong>della</strong> tomba <strong>di</strong> S. Antonio <strong>di</strong> Padova, in CHESNE DAUPHINÉ<br />
GRIFFO, Giuliana, (a cura <strong>di</strong>), Aspetti e problemi degli stu<strong>di</strong> sui tessili antichi, atti del II Convegno<br />
Centro Italiano Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Storia del Tessuto, Firenze, CISST, 1981, pp. 13-21<br />
31
MENEGHELLI, Virgilio, POPPI, Antonino, Ricognizione del corpo <strong>di</strong> Sant’Antonio <strong>di</strong> Padova,<br />
Padova, 1981<br />
1983<br />
BRUSATIN, Manlio, Storia dei colori, Torino, Einau<strong>di</strong>, 1983<br />
1984<br />
DAVANZO POLI, Doretta, I mestieri <strong>della</strong> <strong>moda</strong> a Venezia nei secoli XIII-XVIII. Documenti, voll.<br />
2, Venezia, Il Gazzettino, 1984-86<br />
SEMENZATO, Camillo, Le pitture del Santo <strong>di</strong> Padova, Vicenza, Neri Pozza, 1984<br />
1985<br />
DAVANZO POLI, Doretta, MORONATO, Stefania, ARIANO, Irene, Tessuti costumi <strong>moda</strong>. Le<br />
raccolte storiche <strong>di</strong> palazzo Mocenigo, Venezia, Civici musei, 1985<br />
DAVANZO POLI, Doretta, Tessuti, costumi e <strong>moda</strong>, in Davanzo Poli, Doretta-Moronato, Stefania-<br />
Ariano, I., I.,Tessuti costumi <strong>moda</strong>. Le raccolte storiche <strong>di</strong> palazzo Mocenigo, Venezia, Civici<br />
musei, 1985<br />
1986<br />
DAVANZO POLI, Doretta, L’arte <strong>della</strong> seta a Venezia, in AA.VV., Le fortune <strong>della</strong> seta, Milano,<br />
Fabbri, 1986, pp. 42-45, 62-63<br />
1987<br />
ARGENTIERI ZANETTI, Attiliana, Dizionario tecnico <strong>della</strong> tessitura, U<strong>di</strong>ne, Arti Grafiche<br />
Friulane, 1987<br />
DAVANZO POLI, Doretta, La <strong>moda</strong> nel “libro del sarto”, in AA. VV., Il libro del sarto, Modena,<br />
Panini, 1987, pp. 57-63<br />
1988<br />
CHIAPPINI DI SORIO, Ileana, L’arte <strong>della</strong> tessitura serica a Venezia, Venezia, Centro<br />
Internazionale <strong>della</strong> Grafica, 1988<br />
DAVANZO POLI, Doretta, L’arte e il mestiere <strong>della</strong> tessitura a Venezia nei secoli XIII-XVIII, in<br />
AA.VV., I mestieri <strong>della</strong> <strong>moda</strong> a Venezia, Catalogo <strong>della</strong> mostra, Venezia, Il Cavallino, 1988, pp.<br />
39-53<br />
D’ORLANDI, Lea, PERUGINI, Gaetano, Antichi costumi friulani, a cura <strong>di</strong> Novella Cantarutti e<br />
Gian Paolo Gri, U<strong>di</strong>ne, Società Filologica Friulana, 1988<br />
ROMANELLI, Giandomenico, «Gli abiti <strong>di</strong>’ Veneziani». Mille mestieri <strong>di</strong> una città <strong>di</strong> <strong>moda</strong>, in<br />
AA.VV., I mestieri <strong>della</strong> <strong>moda</strong> a Venezia, Venezia, Il Cavallino, 1988, pp. 23-29<br />
1989<br />
DEVOTI, Donata, La seta. Tesori <strong>di</strong> un’antica arte lucchese, Lucca, Banca del Monte <strong>di</strong> Lucca,<br />
1989<br />
1990<br />
CARGNELUTTI, Liliana, I toscani nell’Archivium Civitatis Utini. Le aggregazioni alla<br />
citta<strong>di</strong>nanza, in I toscani in Friuli, a cura <strong>di</strong> A. Malcangi, Firenze, 1990<br />
DAVANZO POLI, Doretta-BARZAGHI, Antonio, (a cura <strong>di</strong>), Le vie <strong>della</strong> seta in Italia, Asolo,<br />
Tipografia Asolana, 1990<br />
FRUGONI, Chiara, La donna nelle immagini, la donna immaginata, in La <strong>storia</strong> delle donne in<br />
Occidente. Il Me<strong>di</strong>oevo, Cristiane Klapisch-Zuber, (a cura <strong>di</strong>), Roma-Bari, Laterza, 1990<br />
LECOMTE, Georges, Le vie <strong>della</strong> seta in Italia. L’arte serica dal XII al XX secolo, Asolo, 1990<br />
OWEN HUGES, Diane, Le mode femminili e il loro controllo, in Duby, Georges-Perrot, Michelle,<br />
Storia delle donne. Il Me<strong>di</strong>oevo, a cura <strong>di</strong> Christine Klapisch-Zuber, Milano, Laterza, 1990<br />
URBAN, Lina, Habiti, Venezia, Centro internazionale <strong>della</strong> Grafica, 1990<br />
1991<br />
DAVANZO POLI, Doretta-PAGGI COLUSSI, Carla, Pizzi e ricami, Milano, Fabbri, 1991<br />
PEACOCK, John, Storia illustrata del costume, Milano, E<strong>di</strong>zioni CDE, 1991<br />
1992<br />
GIORGETTI, Cristina, Manuale <strong>di</strong> <strong>storia</strong> del costume e <strong>della</strong> <strong>moda</strong>, Firenze, Cantini, 1992<br />
32
MALCANGI, Alessandro, (a cura <strong>di</strong>), I Toscani in Friuli. Atti del convegno, Firenze, Leo Olschki,<br />
1992<br />
VITALI, Achille, La <strong>moda</strong> a Venezia attraverso i secoli: lessico ragionato, Venezia, Filippi, 1992<br />
1993<br />
COLLODO, Silvana, La produzione tessile nel Veneto me<strong>di</strong>evale, in Tessuti nel Veneto, Ericani,<br />
Giuliana-Frattaroli, Paola, (a cura <strong>di</strong>) Verona, 1993<br />
1994<br />
CAGNIN, Giampaolo, Produzione e commercio dei panni a Treviso nel Me<strong>di</strong>oevo, in Tessuti<br />
antichi a Treviso, catalogo <strong>della</strong> mostra, a cura <strong>di</strong> Doretta Davanzo Poli, Treviso, Canova, 1994<br />
DAVANZO POLI, Doretta-MORONATO, Stefania, Le stoffe dei Veneziani, Venezia, Marsilio,<br />
1994<br />
DAVANZO POLI, Doretta, Tessuti antichi- secoli XIV-XIX. Tessuti, abbigliamento, merletti,<br />
ricami, Treviso, Canova, 1994<br />
1995<br />
BUTAZZI, Grazietta-VARESE, Ranieri, Storia <strong>della</strong> <strong>moda</strong>, Bologna, Calderini, 1995<br />
DUBY, Georges, PERROT, Michelle, Storia delle donne. Il Me<strong>di</strong>oevo, a cura <strong>di</strong> Christine<br />
Klapisch-Zuber, Roma-Bari, Laterza, 1995<br />
1996<br />
DAL PRA’, Laura-PERI, Paolo, (a cura <strong>di</strong>), Dalla testa ai pie<strong>di</strong>. Costume e <strong>moda</strong> in età gotica,<br />
Trento, Provincia autonoma <strong>di</strong> Trento, 1996<br />
ARGENTIERI ZANETTI, Attiliana, Tessuti, stoffe e ricami nel Friuli tardo-me<strong>di</strong>evale, in In domo<br />
Habitationis. L’arredo in Friuli nel tardo Me<strong>di</strong>oevo, a cura <strong>di</strong> Fiaccadori, Lorenzo e Grattoni<br />
D’Arcano, Maurizio Venezia, Marsilio, 1996<br />
BERTINI, Ferruccio, CARDINI, Franco, LEOPARDI, Clau<strong>di</strong>o, FUMAGALLI BEONIO<br />
BROCCHIERI, Maria Teresa, Me<strong>di</strong>oevo al femminile, Roma-Bari, Laterza, 1996<br />
LAVER, James, Moda e costume. Breve <strong>storia</strong> dall’antichità a oggi, Milano, Rizzoli Skira, 1996<br />
1997<br />
AA.VV., Tessuti, oreficerie, miniature in Liguria nel XIII-XV secolo, Bor<strong>di</strong>ghera, Istituto<br />
Internazionale degli Stu<strong>di</strong> Liguri, 1997<br />
LUZZATTO, Lia, POMPAS, Renata, I colori del vestire. Variazioni, Ritorni, Persistenze, Milano,<br />
Hoepli, 1997<br />
MARANGONI, Giorgio, Evoluzione storica e stilistica <strong>della</strong> <strong>moda</strong>, Milano, E<strong>di</strong>zioni S.M.C., 1997<br />
AA.VV., Dal baco al drappo. La seta in Italia tra Me<strong>di</strong>oevo e Seicento, Convegno <strong>di</strong> Stu<strong>di</strong> sulla<br />
seta, Fondazione Cini, Venezia, 1997<br />
1998<br />
PERNOUD, Régine, Immagini <strong>della</strong> donna nel Me<strong>di</strong>oevo, Milano, Jaca Book, 1998<br />
1999<br />
AA.VV. Il Patriarcato d’Aquileia. Uno stato nell’Europa me<strong>di</strong>evale, U<strong>di</strong>ne, Casamassima, 1999<br />
AMABILE, Mariarosa-RIBEZZI-Tiziana-MANSI LUNAZZI, Maria, Tessuti antichi, U<strong>di</strong>ne, Civici<br />
musei, 1999<br />
BRUNETTIN, Giordano, L’evoluzione impossibile. Il principato ecclesiastico <strong>di</strong> Aquileia tra<br />
retaggio feudale e tentazioni signorili (1251-1350), in AA.VV. Il Patriarcato d’Aquileia. Uno stato<br />
nell’Europa me<strong>di</strong>evale, U<strong>di</strong>ne, Casamassima, 1999, pp. 69, 77<br />
CAMMAROSANO, Paolo, Patriarcato, impero e sede apostolica 1077-1251, in AA.VV. Il<br />
Patriarcato d’Aquileia. Uno stato nell’Europa me<strong>di</strong>evale, U<strong>di</strong>ne, Casamassima, 1999<br />
DOLCINI, Loretta-DAVANZO POLI, Doretta-VIO, Ettore, Gli arazzi <strong>di</strong> S.Marco, Milano, Rizzoli,<br />
1999<br />
MUZZARELLI, Maria Giuseppina, Guardaroba me<strong>di</strong>evale. Vesti e società dal XIII al XVI secolo,<br />
Bologna, Il Mulino, 1999<br />
33
2000<br />
DEGRASSI, Donata, L’organizzazione militare nel Patriarcato d’Aquileia nel Due e Trecento, in Il<br />
Patriarcato <strong>di</strong> Aquileia. Uno stato nell’Europa me<strong>di</strong>evale, U<strong>di</strong>ne, Arti Grafiche Friulane, 2000<br />
JACOBY, David, Dalla materia prima ai drappi tra Bisanzio, il levante e Venezia: la prima fase<br />
dell’industria serica veneziana, in La seta in Italia dal Me<strong>di</strong>oevo al Seicento, a cura <strong>di</strong> Luca Molà,<br />
Reinhold C. Mueller, Clau<strong>di</strong>o Zannier, Venezia, Marsilio, 2000<br />
2001<br />
COCCIOLO, Laura, SALA, Davide, Atlante illustrato <strong>della</strong> <strong>moda</strong>, Varese, Demetra, 2001<br />
DAVANZO POLI, Doretta, Abiti antichi e moderni dei Veneziani, Vicenza, Neri Pozza, 2001<br />
(2002)<br />
FRUGONI, Chiara, Me<strong>di</strong>oevo sul naso. Occhiali bottoni e altre invenzioni me<strong>di</strong>evali, Bari, Laterza,<br />
2001<br />
MAUGERI, Vincenza-PAFFUMI, Angela, Percorsi <strong>di</strong> <strong>storia</strong> <strong>della</strong> <strong>moda</strong> e del costume, Bologna,<br />
Calderini, 2001<br />
ZANIER, Clau<strong>di</strong>o, Il tempo <strong>di</strong> Odorico e la seta, in La Cina e la Via <strong>della</strong> Seta nel viaggio <strong>di</strong><br />
Odorico da Pordenone, Pordenone, 2001<br />
2002<br />
AA.VV. Interno veneto. Arredamento domestico fra Trevigiano e Bellunese del Gotico al<br />
Rinascimento, catalogo <strong>della</strong> mostra 2002, Conegliano, ed. città <strong>di</strong> Vittorio Veneto, 2002<br />
BEVILACQUA, Silvia, L’abbigliamento nel XIII secolo: le premesse al sistema <strong>della</strong> <strong>moda</strong>, in<br />
AA.VV. Interno veneto. Arredamento domestico fra Trevigiano e Bellunese del Gotico al<br />
Rinascimento, catalogo <strong>della</strong> mostra 2002, Conegliano, ed. città <strong>di</strong> Vittorio Veneto, 2002, pp. 121-<br />
146<br />
DAL PRA’, Laura-PERI, Paolo-CHINI, Ezio-BOTTERI OTTAVIANI Marina, (a cura <strong>di</strong>), Le vie<br />
del gotico. Il Trentino fra Trecento e Quattrocento, Trento, Temi, 2002<br />
PASTOUREAU, Michel, Blu. Storia <strong>di</strong> un colore, Milano, Ponte alle Grazie, 2002<br />
2003<br />
ARGENTIERI ZANETTI, Attiliana, La stoffa <strong>di</strong> seta a Pordenone, in AA.VV.,Odorico da<br />
Pordenone dalle rive del Noncello al trono del drago, a cura <strong>di</strong> Gilberto Ganzer e Giordano<br />
Brunettin, Pordenone, E<strong>di</strong>zioni del Comune <strong>di</strong> Pordenone, 2003<br />
DAVANZO POLI, Doretta, Il sarto, in Storia d’Italia. Annali 19. La <strong>moda</strong>, a cura <strong>di</strong> Carlo Marco<br />
Belfanti e Fabio Giusberti, Torino, Einau<strong>di</strong>, 2003<br />
SCHOESER, Mary, Tessuti del mondo, Milano, Rizzoli Skira, 2003<br />
2004<br />
CASADIO, Paolo-FURLAN, Caterina, (a cura <strong>di</strong>) foto <strong>di</strong> Laureati, Luca, L’arca del Beato<br />
Bertrando, U<strong>di</strong>ne, Forum, 2004<br />
BERTONE, Maria Beatrice, Fogge e dettagli <strong>di</strong> <strong>moda</strong>, in L’arca del Beato Bertrando, a cura <strong>di</strong><br />
Casa<strong>di</strong>o, Paolo, Furlan, Caterina, foto <strong>di</strong> Luca Laureati, U<strong>di</strong>ne, Forum, 2004, pagine non numerate.<br />
DAVANZO POLI, Doretta, Abbigliamento, <strong>moda</strong>, gerarchie sociali nel tardo me<strong>di</strong>oevo, in Marini,<br />
Paola-Napione, Ettore, Varanini, Gian Maria (a cura <strong>di</strong>), Cangrande <strong>della</strong> Scala. La morte e il<br />
corredo <strong>di</strong> un principe nel me<strong>di</strong>oevo europeo, Venezia, Marsilio, 2004, pp. 155-165<br />
DAVANZO POLI, Doretta, Le vesti, il tessuto, il portamento; il caso “Petrarca”: esempio <strong>di</strong><br />
ricostruzione filologica, in AA. VV., Costumi del potere, Conegliano, Regione del Veneto, 2004,<br />
pp. 18-32<br />
DAVANZO POLI, Doretta, Stoffe e pittura. Dalle origini al secolo XIII, in Flores D’Arcais,<br />
Francesca, (a cura <strong>di</strong>), La pittura nel Veneto: le origini, Milano, Electa, 2004, pp. 293-307<br />
MARINI, Paola-NAPIONE, Ettore, VARANINI, Gian Maria (a cura <strong>di</strong>), Cangrande <strong>della</strong> Scala,<br />
Venezia, Marsilio, 2004<br />
PICCOLO PACI, Sara, Parliamo <strong>di</strong> <strong>moda</strong>. Manuale <strong>di</strong> <strong>storia</strong> del costume e <strong>della</strong> <strong>moda</strong>, vol. I,<br />
Bologna, Cappelli, 2004<br />
34
2006<br />
DAL PRA’, Laura-PERI, Paolo (a cura <strong>di</strong>), Dalla testa ai pie<strong>di</strong>. Costume e <strong>moda</strong> in età gotica,<br />
Trento, Temi, 2006<br />
PERI, Paolo, Considerazioni introduttive, in Dal Prà, Laura-Peri, Paolo (a cura <strong>di</strong>), Dalla testa ai<br />
pie<strong>di</strong>. Costume e <strong>moda</strong> in età gotica, Trento, Temi, 2006, pp. 13-29<br />
SCOPAS SOMMER, Rossella-SALVATICO, Elena, Recenti scoperte e restauri nella chiesa <strong>di</strong> San<br />
Giorgio in Vado a Cividale: gli affreschi <strong>della</strong> facciata. Glosse a margine <strong>di</strong> un’indagine in fase <strong>di</strong><br />
elaborazione, in Forum Iulii. Annuario del museo nazionale <strong>di</strong> Cividale del Friuli, XXX, 2006<br />
2007<br />
VECCHIES, Francesco, Le sepolture trecentesche in San Giovanni dei Cavalieri, in AA.VV., Una<br />
signoria territoriale nel Me<strong>di</strong>oevo. Storia <strong>di</strong> Prata dal X al XV secolo, Prata, e<strong>di</strong>zioni Comune <strong>di</strong><br />
Prata <strong>di</strong> Pordenone, 2007<br />
VINCO, Mattia, (a cura <strong>di</strong>), La chiesa <strong>di</strong> San Zeno a Verona e le sue opere d’arte, ristampa<br />
anastatica <strong>di</strong> un saggio <strong>di</strong> Eduard Von Sacken per la K.K. Centralcommission, Verona, Comitato<br />
per le celebrazioni in onore <strong>di</strong> San Zeno patrono <strong>di</strong> Verona, 2007<br />
2008<br />
AA. VV. Le favolose historie <strong>di</strong> Palazzo Ricchieri. Testimonianze tardogotiche nei soffitti lignei <strong>di</strong><br />
Pordenone, Treviso, Canova, 2008<br />
EMEROGRAFIA<br />
1999<br />
FUMAGALLI BEONIO BROCCHIERI, Maria Teresa, “Quando vestivamo la cioppa”, Il sole 24<br />
ore, 5 Settembre 1999<br />
2000<br />
AURORA, Marina-LAVORINI, Mila, “Trame d’altri tempi”, Me<strong>di</strong>oevo, anno 4 n°9, Settembre<br />
2000, p. 85<br />
MUZZARELLI, Maria Giuseppina, “Dimmi come vesti e ti <strong>di</strong>rò chi sei”, Me<strong>di</strong>oevo, anno4 n°10,<br />
Ottobre 2000, pp. 62-68<br />
2001<br />
DEGRASSI, Donata, “Un confronto a più voci”, Me<strong>di</strong>oevo, anno 5 n°2, Febbraio 2001, pp. 43-47<br />
DEGRASSI, Donata, “Una regione al bivio”, Me<strong>di</strong>oevo, anno 5 n°2, Febbraio 2001, pp. 28-35<br />
DEGRASSI, Donata-BRUNETTIN, Giordano, “Il pastorale e la spada”, Me<strong>di</strong>oevo, anno 5 n°2,<br />
Febbraio 2001, pp. 36-42<br />
PIRANI, Francesco, “Pecunia non olet”, Me<strong>di</strong>oevo, Anno 5 n°9, Settembre 2001, pp. 68-74<br />
2002<br />
SCHISA, Brunella, “Giotto e il mistero dei due scrovegni”, Il Venerdì <strong>di</strong> Repubblica, 2002<br />
2003<br />
BOLOGNINO, Andrea-DELLA VECCHIA, Isabella-MARTIN, Maurizio-MORANDI, Benedetta,<br />
“Sesso debole? Ma chi l’ha detto?”, Rivivere la <strong>storia</strong>, n°1 Marzo-Aprile 2003, pp. 12-16<br />
2005<br />
PICCOLO PACI, Sara, “Così vestiva lei”, Rivivere la <strong>storia</strong>, n°13 Marzo-Aprile 2005, p. 77<br />
PICCOLO PACI, Sara, “La decorazione degli abiti”, Rivivere la <strong>storia</strong>, n° 14 Maggio-Giugno 2005<br />
PICCOLO PACI, Sara, “La prei<strong>storia</strong> <strong>della</strong> sartoria”, Rivivere la <strong>storia</strong>, n°16 Settembre-Ottobre<br />
2005, pp.74 sg.<br />
BERTONE, Maria Beatrice, schede in “Filo Forme”, numero speciale 2005, ed. Il prato<br />
2006<br />
BALESTRACCI, Duccio, “Profumo <strong>di</strong> donna”, Me<strong>di</strong>oevo, anno 10 n°1, Gennaio 2006, pp. 42-51<br />
2008<br />
35
AA.VV., “L’arca marmorea del Beato Bertrando nel battistero <strong>della</strong> cattedrale <strong>di</strong> U<strong>di</strong>ne. La nuova<br />
sistemazione, il restauro e le indagini scientifiche”, Relazioni 14, U<strong>di</strong>ne, Forum, 2008<br />
SITOGRAFIA<br />
Sito web dell’Università <strong>di</strong> Heidelberg: www.uni-heidelberg.de per la versione <strong>di</strong>gitale del Co<strong>di</strong>ce<br />
Manesse<br />
Sito web <strong>della</strong> Biblicothèque Nationale de France: www.bnf.fr<br />
Sito web dell’istituto Pio Paschini per la <strong>storia</strong> <strong>della</strong> chiesa in Friuli: www.istitutopiopaschini.it, per<br />
alcune immagini <strong>di</strong>gitali del Salterio <strong>di</strong> Santa Elisabetta<br />
Sito web <strong>della</strong> John Pierpont Morgan Library: www.themorgan.org per la versione <strong>di</strong>gitale <strong>della</strong><br />
Bibbia Maciejowski<br />
36