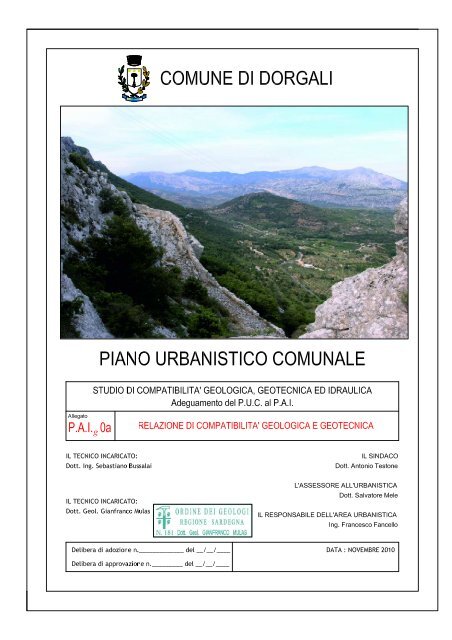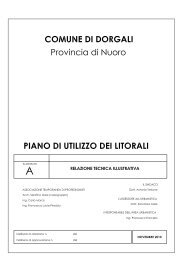relazione compatibilità geologica - Comune di Dorgali
relazione compatibilità geologica - Comune di Dorgali
relazione compatibilità geologica - Comune di Dorgali
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Regione Regione Autonoma Autonoma della della Sardegna<br />
Sardegna<br />
INDICE<br />
PROVINCIA DI NUORO<br />
C O M U N E D I D O R G A L I<br />
PIANO URBANISTICO COMUNALE<br />
STUDIO DI COMPATIBILITA’<br />
GEOLOGICA, GEOTECNICA E IDRAULICA<br />
RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA<br />
Premessa Pag. 1<br />
Metodologia Pag. 2<br />
Relazione Geologica Pag. 5<br />
Relazione Geotecnica Pag. 31<br />
Fenomeni Franosi Pag. 36<br />
Interazioni tra il P.U.C. ed il P.A.I. Pag. 39<br />
Interventi <strong>di</strong> Mitigazione del Rischio Pag. 43
PREMESSA<br />
Il presente elaborato, che deve essere considerato ad integrazione dello stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong><br />
pianificazione urbanistica del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Dorgali</strong>, è stato sviluppato ai sensi e per gli<br />
effetti delle prescrizioni <strong>di</strong> cui all’art. 8 comma 2 delle Norme <strong>di</strong> Attuazione del P.A.I.<br />
SARDEGNA, il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino unico della<br />
Sardegna, in ottemperanza e nel rispetto <strong>di</strong> quanto enunciato nel Titolo III - Capi I, II e<br />
III delle N.d.A, nonché con riferimento <strong>di</strong>retto agli allegati E ed F del medesimo<br />
strumento.<br />
L’intento dello stu<strong>di</strong>o è, fondamentalmente, quello <strong>di</strong> analizzare le potenziali<br />
mo<strong>di</strong>fiche sui regimi idraulici e sulla stabilità dei versanti determinabili dalla<br />
attuazione delle nuove previsioni <strong>di</strong> uso del territorio, con particolare riguardo ai<br />
progetti <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amenti residenziali, produttivi, <strong>di</strong> servizi, <strong>di</strong> infrastrutture.<br />
La finalità è stata quella <strong>di</strong> valutare la <strong>compatibilità</strong> della pianificazione territoriale con<br />
le caratteristiche geologiche, geotecniche ed idrauliche dello stesso, nonché con le<br />
Norme <strong>di</strong> Attuazione del P.A.I., al fine <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare eventuali criticità della<br />
programmazione e dell’attuale stato <strong>di</strong> fatto, valutare la possibilità <strong>di</strong> delocalizzazione<br />
degli interventi ricadenti in aree a pericolosità elevata o molto elevata e prevedere la<br />
necessità <strong>di</strong> porre in essere una serie <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> compensazione e <strong>di</strong> mitigazione<br />
del rischio, laddove non fosse possibile operare la delocalizzazione degli interventi<br />
previsti o delle strutture già esistenti.<br />
dott. ing. Sebastiano Bussalai<br />
dott. geol. Gianfranco Mulas Relazione <strong>di</strong> Compatibilità <strong>geologica</strong> e geotecnica pag. 1
METODOLOGIA<br />
Lo stu<strong>di</strong>o, seguendo le in<strong>di</strong>cazioni delle Linee Guida che hanno ispirato le attività <strong>di</strong><br />
in<strong>di</strong>viduazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e geomorfologico e delle<br />
relative misure <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a del Bacino Unico della Sardegna, rispetto alla quale,<br />
però, non si è proceduto alla definizione alla programmazione <strong>di</strong> eventuali misure <strong>di</strong><br />
mitigazione del rischio.<br />
L’attività <strong>di</strong> completamento della perimetrazione dell’intero territorio comunale è<br />
stata sviluppata, in questa fase, partendo dalla carta della pericolosità <strong>geologica</strong> da<br />
frana prodotta durante lo sviluppo della recente variante al P.A.I., indagando le<br />
porzioni <strong>di</strong> territorio escluse dalla perimetrazione.<br />
Per fare ciò sono stati utilizzati gli stessi identici parametri e valori <strong>di</strong> riferimento posti<br />
alla base dell’estensione del P.A.I. servendosi, per i dati già elaborati e sviluppati<br />
durante lo stu<strong>di</strong>o del P.U.C., delle in<strong>di</strong>cazioni da questo fornite, ulteriormente<br />
implementate da apposite elaborazioni basate sulle conoscenze personali e da<br />
specifiche indagini in sito, per quanto attiene agli elementi non valutati nello specifico,<br />
o con il dettaglio necessario, dal Piano Urbanistico Comunale.<br />
I tematismi mutuati dal P.U.C., nello specifico, sono quelli inerenti l’assetto litologico,<br />
quelli relativi all’uso del suolo e quelli concernenti l’esposizione dei versanti, mentre<br />
non è stato possibile utilizzare la sud<strong>di</strong>visione in classi <strong>di</strong> pendenza, in quanto<br />
sviluppata secondo intervalli <strong>di</strong> classi non congruenti con quelle previste dalle Linee<br />
Guida.<br />
L’incrocio dei dati derivanti dalle pendenze, dalla litologia e dall’uso del suolo, hanno<br />
consentito l’elaborazione della carta dell’instabilità potenziale dei versanti, in cui si<br />
in<strong>di</strong>viduano aree omogenee a maggiore o minore attinenza potenziale allo sviluppo <strong>di</strong><br />
fenomeni instabili.<br />
Questa carta, a sua volta, è stata rapportata alla carta dei fenomeni franosi, in cui<br />
vengono in<strong>di</strong>viduate non solo le frane già verificatesi, sottoposte o meno ad interventi<br />
<strong>di</strong> consolidamento, e quelle potenzialmente attivabili e già censite ed in<strong>di</strong>viduate, ma<br />
anche tutte quelle superfici che, per caratteri altimetrici, orografici, morfologici,<br />
litologici, stratigrafici, tettonico-strutturali, <strong>di</strong> esposizione, geotecnici, idrografici,<br />
dott. ing. Sebastiano Bussalai<br />
dott. geol. Gianfranco Mulas Relazione <strong>di</strong> Compatibilità <strong>geologica</strong> e geotecnica pag. 2
idrologici ed idrogeologici, presentano una maggiore o minore propensione alla<br />
formazione, innesco e sviluppo <strong>di</strong> manifestazioni instabili.<br />
Per lo sviluppo concreto della carta <strong>di</strong> sintesi interme<strong>di</strong>a, quella della pericolosità<br />
potenziale dei versanti, partendo da quelle <strong>di</strong> base e in, particolare, da quella litologia<br />
e quella dell’uso del suolo sviluppate dalla perimetrazione definita dal P.U.C., si è<br />
proceduto a realizzare delle carte pesate fornendo, a tutti gli elementi singolari dotati<br />
<strong>di</strong> caratteri e <strong>di</strong> comportamento analogo, un valore ponderale identico, ed<br />
eseguendone il raggruppamento, sempre in accordo con le in<strong>di</strong>cazioni delle Linee<br />
Guida.<br />
Per quanto attiene alle carte dell’uso del suolo e delle pendenze, entità per le quali<br />
sono previste solo cinque classi <strong>di</strong> peso, sono stati adottati pe<strong>di</strong>ssequamente i valori<br />
proposti, senza eseguire alcuna semplificazione che, invece, è stata operata nel caso<br />
della litologia.<br />
In questo caso, basandosi sulle conoscenze in possesso abbastanza approfon<strong>di</strong>te<br />
relativamente a tutte le litologie presenti nell’ambito territoriale esaminato, preso<br />
atto dell’assenza <strong>di</strong> numerosi dei litotipi posti a riferimento dalle Linee Guida, e<br />
tenendo in particolare conto il comportamento geotecnico <strong>di</strong> quelli presenti in<br />
<strong>relazione</strong> alla stabilità dei versanti, sono stati realizzati tre raggruppamenti ai quali<br />
sono stati attribuiti valori <strong>di</strong> peso minimo, pari ad 1, interme<strong>di</strong>o, pari a 5, massimo, pari<br />
a 9.<br />
Tale <strong>di</strong>scretizzazione si è resa in<strong>di</strong>spensabile per consentire una semplificazione <strong>di</strong><br />
interpretazione <strong>di</strong> dati caratterizzati da una elevatissima <strong>di</strong>spersione territoriale che si<br />
sarebbe andata ad aggiungere all’altissima frammentazione <strong>di</strong> altri dati, quali quello<br />
attinente alle pendenze e quello relativo all’uso del suolo.<br />
L’incrocio dei tre tematismi, litologia pesata, uso del suolo pesato e pendenze, ha<br />
consentito lo sviluppo della carta della instabilità potenziale dei versanti.<br />
Questa, a sua volta, interfacciata alla carta dei fenomeni franosi, ha consentito la<br />
restituzione della carta della pericolosità <strong>geologica</strong> da frana.<br />
Si precisa che l’elaborazione prodotta scaturisce dal fatto che sono state valutate,<br />
seguendo questo metodo, solo le aree originariamente non classificate dal P.A.I. nella<br />
dott. ing. Sebastiano Bussalai<br />
dott. geol. Gianfranco Mulas Relazione <strong>di</strong> Compatibilità <strong>geologica</strong> e geotecnica pag. 3
sua versione in variante, mentre per quelle che invece sono oggetto della<br />
perimetrazione vigente, è stata riportata la classificazione in atto, con la sola<br />
esclusione <strong>di</strong> quelle aree in cui il livello <strong>di</strong> pericolosità riscontrato in questo stu<strong>di</strong>o, è<br />
risultato essere maggiore rispetto a quello definito dallo P.A.I.<br />
Questo si è verificato solo in due casi isolati, riscontrati all’interno dell’abitato <strong>di</strong> Cala<br />
Gonone, a margine della scarpata che delimita la colata basaltica sudorientale, in<br />
località La Favorita, e tra via del Bue Marino e via Vasco de Gama, alla fine della via<br />
delle Stelle Marine.<br />
In una fase successiva al presente sta<strong>di</strong>o <strong>di</strong> adeguamento del P.U.C. al P.A.I., che potrà<br />
essere configurata come variante, verrà proposta una restituzione cartografica che<br />
terrà conto, in maniera puntuale e precisa, delle reali valutazioni oggettive scaturite<br />
dal presente stu<strong>di</strong>o estese su tutto il territorio comunale, ivi compresa quella porzione<br />
già interessata dalla variante al Piano <strong>di</strong> Assetto Idrogeologico.<br />
dott. ing. Sebastiano Bussalai<br />
dott. geol. Gianfranco Mulas Relazione <strong>di</strong> Compatibilità <strong>geologica</strong> e geotecnica pag. 4
RELAZIONE GEOLOGICA<br />
Come anticipato in premessa, per una caratterizzazione <strong>geologica</strong> <strong>di</strong> dettaglio si<br />
rimanda alle relazioni specialistiche allegate al Piano Urbanistico Comunale, mentre <strong>di</strong><br />
seguito si riporta un sunto sintetico dei caratteri geologici generali.<br />
Litologia<br />
Nell’ambito del territorio comunale <strong>di</strong> <strong>Dorgali</strong> affiorano terreni che spaziano dalle<br />
metamorfici paleozoiche fino ai depositi alluvionali recenti ed attuali ed ai se<strong>di</strong>menti<br />
marini.<br />
Partendo dai terreni più antichi si possono riconoscere i seguenti litotipi:<br />
Metamorfiti.<br />
Si tratta <strong>di</strong> rocce <strong>di</strong> basso e me<strong>di</strong>o grado metamorfico, classificate prevalente come<br />
micascisti e in secondo luogo come metarenarie e filla<strong>di</strong>.<br />
Sono localizzate quasi esclusivamente nel settore settentrionale estremo, al confine<br />
con l’agro <strong>di</strong> Lula , e in qualche lembo isolato nel settore nordorientale al confine con<br />
l’agro <strong>di</strong> Galtelli e sono rappresentate da micascisti e scisti sericitici <strong>di</strong> età cambrico-<br />
ordoviciana.<br />
Un modestissimo lembo <strong>di</strong> rocce metamorfiche affiora anche nell’estrema propaggine<br />
meri<strong>di</strong>onale dell’agro, al triplice <strong>di</strong> confine con i territori <strong>di</strong> Urzulei e <strong>di</strong> Orgosolo ma, in<br />
questo caso, sono presenti litologie metarenacee , quarziti che filla<strong>di</strong>che <strong>di</strong> età<br />
cambrica.<br />
Le metamorfici del settore settentrionale manifestano un profondo ed intenso grado <strong>di</strong><br />
alterazione, solitamente superficiale ma talora spinto a profon<strong>di</strong>tà me<strong>di</strong>e, con intensa<br />
scistosità e foliazione manifesta anche nelle facies francamente litoi<strong>di</strong>.<br />
Il grado <strong>di</strong> alterazione avanzato talora conferisce loro un comportamento terrigeno.<br />
Nel settore meri<strong>di</strong>onale le rocce metamorfiche si presentano più massive e meno<br />
alterate, con un comportamento francamente litoide o sublitoide, sebbene risultino<br />
essere interessate da una strutturazione tettonica più intensa.<br />
dott. ing. Sebastiano Bussalai<br />
dott. geol. Gianfranco Mulas Relazione <strong>di</strong> Compatibilità <strong>geologica</strong> e geotecnica pag. 5
Granitoi<strong>di</strong><br />
Il complesso granitoide affiora in maniera più estesa rispetto a quello metamorfico e,<br />
al pari <strong>di</strong> questo, è localizzato in due settori <strong>di</strong>stinti, uno settentrionale ed uno<br />
meri<strong>di</strong>onale.<br />
Nell’area settentrionale i graniti sono presenti a sud del tracciato della S.S. 131 D.C.N.<br />
e sono rappresentati da rocce a composizione granitoide interme<strong>di</strong>a, con una<br />
tendenza lievemente basica.<br />
Anche in questo caso le rocce presentano un grado <strong>di</strong> alterazione me<strong>di</strong>o, che<br />
determina processi <strong>di</strong> ossidazione intensi nei livelli più superficiali, comunque per<br />
profon<strong>di</strong>tà quasi mai superiori a tre metri.<br />
Nella porzione meri<strong>di</strong>onale del territorio, localizzata nella vallata <strong>di</strong> Oddoene al cui<br />
fondo scorre il rio Flumineddu, i litotipi granitoi<strong>di</strong> appartengono a facies<br />
monzogranitiche e grano<strong>di</strong>oritiche e, mentre le prime denotano un carattere più<br />
francamente lapideo con fenomeni alterativi solitamente limitati ai livelli corticali e alle<br />
superfici <strong>di</strong> <strong>di</strong>scontinuità, le seconde manifestano una maggiore propensione<br />
all’alterazione, che spesso si sviluppa per profon<strong>di</strong>tà anche superiori ai tre metri dal<br />
piano <strong>di</strong> campagna.<br />
Il complesso granitoide, in particolar modo nel settore meri<strong>di</strong>onale, è intersecato da<br />
un fitto sistema filoniano costituito prevalentemente da intrusioni a composizione<br />
microgranitica ed aplitica, mentre molto meno frequenti sono le manifestazioni a<br />
chimismo basico, per lo più <strong>di</strong> tipo lamprofirico.<br />
I primi, sebbene intensamente fratturati, hanno un carattere lapideo franco o poco<br />
alterato, mentre i secon<strong>di</strong> sono contrad<strong>di</strong>stinti da un livello <strong>di</strong> alterazione spesso molto<br />
avanzato che, nei livelli superficiali, può essere totale.<br />
Conglomerati <strong>di</strong> base<br />
Al contatto tra il basamento metamorfico o granitoide, in maniera <strong>di</strong>scontinua e<br />
puntuale, sono presenti se<strong>di</strong>menti conglomeratici più o meno cementati, a<br />
componente fondamentalmente quarzosa, generati dallo smantellamento delle rocce<br />
<strong>di</strong> base in facies continentale frequentemente <strong>di</strong> ambiente molassico.<br />
dott. ing. Sebastiano Bussalai<br />
dott. geol. Gianfranco Mulas Relazione <strong>di</strong> Compatibilità <strong>geologica</strong> e geotecnica pag. 6
Questi affioramenti, che rappresentano l’esor<strong>di</strong>o dell’ingressione marina mesozoica e<br />
che, quin<strong>di</strong>, sono attribuibili al triassico me<strong>di</strong>o-inferiore, sono quasi sempre occultati<br />
dai depositi detritici generati dallo smantellamento delle rocce soprastanti.<br />
Serie carbonatica mesozoica<br />
Il complesso carbonatico mesozoico costituisce una delle litologie maggiormente<br />
<strong>di</strong>ffuse e caratterizzanti nell’ambito del territorio comunale <strong>di</strong> <strong>Dorgali</strong>, sia dal punto <strong>di</strong><br />
vista litostratigrafico che morfologico.<br />
I terreni carbonatici, dolomitici alla base e calcarei nella parte interme<strong>di</strong>a e sommitale<br />
della serie, affiorano <strong>di</strong>ffusamente nella fascia costiera e nell’entroterra<br />
sudoccidentale, oltre ad una modesta insula localizzata nel settore centroorientale.<br />
La copertura mesozoica è costituita da una serie se<strong>di</strong>mentaria che esor<strong>di</strong>sce con una<br />
componente continentale costituita conglomerati basali <strong>di</strong> età carbonifero superiore,<br />
cui fa’ seguito una successione <strong>di</strong> strati a composizione carbonatica marina, a partire<br />
dalle dolomiti del Giurassico me<strong>di</strong>o, fino ad arrivare a calcareniti del Cretaceo me<strong>di</strong>o.<br />
Sono presenti se<strong>di</strong>menti nettamente da massivi a debolmente stratificati alla base,<br />
passando a depositi massivi nella porzione me<strong>di</strong>ana della successione, per tornare a<br />
una netta stratificazione nella porzione terminale della serie.<br />
Le dolomie, denominate con il termine <strong>di</strong> Formazione <strong>di</strong> Monte Bar<strong>di</strong>a, presentano un<br />
carattere conglomeratico nei livelli inferiori, per progre<strong>di</strong>re verso depositi massivi<br />
francamente dolomitici, <strong>di</strong> colore da bruno a grigiastro, la cui potenza complessiva<br />
me<strong>di</strong>a si aggira attorno ai cento metri.<br />
In continuità, ma localmente anche in eteropia laterale, i depositi assumono<br />
composizione francamente calcarea, in facies spesso oolitiche, pisolitiche o<br />
calcarenitiche, <strong>di</strong> colore nocciola e nettamente stratificati, con una potenza me<strong>di</strong>a <strong>di</strong><br />
centocinquantina <strong>di</strong> metri.<br />
Questa facies, definita come Formazione <strong>di</strong> Monte Tului, non è ubiquitariamente<br />
potente all’interno del bacino se<strong>di</strong>mentario, e i suoi affioramenti sono solitamente<br />
localizzati lungo specchi <strong>di</strong> faglia o entro finestre erosive.<br />
dott. ing. Sebastiano Bussalai<br />
dott. geol. Gianfranco Mulas Relazione <strong>di</strong> Compatibilità <strong>geologica</strong> e geotecnica pag. 7
Verso l’alto gli stessi se<strong>di</strong>menti assumono il carattere organogeno tipico <strong>di</strong> bioherma<br />
con calcari bianchi, quasi sempre massivi, talora stratificati con evidente componente<br />
oolitica, soprattutto verso la sommità, presentano una potenza complessiva <strong>di</strong> oltre<br />
duecento metri e costituiscono la Formazione <strong>di</strong> Monte Bar<strong>di</strong>a.<br />
Questa, databile al Malm superiore, rappresenta, nella zolla orientale, il tetto della<br />
serie mesozoica, probabilmente per erosione totale delle facies successive che, invece,<br />
si trovano in lembi residui nella zolla interna.<br />
Ai pie<strong>di</strong> dell’estrema propaggine settentrionale della zolla interna è presente anche un<br />
modesto affioramento <strong>di</strong> un conglomerato a composizione carbonatica e cristallina, il<br />
Conglomerato Polimittico <strong>di</strong> Lanaitto, che testimonia l’esor<strong>di</strong>o della fase <strong>di</strong> emersione<br />
delle assise carbonatiche.<br />
Sempre solo in sommità della zolla interna affiorano le litologie cretacee,<br />
rappresentate da litologie calcarenitiche , talora tendenzialmente marnose, a grana<br />
me<strong>di</strong>a e fine, più grossolana verso il tetto della serie, me<strong>di</strong>amente coese alla base,<br />
sublitoi<strong>di</strong> o litoi<strong>di</strong> al tetto, la cui potenza complessiva, per lo meno quella residua,<br />
<strong>di</strong>fficilmente supera i cento metri.<br />
Calcari conglomeratici<br />
Successivamente all’emersione determinata dall’orogenesi alpina, ma anche durante le<br />
fasi prodromiche <strong>di</strong> questa, l’associazione dei processi <strong>di</strong>sgiuntivi e gravitativi ha dato<br />
origine alla formazione <strong>di</strong> una facies detritica <strong>di</strong> natura carbonatica, depostasi al piede<br />
delle faglie principali probabilmente in ambiente ancora sommerso, che ha portato alla<br />
formazione, talora <strong>di</strong>ffusa ma più frequentemente localizzata, <strong>di</strong> un conglomerato a<br />
componenti carbonatici ed a cemento calcareo, fortemente cementato, <strong>di</strong>sposto in<br />
conoi<strong>di</strong> o piccole falde localizzato prevalentemente al piede delle scarpate <strong>di</strong> faglia che<br />
delimitano le assise mesozoiche.<br />
Questa facies, attribuibile al paleocene inferiore, è frequentemente occultata dai<br />
depositi gravitativi più recenti, che molto frequentemente le hanno ricoperte in<br />
concordanza stratigrafica.<br />
dott. ing. Sebastiano Bussalai<br />
dott. geol. Gianfranco Mulas Relazione <strong>di</strong> Compatibilità <strong>geologica</strong> e geotecnica pag. 8
Alluvioni pre ed infrabasaltiche<br />
In tutto l’agro comunale <strong>di</strong> <strong>Dorgali</strong> non sono presenti in affioramento terreni<br />
appartenenti al cenozoico, infatti, l’ingressione marina eocenica pare non aver<br />
raggiunto le zone dell’entroterra o, se ciò è avvenuto, non ha dato origine alla<br />
formazione <strong>di</strong> se<strong>di</strong>menti apprezzabili che, se formatisi, sono stati erosi dalle<br />
manifestazioni morfogenetiche imme<strong>di</strong>atamente successive.<br />
Tutte le litologie successivo sono ascrivibili al quaternario.<br />
Le più antiche tra queste sono rappresentate da una serie <strong>di</strong> depositi finegranulari,<br />
sabbie e sabbie limose, <strong>di</strong> origine fluviale e fluvio lacustre depostesi nel<br />
Villafranchiano, al passaggio tra il cenozoico ed il quaternario, quando i corsi d’acqua,<br />
ad opera della tettonica più recente e delle prime effusioni vulcaniche, subivano<br />
l’occlusione più o meno parziale degli alvei, dando origine ad una serie se<strong>di</strong>mentaria <strong>di</strong><br />
modesta entità.<br />
Questi depositi, che prendono il nome <strong>di</strong> formazione <strong>di</strong> Nuraghe Su Casteddu, si<br />
ritrovano spesso intercalati anche tra le varie colate laviche successive, in<strong>di</strong>cando<br />
chiari fenomeni <strong>di</strong> stasi tra un episo<strong>di</strong>o effusivo ed il successivo.<br />
Nella facies basale, in cui prevalgono i se<strong>di</strong>menti grossolani a composizione sabbiosa,<br />
possono raggiungere una potenza massima <strong>di</strong> circa cinquanta metri mentre, quando<br />
intercalate alle lave, dove invece sono prevalenti i se<strong>di</strong>menti limosi e localmente<br />
argillosi, non superano i cinque metri.<br />
Basalti<br />
L’inizio dell’era quaternaria è marcata, nell’area <strong>di</strong> interesse, da un vulcanismo effusivo<br />
che interessa per oltre un terzo della superficie tutto il territorio comunale <strong>di</strong> <strong>Dorgali</strong>.<br />
Si tratta <strong>di</strong> litologie basaltiche effuse prevalentemente in ambiente subaereo e, solo in<br />
piccole tratte lungo la costa, in con<strong>di</strong>zione sottomarina, con carattere tabulare tipico<br />
dei plateaux sviluppato attorno a pochi apparati vulcanici a scudo o, più<br />
prevalentemente, attraverso effusione <strong>di</strong> trabocco da strutture tettoniche lineari.<br />
Il carattere centralizzato è, comunque, sempre determinato dall’incrocio <strong>di</strong> due faglie o<br />
fratture <strong>di</strong>versamente orientate, come accade nei centri effusivi <strong>di</strong> Sant’Elene, del<br />
dott. ing. Sebastiano Bussalai<br />
dott. geol. Gianfranco Mulas Relazione <strong>di</strong> Compatibilità <strong>geologica</strong> e geotecnica pag. 9
Carmelo, <strong>di</strong> Pirischè e <strong>di</strong> Sa Tupped<strong>di</strong>, nei pressi dell’abitato <strong>di</strong> <strong>Dorgali</strong>, o in quello <strong>di</strong><br />
Codula Manna a Cala Gonone.<br />
Occasionalmente le lave fuoriescono dalla vetta o dai fianchi dei rilievi carbonatici, con<br />
i versanti già normalizzati, li ricoprono aderendovi perfettamente tanto da ripeterne la<br />
forma, fornendo in tal modo l'illusione <strong>di</strong> aver generato un vero e proprio apparato<br />
vulcanico conico, come accade nel rilievo <strong>di</strong> Codula Manna.<br />
L’ attività vulcanica in questa zona è rappresentata esclusivamente da effusioni<br />
tranquille, semplici traboccamenti <strong>di</strong> lava senza manifestazioni esplosive e prodotti<br />
piroclastici, mentre in un solo caso, nel centro effusivo del Carmelo, sono presenti<br />
materiali che possono essere assimilati a flussi <strong>di</strong> materiali lavici scoriacei ai quali,<br />
frequentemente, sono associate lave estremamente vacuolarizzate.<br />
Le lave sono costituite prevalentemente da alcalibasalti, olocristallini, localmente<br />
ipocristallini, debolmente porfirici per la presenza <strong>di</strong> fenocristalli <strong>di</strong> clinopirosseno e <strong>di</strong><br />
plagioclasio ed olivina, con inclusi frequenti noduli peridotitici e xenoliti quarzosi a<br />
struttura garnoblastica.<br />
Minore <strong>di</strong>ffusione hanno invece le vulcaniti chimicamente e mineralogicamente<br />
definibili come andesiti basaltiche subalcaline, a carattere ipocristallino, con struttura<br />
ofitica a fenocristalli <strong>di</strong> clinopirosseno, olivina e plagioclasio.<br />
Mentre le prime sono solitamente estremamente compatte, le seconde manifestano<br />
frequentemente una intensa vacuolarizzazione,<br />
Tutte le singole colate si <strong>di</strong>stinguono per essere costituite da tre fasi,<br />
petrograficamente <strong>di</strong>stinguibili, definibili come letto e tetto quelle estreme, e come<br />
nucleo quella interme<strong>di</strong>a.<br />
Gli strati centrali, che compongono il nucleo si presentano compatti e lapidei, privi <strong>di</strong><br />
alterazione o poco alterati, mentre quelli estremi, formati da orizzonti <strong>di</strong> potenza<br />
variabile, compresa tra cinquanta centimetri ed oltre due metri, sono costituiti da<br />
scorie composte da inclusi lavici lapidei o semialterati immersi in una matrice limo-<br />
argilloso-sabbiosa, derivante da processi <strong>di</strong> raffreddamento e da formazione <strong>di</strong><br />
paleosuoli.<br />
In tutti e due i casi la datazione è ascrivibile al Plio-Pleistocene.<br />
dott. ing. Sebastiano Bussalai<br />
dott. geol. Gianfranco Mulas Relazione <strong>di</strong> Compatibilità <strong>geologica</strong> e geotecnica pag.<br />
10
Falde detritiche<br />
Concomitantemente alle manifestazioni effusive si sviluppa con la massima intensità<br />
un’importante azione gravitativa a carico delle litologie carbonatiche mesozoiche,<br />
concentrata prevalentemente lungo le scarpate che delimitano le faglie e le fratture<br />
che hanno <strong>di</strong>slocato le assise messozoiche.<br />
Questi fenomeni hanno avuto inizio già durante l’inizio della regressione<br />
tardopliocenica, protraendosi per tutto il pleistocene.<br />
Si formano in tal modo le conoi<strong>di</strong> e le falde detritiche che orlano, in maniera<br />
pressochè continua, il piede <strong>di</strong> tutte le cornici carbonatiche.<br />
Sono depositi clastici eterometrici, che vanno dalla componente sabbiosa e limosa fino<br />
agli elementi ciclopici con volume superiore ai due ÷ quattro metri cubi, intimamente<br />
compenetrati ed amalgamati, <strong>di</strong> me<strong>di</strong>o spessore, eccezionalmente superiore ai <strong>di</strong>eci<br />
metri, composti da elementi litoi<strong>di</strong> <strong>di</strong> natura esclusivamente carbonatica, per lo più<br />
sciolti ed incoerenti e solo occasionalmente, prevalentemente alla base, lievemente<br />
saldati da un cemento calcareo secondario, <strong>di</strong>sposti secondo l’angolo <strong>di</strong> natural<br />
declivio che spesso raggiunge e supera i quarantacinque gra<strong>di</strong>.<br />
In alcune occasioni è si riscontra la presenza intercalata <strong>di</strong> paleosuoli poco potenti.<br />
Eboulis Ordonnes<br />
La litogenesi antica termina alla fine del pleistocene, durante il quale si esplicano le<br />
massime azioni collegate con le alternanze ana e cata glaciali, alle cui è collegabile la<br />
formazione <strong>di</strong> potenti falde detritiche a stratificazione alternata, i cosidetti Eboulis<br />
Ordonnes.<br />
Si tratta <strong>di</strong> se<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> origine crioclastica, deposti in strati alternati a granulometria<br />
per lo più omogenea, cha spazia dalle sabbie fini alle ghiaie me<strong>di</strong>e, generati dal<br />
frequente alternarsi dei cicli <strong>di</strong> gelo e <strong>di</strong>sgelo a carico delle litologie calcaree.<br />
Sono <strong>di</strong>sposti in falde continue e manifestano me<strong>di</strong>a tenacità conferita loro da un<br />
cemento calcareo secondario, spesso molto abbondante.<br />
dott. ing. Sebastiano Bussalai<br />
dott. geol. Gianfranco Mulas Relazione <strong>di</strong> Compatibilità <strong>geologica</strong> e geotecnica pag.<br />
11
La loro giacitura è concordante con l’estradosso delle assise mesozoiche, che ricoprono<br />
<strong>di</strong>rettamente in maniera <strong>di</strong>scontinua esclusivamente sul versante orientale della falda<br />
esterna.<br />
Alluvioni antiche<br />
I depositi alluvionali in genere sono una litologia estremamente poco <strong>di</strong>ffusa nell’agro<br />
<strong>di</strong> <strong>Dorgali</strong>, soprattutto per via della scarsa <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> alcuna idrografia importante.<br />
Le principali coltri alluvionali sono quelle associate al rio Flumineddu ed al rio Isalle,<br />
che sono in soli corsi d’acqua a deflusso perenne e che presentano un bacino <strong>di</strong><br />
alimentazione ampio e <strong>di</strong>ffuso.<br />
Sono anche i soli corsi d’acqua che hanno dato origine a processi se<strong>di</strong>mentari antichi,<br />
databili al pleistocene antico, ai quali sono associati anche modesti depositi terrazzati<br />
formati prevalentemente da sabbie ghiaie con scarso contenuto <strong>di</strong> prodotti<br />
finegranulari.<br />
La potenza <strong>di</strong> questi depositi è sempre molto contenuta, soprattutto nel caso del<br />
Flumineddu, dove eccezionalmente si supera lo spessore <strong>di</strong> cinque metri, mentre nel<br />
rio Isalle si può arrivare a superare i quin<strong>di</strong>ci metri, sebbene solo in casi eccezionali<br />
nell’area compresa nel territorio comunale <strong>di</strong> <strong>Dorgali</strong>.<br />
Depositi <strong>di</strong> versante<br />
Al tardo Pleistocene ed all’Olocene possono essere ascritte tutte le coltri <strong>di</strong> depositi <strong>di</strong><br />
versante formatesi, secondo processi <strong>di</strong>versi, prevalentemente a carico delle litologie<br />
metamorfiche, granitoi<strong>di</strong> e basaltiche.<br />
Nei primi due casi i fenomeni alterativi, esplicatisi quasi esclusivamente per<br />
ossidazione dei femici e delle miche, associati all’azione della gravità o a modesti<br />
processi idrici superficiali <strong>di</strong> tipo prevalentemente colluviale, hanno determinato la<br />
formazione <strong>di</strong> limitate coltri terrigene, a composizione prevalentemente sabbiosa, nei<br />
graniti, e limoargillosa nelle metamorfiti.<br />
dott. ing. Sebastiano Bussalai<br />
dott. geol. Gianfranco Mulas Relazione <strong>di</strong> Compatibilità <strong>geologica</strong> e geotecnica pag.<br />
12
Sono depositi incoerenti o poco coesi, <strong>di</strong>scontinui, che si rinvengono a mezza costa ed<br />
al piede dei rilievi collinari, in forma <strong>di</strong> conoi<strong>di</strong> isolate a <strong>di</strong> piccole falde, con potenza<br />
eccezionalmente superiore al metro.<br />
Nel caso delle litologie basaltiche sono costituiti quasi esclusivamente da blocchi <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>mensioni eterometriche che costituiscono modesti corpi <strong>di</strong> frana generati dal<br />
<strong>di</strong>stacco, crollo e rotolamento verso valle <strong>di</strong> porzioni periferiferiche delle scarpate che<br />
orlano gli espan<strong>di</strong>menti lavici lungo le principali incisioni fluviali.<br />
Spesso questi processi, soprattutto quelli più antichi, sono stati innescati dallo<br />
scalzamento alla base delle bancate basaltiche e sono stati facilitati dalla fratturazione<br />
delle lave e dalla presenza degli intercalari scoriacei.<br />
Solo raramente si verificano, a carico delle litologie laviche, fenomeni <strong>di</strong> accumulo<br />
terrigeno ai pie<strong>di</strong> degli apparati conici che, comunque, presentano prevalentemente<br />
litologie lapidee <strong>di</strong>fficilmente alterabili ed ero<strong>di</strong>bili.<br />
I pochi fenomeni che si verificano in questi casi sono presenti in alcuni versanti<br />
me<strong>di</strong>amente acclivi, solitamente con pendenza superiore al trentacinque per cento,<br />
nei quali la potenza del suolo supera il metro.<br />
Alluvioni recenti<br />
Sono rappresentate da modestissime coltri a<strong>di</strong>acenti ai corsi d’acqua attivi, limitate per<br />
spessore, che non supera il metro, e per estensione, limitata ad una fascia ampia non<br />
più <strong>di</strong> quattro metri, nei casi più eccezionali, altrimenti limitata a meno <strong>di</strong> due metri.<br />
Sono prevalentemente costituite da sabbie <strong>di</strong> <strong>di</strong>versa granulometria, da ghiaie e da<br />
ciottoli e, solo in rarissime occasioni, esclusivamente sulle litologie metamorfiche, da<br />
modesti accumuli limoargillosi.<br />
Depositi colluviali e palustri<br />
Nel territorio comunale <strong>di</strong> <strong>Dorgali</strong>, se si escludono gli stagni <strong>di</strong> Cala Luna, <strong>di</strong> Cartoe e <strong>di</strong><br />
Osalla, non esistono palu<strong>di</strong> o stagni chiusi.<br />
Nei casi sopracitati la se<strong>di</strong>mentazione è <strong>di</strong> tipo fluviale ed è costituita esclusivamente<br />
da ghiaie e sabbie, al più da limi.<br />
dott. ing. Sebastiano Bussalai<br />
dott. geol. Gianfranco Mulas Relazione <strong>di</strong> Compatibilità <strong>geologica</strong> e geotecnica pag.<br />
13
Fenomeni <strong>di</strong> stagnazione idrica, tuttavia, si manifestano in alcune depressioni<br />
sviluppate sugli altopiani basaltici, ma sono limitate a fenomeni stagionali <strong>di</strong> ristagno<br />
temporaneo delle acque meteoriche determinato dalla scarsa permeabilità dei litotipi<br />
lavici, che limitano l’infiltrazione delle acque piovane e che generano locali<br />
manifestazioni <strong>di</strong> idromorfia.<br />
Tali manifestazioni danno origine, associate a processi <strong>di</strong> tipo colluviale, a modesti<br />
accumuli <strong>di</strong> materiali argilloso – limosi, che si sviluppano al fondo delle depressioni per<br />
strati <strong>di</strong> spessore molto modesto, eccezionalmente superiore al metro, e che<br />
frequentemente sono interessati da processi <strong>di</strong> eluviazione.<br />
Se<strong>di</strong>menti colluviali sottoposti ad azione eluviale, pur non in forma <strong>di</strong> accumulo<br />
palustre, si rinvengono limitatamente anche in alcune aree depresse sviluppate sulle<br />
litologie granitoi<strong>di</strong> e metamorfiche, laddove le pendenze longitu<strong>di</strong>nali e trasversali<br />
<strong>di</strong>minuiscono rapidamente formando rotture <strong>di</strong> pen<strong>di</strong>o concavo a bassissima<br />
inclinazione presenti in aree a scarsa strutturazione ed a caratterizzazione<br />
fondamentalmente lapidea.<br />
Anche in questo caso le manifestazioni <strong>di</strong> ristagno hanno durata stagionale limitata ai<br />
soli perio<strong>di</strong> umi<strong>di</strong>, ad esclusione <strong>di</strong> quei pochi casi in cui si verificano fenomeni <strong>di</strong><br />
alimentazione idrica in<strong>di</strong>retta da forme <strong>di</strong> accumulo profondo per risalita capillare e/o<br />
per spinta idrostatica.<br />
Depositi marini<br />
La costa <strong>di</strong> <strong>Dorgali</strong>, sebbene contrad<strong>di</strong>stinta da una estensione lineare notevole, è<br />
caratterizzata da un numero molto limitato <strong>di</strong> spiagge, soprattutto a causa della scarsa<br />
presenza <strong>di</strong> corsi d’acqua che la intersecano.<br />
Se si escludono le spiagge <strong>di</strong> Cala Gonone, quella centrale e quella <strong>di</strong> Palmasera, e la<br />
caletta <strong>di</strong> Oddoana, formatesi a ridosso <strong>di</strong> falesie detritiche, le altre spiagge, quella <strong>di</strong><br />
Cala Luna, quella <strong>di</strong> Fuili, quella <strong>di</strong> Cartoe e quella <strong>di</strong> Osalla, sono i soli arenili presenti e<br />
sviluppatisi alla foce <strong>di</strong> corsi d’acqua.<br />
L’energia me<strong>di</strong>o alta degli stessi, associata alle litologie su cui si estendono i relativi<br />
bacini idrografici, grazie anche ad una <strong>di</strong>namica marina contrad<strong>di</strong>stinta da un’energia<br />
dott. ing. Sebastiano Bussalai<br />
dott. geol. Gianfranco Mulas Relazione <strong>di</strong> Compatibilità <strong>geologica</strong> e geotecnica pag.<br />
14
ilevante e dalla presenza <strong>di</strong> coste alte, fanno sì che l’estensione degli arenili, sia in<br />
senso trasversale che longitu<strong>di</strong>nale, sia molto limitato, con profon<strong>di</strong>tà me<strong>di</strong>e <strong>di</strong> una<br />
decina <strong>di</strong> metri e lunghezze eccezionalmente superiori a trecento metri.<br />
La sola eccezione è rappresentata dalle spiagge antistanti l’abitato <strong>di</strong> Cala Gonone,<br />
che però sono state oggetto <strong>di</strong> importanti lavori <strong>di</strong> ripascimento i quali ne hanno<br />
determinato l’ampliamento sia in senso trasversale che longitu<strong>di</strong>nale.<br />
Come effetto in<strong>di</strong>retto il ripascimento, a causa delle correnti marine, ha determinato la<br />
ri<strong>di</strong>stribuzione dei materiali <strong>di</strong> apporto anche in porzioni <strong>di</strong> spiaggia, quali quella<br />
centrale, che non erano state interessate dai lavori.<br />
Le stesse cause che determinano la scarsa estensione <strong>di</strong> sviluppo degli arenili ne<br />
influenzano la composizione granulometrica che, prevalentemente, è formata da<br />
sabbie grossolane e da ciottoli.<br />
Solo le spiagge <strong>di</strong> Cartoe e <strong>di</strong> Osalla, poste alla foce <strong>di</strong> corsi d’acqua contrad<strong>di</strong>stinti da<br />
una <strong>di</strong>namica attiva <strong>di</strong> trasporto più o meno continuo, sono contrad<strong>di</strong>stinte da una<br />
granulometria più fine, estesa comunque dalle sabbie me<strong>di</strong>e a quelle grosse, con<br />
esclusione <strong>di</strong> quelle fini e finissime.<br />
Morfologia<br />
L’assetto morfologico del territorio comunale <strong>di</strong> <strong>Dorgali</strong>, causa la notevole estensione,<br />
la presenza <strong>di</strong> un elevato numero <strong>di</strong> litologie a <strong>di</strong>fferente comportamento nei confronti<br />
degli agenti esogeni, e la collocazione geografica in ambito costiero, cui si associa la<br />
presenza <strong>di</strong> processi <strong>di</strong>namici attivi sviluppati fino al quaternario, risulta essere<br />
estremamente articolato ed eterogeneo.<br />
La caratterizzazione morfologica <strong>di</strong>pende in maniera fondamentale da tre fattori<br />
principali.<br />
La litologia assume importanza primaria, presentando litotipi estremamente <strong>di</strong>fferenti<br />
nella loro facilità <strong>di</strong> alterazione e <strong>di</strong> resistenza agli agenti erosivi.<br />
dott. ing. Sebastiano Bussalai<br />
dott. geol. Gianfranco Mulas Relazione <strong>di</strong> Compatibilità <strong>geologica</strong> e geotecnica pag.<br />
15
I rapporti giaciturali assumono anche questi un carattere fondamentale, soprattutto in<br />
merito alla tipologia e forma delle valli.<br />
Da ultima la strutturazione tettonica influenza l’orientamento delle forme e la loro<br />
profon<strong>di</strong>tà ed intensità <strong>di</strong> evoluzione.<br />
In linea <strong>di</strong> massima possono essere in<strong>di</strong>viduate sette grosse unità fisiografiche, quasi<br />
sempre univocamente localizzate nell’ambito territoriale-<br />
Le litologie metamorfiche e granitoi<strong>di</strong> localizzate nel settore settentrionale, sia a causa<br />
della estrema anzianità della fase continentale <strong>di</strong> emersione in cui si trovano, sia per<br />
via della caratterizzazione mineralogica e strutturale che le contrad<strong>di</strong>stingue, danno<br />
origine a forme estremamente dolci e arrotondate tipiche degli ambienti collinari, con<br />
bassi rilievi a modesta pendenza, valli dal profilo concavo con alvei poco incisi su<br />
fondovalle spesso appiattito.<br />
La <strong>di</strong>namica attiva è estremamente contenuta e <strong>di</strong> bassa intensità, rappresentata<br />
quasi esclusivamente da processi fluviali occasionali e <strong>di</strong> eluviazione dei versanti<br />
generati quasi esclusivamente a manifestazione meteoriche eccezionali.<br />
I graniti del settore meri<strong>di</strong>onale, soprattutto a causa <strong>di</strong> una minore durata del periodo<br />
<strong>di</strong> continentalità, danno origine ad una morfologia più giovane, con una <strong>di</strong>namica più<br />
intensa che genera forme aspre, con rilievi me<strong>di</strong>amente elevati ed acuminati, separati<br />
da valli con profilo a V solitamente stretta.<br />
I processi attivi sono quelli fluviali concentrati e quelli <strong>di</strong> versante attivi non solo in<br />
con<strong>di</strong>zioni meteoclimatiche estreme ma anche in quelle or<strong>di</strong>narie, per cui i processi<br />
evolutivi risultano attivi anche nelle fasi attuali, soprattutto alle quote maggiori,<br />
mentre nel fondovalle, complice una lieve <strong>di</strong>fferenziazione mineralogica dei graniti,<br />
prevalgono fenomeni <strong>di</strong> accumulo.<br />
Il settore metamorfico e quello granitoide settentrionale sono separati dalla più estesa<br />
unità fisiografica fluviale del comune <strong>di</strong> <strong>Dorgali</strong>, quella associata al fiume Isalle, la sola<br />
nella quale è possibile in<strong>di</strong>viduare la presenza <strong>di</strong> terrazzi fluviali <strong>di</strong> età antica e <strong>di</strong> piane<br />
<strong>di</strong> esondazione <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a estensione.<br />
dott. ing. Sebastiano Bussalai<br />
dott. geol. Gianfranco Mulas Relazione <strong>di</strong> Compatibilità <strong>geologica</strong> e geotecnica pag.<br />
16
Forme e processi sono quelli tipici della <strong>di</strong>namica fluviale in ambiente senile<br />
interme<strong>di</strong>o, con la prevalenza dei processi <strong>di</strong> trasporto rispetto alla se<strong>di</strong>mentazione, e<br />
modestissime azioni erosive lungo le sponde durante i casi <strong>di</strong> piena eccezionale.<br />
La seconda unità fluviale vera e propria è quella del rio Flumineddu che si sviluppa<br />
nella vallata <strong>di</strong> Oddoene, nella porzione meri<strong>di</strong>onale del territorio, tra le due falde<br />
calcaree.<br />
In questo caso si è in presenza <strong>di</strong> una <strong>di</strong>namica più attiva del corso d’acqua, che risulta<br />
contrad<strong>di</strong>stinto da un ambiente più giovanile, rispetto al rio Isalle, e spesso con<br />
carattere torrentizio in cui prevalgono processi erosivi e <strong>di</strong> trasporto rispetto a quelli<br />
se<strong>di</strong>mentari, che danno origine a depositi più grossolani e <strong>di</strong> minore estensione.<br />
I raccor<strong>di</strong> del fondovalle con i versanti sono più netti rispetto alla valle <strong>di</strong> Isalle,<br />
soprattutto in destra idrografica dove i fianchi sono sub verticali e orlati da falde<br />
detritiche.<br />
Quasi tutto il settore centrale del territorio comunale <strong>di</strong> <strong>Dorgali</strong> presenta in<br />
affioramento, dal confine nordorientale con l’agro <strong>di</strong> Galtellì a quello sudoocidentale<br />
con il comune <strong>di</strong> Oliena, esclusivamente litologie effusive laviche in forma <strong>di</strong> plateaux,<br />
che formano un vasto altopiano sub orizzontale modestamente inclinato con<br />
immersione verso NNO a occidente e NNE ad oriente, che rappresentano anche le<br />
<strong>di</strong>rezioni prevalenti <strong>di</strong> scorrimento delle lave, che hanno colmato le depressioni<br />
preesistenti fossilizzando la morfologia originaria.<br />
L’assetto tabulare dei basalti è articolato solo da modesti rilievi poco elevati e a<br />
bassissima pendenza che rappresentano apparati vulcanici a scudo, e da modestissime<br />
depressioni se<strong>di</strong> <strong>di</strong> processi <strong>di</strong> idromorfia superficiale, che rappresentano l’unico<br />
processo evolutivo in essere all’estradosso dell’altopiano basaltico.<br />
La continuità del plateaux è interrotta da due importanti incisioni <strong>di</strong> origine fluviale<br />
sviluppate come canyon lungo il corso del rio Littu e del rio Tinniperedu,<br />
caratterizzate da pareti verticali o sub verticali che incidono le bancate laviche fino a<br />
raggiungere il basamento granitoide.<br />
Questa terza unità fisiografica, quella dei canyons o delle codule, si manifesta sia su<br />
litologie basaltiche che su quelle calcaree.<br />
dott. ing. Sebastiano Bussalai<br />
dott. geol. Gianfranco Mulas Relazione <strong>di</strong> Compatibilità <strong>geologica</strong> e geotecnica pag.<br />
17
Nelle lave presenta i caratteri più esasperati, sia per la maggiore facilità erosiva <strong>di</strong><br />
questi litotipi, sia per la maggiore velocità con cui si sono sviluppate, sia ancora per la<br />
superiore giovinezza che le caratterizza.<br />
Esse, infatti, nelle lave rappresentano le fasi iniziali del processo <strong>di</strong> inversione del<br />
rilievo, sono impostate prevalentemente lungo linee <strong>di</strong> <strong>di</strong>scontinuità strutturale<br />
preesistente, e il loro approfon<strong>di</strong>mento rapido è stato possibile grazie ad numerosi,<br />
molto rapi<strong>di</strong> e ravvicinati abbassamenti del livello <strong>di</strong> base, determinati dagli episo<strong>di</strong><br />
glaciali del quaternario.<br />
I canaloni basaltici sono caratterizzati da pareti verticali e sub verticali, orlate alla base<br />
da una serie <strong>di</strong> conoi<strong>di</strong> e <strong>di</strong> falde detritiche, prevalentemente rappresentate da massi<br />
più o meno isolati <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni solitamente contenute, che costituiscono corpi <strong>di</strong><br />
frana antiche e recenti.<br />
Queste manifestazioni rappresentano, allo stato attuale, i processi <strong>di</strong>namici più<br />
evidenti e più frequenti non solo all’interno <strong>di</strong> questa unità fisiografica, ma anche<br />
entro tutto il territorio <strong>di</strong> <strong>Dorgali</strong> presentando, tra i fenomeni <strong>di</strong>namici gravitativi, i<br />
caratteri più parossistici.<br />
La <strong>di</strong>namica fluviale attuale dei canyon è estremamente contenuta e spesso i corsi<br />
d’acqua presentano deflusso stagionale o, quando perenne, nel periodo arido risulta<br />
caratterizzato da deflusso subalveo.<br />
Le codule, quando impostate su litologie calcaree, sono contrad<strong>di</strong>stinte da una<br />
maggiore senilità evolutiva, essendosi impostate già durante le prime fasi <strong>di</strong><br />
continentalità delle assise carbonatiche determinate dall’orogenesi alpina,<br />
normalmente presentano pareti più approfon<strong>di</strong>te ma meno inclinate e, soprattutto,<br />
sono caratterizzate da un maggiore grado <strong>di</strong> stabilità delle pareti, alla base delle quali<br />
sono quasi del tutto assenti i depositi gravitativi in accumuli, localizzati o estesi, che<br />
sono per lo più costituiti da singoli massi che però, in questo caso possono raggiungere<br />
<strong>di</strong>mensioni superiori.<br />
L’ambiente fisiografico delle falde calcaree, che oggi rappresenta una porzione<br />
residuale <strong>di</strong> una formazione che si estendeva su tutta la costa orientale della Saregna,<br />
dott. ing. Sebastiano Bussalai<br />
dott. geol. Gianfranco Mulas Relazione <strong>di</strong> Compatibilità <strong>geologica</strong> e geotecnica pag.<br />
18
è quello che caratterizza la fascia costiera e, nel settore sudoccidentale anche<br />
l’entroterra.<br />
Già nel miocene le assise carbonatiche, sottoposte all’azione compressiva generata<br />
dalla rotazione del blocco sardo corso, subivano una strutturazione fondamentale che<br />
ricalca grossomodo quella attuale, venendo smembrate in falde interne e falde<br />
esterne.<br />
La fascia costiera rappresenta la porzione settentrionale <strong>di</strong> una falda esterna estesa<br />
fino a Baunei, contrad<strong>di</strong>stinta da una sensibile inclinazione verso est degli strati<br />
originari.<br />
Anche la falda interna costituisce l’estremità settentrionale <strong>di</strong> una zolla che si estende<br />
fino al comunale <strong>di</strong> Orgosolo e, anche in questo caso sebbene con inclinazione minore,<br />
gli strati calcarei presentano una netta immersione verso E.<br />
L’isolamento delle falde ha origini essenzialmente tettonica, per questo il loro limite è<br />
molto netto, soprattutto sui lati orientali ed occidentali, dove sono delimitate da<br />
falesie a strapiombo sul mare o da scarpate sub verticali <strong>di</strong> arretramento degli<br />
originari specchi <strong>di</strong> faglia.<br />
La morfologia che caratterizza questa unità fisiografica è quella tipica carsica, sia in<br />
superficie che in profon<strong>di</strong>tà, dove il carsismo assume uno sviluppo particolarmente<br />
evoluto.<br />
Le forme ed i processi attivi sono molto scarsi e molto lenti e, in linea <strong>di</strong> massima,<br />
possono essere considerati fossili, per cui la stabilità <strong>di</strong> questa unità può essere<br />
considerata assoluta.<br />
Diversa considerazione deve essere sviluppata per quanto attiene a quell’ambiente<br />
sviluppato a margine delle assise calcaree, in corrispondenza delle scarpate che le<br />
delimitano, soprattutto lungo il bordo occidentale.<br />
Qui la strutturazione dell’ammasso, l’azione gravitativa e la scarsa attività dei<br />
fenomeni erosivi recenti, hanno permesso la formazione <strong>di</strong> potenti accumuli detritici<br />
<strong>di</strong>sposti in conoi<strong>di</strong> e falde localizzate imme<strong>di</strong>atamente a valle delle scarpate, che<br />
modulano in maniera meno netta il raccordo tra queste ed il fondovalle.<br />
dott. ing. Sebastiano Bussalai<br />
dott. geol. Gianfranco Mulas Relazione <strong>di</strong> Compatibilità <strong>geologica</strong> e geotecnica pag.<br />
19
I processi evolutivi <strong>di</strong> questa unità risultano essere ancora attivi, sebbene con una<br />
velocità estremamente rallentata, e rappresentati da perio<strong>di</strong>ci fenomeni frana per<br />
<strong>di</strong>stacco, crollo e rotolamento <strong>di</strong> massi provenienti dalla cornice calcarea retrostante.<br />
Molto rari sono invece i fenomeni <strong>di</strong> instabilità a carico del corpo detritico che, anche<br />
grazie alla presenza <strong>di</strong> una vegetazione boschiva evoluta, è contrad<strong>di</strong>stinto da un<br />
livello <strong>di</strong> stabilità me<strong>di</strong>o-alto, per lo meno in <strong>relazione</strong> alle caratteristiche generali clivo<br />
metriche e composizionali.<br />
Un ulteriore ambiente fisiografico è quello rappresentato dai depositi crioclastici.<br />
Questi sono presenti quasi esclusivamente in uno strato paraconcordante alla falda<br />
calcarea nel versante orientale della falda esterna, in concomitanza della strada<br />
provinciale che collega la S.S. 125 con l’abitato <strong>di</strong> Cala Gonone e si estendono con<br />
continuità dalla sommità del versante fino alla linea <strong>di</strong> costa.<br />
La stabilità generale <strong>di</strong> questi terreni è molto elevata, essendo interessati da processi<br />
<strong>di</strong> cementazione calcarea, ed i processi erosivi sono limitati prevalentemente all’azione<br />
laminare delle acque superficiali localizzati prevalentemente nelle aree prive <strong>di</strong><br />
vegetazione dove si può sviluppare il denudamento corticale dello strato più<br />
superficiale totalmente allentato, oppure lungo canali <strong>di</strong> ruscellamento concentrato,<br />
localizzati soprattutto lungo le linee <strong>di</strong> massima pendenza, oppure ancora dove<br />
l’attività estrattiva, o comunque gli interventi antropici, hanno mo<strong>di</strong>ficato la giacitura<br />
originaria, creando soluzioni della continuità che, comunque, <strong>di</strong>fficilmente danno<br />
origine a fenomeni franosi veri e propri.<br />
L’ultima unità fisiografica rilevante è quella delle coste.<br />
La litologia lapidea prevalente dei terreni affacciati al mare, associata alla forte<br />
strutturazione tettonica del settore ed all’assenza fondamentale <strong>di</strong> corsi d’acqua<br />
caratterizzati da trasporto solido rilevante, influenza il carattere fondamentale della<br />
linea <strong>di</strong> riva marina che, per oltre l’ottanta per cento del suo sviluppo, è rappresentata<br />
da una costa alta e, per lo più da falesie a strapiombo sul mare.<br />
Queste sono costituite nella maggior parte dei casi da antichi specchi delle faglie che<br />
hanno <strong>di</strong>slocato e smembrato le assise carbonatiche, si presentano a strapiombo sul<br />
mare con altezze spesso superiori a quaranta metri.<br />
dott. ing. Sebastiano Bussalai<br />
dott. geol. Gianfranco Mulas Relazione <strong>di</strong> Compatibilità <strong>geologica</strong> e geotecnica pag.<br />
20
Le falesie sono intaccate, a <strong>di</strong>verse quote da solchi <strong>di</strong> battente, <strong>di</strong> cui almeno due serie<br />
sono fossili e testimoniano le <strong>di</strong>verse quote del livello marino raggiunto durante i<br />
perio<strong>di</strong> interglaciali del quaternario.<br />
Allo stesso periodo può essere attribuito il più basso dei terrazzi <strong>di</strong> abrasione marina<br />
che si sviluppa quasi esclusivamente a nord <strong>di</strong> Cala Gonone, ad una quota <strong>di</strong> circa un<br />
metro rispetto al livello del mare attuale.<br />
Le falesie calcaree presentano in affaccio sul mare numerose grotte <strong>di</strong> origine carsica il<br />
cui sviluppo sotterraneo e subacquee testimoniano il grado <strong>di</strong> evoluzione del sistema<br />
carsico locale, contrad<strong>di</strong>stinto oltre che da notevole estensione, anche da un livello <strong>di</strong><br />
maturità molto elevato.<br />
Dal punto <strong>di</strong> vista morfi<strong>di</strong>namico attuale si può descrivere una con<strong>di</strong>zione essenziale <strong>di</strong><br />
staticità, con processi che sono limitati prevalentemente al lento sviluppo delle forme<br />
carsiche e a modestissimi fenomeni, molto localizzati, <strong>di</strong> crollo <strong>di</strong> elementi litoi<strong>di</strong><br />
completamente isolati.<br />
Queste manifestazioni sono quasi sempre localizzate dove l’equilibrio statico è stato<br />
alterato da interventi antropici, come accade lungo la strada provinciale che collega<br />
Gonone con Cala Fuili.<br />
Coste a falesia sono presenti anche su altre litologie, come avviene per i basalti <strong>di</strong><br />
Codula Manna, in località S’Abba Durche, dove però la falesia è preesistente agli<br />
episo<strong>di</strong> effusivi che, copiando la morfologia esistente, hanno parzialmente<br />
sovrapposto le scarpate, talora incrementandone l’altezza e la pendenza.<br />
Sono proprio le falesie sviluppate sui basalti la fonte delle maggiori e più frequenti<br />
manifestazioni <strong>di</strong> instabilità, infatti il notevole livello <strong>di</strong> <strong>di</strong>scontinuità che le colate<br />
laviche presentano nelle aree marginali, associate alla con<strong>di</strong>zione clivo metrica ed<br />
all’azione <strong>di</strong> scalzamento alla base, intensificano in maniera considerevole i fenomeni<br />
gravitativi.<br />
Maggiore stabilità hanno invece le falesie e le scarpate <strong>di</strong> erosione fluviale sviluppate<br />
sugli eboulis ordonnes, i conglomerati <strong>di</strong> origine crioclastica.<br />
La loro con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> stabilità attuale, peraltro, appare determinata sostanzialmente<br />
dall’assenza <strong>di</strong> fenomeni erosivi <strong>di</strong> entità concreta.<br />
dott. ing. Sebastiano Bussalai<br />
dott. geol. Gianfranco Mulas Relazione <strong>di</strong> Compatibilità <strong>geologica</strong> e geotecnica pag.<br />
21
I soli processi esogeni attualmente attivi sono, infatti rappresentati dall’azione delle<br />
acque meteoriche, <strong>di</strong> scarsa efficacia vista l’elevata permeabilità <strong>di</strong> questi terreni, e<br />
l’azione del vento e dell’umi<strong>di</strong>tà che, <strong>di</strong> fatto, determinano solo una lenta <strong>di</strong>ssoluzione<br />
del cemto carbonatico che lega i clasti dei livelli corticali, senza comprometterne la<br />
stabilità in grande.<br />
La manifestazione più evidente in questa formazione è rappresentato da modesti<br />
fenomeni <strong>di</strong> sifonamento che si sviluppano nei livelli più fine granulari dove l’intensità<br />
della cementazione è inferiore e dove la circolazione idrica può assumere maggiore<br />
pressione.<br />
Le tratte <strong>di</strong> costa in cui sono presenti gli arenili sono interessate quasi esclusivamente<br />
dalla <strong>di</strong>namica marittima, a volte così intensa, come nel caso della Caletta <strong>di</strong> Oddoana,<br />
che può determinarne la scomparsa temporanea e la riformazione perio<strong>di</strong>ca.<br />
Le sole eccezioni sono rappresentate dalle spiagge <strong>di</strong> Osalla, Cartoe e per la porzione<br />
meri<strong>di</strong>onale <strong>di</strong> Cala Luna, dove si sviluppa una <strong>di</strong>namica fluviale che è prevalentemente<br />
rappresentata da processi <strong>di</strong> se<strong>di</strong>mentazione deltizia e stagnale e, solo<br />
occasionalmente ed in concomitanza con le piene eccezionali, da processi erosivi<br />
parossistici <strong>di</strong> tipo alluvionale con l’erosione del cordone litorale e il ricollegamento<br />
<strong>di</strong>retto a mare del fiume.<br />
Tettonica<br />
Il settore esaminato risulta influenzato in modo fondamentale da due cicli orogenetici,<br />
quello ercinico prima e quello alpino poi.<br />
Il primo ha determinato la strutturazione del basamento cristallino paleozoico,<br />
attraverso le sue <strong>di</strong>verse fasi, in particolar modo quelle tardo e post-orogeniche<br />
caratterizzate prima dal magmatismo intrusivo calcoalcalino, con la messa in posto del<br />
batolite sardo, poi dalla riesumazione e dall'inizio dello smantellamento della catena<br />
appena formatasi nelle sta<strong>di</strong> tar<strong>di</strong>vi.<br />
dott. ing. Sebastiano Bussalai<br />
dott. geol. Gianfranco Mulas Relazione <strong>di</strong> Compatibilità <strong>geologica</strong> e geotecnica pag.<br />
22
Questi ultimi sono caratterizzati da fasi a carattere generalmente <strong>di</strong>stensivo con gran<strong>di</strong><br />
movimenti trascorrenti che generano un complicato sistema <strong>di</strong> faglie a varie scale.<br />
L’impostazione strutturale fondamentale del territorio risale all’orogenesi ercinica, alla<br />
quale è imputabile la genesi delle due strutture tettoniche principali, rappresentate<br />
dalla faglia <strong>di</strong> Oddoene, lungo la cui <strong>di</strong>rettrice si è impostato l’alveo del rio<br />
Flumineddu, e la faglia <strong>di</strong> Isalle, su cui si sviluppa l’omonimo corso d’acqua.<br />
Questa è evidentemente impostata esclusivamente sui litotipi granitoi<strong>di</strong>, localizzati a<br />
sud, mettendoli a contatto con quelli metamorfici, presenti invece a nord della linea <strong>di</strong><br />
faglia e, pur se riesumata in fasi più recenti, non ha interessato altri litotipi.<br />
La sua entità, oltre che dalla <strong>di</strong>mensione regionale, è rappresentata anche dalla<br />
presenza ad essa associata <strong>di</strong> una potente formazione milonitica.<br />
La faglia <strong>di</strong> Oddoene, <strong>di</strong> tipo <strong>di</strong>stensivo e trascorrente con <strong>di</strong>rezione N30E, invece,<br />
sebbene impostata sul basamento granitoide, è stata ringiovanita sia dalla tettonica<br />
alpina, influenzando la strutturazione e generando il <strong>di</strong>slocamento in falde delle assise<br />
carbonatiche, sia dalla neotettonica, attraverso la quale ha determinato la fatturazione<br />
e la <strong>di</strong>aclasizzazione delle colate laviche permettendo lo sviluppo dei canyons, che le<br />
incidono secondo la <strong>di</strong>rettrice fondamentale NE-SW, che rappresenta la <strong>di</strong>rettrice<br />
principale <strong>di</strong> tutto il territorio <strong>di</strong> <strong>Dorgali</strong>.<br />
La riesumazione <strong>di</strong> questa <strong>di</strong>rettrice è testimoniata anche dall’allineamento dei<br />
principali centri effusivi, a Gonone quello <strong>di</strong> Codula Manna, a NE dell’abitato, e quello<br />
<strong>di</strong> Fruncu de Pala, verso SO del paese, mentre a <strong>Dorgali</strong> risultano grossomodo allineati<br />
il monte S.Elene, il colle del Carmelo, la collina <strong>di</strong> Pirischè e quella <strong>di</strong> Sa Tupped<strong>di</strong>e.<br />
Pur se non <strong>di</strong>rettamente associato ad altro apparato centralizzato ad esso vicino,<br />
anche il vulcano a scudo <strong>di</strong> Conca ‘e Janas risulta allineato secondo tale <strong>di</strong>rettrice a<br />
<strong>di</strong>versi punti <strong>di</strong> effusione <strong>di</strong> traboccamento, oltre che all’a<strong>di</strong>acente punta Arjadores.<br />
Al ciclo alpino va attribuita una tettonica <strong>di</strong>stensiva rigida che per lo più riattiva le<br />
<strong>di</strong>rettrici fondamentali erciniche, associandone nuove subor<strong>di</strong>nate e rendendo<br />
irriconoscibili le più antiche.<br />
Tra Oligocene e Miocene si esplica una intensa fase tettonica compressiva collegata a<br />
fenomeni traslativi cui si associano fenomeni <strong>di</strong>sgiuntivi rigi<strong>di</strong> che determinano una<br />
dott. ing. Sebastiano Bussalai<br />
dott. geol. Gianfranco Mulas Relazione <strong>di</strong> Compatibilità <strong>geologica</strong> e geotecnica pag.<br />
23
nuova ulteriore strutturazione al basamento cristallino e danno origine alla<br />
strutturazione primaria delle assise carbonatiche <strong>di</strong> copertura, sulle quali si riscontrano<br />
anche limitati cenni fenomeni plicativi.<br />
Le trasgressioni miocenica e pliocenica sortiscono effetti molto blan<strong>di</strong> in tutto il<br />
settore, mentre risultano molto evidenti gli effetti della regressione tardopliocenica,<br />
durante la quale hanno luogo i massimi eventi morfo<strong>di</strong>namici a carico dei se<strong>di</strong>menti<br />
carbonatici, sui quali si esplica una forte erosione concentrata con la formazione <strong>di</strong><br />
unità fisiografiche notevolmente evolute, con inversione del rilievo rispetto al<br />
basamento metamorfo-cristallino e deposizione <strong>di</strong> se<strong>di</strong>menti esclusivamente in facies<br />
continentale.<br />
E’ in questa fase che le assise carbonatiche, ormai già strutturate, subiscono i principali<br />
<strong>di</strong>slocamenti e basculamenti verso Est, e cominciano a formarsi le potenti coltri<br />
detritiche superficiali.<br />
La fine del Pliocene coincide anche con una fase tettonica <strong>di</strong>stensiva conseguente al<br />
rilascio delle tensioni generate dalla rotazione del blocco Sardo-Corso, durante la quale<br />
ha luogo una intensa azione morfo<strong>di</strong>namica gravitativa con la formazione <strong>di</strong> estese<br />
facies detritiche e <strong>di</strong> frana, cui si accompagna una intensa <strong>di</strong>namica vulcanica<br />
esogena, con la messa in posto <strong>di</strong> vasti espan<strong>di</strong>menti lavici a chimismo basico che<br />
determinano la colmata delle maggiori depressioni appena formatesi.<br />
Il sistema <strong>di</strong> fratture più importante è <strong>di</strong>retto N30E e presenta un notevole sviluppo<br />
lineare interessando tutta l'area <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o.<br />
Le fratture generalmente riutilizzano linee <strong>di</strong> debolezza primaria, generando piani <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>scontinuità variamente orientati ed inclinati.<br />
Un sistema secondario coniugato N45E interferisce con il precedente generando<br />
strutture minori.<br />
Ulteriori strutture <strong>di</strong> minore importanza, con orientazioni N-S, N30O e N50O, sono<br />
presenti in varie zone dell'area ma non determinano una caratterizzazione<br />
fondamentale se non nel tardo Pliocene quando consentono, al rilascio delle tensioni<br />
generate dalla rotazione della zolla Sardo-Corsa, la fuoriuscita dei magmi attraverso<br />
dott. ing. Sebastiano Bussalai<br />
dott. geol. Gianfranco Mulas Relazione <strong>di</strong> Compatibilità <strong>geologica</strong> e geotecnica pag.<br />
24
condotti fissurali notevolmente estesi linearmente e, quando associate alle <strong>di</strong>rettrici<br />
ortogonali, la formazione dei centri <strong>di</strong> effusione centralizzata.<br />
Faglie, fratture e <strong>di</strong>aclasi si presentano oggi con aperture da sub-millimetriche a<br />
millimetriche, sempre caratterizzate dalla presenza <strong>di</strong> un riempimento a carattere limo<br />
sabbioso sui litotipi intrusivi, limo-argilloso in quelli lavici.<br />
Idrogeologia<br />
Analogamente alla morfologia anche i caratteri Idrogeologici ed idrologici risultano<br />
strettamente influenzati dai parametri litologici, stratigrafici, tettonici e, in questo caso<br />
anche morfologici.<br />
Per quanto attiene alle caratteristiche <strong>di</strong> permeabilità dei terreni si possono<br />
in<strong>di</strong>viduare quattro classi <strong>di</strong>fferenti <strong>di</strong> comportamento dei materiali in <strong>relazione</strong> alla<br />
circolazione idrica sotterranea:<br />
- Terreni permeabili per porosità;<br />
- Terreni permeabili per fratturazione e carsismo;<br />
- Terreni permeabili per fratturazione;<br />
- Terreni impermeabili.<br />
Deve essere precisato che non sempre la separazione tra le classi C e D risulta essere<br />
netta e ben demarcata, ma piuttosto tale sud<strong>di</strong>visione si deve intendere come<br />
orientativa, in quanto i terreni impermeabili, in particolari situazioni strutturali,<br />
possono presentare limitati valori <strong>di</strong> permeabilità secondaria, soprattutto per le fasce<br />
più superficiali in cui le <strong>di</strong>scontinuità risultano beanti e facilmente saturabili.<br />
Tra i materiali permeabili per porosità possono includersi tutti i prodotti alluvionali,<br />
recenti ed antichi, i terreni detritici, falde, conoi<strong>di</strong>, glacis, corpi <strong>di</strong> frana.<br />
Le litologie permeabili per carsismo e fratturazione sono esclusivamente quelle<br />
carbonatiche, nelle quali l’evoluzione dei processi carsici risulta particolarmente<br />
rilevante.<br />
dott. ing. Sebastiano Bussalai<br />
dott. geol. Gianfranco Mulas Relazione <strong>di</strong> Compatibilità <strong>geologica</strong> e geotecnica pag.<br />
25
L’acquifero carsico è caratterizzato da uno sviluppo particolarmente rilevante, sia in<br />
senso planimetrico che in profon<strong>di</strong>tà, estendendosi anche al <strong>di</strong> sotto del livello marino<br />
con il tipico sistema <strong>di</strong> cavità e condotte interconnesse.<br />
Una particolarità <strong>di</strong> questo sistema idrogeologico è costituita dalla presenza <strong>di</strong><br />
numerose sorgenti <strong>di</strong> acqua dolce manifeste in con<strong>di</strong>zione sottomarina bassa<br />
profon<strong>di</strong>tà, spesso a meno <strong>di</strong> un metro dalla superficie, localizzate imme<strong>di</strong>atamente a<br />
ridosso della linea <strong>di</strong> costa..<br />
Le più famose sono quelle <strong>di</strong> S’Abba Durche e <strong>di</strong> S’Abba Meica, rispettivamente subito<br />
a nord e a sud <strong>di</strong> Cala Gonone.<br />
Alla classe dei litotipi permeabili per fratturazione appartengono esclusivamente i<br />
granitoi<strong>di</strong>, la cui permeabilità, quando inalterati, è da ritenersi generalmente molto<br />
scarsa e legata esclusivamente alla fratturazione.<br />
L’acquifero si può formare, secondo uno schema <strong>di</strong> reti interconnesse più o meno in<br />
pressione, ma sempre con carattere artesiano, solo quando le <strong>di</strong>scontinuità risultano<br />
aperte, beanti e prive <strong>di</strong> riempimento, con<strong>di</strong>zioni che solitamente si possono<br />
riscontrare a profon<strong>di</strong>tà superiori ai trenta – quaranta metri dal piano <strong>di</strong> campagna<br />
nelle rocce acide, mentre in quelle interme<strong>di</strong>e e basiche solitamente si superano i<br />
sessanta metri.<br />
Tali con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> accumulo si possono sviluppare anche nei basalti ma solo<br />
eccezionalmente, soprattutto poche le colate lapidee sono sempre intercalate da livelli<br />
scoriacei o ricoperte da suoli a componente argillosa prevalente, che non consentono<br />
l’infiltrazione efficace se non in modestissime quantità,<br />
Un acquifero relativamente importante è presente all’interno delle colate basaltiche in<br />
alcune aree ben localizzate, seppure notevolmente estese, e si sviluppa nel corpo<br />
se<strong>di</strong>mentario delle alluvioni infrabasaltiche.<br />
La presenza <strong>di</strong> un letto e <strong>di</strong> un tetto praticamente impermeabili, conferisce a questo<br />
acquifero, sviluppato come una vera e propria falda omogeneamente <strong>di</strong>ffusa, un netto<br />
carattere artesiano.<br />
Un acquifero, dotato <strong>di</strong> caratteri molto simili a quello appena sopra descritto, è<br />
presente, anche questo i maniera localizzata, al contatto tra le rocce granitoi<strong>di</strong> e quelle<br />
dott. ing. Sebastiano Bussalai<br />
dott. geol. Gianfranco Mulas Relazione <strong>di</strong> Compatibilità <strong>geologica</strong> e geotecnica pag.<br />
26
che le ricoprono, qualunque sia la loro natura, ma la sua capacità <strong>di</strong> accumulo è spesso<br />
molto limitata.<br />
Notevole importanza rivestono inoltre i filoni, i quali danno origine ad un effetto "<strong>di</strong>ga"<br />
che limita il deflusso sotterraneo delle acque, sud<strong>di</strong>videndo i bacini in unità<br />
idrogeologiche in<strong>di</strong>pendenti.<br />
I terreni impermeabili, quelli in cui la permeabilità primaria è nulla o presenta valori<br />
inferiori a 10-6 cm/sec, ed in cui si possono riscontrare minimi valori <strong>di</strong> permeabilità<br />
per fratturazione, limitati peraltro alle sole fasce <strong>di</strong> intensa strutturazione, sono<br />
rappresentati dalle metamorfiti, lapidee o alterate, dai granitoi<strong>di</strong> lapidei compatti o<br />
parzialmente alterati, e dai basalti lapidei e compatti.<br />
Anche i basalti scoriacei possono, in linea <strong>di</strong> massima, essere considerati come<br />
assolutamente impermeabili, pur presentando, soprattutto quando la componente<br />
argillosa è limitata, un modesto coefficiente <strong>di</strong> permeabilità primaria tale da consentire<br />
loro minime capacità <strong>di</strong> accumulo che permette la formazione <strong>di</strong> limitate falde<br />
sospese sub superficiali <strong>di</strong> bassa rilevanza.<br />
In definitiva possono essere in<strong>di</strong>viduate due tipologie <strong>di</strong> circolazione idrica sotterranea,<br />
una superficiale e subsuperficiale ed una profonda.<br />
Le falde freatiche possono svilupparsi solo nei terreni allentati <strong>di</strong> copertura e sono<br />
sempre <strong>di</strong> tipo superficiale, vista la modesta potenza <strong>di</strong> queste formazioni, soprattutto<br />
<strong>di</strong> quelle alluvionali che sono localizzate, in quantità tali da consentire la formazione <strong>di</strong><br />
un acquifero, solo nella piana associata al Rio Isalle e, in misura molto minore, al rio<br />
Flumineddu.<br />
Modesti acquiferi si sviluppano negli accumuli colluviali, dove questi raggiungono<br />
potenza plurimetrica, ma soprattutto dove possono svilupparsi fenomeni <strong>di</strong> risalita<br />
idrostatica o per capillarità delle acque profonde.<br />
Lo schema della circolazione idrica influenza anche il sistema delle sorgenti che, se si<br />
escludono quelle <strong>di</strong> origine carsica, quali quelle già citate <strong>di</strong> Cala Gonone, quella <strong>di</strong> San<br />
Giovanni e Quella <strong>di</strong> San Pantaleo, tutte contrad<strong>di</strong>stinte da portate rilevanti, sono<br />
rappresentate solo da modestissime venute d’acqua localizzate esclusivamente nelle<br />
dott. ing. Sebastiano Bussalai<br />
dott. geol. Gianfranco Mulas Relazione <strong>di</strong> Compatibilità <strong>geologica</strong> e geotecnica pag.<br />
27
occe granitoi<strong>di</strong>, come la sorgente <strong>di</strong> Gurosai localizzata nella periferia meri<strong>di</strong>onale <strong>di</strong><br />
<strong>Dorgali</strong>-<br />
Di alimentazione carsica, sebbene occulta, appaiono essere le sorgenti presenti<br />
all’interno dell’abitato <strong>di</strong> <strong>Dorgali</strong>, Roseddu e Funtana, manifeste in litologie laviche ma<br />
allineate lungo quella che sembra una superficie <strong>di</strong> <strong>di</strong>scontinuità strutturale, che può<br />
costituire una netta soglia <strong>di</strong> permeabilità e permettere l’affioramento delle acque<br />
sotterranee.<br />
Questo allineamento, inoltre pare essere coincidente con la linea <strong>di</strong> raccordo tra le<br />
colate provenienti dal centro effusivo del Carmelo, e quelle provenienti da Pirischè, le<br />
cui lave presentano sensibili <strong>di</strong>fferenze composizionali, con quelle meri<strong>di</strong>onali più<br />
scoriacee e bollose, composte anche da livelli esplosivi, mentre quelle settentrionali<br />
risultano essere quasi esclusivamente lapidee.uesto allineamento appare, inoltre<br />
costituire la linea Q<br />
Alcune sorgenti, pochissime e <strong>di</strong> tipo effimero, sono presenti anche lungo le scarpate<br />
che delimitano le colate laviche, dove queste intersecano quei pochi livelli scoriacei o i<br />
livelli se<strong>di</strong>mentari infrabasaltici dotati <strong>di</strong> alcuna capacità <strong>di</strong> accumulo.<br />
Idrografia<br />
Anche l’assetto idrografico <strong>di</strong> superficie risente in maniera determinante della<br />
caratterizzazione litologica, influenzando il grado <strong>di</strong> sviluppo e l’estensione del reticolo<br />
idrografico.<br />
Tutti i corsi d’acqua, con la sola esclusione del rio Isalle e in maniera parziale il rio<br />
Flumineddu, presentano un carattere decisamente torrentizio, sia per la limitata<br />
estensione dei loro bacini <strong>di</strong> alimentazione, sia per l’assenza sostanziale <strong>di</strong> sorgenti che<br />
determinino un alimentazione continua.<br />
Il rio Isalle, che più a valle è identificato con il nome <strong>di</strong> rio Sologo, si estende<br />
notevolmente verso monte ed ha come tributari numerosi affluenti alimentati da un<br />
elevato numero <strong>di</strong> manifestazioni sorgentizie e che si sviluppano prevalentemente su<br />
dott. ing. Sebastiano Bussalai<br />
dott. geol. Gianfranco Mulas Relazione <strong>di</strong> Compatibilità <strong>geologica</strong> e geotecnica pag.<br />
28
terreni granitoi<strong>di</strong> a bassa permeabilità, per cui l’alimentazione è garantita durante<br />
tutto l’arco dell’anno, seppure con forti variazioni delle portate, consentendo un<br />
deflusso subaereo praticamente perenne.<br />
Il rio Flumineddu, invece, ha un bacino imbrifero che si estende sia su litologie<br />
metamorfiche, praticamente sterili per quanto attiene al carattere idrogeologico, sia<br />
su terreni calcarei che, per lo meno in parte, determinano un’alimentazione continua,<br />
pur con portate relativamente contenute, e questo fa si che, nei perio<strong>di</strong> ari<strong>di</strong> il<br />
deflusso, soprattutto nella tratta sviluppata nell’agro <strong>di</strong> <strong>Dorgali</strong>, possa manifestarsi<br />
solo in con<strong>di</strong>zione subalvea.<br />
Nella porzione <strong>di</strong> territorio in esame tutti e due i corsi d’acqua presentano un alveo<br />
abbastanza regolare, con ripe nette e perfettamente incassate nel materasso<br />
alluvionale o, come nel caso <strong>di</strong> alcune tratte del rio Flumineddu, incise profondamente<br />
nei se<strong>di</strong>menti calcarei mesozoici.<br />
Pochi sono gli affluenti sviluppati nell’agro <strong>di</strong> <strong>Dorgali</strong> che versano <strong>di</strong>rettamente<br />
nell’Isalle o nel Flumineddu e, per lo più, sono rappresentati da canali <strong>di</strong> ruscellamento<br />
concentrato.<br />
Nelle litologie laviche vi sono due forme <strong>di</strong>verse <strong>di</strong> circolazione idrica <strong>di</strong> superficie.<br />
Una è quella areica tipica degli altopiani, con una praticamente totale assenza <strong>di</strong> corsi<br />
d’acqua organizzati ed in cui il reticolo è rappresentato solo da modesti canali <strong>di</strong><br />
deflusso concentrato, con vaste aree <strong>di</strong> idromorfia superficiale.<br />
La seconda tipologia è rappresentata dai rii che hanno inciso le codule, corsi d’acqua <strong>di</strong><br />
modestissimo sviluppo lineare e attualmente contrad<strong>di</strong>stinti da un regime fortemente<br />
torrentizio, anche se la loro alimentazione ha luogo anche attraverso alcune sorgenti<br />
relativamente potenti.<br />
Il loro tracciato è solitamente rettilineo, o al più angolare, essendosi sviluppati<br />
prevalentemente lungo strutture tettoniche preesistenti.<br />
Gli alvei sono sempre profondamente incisi nelle rocce basaltiche fino a raggiungere i<br />
sottostanti litotipi granitoi<strong>di</strong>.<br />
Il loro reticolo è sempre molto poco sviluppato, con ramificazioni che al più possono<br />
raggiungere il terzo or<strong>di</strong>ne.<br />
dott. ing. Sebastiano Bussalai<br />
dott. geol. Gianfranco Mulas Relazione <strong>di</strong> Compatibilità <strong>geologica</strong> e geotecnica pag.<br />
29
Maggiore sviluppo ha invece il reticolo idrografico minore e, in particolar modo quello<br />
che si manifesta sulle litologie granitoi<strong>di</strong> della vallata <strong>di</strong> Oddoene.<br />
In questo settore, il carattere sublitoide alterato dei terreni, la loro scarsa<br />
permeabilità, le pendenze me<strong>di</strong>o alte e la notevole durata del periodo continentale,<br />
hanno portato ad uno sviluppo estremamente articolato degli alvei.<br />
Il reticolo ha la tipica organizzazione dendritica, seppure parzialmente influenzata dalla<br />
strutturazione tettonica, con rami che possono raggiungere anche il quinto or<strong>di</strong>ne.<br />
Questi corsi d’acqua sono contrad<strong>di</strong>stinti da un forte potere morfo<strong>di</strong>namico che,<br />
ormai con cadenza annuale, generano erosioni canaliformi sempre più accentiuate.<br />
dott. ing. Sebastiano Bussalai<br />
dott. geol. Gianfranco Mulas Relazione <strong>di</strong> Compatibilità <strong>geologica</strong> e geotecnica pag.<br />
30
RELAZIONE GEOTECNICA<br />
In questo paragrafo, vista la finalità dello stu<strong>di</strong>o, si sviluppano in maniera sintetica<br />
alcune considerazioni generali relativamente alle caratteristiche geotecniche dei vari<br />
terreni che affiorano nell’ambito esaminato.<br />
Le stesse derivano fondamentalmente da numerosi stu<strong>di</strong> eseguiti precedentemente, <strong>di</strong><br />
cui tutti applicativi nel senso geotecnico, essendo stati realizzati a seguito <strong>di</strong> indagini<br />
geognostiche ed analisi <strong>di</strong> laboratorio appositamente pre<strong>di</strong>sposte nell’ambito <strong>di</strong><br />
specifici progetti, tra i quali particolare rilievo assumono quelli relativi ai lavori <strong>di</strong><br />
ripristino dei danni alluvionali del 2004, durante i quali le problematiche affrontate<br />
erano strettamente concernenti al <strong>di</strong>ssesto idrogeologico dell’intero territorio<br />
comunale.<br />
In linea generale i terreni possono essere sud<strong>di</strong>visi in quattro grosse categorie:<br />
- Materiali lapidei;<br />
- Materiali sub lapidei;<br />
- Materiali granulari;<br />
- Materiali coesivi.<br />
Le rocce metamorfiche sono quasi sempre caratterizzate da un grado me<strong>di</strong>o alto del<br />
livello alterativo e, quasi sempre in affioramento denotano processi <strong>di</strong> argillificazione<br />
piuttosto intensi che, associati ad una giacitura talora a franappoggio, facilitano i<br />
fenomeni instabili, peraltro solitamente limitati ai soli livelli corticali, solo<br />
eccezionalmente estesi a profon<strong>di</strong>tà comunque inferiori al metro.<br />
Quando privi <strong>di</strong> alterazione i litotipi metamorfici presentano comunque una intensa<br />
fissilità per scistosità, foliazione e stratificazione, che ne sminuiscono notevolmente la<br />
caratterizzazione geotecnica.<br />
Quando intensamente alterate, le metamorfiti, rappresentate prevalentemente da<br />
argilloscisti, assumono un comportamento terrigeno moderatamente coesivo ma, per<br />
via della componente sabbiosa, risultano estremamente sensibili alle acque<br />
superficiali.<br />
dott. ing. Sebastiano Bussalai<br />
dott. geol. Gianfranco Mulas Relazione <strong>di</strong> Compatibilità <strong>geologica</strong> e geotecnica pag.<br />
31
Occasionalmente questi materiali, per eccesso <strong>di</strong> imbibizione, possono dare origine a<br />
modeste colate <strong>di</strong> fango, anche quando contrad<strong>di</strong>stinte da pendenze moderate.<br />
Il loro angolo <strong>di</strong> attrito è compreso tra 24° e 28°, mentre la coesione non supera i 0.3<br />
kg/cmq.<br />
I graniti si presentano, in superficie, quasi sempre interessati da processi <strong>di</strong> alterazione<br />
per ossidazione dei femici, secondo un processo definito arenizzazione che mo<strong>di</strong>fica<br />
l’ammasso lapideo in un materiale più o meno coeso che, in con<strong>di</strong>zioni estreme, si può<br />
trasformare in una sabbia limosa più o meno grossolana con potenza variabile ma<br />
sempre inferiore al metro.<br />
Questo materiale è contrad<strong>di</strong>stinto da un elevato potere attritivo ma da una assenza<br />
assoluta della coesione e, per tale motivo, pur geotecnicamente definibile come<br />
buono, risulta estremamente sensibile al’azione erosiva delle acque meteoriche.<br />
I corsi d’acqua che si sviluppano su questi materiali sono quelli contrad<strong>di</strong>stinti dal<br />
maggior trasporto solido e, in occasioni <strong>di</strong> manifestazioni meteoriche eccezionali,<br />
possono dare origine anche a notevoli colate <strong>di</strong> fango, mentre gli smottamenti veri e<br />
propri, visto il modesto spessore <strong>di</strong> questi terreni, sono sempre contenuti.<br />
All’aumentare della profon<strong>di</strong>tà i graniti vedono <strong>di</strong>minuire gradualmente il livello <strong>di</strong><br />
alterazione.<br />
Le facies moderatamente alterate presentano carattere sublitoide, coeso e tenace, che<br />
consente <strong>di</strong> valutarli come buoni o ottimi, con un livello <strong>di</strong> stabilità altissimo, tanto che<br />
solo eccezionalmente possono dare origine a manifestazioni instabili e, rispetto ai<br />
normali processi erosivi <strong>di</strong>mostrano una elevatissima resistenza.<br />
Per essi non ha senso definire un valore dell’angolo <strong>di</strong> attrito interno, sempre<br />
superiore a 40°, quanto appare più idoneo in<strong>di</strong>care il valore <strong>di</strong> resistenza a<br />
compressione, che raramente è inferiore a 400 kg/cmq.<br />
Solitamente con una progressione graduale, già con minimi incrementi <strong>di</strong> profon<strong>di</strong>tà, i<br />
graniti assumono carattere lapideo franco, solitamente già a meno <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci metri dal<br />
piano <strong>di</strong> campagna.<br />
I graniti in facies litoide sono chiaramente contrad<strong>di</strong>stinti da caratteristiche<br />
geotecniche eccellenti, soprattutto per il modesto livello <strong>di</strong> fatturazione che li<br />
dott. ing. Sebastiano Bussalai<br />
dott. geol. Gianfranco Mulas Relazione <strong>di</strong> Compatibilità <strong>geologica</strong> e geotecnica pag.<br />
32
interessa, e possono essere considerati come assolutamente stabili, tanto che delle<br />
oltre trenta manifestazioni instabili, attive o potenziali, note e censite nell’ambito del<br />
territorio comunale <strong>di</strong> <strong>Dorgali</strong>, neanche una si è sviluppata su questi materiali.<br />
Anche i calcari rientrano nel gruppo dei terreni lapidei, non manifestano mai fenomeni<br />
<strong>di</strong> alterazione e si presentano, sia quando massivi che nelle facies stratificate,<br />
estremamente compatti e tenaci.<br />
Sono contrad<strong>di</strong>stinti da un valore <strong>di</strong> resistenza a compressione sempre molto elevato,<br />
comunque superiore ad 800kg/cmq.<br />
La loro strutturazione è sempre contenuta e presentano un livello <strong>di</strong> stabilità me<strong>di</strong>o<br />
alta, sia quando in facies che quando presenti in facies conglomeratica mentre,<br />
quando sono contrad<strong>di</strong>stinti da una evidente stratificazione in banchi <strong>di</strong> spessore<br />
decimetrico e da giacitura a franappoggio, possono dare a<strong>di</strong>to a fenomeni <strong>di</strong> instabilità<br />
per crollo e rotolamento o anche solo per scivolamento.<br />
La fratturazione si intensifica notevolmente in particolare nelle fasce <strong>di</strong> bordo più<br />
prossime alle superfici <strong>di</strong> faglia che hanno <strong>di</strong>slocato l’ammasso originario e, in queste<br />
con<strong>di</strong>zioni, la caratterizzazione geotecnica ottenuta seguendo i criteri valutativi delle<br />
geomeccanica, subisce un sensibile sca<strong>di</strong>mento tanto da permettere lo sviluppo <strong>di</strong><br />
numerose con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> instabilità, potenziali o in atto, <strong>di</strong> cui alcune particolarmente<br />
rilevanti.<br />
I litotipi effusivi rientrano in parte nel gruppo dei materiali lapidei e in parte in quello<br />
dei prodotti coesivi.<br />
Al primo appartengono sia le lave compatte sia quelle vacuolari e, mentre le prime<br />
sono sempre prive <strong>di</strong> fenomeni <strong>di</strong> alterazione, le seconde ne sono interessate con<br />
maggiore frequenza.<br />
Per contro le facies più bollose sono meno interessate dai fenomeni <strong>di</strong>sgiuntivi,<br />
soprattutto quelli legati alla loro messa in posto ed al loro raffreddamento.<br />
La resistenza a compressione varia da circa quattrocento chilogrammi per centimetro<br />
quadrato nelle facies vacuolari, fino ad otre millecinquecento chilogrammi per<br />
centimetro quadrato in quelle compatte.<br />
dott. ing. Sebastiano Bussalai<br />
dott. geol. Gianfranco Mulas Relazione <strong>di</strong> Compatibilità <strong>geologica</strong> e geotecnica pag.<br />
33
La caratterizzazione geotecnica generale quin<strong>di</strong> può essere considerata da buona ad<br />
eccellente ma, come accade per i calcari, in particolari con<strong>di</strong>zioni morfologiche subisce<br />
un drastico deca<strong>di</strong>mento, soprattutto per incremento della fratturazione, che ne<br />
determina la tendenziale instabilità nelle con<strong>di</strong>zioni morfologiche critiche.<br />
Nelle lave compatte questa con<strong>di</strong>zione risulta più frequente ed evidente, vista la<br />
maggiore fragilità che le contrad<strong>di</strong>stingue e data la localizzazione geografica che le<br />
vede colocate sempre in posizione <strong>di</strong>stale rispetto agli apparati effusivi centralizzati.<br />
Le componenti scoriacee o <strong>di</strong> origine esplosiva delle rocce effusive sono classificabili<br />
come materiali coesivi, infatti la loro composizione vede la presenza costante <strong>di</strong> un<br />
abbondante matrice argillosa che lega tra loro gli elementi litoi<strong>di</strong> inglobati, sia che essi<br />
derivino da processi alterativi della roccia originaria, sia che abbiano origine<br />
singenetica.<br />
Questi materiali sono contrad<strong>di</strong>stinti da un livello <strong>di</strong> coesione efficace altissimo, con<br />
valori frequentemente superiori a 0,5 chilogrammi per centimetro quadrato, mentre<br />
la presenza <strong>di</strong> una componente granulare rilevante consente anche angoli <strong>di</strong> attrito<br />
me<strong>di</strong>amente superiori a 25°.<br />
Sono materiali geotecnicamente me<strong>di</strong>ocri o buoni, in funzione del grado <strong>di</strong><br />
rinsaldamento che conservano, contrad<strong>di</strong>stinti da una stabilità assoluta piuttosto<br />
elevata, pur manifestando una resistenza moderata all’azione erosiva delle acque<br />
superficiali.<br />
Ai materiali coesivi possono essere fatti appartenere a che le modeste coltri <strong>di</strong> terreni<br />
a se<strong>di</strong>mentazione palustre o colluviale che derivano più o meno <strong>di</strong>rettamente<br />
dall’alterazione dei basalti.<br />
Sono materiali geotecnicamente scadenti o al più me<strong>di</strong>ocri, con valori <strong>di</strong> angolo <strong>di</strong><br />
attrito me<strong>di</strong>amente contenuto entro i 23°, mentre la coesione non supera i 0.2<br />
chilogrammi per centimetro quadrato.<br />
Sono dotati <strong>di</strong> una scarsissima resistenza agli agenti erosivi e un basso livello <strong>di</strong> stabilità<br />
generale.<br />
dott. ing. Sebastiano Bussalai<br />
dott. geol. Gianfranco Mulas Relazione <strong>di</strong> Compatibilità <strong>geologica</strong> e geotecnica pag.<br />
34
Tutti gli altri terreni <strong>di</strong> copertura se<strong>di</strong>mentaria recente possono essere inclusi tra i<br />
materiali attritivi, a partire dai depositi <strong>di</strong> pen<strong>di</strong>o, per passare ai corpi <strong>di</strong> frana e ai<br />
se<strong>di</strong>menti crioclastici.<br />
Si tratta <strong>di</strong> materiali fondamentalmente attritivi e solitamente privi <strong>di</strong> coesione che<br />
quando presente non è del tipo efficace essendo generata da fenomeni <strong>di</strong><br />
cementazione secondaria.<br />
I valori dell’angolo d’attrito interno sono variabili in funzione sia della pezzatura<br />
granulometrica, sia della loro natura litologica ma, comunque, sono sempre superiori<br />
a 28°, anche nel caso delle componenti fine granulari degli eboulis ordonnes.<br />
Dal punto <strong>di</strong> vista geotecnico sono considerabili da buoni ad ottimi, mai scadenti, e<br />
presentano un livello <strong>di</strong> stabilità me<strong>di</strong>o alto, con valori <strong>di</strong> eccellenza per i se<strong>di</strong>menti<br />
crioclastici, pur con una modesta resistenza ai processi erosivi idrici.<br />
dott. ing. Sebastiano Bussalai<br />
dott. geol. Gianfranco Mulas Relazione <strong>di</strong> Compatibilità <strong>geologica</strong> e geotecnica pag.<br />
35
FENOMENI FRANOSI<br />
L’elevata articolazione litologica ed orografica, associata alla fase <strong>di</strong> giovinezza in cui si<br />
ritrovano alcune porzioni del territorio comunale <strong>di</strong> <strong>Dorgali</strong>, hanno generato con<strong>di</strong>zioni<br />
tali per cui in certi settori si sono potute creare con<strong>di</strong>zioni particolarmente critiche e<br />
favorevoli per lo sviluppo e la pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> fenomeni instabili.<br />
La scarsa <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> terreni allentati <strong>di</strong> copertura, che quando presenti sono<br />
localizzati in aree morfologicamente stabili, unito al carattere assolutamente lapideo<br />
dei terreni presenti in affioramento, determinano in maniera fondamentale la tipologia<br />
delle manifestazioni <strong>di</strong> instabilità, in atto o potenziale.<br />
La quasi totalità dei fenomeni conosciuti e censiti, dall’IFFI prima e dal PAI dopo,<br />
riconducibili a circa trenta episo<strong>di</strong> o aree a d elevata criticità, sono rappresentate dalla<br />
tipologia del <strong>di</strong>stacco, crollo e rotolamento <strong>di</strong> singoli massi più o meno isolati.<br />
Oltre la metà <strong>di</strong> questi fenomeni è riconducibile alle litologie basaltiche ed è<br />
localizzabile a margine delle pareti verticali o sub verticali che orlano i tavolati, mentre<br />
le restanti sono localizzate lungo le pareti verticali che delimitano i rilievi calcarei,<br />
laddove queste rappresentano superfici <strong>di</strong> arretramento <strong>di</strong> antichi specchi <strong>di</strong> faglia.<br />
Qualche fenomeno instabile, soprattutto a livello potenziale, è stato in<strong>di</strong>viduato<br />
sempre nelle litologie sia basaltiche che calcaree, nella tipologia dello scivolamento per<br />
azione mista e congiunta <strong>di</strong> azioni gravitative e flui<strong>di</strong>ficanti, <strong>di</strong> elementi litoi<strong>di</strong> isolati<br />
lungo superfici, stratigrafiche o strutturali, me<strong>di</strong>amente inclinate ma fortemente<br />
pre<strong>di</strong>sponenti al movimento.<br />
Molto scarse sono tutte le altre tipologie <strong>di</strong> frana, con assenza totale <strong>di</strong> quelle<br />
rototraslative <strong>di</strong> grosse porzioni <strong>di</strong> versante o <strong>di</strong> quelle formate da creeping o da<br />
processi <strong>di</strong> lento movimento del suolo.<br />
Qualche modesta manifestazione è invece riconducibile all’azione <strong>di</strong> <strong>di</strong>lavamento<br />
laminare o concentrata delle acque meteoriche, che in alcune con<strong>di</strong>zioni possono<br />
generare colate <strong>di</strong> fango o <strong>di</strong> detriti, assimilabili peraltro più a manifestazioni <strong>di</strong> tipo<br />
idraulico, considerando che la componente liquida della massa instabile rappresenta<br />
quella preponderante.<br />
dott. ing. Sebastiano Bussalai<br />
dott. geol. Gianfranco Mulas Relazione <strong>di</strong> Compatibilità <strong>geologica</strong> e geotecnica pag.<br />
36
Lo stu<strong>di</strong>o geomorfologico ha <strong>di</strong>mostrato che, a <strong>di</strong>spetto della elevata superficie del<br />
territorio che ricade all’interno della classe <strong>di</strong> pericolosità molto alta Hg 4, il numero<br />
delle manifestazioni instabili risulta abbastanza contenuto ed è influenzato dall’azione<br />
antropica in maniera molto contenuta.<br />
La grande maggioranza dei fenomeni franosi o delle aree a stabilità critica, peraltro,<br />
ricadono o insistono su porzioni <strong>di</strong> territorio non popolate e contrad<strong>di</strong>stinte da una<br />
frequentazione umana occasionale o spora<strong>di</strong>ca e legata prevalentemente ad attività<br />
ricreazionale e non produttive.<br />
Solo in pochissimi casi le aree caratterizzate da un reale livello me<strong>di</strong>o alto <strong>di</strong><br />
pericolosità per frana sono localizzate in contesti urbani, più o meno densamente<br />
popolati o a frequentazione umana.<br />
Nell’abitato <strong>di</strong> <strong>Dorgali</strong> la sola <strong>di</strong> queste con<strong>di</strong>zioni è quella presente nella periferia<br />
orientale del paese, in via Santa Maria Maddalena, dove peraltro è in fase <strong>di</strong> sviluppo<br />
un progetto per il consolidamento e la messa in sicurezza <strong>di</strong> tutto il settore,<br />
analogamente a quanto accade per l’area destinata a parco urbano localizzata<br />
imme<strong>di</strong>atamente a monte della strada <strong>di</strong> circonvallazione alta.<br />
A Cala Gonone le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> instabilità potenziale sono più numerose, con quella più<br />
rilevante localizzata in località S’Ischina ‘e Su Rè, dove un piano <strong>di</strong> lottizzazione già<br />
esistente e parzialmente completato ricade in area Hg 3 come una porzione <strong>di</strong> una<br />
nuova zona D , la costa <strong>di</strong> S’Abba Durche in Hg 4 così come le spiagge e una parte del<br />
piazzale del porto.<br />
Di particolare interesse risultano anche le manifestazioni instabili ripetutamente già<br />
verificatesi, oltre a quelle potenzialmente verificabili lungo la strada che collega Cala<br />
Gonone con Cala Fuili.<br />
Alcune <strong>di</strong> queste criticità sono già state oggetto <strong>di</strong> interventi parziali <strong>di</strong><br />
consolidamento, mentre per altre si dovrà procedere in tale <strong>di</strong>rezione al fine <strong>di</strong> poter<br />
procedere alla realizzazione <strong>di</strong> quegli interventi non altrimenti de localizzabili.<br />
In alcuni casi, peraltro, la definizione della superficie dell’area <strong>di</strong> pericolosità appare<br />
essere non appieno supportata dalla stima oggettiva delle reali con<strong>di</strong>zioni generali dei<br />
dott. ing. Sebastiano Bussalai<br />
dott. geol. Gianfranco Mulas Relazione <strong>di</strong> Compatibilità <strong>geologica</strong> e geotecnica pag.<br />
37
luoghi, ma appare influenzata in maniera determinante da fattori <strong>di</strong> valutazione<br />
soggettiva.<br />
La perimetrazione proposta in questa fase in<strong>di</strong>vidua per le aree a pericolosità molto<br />
elevata <strong>di</strong> classe Hg4 una estensione <strong>di</strong> circa 20 kmq, mentre per la classe <strong>di</strong> livello<br />
elevato Hg3 è pari a 6.3 kmq, per la classe <strong>di</strong> livello me<strong>di</strong>o Hg2 6.4 kmq, per la classe <strong>di</strong><br />
livello moderato Hg2 è pari a 6.8 kmq, mentre la restante superficie non presenta<br />
alcun livello <strong>di</strong> pericolosità potenziale.<br />
A <strong>di</strong>spetto della notevole estensione delle aree a pericolosità molto elevata ed elevata,<br />
la loro particolare localizzazione fa si che le aree a rischio geologico elevato Rg3 e<br />
molto alto Rg4 abbiano un’estensione molto contenuta, <strong>di</strong> poco superiore ad un<br />
chilometro quadrato, e siano localizzate prevalentemente in zone a scarsa<br />
interferenza con la presenza umana stabile e continuativa, solo poche sono ricadenti<br />
all’interno dl perimetro urbano dei centri abitati <strong>di</strong> Cala Gonone e <strong>di</strong> <strong>Dorgali</strong>e, le più<br />
rilevanti sono rappresentate dal piazzale del porto, dalla via Cala Luna e dalle superfici<br />
limitrofe a queste dove sono localizzate zone B e zone G, già preesistenti o, in parte,<br />
<strong>di</strong> nuova programmazione.<br />
dott. ing. Sebastiano Bussalai<br />
dott. geol. Gianfranco Mulas Relazione <strong>di</strong> Compatibilità <strong>geologica</strong> e geotecnica pag.<br />
38
INTERAZIONI TRA IL PUC E IL PAI<br />
La fase iniziale del presente stu<strong>di</strong>o, come prima detto, è stata sviluppata con l’intento<br />
<strong>di</strong> stabilire quali effetti sull’ambiente in saranno realizzate, possano determinare le<br />
variazioni introdotte dal Piano Urbanistico Comunale <strong>di</strong> <strong>Dorgali</strong>.<br />
Queste interazioni possono essere in<strong>di</strong>viduate, fondamentalmente, in due tipologie<br />
principali: consumo <strong>di</strong> suolo utile ed esposizione ai fenomeni franosi ed<br />
idraulicamente pericolosi.<br />
L’espansione dell’area urbana in senso lato, comprendendo in questa anche le<br />
superfici destinate ad usi industriali ed artigianali, quali i Piani per gli Inse<strong>di</strong>amenti<br />
Produttivi, determina in maniera consequenziale automatica la per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> porzioni più<br />
o meno ampie <strong>di</strong> aree a destinazione originaria <strong>di</strong>fferente e, quasi sempre, ad uso<br />
agricolo generico.<br />
Gli in<strong>di</strong>rizzi del P.U.C. sono stati volti a determinare la minore occupazione delle<br />
superfici a maggiore vocazione agricola, localizzando gli sviluppi futuri, per quanto<br />
possibile, nelle imme<strong>di</strong>ate vicinanze dell’abitato dove le attività agricole risultano<br />
essere comunque <strong>di</strong> scarsa valenza e pressoché in abbandono, in<strong>di</strong>viduando,<br />
soprattutto per quanto attiene alle attività produttive, porzioni <strong>di</strong> territorio già più o<br />
meno parzialmente compromesse dal reale utilizzo attuale.<br />
Analogamente si è proceduto con la in<strong>di</strong>viduazione delle nuove aree a destinazione<br />
residenziale, in<strong>di</strong>viduate in settori che, per la destinazione d’uso specifica, dovevano<br />
essere quanto più prossimi all’abitato e non essere in conflitto con i vincoli dettati<br />
dalle Norme <strong>di</strong> Attuazione del P.A.I. e dalle altre norme e regolamenti vigenti.<br />
La programmazione urbanistica proposta, <strong>di</strong> fatto, presenta modeste situazioni <strong>di</strong><br />
conflittualità con le prescrizioni dettate dal Piano <strong>di</strong> Assetto Idrogeologico ma, nella<br />
quasi totalità dei casi, si tratta <strong>di</strong> situazioni preesistenti che, nel concreto, non<br />
determinano sensibili variazioni future e quelle possibili risultano sostanzialmente<br />
ammissibili.<br />
In questa casistica rientrano, nell’abitato <strong>di</strong> <strong>Dorgali</strong>, la zona G1-6, su cui insiste il<br />
macello comunale, e la zona G3-2 in cui sorge l’impianto <strong>di</strong> depurazione fognaria,<br />
dott. ing. Sebastiano Bussalai<br />
dott. geol. Gianfranco Mulas Relazione <strong>di</strong> Compatibilità <strong>geologica</strong> e geotecnica pag.<br />
39
icadenti in aree a pericolosità elevata <strong>di</strong> classe Hg3, rispettivamente per ratei del 90%<br />
e del 30%.<br />
In tutti gli altri casi le in<strong>compatibilità</strong> sono rappresentate da interferenze con aree a<br />
pericolosità me<strong>di</strong>a, <strong>di</strong> livello Hg2, e si tratta <strong>di</strong> zone destinate a servizi pubblici già<br />
esistenti, quali i caseggiati scolastici della zona S1 a monte <strong>di</strong> viale Kennedy ed della<br />
zona S2 sulla via Don Meloni, la biblioteca e le se<strong>di</strong> comunali in zona S2 lungo il corso<br />
Umberto etc., o ancora da realizzare quali i parcheggi posti a valle <strong>di</strong> viale Kennedy in<br />
zona G4-1, o <strong>di</strong> zone <strong>di</strong> rispetto quali la H2-4 a monte della via Enrico Fermi, la<br />
circonvallazione alta.<br />
Per quanto attiene alle aree a destinazione residenziale si riscontra la presenza <strong>di</strong><br />
buona parte della porzione meri<strong>di</strong>onale dell’abitato all’interno della classe Hg2, ma si<br />
tratta per lo più <strong>di</strong> zone A del centro storico, zone B <strong>di</strong> completamento con lotti<br />
interclusi, e zone B facenti capo a Piani <strong>di</strong> risanamento e localizzate in aree marginali<br />
e <strong>di</strong> frangia a valle delle quali non è consentita l’e<strong>di</strong>ficazione.<br />
Caso a parte sono rappresenta la zona C3 posta a nord del campo sportivo lungo viale<br />
Kennedy, che ricade in parte in area Hg1, per circa il 60% e in area Hg2 per circa il 40%.<br />
Stante l’inquadramento attuale gli interventi potranno essere consentiti<br />
esclusivamente nella porzione inclusa nella classe inferiore, destinando quella parte<br />
compresa nella classe maggiore alle cessioni ed alla realizzazione <strong>di</strong> volumi non e<strong>di</strong>lizi,<br />
quali autorimesse o parcheggi.<br />
Maggiori interferenze risultano esservi, invece, nel caso dell’abitato <strong>di</strong> Cala Gonone,<br />
che è interessato da una vincolistica legata al PAI <strong>di</strong> maggiore gravità.<br />
In particolare una porzione dell’abitato lungo viale Colombo, una parte del piazzale del<br />
porto, oltre la metà della zonaD2-1-1 su cui si sviluppa l’impianto <strong>di</strong> depurazione<br />
fognaria, e una zona <strong>di</strong> servizi già infrastrutturata lungo la via Cala Luna, oltre che la<br />
stessa via Cala Luna ed una modesta porzione della zona D2-1-4, ricadono in area Hg4.<br />
E’ evidente che su queste superfici, stanti l’attuale classificazione attribuita dal P.A.I.,<br />
sussistono gravi limitazioni d’utilizzo che ne precludono, in toto per alcune ed in parte<br />
per altre, lo sviluppo.<br />
dott. ing. Sebastiano Bussalai<br />
dott. geol. Gianfranco Mulas Relazione <strong>di</strong> Compatibilità <strong>geologica</strong> e geotecnica pag.<br />
40
La stessa zona D2-1-4 è inclusa, per una quota notevole della sua superficie, nella<br />
classe <strong>di</strong> rischio Hg3, il che ne limita ulteriormente le potenzialità, relegando la<br />
possibilità <strong>di</strong> intervento a solo in 50% circa della sua estensione complessiva, che<br />
ricade in classe Hg1.<br />
Analoga considerazione deve essere estesa alla zona B2, quella che delimita il piano <strong>di</strong><br />
lottizzazione <strong>di</strong> S’Ischina ‘e su Rè, in cui una buona parte dei lotti ancora non e<strong>di</strong>ficati<br />
ricadono in zona Hg3, i cui vicoli impe<strong>di</strong>scono la realizzazione <strong>di</strong> volumi e<strong>di</strong>lizi.<br />
Maggiore è invece la percentuale <strong>di</strong> superficie della stessa zona B2 che inclusa nella<br />
classe Hg2, nella quale l’e<strong>di</strong>ficazione è subor<strong>di</strong>nata a particolari con<strong>di</strong>zioni prescritte<br />
dalle stesse norme <strong>di</strong> attuazione del P.A.I. e che comunque ne limitano notevolmente<br />
la possibilità <strong>di</strong> uso specifico.<br />
Minore peso gravame insiste sulla zona G1-4 <strong>di</strong> Gustui, dove solo una fascia marginale<br />
ricade snelle classe Hg3, peraltro localizzata su una superficie caratterizzata da una<br />
pendenza che ne rende poco conveniente lo sfruttamento specifico.<br />
Molto più importante dal punto <strong>di</strong> vista vincolistico, risulta essere l’inserimento delle<br />
spiagge <strong>di</strong> Palmasera, <strong>di</strong> Sos Dorroles e <strong>di</strong> S’Abba Meica, all’interno della classe <strong>di</strong><br />
pericolosità a valore massimo Hg4 che <strong>di</strong> fatto, pur non precludendone la fruizione,<br />
non consente la realizzazione neanche <strong>di</strong> strutture temporanee, provvisorie e<br />
stagionali.<br />
In merito alla delimitazione attualmente in vigore si significa che alcune perimetrazioni<br />
appaiono non essere perfettamente in accordo con i criteri definiti dalla Linee Guida<br />
da utilizzare per il calcolo della pericolosità <strong>geologica</strong> per frana.<br />
Si ritiene che lo stu<strong>di</strong>o della variante al P.A.I. che farà seguito alla presente fase, potrà<br />
consentire una perimetrazione più precisa e dettagliata, sicuramente basata su una<br />
scala <strong>di</strong> lettura a maggiore dettaglio, per cui alcune delle ripartizioni potranno subire<br />
un parziale declassamento, mentre per altre aree appare evidente che l’attuale<br />
delimitazione risponde alla reale caratterizzazione dei luoghi.<br />
Una eventuale riclassificazione <strong>di</strong> queste ultime superfici, tenendo conto<br />
dell’impossibilità <strong>di</strong> delocalizzazione degli interventi previsti, potrà aver luogo solo a<br />
seguito della realizzazione <strong>di</strong> idonee opere <strong>di</strong> mitigazione e <strong>di</strong> compensazione del<br />
dott. ing. Sebastiano Bussalai<br />
dott. geol. Gianfranco Mulas Relazione <strong>di</strong> Compatibilità <strong>geologica</strong> e geotecnica pag.<br />
41
ischio, solo successivamente alla cui esecuzione potrà valutarsi la ipotesi <strong>di</strong> un<br />
eventuale declassamento.<br />
Allo stato attuale, stante la perimetrazione vigente, la definizione delle zone<br />
urbanistiche comporta che alcuni degli interventi potenziali localizzabili al loro interno<br />
dovranno considerarsi sospesi e <strong>di</strong>rettamente sottoposti alla normativa definita dalle<br />
Norme <strong>di</strong> Attuazione del Piano <strong>di</strong> Assetto Idrogeologico della Sardegna.<br />
dott. ing. Sebastiano Bussalai<br />
dott. geol. Gianfranco Mulas Relazione <strong>di</strong> Compatibilità <strong>geologica</strong> e geotecnica pag.<br />
42
INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO<br />
In questa fase <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o e <strong>di</strong> pianificazione territoriale non è contemplata la realizzazione <strong>di</strong><br />
alcun intervento <strong>di</strong> compensazione e <strong>di</strong> mitigazione del rischio geologico per frana, per cui<br />
questo aspetto viene considerato solo in modo estremamente superficiale.<br />
Tuttavia, essendo state riscontrate alcune forme <strong>di</strong> in<strong>compatibilità</strong> tra le previsioni del P.U.C. e<br />
la perimetrazione delle aree a pericolosità <strong>geologica</strong> per frana rispetto alle prescrizioni<br />
riportate nelle Norme <strong>di</strong> Attuazione del Piano <strong>di</strong> Assetto idrogeologico della Sardegna, prima<br />
che gli interventi programmati all’interno delle aree risultate essere critiche siano posti in<br />
essere, si dovrà procedere alla realizzazione <strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> interventi che determinino la<br />
<strong>di</strong>minuzione del rischio geologico.<br />
Questi, da un primo esame, risultano nella maggior parte dei casi realizzabili con opere <strong>di</strong><br />
salvaguar<strong>di</strong>a idraulica e <strong>di</strong> consolidamento dei versanti <strong>di</strong> modestissima entità e, solo in poche<br />
situazioni si renderanno necessarie opere <strong>di</strong> maggiore rilevanza, la cui in<strong>di</strong>viduazione puntuale<br />
e <strong>di</strong>mensionamento esecutivo potranno essere oggetto <strong>di</strong> specifiche fasi <strong>di</strong> progettazione.<br />
dott. ing. Sebastiano Bussalai<br />
dott. geol. Gianfranco Mulas Relazione <strong>di</strong> Compatibilità <strong>geologica</strong> e geotecnica pag.<br />
43