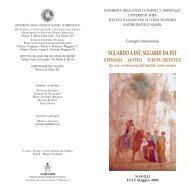I. A. Richards: teoria e pratica della Glottodidattica - L'Orientale
I. A. Richards: teoria e pratica della Glottodidattica - L'Orientale
I. A. Richards: teoria e pratica della Glottodidattica - L'Orientale
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ALESSANDRA OLEVANO<br />
I. A. RICHARDS: TEORIA E PRATICA DELLA GLOTTODIDATTICA<br />
Dei molti scritti di Ivor Armstrong <strong>Richards</strong> (1893–1979) che<br />
rivestono un interesse glottodidattico, pochi sono usciti in traduzione<br />
italiana, e si può dire in generale che questo aspetto <strong>della</strong> sua<br />
produzione scientifica non abbia ricevuto nel nostro paese sufficiente<br />
attenzione. Cercherò in quel che segue di mostrare alcuni aspetti di<br />
originalità e contemporaneità delle sue proposte, soprattutto del<br />
progetto di Basic English. Autore, com'è noto, insieme a Charles Kay<br />
Ogden, di The Meaning of Meaning (1923), opera fondamentale per gli<br />
studi di semantica e di linguistica, tradotta in italiano soltanto nel<br />
1966, <strong>Richards</strong> fu una figura fondamentale per il rinnovamento<br />
dell’insegnamento <strong>della</strong> letteratura inglese a Cambridge dagli anni<br />
'20; ma agli studi di critica letteraria si affiancò quasi naturalmente la<br />
riflessione sulla lingua, il linguaggio e l’intepretazione. Uno dei<br />
motivi d'interesse dell’opera di <strong>Richards</strong> è certamente la circolarità,<br />
costante nel suo pensiero, fra <strong>teoria</strong> e prassi, così come<br />
l’interdisciplinarità, essendo la sua ricerca situata all'incrocio di<br />
linguistica generale, scienza <strong>della</strong> comunicazione, psicopedagogia e<br />
filosofia del linguaggio. La didattica delle lingue, inserita in questo<br />
complesso quadro teorico, è intimamente legata al tema<br />
dell’interpretazione e <strong>della</strong> definizione del significato.<br />
All’insegnamento, svolto in Cina a due riprese, tra la fine degli<br />
anni '20 e il decennio successivo e poi, dal 1939, presso l'Università di<br />
Harvard, si affiancarono altre attività ed incarichi: i quaranta anni<br />
dedicati alla diffusione del Basic English; la lunga attività di direttore<br />
del Committee of Communication a Harvard; i molti progetti per<br />
l’alfabetizzazione e l’insegnamento dell’inglese agli immigrati, ai<br />
rifugiati politici, agli stranieri e analfabeti; l’organizzazione di corsi<br />
linguistici, radiofonici prima, e poi audio-visivi. Frutto di questa<br />
lunga operosità furono fra l'altro i volumi per l’autoapprendimento di<br />
A. Olevano, "I. A. <strong>Richards</strong>: <strong>teoria</strong> e <strong>pratica</strong> <strong>della</strong> <strong>Glottodidattica</strong>", LZ 1/2010, pp. 47-64
48<br />
Alessandra Olevano<br />
lingue straniere noti come Picture Series, che vanno dal francese allo<br />
spagnolo, al tedesco, all’ebraico, all’italiano, all’inglese, al russo,<br />
all’arabo; i vari Workbooks relativi all’insegnamento per immagini; la<br />
redazione di rapporti per enti e istituzioni governativi e internazionali<br />
sull’insegnamento, l’istruzione e l’alfabetizzazione; e i volumi e i<br />
saggi in cui pubblicò la sua riflessione teorica su tutti questi<br />
argomenti.<br />
1. L'esordio di <strong>Richards</strong> in questi settori di ricerca coincise con un<br />
periodo di grande fermento ideologico e politico, avviato in Gran<br />
Bretagna già dalla seconda metà dell’Ottocento, quando erano nati gli<br />
English Studies, che costituirono un nuovo modello educativo e<br />
lanciarono un’importante sfida al prestigio intellettuale e culturale a<br />
lungo riservati ai classici (Doyle 1989: 20). Soltanto nel 1904 le School<br />
Regulations raggrupparono, sotto la voce “English”, lo studio <strong>della</strong><br />
lingua, <strong>della</strong> letteratura, <strong>della</strong> geografia e <strong>della</strong> storia del paese: la<br />
nuova disciplina concorreva così certamente all’affermazione<br />
dell’identità nazionale. Nel 1907 la nascita <strong>della</strong> English Association<br />
ribadiva l’importanza degli English Studies per la formazione<br />
umanistica, in competizione con la formazione classica, fondata sul<br />
latino e sul greco. Nel 1917 venne introdotto a Cambridge l’English<br />
Tripos, un corso di laurea grazie al quale la materia denominata<br />
appunto English assumeva uno statuto autonomo, con due corsi<br />
distinti, uno per la parte medioevale e uno per il moderno, e veniva<br />
riconosciuta una tradizione di studi specifica per la lingua inglese e la<br />
sua letteratura (Tillyard 1958: 55). <strong>Richards</strong> apportò negli anni un<br />
contributo importante ed originale alla realizzazione di questo<br />
progetto.<br />
L’English, letteratura e lingua, divenne quindi uno strumento<br />
pedagogico fondamentale, e dagli anni ’30 le Università intrapresero<br />
un mirato progetto d’insegnamento <strong>della</strong> lingua e <strong>della</strong> letteratura<br />
nazionale, che fu certamente una risposta alle minacce di guerra <strong>della</strong><br />
Russia e <strong>della</strong> Germania, e anche più in generale un progetto volto a<br />
incoraggiare lo spirito critico: “grazie al metodo critico, lo studente<br />
A. Olevano, "I. A. <strong>Richards</strong>: <strong>teoria</strong> e <strong>pratica</strong> <strong>della</strong> <strong>Glottodidattica</strong>", LZ 1/2010, pp. 47-64
I. A. <strong>Richards</strong>: <strong>teoria</strong> e <strong>pratica</strong> <strong>della</strong> <strong>Glottodidattica</strong><br />
avrebbe imparato, si sperava, a respingere le lusinghe dei media”<br />
(Mathieson 1975: 123). Si apriva una vera diatriba sulla scelta fra i testi<br />
classici <strong>della</strong> letteratura inglese e la produzione contemporanea: un<br />
problema che investiva la stessa metodologia di studio. <strong>Richards</strong>,<br />
rinnovando questa metodologia, riuscì negli anni a ricreare l’interesse<br />
per la letteratura inglese classica, valorizzando nel contempo i nuovi<br />
mezzi di comunicazione e incrementandone la funzione divulgativa.<br />
A livello specificamente linguistico prestò grande attenzione al<br />
rinnovamento in corso <strong>della</strong> comunicazione veloce e alla nuova<br />
relazione fra immagine e parola che s’imponevano nei media.<br />
A causa delle precarie condizioni di salute <strong>Richards</strong> non partecipò<br />
alla prima guerra mondiale e nel ’18 torno a Cambridge, dove aveva<br />
studiato, dedicandosi dapprima agli studi filosofici e poi dal ‘19<br />
tenendo corsi sul romanzo contemporaneo nell'ambito degli English<br />
Tripos. Un primo frutto di questa attività didattica furono i Principles<br />
of Literary Criticism del 1924, seguiti nel 1925 da un corso di Pratical<br />
Criticism che sarebbe stato pubblicato nel ’29, un'opera, scrive Russo<br />
(1989: 89) “che richiese gran parte del suo miglior pensiero”. In questi<br />
studi <strong>Richards</strong> avviava un nuovo metodo d’insegnamento dei testi<br />
letterari: inserendosi nell’ampio dibattito in corso, avvalorava sin<br />
d’allora la possibilità di una lettura scientifica, basata non sulle mere<br />
impressioni del lettore, ma capace di dar conto del pensiero<br />
dell’autore e del suo contesto. Soprattutto nasceva l’esigenza di una<br />
sperimentazione tecnica <strong>della</strong> lettura <strong>della</strong> poesia che potesse essere<br />
d’ausilio all’intepretazione del senso. Già nella prima opera, The<br />
Meaning of Meaning (1923), <strong>Richards</strong> aveva approfondito il tema<br />
dell’interpretazione del testo poetico, legandola al problema<br />
dell’ambiguità del significato e dell’importanza del contesto; lo studio<br />
<strong>della</strong> letteratura per <strong>Richards</strong> portava naturalmente a quello <strong>della</strong><br />
lingua e delle sue funzioni. A Cambridge si era intanto realizzata<br />
“una massiccia importazione, negli studi accademici di inglese, di<br />
teorie e metodi variamente associati con lo strutturalismo, la<br />
linguistica, la semiotica, la sociologia, il marxismo, e i poststrutturalismo”<br />
(Doyle 1989: 123). Analizzando le possibilità<br />
A. Olevano, "I. A. <strong>Richards</strong>: <strong>teoria</strong> e <strong>pratica</strong> <strong>della</strong> <strong>Glottodidattica</strong>", LZ 1/2010, pp. 47-64<br />
49
50<br />
Alessandra Olevano<br />
referenziali e simboliche <strong>della</strong> lingua quale sistema di comunicazione,<br />
<strong>Richards</strong> attraversava tutte questi approcci, apportandovi un<br />
contributo originale. Il significato e il contesto costituirono sin<br />
dall’inizio una prospettiva di analisi per la lingua, come per la<br />
letteratura: “Lo studio <strong>della</strong> letteratura diventava un esercizio<br />
cooperativo: non più questione di fonologia oppure di storia nella<br />
vecchia accezione.” (Brower Reuben 1973: 63).<br />
Il cuore del problema era l’“esplosione semantica” del testo, che<br />
motivava la ricerca di un metodo per una corretta intepretazione, e<br />
che avrebbe condizionato anche il metodo dell'insegnamento<br />
linguistico. Essa appariva determinata dalle parole non nella loro<br />
singolarità, ma nel loro contesto sintagmatico: “Solo nel momento in<br />
cui un ente pensante ne fa uso, che esse si riferiscono a qualcosa…”<br />
(<strong>Richards</strong> 1923: 12-13). Interpretare un testo poetico significava per<br />
<strong>Richards</strong> compiere un percorso attraverso i singoli sintagmi,<br />
enucleando le singole formazioni; e la stessa musicalità del testo<br />
sembrava partecipare a tale valore contestuale.<br />
La lingua già nella prima opera si connotava capace di più<br />
funzioni, una simbolico-referenziale e l’altra emotiva; con le sue<br />
enormi potenzialità comunicative sembrava permettere qualsiasi<br />
predicazione del mondo ed evocazione di senso. In appendice a The<br />
Meaning of Meaning (1923), <strong>Richards</strong> aggiungeva un articolo “The<br />
future of Grammar”, già apparso sul Cambridge Magazine nel 1924,<br />
dove indicava il ruolo fondamentale <strong>della</strong> grammatica per l’analisi<br />
<strong>della</strong> struttura testuale e <strong>della</strong> stessa “esplosione di significato”.<br />
L’analisi dell’architettura grammaticale del testo sembrava costituire<br />
una strada importante per la ricostruzione ed interpretazione del<br />
senso.<br />
Anche lo studio <strong>della</strong> metafora, centrale nel pensiero richardsiano,<br />
rientrava in questa prospettiva semantica: la lingua, attraverso la<br />
metafora, è capace di ulteriori predicazioni ed evocazioni di senso,<br />
operando accostamenti di diverse dimensioni del reale. In Practical<br />
Criticism <strong>Richards</strong> distingueva una “sense metaphor” e una “emotive<br />
metaphor”, dove la “sense metaphor” si realizza “quando lo<br />
A. Olevano, "I. A. <strong>Richards</strong>: <strong>teoria</strong> e <strong>pratica</strong> <strong>della</strong> <strong>Glottodidattica</strong>", LZ 1/2010, pp. 47-64
I. A. <strong>Richards</strong>: <strong>teoria</strong> e <strong>pratica</strong> <strong>della</strong> <strong>Glottodidattica</strong><br />
slittamento verbale si verifica grazie a una qualche somiglianza fra<br />
due oggetti” (Russo 1989: 255); la “emotive metaphor” quando “lo<br />
slittamento è prodotto da una qualche somiglianza di sentimento e di<br />
tono” (Russo 1989: 255), con un effetto di evocazione. In Mencius on<br />
the Mind (1932) <strong>Richards</strong> parlava di methaphorical reduction: la metafora<br />
è allora “assunta come sostituto di una espressione non-metaforica”<br />
(Russo 1989: 255). La metafora si andava via via configurando per<br />
<strong>Richards</strong> come un accostamento fra contesti, un passaggio da un<br />
contesto ad un altro.<br />
Sempre più appariva fondamentale, per <strong>Richards</strong>, da una parte,<br />
tracciare attraverso il testo scritto percorsi capaci di farne risultare il<br />
senso profondo; dall’altra, osservare la lingua nella sua produzione<br />
contingente, come mezzo leggero e veloce di comunicazione. Così,<br />
negli anni d’insegnamento di letteratura e <strong>teoria</strong> letteraria, <strong>Richards</strong><br />
metteva a fuoco diverse tecniche di lettura del testo, mirate ad<br />
appianare le difficoltà <strong>della</strong> fruizione dell’opera, e elaborava via via<br />
una <strong>teoria</strong> <strong>della</strong> comunicazione mirata ad avvicinare i giovani alla<br />
letteratura. In Interpretation in Teaching (1936) proponeva la sua <strong>teoria</strong><br />
del close reading, una lettura attenta capace di dar conto di diverse<br />
sfumature del testo. Dalla testimonianza di un suo studente dei primi<br />
anni ’30 capiamo l’impegno profuso da <strong>Richards</strong> nell’interpretazione<br />
dei testi: “Scrivevo un saggio a settimana, sempre impegnativo, e la<br />
successiva discussione con <strong>Richards</strong> non richiedeva minor impegno.<br />
Dovevo riflettere su ogni mia affermazione e giustificarla: Era un<br />
enorme divertimento.” (Russo 1989: 94).<br />
Impegnato a seguire i processi di comprensione degli studenti,<br />
<strong>Richards</strong> osteggiava la loro tendenza a cercare nei testi un “contenuto<br />
intellettuale” che secondo lui nuoceva alla fruizione dell’opera d’arte,<br />
ostacolando la fruizione <strong>della</strong> poesia e “impedendoci pertanto di<br />
acquisire nuovi punti di vista sull'io” (<strong>Richards</strong> 1929: 157). La lettura<br />
poetica, l'interpretazione, si configurava come un viaggio esistenziale;<br />
perché la poesia per <strong>Richards</strong> “trascende la divisione tra pensiero e<br />
sentimento e offre modelli di armoniosa integrazione” (<strong>Richards</strong> 1929:<br />
156).<br />
A. Olevano, "I. A. <strong>Richards</strong>: <strong>teoria</strong> e <strong>pratica</strong> <strong>della</strong> <strong>Glottodidattica</strong>", LZ 1/2010, pp. 47-64<br />
51
52<br />
Alessandra Olevano<br />
La tecnica di close reading si era delineata progressivamente<br />
attraverso gli anni d’insegnamento e man mano l’uso <strong>della</strong> voce e<br />
delle immagini assunse un ruolo fondamentale. <strong>Richards</strong> proponeva<br />
agli studenti una lettura registrata in uno “stile neutro”; suggeriva di<br />
leggere con ritmo lento e studiare prima a lungo il testo. Scriveva. in<br />
Pratical Criticism: “Una lettura privata molto lunga ha più probabilità<br />
di produrre la necessaria integrazione tra forma e significato di<br />
quante non ne abbia un numero quanto si voglia elevato di scorse<br />
rapide” (<strong>Richards</strong> 1929: 234). Si trattava di una fruizione guidata del<br />
testo, capace di dar conto di tutto il potere evocativo dell’opera d’arte.<br />
“Il metodo di <strong>Richards</strong>, analizzando il senso del poeta, le sue<br />
immagini e metafore, il ritmo, il tono, la forma, l'intenzione,<br />
l'atteggiamento e l'ironia, era pienamente preparato trattare la<br />
compressione, l'abiguità, l'auto-refenzialità, l'oscurità e allusività”<br />
(Russo 1989: 83).<br />
Le tecniche di lettura intese a guidare il processo<br />
d’interpretazione confluivano come bagaglio fondamentale<br />
nell’approccio alle lingue. Lo studio del contesto e quindi la<br />
definizione del significato delle singole parole attraverso il sintagma,<br />
divennero delle chiavi importanti per entrare nei mondi delle diverse<br />
lingue. Abbiamo visto come questa <strong>teoria</strong> dell’interpretazione avesse<br />
una matrice semantica. Aveva trovato un'ampia trattazione già in<br />
Meaning of Meaning, dove peraltro, come abbiamo accennato, veniva<br />
specificata l’importanza <strong>della</strong> struttura grammaticale nella<br />
costruzione del senso. L’interpretazione del testo poetico e la<br />
glottodidattica si configurano come una conseguente e naturale<br />
applicazione <strong>della</strong> <strong>teoria</strong> sulle capacità simbolico-referenziale ed<br />
emotiva <strong>della</strong> lingua.<br />
Alla predicazione del mondo contribuiscono distintamente tanto la<br />
grammatica quanto l’immagine, costruzioni di pensiero diverse e del<br />
pari essenziali. In Principles of Literary Criticism (1924) <strong>Richards</strong><br />
distingue tre tipologie di immagini: l’immagine tipografica, legata alla<br />
sensazione visiva <strong>della</strong> parola stampata, l’immagine uditiva, legata al<br />
suono o all’articolazione <strong>della</strong> parola, e l' immagine mentale, legata alla<br />
A. Olevano, "I. A. <strong>Richards</strong>: <strong>teoria</strong> e <strong>pratica</strong> <strong>della</strong> <strong>Glottodidattica</strong>", LZ 1/2010, pp. 47-64
I. A. <strong>Richards</strong>: <strong>teoria</strong> e <strong>pratica</strong> <strong>della</strong> <strong>Glottodidattica</strong><br />
parola. Scriveva ancora nel ’29: “Se il test <strong>della</strong> raffigurazione mentale<br />
prodotta nella mente del lettore dalle parole del poeta è<br />
effettivamente un test, allora la poesia è buona” (<strong>Richards</strong> 1929: 132).<br />
Certo, tanto l’associazione d’immagini al testo poetico, quanto<br />
l’associazione d'un ritmo ossessivo o d'un tono sbagliato, possono dar<br />
luogo a una errata interpretazione. Tuttavia l’immagine, come il tono<br />
e il ritmo, sembravano a <strong>Richards</strong> costituire parti importanti del<br />
processo interpretativo.<br />
A partire da questa grande attenzione per il giusto uso delle<br />
immagini e del tono, <strong>Richards</strong> non solo andò via via elaborando delle<br />
tecniche di lettura dei testi, ma teorizzò anche l’ausilio degli<br />
audiovisivi, manifestando grande fiducia nei nuovi media come<br />
strumento per lo studio <strong>della</strong> letteratura e delle lingue: “Molti di essi<br />
possono contare su quel reciproco controllo di orecchio e occhio che è<br />
la fonte <strong>della</strong> capacità di scrivere. Là sullo schermo stanno, stabili e<br />
chiare, le frasi mentre la voce del lettore azzarda i diversi modi di<br />
dirle” (Engel 1973: 208).<br />
Voce e immagine, con il loro grande potere evocativo, potevano<br />
costituire un grande ausilio sia per la fruizione <strong>della</strong> letteratura, sia – e<br />
ancora di più, proprio per tutte le associazioni mentali ad esse legate<br />
– per l’apprendimento linguistico. Sull’associazione fra immagini e<br />
parole sembravano poter viaggiare molti significati; la loro relazione<br />
sembrava contribuire alla comunicazione immediata, come al<br />
percorso interpretativo di un testo poetico.<br />
2. L’anno che segna ufficialmente l’inizio dell’interesse di <strong>Richards</strong><br />
per l’insegnamento dell’inglese è il 1927, quando pubblica sul New<br />
Statesman un articolo intitolato “The teaching of English”, dove<br />
sottolineava l'importanza e le difficoltà dell' insegnamento linguistico<br />
(Russo 1973: 329). Nel 1933 in un altro articolo, “Our lost Readers”, sul<br />
Saturday Review of Literature, esprimeva la sua avversione per lo stile<br />
dogmatico dell’insegnamento accademico e sottolineava l'importanza<br />
di altri fattori: la buona cultura di base dell’insegnante, l'aderenza alla<br />
realtà e lo scambio con le altre discipline (Russo 1973: 335). Lo studio<br />
A. Olevano, "I. A. <strong>Richards</strong>: <strong>teoria</strong> e <strong>pratica</strong> <strong>della</strong> <strong>Glottodidattica</strong>", LZ 1/2010, pp. 47-64<br />
53
54<br />
Alessandra Olevano<br />
dell’insegnamento linguistico doveva quindi non solto procedere di<br />
pari passo con quello <strong>della</strong> letteratura, secondo lo specifico<br />
programma degli English Studies, ma allargarsi all’interezza <strong>della</strong> vita,<br />
nella certezza che la lingua sia capace di adattarsi alle diverse<br />
contestualità. In un intervista rilasciata, quasi alla fine del suo<br />
percorso, a J. Russo e a B. A. Boucher, <strong>Richards</strong> affermava<br />
l’importanza dello lo studio dell’inglese per un percorso esistenziale,<br />
un viaggio capace di farci conoscere nuovi valori culturali, filosofici,<br />
una nuova visione del mondo. In particolare la diffusione dell’inglese<br />
poteva contribuire all’effettiva crescita culturale dell’uomo per tutti<br />
quei paesi isolati dalla cultura occidentale (Russo 1977: 268-269).<br />
L'interesse per la glottodidattica fu ispirato in <strong>Richards</strong> non<br />
soltanto dall’interesse nazionale per gli English Studies, ma anche<br />
dall’attività all’estero. Nel ’27 si era recato in Giappone, poi a<br />
Pechino, dove si dedicò ad esperimenti di lettura poetica (Russo 1989:<br />
89), poi di nuovo nel ’29 a Pechino e quindi nel ’31 negli Stati Uniti, a<br />
Harvard, dove tenne ancora corsi sul Pratical Criticism e sulla<br />
Contemporary English Literature. Qui ebbe modo di avvicinarsi al<br />
progetto di Basic English, iniziato da Ogden nel 1928 con la<br />
costruzione di una lingua semplificata di 850 parole, funzionale ad<br />
una comunicazione immediata. Il progetto appassionò <strong>Richards</strong>, che<br />
nel 1933 partecipò insieme a Ogden a un convegno a New York su<br />
questa tematica: era nato il Basic Movement che avrebbe avuto una<br />
diffusione enorme. <strong>Richards</strong> lo espose davanti alla Aristolelian Society<br />
nel 1933 e alla English Association di Londra nel 1934 (Russo 1989:<br />
89). Nello stesso anno il General Education Board di New York non solo<br />
lo consultò sul tema dell' “insegnamento dell'interpretazione”, ma lo<br />
incaricò di redigere un “Pratical Criticism about Prose” (Russo 1989:<br />
412).<br />
Il Basic Movement trovò in <strong>Richards</strong> un paladino importante. Nel<br />
1936 si recò di nuovo in Cina con lo scopo di avviare lì il Movimento e<br />
nello stesso anno tenne un corso estivo sull'insegnamento dell'inglese<br />
a Shih Fan Hsuch, presso un istituto per la preparazione di insegnanti<br />
di scuola superiore <strong>della</strong> Cina settentrionale (Russo 1989: 412);<br />
A. Olevano, "I. A. <strong>Richards</strong>: <strong>teoria</strong> e <strong>pratica</strong> <strong>della</strong> <strong>Glottodidattica</strong>", LZ 1/2010, pp. 47-64
I. A. <strong>Richards</strong>: <strong>teoria</strong> e <strong>pratica</strong> <strong>della</strong> <strong>Glottodidattica</strong><br />
sembrava infatti importante agganciare culturalmente il mondo<br />
orientale. Tornò di nuovo in Cina nel 1937 collaborando con il locale<br />
Ministero dell’educazione per l'introduzione dell'insegnamento<br />
dell’inglese nelle scuole secondarie. Il Ministero approvò il<br />
programma di insegnamento del Basic nelle scuole medie (Russo<br />
1989: 366); ma il Giappone invase la Cina, così solo nell’anno<br />
successivo, nel ’38, <strong>Richards</strong> riprese il suo progetto, questa volta in<br />
Canada dove “ cominciò a pensare di sperimentare il basic in progetti<br />
di ampia portata, possibilmente di dimensione nazionale, forse anche<br />
negli Stati Uniti” (Russo 1989: 430). Ben presto peraltro rientrò a<br />
Cambridge dove continuò a insegnare Pratical Criticism, fin quando<br />
nel 1939 gli venne proposto dalla Harvard University un ricchissimo<br />
finanziamento per una ricerca “nell'ambito <strong>della</strong> critica e dell'uso del<br />
linguaggio” e il coordinamento di molti progetti di Basic English nelle<br />
Americhe (Russo 1989: 431). Furono anni fondamentali per gli studi di<br />
glottodidattica. Tutte le idee di <strong>Richards</strong> sulle tecniche di analisi<br />
trovarono una nuova formulazione; il Basic English venne rielaborato e<br />
l’uso <strong>della</strong> voce e dell’immagine, già adottati nel caso del romanzo,<br />
trovarono una canonizzazione anche nell' insegnamento linguistico.<br />
All’inizio degli anni ’40 nacquero due commissioni importanti:<br />
l’Orthological Committee, che si occupava dell’insegnamento<br />
dell’inglese come lingua straniera, e il Committee on Communication<br />
(poi English Language Research nel 1946, e Language Research, Inc. nel<br />
1950). <strong>Richards</strong> vi ebbe un ruolo fondamentale, focalizzando la sua<br />
attenzione soprattutto sulla glottodidattica per stranieri. Nel 1943 era<br />
divenuto poi membro del General Harvard Commitee in a Free Society<br />
che aveva come obbiettivo di: “di rivedere i criteri del curriculum di<br />
base di Harvard e, più in generale, di esaminare il curriculum<br />
educativo delle scuole secondarie e dei college d'America e fare<br />
proposte” (Russo 1989: 486).<br />
Furono anni di grande sperimentazione. Tuttavia bisogna<br />
specificare che molte attività dei trentacinque anni successivi alla<br />
guerra possono essere ricondotti a due progetti completati nei primi<br />
cinque anni: il libro di base con figure e didascalie e una serie di film:<br />
A. Olevano, "I. A. <strong>Richards</strong>: <strong>teoria</strong> e <strong>pratica</strong> <strong>della</strong> <strong>Glottodidattica</strong>", LZ 1/2010, pp. 47-64<br />
55
56<br />
Alessandra Olevano<br />
è quanto afferma Russo (1989: 438). Dal primo progetto scaturirono<br />
The Pocket Book of Basic English e quindi English Self-taught through<br />
Pictures (1949), pubblicato con il titolo definitivo English through<br />
Pictures nel 1952. La seconda parte del progetto riguardava invece i<br />
“March of Time Studio Films of Basic Lessons” (Russo 1989: 438).<br />
<strong>Richards</strong> si applicò anche allo studio dei cartoons <strong>della</strong> Walt Disney’s<br />
Studio. Era, come dichiarò, “un modo di studiare i significati che si<br />
rivelava inaspettatamente rivelatore. Mi suscitò quella che poteva<br />
essere un'idea chiave: che la molteplicità di canali era la più grande<br />
delle nostre speranze” (Russo 1989: 436). L’interesse per l’uso degli<br />
audiovisivi crebbe nel tempo.<br />
<strong>Richards</strong> ebbe un’influenza enorme sul Language Research Inc., con<br />
il suo contributo allo studio delle tecniche e modalità<br />
dell’insegnamento linguistico, fondato sui classici <strong>della</strong> letteratura e<br />
inteso alla conoscenza e all' uso facile <strong>della</strong> lingua:<br />
“… era <strong>Richards</strong> naturalmente a raccomandare ‘uno studio intensivo e attento<br />
di buoni brani e poesie’ e l'analisi ‘di ciò che una parola fa in un certo punto<br />
<strong>della</strong> pagina – in aggiunta al suo senso dizionariale’; a enumerare ‘i normali<br />
ingredienti di un pieno significato: il senso letterale, le implicazioni<br />
metaforiche, lo stato d'animo di chi parla o scrive, il suo tono, intento, i suoi<br />
atteggiamenti verso il punto in questione, i suoi lettori, lui stesso, la sua opera, e<br />
altre persone e cose’, a parlare dell'uso <strong>della</strong> parafrasi nell'interpetazione, a<br />
ridimensionare il ruolo <strong>della</strong> grammatica come fondamento <strong>della</strong> lingua”<br />
(Russo 1989: 487) .<br />
L'insegnamento <strong>della</strong> letteratura e quello <strong>della</strong> lingua<br />
proseguirono uno accanto all'altro per tutta la vita di <strong>Richards</strong>: poco<br />
prima di morire aveva di nuovo tentanto la diffusione del Basic<br />
Movement in Cina.<br />
3. Interpretazione e definizione sono i presupposti necessari per<br />
una ricerca del significato d'un testo poetico o quello che si manifesta<br />
nel passaggio ad una nuova lingua. Questo era l' approccio teorico<br />
A. Olevano, "I. A. <strong>Richards</strong>: <strong>teoria</strong> e <strong>pratica</strong> <strong>della</strong> <strong>Glottodidattica</strong>", LZ 1/2010, pp. 47-64
I. A. <strong>Richards</strong>: <strong>teoria</strong> e <strong>pratica</strong> <strong>della</strong> <strong>Glottodidattica</strong><br />
del Basic English, “un inglese semplificato limitando a 850 il numero<br />
delle parole, e riducendo le regole per il loro uso al numero minimo<br />
necessario per esprimere chiaramente le idee” (<strong>Richards</strong> 1943: 20).<br />
Proprio lo studio compiuto con Ogden in Meaning of the Meaning lo<br />
aveva portato a pensare che: “qualunque cosa stiate definendo, certe<br />
parole continuano a ricorrere nelle vostre definizioni. Definitele, e con<br />
quelle potrete definire qualsiasi cosa” (<strong>Richards</strong> 1943: 23). Il processo<br />
definitorio sembrava quindi possibile attraverso la composizione <strong>della</strong><br />
frase con un numero limitato di parole: “Potrebbe esserci una serie<br />
limitata di parole nei cui termini si potrebbe stabilire il significato di<br />
tutte le altre parole. Se così è, allora una lingua molto limitata –<br />
limitato nel vocabolario, ma di ambito molto comprensivo – potrebbe<br />
essere possibile” (<strong>Richards</strong> 1943: 23). Un processo del genere non<br />
sembrava a <strong>Richards</strong> dover limitare l’effettiva capacità espressiva.<br />
Come già detto <strong>Richards</strong> aderì solo nel 1933 al progetto già avviato<br />
da Odgen. Il Basic Movement registrò subito un gran numero di<br />
adesioni, tanto che già nel 1939 erano già stati aperti sedi in 25 paesi<br />
del mondo; in un momento storico di grande crescita dell’influenza<br />
mondiale degli Stati Uniti, in modo forse troppo semplicistico,<br />
<strong>Richards</strong> attribuiva l’ampia diffusione <strong>della</strong> lingua inglese al fatto che<br />
essa fosse più facile da apprendere rispetto alle altre e quindi più<br />
insegnata in tutte le scuole del mondo. Ancora nel 1963 affermava:<br />
“[il Basic English] era inteso come lingua ausiliaria universale per<br />
l'uso negli affari, nell'amministrazione, nella ricerca, nell'istruzione e<br />
nel commercio” (<strong>Richards</strong> 1968: 243).<br />
Il Basic English era una lingua capace di consentire in modo<br />
semplice la comunicazione quotidiana, senza sovvertire l’ordine delle<br />
parole e soprattutto senza forzare la grammatica del full English: come<br />
rilevava Odgen, le forme e strutture che erano soppresse erano le<br />
stesse che oggi sono state lasciate cadere dall'uomo <strong>della</strong> strada e,<br />
talvolta, anche dagli insegnanti di grammatica (Sargant & Anderson<br />
1977: 138). Il Basic assecondava in effetti la grammatica del full English<br />
anche nelle sue forme irregolari, anzi seguiva i fenomeni di<br />
semplificazione in atto nell’uso, rilevati dagli stessi insegnanti, e<br />
A. Olevano, "I. A. <strong>Richards</strong>: <strong>teoria</strong> e <strong>pratica</strong> <strong>della</strong> <strong>Glottodidattica</strong>", LZ 1/2010, pp. 47-64<br />
57
58<br />
Alessandra Olevano<br />
applicava le costruzioni più semplici, proprie del parlato. (<strong>Richards</strong><br />
1943: 68).<br />
Le 850 parole erano divise in tre classi: seicento nomi di cose,<br />
centocinquanta nomi di qualità, e cento di ‘operations’ (“parole che<br />
entrano fra di loro in relazioni significative” (<strong>Richards</strong> 1943: 24).<br />
Senza dubbio la parte più interessante di questa lingua è costituita<br />
dagli operators, che consentono l’espressione dell’azione. Scorrendone<br />
l’elenco notiano che i primi 18 vocaboli sono propriamente verbi:<br />
“Questi ‘operatori’, combinandosi con altre parole di base, traducono<br />
in modo adeguato oltre quattromila verbi del full English” (<strong>Richards</strong><br />
1943: 29). È la combinazione dei termini che costituisce la ricchezza di<br />
significato. <strong>Richards</strong> è fedele all'idea elaborata in Meaning of Meaning<br />
sul significato e la sua definizione: è il contesto sintagmatico che<br />
determina l’”esplosione di significato”. Vediamo un esempio: “If we<br />
jump, we go up and down, if we rise a building we put it up, and if<br />
we raze it we take it down. If we donate a thing we give it to someone<br />
or something.” (<strong>Richards</strong> 1943: 33).<br />
Gli operators sono coadiuvati da altre parole del Basic, denominate<br />
directives che indicano movimento, posizione, direzione; sulla Basic<br />
List ne troviamo 20. Tale struttura sintattica asseconda ovviamente il<br />
carattere isolante dell’inglese: si costruisce senso con la<br />
giustapposizione di elementi in modo ordinato.<br />
Il numero esiguo dei verbi permetteva senza dubbio la loro<br />
immediata identificazione. <strong>Richards</strong> suggeriva di impartire allo<br />
studente per prima cosa uno studio intensivo dei verbi basilari<br />
(<strong>Richards</strong> 1943: 51-51). Questi avrebbero già da soli consentito una<br />
primitiva espressione dell’azione. Le preposizioni, invece, non<br />
andavano mostrate nell’immediato contesto d’uso, ma insegnate<br />
prima teoricamente, presentando i loro possibili ruoli per evitare<br />
fraintendimenti di significato (<strong>Richards</strong> 1943: 52).<br />
Scorrendo la lista dei 600 vocaboli che designano “cose”, things,<br />
molti sembrano essere verbi, come ad esempio act, attack, attempt, …<br />
In realtà nel Basic English essi hanno funzione di sostantivi perché,<br />
come spiega <strong>Richards</strong>: “… Nel Basic non tentiamo qualcosa o<br />
A. Olevano, "I. A. <strong>Richards</strong>: <strong>teoria</strong> e <strong>pratica</strong> <strong>della</strong> <strong>Glottodidattica</strong>", LZ 1/2010, pp. 47-64
I. A. <strong>Richards</strong>: <strong>teoria</strong> e <strong>pratica</strong> <strong>della</strong> <strong>Glottodidattica</strong><br />
attacchiamo qualcuno, ma facciamo un tentativo o un attacco<br />
(<strong>Richards</strong> 1943: 33). L’aspetto più interessante del Basic English<br />
riguarda la struttura semantica: <strong>Richards</strong> concepiva il significato delle<br />
singole parole come avesse un centro ed una periferia, una struttura<br />
radiale: “dobbiamo anche studiare attentamente il significato di<br />
ciascuna parola e decidere qual è il significato cardine, centrale, o<br />
significato chiave, di ciascuna. Parallelamente alla riduzione e<br />
all'ordinamento del dizionario, ci deve essere una riduzione e<br />
ordinamento dei significati delle parole che esso raccomanda... Questo<br />
significato centrale sarà il significato con riferimento al quale gli altri<br />
significati potranno essere facilmente intesi” (<strong>Richards</strong> 1943: 20).<br />
La combinazione contestuale delle parole per il senso complessivo<br />
<strong>della</strong> frase era quindi vincolata a tale struttura delle singole parole, e il<br />
significato centrale <strong>della</strong> parole sembrava determinato dalla<br />
frequenza d’uso. Una volta individuato il significato centrale,<br />
imparare il Basic English diventava molto più facile che non imparare<br />
in maniera indifferenziata la lista di 850 parole (<strong>Richards</strong> 1943: 32).<br />
Questa concezione radiale del meaning risultava allora molto<br />
originale, e ci appare molto vicina a quella maturata da Ludwig<br />
Wittgenstein nelle Philosophische Untersuchungen circa<br />
l’identificazione del significato con l’uso delle parole. Inoltre l’idea di<br />
centro e periferia semantica anticipa la <strong>teoria</strong> prototipica del<br />
significato. L’ordine di stesura <strong>della</strong> Basic List non sembrava<br />
rigidamente legato alla frequenza d’uso delle parole: “l'esatta<br />
collocazione di ciascuna in un testo didattico e con quanta forza<br />
ciascuna debba essere evidenziata al confronto con le altre, è un<br />
problema pedagogico che andrebbe accuratamente discusso”<br />
(<strong>Richards</strong> 1943: 54).<br />
Anche per un sistema linguistico così semplificato si poneva per<br />
<strong>Richards</strong> il problema <strong>della</strong> gradualità dell’insegnamento.<br />
Somministrare un lessico così esiguo, ma carico di potenzialità<br />
comunicativa, comportava una riflessione sulla questione. Un<br />
problema di ordine pedagogico quindi; tuttavia la snellezza <strong>della</strong><br />
struttura linguistica permetteva senz’altro un'organizzazione<br />
A. Olevano, "I. A. <strong>Richards</strong>: <strong>teoria</strong> e <strong>pratica</strong> <strong>della</strong> <strong>Glottodidattica</strong>", LZ 1/2010, pp. 47-64<br />
59
60<br />
Alessandra Olevano<br />
semplice dell’insegnamento: “Quanto più piccolo è il numero di cose<br />
che dovete insegnare, tanto più potete badare all'ordine in cui le<br />
insegnate” (<strong>Richards</strong> 1943: 72). D'altra parte, non c'è lingua che possa<br />
essere insegnata tutta in una volta, osserva <strong>Richards</strong> (1943: 46). È<br />
inevitabile che ci siano gradini e stadii nel processo d'apprendimento,<br />
e uno dei grandi vantaggi del Basic, secondo <strong>Richards</strong>, è appunto che<br />
l'accesso a un inglese più completo possa essere procurato appunto<br />
attraverso spiegazioni in Basic. Si evitino così i rischi del dizionario<br />
bilingue tascabile e l'identificazione erronea di espressioni <strong>della</strong><br />
seconda lingua (ivi).<br />
Le strutture frasali del Basic English dovevano appunto favorire il<br />
processo interpretativo diretto del discente, immediato fin dall’inizio<br />
del corso, mai passivo, legato all’uso vivo <strong>della</strong> lingua. Inoltre il<br />
progettista del corso poteva riuscire, secondo <strong>Richards</strong>, a commisurare<br />
gli argomenti trattati a un “ordine ideale”, quello che meglio<br />
incoraggia lo sviluppo in direzione d'una piena padronanza <strong>della</strong><br />
lingua (<strong>Richards</strong> -Gibson: 1957: 3).<br />
Tuttavia tale semplicità del Basic non appariva sufficiente per un<br />
buon insegnamento. <strong>Richards</strong> dichiarava: “L'occhio, e<br />
l'immaginazione visiva che gli sta dietro, sono in effetti ausiliari e<br />
alleati incomparabili dell'orecchio” Di qui il valore dell’immagine,<br />
intesa a semplificare quanto più possibile il compito del discente<br />
(<strong>Richards</strong> 1943: 20). Le immagini possono favorire l’apprendimento,<br />
riproducendo la sequenza del discorso e rappresentando la stessa<br />
organicità <strong>della</strong> frase:<br />
“La singola immagine (una figura del dizionario, ad esempio) è di solito ambigua:<br />
può servire a rappresentare troppe cose diverse perché si possa contare su di essa per<br />
fini illustrativi. Una serie di immagini, tuttavia, può essere progettata in modo che le<br />
loro interazioni – il modo in cui sono le stesse per un certo rispetto, ma diverse per altri<br />
rispetti – risultino sufficientemente univoche da supportare una serie verbale di<br />
struttura parallela. Sono le differenze che attirano l'attenzione, e quando le serie di frasi<br />
e le serie di immagini sono combinate in modo che la domanda ‘Che cosa varia con che<br />
A. Olevano, "I. A. <strong>Richards</strong>: <strong>teoria</strong> e <strong>pratica</strong> <strong>della</strong> <strong>Glottodidattica</strong>", LZ 1/2010, pp. 47-64
I. A. <strong>Richards</strong>: <strong>teoria</strong> e <strong>pratica</strong> <strong>della</strong> <strong>Glottodidattica</strong><br />
cos'altro?’ diventa la questione su cui concentrarsi, allora ecco che abbiamo gli<br />
strumenti richiesti per un uso adeguato degli audiovisivi” (<strong>Richards</strong> 1957:6).<br />
Non la singola immagine, che può essere ambigua, ma una serie<br />
d’immagini, aiuta dunque la comprensione delle frasi e<br />
l’apprendimento linguistico; come per le parole, è la sequenza, il<br />
contesto, che ne determinano l’interpretazione. La frase, come<br />
l’insieme d’immagini, costituiscono un organismo le cui parti<br />
ricavano il loro valore dall’insieme.<br />
Tuttavia la sequenza di immagini doveva essere ben congegnata<br />
per aderire a quella frasale. Doveva stabilirsi una buona relazione fra<br />
le due componenti comunicative, visto che “entrambe sono simboli<br />
che si riferiscono a, o mediano, qualcos'altro” (<strong>Richards</strong> 1957:6).<br />
Sembrava fondamentale che immagini e frasi fossero presentate in<br />
sequenze parallele e fossero perfettamente corrispondenti (<strong>Richards</strong><br />
1957:6). Inoltre <strong>Richards</strong> sottolineava una serie di dinamiche fra la<br />
componente linguistica e quella visiva, osservando che la parte<br />
dell’immagine è essenziale in un primissimo momento<br />
dell’apprendimento linguistico, mentre in una fase appena avanzata il<br />
rapporto fra le due componenti s’inverte. Frase e immagine se ben<br />
impostate diventano un unico, internamente collegate; la loro<br />
relazione, diceva <strong>Richards</strong>, (1957:6) “crea un gioco reciproco molto<br />
sottile e complesso” (<strong>Richards</strong> 1957:6).<br />
Un testo fondamentale fu la serie Language Through Pictures, che<br />
creava poi una metodologia d’insegnamento non soltanto per l’inglese<br />
ma anche per altre lingue; fra gli anni ’50 e ’60 ne uscì infatti una serie<br />
per lingue diverse. Ugualmente gli audiovisivi sembravano apportare<br />
un ausilio enorme all’apprendimento linguistico: “È un luogo comune<br />
pedagogico che quel che viene appreso attraverso diversi sensi si<br />
memorizza più facilmente, e quando si fa una lista di parole [...] il<br />
fatto non si deve certo trascurare. L'occhio, e l'immaginazione visiva<br />
che sta dietro di esso, sono fuor di dubbio ausilii ed alleati impagabili<br />
dell'orecchio nell'apprendimento linguistico” (<strong>Richards</strong> 1943: 80).<br />
A. Olevano, "I. A. <strong>Richards</strong>: <strong>teoria</strong> e <strong>pratica</strong> <strong>della</strong> <strong>Glottodidattica</strong>", LZ 1/2010, pp. 47-64<br />
61
62<br />
Alessandra Olevano<br />
Anni dopo, con la collaborazione di C. M. Gibson, <strong>Richards</strong><br />
modificò leggermente la struttura del Basic English rendendola più<br />
ricca e meno rigida, con l'utilizzazione di nomi in luogo di verbi<br />
(advertisement, attraction, knowledge and statement in luogo di<br />
advertise, attract, know and state) e l'aggiunta di alcune parole d'uso<br />
comune (can, must, many, few, either, soon, too, both, each). La lista<br />
originaria si arricchiva così di circa 150 parole (Russo 1989:401).<br />
Nonostante la sua capacità espressiva, il Basic English non<br />
sembrava adeguato a specifici ambiti argomentativi. <strong>Richards</strong> propose<br />
allora un supplemento lessicale per alcune specifiche discipline: liste<br />
di termini scientifici, economici, termini che servivano nello studio<br />
<strong>della</strong> letteratura o <strong>della</strong> Bibbia. Insomma si trattava di fare in modo<br />
che “interessi specialistici potessero svilupparsi quanto più<br />
precocemente possibile grazie al Basic” (<strong>Richards</strong> 1943: 37-38). Era un<br />
chiaro riconoscimento dei diritti delle lingue speciali e <strong>della</strong> loro<br />
terminologia e del relativo problema <strong>della</strong> traduzione. Il semplice<br />
accostamento di elementi non sempre costituiva una traduzione<br />
adeguata.<br />
Un uso importante del Basic English promosso da <strong>Richards</strong><br />
riguardava poi la traduzione dei testi poetici, certamente collegato al<br />
suo forte e costante interesse per la divulgazione <strong>della</strong> letteratura.<br />
Certo l'operazione comportava un impoverimento dell’opera<br />
letteraria, di cui veniva certamente ricostruito il senso, il pensiero,<br />
lasciando tuttavia che il tono, il sentimento e l’intenzione seguissero,<br />
come “implicazioni del pensiero” (Russo 1989: 480). Anche in questa<br />
operazione era presente la profonda convinzione che al contesto<br />
potesse essere affidata la capacità referenziale e comunicativa in senso<br />
lato. Denys Thompson commentava in proposito: “La traduzione<br />
<strong>della</strong> poesia in Basic può farsi sfuggire sfumature di sentimento, ma<br />
ciò non toglie il fatto che contribuisce molto a spiegare il senso pieno”<br />
(Brower, Reuben 1973: 301). Sicuramente il Basic English costituiva un<br />
ottimo strumento almeno per un iniziale approccio alla letteratura<br />
inglese, e i sistemi audiovisivi avrebbero potuto contribuire alla<br />
riproduzione del sentimento e tono dell’opera d’arte. Con la<br />
A. Olevano, "I. A. <strong>Richards</strong>: <strong>teoria</strong> e <strong>pratica</strong> <strong>della</strong> <strong>Glottodidattica</strong>", LZ 1/2010, pp. 47-64
I. A. <strong>Richards</strong>: <strong>teoria</strong> e <strong>pratica</strong> <strong>della</strong> <strong>Glottodidattica</strong><br />
cooperazione di questi strumenti, e in seguito del computer, il Basic<br />
English poteva così costituire un importante ausilio non solo per<br />
l’insegnamento <strong>della</strong> lingua ma anche per quello <strong>della</strong> letteratura.<br />
Non c'è dubbio che le teorie e pratiche glottodidattiche di <strong>Richards</strong><br />
fossero l'opera di un pioniere. Dal punto di vista <strong>della</strong> traduzione<br />
letteraria, l'idea del Basic English riproponeva il complesso problema<br />
dell’interpretazione. Pur con tutti i limiti dovuti alla semplicità <strong>della</strong><br />
lingua adottata, un processo interpretativo importante era comunque<br />
garantito, e l’uso degli audiovisivi sembrava poterlo coadiuvare.<br />
Certamente pionieristica, perché avviata fin dal 1939, fu la proposta di<br />
questi strumenti ausiliari sia nel close reading, sia nella traduzione in<br />
Basic English, sia nell’apprendimento delle lingue straniere. Che si<br />
trattasse di un romanzo o di un parlato, essi sembravano garantire<br />
comunque la ricostruzione di un contesto di vita. Soprattutto appariva<br />
chiarissimo che <strong>della</strong> lingua si doveva fruire in modo multisensoriale,<br />
coinvolgendo l'udito e la vista, e che la sua eccellenza comunicativa<br />
non si limitava alle potenzialità referenziali ed evocative. Anche<br />
l’interpretazione dell’opera letteraria rinviava ad un processo<br />
psicologico di comprensione aperto alle diverse dimensioni del reale.<br />
A. Olevano, "I. A. <strong>Richards</strong>: <strong>teoria</strong> e <strong>pratica</strong> <strong>della</strong> <strong>Glottodidattica</strong>", LZ 1/2010, pp. 47-64<br />
63
64<br />
Alessandra Olevano<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
BROWER Reuben, Helen VENDLER, John HOLLANDER (eds.) I.A.<br />
<strong>Richards</strong>: Essays in His Honour, Oxford, Cambridge (MA): Harvard,<br />
University Press, 1973.<br />
DOYLE Brian, English and Englisheness, New York, Routledge, 1989.<br />
ENGEL Monroe, Uses of Literature, Cambridge Harvard, University<br />
Press, 1973.<br />
MATTHEISON Margaret, The Preachers of Culture: A Study of English<br />
and its Teachers, London, Allen & Unwin, 1975.<br />
RICHARDS Ivor Armstrong, The Meaning of Meaning, London, Kegan<br />
Paul, Trench & Trubner, 1923.<br />
RICHARDS Ivor Armstrong, Principles of Literary Criticism. London,<br />
Kegan Paul, Trench & Trubner, 1924.<br />
RICHARDS Ivor Armstrong, Practical Criticism: A Study of Literary<br />
Judgment, London, Kegan Paul, Trench & Trubner, 1929.<br />
RICHARDS Ivor Armstrong, Interpretation in Teaching, New York,<br />
Harcourt Brace, 1936.<br />
RICHARDS Ivor Armstrong, Basic English and Its Uses, London, Kegan<br />
Paul, Trench & Trubner, 1943.<br />
RICHARDS Ivor Armstrong, Cristin M. GIBSON, “Mechanical Aids<br />
in Language Teaching”, in English Language Reachin, 12, pp. 3-9, 1957.<br />
RICHARDS Ivor Armstrong, So Much Nearer: Essays Toward a World<br />
English, New York, Harcourt Brace, 1968.<br />
RUSSO John Paul, <strong>Richards</strong> I.A. Complementarities, Manchester, Carnet<br />
New Press, 1977.<br />
RUSSO John Paul, I.A. <strong>Richards</strong>. His life and Work, Baltimore, Jons<br />
Hopkins, 1989.<br />
SARGANT Florence and J.R.L. ANDERSON (eds.), C. K. Odgen, A<br />
Collective Memoir, London, Ellek P., 1977.<br />
TYLLYARD E.M.W., The Muse Unchained, Cambridge, Bowes &<br />
Bowes, 1958.<br />
WITTGENSTEIN Ludwig, Philosophische Untersuchungen, Oxford,<br />
Blackwell, 1953.<br />
A. Olevano, "I. A. <strong>Richards</strong>: <strong>teoria</strong> e <strong>pratica</strong> <strong>della</strong> <strong>Glottodidattica</strong>", LZ 1/2010, pp. 47-64