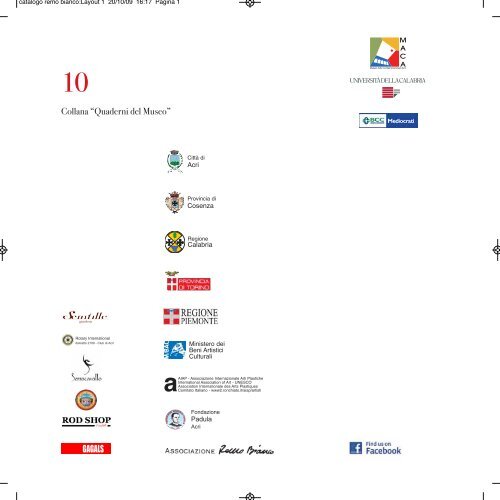clicca qui - MACA (Museo Arte Contemporanea Acri)
clicca qui - MACA (Museo Arte Contemporanea Acri)
clicca qui - MACA (Museo Arte Contemporanea Acri)
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:17 Pagina 1<br />
10<br />
Collana “Quaderni del <strong>Museo</strong>”<br />
<br />
Rotary International<br />
distretto 2100 - Club di <strong>Acri</strong><br />
<br />
a<br />
Città di<br />
<strong>Acri</strong><br />
Provincia di<br />
Cosenza<br />
Regione<br />
Calabria<br />
Ministero dei<br />
Beni Artistici<br />
Culturali<br />
AIAP - Associazione Internazionale Arti Plastiche<br />
International Association of Art - UNESCO<br />
Association Internationale des Arts Plastiques<br />
Comitato Italiano - www2.ronchiato.it/aiap/artisti<br />
Fondazione<br />
Padula<br />
<strong>Acri</strong><br />
M<br />
A<br />
C<br />
A<br />
<strong>Museo</strong> <strong>Arte</strong> <strong>Contemporanea</strong> <strong>Acri</strong>
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:17 Pagina 2<br />
In copertina:<br />
<strong>Arte</strong> elementare 1980<br />
cm 100x50<br />
Organizzazione<br />
<strong>MACA</strong> <strong>Museo</strong> <strong>Arte</strong> <strong>Contemporanea</strong> <strong>Acri</strong><br />
Direttore <strong>Museo</strong>: Giuseppe Altomari<br />
Direttore Artistico: Valerio Vigliaturo<br />
Curatore della mosrta<br />
Lorella Giudici, critico storico dell’arte<br />
Boris Brollo, curatore esterno del <strong>MACA</strong><br />
Collaboratori<br />
Antonella Algieri<br />
Alice Ferraris<br />
Franco Gaccione<br />
Massimo Garofalo<br />
Andrea Rodi<br />
Ra pporti con gli orga ni di informa zione<br />
Francesco Kostner, portavoce del Rettore Università della Calabria<br />
ufficio stampa <strong>MACA</strong><br />
Archivio fotogra fico<br />
Collezione Gianni<br />
GraficArtFronzoli
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:17 Pagina 3<br />
Architetto<br />
di sorprese<br />
Remo Bianco<br />
a cura di Lorellla Giudici e Boris Brollo
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:17 Pagina 4<br />
REMO BIANCO<br />
Architetto di sorprese<br />
<strong>MACA</strong><br />
<strong>Museo</strong> <strong>Arte</strong> <strong>Contemporanea</strong> <strong>Acri</strong><br />
Palazzo Sanseverino, <strong>Acri</strong> (CS)<br />
dal 22 novembre 2009 al 15 febbraio 2010
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:18 Pagina 5
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:18 Pagina 6<br />
6_7 Ringrazio Lyda Bianchi e Mino Bendotti, generosi e impareggiabili custodi dei ricordi, delle opere e della<br />
memoria dell’artista.<br />
Ringrazio tutta la famiglia Gianni che, nonostante il difficile momento, ha dato la sua disponibilità e la sua<br />
collaborazione per la riuscita della mostra.<br />
Lorella Giudici
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:18 Pagina 7<br />
È una piacevole sorpresa quella che il <strong>MACA</strong> ci offre donando alla città di <strong>Acri</strong> l’opportunità di ospitare una raccolta<br />
efficacemente rappresentativa delle opere dell’artista Remo Bianco. Un nome di rilievo, testimone di un periodo artistico incredibilmente<br />
vivace, e, soprattutto, un innovatore guidato da un’indefessa necessità di sperimentare con materiali sempre nuovi,<br />
dando vita a soluzioni inattese; un vero e proprio «architetto di sorprese».<br />
Ringraziamo, dunque, l’organizzazione del <strong>MACA</strong> per essere riuscita a portare in Calabria una mostra di estremo fascino<br />
ed indubbia importanza; i curatori Lorella Giudici e Boris Brollo per la sensibilità con cui si sono adoperati per la realizzazione<br />
dell’evento; e, immancabilmente, l’Associazione Remo Bianco che ha prestato queste magnifiche opere.<br />
Elio Coschignano<br />
Sindaco della città di <strong>Acri</strong><br />
Angela Vita<br />
Assessore alla Cultura della città di <strong>Acri</strong>
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:18 Pagina 8<br />
8_9<br />
Remo Bianco. La poetica del frammento e le impronte della vita<br />
“Orgoglioso ambiguo versatile sospettoso<br />
buono e generoso, di tenerezza nascosta,<br />
affettuoso amico.<br />
Pensieroso. Sempre in agguato. Negligente<br />
smemorato complicato superstizioso<br />
irreale e pazzo. Artista vero attore vero<br />
architetto di sorprese, inventore geniale<br />
impenetrabile immensurabile inscandagliabile<br />
segreto.<br />
Enigma umano per eccellenza: Remo Bianco”.<br />
Elmut Zimmerma n 1<br />
Lorella Giudici<br />
“Remin del mar” lo chiamava Filippo de Pisis 2 . Era il lontano 1939, Remo Bianco era solo un ragazzo e frequentava i corsi<br />
serali dell’Accademia di Brera. In cambio di pochi spiccioli, il ragazzo aveva offerto il suo aiuto al pittore ferrarese, da poco arrivato a<br />
Milano da Parigi. Gli portava il cavalletto e la scatola dei colori, gli puliva i pennelli, riassettava lo studio, lo accompagnava nelle uscite en<br />
plein air e gli faceva un poco da modello 3 , e intanto “Remin” guardava rapito le svolazzanti architetture del maestro, la nervosa leggerezza<br />
dei suoi segni, la pioggia di quei segmenti che parevano vaporizzarsi nella luce e cercava di farne tesoro. Poi, di sera, nella cucina<br />
di casa, quando tutti dormivano, provava a ricreare quelle magie: “Sentivo in quei momenti che avrei dato tutto, anche me stesso, per raggiungere<br />
una simile trasparenza, per alzarmi dalla terra e volare. Di nascosto, nella mia misera casa di Milano […], appoggiavo sul tavolo,<br />
dove si mangiava, qualche cartone e con gli avanzi di tubetti di colore che de Pisis buttava via, e con un suo vecchio pennello, pregavo<br />
Dio che mi venisse in aiuto. La pittura era ormai dentro di me, anche se non capivo come potessi ottenere un qualche risultato” 4 . Così era<br />
incominciata la sua lunga, irre<strong>qui</strong>eta e anarchica carriera d’artista.<br />
Le prime opere, almeno quelle che ci sono rimaste, risalgono alla metà degli anni quaranta; sono figure, ritratti e autoritratti<br />
dai contorni insistiti e dai colori espressionisti, che più che a de Pisis sembrano aver guardato a Rouault, anche nei temi 5 . Sono demora -<br />
lizza to per le pessime condizioni in cui mi trovo, è ad esempio il titolo di un autoritratto del 1945, un misto di allegria e disperazione, di<br />
gioco e malinconia, di maladresse e divertissement.<br />
Solo in rare prove, come Lavoratore ammalato (un olio del 1947) e in alcuni paesaggi che l’artista dipinge su vetro o su plastica<br />
al principio degli anni cinquanta, si può vagamente rintracciare il fremito di quel “paradiso provvisorio” 6 , di quella grafia veloce e<br />
ansiosa, i toni grigi e gessosi di alcuni interni depisisiani. Ma la lezione di de Pisis si manifesta piuttosto altrove. Prima di tutto nell’amore<br />
per le lettere, in particolare per la poesia – arte che entrambi hanno coltivato e praticato (de Pisis con maggior successo e assiduità) –,<br />
e nell’ineluttabile consapevolezza che tutto è momentaneo, passeggero, provvisorio. E quello che in de Pisis è pennellata evanescente,<br />
ombra fuggente e vuoto imprendibile, in Bianco diviene ossessione per il ricordo, ostinazione per il reperto, caparbietà nel cogliere e<br />
rivelare l’enigmaticità del quotidiano. Inoltre, l’amore di de Pisis per il particolare e per il frammentario (che gli fa dipingere un catalogo<br />
di piccole e futili cose: una conchiglia, una piuma, una foglia, una scatolina…), in Bianco si conferma in affezione per le cose minime,<br />
inutili, per una manciata di istanti che ferma nel gesso, che chiude in bustine di plastica o imprigiona in asettiche teche di plexiglas.<br />
Quelle che Bianco si ostinerà a documentare per tutta la vita sono dunque cose trascurabili, materiali di scarto, vecchi, consunti,<br />
dimenticati, ma, come dice l’artista, “con un aspetto molto poetico” 7 , perché sono le tracce della vita: “Io volevo ricostruire parte<br />
della mia vita, quasi tutti questi oggetti erano miei, appartenuti a me, alla mia infanzia. Poi ho collegato questo problema agli altri, ricostruendo<br />
attraverso questi oggetti la vita dell’uomo, raccontando proprio ciò che era avvenuto attraverso l’incontro con gli altri in una<br />
giornata” 8 . Nell’imbustare, in un sommario e approssimativo tentativo di catalogazione (Testimonia nze); nell’imprigionare nella gomma
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:18 Pagina 9<br />
o nel gesso (come in blocchi di ambra bianca) sagome prelevate dall’avvicendarsi dei giorni (Impronte); nel racchiudere metafisiche e<br />
silenziose nature morte in asettici scrigni di plexiglas (Sculture neve), Bianco si prefigge solo uno scopo o, se si preferisce, una romantica<br />
illusione: non dimenticare. “Tutto il mondo poetico di Bianco – ha scritto Elena Pontiggia - non è che una lunga e ininterrotta pagina<br />
autobiografica: una pagina di diario in cui l’artista descrive se stesso e il suo rapporto col mondo. Bianco ha lavorato per tutta la vita con<br />
quello che Proust chiamava «l’immenso edificio del ricordo»: ha raccolto, catalogato, riunito le tracce e le impronte della vita” 9 .<br />
Dai primi dipinti degli anni quaranta fino all’ultimo ciclo dell’<strong>Arte</strong> Elementa re, passando per l’<strong>Arte</strong> Nucleare, l’<strong>Arte</strong><br />
Improntale, le Sculture Viventi quelle gonfia bili (del 1956), i Ta blea ux dorés, i Collages e le Sculture neve, la sua ricerca si è dunque rivelata<br />
come un continuo desiderio narrativo, come un’insopprimibile urgenza di far sapere o, per usare un termine a lui caro, di testimoniare,<br />
prima di tutto a se stesso e poi agli altri, ciò che avviene in ogni spicciolo di vita prima che anche un solo secondo vada irrimediabilmente<br />
perduto. La memoria, intesa come un’interminabile stratificazione di ricordi e di pensieri, è per Bianco la fonte più pura, la ricchezza<br />
più grande, il rifugio più sicuro, inarrestabile commozione.<br />
La mostra si articola attorno ad alcuni importanti momenti della sua attività: i 3D, i Collages, i Ta blea ux dorés, le Impronte e<br />
l’<strong>Arte</strong> Elementa re, cinque delle sue ricerche più significative, sufficienti a testimoniare (in una sintesi efficace) l’originalità di questo “architetto<br />
di sorprese, inventore geniale impenetrabile immensurabile inscandagliabile segreto. Enigma umano per eccellenza: Remo Bianco” 10 .<br />
Nato a Milano nel 1922, Bianco si inserisce appieno nello stimolante contesto culturale che anima la città lombarda negli anni<br />
cinquanta e sessanta: la galleria del Naviglio, le radicali ricerche di Lucio Fontana e di Piero Manzoni, le monocrome pitture di Yves<br />
Klein, le riflessioni di Pierre Restany (il mentore del Nouveau Réalisme), i primi germi dell’informale, dell’arte concettuale e di quella<br />
spaziale; tutti stimoli che Bianco raccoglie, a volte anticipa, ma sempre trasforma in qualcosa di più personale ed eretico.<br />
Dopo le prime esperienze di ascendenza espressionista, che attraverso il gesto e il colore riaffioreranno di continuo lungo<br />
tutto il suo percorso creativo, Bianco si volge verso un astrattismo geometrico – cubista. Al principio, però, più che la dimensione pittorica,<br />
a lui interessano lo spazio, il movimento e la metamorfica sovrapposizione di forme che, mescolandosi, assumono fisionomie cangianti.<br />
Bianco trasferisce allora le sue composizioni più geometriche (un astrattismo a metà strada tra Mirò e Kandinsky, Magnelli e Dova,<br />
Capogrossi e Scanavino, Consagra e Accardi, Soldati e Perilli) su supporti trasparenti – in vetro o in plastica, arrivando a forarli e a<br />
sovrapporli in una tridimensionalità che intende coniugare plasticità e pittoricità, colore e diafanità; oppure le ritaglia nel legno, nella<br />
plastica e nella lamiera (anticipando, con tutte le doverose differenze del caso, i famosi teatrini di Lucio Fontana, iniziati solo nel 1964),<br />
raggiungendo un minimalismo estremo, fatto solo di luce, di ombra e di vuoto. Qui lo spazio è intuitivo, mentale, quasi orientale. Li ha<br />
chiamati 3D, cioè “Tridimensionali”. E sui 3D l’insigne penna di Gillo Dorfles scrive: “è il reciproco comporsi ed annullarsi dei singoli<br />
strati ad avere la meglio: le figure intagliate, anche quando sono basate su un disegno elementare, vengono ad assumere complessità ed<br />
a lea torità per la parziale loro obliterazione da parte delle superfici successive: e da questo incontro vengono a determinarsi, alle volte,<br />
impensati e magici labirinti dove s’annida l’ombra del dubbio, e dove il gioco del chiaroscuro e delle luci accresce ed accentua il mistero.<br />
Ed è questa duplice qualità di labirinto inesplorato e di forma in divenire – promossa e suscitata dall’incontro di colori, di forme e di luci<br />
spesso impreviste - a conferire ai 3D di Bianco quella qualità d’universo in fieri, ma anche d’oggetto definito e tangibile, che rende queste<br />
opere particolarmente singolari e suasive” 11 .<br />
Lo stesso Fontana, presentandolo in una mostra alla Galleria Montenapoleone di Milano nel 1953, nota i “nuovi aspetti della<br />
«pittura spaziale»” 12 . Fontana è dunque pronto (anche per affinità) a coglierne le potenzialità di uno spazio che nella versione pittorica<br />
(fogli di vetro o di plastica dipinti e sovrapposti) è affidato alla trasparenza e al gioco di linee, mentre in quella «scultorea» (come la serie<br />
dei 3D scelti per questa mostra) è scenografico, scandito com’è dalla successione di <strong>qui</strong>nte, dai ritagli che scoprono la profondità, dai<br />
sottili e suggestivi giochi di ombre e dall’alternanza di vuoti sospesi e silenziosi pieni. Nel 1955, i 3D saranno il suo biglietto da visita<br />
per l’America, la testimonianza di un’arte che lui stesso definisce “più fredda, più cerebrale dell’impressionismo astratto” 13 .<br />
Intanto, nel ’50, mentre Peggy Gugghenheim e Bruno Alfieri organizzarono una mostra di venti opere di Pollock al <strong>Museo</strong><br />
Correr di Venezia e Carlo Cardazzo allestisce (nella sua galleria milanese) una personale del maestro dell’action painting, nel lavoro di
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:18 Pagina 10<br />
10_11<br />
Bianco, a una stagione geometrica, subentra una stagione informale. Dei primi anni sono le tele (ma anche carte e plastiche) su cui, in<br />
modo apparentemente casuale, il colore si libera in macchie, segni, colature e pennellate. A prima vista esse appaiono come delle prove<br />
nate sulla spinta dell’automatismo spontaneo e disinibito di Pollock, in realtà, quelle di Bianco, sono scritture precise e sgorgano da un<br />
gesto modulato, seguono un loro ordine, tessono percorsi ben leggibili e molti segni sono persino speculari. Quindi, diversamente dalle<br />
contemporanee esperienze americane, i segni di Bianco conservano sempre un grafismo controllato e garbato, privo di quel pathos vitalistico<br />
che è nel dna della pittura pollockiana. Queste nuove sperimentazioni sono il punto di partenza della lunga stagione Nucleare e<br />
Spa zia le, oltre che la matrice dei più noti (e numerosi) Collages. La pittura, ramificata in una ragnatela di segni, stratificata in fili e pennellate<br />
che lui stesso definisce “suggestive” – “Erano delle colate, delle colature su tela. Io chiamavo appunto suggestiva questa pittura<br />
perché mi suggeriva delle immagini. Questa procedeva, risalivi a un concetto nientemeno che leonardesco, il quale aveva scoperto nelle<br />
macchie il suggerimento di forme; effettivamente questo colare il colore sulla tela causava delle forme strane che suggerivano delle visioni”<br />
14 –, nei Collage, nati nel 1957, recupera, negli ortogonali tagli perimetrali, la regola che aveva perso. Le superfici si dividono in tanti<br />
quadrati o rettangoli 15 , tutti simili, tutti conformi a quell’idea di scansione ritmico-spaziale che sta alla base del loro alternarsi. Dopo il<br />
caos c’è l’ordine. Dopo l’emozione c’è la ragione. La scrittura si fa codice, puzzle polimaterico e affascinante racconto sillabato.<br />
Bianco non ascolta il grido della passione, non si abbandona alla seduzione dell’istinto, non si lascia soggiogare dalla magia<br />
dell’astrazione, anche se lirica. Tutt’altro. E’, semmai, più propenso a dare retta alle leggi della ragione, a far rientrare l’istinto nelle più<br />
sicure e speculative regole della coscienza. Come fa notare anche Altamira: “Con queste opere Remo Bianco, oltre a dichiarare morto<br />
l’informale, poco dopo la metà degli anni cinquanta, inventa quel suo sistema a scacchiera che sarebbe rimasto la griglia fissa di quasi<br />
tutta la sua produzione pittorica importante degli anni successivi: i Ta blea ux dorés e i Sa cchettini. Una griglia che non a caso si riassume<br />
tutta in una formula concettuale che trova per esempio riscontro, sia pure più lucidamente, nell’opera di Piero Manzoni” 16 .<br />
“Mi interessava – confessa Bianco - di ricostruire a freddo” quella “calda” pittura nata dall’emotività del gesto. Cioè “si trattava<br />
– continua - di tagliare la tela dipinta in tanti quadratini e di conservare le parti che mi interessavano di più e ricomporre poi questa<br />
tela, che diventava come una specie, così, di scacchiera, dove tutte queste forme risultavano spezzate (solo ora ho saputo che Kelley mi<br />
aveva in parte preceduto)” 17 . E anche quando le pennellate spariscono dalle quadrettate superfici, per lasciare la scena unicamente alla<br />
geometria, e quando le superfici diventano dei volumi solidi (parallelepipedi o spirali ascendenti che Bianco chiama Pagode) il fascino di<br />
quel racconto, fattosi più minimale e pulito, rimane intatto: “Io non credo in una verità, ma in molte verità che ne fanno una”, ha scritto<br />
Bianco, “i collages hanno questo senso: sono particolari di un tutto, rappresentano una verità” 18 .<br />
Infatti, i Collage – come tutta la sua ricerca – sono delle pagine autobiografiche, sono il calendario di una vita, che l’artista<br />
non ha mai visto né come successione di anni né come carrellata di giorni, ma piuttosto come una scansione infinita di istanti da prendere<br />
singolarmente, come i grani di un rosario. Un’unità parcellare che per Bianco non solo è da vivere, ma anche da conservare, custodendola<br />
in un archivio tutto personale. Ed è dallo sviluppo di questo casellario enciclopedico che Bianco giunge a creare le opere più conosciute<br />
di tutta la sua produzione: i Ta blea ux dorés 19 .<br />
La necessità di recuperare un e<strong>qui</strong>librio, un’armonia, persino una dimensione in qualche modo mistica, gli ha fatto ricoprire<br />
le tele e le carte con sottili rettangoli (o quadrati) di foglia d’oro (o più raramente d’argento), componendo quelle che Raffaele Carrieri<br />
aveva definito “dorate scacchiere” 20 .<br />
Come tarocchi allineati (e anche in questo c’è una nota autobiografica, visto che la madre praticava abitualmente la cartomanzia<br />
e la chiromanzia), gli arcani di Bianco si leggono per trovare conferme, si consultano per rassicurarsi sul presente e sul passato più<br />
che per vaticinare il futuro. Come in un antico rituale buddista, l’artista attacca alla tela (al legno o al cartone) le sue preghiere con lo<br />
schema di una scacchiera e affida alla musa dell’arte i suoi voti e i suoi sogni. Niente potrà mai cancellare la bellezza di queste dorature<br />
che, come ha scritto l’artista Mark Tobey, “brillano come un altare, come le luci di un crepuscolo greco” 21 .<br />
Negli anni la foglia d’oro diventa la sigla distintiva di Bianco, il marchio di riconoscimento della sua presenza. Alla fine degli<br />
anni sessanta, ma ancor più negli anni settanta i piccoli e preziosi quadrilateri si depositano su poster che riproducono famosi dipinti del<br />
passato, su piccoli o grandi oggetti (ad esempio un’automobile), su bandiere che divengono il simbolo di nuove con<strong>qui</strong>ste. Sono le
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:18 Pagina 11<br />
Appropriazioni, ovvero quel fenomeno che lui stesso definisce “araldismo” e attraverso il quale “sottrae” al mondo per fare propri alcuni<br />
importanti simboli, semplici oggetti o particolari porzioni di spazio.<br />
Diversi sono gli artisti che tra la fine del cinquanta e i primi anni del sessanta sono ritornati all’oro: Fontana, Manzoni, Klein<br />
e tutta la schiera del Nouveau Réalisme francese, che sicuramente Bianco conosceva, vista anche la sua amicizia con Restany e Raymond<br />
Hains (artista e critico, militante del gruppo francese) e la sua assidua frequentazione della Galleria del Naviglio (avamposto dell’avanguardia<br />
europea), ma non per questo se ne possono accomunare le ricerche. Certo è che, negli anni in cui la pittura non è più di moda<br />
(perché troppo personale e emotiva), negli anni in cui al pennello si preferisce l’idea, un colore così distaccato, sofisticato e intellettuale<br />
come l’oro appaga.<br />
Bianco lo fa diventare forma, ma soprattutto ne sfrutta le capacità oniriche e evocative, trasformando, ancora una volta, la<br />
materia in pensiero e il pensiero in sogno.<br />
Bianco è ossessionato dal trascorrere inesorabile del tempo, dall’idea che tutto finisca e venga dimenticato. Non sopporta che<br />
i ricordi sbiadiscano e scompaiano senza lasciare traccia, non accetta che ogni giorno si cancellino dalla memoria paragrafi di vita spicciola,<br />
frammenti insignificanti, cose infinitesimali. Però, è altresì convinto, e lo ha dimostrato, che la non reversibilità del tempo possa<br />
essere sconfitta se lo si trasforma in ricordo, in memoria, in accumuli e sedimentazioni. E’ da queste riflessioni che, alla metà degli anni<br />
cinquanta, contemporaneamente ai Ta blea ux, nascono le Impronte e le Testimonia nze: almanacchi che ai giorni preferiscono le cose e<br />
ai santi i ricordi. Bianco allinea, con il ritmo dei Ta bleux, bustine di plastica colme di piccole cianfrusaglie, e la necessità di “archiviare”<br />
trucioli, carte, pezzi di giocattoli, mozziconi di sigaretta, legnetti, fili, lo ha portato a “scrivere” uno struggente biografia costellata di<br />
cose senza valore, se non quello affettivo.<br />
Accanto a questi le Impronte: calchi in carta o in gomma di piccoli oggetti e variopinti giocattoli affogati nel gesso che, come<br />
ludici fossili di un’infanzia ormai perduta - ma mai dimenticata -, commuovono, come i tasselli di una storia lontana e fantastici capitoli<br />
dei racconti rodariani. Quale sia il loro significato Bianco lo spiega nel Manifesto dell’<strong>Arte</strong> Improntale: “L’arte dell’avvenire è posta sotto<br />
il segno dell’IMPRONTALE. IMPRONTALE è tutto ciò che resta impresso nel nostro subcosciente: IMPRONTA della società stessa, in<br />
quanto immagine di tutti quei condizionamenti che l’essenza della vita oggi comporta. Dichiaro perciò che l’uomo non può evitare di<br />
essere IMPRONTA di una società che continuamente muta e ci circonda sempre di cose nuove. Per sfuggire ai fenomeni non sempre desiderati,<br />
l’uomo dovrà impadronirsene, creando l’impronta che non sarà più l’oggetto, ma un qualcosa di conforme alla sua natura. Tutto<br />
ciò richiede un modo diverso di espressione, che tenga conto di tutti questi presupposti. Dichiaro che le mie IMPRONTE sono una documentazione<br />
universale che catalogherà tutte le cose venute a contatto con me attraverso una realtà ridimensionata della verità attuale.<br />
Dichiaro che in un prossimo futuro gli uomini prenderanno le impronte per poter possedere la realtà che li circonda” (1956) 22 .<br />
Bianco, ancora una volta dimostra di non essere una voce fuori dal coro. In quegli stessi mesi Manzoni sperimentava i primi<br />
Achrome in gesso, mentre attorno a Pierre Restany, già dalla fine degli anni cinquanta, gravitano anche Arman e Spoerri, due artisti che<br />
condividono con Bianco la poetica del frammento. Nel 1959 Arman, dopo aver esposto i Ca chets (impronte di stoppini) e le Allures d’objets<br />
(tracce d’oggetti inchiostrati o dipinti, un processo che anche Bianco confessa di avere praticato 23 ), crea le prime Accumula zioni:<br />
oggetti in serie giustapposti e incorniciati in scatole o vetrine. Anche Arman parte dallo scarto, dall’inutilizzato, ma per pensarlo come<br />
colore e per “ricontestualizzarlo in se stesso in una superficie sensibilizzata x volte dalla sua presenza duplicata” 24 . Spoerri, di contro,<br />
nei suoi famosi Ta blea ux-piéges, a cui arriva alla fine degli anni cinquanta, finisce con l’assemblare, o meglio con l’imprigionare in una<br />
sorta di straniante incantesimo frammenti della realtà: tavoli ingombri delle cose più disparate, di oggetti di uso quotidiano che incolla<br />
saldamente al piano e poi ribalta in posizione verticale. La carica evocativa delle cose perdute, dimenticate, buttate di quegli oggetti, ad<br />
un tempo magici e ironici, è forte. Stanno lì a suscitare un ricordo, a evocare un passato di cui non si conosce nulla se non le conseguenze<br />
di un frammento appena consumato. Come Morandi, Spoerri non toglie poesia alla cose, ma le sacralizza in un tempo che è eterno.<br />
C’è comunque un abisso tra l’<strong>Arte</strong> Impronta le di Bianco e le primogenite impronte di Yves Klein, le coeve sperimentazioni di<br />
Manzoni e le appropriazioni di Spoerri o Arman. Ma dal momento che non si tratta di stabilire primogeniture (il percorso storico lo ha<br />
già tracciato Altamira 25 ) – perché l’arte non è una gara a cronometro – è semmai il caso di stabilirne le diversità. In Bianco, oltre alla
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:18 Pagina 12<br />
12_13<br />
valenza compositiva e poetica (comune a tutti gli interpreti citati), c’è una nota sentimentale, letteraria, s<strong>qui</strong>sitamente sognatrice che lo<br />
isola dal gruppo e lo porta su strade diverse. Ancora molti anni più tardi, in un testo-confessione, pubblicato da Niklos N. Varga (uno dei<br />
critici più attenti al lavoro di Bianco, oltre che uno degli amici più cari), Bianco racconta: “Ho recuperato la banalità per meglio riconoscerla<br />
e difendermi dalle sue insidie. Ora, che sono un po’ più vecchio e stanco, ma sempre in fermento creativo, non mi resta che trovare<br />
sostentamento in quel tozzo di pane poetico che mi è rimasto, oppure mettere ancora una volta il dito nella ferita per andare verso la<br />
non-arte, rifiutando il consumismo dell’arte, proiettandomi direttamente nella vita, alla ricerca dell’arte per vivere” 26 .<br />
Al contrario di Arman, dunque, e più vicino, per certi versi, alla poetica di Spoerri, per Bianco il frammento ha, caso mai, un<br />
valore emotivo, affettivo, si potrebbe dire sacrale. Con lui, cataloghi di cose senza valore ac<strong>qui</strong>stano una posizione primaria, ottengono<br />
l’attenzione del mondo: “La mia natura – riconosce l’artista - è una specie di negozio per le vendite al dettaglio, mi concentro piuttosto<br />
sul frammento, o per natura o per mancanza di mezzi” 27 .<br />
Andando in questa direzione, alla metà degli anni sessanta, in linea con il ciclo delle Testimonia nze, Bianco sperimenta un<br />
nuovo materiale: la neve artificiale. La spruzza sugli oggetti più diversi: giocattoli, piccole sculture, tubetti di colore spremuti, frutta di<br />
plastica, ma anche su uomini, donne e se stesso. La sottile polvere bianca, impalpabile e farinosa, si deposita sulle cose in strati più o<br />
meno consistenti, accomunandole in un candore immacolato. Bianco racchiude questi campionari in teche trasparenti o li immortala in<br />
suggestive fotografie in bianco e nero, fermando per sempre questa loro condizione “invernale”. L’innevamento, seppur provocato e chimico,<br />
conferisce alle cose una dimensione metafisica, le congela in un tempo eterno e immutabile, le avvolge in un’atmosfera a metà<br />
dechirichiana (per quel senso iperuranico che le permea) e a metà da reperto archeologico (per quella sottile patina che le storicizza). Gli<br />
oggetti, immobili e muti, sembrano prigionieri di uno strano e perverso incantesimo, incapaci di raccontare la storia che li ha condotti<br />
fino a lì, incapaci di mutare la loro condizione, eppure così eloquenti nella loro enigmatica fissità. Inutili e storicamente irrilevanti, essi<br />
testimoniano unicamente e ironicamente di aver vissuto.<br />
Negli anni settanta, pur proseguendo la serie dei Ta blea ux dorés e dei Collages, Bianco ha pensato a un’<strong>Arte</strong> Elementa re. In<br />
un sorta di estremo tentativo di chiarezza, sempre più consapevole del caos filologico della propria ricerca (che nel 1972 lo fa amaramente<br />
scrivere su un gradino della scala della galleria Naviglio di Milano: “Non mi hanno mai preso sul serio, ho bombardato tutti con troppe<br />
idee, troppe intuizioni, troppo disordine” e, qualche gradino più su: “Qualcuno purtroppo se n’è accorto, ha preso queste cose, le ha<br />
fatte sue... Così il mio albero ha fatto tanti fiori e dato pochi frutti” 28 ), nascono, a volte su fondi quadrettati come le pagine dei quaderni,<br />
file di trenini, fiori, frutti, giostre, soldatini, mobili, persino scritte corsive che rimandano a un mondo di rappresentazioni minimali<br />
e stereotipate. Le loro superfici, colorate con campiture piatte e compatte, imitano le vivaci e antinaturalistiche vignette dell’abbecedario<br />
elementare. Bianco è tornato all’abc della pittura, a disegni semplici, da sillabario scolastico.<br />
E anche se sembrerebbe che a ispirare Bianco sia il magico mondo delle filastrocche, i giochi popolari dell’infanzia, l’irridente<br />
banalità delle ludiche canzoncine da cortile, in realtà il senso di questa stilizzata figurazione è serio. Prima di tutto è pedagogico e poi<br />
(con la stessa importanza) è, ancora una volta, biografico: “All’uomo immaturo che regredisce inconsapevolmente all’infanzia, si contrappone<br />
l’artista, l’uomo che consapevolmente sceglie di tornare a una condizione primigenia. Ludica non può essere la vita: ludico può<br />
essere solo l’atteggiamento di chi medita sulla vita” 29 .<br />
Per anni Bianco non ha fatto altro: raccogliere, raccontare e conservare le impronte della vita.<br />
1 E. Zimmerman, Remo Bianco, catalogo mostra, Centro d’<strong>Arte</strong> Settimiano, Roma 1962.<br />
2 R. Bianco, in F. De Santi, Il tempo culturale di Remo Bianco, catalogo mostra Abbazia Olivetana, Rodendo Saiano 1998, p. 21.<br />
3 Bianco e de Pisis si erano dunque conosciuti a Brera. Una sera, de Pisis e Carrà, uscendo da una mostra alla Galleria del<br />
Milione (allora, prima che i bombardamenti lo radessero al suolo, il noto spazio espositivo sorgeva proprio davanti al palazzo dell’accademia),<br />
decidono di dare un’occhiata ai giovani studenti. “Io – ricorda Remo – avevo lasciato libero il mio posto […]. Un uomo grasso,<br />
che seppi poi era de Pisis, si fermò proprio davanti al mio tavolo. Il disegno era non scolastico, aveva qualche aspetto di singolarità, direi<br />
che era espressionista. Lo osservò e non disse nulla. Mi avvicinai timidamente. Mi disse il suo nome, mi lasciò l’indirizzo” [R. Bianco, in<br />
Franceschetti Remo Bianco, La Nuova Cartografia, Brescia 1992, p. 16]. In quello studio il giovane Remo conosce artisti come Carrà,
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:18 Pagina 13<br />
Sironi, Savinio, Soffici, Soldati; ma anche scrittori come Montale o registi come De Sica. Per una ricostruzione dettagliata del rapporto<br />
Bianco - de Pisis si rimanda al bel racconto di Milena Milani pubblicato in F. De Santis 1998 op. cit, pp. 21-31.<br />
4 R. Bianco, in F. De Santi 1998, op. cit., p. 22.<br />
5 Non è un caso, dal momento che proprio nel 1945 a Milano esce la prima monografia italiana su Rouault (con le Edizioni<br />
<strong>Arte</strong> e Scienza) e solo qualche anno prima (1940) Venturi, sulla scia delle mostre dedicate al maestro (una al Grand Palais nel 1937 e una<br />
al MOMA di New York nel 1938), gli aveva dedicato una monografia newyorkese.<br />
6 Sono versi di una poesia di de Pisis.<br />
7 R. Bianco, in A. Franceschetti 1992, op. cit., p. 54.<br />
8 Ibidem, p. 55.<br />
9 E. Pontiggia, La ra ccolta Gia nni, Electa, Milano 1999, p. 11.<br />
10 E. Zimmerman 1962, op. cit.<br />
11 G. Dorfles, Remo Bianco, catalogo mostra, Galleria del Naviglio, Milano 1965.<br />
12 L. Fontana, pieghevole della mostra, giugno-luglio 1953.<br />
13 R. Bianco, in Franceschetti 1992, op. cit., p. 34. Bianco intendeva probabilmente parlare di espressionismo astratto, di<br />
cui Pollock e Tobey, che Bianco aveva conosciuto a New York, erano degni rappresentati.<br />
14 R. Bianco, in Franceschetti 1992, op. cit., p. 48.<br />
15 Esistono anche dei collage con forme diverse (nel lavoro di Bianco c’è sempre l’eccezione), ma sono appunto dei casi sporadici<br />
e così numericamente limitati che non è il caso di prenderli in considerazione in questa sede.<br />
16 A. Altamira – C. Franza Remo Bianco, catalogo mostra, Civica Galleria, Gallarate 1996, p. 10.<br />
17 A. Franceschetti 1992, op. cit., p. 52.<br />
18 R. Bianco, in L. Giudici, Remo Bianco. La metamorfosi della materia, catalogo mostra, Palazzo del Monte, Padova 2005, p. 33.<br />
19 Bianco ha sempre utilizzato un sistema di lavoro seriale e i grandi cicli della sua ricerca (ad esempio i Ta blea ux, i 3D, i<br />
Collage) non li ha mai abbandonati. “Quello che mi capita - confessa - è di non esaurire completamente un periodo. Sto cercando in un<br />
campo e mi appassiono in un altro e allora interrompo questo e incomincio quello e poi a distanza di anni riprendo. […] Certo non posso<br />
mai dire «sto lavorando a questo», sì lavoro anchea questo, ma nel frattempo continuano dentro di me le risonanze di altri momenti, di altri<br />
periodi che devo continuamente portare avanti” (R. Bianco, in E. Pontiggia 1999, op. cit. p. 23).<br />
20 R. Carrieri, Le dorate scacchiere di Remo Bianco, “Epoca”, Milano, 14 ottobre 1962. Il primo Ta blea u doré è del 1957,<br />
l’ultimo è del 1988, pochi mesi prima che morisse.<br />
21 M. Tobey, testo di presentazione alla mostra di Remo Bianco al Fiac di Parigi per la Galleria del Naviglio di Milano, Parigi 1982.<br />
22 R. Bianco, in L. Caramel, I Bia nco di Bia nco. Dentro, fuori e oltre la pittura , catalogo mostra, Galleria del Naviglio e<br />
Galleria San Carlo, Milano, 1999, pp. 22-23.<br />
23 Per una biografia completa e una ricostruzione sistematica del suo lavoro si rimanda al regesto curato da me nel catalogo<br />
edito in occasione della mostra antologica di Bianco al Complesso del Vittoriano di Roma: C. Strinati - L. Giudici, Remo Bianco. Al di là<br />
dell’oro, Silvana Editoriale, Milano 2006, pp. 175-183.<br />
24 Arman, Realismo delle Accumulazioni, Zero 3, Dusseldorf, luglio 1961, pubblicato in Le Nouveau Réalisme, catalogo<br />
dell’esposizione, M.A.M., Parigi 1986.<br />
25 A. Altamira, Remo Bia nco. Ca ta logo genera le, vol. 1, Mazzotta, Milano 2001, pp. 23-24.<br />
26 R. Bianco, Vivere nella ricerca, “Terzo Occhio”, n. 41, Bologna, dicembre 1986.<br />
27 R. Bianco, Appunti-dia rio per un’a utobiogra fia , op. cit., p. 180. Quest’ultima parte di testo è stata tratta, e in parte rivista,<br />
dal mio scritto pubblicato in occasione della recente mostra sull’artista al Centro per l’<strong>Arte</strong> Otello Cirri a Pontedera (novembre<br />
2008-gennaio 2009).<br />
28 Altamira, Idee per una scala, 1972.<br />
29 E. Pontiggia 1999, op. cit., p. 19.
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:18 Pagina 14<br />
Con riconoscienza e affetto, dedico questa mostra a Virgilio Gianni, il più grande collezionista dell’opera di Bianco, ma soprattutto<br />
amico e instancabile sostenitore dell’artista.<br />
Lorella Giudici
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:18 Pagina 15<br />
Architetto di sorprese
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:18 Pagina 16<br />
Testimonianza<br />
Testimonia nze, 1956<br />
cm 79x98
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:18 Pagina 17<br />
Impronta le, 1956<br />
cm 71x95
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:18 Pagina 18<br />
18_19<br />
Accumula zioni, 1968<br />
cm 70x100
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:18 Pagina 19<br />
Testimonia nze, 1966<br />
cm 100x80
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:18 Pagina 20<br />
20_21 Appropria zione, 1970<br />
cm 90x60<br />
Appropria zione, 1970<br />
cm 98x68
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:18 Pagina 21<br />
Ba na l Art, 1970<br />
cm 75x55
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:19 Pagina 22<br />
22_23<br />
Scultura neve, 1956<br />
cm 20x20x30<br />
Scultura neve, 1965<br />
cm 18x12x19
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:19 Pagina 23<br />
Scultura neve, 1965<br />
cm 13x19x18<br />
Scultura neve, 1965<br />
cm 17x16x16<br />
Scultura neve, 1965<br />
cm 52x49x60
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:19 Pagina 24<br />
24_25 Impronta le, 1956<br />
cm 28x43,5
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:19 Pagina 25<br />
Scultura neve, 1965<br />
cm 50x50x50
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:19 Pagina 26<br />
26_27<br />
Appropria zione, 1970<br />
cm 55x75
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:19 Pagina 27
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:19 Pagina 28<br />
3D
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:19 Pagina 29<br />
3D, 1956<br />
cm 129x112<br />
3D, 1956<br />
cm 87,5x57,5<br />
3D, 1956<br />
cm 128x88
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:19 Pagina 30<br />
Tableau Doré<br />
Ta blea u Doré, 1971<br />
cm 70x50
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:19 Pagina 31
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:19 Pagina 32<br />
Ta blea u Doré, 1981<br />
cm 100x60<br />
Ta blea u Doré, 1980<br />
cm 120x100
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:19 Pagina 33<br />
Ta blea u Doré, 1980<br />
cm 100x100
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:19 Pagina 34<br />
Ta blea u Doré, 1979<br />
cm 100x100
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:19 Pagina 35<br />
Ta blea u Doré, 1979<br />
cm 100x100
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:19 Pagina 36<br />
36_37<br />
Ta blea u Doré, 1972<br />
cm 120x100<br />
Ta blea u Doré, 1966<br />
cm 56x50
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:19 Pagina 37
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:19 Pagina 38<br />
38_39
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:19 Pagina 39<br />
Ta blea u Doré, 1958<br />
cm 61x50<br />
Impronta , 1967<br />
cm 90x60
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:19 Pagina 40
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:19 Pagina 41
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:19 Pagina 42<br />
Collage
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:19 Pagina 43<br />
Pa goda , 1959<br />
Collage su legno<br />
cm 35x2x10<br />
Colla ge, 1955<br />
cm 71x68
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:19 Pagina 44<br />
Colla ge a l gia rdino i ba mbini a ccendono i colori, 1985<br />
cm 70x50
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:19 Pagina 45<br />
Colla ge, 1959<br />
cm 73x103
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:19 Pagina 46<br />
46_47<br />
Colla ge, 1967<br />
cm 102x72
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:19 Pagina 47<br />
Colla ge, 1965<br />
cm 80x60
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:19 Pagina 48<br />
48_49<br />
Colla ge, 1972<br />
cm 98x70
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:19 Pagina 49<br />
Colla ge, 1974<br />
cm 68x68<br />
Colla ge, 1970<br />
cm 84x72
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:19 Pagina 50<br />
Colla ge, 1983<br />
cm 69x57
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:19 Pagina 51<br />
Pa goda , 1959<br />
cm 270x50x40
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:19 Pagina 52<br />
<strong>Arte</strong> elementare
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:19 Pagina 53<br />
<strong>Arte</strong> elementa re, 1972<br />
cm 80x80
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:19 Pagina 54<br />
54_55 <strong>Arte</strong> elementa re, 1970<br />
cm 100x55
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:19 Pagina 55
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:19 Pagina 56<br />
56_57 <strong>Arte</strong> elementa re, 1972<br />
cm 70x50
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:20 Pagina 57<br />
<strong>Arte</strong> elementa re, 1971<br />
cm 40x30
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:20 Pagina 58<br />
<strong>Arte</strong> elementa re, 1970<br />
cm 30x24
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:20 Pagina 60<br />
Remo Bia nco ta kes over his ca r covering it<br />
with sheets of gold lea f, 1986
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:20 Pagina 61<br />
Lyda Bianchi, sorella di Remo Bianco, noto pittore italiano, mi scrive:<br />
“Esaurita la lettura dell’articolo, ho constatato, con molto stupore ed altrettanta delusione, che in esso non vi è neppure un minimo cenno al<br />
contributo – da tutti unanimemente riconosciuto – fornito dall’opera del mio amato fratello, Remo Bianco, al movimento dello Spazialismo. A tal proposito<br />
basti ricordare, a titolo puramente esemplificativo, la sua personale tenutasi nell’autunno del 1952 giustappunto alla galleria Il Cavallino di<br />
Venezia, di Carlo Cardazzo ( da Lei più volte correttamente citata per aver supportato l’attività degli spazialisti), ovvero il soggiorno da lì a poco effettuato<br />
a New York da mio fratello per assorbire le nuove visioni artistiche del giovane Pollock”.<br />
Cara Lyda,<br />
mi consenta di chiederLe scusa per non aver nominato suo fratello Remo Bianco, fra l’altro da me conosciuto nel 1968 a Rho, alla galleria Il<br />
Portichetto di Guido Palmieri, in occasione di una personale dedicata alle sue tracce/pitture a foglia d’oro.<br />
Si dà il caso che questa mostra, di cui le invierò il catalogo a parte, si intitolasse : Lo Spazialismo e l’apporto veneziano, con ciò intendendo,<br />
per parte mia, uno sguardo tutto “localistico” inteso a dare risalto alla figura del grande Fontana.<br />
Ho osservato, inoltre, che i manifesti degli spazialisti – i primi quattro, che vanno dal 1950 al 1953 – non recano la firma di suo fratello, mentre<br />
ci sono quelle di tutti i veneziani.<br />
Ora, aver fatto una mostra da Cardazzo al Cavallino, in quegli anni, non voleva di certo dire essere spazialisti, anche perché, come sostenevano<br />
molti degli appartenenti al gruppo, lo Spazialismo fu un movimento che generò un atteggiamento culturale aperto, e non limitato ad adepti stretti in<br />
un regolamento fisso e settario. Quindi, chiunque poteva richiarmarsi allo Spazialismo senza effettivamente averne fatto parte. Si prenda a esempio il<br />
caso di Luciano Gaspari. Pertanto, nulla vieta che suo fratello fosse considerato spazialista dagli stessi appartenenti al gruppo, senza essere iscritto a<br />
nessuna corrente specifica, come lo furono molti, e fra questi, non a caso, faccio l’esempio dei “compagni di strada” quali Pancino, Caramel e Sergi.<br />
Così, lo stesso Scanavino espose con gli spazialisti alla Biennale del 1958, pur non avendo mai firmato alcun manifesto; mentre lo fece<br />
Capogrossi, che successivamente si orientò verso una sua personalissima rilettura dell’informale.<br />
Credo che Lei stessa abbia dato risposta all’operato di suo fratello quando ne ha intravisto gli interessi orientati all’informale compulsivo di Pollock.<br />
Alla mia età ho imparato che si può appartenere ad un’Idea senza peraltro fargli da chierico. Anzi, direi che preferisco suo fratello, che ha svolto<br />
ricerche in settori diversi, sperimentando strade nuove senza fossilizzarsi in un solo ambito, a quelli che, come alcuni degli spazialisti, hanno fatto il<br />
verso a se stessi sino alla fine delle loro rispettive carriere.<br />
Lei, Lyda, si dice convinta che saprò “riabilitarmi”; lo spero davvero, e se avrò l’occasione di incontrarLa a Milano spero di saperLe anche dire come.<br />
Suo cordialmente.<br />
2007 - Boris Brollo<br />
Da sinistra Mino Bendotti, Lyda Bianchi<br />
e Boris Brollo.
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:20 Pagina 62<br />
Regesto biografico 1<br />
Lorella Giudici<br />
1922<br />
Remo Bianchi (cambierà poi il cognome in Bianco) nasce a Milano. Il padre, Guido, era elettricista del teatro alla Scala. La madre, Giovanna Ripamonti, aveva<br />
studiato astrologia e impegnava le sue ore libere nella lettura dei tarocchi per tutte le donne del vicinato. Remo è il secondo di due gemelli, ma il fratello Romolo<br />
morirà un anno dopo. Prima di loro è nata la sorella Lyda, futura étoile della danza classica.<br />
1928<br />
La famiglia Bianchi abita in una delle case di ringhiera di via Giusti, il quartiere popolare nei pressi dell’arena, dove l’artista trascorrerà la giovinezza e dove avrà<br />
anche il suo primo studio.<br />
1934<br />
Dopo le elementari frequenta le scuole professionali e nel frattempo, per aiutare il magro bilancio famigliare, tenta vari mestieri: lavora come garzone in un negozio<br />
di pellicceria, diventa apprendista fabbro in un’officina vicina a casa e poi aiutante vetrinista alla Rinascente.<br />
1937<br />
S’iscrive ai corsi serali dell’Accademia di Brera. Legge Tolstoi, Turgebìnev, Dostoievsky.<br />
1939<br />
E’ alla scuola serale di Brera e una sera conosce De Pisis.<br />
1941<br />
Si arruola come puntatore mitragliere su un cacciatorpediniere. Due anni dopo la sua nave viene silurata e affondata. Recuperato dagli inglesi, è internato a<br />
Tunisi. E’ il primo contatto con l’oriente, con i colori e la luce del deserto, con i mosaici, le ceramiche policrome e le moschee. Ammalatosi di broncopolmonite<br />
viene rimandato in Italia. Trascorre la convalescenza a Sassuolo dove, nelle aule della scuola elementare, apre una scuola di disegno<br />
1944<br />
Congedato ritorna a Milano. Riprende i contatti con De Pisis.<br />
1945<br />
Dipinge oli dal sapore rouaultiano. Figure intere, primi piani o nature morte sono contornate da pesanti linee nere e dipinte con tonalità plumbee, sulfuree.<br />
1946<br />
Riprende a frequentare i corsi all’Accademia.<br />
1947<br />
Attraversa una forte crisi e per quasi un anno non tocca più pennello.<br />
1948<br />
L’attività artistica riprende con grande vitalità. Nelle opere figurative dimostra di aver meditato su Cézanne, ma soprattutto di aver appreso la lezione di Picasso.<br />
Accanto alle pitture figurative Bianco comincia i primi esperimenti tridimensionali. E’ di aprile la sua prima partecipazione a una mostra collettiva, a Villa Reale<br />
di Milano, per la “I Mostra Nazionale d’<strong>Arte</strong> <strong>Contemporanea</strong>” a cura di Enrico Somaré. A giugno data, invece, la sua prima personale, una mostra a due con<br />
Franco Sapi, alla galleria dell’Esagono.<br />
1950<br />
All’inizio degli anni cinquanta appartengano i primi lavori di pittura Spa zia le, che proseguono per tutti gli anni cinquanta.<br />
1951<br />
Alla fine dell’anno appaiono i primi Nucleari. Con questa definizione Bianco indica sia una serie di opere realizzate con smalti e colle, prima colati e poi rappresi<br />
in modo da creare suggestivi effetti erosivi, sia telai riempiti con un colore denso e materico, nel quale affoga oggetti di vario tipo, a formare curiose orogenesi<br />
e imprevedibili contrasti materici.<br />
1952<br />
A gennaio partecipa a una collettiva sul ritratto organizzata da Carlo Cardazzo nella sua galleria milanese (Il Naviglio), inaugurando un sodalizio che durerà tutta<br />
la vita (prima con lui e poi con il fratello Renato). Intanto continuano le opere Spa zia li, mentre con il ’52 abbandona i Nucleari, forse a causa della nitro e del<br />
benzolo che era costretto ad usare, ma che andavano ad infierire sui suoi polmoni già provati.<br />
1953<br />
A Villa Brugherio, dove va spesso a trovare l’amico De Pisis, Bianco conosce Virgilio Gianni, imprenditore milanese e collezionista, che da questo momento<br />
diviene il suo più grande sostenitore e moderno mecenate. Ad ottobre presenta per la prima volta i suoi 3D alla Galleria Montenapoleaone 6A di Milano. A scrivergli<br />
un pezzo sul depliant d’invito è nientemeno che Lucio Fontana.<br />
1954<br />
L’anno si apre con una mostra di opre tridimensionali alla Galleria del Naviglio di Milano. A presentarlo questa volta è Salvatore Quasimodo. Risalgono a questa<br />
data i primi Sa cchettini-Tesimonia nze.
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:20 Pagina 63<br />
1955<br />
E’ l’anno della svolta. Remo parte per l’America. In America soggiorna a New York, ma visita anche Chicago e la Florida. Vede per la prima volta una mostra di<br />
Burri, vede il lavoro di Donati, Marcarelli, Thomas Benton, di Franz Kline e, soprattutto, di Pollock. Al suo rientro Bianco si mette al lavoro sui Collage. Prima<br />
di rientrare, però, a giugno, espone le sue opere tridimensionali al Village Art Center di New York.<br />
1956<br />
Inizia il periodo dell’<strong>Arte</strong> Impronta le, di cui fanno parte anche i Sa cchetti. Contemporanei dei Collage sono gli Assembla ge, stoffe, carte o brandelli di abiti, a<br />
volte ricoperti di colature e pennellate di colore.<br />
1957<br />
Aun anno di distanza dall’inizio dei Collage, avvia i Ta blea ux dorés.<br />
1959<br />
Appartengono a questa data una serie di impronte umane: calchi in gesso a grandezza naturale del corpo nudo dell’artista, moderni sarcofaghi tridimensionali a<br />
testimonianza del suo passaggio terreno. Ma, soprattutto, comincia a pensare a quella che lui chiama <strong>Arte</strong> Chimica .<br />
1961<br />
Ralizza opere fatte di fumo e costruisce all’uopo camini di deperiana memoria (per forma e per colore), dai quali fa uscire colonne di nuvole colorate, che poi si<br />
mescolano e rarefanno direttamente nell’aria.<br />
1962<br />
Nel corso dell’anno Bianco tiene tre mostre: la prima a Palermo (Galleria d’<strong>Arte</strong> Flaccovio), con una presentazione di Giani, la seconda a Livorno (Galleria<br />
Modigliani) e la terza a Venezia, al Cavallino. Quest’ultima è accompagnata da uno scritto di Apollonio. In tutte e tre Bianco porta i Collage e i Ta blea ux.<br />
Questi ultimi colpiscono molto Raffaele Carrieri. A maggio si reca in Iran, dove è probabile che sia già stato l’anno precedente. A giugno esce la monografia,<br />
per le Edizioni del Cavallino, firmata da Alain Jouffroy.<br />
1964<br />
E’ l’anno del Primo ma nifesto dell’a rte chimica , ma è anche l’anno delle Sculture viventi.<br />
1965<br />
In febbraio è a Bourges e poi a Basilea, con Virgilio Gianni, che vuole ac<strong>qui</strong>stare delle opere di Mark Tobey. L’incontro tra i due artisti è memorabile, tanto che<br />
Tobey, dopo avergli regalato un disegno, qualche anno dopo (forse nel 1972) gli scriverà una bella lettera sui Ta blea ux, che Bianco utilizzerà come apertura del<br />
catalogo per una mostra alla Galleria Lara Vncy (1982). Nel corso dell’anno è a Carrara e nella terra del marmo raccoglie busti, santi o frammenti di statue dai<br />
lineamenti classicheggianti, in una doppia operazione di appropriazione e di sovrastruttura. E’ l’anno delle Sculture Neve. Prende vita il ciclo delle<br />
Appropriazioni.<br />
1969<br />
Tra la fine di quest’anno e l’inizio del successivo prende forma l’idea di un nuovo ciclo: l’<strong>Arte</strong> Elementa re.<br />
1972<br />
Sabato 16 settembre, al Teatro Angelicum di Milano viene messo in scena lo spettacolo Sa dico Mistico Elementa re, un’opera scritta da Remo Bianco, diretta e<br />
coreografata da Lyda Bianchi.<br />
1976<br />
I Quadri parlanti sono tra le esperienze più significative e originali (per i tempi) di Bianco. Inizialmente sono solo tele bianche o nere, a cui appone sul retro<br />
degli amplificatori vocali (che si attivano solo quando ci si avvicina), poi su queste tele Bianco fa imprimere la propria immagini o di altri suoi lavori. Il più noto<br />
è quello che chiama lo spettatore con la voce dell’artista (e impressa sulla superficie l’immagine di lui con il dito alzato e puntato, una fotografia che aveva utilizzato<br />
nel 1965 per reclamizzare una sua mostra al Naviglio e affissa su tutti i tram e i muri di Milano), il famoso Scusi signore.<br />
1982<br />
Bianco è malato, viene ricoverato all’ospedale di Trento e tra il letto e lo studio scrive la sua ultima Autobiografia, il tassello terminale di quella che lui chiama<br />
<strong>Arte</strong> a utobiogra fica . In molti passaggi è malinconico, amareggiato, prima di tutto dalla sua stessa incontenibile (e dispersiva) energia creativa e poi dall’indifferenza<br />
del mondo.<br />
1988<br />
Il 23 febbraio muore. Il bilancio della sua vita lo aveva già fatto qualche anno prima: “Sono stato felice, ho avuto una vita bellissima, una madre adorabile e affettuosa,<br />
molti amori, ho conosciuto presto la fortuna, ho avuto denaro, libertà e anche talento” (Giudici-Strinati 2006, op. cit, p. 183).<br />
1 Per una biografia completa si rimanda a quella pubblicata in L. Giudici-C. Strinati, Remo Bianco al di là dell’oro, Silvana, Milano 2006.
catalogo remo bianco:Layout 1 20/10/09 16:20 Pagina 64<br />
Remo Bianco’s studio in via G. Giusti, 5 Milan