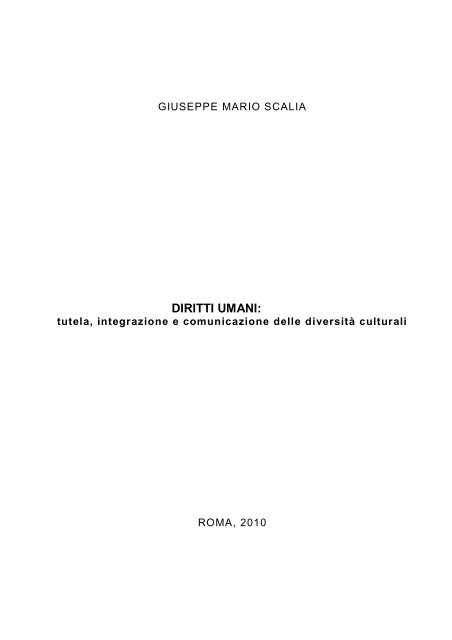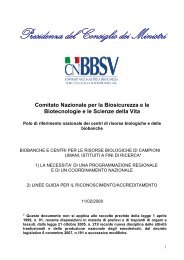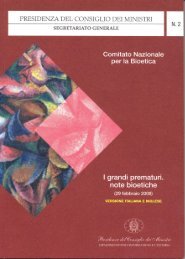DIRITTI UMANI: - Governo Italiano
DIRITTI UMANI: - Governo Italiano
DIRITTI UMANI: - Governo Italiano
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
GIUSEPPE MARIO SCALIA<br />
<strong>DIRITTI</strong> <strong>UMANI</strong>:<br />
tutela, integrazione e comunicazione delle diversità culturali<br />
ROMA, 2010
PRESENTAZIONE<br />
La cultura va accettata e salvaguardata, giacché la perdita di alcune delle<br />
sue componenti sarebbe una grave sconfitta per tutti, un impoverimento<br />
come se, ad esempio, sostituissimo le tessere di un mosaico, brillante, di<br />
grande contenuto espressivo ed artistico con una lastra monocolore sia<br />
pure di materiale preziosissimo.<br />
Da questa nuova consapevolezza ne deriva che l’Europa deve realizzare<br />
la sua vita e dialettica interna. Il primo punto è costituito dalla possibilità<br />
di un dialogo che, per definizione, si situa nell’incontro fra due o più linguaggi<br />
culturali diversi. Se usiamo il termine dialogo infatti, ricordando<br />
che, derivato dal greco “dialegomai” esso significa trascorrere, passare<br />
nel diverso, vale a dire: dialogare è collegare fra loro due eventi o realtà<br />
che necessitano di essere messe a confronto. Nel gioco misterioso del<br />
linguaggio, l’evento A acquisisce un po’ dell’evento B, del suo significato,<br />
della sua risonanza, del rimando a colori e a sapori diversi, a un nuovo<br />
modo di porgersi che coglie il suo essere più profondo e irripetibile, ma<br />
anche irrinunciabile.<br />
L’evento B a sua volta riceve del punto di vista A un po’ più di chiarezza,<br />
di lucidità su se stesso, dove si fanno avanti dubbi o almeno istanze critiche<br />
che scuotono la monolitica convinzione della sua propria superiorità.<br />
Nel dialogo non ci sono né vinti, gli immigrati, né vincitori, i popoli che li<br />
accolgono. Il senso patriarcale della famiglia, la fedeltà o il dubbio in ambito<br />
religioso, l’apertura e modalità dell’umano che le nostre società avanzate<br />
tendono a negare così come si ritraggono infastidite di fronte alla<br />
morte, al dolore o al sacrificio, sono elementi e valori collegati a uno sviluppo<br />
più arcaico di quello attuale. Nello stesso tempo gli immigrati devono<br />
prendere coscienza della differenza tra persone e ospiti, senza temere<br />
il problema di un nuovo valore assegnato alla persona.<br />
Assistiamo ad atroci fraintendimenti perché gli immigrati a volte non hanno<br />
interiorizzato il concetto di persona; valga per tutti l’esempio di una<br />
ragazza uccisa dal padre perché aveva acquisito un modello di vita troppo<br />
aperto e autonomo rispetto alla pesante autorità paterna.<br />
Dobbiamo dire che si devono porre in atto comportamenti, strategie, forme<br />
che possono operare la mediazione fra diverse tradizioni, soprattutto<br />
in campo morale: le più delicate. È infatti la tradizione che ci permette di<br />
comprendere il significato così come si presenta al soggetto, di cogliere<br />
la distorsione a cui esso è sottoposto e in qual misura si possa dire che la<br />
conoscenza è oggettiva oppure soggettivamente filtrata.<br />
Gli studiosi Karl Otto Apel e Jürgen Habermas hanno avanzato la pretesa<br />
critica di delineare un momento di espressione oggettiva dell’attività umana,<br />
di individuare che cosa c’è alla base di questa attività che cambia di<br />
direzione e si chiedono quale sia il significato contenuto nelle oggettivazioni<br />
di tale agire.<br />
Il sociologo è in grado di analizzare le intenzioni che stanno alla base delle<br />
oggettivazioni prodotte. Gli specialisti del mondo sociale possono riuscire<br />
a mostrare agli operatori sociali i motivi, le cause per cui ciò che si<br />
pensa potrebbe essere errato, potrebbe costituire un sistema di copertura<br />
di interessi che non vengono alla luce.<br />
L’insistenza sulla mediazione fra le diverse tradizioni diviene ancor più<br />
precisa se esaminata per mezzo degli strumenti propri dei progetti che<br />
I
segnano le diverse modalità culturali delle minoranze, in particolare del<br />
linguaggio.<br />
Lo studio del linguaggio parlato dalle minoranze linguistiche costituisce<br />
un primo importante punto, unito successivamente al carattere<br />
dell’espressione artistica, espressione tipica delle comunità minoritarie,<br />
soprattutto a livello giovanile. Quanto più sarà utile ogni altra iniziativa o<br />
attività che consenta di attuare nella società civile, quei principi di uguaglianza<br />
che favoriscono la formazione di una identità sicura. È importantissimo<br />
mantenere il rispetto da entrambe le parti che compiono delle<br />
scelte. Il filosofo Gadamer, nel nostro secolo ha rivalutato l’esperienza<br />
del linguaggio, dove le domande della ricerca sono: “E’ sempre possibile<br />
comprendere come si produce comprensione o come si produca verità?”<br />
Altrettanto condizionante la domanda strategica di Habermas: “Come e<br />
perché si produce una comunicazione distorta? Come e perché si producano<br />
errore e dominio?”<br />
La vita è il mondo dell’esperienza comune, quello in cui le cose e le persone<br />
si offrono nella loro presenza immediatamente intuibile. Si tratta<br />
cioè della presenza della vita non solo come ambiente naturale, ma anche<br />
come ambiente storico-culturale, il mondo sociale in cui vengono innanzi<br />
forme di vita già elaborate, culturalmente già preformate. Si tratta di un<br />
mondo storico; è il flusso in cui si trovano diverse comunità e gruppi che<br />
elaborano le loro credenze, relative e proprie di ogni comunità così come<br />
di ogni individuo che vive e appartiene alla propria comunità storica. Dialogare<br />
in questo ambito è veramente mettere in atto una forma nuova di<br />
linguaggio.<br />
Si deve tenere, altresì, presente che è necessaria un’attenzione ancora<br />
più consapevole e approfondita dei problemi che il multiculturalismo presenta.<br />
Direi che oggi non è il problema centrale il multiculturalismo, ma<br />
problema centrale è il discorso sull’identità, dove i giovani faticano ad<br />
emanciparsi dalla famiglia d’origine, a costruirsi una identità forte attraverso<br />
mezzi autonomi e si trovano sprovveduti di fronte ad una società<br />
che richiede mezzi ben più onerosi per garantirsi un’esistenza decorosa.<br />
Nella pratica scolastica ciò si traduce in una ripresa consapevole di tutte<br />
quelle culture che, anche quelle su cui lo Stato ha esteso la tutela prevista<br />
dall’art. 6 della Costituzione, possano aiutare i giovani ad una emancipazione<br />
e ad un inserimento nel sociale.<br />
Il legislatore ha sempre posto un’attenzione sul territorio nazionale, elaborando<br />
una serie di facilitazioni che permettano ai gruppi di partecipare,<br />
ad un tempo, agli stessi valori, agli interessi, alle memorie individuali e<br />
collettive comuni ed ai riferimenti giuridico-istituzionali.<br />
Gli alunni stranieri in un contesto del genere, così pianificato, possono<br />
partecipare ad una integrazione fondata sul “dialogo interculturale e la<br />
convivenza democratica”, dove la scuola italiana sembra ormai fare proprio<br />
il principio della strutturazione dei gruppi sociali sia nel contesto nazionale,<br />
sia anche proiettandosi nella prospettiva europea e successivamente<br />
mondiale.<br />
Nello stesso tempo non sarebbe possibile pensare che l’apporto degli immigrati<br />
ponesse in discussione le strutture e le idealità europee nei loro<br />
valori più alti, di rispetto della persona e delle istituzioni. L’esercizio<br />
dell’agire democratico, non a caso stratificato fin dall’educazione classica<br />
greca, in opere che furono alla base di una mentalità dove – se pensiamo<br />
II
alla Repubblica di Platone – lo Stato si presenta come palestra dell’uomo<br />
politico: nello Schiavo di Menone appare l’uomo come fonte di razionalità<br />
argomentante e capace di cogliere il vero matematico.<br />
Nella grandezza della riflessione storica greca – si pensi al capolavoro di<br />
Tucidide “La guerra del Peloponneso” – dove è descritto e analizzato il<br />
comportamento dell’essere umano in tempi di crisi e di difficoltà. L’analisi<br />
della peste ad Atene è rimasta a modello di tutte le situazioni similari,<br />
passando da Boccaccio a Camus. Se questo è il quadro forte ed incisivo<br />
della individuazione dei temi, propri di una imperitura grandezza<br />
dell’umanità accanto pur sempre al rischio della sua caduta, non possiamo<br />
dimenticare la presenza costruttiva dell’Illuminismo che ci fa rabbrividire<br />
di fronte alla cultura attuale di alcune minoranze etniche che non rispettano<br />
né colgono in modo equilibrato la figura della donna, soggetto di<br />
diritti e doveri, persona umana che deve costituirsi in una parità assoluta<br />
con il genere maschile.<br />
Sottolineato quindi, il valore imprescindibile di tutti gli esseri umani, il lavoro<br />
che qui introduciamo sa recuperare criticamente il tema delle minoranze,<br />
ma non tradendole con una demagogia facile. Le minoranze per<br />
potersi guadagnare l’appartenenza al gruppo sociale devono giustificare<br />
sé stesse rispettando la legge dello Stato e i doveri del momento storico<br />
in cui essi vivono.<br />
Il volume si presenta come un utilissimo strumento di indagine e, mi si<br />
permetta, anche come un commovente appello ad un sentire alto e nobile,<br />
in cui riecheggiano echi dell’ambiente che ha prodotto Dante Alighieri fino<br />
agli estensori della preziosa Carta Costituzionale Italiana.<br />
III<br />
Sen. Francesco Rutelli<br />
Senatore della Repubblica
PREMESSA<br />
Una delle costanti che ha caratterizzato il lungo processo di costruzione dell’Unione europea<br />
è l’attenzione che, in relazione alla contiguità dei confini dei singoli Stati, è stata posta alla<br />
condizione delle minoranze etniche.<br />
La riflessione su questo tema, intensificatasi in modo particolare nell’ultimo ventennio, si<br />
è concretizzata nell’elaborazione, sia in ambito CEE e, poi UE, che nel più vasto contesto della<br />
CSCE (ora OSCE) e, più di recente nel quadro della ICE, di una serie di direttive, raccomandazioni<br />
e progetti di convenzioni (o carte) europee dei diritti delle minoranze. Sembra, ora, essere<br />
giunta ad una fase di grande maturità, dato che la presa di coscienza del valore della multiculturalità<br />
tende a tradursi in norme e comportamenti che tutelano tale peculiarità: ciò segna in molte<br />
realtà una vera e propria inversione di tendenza nei confronti delle politiche tendenzialmente<br />
omologatrici.<br />
Occorre promuovere la consapevolezza che la struttura estremamente composita della<br />
società europea è un grande patrimonio comune. Esso, nella dialettica delle sue componenti,<br />
alimenta una vitalità culturale ineguagliabile. Come tale, essa va accettata e salvaguardata,<br />
giacché la perdita di alcune delle sue componenti, lungi dall’essere una vittoria per le culture<br />
maggioritarie, sarebbe una grave sconfitta per tutti, allo stesso modo come sostituendo le tessere<br />
di un mosaico con una lastra monocolore, sia pure di materiale preziosissimo, si farebbe<br />
scempio del suo contenuto espressivo ed artistico.<br />
Occorre vigilare e dotarsi di strumenti tali da impedire che alcune tragiche esperienze del<br />
passato più o meno recente abbiano a ripetersi.<br />
In questa prospettiva, l’impegno di ogni Stato dovrebbe essere quello di promuovere e<br />
realizzare una serie di iniziative concrete a sostegno dell’identità culturale ed etnica di tutte le<br />
comunità minoritarie presenti sul suo territorio. Tali azioni vanno mirate, tra l’altro, alla promozione<br />
della conoscenza reciproca delle culture di minoranza tra loro e di queste con la maggioritaria,<br />
in un rapporto non più gerarchico di subalternità/dominanza, ma paritetico ed inteso come<br />
interesse reciproco.<br />
Funzionali a tale scopo sarebbero progetti che consentano:<br />
a) lo sviluppo e la diffusione delle scuole di madre-lingua presso ogni comunità, nonché di programmi<br />
di studio e di ricerca sulla cultura delle minoranze;<br />
b) il sostegno e la promozione dell’arte nelle forme ed espressioni tipiche di ciascuna comunità;<br />
c) gli scambi culturali tra diverse comunità minoritarie, soprattutto a livello giovanile;<br />
d) ogni altra iniziativa o attività che consenta l’attuazione quanto più completa possibile dei<br />
principi di uguaglianza tra tutti i cittadini sanciti da ciascuna delle Carte Costituzionali dei<br />
singoli Stati e dalle diverse Convenzioni internazionali;<br />
e) l’attivazione di tutti gli strumenti indicati a salvaguardia dei diritti delle minoranze.<br />
Tali iniziative dovrebbero mirare alla costruzione di ponti di collegamento e di scambio<br />
reciproco tra le varie ‘isole’ che costituiscono quel variegato arcipelago linguistico e culturale<br />
che è l’Europa.<br />
In questo contesto, l’identità culturale di ciascuna comunità deve essere vista in un rapporto<br />
dialettico con tutte le altre componenti della realtà, come strumento, quindi, di apertura<br />
verso le altre culture, maggioritarie o minoritarie che siano, e di fecondo confronto con esse,<br />
senza perdita della propria peculiarità creativa.<br />
Ancora una volta va affermato che, se non si riesce a salvaguardare – anche attraverso<br />
semplici momenti di discussione – il valore della “diversità”, una parte dell’umanità ne riceverà<br />
un danno: il danno che ne viene dal non rispetto di una parte della stessa.<br />
Prof.Giuseppe Vedovato<br />
PROFESSORE EMERITO DI RELAZIONI INTERNAZIONALI ALLA “SAPIENZA” IN ROMA,<br />
GIA’ DEPUTATO E SENATORE DELLA REPUBBLICA ITALIANA<br />
PRESIDENTE ONORARIO DELL’ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D’EUROPA<br />
1
INTRODUZIONE<br />
Uno dei fenomeni più macroscopici che ha investito la società italiana contemporanea è<br />
costituito certamente dalla crescita costante, soprattutto nell’ultimo decennio, del numero degli<br />
immigrati; esso pone una serie di problemi ai diversi livelli istituzionali, risolvibili mediante opportuni<br />
interventi legislativi mirati ed attraverso una serie di iniziative e interventi di carattere gestionale<br />
altrettanto puntuali, ma non necessariamente legati, almeno allo stato attuale, ad una<br />
specifica attività legislativa.<br />
La consistenza del numero degli immigrati ed, in particolare, la consistenza di alcuni<br />
gruppi caratterizzati dall’unitarietà della provenienza e, conseguentemente, dall’omogeneità culturale,<br />
fa sì che, soprattutto in alcune zone, la società italiana dei nostri giorni vada definendosi<br />
sempre più come una società multiculturale, caratterizzata cioè dalla coesistenza di popolazioni<br />
di diversa origine, cultura e, spesso, religione, con le quali la componente autoctona, ancorché<br />
ampiamente maggioritaria, deve tuttavia quotidianamente confrontarsi.<br />
Va, tuttavia, sottolineato che nel nostro Paese la multiculturalità non è un fenomeno<br />
nuovo.<br />
Nonostante che a livello di opinione pubblica se ne sia presa coscienza solo in tempi relativamente<br />
recenti, la società italiana è costituita, praticamente ab inizio, da una pluralità di<br />
soggetti etnicamente e culturalmente diversi che, prima e dopo l’Unità, hanno convissuto in<br />
rapporto più o meno dialettico tra loro, all’ombra dell’elemento “italiano” dominante, senza mai<br />
esserne completamente soffocati. Anzi, essi sono riusciti a svilupparsi, in alcuni casi, e, nonostante<br />
la mancanza quasi totale, fino a tempi recenti, di istituzioni educative specifiche, a dimostrare<br />
una grande vitalità culturale, con produzioni letterarie di grande rilievo.<br />
È evidente che non si vuole, qui, accennare alle realtà regionali, o, più genericamente<br />
locali, anche abbastanza diversificate che, ad un secolo dall’unificazione, continuano positivamente<br />
a caratterizzare il nostro Paese, quanto piuttosto a quelle popolazioni autoctone o di antica<br />
immigrazione, che vengono correttamente raggruppate sotto la denominazione di “minoranze<br />
linguistiche”.<br />
Tra i Paesi dell’Unione europea, l’Italia è il paese che registra sul suo territorio il più alto<br />
numero di minoranze linguistiche.<br />
Secondo un recente rapporto del Ministero dell’Interno, sono presenti sul territorio italiano<br />
sedici minoranze linguistiche.<br />
A tali popolazioni si riferisce l’art. 6 della Costituzione italiana, che recita: “La Repubblica<br />
tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”.<br />
Si tratta di un’enunciazione di principio che, per il fatto di essere stata posta tra quelli<br />
fondamentali della Carta fondamentale, assume rilevanza particolare: testimonia della profonda<br />
consapevolezza che, già alla fondazione dell’Italia repubblicana, i Costituenti avevano della<br />
struttura multiculturale della società italiana.<br />
Tale articolo ha trovato applicazione totale con l’approvazione della legge – quadro 15<br />
dicembre 1999 n. 482, recante “Norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche”.<br />
In ambito scolastico, anche in seguito al dibattito avviato negli ultimi decenni proprio sulla<br />
necessità di estendere l’applicazione dell’art. 6 della Costituzione a tutte le minoranze linguistiche<br />
esistenti sul territorio della Repubblica, è andato progressivamente costituendosi, attraverso<br />
una serie di provvedimenti (si ricordano, per tutti, le possibilità offerte dall’applicazione dei<br />
cosiddetti “decreti delegati”) e circolari ministeriali, nonché attraverso la definizione dei nuovi<br />
programmi della scuola dell’obbligo, un’apertura che trova la sua massima espressione in una<br />
pronuncia del Consiglio nazionale della pubblica istruzione del 15.6.1993, che rileva:<br />
“(...) sarebbe quanto meno assurdo se la scuola italiana, su tutto il territorio nazionale,<br />
si impegnasse a studiare capire, considerare usi, costumi, storie, spiritualità assai remote dalla<br />
nostra, e non realtà straordinariamente più vicine, ricche di elementi di grande affinità, compartecipi<br />
da tempo di valori, interessi, riferimenti giuridico-istituzionali, memorie individuali e collettive<br />
comuni, come, appunto, la realtà delle minoranze linguistiche (...)“.<br />
Come risulta anche da una circolare del Ministero dell’Istruzione (n. 73 del 2 marzo<br />
1994), che pone all’attenzione di tutti gli organismi competenti sul territorio nazionale un documento,<br />
elaborato dal gruppo interdirezionale di lavoro per l’educazione interculturale e<br />
l’integrazione degli alunni stranieri dal titolo “Il dialogo interculturale e la convivenza democratica”,<br />
la scuola italiana sembra ormai fare proprio il principio della strutturazione multiculturale<br />
3
della società, sia nel contesto nazionale sia anche proiettandolo nella prospettiva europea e,<br />
successivamente mondiale.<br />
Il riconoscimento della strutturazione multiculturale della società italiana ha come diretta<br />
conseguenza la fine dell’assunto dogmatico proprio, fino a tempi recenti, anche della scuola<br />
dell’omogeneità linguistica, culturale ed etnica dell’Italia.<br />
Ciò si traduce, nella pratica scolastica, nella fine dell’emarginazione delle culture “altre”,<br />
anche di quelle di cui lo Stato ha esteso la tutela prevista dall’art. 6 della Costituzione.<br />
Il nuovo progetto educativo che la scuola italiana fa proprio si propone, infatti, come obiettivo<br />
il rispetto dell’alterità culturale, nel quadro di un positivo confronto tra culture che, da un<br />
lato, siano la base di un processo di integrazione sociale che non implichi necessariamente<br />
l’omologazione culturale, e siano, dall’altro, fattore di crescita per l’elemento culturale dominante,<br />
attraverso il confronto dialettico con gli elementi “altri”.<br />
Queste riflessioni introduttive hanno ispirato il documento, che intende per ciò stesso<br />
configurarsi come un commentario sistematico di tutti quei strumenti di livello internazionale<br />
(carte, convenzioni etc.) elaborati per assicurare una dignità sostanziale alle minoranze.<br />
Esso contiene, altresì alcuni saggi di vario tipo riguardanti la ricchezza del patrimonio<br />
culturale prodotto dalle minoranze, nonché alcuni temi sull’integrazione.<br />
L’appendice estremamente ricca comprende le disposizioni sulla non discriminazione e<br />
sugli aspetti della comunicazione.<br />
Tabelle e dati statistici sulle minoranze in Europa e in Italia completano l’opera.<br />
Di ciò occorre dare una testimonianza. Anche per questo il volume – per la struttura e<br />
per i contenuti – si raccomanda come testo che può formare oggetto di dibattito per i giovani,<br />
con particolare riferimento all’ambito scolastico.<br />
Educare alla pace, educare alla tolleranza, significa anche mettere a disposizione del<br />
giovane i materiali che possono essere usati per costruire ragionamenti, per impostare strategie<br />
di comprensione reciproca, per valutare la realtà come complessità.<br />
Al termine di questa breve introduzione, non posso non esprimere il mio più vivo apprezzamento<br />
all’autore per il competente impegno, per la professionalità e per l’apprezzabile<br />
sforzo di analisi che hanno consentito un sostanziale approfondimento delle tematiche affrontate<br />
in questo documento di studio.<br />
4<br />
Prof. Christoph Pan<br />
Direttore dell’Istituto dei Gruppi Etnici di Bolzano
I CONCETTI - BASE<br />
5
LA LINGUA<br />
La lingua può essere definita come lo specchio della cultura di un popolo.<br />
In sintesi, può essere considerata il simbolo dell'identità etnica e culturale. Ad esempio,<br />
prendendo in esame la cultura dei Greci, notiamo come la lingua è ricca di vocaboli, con moltissime<br />
sfumature diverse, cui corrisponde un mondo filosofico tra i più spirituali dell'area occidentale.<br />
Quello latino, diversamente, essendo più sensibile al discorso immediato, materialistico,<br />
corrisponde ad una lingua che ha meno termini e non si perde in tante sfumature.<br />
L'italiano, a sua volta, è una lingua che è frutto di una evoluzione artificiale, in quanto è<br />
il prodotto di un ceto intellettuale.<br />
In J. Burckhardt, "al sommo di ogni cultura sta il miracolo intellettuale: le lingue, l'intimo<br />
e irreversibile impulso dello spirito a esprimere con parole il pensiero. Esse sono la più specifica<br />
manifestazione dello spirito dei popoli. Arte e poesia sono l'unica manifestazione terrena durevole.<br />
La poesia crea nuove realtà e giova più della storia alla conoscenza della natura dell'umanità.<br />
La storia trova nella poesia una delle sue fonti più importanti e spesso è l'unica cosa che<br />
se ne è conservata" 1 .<br />
La lingua non è solo un mezzo per comunicare, ma riflette un modo di ragionare, cioè la<br />
struttura mentale, di un popolo; essa, educando l'anima, ne delinea le peculiarità.<br />
A tal riguardo c’è chi ha sottolineato la particolare situazione in cui si vengono a ritrovare<br />
le genti d’Europa: “Cittadini di una terra multiforme, gli Europei non possono che essere in<br />
ascolto del grido polifonico delle lingue umane.<br />
L’attenzione all’altro che parla la propria lingua è preliminare se si vuole costruire una<br />
solidarietà che abbia un contenuto più concreto dei discorsi propagandistici” 2 .<br />
E ciò in considerazione del fatto che “ogni lingua costituisce un certo modello<br />
dell’universo, un sistema semiotico di comprensione del mondo, e se abbiamo 4.000 modi diversi<br />
di descrivere il mondo, questo ci rende più ricchi. Dovremmo preoccuparci della preservazione<br />
delle lingue così come ci preoccupiamo dell’ecologia” 3<br />
1 J. Burckhardt, Considerazioni sulla storia universale, cap. 2 (Sulle tre potenze).<br />
2 Claude Hagège, Le souffle de la langue, Odile Jacob, 1992, pag. 273.<br />
3 Vjacelav V. Ivanov, Reconstructing the Past, in “Intercom” (University of California, Los Angeles),<br />
1992, pag. 4.<br />
7
LA CULTURA<br />
"La cultura è intesa come la somma complessiva di quelle manifestazioni dello spirito<br />
che avvengono spontaneamente e non rivendicano a sé nessuna validità universale e coercitiva.<br />
Ha un'azione costantemente modificatrice e disgregatrice sull'istituzione Stato e sull'istituzione<br />
Religione” 4 .<br />
Jacques Maritain ha proposto, tuttavia, questa definizione della cultura: "... la cultura, o<br />
la civiltà, consiste nell'espansione della vita propriamente umana, comprendente non solo lo<br />
sviluppo materiale necessario e sufficiente per permetterci di condurre un'esistenza retta quaggiù,<br />
ma anche e soprattutto quello sviluppo morale, quello sviluppo delle attività speculative e<br />
delle attività pratiche (artistiche ed etiche) che merita di essere propriamente chiamato uno sviluppo<br />
umano" 5 .<br />
Ma quale rapporto c'è tra la "cultura" e l'uomo?<br />
Si può immaginare la cultura come una specie di entità sociale a sé stante, diversa dall'individuo?<br />
Certamente no.<br />
La cultura non è una realtà oggettiva, indipendente dagli individui.<br />
Certo, la cultura di un popolo o di un'epoca contiene di più che non quella di un individuo<br />
determinato; e tuttavia la cultura non è nulla se non è vissuta dagli uomini come persone,<br />
come collettività.<br />
In altri termini, possiamo parlare di cultura solo nella misura in cui gli uomini, nel loro agire<br />
e nell'esercizio del pensiero o del lavoro, acquistano una familiarità, una sicurezza, una<br />
nuova spontaneità, che li inclinano verso i beni della cultura, in modo tale che questi beni si<br />
presentino a loro come propri beni, nei quali essi si riconoscono e coi quali si trovano ad avere<br />
un legame di parentela.<br />
La cultura è viva se la verità e i valori di cui essa è essenzialmente costituita sono elementi<br />
vitali della persona, cioè se essa è vissuta nella quotidianità di ognuno.<br />
Molto spesso la cultura si concreta nella conservazione delle cose belle, della natura,<br />
del paesaggio.<br />
a. La difficile ricerca degli eventi “culturali”<br />
Nella società contemporanea è assai facile - mancando un tempo dedicato espressamente<br />
allo sviluppo della intelligenza individuale, del sapere, mentre molto tempo ciascuno dedica<br />
al proprio corpo - che alcuni fatti ci vengano propinati sotto l'etichetta di "cultura". Il più delle<br />
volte essi sono "pseudocultura".<br />
Ci accorgiamo che questo mondo artificiale, che si è andato umanamente mettendo insieme,<br />
ci ha imposto dei ritmi, oltre che dei canali e dei sistemi di distribuzione, che sono molto<br />
pericolosi: queste macchine, che chiamiamo le città, dove siamo costretti a vivere come polli in<br />
batteria, questa sopravvivenza meccanizzata, dove chiunque potrebbe da un momento all'altro,<br />
chiudendo una valvola, sopprimere tutti, dove all'uomo - come singolo - è tolta ogni possibilità di<br />
iniziativa.<br />
Noi abbiamo molti diritti sulla carta, e li proclamiamo; di fatto siamo privati di ogni potere.<br />
Di questa oppressione materiale non è difficile accorgersi, ma, parallelamente, esiste<br />
una oppressione spirituale di cui forse non ci accorgiamo per nulla.<br />
Tutti hanno diritto al sapere, ma i mezzi per farlo crescere, i tempi perché esso si configuri<br />
sono quelli che sono.<br />
b. La cultura non è costituita solo dalla scienza<br />
A seguito di pregiudizi radicati da secoli nella nostra cultura moderna siamo convinti<br />
(nulla di più falso!) che ci sia un unico sapere possibile: quello esente da ogni metafisica, e che<br />
4 J. Burckhardt, op. cit., v. nota 1.<br />
5 "Cultura e istituzioni per la cultura”, a cura dell'Istituto "Max Weber", Roma, 1995.<br />
8
nell'ordine di tale sapere ci sia un solo tipo di conoscenza incrollabile autenticamente capace di<br />
prove: la scienza, la scienza matematica, la scienza dei fenomeni della natura....<br />
Un fatto è da tutti riconosciuto: "la società in quanto tale non ha nulla da dirci sui problemi<br />
che maggiormente ci preoccupano e sulla concezione del mondo dell'uomo e forse di<br />
Dio... tutto ciò rimane del tutto al di fuori del dominio della scienza..." (J. Maritain).<br />
Riflettiamo sui richiami molto pertinenti che fa la scrittrice Serena Foglia nel suo libro<br />
"Mille e ancora mille": Moltmann sottolinea il fatto che "le scienze e la futurologia ci mettono a<br />
disposizione una varietà di possibili e pianificabili futuri, ma abbiamo noi una qualche rappresentazione<br />
di un futuro desiderabile? (...). La ragione umana deve di nuovo farsi creativa e noi<br />
dobbiamo elaborare progetti di un futuro desiderabile" (da "L'esperimento speranza", Queriniana,<br />
Brescia, 1976, pag. 41).<br />
Perché ciò avvenga - egli dice - bisogna sviluppare una teologia della speranza che,<br />
fondata sulla storia biblica e orientata verso il regno promesso, sia "in grado di far svolgere alla<br />
speranza cristiana il suo ruolo di responsabilità nelle rivolte e nelle repressioni dell'epoca moderna".<br />
"Guardando alla realtà contemporanea Moltmann non può esimersi dal sottolinearne gli<br />
aspetti negativi: la società tecnocratica, essendo strutturata secondo il modello del sistema<br />
chiuso, tesse intorno all'uomo una rete sempre più fitta di condizionamenti. Diventa perciò sempre<br />
più difficile conservare negli uomini la speranza, ... l'entusiasmo ... nel progresso della tecnica,<br />
sorretto dall'industrializzazione e dalla fiducia che si potesse costruire il Regno dell'Uomo,<br />
si è dissipato lasciando il posto alla tristezza apocalittica, alla nostalgia romantica del passato,<br />
alla fuga dal mondo predicata dai figli dei fiori e tragicamente diffusa dalla droga, ..." (op. cit.,<br />
pag. 58).<br />
E poiché "su nessuna carta geografica c'è il paese di Utopia dove scorre latte e miele, o<br />
dove pace e giustizia si baciano e in nessun angolo della Terra esiste il nuovo mondo, dove<br />
volgere lo sguardo, dove emigrare?”<br />
Quante volte l'Utopia, però, ha cercato di cambiare, di recente, il corso della cultura<br />
umana? Tutte le volte che nasce e si afferma nelle coscienze dei singoli la convinzione che<br />
l'Assoluto (che è la voglia dell'Eden) si può realizzare con facilità su questa Terra e gli uomini<br />
senza cultura sono indotti, purtroppo, a seguire facilmente ciò che dicono i falsi profeti (S. Foglia).<br />
Piero Citati ricorda come "il consumismo sia soltanto uno dei tanti esempi di ricerca dell'Assoluto<br />
che la storia incessantemente ci propone; il più recente, quello i cui effetti devastanti<br />
e il cui sanguinoso terrore sono ancora ben presenti alla memoria dei contemporanei".<br />
Piero Citati indica chi può svolgere la funzione di anticorpo, di antidoto "per impedire,<br />
rallentare, contenere le devastazioni che derivano dall'inverarsi dell'Utopia"; egli ne elenca alcuni:<br />
"I liberali o gli artisti o i filosofi o gli osservatori disinteressati, tutti coloro che scrivono pensieri<br />
puri, che l'utilità non contamina .... Chi investe nella storia delle mete assolute finisce per<br />
non capirle. Per capire ciò che è accaduto, ciò che accade o sta per accadere, bisogna conservare<br />
nella mente una specie di distanza ironica, uno specchio lucido e disinteressato, che permette<br />
agli scienziati di riflettersi senza venire offuscati".<br />
c. La cultura insegna ad essere tolleranti e disponibili al colloquio<br />
La cultura senza libertà non ha mai prodotto menti libere e di ampie vedute; però, può<br />
produrre astuti avvocati (Stuart Mill).<br />
La società, intesa come insieme di persone che condividono valori e comportamenti,<br />
non può permettersi di mandare al potere astuti avvocati. Essa deve essere rappresentata da<br />
persone colte, cioè capaci di modificare il loro giudizio quando la realtà da governare lo richieda,<br />
ma devono avere appreso dalla cultura che occorre essere tolleranti e disponibili al colloquio.<br />
Se c'è mancanza di tolleranza e di disponibilità al colloquio si può essere certi che chi è<br />
al potere, prima o poi, è destinato a cadere, in quanto altri avranno smascherato la loro corruzione,<br />
o semplicemente la loro intolleranza.<br />
L’intolleranza e l'indisponibilità al colloquio, a ben rifletterci, sono caratteri propri dei regimi<br />
totalitari.<br />
9
La storia, comunque, ci insegna che i regimi totalitari - preoccupati soltanto di perpetuare<br />
se stessi - non tollerano le critiche; e siccome la critica proviene da chi ragiona degli avvenimenti<br />
e delle cause che le hanno prodotte (la c.d. "opposizione"), il regime totalitario (sia esso di<br />
sinistra o di destra) si orienta per sua natura a soffocare il dissenso.<br />
Una società in cui non sia data la possibilità al dissenso di manifestarsi non è in grado<br />
di salvare la cultura, né tantomeno di accrescerla.<br />
d. La cultura evita la creazione del radicamento dei dogmatismi. Il dogmatismo riduce<br />
la percezione dei fondamentali valori umani<br />
Stuart Mill, nel suo saggio "Della libertà di pensiero e di discussione" (1859) formula<br />
questa considerazione che possiamo condividere: "Qual è, ..., la ragione per cui, complessivamente,<br />
nell'umanità esiste una prevalenza di opinioni razionali e comportamenti razionali?”<br />
Se questa prevalenza esiste veramente - e dove esiste, altrimenti le relazioni umane<br />
sarebbero, e sarebbero sempre state, in condizioni quasi disperate - ciò è dovuto ad una qualità<br />
della mente umana, fonte di tutto ciò che di rispettabile è nell'uomo come essere sia intellettuale<br />
sia morale, vale a dire la facoltà di correggere i propri errori.<br />
Continuando nel suo ragionamento Mill ci avverte: "L'uomo è capace di rettificare i propri<br />
sbagli, attraverso la discussione e l'esperienza. Non attraverso la sola esperienza. La discussione<br />
è necessaria, per mostrare come l'esperienza deve essere interpretata".<br />
In effetti, è vero che "pratiche ed opinioni sbagliate cedono gratuitamente il passo a fatti<br />
e argomenti; ma non bisogna mai dimenticare che fatti e argomenti, per produrre un qualsiasi<br />
effetto sulla mente, devono essere portati al suo cospetto”.<br />
Se occorre riconoscere che "pochissimi fatti possono raccontare la loro storia, senza<br />
commenti che ne chiariscano il significato", c'è un metodo perché il giudizio dell'individuo, fin da<br />
piccolo, sia posto nella condizione per discernere ciò che è bene da ciò che è male: il metodo è<br />
quello di tenere costantemente presenti tutti i mezzi per correggerlo.<br />
Chi ha il compito di insegnare alla persona umana in evoluzione i mezzi che hanno la<br />
capacità di modificare il suo giudizio su un fatto, su un individuo?<br />
Il compito è di chi, in quanto appartenente a una generazione, ci ha preceduto: il padre<br />
e la madre, il maestro e, poi, gli insegnanti, il docente universitario, il datore di lavoro o il maestro-artigiano,<br />
....<br />
I luoghi della discussione, a seconda dei casi, sono - congiuntamente o disgiuntamente<br />
sotto il profilo del tempo - la propria casa, la propria scuola, l'aula universitaria, la stanza del<br />
proprio ufficio ....<br />
La nostra società, quindi, ha destinato una parte della propria ricchezza per rendere fisicamente<br />
possibile questa esigenza di confronto tra chi più sa, cioè chi è più colto, e chi meno<br />
sa, e, quindi, ha il dovere di apprendere.<br />
Si costruiscono a tale scopo gli edifici scolastici, i campus universitari, le biblioteche, i<br />
musei ....<br />
Tutti questi luoghi sono destinati, ogni giorno, a consentire la trasmissione della cultura,<br />
il suo perfezionamento, la sua evoluzione.<br />
e. La cultura è frutto dei tempi. L'identificazione della cultura come civiltà<br />
Ogni epoca storica, così come ogni complesso umano, producono cultura, che è costituita<br />
dal complesso dei modi in cui l'intelligenza umana si esprime: il romanzo è il prodotto dell'intelligenza<br />
di uno scrittore; il quadro o l'affresco è il prodotto dell'intelligenza di un pittore; il<br />
saggio su un determinato istituto giuridico è il prodotto dell'intelligenza di un giurista ...<br />
Vogliamo così far capire a chi legge che la cultura è qualcosa di complesso e di complicato;<br />
oltre che di immenso.<br />
La cultura, quindi, "non è solo scienza". Perché?<br />
"La scienza, d'altro canto, ha perduto gran parte del suo fascino e del suo alone salvifico<br />
(...). Le sue verità possono ben essere verificate, consacrate in formule standardizzate e aperte<br />
al controllo intersoggettivo, ma sono "verità piccole", a breve o a medio raggio, che non<br />
hanno nulla da dire di fronte ai problemi umani non risolubili e non riducibili ad aggiustamenti<br />
tecnici in cui è sufficiente l'applicazione corretta della formula. I problemi propriamente umani<br />
10
sono problemi teoricamente non risolvibili. Sono tensioni permanenti di fronte a situazioni problematiche<br />
globali: la giustizia, l'amore, la libertà, la morte” 6 .<br />
E' difficile dire perché una civiltà muoia, cioè perché diventa sterile, incapace di creare;<br />
è ugualmente impossibile spiegare perché una civiltà riesca a influenzare un'altra civiltà.<br />
La cultura di un popolo, che si può sinteticamente chiamare "civiltà", è fatta di un insieme<br />
di segni; quelli tra di essi che sopravvivono alla morte di chi li ha creati contribuiscono a<br />
rendere influente la civiltà del popolo in cui si è nati e si è cresciuti.<br />
La civiltà che riesce a far parlare le intelligenze (libertà) è una civiltà degna di vivere più<br />
a lungo di altre.<br />
6 E. Morin, La connaissance de la connaissance, Senil, Paris, 1986.<br />
11
LE MINORANZE<br />
Può intendersi per minoranza quella parte di una popolazione più ampia, storicamente<br />
stabilitasi su un determinato territorio, che mantenga una propria identità tale da distinguerla per<br />
cultura, lingua, caratteristiche etniche o razziali; diversamente, non sono considerate minoranze<br />
i lavoratori migranti.<br />
Il problema tuttora aperto è il riconoscimento dei diritti collettivi in aggiunta a quelli individuali.<br />
Alcuni Stati temono che l'affermazione di tali diritti collettivi, portando ad un riconoscimento<br />
delle minoranze ed al conseguente conferimento a queste ultime dello "status" di popolo,<br />
finirebbero per mettere in pericolo la loro integrità territoriale e, anche, sociale.<br />
Tuttavia, gli Stati hanno dovuto assumere provvedimenti di promozione dell'identità del<br />
gruppo, quali quelli rivolti ad assicurare specifiche istituzioni scolastiche, culturali e religiose.<br />
Le minoranze si distinguono, tra l'altro, anche:<br />
a) in minoranze circoscritte all'interno di uno Stato;<br />
b) in gruppi isolati o maggioritari nella propria regione;<br />
c) in minoranze collocate in territori di più Stati, ossia che travalicano le frontiere di due o più<br />
Stati.<br />
Nell'affrontare il tema dei diritti delle minoranze linguistiche, occorre non dimenticare<br />
mai che ciascuna minoranza ha una storia, una condizione politica e materiale diversa dalle altre.<br />
Alla base dei problemi posti dalle minoranze stanno i contrasti di volontà, che possono<br />
essere risolti attraverso una serie di strumenti istituzionali e giuridici internazionali (garanzie giuridiche<br />
o politiche, trattati sia contrattuali che esortativi, convenzioni e soluzioni costituzionali).<br />
a. Le minoranze linguistiche<br />
Approfondimenti richiede, comunque, il concetto di "minoranza linguistica" dovendo riconoscere<br />
che diversi possono essere i criteri per pervenire alla definizione di esso (ad es., il<br />
peso numerico; la provenienza geografica; la posizione di "potere" della minoranza nell'ambito<br />
territoriale in cui risiede; l'antropologico; il geodemografico).<br />
Ma nessuno di quelli ora richiamati, isolatamente preso, può considerarsi il criterio. Forse,<br />
occorre ricorrere ad alcuni o a tutti fra di essi nell'intento di pervenire ad una definizione che<br />
possa rilevarsi soddisfacente, anche perché è attraverso la lingua (romanzo, poesia, racconto,<br />
fiaba) che sovente transita "la cultura": una qualunque collettività di persone che vivano in un<br />
paese o in una località data, che abbiano una razza, una religione, una lingua e tradizioni proprie,<br />
e che siano unite da identità di tale razza, di tale religione, di tale lingua e di tali tradizioni<br />
in un sentimento di solidarietà, al fine di conservare le loro tradizioni, mantenere il loro culto,<br />
assicurare l'istruzione e l'educazione dei loro figli in conformità al genio della loro razza e di assistersi<br />
reciprocamente.<br />
Ma alcuni studiosi considerano questa definizione, fornita dalla Corte internazionale di<br />
giustizia, ancora poco soddisfacente.<br />
L'ONU, attraverso la specifica sottocommissione della Commissione dei diritti dell'Uomo,<br />
ha ritenuto di contribuire alla comprensione del fenomeno sottolineando che:<br />
il termine va applicato solo nel caso in cui le popolazioni non dominanti abbiano - e soprattutto<br />
desiderino conservare - tradizioni o caratteristiche etniche, religiose e linguistiche diverse<br />
da quelle del resto della popolazione;<br />
il numero degli appartenenti al gruppo in questione debba essere rilevante e sufficiente affinché<br />
essi possano conservare le loro caratteristiche;<br />
ci sia, da parte dei componenti delle minoranze, un atteggiamento di lealtà nei confronti dello<br />
Stato di cui fanno parte.<br />
Sembra dimostrare maggiore consapevolezza dell'origine della "minoranza linguistica",<br />
quella definizione datane che si fonda sulla storicità (tempo lungo) dell'insediamento e sui suoi<br />
rapporti mantenuti con il paese d'origine che è diverso da quello in cui vi è l'insediamento. A tal<br />
riguardo, secondo questa concezione è minoranza un qualunque gruppo che nel passato abbia<br />
costituito una nazione indipendente e organizzata in Stato distinto; che abbia fatto parte, sempre<br />
nel passato, di una nazione organizzata in Stato distinto e sia stata poi da esso separata;<br />
12
oppure che possa costituire ancora un gruppo regionale o disperso che, anche se ancora legato<br />
da sentimenti di solidarietà al gruppo dominante, non si è ad esso minimamente assimilato.<br />
C'è chi pone l'accento, poi, sulla dimensione geografica del fenomeno. Sulla base di tale<br />
criterio metodologico ci si può trovare di fronte a diversi gruppi:<br />
gruppi che abitano una intera regione geografica del Paese;<br />
gruppi che abitano la maggior parte di una regione del Paese;<br />
gruppi concentrati in una regione del Paese ma che non costituiscono la maggioranza della<br />
popolazione di quel territorio;<br />
gruppi i cui appartenenti abitano in una certa regione del Paese o sono distribuiti su tutto il<br />
territorio nazionale;<br />
gruppi i cui componenti sono dispersi su tutto il territorio del Paese;<br />
gruppi i cui appartenenti non abitano tutti nello stesso Paese, ma sono diffusi in Paesi diversi.<br />
Se si assume a minimo comune denominatore dell'analisi la dimensione storica, è possibile<br />
pervenire alla individuazione di diversi gruppi:<br />
gruppi che esistevano già sul territorio prima della creazione dello Stato;<br />
gruppi che appartenevano originariamente a vari Stati ma che, per vicende storiche diverse,<br />
si trovano ora sotto la giurisdizione dello Stato attuale (a seguito di cessioni o annessioni di<br />
territori);<br />
gruppi formatisi nel Paese in questione a seguito di fenomeni di immigrazione di un gruppo<br />
appartenente alla stessa etnia, alla stessa religione, alla stessa lingua e che al momento attuale<br />
sono considerati cittadini dello Stato.<br />
Altro criterio di analisi è quello statistico: esso si fonda sul rapporto numerico che contraddistingue<br />
il gruppo minoritario rispetto all'intera popolazione di uno Stato che il gruppo ospita<br />
o accoglie nel suo territorio.<br />
Rivedendo - come si è fatto - la validità di questo o di quel criterio da usare per la definizione<br />
di "minoranza linguistica" a fronte di quella che è la differenziata realtà di tale fenomeno,<br />
si finisce per concordare con le riflessioni svolte da F. Capotorti, il quale, consapevole di non<br />
potere ingabbiare la realtà in una formula che si sarebbe potuto rivelare inaccettabile nei fatti,<br />
scriveva: "allo stato attuale, sembrerebbe illusorio pensare che si possa formulare una definizione<br />
suscettibile di una generale adesione".<br />
Eppure, nonostante questo legittimo dubbio, il Capotorti offre all'attenzione dello studioso<br />
della cultura delle minoranze una definizione assai equilibrata di esse: "Un gruppo numericamente<br />
inferiore al resto della popolazione di uno Stato, in posizione non dominante, i cui<br />
membri - appartenenti allo Stato - possiedono dal punto di vista etnico religioso o linguistico caratteristiche<br />
che si differenziano da quelle del resto della popolazione e manifestano anche in<br />
maniera implicita un sentimento di solidarietà allo scopo di conservare la loro cultura, le loro<br />
tradizioni, la loro religione o la loro lingua".<br />
Dato che la salvaguardia fondamentale di una minoranza è da rinvenire nel grado di tutela<br />
che lo Stato ospitante offre alla lingua che essa usa, dato che per mezzo di essa diventa<br />
testimone della sua cultura, sembra utile riflettere su alcune asserzioni.<br />
In primo luogo, è esatto dire che "normalmente le comunità che si considerano nazione<br />
(o parte di una nazione residente in un altro Stato) non sono disposte a considerare il proprio<br />
idioma come un dialetto, ma lo considerano una lingua a pieno titolo.<br />
Il termine dialetto ha, per esse, una evidente connotazione riduttiva".<br />
In secondo luogo, occorrerà ricorrere al concetto di "sentimento di solidarietà" (Salvi) rispetto<br />
alla propria lingua (e alla propria cultura) per identificare in quali dei quattro livelli di approssimazione<br />
siano collocabili gli articolati fenomeni del "sentirsi minoranza linguistica" da parte<br />
di una comunità:<br />
Livello 0: mancanza di ogni specifica percezione della propria specificità culturale;<br />
Livello I: percezione di un sentimento di diversità della propria comunità rispetto al resto<br />
delle comunità ospitate nel territorio del Paese;<br />
Livello II: percezione di un sentimento di diversità e di opposizione tra la cultura della<br />
propria comunità e quelle ospitate nel resto del Paese;<br />
Livello III: percezione di un sentimento di diversità e di opposizione della cultura della<br />
propria comunità rispetto a quella delle altre comunità del Paese, aggravato da<br />
13
misure di ostilità, da parte del <strong>Governo</strong> del Paese stesso, sia sul piano storico<br />
sia anche sul piano dell'attualità.<br />
Nel definito I livello possiamo posizionare tutte le comunità culturali cui la nostra coscienza<br />
culturale fa normale riferimento: ad es., gli abitanti di un sobborgo di Roma avvertiranno<br />
la loro specificità culturale rispetto al resto degli abitanti della capitale, ma non per questo si<br />
considerano "minoranze linguistica". Eppure un poeta come il Belli, che ha scritto in romanesco,<br />
è conosciuto anche all'estero.<br />
Nel II livello si possono far rientrare una varietà di comunità che saranno di gran lunga<br />
numericamente inferiore a quelle che abbiamo ritenuto di dover far rientrare nel I livello.<br />
Si possono fare degli esempi in grado di fare comprendere questa categoria concettuale:<br />
la comunità polacca nella Repubblica Federale di Germania, oppure quella friulana in Italia.<br />
Nel III livello si possono catalogare, invece, un ristretto numero di gruppi minoritari.<br />
Qualche esempio riesce a rendere l'idea: i Corsi o gli Occitani in Francia sono minoranze che<br />
avvertono l'ostilità "culturale" della dirigenza francese, essendo questa orientata a negare le loro<br />
identità.<br />
14
LA NAZIONE<br />
Secondo R. Hartshorne per "nazione" si intende un gruppo umano residente in un'area<br />
determinata che si sente legato da vincoli di accettazione comune di particolari valori talmente<br />
importanti da richiedere che quell'area e quella popolazione siano organizzate in uno Stato distinto,<br />
in modo che quei valori siano preservati e perpetuati 7 .<br />
Quando un popolo ha coscienza della comunanza di sentimenti analoghi, affinità culturali<br />
e spirituali, più in particolare di avere un futuro comune, si ha una nazionalità.<br />
Occorre porre l'attenzione sui due aspetti che caratterizzano il ruolo della nazione nella<br />
formazione dello Stato; essi, peraltro, presentano una validità di carattere generale.<br />
In primo luogo, il fatto che, nell'ambito dei contesti sociali, la nazione occupa la posizione<br />
più elevata; essa è la forma la più ampia e la più complessa tra tutte le collettività umane.<br />
"Essa è la collettività-limite, quella che ingloba tutte le altre e non è inglobata da alcuna" (R.<br />
Bonnard).<br />
Così, allorché una società umana è giunta al tipo-nazione, essa non può evolversi nel<br />
senso di un rafforzamento della solidarietà che unisce i suoi membri, senza costituirsi in Stato.<br />
C'è l'orda, il clan, la tribù, la città, la nazione; ma al di sopra della nazione non c'è null'altro<br />
che lo Stato.<br />
Senza dubbio ciò non significa che lo Stato sia della stessa natura delle forme delle società<br />
politiche che lo precedono.<br />
E' in esso che si conclude l'evoluzione, ma ciò non pregiudica la sua natura che è assai<br />
differente da quella delle forme politiche che essa viene a rimpiazzare.<br />
Questa affermazione sembra essere sufficiente per respingere tutte le altre definizioni di<br />
Stato che pretendono di dissociarlo dall'elemento nazione da cui nasce. E si vedrà, in effetti,<br />
che definendo lo Stato come Potere istituzionalizzato, bisogna riguardare questo Potere come<br />
Potere nazionale, allo stesso modo come è nazionale l'idea del diritto che, allo stesso tempo, è<br />
incorporata nell'istituzione statale.<br />
Una seconda osservazione viene formulata: il ruolo fondamentale che gioca l'idea del<br />
fine sociale nel sentimento nazionale.<br />
E', in effetti, la rappresentazione di questo fine, che è l'agente decisivo della solidarietà<br />
che unisce i membri del gruppo.<br />
Senza dubbio il ricordo delle prove comuni, le tradizioni, giocano un ruolo importante.<br />
La nazione è continuare a essere ciò che si è stato, a vivere secondo la stessa legge<br />
che ha prodotto la forza delle generazioni precedenti; è dunque, anche attraverso la solidarietà<br />
che si pone, volgendo al passato, una rappresentazione del futuro.<br />
Senza dubbio ancora, la concordanza sugli interessi attuali, i vantaggi di una divisione<br />
del lavoro, l'identità dei bisogni e dei costumi creano tra gli individui un sentimento di interdipendenza<br />
estremamente vivace.<br />
Lo strumento più efficace della coscienza nazionale è una concezione del fine della vita<br />
comune perché "il divenire è ugualmente indispensabile a una collettività umana come a ciascun<br />
essere vivente".<br />
Una nazione - è stato detto - è un sogno delle cose a venire.<br />
Ora l'uomo si interessa al suo passato nella misura in cui egli consulta l'avvenire.<br />
Ogni giorno l'uomo compie i suoi sforzi che si inscriveranno nel tempo; ora, ciò che dà<br />
certezza è sapere che egli non affronta da solo il futuro da cui si attende un premio per il suo<br />
impegno.<br />
Grazie alla sua integrazione nella comunità nazionale, egli proietta, in qualche modo,<br />
nell'avvenire i quadri della sua sicurezza attuale.<br />
Più egli sente affermarsi in sé il senso nazionale e più diventa sicura l'ipoteca presa sull'avvenire.<br />
Occorre, d'altra parte, distinguere il concetto di nazionalismo da quello di nazionalitarismo.<br />
Il primo concetto può essere inteso come esaltazione della nazione, secondo questo concetto<br />
si afferma la tesi secondo la quale: solo io conto perché "nazione" e devo insegnare agli<br />
7 M.A. Belasio, Aspetti demografici, struttura etnica, nazione, A.A. 1993/94, Istituto di Studi Europei<br />
A. De Gasperi - Roma.<br />
15
altri; ossia la mia nazionalità è superiore alle altre e, in tal modo, funge da molla culturale dell'imperialismo.<br />
Altro è il concetto di nazionalitarismo, inteso come il sentimento, nel senso buono di<br />
fondare una nazione, a cui si richiamava lo stesso Mazzini.<br />
Nell'affrontare il discorso delle culture nazionali in Europa si rischia di finire con il dividere<br />
qualcosa che ancora non è sentito e non esiste.<br />
Se, ad esempio, facciamo riferimento al nazionalismo nell'800, il Ghisò afferma senza<br />
ombra di dubbio "che ad esempio la Francia aveva fatto sì che le idee nate ovunque in Europa<br />
divenissero idee europee; distingueva nell'Europa le varie nazionalità..." 8 .<br />
Possiamo considerare il nazionalismo europeo più come un fenomeno politico, un desiderio<br />
di dichiarare la propria presenza, che considerarlo quale volontà, intesa in chiave culturale,<br />
di imporre la propria nazionalità sugli altri. In questo ambito, rimane difficile specificare cosa<br />
si intende per culture nazionali.<br />
In tutta l'epoca imperialista l'Europa è "una"; nel corso di tutto il XIX secolo, si poteva girare<br />
liberamente per l'Europa: non serviva, infatti, nessun passaporto o altra formalità burocratica.<br />
La libera circolazione era garantita anche durante le famose guerre coloniali: ad esempio,<br />
nessuno pensò di ostacolare il rientro di Bismarck dall'Austria, anche se quest'ultima venne<br />
sconfitta dagli stessi prussiani nel 1866.<br />
Altra testimonianza della quantità dei viaggi compiuti in quel periodo è data dall'archeologia<br />
alberghiera rinvenibile nelle località termali.<br />
L'Europa sviluppa un tipo di imperialismo e di colonialismo proprio, conseguente alla<br />
convinzione, da parte degli Stati europei, di essere gli unici detentori della legge del progresso,<br />
che "doveva", quindi essere imposta agli altri. A prescindere da parte di quale Stato dell'Europa<br />
avvenisse tale imposizione, era comunque la superiorità della civiltà europea che veniva portata<br />
all'attenzione di questi.<br />
Ovviamente esistevano ed esistono delle differenze fra le culture nazionali in Europa, le<br />
quali, pur avendo caratteristiche peculiari, in fondo derivano tutte dalla cultura europea, che pur<br />
se non univoca ma ricca di sfaccettature, si distingue per tre caratteristiche peculiari e qualificanti,<br />
che ancora oggi possiamo riscontrare in ogni manifestazione umana; esse sono la razionalità<br />
greca, il diritto romano e la carità cristiana.<br />
Diversamente, come abbiamo già visto, una cultura nazionale vera e propria sorge sulla<br />
base del dominio e sul soffocamento delle etnie e, quindi, si colloca all'opposto dell'etnia.<br />
In tal senso, la cultura nazionale può essere intesa come il prodotto di una attività sociale<br />
che mira ad essere unificante e di carattere sovraetnico.<br />
8 Marongiu Buonaiuti C., Coscienza d'Europa attraverso i secoli, Roma 1987, Istituto di Studi Euro-<br />
pei “A. De Gasperi” - Roma.<br />
16
LO STATO<br />
Nel tentativo di fornire la definizione di "Stato", gli studiosi di diritto costituzionale associano,<br />
nella stessa nozione, gli elementi materiali (tali sono la popolazione e il territorio) e l'elemento<br />
spirituale: la potenza di dominio o autorità statale.<br />
C'è, ad esempio, chi definisce "ciascuno Stato in concreto" come "una comunità di uomini,<br />
presenti su un proprio territorio e che possiedono una organizzazione da cui risulta per il<br />
gruppo incaricato di mantenere rapporti con i suoi membri un potere superiore di azione, di comando<br />
e di coercizione".<br />
Altri, ancora, ritengono che "lo Stato formi una unità giuridica perpetua; esso è un organismo<br />
sociale che, generalmente attraverso l'impiego di un potere unilaterale e attraverso l'esercizio<br />
della costrizione materiale di cui ha il monopolio, esercita certi poteri giuridici su una<br />
Nazione presente su un territorio".<br />
Ambedue queste definizioni presentano una caratteristica: quella di fondarsi sulla terminologia<br />
giuridica.<br />
Lo Stato non è, però, monopolio della scienza del diritto; esso appartiene in effetti come<br />
realtà e come nozione a un gran numero di discipline (alla scienza politica, alla storia, all'economia,<br />
alla sociologia, ...).<br />
Ma occorre ritornare sul concetto espresso poco fà: la necessità di ricorrere al linguaggio<br />
giuridico per definire lo Stato.<br />
Infatti, solo il linguaggio giuridico consente di fornire dello Stato una definizione che sia<br />
utilizzabile da tutti. Una definizione che, fondandosi sull'elemento essenziale dello Stato, possa<br />
essere messa in opera ogni volta che, nella particolare scienza o branca, si avrà avuto bisogno<br />
di ricorrere alla nozione di Stato.<br />
Ma, ancora una volta, non vi possono essere più definizioni possibili secondo il punto di<br />
vista sotto il quale ci si pone; non ve ne è che una ed è quella giuridica. Essa, quindi, deve risultare<br />
soddisfacente nell'ambito di quello scambio generale delle idee che caratterizza la cultura.<br />
Se, ad esempio, noi stiamo affrontando il tema dell'intervento dello Stato nel campo dell'economia,<br />
l'economista non potrà dire: lo Stato è il regolatore o il dispensatore della ricchezza<br />
sociale, senza sottintendere: lo Stato, quale risulta definito dalla scienza giuridica, è il regolatore<br />
o il dispensatore della ricchezza sociale.<br />
Ugualmente, se lo storico deve richiamarsi alla nozione di Stato mettendola in campo in<br />
questa o quell'episodio della vita, egli dovrà far riferimento alla definizione fornita dai giuristi che<br />
sono i soli competenti per stabilirlo.<br />
a. Lo Stato non è un organismo spontaneo<br />
E' possibile dimostrare che lo Stato è il risultato necessitato di tutte le tendenze che<br />
vengono alla luce, a un certo momento dato, dall'evoluzione dei gruppi nazionalistici (dalla Nazione<br />
può generarsi lo Stato...). Solamente, non bisogna prestare troppo attenzione al carattere<br />
di queste forze di cui lo Stato è un prodotto, un risultato.<br />
Esse non sono per nulla spontanee come lo è il movimento che spinge gli uomini a riunirsi<br />
in società; esse non sono ugualmente favorite dall'istituto o dai gusti di ciascuno, perché se<br />
gli uomini si lasciassero andare dietro alla loro inclinazione naturale, la vita collettiva non si orienterebbe<br />
verso la forma statale.<br />
Queste forze sono, al contrario, l'espressione di una meditata volontà; esse costituiscono<br />
una reazione agli impulsi naturali, una resistenza dell'intelligenza agli inviti che nascono nella<br />
parte più oscura dell'animo umano.<br />
Così, è ben evidente come lo Stato è di una essenza totalmente differente rispetto a<br />
quella del clan o della tribù, perché mentre queste qui nascono da una associazione spontanea<br />
di individui, lo Stato, al contrario, per formarsi, ha bisogno che ciascuno eserciti su lui stesso un<br />
controllo, rifletta sulle esigenze dell'ordine giuridico e finalmente pensi allo Stato come lo strumento<br />
di realizzazione del nostro destino temporale.<br />
In questo senso lo Stato è, innanzitutto, l'effetto di una volontà mirata ad evitare l'incontro<br />
con le insofferenze e le indifferenze dell'individuo portato a lasciarsi guidare dal suo istinto<br />
egoista.<br />
b. Lo Stato oggettivizza una disciplina di vita<br />
17
Se lo Stato non esiste che in ragione dello sforzo che esso suscita nello spirito di ciascuno,<br />
è nell'operazione intellettuale da cui nasce che dobbiamo cercare la sua essenza funzionale<br />
e, di conseguenza, gli elementi della sua definizione.<br />
Quale problema intende risolvere ciascuno quando il suo spirito pensa allo Stato?<br />
Al centro di ogni riflessione sullo Stato, all'origine e al fondo di tutti gli sforzi che la volontà<br />
umana applica alla concezione dello Stato, c'è l'idea di una disciplina di vita.<br />
Lo Stato è la forma attraverso la quale il gruppo si unifica sottomettendosi al diritto.<br />
Ciò è necessario alla durata della vita collettiva; esso riposa sull'acquiescenza dell'uomo<br />
che lo concepisce, come il simbolo di un'insieme di valori alla cui sottomissione la personalità<br />
umana ha una vocazione temporale.<br />
Allorché l'uomo comprende che solo un "potere", che trascende e libero da qualsiasi<br />
condizionamento rispetto alle singole volontà, può incarnare la disciplina necessaria alla vita<br />
della comunità; allorché si concepisce una disciplina in conformità agli obiettivi che persegue il<br />
gruppo e attorno ai quali si forma la comunione della generazione attuale con quelle del passato<br />
e quelle che sopraggiungeranno domani; allorché infine l'organizzazione politica del gruppo<br />
cessa di essere considerata dai suoi membri come un coordinamento effimero di forze instabili<br />
e di interessi divergenti, per essere compresa come un ordine durevole al servizio di valori universali<br />
che legano il capo e i soggetti, allora l'idea di Stato si fa strada e, con essa, la realtà dello<br />
Stato che esiste in questa idea.<br />
c. Dallo Stato come organizzazione allo "Stato culturale"<br />
Lo Stato non va considerato come un semplice fatto organizzatorio, ma è la qualificazione<br />
di un certo tipo di organizzazione e, poi, dei comportamenti umani che in essa si svolgono.<br />
Abbiamo diversi “Stati culturali”, che vengono qualificati a seconda di quello che ci<br />
sembra il tratto più determinante.<br />
Oggi, infatti, è in corso un dibattito sulla crisi dello "Stato sociale" e sul passaggio ad<br />
uno "Stato dei diritti", ma di certo c'è che ci troviamo in uno "Stato di provvidenza" più che in<br />
uno "Stato sociale", in quanto la protezione viene dall'alto e ciascuno sente di non essere determinante.<br />
Quando si afferma la pretesa di governare anche lo “Stato sociale”, si creano i presupposti<br />
per la nascita di uno "Stato dei diritti".<br />
Diversamente, lo "Stato culturale" va inteso come qualcosa di specifico, quale forma più<br />
alta dello Stato stesso.<br />
Il problema dello "Stato culturale" è importante per l'affermazione del diritto di partecipazione<br />
di tutte le comunità alla costruzione del nuovo tipo di organizzazione politica dell'Unione<br />
europea.<br />
Fino ad ora abbiamo un solo modello di Stato pluriculturale avanzato - sia ad economia<br />
capitalistica che a stato sociale - che sono gli Stati Uniti d'America. Però è molto difficile ipotizzare<br />
di poter usare tale modello per la costruzione dello “Stato delle Comunità Europee”, in<br />
quanto lo Stato americano è multiculturale e multietnico, costruito sul fatto che tutte le culture<br />
avevano diritto di accesso (immigrazione), la cultura non era determinante nella concessione<br />
del visto di entrata o per l'appartenenza a quel Paese; arrivando negli U.S.A., occorreva però<br />
rinunciare alla propria identità culturale, come identità forte (giuridico-politica).<br />
Gli U.S.A. si sono fondati sul principio dell'individualità in base al quale bisognava garantire<br />
l'eguaglianza di tutti, almeno a livello della legislazione costituzionale. L'individualismo è<br />
stato il cemento necessario cui si sono subordinate le culture, finendo, ovviamente, per spezzare<br />
l'identità culturale. Questo meccanismo è di difficile realizzazione in Europa.<br />
La società civile esprime la tendenza ad affermarsi in uno "Stato pluralista", che salvaguarda<br />
alcune sfere di autonomia della persona umana, attraverso soprattutto l'associazionismo.<br />
Questo tipo di società è composta, sì, dai cittadini, ma soprattutto dalle loro organizzazioni<br />
autonome, i cui diritti, libertà ed autonomie devono essere riconosciuti e tutelati dalla legge.<br />
18
IL RAPPORTO TRA STATO E CULTURA<br />
Avendo già analizzato vari tipi di Stato, possiamo quindi definire lo stesso come la continua<br />
qualificazione di una condizione esistenziale. Da ciò possiamo desumere che il nesso tra<br />
Stato e cultura è dato dalla rappresentazione e dal tipo di agire, in sostanza, dalla condizione<br />
esistenziale.<br />
Quindi, si può agevolmente affermare che esiste sempre il nesso tra Stato e cultura; a<br />
ben vedere anche lo "Stato di potenza" finisce per diventare un valore culturale e presenta, anch'esso,<br />
una dimensione culturale.<br />
Nello "Stato liberale" la cultura è il fondamento vero dello Stato; quest'ultimo non è l'organizzazione,<br />
ma è una serie di valori che poi vengono tradotti in organizzazione.<br />
In J. Burckhardt lo Stato è una potenza statica, mentre la cultura è l'elemento dinamico<br />
che opera sulle altre due potenze (cioè, sullo Stato e sulla religione).<br />
Lo Stato e la religione sono l'espressione dell'esigenza politica e di quella metafisica.<br />
La cultura corrisponde, invece, alle esigenze materiali e spirituali in senso più stretto e<br />
rappresenta, tra l'altro, l'insieme di tutto ciò che si è formato spontaneamente per promuovere la<br />
vita materiale come espressione della vita morale e spirituale. La cultura è intesa come mondo<br />
della libertà e del movimento.<br />
La O.S.C.E., fin dall'inizio del dibattito per la piena realizzazione degli obiettivi della sicurezza<br />
e della cooperazione, aveva individuato lo scambio culturale quale condizione ed elemento<br />
fondamentale per una efficace integrazione ed interscambio tra i Paesi europei.<br />
Lo "Stato culturale" può essere realizzato - si è detto - solo attraverso il dialogo fra tutti i<br />
gruppi e l'istituzionalizzazione delle consultazioni, sia per quelli rappresentati dall'autorità statale<br />
che per quelli minoritari, al fine di confrontare le posizioni dominanti, onde evitare qualsiasi situazione<br />
di prevaricazione, anche in quelle regioni dove i gruppi che hanno la rappresentanza<br />
statale costituiscono la minoranza.<br />
19
LA TUTELA DELLA CULTURA<br />
DELLE MINORANZE<br />
DEGLI STATI DELL’UNIONE EUROPEA<br />
21
a. Quali misure concrete può adottare lo Stato per tutelare la cultura delle minoranze?<br />
Non si può né si deve considerare la politica, sia nazionale che propria delle istituzioni<br />
comunitarie, da elaborare a favore delle minoranze linguistiche, avulsa dalla realtà 9 .<br />
Non si deve dimenticare, infatti, che azioni a sostegno risultano già avviate, e molte altre<br />
sono state concluse ed anche con successo. Ciò che non appare giusto accogliere del tutto<br />
- come qualsiasi evento umano - è che non si riesca ancora a porre un limite all'aspirazione di<br />
affermare, sotto il profilo giuridico, i diritti della minoranza sopra e al di fuori di quelli della maggioranza.<br />
Né appare ugualmente accettabile, oggi, che il limite di accoglimento delle aspirazioni<br />
della minoranza, in questo caso "linguistica", si sposti sempre più in avanti, finendo per determinare<br />
uno stato di permanente rivendicazione di "diritti" che tali di per sé non sono ma che alla<br />
coscienza del soggetto "minoritario" possono apparire o rappresentare come tali.<br />
Perché questo non accada e per evitare che l'aspirazione di giustizia sostanziale finisca<br />
per essere mortificata nei fatti, cioè nello svolgersi della vita quotidiana, è necessario recuperare<br />
questo senso del limite: esso si sostanzia di una serie di riflessioni fondate sulla fattibilità delle<br />
cose, delle azioni proponibili perché una "minoranza linguistica" si possa, oltre che nella coscienza<br />
collettiva anche in quella individuale, considerare adeguatamente tutelata.<br />
Anche in tal caso il ricorso al concetto di adeguatezza delle misure, degli interventi rappresenta<br />
un traguardo dell'intelligenza cui tendere.<br />
Recuperando, a questo punto dello studio, le linee-guida elaborate in termini di pratica<br />
operatività a livello di istituzioni comunitarie competenti nel settore, si possono sviluppare quelle<br />
tra esse che abbisognano dell'identificazione dei soggetti che le devono attuare, dei percorsi<br />
politici che si devono seguire, delle modalità di attuazione sull'intero territorio europeo.<br />
b. Le misure di ordine normativo<br />
Nel contesto delle misure di tale tipo il primo obiettivo (primario) politico da perseguire<br />
sarebbe quello di "costituzionalizzare" il principio, che è esigenza dello spirito umano, di tutela<br />
delle "minoranze linguistiche".<br />
Esempi, in Europa, di "costituzionalizzazione" dei diritti delle minoranze linguistiche sono<br />
da ritrovare nella carta fondamentale italiana e in quella belga, che ha subito, per tale aspetto,<br />
sostanziali modifiche anche in tempi relativamente recenti.<br />
Quale è il soggetto che si deve preoccupare di muovere questa idea verso la sua sustanziazione<br />
normativa?<br />
Si può immaginare che, a parte la creazione di uno o più movimenti culturali fondati su<br />
questo tema, l'interesse debba essere fatto proprio, all'interno di ciascuna classe o di direzione<br />
o di opposizione, dal "partito politico" operante in ciascuno Stato. E ciò indipendentemente dallo<br />
sforzo, anch'esso di tipo normativo, che si sta concretizzando nella realizzazione di uno (o più)<br />
strumento/i normativo/i (convenzione, accordo) di livello comunitario o similare.<br />
Conseguito questo primo obiettivo, ciascuno dei soggetti produttori di norme ordinarie<br />
(di livello nazionale, di livello subnazionale) dovrebbe risultare impegnato, nei rispettivi ordinamenti<br />
statali, a:<br />
costruire un sistema normativo di base che si configuri come esplicitatore del principio costituzionalmente<br />
posto;<br />
implimentazione del sistema normativo, dopo che siano poste in essere controlli di esecuzione<br />
della legislazione e dei programmi e progetti (annuali-pluriennali) di attuazione.<br />
In considerazione del fatto che l'attività normativa dovrà essere sostenuta dalla ricerca<br />
dottrinale sul tema specifico delle "minoranze", occorrerebbe sviluppare - non solo nell'area del<br />
diritto, ma anche in altri campi, ad es. in quello sociologico e biologico - una "dottrina della minoranza".<br />
In questo caso, i soggetti da coinvolgere, nel nostro Paese, sono:<br />
le Università degli studi (in particolare, gli Istituti di diritto pubblico delle Facoltà di Giurisprudenza);<br />
9 “La tutela delle minoranze linguistiche. Riflessioni per un movimento culturale di sostegno”, a cura<br />
dell'Istituto "Max Weber", Roma, 1995.<br />
23
il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il quale dovrebbe destinare una quota-parte del<br />
suo budget all'approfondimento del tema "minoranza".<br />
c. Le misure di ordine ricognitivo<br />
Alla base di un corretto uso dell'intervento legislativo si deve porre l'esigenza, per lo<br />
stesso legislatore (soggetto), di conoscere la dimensione, sia di tipo quantitativo che di tipo qualitativo,<br />
del fenomeno.<br />
Lo strumento principale di conoscenza è la statistica. E siccome il più importante dei<br />
problemi di ordine conoscitivo è avere certezza delle entità numeriche delle minoranze (non solo<br />
di quelle di antico insediamento) in Europa, si tratta di porre in essere da parte delle diverse<br />
istituzioni statali di indagine, ad es. in Italia l'ISTAT, un programma nazionale di verifica.<br />
L'occasione può essere fornita dai periodici censimenti della popolazione.<br />
Altro strumento di rilevazione del fenomeno, in grado di svolgere funzione promozionale<br />
di tempestiva conoscenza anche tra popolazione/etnia e gruppi minoritari sparsi sul territorio di<br />
altri Stati, potrebbe essere un "Annuario".<br />
Tale testo potrebbe essere elaborato, per ciascuno Stato appartenente all'UE, dal dicastero<br />
o agenzia nazionale competente (soggetto coordinatore).<br />
A livello di UE, della creazione di un "Annuario" europeo delle minoranze si potrebbe<br />
rendere promotore il Parlamento europeo.<br />
L'Annuario delle minoranze dovrebbe essere aggiornato annualmente oppure ogni<br />
biennio.<br />
d. Le misure di ordine analitico-investigativo<br />
Attualmente esiste il Bureau Europèen pour les langues moins répandues che opera in<br />
stretta cooperazione con le istituzioni europee, in particolare con il Parlamento europeo e la<br />
Commissione delle Comunità Europee.<br />
Collabora, inoltre, con il Consiglio d’Europa.<br />
Finalità del Bureau europeo per le lingue meno diffuse è la conservazione e la promozione<br />
delle lingue e delle culture regionali autoctone dell’Unione europea.<br />
Il Bureau si compone di comitati, che rappresentano le comunità linguistiche minoritarie<br />
degli Stati membri dell’Unione europea. I delegati di tali comunità formano il Consiglio, supremo<br />
organo decisionale. Il Segretariato generale del Bureau ha sede a Dublino, mentre a Bruxelles<br />
è in funzione un Centro di informazione. A Lussemburgo opera un Centro di animazione<br />
dell’insegnamento in lingue minoritarie.<br />
L’esistenza del Bureau si può considerare, certamente, un segnale positivo di attenzione<br />
al problema.<br />
La politica del Bureau è riassumibile in tre punti principali:<br />
ricerca di supporti giuridici e politici e di mezzi finanziari a livello europeo, statale e regionale,<br />
per la realizzazione di progetti relativi alle lingue meno diffuse;<br />
pubblicazione e diffusione di materiale informativo sulle lingue meno diffuse e scambio di informazioni<br />
e di esperienze tra gruppi attivi nella promozione di queste lingue;<br />
creazione di strutture a sostegno delle comunità linguistiche autoctone, come Mercator, la<br />
Segreteria europea di coedizione per l’Infanzia, e Euroskol.<br />
e. Le misure di ordine culturale<br />
Le misure di quest'ordine si possono articolare su tre azioni di intervento:<br />
e.1 l'azione educativa;<br />
e.2 l'azione di sostegno all'associazionismo;<br />
e.3 l'azione di scambio delle esperienze.<br />
24
e.1 L'azione educativa<br />
E' stato correttamente sottolineato che "è nell'educazione che si trasmettono i valori culturali<br />
e gli atteggiamenti, che si creano orientamenti di apertura o viceversa di intolleranza, che<br />
si pongono i presupposti per l'azione del cittadino adulto".<br />
D'altra parte, si è consapevoli del fatto che "la lotta per la protezione delle minoranze si<br />
vince o si perde precisamente sul terreno dell'educazione".<br />
Pertanto, una attenzione fondamentale va posta alla messa a punto di azioni positive di<br />
educazione all'interno e verso l'esterno del gruppo minoritario.<br />
Le azioni positive di educazione rivolta agli appartenenti al gruppo linguistico minoritario<br />
si possono indicare nelle seguenti:<br />
creare la figura professionale dell'insegnante attivo nelle minoranze (il soggetto pubblico da<br />
individuare è il Ministero dell’Istruzione e, a livello periferico, l'Assessorato regionale alla cultura<br />
e alla formazione);<br />
attivare una indagine (anche di livello europeo) sulle misure educative attuabili in un contesto<br />
di minoranza (aspetti organizzativi, didattici e culturali dell'educazione) - (il soggetto pubblico<br />
da individuare è, anche in tal caso, il Ministero dell’Istruzione e, a livello periferico, l'Assessorato<br />
regionale alla cultura e alla formazione);<br />
favorire la produzione di testi scolastici in lingua di minoranza (a livello centrale, il soggetto<br />
pubblico è il Garante per l'editoria e l'informazione: erogazione di contributi a sostegno delle<br />
case editrici);<br />
favorire la costituzione di supporti informatici all'insegnamento e all'apprendimento (floppy<br />
disk, CD-ROM, ...);<br />
costituire nelle scuole classi miste, cioè composte di giovani appartenenti alla minoranza e di<br />
giovani appartenenti alla maggioranza.<br />
Le azioni positive di educazione rivolte a chi sta fuori del gruppo minoritario si possono<br />
così individuare:<br />
promuovere corsi di lingua minoritaria per gli adulti parlanti altra lingua residenti in zona di<br />
minoranza;<br />
promuovere tutte quelle manifestazioni culturali che facciano capire alle persone parlanti la<br />
lingua diversa da quella di minoranza i problemi di quest'ultime (sensibilizzazione);<br />
trattare in maniera diffusa nei testi scolastici adottati nel sistema scolastico l'origine storica<br />
delle attuali minoranze e l'apporto che essi hanno dato alla cultura e all'economia del Paese<br />
ospitante.<br />
e.2 L'azione di sostegno all'associazionismo<br />
L'associazionismo tra minoranze può essere sostenuto in vari modi.<br />
Innanzitutto, è indispensabile coinvolgere a livello nazionale (oltre che europeo) i rappresentanti<br />
delle associazioni che si occupano della salvaguardia della lingua, delle tradizioni e<br />
dei costumi, della letteratura in lingua (poesia, narrativa), delle forme artistiche d'origine.<br />
In tale contesto, si possono indicare i punti di sostegno da promuovere:<br />
favorire la formazione di biblioteche specializzate in pubblicazioni in lingua di minoranza;<br />
favorire lo studio e il recupero di traduzioni locali e di espressioni artistiche in lingue locali<br />
(musica, teatro, ...);<br />
creare festivals nazionali/europei dedicati alla produzione di opere (musicali, teatrali, ...) in<br />
lingua di minoranza o collegate alle lingue di minoranza;<br />
sostenere la creazione e il mantenimento di musei delle tradizioni e delle manifestazioni artistiche<br />
(delle culture, in genere) delle minoranze.<br />
Il coinvolgimento delle organizations non profit in tali azioni può realizzarsi:<br />
affidando ad esse la gestione delle stesse;<br />
finanziando le attività in questione gestite da esse;<br />
creando strutture di collegamento tra pubblico (controllo e finanziamento) e privato (gestione).<br />
25
e.3 L'azione di scambio delle esperienze<br />
Per favorire, comunque, la vitalità dell'associazionismo e dei movimenti in cui le minoranze<br />
risultano, allo stato, organizzate si può ritenere utile:<br />
favorire gli scambi di informazioni e di iniziative tra le minoranze e tra esse e gli eventuali interessati<br />
(comprese le strutture pubbliche dei Governi);<br />
favorire gli scambi di persone (viaggi, soggiorni brevi o lunghi).<br />
Al riguardo, sembra interessante promuovere, a livello di singolo Stato, ogni tre anni,<br />
una Conferenza nazionale delle minoranze; ogni quattro/cinque anni, a livello sovranazionale,<br />
una Conferenza europea delle minoranze.<br />
f. Le misure di ordine culturale (in senso generale)<br />
La "visibilità" della cultura delle minoranze si può favorire a mezzo dei seguenti interventi,<br />
che puntano alla diffusione di essa su quelli che sono i supporti tecnici tradizionali (libro,<br />
film, videocassetta, trasmissione radio/ televisiva):<br />
favorire e sostenere l'editoria in lingua minoritaria, e, ove necessario, contribuire alla standardizzazione<br />
grafica di lingue scritte o non scritte in forma stabile;<br />
favorire, anche finanziariamente, la sopravvivenza di organi di stampa a diffusione locale<br />
che adoperino la lingua di minoranza;<br />
favorire l'accesso delle minoranze alla radio e alla televisione nazionale per un periodo di<br />
tempo non irrilevante (secondo le normative locali);<br />
favorire, anche finanziariamente, la creazione di emittenti locali, radio e televisive, in lingua<br />
di minoranza;<br />
favorire la produzione di trasmissioni in lingua di minoranza, da diffondere localmente attraverso<br />
le reti radio e televisive nazionali;<br />
favorire le coproduzioni internazionali, ove possibile, con specifico riferimento alle minoranze;<br />
favorire l'istituzione di premi letterari per studi sulle minoranze europee o per opere dell'ingegno<br />
scritte in una lingua di minoranza.<br />
g. Le misure di ordine socio-conomico<br />
Le azioni positive, da elaborare sia a livello europeo (ricorso al F.S.E. e al F.E.R.S.) e a<br />
livello nazionale (aiuti), possono consistere nel:<br />
favorire la ripresa economica delle minoranze particolarmente svantaggiate e isolate;<br />
sensibilizzare le maggioranze ai problemi delle minoranze interne (cooperazione, scambio<br />
culturale);<br />
permettere l'uso della lingua di minoranza nei tribunali, e, in rapporto a questo, costituire<br />
gruppi di interpreti qualificati;<br />
permettere l'uso delle lingue di minoranza nelle transazioni quotidiane con l'amministrazione<br />
e i servizi (poste, banca), e, in rapporto a queste, favorire la formazione di una sia pur limitata<br />
forma di bilinguismo nel personale dei servizi stessi;<br />
favorire le insegne stradali bilingui e la ricostituzione, ove necessario, di una toponomastica<br />
bilingue.<br />
26
LA COSTRUZIONE DELLA “NAZIONE” EUROPEA<br />
La coincidenza tra Stato e Nazione non è mai stata raggiunta, sebbene siano stati posti<br />
in essere vari tentativi a partire dal Congresso di Vienna.<br />
Certamente la prima cosa che ci si trova ad affrontare è il conflitto tra le nazionalità, che<br />
frappongono resistenza della loro fusione in un organismo più complesso e vasto.<br />
In atto, oltre ai problemi di assimilazione dei nuovi Paesi, soltanto la creazione dell'Unione<br />
Economica è stata più semplice.<br />
L'Europa comprende tre gruppi etnici:<br />
1) i gruppi etnici che vantano un proprio Stato;<br />
2) gli altri senza un proprio Stato;<br />
3) gli altri, infine, non riconosciuti giuridicamente come comunità, aventi, tuttavia, una cultura<br />
quale criterio politico essenziale.<br />
Nel quadro evolutivo della Storia europea, infatti, e precisamente della fine della Repubblica<br />
cristiana del Medioevo e alla affermazione dell'Impero e delle diverse nazionalità, i<br />
gruppi etnici costantemente custodiscono e difendono la loro cultura e la loro autonomia, ragion<br />
per cui ad ogni progetto di edificazione di una comunità politica europea corrisponde l'affermazione<br />
di una cultura espressamente codificata.<br />
27
LA MAPPA DELLE MINORANZE<br />
Il quadro della distribuzione delle minoranze in Europa è molto variegato. I gruppi etnici<br />
presenti nel nostro continente sono più di 200, e riguardano più di 100 milioni di persone.<br />
Esistono paesi in cui la loro presenza è molto scarsa, sia nella varietà delle stesse che<br />
nel numero dei componenti, mentre in altri paesi questa presenza è molto forte.<br />
Fra i Paesi con scarsa presenza di minoranze troviamo la Bulgaria, la Polonia, la Norvegia,<br />
l'Olanda ed il Portogallo.<br />
Mentre, fra quelli più interessati, possiamo citare, insieme all'Italia, la Romania - con<br />
ben 28 etnie censite - l'Ungheria, l'Ucraina, la Gran Bretagna, la Francia e la Spagna, per citare<br />
solo quelli con maggiore presenza.<br />
Si riporta un elenco, in ordine alfabetico, delle minoranze più consistenti in Europa:<br />
gli Albanesi sono presenti in Italia;<br />
gli Aragonesi e gli Aranesi sono presenti in Spagna;<br />
gli Armeni sono presenti in Turchia ed Ungheria;<br />
gli Asturiani sono presenti in Spagna;<br />
i Baschi sono presenti in Spagna e Francia;<br />
i Bretoni sono presenti in Francia;<br />
i Bulgari sono presenti in Romania e Ungheria;<br />
i Catalani sono presenti in Francia, Italia e Spagna;<br />
i Cechi sono presenti in Romania e Slovacchia;<br />
i Cimbri sono presenti in Italia;<br />
i Cornici sono presenti in Gran Bretagna;<br />
i Corsi sono presenti in Francia;<br />
i Croati sono presenti in Austria, Italia e Ungheria;<br />
i Danesi sono presenti in Germania;<br />
i Fiamminghi sono presenti in Francia;<br />
i Francesi sono presenti in Svizzera e Belgio;<br />
i Franco-Provenzali sono presenti in Italia;<br />
i Frisoni sono presenti in Olanda e Germania;<br />
i Friulani sono presenti in Italia;<br />
i Gaelici sono presenti in Gran Bretagna;<br />
i Galiziani sono presenti in Spagna;<br />
i Gallesi sono presenti in Gran Bretagna;<br />
i Greci sono presenti in Italia, Cipro, Ungheria ed Albania;<br />
i Greci Ortodossi sono presenti in Turchia;<br />
gli Irlandesi sono presenti in Irlanda e Gran Bretagna;<br />
gli Italiani sono presenti in Slovenia, Croazia e Svizzera;<br />
i Ladini sono presenti in Italia;<br />
i Lapponi sono presenti in Norvegia, Svezia e Finlandia;<br />
i Lussemburghesi sono presenti in Belgio;<br />
i Mocheni sono presenti in Italia;<br />
gli Occitani sono presenti in Italia e Francia;<br />
i Polacchi sono presenti in Germania, Ungheria, Slovacchia, Lituania, Bielorussia ed Ucraina;<br />
i Romanci sono presenti in Svizzera;<br />
i Rumeni (inclusi gli Arumeni sparsi in piccoli gruppi nelle varie regioni dell’Europa sud-est)<br />
sono presenti in Slovenia e Ungheria;<br />
i Ruteni sono presenti in Slovacchia e in alcune zone dei Paesi dell’Europa occidentale;<br />
i Sardi sono presenti in Italia;<br />
i Serbi sono presenti in Croazia, in Romania ed Ungheria;<br />
gli Sloveni sono presenti in Italia, Austria ed Ungheria;<br />
gli Slovacchi sono presenti in Romania, Austria ed Ungheria;<br />
i Sorabi sono presenti in Germania;<br />
28
gli Svedesi sono presenti in Finlandia ed Estonia;<br />
i Tedeschi sono presenti in Belgio, Danimarca, Francia, Italia, Romania, Svizzera, Polonia,<br />
Repubblica Ceca, Slovacchia, Ucraina, Russia, Croazia, Slovenia, Ungheria e Kazakistan;<br />
i Tornedalsfinski sono presenti in Svezia;<br />
i Turchi sono presenti in Romania e Cipro;<br />
i Musulmani sono presenti in Grecia;<br />
gli Ucraini sono presenti in Romania, Slovacchia, Polonia ed Ungheria;<br />
gli Ungheresi sono presenti in Slovacchia, Slovenia, Romania, Austria, Croazia, Jugoslavia<br />
ed Ucraina;<br />
i Valenziani sono presenti in Spagna;<br />
i Valloni sono presenti in Belgio;<br />
i Walser sono presenti in Italia;<br />
gli Zingari, di origine asiatica, sono presenti in molti Paesi europei ed in particolare in Italia,<br />
in Romania ed in Ungheria.<br />
Appare evidente, da questo elenco, la varietà e la quantità delle minoranze etniche e<br />
linguistiche presenti in Europa.<br />
Alcuni Stati hanno forti problemi a riconoscere la presenza di queste minoranze al proprio<br />
interno e variegato risulta essere il grado di tutela nei vari Stati. Sono pochissimi i paesi che<br />
finora hanno adottato provvedimenti giuridici volti alla tutela delle minoranze.<br />
In Belgio abbiamo comunità con pari dignità; in Finlandia esiste il bilinguismo con gli<br />
Svedesi; in Francia esistono scuole per l'insegnamento della lingua basca, catalana, bretone e<br />
corsa; in Grecia, il Trattato di Losanna del 1923 prevede la tutela linguistica-religiosa per i Musulmani.<br />
L'Italia si colloca, senza ombra di dubbio, fra i Paesi più avanzati in questo campo, tant'è<br />
che le disposizioni legislative che riguardano la minoranza sud-tirolese del Trentino-Alto Adige<br />
costituiscono il modello normativo più perfezionato e preso ad esempio dal gruppo di lavoro<br />
della Commissione per la democrazia attraverso il diritto che ha redatto il progetto di Convenzione<br />
europea per i diritti delle minoranze etniche.<br />
29
LA TUTELA INTERNAZIONALE<br />
DELLE MINORANZE IN EUROPA<br />
31
INTRODUZIONE<br />
I documenti di studio, qui di seguito riportati, costituiscono un contributo di riflessioni inteso<br />
a diffondere la conoscenza della legislazione a tutela delle minoranze etniche e linguistiche<br />
presenti nel nostro continente, ormai soggetto istituzionale unitario, sulla base di un percorso<br />
che intende recuperare i contenuti degli atti elaborati nelle sedi delle Organizzazioni mondiali ed<br />
europee più rappresentative.<br />
Tali documenti, raccolti e commentati e che, certamente, costituiscono solo il nucleo<br />
centrale degli strumenti esistenti, possono ben rappresentare un momento di valutazione delle<br />
questioni che, pur tra le difficoltà in cui ancora si dibattono le minoranze, hanno assunto una loro<br />
intrinseca rilevanza.<br />
Il nostro futuro prossimo, che può essere chiamato presente, sarà certamente un tempo<br />
caratterizzato dalla multietnicità, nel quale dovranno riuscire a convivere culture che è bene che<br />
conservino i loro tratti differenziali.<br />
Oggi, in Europa sembra più che mai viva l’idea di una coscienza comune tesa a considerare,<br />
nella società vivente, la plurietnia come un arricchimento ed un’opportunità. Il pur complesso<br />
processo di unificazione, considerato come un movimento più ampio di quello della Comunità<br />
europea, pur condizionato dalla tendenza all’omologazione, dovrà riscoprire i percorsi<br />
che portano a salvaguardare e perché no, a sviluppare le molteplicità culturali ed etniche presenti<br />
sul territorio.<br />
Le istituzioni, i gruppi e gli individui che lavorano in quest’ambito debbono essere posti,<br />
altresì, nelle condizioni di operare per una pacifica coesistenza interetnica, creando dialogo e<br />
cooperazione.<br />
Dall’incontro di culture differenti può radicarsi nella coscienza dell’individuo, della società<br />
di cui è parte integrante, la convinzione che le comunità minoritarie sono una occasione di<br />
progresso: conoscerne la storia, la lingua, le abitudini, le tradizioni aiuta certamente a comprendere<br />
i valori e le ricchezze insite nel patrimonio culturale di tali comunità. Aiuta al rispetto della<br />
loro dignità umana.<br />
Le leggi e le istituzioni non solo possono incoraggiare scelte di buona convivenza per<br />
assicurare un’esistenza civile tra le diverse culture; esse si debbono assumere l’impegno morale<br />
di diffondere e coltivare nella comunità, dalla più piccola alla più grande, quei valori che siano<br />
capaci di far percepire al cittadino la potenziale ricchezza del confronto.<br />
Uno degli obiettivi che questo lavoro intende perseguire è, appunto, quello di divulgare<br />
l’idea che, sostenuta dalla potenzialità innovativa delle norme, la cultura delle comunità minoritarie,<br />
intesa come circolazione di esperienze umane, come espressione dello spirito, va tutelata<br />
e valorizzata, in ogni tempo e in ogni luogo.<br />
33
PREAMBOLO<br />
La presenza, in molti Paesi europei, di numerosi gruppi e lingue minoritarie diversi ha<br />
richiamato nel tempo una attenzione sempre più profonda e diffusa verso il tema della loro protezione,<br />
nell’intento di promuovere legislazioni e politiche adeguate volte a preservarne e a tutelarne<br />
l’identità.<br />
Così, nel periodo immediatamente successivo alla seconda guerra mondiale, alcuni<br />
Stati rilanciarono quei principi di protezione delle minoranze già in parte realizzati negli anni<br />
precedenti, dando l’avvio, durante il lungo cammino di costruzione dell’Unione Europea, ad un<br />
processo di crescente approfondimento e maturazione delle problematiche relative alla tutela<br />
delle minoranze etniche e linguistiche.<br />
La riflessione su questo tema in ambito europeo e nel più vasto contesto della Conferenza<br />
per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (C.S.C.E. ora OSCE), intensificatasi in modo<br />
particolare negli ultimi decenni, si è concretizzata in una serie di risoluzioni, raccomandazioni,<br />
direttive e nell’adozione di convenzioni europee per la protezione dei diritti delle minoranze e<br />
delle loro peculiarità culturali e linguistiche, giungendo quindi ad una fase di più diffusa e radicata<br />
coscienza del valore della multiculturalità e della necessità di tutelarla anche attraverso strumenti<br />
giuridicamente vincolanti per gli Stati, con l’affermazione di principi e la previsione di impegni<br />
e misure concrete in forma pattizia.<br />
In tale contesto, uno dei problemi che si è posto con forza è stato quello di definire il<br />
concetto di minoranza e, quindi, di individuare, in una realtà multinazionale e diversificata, gli<br />
elementi di identificazione della stessa in quanto tale.<br />
Alla difficoltà di approccio concettuale ha corrisposto quella di pervenire ad una normativa<br />
comune di tutela delle minoranze, questione altrettanto complessa e di non agevole soluzione<br />
dal momento che una disciplina internazionale uniforme e unanimemente accettabile si<br />
doveva confrontare con l’esigenza di tenere conto di realtà storiche, giuridiche, sociali ed economiche<br />
sostanzialmente diverse.<br />
In ambito europeo, infatti, le situazioni differivano sensibilmente nei vari Stati ed anche<br />
le legislazioni nazionali presentavano nella materia differenziazioni sia per quantità che per contenuti<br />
ed ampiezza di tutela garantita, con quadri legislativi più o meno avanzati e norme diversificate<br />
in relazione alla specificità delle caratteristiche dei gruppi minoritari presenti sul territorio.<br />
Il cammino verso l’unificazione della normativa nel campo della protezione delle minoranze<br />
si è pertanto rivelato non sempre agevole, incontrando anche momenti di incertezza nello<br />
sforzo teso a superare i molteplici problemi derivanti dall’esistenza di quadri storici, culturali,<br />
normativi e sociali quanto mai diversificati nei diversi Stati, e i numerosi interventi realizzati nel<br />
tempo hanno tenuto presenti non soltanto le esigenze di garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali<br />
dell’uomo e di salvaguardia dell’identità delle minoranze, ma anche la necessità e<br />
l’opportunità di consolidare le condizioni per assicurare e mantenere la pace e la stabilità in Europa<br />
a fronte delle conseguenze che, sotto tale essenziale profilo, i contrasti interetnici sono suscettibili<br />
di innescare in mancanza di adeguate forme di protezione dei gruppi minoritari.<br />
La trattazione che segue si riferisce specificamente all’azione di tutela delle minoranze<br />
in Europa posta in essere dagli Organismi europei, e in particolare dal Consiglio d’Europa,<br />
dall’Unione Europea e nel più vasto contesto della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione<br />
in Europa, nonché nell’ambito dell’Iniziativa Centro-Europea.<br />
Nondimeno, per una migliore comprensione del processo che ha portato all’adozione di<br />
strumenti normativi di fondamentale importanza per la protezione delle minoranze in Europa, si<br />
ritiene utile fare un sia pur sintetico riferimento anche a talune delle principali iniziative assunte<br />
nel campo dalle Nazioni Unite.<br />
Qui di seguito si citano i documenti di maggiore rilievo sui quali seguiranno cenni di riferimento:<br />
34
Interventi dell'O.N. U<br />
la “Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale” (21<br />
dicembre 1965);<br />
l’art. 27 del “Patto internazionale sui diritti civili e politici” (16 dicembre 1966);<br />
la “Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose<br />
e linguistiche” (18 dicembre 1992).<br />
Interventi del Consiglio d’Europa<br />
la “Carta europea delle lingue regionali o minoritarie”, adottata dal Comitato dei Ministri il 25<br />
giugno 1992;<br />
la “Proposta di Convenzione europea per la protezione delle minoranze” elaborata dalla Commissione<br />
Europea per la Democrazia attraverso il Diritto (c.d. Commissione di Venezia 8-9 febbraio<br />
1991);<br />
la “Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali” adottata dal Comitato dei<br />
Ministri il 10 novembre 1994;<br />
le Raccomandazioni dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.<br />
Interventi della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa<br />
l’Atto Finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa - Helsinki 1975;<br />
le Conferenze per la sicurezza e la cooperazione in Europa di Madrid del 1983, di Vienna nel<br />
gennaio 1989, di Copenaghen nel giugno 1990, di Parigi nel novembre 1990, di Ginevra nel luglio<br />
1991, di Mosca nell’ottobre 1991, di Helsinki nel luglio 1992 e di Budapest nel dicembre<br />
1994.<br />
Interventi del Parlamento europeo<br />
le Risoluzioni del Parlamento Europeo.<br />
Interventi dell’Iniziativa Centro-Europea<br />
lo “Strumento CEI” per la tutela dei diritti delle minoranze (novembre 1994).<br />
Il contributo dell ‘Unione federalista dei gruppi Etnici Europei (UF.G.E.).<br />
il Progetto di Convenzione per la tutela dei gruppi etnici in Europa (12 maggio 1994).<br />
35
GLI INTERVENTI DELL’ORGANIZZAZIONE<br />
DELLE NAZIONI UNITE<br />
37
PREMESSA<br />
L’azione delle Nazioni Unite nel campo della tutela delle minoranze nasce inizialmente<br />
con esplicito richiamo alla protezione universale dei diritti dell’uomo, fra i quali sono compresi<br />
quelli di appartenenza non discriminata a particolari gruppi etnici, religiosi, linguistici.<br />
Nei primi documenti ufficiali delle Nazioni Unite, quindi, le minoranze venivano sostanzialmente<br />
identificate come gruppi etnici, religiosi o linguistici e non si distingueva fra “prevenzione<br />
della discriminazione”, cioè opposizione a qualsiasi azione che negasse ad individui, o a<br />
gruppi di individui, il trattamento da loro stessi auspicato, e “protezione delle minoranze”, vale a<br />
dire la tutela dei gruppi minoritari, con un insieme di misure tese ad un trattamento speciale, finalizzato<br />
a garantirne la conservazione delle caratteristiche peculiari fondamentali.<br />
Ulteriori principi di rilievo anche per le minoranze etniche vengono poi affermati nella<br />
Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale,<br />
adottata dall’Assemblea Generale il 21 dicembre 1965 e aperta alla firma a New York il 7 marzo<br />
1966, che dà esecuzione ai principi enunciati nella Dichiarazione sull’eliminazione di ogni forma<br />
di discriminazione razziale proclamata il 20 novembre 1963 (Risoluzione n. 1904 [XVIII]<br />
dell’Assemblea Generale).<br />
Essa si fonda sullo Statuto delle Nazioni Unite basato sui principi della dignità e della<br />
uguaglianza di tutti gli esseri umani e sull’impegno degli Stati membri a sviluppare ed incoraggiare<br />
il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali senza discriminazioni di razza,<br />
sesso, lingua o religione, e mira ad assicurare nel più breve tempo l’adozione di concrete misure<br />
a tale scopo.<br />
Ciò sulla base della considerazione, riaffermata nel “Preambolo”, che la discriminazione<br />
per motivi fondati sulla razza, sul colore o sull’origine etnica costituisce un ostacolo alle relazioni<br />
pacifiche ed amichevoli tra i vari Paesi ed è suscettibile di turbare la pace e la sicurezza tra i<br />
popoli e l’armoniosa convivenza all’interno degli Stati, e che l’esistenza di barriere razziali è incompatibile<br />
con gli ideali di ogni società umana.<br />
Con tale Convenzione, pertanto, gli Stati contraenti si impegnano sia a condannare la<br />
discriminazione razziale ed ogni connessa propaganda ed organizzazione che si ispiri a teorie<br />
basate sulla superiorità di una razza, sia ad adottare anche una politica tesa ad eliminare ogni<br />
forma di discriminazione razziale con l’attuazione di un insieme di misure volte a garantire il<br />
pieno godimento dei diritti fondamentali senza distinzione di razza, colore od origine nazionale o<br />
etnica e a favorire la comprensione, la tolleranza e l’amicizia tra le nazioni ed i gruppi razziali ed<br />
etnici.<br />
Pressoché contemporaneamente, nel dicembre 1966, le Nazioni Unite portano inoltre a<br />
compimento un altro intervento in difesa dei diritti umani, il Patto internazionale sui Diritti civili e<br />
politici, di particolare importanza per la protezione delle minoranze perché vi riserva una disposizione<br />
direttamente mirata, l’art. 27, con il quale si perviene al riconoscimento del diritto specifico,<br />
fino a giungere poi, dopo un lungo periodo di approfondimenti ed elaborazioni alla “Dichiarazione<br />
dei diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose o linguistiche”<br />
proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1992.<br />
39
L’ART. 27 DEL PATTO INTERNAZIONALE SUI <strong>DIRITTI</strong> CIVILI E POLITICI<br />
Senza dubbio il Patto internazionale sui Diritti civili e politici, adottato dall’Assemblea<br />
Generale dell’ONU il 16 dicembre 1966, e in particolare le previsioni contenute nell’articolo 27,<br />
rappresentano una tappa di grandissimo rilievo nel cammino per la tutela internazionale delle<br />
minoranze.<br />
Con la sua enunciazione di principio, infatti, l’art. 27 si pone come norma internazionale<br />
basilare in materia e ha, rispetto agli altri articoli del Patto, la peculiarità di essere specificamente<br />
previsto per le persone appartenenti a minoranze, disponendo che “in quegli Stati nei quali<br />
esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze<br />
non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare<br />
la propria religione o di usare la propria lingua in comunanza con gli altri membri del proprio<br />
gruppo”.<br />
Con la disposizione, inoltre, contenuta nell’art. 28 del Patto, che istituisce un “Comitato<br />
dei diritti dell’uomo”, l’attenzione delle Nazioni Unite per i diritti civili e politici in genere, tra i quali<br />
anche quelli delle minoranze specificamente considerati nell’art. 27, manifesta quella concretezza<br />
e quell’approccio pragmatico che si riscontreranno poi in altri importanti strumenti di tutela<br />
adottati in ambito europeo, quali la Carta europea delle Lingue regionali o minoritarie e la Convenzione<br />
quadro per la protezione delle minoranze nazionali, che prevedono meccanismi di verifica<br />
simili.<br />
Composizione, funzionamento e compiti del Comitato dei Diritti dell’Uomo, che sostanzialmente<br />
svolge funzioni di verifica sull’applicazione del Patto e di interpretazione delle relative<br />
norme, sono disciplinati dagli articoli 28 - 42.<br />
Per quanto concerne la sua composizione, i membri sono eletti tra una lista di cittadini<br />
degli Stati aderenti di riconosciuta competenza nel campo dei diritti dell’uomo ed è significativo<br />
che sia previsto che nella elezione “debba tenersi conto di un’equa ripartizione geografica dei<br />
seggi e della rappresentanza sia delle diverse forme di civiltà, sia dei principali sistemi giuridici”<br />
(art. 31).<br />
Compito del Comitato è quello di esaminare i rapporti che gli Stati sono tenuti a presentare<br />
(art. 40), di ricevere e valutare le comunicazioni “nelle quali uno Stato parte asserisca che<br />
un altro Stato parte non adempie gli obblighi derivanti dal Patto” (art. 41), nonché, in base al<br />
Protocollo Facoltativo relativo al Patto, le comunicazioni individuali provenienti da singoli cittadini<br />
di uno Stato che lamentino pretese violazioni di taluno dei diritti affermati nel Patto.<br />
Di particolare rilievo è indubbiamente il meccanismo di verifica previsto dall’art. 40: gli<br />
Stati che hanno aderito al Patto presentano, entro un anno e, successivamente, ogni volta che il<br />
Comitato ne farà richiesta, rapporti sulle misure adottate per dare attuazione ai diritti riconosciuti<br />
dal Patto e sui progressi compiuti nel godimento di tali diritti; il Comitato studia i rapporti presentati<br />
e trasmette agli Stati i propri rapporti e le osservazioni generali ritenute opportune, con facoltà,<br />
per gli Stati interessati, di presentare i propri rilievi circa le osservazioni eventualmente<br />
formulate dal Comitato stesso.<br />
Il Comitato, quindi, è chiamato anche a redigere “osservazioni generali” (General comments)<br />
riguardanti singole norme o gruppi di norme contenute nel Patto, che vengono elaborate<br />
sulla base dei rapporti periodici degli Stati e che spesso contengono inviti, richieste e suggerimenti<br />
operativi rivolti ai Governi.<br />
Sicché, attraverso un sistema di flusso e riflusso (rapporti degli Stati - valutazione, rapporti<br />
ed osservazioni generali del Comitato - eventuali deduzioni degli Stati interessati), si va ad<br />
attivare un circuito virtuoso ed integrato di informazioni che consente non soltanto di valutare<br />
ciò che via via viene in concreto posto in essere dai singoli Stati in attuazione del Patto, ma di<br />
realizzare anche, conseguentemente, un adeguamento continuo, e quindi una crescita del livello<br />
degli interventi di tutela.<br />
40
Ed infatti un contributo importante per una corretta interpretazione dell’articolo 27 viene<br />
fornito proprio dal Comitato con il “General Comment n. 23(50)” formulato il 26 aprile 1994, che<br />
svolge una puntuale analisi del contenuto e della portata della disposizione normativa, la quale<br />
“stabilisce e riconosce un diritto conferito alle persone appartenenti a gruppi minoritari”, diritto<br />
che “è distinto e va ad aggiungersi a tutti gli altri diritti” di cui tali persone, come ogni altro individuo,<br />
sono già titolari in base al Patto (p. 1).<br />
Il Comitato ha in proposito evidenziato (p. 2) che in alcune comunicazioni presentate ai<br />
sensi del Protocollo Facoltativo il diritto garantito dall’art. 27 è stato confuso con il diritto dei popoli<br />
all’autodeterminazione sancito nell’art. 1 del Patto, così come in alcuni rapporti presentati<br />
dagli Stati ai sensi dell’art. 40.<br />
Il Comitato ha al riguardo chiarito come la Convenzione tracci una distinzione tra il diritto<br />
all’autodeterminazione e i diritti garantiti ai sensi dell’art. 27: il diritto all’autodeterminazione<br />
viene definito come diritto spettante ai popoli, è trattato in una parte separata (la Parte I) del<br />
Patto e non è un diritto riconoscibile ai sensi del Protocollo Facoltativo; l’art. 27 invece, riguarda<br />
i diritti riconosciuti agli individui in quanto tali, è incluso, così come gli articoli relativi - agli altri<br />
diritti personali riconosciuti agli individui, nella Parte III della Convenzione ed è riconoscibile ai<br />
sensi del Protocollo Facoltativo (p. 3.1).<br />
Nello stesso General Comment viene inoltre ribadito che il godimento dei diritti di cui<br />
all’art. 27 non pregiudica la sovranità e l’integrità territoriale degli Stati (p. 3.2), ma viene anche<br />
ulteriormente sottolineata l’attenzione specifica che si è ritenuto di attribuire con tale norma alla<br />
tutela delle minoranze.<br />
Ed infatti, la specificità di tutela che si è voluta attribuire nel Patto alle persone appartenenti<br />
a minoranze è ampiamente evidenziata nel General Comment, ove si sottolinea la distinzione<br />
operata dal Patto tra i diritti tutelati ai sensi dell’art. 27 e le garanzie previste dagli articoli<br />
2 e 26 del Patto stesso (p. 4).<br />
In particolare, la titolarità del diritto di cui all’art. 2, di godere dei diritti sanciti dal Patto<br />
senza alcuna discriminazione si applica a “tutti gli individui” presenti sul territorio o che sono<br />
sotto la giurisdizione dello Stato a prescindere dalla loro appartenenza ad una minoranza”, come<br />
pure il diritto di cui all’art. 26, che afferma la generale uguaglianza, formale e sostanziale, di<br />
tutti gli individui di fronte alla legge, indipendentemente dal fatto che tali individui appartengano,<br />
o non appartengano, alle minoranze specificate nell’art. 27.<br />
Ed in proposito il Comitato rileva come taluni Stati, che vantino di non porre in essere<br />
comportamenti discriminatori in base all’etnia, alla lingua o alla religione, erroneamente sostengano,<br />
solo per questo fatto, di non avere minoranze (p.4), e precisa che “l’esistenza di una minoranza<br />
etnica, religiosa o linguistica in uno Stato parte non dipende da una decisione di questo<br />
Stato, ma richiede di essere stabilita in base a criteri oggettivi” (p. 5.2).<br />
Chiarimenti sono stati forniti dal Comitato anche in merito al diritto di usare la propria<br />
lingua da parte delle persone appartenenti a minoranze linguistiche, diritto che va distinto dagli<br />
altri diritti linguistici previsti dal Patto e, in particolare, dal generale diritto alla libertà di espressione<br />
tutelato dall’ art. 19, spettante ad ogni individuo a prescindere dalla sua appartenenza o<br />
meno ad una minoranza, come pure dal diritto specifico di farsi assistere da un interprete, che<br />
l’art. 14, paragrafo 3 lett. f), del Patto prevede per gli imputati quando non siano in grado di<br />
comprendere o di parlare la lingua utilizzata nei tribunali, ma che non implica in alcun modo il<br />
diritto di utilizzare la lingua di propria scelta nei procedimenti penali (p. 5.3).<br />
La chiave interpretativa dell’art. 27 in un’ottica positiva per le minoranze emerge anche<br />
dal contenuto del paragrafo 6.2 del General Comment, nel quale viene precisato che sebbene i<br />
diritti previsti dall’art. 27 siano diritti individuali, essi dipendono, a loro volta, dalla capacità del<br />
gruppo minoritario di conservare la propria cultura, lingua o religione; potrebbero, quindi, essere<br />
necessarie “anche azioni positive da parte degli Stati”, volte a proteggere l’identità di una minoranza<br />
ed il diritto dei suoi membri di conservare e sviluppare la propria cultura e lingua e di praticare<br />
la propria religione, in comunanza con gli altri membri del gruppo.<br />
41
Sull’art. 27 del Patto il Comitato conclusivamente afferma (p. 9) che esso “fa riferimento<br />
ai diritti la cui protezione impone obblighi specifici agli Stati parte. La tutela di questi diritti è volta<br />
a garantire la sopravvivenza ed il costante sviluppo dell’identità culturale, religiosa e sociale<br />
delle minoranze interessate, così arricchendo il tessuto dell’intera società”. Di conseguenza,<br />
questi diritti devono essere tutelati in quanto tali e non dovrebbero essere confusi con altri diritti<br />
personali riconosciuti al singolo o alla generalità dalla Convenzione. Gli Stati parte hanno, pertanto,<br />
l’obbligo di garantire il pieno rispetto dell’esercizio di questi diritti e nei loro rispettivi rapporti<br />
dovrebbero indicare le misure che hanno adottato a tale scopo.<br />
42
LA DICHIARAZIONE SUI <strong>DIRITTI</strong> DELLE PERSONE APPARTENENTI A MINORANZE NA-<br />
ZIONALI O ETNICHE, RELIGIOSE E LINGUISTICHE<br />
Dopo l’adozione del Patto internazionale sui Diritti civili e politici e del suo art. 27, specificamente<br />
rivolto ai diritti delle persone appartenenti a minoranze, l’impegno dell’ONU nel campo<br />
della tutela di tali minoranze è ulteriormente proseguito portando, nel 1992, alla proclamazione<br />
della “Dichiarazione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche,<br />
religiose e linguistiche” (Risoluzione 47/135) che si ispira appunto, come esplicitamente affermato<br />
nel Preambolo, alle disposizioni dell’art. 27 del Patto.<br />
Alla Risoluzione, adottata dall’Assemblea Generale il 18 dicembre 1992, si è giunti dopo<br />
una intensa attività di studi ed approfondimenti nell’ambito delle Nazioni Unite, e in particolare<br />
della Commissione dei Diritti dell’Uomo, che aveva anche istituito un gruppo di lavoro per la<br />
predisposizione di un progetto di dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze<br />
nazionali, etniche, religiose e linguistiche.<br />
La Dichiarazione si compone del Preambolo e di 9 articoli.<br />
Nel Preambolo si sottolinea innanzitutto l’importanza della promozione costante e della<br />
realizzazione dei diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e<br />
linguistiche, parte integrante dello sviluppo della società entro un quadro democratico di preminenza<br />
del diritto, come fattore di stabilità politica e sociale degli Stati nei quali esse vivono e di<br />
rafforzamento dell’amicizia e della cooperazione tra i popoli e gli Stati.<br />
Sulla base di tale fondamentale premessa, la Dichiarazione definisce conseguentemente<br />
gli obblighi di protezione delle minoranze facenti capo agli Stati ed enuncia i diritti spettanti<br />
alle persone appartenenti ad esse, prevedendo che il loro esercizio può avvenire sia individualmente<br />
che in comune con gli altri membri del proprio gruppo, senza discriminazione alcuna<br />
e senza pregiudizio per il fatto di esercitare o meno tali diritti.<br />
Con riguardo agli impegni degli Stati, definito all’art. 1 quello basilare della protezione<br />
dell’esistenza e dell’identità nazionale o etnica, culturale, religiosa e linguistica delle minoranze<br />
sui rispettivi territori e della promozione delle condizioni atte ad esprimere questa identità, si indicano,<br />
in successivi articoli, le misure che in concreto gli Stati devono adottare per assicurare<br />
l’esercizio dei diritti affermati nella Dichiarazione.<br />
I diritti spettanti agli appartenenti alle minoranze sono enunciati all’art. 2 e riguardano gli<br />
aspetti fondamentali delle peculiarità da tutelare.<br />
Così, viene affermato il diritto di usufruire della propria cultura, di praticare la propria religione<br />
e di utilizzare la propria lingua, liberamente e senza discriminazioni, nonché di partecipare<br />
effettivamente alla vita culturale, religiosa, sociale, economica e pubblica del Paese nel quale<br />
essi vivono.<br />
E’ altresì affermato il diritto di prendere parte attiva, sia a livello nazionale che,<br />
all’occorrenza, regionale, alle decisioni che riguardano la minoranza alla quale appartengono o<br />
che riguardano le regioni in cui vivono, come pure il diritto di creare e gestire proprie associazioni.<br />
Ed ancora, è previsto il diritto di stabilire e mantenere contatti liberi e pacifici con gli altri<br />
membri del gruppo e con persone appartenenti ad altre minoranze, e contatti al di là delle frontiere<br />
con cittadini di altri Stati con i quali sono legati dalla loro origine nazionale o etnica o dalla<br />
loro appartenenza religiosa o linguistica: diritto, questo, che riveste una valenza particolare per<br />
tutte quelle minoranze che, divise dal loro Stato-madre per vicende storiche o insediate in zone<br />
di frontiera, vogliano mantenere liberamente contatti transfrontalieri che permettano di promuovere<br />
e rafforzare la loro identità.<br />
Più volte la Dichiarazione ribadisce che l’esercizio dei diversi diritti enunciati deve avvenire<br />
senza alcuna discriminazione; ciò nell’evidente scopo di assicurare alle persone appartenenti<br />
alle minoranze le condizioni di piena eguaglianza davanti alla legge e rispetto al resto della<br />
popolazione dello Stato nel quale vivono.<br />
43
I diritti affermati nella Dichiarazione, così come previsto in altri documenti internazionali<br />
oggetto di esame in altra parte della trattazione, sono diritti individuali in quanto riconosciuti alle<br />
persone appartenenti alle minoranze e non alle minoranze in quanto tali; va però considerato al<br />
riguardo che il concreto esercizio di molti di questi diritti non potrà non avvenire in comunanza<br />
con gli altri membri del gruppo, ed anzi, lo stesso articolo 3 della Dichiarazione prevede espressamente<br />
che “le persone appartenenti alle minoranze possono esercitare i propri diritti, cioè<br />
quelli enunciati nella presente Dichiarazione, individualmente come pure in comune con gli altri<br />
membri del proprio gruppo, senza alcuna discriminazione”.<br />
Parallelamente ai diritti, vengono definiti gli strumenti che gli Stati devono adottare per<br />
garantirne il concreto esercizio, senza discriminazione alcuna: misure legislative ed altre misure<br />
per conseguire le finalità di protezione dell’esistenza e dell’identità delle minoranze; appropriate<br />
misure per permettere alle persone appartenenti alle minoranze di esprimere le proprie caratteristiche<br />
e sviluppare la propria cultura, lingua, tradizioni e costumi, come pure per assicurare<br />
“nella misura del possibile” l’opportunità di apprendere la propria lingua madre o di ricevere un<br />
insegnamento in tale lingua; iniziative nel campo dell’istruzione al fine di incoraggiare la conoscenza<br />
della storia, delle tradizioni, della lingua e della cultura delle minoranze che vivono sui<br />
loro territori, nonché misure adeguate per consentire la piena partecipazione al progresso e allo<br />
sviluppo economico del loro Paese.<br />
Ovviamente, al pari degli altri strumenti internazionali, anche nella Dichiarazione sui diritti<br />
delle persone appartenenti a minoranze la protezione prevista incontra il limite del rispetto<br />
dei diritti fondamentali degli Stati perché, come è affermato nell’art. 8, nessuna disposizione può<br />
essere interpretata come autorizzazione ad una qualunque attività contraria agli scopi e ai principi<br />
delle Nazioni Unite, ivi compresa l’uguaglianza sovrana, l’integrità territoriale e<br />
l’indipendenza politica degli Stati.<br />
La Dichiarazione dell’ONU rivela, dunque, la radicata coscienza, chiaramente esplicitata<br />
anche nel Preambolo, che per la tutela dei diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali<br />
o etniche, religiose e linguistiche, è necessaria la previsione di strumenti ancora più mirati<br />
rispetto a quelli concernenti i diritti umani, che sono riferiti alla generalità delle persone e<br />
che, seppure ricomprendono in tale ambito anche gli appartenenti a gruppi minoritari, non garantiscono<br />
appieno la protezione degli aspetti che sono peculiari della identità delle minoranze<br />
in quanto tali.<br />
Con la Dichiarazione delle Nazioni Unite si è inteso quindi realizzare, nel contesto dei<br />
principi sui diritti umani e sulle libertà fondamentali e nel quadro delle azioni per promuoverne<br />
ed incoraggiarne il rispetto, una protezione mirata dei gruppi minoritari con l’enunciazione di diritti<br />
specifici e la previsione di corrispondenti obblighi degli Stati e di misure speciali, demandando<br />
però agli Stati stessi la scelta dei contenuti, della portata, e talora della necessità, di specifiche<br />
misure, onde permettere ad essi di tenere conto delle situazioni esistenti nei rispettivi territori.<br />
44
GLI INTERVENTI DEL CONSIGLIO D’EUROPA<br />
45
PREMESSA<br />
Il problema della tutela delle minoranze etniche e linguistiche ha costantemente formato<br />
oggetto di particolare attenzione da parte del Consiglio d’Europa, fin dalla sua costituzione, divenendo<br />
nel tempo uno dei più importanti impegni dell’Organismo.<br />
Già nel 1949, nel rapporto concernente l’organizzazione di una garanzia comune delle<br />
libertà essenziali e dei diritti fondamentali, presentato dalla Commissione sulle Questioni giuridiche<br />
ed amministrative (Doc. 77), veniva unanimemente riconosciuta l’importanza “del problema<br />
di una più ampia protezione dei diritti delle minoranze nazionali” e nel proposto progetto di<br />
risoluzione per definire le linee generali di una convenzione sui diritti umani, allora allo studio, si<br />
prevedeva espressamente anche il principio della non discriminazione fondata, tra l’altro, sulla<br />
lingua o sull’appartenenza ad una minoranza nazionale.<br />
Così, quando l’impegno del Consiglio d’Europa si concretizzò con la definitiva messa a<br />
punto della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,<br />
firmata a Roma il 4 novembre 1950, all’articolo 14 fu sancito tale principio, vietando<br />
ogni forma di discriminazione nel godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella Convenzione<br />
che fosse fondata su elementi tra i quali la lingua o l’appartenenza ad una minoranza nazionale.<br />
Vi fu quindi, nel più generale contesto della garanzia dei diritti umani e delle libertà fondamentali,<br />
un riferimento specifico anche alle minoranze, ma non si andò oltre l’affermato principio<br />
del divieto di ogni forma di discriminazione, ritenuto di per sé sufficiente a garantire una<br />
adeguata protezione.<br />
La questione continuava però a tenere viva l’attenzione del Consiglio d’Europa e fu ripresa<br />
dall’Assemblea Parlamentare con la Risoluzione 136 del 29 ottobre 1957 sulla situazione<br />
delle minoranze nazionali in Europa, questa volta per affermare che, sebbene l’art. 14 della<br />
Convenzione sui Diritti Umani già fornisse alle persone appartenenti alle minoranze nazionali.<br />
soddisfacenti garanzie di protezione da ogni forma di discriminazione fondata su tale appartenenza,<br />
era pur tuttavia auspicabile assicurare alle minoranze il soddisfacimento dei loro interessi<br />
collettivi “in tutta la misura compatibile” con la salvaguardia degli interessi essenziali degli<br />
Stati di appartenenza.<br />
Ed ancora, a seguito del rapporto della Commissione giuridica consultiva sui diritti delle<br />
minoranze nazionali (Doc. 1299 del 26 aprile 1961, Relatore Lannung), l’Assemblea tornò ad<br />
insistere sul problema di uno specifico intervento per le minoranze nazionali invocando, con la<br />
Raccomandazione 285 del 1961, l’adozione di un’apposita disposizione, di cui proponeva il testo,<br />
da inserire in un secondo protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea sui Diritti<br />
dell’Uomo.<br />
L’approfondimento condotto da un comitato di esperti portò però ad escludere la necessità,<br />
sotto il profilo strettamente giuridico, di un ulteriore protocollo per la protezione delle minoranze.<br />
Un rilevante passo in avanti si ha nel 1981 con la Raccomandazione 928 riguardante i<br />
problemi dell’educazione e della cultura delle lingue minoritarie e dei dialetti in Europa, adottata<br />
dall’Assemblea Parlamentare il 7 ottobre: sulla considerazione della grande importanza “per il<br />
progresso dell’Europa e dell’idea europea di assicurare il rispetto e lo sviluppo equilibrato di tutte<br />
le culture europee, e delle identità linguistiche in particolare”, essa definiva i principi che avrebbero<br />
dovuto ispirare il trattamento scientifico, umano e culturale di ogni lingua - e cioè il rispetto<br />
dell’autenticità scientifica, il diritto dei bambini alla propria lingua ed il diritto delle comunità<br />
a sviluppare la propria lingua e cultura -, raccomandando al Comitato dei Ministri di esaminare<br />
la possibilità per gli Stati membri di realizzare, nei modi più appropriati, talune misure con riguardo<br />
all’aspetto scientifico, umano, culturale e politico.<br />
Si indicavano in particolare, per l’aspetto scientifico, la graduale adozione, ove del caso<br />
in aggiunta alla denominazione divenuta usuale, di forme corrette della toponomastica derivate<br />
dalla lingua originale di ciascun territorio, ancorché piccolo; sotto l’aspetto umano, la graduale<br />
47
adozione della lingua materna nell’istruzione dei bambini; con riguardo all’aspetto culturale, “il<br />
rispetto ed il sostegno ufficiale dell’uso, a livello locale, delle lingue minoritarie standardizzate e<br />
del loro impiego abituale nell’insegnamento superiore e da parte dei mezzi di comunicazione di<br />
massa locali”; ed infine, sotto l’aspetto politico, la possibilità, in tutti i territori aventi una lingua<br />
propria e un qualche livello di struttura amministrativa nell’ambito dello Stato di appartenenza, di<br />
adottare tale lingua come lingua ufficiale o co-ufficiale da parte dei pubblici poteri locali.<br />
Si manifestava con chiarezza, quindi, l’importanza attribuita alle lingue minoritarie ed al<br />
loro uso quale strumento essenziale, per le minoranze, per esprimere e mantenere la propria<br />
identità, importanza che veniva sottolineata in quello stesso periodo anche dal Parlamento Europeo<br />
con un documento di grande rilievo nella medesima materia, la Risoluzione su una Carta<br />
comunitaria delle lingue e culture regionali e una Carta dei diritti delle minoranze etniche, adottata<br />
il 16 ottobre 1981.<br />
Con sempre maggiore forza in ambito europeo andava pertanto maturando non soltanto<br />
l’esigenza di una normativa internazionale mirata per la protezione delle minoranze etniche e<br />
linguistiche che affermasse i principi fondamentali di tutela, ma anche la necessità di tradurre<br />
tali principi in misure attuative concrete da parte degli Stati, al fine di rendere effettiva la tutela<br />
stessa.<br />
Verso tale direzione ha perciò continuato a rivolgersi il successivo, crescente impegno<br />
del Consiglio d’Europa, che ha portato, dopo anni di intenso e complesso lavoro,<br />
all’approvazione di due strumenti di fondamentale importanza per la protezione delle minoranze,<br />
la “Carta europea delle Lingue regionali o minoritarie” e la “Convenzione quadro per la protezione<br />
delle minoranze nazionali”, entrambe adottate in forma di convenzione proprio per rendere<br />
più cogenti per gli Stati firmatari gli obblighi in esse previsti.<br />
La “Carta”, adottata dal Comitato dei Ministri il 25 giugno 1992, ha scopo prevalentemente<br />
culturale essendo volta alla protezione ed alla promozione delle lingue regionali o minoritarie,<br />
di cui mira a garantire l’uso in tutti i settori della vita civile mediante un insieme di specifiche<br />
misure di tutela e la previsione di impegni per gli Stati firmatari, con l’accettazione di un<br />
numero minimo di prescrizioni al momento della ratifica.<br />
48
LA CARTA EUROPEA DELLE LINGUE REGIONALI E/O MINORITARIE<br />
La definizione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie ha richiesto un intenso<br />
impegno di studio e lavoro sviluppatosi nell’arco di circa un decennio.<br />
Il Rapporto esplicativo della Carta, che ne illustra diffusamente obiettivi e contenuti fornendo<br />
un approfondito ed analitico commentario alle singole disposizioni, spiega anche le ragioni<br />
di fondo e ripercorre i passaggi per giungere all’adozione dello strumento, nel 1992, da<br />
parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.<br />
Circa le ragioni, il Rapporto evidenzia che le numerose lingue regionali o minoritarie<br />
presenti in molti Paesi europei, a fronte di notevoli differenziazioni sia con riguardo alla loro situazione<br />
demografica che alla legislazione ed alla prassi seguita in materia dai singoli Stati,<br />
hanno però in comune, per buona parte, un livello più o meno alto di precarietà, dovuta “almeno<br />
in eguale misura da un lato all’influenza necessariamente unificante della civiltà moderna e in<br />
particolar modo dei mass media, e dall’altro ad un ambiente ostile o a politiche governative volte<br />
all’assimilazione” (par. 2).<br />
Di qui una sempre crescente preoccupazione, in ambito europeo, per la situazione e<br />
per la sorte di tali lingue e, parallelamente, il maturarsi di una progressiva presa di coscienza<br />
della necessità di andare oltre il pur fondamentale principio della non discriminazione sancito<br />
dalla Convenzione europea del 1950 per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali,<br />
realizzando un sistema di protezione positiva delle lingue regionali o minoritarie atto a<br />
preservarne l’esistenza e le peculiarità.<br />
Anche in tale direzione si mosse perciò la già citata Raccomandazione 285 del 1961<br />
dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, che con il progetto di norma proposto mirava<br />
a garantire alle persone appartenenti a minoranze il diritto, tra gli altri, a mantenere la propria<br />
cultura, ad usare la propria lingua, ad istituire proprie scuole e a ricevere l’insegnamento<br />
nella lingua di propria scelta.<br />
Ma l’idea di una apposita Carta con obiettivi e principi, obblighi per gli Stati e misure<br />
concrete di tutela specifica da attuare, prende soprattutto corpo con la Raccomandazione 928<br />
dell’Assemblea Parlamentare sui problemi dell’educazione e della cultura delle lingue minoritarie<br />
e dei dialetti d’Europa e con la Risoluzione del Parlamento Europeo su una Carta delle lingue<br />
e culture regionali e una Carta dei diritti delle minoranze etniche, entrambe approvate nel<br />
1981 ed entrambe volte all’adozione, da parte degli Stati, di politiche ed azioni positive di protezione<br />
delle diverse identità e patrimoni culturali, quale contributo importante per lo sviluppo<br />
dell’Europa e dell’idea europea e per la coesione dei popoli.<br />
Come evidenziato nel Rapporto esplicativo, la conseguente iniziativa, in ragione del<br />
ruolo da svolgere nel campo delle lingue e delle culture a livello locale e regionale, fu assunta<br />
dalla Conferenza Permanente sulle Autorità Locali e Regionali in Europa (CLRAE), che eseguì<br />
innanzitutto una ricognizione della situazione di tali lingue in ambito europeo ed organizzò anche,<br />
nel maggio 1984, una audizione pubblica dedicata allo specifico tema “Verso una Carta<br />
delle lingue regionali e minoritarie in Europa”, trattando gli argomenti dell’insegnamento delle<br />
lingue minoritarie, del loro accesso ai mezzi di comunicazione di massa, dei rapporti con la<br />
pubblica amministrazione e della partecipazione alla vita pubblica.<br />
Così, da una intensa attività preparatoria scaturì una prima bozza di Carta, alla cui redazione<br />
partecipò anche I ‘Assemblea Parlamentare e furono tenuti contatti con membri del<br />
Parlamento Europeo, atteso il forte interesse per il tema sempre concretamente dimostrato dai<br />
due Organismi.<br />
Il testo finale del progetto fu presentato dalla Conferenza Permanente nel 1988 e ciò<br />
che è di particolare rilievo per gli effetti connessi – venne proposto sotto forma di convenzione,<br />
destinata cioè, in quanto tale, ad avere natura di strumento giuridicamente impegnativo per gli<br />
Stati firmatari.<br />
L’iniziativa ebbe il sostegno dell’Assemblea Parlamentare, cui seguì l’istituzione, da parte<br />
del Comitato dei Ministri, di un Comitato ad hoc di esperti sulle lingue regionali o minoritarie<br />
49
(CAHLR) con il compito di elaborare una Carta tenendo presente il testo proposto dalla Conferenza<br />
Permanente sulle Autorità Locali e Regionali.<br />
Dopo approfonditi lavori, che naturalmente videro la partecipazione anche dei rappresentanti<br />
della Conferenza Permanente e dell’Assemblea Parlamentare e che inoltre si avvalsero<br />
dei pareri della Commissione Europea per la Democrazia attraverso il Diritto e di comitati specializzati<br />
operanti nell’ambito del Consiglio d’Europa, nel 1992 la bozza definitiva della Carta<br />
Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie veniva presentata al Comitato dei Ministri, che il<br />
25 giugno dello stesso anno l’ha adottata, come proposto, in forma di convenzione, così traducendo<br />
gli impegni politici assunti dagli Stati nelle diverse sedi internazionali in impegni giuridicamente<br />
vincolanti.<br />
La Carta, aperta alla firma degli Stati membri dal 5 novembre 1992, è entrata in vigore il<br />
10 marzo 1998 dopo la prescritta ratifica di cinque Stati membri e, a partire da tale data, può<br />
aderirvi anche ogni Stato non membro su invito del Comitato dei Ministri (articoli 18-20).<br />
Essa si compone del Preambolo e di cinque Parti, per complessivi 23 articoli.<br />
La Convenzione ha principalmente uno scopo culturale, come evidenziato nelle “Considerazioni<br />
generali” del Rapporto esplicativo, essendo mirata a proteggere e a promuovere le<br />
lingue regionali o minoritarie, “in quanto costituiscono un elemento a rischio del patrimonio culturale<br />
europeo”(par. 10).<br />
Lo stesso Preambolo sottolinea questo aspetto facendo anche trasparire le preoccupazioni<br />
degli Stati membri del Consiglio d’Europa per la sopravvivenza di tali lingue, “certune delle<br />
quali, col passare del tempo, rischiano di scomparire”, ed espressamente richiama l’importanza<br />
attribuita dagli Stati stessi alla protezione ed alla promozione delle lingue regionali o minoritarie<br />
quale contributo “a mantenere e sviluppare le tradizioni e la ricchezza culturale dell’Europa” e<br />
“alla costruzione di una Europa fondata sui principi della democrazia e della diversità culturale,<br />
nel quadro della sovranità nazionale e dell’integrità territoriale”, in conformità dei fini perseguiti<br />
dal Consiglio d’Europa.<br />
Protezione e promozione da conseguire, dunque, attraverso un sistema di garanzie e di<br />
concrete misure specifiche per assicurare il godimento del diritto di praticare una lingua regionale<br />
o minoritaria nella vita privata e pubblica, diritto definito “imprescrittibile” nel Preambolo,<br />
che si richiama al Patto Internazionale sui Diritti civili e politici dell’ONU e alla Convenzione Europea<br />
per la salvaguardia dei diritti umani del Consiglio d’Europa, e che fa riferimento all’attività<br />
svolta nel quadro della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa e, in particolare,<br />
all’Atto Finale di Helsinki del 1975 e al Documento della Riunione di Copenaghen deI 1990,<br />
di cui più diffusamente si dirà nel seguito della trattazione.<br />
In tale ottica la Carta, oltre a contenere una disposizione (art. 7 paragrafo 2) espressamente<br />
volta ad eliminare ogni “ingiustificato” comportamento discriminatorio che abbia lo scopo<br />
di scoraggiare l’uso di una lingua regionale o minoritaria o di metterne in pericolo il mantenimento<br />
o lo sviluppo, prevede anche misure positive di tutela tese ad assicurare, facilitare ed incoraggiare<br />
l’uso di tali lingue nei diversi contesti della vita sociale, sia in privato che in pubblico,<br />
e in particolare nell’insegnamento, nel campo giudiziario, amministrativo e dei servizi pubblici,<br />
nel campo dei mezzi di comunicazione di massa e nelle attività culturali, economiche e sociali.<br />
Il Rapporto esplicativo, che fornisce la chiave per una corretta interpretazione ed applicazione<br />
dei principi enunciati e delle disposizioni contenute nella convenzione, nelle “Considerazioni<br />
generali” spiega la filosofia di fondo che ha ispirato la Carta nel sottolineare<br />
“l’importanza della dimensione culturale e dell’uso della lingua regionale o minoritaria in tutti gli<br />
aspetti della vita di coloro che la parlano”: la Carta, che come detto ha precipuo scopo culturale,<br />
si prefigge di proteggere e promuovere le lingue regionali o minoritarie, non le minoranze linguistiche,<br />
e “non stabilisce alcun diritto individuale o collettivo riferito alle persone” che parlano tali<br />
lingue; “pur tuttavia — sottolinea il Rapporto esplicativo — i doveri delle Parti in relazione alla<br />
posizione di tali lingue e gli strumenti legislativi nazionali che dovranno essere introdotti in adempimento<br />
della Carta avranno ovviamente il loro effetto sulla situazione delle comunità interessate<br />
e sui singoli membri”(par. 11).<br />
50
Chiarisce inoltre il Rapporto esplicativo che l’affermazione dei principi di interculturalità<br />
e multilinguismo contenuta nel Preambolo è tesa ad eliminare eventuali equivoci circa gli scopi<br />
della Carta, la quale, lungi dal voler promuovere forme di segregazione dei gruppi linguistici, mira<br />
al contrario a rafforzare le relazioni tra i popoli e ad una migliore comprensione tra i vari<br />
gruppi di una stessa popolazione, e riconosce quindi, espressamente, nel Preambolo la necessità<br />
di conoscere la lingua ufficiale sottolineando che la protezione e la promozione delle lingue<br />
regionali o minoritarie non deve svolgersi a detrimento delle lingue ufficiali degli Stati e del loro<br />
apprendimento (paragrafi 14 e 29).<br />
Per meglio orientare nella comprensione, e quindi nell’applicazione della Carta, il Rapporto<br />
esplicativo fa precedere il commento delle singole disposizioni da chiarimenti anche sui<br />
concetti di base contenuti nella convenzione, sulla terminologia utilizzata e sulla filosofia di fondo<br />
che ha ispirato le scelte operate in merito (paragrafi 17-21). In sintesi, viene evidenziato che:<br />
- il concetto di lingua come usato nella Carta mette a fuoco essenzialmente la funzione culturale<br />
della lingua ed è per ciò che da essa non viene definita soggettivamente in modo tale da<br />
consacrare un diritto individuale, cioè il diritto di parlare “la propria lingua”, né si è inteso dare<br />
“una definizione socio-politica o etnica” del concetto di lingua; conseguentemente, la Carta<br />
“può astenersi dal definire il concetto di minoranze linguistiche, giacchè il suo scopo non è<br />
sancire i diritti dei gruppi minoritari etnici e/o culturali, bensì di proteggere e promuovere le<br />
lingue regionali o minoritarie in quanto tali”;<br />
- nell’espressione “lingue regionali o minoritarie”, preferita rispetto ad altre quali “lingue meno<br />
diffuse”, il termine “regionale sta ad indicare le lingue parlate in una parte limitata del territorio<br />
di uno Stato, nel quale peraltro possono essere parlate dalla maggioranza dei cittadini, mentre<br />
con il termine “minoritarie” si fa riferimento a situazioni nelle quali la lingua è parlata o da<br />
persone che non sono concentrate in una parte specifica del territorio di uno Stato, ovvero da<br />
un gruppo di persone che, pur se concentrato in una parte del territorio dello Stato, è numericamente<br />
inferiore rispetto alla popolazione di questa regione che parla la lingua della maggioranza;<br />
- entrambi gli aggettivi fanno perciò riferimento a criteri di fatto e non a nozioni giuridiche, e in<br />
ogni caso sono riferiti alla specifica situazione dei singoli Stati;<br />
- l’assenza, nella Carta, di una distinzione tra le diverse categorie di lingue regionali o minoritarie<br />
in base alle rispettive situazioni è il risultato di una scelta precisa che ha tenuto conto delle<br />
notevoli differenze delle situazioni linguistiche esistenti negli Stati europei e che ha perciò<br />
portato a limitarsi alla sola definizione di lingua regionale o minoritaria, pur permettendo agli<br />
Stati di adattare le proprie iniziative alla situazione di ciascuna lingua nei rispettivi territori;<br />
- si è parimenti preferito non specificare quali delle lingue europee avessero le caratteristiche<br />
rispondenti alla definizione di lingua regionale o minoritaria data dalla Carta: un siffatto elenco<br />
sarebbe stato, infatti, certamente messo in discussione sotto vari profili, e, comunque, avrebbe<br />
avuto un valore limitato tenuto conto dell’ampia discrezionalità lasciata alle Parti nello<br />
scegliere quali norme, in particolare della Parte III, applicare e a quali lingue applicarle.<br />
Oltre al Preambolo, la Carta si compone di cinque Parti.<br />
Nella Parte I (artt. 1-6) si danno innanzitutto le definizioni del concetto di “lingue regionali<br />
o minoritarie” e del relativo “territorio”, e si fissa la cornice degli impegni che gli Stati firmatari<br />
devono assumere, in ciò operando una distinzione tra la Parte Il e la Parte III.<br />
La Parte II (art.7) enuncia, infatti, una serie di principi generali comuni, che si applicano<br />
a tutte le lingue regionali o minoritarie come definite nella Parte I; le disposizioni della Parte III<br />
(artt. 8-14) prevedono invece misure specifiche da attuare nei diversi campi della vita civile, lasciando<br />
però agli Stati margini anche ampi di discrezionalità circa le disposizioni da applicare e<br />
le relative, numerose opzioni alternative da scegliere, così da tenere conto delle differenti situazioni<br />
delle lingue regionali o minoritarie esistenti sul territorio e delle implicazioni, sotto il profilo<br />
finanziario ed organizzativo, che l’adozione delle diverse misure di tutela comporta.<br />
51
A tale riguardo il Rapporto esplicativo, nell’evidenziare il carattere di flessibilità che per<br />
tali rilevanti ragioni si è ritenuto di conferire a molti punti della Carta, opportunamente sottolinea<br />
l’importanza che alle Parti sia data inoltre la possibilità (art. 3, par. 2) di integrare i propri impegni<br />
anche in ogni momento successivo, in relazione agli sviluppi della situazione giuridica o delle<br />
capacità finanziarie dei Paesi interessati.<br />
La Parte IV (artt. 15-17) contiene poi le disposizioni applicative e prevede anche un<br />
puntuale meccanismo di verifica in adempimento della Carta e degli impegni assunti, mentre la<br />
Parte V (artt. 18-23) reca le disposizioni finali.<br />
Le definizioni del concetto di “lingue regionali o minoritarie” e di “territorio di una lingua<br />
regionale o minoritaria” sono contenute nell’art. 1.<br />
In particolare, con l’espressione “lingue regionali o minoritarie” si intendono quelle “usate<br />
tradizionalmente in un territorio di uno Stato da cittadini di questo Stato che costituiscono un<br />
gruppo numericamente inferiore al resto della popolazione e che sono “differenti dalla(e) lingua(e)<br />
ufficiale(i) di questo Stato”.<br />
Viene al riguardo esplicitamente precisato che l’espressione “non include i dialetti della<br />
lingua ufficiale o le lingue dei migranti”.<br />
La Carta, quindi, non si rivolge né alle varianti locali o ai diversi dialetti di una stessa<br />
lingua, né alle lingue usate dagli immigrati.<br />
Quanto alle varianti locali ed ai dialetti di una lingua, il Rapporto esplicativo chiarisce<br />
che la Carta non ha ritenuto di affrontare la relativa dibattuta questione, lasciando agli Stati il<br />
compito di determinare le condizioni in cui una forma di espressione va a costituire una lingua<br />
separata (par. 32).<br />
Circa le lingue dei migranti, il Rapporto evidenzia (par. 31) come la Carta non abbia lo<br />
scopo di risolvere i problemi dei recenti fenomeni immigratori, di cui non si occupa, bensì quello<br />
di tutelare soltanto le lingue storiche, così come dimostrano anche le espressioni “lingue regionali<br />
o minoritarie storiche d’Europa” e lingue “tradizionalmente usate”, rispettivamente indicate<br />
nel Preambolo e nella definizione data nell’art. 1, lett. a sub i.<br />
Tre sono quindi, come posto in evidenza nel Rapporto esplicativo, gli aspetti sottolineati<br />
nella definizione data dalla Carta per qualificare una lingua come regionale o minoritaria:<br />
- essere “tradizionalmente usata”;<br />
- essere diversa da quella parlata dal resto della popolazione;<br />
- avere una base territoriale, essere cioè usata tradizionalmente in una particolare area geografica;<br />
e ciò “per il fatto che, per la maggior parte, le misure di tutela che la Carta propugna<br />
richiedono la definizione di un ambito geografico di applicazione diverso da quello dello Stato<br />
nel suo complesso” (par. 33).<br />
Donde la definizione, nella lettera b) dell’art. 1, anche di “territorio nel quale la lingua regionale<br />
o minoritaria viene usata”, inteso come “l’area geografica in cui tale lingua è il modo di<br />
espressione di un numero di persone che giustifichi l’adozione delle differenti misure di protezione<br />
e di promozione” previste dalla Carta; una consistenza percentuale che però si è preferito<br />
non quantificare, demandandone la valutazione ai singoli Stati.<br />
Una ulteriore distinzione è operata con riguardo a quelle che vengono definite come<br />
“lingue sprovviste di territorio” (art. 1, lett. c), intese come lingue che “benché tradizionalmente<br />
praticate sul territorio dello Stato, non possono essere ricollegate ad un’area geografica particolare”.<br />
Per tali lingue, che in mancanza di una base territoriale non rientrano tra le lingue regionali<br />
o minoritarie come definite nella lettera a), i principi saranno applicati dalle Parti “mutatis mutandis”<br />
e “la natura e la portata” delle misure di tutela da attuare “saranno determinate in modo<br />
flessibile”, tenendo conto dei bisogni e dei voti e nel rispetto delle tradizioni e delle caratteristiche<br />
dei gruppi che le usano (art. 7 par. 5).<br />
52
Per l’applicazione delle norme di tutela è riconosciuto il ruolo determinante di ogni singolo<br />
Stato, al quale viene rimessa facoltà di scelte, sia pure entro certi ambiti.<br />
Ferma restando, infatti, l’applicazione dei principi e degli obiettivi contenuti nella Parte Il<br />
per tutte le lingue regionali o minoritarie praticate sul territorio che siano rispondenti alle definizioni<br />
date dalla Carta (art. 2, paragrafo 1), è previsto che ciascuno Stato debba specificare nello<br />
strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, ogni lingua regionale o minoritaria od<br />
ogni lingua ufficiale meno usata su tutto o su una parte del suo territorio, alla quale devono essere<br />
applicati i paragrafi scelti in conformità al paragrafo 2 dell’art. 2 (art.3, paragrafo 1).<br />
Per ogni lingua così specificata lo Stato si impegna ad applicare un minimo di trentacinque<br />
paragrafi o commi, scelti fra le disposizioni della Parte III (insegnamento; giustizia; autorità<br />
amministrative e servizi pubblici; mezzi di comunicazione di massa; attività ed attrezzature culturali;<br />
vita economica e sociale; scambi transfrontalieri), di cui almeno tre scelti in ciascuno degli<br />
articoli 8 (insegnamento) e 12 (attività e strutture culturali) ed uno in ciascuno degli articoli 9<br />
(giustizia), 10 (autorità amministrative e servizi pubblici), 11 (mass media) e 13 (vita economica<br />
e sociale).<br />
E’ comunque inoltre previsto, come già evidenziato, che ciascuno Stato possa poi, in<br />
ogni successivo momento, accettare ulteriori obbligazioni non precisate all’atto della ratifica o<br />
specificare altre lingue regionali o minoritarie cui applicare le disposizioni, potendo così accrescere<br />
i propri impegni nel tempo tenuto anche conto delle concrete capacità di farvi fronte (art. 3<br />
paragrafo 2).<br />
In sostanza, quindi, agli Stati viene lasciata libertà di decidere a quali lingue indirizzare<br />
la protezione e a quale livello assicurarla.<br />
Chiarisce però in proposito il Rapporto esplicativo che gli Stati che aderiscono alla Carta<br />
non hanno la libertà di concedere o rifiutare ad una lingua regionale o minoritaria la posizione<br />
assicurata ai sensi della Parte II, che ha portata generale, ma che essi, in quanto competenti<br />
per l’applicazione della Carta, hanno la responsabilità di decidere se la forma di espressione<br />
praticata in un’area del loro territorio o da un gruppo di loro cittadini costituisca una lingua regionale<br />
o minoritaria nel senso previsto dalla Carta, nonché quali misure concrete adottare nel<br />
quadro della Parte III (par. 40).<br />
La Carta si presenta, perciò, come uno strumento altamente flessibile per la protezione<br />
delle diverse lingue regionali o minoritarie, che tiene conto della interdipendenza tra livello di<br />
protezione da accordare e quadro complessivo giuridico, sociale ed economico di ciascuno Stato,<br />
riconoscendo ad ogni Stato firmatario la possibilità di diverse opzioni alternative, “secondo la<br />
situazione di ciascuna lingua” (cfr. art.7 e articoli della Parte III).<br />
Tutto ciò nel rispetto del principio della sovranità nazionale e dell’integrità territoriale e<br />
con la salvaguardia delle disposizioni più favorevoli, preesistenti in uno Stato, che regolano la<br />
situazione delle lingue regionali o minoritarie o la posizione giuridica delle persone appartenenti<br />
alle minoranze (articoli 4 e 5).<br />
Le disposizioni contenute nella Parte II (art.7) - che, come detto, si applicano a tutte le<br />
lingue regionali o minoritarie come definite dalla Carta - fissano gli obiettivi ed i principi generali<br />
comuni sui quali “nei territori ove tali lingue sono usate e secondo la situazione di ciascuna lingua”<br />
gli Stati contraenti devono fondare la propria politica, legislazione e prassi in materia. Obiettivi<br />
e principi che secondo il Rapporto esplicativo (paragrafi 57-70) costituiscono “il necessario<br />
quadro di riferimento per la conservazione delle lingue regionali o minoritarie” e che sono<br />
suddivisi in sei categorie principali:<br />
- il riconoscimento di tali lingue come espressione della ricchezza culturale, presupposto indispensabile<br />
per l’adozione delle misure di tutela (par. 1 lett a);<br />
- il rispetto dell’area geografica ove le lingue regionali o minoritarie insistono, evitando che le<br />
situazioni amministrative territoriali esistenti o le ripartizioni nuove costituiscano un ostacolo<br />
alla loro promozione (par. 1 lett. b);<br />
53
- la necessità di azioni positive, con una azione di promozione per la salvaguardia di tali lingue<br />
che deve essere “risoluta” e che deve comprendere anche misure volte a facilitare e ad incoraggiare<br />
il loro uso orale e scritto sia in privato che nella vita pubblica (par. 1 lett. c e lett. d);<br />
- la garanzia dell’insegnamento e dello studio delle lingue regionali o minoritarie, strumento<br />
essenziale per la loro preservazione e per il loro sviluppo, da assicurarsi “con forme e mezzi<br />
adeguati” e “in tutte le fasi appropriate” del sistema scolastico e con la promozione di studi e<br />
ricerche nelle università e negli istituti equivalenti (par. 1 lett. f e lett. h);<br />
- la messa a disposizione, nei territori ove è usata una lingua regionale o minoritaria, di mezzi<br />
che permettano agli abitanti non locutori di apprenderla (par. 1 lett. g); ciò al fine di favorire la<br />
comunicazione ed i rapporti tra gruppi linguistici diversi;<br />
- relazioni tra gruppi parlanti una lingua identica o simile, da promuovere, nei campi coperti<br />
dalla Carta, sia all’interno di uno Stato, sia al di là delle frontiere nazionali con “forme appropriate<br />
di scambi transnazionali”, nonché, sempre allo scopo di favorire il dialogo interculturale<br />
ed una migliore reciproca comprensione all’interno di uno Stato, relazioni culturali con altri<br />
gruppi del medesimo Stato che parlano lingue diverse (par. 1 lett. e e lett. i).<br />
Ulteriori specifici impegni richiesti agli Stati nella Parte II riguardano:<br />
- l’eliminazione di ogni forma di “ingiustificata” discriminazione tesa a scoraggiare l’uso di una<br />
lingua regionale o minoritaria o a metterne in pericolo il mantenimento o lo sviluppo, con<br />
l’adozione di misure speciali in favore di tali lingue, da non considerare come atti discriminatori<br />
nei confronti delle lingue più diffuse (art.7 par.2);<br />
- la promozione del rispetto e della comprensione reciproci tra tutti i gruppi linguistici esistenti<br />
nei singoli Stati, da attuare in special modo attraverso il sistema scolastico e dei mezzi di<br />
comunicazione di massa (art.7 par.3);<br />
- l’istituzione inoltre, ove già non esistano, di organismi incaricati di rappresentare alle competenti<br />
autorità gli interessi di ciascuna lingua regionale o minoritaria, affinché se ne possa<br />
tenere conto nel definire la politica in materia (art.7 par.4).<br />
La Parte III (artt. 8-14) traduce in regole precise i principi generali affermati nella Parte<br />
II, prevedendo disposizioni e misure mirate di tutela volte a promuovere l’uso delle lingue regionali<br />
o minoritarie in tutti i settori della vita civile.<br />
E’ in tale contesto che soprattutto si estrinseca l’ampia discrezionalità rimessa ad ogni<br />
Stato, il quale resta libero di determinare quali norme applicare e quali misure attuare, tenendo<br />
conto della situazione di ogni singola lingua usata nel suo territorio e della incidenza delle singole<br />
misure sotto il profilo finanziario, amministrativo ed organizzativo.<br />
Vengono trattati i diversi campi in cui si sviluppa la vita pubblica e in tale ambito un ampio<br />
spazio è riservato all’aspetto dell’insegnamento delle e nelle lingue regionali o minoritarie,<br />
nella consapevolezza del ruolo fondamentale che l’istruzione è suscettibile di svolgere per la<br />
salvaguardia e lo sviluppo di tali lingue.<br />
Così, oltre ai già accennati impegni previsti in materia nella Parte II (art.7, comma 1 lett.<br />
f. e lett. h), volti ad assicurare forme e mezzi adeguati di insegnamento e di studio in tutte le fasi<br />
appropriate del percorso formativo e la promozione di studi nelle università, all’art. 8 della Parte<br />
III viene definita una serie analitica di misure in tale campo da attuare “nel territorio in cui tali<br />
lingue sono parlate” e “in base alla situazione di ciascuna di queste lingue”, senza pregiudizio<br />
alcuno per l’insegnamento della lingua ufficiale dello Stato (art. 8, comma 1).<br />
Sono prese in considerazione tutte le fasi del percorso di studi, dalla scuola materna<br />
all’università, prevedendo per ciascuna fase numerose opzioni alternative per gli Stati e talora<br />
richiedendo, per l’adozione delle relative misure, l’esistenza di un “numero ritenuto sufficiente”<br />
di studenti.<br />
Interventi vengono richiesti agli Stati anche per assicurare l’insegnamento della storia e<br />
della cultura di cui la lingua regionale o minoritaria è l’espressione, nonché l’occorrente formazione<br />
degli insegnanti e la creazione di organi di controllo incaricati di monitorare le misure pre-<br />
54
se ed i progressi realizzati nel campo dell’insegnamento delle lingue regionali o minoritarie e di<br />
farne oggetto di rapporti periodici da rendere pubblici.<br />
Largo spazio viene parimenti dedicato all’uso della lingua nei procedimenti dinanzi agli<br />
organi della giustizia sia ordinaria che amministrativa (art.9), nonché nei rapporti con la Pubblica<br />
Amministrazione e con gli enti erogatori dei pubblici servizi (art. 10), al fine di permettere alle<br />
persone che parlano le lingue regionali o minoritarie l’esercizio del diritto di difesa e dei diritti civili,<br />
come pure l’adempimento dei doveri civici, nel rispetto delle loro modalità di espressione.<br />
Ciò nell’ulteriore intento di salvaguardare e promuovere tali lingue mantenendole vive<br />
attraverso il loro uso non soltanto nei rapporti privati, ma anche nelle relazioni con le pubbliche<br />
autorità, così come nell’attività degli organi delle collettività regionali e locali.<br />
Anche per tali settori, considerati i notevoli oneri che le varie misure di tutela sono suscettibili<br />
di comportare sia in termini meramente finanziari che di risorse umane, organizzative e<br />
strumentali, la Carta prevede la possibilità di una serie di opzioni e limita gli interventi alle aree<br />
nelle quali “il numero di persone che usano le lingue minoritarie o regionali giustifichi” (art.9,<br />
comma 1 e art. 10 comma 1) l’adozione delle misure previste.<br />
Di rilievo a questo proposito è la limitazione posta agli impegni degli Stati con<br />
l’espressione “nella misura in cui ciò è ragionevolmente possibile”, contenuta nei commi 1 e 3<br />
dell’articolo 10 con riguardo alle misure concernenti le autorità amministrative ed i servizi pubblici:<br />
una clausola che, come sottolineato nel Rapporto esplicativo (par. 104), “non è intesa in<br />
sostituzione dell’esercizio della facoltà, accordata alle Parti dall’art. 2 commi 1, 2 e 3, di omettere<br />
alcune norme della Parte III della Carta” in relazione agli impegni assunti per ciascuna lingua,<br />
ma che piuttosto si propone di tenere conto delle implicazioni, talora anche molto significative,<br />
di alcune misure sotto il profilo finanziario e delle risorse umane e strumentali.<br />
Le disposizioni contenute nell’art. 11 concernono gli spazi da assicurare alle lingue regionali<br />
o minoritarie nel campo della informazione.<br />
A tale proposito la Carta coglie pienamente come in una società quale quella contemporanea,<br />
caratterizzata da un impiego sempre più intenso e diffuso dei mezzi di comunicazione di<br />
massa, una lingua minoritaria non possa avere speranza di sopravvivenza senza un adeguato<br />
spazio nei circuiti informativi.<br />
Il sostegno e l’incoraggiamento dell’accesso di tali lingue nei diversi settori<br />
dell’informazione, ovviamente nel rispetto dei principi di indipendenza e di autonomia dei mezzi<br />
di comunicazione di massa, sono dunque alla base delle disposizioni concernenti tale campo,<br />
nel quale, comunque, la Carta ricalca lo schema di fondo cui si ispira, vale a dire quello di consentire<br />
più scelte per gli interventi di tutela.<br />
Di rilievo in tale contesto l’impegno previsto dal comma 2 dell’art. 11, volto a garantire la<br />
libertà di ricezione dei programmi radiotelevisivi dei Paesi vicini prodotti nella medesima lingua<br />
o in una lingua simile a quella regionale o minoritaria, assicurando per tale via il collegamento<br />
culturale dei locutori della lingua con il Paese di riferimento culturale e linguistico.<br />
Anche in tale modo, quindi, si persegue l’obiettivo di favorire quel collegamento culturale<br />
dei locutori della lingua con il Paese di riferimento culturale e linguistico che è alla base delle<br />
disposizioni (articolo 7, comma 1 lett. i, e articolo 14) tese a promuovere accordi internazionali e<br />
la cooperazione transfrontaliera in materia.<br />
Numerose misure riguardano inoltre le attività culturali miranti ad incoraggiare le iniziative<br />
tipiche delle singole lingue regionali o minoritarie (art.12), nonché la vita economica e sociale,<br />
per la quale è prevista una serie di interventi volti da un lato a dare concreta attuazione al<br />
principio della non discriminazione “per l’insieme del paese”, ovvero sul piano nazionale,<br />
dall’altro a favorire, “nel territorio in cui le lingue regionali o minoritarie sono praticate, e nella<br />
misura in cui ciò è ragionevolmente possibile”, l’uso di tali lingue nelle attività economiche e sociali<br />
(art. 13).<br />
Come già accennato, infine, la Carta prevede anche un meccanismo di verifica<br />
dell’applicazione che ad essa viene data dagli Stati Parte, consentendo così di monitorare co-<br />
55
stantemente le misure via via adottate da ogni Stato per dare concreta attuazione agli impegni<br />
assunti e di promuovere, conseguentemente, un progressivo adeguamento degli interventi di<br />
tutela nei diversi Paesi.<br />
Al meccanismo di verifica è dedicata la Parte IV (articoli 15 -17), che stabilisce un sistema<br />
di rapporti periodici redatti dagli Stati con una cadenza triennale dopo il primo rapporto, il<br />
quale invece deve essere presentato entro un anno dall’entrata in vigore della Carta nei confronti<br />
di ciascuno Stato interessato.<br />
L’esame dei rapporti è affidato ad un “comitato di esperti” appositamente istituito, il quale,<br />
sulla base dei rapporti stessi e delle informazioni su questioni relative all’attuazione degli impegni<br />
eventualmente presentate da organismi e associazioni legalmente costituiti negli Stati,<br />
elabora e sottopone al Comitato dei Ministri un proprio rapporto, che sarà accompagnato dalle<br />
eventuali osservazioni dello Stato e che conterrà in particolare proposte in vista della preparazione<br />
delle raccomandazioni ad una o più Parti ritenute necessarie.<br />
Il sistema di verifica stabilito dalla Carta permette inoltre, a chiunque vi abbia interesse,<br />
di avere una ampia informazione sull’applicazione data dai singoli Stati alla Carta, giacchè prevede<br />
la pubblicità dei rapporti degli Stati e la facoltà, per il Comitato dei Ministri, di rendere pubblico<br />
anche il rapporto del Comitato di esperti.<br />
Lo schema di rapporto degli Stati è stato approvato nel novembre 1998 dal Comitato dei<br />
Ministri secondo quanto stabilito dall’art. 15 della Carta e tocca tutti i profili applicativi concernenti<br />
i vari aspetti trattati dalla Carta, utili a conseguire l’obiettivo dell’acquisizione di ogni informazione<br />
sulla situazione delle lingue regionali o minoritarie nei singoli Stati e della verifica<br />
dell’applicazione data da ciascuno Stato Parte alle disposizioni della Carta.<br />
Scopo della Carta Europea delle Lingue regionali o minoritarie è quindi, come detto, la<br />
tutela di tali lingue e non delle minoranze etniche e linguistiche.<br />
Alla tutela dei diritti delle persone appartenenti a tali minoranze sarà rivolta, a brevissima<br />
distanza di tempo, la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali.<br />
56
LA PROPOSTA PER UNA CONVENZIONE EUROPEA PER LA PROTEZIONE DELLE MI-<br />
NORANZE<br />
La proposta per una Convenzione Europea per la protezione delle minoranze è stata<br />
approvata dalla Commissione Europea per la Democrazia attraverso il Diritto, organo consultivo<br />
del Consiglio d’Europa in materia di diritto costituzionale, in occasione della sesta riunione tenutasi<br />
a Venezia l’8-9 febbraio 1991 (c.d. Commissione di Venezia).<br />
Essa è stata elaborata da un Gruppo di lavoro sulla protezione delle minoranze che era<br />
stato costituito dalla Commissione stessa su richiesta delle autorità ungheresi, italiane e jugoslave<br />
e che, per la redazione del testo ha tenuto conto dei lavori realizzati in seno alla Conferenza<br />
sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, e in particolare della Dichiarazione di Copenaghen<br />
del giugno 1990 e della Carta di Parigi per una nuova Europa del novembre dello<br />
stesso anno, nonché dei documenti europei e dell’ONU in materia di difesa dei diritti umani, e<br />
segnatamente la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà<br />
fondamentali del Consiglio d’Europa e l’art. 27 del Patto internazionale sui diritti civili e politici<br />
delle Nazioni Unite, tutti richiamati nel Preambolo.<br />
Anche di tale proposta si è tenuto particolarmente conto nel corso dei lavori per la predisposizione<br />
della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, che è stata<br />
adottata dal Comitato dei Ministri il 10 novembre 1994.<br />
La Convenzione proposta non si indirizzava alla tutela di profili specifici - culturali o etnici<br />
o religiosi - delle minoranze, ma piuttosto mirava ad assicurare alle minoranze stesse una<br />
protezione globale con riguardo agli aspetti delle loro caratteristiche.<br />
In considerazione della estrema diversificazione delle situazioni relative ai gruppi minoritari<br />
nei diversi Paesi Europei, e talora anche all’interno di uno stesso Stato, la linea adottata<br />
dal gruppo di lavoro è stata quella di affrontare il problema nelle sue linee generali, lasciando ai<br />
singoli Stati il compito e la responsabilità di individuare, per l’applicazione delle disposizioni, gli<br />
strumenti più adatti in relazione alle particolari situazioni esistenti nei loro territori.<br />
La proposta contiene perciò un insieme di principi internazionali da applicarsi nella misura<br />
più larga possibile, a tutte le minoranze rientranti nella definizione, principi per la cui attuazione<br />
occorre l’adozione, da parte degli Stati contraenti, di misure legislative ed amministrative,<br />
che potranno essere adeguate alle esigenze delle situazioni specifiche di ogni Paese.<br />
In tal senso lo strumento proposto si presenta come una “convenzione quadro”, cioè<br />
come un atto di natura pattizia che fissa i principi generali i quali per avere effetto nei diversi<br />
Stati firmatari, richiedono misure attuative negli ordinamenti interni, adattabili alle rispettive, particolari<br />
situazioni.<br />
La proposta di convenzione si compone di cinque Parti, per complessivi 37 articoli, oltre<br />
al Preambolo.<br />
Muovendo dalla considerazione, espressa nel Preambolo, che una adeguata soluzione<br />
al problema delle minoranze in Europa è un fattore fondamentale di democrazia, giustizia, stabilità<br />
e pace, essa si propone di assicurare una efficace protezione dei diritti delle minoranze e<br />
delle persone che vi appartengono.<br />
A tal fine, si sancisce, innanzitutto, all’art. 1, il principio che la tutela internazionale dei<br />
diritti delle minoranze etniche, linguistiche e religiose nonché dei diritti delle persone appartenenti<br />
a tali minoranze, è una componente fondamentale della protezione internazionale dei Diritti<br />
dell’Uomo e, in quanto tale, rientra nell’ambito della cooperazione internazionale, fermo restando<br />
comunque il rispetto dei principi fondamentali del diritto internazionale e in particolare<br />
della sovranità, dell’integrità territoriale e dell’indipendenza politica degli Stati.<br />
Si dà poi, all’art. 2, la definizione, ai fini dell’applicazione della convenzione, del concetto<br />
di “minoranza” - intesa come “un gruppo numericamente inferiore rispetto al resto della popolazione<br />
di uno Stato, i cui membri, che sono cittadini di quello Stato, hanno caratteristiche etniche,<br />
religiose o linguistiche diverse da quelle del resto della popolazione, e sono animati dalla<br />
volontà di salvaguardare la propria cultura, tradizione, religione o lingua, e si afferma quindi il<br />
principio che qualsiasi gruppo che corrisponde a tale definizione deve essere considerato una<br />
minoranza etnica, religiosa o linguistica.<br />
Si vedrà in seguito come, invece, la Convenzione quadro per la Protezione delle Minoranze<br />
Nazionali successivamente adottata dal Comitato dei Ministri, non contenga alcuna definizione<br />
di “minoranza nazionale”, una scelta alla quale si è poi pervenuti per l’impossibilità di<br />
57
trovare una definizione del concetto di minoranza capace di raccogliere il consenso generale di<br />
tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa.<br />
Altra peculiarità della Convenzione proposta dalla Commissione di Venezia è il riconoscimento<br />
formale di diritti di natura collettiva, riguardanti cioè le minoranze in quanto tali, accanto<br />
ai diritti individuali riguardanti ciascun appartenente ad una minoranza.<br />
Che soggetto di diritto dovessero essere considerate anche le minoranze in quanto tali,<br />
oltre che gli appartenenti alle stesse, risulta chiaramente dalle formulazioni contenute nel Preambolo,<br />
che fa espresso riferimento alla volontà di garantire “una efficace protezione dei diritti<br />
delle minoranze e delle persone che appartengono ad esse”, nonché nel già richiamato art. 1,<br />
concernente “la protezione internazionale dei diritti delle minoranze etniche, linguistiche e religiose<br />
e dei diritti delle persone che appartengono a tali minoranze”; ciò è esplicitamente sottolineato<br />
nel Rapporto esplicativo della proposta di Convenzione, che al riguardo chiarisce come<br />
sia “sembrato necessario non riconoscere i diritti ai soli individui appartenenti alle minoranze,<br />
ma anche alle minoranze in quanto tali. Infatti, le minoranze non sono semplicemente una<br />
somma di individui, ma rappresentano altresì un sistema di relazioni tra gli individui stessi. Senza<br />
la nozione di diritti collettivi, la tutela delle minoranze avrebbe un effetto sensibilmente limitato”<br />
(p. l6).<br />
Riferimenti specifici alle minoranze in quanto tali si hanno inoltre nell’art.3, che riconosce<br />
alle minoranze il diritto alla loro esistenza e il diritto alla salvaguardia e allo sviluppo della<br />
loro identità etnica, culturale o linguistica, nonché negli articoli 13 e 14, riguardanti rispettivamente<br />
il divieto di politiche tese all’assimilazione delle minoranze e la effettiva partecipazione<br />
delle stesse alla vita pubblica, in particolare alle decisioni relative alle regioni in cui vivono o agli<br />
affari che le concernono.<br />
Si vedrà ancora, nel seguito della trattazione, come la protezione assicurata con la<br />
Convenzione quadro poi adottata dal Consiglio d’Europa riguardi soltanto i diritti individuali, riferiti<br />
alle persone appartenenti alle minoranze nazionali, e non implichi alcun riconoscimento di<br />
diritti collettivi, pur stabilendo comunque la possibilità di esercitare i diritti garantiti sia individualmente<br />
che in comune con altri membri del gruppo.<br />
Altro aspetto significativo della proposta di convenzione è il riconoscimento, dell’art. 11,<br />
ad ogni persona appartenente ad una minoranza, del diritto a ricorrere dinanzi alle competenti<br />
autorità nazionali in caso di violazione dei diritti garantiti nella convenzione: la previsione di un<br />
rimedio specifico di giustizia, anche se non necessariamente giudiziario come sottolineato nel<br />
Rapporto esplicativo (p.3 9), mira infatti a rendere più pregnante ed effettiva la tutela dei diritti<br />
riconosciuti nella convenzione stessa.<br />
Tali diritti consistono in primo luogo in quelli già citati, all’esistenza della minoranza ed<br />
al rispetto, salvaguardia e sviluppo della sua identità etnica, religiosa o linguistica (art. 3), nonché<br />
il diritto, per le persone appartenenti a minoranze, alla piena uguaglianza con ogni altro cittadino<br />
dello Stato (art. 4), il diritto di associarsi e mantenere contatti, in particolare con altri<br />
membri del proprio gruppo, sia all’interno del Paese che al di la delle frontiere nazionali (art. 5),<br />
il diritto di salvaguardare, esprimere e sviluppare liberamente la propria identità culturale in tutti i<br />
suoi aspetti (art. 6), il diritto di usare liberamente la propria lingua, sia in pubblico che in privato<br />
(art.7), nonché il diritto di professare la propria religione o credo, individualmente o in comune<br />
con altri, sia in pubblico che in privato (art. 10).<br />
Per quanto concerne in particolare l’uso della lingua minoritaria, viene affermato il diritto<br />
di utilizzarla anche nei rapporti con le autorità politiche, amministrative e giudiziarie, locali o, se<br />
del caso, da statali, subordinandolo però alla condizione che la minoranza raggiunga “una percentuale<br />
sostanziale” della popolazione ed ancorandolo però alla “misura del possibile” (art.8);<br />
condizioni che vengono richiamate anche per l’inserimento dell’insegnamento pubblico della<br />
madrelingua nel piano di studi obbligatorio e, “per quanto possibile”, per l’insegnamento del<br />
programma di studi in tutto o in Parte nella lingua materna (art. 9).<br />
L’espressione “per quanto possibile”, che si ritroverà anche nella Convenzione quadro<br />
poi adottata, dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, tiene conto delle difficoltà che il<br />
riconoscimento del diritto all’uso della lingua minoritaria nei rapporti con le pubbliche autorità<br />
può comportare sotto il profilo dei mezzi finanziari e della organizzazione amministrativa, consentendo<br />
quindi ai singoli Stati di considerare i diversi fattori e le particolari situazioni esistenti<br />
nei rispettivi territori.<br />
58
Una scelta, quella operata in questa sede, ma anche in sede di adozione della Convenzione<br />
quadro, che va anche nella direzione di rendere lo strumento accettabile da parte del<br />
maggior numero possibile di Stati, come pure la scelta, che corrisponde alla medesima esigenza,<br />
di non imporre l’obbligo di parificare l’uso della lingua minoritaria all’uso della lingua ufficiale<br />
o di riconoscere la lingua minoritaria come lingua ufficiale nelle regioni in cui essa divenisse lingua<br />
di maggioranza, ma di lasciare tale responsabilità alla discrezionale determinazione dei<br />
singoli Stati interessati.<br />
E del resto, la proposta di convenzione non si limita ad enunciare i diritti spettanti alle<br />
minoranze e ad ogni persona che appartenga, ad essa ma prevede, parimenti, anche i doveri<br />
che tali persone hanno nei confronti dello Stato sul cui territorio sono insediate; ciò al fine di fornire<br />
garanzie con riguardo sia all’integrità territoriale degli Stati (art. 1, comma 2), sia sul rispetto<br />
dei doveri civici, delle leggi nazionali e dei diritti altrui, in particolare di quelli delle persone appartenenti<br />
alla maggioranza e ad altre minoranze (art. 15), prevedendo anche, nella stessa direzione,<br />
l’impegno degli Stati ad adottare le misure necessarie per garantire la non discriminazione<br />
nei riguardi delle persone che siano minoritarie nelle regioni ove le minoranze rappresentano<br />
la maggioranza della popolazione (art. 16).<br />
La proposta stabilisce inoltre, nella Parte III, un meccanismo di controllo del rispetto, da<br />
parte degli Stati, degli impegni assunti ai cui fini istituisce un Comitato Europeo per la protezione<br />
delle minoranze, composto da membri scelti tra personalità note per la loro competenza nel<br />
campo dei diritti umani e delle minoranze, in particolare eletti dal Comitato dei Ministri<br />
nell’ambito di una lista predisposta sulla base delle designazioni degli Stati.<br />
Il predetto Comitato, con il quale le autorità nazionali competenti degli Stati dovranno<br />
collaborare, esamina i rapporti presentati dagli Stati sulle misure adottate per dare attuazione<br />
agli impegni assunti ai sensi della convenzione, rapporti che il Comitato stesso, accompagnandoli<br />
con le proprie osservazioni, inoltrerà al Comitato dei Ministri, il quale potrà rivolgere a ciascuna<br />
Parte tutte le raccomandazioni ritenute necessarie.<br />
Al Comitato Europeo possono inoltre essere indirizzate da ogni Stato istanze sul mancato<br />
rispetto di disposizioni della Convenzione da parte di altro Stato, come pure istituzioni individuali,<br />
cioè di singole persone o gruppi di privati o di qualsiasi organizzazione internazionale<br />
non governativa in rappresentanza di minoranze, su pretese violazioni dei diritti enunciati nella<br />
Convenzione stessa da parte di taluno degli Stati.<br />
Per la soluzione delle relative vertenze è prevista, dopo il necessario accertamento dei<br />
fatti lamentati, una procedura di composizione amichevole che, in caso di esito infruttuoso, si<br />
conclude con un rapporto, anche propositivo del Comitato Europeo, che è trasmesso sia allo<br />
Stato interessato che al Comitato dei Ministri, il quale adotterà tutte le ulteriori misure ritenute<br />
più opportune per assicurare il rispetto della convenzione.<br />
Anche sotto tale profilo la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze già<br />
adottata presenta taluni aspetti di differenziazione dalla proposta di convenzione della Commissione<br />
Europea per la Democrazia attraverso il Diritto, e la funzione di controllo è esplicitamente<br />
demandata al Comitato dei Ministri, assistito da un apposito Comitato consultivo.<br />
In sostanza, comunque, la proposta di convenzione europea tendeva, a conciliare le esigenze<br />
di tutela delle minoranze con i diritti degli Stati e delle popolazioni in essi maggioritarie,<br />
prevedendo anche, per gli Stati stessi, margini di discrezionalità nell’adozione delle diverse misure<br />
di protezione, così da poter tenere conto di ogni concorrente fattore e delle specifiche situazioni<br />
esistenti nei rispettivi territori.<br />
Su tali linee si è improntata l’elaborazione della Convenzione quadro per la protezione<br />
delle minoranze nazionali, adottata dal Comitato dei Ministri nel 1994.<br />
59
LA CONVENZIONE-QUADRO PER LA TUTELA DELLE MINORANZE NAZIONALI<br />
- <strong>DIRITTI</strong> DA TUTELARE -<br />
La Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali non prevede la definizione<br />
di minoranza non essendo stato raggiunto alcun accordo in merito ad essa (Rapporto<br />
esplicativo par. 4) ed essendo stato optato per un approccio pragmatico, basato sulla constatazione<br />
che raccogliere il supporto generale di tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa sulla<br />
definizione sarebbe stata un’impresa impossibile. (Rapporto esplicativo par. 12)<br />
L’assenza della definizione non compromette, però, il contenuto della Convenzionequadro<br />
dato che già si possono individuare nel preambolo gli elementi caratteristici della minoranza<br />
nazionale che sono le proprie peculiarità etniche, culturali, linguistiche e religiose.<br />
Come dichiarato nella Raccomandazione dell’Assemblea parlamentare del Consiglio<br />
d’Europa n. 1255 del 1995, la Convenzione formula un insieme di obiettivi e principi definiti vagamente,<br />
“l’osservazione dei quali sarà un obbligo degli Stati contraenti ma non un diritto che gli<br />
individui possono invocare. Il suo meccanismo di attuazione è debole, e c’è il pericolo che, di<br />
fatto, le procedure di controllo saranno lasciate interamente ai governi”. (par. 7 della citata Raccomandazione)<br />
In conformità con la decisione presa dai Capi di Stato e di <strong>Governo</strong> a Vienna<br />
nell’ottobre del 1993, la Convenzione-quadro è aperta anche a Stati non membri del Consiglio<br />
d’Europa.<br />
Secondo il Rapporto esplicativo “si intende per altri Stati quelli che partecipano alla<br />
Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa”. (par. 99)<br />
L’art. 1 della Convenzione-quadro dichiara: “la protezione delle minoranze nazionali e<br />
dei diritti e delle libertà delle persone appartenenti a quelle minoranze, costituisce parte integrante<br />
della salvaguardia internazionale dei diritti umani e come tale rientra negli obiettivi della<br />
cooperazione internazionale”.<br />
L’articolo specifica che la tutela delle minoranze facendo parte della salvaguardia internazionale<br />
dei diritti dell’uomo non ricade nel dominio riservato agli Stati ma in quello internazionale.<br />
I diritti in essa previsti sono diritti “individuali” e non “collettivi”.<br />
Per quanto concerne la formulazione “protezione delle minoranze nazionali e dei diritti e<br />
delle libertà delle persone ...” secondo il Rapporto esplicativo va intesa nel senso che “non sono<br />
previsti diritti collettivi” e che la protezione delle minoranze può essere ottenuta attraverso la tutela<br />
dei diritti alle persone ad esse appartenenti (par. 31) che “esercitano i loro diritti individualmente<br />
o in comunione con gli altri”. (par. 13)<br />
Nel Preambolo, nel suo penultimo paragrafo, della Convenzione-quadro vengono posti i<br />
limiti alla protezione dei diritti previsti in essa: “nel rispetto della preminenza del diritto,<br />
dell’integrità territoriale e della sovranità nazionale degli Stati”.<br />
Nella Convenzione-quadro si prevedono una serie di diritti per le “persone appartenenti<br />
a minoranze nazionali”:<br />
- Diritto di scegliere liberamente di appartenere ad una minoranza nazionale<br />
“Chiunque appartenga ad una minoranza nazionale ha il diritto di scegliere liberamente di essere<br />
considerato o meno come tale; tale scelta o l’esercizio dei diritti ad essa collegati non debbono<br />
determinare alcun svantaggio”. (art. 3(1)) Tale diritto affida alle persone la facoltà di decidere<br />
se essere o meno protette nell’ambito dei principi stabiliti dalla Convenzione.<br />
Secondo il Rapporto esplicativo questo paragrafo non implica però il diritto per un individuo di<br />
scegliere arbitrariamente se appartenere ad una minoranza, dato che la sua appartenenza si<br />
basa su elementi oggettivi. (par. 35)<br />
La previsione che nessun svantaggio debba provenire da tale scelta all’individuo assicura che il<br />
godimento di tale libertà non venga danneggiato indirettamente.<br />
- Esercizio del diritto individualmente o in comunione con altri.<br />
Le persone appartenenti a minoranze nazionali possono esercitare, sia individualmente che insieme<br />
ad altri, i diritti e le libertà derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzionequadro”.<br />
(art. 3(2)).<br />
In tale comma va sottolineata la dicitura “insieme ad altri” che può sia intendersi “altri membri<br />
del proprio gruppo” sia membri di un’altra minoranza che membri della maggioranza stessa<br />
(Rapporto esplicativo par. 37).<br />
60
- Diritto all’eguaglianza di “diritto” e di “fatto”<br />
In base all’art. 4(1) viene proibita qualsiasi discriminazione basata sull’appartenenza a minoranze<br />
nazionali, alle quali è garantito il diritto di eguaglianza di fronte alla legge e eguale protezione<br />
di legge.<br />
Il secondo comma aggiunge inoltre che le “Parti si impegnano, se necessario, ad adottare tutte<br />
le misure adeguate volte a promuovere, in tutti i settori della vita economica, sociale, politica e<br />
culturale, una piena ed effettiva eguaglianza fra le persone appartenenti ad una minoranza nazionale,<br />
e quelle appartenenti alla maggioranza”.<br />
L’eguaglianza di fatto richiederebbe quindi alle Parti di prevedere misure speciali di tutela per le<br />
persone appartenenti a minoranze; tali misure potrebbero essere interpretate come discriminatorie<br />
dalla maggioranza, proprio per questo nel terzo comma si specifica che “non sono considerate<br />
un atto discriminatorio”.<br />
Gli Stati non sono obbligati ad adempiere a tale articolo dato che è loro riposta la decisione di<br />
decidere “quando necessario”.<br />
- Diritto di mantenere, preservare e sviluppare la propria identità<br />
L’art. 5 ha lo scopo di assicurare alle persone appartenenti a minoranze nazionali di mantenere,<br />
preservare e sviluppare la loro cultura ed identità, prevedendo un impegno da parte degli Stati<br />
“a creare le condizioni adeguate” per consentirlo.<br />
Il Rapporto esplicativo specifica però che ciò non comporta che tutte le differenze etniche, culturali<br />
e linguistiche o religiose, necessariamente costituiscano delle minoranze nazionali, dato che<br />
la “minoranza” presenta delle particolari caratteristiche oggettive e soggettive.<br />
Si specifica inoltre che il riferimento alle “tradizioni” non implica l’accettazione di pratiche contrarie<br />
alla legge nazionale e agli standards internazionali (par. 43, 44).<br />
- Diritto alla non assimilazione<br />
Nel secondo comma dell’art. 5 si prevede che “Le Parti si astengono da qualunque politica o<br />
pratica volta ad assimilare, contro la loro volontà, persone appartenenti a minoranze, e le tutelano<br />
da qualunque atto in tal senso” salvo però disposizioni nel quadro della politica generale di<br />
integrazione degli Stati.<br />
- Tolleranza e dialogo interculturale<br />
Nell’art. 6 (1) le Parti si impegnano a promuovere lo spirito di tolleranza e il dialogo interculturale,<br />
e a prendere misure che favoriscano il rispetto, la comprensione reciproca e la cooperazione<br />
tra tutte le persone che vivono sul loro territorio, in particolare nei settori dell’istruzione, cultura e<br />
mass media.<br />
- Protezione contro atti discriminatori, ostilità o violenza<br />
Le Parti si impegnano a prendere tutte le misure per tutelare le persone che potrebbero essere<br />
vittime di minacce o atti discriminatori ostili o violenti (art. 6.2).<br />
L’art. 6, come ricorda il Rapporto esplicativo è l’espressione delle preoccupazioni espresse<br />
nell’Appendice III della Dichiarazione di Vienna (Dichiarazione e Piano d’Azione per combattere<br />
il razzismo, la xenofobia, l’antisemitismo e l’intolleranza) e nel paragrafo 40.2 del Documento di<br />
Copenaghen della CSCE.<br />
- Diritto alla libertà di associazione, libertà di espressione, libertà di pensiero di coscienza e di<br />
religione<br />
Tali libertà fondamentali in realtà sono diritti riconosciuti a tutti gli individui previste già nella<br />
Convenzione europea sui diritti dell’Uomo, ma riproposti non solo perché di fondamentale importanza<br />
per le minoranze, ma anche perché a tale Convenzione potrebbero aderire Stati che<br />
non essendo membri del Consiglio d’Europa non si sentirebbero vincolati dalla Convenzione<br />
europea per i diritti dell’Uomo (art. 7).<br />
- Diritto di creare istituzioni religiose, organizzazioni e associazioni<br />
L’art. 8 ribadisce il diritto di manifestare la propria religione o il proprio credo nonché il diritto di<br />
creare istituzioni religiose, organizzazioni e associazioni; tale articolo combina vari elementi del<br />
Documento di Copenaghen previsti nei paragrafi 32.2. 32.3, 32.6.<br />
- Diritto a ricevere o comunicare informazioni o idee nella lingua minoritaria e non discriminazione<br />
nei media<br />
Gli Stati parte della Convenzione si impegnano a garantire tali diritti senza ingerenza da parte<br />
delle autorità e a non discriminarne l’accesso ai mass media “nel quadro del loro ordinamento<br />
giuridico”. (art. 9)<br />
61
Gli Stati si impegnano inoltre “nella misura del possibile” ad offrire l’opportunità di creare ed utilizzare<br />
propri mass media.<br />
- Diritto di utilizzare la propria lingua<br />
L’art. 10 (1) riconosce, alle persone appartenenti a minoranze, il diritto di utilizzare liberamente<br />
la propria lingua sia in “pubblico che in privato” senza interferenza.<br />
“In pubblico, significa per esempio, in un luogo pubblico, fuori, o in presenza di altre persone,<br />
ma non riguarda in alcuna circostanza relazioni con le autorità pubbliche” (Rapporto esplicativo<br />
par. 63).<br />
- Uso della lingua minoritaria nelle relazioni con le autorità amministrative<br />
Tale uso (art. 10.2) è garantito “per quanto possibile” dalle Parti, alle condizioni che innanzi tutto<br />
gli insediamenti minoritari siano “consistenti e tradizionali” e che la richiesta avanzata dalle persone<br />
ad esse appartenenti corrisponda “ad una esigenza reale”.<br />
Il diritto viene previsto non nei rapporti con qualsiasi autorità pubblica ma con le sole “autorità<br />
amministrative”.<br />
Nell’articolo è concesso un ampio potere discrezionale agli Stati lasciando loro la decisione non<br />
solo riguardo per quanto attiene alle misure da adottare ma anche per ciò che concerne<br />
l’interpretazione dell’articolo stesso che non riporta un chiarimento né per ciò che intende per<br />
insediamenti minoritari “consistenti e tradizionali” né per ciò che riguarda la “esigenza reale” da<br />
parte delle minoranze.<br />
Il Rapporto esplicativo chiarisce che per “tradizionali” non ci si riferisce alle minoranze storiche<br />
ma “solo a quelle che vivono ancora nella stessa area geografica” (par. 66).<br />
- Diritto di utilizzare cognome e nome nella lingua minoritaria<br />
Nell’art. 11 le Parti si impegnano a riconoscere il diritto di utilizzare cognome e nome nella lingua<br />
minoritaria, nonché il diritto al loro riconoscimento speciale; a riconoscere il diritto di esporre<br />
al pubblico insegne, scritte o altre informazioni di carattere privato, quindi non ufficiale, di esporre<br />
in alcune regioni le denominazioni tradizionali locali, i nomi delle strade, e indicazioni topografiche<br />
anche in lingua minoritaria. L’articolo prevede, però, diverse condizioni, e cioè: che<br />
la regione sia abitata da un numero consistente di persone appartenenti a minoranza, che tale<br />
tentativo venga fatto “nel quadro del loro ordinamento giuridico” e “tenendo conto delle loro<br />
condizioni specifiche” e di eventuali accordi con altri Stati.<br />
- Promozione della conoscenza delle culture minoritarie e non minoritarie<br />
L’art. 12 promuove la conoscenza della cultura, della storia e della religione sia delle minoranze<br />
che della maggioranza della popolazione per consentire il dialogo interculturale, al fine di creare<br />
un clima di tolleranza tra elementi diversi presenti nel territorio statale facilitando “contatti tra alunni<br />
e insegnanti di comunità differenti” e offrendo “pari opportunità nell’accesso all’istruzione a<br />
tutti i livelli alle persone appartenenti a minoranze nazionali” e la “possibilità di formazione per<br />
gli insegnanti e di accesso ai manuali scolastici”.<br />
- Diritto di creare e amministrare istituti privati di istruzione e formazione<br />
Nell’art. 13 viene riconosciuto tale diritto alle persone che appartengono a minoranze nel quadro<br />
dei requisiti richiesti dal sistema educativo dello Stato (in special modo per quelli “relativi alla<br />
scuola dell’obbligo” (Rapporto esplicativo par. 72) per il quale non è previsto alcun impegno<br />
economico, sebbene non si escluda la possibilità di contributi pubblici.<br />
La creazione di tali istituti dipende quindi dalle disponibilità economiche della minoranza stessa.<br />
- Diritto di apprendere la lingua minoritaria<br />
“L’obbligo di riconoscere il diritto ad ogni persona appartenente a minoranze nazionali di apprendere<br />
la propria lingua minoritaria riguarda uno degli strumenti principali attraverso il quale<br />
tali individui possono asserire e preservare la loro identità” (Rapporto esplicativo par. 74), malgrado<br />
ciò, gli Stati non sono obbligati a livello finanziario, e cercheranno di garantire la possibilità<br />
di apprendere la lingua minoritaria e di ricevere un insegnamento in tale lingua, solo nelle zone<br />
nelle quali vi siano insediamenti “consistenti e tradizionali” e se “la richiesta è sufficiente”<br />
“nella misura del possibile” e nel quadro del loro sistema educativo, senza ostacolare<br />
l’apprendimento e l’insegnamento della lingua ufficiale (art. 14).<br />
- Diritto di partecipazione effettiva alla vita culturale, sociale, economica e pubblica<br />
L’articolo 15 richiede alle Parti di creare le condizioni necessarie per una effettiva partecipazione<br />
delle persone appartenenti a minoranze alla vita culturale, sociale economica e pubblica in<br />
particolare per ciò che le interessa direttamente. Esso ha lo scopo soprattutto di incoraggiare<br />
62
l’eguaglianza di fatto tra le persone appartenenti a minoranze nazionali e il resto della popolazione<br />
dello Stato.<br />
Secondo il Rapporto esplicativo le Parti potrebbero prevedere nell’ambito dei loro sistemi costituzionali,<br />
una serie di misure quali: consultazioni nei campi legislativo o amministrativo per ciò<br />
che le interessi direttamente; collaborazione nei piani regionali o nazionali; studi congiunti<br />
sull’impatto delle attività di sviluppo; effettiva partecipazione al processo decisionale e di rappresentanza<br />
sia a livello nazionale che locale, decentramento o forme di governo locale (Rapporto<br />
esplicativo par. 80).<br />
- Cambiamenti demografici<br />
Nell’articolo 16 si prevede l’astensione da parte degli Stati di prendere provvedimenti che modifichino<br />
le proporzioni della popolazione in una zona geografica nella quale risiedano persone<br />
appartenenti a minoranze nazionali, con lo scopo di attentare ai diritti e libertà loro riconosciuti<br />
dalla Convenzione-quadro.<br />
Esempi di tali misure potrebbero essere espropriazioni, escomi ed espulsioni o ridefinizione dei<br />
confini amministrativi con lo scopo di restringere il godimento ditali diritti e libertà. Tale impegno<br />
non implica pèrò l’impossibilità di prevedere misure, che possono essere giustificate e legittime<br />
come ad esempio lo spostamento degli abitanti di un villaggio per la costruzione di una diga<br />
(Rapporto esplicativo par. 81-82).<br />
- Diritto di stabilire e mantenere contatti al di là delle frontiere<br />
Tale diritto viene garantito per lo sviluppo e il mantenimento della propria cultura ed identità favorendo<br />
contatti, in special modo con persone che hanno in comune un’identità etnica, culturale<br />
linguistica e religiosa (art. 17).<br />
Non è stato ritenuto necessario prevedere libertà di contatti all’interno degli Stati dato che tale<br />
libertà viene garantita dalla libertà di espressione e associazione prevista nella Convenzione.<br />
- Diritto a partecipare ai lavori di organizzazioni non governative<br />
L’art. 17 (2) prevede un impegno degli Stati a non ostacolare la partecipazione ad organizzazioni<br />
non governative da parte delle persone appartenenti a minoranze nazionali sia a livello<br />
nazionale che internazionale.<br />
- Accordi bilaterali e multilaterali e cooperazione transfrontaliera<br />
L’art. 18 enuncia che “le parti cercheranno, se necessario, di concludere accordi bilaterali o<br />
multilaterali con gli Stati vicini, per garantire la tutela delle persone appartenenti alle minoranze<br />
nazionali interessate”, accordi, specifica il Rapporto esplicativo, particolarmente nei campi della<br />
cultura, educazione e informazione (par. 86); inoltre si prevede l’opportunità di provvedimenti<br />
che facilitino la cooperazione transfrontaliera.<br />
- Garanzia per la migliore protezione<br />
L’art. 22 specifica che nessuna disposizione della Convenzione può essere intesa come limitativa<br />
di diritti e libertà che potrebbero essere riconosciuti dalle legislazioni delle parti o da qualsiasi<br />
altra Convenzione della quale lo Stato è Parte, garantendo quindi alle persone appartenenti<br />
a minoranza il godimento dei diritti che più le favoriscono nell’ambito degli strumenti giuridici<br />
previsti dallo Stato nel quale vivono.<br />
63
LE RACCOMANDAZIONI DELL’ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO<br />
D’EUROPA<br />
Già in precedenza si è avuto modo di evidenziare come l’Assemblea Parlamentare si<br />
era sempre occupata, fin dagli inizi della sua attività, del problema delle minoranze nazionali e<br />
quanto ripetuti, da allora siano stati i suoi interventi volti a pervenire nell’ambito del Consiglio<br />
d’Europa, all’adozione di strumenti di garanzia dei diritti delle minoranze.<br />
Con la Raccomandazione 285 del 1961 e la Raccomandazione 1134 del 1990 venivano<br />
ribaditi la positiva valenza delle minoranze per la multiculturalità in Europa e l’importante rispetto<br />
dei loro diritti e di quelli delle persone ad esse appartenenti come fattore fondamentale per la<br />
pace, la giustizia, la stabilità e la democrazia. Venivano, inoltre, definiti i principi fondamentali<br />
sui diritti delle minoranze, nazionali e linguistiche, ritenuti “base minima” per una adeguata protezione<br />
giuridica, nonché connessi impegni degli Stati europei, raccomandando al Comitato dei<br />
Ministri di elaborare, sulla base di tali principi, un protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea<br />
sui Diritti dell’uomo ovvero una speciale Convenzione del Consiglio d’Europa.<br />
A tal fine l’Assemblea Parlamentare volle pure riaffermare la necessità di rispettare pienamente<br />
gli impegni assunti nell’ambito della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in<br />
Europa, contenuti nell’Atto Finale di Helsinki del 1975 e nei documenti conclusivi delle riunioni<br />
di Madrid (1983), di Vienna (1989) e di Copenaghen (1990), richiamando anche l’attenzione sugli<br />
obblighi che derivavano agli Stati partecipanti al processo della CSCE dagli strumenti internazionali<br />
concernenti le minoranze nazionali, etniche, religiose e linguistiche.<br />
Nella Raccomandazione 1137 si forniva una prima, sostanziale definizione di “minoranze<br />
nazionali” - vale a dire “gruppi separati o distinti, ben definiti ed insediati sul territorio di uno<br />
Stato, i cui membri sono cittadini di quello Stato e presentano certe caratteristiche religiose, linguistiche,<br />
culturali o altre, che li distinguono dalla maggioranza della popolazione” - , ed inoltre,<br />
tra i diritti presi in considerazione, alcuni erano riferiti alle minoranze in quanto tali.<br />
La Raccomandazione 1134 interveniva quando erano in corso sia i lavori della Commissione<br />
per la democrazia attraverso il diritto per una proposta di Convenzione per la tutela<br />
delle minoranze, quelli per l’elaborazione di un progetto di una Carta Europea delle lingue regionali,<br />
la cui rapida definizione veniva poi auspicata con la Raccomandazione 1177 del 5 febbraio<br />
1992.<br />
Dopo l’adozione, il 25 giugno 1992, della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie<br />
e l’avvio,da parte del Comitato direttivo per i diritti dell’uomo e del Comitato ad hoc di esperti,<br />
dei lavori per l’approfondimento e la predisposizione di specifiche norme di tutela delle<br />
minoranze nazionali, l’Assemblea Parlamentare tornò, ancora, con la Raccomandazione 1201<br />
del 10 febbraio 1993, sul problema della protezione delle minoranze, “uno tra i più importanti<br />
attualmente trattati dal Consiglio d’Europa”, per assicurare il massimo appoggio ad entrambe le<br />
iniziative e dare il proprio contributo ai lavori di elaborazione delle norme di tutela delle minoranze.<br />
Così, con tale Raccomandazione, l’Assemblea Parlamentare da un lato lanciava un appello<br />
agli Stati membri per la più ampia adesione alla Carta Europea, sollecitandone una rapida<br />
ratifica con l’accettazione del maggior numero possibile delle sue clausole, dall’altro proponeva<br />
il testo di un progetto per la protezione delle minoranze nazionali, raccomandando al Comitato<br />
dei Ministri di adottare, sulla base di esso, un protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea<br />
sui diritti dell’uomo, concernente le persone appartenenti a tali minoranze.<br />
Il testo proposto, che costituiva parte integrante della Raccomandazione, si componeva<br />
di cinque Titoli per complessivi 20 articoli, oltre al Preambolo, nel quale si evidenziavano le<br />
considerazioni fondanti del proposto protocollo sottolineando, tra le altre, la rilevante importanza<br />
della protezione delle minoranze, tenuto conto che “soltanto il riconoscimento dei diritti delle<br />
persone appartenenti ad una minoranza nazionale all’interno di uno Stato e la protezione internazionale<br />
di questi diritti sono suscettibili di porre durevolmente fine ai confronti etnici, e di contribuire<br />
in tal modo a garantire la giustizia, la democrazia, la stabilità e la pace”.<br />
Precisato nello stesso Preambolo che comunque i diritti considerati erano quelli che ogni<br />
persona “può esercitare sia singolarmente che in comune con altri” si dava innanzitutto,<br />
all’art. 1, la definizione dell’espressione “minoranza nazionale”, intesa come “un gruppo di persone<br />
in uno Stato che:<br />
64
a) risiedono nel territorio di questo Stato e ne sono cittadini;<br />
b) mantengono legami antichi, solidi e durevoli con tale Stato;<br />
c) presentano specifiche caratteristiche etniche, culturali, religiose o linguistiche;<br />
d) sono sufficientemente rappresentative, sebbene in numero minore rispetto al resto della popolazione<br />
dello Stato o di una sua regione;<br />
e) sono animate dalla volontà di preservare insieme ciò che costituisce la loro identità comune,<br />
inclusa la loro cultura, le loro tradizioni, la loro religione e la loro lingua”.<br />
Veniva poi enunciata una serie di principi generali, con l’affermazione di diritti e di libertà fondamentali,<br />
e di diritti sostanziali concernenti, tra gli altri, la creazione di proprie organizzazioni,<br />
compresi i partiti politici, l’uso della lingua materna in pubblico e in privato nonché nei rapporti<br />
con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari, l’insegnamento della e nella lingua<br />
materna, la costituzione e gestione di proprie scuole ed istituti di insegnamento, l’uso della<br />
lingua minoritaria nella onomastica, nella toponomastica e nelle iscrizioni pubbliche, liberi contatti<br />
oltrefrontiera con cittadini di altri Stati aventi le medesime caratteristiche, appropriate amministrazioni<br />
locali o autonome o statuti speciali nelle regioni in cui le minoranze costituiscono la<br />
maggioranza.<br />
La protezione dei diritti garantiti dal protocollo proposto veniva inoltre resa ancora più<br />
pregnante con l’affermazione, contenuta nell’articolo 9 del testo, del diritto ad un effettivo rimedio<br />
di giustizia dinanzi alle competenti autorità dello Stato in caso di loro violazione, diritto che<br />
era riconosciuto non soltanto ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale, ma<br />
anche ad ogni organizzazione che fosse rappresentativa di una minoranza.<br />
Si è già accennato come, però, la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze<br />
nazionali poi adottata, il 10 novembre 1994, dal Comitato dei Ministri non contenga una previsione<br />
simile, anche se introduce un importante meccanismo di controllo sulla attuazione, da<br />
parte degli Stati contraenti, dei principi enunciati.<br />
Dopo l’adozione della Convezione quadro l’Assemblea Parlamentare è pertanto nuovamente<br />
intervenuta con la Raccomandazione 1255 del 31 gennaio 1995, sul problema della<br />
protezione dei diritti delle minoranze, considerato “uno dei più importanti impegni del Consiglio<br />
d’Europa oggi”, auspicandone la firma e la ratifica da parte del maggior numero di Stati, membri<br />
e non membri oltrechè della Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie, ma segnalando<br />
anche l’esigenza di completare la stessa Convenzione quadro con un protocollo aggiuntivo alla<br />
Convenzione europea sui diritti dell’uomo che definisse chiaramente i diritti azionabili dinanzi<br />
agli organi di giustizia indipendenti.<br />
A tal fine l’Assemblea Parlamentare ricordando le decisioni assunte dai Capi di Stato e<br />
di <strong>Governo</strong> nel vertice di Vienna del 9 ottobre 1993, che comprendevano anche, l’elaborazione<br />
di un progetto di protocollo aggiuntivo alla medesima Convenzione Europea “nel campo culturale<br />
con disposizioni di garanzia dei diritti individuali, in particolare per le persone appartenenti alle<br />
minoranze nazionali”, raccomandava inoltre al Comitato dei Ministri di portare rapidamente a<br />
conclusione i lavori conseguentemente avviati, richiamando, per l’individuazione dei diritti da includere<br />
nel redigendo protocollo, dei quali riproduceva un elenco indicativo, sia la Convenzione<br />
quadro per la protezione delle minoranze nazionali che la propria proposta di protocollo aggiuntivo<br />
contenuta nella Raccomandazione 1201 del 1993.<br />
Ancora un appello a sottoscrivere e ratificare entrambe le Convenzioni, sia la Carta europea<br />
che la Convenzione quadro, veniva poi rivolto con la Raccomandazione 1285 del 23<br />
gennaio 1996, con la quale l’Assemblea Parlamentare nel dare pieno appoggio ai due Strumenti,<br />
raccomandava nuovamente che fossero portati a rapida e soddisfacente conclusione i lavori<br />
per la elaborazione del progetto di protocollo aggiuntivo nel campo culturale e che in tale sede<br />
venissero quanto più possibile specificati gli obblighi derivanti agli Stati, al fine di rendere chiari<br />
ed azionabili i diritti da riconoscere.<br />
Si decise invece, con la Raccomandazione 1300 del successivo 25 gennaio 1996, sulla<br />
base di un parere espresso dalla Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto<br />
(c.d. Commissione di Venezia), di allontanare l’ipotesi di definire, tra le disposizioni della Carta<br />
europea, delle lingue regionali o minoritarie un “nocciolo duro” di diritti suscettibili di essere accettati<br />
da tutti gli Stati contraenti, ipotesi tesa ad accrescere le opportunità di ratifica dello Strumento.<br />
La Commissione aveva al riguardo considerato che il concetto di un nocciolo duro è e-<br />
65
straneo allo spirito e al sistema di funzionamento della Carta europea delle lingue regionali o<br />
minoritarie, che già contiene nella Parte 11, “un nocciolo duro” di principi che garantisce<br />
l’efficacia della tutela assicurando anche come le disposizioni della Parte III, per la loro formulazione<br />
e per l’analiticità della regolamentazione difficilmente si prestino alla determinazione di un<br />
nocciolo duro, suscettibile di essere accettato da tutti gli Stati contraenti, e che un nocciolo duro<br />
di diritti linguistici può essere dedotto dagli obblighi previsti dalla Convenzione quadro per la<br />
protezione delle minoranze nazionali, e in particolare nell’articolo 5 paragrafo 1, nell’art. 6,<br />
nell’art. 9, paragrafo 1, negli articoli da 10 a 14 e nell’art. 17.<br />
L’anno successivo, con la Raccomandazione 1345 del 24 ottobre 1997 l’Assemblea<br />
Parlamentare torna di nuovo, specificatamente, sulla protezione delle minoranze nazionali, che<br />
“continua ad essere uno degli elementi cruciali della pace e della sicurezza in Europa”.<br />
I due importanti strumenti adottati dal Consiglio d’Europa, la Carta Europea e la Convenzione<br />
quadro, entrambi giuridicamente impegnativi per gli Stati, non avevano ancora ottenuto<br />
il numero sufficiente di ratifiche per la rispettiva entrata in vigore e d’altra parte, le dichiarazioni<br />
e le iniziative, pure di grande rilievo, adottate in altre sedi, in particolare nell’ambito del<br />
processo della CSCE, che aveva anche istituito l’Ufficio dell’Alto Commissario per le Minoranze<br />
Nazionali in funzione di prevenzione dei conflitti, avevano natura essenzialmente politica e non<br />
vincolavano, sotto il profilo strettamente giuridico, gli Stati partecipanti.<br />
L’Unione Europea, dal conto suo, aveva fatto della protezione delle minoranze una<br />
condizione per la cooperazione economica e per l’adesione stessa, ma osservava l’Assemblea<br />
Parlamentare, “l’efficacia di questa politica è seriamente ostacolata dall’assenza di un meccanismo<br />
di monitoraggio permanente e dalla mancanza di chiarezza circa i principi che uno Stato è<br />
tenuto a rispettare in tale campo”.<br />
Tale complessiva situazione portava l’Assemblea Parlamentare a ritenere “ancora insufficiente<br />
la volontà politica di accettare e di attuare gli strumenti politici e giuridici internazionali”<br />
nella materia e a concludere che “la protezione delle minoranze resta ancora troppo spesso una<br />
questione di politica estera piuttosto che di politica interna”.<br />
Queste considerazioni inducevano l’Assemblea Parlamentare da un lato a sollecitare<br />
nuovamente la sottoscrizione e la ratifica della Carta Europea e della Convenzione quadro e la<br />
loro osservanza, dall’altro a raccomandare al Comitato dei Ministri di perseguire una cooperazione<br />
intergovernativa nel campo della protezione delle minoranze nazionali e di porre in essere<br />
attività che coinvolgessero i governi e la società civile, finalizzate a facilitare la piena ed efficace<br />
attuazione delle norme giuridiche internazionali in tale campo” e, sollecitando anche il dialogo<br />
con i rappresentanti delle minoranze, ha raccomandato anche di rafforzare la cooperazione con<br />
l’Unione Europea affinché si tenesse sistematicamente conto dei risultati delle procedure di<br />
monitoraggio del Consiglio d’Europa, in particolare in sede di valutazione del rispetto delle clausole<br />
relative ai diritti umani e alle minoranze in occasione della conclusione di accordi con Paesi<br />
terzi, e in sede di esame delle loro richieste di adesione all’Unione.<br />
Poco tempo dopo, rispettivamente il 5 novembre 1992 e il 10 novembre 1993, sarebbero<br />
finalmente entrate in vigore la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie e la Convenzione<br />
quadro per la protezione delle minoranze nazionali.<br />
Un’ulteriore sollecitazione a sottoscrivere e ratificare la Carta europea delle lingue regionali<br />
e minoritarie e la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali veniva<br />
poi rivolta con la Raccomandazione 1285 del 23 gennaio 1996 con la quale l’Assemblea Parlamentare,<br />
nel sostenere pienamente le due Convenzioni, raccomandava anche di riprendere e<br />
portare a rapida e soddisfacente conclusione i lavori per la elaborazione del progetto di protocollo<br />
aggiuntivo alla Convenzione europea sui diritti dell’uomo nel campo culturale, specificando<br />
quanto più possibile gli obblighi degli Stati così da rendere chiari ed azionabili i diritti riconosciuti.<br />
Il tema delle minoranze nazionali è stato poi ancora ripreso con la Raccomandazione 1345<br />
del 24 ottobre 1997 con la quale l’Assemblea Parlamentare, nell’affermare che la loro protezione<br />
“continua ad essere uno degli elementi essenziali della pace e della sicurezza in Europa”, ha<br />
sollecitato il dialogo con i rappresentanti delle minoranze, raccomandando inoltre di rafforzare la<br />
cooperazione con l’Unione Europea perché venga tenuto sistematicamente conto dei risultati<br />
delle procedure di monitoraggio del Consiglio d’Europa, in particolare in sede di accordi con i<br />
Paesi terzi e di esame delle loro richieste di adesione, essendo la protezione delle minoranze<br />
tra le condizioni per l’accoglimento di tali richieste e per la cooperazione economica con quei<br />
Paesi. L’accesso delle minoranze all’insegnamento superiore ha formato poi specifico oggetto<br />
66
della Raccomandazione 1353 del 27 gennaio 1998 con la quale, al fine di assicurare alle minoranze,<br />
con tutte le misure necessarie, le condizioni per esprimere la propria identità e sviluppare<br />
la propria educazione, cultura, lingua e tradizioni, viene definita un serie di principi ai quali gli<br />
Stati aderenti alla Convenzione Culturale Europea devono ispirarsi in sede di revisione della politica<br />
nazionale in materia di educazione.<br />
67
GLI INTERVENTI<br />
DELLA CONFERENZA/ORGANIZZAZIONE<br />
PER LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA<br />
69
PREMESSA<br />
Nel processo di distensione portato avanti dalla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione<br />
per contribuire alla sicurezza e allo sviluppo della cooperazione in Europa, il rispetto dei<br />
diritti umani e delle libertà fondamentali, considerato un elemento essenziale per la pace, la<br />
giustizia ed il benessere nel Continente, è sempre stato al centro degli impegni assunti dagli<br />
Stati partecipanti, a partire dalla loro prima fondamentale dichiarazione, l’Atto finale di Helsinki<br />
del 1975, alla quale si sono poi ispirati tutti i successivi documenti della CSCE.<br />
In questo contesto riferimenti ed impegni mirati hanno riguardato specificamente anche<br />
le minoranze nazionali ed i diritti delle persone che appartengono a tali minoranze, per le quali è<br />
stato pure istituito, in un’ottica di prevenzione di potenziali conflitti, un apposito Alto Commissario.<br />
ATTO FINALE DELLA C.S.C.E. DI HELSINKI<br />
L’Atto Finale di Helsinki fu firmato il 10 agosto 1975 a conclusione della prima Conferenza<br />
sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, che era stata aperta il 3 luglio 1973 e alla<br />
quale parteciparono i Capi di Stato o di <strong>Governo</strong> di trentacinque Paesi, dell’Europa occidentale<br />
e orientale, della Santa Sede, degli Stati Uniti e del Canada.<br />
Esso costituisce senza dubbio documento di grande respiro per le molteplici questioni<br />
affrontate e per i connessi principi affermati, ed ha importanza fondamentale perché fissa i capisaldi<br />
che guideranno la successiva attività della CSCE. Anche le minoranze nazionali rientrano<br />
tra le numerose questioni affrontate dall’Atto Finale, che se ne occupa nella parte concernente<br />
le “Questioni relative alla sicurezza in Europa”, e in particolare nel principio VII della “Dichiarazione<br />
sui Principi che reggono le relazioni fra gli Stati partecipanti”, nonché nella parte riguardante<br />
la “Cooperazione nel settore umanitario e in altri settori” e specificamente alle sezioni<br />
3 e 4 della “Cooperazione e scambi”, concernenti, rispettivamente, il campo della cultura ed il<br />
campo dell’educazione.<br />
In particolare, nel principio VII della “Dichiarazione sui Principi” gli Stati partecipanti riconoscono<br />
il significato universale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il cui rispetto<br />
è un fattore essenziale della pace, della giustizia e del benessere necessari ad assicurare lo<br />
sviluppo di relazioni amichevoli e della cooperazione fra di loro e fra gli Stati” e dichiarano non<br />
soltanto l’impegno a rispettare tali diritti e libertà, inclusa la libertà di pensiero, coscienza, religione<br />
o credo, senza distinzione alcuna di razza, sesso, lingua o religione, di promuoverne ed<br />
incoraggiarne l’esercizio effettivo nei diversi contesti della vita civile, e di rispettare gli obblighi<br />
derivanti in materia di dichiarazioni ed accordi internazionali, ma si prevede altresì, espressamente,<br />
un impegno specifico di tutela delle minoranze nazionali, in base al quale “gli Stati partecipanti<br />
nel cui territorio esistono minoranze nazionali rispettano il diritto delle persone appartenenti<br />
a tali minoranze all’uguaglianza di fronte alla legge, offrono loro la piena possibilità di<br />
godere effettivamente dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e, in tal modo, proteggono<br />
i loro legittimi interessi in questo campo”.<br />
Estremamente significativa in tale sede tenuto conto che si tratta di impegni di natura<br />
essenzialmente politica, la dichiarazione degli Stati partecipanti di adempiere agli obblighi loro<br />
derivanti in materia di diritti umani e di libertà fondamentali da dichiarazioni ed accordi internazionali<br />
da cui siano vincolati.<br />
Nel contesto della “Cooperazione e scambi” nei campi della cultura e dell’educazione il<br />
riferimento attiene invece alle “minoranze nazionali o culture regionali”, delle quali viene riconosciuto<br />
il contributo che possono apportare alla cooperazione in tali settori “che gli Stati partecipanti<br />
si propongono di facilitare “tenendo conto degli interessi legittimi dei loro membri”.<br />
Dopo la Conferenza di Helsinki il tema delle minoranze nazionali è stato costantemente<br />
ripreso e sviluppato nelle successive riunioni della CSCE tenutesi in conformità alle disposizioni<br />
dell’Atto Finale relative ai Seguiti della stessa Conferenza, formando oggetto di riferimenti specifici<br />
nei relativi documenti conclusivi.<br />
71
DOCUMENTO CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA SUI SEGUITI DELLA C.S.C.E. DI MA-<br />
DRID<br />
Con tale documento, adottato a Madrid il 9 settembre 1983 a conclusione della Conferenza<br />
sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa aperta l’11 novembre 1980, gli Stati partecipanti<br />
hanno riaffermato il loro impegno per il processo della CSCE, sottolineando “l’importanza<br />
dell’applicazione di tutte le disposizioni e del rispetto di tutti i principi dell’Atto Finale di Helsinki<br />
da parte di ciascuno di loro in quanto elementi essenziali per lo sviluppo di tale processo”, il cui<br />
futuro “richiede progressi equilibrati in tutti i capitoli dell’Atto Finale”.<br />
In tale quadro, viene riaffermata la determinazione di rispettare e di dare piena applicazione<br />
a tali principi e di promuovere la maggiore efficacia con tutti i mezzi, anche traducendo i<br />
principi stessi in disposizioni legislative interne.<br />
Per quanto concerne i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali, si ribadisce la fondamentale<br />
importanza del loro rispetto ai fini della pace, della giustizia e dello sviluppo, riaffermando<br />
la determinazione di promuoverne ed incoraggiarne l’esercizio effettivo, di assicurarne<br />
un progresso costante e tangibile” per un continuo sviluppo in tutti gli Stati partecipanti, e di sviluppare<br />
leggi e regolamenti nel campo dei diritti per i diversi settori della vita civile.<br />
Con riferimento specifico alle minoranze nazionali è stata inoltre sottolineata<br />
“l’importanza di un costante progresso per garantire il rispetto e l’effettivo godimento dei diritti<br />
delle persone appartenenti a minoranze nazionali, nonché per proteggere i loro interessi legittimi<br />
come previsto nell’Atto Finale”.<br />
72
DOCUMENTO CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA SUI SEGUITI DELLA C.S.C.E. DI<br />
VIENNA<br />
Il Documento conclusivo di Vienna, adottato al termine della riunione dei rappresentanti<br />
degli Stati partecipanti alla CSCE tenutasi dal 4 novembre 1986 al 19 gennaio 1989, non soltanto<br />
si riafferma la determinazione di dare piena attuazione agli impegni contenuti nell’Atto Finale<br />
di Helsinki, compresi tutti i dieci principi della “Dichiarazione sui Principi che reggono le relazioni<br />
tra gli Stati partecipanti” e di privilegiare il principio della soluzione pacifica delle controversie,<br />
ma si manifesta anche la volontà di adoperarsi costantemente per il perfezionamento di un metodo<br />
generalmente accettabile per la soluzione pacifica delle controversie e ridefinisce una serie<br />
di misure concrete che gli Stati partecipanti si impegnano a promuovere e ad attuare.<br />
In tale contesto uno spazio notevolissimo è riservato alle questioni concernenti i diritti<br />
dell’uomo e le libertà fondamentali, con l’impegno a sviluppare leggi, regolamenti e politiche nei<br />
diversi settori della vita civile e a darvi applicazione in modo da garantire il loro esercizio effettivo,<br />
senza discriminazione alcuna e assicurando anche mezzi di ricorso efficaci in caso di violazione<br />
di tali diritti e libertà.<br />
Anche con specifico riguardo alle minoranze nazionali gli impegni per interventi di tutela<br />
si fanno più marcati.<br />
Viene infatti previsto, nell’ambito dei “principi” stabiliti in merito alle “questioni relative alla<br />
sicurezza in Europa”, che gli Stati partecipanti compiranno “sforzi costanti” per applicare le<br />
disposizioni dell’Atto Finale di Helsinki e del Documento conclusivo di Madrid riguardanti le minoranze,<br />
essi “adotteranno tutte le necessarie misure legislative, amministrative, giudiziarie ed<br />
altre ed applicheranno gli strumenti internazionali pertinenti per essi vincolanti, per assicurare la<br />
tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali delle persone che appartengono a minoranze<br />
nazionali nel loro territorio” e “si asterranno da qualsiasi discriminazione contro tali persone<br />
e contribuiranno alla realizzazione dei loro legittimi interessi ed aspirazioni nel campo dei diritti<br />
dell’uomo e delle libertà fondamentali” (Principi, par. 18).<br />
Gli Stati partecipanti, inoltre, “proteggeranno e creeranno le condizioni per la promozione<br />
dell’identità etnica, culturale, linguistica e religiosa delle minoranze nazionali nel loro territorio.<br />
Essi rispetteranno il libero esercizio dei diritti da parte delle persone che appartengono a tali<br />
minoranze e assicureranno la loro piena uguaglianza con le altre persone” (Principi, par. 19).<br />
Una tutela implicita, sotto il profilo linguistico, è contenuta anche nell’ambito delle disposizioni<br />
dei “Principi” volte ad assicurare la libertà di professare e praticare una religione o convinzione.<br />
Tra gli altri impegni a ciò finalizzati agli Stati partecipanti viene infatti richiesto anche il<br />
rispetto del diritto di ciascuno di impartire e ricevere l’educazione religiosa nella lingua di propria<br />
scelta, sia individualmente che in associazione con altri (par. 16.6), nonché il rispetto del diritto<br />
dei singoli credenti e delle comunità di credenti di acquisire, possedere e utilizzare libri sacri e<br />
pubblicazioni religiose nella lingua di propria scelta (par. 16.9).<br />
Più puntuali enunciazioni sono contenute anche nella parte relativa alla “Cooperazione<br />
nel settore umanitario e in altri settori” e in particolare nelle sezioni riguardanti i contatti fra persone,<br />
l’informazione e la cultura, ove vengono affermati principi e diritti di fondamentale rilievo<br />
ai fini della tutela delle minoranze nazionali, quali il principio di eguaglianza effettiva, il diritto di<br />
mantenere contatti con cittadini di altri Stati aventi comune origine o cultura, o il diritto di sviluppare<br />
la propria cultura.<br />
Così il paragrafo 31 della sezione “Contatti fra persone”, che impegna gli Stati partecipanti<br />
ad assicurare che lo status delle persone appartenenti a minoranze o a culture regionali<br />
che si trovano nei loro territori sia uguale a quello degli altri cittadini per quanto riguarda i contatti<br />
fra persone ai sensi dell’Atto Finale e degli altri citati documenti CSCE, compresi<br />
l’instaurazione e il mantenimento di tali contatti, mediante viaggi e altri mezzi di comunicazione,<br />
anche con cittadini di altri Stati aventi una comune origine nazionale o un retaggio culturale comune”.<br />
Così pure il paragrafo 45 della sezione “Informazione”, in base al quale gli Stati partecipanti<br />
dovranno assicurare “concretamente” che le persone appartenenti a minoranze nazionali<br />
o a culture regionali, che si trovano nei loro territori, possano diffondere, ricevere e scambiare<br />
informazioni nella propria madrelingua.<br />
Per quanto concerne la cooperazione e gli scambi nei campi della cultura e<br />
73
dell’educazione, disposizioni che richiedono l’impegno ad azioni positive specificamente riguardanti<br />
le minoranze, sono contenute nei paragrafi 59 e 68, dove si prevede che gli Stati partecipanti<br />
assicurino che le persone appartenenti a minoranze nazionali o a culture regionali che si<br />
trovano nel loro territorio “abbiano ogni opportunità di mantenere e sviluppare la propria cultura<br />
in tutti i suoi aspetti, compresa la lingua, la letteratura, la religione, e che possano preservare i<br />
propri monumenti e oggetti culturali e storici” (par. 59), ed inoltre, che “possano impartire o ricevere<br />
un’istruzione sulla propria cultura, fra l’altro, tramite la trasmissione dai genitori ai figli della<br />
lingua, della religione e dell’identità culturale” (par. 68).<br />
Ma la riunione di Vienna ha segnato un importante passo in avanti nella direzione della<br />
tutela delle minoranze non soltanto per la manifestata crescente concretezza e gli impegni enunciati<br />
ma anche perché ha portato, conseguentemente, all’adozione di specifiche iniziative di<br />
rilievo, che in seguito saranno ulteriormente sviluppate e perfezionate.<br />
In tale sede infatti, gli Stati partecipanti al processo della CSCE, riconoscendo<br />
l’esigenza di migliorare l’attuazione dei loro impegni e della loro cooperazione nei settori dei diritti<br />
dell’uomo e delle libertà fondamentali, dei contatti fra le persone e delle altre questioni aventi<br />
un correlativo carattere umanitario, nonché la loro cooperazione in settori, indicati sotto la dizione<br />
“dimensione umana della CSCE”, hanno definito uno specifico sistema di procedure volto<br />
ad assicurare il rispetto dei principi contenuti nell’Atto Finale di Helsinki e negli altri pertinenti<br />
documenti della CSCE, decidendo inoltre la convocazione di una “Conferenza sulla dimensione<br />
umana” finalizzata a conseguire ulteriori progressi in tale campo.<br />
Le procedure, successivamente denominate “meccanismo” ed ulteriormente perfezionate,<br />
sono contenute nel capitolo “Dimensione umana della CSCE” e sono fissate in quattro paragrafi<br />
riguardanti altrettanti fasi: scambio di informazioni e risposta a richieste di informazioni e<br />
ad osservazioni su questioni relative alla dimensione umana; riunioni bilaterali per la soluzione<br />
di questioni, riguardanti anche situazioni e casi specifici; segnalazione da parte di uno Stato, di<br />
situazioni e casi a tutti gli altri Stati partecipanti; esame delle questioni, con informazioni sulle<br />
fasi precedenti, in occasione delle riunioni della Conferenza sulla Dimensione Umana, nonché<br />
nelle riunioni principali della CSCE nel quadro dei Seguiti.<br />
La Conferenza sulla Dimensione Umana, da tenersi in riunioni, rispettivamente a Parigi,<br />
Copenaghen e Mosca, avrebbe dovuto valutare gli sviluppi nel campo della dimensione umana<br />
e nell’attuazione dei pertinenti impegni, nonché il funzionamento del sistema di procedure definito<br />
e le informazioni fornite in base ad esso, esaminando anche proposte concrete per ulteriori<br />
nuove misure volte a migliorare sia l’attuazione degli impegni che l’efficacia delle procedure<br />
stesse.<br />
74
DOCUMENTI CONCLUSIVI DELLE RIUNIONI DELLA CONFERENZA SULLA DIMENSIONE<br />
UMANA DELLA C.S.C.E. DI COPENAGHEN E MOSCA<br />
In attuazione delle decisioni assunte a Vienna, la Conferenza sulla Dimensione Umana<br />
si è riunita a Parigi dal 30 maggio al 23 giugno 1989, a Copenaghen dal 5 al 29 giugno 1990 e a<br />
Mosca dal 10 settembre al 4 ottobre 1991.<br />
Nelle riunioni sono stati rilevati miglioramenti progressivi nell’attuazione degli impegni<br />
concernenti la dimensione umana, ma è stata anche ravvisata la necessità di passi ulteriori e di<br />
costanti sforzi da parte degli Stati per la piena attuazione di taluni impegni, ai cui fini, soprattutto<br />
nella riunione di Mosca, è stato deciso anche di adeguare il sistema di procedure definito a<br />
Vienna rafforzato ed ampliato per accrescerne l’efficacia.<br />
Per quanto concerne in particolare le minoranze nazionali, la Riunione di Copenaghen<br />
ha costituito una tappa molto significativa nel cammino per la loro tutela, della quale si occupa il<br />
capitolo IV del Documento conclusivo, ove si enunciano i principi da rispettare, i diritti da garantire<br />
e le misure da adottare per assicurarne l’effettivo esercizio.<br />
Viene innanzitutto riottenuto che “il rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze<br />
nazionali, in quanto parte dei diritti dell’uomo universalmente riconosciuti, è un fattore essenziale<br />
per la pace, la giustizia, la stabilità e la democrazia negli Stati Partecipanti”, ed inoltre<br />
riconosce che le questioni relative alle minoranze nazionali “possono essere risolte in maniera<br />
soddisfacente solo in un quadro politico democratico basato sullo stato di diritto, con un sistema<br />
giudiziario indipendente e funzionante”, rilevando l’importante ruolo svolto dalle organizzazioni<br />
non governative che si occupano dei diritti dell’uomo ai fini della promozione della tolleranza e<br />
delle diversità culturali e per la soluzione delle questioni relative alle minoranze (par 30).<br />
Si enuncia poi una serie di diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, che<br />
possono essere esercitati sia individualmente che in associazione con altri membri del loro<br />
gruppo; in particolare: il diritto di esercitare pienamente ed effettivamente i diritti dell’uomo e le<br />
libertà fondamentali senza discriminazione alcuna e in piena uguaglianza dinanzi alla legge,<br />
con l’impegno, per gli Stati partecipanti, ad adottare ove necessario “misure speciali” per garantire<br />
la piena uguaglianza (par. 31); il diritto di esprimere liberamente, preservare e sviluppare la<br />
propria identità etnica, culturale, linguistica o religiosa e di mantenere e sviluppare la propria<br />
cultura in tutti i suoi aspetti, al riparo da ogni tentativo di assimilazione forzata contro la volontà<br />
(par. 32); in tale contesto, il diritto di usare liberamente la propria lingua nella vita privata e in<br />
quella pubblica (par. 32.1), di creare e conservare proprie istituzioni o associazioni, con possibilità<br />
di richiedere interventi finanziari o di altro genere secondo la legislazione nazionale (par.<br />
32.2), di praticare e professare la propria religione e di svolgere attività educative religiose nella<br />
propria lingua (par. 32.3), di stabilire e mantenere liberi contatti sia all’interno del proprio Paese<br />
che oltre frontiera con i cittadini di altri Stati con i quali sono in comune l’origine nazionale o etnica,<br />
il retaggio culturale o le convinzioni religiose (par. 3 2.4), il diritto di diffondere, avere accesso<br />
e scambiare informazioni, nella madrelingua (par. 32.5), di costituire e mantenere organizzazioni<br />
o associazioni all’interno del proprio Paese e di partecipare ad organizzazioni internazionali<br />
non governative (par. 32.6).<br />
Vengono quindi definiti gli impegni degli Stati partecipanti, ai quali si richiede di tutelare<br />
l’identità etnica, culturale, linguistica e religiosa delle minoranze nazionali, di creare le condizioni<br />
per la sua promozione adottando anche, previa consultazione delle minoranze interessate, le<br />
necessarie misure, che devono essere anche “conformi ai principi di uguaglianza e non discriminazione”<br />
(par. 33) e di adoperarsi per assicurare in concreto la possibilità dell’istruzione della<br />
o nella madrelingua, nonché, “laddove possibile e necessario”, l’uso di tale lingua nei rapporti<br />
con le pubbliche autorità (par. 34).<br />
Con riguardo alla vita pubblica gli Stati dovranno inoltre rispettare il diritto delle persone<br />
appartenenti a minoranze nazionali di partecipare effettivamente agli affari pubblici, anche per<br />
le questioni relative alla tutela e alla promozione della loro identità.<br />
A tale proposito si indica in particolare, come uno dei mezzi pubblici per conseguire le<br />
finalità, “la costituzione di amministrazioni locali o autonome adeguate, rispondenti ai fattori<br />
specifici storici e territoriali relativi a tali minoranze e conformi alle politiche dello Stato” (par.<br />
35).<br />
Viene anche riconosciuta la particolare importanza di rafforzare la cooperazione tra gli<br />
75
Stati sulle questioni relative a minoranze nazionali (par. 36) e saranno pienamente rispettati gli<br />
impegni assunti in base alle convenzioni esistenti sui diritti dell’uomo e agli altri pertinenti strumenti<br />
internazionali, valutando di aderire alla Convenzione non ancora sottoscritta, comprese<br />
quelle che prevedono il diritto di ricorso da parte dei singoli (par. 38).<br />
Ulteriori impegni vengono assunti per combattere l’odio razziale, etnico o religioso ed<br />
ogni altra forma di discriminazione e persecuzione, che vengono fermamente condannati, e per<br />
tutelare le persone o i gruppi che possono esserne vittime (par. 40).<br />
Al meccanismo della dimensione umana deciso a Vienna, ritenuto un valido strumento<br />
di cooperazione e di ausilio per la soluzione delle inerenti questioni, vengono apportati taluni ritocchi,<br />
per accrescere l’efficacia delle relative procedure.<br />
Ma è nella terza riunione della Conferenza sulla Dimensione Umana, che ha avuto luogo<br />
a Mosca dal 10 settembre al 4 ottobre 1991, cioè dopo l’adozione della Carta di Parigi per<br />
una nuova Europa e la Riunione di Esperti sulle minoranze nazionali tenutasi a Ginevra, che il<br />
“meccanismo” e stato notevolmente rafforzato ed ampliato, per ridurre i tempi delle procedure e<br />
per favorire la soluzione di questioni o di specifiche situazioni.<br />
Infatti, oltre a fissare i tempi per la risposta alle richieste di informazioni ed alle osservazioni<br />
(dieci giorni) e per gli incontri bilaterali (nel più breve tempo possibile e di regola entro una<br />
settimana), si prevede anche l’intervento di missioni di “esperti” o di “relatori” della CSCE, tratti<br />
da un elenco di eminenti personalità appositamente costituito, che operano secondo presupposti<br />
e procedure diversamente definiti. Nel caso di una minaccia particolarmente grave<br />
all’attuazione delle disposizioni della dimensione umana l’avvio della procedura per l’invio di<br />
una missione di relatori prescinde dall’esaurimento delle prime due fasi del meccanismo o delle<br />
altre procedure, ma deve comunque avere l’appoggio di almeno altri nove Stati.<br />
Il documento conclusivo di Mosca affronta inoltre molteplici questioni nel campo della<br />
giustizia, della libertà personale, dei diritti dell’uomo e delle altre libertà fondamentali, toccando<br />
anche il tema delle minoranze nazionali (par. 37), per le quali vengono confermate le disposizioni<br />
e gli impegni assunti in tutti i documenti CSCE, e in particolare il Documento della Riunione<br />
di Copenaghen della Conferenza sulla Dimensione Umana ed il rapporto della Riunione di<br />
esperti sulle minoranze nazionali di Ginevra, di cui viene chiesta la piena e pronta attuazione.<br />
76
CARTA DI PARIGI PER UNA NUOVA EUROPA<br />
Anche la Carta di Parigi per una nuova Europa riserva particolare attenzione alle minoranze<br />
nazionali.<br />
Adottata a conclusione del Vertice dei Capi di Stato e di <strong>Governo</strong> degli Stati partecipanti<br />
alla CSCE tenutosi a Parigi dal 19 al 21 novembre 1990 dopo i profondi mutamenti verificatisi in<br />
Europa a seguito degli avvenimenti del 1989, la Carta costituisce un documento fondamentale<br />
nel percorso della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, riconfermando la<br />
piena validità dei Dieci Principi dell’Atto Finale di Helsinki e segnando l’avvio, sulla base di essi<br />
e di tutti gli altri impegni CSCE, di una nuova fase delle relazioni tra i Paesi partecipanti, fondata<br />
sul rispetto e sulla cooperazione, verso l’obiettivo di “una democrazia basata sui diritti dell’uomo<br />
e sulle libertà fondamentali, la prosperità attraverso la libertà economica e la giustizia sociale<br />
nonché una uguale sicurezza” per tutti i Paesi partecipanti.<br />
In tale quadro gli Stati partecipanti, nel definire i precetti in tema di diritti dell’uomo, democrazia<br />
e stato di diritto, hanno anche affermato che “l’identità etnica, culturale, linguistica e<br />
religiosa delle minoranze nazionali sarà tutelata e che le persone appartenenti a minoranze nazionali<br />
hanno il diritto di esprimere liberamente, preservare e sviluppare tale identità senza discriminazioni<br />
di alcun genere ed in piena uguaglianza di fronte alla legge”.<br />
In particolare, nel capitolo dedicato agli “Orientamenti per il futuro”, gli Stati partecipanti,<br />
decisi a promuovere “il prezioso contributo delle minoranze nazionali alla vita delle nostre società”,<br />
si sono impegnati a migliorarne ulteriormente le condizioni riaffermando la “profonda convinzione<br />
che le relazioni amichevoli fra i nostri popoli, nonché la pace, la giustizia, la stabilità e<br />
la democrazia, richiedono che venga tutelata l’identità etnica, culturale, linguistica e religiosa<br />
delle minoranze nazionali e che vengano create le condizioni per la promozione di tale identità”.<br />
Essi hanno anche ribadito che le questioni relative alle minoranze nazionali possono<br />
essere risolte in modo soddisfacente soltanto in un contesto politico democratico, riconoscendo<br />
inoltre che i diritti delle persone ad esse appartenenti devono essere pienamente rispettati quale<br />
parte dei diritti universali dell’uomo.<br />
Nell’intento di conseguire una maggiore cooperazione in materia e una migliore tutela<br />
delle minoranze nazionali, della cui “urgente esigenza” gli Stati partecipanti si sono dichiarati<br />
consapevoli, è stata altresì decisa la convocazione di una riunione di Esperti sulle minoranze<br />
nazionali, da tenersi a Ginevra dal 10 al 19 luglio 1991, con lo scopo di discutere approfonditamente<br />
il problema delle minoranze nazionali e dei diritti delle persone che vi appartengono, tenendo<br />
anche conto della diversità delle situazioni e dei contesti giuridici, storici, politici ed economici,<br />
e di avere uno scambio di vedute sull’esperienza pratica, esaminando anche<br />
l’attuazione degli impegni in materia, e i possibili miglioramenti del relativo standard, nonché<br />
nuove misure per migliorare l’attuazione stessa.<br />
77
RAPPORTO DELLA RIUNIONE DI GINEVRA DELLA C.S.C.E. DI ESPERTI SULLE MINO-<br />
RANZE NAZIONALI<br />
Come deciso a Parigi, la riunione degli Esperti sulle minoranze nazionali si è tenuta a<br />
Ginevra dal l° al 19 luglio 1991, e ad essa hanno partecipato anche rappresentanti delle Nazioni<br />
Unite e del Consiglio d’Europa.<br />
Secondo le finalità prefissate, sui problemi delle minoranze nazionali e dei diritti delle<br />
persone appartenenti a tali minoranze è stato svolto un dibattito molto approfondito, che ha rispecchiato<br />
il quadro di diversità delle situazioni e degli antecedenti giuridici, storici, politici ed<br />
economici dei vari Paesi, e sono state inoltre esaminate diverse proposte per il miglioramento<br />
dell’attuazione degli impegni in materia.<br />
A conclusione dei lavori è stato adottato un Rapporto riepilogativo, che è stato poi trasmesso,<br />
per la programmata terza riunione di Mosca, alla Conferenza sulla dimensione umana,<br />
che, come detto in tale sede lo ha espressamente richiamato auspicandone l’attuazione.<br />
Nel Rapporto si afferma che il rispetto ed il pieno esercizio dei diritti dell’uomo e delle libertà<br />
fondamentali, inclusi quelli delle persone appartenenti alle minoranze nazionali, sono “il<br />
fondamento della Nuova Europa” e si sottolinea “la costante importanza di un riesame approfondito<br />
dell’attuazione” dei relativi impegni.<br />
Quanto al rispetto del diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali di partecipare<br />
agli affari pubblici, viene evidenziata a tal fine l’esigenza di un loro effettivo coinvolgimento<br />
allorché vengano discusse questioni relative alla situazione delle minoranze nazionali, come<br />
pure l’importanza di una appropriata partecipazione democratica ad organi decisionali o consultivi,<br />
e si riaffermano il principio della non discriminazione ed il diritto delle persone appartenenti<br />
alle minoranze nazionali di esprimere liberamente, preservare e sviluppare la propria identità<br />
etnica, linguistica o religiosa e di mantenere e sviluppare la propria cultura in tutti i suoi aspetti,<br />
al riparo da ogni tentativo di non voluta assimilazione (par. III).<br />
Si indicano quindi, nel paragrafo IV, le azioni positive che gli Stati devono attuare per<br />
assicurare in concreto la piena uguaglianza e la pari opportunità, per tutelare l’identità etnica,<br />
culturale, linguistica e religiosa delle minoranze nazionali nel loro territorio e per creare le condizioni<br />
per la promozione di tale identità.<br />
Di notevole rilievo in tale contesto la decisione di segnalare anche una lunga serie di<br />
specifiche soluzioni adottate con risultati positivi da alcuni Stati e che singolarmente o in associazione<br />
possono essere utili per migliorare la situazione delle minoranze.<br />
Vengono in particolare citate concretamente - le soluzioni che prevedano:<br />
- organi consultivi decisionali nei quali siano rappresentate le minoranze, in particolare per<br />
quanto riguarda l’educazione, la cultura e la religione;<br />
- organi ed assemblee elettivi per le questioni delle minoranze nazionali;<br />
- amministrazioni locali ed autonome, nonché autonomia su una base territoriale, inclusa<br />
l’esistenza di organi consultivi, legislativi ed esecutivi scelti mediante elezioni libere e periodiche;<br />
- amministrazione autonoma da parte di una minoranza nazionale degli aspetti concernenti la<br />
propria identità in situazioni in cui non si applica l’autonomia su base territoriale;<br />
- forme di governo decentralizzate o locali;<br />
- accordi bilaterali e multilaterali ed altre intese concernenti le minoranze nazionali;<br />
- per le persone appartenenti a minoranze nazionali, opportunità di adeguati livelli di educazione<br />
nella loro madrelingua con il dovuto riguardo al numero, ai modelli di insediamento,<br />
geografico ed alle tradizioni culturali delle minoranze nazionali;<br />
- stanziamenti per l’insegnamento delle lingue delle minoranze alla popolazione in generale,<br />
nonché inserimento delle lingue delle minoranze in istituzioni per la formazione degli insegnanti,<br />
in particolare nelle regioni abitate da persone appartenenti a minoranze nazionali;<br />
- nei casi in cui l’insegnamento di una particolare disciplina non sia assicurato nel loro territorio<br />
nella lingua della minoranza a tutti i livelli, adozione delle misure necessarie al fine di trovare<br />
i mezzi per il riconoscimento dei titoli di studio rilasciati all’estero per un corso di studio<br />
portato a termine in tale lingua;<br />
- creazione di agenzie governative di ricerca per riesaminare la legislazione e diffondere le informazioni<br />
connesse con la parità dei diritti e la non-discriminazione;<br />
78
- fornitura di assistenza finanziaria e tecnica alle persone appartenenti alle minoranze nazionali<br />
che lo desiderino per consentire loro di esercitare il proprio diritto di creare e conservare<br />
le proprie istituzioni, organizzazioni e associazioni educative, culturali e religiose;<br />
- assistenza governativa per affrontare le difficoltà locali relative a prassi discriminatorie (per<br />
esempio, un servizio di consultazione per i cittadini);<br />
- incoraggiamento degli sforzi per migliorare le relazioni di base nell’ambito di una comunità<br />
fra le comunità minoritarie, fra le comunità maggioritarie e minoritarie, e fra le comunità limitrofe<br />
al fine di contribuire a prevenire l’insorgere di tensioni locali e affrontare pacificamente<br />
eventuali conflitti;<br />
- incoraggiamento dell’istituzione di commissioni miste e permanenti, sia interstatali che regionali,<br />
per agevolare la continuazione del dialogo tra le regioni confinanti interessate.<br />
Viene inoltre riaffermato, nella parte V, l’impegno a rispettare il diritto delle persone appartenenti<br />
a minoranze nazionali di esercitare godere dei propri diritti singolarmente o in comune con<br />
altri e di creare e conservare proprie organizzazioni ed associazioni, anche educative, culturali<br />
e religiose, con l’impegno a non ostacolarne l’esercizio, riconoscendo al riguardo il “ruolo rilevante<br />
e vitale” svolto da persone, da organizzazioni non governative e da gruppi religiosi e di<br />
altro genere nel promuovere la comprensione transculturale e nel migliorare le relazioni a tutti i<br />
livelli delle società, anche al di là delle frontiere.<br />
Altri aspetti rilevanti ai fini di tutela vengono trattati nella parte VI, concernente in particolare<br />
i fenomeni di odio razziale, etnico e religioso e di discriminazione, e nella parte VII, ove si<br />
prevedono impegni degli Stati per assicurare libere comunicazioni tra le persone appartenenti a<br />
minoranze nazionali, l’accesso ai “media” senza discriminazioni, liberi contatti sia all’interno dello<br />
Stato che al di là delle frontiere, nonché per incoraggiare accordi di cooperazione transfrontaliera<br />
a livello nazionale, regionale e locale.<br />
79
DOCUMENTO CONCLUSIVO DEL VERTICE DI HELSINKI (9-10 LUGLIO 1992)<br />
“LE SFIDE DEL CAMBIAMENTO”<br />
Il Vertice dei Capi di Stato o di <strong>Governo</strong> tenutosi ad Helsinki il 9 e 10 luglio 1992 ha segnato<br />
ulteriori progressi nel campo della dimensione umana e della protezione delle minoranze<br />
nazionali.<br />
In quella sede, infatti, è stato ulteriormente ritoccato il “meccanismo della dimensione<br />
umana”, per adeguarlo al nuovo assetto delle strutture e delle istituzioni della CSCE e, con più<br />
specifico riguardo alle minoranze nazionali, è stata decisa l’istituzione di un Alto Commissario<br />
per le Minoranze Nazionali, in funzione di prevenzione di conflitti attraverso un sistema di preallarme<br />
e di gestione preventiva di situazioni di crisi.<br />
L’Alto Commissario ha in particolare il compito di fornire un “preallarme” e, se del caso,<br />
un’“azione tempestiva” quanto più sollecitamente possibile in relazione a tensioni concernenti<br />
questioni relative a minoranze nazionali capaci di trasformarsi in un conflitto nell’area CSCE,<br />
che pregiudichino la pace, la stabilità o le relazioni fra gli Stati partecipanti, e di richiedere<br />
l’attenzione e l’azione del Consiglio della CSCE, organo decisionale centrale e di governo, o del<br />
Comitato degli Alti Funzionari (CSO).<br />
In tale contesto gli Stati partecipanti hanno nuovamente ribadito, “nei termini più energici”,<br />
la loro determinazione ad attuare in maniera sollecita e fedele a tutti gli impegni CSCE,<br />
compresi quelli contenuti nei Documenti conclusivi di Vienna e Copenaghen e nel Rapporto degli<br />
Esperti sulle Minoranze Nazionali di Ginevra, riguardanti questioni relative alle minoranze<br />
nazionali e ai diritti delle persone ad esse appartenenti (p. 23), impegnandosi in tale contesto ad<br />
intensificare gli sforzi per assicurare il libero esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali,<br />
incluso il diritto di partecipare pienamente, secondo le procedure decisionali, democratiche<br />
di ciascuno Stato, alla vita politica, economica, sociale e culturale dei loro Paesi, anche attraverso<br />
la partecipazione democratica agli organi decisionali e consultivi a livello nazionale, regionale<br />
e locale, tramite, tra l’altro, i partiti politici e le associazioni (p. 24).<br />
Si è inoltre deciso (p. 25-27) che da parte degli Stati si continuino ad esplorare, con<br />
sforzi unilaterali, bilaterali e multilaterali, nuove vie per una più efficace attuazione dei loro impegni,<br />
compresi quelli relativi alla tutela e alla creazione di condizioni atte a promuovere<br />
l’identità etnica, culturale, linguistica e religiosa delle minoranze nazionali, affrontando le questioni<br />
relative alle minoranze nazionali in maniera costruttiva, con mezzi pacifici e attraverso il<br />
dialogo fra tutte le parti interessate, condannando ogni tentativo di reinsediamento forzoso di<br />
persone finalizzato a modificare la composizione etnica di zone nei loro territori.<br />
80
DOCUMENTO DEL VERTICE DI BUDAPEST<br />
“VERSO UNA VERA PARTNERSHIP IN UNA NUOVA ERA”<br />
Il successivo Vertice di Budapest, conclusosi con l’adozione del documento del 6 dicembre<br />
1994 “Verso una vera partnership in una nuova era”, ha portato al cambiamento della<br />
denominazione della CSCE in Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa<br />
(OSCE), in relazione al mutamento sostanziale e all’ampliamento del ruolo dell’Organismo determinati<br />
dalla nuova era di sicurezza e di cooperazione in Europa.<br />
In tale sede i Capi di Stato e di <strong>Governo</strong> dei Paesi partecipanti, riunitisi, alla vigilia del<br />
cinquantesimo anniversario della Seconda Guerra Mondiale e del ventesimo anniversario della<br />
firma dell’Atto Finale di Helsinki e nella ricorrenza del quinto anniversario della caduta del muro<br />
di Berlino, “per valutare insieme il recente passato, per considerare il presente e per guardare al<br />
futuro” (p. 1) hanno sottolineato come la CSCE sia stata uno strumento efficace “per abbattere<br />
le barriere e gestire il cambiamento”, con sviluppi incoraggianti (p. 4), rilevando però che “il diffondersi<br />
delle libertà è stato accompagnato da nuovi conflitti e dal risveglio di antiche ostilità” e<br />
che “i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali vengono tuttora conculcati” e persistono<br />
l’intolleranza e la discriminazione nei confronti delle minoranze.(p. 5)<br />
Di qui la ribadita esigenza di una azione risoluta da parte degli Stati partecipanti e di<br />
una cooperazione per assicurare il pieno rispetto dei principi e degli impegni CSCE e una effettiva<br />
solidarietà al fine di alleviare le sofferenze, con la conseguente decisione, tra le altre, di potenziare<br />
il quadro della cooperazione e del dialogo nel campo della dimensione umana e di ampliare<br />
il quadro operativo della CSCE, potenziando in particolare l’Ufficio per le Istituzioni Democratiche<br />
e i Diritti dell’Uomo (ODIHR) e rafforzandone il ruolo, anche ai fini di una maggiore<br />
cooperazione con altre organizzazioni ed istituzioni internazionali, che operano nel campo della<br />
dimensione umana. Con specifico riguardo alle minoranze nazionali è stata inoltre confermata<br />
la determinazione di promuovere costantemente l’attuazione delle disposizioni dell’Atto Finale di<br />
Helsinki e di tutti gli altri documenti CSCE relativi alla tutela dei diritti delle persone appartenenti<br />
alle minoranze nazionali, accogliendo con favore le iniziative internazionali volte ad una migliore<br />
tutela dei diritti delle persone appartenenti a tali minoranze, tra le quali la Convenzione quadro<br />
la protezione delle minoranze nazionali che è stata aperta a firma anche agli Stati non membri<br />
(VIII - p. 21-22).<br />
81
GLI INTERVENTI DELL’UNIONE EUROPEA<br />
83
PREMESSA<br />
La difesa e la promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e lo sviluppo delle<br />
culture degli Stati membri rappresentano obiettivi imprescindibili per la Comunità Europea.<br />
L’impegno per il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ha costituito infatti<br />
uno dei compiti centrali del Parlamento e della Comunità europea, che lo ha anche posto<br />
come condizione preliminare, essenziale per poter entrare a far parte della Comunità e per la<br />
conclusione di accordi di cooperazione con i Paesi terzi.<br />
Il Parlamento Europeo ha anche previsto un sistema di monitoraggio delle situazioni<br />
concernenti i diritti dell’uomo nel mondo attraverso relazioni annuali presentate dalla competente<br />
Commissione politica, prendendo posizioni nette e decise in presenza di violazioni.<br />
La cultura, poi, ha assunto nel tempo un ruolo sempre più importante nell’elaborazione<br />
e nell’attuazione delle politiche comunitarie, nel convincimento che essa è uno strumento fondamentale<br />
per favorire la cooperazione e la pace e che per progredire verso l’Unione europea<br />
l’integrazione economica deve essere accompagnata da un incisivo sviluppo delle politiche culturali.<br />
Nel Trattato di Maastricht è stata anche inserita una specifica norma sulla cultura, l’art.<br />
128, che impegna la Comunità a contribuire “al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri<br />
nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale<br />
comune”.<br />
Nel quadro di tali obiettivi la Comunità europea è intervenuta anche a favore della tutela<br />
delle minoranze.<br />
LE RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO<br />
Si è già avuto modo di accennare come negli anni ‘80 andasse sempre più maturando<br />
presso gli Organismi europei la consapevolezza che per una effettiva tutela internazionale delle<br />
minoranze fossero necessarie previsioni volte non soltanto a formulare principi fondamentali sui<br />
diritti delle minoranze, ma anche a tradurre i principi stessi in concrete misure attuative e di garanzia<br />
da parte degli Stati.<br />
Nella medesima direzione si è mossa la Comunità Europea.<br />
E’ in particolare con la Risoluzione del Parlamento Europeo del 16 ottobre 1981 su “una<br />
Carta delle lingue e culture regionali e una Carta dei diritti delle minoranze etniche” e con la<br />
contemporanea Raccomandazione 928 (1981) dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio<br />
d’Europa “sui problemi dell’educazione e della cultura delle lingue minoritarie in Europa”, che si<br />
inizia l’elaborazione dei progetto della Carta Europea delle Lingue regionali e/o minoritarie,<br />
strumento che è stato poi adottato il 5 novembre 1992 e che, in quanto convenzione, è giuridicamente<br />
impegnativo per gli Stati contraenti.<br />
Con la Risoluzione del 1981, infatti, il Parlamento Europeo muoveva dalla considerazione<br />
che l’identità culturale è uno dei bisogni psicologici non materiali più importanti e che per<br />
la salvaguardia di un patrimonio linguistico e culturale è imprescindibile creare e consolidare le<br />
condizioni idonee e necessarie per il suo continuo sviluppo.<br />
Sulla base di tali considerazioni e nell’intento di consolidare la coesione dei popoli europei<br />
e di preservarne le lingue così da arricchirne la multiculturalità, con tale Risoluzione il Parlamento<br />
Europeo invitava i governi nazionali e i poteri regionali e locali ad adottare una politica<br />
di tutela delle minoranze che avesse una comune ispirazione e tendesse agli stessi fini, con misure<br />
nei campi dell’istruzione, dell’informazione, della vita pubblica e dei rapporti sociali.<br />
In particolare, per quanto concerne il settore dell’istruzione, si richiedeva di consentire e<br />
promuovere l’insegnamento delle lingue e culture minoritarie nell’ambito dei programmi ufficiali,<br />
dalla scuola materna fino all’università, nonché nelle lingue minoritarie, in particolare nella scuola<br />
materna, come pure l’insegnamento della letteratura e della storia delle comunità interessate.<br />
Nel campo dei mezzi di comunicazione di massa si invitava a permettere e a rendere<br />
possibile l’accesso alla radio e alla televisione locali, a favorire la formazione di operatori culturali<br />
specializzati e a fare in modo che le minoranze per le loro manifestazioni culturali fruissero,<br />
nelle dovute proporzioni, di aiuti organizzativi e finanziari equivalenti a quelli di cui disponevano<br />
le maggioranze.<br />
85
Quanto al campo della vita pubblica e dei rapporti sociali, si invitava ad attribuire in materia<br />
una responsabilità diretta ai poteri locali, a “favorire al massimo la corrispondenza tra regioni<br />
culturali e disegno geografico dei poteri locali” e a garantire la possibilità di usare la propria<br />
lingua nei rapporti con i rappresentanti dello Stato e dinanzi agli organi giudiziari.<br />
La Commissione Europea veniva inoltre invitata a prevedere, nel quadro<br />
dell’educazione linguistica, progetti-pilota destinati a verificare i metodi di una educazione plurilingue,<br />
ad includere nei propri programmi relativi ai settori dell’informazione e della cultura iniziative<br />
volte a dare vita ad una politica culturale europea che tenesse conto delle aspettative<br />
delle minoranze etniche e linguistiche europee, e a riesaminare tutta la normativa e tutte le<br />
prassi comunitarie che operavano discriminazioni nei confronti delle lingue delle minoranze.<br />
Si raccomandava anche che da parte del Fondo regionale fossero destinati finanziamenti<br />
a progetti rivolti a sostenere le culture regionali e popolari, nonché a progetti economici<br />
regionali, al fine di favorire lo sviluppo economico delle aree interessate.<br />
L’esigenza di prevedere misure specifiche per la tutela delle lingue e delle culture delle<br />
minoranze veniva nuovamente riproposta dal Parlamento Europeo con la Risoluzione del “1<br />
febbraio 1983 “sulle misure a favore delle lingue e delle culture di minoranza”, con l’invito ad intensificare<br />
gli sforzi in tale settore, ed ancora, più diffusamente, con la Risoluzione del 30 ottobre<br />
1987 “sulle lingue e culture delle minoranze etniche e regionali nella Comunità Europea”.<br />
Con tale ultima Risoluzione, richiamandosi ai principi sui diritti delle minoranze sanciti<br />
dalle Nazioni Unite e dal Consiglio d’Europa, il Parlamento Europeo invitava alla completa applicazione<br />
dei principi e delle misure contenute nelle precedenti Risoluzioni e sottolineava la<br />
necessità che gli Stati membri riconoscessero le loro minoranze linguistiche nei rispettivi ordinamenti<br />
giuridici così da creare la premessa per il mantenimento e lo sviluppo delle culture e<br />
delle lingue regionali e minoritarie, sollecitando gli Stati che avevano già previsto nella propria<br />
Costituzione principi generali di tutela delle minoranze a provvedere tempestivamente, con<br />
norme organiche, all’attuazione concreta di tali principi.<br />
Si raccomandava, inoltre, l’adozione di una serie di misure concrete volte a consentire e<br />
favorire l’uso e lo sviluppo delle lingue regionali e minoritarie nei diversi settori della vita pubblica,<br />
culturale, sociale ed economica.<br />
In particolare, per quanto concerne l’istruzione, si richiedeva tra l’altro di organizzare ufficialmente,<br />
nelle zone linguistiche interessate, l’insegnamento nelle lingue regionali e minoritarie<br />
equiparato con quello nella lingua nazionale, dalla formazione prescolare all’università e alla<br />
formazione permanente, e di riconoscere ufficialmente i corsi, le classi e le scuole istituiti da associazioni<br />
abilitate all’insegnamento, che utilizzassero per l’insegnamento una lingua regionale<br />
o minoritaria.<br />
Si invitava anche a dedicare particolare attenzione alla formazione di personale insegnante<br />
nelle lingue regionali o minoritarie e ad assicurare inoltre gli strumenti pedagogici necessari<br />
per la realizzazione degli interventi nel campo dell’istruzione.<br />
Quanto ai rapporti amministrativi e giuridici si raccomandava di garantire, nelle aree di<br />
insediamento, l’impiego delle lingue regionali e minoritarie negli enti locali e negli uffici periferici<br />
dell’autorità centrale e di rivedere la legislazione nazionale e le prassi discriminanti nei confronti<br />
delle lingue delle minoranze, come pure di riconoscere ufficialmente i patronimici e i toponimi<br />
esistenti nelle lingue regionali o minoritarie, consentendo inoltre nelle liste elettorali la denominazione<br />
di località ed altre indicazioni in tali lingue.<br />
Con riguardo al campo dei mezzi di comunicazione di massa si esortava a consentire<br />
l’accesso alle emittenti pubbliche e private e ad assicurare ai gruppi minoritari, per i loro programmi,<br />
sostegni organizzativi e finanziari analoghi a quelli della maggioranza, raccomandando<br />
anche di sostenere la formazione dei giornalisti e del personale operante nel settore.<br />
Nel campo delle attività culturali si richiedeva di garantire la partecipazione diretta dei<br />
rappresentanti di gruppi che utilizzano lingue regionali o minoritarie alla gestione della cultura e<br />
alle attività collaterali, e di creare fondazioni o istituti per lo studio delle lingue regionali o minoritarie<br />
in grado, tra l’altro, di elaborare gli strumenti didattici necessari alla loro introduzione nella<br />
scuola nonché di redigere un “inventario generale” delle lingue regionali o minoritarie interessate,<br />
assicurando il necessario sostegno materiale e finanziario per la realizzazione delle relative<br />
misure.<br />
Per quanto concerne la realtà socioeconomica, si raccomandava di prevedere l’impiego<br />
delle lingue regionali o minoritarie nelle imprese pubbliche e di riconoscere l’impiego di tali lin-<br />
86
gue nei sistemi di pagamento (assegni postali e attività bancarie), nonché nella toponomastica,<br />
nelle iscrizioni dei cartelli stradali e nella segnaletica stradale.<br />
Un riferimento specifico veniva inoltre rivolto alle lingue regionali e minoritarie utilizzate<br />
in più Stati membri, e in particolare nelle zone di confine, per le quali si raccomandava sia di<br />
provvedere a meccanismi appropriati di cooperazione transfrontaliera nell’ambito della politica<br />
culturale e linguistica, sia di incentivare tale cooperazione.<br />
La successiva Risoluzione A3-0396/92 del 21 gennaio 1993 “sulla Comunicazione della<br />
Commissione concernente le nuove prospettive per l’azione della Comunità nel settore culturale”,<br />
interviene dopo l’adozione del Trattato di Maastricht, che introduce la specifica disposizione<br />
di cui all’art. 128 finalizzata allo sviluppo delle culture degli Stati membri.<br />
Tale Risoluzione si occupa pertanto, in particolare della valorizzazione della cultura europea<br />
nelle sue molteplici espressioni di politiche culturali adeguate, anche a livello comunitario<br />
secondo il principio di sussidiarietà, sottolineando che sempre di più la cultura costituisce un fattore<br />
fondamentale di coesione sociale e di crescita della soggettività e che il cammino verso<br />
l’Unione Europea passa “attraverso la manifestazione e la promozione dell’identità culturale europea,<br />
in quanto unità composta tanto più evidente quanto maggiore è la forza ed efficace la<br />
promozione delle diverse culture europee, nazionali, regionali o delle minoranze”.<br />
In tale ampio contesto, quindi, l’attenzione è rivolta anche alle culture delle minoranze e<br />
in particolare alle lingue regionali o minoritarie, la cui difesa e valorizzazione viene considerata<br />
“una premessa metodologica essenziale per ogni politica culturale davvero consapevole di un<br />
approccio finalizzato a mettere in risalto la diversità culturale dell’Europa”.<br />
Ma con la Risoluzione A3-0056/93 sui “diritti dell’uomo nel mondo e sulla politica comunitaria<br />
dei diritti umani per gli anni 1991-1992” del 12 marzo 1993 il Parlamento Europeo amplia<br />
ulteriormente i temi di protezione delle minoranze nazionali, non più specificamente attinenti agli<br />
aspetti della lingua e della cultura, bensì riferiti al più ampio quadro dei diritti dell’uomo e delle<br />
libertà fondamentali.<br />
Nella Risoluzione del 1993, quindi, si sottolinea innanzitutto che il rispetto dei diritti umani<br />
e delle libertà fondamentali deve essere preso sempre più in considerazione nelle posizioni<br />
del Parlamento Europeo sugli accordi con i Paesi terzi e nella cooperazione internazionale<br />
e si chiede, conseguentemente, che i diritti umani rappresentino sempre una parte esplicita del<br />
mandato per negoziare con tali Paesi e che tutti gli accordi con essi contengano un meccanismo<br />
appropriato che possa diventare immediatamente operativo non appena si verifichino palesi<br />
violazioni dei diritti dell’uomo.<br />
Si sottolinea inoltre il ruolo primario del Consiglio d’Europa per quanto concerne i diritti<br />
umani nell’Europa ampliata evidenziando che i criteri dallo stesso fissati “hanno costituito un<br />
punto di riferimento per i Paesi di recente democratizzazione dell’Europa centrale e orientale”<br />
(76).<br />
Si sottolinea anche il crescente impegno della CSCE sul tema della dimensione umana<br />
ricordando che nel documento di Copenaghen del giugno 1990 sono stati affermati molti importanti<br />
diritti, soprattutto in merito a quelli delle minoranze (79), e si considera il meccanismo di<br />
intervento della diplomazia preventiva come definito nella Conferenza di Helsinki del 1992, un<br />
utile strumento per allentare le tensioni e scoraggiare i conflitti, (92) pur rilevando l’opportunità<br />
di un coordinamento con le altre iniziative intergovernative.<br />
Alle minoranze è riservata una specifica parte della Risoluzione, nella quale si rileva<br />
che il problema della crescente tensione tra etnie e nazionalità si sta sviluppando in modo evidente<br />
sia in Europa che nel resto del mondo, e si ricorda che le garanzie giuridiche e politiche a<br />
tutela delle minoranze etniche, nazionali, religiose, linguistiche ed i diritti umani connessi “devono<br />
essere assicurate in modo tale che nessun svantaggio insuperabile derivi dal fatto di appartenere<br />
ad una minoranza” qualunque sia la soluzione che nei diversi casi si dà al problema della<br />
sovranità nazionale e delle frontiere (97), e che la previsione di adeguate garanzie per le minoranze<br />
è tra le condizioni indispensabili per il riconoscimento di nuovi Stati e per stabilire relazioni<br />
di cooperazione con essi (98).<br />
Si appoggia inoltre la nomina dell’Alto Commissario per le Minoranze nazionali in seno<br />
alla CSCE (100) e si afferma che i problemi relativi alle minoranze sono di legittimo interesse<br />
internazionale, riconoscendo il ruolo guida del Consiglio d’Europa nel campo dei diritti umani<br />
(101).<br />
L’adozione, da parte della Assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicembre 1992,<br />
87
della Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose<br />
o linguistiche è accolta con grande favore (102), ma attesa la mancanza, nonostante<br />
questa importante dichiarazione, di uno strumento internazionalmente vincolante per quanto riguarda<br />
la tutela delle minoranze, si ravvisa la necessità “di concepire un sistema internazionale,<br />
che possibilmente trovi ispirazione nella CSCE, per una attiva protezione delle minoranze (103).<br />
Nel ricordare al riguardo che da parte del Consiglio d’Europa è stata adottata la “Carta<br />
Europea per le Lingue regionali e/o minoritarie” sotto forma di convenzione, e quindi internazionalmente<br />
vincolante, aperta alla firma del 5 novembre 1992, si sollecitano gli Stati ad aderirvi<br />
senza indugio e ad accelerare, in sede di Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, la stipula<br />
di un protocollo interlocutorio relativo alla Convenzione sulla tutela dei diritti umani delle minoranze<br />
(107), stipula alla quale poco tempo dopo si perverrà con l’adozione della Convenzionequadro<br />
per la protezione delle minoranze nazionali, aperta alla firma il 10 febbraio 1995.<br />
Si decide, infine, un ulteriore rafforzamento dell’azione del Parlamento europeo nel<br />
campo dei diritti umani, anche in relazione al suo potere di non concedere il parere conforme<br />
per accordi con Paesi terzi in presenza di gravi violazioni dei diritti umani (149 e 150) e di attuare<br />
un maggior coordinamento con altri organismi nazionali ed internazionali operanti nel settore,<br />
sia all’interno che all’esterno della Comunità europea (158).<br />
Sulle minoranze linguistiche e culturali il Parlamento Europeo torna ancora con la Risoluzione<br />
A3-0042/94 del 9 febbraio 1994 per esortare ad una azione di protezione e promozione<br />
della diversità linguistica quale “fattore chiave nella realizzazione di una Europa pacifica e democratica”.<br />
Si considera infatti che la Comunità europea ha la responsabilità di sostenere gli Stati<br />
per quanto attiene allo sviluppo delle loro culture e alla salvaguardia delle loro varie identità nazionali<br />
e regionali, “in particolare delle lingue autoctone e delle minoranze”, e deve garantire<br />
una tutela giuridica, con le necessarie risorse finanziarie, anche delle lingue e culture meno diffuse<br />
in quanto parte della cultura e del patrimonio europeo dell’Unione, ed inoltre che “numerose<br />
lingue meno diffuse si trovano in una difficile situazione, dato il rapido crollo del numero di<br />
parlanti”, ciò che “mette a repentaglio il benessere di gruppi specifici di popolazione e riduce<br />
considerevolmente il potenziale di creatività dell’Europa nel suo complesso”.<br />
Mosso da tali considerazioni, il Parlamento Europeo sollecita la piena applicazione dei<br />
principi e delle proposte contenute nelle precedenti Risoluzioni, ribadendo la necessità che gli<br />
Stati membri riconoscano le proprie minoranze linguistiche e adottino le misure giuridiche ed<br />
amministrative necessarie per la conservazione e lo sviluppo delle lingue minoritarie (1 e 2).<br />
Secondo il Parlamento europeo, inoltre, tutte le lingue e culture meno diffuse debbono<br />
essere protette da uno status giuridico adeguato, che dovrebbe implicare, quanto meno, il loro<br />
uso e la promozione negli ambiti dell’insegnamento, della giustizia, dell’amministrazione pubblica,<br />
dei mezzi di informazione, della toponomastica e degli altri settori della vita pubblica e culturale,<br />
ed i cittadini di uno Stato membro che usano una lingua o hanno una cultura diversa da<br />
quella predominante all’interno dello Stato, o in una sua parte o regione, non debbono subire<br />
alcuna discriminazione, e in particolare “nessun tipo di emarginazione sociale che renda loro<br />
difficile l’accesso o la permanenza in un posto di lavoro” (3-5).<br />
Un ulteriore invito viene rivolto agli Stati membri a firmare e ratificare la Carta europea<br />
delle lingue regionali o minoritarie, che ha la veste giuridica di Convenzione ed è uno “strumento<br />
tanto efficace quanto flessibile ai fini della salvaguardia e della promozione delle lingue meno<br />
diffuse” (6-7) e si esortano gli Stati stessi e le amministrazioni regionali e locali ad incoraggiare<br />
e sostenere le associazioni specializzate, in particolare i comitati nazionali presso l’Ufficio Europeo<br />
per le Lingue meno diffuse, “al fine di valorizzare le responsabilità dei cittadini e delle loro<br />
organizzazioni in ordine all’affermazione delle loro lingue” (8).<br />
Si chiede inoltre alla Commissione di contribuire all’esecuzione delle azioni intraprese<br />
dagli Stati nel settore e di tenere in debito conto le lingue e le culture meno diffuse<br />
nell’elaborazione dei vari aspetti della politica comunitaria, al fine di “provvedere pariteticamente<br />
alle esigenze specifiche di coloro che parlano lingue minoritarie, parallelamente a quelle degli<br />
utenti di lingue maggioritarie” nei programmi concernenti l’istruzione e la cultura, incoraggiando,<br />
tra l’altro, anche l’impiego di tali lingue nell’ambito della politica audiovisiva della Comunità (10).<br />
Vengono altresì sollecitati il sostegno finanziario delle organizzazioni europee rappresentative<br />
delle lingue meno diffuse e la previsione di stanziamenti di bilancio per i programmi<br />
88
comunitari, tenendo in debito conto il retaggio linguistico e culturale delle regioni negli stanziamenti<br />
dei Fondi Strutturali Europei, nonché le esigenze degli utenti di lingue minoritarie nei Paesi<br />
dell’Europa centrale e orientale nella messa a punto di programmi comunitari per la ricostruzione<br />
economica e sociale.<br />
Nel contempo si esorta a garantire che la Comunità europea non incoraggi le lingue<br />
meno diffuse a danno delle lingue nazionali principali ed anzi faccia in modo che non sia compromesso<br />
l’insegnamento della lingua principale nelle scuole (11).<br />
Si esorta, infine, ad applicare per analogia le raccomandazioni contenute nella Risoluzione<br />
alle lingue minoritarie autoctone non territoriali, come ad esempio la lingua degli zingari,<br />
rom, sinti e l’yiddish (13).<br />
89
GLI INTERVENTI DELL’INIZIATIVA CENTRO - EUROPEA<br />
91
PREMESSA<br />
Anche l’Iniziativa Centro Europea, sin dagli inizi della cooperazione tra i suoi Stati<br />
membri, si è occupata delle questioni riguardanti le minoranze, nella considerazione che il rispetto<br />
e la promozione dei loro diritti contribuiscono in modo essenziale alla pace ed alla stabilità<br />
nell’Europa Centrale ed Orientale.<br />
Per l’approfondimento di tali questioni già nel 1990 era stato costituito un Gruppo di lavoro<br />
ad hoc, che è stato successivamente trasformato in Gruppo permanente per le minoranze<br />
e che venne tra l’altro incaricato di elaborare posizioni comuni su taluni temi fondamentali, da<br />
presentare al Vertice di Vienna dei Capi di Stato e di <strong>Governo</strong> del Consiglio d’Europa, programmato<br />
per l’ottobre 1993.<br />
In tale contesto, la delegazione italiana all’interno del Gruppo di lavoro ad hoc presentò<br />
un progetto predisposto in forma di convenzione, e quindi giuridicamente vincolante per i Paesi<br />
firmatari, che si ispirava a numerosi documenti internazionali, e in particolare a quelli della<br />
CSCE adottati nella riunione di Copenaghen del 1990 e nella riunione degli Esperti di Ginevra<br />
del 1991, alle proposte formulate in quella sede dalla Pentagonale e dalla Esagonale alla proposta<br />
di convenzione elaborata dalla Commissione per la democrazia attraverso il Diritto ed alla<br />
Raccomandazione 1201 del 1993 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa.<br />
Senonché, nell’annuale riunione dei Capi di <strong>Governo</strong> della CEI tenutasi a Budapest il 16<br />
e 17 luglio 1993, si ritenne di far predisporre dal Gruppo di Lavoro uno “strumento” accettabile<br />
per tutti gli Stati membri basato sui principi internazionalmente accettati, strumento che per decisione<br />
assunta in quella sede, sarebbe stato, un documento politico.<br />
Dopo un intenso lavoro, mirato anche ad armonizzare i contenuti del documento con il<br />
progetto di Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali elaborato in seno<br />
al Consiglio d’Europa con il quale si era a tal fine sviluppata una stretta cooperazione, nella riunione<br />
ministeriale tenutasi a Torino il 18-19 novembre 1994 il testo dello Strumento CEI per la<br />
Protezione dei Diritti delle Minoranze così predisposto dal Gruppo di Lavoro otteneva la favorevole<br />
accoglienza dei Ministri degli Esteri dei Paesi membri, i quali presero atto che entrambi i<br />
Documenti - lo Strumento CEI e la Convenzione-quadro del Consiglio d’Europa - erano basati<br />
sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali da esercitarsi sia individualmente<br />
sia comunitariamente, considerando inoltre tali minoranze come parte integrante dello Stato e<br />
della società in cui vivono.<br />
Nella stessa riunione lo Strumento veniva aperto alla firma degli Stati membri, di quelli<br />
associati e degli altri Paesi interessati, presso il Ministero degli Affari Esteri dell’Italia, Stato depositario<br />
dello Strumento stesso, dove tutt’ora è a disposizione per la firma.<br />
LO STRUMENTO CEI PER LA TUTELA DEI <strong>DIRITTI</strong> DELLE MINORANZE<br />
Lo Strumento CEI per la protezione dei diritti delle minoranze, che si compone di 27 articoli<br />
preceduti da un preambolo, mira a garantire la protezione delle minoranze nazionali attraverso<br />
il riconoscimento dei diritti e la previsione di misure concrete per assicurarne l’effettivo<br />
esercizio, diritti che, in linea con gli orientamenti prevalentemente emersi nelle sedi europee,<br />
sono riferiti alle persone appartenenti alle minoranze e non alle minoranze stesse in quanto tali.<br />
Nel preambolo vengono evidenziati i principi e le considerazioni ai quali gli Stati si ispirano.<br />
Si riconosce innanzitutto che le questioni relative alle minoranze nazionali possono trovare<br />
soluzioni soddisfacenti soltanto in un quadro politico realmente democratico, che sia fondato<br />
sullo stato di diritto e che garantisca pieno rispetto per i diritti umani e per le libertà fondamentali,<br />
e uguali diritti e status per tutti i cittadini, e si ribadisce che le minoranze nazionali sono<br />
una parte integrante della società dello Stato in cui vivono e un fattore di arricchimento di ogni<br />
rispettivo Stato e società.<br />
Si afferma inoltre che la loro tutela riguarda soltanto i cittadini del rispettivo Stato, in<br />
piena parità di diritti e doveri con il resto della popolazione, ma si conferma anche che le questioni<br />
concernenti i diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali sono “di legittimo<br />
interesse internazionale” e pertanto “non costituiscono esclusivamente un affare interno del ri-<br />
93
spettivo Stato” e che il rispetto di tali diritti, quale parte dei diritti umani universalmente riconosciuti,<br />
è un “fattore essenziale per la pace, la giustizia, la stabilità e la democrazia negli Stati”.<br />
Si sottolinea che le relazioni di buon vicinato sono un rimedio molto efficace “per conseguire<br />
la stabilità nella regione” e che è necessario “evitare ogni incoraggiamento alle tendenze<br />
separatiste delle minoranze nazionali”, affermando che la tutela internazionale dei diritti delle<br />
persone appartenenti alle minoranze nazionali prevista nello Strumento non consente attività<br />
contrarie ai principi fondamentali del diritto internazionale e in particolare della sovranità,<br />
dell’integrità territoriale e dell’indipendenza politica degli Stati.<br />
Si riconosce poi la particolare importanza di una crescente cooperazione costruttiva tra<br />
gli Stati della CEI sulle questioni concernenti le minoranze nazionali, tesa anche a promuovere<br />
la reciproca comprensione e fiducia, relazioni amichevoli e di buon vicinato, pace internazionale,<br />
sicurezza e giustizia, condannando infine il “nazionalismo aggressivo”, l’odio razziale ed etnico,<br />
l’antisemitismo, la xenofobia, la discriminazione contro ogni persona o gruppo e la persecuzione<br />
per motivi religiosi e ideologici.<br />
Sulla base di questi principi, gli Stati che sottoscrivono lo Strumento riconoscono innanzitutto,<br />
all’art. I, “l’esistenza delle minoranze”, che considerano “parte integrante della società in<br />
cui vivono”, e si impegnano a garantire le condizioni idonee per la promozione della loro identità.<br />
Ai fini dell’applicazione dello Strumento, viene poi data la definizione del termine “minoranza<br />
nazionale”, inteso come “un gruppo che ha una consistenza numerica minore rispetto al<br />
resto della popolazione di uno Stato, i cui membri, cittadini di questo Stato, hanno caratteristiche<br />
etniche, religiose o linguistiche differenti da quelle del resto della popolazione, e sono animati<br />
dalla volontà di salvaguardare la propria cultura, le proprie tradizioni, la propria religione e<br />
lingua”.<br />
Nel ricondurre poi l’appartenenza ad una minoranza nazionale alla libera scelta individuale,<br />
dalla quale nessun pregiudizio deve derivare (art. 2), gli Stati riconoscono alle persone<br />
appartenenti alle minoranze nazionali il diritto di esercitare sia individualmente che in comune<br />
con altri i diritti previsti nello Strumento, come pure i diritti umani e le libertà fondamentali, senza<br />
alcuna discriminazione e in piena uguaglianza davanti alla legge (art. 3).<br />
Viene in particolare garantito il diritto di esprimere, preservare e sviluppare la propria<br />
identità etnica, culturale, linguistica o religiosa e di mantenere e sviluppare la propria cultura in<br />
tutti i suoi aspetti (art. 4), stabilendo anche che non è da considerare come atto discriminatorio<br />
l’adozione di misure speciali in favore delle persone appartenenti alle minoranze nazionali volte<br />
a promuoverne l’uguaglianza con il resto della popolazione o a tenere in debito conto le loro<br />
specifiche condizioni (art. 5), e che da parte degli Stati firmatari dovranno essere assunte concrete<br />
misure per assicurare protezione contro ogni atto che costituisca incitamento alla violenza<br />
nei confronti di persone o gruppi per motivi di ostilità, odio o discriminazione nazionale, razziale,<br />
etnica o religiosa (art. 6).<br />
Una specifica previsione poi, contenuta nell’art. 7, riguarda i Rom, di cui gli Stati firmatari<br />
riconoscono “i particolari problemi” impegnandosi ad “adottare tutte le misure giuridiche in materia<br />
amministrativa o scolastica” previste nello Strumento al fine di preservarne e svilupparne<br />
l’identità, nonché a favorire con specifiche misure l’integrazione sociale dei loro appartenenti e<br />
ad eliminare ogni forma di intolleranza nei loro confronti.<br />
Si stabilisce inoltre che gli Stati debbano astenersi dall’adottare od incoraggiare politiche<br />
miranti all’assimilazione forzata delle persone appartenenti alle minoranze, proteggendole,<br />
anche da qualsiasi azione a ciò finalizzata (art. 8), e che eventuali modifiche delle suddivisioni<br />
amministrative, giudiziarie o elettorali dovranno rispettare i diritti di tali persone ed il loro esercizio<br />
e dovranno in ogni caso essere precedute dalla consultazione, secondo la legislazione nazionale,<br />
“con le popolazioni direttamente interessate” (art. 9).<br />
Si prevede in tal modo il coinvolgimento anche della minoranza nazionale interessata,<br />
qui presa in considerazione in quanto tale, in scelte di fondamentale portata per le alterazioni<br />
che queste potrebbero comportare nell’assetto esistente e per le connesse implicazioni, anche<br />
sotto il profilo della sopravvivenza stessa della minoranza.<br />
Ampio spazio lo Strumento dedica alla protezione della lingua e della cultura delle minoranze.<br />
Quanto alla lingua, alle persone appartenenti alle minoranze si riconosce in primo luogo<br />
il diritto all’uso “liberalmente sia in pubblico che in privato, sia oralmente che per iscritto” (art.<br />
94
10), nonché al riconoscimento e alla registrazione ufficiale del proprio nome e cognome nella<br />
propria lingua, oltreché, ovviamente, al relativo uso (art. 11).<br />
Il diritto all’uso della lingua madre è riconosciuto anche nell’esercizio della libertà di religione,<br />
pure espressamente affermata (art. 14).<br />
Per quanto concerne i rapporti con la pubblica amministrazione è previsto, “quando<br />
possibile”, il diritto all’uso orale e scritto della propria lingua nei contatti con le pubbliche autorità<br />
nell’area di insediamento allorché gli appartenenti ad una minoranza raggiungono “un numero<br />
considerevole” secondo le risultanze dell’ultimo censimento o di altri metodi di valutazione (art.<br />
12).<br />
Vengono in tal modo rimesse alla discrezionalità degli Stati sia la valutazione della congruità<br />
della consistenza numerica, sia la determinazione di altre condizioni ritenute necessarie<br />
ai fini del riconoscimento del diritto.<br />
Non è previsto, inoltre, un parallelo obbligo di usare la lingua della minoranza da parte<br />
delle pubbliche autorità locali, le quali “possono rispondere, per quanto possibile” in tale lingua.<br />
Per quanto riguarda, poi, le aree in cui le persone appartenenti ad una minoranza costituiscono<br />
la maggioranza della popolazione, l’art. 15 impegna gli Stati a promuovere la conoscenza<br />
della lingua della minoranza tra i funzionari degli uffici amministrativi locali e statali decentrati<br />
e stabilisce che “sforzi devono essere compiuti per reclutare se possibile” funzionari che<br />
in aggiunta alla lingua ufficiale, abbiano una conoscenza sufficiente della lingua della minoranza.<br />
Spazi di flessibilità sono pure previsti nell’art. 13, che dà facoltà agli Stati di consentire,<br />
ove necessario attraverso accordi bilaterali con altri Stati interessati e in particolare con quelli<br />
confinanti, il ripristino della toponomastica locale e delle indicazioni topografiche in forma bilingue<br />
o plurilingue nelle zone in cui il numero delle persone appartenenti ad una minoranza raggiunge<br />
“un livello significativo”. Anche in tale caso; infatti, sono rimesse agli Stati sia la valutazione<br />
della congruità della soglia ai fini dell’adozione della misura di tutela, sia la determinazione<br />
in ordine all’adozione della misura stessa.<br />
Relativamente al campo della cultura e dell’educazione viene riconosciuto il diritto di<br />
stabilire e conservare propri istituti, organizzazioni ed associazioni culturali, che possono richiedere<br />
contributi privati e sovvenzioni pubbliche in base alla legislazione nazionale (art. 16), nonché<br />
proprie scuole private ed istituti di istruzione, ed eventualmente di ottenerne il riconoscimento<br />
secondo la legislazione nazionale in materia, con possibilità di richiedere finanziamenti<br />
anche pubblici (art. 17).<br />
Viene inoltre garantito il diritto di apprendere la propria lingua e di ricevere una istruzione<br />
in tale lingua e si stabilisce che quando in un’area il numero delle persone appartenenti ad<br />
una minoranza nazionale raggiunga un livello significativo, sforzi debbono essere compiuti “per<br />
assicurare adeguati tipi e livelli di istruzione pubblica”, prevedendo anche un adeguato insegnamento<br />
della storia e della cultura delle minoranze nazionali nell’ambito dei programmi relativi<br />
a tali discipline (art. 18).<br />
Per quanto concerne il campo dell’informazione, viene garantito il diritto di avvalersi dei<br />
mezzi di comunicazione di massa nella lingua della minoranza, con possibilità anche di sostegni<br />
finanziari, prevedendo però che il diritto al libero accesso al mezzo radio-televisivo di proprietà<br />
pubblica, compresa la produzione di programmi in tale lingua, sia garantito dagli Stati “è quando<br />
opportuno e possibile” (art. 19).<br />
Viene inoltre riconosciuto il diritto di partecipare senza alcuna discriminazione alla vita<br />
politica, sociale e culturale della società del proprio Paese, con l’impegno, per gli Stati, a promuovere<br />
le condizioni che permettano il concreto esercizio dei relativi diritti (art. 20) e a consentire<br />
la costituzione di partiti politici (art. 21), come pure a rispettare il diritto di partecipare effettivamente<br />
alla vita pubblica, in particolare ai processi decisionali ,sulle questioni di diretto interesse.<br />
A tale riguardo gli Stati «prendono nota» degli impegni assunti per tutelare e creare le<br />
condizioni per la promozione dell’identità etnica, culturale, linguistica e religiosa minoranze nazionali<br />
con l’adozione di misure adeguate alle specifiche situazioni di tali minoranze come previsto<br />
nei documenti della CSCE (art. 22).<br />
Si garantisce inoltre il diritto, nel rispetto dell’integrità territoriale dello Stato, di tenere<br />
contatti liberi e senza ostacoli oltre frontiera con i cittadini con i quali sono in comune le caratteristiche<br />
etniche, religiose o linguistiche o l’identità culturale nel quadro anche di una promozione<br />
globale degli accordi transfrontalieri a livello nazionale, regionale e locale (art. 23).<br />
95
La previsione contenuta nell’art. 24 mira poi a garantire la possibilità di un effettivo rimedio<br />
di giustizia contro ogni violazione dei diritti previsti nello Strumento che siano stati sanciti<br />
nella legislazione nazionale, mentre con i successivi articoli, oltre a prevedere garanzie di tutela,<br />
con adeguate misure, per le persone che non appartengono alla minoranza nazionale nelle<br />
aree in cui questa costituisce la maggioranza della popolazione (art. 25), si sancisce il principio<br />
della intangibilità dei principi fondamentali del diritto internazionale, e in particolare<br />
dell’uguaglianza sovrana, dell’integrità territoriale e dell’indipendenza politica, e del rispetto dei<br />
diritti altrui da parte delle persone appartenenti alle minoranze nazionali nell’esercizio dei propri<br />
diritti (art. 26).<br />
Lo Strumento CEI si conclude con la clausola di salvaguardia (art. 27) delle disposizioni<br />
delle leggi nazionali o di accordi internazionali più favorevoli per le minoranze nazionali o per le<br />
persone che vi appartengono, previsione che, in presenza di siffatte disposizioni, vincolanti per<br />
gli Stati in quanto contenute nelle rispettive legislazioni o in accordi internazionali che essi abbiano<br />
sottoscritto e che siano anche giuridicamente impegnativi, ha l’effetto di poter assicurare<br />
ulteriori misure di tutela.<br />
96
IL CONTRIBUTO DELL’UNIONE FEDERALISTA<br />
DEI GRUPPI ETNICI EUROPEI (U.F.G.E.E.)<br />
97
PREMESSA<br />
Il progetto di Convenzione per la tutela dei gruppi etnici in Europa dell’Unione Federalista<br />
dei Gruppi Etnici Europei (UFGE), approvato dall’Assemblea dei Delegati in occasione del<br />
35° Congresso tenutosi a Danzica il 12.5.1994, è una stesura aggiornata del progetto di Convenzione<br />
allegato alla Dichiarazione di Cottbus del 28.5.1992 alla luce degli sviluppi intervenuti,<br />
sul piano dialettico ed operativo, nel dibattito internazionale sulla tutela delle minoranze nazionali.<br />
In linea con il compito statutario dell’Unione Federalista, di rappresentare gli interessi<br />
delle organizzazioni dei gruppi etnici e dei loro appartenenti e di contribuire alla formazione di<br />
un diritto dei gruppi etnici internazionalmente riconosciuto, il progetto nasce dalla constatazione<br />
dei positivi sviluppi intervenuti e delle prospettive ulteriori, in particolare a seguito delle decisioni<br />
dei Capi di Stato e di <strong>Governo</strong> del Consiglio d’Europa assunte a Vienna nel Vertice del 9 ottobre<br />
1993, e dalla connessa volontà di fornire un contributo costruttivo per ulteriori passi in avanti<br />
verso una tutela globale dei gruppi etnici.<br />
Era stata adottata, infatti, la Carta Europea delle Lingue regionali o minoritarie ed era in<br />
corso di elaborazione, da parte dell’apposito CAHMlN, il progetto di convenzione per la protezione<br />
delle minoranze nazionali, deciso a Vienna, da aprirsi anche alla firma degli Stati non<br />
membri del Consiglio d’Europa, ed inoltre, nello stesso Vertice di Vienna era stato anche deciso<br />
di avviare i lavori per la predisposizione di un protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea<br />
sui Diritti dell’Uomo nel campo culturale con disposizioni di garanzia dei diritti individuali, in particolare<br />
per le persone appartenenti alle minoranze nazionali.<br />
Si erano quindi creati nuovi presupposti per ulteriori sviluppi positivi, per i quali l’UFGE<br />
intendeva dare un contributo costruttivo con un progetto aggiornato della Dichiarazione di Cottbus<br />
volto ad una tutela giuridica globale dei gruppi etnici in Europa, riferita anche ai diritti collettivi,<br />
che negli strumenti da elaborare non sarebbero stati considerati.<br />
PROGETTO DI CONVENZIONE PER LA TUTELA DEI GRUPPI ETNICI IN EUROPA<br />
DELL’UNIONE FEDERALISTA DEI GRUPPI ETNICI IN EUROPA<br />
Il progetto, intitolato “Tutela dei gruppi etnici in Europa”, è composto da due parti, formalmente<br />
distinte ma fra loro complementari, nell’ottica di una tutela generale dei diritti dei<br />
gruppi etnici e delle persone che vi appartengono.<br />
La prima parte, riguardante i “Diritti fondamentali delle persone appartenenti a gruppi<br />
etnici in Europa”, viene proposta come progetto di Protocollo aggiuntivo alla Convenzione Europea<br />
sui Diritti dell’Uomo”; mentre la seconda, concernente i “Diritti di autonomia dei gruppi etnici<br />
in Europa”, è proposta come progetto di discussione per una Convenzione Speciale.<br />
Nell’elaborazione del progetto si è tenuto conto dei documenti e delle dichiarazioni<br />
dell’O.N.U., della CSCE e degli Organismi europei in materia di tutela delle minoranze nazionali,<br />
come pure di una serie di dichiarazioni di principio emerse nell’ambito di conferenze su problematiche<br />
specifiche.<br />
I diritti fondamentali delle persone appartenenti ai gruppi etnici in Europa. Progetto di<br />
protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea sui diritti dell’Uomo<br />
Tale documento, proposto come Protocollo aggiuntivo alla CEDU, è quello più immediatamente<br />
collegato allo stato del dibattito europeo in materia e agli indirizzi adottati a Vienna e<br />
seguiti dall’apposito Comitato per l’elaborazione del progetto di Convenzione-quadro per la protezione<br />
delle minoranze nazionali.<br />
Esso, pur mantenendosi nei limiti del principio di tutela individuale e dell’autonomia culturale,<br />
mira ad assicurare alle persone appartenenti ai gruppi etnici il massimo livello dì riconoscimento<br />
e tutela dei diritti attraverso una formulazione molto precisa, che riduce al minimo, il<br />
margine di discrezionalità degli Stati contraenti sia per ciò che è intendersi con l’espressione<br />
“gruppo etnico”, definizione non contenuta nella Convenzione-quadro per la protezione delle<br />
minoranze nazionali, sia per quel che concerne le misure da adottare e le condizioni alle quali<br />
tali misure vanno adottate.<br />
99
Oltre all’introduzione, che non ne è parte integrante, il documento, costituito da 23 articoli<br />
è articolato in sei parti, precedute da un Preambolo, e correlato da numerosi fonti giuridiche<br />
e politiche.<br />
La Parte I, che comprende tre articoli, riconduce la tutela internazionale dei diritti delle<br />
persone appartenenti a gruppi etnici alla tutela internazionale dei diritti dell’uomo quale sua<br />
componente essenziale, rientrante, come “fattore essenziale per la pace, la giustizia, la stabilità<br />
e la democrazia”, nell’ambito della cooperazione internazionale e, in quanto questione di legittimo<br />
interesse internazionale, di non esclusivo affare interno dello Stato (art. 1).<br />
Viene poi fornita, all’art. 2, la definizione di “gruppo etnico”, nella cui espressione si mira<br />
a ricomprendere lo spettro più ampio possibile di realtà minoritarie, escludendo però esplicitamente<br />
dal concetto sia i lavoratori migranti, sia altri immigranti, gruppi di rifugiati e individui in<br />
cerca di asilo, i cui diritti formano oggetto di specifica disciplina.<br />
L’art. 3 afferma il principio dell’appartenenza volontaria, impegnando gli Stati contraenti<br />
a creare i presupposti per tale libera scelta individuale e ribadendo il principio, già enunciato<br />
all’art. 1, che i diritti riconosciuti alle persone appartenenti a gruppi etnici possono essere esercitati<br />
sia “individualmente” che in associazione con altri membri del gruppo”; formula, questa, in<br />
sintonia con gli altri documenti elaborati in sedi istituzionali europee, che consente di sorvolare<br />
circa il riconoscimento di quei diritti di natura collettiva che formano invece oggetto di tutela nel<br />
secondo progetto per una Convenzione speciale.<br />
Nella Parte II vengono formulati i diritti fondamentali generali riconosciuti alle persone<br />
appartenenti ai gruppi etnici, premessa dei diritti che vengono sviluppati nella Parte III e che si<br />
configurano più concretamente come misure di tutela.<br />
In sostanza, alle persone appartenenti ai gruppi etnici viene riconosciuto il diritto al rispetto,<br />
alla evoluzione e allo sviluppo della loro identità etnica, culturale e linguistica, al riparo<br />
da ogni tentativo di assimilazione. Componenti essenziali di tale diritto sono il diritto alla patria,<br />
ed in particolare alla tutela dei loro insediamenti e condizioni di vita tradizionali, il diritto al libero<br />
sviluppo economico, il diritto alla protezione da qualsiasi minaccia alla loro identità, con divieto<br />
di politiche di assimilazione forzata e di svantaggiose modifiche intenzionali nella composizione<br />
demografica dei loro insediamenti, anche tramite modifiche delle unità amministrative (art. 4).<br />
Viene inoltre garantito il diritto alla non discriminazione e alla effettiva parità di trattamento,<br />
nonché alla parità di opportunità (art. 5), da assicurare mediante misure di tutela speciali,<br />
con particolare riferimento al diritto alla lingua, alla scuola e all’educazione, ad avere proprie<br />
organizzazioni, ai liberi contatti e alla libera circolazione, alla libertà d’informazione, all’accesso<br />
proporzionale agli uffici pubblici, alla rappresentanza politica, ad adeguate forme di economia,<br />
la cui omissione è “da considerare e da trattare come atto di discriminazione illegittimo”.<br />
I contenuti di questi diritti vengono esplicitati nella Parte III, in relazione alle misure di tutela<br />
specifiche.<br />
In particolare, il diritto alla lingua (art. 6) si estrinseca nel diritto al suo uso orale e scritto<br />
in privato e in pubblico, come pure nei rapporti con la pubblica amministrazione, ivi compresa<br />
quella giudiziaria, alla sua parificazione nei territori di insediamento negli atti ufficiali e in quelli<br />
destinati ad uso pubblico, nonché nei diritti concernenti l’onomastica e la toponomastica.<br />
Al diritto alla lingua è collegato anche il diritto alla scuola (art. 7), nel senso che, ferma<br />
restando l’obbligatorietà dell’apprendimento della lingua ufficiale dello Stato, è previsto il diritto<br />
all’insegnamento della e nella lingua del gruppo etnico nelle scuole di ogni ordine e grado,<br />
nell’università e nell’ambito dell’istruzione permanente, tramite un adeguato numero di scuole<br />
statali o di altro tipo, da dislocarsi tenendo conto della distribuzione geografica delle persone<br />
appartenenti ai gruppi etnici. Il diritto all’insegnamento della e nella lingua materna, il cui finanziamento<br />
fa carico agli Stati contraenti, viene garantito anche se al di fuori degli insediamenti<br />
delle persone appartenenti a gruppi etnici non vi sia il numero minimo necessario di scolari per<br />
la formazione di una classe.<br />
E’ parimenti garantito il diritto di istituire e gestire propri istituti di istruzione e formazione<br />
e si prevede che l’insegnamento sia impartito in linea di massima da personale docente di madrelingua.<br />
Con riguardo alle scuole nella lingua dei gruppi etnici si riconosce alle persone appartenenti<br />
a tali gruppi il diritto di partecipare alla nomina degli insegnanti ed all’impostazione<br />
dei programmi didattici, che potranno essere adeguati alle loro esigenze particolari, comprendendo<br />
l’insegnamento anche della storia e della cultura del gruppo etnico.<br />
Vengono inoltre garantiti il diritto di costituire e mantenere organizzazioni ed associa-<br />
100
zioni proprie, compresi i partiti politici, che lo Stato contribuirà a finanziare nella stessa misura<br />
delle altre simili organizzazioni (art. 8); il diritto ai liberi contatti tra persone appartenenti allo<br />
stesso gruppo sia all’interno dello Stato che oltre frontiera con i cittadini degli altri Stati con i<br />
quali sono in comune l’origine nazionale o etnica o il retaggio culturale, ed i connessi diritti alla<br />
libera circolazione ed alla cooperazione transfrontaliera in vari campi (art. 9); il diritto<br />
all’informazione, che si estrinseca nel diritto di diffondere, scambiare e ricevere informazioni nella<br />
madrelingua, da realizzarsi sia attraverso un accesso equiparato ai mass media statali o comunque<br />
pubblici, sia mediante mezzi di comunicazione propri sostenuti con finanziamenti pubblici,<br />
sia inoltre attraverso la ricezione di programmi radiofonici e televisivi nella lingua del gruppo<br />
etnico trasmessi dall’estero (art. 10).<br />
Tra le garanzie viene anche incluso, senza alcuna condizione restrittiva relativa alla<br />
consistenza del gruppo etnico, il diritto all’accesso proporzionale negli uffici pubblici, da realizzarsi<br />
attraverso accordi di transizione per ovviare a disagi socia1i nonché il diritto alla rappresentanza<br />
politica, al fine di garantire agli appartenenti a gruppi etnici la partecipazione in piena<br />
uguaglianza alla gestione degli affari pubblici, in particolare anche alle decisioni relative a territori<br />
di loro insediamento o a materie che li riguardino.(art. 19912).<br />
L’art. 13 riconosce, infine, alle persone appartenenti ai gruppi etnici, senza pregiudizio<br />
per l’integrità territoriale degli Stati contraenti e in rapporto alla quota rappresentata nell’ambito<br />
della popolazione totale, il diritto all’autonomia, per tutelare gli specifici diritti civili e politici e i<br />
generali diritti dell’uomo e le libertà fondamentali da non giustificate decisioni della maggioranza;<br />
diritto all’autonomia che si configura, in relazione alle diverse situazioni, come “autonomia<br />
territoriale e/o culturale” ed “autoamministrazione locale (autonomia locale)” e che nei suoi presupposti<br />
e contenuti viene ulteriormente sviluppato nel progetto di discussione per una Convenzione<br />
speciale con riferimento ai diritti dei gruppi etnici.<br />
Sanciti i diritti, la parte IV del progetto di Protocollo aggiuntivo tratta della relativa garanzia<br />
e tutela giuridica, riconoscendo in primo luogo, in caso di violazione, il diritto di ricorso, singolarmente<br />
o assieme ad altri, ad una istanza nazionale e dopo l’espletamento delle vie legali<br />
nazionali alla Commissione Europea per i diritti dell’uomo (art. 14).<br />
Alle persone appartenenti a gruppi etnici viene inoltre riconosciuto il diritto alla condeterminazione,<br />
cioè il diritto di partecipare in ambito nazionale alla realizzazione dei diritti e delle<br />
libertà sanciti dal Protocollo attraverso accordi comuni, nonché alla organizzazione delle questioni<br />
che le riguardino tramite la creazione di un proprio organo di rappresentanza presso il<br />
Consiglio d’Europa (art. 15).<br />
Per la tutela dei diritti civili e dei gruppi etnici nei riguardi delle istituzioni politiche e amministrative<br />
è poi riconosciuto il diritto all’istituzione di un “Ombudsman”, in sostanza un difensore<br />
civico, anch’egli appartenente al gruppo etnico (art. 16).<br />
La parte V tratta del meccanismo di controllo, definendo un quadro che fornisce un ampio<br />
spettro di garanzie contro qualsiasi violazione dei diritti sanciti, che prevede all’art. 18 la<br />
possibilità di ricorsi individuali ed interstatali.<br />
Gli adempimenti formali a cui gli Stati aderenti e gli organismi di controllo sono tenuti<br />
vengono dettagliatamente disciplinati dall’art. 19, che fa obbligo agli Stati contraenti di presentare<br />
alla Commissione europea per i diritti dell’uomo, attraverso il Segretario generale del Consiglio<br />
d’Europa, un primo rapporto entro un anno dall’entrata in vigore per ciascuno Stato e rapporti<br />
biennali successivamente, sull’attuazione data al Protocollo, prevedendo anche il diritto, da<br />
parte di chi è legittimato a rappresentare gli interessi dei gruppi etnici, di segnalare al Segretario<br />
Generale del Consiglio d’Europa eventuali situazioni di difficoltà nell’adempimento del Protocollo<br />
stesso, nonché all’art. 20, una procedura di composizione amichevole delle controversie.<br />
Le disposizioni finali contenute nella Parte VI riguardano l’adesione al Protocollo e stabiliscono<br />
che all’atto della sottoscrizione gli Stati dichiarino per quali gruppi etnici esso trova applicazione,<br />
con diritto, per le persone appartenenti a gruppi etnici ingiustamente esclusi, di richiedere<br />
un accertamento del Consiglio d’Europa.<br />
In definitiva, il quadro che il progetto UFGE per un Protocollo aggiuntivo alla Convenzione<br />
europea per i diritti dell’Uomo viene a configurare è quello di una tutela capillare dei gruppi<br />
etnici, ai quali, pur nel rispetto formale degli orientamenti emersi in materia nell’ambito delle<br />
istituzioni europee, relativamente soprattutto all’attribuzione dei diritti riconosciuti alla sfera personale<br />
e non collettiva, viene previsto il massimo delle garanzie, con il limite della salvaguardia<br />
101
dell’integrità territoriale degli Stati e del rispetto, nel godimento dei diritti sanciti,<br />
dell’ordinamento giuridico del proprio Stato e dei diritti di tutti gli altri cittadini.<br />
I Diritti d’autonomia dei gruppi etnici in Europa - Progetto di discussione per una Convenzione<br />
Speciale<br />
Questa seconda parte del Progetto dell’UFGE, che integra la prima parte concernente i<br />
diritti fondamentali delle persone appartenenti a gruppi etnici, mirava a disciplinare, nella prospettiva<br />
di una soluzione globale della tutela dei gruppi etnici in Europa, quegli aspetti che non<br />
avrebbero potuto trovare una regolamentazione nel Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea<br />
sui Diritti umani e nella Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze, soprattutto<br />
con riguardo alle questioni dei diritti collettivi e di autonomia, per la cui disciplina l’UFGE ha<br />
perciò ritenuto di proporre alle competenti istanze europee ed internazionali un progetto di discussione<br />
per un ulteriore strumento in forma di Convenzione Speciale.<br />
Il progetto, che si compone del Preambolo e di quattro Parti per complessivi venti articoli,<br />
si fonda infatti sul principio del diritto dei gruppi etnici all’autonomia, nel cui ambito si sviluppano<br />
i diritti riconosciuti nel progetto stesso e che sono in questa sede riferiti ai gruppi etnici.<br />
L’autonomia viene definita (art. 1) come “strumento di tutela dei gruppi etnici che, senza<br />
pregiudizio per l’integrità territoriale degli Stati, deve garantire un massimo grado di autodeterminazione<br />
interna e nello stesso tempo un corrispondente minimo grado di dipendenza dalla<br />
maggioranza nazionale” allo scopo di tutelare le persone appartenenti a gruppi etnici da esclusioni,<br />
per mezzo di decisioni della maggioranza, non giustificate in base a quanto previsto dal<br />
Protocollo e di garantire loro l’esercizio degli specifici diritti civili e politici, nonché dei diritti e delle<br />
libertà fondamentali dell’uomo spettanti alla generalità.<br />
Anche in questo progetto si fornisce la definizione di “gruppo etnico” (art. 2) riprendendo<br />
tutti gli elementi fissati nel progetto di Protocollo aggiuntivo, ma prevedendo anche che nel garantire<br />
i diritti di autonomia devono essere considerate le “condizioni di base speciali dei gruppi<br />
etnici, che nei loro insediamenti costituiscono: a) la maggioranza della popolazione; b) una parte<br />
sostanziale, però non la maggioranza della popolazione; c) né la maggioranza né una parte<br />
sostanziale della popolazione”, e che inoltre “sono da considerare appartenenti ai gruppi etnici<br />
quelle persone che appartengono a gruppi etnici compattamente insediati ma che risiedono lontano<br />
da essi e in un insediamento sparso e isolato”.<br />
Vengono poi enunciati, all’art. 3, i principi fondamentali stabilendo che i diritti, fissati nella<br />
Convenzione, alla tutela e conservazione e alla promozione ed allo sviluppo “del gruppo etnico<br />
come tale” vengono esercitati in comune dagli appartenenti ad un gruppo etnico, e ribadendo<br />
il principio, pure affermato nel progetto di Protocollo aggiuntivo, che tale appartenenza è una<br />
questione di scelta individuale da cui non deve derivare alcun pregiudizio, con obbligo per gli<br />
Stati di creare le condizioni perché tale scelta possa essere fatta in piena libertà.<br />
La disciplina dei diritti all’autonomia dei gruppi etnici occupa l’intera Parte II del documento,<br />
costituita da dieci articoli.<br />
In particolare, in relazione alle diverse “condizioni di base speciali” precedentemente<br />
definite, vengono individuate tre forme fondamentali di autonomia: a) autonomia territoriale (artt.<br />
4 e 5); b) autonomia culturale (artt. 7 e 8); c) autonomia locale o autoamministrazione locale<br />
(artt. 9 e 10).<br />
Il diritto ad uno “status speciale territorialmente limitato”, definito “autonomia territoriale”<br />
con legislazione, governo, amministrazione e giurisdizione autonoma per la gestione dei propri<br />
affari, è riservato ai gruppi etnici che nelle regioni di insediamento costituiscono la maggioranza<br />
della popolazione e comporta l’istituzione di organi legislativi, esecutivi e giurisdizionali propri, la<br />
cui composizione rispecchierà, proporzionalmente, quella della popolazione.<br />
Tale forma di autonomia deve comprendere le competenze ritenute dai gruppi etnici necessarie<br />
per la gestione dei propri affari, da denominarsi nella legislazione statale “competenze<br />
della sfera autonoma”, di cui viene individuato un elenco a titolo esemplificativo che tocca i diversi<br />
campi di attività, tra i quali l’istruzione, l’informazione, la sanità e la previdenza sociale, il<br />
settore economico e finanziario, la polizia locale, l’imposizione fiscale per scopi locali.<br />
Viene comunque affermato che l’esercizio dei diritti sanciti nella Convenzione non può<br />
pregiudicare il godimento dei diritti delle persone appartenenti alla popolazione che all’interno<br />
dell’autonomia territoriale formano la minoranza numerica.<br />
102
Per i gruppi etnici che nei territori di insediamento non costituiscono la maggioranza della<br />
popolazione e per quelli che per qualsiasi motivo “non ritengano conveniente l’istituzione di<br />
una autonomia territoriale” viene garantito (artt. 7 e 8) il diritto all’“autonomia culturale nella forma<br />
giuridica di diritto pubblico che a loro sembra più appropriata”, da esercitarsi attraverso unità<br />
associative dotate di organi eletti democraticamente e liberamente, per tutte le questioni essenziali<br />
per la conservazione, la tutela e lo sviluppo della identità dei gruppi etnici, stabilendo anche<br />
per tale forma di autonomia un ampio quadro di ambiti di competenza.<br />
Il terzo tipo di autonomia previsto dal progetto concerne il diritto ad una autodeterminazione<br />
locale denominata “autonomia locale” o “autoamministrazione locale” (artt. 9 e 10), che<br />
viene riconosciuto ai gruppi etnici che nei territori di insediamento non costituiscono la maggioranza<br />
della popolazione, nonché agli appartenenti a gruppi etnici insediati lontano da questi in<br />
modo sparso.<br />
Tale forma di autonomia prevede la creazione di unità amministrative in cui gli appartenenti<br />
ai gruppi etnici costituiscono la maggioranza locale della popolazione (come singole circoscrizioni,<br />
comuni o unità amministrative ad essi subordinate), alle quali è attribuito, oltre alle<br />
competenze legate per legge, l’esercizio degli affari propri del gruppo etnico, in una accezione<br />
più limitata, quanto a settori e ambiti di competenza, rispetto alle altre forme di autonomia, ma<br />
tale comunque da fornire un ampio spettro di garanzie per la tutela e lo sviluppo del gruppo.<br />
Nella sfera dell’autonomia locale rientrano, in particolare, la regolamentazione del bilinguismo<br />
nell’ambito dell’ autoamministrazione locale, l’uso di nomi e simboli propri, la regolamentazione<br />
degli usi e delle feste locali, la tutela dei monumenti locali, la polizia di sicurezza e<br />
stradale, l’ispezione sanitaria e dell’edilizia a livello locale, nonché il diritto di fondare e mantenere<br />
istituzioni per l’insegnamento locale, per i mass-media, per la cura della tradizione, per<br />
l’istruzione e per l’esercizio di attività economiche; è inoltre prevista la partecipazione a tutti gli<br />
altri affari amministrativi secondo la loro quota di popolazione.<br />
I diritti alle delineate forme di autonomia trovano poi completamento nell’ulteriore diritto,<br />
pure riconosciuto ai gruppi etnici, che i loro interessi siano presi in considerazione anche nella<br />
suddivisione del territorio statale in circoscrizioni politiche, amministrative, giudiziarie ed elettorali,<br />
da stabilirsi in accordo con i gruppi etnici direttamente interessati (art. 11).<br />
Le risorse finanziarie necessarie all’esercizio delle competenze degli enti collettivi<br />
dell’autonomia territoriale e culturale devono essere assicurate dallo Stato e, per quanto concerne<br />
l’autonomia territoriale, da una quota fissa delle spese pubbliche in proporzione alla media<br />
della consistenza numerica della popolazione e dell’estensione del territorio, con garanzia<br />
comunque di una quota adeguata delle tasse ed imposte riscosse nel proprio territorio, da integrarsi<br />
nel caso che il gettito risulti inferiore alla quota fissa determinata in base al criterio proporzionale<br />
(art. 12).<br />
Gli Stati contraenti sono tenuti all’attuazione dei diritti sanciti nella Convenzione, inserendoli<br />
in modo adeguato nel loro ordinamento giuridico ed emanando le norme legislative necessarie<br />
a renderli concretamente esercitabili, nel quadro del diritto dei gruppi etnici alla condeterminazione,<br />
ovvero del diritto di partecipare al processo di attuazione interna nell’ambito di<br />
commissioni paritetiche composte da rappresentanti dello Stato e dei gruppi etnici, le cui decisioni,<br />
prese all’unanimità, sono vincolanti. Ai gruppi etnici viene altresì riconosciuto il diritto di<br />
partecipare, per mezzo di propri organi collettivi, all’elaborazione di delibere di organismi internazionali<br />
relative a questioni che per essi rivestono un particolare interesse (art. 14).<br />
Le parti IV (artt. 15-17) e V (artt. 18-20) del progetto riguardano il meccanismo di controllo<br />
e le disposizioni finali e sono praticamente sovrapponibili alle corrispondenti parti del progetto<br />
per un Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea sui Diritti dell’Uomo.<br />
103
LE MINORANZE IN EUROPA<br />
105
CLASSIFICAZIONE E NORMATIVA<br />
In questo capitolo sono riportati i dati relativi alle minoranze presenti in 32 Paesi europei qui sotto<br />
indicati, la relativa consistenza numerica e le norme di tutela giuridica.<br />
Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia,<br />
Germania, Irlanda, Liechtenstein, Lituania, Malta, Norvegia, Polonia, Regno Unito, Rep. Ceca,<br />
Rep. della Moldavia, Rep. di Macedonia, Romania, Russia, San Marino, Serbia e Montenegro<br />
(ex Repubblica di Jugoslavia), Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina e Ungheria.<br />
107
DENOMINAZIONE DELLE MINORANZE, CONSISTENZA NUMERICA E NORME DI TUTELA GIURIDICA<br />
Paese: ALBANIA<br />
MINORANZE PRESENTI CONSISTENZA NUMERICA *<br />
GRECI 58.758 Distretti di Saranda, Delvina<br />
e Gjirokastra<br />
MACEDONI 4.878 Area di Prespa<br />
MONTENEGRINI 2.000 circa Area di Vraka<br />
ROM Dati statistici non disponibili per<br />
l’assenza di un censimento di questa<br />
popolazione<br />
Periferia di Tirana<br />
ARUMENI (VALACCHI) Assenza di dati statistici recenti. In<br />
base all’ultimo censimento della<br />
popolazione risalente al 1955 gli<br />
appartenenti a questa minoranza<br />
erano circa 4.249<br />
Città principali<br />
108<br />
TUTELA GIURIDICA<br />
COSTITUZIONALE LEGGE NAZIONALE<br />
I cambiamenti legati al processo di<br />
democratizzazione dell’Albania<br />
verificatisi nello scorso decennio<br />
hanno avuto profonde ripercussioni<br />
anche sulla situazione della minoranza<br />
nazionale greca, con sostanziali<br />
miglioramenti. Questa<br />
minoranza ora gode di tutti i diritti<br />
previsti dalle norme europei più<br />
liberali e nel rispetto dei valori su<br />
cui si basa una società democratica<br />
e pluralista.<br />
A partire dagli anni ’90, il numero<br />
complessivo degli appartenenti alla<br />
minoranza greca si è ridotto notevolmente.<br />
A causa dell’apertura<br />
delle frontiere, dell’arretratezza e<br />
delle numerose difficoltà economiche<br />
incontrate nel periodo di transizione<br />
in Albania, gran parte della<br />
popolazione presente nelle regioni<br />
meridionali del paese ha trovato<br />
opportunità di lavoro in Grecia,<br />
dove si è trasferita per vivere.<br />
Nel campo dell’istruzione, i bambini<br />
arumeni godono del diritto allo<br />
studio garantito dal Ministero<br />
dell’Istruzione e della Scienza albanese,<br />
avendo accesso altresì<br />
alle borse di studio offerte sia dal<br />
Ministero dell’Istruzione e della<br />
Scienza albanese che dalla Romania<br />
e dalla Grecia.<br />
* I dati sono stati tratti dal Rapporto sull’attuazione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali.
Paese: ARMENIA<br />
MINORANZE PRESENTI CONSISTENZA NUMERICA *<br />
AZERI 84.860<br />
CURDI E YEZIDI 56.127<br />
RUSSI 51.555<br />
UCRAINI 8.341<br />
SIRIANI 5.963<br />
GRECI 4.650<br />
ALTRE NAZIONALITA’ 9.664<br />
12. E' accertato che non esistono<br />
paesi monoetnici nel mondo, e<br />
l'Armenia non costituisce un'eccezione.<br />
Nel corso dei secoli<br />
genti appartenenti a varie minoranze<br />
nazionali hanno vissuto sul<br />
territorio dell'Armenia e continuano<br />
a risiedervi anche al giorno<br />
d'oggi; esse non sono mai state<br />
oggetto di discriminazione. Le<br />
TUTELA GIURIDICA<br />
COSTITUZIONALE LEGGE NAZIONALE<br />
16. Il principale fondamento della 17. Il Presidente della Repubblica<br />
politica di stato in tema di tutela dei d'Armenia ha ufficialmente dichia-<br />
diritti delle persone appartenenti alle rato che l'Armenia è la patria non<br />
minoranze nazionali è la Costituzio- solo della popolazione originaria,<br />
ne della Repubblica d'Armenia. In ma anche delle minoranze nazio-<br />
seguito all'evoluzione della vita pubnali che insistono sul suo territorio.<br />
blica e dei valori sociali, la Costitu- 18. Nel Trattato istitutivo della Cozione<br />
ha il compito di proteggere i munità degli Stati Indipendenti,<br />
diritti e le libertà dell'individuo. siglato da Russia, Ucraina e Bielo-<br />
6. L'articolo 4 della Costituzione delrussia in data 8 dicembre 1991 a<br />
la Repubblica d'Armenia stabilisce Minsk, con il quale è stata formal-<br />
che "Lo Stato garantisce la tutela dei mente disciolta l'URSS, è previsto<br />
diritti e delle libertà dell'uomo in base che le parti proteggano le mino-<br />
alla Costituzione e alle leggi e in acranze nazionali che insistono sui<br />
cordo con i principi e le norme del rispettivi territori con l'obiettivo di<br />
diritto internazionale".<br />
esprimere, preservare e sviluppare<br />
7. Il Capitolo 2 della Costituzione fa le loro identità etniche, culturali,<br />
riferimento ai diritti e alle libertà fon- linguistiche e religiose. I Capi di<br />
damentali dell'uomo e del cittadino. stato della CSI hanno siglato la<br />
La Costituzione stabilisce che cia- "Convenzione per la tutela dei diritscuno<br />
è uguale agli altri di fronte alla ti delle persone appartenenti a mi-<br />
legge e che deve avere uguali opnoranze nazionali" nel 1994 a Moportunità<br />
di godere di diritti, libertà e sca. L'Assemblea Nazionale della<br />
responsabilità, previsti dalla Costitu- Repubblica d'Armenia ha ratificato<br />
zione e da altri atti legislativi. tale Convenzione in data 11 ottobre<br />
1995.<br />
19. L'assenza di una legge sulle<br />
minoranze nazionali è una lacuna<br />
nella legislazione della Repubblica<br />
d'Armenia. Pertanto non esiste la<br />
definizione dell'espressione "minoranze<br />
nazionali", ma in pratica essa<br />
sta ad indicare i cittadini della<br />
Repubblica d'Armenia che vi risiedono<br />
permanentemente e che differiscono<br />
dalla popolazione di base<br />
per la propria origine etnica. Tale<br />
accezione coincide con la definizione<br />
data al termine nella "Convenzione<br />
per la tutela dei diritti delle<br />
persone appartenenti alle minoranze<br />
nazionali", secondo la quale<br />
le persone appartenenti alle minoranze<br />
nazionali sono persone residenti<br />
permanentemente nei territori<br />
delle Parti contraenti, ne hanno la<br />
cittadinanza, ma differiscono dalla<br />
popolazione di base della Parte<br />
contraente di appartenenza per<br />
origine etnica, lingua, cultura, religione<br />
e tradizioni.<br />
22. Nel 1998 è stata istituita la<br />
Commissione per i Diritti Umani,<br />
alle dipendenze del presidente della<br />
Repubblica d'Armenia; tale iniziativa<br />
è stata considerata un passo<br />
importante e necessario in direzione<br />
dell'istituzione della figura<br />
del Difensore civico. La Commissione<br />
si occupa del dibattito relativo<br />
alla violazione di diritti, nonché<br />
della loro reintroduzione adottando<br />
anche misure volte a prevenire le<br />
* I dati sono stati tratti dal Rapporto sull’attuazione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali.<br />
109
minoranze nazionali costituiscono<br />
circa il 3% della popolazione<br />
della Repubblica d'Armenia.<br />
110<br />
violazioni dei diritti umani. La<br />
Commissione ha preparato la Legge<br />
sui Difensori civici della Repubblica<br />
d'Armenia, che è stata successivamente<br />
sottoposta all'Assemblea<br />
Nazionale della Repubblica<br />
d'Armenia. La Commissione è<br />
costituita da 17 membri, in rappresentanza<br />
di organismi statali, organizzazioni<br />
non governative,<br />
giornalisti indipendenti e avvocati.
111<br />
23. L'istituzione del Consiglio di<br />
coordinamento per le minoranze<br />
nazionali della Repubblica d'Armenia<br />
è un passo importante nella<br />
sfera della tutela delle minoranze<br />
nazionali. L'obiettivo del Consiglio,<br />
istituito ufficialmente il 15 giugno<br />
2000 per decreto del Presidente<br />
della Repubblica d'Armenia, è garantire<br />
la tutela delle minoranze<br />
nazionali, attivarne i rapporti intercomunitari<br />
ed infine rendere più<br />
efficace l'intervento dello stato in<br />
tema di istruzione, cultura, problemi<br />
giuridici e di altro tipo. E' importante<br />
sottolineare che il decreto del<br />
Presidente è successivo alla prima<br />
conferenza dei rappresentanti delle<br />
minoranze nazionali, tenutasi il 12<br />
marzo 2000. Il Consiglio di coordinamento<br />
prelude all'istituzione di<br />
uno speciale organismo statale in<br />
materia di minoranze nazionali. Il<br />
Presidente e il Primo Ministro della<br />
Repubblica d'Armenia hanno tenuto<br />
varie riunioni con il Consiglio di<br />
coordinamento per dibattere l'istituzione<br />
di un centro culturale destinato<br />
alle minoranze nazionali.<br />
24. Benchè nella Repubblica d'Armenia<br />
non esista una legge sulle<br />
minoranze nazionali, esistono altre<br />
leggi che danno origine e garantiscono<br />
i diritti delle minoranze nazionali.<br />
La legge sulla lingua della<br />
Repubblica d'Armenia costituisce il<br />
quadro di riferimento generale della<br />
politica linguistica della Repubblica<br />
d'Armenia in quanto regolamenta<br />
lo status della lingua nonché<br />
le relazioni linguistiche tra lo<br />
Stato e altri organismi amministrativi<br />
da un lato, e le imprese, gli uffici<br />
e le organizzazioni, dall'altro. In<br />
base a tale legge, l'armeno è dichiarato<br />
lingua ufficiale, da utilizzare<br />
in tutti gli ambiti della Repubblica<br />
d'Armenia. La legge sulla lingua<br />
stabilisce anche che la Repubblica<br />
d'Armenia garantisce la libertà di<br />
impiegare le lingue delle minoranze<br />
nazionali che insistono sul proprio<br />
territorio. L'articolo 2 della legge<br />
stabilisce che "Nelle comunità<br />
delle minoranze nazionali della<br />
Repubblica d'Armenia l'istruzione e<br />
gli studi a livello generale possono<br />
essere organizzati nelle rispettive<br />
lingue madri, coerentemente con i<br />
programmi scolastici statali e con<br />
l'obbligo dello studio dell'armeno".<br />
Esistono anche leggi sull'istruzione,<br />
la libertà di coscienza, le organizzazioni<br />
religiose, ecc.
Paese: AUSTRIA<br />
MINORANZE PRESENTI CONSISTENZA NUMERICA *<br />
CROATI 30.000 Burgenland (Austria meridionale)<br />
e Vienna<br />
SLOVENI 50.000 Carinzia e Stiria<br />
UNGHERESI Da 20.000 a 30.000 Regioni di<br />
Oberwart (Obertwart, Unterwart,<br />
Siget in der Wart) e<br />
Oberpullendorf (Oberpullerndorf,<br />
Mittelpullendorf)<br />
Città di Eisenstadt,<br />
CECHI<br />
Frauenkirchen, Graz e Vienna<br />
Da 15.000 a 20.000 La comunità<br />
più numerosa risiede a Vienna<br />
SLOVACCHI Da 5.000 a 10.000 Vienna e Austria<br />
meridionale<br />
ROM (Sinti, Rom del Burgenland,<br />
Lovara, Kalderash e Arlije)<br />
25.000 circa<br />
Non esistono stime precise sulla<br />
loro consistenza numerica<br />
Principali città austriache<br />
TUTELA GIURIDICA<br />
COSTITUZIONALE LEGGE NAZIONALE<br />
- Art. 8 della Costituzione Federale (B- - Legge sulle Minoranze, Gazzetta<br />
VG), Gazzetta delle Leggi Federali N. Federale N. 396/1976;<br />
1/1920;<br />
- Legge in materia di Istruzione per<br />
- Artt. Da 66 a 68 del Trattato di Saint- le Minoranze in Carinzia, Gazzetta<br />
Germain-en-Laye del 10/09/1919, Federale N. 101/1959;<br />
Gazzetta delle Leggi Statali N. - Legge in materia di Istruzione per<br />
303/1920;<br />
le Minoranze nel Burgenland, Leg-<br />
in base all’Art. 149,§ 1 del B-VG, le ge Federale N. 641/1994;<br />
disposizioni summenzionate sono di Ordinanze emanate in virtù della<br />
rilevanza costituzionale.<br />
Legge sulle Minoranze:<br />
- Art. 7 del Trattato Statale per la Ri- - Ordinanza del <strong>Governo</strong> Federale<br />
costituzione di un’Austria Indipenden- disciplinante i Consigli Consultivi<br />
te e Democratica (Trattato Statale di per le Minoranze, Gazzetta delle<br />
Vienna, Gazzetta delle Leggi Federali Leggi Federali N. 38/1977;<br />
N. 152/1955);<br />
- Ordinanza del <strong>Governo</strong> Federale<br />
in base all’Art. II, § 3 del 31 maggio 1977 che definisce<br />
dell’Emendamento al B-VG, Gazzetta le aree interessate dalla topinoma-<br />
delle Leggi Federali N. 59/1964, l’Art., stica bilingue tedesco-sloveno,<br />
§ 2-, ha valore costituzionale;<br />
Gazzetta delle Leggi Federali N.<br />
- Art. 1 della Legge sull’Istruzione per 306/1977;<br />
le Minoranze in Carinzia (Minderhei- - Ordinanza del <strong>Governo</strong> Federale<br />
ten-Schulgesetz für Kärnten), Gazzet- del 31 maggio 1977 che definisce i<br />
ta delle Leggi Federali N. 101/1959; tribunali, le autorità amministrative<br />
- Sezione 1 della Legge sull’Istruzione ed altri dipartimenti dove è am-<br />
per le Minoranze nel Burgenland messo lo sloveno come lingua uffi-<br />
(Minderheiten-Schulgesetz für Burciale oltre al tedesco, Gazzetta<br />
genland), Gazzetta delle Leggi Fede- delle Leggi Federali N. 307/1977;<br />
rali N. 641/1994.<br />
- Ordinanza del <strong>Governo</strong> Federale<br />
del 31 maggio 1977 sulla topomastica<br />
in sloveno, Gazzetta delle<br />
Leggi Federali N. 308/1977;<br />
- Ordinanza del <strong>Governo</strong> Federale<br />
del24 aprile 1990 che definisce i<br />
tribunali, le autorità amministrative<br />
ed altri dipartimenti in cui è ammesso<br />
il croato come lingua ufficiale<br />
oltre al tedesco, Gazzetta delle<br />
Leggi Federali N. 307/1977;<br />
- Ordinanza topografica per il Bungerland,<br />
Gazzetta delle Leggi Federali<br />
vol. II N. 170/2000;<br />
(Ordinanza per la regolamentazione<br />
dell’uso dell’ungherese come<br />
lingua ufficiale; è stata emanata<br />
dal <strong>Governo</strong> Federale il 14 giugno<br />
2000 ed entrerà in vigore il 1° ottobre<br />
2000).<br />
* I dati sono stati tratti dal Rapporto sull’attuazione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali.<br />
112
Paese: AZERBAIJAN<br />
MINORANZE PRESENTI CONSISTENZA NUMERICA *<br />
AZERBAIGIANI 7.205.500<br />
LESGHI 178.000<br />
RUSSI 141.700<br />
ARMENI 120.700<br />
TALISH 76.800<br />
AVARI 50.900<br />
TURCHI MESKHETIAN 43.400<br />
TATARI 30.000<br />
UCRAINI 29.000<br />
TSAKHURI 15.900<br />
GEORGIANI 13.100<br />
TATI 10.900<br />
EBREI 8.900<br />
UDI 4.200<br />
CURDI 13.100<br />
ALTRE NAZIONALITA’ 9.500<br />
TUTELA GIURIDICA<br />
COSTITUZIONALE LEGGE NAZIONALE<br />
L’Art. 25 della Costituzione della Il Presidente della Repubblica<br />
Repubblica dell’Azerbaijan garanti- dell’Azerbaijan ha firmato in data<br />
sce il diritto all’uguaglianza. Il 16 settembre 1992 il Decreto “Sul-<br />
comma III del precitato articolo la tutela dei diritti e delle libertà e<br />
recita come segue: ”Lo Stato ga- sulla partecipazione dello Stato<br />
rantisce l’uguaglianza dei diritti e alla promozione delle lingue e cul-<br />
delle libertà di ognuno a prescindeture delle minoranze nazionali, dei<br />
re dalla razza, dalla nazionalità, popoli di scrsa consistenza nume-<br />
dalla religione, dalla lingua, dal rica e dei gruppi etnici presenti nel-<br />
sesso, dall’origine, dal patrimonio,<br />
dallo status ufficiale, dal credo,<br />
dall’appartenenza a partiti politici,<br />
sindacati ed altre organizzazioni di<br />
volontariato. E’ fatto divieto di limitare<br />
i diritti e le libertà degli esseri<br />
umani e dei cittadini per motivi<br />
fondati sulla razza, la nazionalità,<br />
la religione, la lingua, il sesso,<br />
l’origine, il credo, l’appartenenza<br />
politica e sociale”.<br />
la Repubblica del’Azerbaijan”.<br />
* I dati sono stati tratti dal Rapporto sull’attuazione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali.<br />
113
Paese: BULGARIA<br />
GRUPPI ETNICI CONSISTENZA NUMERICA TUTELA GIURIDICA<br />
COSTITUZIONALE LEGGE NAZIONALE<br />
Bulgari Dai dati emersi dal censimento effettuato<br />
nel 2001, i turchi costituiscono la maggioranza<br />
in due dei 28 distretti della Bulgaria<br />
(Kurdjali e Razgrad), mentre tutti i restanti<br />
gruppi etnici sono in minoranza. I turchi<br />
costituiscono la maggioranza anche in alcuni<br />
comuni della Bulgaria nord-orientale,<br />
in particolare, nei distretti di Shoumen, Silistra,<br />
Tuturgovishte, Dobrich e Rousse,<br />
nonché in quelli di Burgas e Haskovo. I<br />
musulmani, di lingua bulgara, insistono<br />
prevalentemente nella regione che ospita<br />
la catena montuosa Rodopi Planina, nelle<br />
regioni dello Smolyan (dove rappresentano<br />
oltre il 50 % della popolazione e dove pertanto<br />
i cristiani bulgari sono in minoranza).<br />
In misura minore, gli stessi sono presenti<br />
anche nei distretti di Kurdjali, Blagoevgrad,<br />
Pazardjik e Plovdiv, nonché in vari insediamenti<br />
nei distretti di Lovech e Veliko<br />
Turnovo.<br />
Assente Assente<br />
Turchi<br />
Greci<br />
Armeni<br />
Tatari<br />
Valacchi<br />
Tatari<br />
Ebrei<br />
Albanesi<br />
Rumeni<br />
Gagauzi<br />
Nel censimento del 2001 è previsto, per la prima volta,<br />
come indicatore, anche, il gruppo etnico.<br />
114
Paese: CIPRO<br />
TUTELA GIURIDICA<br />
GRUPPI ETNICI CONSISTENZA NUMERICA * COSTITUZIONALE LEGGE NAZIONALE<br />
Greci ciprioti 621.800<br />
Turchi ciprioti 89.200<br />
Armeni 2.500<br />
Maroniti 4.500<br />
Latini 700<br />
Altro 22.300<br />
In forza dell'art. 2 (commi 1 e 2) della<br />
Costituzione tutti i cittadini ciprioti devono<br />
appartenere alla Comunità greca,<br />
se sono di origine greca, condividono le<br />
tradizioni culturali greche o appartengono<br />
alla Chiesa ortodossa di rito greco,<br />
oppure alla comunità turca, se sono<br />
di origine turca, condividono le tradizioni<br />
culturali turche o sono musulmani. I<br />
citati gruppi religiosi, formati da Armeni,<br />
Maroniti e Latini, hanno avuto tre mesi<br />
di tempo per esercitare l'opzione e<br />
hanno scelto di appartenere alla comunità<br />
greca, perché sono cristiani, anche<br />
se di confessione diversa.<br />
* I dati sono stati tratti dal Rapporto sull’attuazione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali.<br />
115
Paese: CROAZIA<br />
MINORANZE PRESENTI CONSISTENZA NUMERICA *<br />
MINORANZE<br />
ITALIANI 21.303 Istria, contea di Promosko-<br />
Goranska, comuni di Buje, Pula,<br />
Rovinj, Rijeka e Pakrac<br />
CECHI 13.086 Daruvar, Grubisno Polije,<br />
Zagabria, Pakrac, Bjelovar, Kutina,<br />
Rijeka<br />
SLOVACCHI 5.606 Ilok, Nasice, Osijek, Zagabria<br />
UNGHERESI 22.355 Beli Manastir, Osijek, Vukovar,<br />
Vinkovci, Zagabri, Bjelovar,<br />
Daruvar, Rijeka, Pula, Dakovo,<br />
Split<br />
RUTENI 3.253 Vukovar, Vinkovci, Zagabria,<br />
Slavonski Brod<br />
UCRAINI 2.494 Vukovar, Slavonski Brod,<br />
Novaska, Zagabria, Vinkovci<br />
SERBI 581.663 Zagabria, Knin, Osijek,<br />
Vukovar, Karlovac, Rijeka, Sisak,<br />
Benkovac, Petrinja, Beli Manastir,<br />
Glina, Pakrac, Vrginmost, Daruvar,<br />
Vojnic, Vrbovsko, Lipik<br />
TEDESCHI 2.635 Beli Manastir, Zagabria, Osijek,<br />
Vukovar, Slavonski Brod, Rijeka,<br />
Pakrac<br />
AUSTRIACI 214 Zagabria<br />
EBREI 600 Zagabria, Split, Osijek, Rijeka<br />
SLOVENI 22.376 Rijeka, Zagabria, Split, Pula,<br />
Cakovec, Opatija, Buje<br />
ALBANESI 12.032 Zagabria, Rijeka, Bjelovar,<br />
Zadar, Osijek<br />
MUSSULMANI 43.469 Zagabria, Dubrovnik, Split,<br />
Zupanja, Labin, Pula, Rijeka, Sisak<br />
ROM 6.695 Cakovec, Zagabria, Pula,<br />
Rijeka, Varazdin, Osijek, Slavonski<br />
Brod<br />
MONTENEGRINI 9.724 Zagabria, Split, Dubrovnik,<br />
Pula, Rijeka, Osijek<br />
MACEDONI 6.280 Zagabria, Split, Pula, Rijeka,<br />
Osijek, Zadar<br />
ALTRI 294.124<br />
Tutti i cittadini della Repubblica di<br />
Croazia che hanno dichiarato di<br />
non essere di nazionalità croata in<br />
occasione dell’ultimo censimento<br />
della popolazione risalente al 1991<br />
e che non appartengono alle minoranze<br />
sopra elencate non sono<br />
organizzate in minoranze nazionali.<br />
Hanno una scarsa consistenza<br />
numerica e sono generalmente<br />
presenti ovunque sul territorio della<br />
Repubblica di Croazia, come ad<br />
esempio i Bulgari (458), i Polacchi<br />
(679) ed i Turchi (320).<br />
In alcuni paesi dell’Istria (Susnjevica,<br />
Zejane) è, inoltre, presente un<br />
gruppo etnico composto da Istriano-Romeni<br />
i quali hanno conservato<br />
un idioma appartenente ad un<br />
gruppo separato.<br />
116<br />
TUTELA GIURIDICA<br />
COSTITUZIONALE LEGGE NAZIONALE<br />
L’Art. 170 della Costituzione delle<br />
ex Repubblica di Jugoslavia e le<br />
norme costituzionali delle Repubblica<br />
Socialista della Croazia garantivano<br />
la libertà di espressione<br />
della nazionalità, ma consentivano<br />
anche ai cittadini di dichiarare la<br />
nazionalità jugoslava.<br />
* I dati sono stati tratti dal Rapporto sull’attuazione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali.
COMUNITA’ LINGUISTICHE<br />
SERBOCROATI 466.968<br />
N.B.: La lingua serbocroata è una<br />
creazione artificiale.<br />
Nonostante la popolazione sia stata<br />
sottoposta a forti pressioni affinché<br />
la accettasse, ha dichiarato<br />
come propria lingua madre il croato.<br />
SERBI 207.300<br />
MACEDONI 5.462<br />
SLOVENI 19.341<br />
ALBANESI 12.735<br />
CECHI 10.378<br />
UNGHERESI 19.684<br />
ROM 7.657<br />
RUTENI 2.845<br />
SLOVACCHI 5.265<br />
ITALIANI 26.580<br />
UCRAINI 1.430<br />
ALTRE LINGUE 11.480<br />
117
Paese: DANIMARCA<br />
MINORANZE PRESENTI CONSISTENZA NUMERICA *<br />
In occasione della ratifica, la Danimarca<br />
ha dichiarato che la Convenzione<br />
quadro verrà applicata<br />
alla minoranza tedesca nello Jutland<br />
meridionale. Tale dichiarazione<br />
riflette il fatto che il confine tra il<br />
Regno di Danimarca e la Repubblica<br />
Federale di Germania non<br />
delimita le zone abitate dai due<br />
popoli. Nelle regioni a nord e a sud<br />
del confine (fissato fin dai referendum<br />
del 1920), cioè lo Jutland Meridionale<br />
in Danimarca e lo Schleswig<br />
in Germania, i Danesi e i Tedeschi<br />
convivono nelle aree tradizionali<br />
di insediamento. I membri<br />
della minoranza tedesca in Danimarca<br />
sono cittadini della Danimarca<br />
e i membri della minoranza<br />
danese in Germania sono cittadini<br />
tedeschi<br />
Groenlandesi (Inuit) 56.124<br />
Abitanti isole Faer Oer 45.400<br />
Tedeschi 15.000-20.000<br />
Rom 1.500<br />
123.024<br />
A seguito della seconda guerra<br />
mondiale è stato possibile dare<br />
una soluzione al problema delle<br />
minoranze, grazie all'opinione,<br />
condivisa dai governi danese e<br />
tedesco, che il confine era fisso.<br />
Da allora tale posizione è stata<br />
sostenuta dalle maggioranze e<br />
minoranze a nord e a sud del confine.<br />
Tale identità di vedute ha<br />
permesso di trovare delle soluzioni<br />
pratiche basate sulle Dichiarazioni<br />
di Copenhagen-Bonn (per la tutela<br />
e la promozione delle minoranze<br />
nazionali nella regione di confine<br />
tra Danimarca e Germania) del<br />
1955, che hanno dimostrato il loro<br />
valore nei 44 anni di applicazione<br />
* I dati sono stati tratti dalla pubblicazione “Le minoranze in Europa“ di Christoph Pan e Beate Sibille Pfeil.<br />
118<br />
TUTELA GIURIDICA<br />
COSTITUZIONALE LEGGE NAZIONALE<br />
La Danimarca ha ratificato la<br />
Convenzione quadro per la Protezione<br />
delle Minoranze Nazionali<br />
(Consiglio d'Europa) il 22<br />
settembre 1997. La Convenzione<br />
Quadro è entrata in vigore in<br />
Danimarca il 1° febbraio 1998.<br />
prima della ratifica, il 27 novembre<br />
1996, il Ministro danese degli<br />
Affari Esteri ha presentato una<br />
proposta di risoluzione parlamentare<br />
per la ratifica della Convenzione<br />
quadro da parte della<br />
Danimarca. Il 22 aprile 1997 il<br />
Parlamento ha dato l'approvazione<br />
per la ratifica.
Paese: ESTONIA<br />
MINORANZE PRESENTI CONSISTENZA NUMERICA *<br />
RUSSI 409.111 Contee di Harjumaa,<br />
Ida-Virumaa, Tartumaa e<br />
Jogevamaa<br />
INGRI (Finni-Ingri) 13.317 Contee di Harjumaa,<br />
Ida-Virumaa, Laane-Virumaa e<br />
Tarturnaa<br />
TEDESCHI 1.288<br />
SVEDESI 400<br />
EBREI 2.423<br />
LETTONI 2.691<br />
UCRAINI 36.929<br />
BIELORUSSI 21.589<br />
TATARI 3.271<br />
POLACCHI 2.355<br />
LITUANI 2.221<br />
ROM 1.500<br />
TUTELA GIURIDICA<br />
COSTITUZIONALE LEGGE NAZIONALE<br />
- I n b as e al l’ art ic ol o 49 d el l a - Legge sull’autonomia delle minoran-<br />
C os t it u zi on e d el l’ Es t on i a ze nazionali del 12 febbraio 1925.<br />
(RT 19 9 2, 2 6, 3 49) c hi u nq u e E’ stata la prima legge adottata in<br />
h a i l d iri tt o d i pr es er var e l a questa specifica materia, con la quale<br />
pr op ri a i d ent it à n az i on al e. è stato riconosciuto a tutti i gruppi et-<br />
- L’art. 50 della stessa sancisce, inici presenti in Estonia il diritto di prenoltre,<br />
che le minoranze nazionali servare la propria identità etnica, la<br />
hanno il diritto, nell’interesse della propria cultura ed il proprio credo.<br />
cultura nazionale, di creare istituzio- In virtù delle disposizioni in essa conni<br />
autonome nelle condizioni e setenute, ai tedeschi, ai russi, agli svecondo<br />
la procedura previste dalla desi, agli ebrei e ad altri gruppi con<br />
Legge sull’autonomia culturale delle una consistenza numerica superiore a<br />
minoranze nazionali.<br />
3.000 appartenenti, residenti in Estonia,<br />
è stato concesso il diritto di creare<br />
una propria autonomia culturale che<br />
prevede: l’organizzazione,<br />
l’amministrazione ed il controllo di istituti<br />
di istruzione pubblici e privati di<br />
madre lingua; provvedere ad altre esigenze<br />
culturali legate alla realtà minoritaria<br />
di appartenenza nonché alla<br />
creazione di apposite istituzioni ed<br />
organizzazioni.<br />
- Il 26 ottobre 1993 è stata approvata<br />
la nuova Legge sull’autonomia culturale<br />
delle minoranze nazionali (RT I<br />
1993, 71, 1001). Pur mantenendo gli<br />
stessi concetti di base della legge precedente,<br />
essa fornisce anche le corrispondenti<br />
garanzie ed orientamenti.<br />
La Sezione 1 della citata legge definisce<br />
come minoranza nazionale quei<br />
cittadini che risiedono sul territorio<br />
estone, mantengono antichi, durevoli<br />
e solidi legami con l’Estonia e sono<br />
distinti dagli estoni sulla base delle<br />
loro caratteristiche etniche, culturali,<br />
religiose o linguistiche e sono motivati<br />
dal desiderio di salvaguardare le proprie<br />
tradizioni culturali, la propria religione<br />
o la propria lingua, come fondamento<br />
della loro identità comune.<br />
La Sezione 2 della stessa legge prevede,<br />
inoltre, il diritto di creare istituzioni<br />
per l’autonomia culturale. Tale<br />
diritto può essere esercitato da tutti i<br />
gruppi minoritari riconosciuti dalla legge<br />
del 1925 (tedeschi, russi, svedesi<br />
ed eberi) e da altri gruppi etnici con<br />
più di 3.000 appartenenti.<br />
* I dati sono stati tratti dalla pubblicazione “Le minoranze in Europa” di Christoph Pan e Beate Sibylle Pfeil.<br />
119
Paese: FINLANDIA<br />
MINORANZE PRESENTI CONSISTENZA NUMERICA *<br />
Sami 6.400 persone circa<br />
I Sami sono una popolazione<br />
indigena; la maggior parte di<br />
essi, circa 4.000 persone, vivono<br />
nel territorio nativo localizzato<br />
nella Lapponia settentrionale, e<br />
circa 2.400 Sami vivono in altre<br />
parti del paese<br />
Rom In Finlandia vivono circa 10.000<br />
Rom. I Rom sono distribuiti in<br />
tutta la Finlandia, anche se la<br />
maggior parte di loro vive nelle<br />
maggiori città della Finlandia<br />
meridionale. Vi si sono stabiliti<br />
da circa 500 anni<br />
Ebrei 1.300 persone circa. La comunità<br />
degli Ebrei che insiste in Finlandia<br />
è costituita da circa 1.300<br />
persone. Per la maggior parte<br />
vivono a Helsinki, Turku e Tampere.<br />
Non sono disponibili informazioni<br />
precise in merito al<br />
momento del loro arrivo in Finlandia,<br />
ma nel 1850 assommavano<br />
a 200 persone<br />
Tatari 900 persone circa Tatari sono<br />
una minoranza islamica di ceppo<br />
turco. I predecessori di questo<br />
gruppo sono immigrati in Finlandia<br />
tra il 1870 e il 1920. In Finlandia<br />
vivono circa 900 Tatari,<br />
distribuiti soprattutto nel distretto<br />
della capitale<br />
Vecchi Russi Attualmente in Finlandia vivono<br />
circa 20.000 persone di lingua<br />
russa, dei quali circa 5.000 sono<br />
Vecchi Russi. I Vecchi Russi<br />
sono discendenti dei Russi immigrati<br />
in Finlandia tra la fine del<br />
19° e l'inizio del 20° secolo.<br />
Finlandesi di lingua svedese 293.691 persone al 31.12.1997,<br />
ovvero il 5,71% della popolazione.<br />
(3) I Finlandesi di lingua<br />
svedese costituiscono la minoranza<br />
più consistente della Finlandia.<br />
I Finlandesi di lingua<br />
svedese sono una minoranza<br />
linguistica. Per la maggior parte<br />
vivono sulle coste meridionali,<br />
sud-orientali e orientali delle isole<br />
Aland.<br />
Altri Tra la fine del 1997 e l'inizio del<br />
1998 in Finlandia si trovavano<br />
80.600 stranieri. I quattro gruppi<br />
più consistenti erano costituiti da<br />
Russi (14.316), Estoni (9.689),<br />
Svedesi (7.507) e Somali<br />
(5.238). Circa 20.000 Finlandesi<br />
originari di detta regione si sono<br />
trasferiti in Finlandia tra il 1990 e<br />
il 1997.<br />
TUTELA GIURIDICA<br />
COSTITUZIONALE LEGGE NAZIONALE<br />
Il concetto di "minoranza nazio- In pratica si ritiene che la Convenzione<br />
nale" non viene usato nella legi- quadro riguardi i Sami, i Rom, gli Ebrei, i<br />
slazione finlandese. L'articolo 14, Tatari e i cosiddetti Vecchi Russi ed inol-<br />
comma 3 della Costituzione della tre, de facto, anche i Finlandesi di lingua<br />
Finlandia garantisce a "gruppi" Svedese. Per quanto riguarda la legisla-<br />
diversi il diritto di mantenere e zione finlandese, tuttavia, esistono defi-<br />
sviluppare le proprie lingue e nizioni delle minoranze nelle seguenti<br />
culture. La Costituzione non de- leggi: legge sul parlamento Sami, legge<br />
finisce in maggiore dettaglio tali sull'uso della lingua Sami nei rapporti<br />
"gruppi". Secondo una legge go- con le autorità, la legge Skolt (253/1995)<br />
vernativa (HE 309/1993 vp) i ed infine la legge per il miglioramento<br />
"gruppi" cui fa riferimento la Co- delle condizioni di vita della popolazione<br />
stituzione comprendono i Sami, i Rom (713/1975), rimasta in vigore dal<br />
Rom e, inoltre, minoranze nazionali<br />
ed etniche, quali gli Ebrei e i<br />
Tatari.<br />
1976 al 1981.<br />
* I dati sono stati tratti dal Rapporto sull’attuazione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali.<br />
120
Paese: GERMANIA<br />
MINORANZE PRESENTI CONSISTENZA NUMERICA *<br />
SORABI 60.000 Sassonia e Brandeburgo<br />
DANESI 50.000 Regione dello Schleswig,<br />
Land di Schleswin-Holstein<br />
SINTI-ROM 70.000 Capitali degli antichi Länder<br />
della Germania (gli 11 Stati Federali<br />
della Republica Federale Tedesca<br />
prima dell’unificazione), tra<br />
cui Berlino e dintorni, sobborghi di<br />
Amburgo e di Kiel, regione del Reno/Rhur<br />
con Düsseldorf e Colonia,<br />
agglomerati del Reno/Main e del<br />
Reno/Neckar, nonché alcune città<br />
di media e piccole dimensioni della<br />
Frisia Orientale, dell’Hesse Settenarionale,<br />
del Palatinato, del Baden<br />
e della Baviera.<br />
FRISONI 12 . 00 0 Fr is i a or i en t al e,<br />
c om pr en d en t e i l S at erl an d ,<br />
l e vi c i n an z e di O l d en b ur g,<br />
c on i p a es i d i Str üc kl in g en ,<br />
R ams l oh , Sc h arr el e S ed<br />
els b er g ;<br />
Fris i a s et t en tri on al e, c om -<br />
pr en d en t e il d is tr et t o d el<br />
N or df ri es l an d s u ll a c os t a<br />
oc c i d ent al e d el L an d<br />
Sc hl es w i g-H ols t ei n (c on l e<br />
is ol e d i S yl t , F öh r , A mr u m<br />
e H el g ol an d );<br />
Frisia occidentale (regioni confinanti<br />
con la provincia olandese del<br />
Friesland).<br />
TUTELA GIURIDICA<br />
COSTITUZIONALE LEGGE NAZIONALE<br />
I cittadini tedeschi appartenenti alle Legge federale di ratifica della Con-<br />
minoranze tutelate ai sensi della venzione-quadro per la tutela delle<br />
Convenzione-quadro per la Tutela minoranze nazionali del 22 luglio<br />
delle Minoranze Nazionali godono<br />
di tutti i diritti e le libertà riconosciuti<br />
dalla Costituzione della Repubblica<br />
Federale Tedesca. Agli stessi<br />
si applica anche il divieto di discri-<br />
1997.<br />
minazione previsto dall’art. 3,<br />
comma 3, prima frase, della Costituzione.<br />
* I dati sono stati tratti dal Rapporto sull’attuazione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali e dalla pubbli-<br />
cazione “Le minoranze in Europa” di Christoph Pan e Beate Sibylle Pfeil.<br />
121
Paese: IRLANDA<br />
MINORANZE PRESENTI CONSISTENZA NUMERICA<br />
TUTELA GIURIDICA<br />
*<br />
COSTITUZIONALE LEGGE NAZIONALE<br />
VIAGGIATORI 24.000 Centri urbani<br />
Il diritto irlandese non prevede al- Legge sulla parità di status del<br />
DISTRIBUZIONE SECONDO LA LINGUA D’USO<br />
cuna definizione giuridica del ter- 2000. Questa norma definisce<br />
MAGGIORANZA: IRLANDESI 3.557.336<br />
mine “minoranza nazionale”. la comunità di Viaggiatori co-<br />
MONOLINGUI INGLESE<br />
L’Irlanda non ha fatto alcuna dime:“la comunità di persone<br />
MINORANZA: PARLANTI IRLAN-<br />
DESE GAELICO<br />
360.000 Alcune aree del paese<br />
ufficialmente definite come distretti<br />
parlanti la lingua gaelica (i Gaeltacht)chiarazione<br />
sull’applicazione della<br />
Convenzione-quadro sulle minoranze<br />
nazionali ad una particolare<br />
minoranza o comunità minoritaria.<br />
L’Irlanda ha sempre sostenuto che<br />
che vengono comunemente<br />
chiamate Viaggiatori e che sono<br />
identificate (da se stesse e<br />
da altri) come persone con una<br />
storia, una cultura e tradizioni<br />
il riconoscimento e la tutela delle comuni, caratterizzate altresì<br />
minoranze nazionali quale parte da uno stile di vita storicamen-<br />
integrante della tutela internazionate nomade sull’Isola di Irlanle<br />
dei diritti umani non sia materia<br />
di esclusiva competenza dello Stato<br />
interessato. A tale proposito,<br />
l’Irlanda fa notare come nel Commento<br />
Generale 23(50) del Comitato<br />
ONU per i Diritti Umani riferito<br />
all’art. 27 (diritti delle minoranze<br />
etniche, religiose e linguistiche) del<br />
Patto Internazionale sui Diritti Civili<br />
da”.<br />
e Politici, si specifichi che<br />
l’esistenza/il riconoscimento non<br />
dipende da una decisione dello<br />
Stato, ma sia piuttosto da riferire a<br />
dei criteri oggettivi.<br />
L’Irlanda ha, altresì, preso atto del<br />
diritto (previsto all’art. 3 della Convenzione-quadro)<br />
riconosciuto agli<br />
individui e/o gruppi di individui di<br />
scegliere liberamente se essere<br />
trattati o meno come una minoranza<br />
riconosciuta.<br />
* I dati sono stati tratti dalla pubblicazione “Le minoranze in Europa” di Christoph Pan e Beate Sibylle Pfeil.<br />
122
Paese: ITALIA<br />
MINORANZE PRESENTI CONSISTENZA NUMERICA *<br />
Ladini 48.164<br />
Sloveni 80.000 x<br />
Albanesi 70.479<br />
Greci 22.903<br />
Francofoni 126.990 xi<br />
Catalani 18.000<br />
Croati 1.650<br />
Francoprovenzali 81.642-91.642<br />
Friulani 541.242<br />
Sarda 531.549 (+55 paesi, in attesa dei dati)<br />
Occitani 48.161<br />
Altoatesina 291.873<br />
Carinziana 2.623<br />
Cimbra 315<br />
Mochena 697<br />
Walser 1.215<br />
Totale 1.867.503 – 1.877.503 circa<br />
123<br />
TUTELA GIURIDICA<br />
COSTITUZIONALE LEGGE NAZIONALE<br />
Artt. 2 e 3 della Costituzione. A norma degli Statuti speciali<br />
delle Regioni Trentino-Alto A-<br />
Art. 6 della Costituzione che recita: dige, Valle d’Aosta e Friuli-<br />
“La Repubblica tutela con apposite Venezia Giulia, con decreti<br />
norme le minoranze linguistiche”. legislativi, sono molteplici le<br />
norme di attuazione emanate.<br />
Esiste una vasta produzione<br />
normativa regionale sia<br />
nell’ambito degli Statuti che nel<br />
contesto della disciplina regionale<br />
in materia di competenza,<br />
soprattutto nel settore dei beni<br />
culturali e delle attività di promozione<br />
culturale ed educativa.<br />
Legge-quadro 15 dicembre<br />
1999, n. 482 recante “Norme<br />
in materia di tutela delle minoranze<br />
linguistiche storiche”.<br />
Legge 23 febbraio 2001, n. 38<br />
recante Norme a tutela della<br />
minoranza linguistica slovena<br />
della regione Friuli-Venezia<br />
Giulia”.<br />
* I dati sono stati desunti a seguito della delimitazione territoriale adottata dall’Organismo competente, in base alla normativa vigente.<br />
Gli stessi dati rivestono carattere di stima e quindi sono da ritenersi puramente indicativi.<br />
x Il dato risale al 1° Rapporto del Ministero dell’Interno del 1994 ed è puramente indicativo. Si è in attesa, quindi, delle delimitazioni terri-<br />
toriali previsti dalla legge n. 38/2001.<br />
xi In Valle d’Aosta circa 122.000; in Piemonte 4.990 circa.
Paese: LIECHTENSTEIN<br />
MINORANZE PRESENTI CONSISTENZA NUMERICA<br />
NON ESISTONO<br />
Il Liechtenstein ha ratificato<br />
la Convenzione<br />
quadro per la protezione<br />
delle minoranze nazionali<br />
il 18 novembre 1997, inserendo<br />
la seguente dichiarazione<br />
nello strumento<br />
di ratifica: Il Principato<br />
del Liechtenstein<br />
dichiara che, in particolare,<br />
gli articoli 24 e 25 della<br />
Convenzione quadro per<br />
la protezione delle minoranze<br />
nazionali del 1°<br />
Febbraio 1995 vanno<br />
presi in considerazione<br />
tenendo conto del fatto<br />
che sul territorio del Principato<br />
non insistono minoranze<br />
nazionali, nel<br />
senso previsto dalla Convenzione<br />
quadro. Il Principato<br />
del Liechtenstein<br />
considera la propria ratifica<br />
della Convenzione<br />
quadro quale atto di solidarietà<br />
in vista degli obiettivi<br />
della Convenzione.<br />
TUTELA GIURIDICA<br />
COSTITUZIONALE LEGGE NAZIONALE<br />
La Costituzione prevede che il tedesco<br />
sia la lingua nazionale e ufficiale<br />
del Liechtenstein. A livello generale, e<br />
per uso colloquiale, viene parlato un<br />
dialetto germanico, con caratteristiche<br />
alemanne.<br />
124
Paese: LITUANIA<br />
MINORANZE PRESENTI CONSISTENZA NUMERICA<br />
TUTELA GIURIDICA<br />
*<br />
COSTITUZIONALE LEGGE NAZIONALE<br />
Popolazione 3.653.000 Art. 25 e 26: la libertà di opinio- Legge sulle minoranze del<br />
ne,religione e coscienza è ricono- 1989 (parzialmente modificata<br />
sciuta a tutti. La libertà di cultura, nel gennaio 1991):<br />
scienza, ricerca e insegnamento è Artt. 1 e 2: alle minoranze na-<br />
riconosciuta a tutti<br />
zionali che insistono sul territo-<br />
Art 29: prevede il principio rio nazionale della Lituania è<br />
dell’uguaglianza e il divieto di di- riconosciuto il diritto al riconoscriminazionescimento<br />
e alla promozione<br />
Artt. 35 e 36: la libertà di riunione e dell’identità etnica, nonché alla<br />
associazione è riconosciuta solo ai tutela dalla discriminazione<br />
cittadini<br />
Art. 2, comma 2: particolari<br />
art. 37: “I cittadini che appartengo- misure di tutela nei settori<br />
no a comunità nazionali hanno il dell’istruzione, dei media e<br />
diritto di sviluppare la propria lin- dell’accesso ai pubblici uffici.<br />
gua e cultura e i propri costumi”. Prevede il diritto<br />
Art. 45: alle minoranze nazionali è all’insegnamento nella lingua<br />
riconosciuto il diritto di mantenere di minoranza a tutti i livelli del<br />
istituti di istruzione e di altro tipo, in sistema scolastico. Autorizza<br />
autonomia amministrativa e con il espressamente le organizza-<br />
sostegno dello Stato.<br />
zioni sociali e culturali delle<br />
Capitolo 2 della Costituzione (parte minoranze; inoltre le minoran-<br />
riguardante i diritti fondamentali): ze possono creare istituzioni<br />
distinzione tra i diritti di tutti gli indi- formative e culturali che devovidui<br />
e i diritti dei cittadini.<br />
no essere sostenute dallo Sta-<br />
Art. 117, commi 2 e 3 della Costito. Prevede espressamente il<br />
tuzione: benché la lingua usata in diritto ad intrattenere contatti<br />
tribunale sia il lituano (legge sulla con persone della medesima<br />
lingua dei pubblici uffici del 1995 e appartenenza etnica, ma resi-<br />
art. 8 della legge sui tribunali del denti all’estero. Garantisce il<br />
1994), i partecipanti ad un proces- diritto all’uso della lingua maso<br />
che non padroneggiano tale dre per la stampa, per i prodot-<br />
lingua hanno diritto all’intervento di to editoriali e l’informazione.<br />
un interprete.<br />
Art. 3: prevede l’obbligo di creare<br />
le condizioni per la formazione<br />
degli insegnanti necessari<br />
a provvedere a tale tipo di<br />
insegnamento nelle lingue di<br />
minoranza.<br />
Art. 4: particolari misure di tutela<br />
per quanto riguarda<br />
l’impiego della lingua di minoranza<br />
nei rapporti con gli uffici<br />
pubblici, le autorità e le organizzazioni<br />
locali, nei territori<br />
dove le minoranze sono presenti<br />
in maniera compatta<br />
Art. 5: particolari misure di tutela<br />
per quanto riguarda i toponimi.<br />
Le scritte “informative”,<br />
alle quali appartengono anche<br />
le denominazioni topografiche,<br />
possono essere espresse nella<br />
lingua della minoranza interessata<br />
(lingua locale), nelle parti<br />
della Lituania dove le minoranze<br />
nazionali insistono in maniera<br />
compatta, a condizione<br />
che venga aggiunta anche la<br />
lingua diStato.<br />
Art. 6: i monumenti appartenenti<br />
alla cultura delle minoranze<br />
nazionali sono considerati<br />
parte del patrimonio nazionale<br />
della Lituania e in quanto<br />
* I dati sono stati desunti a seguito della delimitazione territoriale adottata dall’Organismo competente, in base alla normativa vigente.<br />
Gli stessi dati rivestono carattere di stima e quindi sono da ritenersi puramente indicativi.<br />
125
Lituani 3.000.222 tali sono protetti<br />
Art. 7: prevede l’istituzione di<br />
scuole private per le minoranze<br />
con il sostegno dello Stato<br />
Art. 9: prevede la libertà di associazione<br />
per gli appartenenti<br />
alle minoranze nazionali<br />
Art. 10: prevede il diritto alla<br />
creazione di organismi propri.<br />
Al comma 1 stabilisce che il<br />
parlamento e i consigli comunali<br />
possano costituire dei comitati<br />
pubblici delle minoranze.<br />
Al comma 2 stabilisce che il<br />
Consiglio dei Ministri istituisca<br />
un comitato per le minoranze,<br />
al fine di dare espressione alle<br />
esigenze sociali e culturali delle<br />
minoranze etniche.<br />
Minoranze: Regolamento sui nomi delle<br />
persone del 1991: nei documenti<br />
ufficiali i nomi e i cognomi<br />
devono essere scritti in<br />
caratteri latini (caratteri della<br />
lingua lituana); tuttavia i cittadini<br />
di nazionalità diversa da<br />
quella lituana, con istanza<br />
scritta, possono richiedere che<br />
il proprio nome venga scritto in<br />
accordo con la pronuncia, ovvero<br />
con o senza le desinenze<br />
proprie del lituano. Anche i<br />
nomi di persone, a cui sia stata<br />
concessa la cittadinanza, possono<br />
essere usati in accordo<br />
con la forma originaria, utilizzando,<br />
però, i caratteri latini.<br />
Art. 18 della legge sulla lingua<br />
dei pubblici uffici del 1995:<br />
stabilisce che i nomi e gli indirizzi<br />
delle comunità o organizzazioni<br />
etniche possono essere<br />
usati nelle lingue di minoranza,<br />
ma solo accanto alla<br />
lingua usata nei pubblici uffici.<br />
Art 4 della legge sulla radio e<br />
la televisione del 1996:<br />
l’emittente di stato deve tenere<br />
conto anche delle varie nazionalità.<br />
Art. 9 della legge sul processo<br />
amministrativo del 1999: stabilisce<br />
che la lingua da usare sia<br />
il lituano, ma per chi non lo<br />
padroneggia è previsto un servizio<br />
di traduzione a spese dello<br />
Stato.<br />
Art. 31 della legge per la diffusione<br />
delle informazioni al<br />
pubblico: stabilisce che nella<br />
concessione delle licenze si<br />
tenga conto, fra l’altro delle<br />
esigenze delle minoranze nazionali.<br />
Art. 34 della legge per la diffusione<br />
delle informazioni al<br />
pubblico: prevede che le trasmissioni<br />
radiotelevisive in lingua<br />
diversa dal lituano siano<br />
tradotte in lituano o vengano<br />
completate con sottotitoli in<br />
lituano.<br />
126
Russi 300.000<br />
Polacchi 250.000<br />
Bielorussi 45.000<br />
Ucraini 35.000<br />
Ebrei 6.000<br />
Tatari 5.000<br />
Lettoni 4.000<br />
Rom 2.718<br />
Tedeschi 2.060<br />
Karaime 3.000<br />
127
Paese: MALTA<br />
MINORANZE PRESENTI CONSISTENZA NUMERICA<br />
128<br />
TUTELA GIURIDICA<br />
COSTITUZIONALE LEGGE NAZIONALE<br />
All'atto della ratifica della Convenzione<br />
quadro Malta ha reso<br />
nota la seguente Dichiarazione:<br />
Malta dichiara che sul proprio<br />
territorio non esistono minoranze<br />
nazionali nel senso previsto<br />
dalla Convenzione quadro per la<br />
protezione delle minoranze nazionali.<br />
Ratificando la Convenzione<br />
quadro, Malta intende fare<br />
un atto di solidarietà ai fini degli<br />
obiettivi della Convenzione
Paese: NORVEGIA<br />
MINORANZE PRESENTI CONSISTENZA NUMERICA *<br />
SAMI (LAPPONI) 40.000-60.000 Contee di Finnmark<br />
e Troms<br />
FINNI (Kven e Skog) 12.000-20.000 Provincia sudorientale<br />
Hedmark<br />
ROM/VIAGGIATORI 5.000 Area di Oslo<br />
EBREI 1.000<br />
129<br />
TUTELA GIURIDICA<br />
COSTITUZIONALE LEGGE NAZIONALE<br />
* I dati sono stati tratti dalla pubblicazione “Le minoranze in Europa” di Christoph Pan e Beate Sibylle Pfeil.<br />
- Nel corso degli anni ’70 e ’80<br />
erano state adottate varie misure<br />
in favore della minoranza<br />
Rom, le quali tra l’altro avevano<br />
previsto la creazione di un<br />
apposito Ufficio per gli Zingari<br />
con sede ad Oslo. Tali interventi,<br />
tuttavia, sono stati gradualmente<br />
eliminati all’inizio<br />
degli anni ’90, sia perché il loro<br />
costo è risultato essere troppo<br />
elevato sia per l’inadeguatezza<br />
dei risultati conseguiti.<br />
- Nel Rapporto sulle misure di<br />
attuazione della Convenzione<br />
n. 169 sui Popoli Indigeni e<br />
Tribali nei Paesi Indipendenti, i<br />
Sami non si definiscono minoranza<br />
ma popolo autoctono.
Paese: POLONIA<br />
MINORANZE PRESENTI CONSISTENZA NUMERICA *<br />
La Polonia è attualmente abitata<br />
da rappresentanti di 13 minoranze<br />
nazionali ed etniche, che assommano<br />
a circa 1 milione di persone<br />
(circa il 2-3% di tutti gli abitanti).<br />
Parte degli appartenenti alle minoranze<br />
nazionali ed etniche vivono<br />
in comunità, altri sono distribuiti a<br />
pioggia. nel dopoguerra non sono<br />
stati raccolti dati concernenti il numero<br />
delle persone appartenenti<br />
alle minoranze nazionali; pertanto<br />
tutti i dati citati sono stime. Le informazioni<br />
complete sulla struttura<br />
nazionale provengono da censimenti<br />
effettuati prima della Guerra<br />
(1921 e 1931). Nel 1998 l'Ufficio<br />
Centrale di Statistica ha deciso di<br />
inserire la categoria "nazionalità"<br />
nel censimento generale preliminare.<br />
Nel 1999 il Parlamento ha votato<br />
la legge del 2 dicembre sul censimento<br />
nazionale generale della<br />
popolazione e delle abitazioni, che<br />
stabiliva che il censimento doveva<br />
essere effettuato nel maggio 2002.<br />
Il questionario conteneva, fra l'altro,<br />
due domande concernenti la<br />
nazionalità: a quale nazionalità<br />
appartiene la persona e quale lingua/lingue<br />
viene/vengono parlata/parlate<br />
più spesso a casa.<br />
Bielorussi<br />
(appartenenti quasi esclusivamente<br />
alla Chiesa Ortodossa Polacca)<br />
200.000-300.000 Voivodato: Podlaskie<br />
Cechi 3.000 Voivodati: Bassa Slesia, Lubelskie,<br />
Lodzkie<br />
Karaime 200 distribuzione a pioggia<br />
Lituani 20-25.000 Voivodato Podlaskie<br />
Lemks 60-70.000 Voivodati: Malopolskie,<br />
Podkarpackie, Dolnoslaskie, Warminsko-Mazurskie,<br />
Lubuskie<br />
Tedeschi 300-500.000 Voivodati: Oploskie,<br />
Staskie, Warminsko-Mazurskie,<br />
Kujawsko-Pomorskie<br />
Armeni 5-8.000 Voivodati: Bassa Slesia,<br />
Malopolskie<br />
Rom 20-30.000 Voivodati: Malopolskie,<br />
a pioggia<br />
Russi 10-15.000 Voivodati: Podlaskie,<br />
Warmia e Mazury<br />
Slovacchi 10-20.000 Voivodato Malopolskie<br />
Tatari 5.000 Voivodato Podlaskie<br />
Ucraini 200-300.000 Voivodati: Bassa Slesia,<br />
Lubelskie, Lubuskie, Malopolskie,<br />
V. Subcarpatico, Warmia e<br />
Mazury, V. Pomerania occidentale<br />
Casciubi 300.000-500.000<br />
Greci 4000-5000<br />
Ebrei 8-10.000 a pioggia<br />
130<br />
TUTELA GIURIDICA<br />
COSTITUZIONALE<br />
Le norme costituzionali riguardanti<br />
i diritti linguistici sono attuate ri-<br />
LEGGE NAZIONALE<br />
spetto alla comunità casciuba<br />
(gruppo etnico che coltiva le proprie<br />
tradizioni regionali e usa la<br />
propria lingua, che è diversa dal<br />
polacco; la consistenza numerica è<br />
di circa 350-500.000 persone.<br />
* I dati sono stati tratti dal Rapporto sull’attuazione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali e dalla pubbli-<br />
cazione “Le minoranze in Europa” di Christoph Pan e Beate Sibylle Pfeil.
Paese: REGNO UNITO<br />
MINORANZE PRESENTI CONSISTENZA NUMERICA *<br />
Scozzesi 63.000<br />
Irlandesi 140.000<br />
Gallesi 543.000<br />
Rom 90.000<br />
Cornici 1000<br />
Gallesi Isola di Man 300<br />
* I dati sono stati tratti dalla pubblicazione “Le minoranze in Europa” di Christoph Pan e Beate Sibylle Pfeil.<br />
131<br />
TUTELA GIURIDICA<br />
COSTITUZIONALE LEGGE NAZIONALE<br />
Non esiste una definizione giuridica<br />
di minoranza nazionale.<br />
Viene definito il gruppo razziale<br />
di cui alla legge del 1976 sui<br />
Rapporti razziali: "gruppo di persone<br />
definite per mezzo del colore,<br />
razza, nazionalità (compresa<br />
la cittadinanza) o delle origini<br />
etniche o nazionali". Tale definizione<br />
comprende le comunità<br />
minoritarie etniche (o minoranze<br />
visibili), gli scozzesi, gli irlandesi<br />
e gallesi, gli zingari e la comunità<br />
dei nomadi dell'Irlanda del<br />
Nord. E' importante notare che<br />
l'appartenenza ad una comunità<br />
minoritaria etnica non esclude il<br />
senso di appartenenza alle unità<br />
costitutive del Regno Unito.<br />
La legge del 1998 sulla criminalità<br />
e i disordini ha rafforzato<br />
l'efficacia della legge penale<br />
contro i reati con aggravante<br />
razziale. La legge del 1976 tutela<br />
gli appartenenti alle minoranze<br />
etniche dalla discriminazione.<br />
Secondo tale legge la discriminazione<br />
è illegale nell'istruzione,<br />
formazione e questioni attinenti;<br />
nella fornitura di beni, strutture,<br />
servizi e locali, nonché nell'utilizzo<br />
e nella gestione di ambienti.<br />
Detta legge prevede che le<br />
persone abbiano diritto di accedere<br />
direttamente ai Tribunali<br />
civili e a quelli del lavoro per<br />
tutelarsi dalla discriminazione<br />
illegale. La citata legge ha istituito<br />
la Commissione per l'uguaglianza<br />
razziale, indipendente<br />
dal <strong>Governo</strong>, che opera per l'eliminazione<br />
della discriminazione<br />
e la promozione delle pari<br />
opportunità.
Paese: REPUBBLICA CECA<br />
MINORANZE PRESENTI CONSISTENZA NUMERICA *<br />
MINORANZE<br />
SLOVACCHI 314.877 Distretti di Sokolov, Cheb,<br />
Cesky Krumlov, Karvina, Bruntal,<br />
città di Praga<br />
POLACCHI 59.383 Zone confinanti con la Polonia;<br />
Distretti di Frydek-Mistek e Karvina<br />
TEDESCHI 48.556 Regioni a ridosso dei confini<br />
meridionale, settentrionale ed<br />
occidentale (distretti di Jihlava e<br />
Viyskov);<br />
Distretti di Sokolov, Karlovy Vary,<br />
Chomutov e Teplice;<br />
in Moravia, distretto di Opava<br />
ROM 32.903 Sull’intero territorio delle<br />
Terre Ceche, con le maggiori concentrazioni<br />
nelle città industriali<br />
della Boemia settentrionale e della<br />
Moravia settentrionale, nonché a<br />
Praga<br />
UNGHERESI 19.932 Praga, Boemia centrale,<br />
Moravia settentrionale<br />
UCRAINI 8.220 Praga, Boemia centrale, Moravia<br />
settentrionale<br />
RUSSI 5.062 su tutto il territorio nazionale<br />
RUTENI 1.926 su tutto il territorio nazionale<br />
BULGARI 3.487 su tutto il territorio nazionale<br />
GRECI 3.379 su tutto il territorio nazionale,<br />
con le maggiori concentrazioni nelle<br />
città di Krnov e Brno<br />
ROMENI 1.043 su tutto il territorio nazionale<br />
AUSTRIACI 413 Cfr. minoranza tedesca<br />
VIETNAMITI 421<br />
EBREI<br />
218 su tutto il territorio nazionale<br />
ALTRI<br />
9.860<br />
(di cui cecoslovacchi)<br />
3.464<br />
SECONDO L’APPARTENENZA REGIONALE<br />
BOEMI 9.270.615<br />
MORAVI 373.294<br />
132<br />
TUTELA GIURIDICA<br />
COSTITUZIONALE LEGGE NAZIONALE<br />
Provvedimenti legislativi aventi - Legge 122/1920, basata<br />
rilevanza costituzionale:<br />
sull’art. 129 della Costituzione<br />
- Legge 121/1920, che recepisce la che stabilisce i principi dei diritti<br />
legge costituzionale della Repub- linguistici nella Repubblica Ceblica<br />
Cecoslovacca;<br />
coslovacca;<br />
- Legge 508/1921, Trattato tra le<br />
principali potenze alleate ed associate<br />
e la Cecoslovacchia firmato a<br />
Saint- Gennain-en Laye il<br />
10/9(1919;<br />
- Legge 144/1968 sullo status delle<br />
minoranze nazionali nella Repubblica<br />
Socialista Cecoslovacca;<br />
- Legge 23/1991, che recepisce la<br />
Carta dei Diritti e delle Libertà<br />
Fondamentali quale legge costituzionale<br />
della Repubblica Federativa<br />
Ceca e Slovacca;<br />
- Legge 2/1993, Risoluzione del<br />
Consiglio Nazionale Ceco del 16<br />
dicembre 1992 sulla dichiarazione<br />
della Carta dei Diritti e delle Libertà<br />
Fondamentali quale parte integrante<br />
dell’ordine costituzionale della<br />
Repubblica Ceca<br />
Nel 1968, dopo la creazione della<br />
Federazione Cecoslovacca, il Parlamento<br />
ha adottato una legge costituzionale<br />
sullo status delle minoranza.<br />
L’elenco delle minoranze<br />
nazionali in essa presentato includeva<br />
anche la minoranza nazionale<br />
tedesca, oltre a quella ungherese,<br />
polacca, ucraina (rutena) già<br />
previste. Altre minoranze, tra cui i<br />
Rom non sono state riconosciute.<br />
In base alla costituzione ed alla<br />
legge summenzionata, all’epoca la<br />
Cecoslovacchia comprendeva due<br />
nazioni (nel significo etnico del<br />
termine) e quattro gruppi etnici descritti<br />
con un termine diverso da<br />
nazione, ossia con quello di gruppo<br />
etnico. Le stesse minoranze<br />
non sono state e continuano a non<br />
essere descritte come nazionali,<br />
ma piuttosto con l’aggettivo “etnico”.<br />
La tradizione della doppia etnicità<br />
è stato mantenuto<br />
nell’attuale Repubblica Ceca, nonostante<br />
l’ordinamento interno del<br />
paese non riconosca il termine di<br />
nazione (etnica) costituente lo Stato.<br />
Il termine nazione viene generalmente<br />
associato alla lingua, alla<br />
cultura ed alla patria potestà.<br />
Nel 1991, la legge costituzionale<br />
sullo status delle minoranze nazio-<br />
* I dati sono stati tratti dal Rapporto sull’attuazione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali e dalla pubbli-<br />
cazione “Le minoranze in Europa” di Christoph Pan e Beate Sibylle Pfeil.
SLESIANI 11.248 nali del 1968 è stata sostituita dalla<br />
Carta dei Diritti e delle Libertà<br />
Fondamentali che, agli artt. 24 e<br />
25, definisce la tutela dei diritti delle<br />
minoranze nazionali. Dopo lo<br />
scioglimento della Federazione<br />
Cecoslovacca, la Carta è stata inserita<br />
nell’ordinamento costituzionale<br />
della Repubblica Ceca a decorrere<br />
dal 1° gennaio 1993.<br />
133
Paese: REPUBBLICA DELLA MOLDAVIA<br />
MINORANZE PRESENTI CONSISTENZA NUMERICA *<br />
UCRAINI 600.366<br />
RUSSI 562.062<br />
GAGAUZI 153.458 La maggioranza risiede<br />
nella regione occupata dall’Unità<br />
Territoriale Amministrativa della<br />
Gagauzia (Gagauz-Yeri), entità<br />
politica autonoma.<br />
BULGARI 88.419<br />
EBREI 65.672<br />
BIELORUSSI 19.608<br />
ROM 11.571<br />
TEDESCHI 7.335<br />
POLACCHI 4.739<br />
I dati demografici sopra indicati si<br />
riferiscono al censimento della popolazione<br />
condotto nel 1989,<br />
quando il paese era ancora parte<br />
dell’Unione Sovietica.<br />
La Repubblica di Moldova comprende,<br />
oltre alla Gagauzia, anche<br />
un’altra regione autonoma costituita<br />
dalla Transdniestria, dove sono<br />
presenti varie minoranze etniche,<br />
fra cui ucraini, russi, bulgari, gagauzi<br />
ed altre.<br />
134<br />
TUTELA GIURIDICA<br />
COSTITUZIONALE LEGGE NAZIONALE<br />
* I dati sono stati tratti dalla pubblicazione “Le minoranze in Europa” di Christoph Pan e Beate Sibylle Pfeil.
Paese: REPUBBLICA DI MACEDONIA<br />
MINORANZE PRESENTI CONSISTENZA NUMERICA *<br />
Albanesi 442.914<br />
Turchi 77.252<br />
Rom 43.732<br />
Valacchi 8.467<br />
Serbi 39.260<br />
Altri 34.960<br />
135<br />
TUTELA GIURIDICA<br />
COSTITUZIONALE LEGGE NAZIONALE<br />
La Costituzione della Repubblica di<br />
Macedonia non prevede l'uso del<br />
termine minoranze nazionali; con<br />
gli emendamenti costituzionali del<br />
2004 è stato eliminato anche il<br />
termine nazionalità.<br />
Il IV emendamento alla Costituzione<br />
prevede che la Repubblica di<br />
Macedonia costituisca uno stato<br />
indipendente e sovrano in cui i cittadini,<br />
sia macedoni sia appartenenti<br />
al popolo albanese, turco,<br />
valacco, serbo, rom, bosniaco si<br />
assumano la responsabilità del<br />
presente e del futuro della loro patria.<br />
L'articolo 8 della Costituzione<br />
prevede la libera espressione dell'affiliazione<br />
etnica, che è uno dei<br />
valori fondamentali dell'ordine costituzionale<br />
della Repubblica di<br />
Macedonia, unitamente a quello<br />
della rappresentazione adeguata<br />
ed equa dei cittadini appartenenti<br />
ad altre comunità presso gli organi<br />
delle autorità statali e di altre pubbliche<br />
istituzioni, a tutti i livelli.<br />
* I dati sono stati tratti dalla pubblicazione “Le minoranze in Europa” di Christoph Pan e Beate Sibylle Pfeil.
Paese: ROMANIA<br />
MINORANZE PRESENTI CONSISTENZA NUMERICA *<br />
Romeni<br />
20.350.980 In 38 distretti la popolazione<br />
di origine etnica rumena<br />
costituisce la maggioranza. Nei<br />
distretti di Covasna e Harghita la<br />
popolazione di origine etnica magiara<br />
costituisce la maggioranza.<br />
Magiari e Szekel 1.620.199<br />
Rom 409.723<br />
Tedeschi, Svevi e Sassoni 119.436<br />
Ucraini 66.833<br />
Russi-Lipovani 38.688<br />
Serbi 29.080<br />
Tatari 24.649<br />
Slovacchi 20.672<br />
Bulgari 9.935<br />
Ebrei 9.107<br />
Croati 4.180<br />
Cechi 5.800<br />
Polacchi 4.247<br />
Greci 3.897<br />
Armeni 2.023<br />
Valacchi 200.000-250.000<br />
Turchi 32.596<br />
Carasciovani 207<br />
Macedoni 731<br />
Altri 8.420<br />
136<br />
TUTELA GIURIDICA<br />
COSTITUZIONALE LEGGE NAZIONALE<br />
I Trattati politici fondamentali<br />
conclusi dalla Romania con<br />
l'Ungheria (1996) e l'Ucraina<br />
(1997), contengono articoli separati<br />
sulla tutela delle persone<br />
appartenenti alle minoranze nazionali<br />
e prevedono che le Parti<br />
contraenti diano attuazione alle<br />
norme e agli standard previsti<br />
dalla Convenzione quadro per la<br />
protezione delle minoranze nazionali.<br />
* I dati sono stati tratti dal Rapporto sull’attuazione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali e dalla pubbli-<br />
cazione “Le minoranze in Europa” di Christoph Pan e Beate Sibylle Pfeil.
Paese: RUSSIA<br />
MINORANZE PRESENTI CONSISTENZA NUMERICA *<br />
Nel soddisfare le varie esigenze<br />
delle minoranze nazionali, nella<br />
pratica si è arrivati ad individuare<br />
due gruppi di entità nella composizione<br />
etnica della Federazione<br />
Russa: nazioni insediate o che vivono<br />
sul territorio della Russia da<br />
un lungo periodo di tempo, che<br />
possono essere chiamati, in un<br />
certo senso, popoli indigeni e<br />
gruppi etnici di origine relativamente<br />
più recente, le cui etnie "madri"<br />
vivono fuori dalla Federazione<br />
Russa (la Comunità di Stati Indipendenti<br />
e i Paesi Baltici, Bulgaria,<br />
Ungheria, Germania, Corea, Polonia,<br />
Finlandia e altri stati); infine vi<br />
sono anche gruppi che non hanno<br />
uno stato corrispondente (Assiri,<br />
Karaiti, Curdi e Rom)<br />
Anche se non riconosciute, vivono<br />
in Russia le seguenti minoranze:<br />
Aguli 18.000<br />
Assiri 9.600<br />
Avari 544.000<br />
Balkari 78.000<br />
Baskiri 1.345.000<br />
Bielorussi 1.206.000<br />
Calmucchi 166.000<br />
Careliani 125.000<br />
Cazacchi 636.000<br />
Ceceni 899.000<br />
Circassi (Adyghei) 174.000<br />
Ciuviassi 1.774.000<br />
Darghini 353.000<br />
Estoni 46.000<br />
Ebrei 548.000<br />
Finni 47.000<br />
Gagauzi 10.000<br />
Georgiani 131.000<br />
Greci 92.000<br />
Ingri 1.100<br />
Ingusci 215.000<br />
Kabardini 386.000<br />
Karaciai 150.000<br />
Komi 336.000<br />
Komi-Permiacchi 147.000<br />
Kumycchi 277.000<br />
Laki 106.000<br />
Lezghini 257.000<br />
Lettoni 47.000<br />
Lituani 70.000<br />
Mari 644.000<br />
Mordvini 1.073.000<br />
Nogai 74.000<br />
Osseti 402.000<br />
Rom 153.000<br />
Rutuli 20.000<br />
Sami 1.800<br />
Tabasarani 94.000<br />
Tatari 5.543.000<br />
Tati 19.000<br />
Tsakhuri 6.500<br />
Tedeschi 842.000<br />
* I dati sono stati tratti dalla pubblicazione “Le minoranze in Europa” di Christoph Pan e Beate Sibylle Pfeil.<br />
137<br />
TUTELA GIURIDICA<br />
COSTITUZIONALE LEGGE NAZIONALE<br />
L'articolo 26 della Costituzione del- La legislazione in vigore non<br />
la Federazione Russa stabilisce contiene alcuna definizione del<br />
quanto segue: "Ciascuno ha il dirit- concetto di "minoranza nazioto<br />
di determinare e dichiarare la nale", pertanto non esiste un<br />
propria nazionalità. Nessuno può elenco di gruppi riconosciuti<br />
essere obbligato a determinare o<br />
dichiarare la propria nazionalità".<br />
quale minoranza nazionale
Ucraini 4.363.000<br />
Udmurti 715.000<br />
Vepsi 12.000<br />
24.156.000<br />
138
Paese: SAN MARINO<br />
MINORANZE PRESENTI CONSISTENZA NUMERICA<br />
Benché San Marino non ospiti minoranze<br />
etniche sul proprio territorio,<br />
in anni recenti ha sperimentato<br />
il fenomeno dell'immigrazione. Un<br />
consistente numero di persone,<br />
relativamente alle dimensioni della<br />
popolazione locale, si reca a lavorare<br />
a San Marino, in particolare<br />
dall'Europa orientale o dal Magreb.<br />
Per la maggior parte si tratta<br />
di lavoratori stagionali, in quanto,<br />
in primavera ed estate si creano<br />
molti posti di lavoro nel settore del<br />
turismo. Alcuni di questi lavoratori<br />
stagionali, che normalmente sono<br />
impiegati nel settore della ristorazione<br />
o come commessi, potrebbero<br />
prendere in conoiderazione l'ipotesi<br />
di fermarsi permanentemente<br />
a San Marino.<br />
Attualmente, anche in considerzione<br />
del loro numero limitato, non<br />
esistono problemi di coesistenza<br />
con la comunità indigena.<br />
139<br />
TUTELA GIURIDICA<br />
COSTITUZIONALE LEGGE NAZIONALE
Paese: SERBIA E MONTENEGRO<br />
MINORANZE PRESENTI CONSISTENZA NUMERICA *<br />
ALBANESI 1.714.768 Regioni del Kossovo e<br />
di Mentohija; Serbia Centrale; Serbia<br />
meridionale (comuni di Presvo<br />
e Bujanovac); comune di Medvedja<br />
al confine con il Kossovo; città di<br />
Belgrado (presenza esigua) Vojvodina;<br />
Repubblica del Montenegro<br />
(maggiore concentrazione nel comune<br />
di Ulcinj, altri gruppi presenti<br />
nei comuni di Plav, Bar e nella capitale<br />
Podgorica)<br />
BOSNIACI/MUSSULMANI 327.339 Sandzak (regione comprendente<br />
parte della Serbia e del<br />
Montenegro, confinante con la Bosnia)<br />
con le maggiori concentrazioni<br />
nei comuni di Tutin, Snjenica<br />
e Novi Pazar; Serbia centrale;<br />
Kossovo; Vojvodina;<br />
Montenegro<br />
BULGARI 26.922Serbia orientale confinante<br />
con la Bulgaria (comuni di Dimitrovgrad<br />
e Bosilegrad); Serbia meridionale<br />
(comuni di Pirot, Babusnica<br />
e Surdulica); Vojvodina (villaggio<br />
di Ivanovo in Banat); Kossovo;<br />
Montenegro<br />
BUNJEVCI 21.434 Vojvodina (la comunità più<br />
numerosa è presente nei comuni di<br />
Subotica nel Backa settentrionale<br />
e di Sombor, mentre gruppi meno<br />
consistenti risiedono a Bajmok,<br />
Gornji e Donji Tavankut, Djurdjin,<br />
Kelebija, Mala Bosna, Novi Zednik,<br />
Palic)<br />
CROATI 111.650 Repubblica di Serbia; Repubblica<br />
del Montenegro; Kossovo<br />
(principalmente nel comune di Janjevo);<br />
Vojvodina; Le comunità di<br />
croati più numerose risiedono nei<br />
seguenti comuni: Subotica, Sombor,<br />
Sid, Indjia, Apatin, Ruma, Bac,<br />
Kula, Sremski Karlovci, Backa Palanka,<br />
Beocin, Irig e Novi Sad<br />
UNGHERESI 344.147 Vojvodina (la maggiore<br />
presenza si riscontra nelle seguenti<br />
città: Ada, Backa Topola, Becej,<br />
Kanjiza, Mali Idjos, Senta, Coka,<br />
Banat, Srem, Subotica; gruppi numericamente<br />
più esigui sono presenti<br />
nei comuni di Nova Crnja,<br />
Becej, Zitiste e Srbobran)<br />
TEDESCHI 5.387 Vojvodina (comuni di Apatin,<br />
Zrenjanin, Pancevo Vrbas, Subotica,<br />
Kula, Sombor, Sremska Mitrovica,<br />
Odzaci, Novi Sad, Backa Palanka<br />
e Bela Crkva); città di Belgrado;<br />
Repubblica del Montenegro<br />
RUMENI 42.364 Vojvodina (principlamente<br />
nella zona di Banat e nei comuni di<br />
Alibunar, Vrsac, Pancevo, Zrenjanin);<br />
Serbia centrale;<br />
Montenegro; Kossovo<br />
140<br />
TUTELA GIURIDICA<br />
COSTITUZIONALE LEGGE NAZIONALE<br />
Legge della Repubblica del Montenegro<br />
sull’elezione di consiglieri<br />
e deputati. Tale legge consente ai<br />
comuni con una popolazione costituita<br />
in prevalenza da albanesi di<br />
creare una circoscrizione elettorale<br />
separata in seno alla singola circoscrizione<br />
repubblicana, fissando<br />
all’1% la soglia dei voti necessari<br />
per l’ingresso in Parlamento.<br />
* I dati sono stati tratti dal Rapporto sull’attuazione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali.<br />
Firma dell’Accordo intergovernativo<br />
sulla normalizzazione dei rapporti<br />
tra la Repubblica di Croazia e<br />
la ex Repubblica di Jugoslavia, che<br />
all’art. 8 prevede, indirettamente, il<br />
riconoscimento dello status di minoranza<br />
nazionale ai Croati in Jugoslavia.
RUTENI 18.099 Vojvodina (comuni di Kula,<br />
Vrbas, Zabalj, Sid, Sremska Mitrovica,<br />
Novi Sad); Serbia Centrale;<br />
Montenegro; le comunità più numerose<br />
sono presenti nelle aree di<br />
Backa, e Srem, mentre altri importanti<br />
insediamenti sono localizzati<br />
a Ruski Krstur, Kucura e Bikic<br />
ROM 143.519 Montenegro (comuni di<br />
Andrijevica, Pluzine, Pljevlja, Savnik,<br />
insediamenti di Vrela Ribnicka<br />
e Konik presso Podgorica, insediamento<br />
di Niksic presso Pod<br />
Trejesom e di Cetinje presso Zabrdje;<br />
Serbia centrale;<br />
Vojvodina; Kossovo; le maggiori<br />
concentrazioni sono presenti nel<br />
bacino meridinale del fiume Morava<br />
e nella zona di Nis, in particolare<br />
nei comuni di Surdulica, Bujanovac,<br />
Bojnik, Vladicin Han<br />
SLOVACCHI 66.863 Vojvodina (comuni di Backi<br />
Petrovac, Kovacica, Bac, Stara<br />
Pazova, Backa Palanka, Novi Sad)<br />
UCRAINI 4.565 Vojvodina (comuni di Vrbas,<br />
Kula, Sremska Mitrovica, Indjija,<br />
Bac e Novi Sad)<br />
VALACCHI 17.810 Serbia nord-orientale; Montenegro;<br />
Kossovo; Vojvodina<br />
MONTENEGRINI 519.757 Repubblica federativa del<br />
Montenegro<br />
TURCHI 11.264 Kossovo e Metohija<br />
TSINTSARS (appellativo dai - Aree urbane<br />
Serbi agli Arumeni)<br />
GORANTSI - Kossovo e Mettohija<br />
MACEDONI - Karacevo e Jabuka<br />
CECHI - Dintorni di Kovin<br />
EBREI - Aree urbane<br />
POLACCHI - Aree urbane<br />
SLOVENI - Aree urbane<br />
RUSSI - Vojvodina<br />
HASHKALIS/EGIZIANI 80.000 Kossovo ed altre zone del<br />
paese<br />
141
Paese: SLOVACCHIA<br />
MINORANZE PRESENTI CONSISTENZA NUMERICA *<br />
UNGHERESI 520.528<br />
ROM 89.920<br />
CECHI 46.968<br />
RUTENI<br />
Poiché i Ruteni sono considerati in<br />
Slovacchia come gruppo a parte,<br />
sono qui indicati separatamente<br />
dagli Ucraini<br />
24.201<br />
UCRAINI 10.814<br />
TEDESCHI 5.405<br />
CROATI 890<br />
EBREI 218<br />
POLACCHI 2.602<br />
BULGARI 1.179<br />
142<br />
TUTELA GIURIDICA<br />
COSTITUZIONALE LEGGE NAZIONALE<br />
- Legge costituzionale N. 23/1991,<br />
che introduce la Carta dei Diritti<br />
Fondamentali e delle Libertà Fondamentali<br />
(in particolare arrt. 24,<br />
25, 37);<br />
- Costituzione della Rep. Slovacca<br />
(artt. 6, 12, 33, 34, 47).<br />
* I dati sono stati tratti dalla pubblicazione “Le minoranze in Europa” di Christoph Pan e Beate Sibylle Pfeil.<br />
- Decreto del Ministero degli Affari<br />
Esteri N. 95/1974 relativo<br />
alla Convenzione Internazionale<br />
sulla Eliminazione di ogni Forma<br />
di Discriminazione Razziale;<br />
- Decreto del Ministero degli Affari<br />
esteri N. 120/1976 relativo al<br />
Patto sui Diritti Civili e Politici ed<br />
al Patto Internazionale sui Diritti<br />
Economici, Sociali e Culturali;<br />
- Legge N. 468/1991 sul funzionamento<br />
del Servizio radiotelevisivo<br />
e successive modifiche<br />
(art. 9 comma 2 lettera c/);<br />
- Legge del Consiglio Nazionale<br />
Slovacco N. 254/1991 sulla Televisione<br />
slovacca (art. 3, comma<br />
3, capoverso 6, lettera j/);<br />
-Legge del Consigli Nazionale<br />
Slovacco N. 255/1991 sulla Radio<br />
slovacca (art. 6, lettera d/);<br />
Legge del Consiglio Nazionale<br />
Slovacco N. 36/1978 sui teatri<br />
emendata con Legge del Consiglio<br />
Nazionale Slovacco N.<br />
115/1989 (art. 31, lettera f/);<br />
- Legge N. 29/1984 sulla Rete<br />
delle Scuole Primarie e Secondarie<br />
e successive modifiche<br />
(art. 3, comma 1);<br />
- Decreto del Ministero<br />
dell’Istruzione, della Gioventù e<br />
dello Sport N.293/1991 relativo<br />
ai Provveditorati agli Studi;<br />
- Ordinanza del <strong>Governo</strong> della<br />
Repubblica Slovacca N.<br />
282/1994 sull’Utilizzo dei libri di<br />
testo;<br />
- Decreto del Ministero<br />
dell’Istruzione N. 280/1994 relativo<br />
alle scuole private;<br />
- Legge del Consiglio Nazionale<br />
della Repubblica Slovacca N.<br />
279/1993 sulle Strutture scolastiche<br />
e successive modifiche;<br />
- Decreto del Ministero<br />
dell’Istruzione N. 353/1994 relativo<br />
alle strutture adibite all’uso<br />
per l’istruzione in età prescolare;<br />
- Legge del Consiglio Nazionale<br />
Slovacco N. 542/1990<br />
sull’Amministrazione statale e<br />
l’Autonomia delle scuole e successive<br />
modifiche;<br />
- Decreto del Ministero<br />
dell’Istruzione e del Ministero<br />
della Salute N. 536/1990 relativo<br />
alla creazione ed al funzionamento<br />
delle scuole religiose;<br />
- Ordinanza del <strong>Governo</strong> della<br />
Repubblica Slovacca N.<br />
113/1991 relativa alla conces-
MORAVI, SLESIANI 6.361<br />
143<br />
sione di sussidi statali alle scuole<br />
private;<br />
- Legge N. 175/1990 (art. 10,<br />
comma 1, lettera a/);<br />
- Legge N. 84/1990 sul Diritto di<br />
riunione modificato con - Legge<br />
N. 83/1990 sull’Associazione di<br />
Cittadini e successive modifiche<br />
(art. 4);<br />
- Legge N. 85/1990 sul Diritto di<br />
voto (art. 1, comma 4);<br />
- Legge N. 256/1992 sulla Protezione<br />
dei dati personali nei<br />
Sistemi di Informazione ((art.<br />
16);<br />
- Legge del Consiglio Nazionale<br />
della Repubblica Slovacca sui<br />
nomi ed i cognomi N. 300/1993<br />
(art. 2, comma 1, art. 4, comma<br />
ed art. 14);<br />
- Legge del Consiglio Nazionale<br />
della Repubblica Slovacca sui<br />
Registri N. 154/1994 (art. 16,<br />
art. 19, commi 3 e 5);<br />
- Legge del Consiglio Nazionale<br />
della Repubblica Slovacca N.<br />
191/1994 sulla toponomastica<br />
nella lingua delle minoranze nazionali;<br />
- Legge sulla procedura civile N.<br />
70/1992;<br />
- Codice civile N. 40/1964 e<br />
successive modifiche;<br />
- Legge N. 141/1961 sui procedimenti<br />
penali (Procedura penale)<br />
(art. 2, comma 14);<br />
- Codice penale N. 140/1961 e<br />
successive modifiche (artt. 196,<br />
198 e 259);<br />
- Codice del lavoro N. 65/1965 e<br />
successive modifiche;<br />
Legge del Consiglio Nazionale<br />
della Repubblica Slovacca, sui<br />
Procedimenti innanzi ad essa e<br />
sulla posizione dei giudici, modificata<br />
con Legge del Consiglio<br />
Nazionale della Repubblica Slovacca<br />
N. 293/1995 (art. 23);<br />
- Legge sui Tribunali ed i Giudici<br />
N. 335/1991 (art. 7, comma 3);<br />
- Decreto del Ministero<br />
dell’Istruzione, della Gioventù e<br />
dello Sport N. 280/1991 relativo<br />
al completamento dei corsi di<br />
studio nelle scuole secondarie e<br />
di preparazione nelle scuole professionali,<br />
e successive modifiche<br />
(art. 10).
Paese: SLOVENIA<br />
MINORANZE PRESENTI CONSISTENZA NUMERICA *<br />
Magiari 8.503<br />
Italiani 3.064<br />
Rom 2.293<br />
Tedeschi (inclusi vecchi austriaci) 745<br />
Le comunità nazionali italiane ed<br />
ungheresi vivono in zone relativamente<br />
compatte, che vengono definite<br />
zone etnicamente miste. La<br />
comunità italiana è insediate in tre<br />
comuni costieri lungo il confine con<br />
l'Italia (Capodistria, Isola e Pirano).<br />
La comunità nazionale ungherese<br />
è insediata nella regione lungo il<br />
confine tra la repubblica di Slovenia<br />
e la repubblica di Ungheria<br />
(comuni di Dobrovnik, Hodo, Lendava,<br />
Moravske Toplice e Alovci)<br />
La parte principale della comunità<br />
Rom nella repubblica di Slovenia è<br />
insediata a Prekmurje e nella regione<br />
di Dolenjsko, nella Slovenia<br />
centrale.<br />
* I dati sono stati tratti dalla pubblicazione “Le minoranze in Europa” di Christoph Pan e Beate Sibylle Pfeil.<br />
144<br />
TUTELA GIURIDICA<br />
COSTITUZIONALE LEGGE NAZIONALE<br />
La tutela dei diritti delle comunità L'esercizio dei diritti previsti dalla<br />
nazionali autoctone e della comu- Costituzione è garantito per legge<br />
nità Rom in Slovenia è garantita relativamente agli insediamenti<br />
dalla legislazione della repubblica autoctoni di entrambe le comunità,<br />
di Slovenia a due livelli: tutela dei indipendentemente dal numero di<br />
diritti individuali dei membri delle appartenenti. In forza del principio<br />
comunità minoritarie e garanzia di territoriale, i diritti speciali vengono<br />
diritti speciali per le comunità mino- esercitati nelle zone etnicamente<br />
ritarie (art. 64 della Costituzione) e miste, abitate dalle comunità etni-<br />
la comunità Rom (art. 65 della Coche. Al di fuori di dette zone i diritti<br />
stituzione). Secondo la Costituzio- speciali delle minoranze nazionali<br />
ne le comunità nazionali autoctone vengono attuati solo eccezional-<br />
italiana e ungherese godono dello mente, come previsto dalla legge.<br />
speciale diritto all'uso dei propri La Costituzione stabilisce che lo<br />
simboli nazionali, all'uso della pro- status e i diritti speciali della copria<br />
lingua nell'istruzione, alle promunità Rom che vive in Slovenia<br />
prie attività economiche, culturali e siano determinati per legge.<br />
di ricerca, ad attività nel settore dei Per la loro situazione specifica,<br />
mass media e dell'editoria ed infine che è dovuta al tradizionale stile di<br />
godono del diritto a mantenere vita, le misure adottate dalla co-<br />
contatti con le proprie nazioni di munità maggioritaria sono volte<br />
origine. La Costituzione vincola lo all'assistenza dei Rom e riguarda-<br />
Stato a sostenere, concretamente no prevalentemente le codizioni di<br />
e moralmente l'esercizio di tali dirit- vita elementari: garanzia dell'abitati.<br />
La Costituzione garantisce ad zione e dei mezzi di sussistenza.<br />
entrambe le comunità nazionali il In tal modo le condizioni per un<br />
diritto alla partecipazione diretta al reale miglioramento della situazio-<br />
processo decisionale congiunto ne dei Rom (mantenimento dell'i-<br />
relativo a questioni pubbliche a dentità, istruzione, occupazione e<br />
livello locale e nazionale. Presso partecipazione alla vita pubblica e<br />
l'Assemblea Nazionale è attiva una politica) sono in via di graduale<br />
commissione speciale per le co- miglioramento. Le disposizioni nel<br />
munità nazionali. Al fine di vedere settore dell'istruzione tengono con-<br />
realizzati i propri interessi i membri to delle specifiche esigenze dei<br />
delle minoranze nazionali danno bambini Rom e sono volte a garan-<br />
vita a comunità nazionali autogotirne l'integrazione nella società in<br />
vernate, che sono enti di diritto senso più ampio, pur preservan-<br />
pubblico e che in quanto tali rapdone l'identità e la cultura. Nelle<br />
presentano politicamente le mino- zone di antico insediamento dei<br />
ranze nazionali e fungono da inter- Rom, la comunità Rom ha il diritto<br />
locutori dello Stato e delle comuni- ad essere rappresentata negli ortà<br />
locali. La Costituzione stabilisce ganismi di autogoverno locale.<br />
che le leggi e i regolamenti che Sono garantite le attività culturali e<br />
hanno un'influenza sull'esercizio lo sviluppo dei servizi per l'accesso<br />
dei diritti sanciti costituzionalmente alle informazioni. Per la specifica<br />
delle comunità nazionali possono situazione della comunità Rom, il<br />
entrare in vigore solo con il con- <strong>Governo</strong> della Repubblica di Slosenso<br />
dei rappresentanti delle covenia ha adottato, nel 1995, un<br />
munità nazionali.<br />
programma di misure articolato per<br />
l'assistenza ai Rom. Il programma<br />
mira al miglioramento della situazione<br />
dei Rom e prevede l’attività<br />
di vari organismi governativi in que<br />
sto settore. La Costituzione, oltre a<br />
sancire i diritti umani in generale,<br />
prevede anche diritti speciali per le<br />
comunità nazionali autoctone di<br />
italiani e ungheresi e per la comunità<br />
Rom; tali diritti vengono coerentemente<br />
attuati dall'intero sistema<br />
giuridico della Repubblica
145<br />
di Slovenia e dalla politica governativa.<br />
Pertanto la Repubblica di<br />
Slovenia, all'atto della ratifica della<br />
Convenzione quadro, ha dichiarato<br />
di volerne applicare le disposizioni<br />
in favore dei membri di dette comunità.
Paese: SPAGNA<br />
MINORANZE PRESENTI CONSISTENZA NUMERICA *<br />
CATALANI 4.194.202 Circa 3.700.000 in Catalogna<br />
e circa 500.000 nelle isole<br />
Baleari<br />
VALENZIANI 2.005.720 Regione valenziana<br />
GALIZIANI 1.514.609 Galizia<br />
GITANI (ROM) 600.000-650.000 disomogenei sul<br />
territorio nazionale, con la maggior<br />
presenza nelle collettività atonome<br />
dell’Andalusia (45%), di Valencia e<br />
Murcia e nelle principali città, come<br />
Madrid, Barcellona, Siviglia, Granada,<br />
Valenzia e Saragozza.<br />
BASCHI 586.741 Paesi Baschi e Navarra<br />
OCCITANI (ARANESI) 4.000<br />
146<br />
TUTELA GIURIDICA<br />
COSTITUZIONALE LEGGE NAZIONALE<br />
Costituzione spagnola (Preambolo,<br />
artt. 9.2 e 14)<br />
La Costituzione spagnola non riconosce<br />
formalmente né definisce le<br />
minoranze etniche. Come dichiarato<br />
nel Preambolo, essa riconosce e<br />
tutela tutti i popoli della Spagna e<br />
le rispettive culture, tradizioni, lingue<br />
e reciproca solidarietà.<br />
Non esiste, inoltre, alcuna istituzione<br />
o agenzia statale o governativa<br />
competente in materia di minoranze.<br />
* I dati sono stati tratti dal Rapporto sull’attuazione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali e dalla pubbli-<br />
cazione “Le minoranze in Europa” di Christoph Pan e Beate Sibylle Pfeil.
Paese: SVEZIA<br />
MINORANZE PRESENTI CONSISTENZA NUMERICA *<br />
FINNI 516.000<br />
La consistenza numerica del gruppo<br />
finnico in Svezia, da poco dichiarato<br />
minoranza nazionale, è<br />
calcolata fra le 75.000 e le 225.000<br />
unità, numero nel quale dovrebbero<br />
essere compresi anche circa<br />
30.000 careliani (Associazione dei<br />
careliani 1996: 626). Le autorità<br />
svedesi qualche tempo fa parlavano<br />
di 25.000 finni, oltre ai quali andavano<br />
considerati i circa 190.000<br />
finni temporaneamente immigrati<br />
per motivi di lavoro con le loro famiglie<br />
(Consiglio d’Europa 1994°:<br />
126). Ora invece il governo ritiene<br />
che vi siano circa 450.000 finni di<br />
prima o seconda generazione in<br />
Svezia, di cui la metà usa il finno.<br />
La maggior parte dei finni è immigrata<br />
dopo la seconda guerra<br />
mondiale. Il culmine si è raggiunto<br />
nel 1970, poi il numero degli immigrati<br />
è regredito (Rapporto svedese<br />
2001: 42 e seg.). Vi sono inoltre<br />
i circa 66.000 finni tornedali, riconosciuti<br />
come minoranza a parte e<br />
denominati dalla valle del fiume<br />
Torne, il quale scorre non lontano<br />
dalla frontiera fra Svezia e Finlandia.<br />
Circa 50.000 di questi parlano<br />
il dialetto finnico tornedale [chiamato<br />
Meänkieli], mentre 16.000<br />
parlano il finno standard o perché<br />
vivono in zone nelle quali esso è<br />
parlato in maggioranza o perché<br />
sono insediati nella valle da poco<br />
tempo (Rapporto svedese 2001:<br />
43) (Fonte: “Le minoranze in Europa”<br />
di Christoph Pan e Beate Sibylle<br />
Pfeil)<br />
ROM 35.000-40.000<br />
Di questi circa 2.500 sono chiamati<br />
Rom svedesi, immigrati in Svezia<br />
alla fine del XIX secolo, 3.200 sono<br />
detti Rom Finni, giunti nel paese<br />
all’inizio del XVI secolo e poi transitati<br />
nell’attuale Finlandia ed infine<br />
circa 10.000 Rom non nordici,<br />
provenienti da paesi dell’Est, tra<br />
cui la Polonia tra la fine degli anni<br />
’60 e l’inizio degli anni ’70. A questi<br />
si aggiunge un altro gruppo originario<br />
della ex Jugoslavia insediatosi<br />
di recente.Attualmente si stima<br />
che il numero dei Viaggiatori ammonti<br />
a circa 20.000 unità.<br />
147<br />
TUTELA GIURIDICA<br />
COSTITUZIONALE LEGGE NAZIONALE<br />
* I dati sono stati tratti dal Rapporto sull’attuazione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali e dalla pubbli-<br />
cazione “Le minoranze in Europa” di Christoph Pan e Beate Sibylle Pfeil.
EBREI 25.000 Città di Stoccolma,<br />
Gothenburg e Malmö. Altre comunità<br />
indipendenti sono presenti località<br />
come Borås, Västerås, Helsingborg,<br />
Lund e Norrköpin.<br />
SAMI 15.000-20.000 (Stime ufficiali)<br />
20.000-25.000 (Stima non ufficiale<br />
riportata nel testo “Minoranze in<br />
Europa” a cura di Christoph Pan e<br />
Beate Sibylle Pfeil. E’ presente<br />
lungo la fascia costiera centrale e<br />
settentrionale, nonché nell’area di<br />
Stoccolma.<br />
STRANIERI 595.000<br />
148
Paese: SVIZZERA<br />
MINORANZE PRESENTI CONSISTENZA NUMERICA *<br />
MINORANZE<br />
VIAGGIATORI (Jenis, Sinti) 25.000-30.000<br />
In Svizzera la Convenzione-quadro<br />
può essere applicata anche ad altri<br />
gruppi minoritari della popolazione,<br />
come i viaggiatori.<br />
La comunità nomade conta da<br />
25.000 a 30.000 appartenenti. Gli<br />
Jenis formano il gruppo più numeroso<br />
di viaggiatori di nazionalità<br />
svizzera, sebbene ne esistano altri<br />
sul territorio, in genere appartenenti<br />
al gruppo Sinti (Manouche). La<br />
maggior parte dei viaggiatori è divenuta<br />
stanziale, in particolare a<br />
seguito dell’azione “Enfants de la<br />
grande route”. Il nomadismo resta,<br />
comunque, uno degli elementi che<br />
costituiscono l’identità culturale di<br />
queste popolazioni; esso è direttamente<br />
correlato allo svolgimento<br />
delle loro varie e redditizie occupazioni.<br />
Si stima che attualmente<br />
siano circa 4.000 o 5.000 i viaggiatori<br />
che conducono una vita nomade<br />
o seminomade.<br />
149<br />
TUTELA GIURIDICA<br />
COSTITUZIONALE LEGGE NAZIONALE<br />
Non esistono specifiche norme a<br />
tutela delle minoranza. Le minoranze,<br />
tuttavia, sono indirettamente<br />
tutelate dal sistema politico e dalla<br />
garanzia di non discriminazione dei<br />
loro diritti costituzionali. Inoltre,<br />
alcune libertà costituzionali assumono<br />
particolare importanza in<br />
materia di tutela delle minoranze,<br />
come ad esempio la libertà linguistica<br />
e la libertà di coscienza e di<br />
credo.<br />
Infine, occorre notare che anche<br />
alcune costituzioni cantonali fanno<br />
riferimento al concetto di minoranza.<br />
La Costituzione di Berna, ad<br />
esempio, prevede che sia tenuto<br />
conto delle esigenze proprie delle<br />
minoranze linguistiche, culturali e<br />
regionali e che, a tal fine, sia prevista<br />
la possibilità di assegnare a<br />
quest’ultime specifiche competenze.<br />
* I dati sono stati tratti dalla pubblicazione “Le minoranze in Europa” di Christoph Pan e Beate Sibylle Pfeil.<br />
Dal momento che la Convenzione-quadro<br />
non contiene una definizione<br />
di minoranza nazionale,<br />
la Svizzera ha presentato una<br />
dichiarazione al momento del<br />
deposito dello strumento di ratifica,<br />
in cui fornisce la propria interpretazione<br />
del concetto di minoranza<br />
nazionale. In sostanza,<br />
la dichiarazione si basa sulle<br />
proposte presentate dai gruppi di<br />
lavoro a livello internazionale e<br />
recita come segue: ”La Svizzera<br />
dichiara che sul proprio territorio<br />
le minoranze nazionali, nel significato<br />
della Convenzione-quadro,<br />
sono gruppi di individui numericamente<br />
inferiori al resto della<br />
popolazione del paese o di un<br />
cantone, i cui appartenenti sono<br />
cittadini svizzeri, con antichi, durevoli<br />
e solidi legami con la Svizzera<br />
e sono guidati dalla volontà<br />
di preservare insieme ciò che<br />
costituisce la propria identità<br />
comune, in particolare la propria<br />
cultura, le proprie tradizione, la<br />
propria religione o la propria lingua”.<br />
Da tale definizione appare che la<br />
Convenzione-quadro possa applicarsi<br />
in Svizzera non solo alle<br />
minoranze linguistiche, ma anche<br />
ad altri gruppi minoritari della<br />
popolazione, come gli appartenenti<br />
alla comunità ebrea ed i<br />
viaggiatori. Ogni appartenente<br />
ad una minoranza nazionale ha il<br />
diritto di scegliere liberamente se<br />
essere trattato o meno come<br />
tale. Ogni persona interessata è<br />
autorizzata a decidere se desidera<br />
o meno godere della tutela<br />
prevista dalla Convenzionequadro.<br />
Ciò, tuttavia, non implica<br />
il fatto che un individuo sia libero<br />
di scegliere arbitrariamente di<br />
appartenere ad una qualsiasi<br />
delle minoranze nazionali. La<br />
formulazione data dalla Convenzione-quadro<br />
(“ogni appartenente<br />
ad una minoranza nazionale”)<br />
mostra che non si tratta di riconoscere<br />
un diritto di libera scelta,<br />
ma piuttosto che il desiderio di<br />
essere identificato con una minoranza<br />
nazionale debba basarsi<br />
su prove oggettive.<br />
Giova notare che la dichiarazione<br />
fatta dalla Svizzera al momento<br />
della ratifica della Convenzione-quadro<br />
stabilisce una<br />
correlazione tra lo status di minoranza<br />
nazionale e la cittadinanza.<br />
Di conseguenza, un individuo<br />
privo della cittadinanza
EBREI 18.000<br />
COMUNITA’ LINGUISTICHE<br />
SVIZZERI TEDESCHI 4.131.027<br />
ROMANDI 1.155.683<br />
ITALIANI 229.090<br />
ROMANCI 38.454<br />
150<br />
svizzera non può invocare la<br />
speciale tutela concessa ad ogni<br />
appartenente ad una minoranza<br />
nazionale; in simili casi, tuttavia,<br />
l’individuo è tutelato dall’articolo<br />
27 del Patto delle Nazioni Unite<br />
sui Diritti Civili e Politici.
Paese: UCRAINA<br />
MINORANZE PRESENTI CONSISTENZA NUMERICA *<br />
RUSSI 11.355.582<br />
EBREI 487.005<br />
RUMENI/MOLDAVI 459.350<br />
BIELORUSSI 440.045<br />
BULGARI 233.800<br />
POLACCHI 219.179<br />
UNGHERESI 163.111<br />
TATARI/TATARI DI CRIMEA 133.682<br />
GRECI 98.594<br />
ARMENI 54.200<br />
ROM 47.917<br />
TEDESCHI 37.849<br />
AZERI 36.961<br />
GAGAUZI 31.967<br />
GEORGIANI 23.540<br />
CIUVASSI 20.395<br />
UZBECHI 20.333<br />
MORDVINI 19.332<br />
LITUANI 11.278<br />
CAZACHI 10.505<br />
CECHI 9.122<br />
SLOVACCHI 7.943<br />
KARAIME 1.404<br />
ALTRI 109.887<br />
* I dati sono stati tratti dalla pubblicazione “Le minoranze in Europa” di Christoph Pan e Beate Sibylle Pfeil.<br />
151<br />
TUTELA GIURIDICA<br />
COSTITUZIONALE LEGGE NAZIONALE<br />
Secondo la Costituzione ucraina il La legislazione nazionale non<br />
“popolo ucraino” si compone “dei contiene l’elenco dei gruppi di<br />
cittadini dell’Ucraina di ogni nazio- cittadini appartenenti alle minalità.<br />
Riconoscendo la sovranità e noranze nazionali. All’art. 3<br />
la potestà del popolo ucraino nella della legge sulle minoranze<br />
sua multietnicità la Costituzione nazionali in Ucraina si afferma<br />
definisce implicitamente le compo- che “In Ucraina i gruppi di citnenti<br />
strutturali della società ucraitadini di altra nazionalità ena<br />
– la nazione ucraina, le minosprimono tra loro il senso coranze<br />
nazionali e le popolazioni mune di autoconsapevolezza,<br />
indigene – affidando allo Stato il di comunità e di appartenenza<br />
compito di promuovere lo sviluppo a minoranze nazionali”.<br />
della loro identità etnica, culturale, In base ai dati raccolti attra-<br />
linguistica e religiosa (art. 11 ). verso il censimento del 1989,<br />
le nazionalità presenti sul territorio<br />
del paese sono 130.<br />
L’ordinamento nazionale prevede<br />
che “i cittadini appartenenti<br />
a minoranze nazionali<br />
sono liberi di scegliere come<br />
esercitare i diritti riconosciuti<br />
loro dalle leggi vigenti sia individualmente<br />
che attraverso<br />
propri organismi statali ed associazioni<br />
pubbliche” (art. 13<br />
della Legge dell’Ucraina)
Paese: UNGHERIA<br />
MINORANZE PRESENTI CONSISTENZA NUMERICA *<br />
BULGARI 3.000-3.500<br />
ROM 400.000-600.000<br />
GRECI 4.000-4.500<br />
CROATI 80.000-90.000<br />
POLACCHI 10.000<br />
TEDESCHI 200.000-220.000<br />
ARMENI 3.500-10.000<br />
RUMENI 25.000<br />
RUTENI 6.000<br />
SERBI 5.000-10.000<br />
SLOVACCHI 100.000-110.000<br />
SLOVENI 5.000<br />
UCRAINI 2.000<br />
* I dati sono stati tratti dalla pubblicazione “Le minoranze in Europa” di Christoph Pan e Beate Sibylle Pfeil.<br />
152<br />
TUTELA GIURIDICA<br />
COSTITUZIONALE LEGGE NAZIONALE<br />
Con Decreto Governativo<br />
34/1990 (VIII.30.), l’Ungheria<br />
ha istituito l’Ufficio per le Minoranze<br />
Etniche e Nazionali, avente<br />
il compito specifico di<br />
coordinare tutte le attività del<br />
<strong>Governo</strong> connesse alle tematiche<br />
afferenti i gruppi minoritari<br />
presenti nel paese. Si tratta di<br />
un organismo pubblico indipendente,<br />
competente per<br />
l’intero territorio nazionale ed<br />
operante sotto la supervisione<br />
del Ministro della Giustizia.<br />
- Legge sulle Minoranze del<br />
1993.<br />
Secondo le disposizioni della<br />
citata legge, ogni individuo ha<br />
il diritto esclusivo ed inalienabile<br />
di scegliere di appartenere<br />
ad un gruppo o minoranza etnico/a<br />
o nazionale e di dichiararlo.<br />
Analogamente, il diritto<br />
all’identità nazionale o etnica e<br />
la scelta di appartenere ad una<br />
minoranza non escludono il<br />
riconoscimento di una o più<br />
affiliazioni. Tale legge, inoltre,<br />
stabilisce che, nel censimento<br />
nazionale, i cittadini appartenenti<br />
a minoranze nazionale o<br />
etniche hanno il diritto alla<br />
riservatezza della loro dichiarazione<br />
di appartenenza a simili<br />
gruppi.
L’INTEGRAZIONE: ASPETTI GENERALI<br />
153
NATURA E CONCETTO DI INTEGRAZIONE<br />
Il nostro mondo, duramente provato da varie esperienze avverte oggi, ancora di più,<br />
che le istanze di realizzazione della civile convivenza, che è la base della democrazia, devono<br />
penetrare, addirittura, negli animi e trasformarsi in intima convinzione, per non usare termini più<br />
sonori, ma forse meno efficaci, come quelli di ideale o di fede.<br />
L’uomo contemporaneo deve capire che, in un mondo globalizzato, come il nostro attuale,<br />
la civica convivenza e la cooperazione sociale dipendono soprattutto dalle capacità di rispetto<br />
e tolleranza reciproche insite in ciascuno di noi (certamente educato a determinati valori).<br />
L’uomo contemporaneo deve cioè convincersi che l’autorità non può essere delegata<br />
completamente alle istituzioni, ma che risiede anche in ciascuno di noi ed implica, soprattutto<br />
responsabilità e dovere di contribuire al benessere comune.<br />
Oggi nel nostro mondo così globalizzato ed interessato da continui e sempre più forti<br />
flussi migratori dal sud e oriente del mondo, verso nord e occidente, la responsabilità per la civica<br />
convivenza ed il dovere di contribuire al benessere comune passano attraverso i concetti di<br />
accoglienza dell’altro e del diverso.<br />
E’ un processo di continua integrazione che non è una terza via tra assimilazione e inserzione;<br />
si tratta di un processo specifico capace di suscitare la partecipazione alla società nazionale<br />
di elementi diversi accettandone la permanenza di specificità culturali, sociali e morali.<br />
E’ l’insieme della società che si arricchisce con questa complessa varietà grazie<br />
all’integrazione.<br />
Integrazione è un termine ricco di implicazioni che contempla non solo il riconoscimento<br />
allo straniero dei diritti primari politici al lavoro, alla casa, all’istruzione, ma anche una sostanziale<br />
accettazione, una condizione di parità nel rispetto della differenza.<br />
L’integrazione è quindi un processo specifico in divenire che non deve negare le differenze<br />
ma nemmeno esaltarle: è sulla rassomiglianza e sulle convergenze che una politica di integrazione<br />
deve mettere l’accento.<br />
In questa prospettiva, l’integrazione non è un obbligo esclusivo degli stranieri, ma è la<br />
via che tutta la società (autoctoni e stranieri) deve percorrere se si accettano le dinamiche della<br />
relazione interculturale che produce sempre nuove identità.<br />
L’incontro, il conf ronto e lo scambio ci cambiano e ci f anno ev olvere<br />
tutti: autoctoni ed immigrati.<br />
L’INTEGRAZIONE DIFFICILE DEGLI IMMIGRATI IN EUROPA<br />
Studi approfonditi hanno evidenziato come il fenomeno immigratorio dal punto di vista<br />
sociale non si presenti monodimensionale e unitario, ma correlato ad almeno quattro differenti<br />
processi o dinamiche:<br />
l’integrazione sociale comprendente l’acquisto di status e ruoli all’interno del paese ospitante;<br />
l’inclusione sociale, in tema di protezione;<br />
l’adattamento culturale;<br />
la responsabilizzazione degli immigrati nei confronti del Paese di origine.<br />
Tale considerazione consente una visione maggiormente prospettica e a più ampio<br />
raggio del fenomeno migratorio ed evidenziano che se da un lato gli immigrati spesso hanno<br />
difficoltà di inserimento sociale e di acquisizione di status, dall’altro c’è la tendenza a realizzarsi,<br />
sviluppando forme autonome d’imprenditorialità ed altre forme di autorganizzazione tese a sopperire<br />
alla presenza della parte pubblica.<br />
Da tutto ciò si evidenzia una mancanza di linearità e coerenza degli itinerari<br />
d’integrazione degli immigrati con situazioni di stallo prolungate, di regressioni improvvise e forti<br />
dislivelli nel grado d’inserimento nei differenti contesti sociali.<br />
155
L’IMMIGRAZIONE TRA CITTADINANZA NEGATA E INCERTEZZA DELLA SITUAZIONE<br />
IMMIGRATORIA IN EUROPA<br />
Al di là delle strategie politiche in tema di immigrazione, da parte dei governi dei singoli<br />
Stati, si evidenziano aree d’emarginazione e sofferenze comuni agli immigrati extracomunitari in<br />
Europa.<br />
Questo deficit non è senza conseguenze sia sui percorsi di vita degli immigrati, sia<br />
sull’impatto che la gestione dei processi migratori produce sulle società ospiti.<br />
Le conseguenze sono sia di ordine pubblico che di convivenza sociale e civile.<br />
Manca in sostanza un regime ordinario di gestione dei processi d’integrazione.<br />
D’altra parte gli immigrati, nel corso del processo d’inserimento nei paesi europei sperimentano<br />
oggi forme di spaesamento e di sofferenza che vanno spesso ben al di là del sopportabile,<br />
dando luogo spesso a fenomeni altalenanti di inserimento e d’emarginazione.<br />
Nonostante queste avverse condizioni gli immigrati mostrano tuttavia una marcata attitudine<br />
a non scoraggiarsi ed all’inserimento.<br />
In particolare si indicano alcuni fattori che favoriscono tutto ciò:<br />
un buon livello culturale;<br />
l’acquisizione di tratti delle culture europee sin dal periodo di residenza in patria;<br />
un notevole senso di autocontrollo;<br />
un ottimismo di fondo;<br />
la capacità di assorbire più culture differenti.<br />
Da ciò emerge che, complessivamente, il processo d’integrazione degli immigrati non è<br />
lineare né scontato, ma dipende da una molteplicità di fattori non ancora sufficientemente elaborati<br />
da chi opera e decide in questo contesto.<br />
PROSPETTIVE DI SVILUPPO DELL’INTEGRAZIONE<br />
Le prospettive degli sviluppi futuri dei flussi immigratori nei paesi europei richiedono una<br />
messa a punto di nuove strategie e politiche che tengano conto della nuova composizione sociale<br />
dei flussi stessi e della fenomenologia dell’integrazione.<br />
Appare evidente, dall’esame della situazione, come l’integrazione sia un processo già in<br />
atto dovuto anche spesso al buon grado di livello intellettuale degli immigrati stessi. Buon grado<br />
presente sia a livello individuale che a livello collettivo, grazie anche alla creazione di organizzazioni<br />
che favoriscono l’integrazione tramite la sperimentazione di attività imprenditoriali.<br />
In tale ottica mal si presenta una politica tesa alla “ghettizzazione degli immigrati”, vanno<br />
invece favorite tutte le opportunità tese all’integrazione degli immigrati stessi.<br />
Si riscontra una miriade di nuove esperienze, in tal senso, a livello locale segnalando<br />
altresì l’opportunità della creazione di un ambiente favorevole sul piano giuridico, dei finanziamenti<br />
della sensibilizzazione dell’opinione pubblica, ecc..<br />
Tutto ciò richiede una parziale riorganizzazione della società su diversi livelli:<br />
quello assistenziale;<br />
quello educativo;<br />
quello dell’assetto urbano;<br />
quello della rappresentanza politica;<br />
quello delle diversità culturali e religiosi.<br />
MISURE DI INTEGRAZIONE<br />
Con legge n. 189/2002 di riforma del testo unico sull’immigrazione, è stata introdotta la<br />
figura del contratto di soggiorno per lavoro, fondante l’integrazione del cittadino straniero sul reale<br />
inserimento nel mondo del lavoro.<br />
Lo scopo è quello d’inserire l’immigrato in un circuito di legalità, evitandone lo scivolamento<br />
nel mondo della criminalità organizzata.<br />
156
Ma sono altri i fattori di integrazione, oltre a quello del lavoro, atteso che gli immigrati<br />
non possono essere considerati come mera forza-lavoro, ma come cittadini a tutti gli effetti, titolari<br />
di diritti inalienabili, di relazioni affettive e familiari e di una cultura “altra” ma, proprio per<br />
questo, ricca di motivi di interesse.<br />
In tal senso, occorre sottolineare come la legge di riforma abbia mantenuto sostanzialmente<br />
inalterate le norme riguardanti l’integrazione sociale degli stranieri immigrati.<br />
In tal senso, la normativa sull’immigrazione, recependo la costituzione e le convenzioni<br />
internazionali, promuove la valorizzazione delle multiculturalità ma anche il rispetto per i principi<br />
ed i valori condivisi: rispetto per i diritti e la dignità dell’uomo, valutazione positiva del pluralismo,<br />
accettazione di tutta una serie di responsabilità.<br />
La normativa sull’integrazione si è preoccupata, infatti, di assicurare agli stranieri presenti<br />
nel nostro Paese basi di partenza equiparabili a quelle degli italiani nell’accesso a beni e<br />
servizi essenziali e, più in generale, a condizioni di vita decorose.<br />
Ad esempio, la L. 189/2002, in tema di centri di accoglienza e di accesso all’abitazione<br />
ha inserito all’art. 40, co. 1 del T.U., l’importante specificazione che l’accesso alle misure<br />
d’integrazione sociale è riservato agli stranieri extracomunitari che dimostrino di essere in regola<br />
con le norme di soggiorno in Italia.<br />
Altri diritti riconosciuti agli immigrati regolarizzati sono in materia previdenziale, di maternità<br />
e d’infanzia, di alloggio, di assistenza sociale e di diritto allo studio.<br />
Viceversa, l’assistenza sanitaria ed il diritto-dovere all’istruzione obbligatoria sono riconosciuti<br />
a tutti, anche se irregolari, in quanto presenti a qualunque titolo sul territorio.<br />
In particolare, l’art. 42, co. 1 del T.U. delinea l’azione dello Stato e degli Enti pubblici territoriali,<br />
in collaborazione con le associazioni di settore e con le autorità e gli enti pubblici e privati<br />
dei paesi d’origine, azione tesa a rendere effettiva un’armonica integrazione sociale.<br />
In particolare, Stato ed altri Enti pubblici sono chiamati a favorire:<br />
1. attività e collaborazione con scuole ed istituti culturali stranieri legalmente funzionanti nel<br />
nostro Paese;<br />
2. diffusione di tutte quelle informazioni tese all’inserimento degli immigrati (diritti-doveri, opportunità<br />
d’integrazione, ecc.);<br />
3. conoscenza e valorizzazione del panorama culturale-etnico-religioso degli stranieri, anche<br />
attraverso la raccolta presso biblioteche scolastiche ed universitarie di libri, periodici, materiale<br />
audiovisivo prodotti nella lingua originale dei paesi stranieri;<br />
4. realizzazione di convenzioni con associazioni registrate presso la Presidenza del Consiglio<br />
dei Ministri e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l’inserimento di stranieri regolarmente<br />
soggiornanti in qualità di mediatori interculturali;<br />
5. organizzazione di corsi di formazione ispirati a criteri di convivenza multiculturale e destinati<br />
agli operatori di organi ed uffici pubblici e di enti privati che hanno rapporti abituali con stranieri,<br />
o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione.<br />
E’ prevista, inoltre, un’azione coordinata tra Stato, Enti pubblici locali ed associazioni<br />
coinvolte, tesa alla formazione culturale, all’informazione, alla mediazione interculturale, alla<br />
prevenzione o rimozione di comportamenti discriminatori.<br />
A livello locale, l’art. 3, co. 6 del T.U. prevede i Consigli territoriali per l’immigrazione, in<br />
cui sono rappresentati le competenti amministrazioni territoriali dello Stato, gli enti e le associazioni<br />
attivi localmente nel soccorso e nell’assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori<br />
e dei datori di lavoro.<br />
A livello centrale, con funzione di coordinamento dei Consigli territoriali degli enti e delle<br />
associazioni di rilievo nel settore è prevista la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e<br />
delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato.<br />
La Consulta raccoglie ed elabora dati ed informazioni al fine di predisporre un documento<br />
programmatico triennale sulla condizione degli immigrati e dello stato d’applicazione della<br />
normativa in materia d’immigrazione.<br />
Della Consulta fanno parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:<br />
almeno 10 rappresentanti d’associazioni ed enti presenti nell’organismo nazionale di coordinamento<br />
istituito presso il C.N.E.L. e/o impiegati nel settore dell’immigrazione;<br />
almeno 6 esponenti di associazioni più rappresentative di stranieri extracomunitari operanti<br />
sul territorio;<br />
157
4 rappresentanti di associazioni sindacali dei lavoratori;<br />
3 rappresentanti di associazioni sindacali dei datori di lavoro;<br />
8 rappresentanti delle autonomie locali;<br />
8 esperti designati dai seguenti Ministeri: lavoro e politiche sociali, istruzione, interno, giustizia,<br />
affari esteri, finanze e dal Dipartimento delle pari opportunità;<br />
due rappresentanti del C.N.E.L.;<br />
esperti in problematiche dell’immigrazione (in numero non superiore a dieci unità).<br />
L’art. 42, co. 6 del T.U. attribuisce inoltre alle Regioni la facoltà d’istituire consulte regionali<br />
per i problemi dei lavoratori stranieri e delle loro famiglie.<br />
Il C.N.E.L., nell’ambito delle proprie attribuzioni svolge attività di studio e di ricerca tesa<br />
all’inserimento degli immigrati nella vita pubblica ed alla circolazione delle informazioni<br />
sull’applicazione della normativa in materia.<br />
Nell’ambito del C.N.E.L. (art. 42, co. 3 T.U.) è poi previsto un ulteriore organismo nazionale<br />
di coordinamento finalizzato ad elaborare iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che<br />
impediscono l’effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero.<br />
Tale organismo opera in sinergia con la Consulta dei problemi degli stranieri immigrati e<br />
delle loro famiglie, con i Consigli territoriali per l’immigrazione, con i centri di osservazione, informazione,<br />
assistenza legale contro le discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose,<br />
con le istituzioni e gli altri organismi impegnati nelle politiche d’immigrazione a livello locale, al<br />
fine di accompagnare e sostenere lo sviluppo dei processi locali d’accoglienza e d’integrazione<br />
dei cittadini stranieri, la loro rappresentanza e partecipazione alla vita pubblica.<br />
Inoltre lo Stato e gli altri Enti pubblici sono chiamati ad adottare, nelle materie di propria<br />
competenza, programmi annuali e pluriennali indicanti le iniziative pubbliche, private prioritarie<br />
per il finanziamento da parte del Fondo nazionale per le politiche migratorie.<br />
Tale fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ex art. 45 del T.U. è<br />
costituito dalle somme derivanti da contributi e donazioni di privati, enti, organizzazioni anche<br />
internazionali, da organismi dell’Unione Europea ed è destinato al finanziamento di diverse iniziative<br />
in ambito migratorio.<br />
Il nostro ordinamento tutela le differenze come valore e ricchezza, riconoscendo i diritti<br />
inviolabili dell’uomo ed affermando il diritto di tutti all’uguaglianza di trattamento.<br />
L’art. 43 del T.U., già profila come discriminazione ogni azione od omissione che direttamente<br />
od indirettamente sia causa di distinzione, esclusione, restrizione e preferenza basate<br />
su razza, colore, etnia, convinzione o pratica religiosa.<br />
L’illiceità del comportamento si manifesta allorché viene lesa la parità del soggetto immigrato<br />
nei confronti degli altri cittadini in tema di diritti umani e libertà fondamentali nei vari<br />
campi della vita pubblica (politica, economica, sociale e culturale).<br />
Non occorre dunque l’elemento soggettivo per il perfezionarsi della fattispecie discriminatoria,<br />
è sufficiente il fatto, cioè la dimostrazione dell’oggettiva disparità di trattamento.<br />
Principio base della tutela ex artt. 43 e 44 del T.U. è che lo status riconosciuto al cittadino<br />
straniero non può mai essere inferiore a quello riconosciuto al cittadino italiano o comunitario.<br />
Altra fonte in tema di lotta alla discriminazione è la direttiva del Consiglio dell’U.E. n.<br />
2000/43/CE del 29 luglio 2000 che si propone l’attuazione del principio di parità di trattamento,<br />
stabilendo un quadro per la lotta alla discriminazione fondata sulla razza e sull’origine etnica.<br />
La direttiva ha il fine di assicurare lo sviluppo di società democratiche e tolleranti che<br />
consentano la partecipazione attiva di tutte le persone, in omaggio a quel diritto all’uguaglianza<br />
dinanzi alla legge ed alla protezione contro le discriminazioni riconosciuto, fra gli altri, dalla Dichiarazione<br />
dei Diritti dell’Uomo, dalla Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le<br />
forme di discriminazione razziale, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti<br />
dell’Uomo e delle libertà fondamentali.<br />
L’adeguamento degli Stati membri dovrà avvenire entro il 19 luglio 2003.<br />
La tutela prevista dal Testo Unico sull’immigrazione è già allineata alla direttiva.<br />
Un’altra forma di tutela è prevista dall’art. 44 del T.U. che prevede che il soggetto discriminato<br />
sia da un privato che da una P.A. possa, anche senza l’assistenza di un legale, presentare<br />
ricorso al Tribunale del luogo del suo domicilio per ottenere, in via d’urgenza,<br />
158
l’emanazione di un provvedimento che ordini la cessazione del comportamento pregiudizievole,<br />
la rimozione dei relativi effetti e l’eventuale riconoscimento del danno anche non patrimoniale.<br />
Un’altra misura di tutela è prevista dall’art. 44, co. 10 del T.U., secondo cui le rappresentanze<br />
locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale<br />
possono ricorrere contro atti o comportamenti discriminatori di carattere collettivo anche laddove<br />
non sono direttamente ed immediatamente individuabili i singoli lavoratori lesi dalle discriminazioni.<br />
Nel caso di accoglimento del ricorso, il giudice, nella sentenza che accerta la discriminazione,<br />
ordina al datore di lavoro di definire un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.<br />
Per rafforzare le norme contro la discriminazione, l’art. 44, co. 12 del T.U. predispone<br />
centri d’osservazione, d’informazione e d’assistenza legale per gli stranieri vittime di discriminazioni<br />
da realizzarsi a cura delle regioni in collaborazione con Provincia, Comune, associazioni<br />
d’immigrati e volontariato sociale.<br />
POLITICHE CULTURALI E SOCIETA’ MULTICULTURALE<br />
La diversità culturale, in tutte le sue forme, mette seriamente in discussione le tradizionali<br />
formulazioni delle politiche culturali e dell’istruzione nonché la nostra concezione di interesse<br />
pubblico che tali politiche devono sostenere. In molti paesi il paesaggio culturale non si è evoluto<br />
in maniera tale da riflettere le realtà di un ambiente sociale modificato. Questa spaccatura<br />
rischia di delegittimare le istituzioni culturali e la politica pubblica che le sostiene. Il passaggio<br />
dalla omogeneità alla diversità come nuova norma sociale impone un ripensamento dei processi,<br />
dei meccanismi e dei rapporti necessari ai fini di uno sviluppo democratico delle politiche in<br />
diversi settori, soprattutto nell’area del Mediterraneo.<br />
Il “pluralismo culturale” non è sufficiente per la creazione di una società solidale. Esiste<br />
la necessità di attuare una piattaforma di politiche che, affrontando la complessa rete di fattori<br />
socio-culturali, abbia l’obiettivo di risolvere i problemi derivanti dalla diversità culturale: politiche<br />
culturali che promuovano il rispetto reciproco e la solidarietà sulla base di bisogni comuni.<br />
Le politiche dell’istruzione svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere i valori della<br />
libertà individuale, delle istituzioni democratiche e della risoluzione pacifica dei conflitti: esse<br />
dovrebbero costituire un mezzo per trasformare le condizioni socio-culturali e per promuovere la<br />
comprensione reciproca.<br />
Ovviamente nell’era della globalizzazione la diversità culturale e le società multiculturali<br />
sono un fatto scontato. Benché le migrazioni di popolazioni da paesi in via di sviluppo a paesi<br />
sviluppati stiano aumentando, esistono migrazioni imponenti anche all’interno dei paesi in via di<br />
sviluppo, pertanto gli Stati, le società civili e le organizzazioni internazionali rivestono ruoli egualmente<br />
importanti nel dialogo multiculturale e interculturale. Attualmente l’identità culturale si<br />
è molto accentuata ed è pertanto molto importante allontanarsi dai conflitti culturali e avvicinarsi<br />
a delle modalità negoziali di dialogo interculturale.<br />
IL GRADO DI INSERIMENTO DEGLI IMMIGRATI NELLE DIVERSE AREE ITALIANE<br />
In linea di massima, si può affermare che, in merito al grado di inserimento degli immigrati<br />
nel tessuto socio-economico del Paese, si riscontrano essenzialmente due realtà: l’area<br />
settentrionale e quella meridionale-insulare, ancora marcatamente distinte fra loro, mentre il<br />
Centro (tradizionalmente zona d’insediamento stabile, e infatti la provincia della Capitale vede<br />
ancora oggi il maggiore insediamento di stranieri rispetto a tutte le altre province italiane) va visto<br />
essenzialmente come area di passaggio e smistamento verso il più promettente Nord Italia.<br />
Ancora si registrano, infatti, consistenti flussi migratori sulle coste meridionali del Paese,<br />
dove, accanto alle tradizionali rotte mediterranee (Albania ed ex Jugoslavia) si stanno affermando<br />
quelle provenienti dall’Africa meridionale (Libia ed Egitto) e dal Medio Oriente (Turchia).<br />
Dal Meridione, zona di primo ingresso, gli immigrati puntano essenzialmente a Nord:<br />
anzitutto il Nord-Ovest, direttrice tradizionale di migrazione e conosciuta fin da quando gli stessi<br />
italiani del meridione vi si riversavano in massa per ragioni di lavoro e poi verso la nuova diret-<br />
159
trice del Nord-Est, nuovo polo d’attrazione costituito dalle regioni orientali del settentrione italiano,<br />
la cui economia, basata sulla piccola e media impresa, ne ha fatto uno dei centri di reddito<br />
più ricchi d’Europa, innalzando di conseguenza la richiesta di manodopera nel locale mercato<br />
occupazionale.<br />
Emerge, da tutto ciò, come gli immigrati che dal Sud Italia vanno cercando una sistemazione<br />
più sicura al nord, non fanno altro che ripercorrere i medesimi itinerari che i nostri connazionali<br />
tracciarono per le medesime ragioni al tempo delle consistenti migrazioni interne, riproponendo<br />
ancor oggi (sebbene in forme e con diversi protagonisti) l’antico ed irrisolto problema<br />
della “questione meridionale”.<br />
Ciò posto, non mancano situazioni locali di felice eccezione: al Centro, infatti, abbiamo il<br />
Lazio, una realtà in grado di offrire ancora reali possibilità d’insediamento stabile, ma vi sono<br />
anche le Marche e la Toscana ad offrire e costituire per diversi immigrati luoghi di radicamento<br />
ormai definitivo nel nostro Paese.<br />
LA SITUAZIONE MIGRATORIA AL NORD<br />
Il Nord, con oltre la metà delle presenze (54,8%) risulta essere l’area a più intenso insediamento<br />
di immigrati: i circa 925.000 soggiornanti si distribuiscono per il 56,9% nel nordovest<br />
(526.698) e per il 43,1% nel nord-est (398.278).<br />
Si conferma in tal modo la grande capacità di attrazione che tutta l’area esercita sugli<br />
immigrati, in vista di un progetto migratorio a medio e lungo termine che trova evidentemente<br />
qui più che altrove le condizioni più probabili e favorevoli di riuscita.<br />
Occorre peraltro distinguere che, mentre per il nord-ovest si tratta per lo più di migrazione<br />
direttamente proveniente dall’estero, nell’area nord-orientale giungono in misura relativamente<br />
maggiore stranieri che hanno già fatto ingresso nel Paese, probabilmente da qualche regione<br />
meridionale, e che una successiva migrazione interna indirizza verso questo più promettente<br />
territorio nord-orientale.<br />
La comunità più presente risulta essere il Marocco, con una media di un soggiornante<br />
ogni sette e sempre prima in tutte le regioni, tranne che in Trentino (Germania) e Friuli (USA,<br />
soprattutto per la presenza della base militare di Aviano).<br />
La presenza femminile (336.000), poco più del 44% di tutti i soggiornanti, incide per<br />
quasi due punti percentuali in meno rispetto alla media nazionale, con una leggera flessione<br />
della presenza soprattutto nel nord-est (43,8%), mentre in tutta l’area risulta essere notevole la<br />
presenza di stranieri in giovane età; sono circa 170.000 i minori residenti, il 61,1% di tutti quelli<br />
presenti in Italia ed un quinto di tutti i residenti stranieri del nord, con un’incidenza maggiore di<br />
un punto e mezzo nel nord-est ed un tasso di scolarizzazione (55,8% nel nord-ovest e 56,6%<br />
nel nord-est) generalmente superiore alla media italiana (53%).<br />
Quanto all’appartenenza religiosa, nel nord-ovest un immigrato su tre è cattolico, uno su<br />
quattro è di un’altra confessione cattolica, oltre uno su tre è musulmano, mentre uno su dodici<br />
appartiene ad altre religioni.<br />
Nel nord-est, invece, è cattolico uno straniero su cinque, è altro cristiano ma non cattolico<br />
oltre uno su quattro, è musulmano ancora uno ogni quattro, mentre oltre un quarto si riconosce<br />
in altre religioni.<br />
Dai dati, globalmente si evince un più antico e tradizionale insediamento nel nord-ovest,<br />
ma anche la tendenza ad un rapido allineamento della zona nord-orientale, in termini di stabilità<br />
dell’insediamento, rispetto alla maggiormente assestata zona nord occidentale.<br />
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGIO E ASSISTENZA SOCIALE<br />
La casa è un bene essenziale per tutti perché soddisfa alcune delle fondamentali esigenze<br />
della persona.<br />
Tuttavia la Costituzione non prevede un vero e proprio riconoscimento di un diritto alla<br />
casa, ma si ritiene che ciò rientri nella previsione dell’art. 2 laddove si fa riconoscimento ai diritti<br />
inviolabili dell’Uomo. Quello della casa è un ambito che coinvolge la salute, la dignità, l’unità<br />
familiare e l’infanzia.<br />
160
Il delicato tema dell’accesso all’abitazione per gli immigrati s’innesta sul più ampio tema<br />
delle politiche d’integrazione. Purtroppo la situazione abitativa degli immigrati nel nostro Paese<br />
è contraddistinta da una situazione di povertà, che si manifesta spesso in forme estreme.<br />
La legge, all’art. 7, comma 2 bis T.U., prevede l’obbligo di denuncia all’autorità di pubblica<br />
sicurezza da parte di chiunque dà alloggio ovvero cede un immobile in godimento ad uno<br />
straniero.<br />
Il T.U. sull’immigrazione, all’art. 43, comma 2, lett. c), vieta il comportamento discriminatorio<br />
da parte di chi impone allo straniero condizioni più svantaggiose o si rifiuta di fornire<br />
l’accesso all’alloggio allo straniero regolarmente soggiornante in ragione della sua condizione di<br />
straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità. Contro<br />
questo tipo di atti di discriminazione è prevista una specifica tutela giurisdizionale: l’azione civile<br />
contro la discriminazione ex art. 44 del T.U.<br />
Uno dei requisiti di validità per la stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato<br />
ex L. 189/2002 è la garanzia da parte del datore di lavoro di un alloggio a beneficio del lavoratore<br />
che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale<br />
pubblica.<br />
Questo è altresì uno dei requisiti indispensabili affinchè uno straniero possa ottenere<br />
per un proprio congiunto ex art. 29 T.U. un permesso di soggiorno per motivo familiare.<br />
Accesso all’abitazione<br />
In base alla L. 189/2002, l’efficacia dell’art. 40 del T.U. co. 1 bis l’accesso alle misure<br />
d’integrazione da parte di stranieri non comunitari è condizionato dalla regolarità degli stessi<br />
con le norme di soggiorno.<br />
Infatti solo la titolarità della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno almeno<br />
biennale e lo svolgimento di una regolare attività lavorativa autonoma o subordinata danno il diritto<br />
all’immigrato di accedere in parità con i cittadini italiani all’edilizia residenziale pubblica e a<br />
tutte quelle operazioni connesse con l’assegnazione di un alloggio pubblico (art. 40 c. 6 T.U.).<br />
In base alla L. 189/2002 è stabilita la durata biennale del soggiorno parificando in tal<br />
modo i cittadini stranieri agli italiani nell’accesso agli alloggi pubblici.<br />
In attesa dell’assegnazione dell’alloggio pubblico in via definitiva lo straniero può accedere<br />
ad altre forme di alloggio alternativo quali alloggi sociali, collettivi o privati predisposti dalle<br />
regioni, dai comuni, dal volontariato sotto forma di pensionato con sistemazione a pagamento<br />
secondo quote calmierate (art. 40 c. 4 T.U.).<br />
Centri di accoglienza<br />
I centri di accoglienza sono strutture particolari di sostegno agli stranieri regolarmente<br />
soggiornati che offrono loro temporanea assistenza alloggiativa ed alimentare, e talora di apprendimento<br />
della lingua e di formazione professionale in attesa dell’integrazione e del raggiungimento<br />
dell’autonomia personale.<br />
I centri di accoglienza sono predisposti dalle regioni in collaborazione con gli altri enti<br />
pubblici locali e con le organizzazioni di volontariato (art. 40 c. 1 e 3 T.U.).<br />
Sempre in base all’art. 40 del T.U. il soggiorno deve essere temporaneo.<br />
Assistenza sociale<br />
Anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno nonché i minori iscritti nel loro titolo di<br />
soggiorno sono equiparati ai cittadini italiani nella fruizione di provvidenza e prestazioni anche<br />
economiche di assistenza sociale.<br />
La Legge n. 488/1999 ha inoltre introdotto per le donne straniere titolari di carta di soggiorno<br />
la possibilità di ottenere l’assegno di maternità corrisposto dai comuni alle donne che<br />
non beneficiano di alcuna tutela economica della maternità per ogni figlio nato dal 1° luglio 2000<br />
o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo.<br />
IMMIGRAZIONE E ISTRUZIONE<br />
Nel suo essere luogo di formazione, scambio, interazione e trasmissione di modelli culturali,<br />
la scuola gioca anche un ruolo strategico nell’integrazione degli immigrati, ponendo le ba-<br />
161
si di un’armonica convivenza e conferendo le abilità relazionali necessarie alla crescita e<br />
all’inserimento sociale.<br />
E’ da riscontrare un aumento progressivo del numero di alunni e studenti stranieri, segno<br />
di una tendenza al ricongiungimento dei nuclei familiari, di un accresciuto benessere socioeconomico<br />
e di un’anzianità d’insediamento.<br />
Le più recenti politiche educative, richiamando espressamente i diritti dell’uomo e del<br />
bambino, hanno teso al riconoscimento del valore delle culture originarie e a promuovere la cultura<br />
dei popoli.<br />
La normativa prevede, tra i suoi punti qualificanti:<br />
l’obbligo scolastico per tutti i minori stranieri presenti sul territorio a prescindere dalla regolarità<br />
della loro posizione rispetto alle norme sul soggiorno;<br />
la promozione di iniziative volte all’accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua<br />
d’origine;<br />
l’effettività del diritto allo studio;<br />
la parità di trattamento in materia d’accesso all’istruzione universitaria.<br />
Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale<br />
L’art. 38 del T.U. stabilisce la completa equiparazione di minori italiani e stranieri in materia<br />
d’istruzione di accesso ai servizi educativi e di partecipazione alla vita della comunità scolastica.<br />
Inoltre è previsto l’assoggettamento dei minori stranieri all’obbligo scolastico, a prescindere<br />
dalla regolarità della loro posizione in ordine al loro soggiorno (art. 45, co. 1 del d.P.R. n.<br />
394/99).<br />
L’iscrizione dei minori stranieri avviene nei modi e nelle condizioni previste per i minori<br />
italiani.<br />
L’iscrizione del minore straniero avviene nella classe corrispondente all’età anagrafica,<br />
tuttavia il collegio dei docenti può deliberare l’iscrizione ad una classe diversa tenendo conto sia<br />
dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza, sia della competenza, dell’abilità e dei<br />
livelli di preparazione dell’alunno e del titolo di studio eventualmente posseduto dallo stesso<br />
(art. 45, co. 2 d.P.R. n. 394/99).<br />
Onde favorire l’integrazione in modo omogeneo è prevista, da parte del collegio dei docenti<br />
un’equa ripartizione degli alunni stranieri nelle varie classi (art. 45, co. 3 d.P.R. n. 394/99)<br />
ed è previsto altresì l’ausilio di mediatori culturali qualificati per le comunicazioni scuola/famiglia<br />
(art. 45, co. 5 d.P.R. n. 394/99).<br />
Come è prevista l’incentivazione della conoscenza della lingua italiana, così sono previste<br />
azioni di promozione, accoglienza ed integrazione della cultura e delle lingue d’origine ed<br />
attività interculturali comuni in base all’art. 38 del T.U.<br />
Tali iniziative sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali e di una<br />
programmazione territoriale integrata anche in convenzione con le associazioni degli stranieri,<br />
con le rappresentanze diplomatiche o consolari dei paesi d’appartenenza e con le organizzazioni<br />
di volontariato.<br />
Peraltro l’attività d’integrazione di cui all’art. 38 del T.U. non è ad esclusivo beneficio dei<br />
minori alunni stranieri ma è prevista altresì anche a favore degli stranieri adulti regolarmente<br />
soggiornanti, art. 38, co. 5 T.U.<br />
Sono previste infatti convenzioni tra le Regioni e gli enti locali, attivazione di corsi<br />
d’alfabetizzazione primaria e secondaria, organizzazione di corsi in lingua italiana e tutte le altre<br />
iniziative di studio previste dall’ordinamento vigente anche nel quadro di accordi di collaborazione<br />
internazionale in vigore per l’Italia (art. 38, co. 5 T.U. e art. 45, co. 7, d.P.R. n. 394/99).<br />
Sono previsti anche programmi culturali varati dalle Regioni per i diversi gruppi nazionali<br />
presso le scuole superiori o gli istituti universitari e altresì sono previsti specifici insegnamenti<br />
integrativi nella lingua e cultura d’origine (art. 38, co. 6 T.U.).<br />
Permesso di soggiorno per motivi di studio<br />
Lo straniero che desideri seguire in Italia corsi universitari, di studio superiore o di formazione<br />
professionale presso istituti riconosciuti o qualificati, può ottenere, in base ad un valido<br />
visto per studio, un permesso di soggiorno a tempo indeterminato.<br />
In base al D.M. 12 luglio 2000 (all. A, n. 16), per l’ottenimento del visto occorrono:<br />
162
documentazione del corso di studio o formazione professionale;<br />
adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento;<br />
polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri;<br />
età maggiore di quattordici anni.<br />
Ciò posto, v iene rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di studio<br />
della durata non superiore ad un anno ma rinnov abile.<br />
Va sottolineato lo stretto legame tra permesso di soggiorno e corso di studi sicché il<br />
permesso stesso non può essere utilizzato per la frequenza di un corso diverso da quello originario.<br />
Fa eccezione l’ipotesi di un rilascio del permesso per corsi superiori e il soggetto intenda<br />
proseguire per un corso universitario, in tal caso, se sussistono i requisiti richiesti, può essere<br />
consentito l’ulteriore permanenza.<br />
Le istanze di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio dovranno essere il<br />
più possibile dettagliate ed essere corredate della documentazione relativa al corso di studio, la<br />
frequenza del quale è posta alla base della concessione del visto d’ingresso in favore dello<br />
straniero.<br />
Lo studente straniero può altresì svolgere concomitante attività lavorativa purché non<br />
superi le 1040 ore annuali.<br />
Il permesso di soggiorno per motivi di studio può essere convertito in permesso per motivi<br />
di lavoro entro i limiti delle quote di stranieri ammessi in Italia con decreto di programmazione<br />
annuale (art. 6, co. 1 T.U.) tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare<br />
riguardo all’inserimento di una quota di studenti stranieri, stipulando apposite intese con gli<br />
atenei stranieri, per la mobilità studentesca, nonché organizzando attività d’orientamento e<br />
d’accoglienza (art. 39, co. 2 T.U.).<br />
Accesso ai corsi delle Università<br />
In materia d’accesso all’istruzione universitaria, l’art. 39 T.U., 1° co. prevede parità di<br />
trattamento tra italiani e stranieri, pur con taluni limiti, in particolare quello che prevede in base<br />
alla L. 189/2002 il regolare soggiorno sul territorio da almeno un anno.<br />
L’accesso all’istruzione universitaria degli studenti stranieri residenti all’estero è disciplinato<br />
annualmente con decreto del Ministro degli Affari Esteri, di concerto con il Ministro<br />
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Ministro dell’Interno, che determina il numero<br />
massimo dei visti d’ingresso e dei permessi di soggiorno da rilasciare (art. 39, co. 4 del<br />
T.U.).<br />
Lo schema del decreto è trasmesso al Parlamento per l’acquisizione del parere delle<br />
commissioni competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni.<br />
Gli studenti stranieri accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi<br />
ed interventi per il diritto allo studio.<br />
Le Università, nella loro autonomia e viste le loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative<br />
volte alla promozione dell’accesso degli stranieri ai corsi universitari.<br />
NUOVI MESTIERI NELL’OTTICA DELL’INTEGRAZIONE<br />
Vengono da ogni angolo del mondo: colombiani, curdi, messicani, nigeriani; svolgono<br />
un lavoro che è quasi una missione: il mediatore linguistico per gli immigrati.<br />
Sono dunque tanti gli immigrati attivi nei comuni, presso i tribunali, nelle scuole e nelle<br />
strutture sanitarie; si tratta appunto di un nuovo mestiere: quello di mediatore linguistico e interculturale,<br />
il simbolo dell’integrazione, il ponte fra le diverse etnie.<br />
Mestiere e non ancora professione, perché manca un albo ed i percorsi formativi non<br />
sono omogenei così come non è omogenea la retribuzione.<br />
Secondo un sondaggio della CARITAS ed una ricerca condotta dal CISP per conto del<br />
Ministero del Welfare sarebbero circa 1000 tali esperienze tra agenzie e singoli lavoratori, ma il<br />
dato è approssimato per difetto perché i mediatori, già oggi, sono almeno il doppio.<br />
163
Anche il tipo di prestazione è variabile: nella scuola, per esempio, ci vuole il mediatore/interprete,<br />
che aiuti un nuovo alunno straniero, giunto magari da fuori ad anno scolastico già<br />
cominciato, ed il mediatore/ animatore.<br />
La CIES, la più grossa agenzia nazionale con almeno 300 mediatori in servizio in tutta<br />
Italia, più di 400 formati e 500 in banca-dati, aiuta a tracciare il profilo del mediatore culturale:<br />
non è un italiano né un dipendente pubblico perché la sua funzione è rigorosamente di terza<br />
parte, di equidistanza fra straniero ed istituzione.<br />
Il mediatore non può essere un sindacalista né un portavoce di istanze, perché deve<br />
essere solo un ponte di comunicazione, né può essere pagato dall’utente straniero perché il suo<br />
servizio ha un carattere sociale e va finanziato dalla collettività.<br />
Non può essere un rancoroso né un egocentrico, perché il suo profilo psicologico prevede<br />
una grande capacità d’ascolto.<br />
Funzione del mediatore linguistico-culturale è quella di favorire l’incontro e la comunicazione<br />
fra italiani ed immigrati, specie negli “avamposti pubblici” prevenendo o risolvendo i conflitti.<br />
Il suo bagaglio culturale include una profonda conoscenza delle leggi e della cultura italiana,<br />
un’istruzione medio-alta e la conoscenza di una terza lingua “veicolare” (inglese, francese,<br />
spagnolo) oltre all’italiano e a quella del paese d’origine; è un professionista tenuto al segreto<br />
d’ufficio e il suo ciclo di formazione ideale, fra base e specializzazione, è di circa 400 ore.<br />
E’ in corso di predisposizione un disegno di legge sulle professioni sociali, tra cui appunto<br />
quella di mediatore culturale.<br />
Sarebbe auspicabile aprire l’Università alle culture straniere e consentire anche a studenti<br />
italiani, laureati in scienze sociologiche e di comunicazione, di accedere a tale professione.<br />
IMMIGRATI E COMUNICAZIONE<br />
La considerazione dell’immigrato nei paesi di insediamento, assai poco spesso è frutto<br />
di quello che fa veramente, mentre invece è frutto assai spesso dell’immagine stereotipata che<br />
la popolazione locale si è fatta di lui spesso in maniera pregiudiziale.<br />
Ciò è frutto di una ricerca di sociologi e antropologi che pone le premesse per lo sviluppo<br />
di un progetto recentemente avviato in Italia con il supporto della Commissione Europea (iniziativa<br />
comunitaria EQUAL).<br />
L’organizzazione Internazionale per le migrazioni, l’Archivio dell’Immigrazione e la Caritas<br />
di Roma / Dossier Statistico Immigrazione hanno infatti proposto un progetto sul tema<br />
“L’immagine degli immigrati tra media e società civile e mondo del lavoro”.<br />
Sinteticamente il progetto si propone di:<br />
istituire un archivio delle comunità immigrate, che raccoglie le varie espressioni della loro<br />
ricchezza culturale;<br />
creare un’agenzia di informazione destinata a favorire le notizie riguardanti l’immigrazione e<br />
imperniata sull’apporto di corrispondenti immigrati sia a livello centrale che territoriale;<br />
promuovere una migliore interazione tra operatori del sociale ed immigrati;<br />
offrire istanze formative di alto livello a beneficio di operatori immigrati e italiani nel settore<br />
del giornalismo e della sensibilizzazione delle competenze interculturali.<br />
A livello internazionale, il progetto si propone di creare collegamenti con quanto, nello<br />
stesso campo, svolto in altri paesi dell’Unione tramite traduzione del materiale di lavoro.<br />
A livello nazionale uno dei partner è RAI NEWS 24 che ha il compito di supportare e<br />
promuovere iniziative e progetti, mentre il CENSIS è chiamato ad approfondire la collocazione<br />
degli immigrati nel sistema della comunicazione.<br />
I partner a dimensione territoriale in buona parte associazioni di immigrati, dei quali si è<br />
inteso valorizzare la partecipazione saranno di sostegno per il conseguimento degli obiettivi<br />
prima esposti.<br />
Il tema “immigrato e comunicazione” viene in questa sede trattato sotto diversi aspetti:<br />
come viene presentato l’immigrato nelle televisioni a carattere nazionale in base a una ricerca<br />
del CENSIS;<br />
164
censimento di tutte le testate ed emittenti che si occupano del COSPE;<br />
riflessione approfondita sull’argomento in base alle notizie fornite dal mondo migrante;<br />
l’immigrato nella televisione italiana.<br />
Secondo una prima indagine del CENSIS l’immagine tipo dell’immigrato rappresentato<br />
in televisione non pecca di razzismo ma è certamente distratta, ai confini della cronaca nera e<br />
ciò non favorisce adeguatamente il processo d’integrazione e reciproca conoscenza.<br />
Il periodo di rilevazione è nell’estate del 2001. Sono state riscontrate queste linee nella<br />
rappresentazione degli immigrati in televisione:<br />
per fasce d’età: vi è una maggiore presa in considerazione dei minori rispetto agli adulti;<br />
quanto al sesso la presenza maschile è preponderante rispetto a quella femminile con ciò<br />
non tenendo conto che le maggior parte degli immigrati è di sesso femminile;<br />
il ruolo affidato all’immigrato è in prevalenza negativo per lo più protagonista di incidenti, di<br />
atti criminosi ed inconvenienti vari con la burocrazia;<br />
l’immigrato viene considerato più come rappresentante di una categoria che come individuo;<br />
le trasmissioni che più trattano degli immigrati sono i telegiornali (95,4%) con notizie in gran<br />
parte di cronaca nera;<br />
l’argomento trattato in prevalenza è criminalità/illegalità (56,7%) seguito da assistenza/solidarietà<br />
(13,4%) e da “immigrazione”, affrontato peraltro per fatti legati alla cronaca,<br />
mentre ricorrono più raramente argomenti quotidiani come lavoro, sport e spettacoli o riflessioni<br />
di tipo giuridico, etico, sociale e storico;<br />
a dare più spazio all’immigrazione sono le tre reti RAI (63,1%), contro il 32,1% di Mediaset<br />
e il 4,8% di Telemontecarlo;<br />
gli immigrati non hanno spazio per esprimersi in prima persona: per lo più o sono citati o<br />
consultati come immigrati o esperti oppure sono semplicemente ospiti della trasmissione o<br />
come diretti interessati o come testimoni;<br />
le trasmissioni degli o per gli immigrati.<br />
Gli immigrati, nei programmi a loro dedicati possono avere due tipi di inclusione che,<br />
allo stato attuale, influiscono pressochè in egual misura:<br />
Un’inclusione assistita, promossa da volontari e/o operatori che lavorano nel campo dei<br />
servizi d’accoglienza e all’immigrazione, che offrono spazi di programmazione, in radio e televisione<br />
oppure favoriscono l’avvio di testate senza particolare riflessione sugli obiettivi, sui<br />
potenziali destinatari e sull’organizzazione dell’offerta.<br />
Un’inclusione garantita, che deriva da una più articolata riflessione circa le opportunità di un<br />
migliore coinvolgimento sociale degli immigrati e delle loro prospettive culturali anche grazie<br />
alla partecipazione delle istituzioni nella logica di un servizio pubblico.<br />
Dall’indagine COSPE risulta che in Italia operano 16 emittenti televisive e 44 radio che<br />
hanno almeno un’esperienza di iniziativa linguistica nel loro palinsesto, a cui si aggiungono 31<br />
testate editoriali dedicate agli immigrati o al tema dell’immigrazione.<br />
La radio risulta quindi essere lo strumento privilegiato seguito dalla carta stampata,<br />
mentre, scarsamente rilevante risulta essere la TV.<br />
Per quanto riguarda, più in dettaglio, l’analisi di quanto viene prodotto per gli immigrati il<br />
COSPE ha censito 117 prodotti di cui 70 programmi radio, 16 televisivi e 31 editoriali.<br />
I primi tentativi risalgono all’inizio degli anni ’90, la maggior parte però è collocata più<br />
nella seconda metà di quegli anni e sono numerose anche le iniziative più recenti.<br />
Tutto ciò mostra un crescente interesse alle iniziative multilinguistiche e multiculturali.<br />
A livello geografico le regioni più vitali sono la Toscana, il Lazio, la Lombardia e l’Emilia<br />
Romagna alle quali spetta una quota del 50%, mentre seguono a distanza Piemonte, Veneto,<br />
Puglia e Sicilia.<br />
a) Programmi radiotelevisivi<br />
Si tratta per lo più di programmi lunghi del tipo contenitore a cadenza settimanale e con fascia<br />
oraria prevalentemente serale. In parte sono programmi a produzione interna (2/3) mentre per il<br />
restante si ricorre a soggetti esterni (associazione di volontariato, sindacati, enti locali).<br />
165
Oltre al programma tipo contenitore vi sono anche TG (26,7%), programmi di approfondimento<br />
rubrica (9,3%), trasmissioni musicali (7 %), di servizio (4,7%) e talk-show (3,5%), comunque il<br />
programma-contenitore è quello che meglio si appresta all’integrazione degli immigrati.<br />
b) Carta stampata<br />
La produzione editoriale destinata agli immigrati è ampia e variegata: abbiamo bollettini di servizio,<br />
riviste di comunità, monografie colte, guide alla legislazione e servizi, riviste di approccio<br />
antropologico ed etnografico.<br />
L’attenzione è centrata sugli immigrati di nuovo arrivo piuttosto che su quelli già residenti.<br />
La tiratura si aggira su una quota tra le 1.000 e le 5.000 copie, in gran parte si tratta di periodici<br />
a cadenza mensile.<br />
Editori di queste testate sono i privati cittadini (16%), l’associazionismo, il volontariato, il sindacato<br />
(15%), gli enti locali (6,5%) e le vere e proprie case editrici (13%).<br />
La logica di queste attività non è tanto quella di mercato ma quella di servizio per fini di<br />
studio o etnico-culturali.<br />
In buona parte le iniziative sono supportate da intenti e tematiche quali il ruolo degli<br />
immigrati nella società, la solidarietà sociale e lo spirito di servizio.<br />
Sia per quanto riguarda i programmi televisivi che la carta stampata scarsi risultano essere<br />
i finanziamenti pubblici e per gran parte si fa leva sul volontariato.<br />
La lingua usata è in gran parte l’italiano ma spesso si ricorre anche ad una lingua straniera,<br />
in genere quella della fascia di immigrati di riferimento.<br />
Secondo il COSPE l’offerta mediale multiculturale costituisce un elemento importante di<br />
prima accoglienza per gli immigrati ed anche un primo ma importante passo verso la costruzione<br />
di una società multietnica in cui le diverse nazionalità abbiano pari diritto di cittadinanza.<br />
Il protagonismo per una nuova immagine dell’immigrazione<br />
I problemi di impatto del fenomeno migratorio con i residenti possono essere attuati anche<br />
mediante il corretto intervento dei mass-media che possono influire positivamente o negativamente<br />
sulla percezione collettiva della presenza immigrato.<br />
Il giornalista è, anche se non unico, la figura professionale-chiave di questo processo e,<br />
accanto a lui i politici nazionali ed internazionali, gli enti locali, il mondo associativo e in particolare<br />
le grandi agenzie di sensibilizzazione e gli istituti di ricerca.<br />
Valido, ai fini di una nuova strategia, è l’apporto che può essere fornito dalle associazioni<br />
degli immigrati.<br />
Occorre, poi, tener presente la componente intellettuale dell’immigrazione straniera che<br />
presenta caratteristiche meritevoli di attenta considerazione.<br />
E’ auspicabile altresì la formazione dei giornalisti immigrati.<br />
LA COMPONENTE FEMMINILE NELL’AMBITO DELLA FENOMENOLOGIA MIGRATORIA<br />
Di fronte all’imponente manifestarsi, nell’ultimo decennio più marcatamente, di fenomeni<br />
migratori (soprattutto via mare) dal sud e dall’est del mondo verso nord ed occidente, siamo abituati,<br />
a livello dell’immagine informativa che ci viene trasmessa dai media (giornali, televisione,<br />
ecc.) ad osservare e soffermarci sulla sola componente maschile del fenomeno migratorio di cui<br />
sopra; infatti sia nelle immagini trasmesse in TV nei notiziari, che nelle interviste ai quotidiani è<br />
quasi sempre l’elemento maschile ad essere evidenziato.<br />
Tale predominanza dell’elemento migratorio maschile trova risonanza ed elaborazione<br />
di soluzioni nelle più varie sedi da quella politica a quella statistica a quella istituzionale in senso<br />
lato.<br />
In effetti, quindi, si evidenzia come, in sede di valutazione della fenomenologia dei flussi<br />
migratori la conoscenza e la valutazione della presenza femminile vadano, senz’altro, approfonditi.<br />
Dalle statistiche emerge peraltro una certa consistenza quantitativa della componente<br />
femminile, ma risultano di difficile individuazione e definizione i caratteri e le dinamiche delle<br />
stesse.<br />
166
A monte del fenomeno migratorio femminile, mentre se ne evidenziano, da un lato, tematiche<br />
quali il ricongiungimento familiare o la collaborazione domestica, restano oscuri<br />
dall’altro, altri non meno importanti fattori dal punto di vista umano e sociale quali condizioni di<br />
vita estremamente critiche (donne capofamiglia) o discriminazione di genere.<br />
Un altro livello di riflessione da approfondire, in seno alla tematica della componente<br />
femminile nella fenomenologia immigratoria, riguarda l’accesso all’erogazione di alcuni servizi<br />
sociali fondamentali come sanità ed istruzione.<br />
Non bisogna, poi, per arricchire il quadro, mancare di menzionare e sottolineare come<br />
l’elemento femminile costituisca un forte fattore di potenzialità nel facilitare l’integrazione sociale<br />
ed economica della popolazione immigrata.<br />
L’elemento femminile, in quanto risultante più esposto al cambiamento (mutamento di<br />
abitudini domestiche, di educazione della prole, ecc.) tende ad inserirsi più rapidamente nei paesi<br />
ospitanti, svolgendo in tal modo un ruolo decisivo di mediazione culturale fra paese ospitante<br />
e paese d’origine.<br />
Si evince, infatti, come all’interno delle comunità di immigrati la presenza femminile favorisca<br />
da un lato l’interscambio tra persone e culture, dall’altro come madri visto che entrano in<br />
rapporto per i figli con le strutture educative e socio-sanitarie del paese ospitante, mentre il marito<br />
è impegnato nel lavoro.<br />
Si consideri, infine, la maggiore flessibilità ed adattabilità rispetto ai maschi ad affrontare<br />
situazioni difficili di questa componente femminile oltre che alla propensione ad organizzarsi<br />
in gruppo per promuovere azioni socialmente rilevanti di vario tipo.<br />
L’IMPEGNO DELLA CHIESA PER L’INSERIMENTO DEGLI STRANIERI<br />
Anche la Chiesa è fortemente impegnata in prima linea nelle tematiche dell’integrazione<br />
dello straniero e dell’immigrato.<br />
Secondo la Fondazione Migrantes, problemi sociali, antropologici, culturali, economici e<br />
politici complicano l’accoglienza degli immigrati.<br />
L’istituzione della Giornata nazionale delle migrazioni si rivolge alle comunità cristiane<br />
affinché gli immigrati trovino in Italia una continuazione di vita religiosa.<br />
Sarebbe auspicabile incrementare il dialogo interreligioso che, come afferma Papa Giovanni<br />
Paolo II, è veicolo di pace.<br />
In tal senso, la Fondazione Migrantes facendo proprio il tema “Accoglietevi come Cristo<br />
ha accolto voi”, sta svolgendo un lavoro per rendere le parrocchie palestre di ospitalità.<br />
Migrantes prima di tutto cerca di creare una mentalità di comunione tra le varie etnie e<br />
successivamente le parrocchie ospitano le varie comunità, perché solo attraverso la conoscenza<br />
reciproca si superano i problemi di integrazione.<br />
Maggiori difficoltà si incontrano con i nomadi perché è una cultura che difficilmente si<br />
integra.<br />
Occorre un lavoro integrato con le autorità civili rendendo vivibili i campi, mandando i<br />
bambini a scuola, regolando la vita sociale; con gli altri immigrati invece si evidenzia che, ove<br />
svolgano attività lavorative, l’integrazione si profila in modo positivo.<br />
167
LINEE DI INTERVENTO SULL’INFORMAZIONE<br />
E LA COMUNICAZIONE DEI 32 PAESI EUROPEI<br />
IN APPLICAZIONE ALLA CONVENZIONE-QUADRO<br />
PER LA PROTEZIONE DELLE MINORANZE NAZIONALI<br />
169
SCHEDE ILLUSTRATIVE DEI 32 PAESI EUROPEI<br />
ALBANIA<br />
Allo scopo di preservare e consolidare l'identità culturale delle minoranze nazionali e al<br />
fine di tenerle costantemente informate relativamente agli sviluppi politici, sociali, economici e<br />
culturali riguardanti non solo l'Albania, ma anche il contesto internazionale, la legislazione albanese<br />
contempla per le stesse la piena possibilità di accedere ai media sia stampati che elettronici,<br />
nella loro lingua madre.<br />
La libertà di espressione, come contemplata dalla Convenzione quadro, è un diritto costituzionale<br />
fondamentale in Albania. L'articolo 22 della Costituzione garantisce a tutti, comprese<br />
le minoranze nazionali, la libertà di espressione, la libertà di stampa e dei mezzi radiotelevisivi<br />
e proibisce la censura preventiva in relazione ai mezzi di comunicazione.<br />
La legge n. 7756 dell'11/10/93 denominata "Legge sulla stampa", emendata con legge<br />
n. 8239 del 3/9/97 è costituita da un unico articolo che stabilisce quanto segue: "La stampa è<br />
libera. La libertà di stampa è protetta per legge".<br />
In forza delle disposizioni della succitata legge, gli appartenenti alle minoranze nazionali<br />
godono, senza alcun ostacolo, del diritto di dar vita a media della carta stampata nella propria<br />
lingua d'origine, come tutti i cittadini albanesi. La stampa delle minoranze nazionali, come tutta<br />
la stampa albanese, non è soggetta alla censura preventiva.<br />
Le minoranze greca, macedone, montenegrina e arumena hanno accesso a riviste e<br />
quotidiani nelle rispettive lingue.<br />
La legge n. 8410 del 30/9/98 intitolata "Le radio e televisioni pubbliche e private della<br />
Repubblica di Albania" garantisce l'accesso delle minoranze nazionali ai media elettronici. Detta<br />
legge stabilisce la libertà dell'attività radiotelevisiva, nonché l'indipendenza editoriale (articoli 4 e<br />
5). L'articolo 39 della citata legge proibisce "la trasmissione di programmi che incitino alla violenza,<br />
alla guerra di aggressione, all'odio razziale e basato sulla nazionalità." ecc., mentre l'articolo<br />
36 stabilisce che " i programmi radiotelevisivi pubblici e privati devono rispettare la dignità<br />
personale e i diritti umani fondamentali, nonché l'imparzialità, completezza, veridicità e il pluralismo<br />
dell'informazione, i diritti di bambini e adolescenti, l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale,<br />
la lingua e cultura albanesi, i diritti umani e costituzionali delle minoranze nazionali in adempimento<br />
alle convenzioni internazionali siglate dall'Albania ed infine la diversità religiosa in Albania."<br />
L'articolo 37, poi, afferma che: "L'uso della lingua albanese è obbligatorio per tutti i programmi,<br />
ad eccezione di lavori di tipo musicale con testi in lingua straniera, di programmi per<br />
l'insegnamento delle lingue straniere, di programmi specificatamente destinati alle minoranze<br />
nazionali e dei programmi di enti radiotelevisivi titolari di licenza per la trasmissione nella lingua<br />
delle minoranze."<br />
Su tale base, viene garantita, agli appartenenti alle minoranze nazionali di poter fondare<br />
stazioni radiotelevisive locali, con l'uso della lingua madre. L'emissione delle licenze è di competenza<br />
del Consiglio Nazionale Radiotelevisivo, le stesse devono essere richieste a norma di<br />
legge e conformemente agli standard internazionali riconosciuti.<br />
In base all'articolo 69 della legge 8410, la ART (l'emittente radiotelevisiva albanese), è<br />
tenuta a garantire la trasmissione di notiziari destinati anche alle minoranze nazionali, sia dalle<br />
sedi centrali che da quelle regionali. Nonostante sia esplicitamente contemplato detto obbligo<br />
nei confronti della ART, la legge non stabilisce concretamente, né in termini nominali né percentuali,<br />
l'entità e l'estensione del volume dei notiziari obbligatori destinati alle minoranze nazionali,<br />
all'interno del tempo di programmazione. Si sottolinea che uno dei 15 membri del Consiglio di<br />
Amministrazione della Art, eletto dal Parlamento in base alla legge sui media elettronici (art.<br />
88), è il rappresentante delle minoranze nazionali e pertanto dovrebbe normalmente rispettare<br />
le percentuali in termini di volume e tempo che devono essere dedicate alle informazioni sulle<br />
minoranze nazionali all'interno dei programmi ART.<br />
Tuttavia, l'attività delle minoranze in tutte le sfere della vita, le loro conquiste e i loro<br />
problemi hanno assunto una collocazione importante e vengono ampiamente trattati all'interno<br />
dei principali programmi della ART, sia nei notiziari, che in altri programmi di carattere culturale,<br />
economico e sociale.<br />
171
Le minoranze greca, macedone e montenegrina hanno accesso a programmi radiotelevisivi<br />
nelle rispettive lingue; nel 2000 i media hanno dato risalto alla situazione dei Rom e degli<br />
arumeni.<br />
ARMENIA<br />
La Costituzione della Repubblica d' Armenia, all'articolo 24, conferma uno dei principali<br />
diritti umani. In base al citato articolo, ciascuno ha il diritto di esprimere la propria opinione.<br />
Nessuno può essere obbligato a ritrattare o modificare la propria opinione; quindi si afferma che<br />
ognuno ha diritto alla libertà di parola, ivi compreso il diritto di ricercare, ricevere e divulgare informazioni<br />
e idee attraverso qualsiasi mezzo di informazione, indipendentemente dalla posizione<br />
dei confini di stato.<br />
Nella Repubblica d'Armenia sono in vigore la legge sui mass media e quella sulla radio<br />
e la televisione, adottate il 9 ottobre 2000. Detta legge definisce lo status delle società radiotelevisive,<br />
lo strumento giuridico necessario all'istituzione, la licenza e la gestione e altri elementi.<br />
L'articolo 5 della Legge sulla radio e la televisione stabilisce che la lingua per la diffusione<br />
dei programmi è l'armeno, ad eccezione dei casi previsti dalla legge medesima. I programmi<br />
televisivi, i lungometraggi e i documentari, i cartoni animati nonché episodi di programmi<br />
armeni in lingua straniera vengono trasmessi con traduzione/interpretazione simultanea in<br />
armeno. Per quanto riguarda le minoranze nazionali, la TV pubblica trasmette un'ora di programmi<br />
settimanali, mentre la radio trasmette giornalmente per la durata di un'ora.<br />
L'articolo 8 della Legge sulle diffusioni radiotelevisive stabilisce che, in territorio armeno, gli<br />
indirizzi di dichiarazioni scritte, ricevute e trasmesse dagli enti devono essere in armeno, mentre<br />
il testo può essere in qualsiasi lingua o alfabeto, fatta salva la disponibilità tecnica. L'articolo 10<br />
della citata legge definisce i principi ispiratori dell'attività per quanto riguarda le emissioni radiotelevisive:<br />
a) Uguali diritti per gli utenti dei servizi di diffusione radiotelevisiva;<br />
b) garanzia della riservatezza e della libertà della diffusione dei programmi sia per l'aspetto dei<br />
mezzi tecnici che per quanto riguarda le reti di trasmissione;<br />
c) tutela statale delle postazioni orbitali dei satelliti e della banda di radiofrequenze tramite sistemi<br />
tecnici e reti di trasmissione.<br />
Per quanto riguarda la stampa vale vengono pubblicati 10 riviste e quotidiani in russo. Segue<br />
l'elenco delle pubblicazioni delle minoranze nazionali, accreditate presso il Ministero della<br />
Giustizia e di altri mass media, facenti capo alle medesime minoranze.<br />
La radio trasmette programmi in georgiano, curdo, russo e yezidi. Gli appartenenti a matrimoni<br />
misti hanno la possibilità di ascoltare programmi radiofonici in arabo, azero, inglese, francese,<br />
persiano e turco.<br />
AUSTRIA<br />
Per quanto riguarda le sovvenzioni alla stampa, si richiama l'articolo 2 comma 2 della<br />
Legge per la promozione della stampa del 1985, che facilita l'accesso alle misure di sostegno,<br />
per i media delle minoranze. La citata legge prevede una tiratura minima di 5.000 copie e l'impiego<br />
di almeno due giornalisti a tempo pieno per quanto riguarda i settimanali, ma tali requisiti<br />
non vengono applicati per i settimanali pubblicati in una lingua minoritaria.<br />
ORF (Compagnia radiotelevisiva austriaca)<br />
La ORF è un organismo radiotelevisivo istituito in base al diritto pubblico.<br />
I programmi televisivi della ORF<br />
In base all'articolo 2 comma 1 paragrafo 2 della Legge sulle trasmissioni radiotelevisive,<br />
la ORF, nella progettazione dei programmi, mira anche ad incoraggiare la conoscenza e la<br />
comprensione della coesistenza democratica. Per quanto riguarda le minoranze nazionali, tale<br />
requisito è soddisfatto in particolare dal programma "Heimat, fremde Heimat" (Patria, patria<br />
172
straniera). Esso è una rubrica settimanale di immigrazione su e per gli immigrati e le minoranze<br />
nazionali che vivono in Austria. Scopo del programma è promuovere la coesistenza, la diversità<br />
culturale e l'integrazione e viene trasmesso in tedesco ed eventualmente in altre lingue, con<br />
sottotitoli in tedesco.<br />
Esistono anche programmi in croato, sloveno e ungherese.<br />
Il progresso tecnico dà maggiori opportunità alle persone appartenenti alle minoranze<br />
nazionali che insistono in Austria di guardare programmi nella loro lingua d'origine.<br />
L'Ufficio Editoriale per le Minoranze della ORF<br />
Con l'introduzione dei programmi televisivi per le minoranze nazionali, presso il Centro<br />
di Trasmissione della ORF è stato istituito un Ufficio editoriale per le minoranze.<br />
La varietà di formazione culturale del personale addetto permette di adottare un approccio<br />
differenziato. Il personale è costituito da croati, serbi, turchi, curdi, armeni e da appartenenti<br />
ad altre minoranze nazionali che insistono in Austria. A livello internazionale, l'Ufficio editoriale<br />
per le minoranze ha partecipato, fin dal 1997, a vari progetti di scambio del Gruppo EBU<br />
per i programmi interculturali.<br />
Programmi radiofonici della ORF<br />
La ORF trasmette programmi radiofonici nelle seguenti lingue minoritarie: croato, ungherese,<br />
sloveno e, in passato, lingua Rom. Inoltre trasmette anche programmi per e sulle minoranze<br />
etniche.<br />
La Homepage della ORF<br />
Dal 15 maggio 2000, la ORF ha attivato l'indirizzo Internet "volksgruppen.orf.at" attraverso<br />
il quale è possibile accedere ad informazioni sulle minoranze nazionali in tedesco, croato,<br />
ungherese. Il medesimo servizio è offerto anche in sloveno.<br />
Le campagne e i progetti dell'Ufficio Editoriale per le Minoranze della ORF<br />
Al fine di tutelare le minoranze etniche l'Ufficio per le minoranze ha avviato varie iniziative<br />
e manifestazioni negli ultimi anni.<br />
Premi<br />
Negli ultimi anni l'Ufficio editoriale per le minoranze ha ricevuto molti premi e riconoscimenti.<br />
Dal Memorandum del 24 giugno 1997 si deduce chiaramente che tutte le minoranze<br />
nazionali concordano sull'esigenza di definire in maniera più precisa il mandato pubblico della<br />
ORF in merito alla diffusione dei programmi educativi e culturali nelle lingue minoritarie. Le<br />
stesse minoranze, inoltre, ritengono che sia un fattore importante inviare un membro del Consiglio<br />
consultivo per le minoranze nazionali alle riunioni della Commissione dei Radioascoltatori e<br />
Telespettatori, come previsto dall'articolo 15, comma 3 della Legge sulle trasmissioni radiotelevisive.<br />
Un ulteriore obiettivo prevede la creazione di uno speciale programma televisivo per i<br />
Rom, da trasmettere quattro volte l'anno, nonché l'apertura di un ufficio editoriale ungherese<br />
presso il centro ORF del Burgenland. Il Memorandum contiene anche suggerimenti in merito<br />
alla creazione di un'unità speciale all'interno dell'ufficio editoriale per le minoranze della ORF a<br />
Vienna, che si occupi esclusivamente di problematiche relative alle minoranze nazionali; vengono<br />
altresì formulate proposte in merito ad una adeguata durata delle trasmissioni nelle lingue<br />
di minoranza.<br />
Radio private<br />
Esistono varie radio private che trasmettono esclusivamente o parzialmente nelle lingue<br />
minoritarie. Esse ricevono anche sovvenzioni dalla Cancelleria Federale.<br />
Riunione di esperti<br />
In data 15 novembre 1999, la Cancelleria Federale, in cooperazione con l'Unità di lavoro<br />
per gli studi interculturali e l'Istituto per gli studi sui media e la comunicazione dell'Università<br />
173
di Klagenfurt ha organizzato una riunione di esperti dal titolo "I media in un ambiente multilingue<br />
e modelli a livello europeo nel campo della promozione della stampa nelle lingue minoritarie".<br />
L'Associazione europea per la trasmissione di programmi sui gruppi etnici<br />
Il compito dell’Associazione europea per la trasmissione di programmi sui gruppi etnici<br />
(EEBA), con sede a Klagenfurt, è quello di contrastare i pericoli imminenti che incombono sui<br />
paesi europei di piccole dimensioni e sulle minoranze nazionali a seguito della rivoluzione che<br />
ha cambiato il settore delle comunicazioni a livello mondiale. La EEBA si prefigge l'obiettivo di<br />
incoraggiare, promuovere e facilitare la cooperazione fra giornalisti impegnati nella tutela del<br />
patrimonio etnico-culturale, fornire informazioni in merito a tematiche relative alla tutela delle<br />
minoranze nazionali ed infine promuovere un maggiore livello di comprensione da parte del<br />
pubblico a favore delle culture autoctone a rischio.<br />
La carta stampata<br />
La pubblicazione di riviste e giornali è fondamentalmente accessibile a tutte le minoranze<br />
nazionali. In pratica, tuttavia, la pubblicazione regolare è ostacolata da mancanza di personale.<br />
Nonostante il Fondo per l'assistenza alle minoranze della Cancelleria Federale eroghi delle<br />
sovvenzioni, questi gruppi spesso non sono in grado di finanziare periodici e quotidiani. Questa<br />
è probabilmente la principale ragione per la mancanza di quotidiani nelle lingue di minoranza.<br />
Esistono riviste e pubblicazioni nelle seguenti lingue minoritarie: croato, sloveno, ungherese,<br />
ceco, slovacco e rom.<br />
AZERBAIGIAN<br />
L'articolo 47 della Costituzione della Repubblica d'Azerbaigian prevede il diritto universale<br />
alla libertà di pensiero e di convinzioni. Inoltre "nessuno può essere obbligato ad esporre<br />
pubblicamente i propri pensieri o convinzioni o a rinnegarle".<br />
L'articolo 50 della Legge Fondamentale del paese garantisce a ciascuno il diritto di "ricercare,<br />
acquisire, trasmettere, redigere e divulgare informazioni attraverso metodi legali". Allo<br />
stesso tempo garantisce "la libertà dei media" e "proibisce la censura del governo nei confronti<br />
dei mass media, compresa la stampa".<br />
La Legge della Repubblica d'Azerbaigian relativa ai mass media del 12 luglio 1999 opera<br />
in Azerbaigian per dare attuazione ad un inalienabile diritto dell'uomo: la libertà di parola. In<br />
base all'articolo 6 di detta legge "i mass media si servono della lingua di Stato nel territorio della<br />
Repubblica d'Azerbaigian. I cittadini della Repubblica d'Azerbaigian, nel redigere e divulgare le<br />
informazioni di massa, possono servirsi di altre lingue, parlate dalla popolazione della Repubblica<br />
d'Azerbaigian, nonché di altre lingue con un'ampia diffusione a livello mondiale".<br />
L'articolo 10 della succitata legge prevede l'inammissibilità dell'abuso della libertà dei<br />
mass media. In particolare non è permesso l'uso dei mass media a fini di violenza e crudeltà, e<br />
per fomentare la discordia o l'intolleranza a livello nazionale, razziale o sociale.<br />
Secondo l'articolo 14 della presente legge, tutti i cittadini della Repubblica d'Azerbaigian<br />
hanno il diritto di fondare un mezzo di comunicazione.<br />
Il 20 luglio 2001 il Presidente della Repubblica d'Azerbaigian ha emanato due decreti,<br />
intitolati rispettivamente "Istituzione del Consiglio nazionale per la stampa, la TV, la radio e<br />
Internet" e "Miglioramento dell'attenzione dello Stato nei confronti dei mass media".<br />
Il 27 dicembre 2001 il Presidente ha emanato un ulteriore decreto intitolato "Misure integrative<br />
per il miglioramento dell'attenzione dello Stato nei confronti dei mass media".<br />
In Azerbaigian i programmi radiotelevisivi, i libri, le riviste e i quotidiani si servono delle<br />
lingue delle varie minoranze nazionali che vivono nel paese. In particolare vengono usate le seguenti<br />
lingue: curdo, lezgi, talish, georgiano, russo, avaro, tat.<br />
174
BULGARIA<br />
Nella Repubblica di Bulgaria, tutte le persone, comprese quelle appartenenti alle minoranze<br />
nazionali, hanno diritto alla libertà di opinione, nonché a ricevere e comunicare informazioni<br />
e idee nella propria lingua madre.<br />
Aspetti giuridici<br />
Il diritto alla libertà di opinione è garantito dall’art. 39, comma 1 della Costituzione che<br />
stabilisce che: "Tutti hanno diritto ad esprimere opinioni o a divulgarle per iscritto o oralmente,<br />
con suoni o immagini, e comunque con ogni altro mezzo." Il secondo comma stabilisce: "Tale<br />
diritto non può essere esercitato a scapito dei diritti e della reputazione di terzi, oppure al fine di<br />
incitare ad un cambiamento violento dell'ordine costituito in virtù della costituzione, oppure al<br />
fine di istigare al crimine o ad un senso di inimicizia o violenza nei confronti di chiunque".<br />
L’articolo 40, comma 1 recita: "La stampa e altri mezzi di informazione di massa devono<br />
essere liberi e non soggetti alla censura"; il secondo comma dello stesso articolo afferma: "Un'ingiunzione<br />
a sospendere l'attività, o un sequestro di materiale stampato o di altri mezzi di informazione<br />
sono permessi solo in forza di un atto dell'autorità giudiziaria ed in caso di offesa al<br />
pudore o di incitamento al cambiamento violento dell'ordine istituito in forza della costituzione, di<br />
istigazione al crimine, o di incitamento alla violenza nei confronti di chiunque. Una eventuale ingiunzione<br />
sospensiva perde di efficacia se non è seguita da un sequestro entro 24 ore".<br />
Infine l’articolo 41, comma 1 dispone: "Tutti hanno diritto a richiedere, ottenere e divulgare<br />
informazioni. Tale diritto non può essere esercitato a detrimento dei diritti e della reputazione<br />
di altri, oppure a detrimento della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico e di una sana<br />
morale pubblica."<br />
Con sentenza n. 2 del 14 novembre 1996, la Corte Costituzionale ha stabilito che "non<br />
vi è alcuna restrizione costituzionale rispetto alla lingua usata per esercitare tale diritto (art. 39,<br />
comma 1 della Costituzione). Inoltre, i cittadini con madre lingua diversa dal bulgaro godono del<br />
diritto costituzionalmente stabilito di servirsi della propria lingua (art. 36, comma 2 della Costituzione)."<br />
La Legge sulla Radio e la Televisione stabilisce anche il diritto alla libera divulgazione<br />
delle informazioni nella lingua madre delle comunità etniche del paese.<br />
Articolo 6, comma 3: "Gli enti pubblici radiotelevisivi…devono garantire, attraverso la loro<br />
politica di programmazione, la tutela degli interessi nazionali, i comuni valori culturali dell'uomo,<br />
le scienze nazionali, l'istruzione e la cultura, in favore di tutti i cittadini bulgari, indipendentemente<br />
dall'appartenenza etnica";<br />
Articolo 7, comma 1: "La Radio Nazionale Bulgara (BNR) e la Televisione Nazionale<br />
Bulgara (BNTV) sono enti nazionali radiotelevisivi, che …contribuiscono allo sviluppo e alla divulgazione<br />
della lingua e della cultura bulgare, nonché della cultura e della lingua dei cittadini<br />
coerentemente con la loro appartenenza etnica."<br />
Articolo 12, comma 2: "I programmi radiotelevisivi e le trasmissioni di tipo individuale<br />
possono utilizzare un'altra lingua, quando…vengono trasmessi per cittadini bulgari, con madre<br />
lingua diversa dal bulgaro…;"<br />
Articolo 49, comma 1: "La Radio Nazionale Bulgara e la Televisione Nazionale Bulgara<br />
devono produrre programmi nazionali e regionali e trasmissioni per altri paesi, anche a vantaggio<br />
di cittadini bulgari all'estero; inoltre devono curare la produzione di programmi per cittadini<br />
bulgari nelle rispettive lingue madri, qualora siano diverse dal bulgaro."<br />
Articolo 76, comma 2: "Non devono essere divulgati avvisi pubblicitari basati sulla discriminazione<br />
nazionale, politica, etnica, religiosa, sessuale o di altro tipo".<br />
Articolo 90, comma 1: "I Partiti e le organizzazioni politiche, comprese quelle religiose,<br />
non possono sponsorizzare alcuna trasmissione".<br />
Infrastruttura statale<br />
La Legge sulla Radio e la Televisione ha dato vita al Consiglio per i Media Informatici<br />
(CEM), che, quale ente specializzato indipendente, regolamenta le attività radiotelevisive registrando<br />
o rilasciando le licenze per le attività radiotelevisive, nonché effettuando controlli sul rispetto<br />
della citata legge da parte degli enti radiotelevisivi. La composizione del citato Consiglio<br />
175
è costituita da: nove membri, dei quali 5 eletti dall'Assemblea Nazionale e 4 di nomina presidenziale.<br />
Il medesimo Consiglio elegge e rimuove i Direttori Generali della Radio e TV nazionali;<br />
su proposta dei Direttori Generali approva la composizione dei rispettivi consigli di amministrazione.<br />
Dati<br />
Esistono trasmissioni in turco e rom; altre che trattano i problemi delle minoranze. In<br />
occasione di festività religiose, esponenti di minoranze religiose, soprattutto turchi, esponenti<br />
del rito armeno-gregoriano e rappresentanti ebraici si rivolgono ai credenti e al pubblico in generale,<br />
anche nelle lingue di minoranza.<br />
In Bulgaria esistono circa 180 stazioni radio private e circa 80 TV private via cavo.<br />
Infrastruttura statale<br />
La Commissione statale per le telecomunicazioni (STC) e il Consiglio per i Media Informatici<br />
(CEM) sono gli organismi che rilasciano le licenze agli enti radiotelevisivi, in ottemperanza<br />
alla Legge sulla Radio e la Televisione, e la Legge sulle Telecomunicazioni.<br />
Conformemente ai principi costituzionali della libertà di parola e di divulgazione delle informazioni,<br />
nessuna istituzione statale ha titolo ad esercitare controlli sulla stampa, relativamente<br />
al volume e ai contenuti delle informazioni, alla struttura tematica e del genere.<br />
A partire dall'avvio delle trasformazioni in senso democratico della situazione, i periodici<br />
riferibili alle minoranze, dopo aver superato gravi difficoltà organizzative e finanziarie, hanno<br />
gradualmente riconquistato le proprie posizioni. Per poter uscire, le riviste periodiche riferibili<br />
alle minoranze etniche dipendono dalle donazioni di fondazioni e privati cittadini, mentre fino a<br />
poco tempo fa lo Stato non aveva praticamente alcun ruolo, anche se si registrano nuove iniziative<br />
nel settore.<br />
Pubblicazioni riferibili alle minoranze etniche attualmente in circolazione in Bulgaria<br />
Ethnodialog (organizzazioni di Armeni, Arumeni, Valacchi, Ebrei, Rom, russi, turchi)<br />
Klub Zaedno (varie origini etniche e religiose)<br />
Stampa periodica armena: esistono tre testate; stampa periodica ebraica: esistono tre testate;<br />
stampa periodica rom: esistono sei testate; stampa periodica turca: esistono sei testate; stampa<br />
periodica arumena: esiste una testata; stampa periodica valacca: esiste una testata; stampa periodica<br />
russa: esiste una testata; altre pubblicazioni: due testate; periodici di comunità religiose:<br />
esistono otto testate.<br />
La legge non prevede restrizioni di accesso ai mass media a carico di persone appartenenti<br />
alle minoranze nazionali. E' piuttosto necessaria una maggiore presenza di rappresentanti<br />
delle minoranze nei media informatici, compresa la Radio e la TV nazionali, nonché un più efficace<br />
ruolo dello Stato a sostegno dei media riferibili alle minoranze.<br />
CIPRO<br />
Una delle condizioni per la concessione di una licenza radiotelevisiva è il rispetto della<br />
democrazia e dei diritti umani.<br />
Esiste un'unica stazione radiotelevisiva di proprietà dello Stato, ed è gestita da una società<br />
indipendente.<br />
Esistono diversi tipi di giornali (quotidiani, settimanali, ecc.) e periodici; sono tutti appartenenti<br />
a privati.<br />
L'articolo 19 della Costituzione prevede per tutti il diritto alla libertà di parola e di espressione,<br />
in qualsiasi forma; in tale diritto è esplicitamente previsto il diritto alla libertà di opinione<br />
e a divulgare e ricevere informazioni e idee senza interferenze da parte delle pubbliche<br />
autorità e indipendentemente dalla posizione dei confini.<br />
176
CROAZIA<br />
La Repubblica di Croazia garantisce a tutte le minoranze nazionali il libero accesso ai<br />
media conformemente alla Legge Costituzionale sui diritti e le libertà dell'uomo e sui diritti delle<br />
comunità nazionali ed etniche. La Costituzione della Repubblica di Croazia garantisce anche la<br />
libertà di avere ed esprimere opinioni. I membri delle minoranze nazionali possono liberamente<br />
organizzare attività di informazione ed editoriali, servendosi della propria lingua e anche nella<br />
sua forma scritta; a tal fine la Repubblica di Croazia, unitamente agli enti dell'autogoverno locale,<br />
dispongono forme di sostegno finanziario.<br />
Aspetti giuridici<br />
Estratti dalla Costituzione della Repubblica di Croazia<br />
Articolo 38: "La libertà di idee e la libertà di esprimerle sono garantite.<br />
La libertà di pensiero deve comprendere specificamente la libertà di stampa e degli altri mezzi<br />
di comunicazione, la libertà di parola e di esprimersi in pubblico ed infine la libertà di fondare<br />
ogni tipo di istituzione nell'ambito delle comunicazioni di massa. La censura è proibita. I giornalisti<br />
hanno il diritto alla libertà di divulgazione delle notizie e di accesso alle informazioni.<br />
Il diritto di smentita è garantito a chiunque patisca una violazione dei diritti previsti dalla<br />
Costituzione, per effetto delle comunicazioni di massa."<br />
Estratti dalla Legge Costituzionale sui diritti e le libertà dell'uomo e sui diritti delle comunità o<br />
minoranze nazionali ed etniche<br />
Articolo 6 comma 1.d): "La Repubblica di Croazia garantisce ai membri delle comunità o<br />
minoranze nazionali o etniche quanto segue: la tutela di un'equa partecipazione alla vita pubblica,<br />
quali il diritto alle libertà politiche ed economiche nella sfera sociale, l'accesso ai media ed<br />
infine la tutela nei settori dell'istruzione e della cultura in generale".<br />
Articolo 10: "I membri delle comunità o minoranze nazionali ed etniche godono della libertà<br />
di organizzare attività informative ed editoriali, servendosi della lingua d'origine, compresa<br />
anche la più appropriata forma scritta. La Repubblica di Croazia e gli enti locali di autogoverno<br />
mettono a disposizione dei mezzi finanziari per la realizzazione dei diritti previsti dal comma 1<br />
del presente articolo, in misura relativa alle proprie risorse finanziarie."<br />
Infrastruttura statale<br />
Le attività informative ed editoriali a livello statale sono finanziate dall'Ufficio per le Minoranze<br />
Nazionali della Repubblica di Croazia. A livello locale la competenza spetta alle autorità<br />
di contea, di città e di comune.<br />
Linee politiche e dati informativi<br />
Descrizione delle competenze dell'Ufficio per le Minoranze Nazionali del <strong>Governo</strong> della Rep. di<br />
Croazia<br />
Il governo croato fornisce sostegno di tipo finanziario per la pubblicazione di giornali<br />
(quotidiani, settimanali e altri periodici) a favore di tutte le minoranze nazionali che possono servirsi<br />
della propria lingua e del proprio alfabeto; i mezzi vengono forniti anche a favore di lavori di<br />
autori che hanno contribuito alla conservazione e allo sviluppo dell'identità delle minoranze nazionali.<br />
L'assistenza finanziaria dipende strettamente dalle tradizioni e dalle caratteristiche delle<br />
singole minoranze nazionali; pertanto ogni minoranza nazionale eserciterà il proprio diritto in<br />
una misura che dipende dalle tradizioni e dal lasso di tempo durante il quale hanno avuto la<br />
possibilità di esprimere la propria individualità. Ne consegue che, per esempio, la minoranza<br />
nazionale italiana pubblica molti più giornali (di vario tipo) delle minoranze tedesca e austriaca,<br />
che sotto il precedente regime non avevano avuto il diritto di esprimere la propria identità o di<br />
riunirsi in associazioni riferibili alla minoranza.<br />
Informazioni relative alle singole minoranze nazionali<br />
177
Esistono associazioni di vario tipo che rappresentano le minoranze nazionali elencate di<br />
seguito. Tali associazioni si dedicano ad attività editoriali (pubblicazione di supporti sia cartacei<br />
che elettronici), anche grazie a finanziamenti governativi. Le minoranze nazionali interessate<br />
sono le seguenti: italiana, ceca, slovacca, ungherese, rutena e ucraina, serba, tedesca e austriaca,<br />
ebraica, slovena, albanese, bosniaca, rom, montenegrina, macedone.<br />
Estratti dalla Legge sulle telecomunicazioni<br />
Articolo 64:<br />
"(1) I concessionari radiotelevisivi devono trasmettere i programmi in lingua croata.<br />
(2) I concessionari radiotelevisivi possono trasmettere programmi, a livello locale, anche<br />
nei dialetti croati usati dalla popolazione nella zona relativa alla concessione, nonché nelle lingue<br />
delle comunità o minoranze etniche e nazionali, che insistono nella zona relativa alla concessione,<br />
in deroga al disposto del comma 1 del presente articolo. La durata giornaliera dei<br />
programmi dialettali non può superare il 20% della durata media della programmazione giornaliera.<br />
La durata giornaliera della programmazione nelle lingue delle comunità o minoranze etniche<br />
e nazionali, espressa in forma di percentuale rispetto alla durata media giornaliera della<br />
programmazione, dovrà corrispondere, il più possibile, alla percentuale rappresentata dalla popolazione<br />
delle comunità o minoranze nazionali e etniche rispetto al numero totale di abitanti<br />
nella zona in concessione, senza tuttavia poter superare il 50% della durata media della programmazione.<br />
(3) I concessionari radiotelevisivi possono trasmettere programmi informativi e informazioni<br />
di utilità generale per le esigenze degli ospiti stranieri, nelle lingue straniere parlate dagli<br />
stessi, in deroga al comma 1 del presente articolo.<br />
(4) Il disposto del comma 1 del presente articolo non fa riferimento alla riproduzione di<br />
film o musica, alla trasmissione di manifestazioni religiose, teatrali e musicali e di programmi di<br />
istruzione relativi allo studio delle lingue straniere."<br />
Infrastruttura statale<br />
Estratti dalla descrizione delle competenze del Ministero per gli affari marittimi, i trasporti e le<br />
comunicazioni<br />
In ottemperanza con l'articolo 85, comma 1 della Legge sulle telecomunicazioni, detto<br />
Ministero ha la delega per le telecomunicazioni e ha il compito di sovrintendere allo stato di attuazione<br />
della legge. In ottemperanza con l'articolo 13 della legge sull'organizzazione e le competenze<br />
dei ministeri e delle amministrazioni governative tale funzione rientra nella competenza<br />
del Ministero per gli affari marittimi, i trasporti e le comunicazioni.<br />
Articolo 13<br />
" (1) Il Consiglio per le telecomunicazioni è competente in materia di concessioni per<br />
l'espletamento di attività nel settore delle telecomunicazioni pubbliche.<br />
Linee politiche<br />
Dati informativi<br />
La radio e televisione croata<br />
Tutte le minoranze nazionali hanno diritto, alle medesime condizioni, all'accesso e alla<br />
libertà di espressione alla programmazione e alle emissioni della HTV.<br />
Estratti dalla Legge sulla radio-televisione croata:<br />
Articolo 6, comma 2: "La radio-televisione croata è responsabile della produzione ed<br />
emissione del programma destinato all'informazione delle minoranze nazionali in Croazia."<br />
Articolo 8: "Nella propria programmazione, la radio-televisione croata è vincolata al rispetto<br />
dei principi dell'etica giornalistica, del pluralismo delle idee e delle fedi religiose, della tolleranza<br />
nei dibattiti, della riservatezza e di altre libertà e diritti dell'uomo".<br />
178
Infrastruttura dello Stato<br />
Linee politiche<br />
Grazie alla Costituzione della Repubblica di Croazia e alla Legge sulla pubblica informazione<br />
è garantita la libertà della stampa e di altri mezzi di comunicazione. La Repubblica di<br />
Croazia garantisce a tutte le minoranze nazionali l'accesso ai mass media, secondo quanto<br />
stabilito dalla Legge costituzionale sui diritti e le libertà dell'uomo, nonché i diritti delle comunità<br />
o minoranze etniche e nazionali.<br />
Dati informativi<br />
La radio-televisione croata<br />
La televisione croata produce e diffonde il programma di informazione delle minoranze<br />
nazionali in Croazia; tale programma, viene trasmesso soprattutto sul primo e secondo canale<br />
della radio-televisione croata, sotto forma di programmi speciali e supplementi.<br />
Partecipano alla produzione, fra gli altri, il programma di informazione, il programma di<br />
cultura religiosa e, in parte, il programma di intrattenimento, benché tutti i programmi della televisione<br />
croata, classificati per contenuto, trattano gli argomenti di interesse, quando si trovano<br />
al centro degli avvenimenti della società.<br />
Programma di informazione<br />
La radio-televisione croata trasmette programmi relativi ai problemi delle minoranze nazionali,<br />
relativamente ai seguenti gruppi: albanesi, austriaci, montenegrini, cechi, ungheresi,<br />
macedoni, musulmani-bosniaci, tedeschi, rom, ruteni, slovacchi, sloveni, serbi, italiani, ucraini,<br />
ebrei.<br />
Programma di cultura religiosa<br />
Il programma tratta della vita e del lavoro di tutte le comunità religiose della Croazia,<br />
promuove il patrimonio di civiltà costituito da tutti i valori nazionali culturali e spirituali e dalla religiosità.<br />
Gli spunti di partenza del programma sono la tolleranza interreligiosa, la cultura del dialogo,<br />
l'ecumenismo, diversità e specificità di determinate confessioni rispetto alla Chiesa cattolica,<br />
che espleta un controllo su altre comunità religiose storiche , meno numerose, esistenti nella<br />
repubblica di Croazia (Comunità ebraica, comunità islamica, chiesa evangelica, battista, avventista,<br />
serbo-ortodossa).<br />
Programma di intrattenimento<br />
Il programma di intrattenimento e musica, con musiche e costumi folk descrive e promuove<br />
il patrimonio culturale croato e illustra la musica e le tradizioni delle minoranze nazionali.<br />
Radio croata<br />
La radio croata trasmette programmi sulla vita e il patrimonio e le tradizioni culturali delle<br />
minoranze. Inoltre esistono programmi dedicati in particolare alle seguenti minoranze nazionali:<br />
ungherese, italiana, ceca, slovacca, rutena-ucraina e serba. Le associazioni di tedeschi e<br />
austriaci e di slovacchi hanno fatto richiesta di poter avviare programmi propri alla radio croata.<br />
DANIMARCA<br />
Il diritto alla libertà di espressione comprende "la libertà di ricevere e divulgare informazioni<br />
e idee nella lingua di minoranza senza interferenze da parte di autorità pubbliche e indipendentemente<br />
dalla posizione dei confini".<br />
In Danimarca la libertà di espressione è regolamentata anche dall'articolo 77 della Costituzione<br />
(Appendice 4). La tutela dalla censura e da altri mezzi preventivi, in forza dell'articolo<br />
77 della Costituzione, si applica indipendentemente dalla lingua usata per esprimersi o per ricevere<br />
informazioni.<br />
Si sottolinea che l'articolo 77 della Costituzione non impedisce interventi successivi contro<br />
espressioni in violazione di norme sostanziali, compreso il codice penale. Ovviamente il me-<br />
179
o fatto che una comunicazione venga fatta da una minoranza nazionale oppure in una lingua di<br />
minoranza non può, di per sé, costituire la base di partenza di un intervento, secondo la legge<br />
danese.<br />
Per quanto riguarda i diritti garantiti dall'articolo 9, commi 1 e 3, primo capoverso, della<br />
Convenzione quadro, non è stato necessario emendare la legislazione danese, per la ratifica<br />
della Convenzione, dal momento che la minoranza tedesca che insiste in Danimarca già gode<br />
della tutela prevista dalla Convenzione quadro a questo proposito. Non è prevista alcuna modifica<br />
alla legislazione in questo settore.<br />
Per quanto attiene i media, la Legge per le emissioni radiotelevisive crea delle opportunità<br />
per società, associazioni e organismi simili, che possono così ottenere licenze per la gestione<br />
di stazioni radiotelevisive (appendice 26). Inoltre chiunque, benché privo di tale autorizzazione<br />
locale, può ottenere la concessione per la gestione di una stazione radiotelevisiva, collegata<br />
via satellite o via cavo, in forza dell'articolo 6 di detta legge. Pertanto, le minoranze nazionali,<br />
in una situazione di parità rispetto a tutti gli altri cittadini, hanno la possibilità di istituire le<br />
proprie stazioni radiotelevisive.<br />
Esiste almeno una stazione trasmittente a disposizione di ogni comune. Le licenze vengono<br />
assegnate dal tribunale locale, che deve essere ampiamente rappresentativo delle associazioni<br />
locali della zona.<br />
Radio Denmark (DR) e TV2, con le rispettive stazioni regionali, sono organismi preposti<br />
al servizio pubblico. Ciò implica che hanno l'obbligo di soddisfare l'intera popolazione dando<br />
particolare importanza alla libertà di parola e informazione. Gli articolo 7 e 18 della legge prevedono<br />
che i programmi trattino la divulgazione di notizie, informazioni, intrattenimento e cultura e<br />
approfondiscano la qualità, il pluralismo e la diversità.<br />
Radio Denmark e TV2 trasmettono programmi relativi alla minoranza tedesca e alla situazione<br />
delle minoranze nelle zone di confine (tedeschi in Danimarca e danesi in Germania).<br />
La minoranza tedesca pubblica un proprio quotidiano ("Der Nordschleswiger") e non<br />
avverte l'esigenza di altre pubblicazioni, in quanto è possibile ricevere direttamente la TV e i<br />
giornali tedeschi.<br />
Nel 1984 è stata varata la legge per il sostegno finanziario in favore dell'Istituto finanziario<br />
della stampa quotidiana, successivamente emendata nel 1997. Detta legge ha introdotto la<br />
possibilità di fornire assistenza finanziaria ai quotidiani (appendice 27). Le sovvenzioni sono gestite<br />
dal citato Istituto, che è una fondazione privata, i cui membri sono i quotidiani danesi. L'obiettivo<br />
primario dell'Istituto è garantire che i quotidiani siano presenti nel modo più ampio e vario<br />
di quanto non sarebbe possibile alle normali condizioni di mercato, dato che viene riconosciuta<br />
la particolare importanza rivestita dai quotidiani per la società, la democrazia e la libertà<br />
di parola.<br />
ESTONIA<br />
Disposizioni costituzionali<br />
In forza dell'articolo 45 della Costituzione (RT 1992, 26, 349), ciascuno gode del diritto<br />
di divulgare liberamente idee, opinioni, convinzioni e altre informazioni, oralmente, a mezzo<br />
stampa, con immagini e altri mezzi. Tale diritto può essere limitato per legge al fine di tutelare<br />
l'ordine pubblico o la morale, oppure i diritti, le libertà, la salute, l'onore e il buon nome di altri.<br />
Tale diritto può altresì essere limitato per legge relativamente a dipendenti pubblici, a livello<br />
sia statale che locale, per proteggere segreti o informazioni di stato o d'affari, ricevuti da<br />
fonte riservata, in ragione dell'incarico ricoperto; oppure per proteggere la famiglia e la vita privata<br />
di altri, nonché gli interessi della giustizia. Non esiste la censura.<br />
L'articolo 44 della Costituzione stabilisce che ognuno ha il diritto di acquisire liberamente<br />
le informazioni divulgate ad uso del pubblico. Su richiesta di un cittadino estone, e nel rispetto<br />
delle procedure stabilite per legge, tutti i funzionari e gli organismi di governo, sia a livello<br />
centrale che locale, sono tenuti a fornire informazioni in merito alle rispettive attività, ad eccezione<br />
delle informazioni che, per legge, non si possono divulgare e di quelle destinate esclusivamente<br />
all'uso interno.<br />
Seguendo la procedura stabilita per legge, ciascun cittadino estone ha diritto ad accedere<br />
alle informazioni che lo riguardano e che sono in possesso di organismi e di archivi di go-<br />
180
verno, a livello sia centrale che locale. Tale diritto può essere limitato per legge per tutelare i diritti<br />
e le libertà di altri, oppure la riservatezza dei dati relativi ai genitori di un minore, oppure al<br />
fine di prevenire un reato penale, di catturare un criminale o di accertare la verità in un procedimento<br />
penale (Articolo 4 della Costituzione).<br />
Legislazione<br />
La Costituzione prevede delle limitazioni alla libertà di espressione solo nei casi previsti<br />
dalla legge. Il codice penale (RT 1992, 20, 287 e 288) prevede delle limitazioni per motivi connessi<br />
alla difesa nazionale, o alla tutela dei diritti, reputazione, salute o morale di altri. Le restrizioni<br />
imposte dal codice penale si possono ritenere necessarie e non discriminatorie in una società<br />
democratica. Per esempio, il codice penale stabilisce che l'incitamento all'odio nazionale,<br />
razziale, religioso o politico, la violenza o la discriminazione vengono puniti con una multa o l'arresto<br />
o restrizione della libertà fino ad un anno (art. 72, comma 1).<br />
La legislazione estone non regolamenta la stampa o l'editoria, non esiste una legge sulla<br />
stampa in quanto tale in Estonia; i casi di diffamazione vengono risolti attraverso l'uso del codice<br />
civile e penale.<br />
Attualmente chiunque può pubblicare liberamente quotidiani, periodici o libri, anche se il<br />
codice penale proibisce la stampa di certe pubblicazioni, quali quelle contenenti propaganda<br />
bellica o incitamento all'odio razziale o religioso. Le restrizioni alla libertà di espressione relative<br />
al divieto di incitazione alla discriminazione sono previste anche dalla legge sulla pubblicità (RT<br />
I 1997, 52, 853), entrata in vigore il primo gennaio 1998, che proibisce anche la pubblicità offensiva<br />
(articolo 5): "una pubblicità è offensiva se è contraria ai buoni costumi e alla morale, se<br />
incita le persone ad agire illegalmente o a violare le norme prevalenti del decoro, oppure se<br />
contiene tali attività. La pubblicità offensiva è proibita. Una pubblicità è considerata offensiva in<br />
particolare nei seguenti casi: se presenta, incita o approva la discriminazione per motivi di nazionalità,<br />
razza, colore, sesso, età, lingua, origine, religione, di opinione politica o altro e per circostanze<br />
finanziarie, per lo status sociale o altre condizioni."<br />
Le attività dei media elettronici nella Repubblica di Estonia sono disciplinate dalla legge<br />
per le emissioni e trasmissioni (RT I 1994, 42, 680), entrata in vigore il 15 giugno 1994. Tale<br />
legge prevede che chiunque possa ottenere l'autorizzazione a produrre emissioni.<br />
L'articolo 1 della legge prevede che uno dei suoi obiettivi sia disciplinare la diffusione di<br />
informazioni e i principi di fondo nel settore della diffusione.<br />
L'articolo 2 della legge dà la seguente definizione di diffusione: "per diffusione si intende<br />
la trasmissione via etere (compresa quella via satellite) o via cavo, in chiaro o criptata, di programmi<br />
radiotelevisivi destinata alla ricezione da parte del pubblico grazie all'uso di ricevitori di<br />
uso corrente". Il comma 3 (1) prevede che, ai fini della presente legge, un trasmettitore è un insieme<br />
di mezzi tecnici, che permette la trasmissione nello spazio di un segnale radiotelevisivo.<br />
I principi che disciplinano le attività di diffusione sono contenuti nel capitolo II. Un soggetto<br />
che svolga questa attività, nel rispetto della legge e delle condizioni della licenza, ha il diritto<br />
di decidere liberamente il contenuto dei programmi (art. 6, comma 1). Pertanto è vietata la<br />
trasmissione di programmi il cui contenuto sia in conflitto con i principi della Costituzione o con<br />
leggi che proibiscono la discriminazione o l'incitamento alla discriminazione. Tale divieto è stabilito<br />
all'articolo 9 che garantisce gli standard del decoro e della legalità: "I soggetti che si occupano<br />
di trasmissioni radiotelevisive non possono trasmettere programmi il cui contenuto sia immorale<br />
oppure in conflitto con la Costituzione o le leggi".<br />
Ai sensi dell'articolo 13, i soggetti che si occupano delle trasmissioni radiotelevisive devono<br />
nominare dei produttori esecutivi, o figure equivalenti, responsabili dei programmi, che dovranno<br />
garantire, fra l'altro, che i rispettivi programmi rispettino i requisiti di legge e osservino il<br />
principio della libertà di espressione.<br />
Ai fini della legge per le emissioni e trasmissioni, la Radio Estone e la Televisione Estone<br />
sono enti radiotelevisivi in regime di diritto pubblico. L'articolo 25, che stabilisce le funzioni<br />
della Radio e Televisione Estoni, afferma, tra l'altro, che compete loro la responsabilità, di soddisfare<br />
le esigenze informative di tutte le nazionalità, comprese le minoranze nazionali. L'articolo<br />
26 stabilisce i requisiti di base per i programmi e i servizi della Radio e Televisione Estoni; inoltre<br />
l'articolo 26, comma 2, stabilisce che i programmi e i servizi della Radio e Televisione Estoni<br />
devono porsi l'obiettivo di far rispettare a tutti la dignità dell'uomo e il rispetto delle leggi,<br />
tenendo in considerazione le convinzioni morali, politiche e religiose delle varie nazionalità.<br />
181
Il sistema delle licenze per i media elettronici<br />
La legge per le emissioni e trasmissioni (in particolare art. 23, comma 2 e art. 37) stabilisce che<br />
le persone in regime di diritto privato possono lavorare nel settore delle emissioni sulla base di<br />
una licenza. Si tratta di un documento dello Stato, concesso in cambio del pagamento di una<br />
tariffa, che concede alla persona titolare della licenza il diritto di operare alle condizioni specificate<br />
nella licenza stessa.<br />
La tariffa da corrispondere per ottenere la licenza è determinata dal Ministero della Cultura.<br />
La licenza viene revocata nei casi previsti dalla legge, fra l'altro, quando la persona registrata<br />
nella licenza viola i requisiti della legge per le emissioni e trasmissioni. L'articolo 43 stabilisce<br />
che per la violazione della legge per le emissioni e trasmissioni esiste, per legge, la responsabilità<br />
disciplinare, civile o amministrativa.<br />
Supervisione<br />
Le attività della stampa sono oggetto della supervisione del Consiglio per la Stampa. Si<br />
tratta di un organismo di autoregolamentazione per la stampa, che opera in due settori principali:<br />
tutela della libertà di parola in caso di tentativi di restrizione e pubbliche denunce contro la<br />
stampa. L'attività di autoregolamentazione comprende la supervisione e la disciplina interne,<br />
prevenendo le interferenze dall'esterno (potere dello Stato, tribunali). Tale aspetto è essenziale<br />
dal punto di vista di una maggiore responsabilità dei media, che deve accompagnare la libertà<br />
di espressione, l'apertura della società e un buon livello di informazione del pubblico, aspetto,<br />
quest'ultimo, di grande rilevanza.<br />
Dati informativi<br />
L'Estonia ha una politica liberale per quanto riguarda la stampa: per fondare un quotidiano<br />
non sono necessarie licenze, permessi o registrazioni. Lo stesso vale per l'utilizzo dei<br />
servizi di un impianto tipografico oppure per la distribuzione di una pubblicazione.<br />
La legislazione estone garantisce espressamente l'accesso ai media delle minoranze<br />
nazionali. Lo Stato non può interferire con la programmazione radiotelevisiva e non può decidere<br />
il contenuto degli articoli da stampare.<br />
Negli ultimi otto anni il numero dei quotidiani russi è aumentato considerevolmente (attualmente<br />
sono 15).<br />
La pubblicazione dei periodici riferibili alle minoranze nazionali costituiscono un settore<br />
specifico. Ogni anno, sulla base dei progetti presentati, vengono concesse delle sovvenzioni direttamente<br />
tramite il bilancio dello Stato, per la pubblicazione di periodici riferibili alle minoranze.<br />
La radio estone, in quanto ente radiofonico in regime di diritto pubblico, trasmette programmi<br />
anche nelle lingue di minoranza. I programmi in lingua russa sensibilizzano il pubblico<br />
in merito ai diversi gruppi etnici, comprese le minoranze nazionali.<br />
La stazione radio di lingua russa Raadio 4 trasmette diversi programmi nelle lingue di<br />
minoranza, quali l'armeno, l'ucraino e il bielorusso.<br />
Il pubblico televisivo di lingua diversa dall'estone può scegliere tra vari canali russi ed<br />
estoni, che trasmettono in russo.<br />
La televisione estone, che, come citato in precedenza, è un ente televisivo in regime di<br />
diritto pubblico, trasmette anche in lingua russa. Anche la stazione privata TV1 trasmette un notiziario<br />
in russo.<br />
Il numero di utenti internet in Estonia è più che decuplicato in quattro anni. Nell'autunno<br />
del 1998, la percentuale di utenti internet estoni era pari al 79%, mentre quella di non-estoni era<br />
del 21%.<br />
FINLANDIA<br />
L'articolo 10 della Costituzione stabilisce che tutti godono del diritto alla libertà di espressione.<br />
Disposizioni più precise in merito all'esercizio del diritto alla libertà di espressione<br />
sono previste da apposita legge. L'articolo 1 della Legge sulla libertà di stampa stabilisce che<br />
"ogni cittadino finlandese ha il diritto di pubblicare scritti, senza che le pubbliche autorità abbiano<br />
facoltà di frapporre ostacoli preventivi, a condizioni che siano osservate le disposizioni della<br />
presente legge."<br />
182
In Finlandia le diffusioni radiotelevisive sono di competenza del Ministero dei Trasporti e<br />
delle Comunicazioni. Le diffusioni radiotelevisive sono soggette al rilascio di una licenza. All'atto<br />
della concessione della licenza vengono presi in particolare considerazione i seguenti aspetti:<br />
promozione della libertà di parola, diversificazione dei programmi, le esigenze di gruppi speciali.<br />
Il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni ha messo a punto i nuovi strumenti legislativi<br />
in merito alle attività radiotelevisive, che sono entrati in vigore il primo gennaio 1999. La<br />
riforma ha previsto la modifica dell'articolo 7 della legge che disciplina l'ente radiotelevisivo finlandese.<br />
E' stato modificato l'obbligo di uguale trattamento dei cittadini di lingua finlandese e<br />
svedese, nonché di produrre servizi in lingua sami, introducendo l'obbligo di produrre servizi in<br />
lingua rom e lingua dei segni.<br />
I media in pratica<br />
Esistono programmi TV specifici per la popolazione di lingua svedese (9% della produzione<br />
di due diversi canali televisivi di proprietà dello Stato) e due canali radiofonici di portata<br />
nazionale, oltre alle stazioni radiofoniche locali. I programmi televisivi sono parzialmente sottotitolati<br />
in svedese. In Finlandia diversi quotidiani e riviste vengono pubblicati in svedese.<br />
I Sami hanno un proprio canale radiofonico (Radio Sami), attivo nella zona d'origine,<br />
che trasmette per circa 40 ore la settimana. Esiste anche un servizio di text TV in lingua sami.<br />
I Rom dispongono di tre giornali, due dei quali pubblicati da una associazione rom nazionale<br />
e uno dalla Associazione Nazionale dell'Istruzione. Questi tre giornali vengono tutti pubblicati<br />
in finlandese e contengono alcuni articoli in lingua rom. Una volta la settimana una delle<br />
reti radiofoniche nazionali trasmette un notiziario in lingua rom.<br />
L'Ente Radiotelevisivo finlandese trasmette anche notiziari in russo.<br />
GERMANIA<br />
In Germania, a livello generale, la libertà di espressione è ampiamente garantita dall'art.<br />
5, comma 1, primo capoverso, della Legge Fondamentale e dall'art. 10 della Convenzione Europea<br />
per i Diritti dell'Uomo. La Legge Fondamentale salvaguarda il diritto sia di esprimere liberamente<br />
e divulgare le proprie opinioni, oralmente, per iscritto e attraverso immagini, sia di mantenere<br />
riservata la propria opinione personale ("libertà di espressione negativa"). Tale tutela riguarda<br />
opinioni in forma di giudizi [personali] o comportamenti; il concetto di "opinione" va inteso<br />
nel senso più ampio e, oltre ai giudizi di valore, riguarda anche dichiarazioni di fatto, ove<br />
queste siano un requisito per la formazione delle opinioni. A questo proposito, non ha importanza<br />
se una data opinione sia obiettivamente corretta o falsa. Pertanto, come input e base di analisi<br />
e discussione vengono tutelate anche espressioni di opinione false, reprensibili e di parte,<br />
entro i limiti prescritti dall'articolo 5, comma 2, della Legge Fondamentale (ovvero violazione<br />
delle norme delle leggi generali, disposizioni di legge per la tutela dei giovani e diritto all'inviolabilità<br />
dell'onore personale). La libertà di espressione è accordata a tutti i cittadini tedeschi e pertanto,<br />
ovviamente, ai gruppi tutelati dalla Convenzione quadro, e agli stranieri.<br />
Il diritto fondamentale alla libertà di parola fornisce in primo luogo una tutela dall'interferenza<br />
del governo. Inoltre obbliga lo Stato a salvaguardare tale libertà. L'articolo 5, comma 1,<br />
primo capoverso della Legge Fondamentale garantisce anche la libertà di informazione, come<br />
diritto fondamentale (diritto ad informarsi, senza ostacoli, da fonti generalmente accessibili). Tale<br />
tutela riguarda sia l'acquisizione attiva di informazioni sia il semplice riceverle. In particolare<br />
la minoranza danese dello Schleswig -Holstein si serve dei programmi radiotelevisivi e della<br />
stampa del Regno di Danimarca, provenienti da oltrefrontiera, nel proprio territorio tradizionale<br />
di insediamento.<br />
La libertà di espressione si manifesta anche attraverso la libertà di creare e usare dei<br />
media (stampa, radio e televisione e altri mezzi di comunicazione). L'articolo 5, comma 1, primo,<br />
secondo e terzo capoverso della Legge Fondamentale garantisce la libertà di stampa e la<br />
libertà di riferire notizie, per mezzo di diffusioni radiotelevisive e film, senza censura. La libertà<br />
di stampa e radiotelevisiva implicano, in particolare, il principio del non-intervento governativo,<br />
che proibisce qualsiasi interferenza dello Stato, che non è compatibile con la libertà di stampa e<br />
radiotelevisiva e che non è garantito dalle limitazioni a tali diritti previsti dall'articolo 5, comma 2<br />
della Legge Fondamentale.<br />
183
Per quanto riguarda la stampa queste garanzie costituzionali sono state dettagliatamente<br />
sviluppate e confermate in via giudiziaria attraverso le sentenze della Corte Costituzionale<br />
Federale e dalle varie Leggi sulla stampa dei Länder, che costituiscono la base per lo sviluppo<br />
libero ed economicamente autonomo della stampa nella Repubblica Federale di Germania.<br />
La libertà di diffusione radiotelevisiva, come la libertà di stampa è un fattore essenziale<br />
nel processo di formazione dell'opinione pubblica e nell'articolazione della volontà politica. Come<br />
la stampa, la diffusione radiotelevisiva ha autonomia istituzionale. Nel rispetto del mandato<br />
costituzionale sulla radiodiffusione, non è sufficiente che lo Stato si astenga da qualsiasi interferenza,<br />
lasciando agli attori sociali il compito di gestire la diffusione radiotelevisiva in tutti gli altri<br />
aspetti. Viene piuttosto richiesta una certa forma di struttura e regolamentazione. Nella Repubblica<br />
Federale di Germania esiste il cosiddetto sistema di diffusione radiodiffusione duale, ovvero<br />
l'esistenza del servizio pubblico a fianco delle emittenti private, tramite il quale lo Stato garantisce<br />
che, grazie all’offerta complessiva da parte di tutti gli enti di diffusione radiotelevisiva,<br />
l’attività di informazione soddisfi i requisiti stabiliti dalla Costituzione per quanto riguarda la diversità<br />
equilibrata, ovvero la possibilità di incoraggiare l’individuo a formare liberamente la propria<br />
opinione e la propria immagine della diversità culturale.<br />
Per la struttura federale della Germania, la competenza per la diffusione radiotelevisiva,<br />
e quindi la garanzia della diversità di opinione, è assegnata ai Länder. La base giuridica per la<br />
diffusione radiotelevisiva è costituita dai Trattati statali per la diffusione, conclusi tra i Länder.<br />
Tali Trattati stabiliscono i requisiti minimi in base ai quali i Länder, a loro volta, adottano<br />
regolamenti dettagliati, nei rispettivi ambiti di competenza, tramite le proprie leggi sui media. Tali<br />
leggi comprendono le norme e i requisiti relativi ai programmi, con specifico riferimento al Land<br />
in argomento; tali misure hanno lo scopo di assicurare il pluralismo di opinione e la libertà di espressione.<br />
Tali leggi regolamentano anche per la concessione delle licenze agli enti privati.<br />
L’articolo 3, commi 1 e 3, della Legge Fondamentale proibisce la discriminazione per<br />
quanto riguarda l’accesso ai media, pertanto anche le minoranze nazionali e i gruppi etnici tutelati<br />
dalla Convenzione quadro godono dell’accesso alle stesse condizioni previste per la popolazione<br />
di maggioranza. A questo proposito, vale la pena ricordare gli organismi di supervisione<br />
e controllo che hanno il dovere di salvaguardare la diversità di opinione e garantire il rispetto dei<br />
principi di programmazione delle diffusioni radiotelevisive. I principali gruppi politici, filosofico/ideologici<br />
e sociali possono partecipare in misura adeguata agli organismi di supervisione<br />
degli enti del servizio pubblico, nonché alle Autorità di Supervisione dei Länder competenti per<br />
gli enti privati, alla Associazione per la Diffusione Radiotelevisiva e alla commissione per la diffusione<br />
radiotelevisiva/Consiglio dei media. La composizione di questi organismi è talmente diversificata<br />
che tutti i gruppi sociali interessati hanno sufficienti possibilità di esprimere la propria<br />
opinione. Oltre a rappresentare gli interessi delle proprie associazioni, o gruppi, i membri di<br />
questi organismi contribuiscono anche a dare una visione complessiva e variegata relativamente<br />
ad argomenti di rilevanza sociale arricchendo così le deliberazioni di tali organismi.<br />
Alcuni rappresentanti dei membri delle minoranze nazionali sono stati eletti a far parte<br />
degli organismi per la diffusione radiotelevisiva (Danesi e Sorabi).<br />
Nel settore della stampa non esistono organismi di supervisione regolamentati per legge,<br />
a causa delle condizioni generali riguardanti la libertà di stampa, garantita dalla Costituzione,<br />
che prevede un gran numero di prodotti che, per orientamento politico, visione del mondo o<br />
ideologia sono in competizione fra loro.<br />
Le libertà succitate, in linea di principio, possono essere esercitate anche dalle minoranze<br />
nazionali nella rispettiva lingua di minoranza.<br />
La regolamentazione delle diffusioni radiotelevisive rientra nella giurisdizione dei Länder.<br />
L'articolo 5, comma 1, secondo capoverso della Legge Fondamentale (libertà di diffusione<br />
radiotelevisiva) non impone a nessun Land di adottare una specifica forma organizzativa per la<br />
diffusione. Tuttavia i Länder sono tenuti ad adottare determinate misure per garantire la libertà<br />
di diffusione radiotelevisiva. Essendo una questione di interesse pubblico, la diffusione radiotelevisiva<br />
deve essere organizzata su base apartitica ed in piena indipendenza e deve essere tutelata<br />
da qualsiasi intervento di parte. Gli enti radiotelevisivi pubblici, in particolare, devono fornire<br />
informazioni complete all'interno della propria programmazione e permettere la pluralità delle<br />
opinioni. Per quanto riguarda gli enti privati, il legislatore deve garantire che anch'essi rispettino<br />
i requisiti costituzionali e, in particolare, che sia raggiunto il più alto livello possibile di diversità<br />
bilanciata. La normativa esistente in merito alle concessioni radiotelevisive si basa esclusi-<br />
184
vamente su criteri obiettivi. Le condizioni per la concessione delle licenze sono stabilite nelle<br />
leggi sui media dei vari Länder.<br />
Le minoranze nazionali e la popolazione di maggioranza godono degli stessi diritti e<br />
possibilità per quanto riguarda la libertà di stampa e di diffusione radiotelevisiva. Inoltre, in considerazione<br />
delle attuali politiche di promozione a livello federale e di Länder, i gruppi tutelati in<br />
forza della Convenzione quadro possono godere della libertà di stampa e di diffusione radiotelevisiva.<br />
A questo proposito vale la pena notare, che, per le diverse dimensioni e capacità economiche<br />
e pratiche dei gruppi protetti, questi usano i media in misura diversa.<br />
Il diritto a creare e servirsi dei media della carta stampata è garantito dalla libertà di informazione<br />
e di stampa, prevista dall'articolo 5, comma 1 della legge Fondamentale. Non esiste<br />
la censura, pertanto, nel rispetto dell'ordine costituzionale, tutti possono dedicarsi al lavoro giornalistico<br />
e alle attività dei mass media. La libertà di stampa, garantita dalla Legge Fondamentale,<br />
si manifesta nel gran numero di pubblicazioni riferibili ai gruppi protetti dalla Convenzione<br />
quadro.<br />
Esistono pubblicazioni in danese, sorabo, frisone (anche nella varietà parlata nel Saterland)<br />
e romany (benché fra i Sinti tedeschi ci sia la convinzione che la lingua romany vada coltivata<br />
solo a livello di famiglia e clan).<br />
Come nel caso della stampa, anche la creazione dei media nel campo della diffusione<br />
radiotelevisiva dipende dalle dimensioni del gruppo tutelato e dalla sua capacità economica.<br />
Quando la creazione vera e propria non è possibile, normalmente sono disponibili i cosiddetti<br />
"canali aperti", che vengono usati per la divulgazione locale e regionale di prodotti non<br />
commerciali, creati e trasmessi, sotto la propria responsabilità, da individui e gruppi. La minoranza<br />
danese si serve occasionalmente dei canali aperti e quella frisone sta preparando un<br />
progetto pilota.<br />
Minoranza danese<br />
Questa minoranza è insediata nella parte settentrionale del Land Schleswig-Holstein,<br />
dove è possibile ricevere i programmi del Regno di Danimarca.<br />
Minoranza soraba<br />
Questa minoranza è tradizionalmente insediata nel Libero Stato della Sassonia e nel<br />
Land del Brandeburgo, dove esistono numerosi programmi radiotelevisivi in lingua soraba, riguardanti<br />
la cultura e le tradizioni di questa minoranza. Particolare attenzione è riservata alla<br />
tradizione musicale di questa minoranza.<br />
Minoranza frisone in Germania<br />
I programmi in lingua frisone sono molto limitati.<br />
I Sinti e i Rom tedeschi<br />
Dato che i Sinti e i Rom tedeschi sono distribuiti più o meno su tutto il territorio della<br />
Germania, la creazione di media propri o la loro partecipazione ai cosiddetti Canali aperti è difficile<br />
per ragioni pratiche ed economiche. Pertanto le associazioni dei Sinti e Rom tedeschi sono<br />
principalmente interessati a mantenere vivo il dialogo con gli enti radiotelevisivi e con la stampa<br />
affinché le notizie vengano riferite senza pregiudizi e per sensibilizzare il pubblico in merito alla<br />
possibilità che rapporti e notizie negativi possono fomentare pregiudizi ancora esistenti in alcune<br />
parti della società. I Sinti tedeschi ritengono che la propria lingua deve essere usata a livello<br />
familiare e di clan. Esistono programmi radiofonici in lingua Romany.<br />
Uno degli obiettivi delle organizzazioni più rappresentative delle minoranze in Germania,<br />
per quanto riguarda la politica dei media, è quello di ottenere una maggiore copertura degli<br />
argomenti connessi alle minoranze e una diffusione di notizie più intensa e priva di pregiudizi,<br />
per informare la popolazione della Repubblica Federale in merito alle minoranze e le rispettive<br />
identità. In relazione a tale obiettivo, i danesi, i sorabi e i frisoni auspicano che le rispettive lingue<br />
siano oggetto di ulteriori programmi radiofonici.<br />
Per quanto riguarda l'accesso ai media da parte delle minoranze nazionali alcune leggi<br />
sui media dei Länder fanno particolare riferimento alle minoranze, senza limitazioni ai gruppi tutelati<br />
dalla Convenzione quadro. Pertanto la seguente disposizione è stata inserita nel Trattato<br />
185
di Stato sulla cooperazione tra Berlino e il Brandeburgo nel settore della diffusione radiotelevisiva<br />
del 29 febbraio 1992:<br />
"Gli enti radiotelevisivi privati con autorizzazione relativa all'area di competenza del presente<br />
Trattato di Stato dovranno dare espressione alla pluralità di opinione nei contenuti dei programmi.<br />
Ai gruppi e agli attori politici, filosofici/ideologici e sociali dovrà essere dato uno spazio<br />
adeguato per esprimere le proprie opinioni in programmi di informazione generali e specializzati;<br />
devono essere prese in considerazione le opinioni delle minoranze."<br />
Inoltre detto Trattato prevede l'obbligo che la programmazione in generale promuova<br />
una convivenza pacifica tra stranieri e tedeschi.<br />
Nel Land dell'Assia, la legge sulla diffusione radiotelevisiva privata (art. 13, comma 1)<br />
stabilisce che i programmi devono contribuire alla "tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche".<br />
IRLANDA<br />
Uno degli aspetti della libertà della persona garantita dalla costituzione è il diritto dei cittadini<br />
ad esprimere liberamente le proprie opinioni e convinzioni.<br />
Il diritto alla libertà d’espressione è riconosciuto dall’art. 40.6.1.(i) della Costituzione:<br />
[Lo Stato garantisce la libertà di esercitare i seguenti diritti, fatti salvi l’ordine e la morale pubblici:]<br />
i) Diritto dei cittadini di esprimere liberamente le proprie idee ed opinioni.<br />
Tuttavia, dal momento che l’educazione dell’opinione pubblica è un problema di enorme<br />
importanza per il bene comune, lo Stato garantirà che gli organi di informazione pubblica, come<br />
la radiotelevisione, la stampa, la cinematografia, pur mantenendo la propria legittima libertà di<br />
espressione, compresa la critica verso la politica del governo, non siano usati per minare<br />
l’ordine e la morale pubblici, né l’autorità dello Stato.<br />
La libertà di esprimere le proprie idee ed opinioni implica di per sé il diritto di poterle<br />
comunicare agli altri.<br />
Accesso ai mezzi di informazione<br />
Nessuna legge irlandese è discriminante nei confronti di appartenenti a minoranze per<br />
quanto concerne il loro accesso ai mezzi di informazione. L’emittente pubblica RTE si impegna<br />
a raggiungere un ampio spettro della popolazione compresi gli appartenenti alle minoranze e<br />
alla comunità dei nomadi.<br />
La Commissione per una società dell’informazione è un’agenzia governativa incaricata<br />
di elaborare e controllare l’attuazione di un quadro strategico per lo sviluppo di una società<br />
dell’informazione in Irlanda. La Commissione, promuove, coordina ed attua un costante controllo<br />
delle attività previste dal <strong>Governo</strong> e da altri enti principali relativamente allo sviluppo di una<br />
società dell’informazione. La Commissione raccomanda l’adozione di misure volte ad accrescere<br />
l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nelle case, nelle scuole,<br />
nelle imprese, negli uffici pubblici con particolare attenzione a quelle rivolte ai gruppi in condizioni<br />
di disagio. Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) si stanno rapidamente<br />
trasformando in una realtà in tutti i campi dell’attività economica e sociale. I temi chiave<br />
che la Commissione per una società dell’informazione è chiamata a coordinare sono i seguenti:<br />
- facilitazione all’accesso alle ICT, anche attraverso un contenimento dei costi relativi<br />
all’interazione con una società dell’informazione;<br />
- accesso alla formazione, onde garantire a tutti l’acquisizione e lo sviluppo delle competenze<br />
necessarie per una piena partecipazione alla società dell’informazione.<br />
186
Le applicazioni informatiche devono essere accessibili a tutti e i vari servizi devono essere<br />
facilmente utilizzabili da tutti.<br />
I principali gruppi presi in considerazione comprendono sia il pubblico in generale che i<br />
gruppi minoritari. Nel suo primo rapporto del dicembre 1997, la Commissione ha evidenziato la<br />
necessità di elaborare proposte di formazione che tengano conto delle esigenze dei gruppi emarginati<br />
in relazione alla società dell’informazione.<br />
La Commissione per una società dell’informazione ha prodotto una serie di rapporti su<br />
temi riguardanti l’accesso alle informazioni e l’integrazione sociale. A gennaio 1999, il <strong>Governo</strong><br />
ha pubblicato un piano d’azione denominato “Realizzare una società dell’informazione in Irlanda”,<br />
nel quale si invitava la Commissione per una società dell’informazione a “terminare la propria<br />
valutazione sia di merito che pratica in relazione alla possibilità di dotare ogni cittadino di un<br />
indirizzo di posta elettronica e di un accesso ad Internet”. In risposta a tale invito, detta Commissione<br />
ha preso in considerazione il più ampio tema dell’accesso per tutti alle tecnologie<br />
dell’informazione, concludendo che sarebbe opportuno agire in favore dei gruppi emarginati ed<br />
in condizioni di disagio.<br />
Nel marzo 2000 la Commissione per una società dell’informazione ha pubblicato un<br />
rapporto dal titolo “Accesso per tutti alle tecnologie dell’informazione” Il rapporto conteneva un<br />
capitolo specifico intitolato “Integrazione sociale e società dell’informazione”. Nel rapporto si afferma<br />
quanto segue: “Le persone già emarginate nella società sono i gruppi che, potenzialmente,<br />
potrebbero trarre il maggior beneficio dall’accesso e dall’utilizzo della tecnologia<br />
dell’informazione e della comunicazione. Ma i problemi che accompagnano l’esclusione sociale<br />
sono gli stessi che rendono più difficile la concreta realizzazione delle proprie opportunità, da<br />
parte di questa parte della comunità”.<br />
Nel proprio rapporto conclude che il concetto stesso di società dell’informazione implica<br />
una situazione di parità, nella quale ciascuno ha le medesime opportunità di beneficiare dei<br />
progressi tecnologici, raccomandando quanto segue: “un orientamento prevalentemente sociale<br />
dovrebbe essenzialmente garantire che i principali benefici dell’Era dell’informazione siano distribuiti<br />
uniformemente all’interno della società”.<br />
Nel settore dell’istruzione, l’Irlanda intende lanciare un programma nazionale di avviamento<br />
alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, rivolto agli adulti.<br />
I principali elementi di questo programma comprenderanno: un programma nazionale di<br />
formazione in ICT; assistenza tecnica ai formatori nel settore della formazione rivolta agli adulti,<br />
per permettere loro di mantenere, migliorare e collegare in rete i propri mezzi informatici e varie<br />
misure ad integrazione dei corsi di perfezionamento per il personale ed a supporto dei programmi<br />
dei corsi stessi.<br />
Nelle scuole già da tempo ci si sta adoperando per dotare ciascuno studente di quanto<br />
necessario per accedere a questo tipo di tecnologie. Nell’ambito del progetto IT 2000, il Ministero<br />
dell’Istruzione e delle Scienze ha erogato stanziamenti per un ammontare di circa £ 41 milioni<br />
(fine 2000) in favore di varie iniziative volte ad integrare l’insegnamento e l’apprendimento con<br />
moderne tecnologie dell’informazione e della comunicazione.<br />
Il Ministro dei Beni Culturali del Gaeltacht e delle Isole è competente in materia di politica<br />
audiovisiva. Tuttavia, l’Ufficio del Direttore della Regolamentazione delle Telecomunicazioni<br />
è l’ente preposto all’assegnazione delle frequenze radio ed alla concessione delle licenze alle<br />
emittenti, mentre al Ministro delle Imprese Pubbliche sono riservate determinate attribuzioni in<br />
ordine alla ripartizione delle frequenze radio.<br />
Le Leggi sull’Autorità responsabile per i mezzi audiovisivi 1963-1999, la Legge sulla radiotelevisione<br />
del 1998 e la Legge sull’audiovisivo del 2001 costituiscono il quadro normativo di<br />
riferimento per le attività di radiodiffusione in Irlanda. Tali leggi prevedono la creazione di Radio<br />
Telefis Eireann quale servizio pubblico nazionale di radiodiffusione autorizzandolo a trasmettere<br />
programmi audiovisivi in ambito nazionale, regionale, locale e comunitario.<br />
187
Tale autorità dispone, nei limiti consentiti dalle relative disposizioni normative, di una<br />
certa autonomia regolamentare nella trattazione delle normali attività di routine e, in particolare,<br />
nella programmazione. Per quanto riguarda la preparazione dei palinsesti nazionali, l’art. 28 della<br />
legge sulla radiotelevisione del 2001 impone alla RTE l’obbligo di:<br />
[...] proporre una gamma completa di trasmissioni in inglese e irlandese che rispecchi la<br />
diversità culturale dell’intera isola d’Irlanda e preveda la programmazione in radio ed in televisione...<br />
di programmi che intrattengano, informino, educhino, si occupino di ogni tipo di attività<br />
sportiva, religiosa e culturale rispondendo alle attese del pubblico in generale e di chi appartiene<br />
a gruppi che abbiano particolari interessi o siano minoritari, sempre nel rispetto della dignità<br />
umana”.<br />
La legge sulla radiotelevisione del 1998 ha previsto la costituzione di una Commissione<br />
Indipendente per la Radio e la Televisione, cui è demandato il compito di gestire alcune stazioni<br />
radiofoniche ed una stazione televisiva indipendenti della RTE, nei limiti delle frequenze radio<br />
disponibili. Ribattezzata “Broadcasting Commission of Ireland” (B.C.I.) (Commissione irlandese<br />
delle comunicazioni) ad essa è stato conferito un più ampio mandato, in considerazione<br />
dell’adozione di tecnologie digitali per le trasmissioni televisive.<br />
Attualmente si contano 56 radio indipendenti in Irlanda, di cui 27 stazioni commerciali,<br />
22 stazioni rivolte a comunità o ad un pubblico con particolari interessi, 7 stazioni al servizio di<br />
alcune istituzioni ed una televisione nazionale indipendente autorizzata a trasmettere dalla<br />
B.C.I.<br />
Nessuna legge irlandese impedisce alle minoranze di creare o utilizzare organi di stampa.<br />
Per quanto riguarda le trasmissioni radiotelevisive, le richieste di autorizzazione a trasmettere<br />
possono essere presentate alla BCI (Broadcasting Commission of Ireland) conformemente a<br />
quanto previsto dalla legge sui mezzi audiovisivi del 1998 per i programmi radio e dalla legge<br />
sui mezzi audiovisivi del 2001 per le trasmissioni della televisione digitale.<br />
Per il rilascio di queste autorizzazioni, la BCI oltre ad applicare specifici criteri, ha anche<br />
l’obbligo di: “verificare che il numero e le categorie dei servizi di diffusione radiotelevisiva autorizzati<br />
dallo Stato in forza della legge del 2001 o del 1998 rispondano alle esigenze del popolo<br />
irlandese tenendo conto delle rispettive lingue e tradizioni, nonché della diversità religiosa, etnica<br />
e culturale”.<br />
Per quanto attiene alla comunità dei Nomadi, varie organizzazioni ad essa riferibili hanno<br />
pubblicato libri e documenti. Il Pavee Point Travellers Centre, nell’ambito del proprio programma<br />
di ricerca, valutazione e pubblicazione, ha una sua sezione editoriale che propone una<br />
vastissima gamma di opere dedicate alla comunità dei Nomadi ed alla discriminazione in generale.<br />
L’Irish Traveller Movement (ITM) pubblica un bollettino periodico. Alcune organizzazioni<br />
riferibili ai Nomadi dispongono di siti internet completi; tra queste: l’Irish Traveller Movement, il<br />
Pavee Point Travellers Centre e l’Exchange House Travellers Service.<br />
La Commissione ricorsi, istituita dalla legge sulla diffusione radiotelevisiva del 2001 è<br />
investita del compito di esaminare e redimere le questioni riguardanti ricorsi per violazione degli<br />
obblighi giuridici da parte delle emittenti radiotelevisive.<br />
L’articolo 18 della legge sulla diffusione radiotelevisiva del 1960 (modificato dall’articolo<br />
8 della legge del 1976) impone all’autorità della RTE l’obbligo di imparzialità e obiettività per<br />
quanto riguarda le questioni oggetto di pubbliche controversie o di dibattito politico.<br />
La consapevolezza dei media in questi ultimi anni si è notevolmente sviluppata per<br />
quanto riguarda la divulgazione delle notizie in merito al razzismo ed alla discriminazione.<br />
Tale circostanza si evidenzia nell’elevato numero di iniziative adottate dalle organizzazioni dei<br />
Nomadi, dall’NCCRI e dall’Unione Nazionale dei Giornalisti (NUJ).<br />
L’articolo 10 del codice d’etica professionale della NUJ prevede che:<br />
“Un giornalista farà riferimento all’età, al sesso, alla razza, al colore, al credo, alla nascita illegittima,<br />
alla disabilità, allo stato civile o all’orientamento sessuale di una persona solo nel caso in<br />
188
cui tali informazioni siano strettamente pertinenti. Nessun giornalista produrrà o tratterà informazioni<br />
che incoraggino il lettore o lo spettatore a discriminare, ridicolizzare o odiare la persona<br />
interessata o che siano basate sulle caratteristiche sopracitate”.<br />
L’art. 15 dello statuto del NUJ affida ad una commissione d’etica professionale il compito<br />
di dare massima diffusione al proprio codice di comportamento e di garantire la promozione e<br />
l’applicazione delle proprie norme etiche e deontologiche. L’Unione dispone, inoltre, di una<br />
Commissione per la Parità ed una Commissione dei Membri Neri (con il compito specifico, previsto<br />
in forza dell’art. 17 dello statuto, di organizzare campagne antirazziste nei mezzi di informazione).<br />
Ad aprile 1996, il NUJ ha elaborato – in collaborazione con organizzazioni per la tutela<br />
dei Nomadi – delle specifiche “Direttive sul nomadismo” che integreranno il Codice deontologico<br />
del NUJ. Queste direttive rappresentano una tappa importante ma, a detta dello stesso<br />
NUJ, insufficiente a sradicare il razzismo di cui sono vittime queste popolazione nell’ambito dei<br />
media.<br />
Le direttive NUJ relative la divulgazione delle notizie che riguardano membri della comunità<br />
nomade stabiliscono quanto segue:<br />
- è appropriato utilizzare il termine “Nomade/i” (che , in quanto nome proprio, va scritto con la<br />
lettera maiuscola), altri termini, sia di tipo gergale che obiettivi, vanno evitati;<br />
- il riferimento all’origine etnica di un individuo deve essere fatto solo se di pertinenza. Come<br />
previsto dall’art. 3 del codice etico dell’Unione, devono essere usate soltanto informazioni<br />
pertinenti ed accurate;<br />
- i giornalisti devono costantemente tenere presente il rischio legato alla possibilità di esacerbare<br />
le tensioni intercomunitarie ed impegnarsi a ridurre al minimo tale eventualità;<br />
- i giornalisti devono adoperarsi affinché nel loro articoli nulla induca la gente a pensare che i<br />
Nomadi non siano cittadini a pieno titolo dello Stato con tutti i diritti ed i privilegi che ne conseguono;<br />
- nel riportare le notizie sui Nomadi, giornalisti devono inoltre sforzarsi di dare spazio alle opinioni<br />
di questi ultimi e delle rispettive organizzazioni, nel rispetto del diritto alla riservatezza e<br />
del diritto a nominare un portavoce che ne rappresenti le opinioni.<br />
Considerato il ruolo fondamentale svolto dai media nell’informazione, nella definizione<br />
di atteggiamenti e nella presa di coscienza di alcuni problemi, gli appartenenti al NUJ sono invitati<br />
ad impegnarsi consapevolmente per accrescere la propria conoscenza della diversità culturale.<br />
L’Unione auspica che tali direttive siano in grado di favorire tale processo.<br />
Campagna “Citizen Traveller”<br />
Tale campagna rientra nell’ambito di un progetto finalizzato ad avvicinare i nomadi ai<br />
mezzi di informazione, nonché ad avvicinare la comunità nomade a quella sedentaria.<br />
Il 24 ottobre 2000 è stato lanciato un programma governativo di sensibilizzazione sul<br />
tema del razzismo, con un finanziamento annuo di £ 1,5 milioni.<br />
Gli obiettivi perseguiti sono i seguenti: stimolare una presa di coscienza ed una conoscenza<br />
da parte del pubblico in merito alla diversità culturale in Irlanda, contribuire a creare le<br />
condizioni tali da scoraggiare il razzismo, contribuire a quelle politiche che promuovono<br />
l’integrazione di gruppi minoritari, compresi i rifugiati ed i richiedenti asilo.<br />
189
LIECHTENSTEIN<br />
Popolazione<br />
Alla fine del 1997, il Lichtenstein contava 31.320 abitanti, di cui il 34,3% stranieri. Circa<br />
due terzi dei residenti stranieri proviene dalla Svizzera, dall’Austria e dalle Germania. Il resto è<br />
originario dell’Italia (7,6%), della Turchia (7,5%), della Repubblica Federale di Jugoslavia<br />
(3,5%), del Portogallo (3,3%), della Spagna (2,4%) e della Bosnia-Erzegovina (2,3%).<br />
Religione<br />
Con riferimento allo stesso periodo in esame, il 79,7% della popolazione era cattolica,<br />
mentre il 7,3% era protestante (non si dispone di dati relativi al restante 7,8% della popolazione).<br />
La Costituzione del Lichtenstein garantisce la libertà di culto e di coscienza ad ogni cittadino.<br />
Difende, inoltre, i diritti civili e politici delle persone, a prescindere dal loro credo religioso.<br />
In virtù del principio di libertà di religione, è possibile essere esonerati dai corsi di religione<br />
tenuti nelle scuole pubbliche. La Costituzione riconosce nella Chiesa Cattolica Romana la Chiesa<br />
di Stato. Essa riceve sovvenzioni dallo Stato così come la Chiesa Protestante. Attualmente si<br />
stanno ridefinendo i rapporti tra Stato e Chiesa a seguito della istituzione dell’arcidiocesi del Lichtenstein.<br />
Lingua<br />
La Costituzione riconosce il tedesco come lingua nazionale ed ufficiale del Lichtenstein.<br />
Tuttavia il gergo in uso nella vita di tutti i giorni è un dialetto alemanico.<br />
Accoglienza e status dei cittadini stranieri<br />
A causa degli stretti legami instaurati con la Svizzera in virtù del trattato di collaborazione<br />
doganale e dell’ingresso del Principato nello Spazio Economico Europeo, viene fatta una distinzione<br />
tra i cittadini stranieri in base alla loro provenienza. A tale proposito, nel rapporto della<br />
Commissione Europea contro il Razzismo e l’Intolleranza si legge:<br />
“I cittadini svizzeri godono di un trattamento privilegiato (su una base di reciprocità) per quanto<br />
attiene alla possibilità di lavorare nel Lichtenstein senza permesso (Grenzgängerbewilligung).<br />
Anche i cittadini degli Stati aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) godono di privilegi<br />
(ad esempio, il diritto di svolgere la propria professione, il diritto di essere iscritti al sistema previdenziale<br />
pubblico, ecc.).<br />
A parte ciò, tuttavia, gli stranieri godono di un trattamento identico per quanto concerne<br />
i loro diritti e doveri e tutti hanno accesso alle scuole pubbliche, ai servizi sanitari pubblici, ecc.<br />
Nelle risposte fornite al questionario dell’ECRI, le autorità del Lichtenstein hanno affermato<br />
che è possibile che alcuni gruppi di stranieri incontrino dei problemi ad integrarsi a causa<br />
della loro diversa religione e cultura rispetto alla maggioranza della popolazione. Tuttavia per la<br />
maggior parte degli stranieri, l’integrazione non pone problemi, data l’assenza di differenze significative<br />
legate alla lingua, alla cultura o alla religione. Le piccole dimensioni del paese, il basso<br />
tasso di urbanizzazione e l’atteggiamento delle autorità sono fattori che giustificano<br />
l’assenza di reali tensioni tra gli stranieri”.<br />
190
Vita associativa<br />
“Conformemente ai propri statuti, tutte le associazioni sono apolitiche ed aperte agli<br />
stranieri, i quali sono generalmente ben rappresentati, soprattutto nei settori dello sport e della<br />
cultura. Le associazioni di stranieri si occupano in particolare dell’organizzazione di riunioni e<br />
dell’elaborazione di posizioni comuni rispetto alle autorità del Lichtenstein e del loro stesso paese<br />
di origine. Nella maggior parte dei casi si tratta di associazioni molto attive nei settori sportivo<br />
e culturale, impegnate nell’organizzazione di eventi a carattere nazionale, ecc. La rappresentanza<br />
a livello di mezzi di informazione non è sottoposta ad alcuna restrizione: i cittadini stranieri<br />
non dispongono di circuiti informativi propri, ma possono utilizzare la stampa e la radio privata<br />
del Lichtenstein (non esiste un servizio televisivo pubblico)”.<br />
Sensibilizzazione<br />
“Sono state lanciate campagne di sensibilizzazione, sia a livello governativo che non<br />
governativo, mirate a far conoscere la situazione e le preoccupazioni degli stranieri residenti nel<br />
Lichtenstein ed a promuovere la loro integrazione. Queste campagne sono principalmente rivolte<br />
ai giovani. Sarebbe opportuno portare avanti simili iniziative”.<br />
Monitoraggio della situazione<br />
“Tutte le fonti ufficiali sono concordi nel dichiarare che nel Lichtenstein i problemi legati<br />
al razzismo ed all’intolleranza assumono uno scarso rilievo. Le autorità ritengono che, al fine di<br />
seguire l’evoluzione della situazione possa risultare utile svolgere un’indagine o un sondaggio<br />
tra la popolazione per verificare se nella realtà esiste una sorta di intolleranza in forma latente,<br />
pur non essendo stato segnalato alcun incidente. Un’altra modalità potrebbe consistere nel<br />
chiedere agli stranieri di comunicare la loro esperienza di vita nel paese, dal momento che possono<br />
esistere forme di discriminazione non denunciate”<br />
Per rafforzare il quadro normativo volto a prevenire ogni forma di razzismo, il governo<br />
ha elaborato disposizioni che integreranno il codice penale e con le quali introdurranno nuove<br />
fattispecie di reato riconducibili ad attività razziste e nazional-socialiste. Tale normativa,<br />
nell’adeguare la legislazione nazionale costituisce la premessa per la futura adesione del Lichtenstein<br />
alla Convenzione ONU sull’abolizione di ogni forma di discriminazione razziale del<br />
1965.<br />
Le libertà ed i diritti fondamentali<br />
La Costituzione del Principato del Lichtenstein garantisce una serie di diritti fondamentali,<br />
tra cui il diritto ad insediarsi in qualsiasi punto del territorio, il diritto alla successione, la libertà<br />
della persona, l’inviolabilità del domicilio ed il segreto della corrispondenza e delle comunicazioni<br />
scritte, il diritto ad un corretto procedimento innanzi ad un giudice debitamente designato,<br />
l’inviolabilità della proprietà privata, il libero commercio, la libertà di religione e di coscienza,<br />
la libertà di espressione e di stampa, la libertà di riunione e di associazione, il diritto di<br />
petizione e di appello.<br />
La Costituzione garantisce, inoltre, l’uguaglianza fra tutti i cittadini innanzi alla legge ed<br />
impone che i diritti degli stranieri siano disciplinati dai trattati o, in loro assenza, dal diritto di reciprocità.<br />
Convenzioni internazionali relative ai diritti dell’uomo e legislazione in vigore nel Lichtenstein<br />
Adesione del Lichtenstein alle convenzioni internazionali sui diritti dell’uomo<br />
191
In qualità di paese membro dell’ONU e del Consiglio d’Europa, il Lichtenstein ha ratificato<br />
una serie di convenzioni europee ed internazionali a tutela dei diritti dell’uomo di cui segue<br />
un elenco:<br />
- Convenzione sullo status dei rifugiati del 28 luglio 1951;<br />
- Protocollo sullo status di rifugiati del 31 gennaio 1967;<br />
- Convenzione sull’abolizione di qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle donne<br />
del 18 dicembre 1979;<br />
- Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989;<br />
- Convenzione per la Difesa dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali ed alcuni dei<br />
relativi protocolli;<br />
- Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 5 novembre 1995;<br />
- Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966;<br />
- Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966;<br />
- Protocollo facoltativo connesso al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16<br />
dicembre 1966.<br />
Il Lichtenstein osserva il principio secondo il quale il paese contrae gli obblighi imposti<br />
dai trattati internazionali solo se è in condizione di poterli rispettare. L’attuale dottrina ritiene che<br />
i trattati internazionali abbiano almeno valore di legge nell’ordinamento giuridico interno.<br />
Informazioni sulle convenzioni relative ai diritti dell’uomo<br />
Qualsiasi legge e, di conseguenza, qualsiasi trattato internazionale, vengono esaminati<br />
dal Landtag (parlamento) e devono essere resi pubblici, permettendo a chiunque di venirne a<br />
conoscenza. Il governo attua un’attenta politica di informazione della popolazione dopo<br />
l’approvazione da parte del Parlamento e l’entrata in vigore di strumenti internazionali relativi ai<br />
diritti dell’uomo. Ne consegue, quindi, che, ogni qualvolta si renda necessario, si procede ad<br />
una puntuale attività informativa. Tuttavia, dato il costante richiamo alla Convenzione Europea<br />
sui Diritti dell’Uomo nelle dichiarazioni pubbliche sia verbali che scritte, si presume che tale<br />
strumento goda di ampia notorietà tra la gente.<br />
Informazioni sulla Convenzione-quadro<br />
Dichiarazione<br />
Il Lichetenstein ha ratificato la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze<br />
nazionali il 18 novembre 1997. Nel suo strumento di ratifica ha presentato la seguente dichiarazione:<br />
“Il Principato del Lichtenstein dichiara che gli artt. 24 e 25, in particolare, della Convenzionequadro<br />
per la protezione delle minoranze nazionali del 1° febbraio 1995 sono da interpretare<br />
tenendo presente che sul territorio non è insediata alcuna minoranza nazionale intesa secondo<br />
la definizione data dalla Convenzione-quadro. Il Principato considera la sua ratifica come un atto<br />
di solidarietà visti gli obiettivi perseguiti dalla Convenzione stessa”.<br />
LITUANIA<br />
Normativa<br />
Il diritto alla libertà di opinione e di espressione è garantito dall’art. 25 della Costituzione.<br />
Questo articolo prevede, inoltre, l’obbligo di “non ostacolare le persone nel ricercare, ricevere<br />
o comunicare informazioni o idee. La libertà di esprimere le proprie convinzioni , nonché di<br />
ricevere e comunicare informazioni, può essere limitata solo nei casi previsti per legge, laddove<br />
si renda necessario per salvaguardare l’incolumità fisica, l’onore e la dignità, la vita privata o la<br />
192
moralità di una persona, oppure per garantire l’ordine costituzionale”. L’art. 44 della Costituzione,<br />
inoltre, afferma che “lo Stato, i partiti politici, le organizzazioni politiche e pubbliche nonché<br />
altre istituzioni o persone non possono monopolizzare gli organi di informazione”. E’ vietata la<br />
censura dei mezzi di informazione.<br />
Le procedure per ricevere, creare, pubblicare e comunicare informazioni pubbliche, i diritti<br />
ed obblighi dei creatori, divulgatori, detentori di informazioni pubbliche nonché i diritti ed obblighi<br />
dei giornalisti sono disciplinati dalla legge sull’Informazione pubblica, adottata il 2 luglio<br />
1996. Il relativo art. 4 garantisce ad ogni individuo il diritto di esprimere liberamente pensieri e<br />
convinzioni. Tale diritto implica altresì la libertà di opinione e la libertà di raccogliere, ricevere e<br />
comunicare informazioni ed idee secondo la prassi ed alle condizioni stabiliti per legge.<br />
L’art. 4, comma 2, della legge sui mezzi di comunicazione garantisce la libertà di ricevere<br />
e trasmettere programmi televisivi dei paesi membri dell’UE e di altri Stati che hanno ratificato<br />
la Convenzione Europea sulla Televisione Transfrontaliera conformemente a quanto previsto<br />
dagli accordi internazionali sottoscritti dalla Lituania. Ciò consente a polacchi, russi, bielorussi,<br />
ucraini ed altri di seguire i programmi trasmessi da varie stazioni televisive straniere.<br />
Le leggi della Repubblica di Lituania garantiscono la libertà di informare il pubblico: “Un<br />
individuo ha il diritto di ricercare, ricevere e comunicare informazioni ed idee senza alcuna interferenza,<br />
tale diritto tuttavia, non può limitare i diritti e le libertà degli altri individui”. Il diritto ad<br />
esprimere le proprie convinzioni ed a ricevere e comunicare informazioni non può limitarsi ai soli<br />
casi previsti dalla legge, qualora si renda necessario per tutelare i diritti umani, l’incolumità fisica,<br />
l’onore e la dignità, la vita privata e la moralità delle persone oppure per difendere l’ordine<br />
costituito. In base a quanto previsto dall’ordinamento giuridico della Repubblica di Lituania, i<br />
funzionari statali sono soggetti a precise responsabilità in caso di ingerenza nella divulgazione<br />
di informazioni ai mezzi di informazione e di illecito rifiuto a comunicare informazioni al pubblico,<br />
ai creatori di informazioni ed ai giornalisti. La libertà di comunicare informazioni al pubblico può<br />
essere limitata solo nei casi previsti dalle leggi a tutela del segreto di stato, del segreto professionale<br />
e commerciale, sulla salvaguardia dell’incolumità personale nonché dalle norme a tutela<br />
dei diritti della persona e della privacy.<br />
L’art. 34 della Legge sull’Informazione Pubblica impone l’obbligo di tradurre in lituano,<br />
anche con l’utilizzo di sottotitoli in questa lingua, tutti i programmi radiotelevisivi trasmessi in altre<br />
lingue, salvo nel caso di programmi a scopo didattico o programmi trasmessi in occasioni<br />
speciali o diffusi da paesi stranieri, nonché quelli prodotti dall’emittente radiotelevisiva pubblica<br />
appositamente per le minoranze nazionali.<br />
L’art. 2 della Legge sulle Minoranze Nazionali (1989) garantisce il diritto delle minoranze<br />
nazionali ad esprimere liberamente i propri pensieri ed a ricevere informazioni nelle propria<br />
lingua.<br />
Regime di autorizzazioni<br />
Le attività di trasmissione sono sottoposte ad un regime di autorizzazioni eccezion fatta<br />
per la Radiotelevisione Nazionale. In base all’art. 31 della Legge sull’Informazione Pubblica,<br />
l’autorità competente a rilasciare le autorizzazioni è la Commissione della Radiotelevisione Nazionale<br />
dietro presentazione di offerte di appalto. Si dà precedenza alle emittenti che si impegnano<br />
a produrre originali programmi di tipo culturale, informativo e didattico, a garantire una<br />
corretta informazione ed informazione obiettiva, a rispettare la dignità umana e tutelare il diritto<br />
alla privacy, a proteggere i minori da un’informazione pubblica che potrebbe esercitare influenze<br />
negative sul loro sviluppo psico-fisico e morale. Sono, inoltre, privilegiate le emittenti i cui programmi<br />
non sono trasmessi da altre stazioni situate nella loro stessa zona di ricezione. In considerazione<br />
delle specifiche esigenze avvertite dalle minoranze nazionali presenti nella zona di<br />
ricezione del segnale di trasmissione, la Commissione può sottoporre il rilascio<br />
dell’autorizzazione a determinate condizioni che prevedano l’indicazione della quota riferita ai<br />
programmi da trasmettere nelle lingue minoritarie.<br />
193
I mezzi di informazione delle minoranze nazionali<br />
In Lituania esistono due tipi di servizi radiotelevisivi – quello assicurato dall’emittente<br />
pubblica (la Radiotelevisione nazionale) e quello delle emittenti private (stazioni radiotelevisive<br />
private). Il servizio d’informazione nazionale è gestito dal Consiglio della radiotelevisione e rappresenta<br />
gli interessi del pubblico; è inoltre tenuto a rispondere del corretto svolgimento delle<br />
proprie funzioni rispetto agli interessi del pubblico, compresi quelli delle minoranze nazionali.<br />
Tenendo in considerazione gli interessi delle minoranze nazionali, la Radiotelevisione nazionale<br />
trasmette speciali programmi rivolti alle minoranze nazionali.<br />
La libertà di espressione e di pensiero nonché la libertà di ricevere e comunicare informazioni<br />
è implicitamente legata alla possibilità di disporre di un proprio mezzo di informazione<br />
(stampa, organi di informazione elettronici o di altro tipo). Alle minoranze nazionali presenti in<br />
Lituania è garantita la possibilità di avere organi di informazione nella propria lingua.<br />
Stampa<br />
Esistono giornali, periodici e pubblicazioni in lingua russa, polacca, bielorussa, tedesca,<br />
tartara, yddish, lettone. I testi scolastici utilizzati nelle scuole di lingua russa sono pubblicati a<br />
spese dello Stato.<br />
Radio<br />
L’art. 4 della Legge sulla Radiotelevisione Nazionale (1996) prevede l’obbligo da parte<br />
dell’emittente pubblica di assicurare che nei propri programmi vengano affrontate varie tematiche<br />
afferenti ai diversi settori della società, alle diverse fasce d’età, alle diverse nazionalità e<br />
credi. La Radiotelevisione Nazionale dispone di una unità impegnata specificatamente nella<br />
produzione di programmi e trasmissioni destinati alle minoranze nazionali. Il primo canale della<br />
Radio lituana trasmette ogni giorno un programma di informazione in lingua russa (30 minuti). Il<br />
secondo canale della stessa emittente radiofonica trasmette regolarmente un programma della<br />
durata di un’ora e mezza intitolato Vaivorykš (l’Arcobaleno) e dedicato ai problemi di carattere<br />
culturale, educativo e quotidiani vissuti da tutte le comunità minoritarie della Lituania. Il programma<br />
prevede trenta minuti di trasmissioni in lingua polacca e 10 minuti in lingua bielorussa.<br />
Nell’ambito di questo programma i dibattiti si svolgono in varie lingue – lituano, russo, polacco,<br />
bielorusso, yddish, ucraino, tartaro ed altre lingue. Ogni due settimane, nel corso della trasmissione<br />
“L’Arcobaleno” viene trasmesso un programma speciale per gli ebrei lituani e per gli ucraini.<br />
Tutti questi spettacoli e trasmissioni vengono prodotti da giornalisti appartenenti alle<br />
stesse minoranze nazionali.<br />
La Lituania ha stazioni radiofoniche private che trasmettono programmi nelle seguenti<br />
lingue minoritarie parlate in Lituania: russo, polacco, bielorusso.<br />
Televisione<br />
Anche la televisione nazionale trasmette molti programmi destinati alle minoranze.<br />
Vengono trasmessi quotidianamente in lingua russa telegiornali della durata di 10 minuti<br />
in lingua russa ed una trasmissione della durata di 15 minuti una volta a settimana. Si diffondono<br />
trasmissioni anche in altre lingue minoritarie, come polacco, ucraino e bielorusso, nonché<br />
programmi per i membri della comunità ebraica, per coloro che praticano il culto russoortodosso<br />
e quello cristiano.<br />
Alcune stazioni televisive private che operano in zone ove insistono comunità minoritarie<br />
numericamente consistenti, trasmettono programmi nelle loro rispettive lingue. Altre stazioni<br />
diffondono programmi di informazione in lingua russa o polacca e trasmettono anche programmi<br />
russi o polacchi. Gli operatori della televisione via cavo trasmettono molti programmi televisivi<br />
prodotti in Russia, Bielorussia, Polonia, Ucraina ed in altri paesi.<br />
Lo Stato sovvenziona le attività dei mezzi di comunicazione che abbiano specifiche finalità<br />
culturali e didattiche. In base all’art. 28 della Legge sull’Informazione Pubblica, è previsto<br />
che grazie all’utilizzo del Fondo a sostegno della Stampa, della Radio e della Televisione, siano<br />
concessi stanziamenti in favore dei mezzi di informazione secondo criteri che tengano conto<br />
194
della competitività fra programmi e della valutazione di quelli proposti. I finanziamenti destinati<br />
all’editoria, al settore delle audio e videocassette e dei CD, nonché all’industria cinematografica<br />
sono concessi dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e delle Scienze.<br />
Il Dipartimento delle Minoranze Nazionali e dei Lituani residenti all’estero, in collaborazione<br />
con il Consiglio delle Comunità Nazionali, il Centro Lituano dei Diritti Umani, l’Open<br />
Society Fund della Lituania, il Centro per le Istituzioni Civili, il Centro di Informazione e Documentazione<br />
del Consiglio d’Europa, organizza annualmente conferenze e seminari sugli stereotipi<br />
relativi alle minoranze nazionali nei mass media. Da un’indagine sui quotidiani lituani emerge<br />
che i mezzi di informazione non sono privi di casi in cui le minoranze sono descritte in termini<br />
negativi. Talvolta li si dipinge come gruppi di persone che vivono ai margini della società, con un<br />
elevato numero di criminali socialmente pericolosi. Le problematiche degli appartenenti a minoranze<br />
nazionali sono spesso presentate in stretta correlazione con il loro gruppo di appartenenza..<br />
Nell’affrontare simili tematiche, nei palinsesti radiotelevisivi si cerca di evitare che venga<br />
ridotto il tempo destinato ai programmi delle minoranze nazionali, concedendo, invece, maggiore<br />
spazio a quei programmi ad elevato contenuto di informazioni e notizie riguardanti i gruppi<br />
etnici, linguistici, religiosi e di altro tipo presenti in Lituania.<br />
Di recente, sono stati avviati dalla istituzioni pubbliche e da organizzazioni non governative<br />
vari progetti tesi ad incoraggiare i giornalisti ed il mondo accademico a svolgere ricerche di<br />
tipo storico-culturale sui gruppi etnici ed a contribuire maggiormente allo sviluppo dei rapporti tra<br />
diverse culture.<br />
L’art. 20 della Legge sull’Informazione pubblica vieta la pubblicazione di informazioni<br />
che istigano all’odio nazionale, razziale o religioso. L’art. 47 afferma che la Commissione di controllo<br />
sull’etica di giornalisti ed editori prenderà in considerazione le violazioni di norme che vietano<br />
la divulgazione di informazioni che istighino all’odio nazionale, razziale, religioso, sociale o<br />
a sfondo sessuale, diffamanti o miranti alla disinformazione. La Commissione è competente a<br />
raccogliere le denunce presentate da chiunque sia interessato. Inoltre, l’attuazione delle disposizioni<br />
normative in materia di Informazione Pubblica è monitorata dall’ispettore preposto a vigilare<br />
sull’etica dei giornalisti. Quest’ultimo esamina le denunce di violazioni dell’onore e della dignità<br />
ad opera dei mezzi di informazione presentate dai cittadini e può notificare ai produttori e<br />
distributori di informazioni pubbliche l’avvenuta violazione delle norme giuridiche che disciplinano<br />
il settore dell’informazione pubblica, invitandoli a prendere i provvedimenti del caso. Lo stesso<br />
può, inoltre, esigere che il produttore o distributore di informazioni pubbliche smentisca le<br />
false informazioni che danneggiano l’onore e la dignità di una persona oppure offra alla persona<br />
l’opportunità di replicare a o smentire simili informazioni.<br />
Ciascun individuo ha il diritto di citare in giudizio chiunque violi le norme di disciplinano il<br />
settore dell’informazione pubblica. La responsabilità sul piano legale per simili violazioni è prevista<br />
dall’art. 21412 del Codice Amministrativo della Repubblica di Lituania (Produzione e possesso,<br />
per fini divulgativi, di materiale informativo che incita alla discordia per motivi fondati<br />
sull’identità nazionale, la razza e la religione). Alcune informazioni relative al soggetto in argomento<br />
sono già state fornite in ordine all’attuazione dell’art. 6 della Convenzione.<br />
MALTA<br />
La libertà di espressione è garantita dall’art. 41 della Costituzione maltese.<br />
(1) “Salvo nei casi in cui sia stato dato il proprio assenso o si agisca in veste di autorità parentale,<br />
nessuno può essere privato della propria libertà di espressione, che comporta la libertà di<br />
manifestare liberamente le proprie opinioni, di ricevere liberamente idee ed informazioni, di comunicare<br />
liberamente idee ed informazioni (sia al pubblico in generale che ad un individuo o<br />
gruppo di individui). Chiunque è tenuto alla riservatezza della propria corrispondenza.<br />
(2) Nessuna legge né provvedimento presi in virtù delle disposizioni di legge saranno giudicati<br />
incompatibili o contrari al comma (1) di cui sopra, nella misura in cui la citata legge preveda:<br />
(a) che sia opportuno;<br />
(i) nell’interesse della difesa, della pubblica sicurezza, dell’ordine pubblico, della pubblica moralità<br />
o decenza o la salute pubblica;<br />
oppure<br />
195
(ii) per difendere la reputazione, i diritti e le libertà altrui, per difendere la vita privata delle persone<br />
sottoposte a procedimento giudiziario, per impedire la divulgazione di informazioni riservate,<br />
per salvaguardare l’autorità e l’indipendenza dei tribunali, per proteggere i privilegi del Parlamento<br />
o per regolamentare la telefonia, la telegrafia, la radiodiffusione via etere, la televisione<br />
o qualsiasi altro mezzo di comunicazione, le mostre e gli spettacoli, ecc.; oppure<br />
(b) sia necessario imporre restrizioni ai pubblici officiali;<br />
salvo nel caso in cui si dimostri che la legge o, eventualmente, il provvedimento adottato in virtù<br />
della legge sono illegittimi in una società democratica.<br />
(3) Chiunque risiede a Malta può pubblicare o stampare un quotidiano o periodico:<br />
Tuttavia la legge può:<br />
(a) vietare ad una persona di età inferiore a 21 anni di pubblicare o stampare qualsiasi giornale<br />
o rivista o di concedere l’autorizzazione solo entro certi limiti; e<br />
(b) obbligare il curatore o editore di giornali o riviste a comunicare all’autorità competente i propri<br />
progetti, la propria età ed il luogo di residenza.<br />
(4) Nel caso in cui la polizia sequestri un giornale come corpo di reato, la stessa è tenuta a consegnarlo<br />
al tribunale competente entro le 24 ore successive al sequestro. Se il tribunale non ritiene<br />
vi siano gravi e convincenti indizi, il giornale sarà restituito alla persona riconducendolo nel<br />
luogo presso cui era stato effettuato il sequestro.<br />
(5) Nessuno può essere privato della propria cittadinanza in virtù dell’art. 30(1)(b) della presente<br />
Costituzione, né della propria capacità giuridica, unicamente in ragione delle proprie opinioni<br />
politiche.<br />
Lo stesso diritto è tutelato anche dall’art. 10 della Convenzione Europea sui Diritti<br />
dell’Uomo.<br />
Il regime di autorizzazioni è disciplinato dalla legge sulla radiotelevisione (legge XII del<br />
1991), il cui art. 10(4) recita come segue:<br />
“L’autorizzazione per creare un servizio radiotelevisivo può essere concessa soltanto ad una<br />
società regolarmente costituita a Malta conformemente al diritto societario attualmente vigente<br />
nel paese; nel caso di un’autorizzazione a svolgere un servizio radiotelevisivo pubblico, la società<br />
deve essere interamente controllata da cittadini maltesi che risiedano abitualmente a Malta;<br />
in tutti gli altri casi, tali cittadini devono disporre della maggioranza dei voti.<br />
L’autorizzazione per creare un servizio radiotelevisivo pubblico può essere concessa anche a<br />
privati con cittadinanza maltese e residenti abitualmente a Malta”.<br />
I servizi radiotelevisivi sono stati liberalizzati e l’accesso ai mezzi di informazione è autorizzato<br />
a condizione che gli interessati rispettino le condizioni imposte dalla legge.<br />
NORVEGIA<br />
La libertà di espressione è un diritto ufficialmente riconosciuto dall’art. 100 della Costituzione.<br />
L’ordinamento norvegese non contiene alcuna norma che limiti la libertà degli appartenenti<br />
a minoranze linguistiche ad avere proprie opinioni ed a ricevere e comunicare informazioni<br />
e idee nella lingua minoritaria. Nel riferire allo Storting (parlamento) in merito alla politica adottata<br />
dal governo nei confronti delle minoranze nazionali, quest’ultimo ha affermato che la Norvegia<br />
ha posto tra i suoi obiettivi quello di accrescere le opportunità di espressione delle minoranze<br />
nazionali, sia mediante i propri canali che attraverso altri mezzi pubblici. Ha poi aggiunto che<br />
il sostegno attivo alla libertà di espressione ed alle opportunità di espressione delle minoranze<br />
rappresenta un’importante misura politica in una società culturalmente pluralista.<br />
La legge n. 127 del 4 dicembre 1992 sulla radiotelevisione e la legge n. 21 del 15 maggio<br />
1987 sui film e le videoregistrazioni nonché la relativa regolamentazione prevedono il rilascio<br />
di un’autorizzazione per la distribuzione e la vendita di film e videoregistrazioni a scopo<br />
commerciale e per l’utilizzo di servizi radiotelevisivi, locali e non. L’origine etnica del richiedente<br />
è irrilevante ai fini del rilascio delle autorizzazioni.<br />
Spetta ai comuni gestire i meccanismi per la concessione delle autorizzazioni necessarie<br />
per la distribuzione e la vendita di film o videoregistrazioni, conformemente all’art. 2 della<br />
legge sui film ed le videoregistrazioni. Si può presentare ricorso al governatore della contea<br />
contro le decisioni prese dalle autorità municipali.<br />
196
Le autorizzazioni per l’utilizzo dei servizi radiotelevisivi sono rilasciate dal Ministero dei<br />
Beni Culturali e dall’Authority norvegese sui mass media.<br />
In Norvegia non è richiesta alcuna autorizzazione per fondare o gestire un organo di<br />
stampa. Per la creazione e l’utilizzo di un mezzo radiotelevisivo, è possibile chiedere una sovvenzione<br />
al governo centrale per progetti come quelli che riguardano le imprese radiotelevisive<br />
locali. Le linee guida del relativo programma di finanziamenti prevedono che sia prestata<br />
un’attenzione particolare alle richieste provenienti da gruppi etnici e linguistici minoritari. Le sovvenzioni<br />
destinate alla realizzazione di progetti da parte di stazioni radiotelevisive locali sono<br />
concesse dalla Fondazione per la produzione audiovisiva, organismo amministrativo facente<br />
capo al Ministero dei Beni Culturali.<br />
Le autorità del governo centrale dispongono stanziamenti a sostegno del giornale kven<br />
Ruijan Kaiku. Progetto pilota avviato nel 1995 su iniziativa della Fondazione kven norvegese,<br />
questo giornale esce ogni due o tre settimane. Dal 1998, Ruijan Kaiku ha ottenuto dal Ministero<br />
dei Beni Culturali sovvenzioni per un ammontare di 250 000 corone norvegesi. Attualmente esso<br />
rappresenta un importante forum di scambio, di informazione e di dibattito in seno alla comunità<br />
kven.<br />
L’obiettivo fondamentale della politica condotta dal governo nel settore dei mezzi di informazione<br />
è quello di garantire la libertà di espressione, di creare condizioni che favoriscano la<br />
varietà delle opportunità di esprimersi e di garantire a tutti coloro che risiedono in Norvegia un<br />
servizio di informazione obiettivo e completo. I programmi radiotelevisivi del servizio pubblico<br />
devono rispondere alle esigenze dei vari gruppi che compongono la società, comprese le minoranze<br />
linguistiche.<br />
L’emittente pubblica in Norvegia è la Società radiotelevisiva norvegese (NRK). Si presenta<br />
come S.r.l. con l’obiettivo di offrire all’intera nazione servizi radiotelevisivi nell’ambito del<br />
servizio pubblico. Benché lo Stato detenga la totalità delle azioni della NRK, il governo non è<br />
autorizzato a deciderne la programmazione. Le autorità del governo centrale possono tuttavia<br />
comunicare la propria opinione alla NRK attraverso il Consiglio del servizio radiotelevisivo pubblico.<br />
Questo è composto da membri nominati dallo Storting e dal governo, uno dei quali è il<br />
Presidente del Consiglio per i programmi in lingua sami. Il suo compito consiste nell’esaminare<br />
l’orientamento della programmazione adottata dalla NRK e di formulare i relativi commenti. Attraverso<br />
il Consiglio del servizio radiotelevisivo pubblico, le autorità si sforzano di garantire il rispetto<br />
dei principi su cui si fonda il servizio radiotelevisivo pubblico, con particolare riguardo alle<br />
esigenze legate ai programmi rivolti ai gruppi linguistici minoritari.<br />
Ogni settimana, la sede regionale della NRK a Troms trasmette un programma della durata<br />
di 12 minuti in finnico, che comprende notiziari, reportages, nonché soggetti musicali e culturali.<br />
Nel rapporto presentato nel 1999, il Consiglio del servizio radiotelevisivo pubblico ha dichiarato<br />
che la NRK avrebbe dovuto concedere un più ampio spazio a questa trasmissione,<br />
prevedendo la sua diffusione su tutto il territorio nazionale.<br />
Le autorità finanziano progetti di ricerca applicati ai mezzi di informazione e programmi<br />
di formazione permanente più specificatamente rivolti agli aspetti deontologici. In tal modo cercano<br />
di sostenere attività che contribuiscano a far sì che i media ed i centri di ricerca sui media<br />
evidenzino il ruolo e la responsabilità di questi ultimi, ad esempio nel trattare le questioni legate<br />
al razzismo ed alla discriminazione, promuovendo un dibattito sul tema. Sono stati stanziati fondi<br />
da utilizzare per lo svolgimento di indagini e per l’organizzazione di seminari su tematiche riguardanti<br />
i mezzi di informazione e l’etica professionale.<br />
POLONIA<br />
La libertà di esprimere opinioni e di ricevere o comunicare informazioni è garantita, come<br />
valore democratico fondamentale, dall’art. 54, comma 1, della Costituzione sulla libertà di<br />
espressione e di stampa.<br />
La prima tappa importante nella formazione di un quadro giuridico che assicuri<br />
l’accesso ai mezzi di informazione elettronici è stata l’adozione della legge sulla diffusione di<br />
trasmissioni radiotelevisive del 29 dicembre 1992. All’art. 21, comma 9, vengono enumerati gli<br />
obblighi imposti alle emittenti pubbliche: “la preparazione di programmi radiotelevisivi deve tener<br />
conto delle specifiche esigenze delle minoranze nazionali e dei gruppi etnici”. Il Consiglio Na-<br />
197
zionale della Radiofonia e della Televisione (KRRiT) svolge un ruolo importante nella direzione<br />
e nel coordinamento delle iniziative adottate dalla televisione pubblica in favore delle minoranze.<br />
Il ruolo svolto dal Consiglio Nazionale della Radiofonia e della Televisione (KRRiT)<br />
L’art. 213, comma 1, della Costituzione della Repubblica di Polonia prevede che il Consiglio<br />
Nazionale della Radiofonia e della Televisione tuteli la libertà di espressione, l’esercizio<br />
del diritto all’informazione e l’interesse pubblico nel settore radiotelevisivo. La legge sulla diffusione<br />
di trasmissioni radiotelevisive specifica nel dettaglio le competenze assegnate a tale organo.<br />
Gli interventi del Consiglio in favore delle minoranze prevedono di:<br />
tenere in considerazione, all’atto della ripartizione degli utili derivanti dal pagamento del canone,<br />
le esigenze finanziarie di alcuni servizi della televisione polacca impegnati nella realizzazione<br />
di programmi destinati alle minoranze;<br />
esaminare i ricorsi presentati dai rappresentanti di organizzazioni appartenenti a minoranze;<br />
organizzare riunioni e conferenze dedicate al tema delle minoranze e dei loro rappresentanti<br />
in seno ai media.<br />
La libertà di ricevere e comunicare informazioni nella lingua minoritaria è garantita<br />
dall’art. 54 della Costituzione sulla libertà di espressione e di stampa. Si segnala, inoltre, che il<br />
diritto di diffondere e scambiare informazioni nella lingua madre degli appartenenti alle varie minoranze<br />
è riconosciuto dai trattati sottoscritti dalla Repubblica di Polonia con la Repubblica Federale<br />
di Germania, la Repubblica Ceca, la Repubblica Slovacca, la Bielorussia e la Repubblica<br />
di Lituania.<br />
Ai sensi dell’art. 2 della legge del 29 dicembre 1992 sulla diffusione di trasmissioni radiotelevisive,<br />
tutti gli organismi (eccetto i servizi pubblici) che producono programmi radiotelevisivi<br />
devono ricevere un’autorizzazione a trasmettere. L’autorità preposta al rilascio di simili autorizzazioni<br />
è il Consiglio Nazionale della Radiofonia e della Televisione (KRRiT) che delibera sulla<br />
base delle risoluzioni adottate dal Consiglio nazionale.<br />
La modifica della citata legge, risalente al 1° febbraio 2001 (G.U. n. 42, punto 469), ha<br />
introdotto un importante elemento di novità per le minoranze nazionali, che prevede la creazione<br />
di una nuova categoria: quella delle “emittenti radiofoniche sociali”. La richiesta per ottenere<br />
tale riconoscimento può essere presentata al KRRiT, tra l’altro, dalle associazioni che operano<br />
in base al mandato loro conferito per statuto e dalle persone giuridiche la cui attività abbia finalità<br />
religiose. Il titolare dell’emittente sociale è esente da oneri derivanti dalla concessione o dalla<br />
modifica dell’autorizzazione a trasmettere.<br />
Il Ministro della Cultura e del Patrimonio ha sancito, in linea di principio, il diritto di ciascuna<br />
minoranza nazionale a pubblicare una propria rivista in polacco o nella propria lingua, le<br />
cui spese sono, totalmente o in larga misura, a carico dello Stato.<br />
Alcune minoranze pubblicano più di una rivista. Giova, altresì, segnalare che nel 1990<br />
in Polonia, il numero delle pubblicazioni curate da minoranze nazionali ed etniche è considerevolmente<br />
aumentato.<br />
Quasi tutte queste riviste sono sovvenzionate dallo Stato, nella persona del Ministro<br />
della Cultura e del Patrimonio. Nel 2001, se ne sono contate 37 per un finanziamento statale<br />
complessivo di 2.678.800 zloty (circa 0,7 milioni di euro).<br />
Nell’ambito dei propri ordinamenti giuridici, le Parti adotteranno opportune misure atte a<br />
favorire l’accesso ai mezzi di informazione da parte degli appartenenti a minoranze nazionali<br />
nonché a promuovere la tolleranza e consentire il pluralismo culturale.<br />
Nel servizio radiotelevisivo pubblico vi è una costante presenza di programmi dedicati<br />
alle minoranze nazionali.<br />
Televisione pubblica<br />
Fin dal 1989, la televisione polacca propone numerosi programmi sulla cultura delle minoranze<br />
nazionali ed etniche presenti in Polonia. Vengono trasmessi periodicamente sia dai<br />
canali nazionali che da quelli regionali. Attualmente questo servizio pubblico è assicurato in larga<br />
misura dal canale regionale TV3 che comprende dodici stazioni locali.<br />
198
Alcuni programmi vengono regolarmente trasmessi (o ritrasmessi) su due diverse frequenze,<br />
di cui una regionale e l’altra appartenente alle emittenti del Programma 2, così da garantire<br />
una maggiore copertura. Ne è un esempio il programma, attualmente prodotto a Bialystok,<br />
intitolato “A proposito di noi” della durata di 40 minuti, nel corso del quale vengono affrontati<br />
importanti problemi ed eventi d’interesse per le minoranze presenti nella regione di Podlasie.<br />
Il programma è suddiviso in varie parti dedicate rispettivamente alla minoranza bielorussa<br />
(15 min.), a quella ucraina (10 min.), a quella lituana (15 min. ogni due settimane) ed a quella<br />
russa, Rom e tartara (7,5 min. al mese). A questo programma lavorano tre impiegati a tempo<br />
pieno e due collaboratori esterni. La stessa stazione trasmette anche un programma intitolato<br />
“Vicini”, co-prodotto da TV Grodno e TV Bialystok, nel quale si parla delle difficoltà attualmente<br />
incontrate dai bielorussi e dalla minoranza bielorussa presente in Polonia.<br />
REGNO UNITO<br />
Nell’ordinamento e nella prassi in uso nel Regno Unito, nulla impedisce la fondazione e<br />
l’uso di mezzi di stampa da parte di persone appartenenti a minoranze nazionali. Chiunque è<br />
libero di creare, individualmente o con altri, società di comunicazione e di utilizzare o meno un<br />
qualunque mezzo di comunicazione.<br />
Uno dei principali obiettivi della legge del 1990 sull’emittenza radiotelevisiva era di offrire<br />
alle comunità di qualsiasi tipo l’opportunità di accedere a stazioni radiofoniche che propongano<br />
programmi appositamente studiati per rispondere alle loro aspirazioni ed ai loro gusti.<br />
L’Authority per la Radio ha l’obbligo di tenere in considerazione, al momento di selezionare<br />
le emittenti da autorizzare, in che misura una data emittente sarà in grado di rispondere ai<br />
gusti ed alle aspirazioni della popolazione locale e fino a che punto il suo operato amplierà la<br />
gamma di programmi già trasmessi dalle radio locali indipendenti. Tali disposizioni hanno spinto<br />
le minoranze etniche a presentare richieste di utilizzo di proprie stazioni radiofoniche. Attualmente<br />
sono state concesse sei autorizzazioni, grazie alle quali vengono garantiti a tempo pieno<br />
servizi radiofonici locali che rispondono ai gusti ed interessi della comunità di colore ed di altre<br />
minoranze etniche. Vengono, inoltre, concesse autorizzazioni temporanee in occasione di particolari<br />
eventi in ambito locale, come le feste religiose.<br />
La Commissione per la televisione indipendente ha rilasciato più di una ventina di autorizzazioni<br />
per l’utilizzo di canali televisivi destinati alle comunità asiatica, giapponese, turca, iraniana<br />
ed afro-caraibica. Alcuni di questi servizi sono accessibili via cavo fin dalla fine degli anni<br />
’80 ed è assai probabile che diverranno più numerosi con l’arrivo della TV digitale.<br />
La legge del 1990 sull’emittenza radiotelevisiva prevede il rilascio di autorizzazioni per<br />
l’utilizzo di servizi televisivi a particolari regioni del Regno Unito affinché anch’esse possano disporre<br />
di un canale televisivo.<br />
Nella Dichiarazione di Impegno rivolta ai propri ascoltatori e telespettatori, la BBC<br />
(l’Emittente Radiotelevisiva britannica) si è impegnata in particolare ad “adoperarsi con maggiore<br />
impegno nella rappresentazione dei vari interessi e delle diverse culture presenti nel Regno<br />
Unito e nel proporre, in particolare, programmi d’interesse per gli ascoltatori e telespettatori appartenenti<br />
a minoranze etniche”.<br />
REPUBBLICA CECA<br />
Le persone appartenenti alle minoranze nazionali hanno libero accesso ai media. Il diritto<br />
a divulgare e ricevere informazioni si fonda su leggi vincolanti a livello generale.<br />
L'accesso ai media da parte delle minoranze nazionali è garantito espressamente dalla<br />
legge sulla Radio ceca che, fra l'altro, stabilisce le modalità di erogazione dei servizi al pubblico<br />
199
nel settore dello sviluppo dell'identità culturale delle minoranze nazionali nella Repubblica ceca.<br />
La legge sulla Televisione ceca contiene la stessa formulazione. In ottemperanza alle leggi in<br />
vigore, le organizzazioni delle persone appartenenti alle minoranze nazionali distribuiscono<br />
pubblicazioni sia di tipo periodico che di tipo non periodico. In realtà ciò significa che la Radio<br />
ceca ha quattro dipartimenti indipendenti per le minoranze nazionali (polacco, slovacco, rom e<br />
tedesco) che provvedono con regolarità alle trasmissioni per le minoranze nazionali. Inoltre la<br />
Radio ceca trasmette regolarmente dei programmi per cittadini delle seguenti comunità: ungherese,<br />
tedesca, polacca, rom, slovacca, ucraina, croata, vietnamita ed ebraica. La Televisione<br />
ceca ha un dipartimento rom indipendente che trasmette regolarmente il programma di orientamento<br />
rom "ROMALE". Anche la televisione pubblica trasmette delle serie di programmi centrati<br />
sulle minoranze nazionali che vivono nella Repubblica ceca.<br />
La pubblicazione di periodici per le minoranze nazionali rappresenta un settore specifico.<br />
Ogni anno, sulla base dei progetti presentati, vengono erogate delle sovvenzioni tratte direttamente<br />
dal bilancio dello Stato per la pubblicazione di periodici destinati alle minoranze nazionali.<br />
Nel 1998 i periodici pubblicati erano suddivisi come segue:<br />
tre in slovacco<br />
sei in polacco<br />
due in tedesco<br />
tre in lingua rom<br />
uno in ungherese<br />
uno in ucraino.<br />
REPUBBLICA DELLA MOLDAVIA<br />
Il diritto di ogni appartenente alle minoranze nazionali di esprimere liberamente le proprie<br />
idee nella propria lingua è garantita da una serie di norme quali: la Costituzione della Repubblica<br />
di Moldavia, che all’art. 32 prevede che ogni cittadino goda della libertà di pensiero, di<br />
opinione, nonché della libertà di espressione in pubblico mediante la parola, l’immagine o ogni<br />
altro possibile mezzo. Tale articolo è la base su cui si fondano vari provvedimenti normativi, tra<br />
cui la Legge sulla stampa e la Legge sui mezzi audiovisivi. La libertà di opinione e di espressione<br />
sono strettamente legati al diritto degli appartenenti alle minoranze nazionali di avere accesso<br />
a qualsiasi informazione di interesse pubblico. Le autorità officiali sono tenute a garantire la<br />
corretta informazione dei cittadini sulla vita pubblica e sui problemi d’interesse personale.<br />
L’ordinamento della Repubblica prevede l’obbligo per gli organi di informazione pubblici<br />
o privati di garantire la corretta informazione dell’opinione pubblica.<br />
Diritto e libertà d’espressione in pubblico<br />
Nella Repubblica di Moldavia né i media, né la creazione artistica e scientifica sono sottoposti<br />
a censura.<br />
Gli appartenenti a minoranze hanno la possibilità di ricevere informazioni e scambiare<br />
informazioni e idee, sia nella propria lingua (oltre il 50% dei mezzi di informazione utilizza lingue<br />
minoritarie) che attraverso i canali radiotelevisivi e qualsiasi altro moderno mezzo di comunicazione.<br />
Ad esempio, il servizio radiotelevisivo assicura la messa in onda di trasmissioni speciali<br />
destinate alle minoranze nazionali in lingua russa, ucraina, bulgara, gagauza, hiddish e zigana.<br />
Inoltre, tutti i cittadini, compresi gli appartenenti alle minoranze, hanno libero accesso ai<br />
programmi trasmessi dalle 100 stazioni della Rete televisiva della Repubblica di Moldavia, regolarmente<br />
autorizzate. Le maggiori agenzie televisive sono Sun TV (26 canali), Nit, Catalan, Aspect,<br />
oltre alle stazioni televisive di Comrat e di Balti. A seguito della riforma amministrativa e<br />
territoriale attuata nel paese, è sorto il problema della creazione di nuove stazioni TV nei centri<br />
regionali.<br />
La legislazione prevede un meccanismo che garantisce il diritto alla libera espressione dei cittadini<br />
senza alcuna discriminazione fondata sull’origine etnica. A conferma di quanto detto, la<br />
Legge sui Mezzi audiovisivi (G.U. della Rep. di Moldavia del 14 dicembre 1995) dispone che<br />
nella Repubblica di Moldavia il diritto alla libera espressione delle idee e delle opinioni, alla libera<br />
comunicazione delle informazioni mediante la televisione e la radiodiffusione, nonché il diritto<br />
200
alla corretta informazione sono garantiti dalla legge, nel rispetto dei diritti e delle libertà costituzionali.<br />
La legge prevede che la libertà di espressione nel settore audiovisivo non leda la dignità<br />
della persona. Ogni persona fisica e giuridica della Rep. di Moldavia può creare un mezzo audiovisivo.<br />
REPUBBLICA DI MACEDONIA<br />
I principi e gli standard di base riguardanti la libertà di espressione nelle lingue delle minoranze<br />
nazionali (ossia delle comunità) e l'accesso delle minoranze nazionali (ovvero dei<br />
membri delle comunità) ai mass media, contenuti nella Convenzione quadro per la tutela delle<br />
minoranze nazionali, sono adeguatamente recepiti dalla legislazione nazionale della Repubblica<br />
di Macedonia.<br />
La Costituzione della Repubblica di Macedonia (articolo 16) garantisce la libertà di parola,<br />
anche in pubblico, e di informazione, nonché la libertà di creare mezzi di informazione di<br />
massa. Garantisce altresì il libero accesso alle informazioni, nonché la libertà di ricevere e divulgare<br />
informazioni.<br />
L'articolo 48 della Costituzione prevede che i membri delle comunità abbiano il diritto di<br />
esprimere, promuovere e sviluppare liberamente l'identità e le caratteristiche delle rispettive<br />
comunità, nonché di usarne i simboli. La Repubblica garantisce la tutela dell'identità etnica, culturale,<br />
linguistica e religiosa di tutte le comunità. I membri delle comunità hanno il diritto di fondare<br />
istituzioni culturali, artistiche e connesse all'istruzione, nonché associazioni scientifiche e di<br />
altro tipo al fine di esprimere, promuovere e sviluppare la propria identità.<br />
L'Accordo Quadro del 13 agosto 2001, in particolare l'Allegato C, intitolato Misure di attuazione<br />
e di creazione della fiducia, comma 6 relativo alla Cultura, Istruzione e Uso delle Lingue<br />
sottolinea la necessità di sviluppare l'assistenza dedicata a progetti nel settore dei media, al<br />
fine di rafforzare ulteriormente la radio, la TV e i media della carta stampata, compresi anche i<br />
media di lingua albanese e quelli multietnici; l'obiettivo, inoltre è anche quello di incrementare i<br />
programmi di formazione professionale nel settore dei media destinati ai membri delle comunità<br />
non appartenenti alla maggioranza in Macedonia.<br />
La Legge sulla diffusione radiotelevisiva (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Macedonia<br />
n. 20/97) nella qualità di lex specialis , stabilisce le condizioni e le modalità di esecuzione<br />
delle attività di diffusione radiotelevisiva. Detta legge, tra l'altro, contiene le disposizioni che definiscono<br />
specificamente il modo in cui i membri delle comunità possono esercitare i propri diritti<br />
in questo settore.<br />
In particolare l'articolo 45, comma 2 della Legge sulla diffusione radiotelevisiva prevede<br />
che l'ente radiotelevisivo pubblico, che diffonde programmi sul territorio della Repubblica di Macedonia<br />
(Radio e Televisione macedone), trasmetta programmi sia in lingua macedone sia nelle<br />
lingue delle comunità.<br />
Il comma 3 del medesimo articolo della citata legge prevede che nelle zone in cui i<br />
membri delle comunità costituiscono la maggioranza oppure sono presenti in numero cospicuo,<br />
l'ente radiotelevisivo pubblico locale deve trasmettere programmi nella lingua della comunità interessata.<br />
Il comma 4 dell'articolo 45 della Legge sulla diffusione radiotelevisiva prevede che gli<br />
enti radiotelevisivi commerciali abbiano il diritto di trasmettere programmi anche nelle lingue delle<br />
comunità, oltre che in macedone.<br />
L'articolo 6, comma 1, paragrafo 1 della Legge istitutiva dell'ente radiotelevisivo pubblico<br />
macedone (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Macedonia n. 6/98 e 98/2000) prevede per<br />
tale ente l'obbligo di produrre e trasmettere programmi radiotelevisivi conformi al quadro dei diritti<br />
e delle libertà garantite all'individuo e al cittadino con riferimento ai contenuti di tipo informativo,<br />
culturale, scientifico, sportivo, musicale, di intrattenimento, di formazione e di altro tipo; tali<br />
201
programmi devono fare uso delle lingue delle nazionalità, ovverosia delle comunità, che vivono<br />
nella Repubblica di Macedonia.<br />
Televisione<br />
Nella Repubblica di Macedonia esistono 138 enti radiotelevisivi riferibili sia al settore<br />
pubblico che a quello privato; tali enti fondano la loro attività sulle citate disposizioni contenute<br />
nella Legge sulla diffusione radiotelevisiva e nella Legge istitutiva dell'ente radiotelevisivo pubblico<br />
macedone.<br />
I citati enti trasmettono programmi nelle lingue delle comunità, sia per quanto riguarda il<br />
settore pubblico che quello privato, come previsto dall'articolo 45, commi 2, 3 e 4 della Legge<br />
sulla diffusione radiotelevisiva.<br />
L'ente radiotelevisivo macedone, che offre un servizio pubblico a livello nazionale, trasmette<br />
programmi nelle lingue di tutte le comunità (albanese, turco, rom, valacco e serbo), con<br />
una discriminazione positiva a favore della comunità albanese.<br />
Anche una parte delle stazioni radiotelevisive pubbliche a livello locale trasmettono programmi<br />
nelle lingue delle comunità.<br />
Nel settore commerciale, i programmi nelle lingue delle comunità sono trasmessi dagli<br />
enti radiotelevisivi commerciali che dispongono della concessione per la diffusione radiotelevisiva<br />
a livello locale<br />
In conclusione si può affermare che nella Repubblica di Macedonia una gran parte dei<br />
programmi dei media elettronici viene trasmesso nelle lingue delle comunità.<br />
La Legge sulla diffusione radiotelevisiva prevede che sia fornito sostegno finanziario alle<br />
produzioni radiotelevisive, sia per programmi in macedone sia per programmi nelle lingue delle<br />
comunità; tale contributo viene prelevato dal costo degli abbonamenti radiotelevisivi, nella misura<br />
del 10% e viene destinato alla produzione di programmi di interesse pubblico da parte di<br />
enti radiotelevisivi commerciali e di produttori indipendenti.<br />
Quando vengono selezionati progetti finanziabili con fondi prelevati dal costo degli abbonamenti,<br />
il Consiglio per la diffusione radiotelevisiva è particolarmente attento a dare sostegno<br />
a progetti che soddisfino gli interessi multiculturali dei cittadini.<br />
ROMANIA<br />
Descrizione<br />
In Romania la libertà di espressione e il diritto all’informazione sono garantiti dalla Costituzione<br />
a tutti i cittadini senza alcuna distinzione fondata sull’origine etnica. I relativi articoli 30 e<br />
31, unitamente al principio della non discriminazione, rappresentano la base giuridica a garanzia<br />
della libertà di espressione e del diritto all’informazione anche degli appartenenti alle minoranze<br />
nazionali.<br />
La Costituzione definisce la libertà di espressione rispetto ai mezzi di comunicazione<br />
pubblici.<br />
Contestualmente, è fatto espressamente divieto di censura o soppressione di pubblicazioni<br />
ed è garantita la libertà di pubblicare materiale.<br />
Inoltre, consentendo ai cittadini di partecipare alla vita pubblica sociale e culturale attraverso la<br />
manifestazione pubblica dei loro pensieri, delle loro opinioni e dei loro credi, la libertà<br />
d’espressione non è assoluta, ma soggetta ad alcuni limiti imposti a livello internazionale. Il<br />
mancato rispetto dei limiti imposti dalla Costituzione e dall’ordinamento giuridico comporta delle<br />
responsabilità sul piano legale.<br />
Garantendo il diritto all’informazione - il diritto della persona ad avere accesso a qualsiasi<br />
informazione di carattere pubblico – la Costituzione impone degli obblighi in relazione al<br />
compito delle autorità pubbliche di fornire ai cittadini una corretta informazione sui problemi di<br />
interesse pubblico, di garantire l’accesso da parte dei maggiori gruppi sociali e politici ai servizi<br />
radiotelevisivi pubblici.<br />
Le norme costituzionali disciplinanti la materia sono state riprese ed elaborate<br />
nell’ambito di un’apposita legge – la Legge sui mezzi audiovisivi (Legge n. 48 del 27 maggio<br />
1992).<br />
202
In pratica, lo Stato sostiene l’esercizio della libertà di espressione e del diritto<br />
all’informazione da parte di coloro che appartengono a minoranze nazionali attraverso misure<br />
specifiche:<br />
- finanzia la pubblicazione di alcuni giornali e periodici in lingua minoritaria,<br />
- offre sostegno finanziario alle case editrici che pubblicano libri stampati nelle lingue minoritarie,<br />
- fa in modo che agli appartenenti a minoranze sia garantito uno spazio nell’ambito della<br />
programmazione radiotelevisiva e il diritto di utilizzare le sedi locali dell’emittente pubblica.<br />
Alle organizzazioni di persone appartenenti a minoranze nazionali che abbiano rappresentanti<br />
in Parlamento sono riservati tempi di trasmissione gratuiti e senza ingerenze previsti<br />
per legge.<br />
Quadro giuridico<br />
Costituzione<br />
Articolo 30 - La libertà di espressione<br />
La libertà di espressione, di pensiero, di opinione o credo e la libertà di creazione, con<br />
parole, per iscritto, attraverso immagini, suoni o altri mezzi di comunicazione in pubblico sono<br />
inviolabili.<br />
E’ fatto divieto per qualsiasi tipo di censura.<br />
La libertà di stampa implica anche la libertà di creare pubblicazioni.<br />
Nessuna pubblicazione può essere soppressa.<br />
La legge può imporre ai mass media l’obbligo di rivelare la loro fonte di finanziamento.<br />
La libertà di espressione non può ledere la dignità, l’onore, la privacy della persona né il<br />
diritto alla propria immagine.<br />
Sono vietati per legge la diffamazione del paese e della nazione, l’esortazione alla guerra<br />
offensiva, l’odio nazionale, razziale, di classe e religioso, l’incitazione alla discriminazione, al<br />
separatismo territoriale o alla violenza pubblica, nonché gli atti osceni che offendono la moralità<br />
pubblica.<br />
In caso di divulgazione al pubblico di informazioni o creazioni la legge prevede che la<br />
responsabilità civile ricada sull’editore o curatore, sull’autore, sull’organizzatore della manifestazione<br />
artistica, sul proprietario delle attrezzature utilizzate per la stampa e la riproduzione, sulla<br />
stazione radiotelevisiva. I reati di stampa sono puniti per legge.<br />
Articolo 31 – Il diritto all’informazione<br />
Il diritto dell’individuo ad accedere a qualsiasi informazione d’interesse pubblico non<br />
può essere limitato.<br />
Le autorità pubbliche, nell’ambito delle competenze loro conferite, sono tenute a garantire<br />
una corretta informazione dei cittadini sulle questioni d’interesse pubblico e privato.<br />
Il diritto all’informazione non deve ledere il diritto dei giovani alla tutela o mettere a rischio<br />
la sicurezza nazionale.<br />
I mezzi di informazione, pubblici e privati, sono tenuti a garantire una corretta informazione<br />
dell’opinione pubblica.<br />
I servizi radiotelevisivi sono autonomi. Essi devono garantire ai maggiori gruppi sociali e<br />
politici l’esercizio del diritto ad un apposito spazio loro riservato nell’ambito della programmazione<br />
radiotelevisiva. L’organizzazione di questi servizi ed il controllo parlamentare sulle loro attività<br />
sono disciplinati da una legge organica.<br />
Articolo 1<br />
La libertà di esprimere idee e opinioni nonché la libertà di comunicare informazioni attraverso<br />
il mezzo radiotelevisivo sono garantiti dalla legge, nel rispetto dei diritti e delle libertà<br />
sanciti dalla Costituzione.<br />
I mezzi di informazione audiovisiva pubblici e privati sono tenuti a garantire la corretta<br />
informazione dell’opinione pubblica.<br />
E’ fatto assoluto divieto di censura.<br />
203
Articolo 2<br />
La libertà di espressione non può ledere la dignità, l’onore, la privacy della persona né il<br />
diritto alla propria immagine.<br />
Infrastruttura statale<br />
Gli enti competenti a garantire nel concreto la libertà di espressione e il diritto<br />
all’informazione degli appartenenti alle minoranze nazionali sono molteplici: il Ministero della<br />
Cultura (Dipartimento per le minoranze), il Dipartimento per la Tutela delle Minoranze Nazionali,<br />
il Consiglio Nazionale dei Mezzi Audiovisivi, la Società Nazionale di Radiodiffusione.<br />
Misure adottate<br />
Una parte degli organi di stampa pubblicati nelle lingue minoritarie riceve sovvenzioni<br />
statali erogate attraverso il Consiglio delle Minoranze Nazionali, organo consultivo del Dipartimento<br />
per la Tutela delle Minoranze Nazionali oppure attraverso il Ministero della Cultura.<br />
Anche le case editrici che pubblicano libri nella lingua degli appartenenti a minoranze<br />
nazionali ricevono finanziamenti dallo Stato.<br />
Sia la Società Romena di Radiodiffusione che la televisione pubblica garantiscono, sia<br />
a livello centrale che locale, nell’ambito della propria programmazione, uno spazio riservato alle<br />
organizzazioni di cittadini appartenenti alle minoranze nazionali.<br />
Fatti<br />
Il numero complessivo di periodici pubblicati nella lingua parlata dagli appartenenti alle<br />
minoranze nazionali è di circa 130 titoli.<br />
Le case editrici “Kriterion” e “Mentor” pubblicano libri nelle lingue minoritarie nazionali.<br />
Viene pubblicato un considerevole numero di riviste culturali nelle seguenti lingue minoritarie:<br />
16 in magiaro, 2 in tedesco, 1 in ucraino, 1 in yddish, ecc.<br />
Per quanto riguarda l’accesso degli appartenenti alle minoranze nazionali a trasmissioni<br />
radiotelevisive nazionali, sono da rilevare i seguenti elementi:<br />
La Società Romena di Radiodiffusione produce e trasmette programmi nelle lingue parlate<br />
dalle minoranze nazionali, sia a livello centrale che locale. Il tempo di programmazione settimanale<br />
riservato a tali programmi è di 25 ore e 20 minuti per la lingua ungherese e di 24 ore e<br />
40 minuti per quella tedesca. I produttori di queste trasmissioni hanno completa autonomia editoriale<br />
e sono, nel contempo, membri di alcune associazioni di categoria (come l’Associazione<br />
dei Giornalisti Magiari di Romania) o di alcune reti di informazione facenti capo ad appartenenti<br />
a minoranze.<br />
Esistono anche trasmissioni radio che si rivolgono ai membri di altre minoranze (“Tradizioni<br />
e valori culturali in Romania”, “Almanacci interculturale”, “Tradizioni”), una realtà in costante<br />
sviluppo.<br />
Anche l’attività del Dipartimento degli studi territoriali e locali si fonda sul principio<br />
dell’autonomia e dell’indipendenza editoriale dei produttori. Gli studi di Cluj-Napoca, Targu Mures<br />
Timisoara e Constanta, trasmettono programmi nelle lingue parlate da 10 minoranze nazionali.<br />
Vengono settimanalmente trasmesse 71 ore in magiaro, 14 in tedesco, 7 in serbo, 30 minuti<br />
in ciascuna delle seguenti lingue: slovacco, ceco,, bulgaro, greco, turco, tartaro e russo. La<br />
Società Nazionale di Radiodiffusione trasmette settimanalmente due programmi dedicati alle<br />
popolazioni zingare/Rom, di cui uno della durata di 60 minuti a Targu Mures e l’altro, della medesima<br />
durata, a Craiova.<br />
Le organizzazioni di appartenenti a minoranze nazionali che hanno dei rappresentanti in<br />
Parlamento dispongono anch’esse di un apposito spazio di trasmissione loro riservato, secondo<br />
quanto previsto dalla legge, del tutto gratuito e senza alcuna ingerenza dall’esterno.<br />
I redattori di programmi radiofonici in lingua minoritaria partecipano a corsi di formazione<br />
organizzati in Romania dai dipartimenti competenti o all’estero da altre associazioni di categoria<br />
nazionali o internazionali.<br />
Le trasmissioni televisive in lingua minoritaria hanno costituito una presenza costante<br />
negli studi centrali, nel periodo compreso tra il 1993 ed il 1999: 180 min. settimanali in magiaro,<br />
115 min settimanali in tedesco. A questi si aggiungono i programmi trasmessi dagli studi territoriali<br />
di Cluj-Napoca.<br />
204
Gli appartenenti a minoranze diverse dai Magiari e dai Tedeschi sono oggetto di un ciclo<br />
di trasmissioni dal titolo “Convietuiri” e “La vita degli Zingari/Rom”, entrambi i programmi trattano<br />
aspetti della vita culturale delle popolazioni nomadi, si occupano della loro integrazione<br />
sociale nell’intento di prevenire eventuali conflitti.<br />
RUSSIA<br />
L’art. 29 della Costituzione della Federazione Russa garantisce ad ognuno la “libertà di<br />
pensiero e di parola”, “il diritto di ricercare, ricevere, comunicare, produrre e divulgare liberamente<br />
informazioni con ogni mezzo legale” e la libertà dei media. Tali principi sono ripresi ed<br />
approfonditi dalla legge sui media, da quella sull’autonomia culturale nazionale nonché da altri<br />
atti normativi. La legge sui media, inoltre, non prevede alcuna restrizione in merito alla lingua<br />
utilizzata dagli organi di informazione e vieta l’utilizzo di questi ultimi con l’intento di incitare<br />
all’intolleranza ed all’odio nazionali e religiosi.<br />
Attualmente nelle diverse regioni della Federazione Russa vengono stampate oltre 400<br />
pubblicazioni fra giornali e riviste nelle 59 lingue delle popoli della Russia.<br />
A Mosca, ad esempio, si pubblica materiale informativo in 9 lingue (armeno, georgiano,<br />
yiddish, kurdo, tedesco, tartaro, ucraino, zigano, ceceno).<br />
In ogni regione esistono pubblicazioni nelle varie lingue minoritarie parlate localmente.<br />
Le spese per la pubblicazione dei giornali e la diffusione di programmi radiofonici nelle lingue<br />
nazionali sono sostenute grazie all’utilizzo di stanziamenti erogati a livello locale e, in parte, con<br />
il contributo offerto da sponsor ed associazioni pubbliche.<br />
Nella Federazione Russa, le trasmissioni radiofonoche sono trasmesse in 43 lingue,<br />
mentre quelle televisive in 33 lingue nazionali. Tutte le società radiotelevisive delle Repubbliche<br />
e numerose altre a carattere regionale trasmettono non solo in russo, ma, contestualmente, anche<br />
nelle lingue locali nazionali.<br />
Nei programmi trasmessi dalle emittenti locali (SRT), l’utilizzo delle lingue nazionali è<br />
limitato e prevalgono i programmi a carattere informativo: notiziari, interviste, reportage. Le<br />
SRT, la cui programmazione abbraccia in larga misura questo genere di programmi, prevede<br />
anche la diffusione di altri format di giornalismo radiotelevisivo, soprattutto di reportage di fondo,<br />
filmati, notiziari televisivi e radiofonici, nonché di programmi letterari, musicali e teatrali.<br />
I servizi federali russi competenti aiutano i mezzi elettronici federali e regionali a trattare<br />
tutti gli aspetti della vita delle etnie numericamente più consistenti, nonché gli eventi ed i fatti<br />
che, a livello di Repubbliche, contribuiscono al rafforzamento delle relazioni e della cooperazione<br />
reciproche tra i vari popoli della Russia; gli stessi forniscono alle emittenti radiotelevisive regionali<br />
che trasmettono in lingua minoritaria attrezzature audiovisive i cui costi sono a carico<br />
dello Stato; i servizi federali, inoltre, elaborano programmi radiotelevisivi comuni e ne consentono<br />
lo scambio tra le varie società radiotelevisive, comprese quelle che trasmettono nelle lingue<br />
nazionali; i citati servizi sovvenzionano con fondi statali le società radiotelevisive regionali, tra<br />
cui quelle trasmesse nelle lingue regionali; offrono il proprio supporto materiale, amministrativo<br />
e scientifico alle emittenti radiotelevisive nazionali; provvedono alla formazione di specialisti del<br />
settore a livello nazionale con corsi organizzati presso l’Istituto di Studi Avanzati per Operatori<br />
Radiotelevisivi.<br />
SAN MARINO<br />
La Repubblica di San Marino è un piccolo Stato, con una superficie di 60 km², conta circa<br />
25 mila abitanti, tutti appartenenti allo stesso gruppo etnico. La lingua ufficiale è l’italiano, insegnato<br />
a scuola ed utilizzato in tutti gli atti ufficiali ad uso pubblico.<br />
Benché non siano presenti sul territorio minoranze etniche, San Marino ha conosciuto di<br />
recente il fenomeno dell’immigrazione. Nel paese lavora un numero di persone molto elevato<br />
rispetto alla popolazione autoctona. Questi lavoratori, provenienti in massima parte dall’Europa<br />
dell’Est o dal Maghreb, sono in gran parte stagionali, poiché il turismo crea numerosi posti di<br />
lavoro in primavera ed estate. Alcuni di questi immigrati stagionali, ordinariamente occupati nel<br />
settore della ristorazione o come venditori, potrebbero prevedere di vivere stabilmente a San<br />
205
Marino. Attualmente, considerato il loro numero esiguo, la convivenza con la comunità autoctona<br />
non pone problemi.<br />
Con riferimento allo stato del diritto internazionale nell’ordinamento giuridico interno,<br />
l’art. 1 della legge n. 59 dell’8 luglio 1974 “Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali<br />
dell’ordinamento costituzionale di San Marino” recita come segue: “La Repubblica di<br />
San Marino considera le norme di diritto internazionale parte integrante del proprio ordinamento<br />
costituzionale, ripudia la guerra come mezzo per risolvere i conflitti tra Stati, aderisce alle convenzioni<br />
internazionali sui diritti dell’uomo e le libertà e ribadisce il diritto all’asilo politico”.<br />
Da tale disposizione deriva che:<br />
a. il diritto consuetudinario internazionale è considerato parte integrante del diritto di San Marino:<br />
non è quindi necessario alcuno strumento interno per la sua integrazione nell’ordinamento<br />
giudico san marinese;<br />
b. una volta approvate e ratificate dall’organo competente, le convenzioni internazionali sono<br />
introdotte nell’ordinamento giuridico del paese. Gli strumenti internazionali sono ordinariamente<br />
ratificati dal parlamento (Gran Consiglio e Consiglio Generale).<br />
La Repubblica di San Marino non ha precise disposizioni in materia di tutela delle minoranze<br />
etniche. Tale lacuna è da attribuirsi alla particolare struttura della repubblica in quanto tale<br />
ed alla composizione della popolazione residente più che alla mancanza di volontà da parte<br />
del legislatore.<br />
La Repubblica di San Marino è di fatto un piccolo Stato, un enclave della Repubblica Italiana<br />
con il quale condivide numerose tradizioni (linguistiche, sociali, culturali, ecc.) La sua<br />
evoluzione storica e la sua scarsa superficie hanno da sempre ostacolato l’inserimento e<br />
l’insediamento di minoranze etniche.<br />
Persino in assenza di leggi specifiche, l’ordinamento giuridico san marinese ha riconosciuto,<br />
benché a grandi linee, l’importanza dei diritti e delle libertà delle minoranze etniche, sia<br />
con l’approvazione di norme interne che con la ratifica degli strumenti internazionali.<br />
In primo luogo, è opportuno sottolineare che l’art. 4 della legge n. 59 dell’8 luglio 1974<br />
(Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale<br />
di San Marino) recita come segue: “Tutti sono uguali innanzi alla legge, senza alcuna distinzione<br />
fondata su motivi di carattere personale, economico, sociale, politico o religioso...”.<br />
Una disposizione analoga figura all’articolo 14 della Convenzione sulla Salvaguardia dei<br />
Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali che, ratificata con decreto n. 22 del 9 marzo 1980,<br />
è divenuta parte integrante dell’ordinamento giuridico san marinese.<br />
Con tali norme, la Repubblica di San Marino riconosce, e si impegna a riconoscere in<br />
futuro, le pari opportunità a tutti coloro che soggiacciono a quanto disposto dal suo ordinamento.<br />
Tuttavia, il principio di uguaglianza non solo vieta al legislatore di operare alcuna discriminazione<br />
per motivi fondati sulla condizione personale o sociale e sul credo religioso o politico<br />
all’atto di applicare la legge, ma gli impone altresì di tener conto della oggettiva specificità di<br />
ciascun caso, dal momento che non vi è peggior discriminazione di quella che tratta sullo stesso<br />
piano e standardizza situazioni fra loro diverse.<br />
In virtù del principio di uguaglianza summenzionato, lo Stato si impegna anche ad eliminare<br />
ogni eventuale privilegio o disparità inerente al sistema economico e sociale in modo<br />
che ognuno possa avere le stesse opportunità di esercitare i propri diritti.<br />
Occorre, comunque, rammentare che per ora la Repubblica di San Marino si impegna a<br />
riconoscere solo ipoteticamente l’uguaglianza dei diritti e dei doveri alle minoranze nazionali,<br />
dato che sul suo territorio non sono presenti questo tipo di minoranze.<br />
SERBIA E MONTENEGRO (EX REPUBBLICA DI JUGOSLAVIA)<br />
La libertà di espressione è ampiamente garantita dalla Costituzione del paese. All’art.<br />
35, essa prevede la libertà di esprimere le proprie idee, i propri pensieri e la propria opinione.<br />
Tale libertà comporta anche quella di ricevere e di comunicare informazioni, la quale è garantita<br />
206
dall’art. 36, comma 2, della Costituzione della Ex Rep. di Jugoslavia, che riconosce ai cittadini il<br />
diritto di esprimere e pubblicare le proprie opinioni attraverso i mezzi di informazione.<br />
In virtù dell’art. 46, comma 2 della Costituzione, le persone appartenenti a minoranze<br />
nazionali hanno diritto all’informazione pubblica nella loro lingua. Quindi allo Stato spetta l’onere<br />
di garantire l’informazione nelle lingue minoritarie attraverso gli organi di informazione di sua<br />
proprietà e sotto il proprio controllo. La legge sulla Tutela delle libertà e dei diritti delle minoranze<br />
nazionali disciplina tale materia all’art. 17, il quale stabilisce che le minoranze nazionali hanno<br />
diritto ad un’informazione completa ed imparziale nella loro lingua, nonché il diritto ad esprimere,<br />
ricevere, comunicare e scambiare informazioni ed idee attraverso la stampa o altri mezzi<br />
di comunicazione; questo stesso articolo dispone, inoltre, che lo Stato assicuri, nei programmi<br />
radiotelevisivi del servizio pubblico, la trasmissione di programmi di informazione, culturali e didattici<br />
nelle lingue minoritarie e che possa creare appositi canali radiotelevisivi per la trasmissione<br />
di programmi nelle citate lingue. L’informazione pubblica nelle lingue delle minoranze nazionali<br />
è regolamentata, nello specifico, dalle leggi delle repubbliche in materia di informazione.<br />
La legge della Repubblica Serba sulla radiotelevisione prevede quanto segue: al fine di garantire<br />
il rispetto dell’interesse del pubblico nell’ambito del settore radiotelevisivo pubblico,<br />
quest’ultimo è tenuto a produrre e trasmettere programmi rivolti a tutti gli strati della società,<br />
senza alcuna discriminazione e prendendosi cura, nel contempo, di specifici gruppi sociali come<br />
le minoranze nazionali; il servizio radiotelevisivo pubblico deve tener conto, in modo adeguato,<br />
delle lingue parlate dalle minoranze nazionali presenti sul territorio nel quale trasmette i propri<br />
programmi; lo stesso è tenuto a soddisfare le richieste dei cittadini di disporre di programmi che<br />
esprimano l’identità culturale delle minoranze nazionali, consentendo loro di seguire programmi<br />
o trasmissioni nella loro lingua, nel luogo in cui vivono e lavorano (art. 78). La legge della Repubblica<br />
del Montenegro sull’informazione pubblica prevede, all’art. 25, commi 2 e 3, che la politica<br />
di programmazione delle imprese che operano nel settore dell’informazione debba garantire,<br />
in termini di volume, qualità e contenuto, l’esercizio del diritto delle minoranze nazionali presenti<br />
nella Repubblica del Montenegro ad un’informazione pubblica nella loro lingua.<br />
Secondo quanto previsto dalla Costituzione della Rep. Federale di Jugoslavia, la libertà<br />
di espressione intesa come libertà di ricevere e comunicare informazioni non riguarda soltanto i<br />
mezzi di informazione. All’art. 36, comma 3, si stabilisce che la pubblicazione di giornali e la divulgazione<br />
pubblica d’informazioni attraverso altri mezzi di informazione, siano essi pubblici o<br />
privati, deve essere accessibile a tutti, compresi le persone appartenenti alle minoranze nazionali.<br />
Tale norma costituzionale disciplina la libertà di fondare ed usare i mezzi di comunicazione,<br />
attraverso cui si manifesta anche la libertà di espressione. Nella Rep. Fed. di Jugoslavia nessun<br />
ostacolo si frappone all’esercizio di questa libertà, quindi, oltre ai mezzi di informazione del servizio<br />
pubblico, è presente un gran numero di giornali e di canali radiotelevisivi privati.<br />
L’art. 36, comma 3, della Costituzione della Rep. Fed. di Jugoslavia vieta qualsiasi limitazione<br />
all’esercizio della libertà di espressione attraverso lo scambio di informazioni e di idee;<br />
lo stesso precisa che non è necessario alcun accordo preliminare per la pubblicazione di giornali<br />
e la trasmissione di informazioni con altri mezzi di informazione, previa registrazione presso<br />
le autorità competenti, che è gratuita. Inoltre, sulla base delle disposizioni non equivoche<br />
dell’art. 38, comma 1, della Costituzione della Rep. Fed. di Jugoslavia, è vietata la censura della<br />
stampa e degli altri mezzi di informazione pubblica. La distribuzione della stampa o la divulgazione<br />
delle altre pubblicazioni può essere impedita solo con decisione di un tribunale competente<br />
qualora si ravvisino gli estremi di alcuni reati che violano i principi sanciti dalla Costituzione<br />
stessa (istigazione a sovvertire l’ordine costituito o violazione dell’integrità territoriale della Rep<br />
Fed. di Jugoslavia, violazione dei diritti e delle libertà dell’uomo e del cittadino, incitazione<br />
all’intolleranza o all’odio razziale o religioso). La libertà di espressione comprende anche quella<br />
di comunicare e ricevere informazioni.<br />
Numerose minoranze nazionali della Rep. Fed. di Jugoslavia godono della libertà di ricevere<br />
informazioni senza badare a frontiere. Tutte le regioni della Rep. Fed. di Jugoslavia ove<br />
insistono delle minoranze nazionali sono in grado di ricevere le trasmissioni diffuse dai canali<br />
della televisione nazionale. Il ministero federale delle Comunità nazionali ed etniche ha finanziato<br />
la costruzione di due trasmettitori televisivi a Bosilegrad e Priboi.<br />
207
Per quanto riguarda la libertà di espressione che si esplica attraverso la libertà di ricevere<br />
e comunicare informazioni, la Costituzione della Rep. Serba e quella della Rep. del Montenegro<br />
contengono disposizioni analoghe a quelle della Costituzione federale. Quest’ultima prevede<br />
che, nel settore delle telecomunicazioni, la regolamentazione dei sistemi tecnici e tecnologici<br />
e dei sistemi di comunicazione sia di competenza federale. Ai sensi della norma costituzionale<br />
in base alla quale tutte le questioni che esulano dalla sfera di attribuzione della Federazione<br />
sono di competenza delle repubbliche (principio della presunzione di competenza in favore<br />
delle repubbliche), il settore dell’informazione è retto dalle leggi emanate dalle repubbliche nella<br />
materia. Tali leggi sanciscono il diritto di tutte le persone fisiche o giuridiche a partecipare<br />
all’informazione pubblica in condizioni di parità, in altri termini, esse prevedono l’obbligo di applicare<br />
alla regolamentazione dei rapporti nel settore della radiotelevisione il principio che vieta<br />
ogni forma di discriminazione (art. 5 della legge della Rep. del Montenegro sull’informazione<br />
pubblica e art. 3 della legge della Rep. Serba sulla radiotelevisione). Dalle disposizioni sopracitate<br />
si evince con chiarezza che gli appartenenti alle minoranze nazionali non sono discriminati<br />
per quanto attiene l’accesso ai mezzi di informazione.<br />
La regolamentazione delle emittenti radiotelevisive nella Federazione Jugoslava è di<br />
competenza delle repubbliche, le cui leggi prevedono la creazione di canali radiofonici e televisivi<br />
previa approvazione da parte delle autorità competenti del servizio pubblico. Il rilascio di tale<br />
autorizzazione dipende unicamente dalla presenza di specifiche condizioni tecniche legate<br />
all’utilizzo delle bande di frequenza e dal rispetto di requisiti tecnici minimi per le trasmissioni<br />
radiotelevisive. Poiché i criteri su cui si basa non sono oggettivi, l’approvazione può essere concessa<br />
senza incorrere in alcuna discriminazione (art. 14, comma 2 della legge della Rep. del<br />
Montenegro sull’informazione pubblica ed artt. 38 e 39 della legge della Rep. Serba sulla radiotelevisione).<br />
In concreto, gli appartenenti alle minoranze nazionali hanno potuto ottenere queste<br />
autorizzazioni senza subire discriminazioni e ciò è confermato dalle cifre relative ai canali radiotelevisivi<br />
che trasmettono programmi nelle lingue minoritarie. Le trasmissioni radiotelevisive devono<br />
rispettare anche un’ultra condizione: la politica di programmazione non deve mirare a sovvertire<br />
l’ordine costituito, a violare l’integrità territoriale della Rep. Del Montenegro e della Rep.<br />
Fed di Jugoslavia, a violare i diritti e le libertà dell’uomo e del cittadino, ad istigare<br />
all’intolleranza o all’odio razziale o religioso (art. 24, comma 2, della legge della Rep. del Montenegro<br />
sull’informazione pubblica); La politica di programmazione, inoltre, non deve fondarsi<br />
sull’odio (artt. 8 e 21 della legge della Rep. Serba sulla radiotelevisione).<br />
Si è affermato che gli appartenenti a minoranze nazionali hanno gli stessi diritti e le<br />
stesse possibilità del resto della popolazione in materia di libertà di espressione (ossia di ricevere<br />
e comunicare informazioni).Lo Stato non impedisce loro né di creare né di utilizzare organi di<br />
stampa. Nella pratica, la creazione e l’utilizzo di organi di stampa sono strettamente connesse<br />
alla disponibilità economica, con il risultato che sono maggiormente diffusi nelle regioni più ricche.<br />
Gli appartenenti alle diverse minoranze nazionali creano ed utilizzano organi di stampa in<br />
misura diversa. Lo Stato finanzia la stampa privata ed i giornali redatti in lingua rom sono quelli<br />
che ricevono la parte più consistente di sovvenzioni.<br />
La maggior parte dei quotidiani di informazione scritti nelle lingue minoritarie vengono<br />
pubblicati in Voïvodina.<br />
Si pubblicano giornali, periodici e riviste nelle seguenti lingue minoritarie: albanese, ungherese,<br />
slovacco, ruteno, romeno, rom, bulgaro e turco.<br />
Si stampano giornali che riportano notizie a carattere locale che nazionale rivolte alla<br />
comunità dei bosniaci/musulmani. La comunità musulmana pubblica un proprio giornale.<br />
Le lingue minoritarie utilizzate dalle numerose stazioni radiofoniche e televisive che trasmettono<br />
sia in ambito locale che a livello nazionale: serbo, croato, albanese, bulgaro, ungherese,<br />
rom, romeno, ruteno, slovacco, ucraino.<br />
La politica di programmazione dei mezzi di informazione non deve istigare<br />
all’intolleranza ed all’odio nazionale, razziale e religioso (art. 24, comma 2 della legge della Rep.<br />
del Montenegro sull’Informazione pubblica ed artt. 8 e 21 della legge della Rep. Serba sulla radiotelevisione).<br />
Il divieto di istigare all’intolleranza ed all’odio nei confronti delle minoranze na-<br />
208
zionali non è l’unico modo per promuovere la tolleranza; oltre a consentire l’accesso ai mezzi di<br />
informazione, in virtù del diritto all’informazione pubblica ed alla libertà sancito dalla Costituzione,<br />
la Rep. Fed di Jugoslavia ha introdotto, tra le disposizioni di legge in materia di Tutela delle<br />
libertà e dei diritti delle minoranze nazionali, anche specifiche norme atte a favorire ulteriormente<br />
l’accesso ai mezzi di informazione. L’art. 19, comma 7 di questa legge dispone che il consiglio<br />
di una minoranza nazionale (una forma di organizzazione dell’autonomia delle minoranze)<br />
rappresenti la stessa nel settore dell’informazione. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dal comma<br />
10 dello stesso articolo, lo Stato è tenuto a stanziare i fondi necessari per l’esercizio di simili<br />
competenze.<br />
Al fine di promuovere la tolleranza e di consentire il pluralismo culturale, la legge serba<br />
sulla radiotelevisione prevede l’obbligo di garantire, nell’ambito dei programmi prodotti e trasmessi<br />
dal servizio pubblico, la diversità e l’armonizzazione dei contenuti a difesa dei valori democratici<br />
della società contemporanea e, in particolare, il rispetto dei diritti dell’uomo, nonché il<br />
pluralismo culturale, nazionale, etnico e politico delle idee e delle opinioni.<br />
SLOVACCHIA<br />
L’accesso degli appartenenti a minoranze nazionali è garantito dalla legislazione ed attuato<br />
nella prassi. E’ uno dei mezzi attuali attraverso cui viene salvaguardata la tutela<br />
dell’identità culturale, della lingua e delle usanze proprie di ogni singola minoranza nazionale. In<br />
Slovacchia, la radiotelevisione pubblica trasmette programmi nelle lingue minoritarie. Vengono<br />
attualmente trasmessi programmi in lingua ungherese, ucraina, rutena, tedesca e rom. Sul territorio<br />
della Repubblica Slovacca, si possono seguire anche programmi radiofonici e televisivi<br />
trasmessi da emittenti estere vicine (sia pubbliche che private). Oltre ai mezzi di informazione<br />
elettronici, ogni anno vengono stampati, fruendo di sovvenzioni statali, vari periodici ed altre<br />
pubblicazioni non periodiche. L’accesso alle pubblicazioni letterarie straniere non è sottoposto<br />
ad alcuna restrizione.<br />
Costituzione della Repubblica Slovacca, art. 34<br />
(1) “La Repubblica Slovacca garantisce ad ogni cittadino appartenente ad una minoranza<br />
nazionale o ad un gruppo etnico il diritto di promuovere e condividere con gli altri appartenenti<br />
alla stessa minoranza nazionale o allo stesso gruppo etnico una propria vita culturale, di<br />
comunicare e ricevere informazioni nella propria lingua, di creare associazioni nazionali e di<br />
fondare e gestire istituti di istruzione e culturali.<br />
Legge n. 268/1993 (Raccolta) sul funzionamento della radio e della televisione<br />
(2) La legge impone agli operatori l’obbligo di: (...)<br />
c) realizzare o far realizzare buona parte dei propri programmi secondo criteri che preservino<br />
l’identità culturale della nazione, delle minoranze nazionali e dei gruppi etnici (...)”.<br />
Legge n. 270/1993 (Raccolta) sulla Radio slovacca<br />
Articolo 6: “La Radio slovacca svolge in particolare i seguenti ruoli:<br />
(...)<br />
d) contribuisce, attraverso le proprie trasmissioni, allo sviluppo della cultura nazionale e<br />
delle culture delle minoranze nazionali presenti sul territorio della Repubblica Slovacca nonché<br />
all’interpretazione dei valori culturali di altre nazioni”.<br />
SLOVENIA<br />
Nel preservare l’identità culturale delle minoranze e restare al passo con i tempi, tutto il<br />
settore dell’informazione nella lingua delle minoranze nazionali riveste una particolare attenzione.<br />
La legislazione che disciplina tale settore tiene conto delle specifiche esigenze avvertite dalle<br />
comunità minoritarie. Le comunità nazionali e la comunità Rom presenti in Slovenia dispongono<br />
di organi di stampa indipendenti che godono di sovvenzioni statali e, nell’ambito della ra-<br />
209
diotelevisione pubblica (RTV), di speciali programmi ad esse rivolti; alcuni rappresentanti dei<br />
gruppi minoritari partecipano alla gestione della RTV. Esistono altri mezzi di informazione per<br />
informare il pubblico su tematiche riguardanti le minoranze.<br />
La legge sui mezzi di comunicazione di massa (G.U. della Rep. Slovena n° 36/94) prevede<br />
l’erogazione di finanziamenti da parte del governo da destinare alla creazione di organi di<br />
informazione non commerciali per le comunità nazionali italiana ed ungherese nonché alla realizzazione<br />
dell’infrastruttura tecnica necessaria alla loro pubblicazione o radiodiffusione (art. 3).<br />
Gli organismi radiotelevisivi creati dalle autorità competenti delle comunità nazionali non<br />
sono soggetti a limitazioni riguardo alla quota di partecipazione al capitale delle società e non<br />
sono tenuti a trasmettere programmi in lingua slovena.<br />
La legge sui mezzi di comunicazione di massa prevede che in materia di concessione<br />
gratuita di un canale sulla RTV, sarà data precedenza all’organizzazione che trasmette gran<br />
parte dei programmi in sloveno, italiano o ungherese sul territorio ove insistono le comunità italiana<br />
ed ungherese (art. 53, comma 3). La legge sulla radiotelevisione slovena (G.U. della Rep.<br />
Slovena n. 36/94) prevede che le minoranze nazionali italiana ed ungherese procedano ciascuna<br />
alla nomina di un membro in seno al Consiglio della RTV, quale organo direttivo.<br />
Quest’ultimo nomina a sua volta i consigli responsabili delle trasmissioni destinate alle comunità<br />
etniche. I programmi per le due minoranze nazionali sono trasmessi dai centri regionali RTV di<br />
Koper-Capodistria e Maribor. Secondo quanto previsto dalla legge slovena sulla radiotelevisione,<br />
la Repubblica di Slovenia contribuisce al finanziamento delle trasmissioni radiotelevisive destinate<br />
alle comunità nazionali italiana ed ungherese. Nell’ambito della RTV slovena si applicano<br />
integralmente le disposizioni sullo status speciale delle trasmissioni destinate alle minoranze.<br />
La Repubblica di Slovenia concorre allo sviluppo dell’infrastruttura tecnica necessaria alla radiodiffusione<br />
ed alla diffusione dei segnali sui territori che ospitano le due comunità nazionale,<br />
nonché all’installazione di altri ripetitori per la trasmissione dei programmi di TV Koper/Capodistria<br />
(che può interessare il 40% della popolazione slovena), di Radio Koper/Capodistria<br />
(i programmi di Modri Val e di Onda Blu, anch’essi rivolti alla minoranza italiana,<br />
possono essere ascoltati dal 24-27% della popolazione slovena) e di Radio Muravidék Magyar<br />
per la minoranza nazionale ungherese ( un programma che può essere ascoltato dal 15% della<br />
popolazione).<br />
Per quanto concerne l’applicazione della legge sui mezzi di comunicazione di massa (il<br />
citato art. 3), le relative disposizioni sono in corso di attuazione, fatta eccezione per il programma<br />
televisivo destinato alla minoranza nazionale ungherese, dal momento che i programmi di<br />
questa minoranza non hanno raggiunto un’ampiezza e frequenza tali da conferire loro la connotazione<br />
di programma televisivo indipendente.<br />
Attraverso l’Ufficio per le Nazionalità, lo Stato eroga contributi per finanziare pubblicazioni<br />
e trasmissioni radiotelevisive destinate alla popolazione Rom ed alle due minoranze nazionali;<br />
attraverso il Ministero della Cultura, il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio per le Relazioni<br />
Pubbliche ed i Mezzi di Informazione, inoltre, stanzia sovvenzioni da destinare alle attività previste<br />
da appositi programmi.<br />
Circa l’85% delle risorse richieste per finanziare Népújság, il settimanale della comunità<br />
ungherese, sono coperte con stanziamenti pubblici. Il Ministero della Cultura mette a disposizione<br />
parte dei fondi necessari la pubblicazione dell’annuario Naptar e della raccolta letteraria<br />
“Muratai”.<br />
Il Ministero della Cultura offre contributi per la stampa dei giornali ed annuari La Città, Il<br />
Mandracchio, Lassa pur dir e Il trillo. Lo Stato finanzia per il 20% circa le attività degli istituti a<br />
composizione mista della minoranza italiana, tra cui si annovera anche la casa editrice “Edit” di<br />
Rijeka che pubblica giornali in lingua italiana (Voce del popolo, Panorama) destinati alla minoranza<br />
italiana presente in Slovenia e Croazia. I rimanenti fondi sono erogati dalla Repubblica di<br />
Croazia; altri contributi sono offerti anche dal paese di origine.<br />
La comunità Rom pubblica la rivista Romano them con articoli in sloveno e romanè.<br />
Questa pubblicazione riceve parte dei finanziamenti dal Ministero della Cultura. L’Ufficio delle<br />
Nazionalità cofinanzia programmi radiofonici per i Rom realizzati dalle emittenti locali di Novo<br />
Mesto e Murska Sobota. Le trasmissioni in sloveno e romanè sono destinate ad istruire ed informare<br />
la popolazione Rom, nonché a far conoscere la sua cultura; sono un utile strumento<br />
anche per informare la società sui problemi incontrati da questa minoranza, favorendo così la<br />
tolleranza e la convivenza.<br />
210
SVEZIA<br />
Libertà di espressione, libertà di pensiero e libertà di coscienza<br />
In base al capitolo 2, art. 1, dello Strumento di <strong>Governo</strong>, ad ogni cittadino svedese viene<br />
garantita, rispetto alla collettività, la libertà di espressione, ossia la libertà di parola, di scrittura o<br />
di rappresentazione pittorica o di altro genere, la libertà di comunicare informazioni ed esprimere<br />
idee, opinioni e sentimenti, nonché la libertà di informazione, vale a dire la libertà di ricevere<br />
ed ottenere informazioni e di conoscere le opinioni altrui. Queste libertà possono essere limitate<br />
dalla legge, a condizione che tali restrizioni perseguano finalità accettabili in una società democratica.<br />
Salvo diversa disposizione, i cittadini stranieri hanno gli stessi diritti dei cittadini svedesi<br />
per quanto attiene alla libertà di riunione, la libertà di manifestazione e la libertà di associazione<br />
secondo le disposizioni del capitolo 2, art. 22. paragrafo 2, comma 1, dello Strumento di <strong>Governo</strong>.<br />
Anche gli articoli 9 e 10 delle Convenzione Europea contengono disposizioni sulla libertà<br />
di pensiero, di coscienza e di espressione, i quali trovano applicazione nel diritto svedese.<br />
Accesso ai mezzi di comunicazione di massa<br />
Nel diritto come nella prassi dello Stato svedese, nulla vieta alle minoranze nazionali di<br />
presentare o di utilizzare qualsiasi tipo di mezzo di informazione. Le norme fondamentali sulla<br />
libertà di stampa e sulla libertà di espressione non prevedono alcuna differenza tra le persone.<br />
Ciascuno è libero di creare e gestire società di comunicazione e di utilizzarle. Inoltre, lo Stato<br />
svedese reputa importante l’applicazione di misure atte a favorire l’accesso degli appartenenti a<br />
minoranze nazionali ai mezzi di comunicazione di massa.<br />
Le autorizzazioni a trasmettere concesse alle emittenti pubbliche (televisione svedese,<br />
radio svedese e radio educativa svedese) impongono a queste di tenere conto delle esigenze<br />
legate alle minoranze linguistiche ed etniche. Il sami, il finnico ed il meänkieli assumono particolare<br />
rilievo nella programmazione. Il governo ha presentato la proposta di legge: Radio e televisione<br />
al servizio del pubblico 2002-2005 (2000/2001:94), relativa al periodo di validità delle autorizzazioni<br />
con decorrenza 2002, in base alla quale alla lingua romani chib è riconosciuto lo<br />
stesso status goduto dalle lingue sami, finnica e meänkieli. Si invitano, inoltre, le imprese di<br />
produzione dei programmi a tenere in considerazione il fatto che in Svezia anche l’yddish ha ottenuto<br />
il riconoscimento di lingua minoritaria.<br />
I mezzi di informazione e le lingue minoritarie<br />
Trasmissioni radiofoniche e televisive nelle lingue minoritarie<br />
La televisione svedese (SFT) trasmette notizie, programmi di attualità, programmi per<br />
bambini e documentari in finnico. Nel notiziario quotidiano Uuiset, si affronta il tema dei rapporti<br />
tra la Svezia e gli altri paesi secondo una prospettiva finnico-svedese. Nel 2000, la STV ha trasmesso<br />
107 ore di programmi rivolti alla minoranza finnico-svedese. Durante lo stesso anno<br />
sono state trasmesse su scala nazionale 17 ore di programmi destinati alla popolazione sami,<br />
comprendenti, tra l’altro, il notiziario Àrran ed il programma per bambini Úlda. Nel 1999, la SFT<br />
ha iniziato a trasmettere programmi in meänkieli. Nel 2000, sono stati trasmessi su scala nazionale<br />
tre programmi con sottotitoli in svedese. Questi programmi trattavano aspetti tipici della vita<br />
nella regione del Tornedal e sono stati prodotti da abitanti di questa regione.<br />
La radio svedese trasmette su P 7 Finnish programmi in finnico e meänkieli, per un totale<br />
di 4 487 ore di trasmissione in queste due lingue nel 1999. La radio svedese produce e trasmette<br />
programmi per il popolo sami attraverso l’emittente radiofonica sami. Nel 1999 le ore di<br />
trasmissione in questa lingua sono state 204.<br />
Produzione cinematografica nelle lingue minoritarie<br />
L’Istituto cinematografico svedese ha creato, sempre negli anni ’90, tre centri regionali<br />
per la produzione di film. Filmpool Nord è il centro di produzione cinematografica regionale e si<br />
occupa anche della realizzazione di video per la contea di Norrbotten. Lavora nelle lingue sami<br />
e meänkieli in collaborazione con le parti interessate a livello regionale e locale. Ad oggi sono<br />
211
stati realizzati congiuntamente cortometraggi e documentari sulla popolazione sami. E’ in corso<br />
anche la produzione di films in lingua meänkieli.<br />
Il comune di Kiruna ha avviato uno studio preliminare in vista della creazione di un centro<br />
di produzione cinematografica in lingua sami e nella lingua parlata nella regione del Tornedal.<br />
Questo studio esaminerà come la cultura e la produzione cinematografica favoriscono lo<br />
sviluppo delle lingue minoritarie sami, finnico e meänkieli, alle quali, grazie alle leggi 1175 e<br />
1176 del 1999, è stato riconosciuto uno status speciale in alcuni comuni della contea di Norrbotten.<br />
Giornali nelle lingue minoritarie<br />
Per la tutela e la promozione delle lingue, è importante offrire un adeguato sostegno ai<br />
giornali stampati nelle rispettive lingue. Esistono alcune norme che disciplinano il finanziamento<br />
pubblico dei quotidiani destinati alle minoranze linguistiche. Si presterà particolare attenzione<br />
alle minoranze nazionali nell’allocazione dei fondi stanziati dallo Stato in favore dei periodici culturali.<br />
SVIZZERA<br />
La libertà di espressione, la libertà di opinione e la libertà di ricevere o comunicare informazioni<br />
La libertà di opinione è sancita dall’art. 16 della Costituzione federale. Si ricorderà che<br />
anche l’articolo 10 delle Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e l’art.19 del Patto delle Nazioni<br />
Unite sui Diritti Civili e Politici tutelano la libertà di opinione e di espressione. Tale libertà<br />
comporta il diritto di formarsi, di esprimere e diffondere liberamente la propria opinione. Questi<br />
sono diritti della persona e come tali, ogni individuo, e quindi ogni appartenente ad una minoranza<br />
nazionale, se ne può avvalere.<br />
In un contesto di democrazia diretta, il diritto di formarsi liberamente un’opinione assume<br />
una rilevante importanza. Questo implica il diritto di ricevere, senza ingerenza da parte dello<br />
Stato e senza badare a frontiere, opinioni ed informazioni e di reperire informazioni da fonti accessibili<br />
a tutti. Lo stesso quindi presuppone il diritto all’informazione poiché è evidente che per<br />
potersi formare un’opinione, è necessario avere anche la possibilità di informarsi. Ne consegue<br />
che il diritto di formarsi liberamente un’opinione vieta all’autorità pubblica di imporre in qualche<br />
modo ad un individuo una qualsiasi opinione. E’ questo il motivo che ha indotto anche il Tribunale<br />
Federale a dichiararsi contrario alla creazione di una radio e di una televisione di Stato. A<br />
tale proposito si fa notare che l’art. 17 della Costituzione garantisce espressamente la libertà dei<br />
mezzi di informazione. La radio e la televisione sono sottoposte ad un regime di autorizzazioni<br />
per la concessione delle quali è competente l’autorità federale.Tale regime, che deroga ai principi<br />
della libera concorrenza, si giustifica in particolare con il desiderio di mantenere in un piccolo<br />
paese poliglotta la diffusione di programmi nazionali nelle quattro lingue nazionali, evitando<br />
così una eccessiva concentrazione di media nelle mani di potenti gruppi. La radio e la televisione<br />
devono rappresentare fedelmente la realtà dei fatti e rispecchiare in modo equo la diversità<br />
delle opinioni. Chiunque ritenga che la radio o la televisione non abbiano adempiuto all’obbligo<br />
di obiettività, può appellarsi ad un organismo indipendente a tutela dei cittadini, per poi presentare<br />
ricorso amministrativo dinanzi al Tribunale Federale. Quanto al diritto di reperire informazioni<br />
da fonti accessibili a tutti, si fa notare che la nozione di “fonti accessibili a tutti” tuttavia non<br />
comprende, salvo diversa disposizione normativa, gli atti dell’amministrazione. La giurisprudenza<br />
in materia, del resto, è piuttosto restrittiva e riconosce il diritto all’informazione solo in quattro<br />
casi: quando l’informazione sia stata dichiarata liberamente accessibile, quando sia stato liberamente<br />
disposto dall’autorità, quando sia in gioco un diritto politico o, infine, quando un individuo<br />
sia personalmente interessato dal documento che chiede di consultare.<br />
Analogamente, la libertà di espressione svolge un ruolo predominante nell’ordinamento<br />
costituzionale svizzero, come mostra la seguente citazione tratta da una sentenza del Tribunale<br />
Federale:”Ma la libertà d’espressione non si limita ad essere, come altre libertà esplicite o implicite<br />
del diritto costituzionale federale, una semplice condizione dell’esercizio della libertà individuale<br />
ed un elemento indispensabile per lo sviluppo dell’essere umano; essa è anche il fondamento<br />
di ogni Stato democratico: consentendo la libera formazione dell’opinione, in particolare<br />
di quella politica, essa è indispensabile per il pieno esercizio della democrazia. Per questo meri-<br />
212
ta un posto a parte rispetto ai diritti individuali garantiti dalla Costituzione ed un trattamento privilegiato<br />
da parte delle autorità”.<br />
L’ambito tutelato dalla libertà d’espressione comprende tutti i “prodotti” o messaggi del<br />
pensiero umano, siano essi sentimenti, opinioni, informazioni od altro. Tuttavia, secondo la giurisprudenza<br />
del Tribunale Federale, la libertà di espressione tutelerebbe soltanto i contenuti di<br />
natura ideale, motivando tale asserzione con il fatto che, avendo le dichiarazioni principalmente<br />
una finalità commerciale, queste rientrerebbero in quanto tali nell’ambito riconducibile alla libertà<br />
economica (art. 27 della Costituzione). La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non opera una<br />
simile distinzione; a suo avviso, il discorso commerciale è tutelato anche dall’art. 10 della Convenzione<br />
Europea sui Diritti dell’Uomo. Tale giurisprudenza vincola le autorità svizzere<br />
nell’interpretazione del citato art. 10 ed estende la sfera di applicazione della libertà delle comunicazioni<br />
al settore della pubblicità commerciale, ferma restando la facoltà del Tribunale Federale<br />
di definire autonomamente i rispettivi campi di applicazione degli artt. 16 e 27 della Costituzione<br />
federale.<br />
Sono tutelati tutti i mezzi atti a stabilire la comunicazione dei messaggi: comunicazioni<br />
verbali, comunicazioni per iscritto, forme artistiche o simboliche (striscioni, badges, ecc.). A tale<br />
proposito, giova notare che la libertà di espressione è anche all’origine di altri diritti fondamentali,<br />
come, ad esempio, la già citata libertà dei mezzi di informazione, la libertà del cinema, la libertà<br />
dell’arte e la libertà della scienza.<br />
La libertà di espressione è soggetta ad alcune restrizioni. In base ai principi sanciti dalla<br />
Costituzione, all’art. 10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo ed all’art. 19 del Patto<br />
delle Nazioni Unite sui Diritti Civili e Politici, tali restrizioni devono attenersi a precise condizioni<br />
per essere lecite: avere un fondamento giuridico, essere giustificate da un interesse pubblico o<br />
dalla difesa di un diritto fondamentale di altri, essere proporzionate allo scopo perseguito e non<br />
violare il nucleo intangibile dei diritti fondamentali. In generale, si tratterà di creare un equilibrio,<br />
talvolta delicato, fra l’interesse pubblico a mantenere l’ordine e quello privato della persona in<br />
causa, ma anche l’interesse pubblico alla libertà di espressione.<br />
Il Codice Penale prevede, tra l’altro, le seguenti restrizioni alla libertà di espressione:<br />
- divieto di diffamazione (art. 303);<br />
- divieto di violazione del segreto commerciale, del segreto attinente alla sfera privata, il segreto<br />
di funzione, professionale o militare (art. 162, 179 e 179quater, 320,321 e 329);<br />
- divieto di abuso di utilizzo del telefono (art. 179septies);<br />
- divieto di provocazione pubblica di atti criminali e violenti (art. 259);<br />
- divieto di violare la pace dei defunti (art. 262) o gli emblemi svizzeri (art. 270);<br />
- divieto di rappresentare la violenza (art. 135);<br />
- divieto di pregiudicare la libertà di professare il proprio credo e di culto (art. 261);<br />
- divieto di discriminazione razziale, etnica o religiosa (art. 261bis);<br />
- divieto di incitazione alla violazione degli obblighi militari (art. 276);<br />
- divieto di propaganda estera sovversiva (art. 275bis);<br />
- divieto di oltraggio ad uno Stato straniero o ad un’istituzione internazionale (artt.296 e 297).<br />
Sono da aggiungere le disposizioni normative a difesa dell’onore (art. 173 e succ.) o di<br />
repressione di alcuni reati contro l’integrità sessuale, come la pornografia (art. 197).<br />
Gli artt. 28 e succ. del Codice Civile tutelano la persona da attacchi illeciti, in particolare,<br />
quelli operati a mezzo stampa (diritto al risarcimento, misure provvisorie per impedire un attacco,<br />
diritto di replica). In tale contesto, occorre notare che la persona accusata di offesa all’onore<br />
non incorre in alcuna pena qualora sia in grado di dimostrare la veridicità delle proprie asserzioni<br />
oppure che vi siano seri motivi per ritenerle tali (art. 173, comma 2, Codice Penale).<br />
Coloro che beneficiano della libertà di espressione e di stampa sono quindi tutelati contro<br />
eventuali processi ingiuriosi.<br />
Anche i detenuti possono avvalersi della libertà di espressione e del diritto di ricevere<br />
informazioni da fonti generalmente accessibili, a condizione che siano salvaguardati l’ordine e la<br />
sicurezza in carcere.<br />
In base alla giurisprudenza del Tribunale Federale, l’uso del mezzo pubblico per manifestare<br />
un’opinione può, “qualora superi, per la sua natura ed intensità, i limiti consentiti”, essere<br />
sottoposto a previa autorizzazione da parte delle autorità cantonali o federali, anche in assenza<br />
di uno specifico riferimento normativo. Tali autorità dovranno tener conto del principio di ugua-<br />
213
glianza di trattamento e di quello di proporzionalità nonché di tutti gli interessi posti in gioco, attribuendo<br />
un peso particolare agli interessi tutelati dai diritti fondamentali.<br />
Nessuna delle restrizioni di cui sopra è tale da costituire una discriminazione razziale o<br />
una discriminazione in danno di una minoranza nazionale.<br />
UCRAINA<br />
La Costituzione dell’Ucraina garantisce il diritto a raccogliere, conservare, utilizzare e<br />
divulgare informazioni sotto qualsiasi forma (art. 34). Al fine di garantire agli appartenenti alle<br />
minoranze nazionali il diritto di ricevere e comunicare informazioni nella loro lingua e di approfondire<br />
il processo di democratizzazione, la cooperazione fra le varie nazionalità e la tolleranza<br />
in seno alla società, lo Stato sostiene lo sviluppo ed offre un sostegno concreto agli organi di<br />
informazione delle minoranze nazionali, assegnando a ciascuno un determinato spazio nel palinsesto<br />
delle emittenti radiotelevisive pubbliche e curando la pubblicazione di opere letterarie<br />
nelle loro lingue materne.<br />
La legislazione vigente riconosce alle minoranze nazionali il diritto di creare propri mezzi<br />
di informazione e di ottenere le necessarie autorizzazioni. L’art. 8 della legge sulla cultura in<br />
Ucraina, che tratta “I diritti delle minoranze nel campo culturale”, dichiara che i cittadini di tutte le<br />
nazionali hanno diritto a “creare mezzi di informazione e case editrici”.<br />
Il diritto ad utilizzare le lingue delle minoranze nazionali nell’ambito dei mezzi di informazione<br />
(radio, televisione, stampa) è definito dall’art. 6 delle legge sulle minoranze nazionali in<br />
Ucraina e dall’art. 33 (capitolo 4) delle legge sulla lingua in Ucraina che recita:“Nel sevizio pubblico<br />
di informazione possono essere utilizzate anche le lingue delle altre nazionalità”.<br />
La Commissione nazionale sulla politica dell’informazione in Ucraina e la Commissione<br />
nazionale della radio e della televisione ucraina hanno il compito di assicurare il servizio di informazione<br />
alle minoranze.<br />
Il programma di interventi adottato dal consiglio dei ministri per il 1999 prevede “di migliorare<br />
i programmi nelle lingue minoritarie trasmessi dai canali radiotelevisivi”.<br />
Il numero di ore destinato ai programmi per le minoranze nazionali e trasmessi nelle rispettive<br />
lingue è di 1.229 all’anno per la televisione e di 1.988 per la radio.<br />
Il palinsesto radiotelevisivo comprende la trasmissione, a livello locale o nazionale, di<br />
programmi nelle seguenti lingue: russo, ebraico, tedesco, polacco, ungherese e romeno.<br />
Nelle regioni ove insistono minoranze nazionali numericamente consistenti, sono sorti,<br />
nell’ambito delle emittenti radiotelevisive pubbliche, degli appositi comitati responsabili della<br />
programmazione.<br />
La programmazione così organizzata prevede trasmissioni nelle seguenti lingue: tedesco,<br />
armeno, tartaro, russo, ungherese, romeno, tedesco, bulgaro, gagauzo, ebraico e polacco.<br />
Nel 1998 è stato organizzato nella città d’Izmail (Oblast di Odessa) il primo festival interregionale<br />
dei programmi radiotelevisivi delle minoranze nazionali, al quale hanno partecipato<br />
rappresentanti delle minoranze nazionali zingara, romena, polacca, azerbaijana, armena, ceca<br />
e moldava.<br />
Al 1° gennaio 1998 si contavano in Ucraina oltre 1.300 giornale in lingua russa e circa<br />
95 (contro i 48 nel 1995) nelle altre lingue minoritarie nazionali.<br />
Tra le pubblicazioni più diffuse figurano giornali e riviste curati dalle seguenti minoranze:<br />
ebraica, bielorussa, polacca, tartara, tedesca, romena ed ungherese.<br />
In base alla legge ucraina sul “Finanziamento pubblico dei mass media e tutela sociale<br />
dei giornalisti” lo Stato alloca fondi in favore dei mezzi di informazione impegnati nella promozione<br />
della lingua e della cultura proprie delle minoranze nazionali.<br />
Sono, inoltre, pubblicati sei supplementi allegati alla rivista parlamentare Holos Ukrainy,<br />
destinati alle seguenti minoranze nazionali: bulgara, polacca, ebraica, armena, romena e tartara.<br />
Tale rivista contribuisce per il 50% alle spese di produzione dei citati supplementi ed offre la<br />
necessaria assistenza logistica. Nelle regioni dove sono presenti gruppi minoritari numerica-<br />
214
mente consistenti, come a Zakarpattia, ad Odessa e nell’Oblast di Tchernivtsi, le autorità locali<br />
pubblicano giornali regionali in romeno ed ungherese.<br />
UNGHERIA<br />
In Ungheria, la libertà di esprimere le proprie opinioni, conformemente al comma 1<br />
dell’articolo 9 della Convenzione-quadro, è un diritto costituzionale fondamentale ai sensi del<br />
quale alla parte lesa è concesso il diritto di appellarsi individualmente alla Corte Costituzionale.<br />
Tale diritto è riconosciuto anche dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dal Patto internazionale<br />
sui diritti civili e politici. Così come per gli altri diritti costituzionali riguardanti le minoranze,<br />
non si è a conoscenza di alcun precedente ricorso individuale a tale organo.<br />
La Repubblica ungherese riconosce il diritto degli appartenenti ad una minoranza di esprimere<br />
le proprie opinioni nella loro lingua materna nonché il diritto delle comunità minoritarie<br />
ad avere accesso ai mezzi di informazione. L’Ungheria ha adottato norme che disciplinano e<br />
garantiscono il corretto funzionamento e la creazione di mezzi di informazione propri delle minoranze<br />
nazionali ed etniche.<br />
L’Ungheria, ratificando la Convenzione-quadro e la Carta europea per le lingue regionali<br />
o minoritarie, si è impegnata a far sì che la programmazione del servizio di informazione pubblico<br />
preveda trasmissioni in lingua minoritaria. La stessa agevola la regolare diffusione di programmi<br />
radiofonici e televisivi in lingua minoritaria, consente di creare e gestire almeno un organo<br />
di stampa che utilizzi una lingua minoritaria, assumendo gli oneri straordinari legati<br />
all’utilizzo degli strumenti necessari per garantire l’informazione pubblica e sostenendo la formazione<br />
dei giornalisti appartenenti ad una minoranza.<br />
Nell’ordinamento giuridico interno ungherese, due leggi trattano specificatamente questa<br />
materia.<br />
La legge sulle minoranze, conformemente alle disposizioni di vari testi di legge, impone<br />
alle emittenti radiotelevisive pubbliche l’obbligo di provvedere alla realizzazione regolare e diffusione<br />
dei programmi curati da minoranze nazionali o etniche.<br />
In forza di tale norma, la legge sulla radiotelevisione prevede l’obbligo per le emittenti<br />
pubbliche di interessarsi alle culture ed alle lingue delle minoranze nazionali ed etniche presenti<br />
in Ungheria e di trasmettere sistematicamente informazione nelle rispettive lingue. Tale missione<br />
viene assolta (in funzione della dislocazione geografica della minoranza) su scala nazionale,<br />
regionale o locale, grazie ad una serie di programmi, sottotitolati se necessario, o a trasmissioni<br />
in più lingue a seconda delle specifiche esigenze della minoranza.<br />
La legge sulla radiotelevisione definisce i programmi da inserire nell’ambito della programmazione<br />
radiotelevisa del servizio di informazione pubblico e fra questi figurano trasmissioni<br />
nelle lingue minoritarie e programmi sulla cultura e sugli usi e costumi che caratterizzano<br />
le minoranze nazionali ed etniche.<br />
La legge sulla radiotelevisione impone una durata dei programmi destinati alle minoranze<br />
nazionali non inferiore a quella prevista dall’articolo di legge alla data di entrata in vigore di<br />
quest’ultima. La federazione nazionale delle autorità locali che rappresentano le varie minoranze<br />
nazionali ed etniche decide autonomamente i criteri di utilizzo dei tempi di programmazione<br />
disponibili nell’ambito del sistema radiotelevisivo pubblico. La legge impone alle emittenti pubbliche<br />
di tener conto delle decisioni prese dagli organismi autonomi rappresentativi delle minoranze.<br />
Sono di seguito citati gli organi abilitati a realizzare programmi in Ungheria, in virtù di<br />
quanto stabilito dalla legge sui mezzi audiovisivi: le persone fisiche residenti in Ungheria, le persone<br />
giuridiche registrate in Ungheria, le società commerciali non registrate. La legge prevede<br />
che l’autorizzazione sia concessa mediante concorso. Vengono bandite gare per rispondere al-<br />
215
la richiesta di programmi da parte di minoranze nazionali o etniche, qualora, nella zona di ricezione<br />
interessata manchi sia la libertà di comunicare o ricevere informazioni che la varietà culturale<br />
prendendo in considerazione l’insieme dei programmi. Il bando di gara deve citare il tempo<br />
medio mensile concesso alle trasmissioni per le minoranze. Le organizzazioni senza scopo di<br />
lucro che agiscono in difesa dell’interesse pubblico ed appartenenti esclusivamente alle autorità<br />
locali che rappresentano le minoranze nazionali o etniche possono ottenere la necessaria autorizzazione<br />
senza partecipare ai bandi di gara qualora nella zona di ricezione non si provveda a<br />
soddisfare la richiesta di informazione nelle lingue minoritarie.<br />
Le autonomie nazionali delle minoranze nazionali ed etniche ungheresi possono delegare<br />
ciascuna un proprio membro in seno alla radio ungherese, alla televisione ungherese ed al<br />
Consiglio consultivo della Fondazione per la televisione pubblica ungherese.<br />
In Ungheria, informazioni ed opinioni possono essere comunicate liberamente attraverso<br />
le emittenti ed i programmi destinati al pubblico sono fruiti gratuitamente. Questi ultimi non<br />
devono violare i diritti umani, né istigare all’odio contro individui appartenenti all’uno o all’altro<br />
sesso, ad una razza, ad una nazione, ad una nazionalità, ad una etnia, ad una minoranza linguistica<br />
o altro, o contro una Chiesa o un gruppo religioso. L’emittente non può attaccare, direttamente<br />
o indirettamente, né escludere una qualsiasi minoranza o maggioranza, né presentarla<br />
o giudicarla per motivi razziali. Il servizio radiotelevisivo pubblico e gli autori di programmi sono<br />
tenuti a rispettare la dignità e gli interessi fondamentali delle minoranze nazionali, etniche, linguistiche<br />
e di altro tipo e non possono in alcun caso offendere la dignità delle altre nazioni.<br />
La televisione ungherese ha recepito nell’ambito della regolamentazione del servizio<br />
radiotelevisivo pubblico le disposizioni di legge riguardanti le minoranze in materia di radio e di<br />
televisione.<br />
In virtù di quanto stabilito dalla legge sulla radiotelevisione, le minoranze possono delegare<br />
congiuntamente un proprio membro, con mandato annuale ed in base ad una turnazione,<br />
presso il Consiglio consultivo della Fondazione per la televisione pubblica ungherese. Le autonomie<br />
delle minoranze hanno delegato propri rappresentanti presso il Consiglio nel 1996, ma<br />
non hanno esercitato tale diritto nel 1997. Nel 1998, il Consiglio consultivo della Fondazione per<br />
la televisione pubblica ungherese ha accolto un rappresentante della minoranza serba, mentre<br />
la minoranza polacca ha delegato un proprio membro in seno al Consiglio di amministrazione<br />
della televisione Duna.<br />
La Fondazione pubblica per le minoranze offre sostegno concreto agli organi di stampa<br />
(carta stampata) pubblici. Nel 1998, questa fondazione ha finanziato 17 giornali nazionali che<br />
rappresentano 13 minoranze. Tenuto conto del fatto che la stampa in lingua minoritaria non è in<br />
grado di autosostenersi e che le minoranze godono del diritto irrinunciabile alla regolare pubblicazione<br />
dei propri organi di informazione, il Comitato della Fondazione pubblica si sta strenuamente<br />
adoperando per reperire quanti più finanziamenti possibili.<br />
La Fondazione pubblica incoraggia la creazione di mezzi di informazione locali propri<br />
delle minoranze, nonché la preparazione e la diffusione di programmi televisivi via cavo in lingua<br />
minoritaria, destinati alle minoranze, per l’utilizzo delle rispettive lingue nella vita sociale.<br />
Nel 1998, tale Fondazione ha devoluto circa 15 milioni di fiorini ungheresi a sostegno di questo<br />
tipo di attività.<br />
La televisione ungherese trasmette programmi per le minoranze fin dal 1978. (Inizialmente<br />
i primi programmi erano rivolti alle minoranze croata, tedesca, serba. slovena ed a partire<br />
dal 1982 vengono diffusi programmi anche in romeno e slovacco). Fin dal 1998, la televisione<br />
ungherese realizza con regolarità programmi destinati alle 12 o 13 minoranze ufficialmente riconosciute<br />
dalla legge sulle minoranze. Si trasmettono programmi televisivi nazionali una volta<br />
a settimana per le minoranze rom, croata, tedesca, romena e slovacca, una volta ogni quindici<br />
giorni per gli sloveni ed i serbi ed una volta al mese per i bulgari, i greci, i polacchi, gli armeni ed<br />
i ruteni. Nel corso della riunione di dicembre 1998, la Commissione mista della minoranza ucraina<br />
d’Ungheria ha avanzato una proposta per la realizzazione di programmi in lingua ucraina<br />
da parte del servizio televisivo pubblico.<br />
216
I programmi per le minoranze vengono prodotti in quattro città ungheresi: Budapest (per<br />
i rom, i greci, i polacchi, gli armeni, i ruteni ed i serbi), Pécs (croati e tedeschi), Szeged (romeni<br />
e slovacchi) e Szombathely (sloveni). L’attività redazionale è coordinata dalla direzione editoriale<br />
della televisione ungherese per le regioni, le minoranze e l’estero.<br />
La durata dei programmi quindicinali o trasmessi ogni quattro giorni è di 25 minuti e la<br />
durata complessiva dei programmi mensili di altre cinque minoranze è di 50 minuti. Questi programmi<br />
vengono trasmessi tutti i giorni della settimana, nel pomeriggio, sulla rete terrestre nazionale,<br />
MTV1. I programmi vengono riproposti il sabato mattina sul canale satellitare MTV2.<br />
Attualmente la televisione ungherese trasmette ogni mese 660 minuti di programmi destinati alle<br />
minoranze, che si aggiungono ad alcuni rotocalchi televisivi in lingua ungherese sulle minoranze<br />
trasmessi ogni due settimane.<br />
Alla televisione pubblica ungherese pervengono frequenti reclami da parte delle autonomie<br />
delle minoranze riguardanti sia gli orari di trasmissione riservati ai programmi televisivi<br />
per le minoranze, che il contenuto e l’organizzazione stessa dei programmi.<br />
Anche la radio ungherese trasmette una serie di programmi di varia durata destinati alle<br />
diverse minoranze presenti nel paese, in particolare alle seguenti: slovacca, croata, tedesca,<br />
romena, serba, rom, slovena, bulgara, greca, polacca, armena, rutena ed ucraina.<br />
Segue una tabella in cui vengono indicati i tempi di programmazione televisiva riservati<br />
ai programmi destinati alle varie minoranze.<br />
Diverse emittenti sia radiofoniche che televisive locali trasmettono regolarmente programmi<br />
nelle lingue minoritarie. Numerose emittenti hanno richiesto sovvenzioni relative ai bandi<br />
di gara pubblicati nel 1998 dalla Fondazione pubblica per le minoranze allo scopo di realizzare<br />
e trasmettere via cavo programmi nelle lingue minoritarie.<br />
Parte delle sovvenzioni erogate dalla Fondazione pubblica per le minoranze è destinata<br />
alla carta stampata delle minoranze. In tal modo vengono finanziati non solo giornali, riviste e<br />
periodici in lingua minoritaria a tiratura locale, ma anche dei giornali appartenenti alle minoranze<br />
a diffusione nazionale.<br />
Gran parte delle spese di pubblicazione dei giornali minoritari è a carico degli organismi<br />
autonomi delle minoranze stesse, sebbene beneficino anche di alcuni finanziamenti provenienti<br />
da altre organizzazioni.<br />
217
LE MINORANZE LINGUISTICHE<br />
NELLA COSTITUZIONE ITALIANA<br />
219
CENNI STORICI: MOMENTI PREPARATORI E ORIGINE DELLA TUTELA COSTITUZIONA-<br />
LE DELLE MINORANZE LINGUISTICHE<br />
La necessità di fornire di adeguata tutela le minoranze esistenti sul territorio nazionale,<br />
per potere salvaguardare i loro diritti che potrebbero venire menomati o trascurati dalla maggioranza,<br />
è presente fin dai lavori preliminari all'attività della Costituente.<br />
Nella seconda seduta del 6 febbraio 1946 la Commissione per gli studi attinenti alla<br />
riorganizzazione dello Stato, nel discutere una relazione sulla tutela delle minoranze nella nuova<br />
Carta Costituzionale presentata da Silvio Innocenti 12 , affrontò il tema relativo alle minoranze<br />
etniche, approvando all'unanimità una risoluzione presentata dall'onorevole Luzzato, che chiariva<br />
in qualche modo i termini del problema.<br />
E', comunque, opportuno esaminare preliminarmente il contenuto della relazione che la<br />
Commissione presentò all'Assemblea Costituente a conclusione della discussione sulla comunicazione<br />
Innocenti, per avere una visione completa degli orientamenti che hanno portato alla<br />
stesura della predetta risoluzione 13 . In essa veniva subito precisato che in Italia il più evidente<br />
fattore discriminante delle minoranze era quello linguistico rispetto a quello di razza e di nazionalità;<br />
di conseguenza era bene fare riferimento "a gruppi alloglotti e a zone mistilingui".<br />
La situazione delle minoranze linguistiche in Italia veniva esaminata dopo avere preso<br />
in considerazione le Convenzioni di diritto internazionale. Queste ultime furono, infatti, le prime<br />
ad affrontare il problema della tutela delle minoranze, visto nella sua completezza soltanto dopo<br />
la I guerra mondiale, quando una serie di trattati internazionali per la protezione delle minoranze<br />
si resero necessari per salvaguardare il principio di nazionalità 14 ; tali accordi internazionali furono<br />
in seguito recepiti dalle Carte Costituzionali di molti degli Stati obbligati.<br />
In Italia, data l'esiguità degli alloglotti rispetto all'intera popolazione, il problema si presentava<br />
in maniera più limitata; inoltre, le minoranze linguistiche da prendere in considerazione<br />
dovevano essere soltanto quelle esistenti nelle zone mistilingue di confine, essendo ivi la lingua<br />
diversa dall'italiano parlata quale lingua materna e di tradizione. Le minoranze interne, invece,<br />
che facevano uso della lingua d'origine esclusivamente quale forma dialettale, potevano destare<br />
soltanto un interesse folkloristico e di studio 15 . Non esistendo, inoltre, nessun obbligo di diritto<br />
internazionale in materia di minoranze e non trovandosi l'Italia in una posizione minoritaria rispetto<br />
ai gruppi alloglotti, il problema della tutela delle minoranze si risolveva, quindi, in un problema<br />
di mero ordine interno.<br />
In questo contesto si evidenziava l'esigenza di creare due tipi di norme: generali e particolari.<br />
Le prime sarebbero state efficaci per tutti i cittadini e quindi per tutti i gruppi minoritari; le<br />
seconde, invece, avrebbero tutelato particolari diritti delle minoranze. Queste ultime si rendevano<br />
opportune soltanto per le minoranze esistenti nelle zone di confine territorialmente ben limitate,<br />
dove la proporzione delle stesse era di particolare rilevanza e aveva un'estensione territoriale<br />
tale da determinare un problema di lingua anche nei rapporti pubblici.<br />
In conformità a questi orientamenti, che andarono sviluppandosi senza eccessive difficoltà,<br />
la sottocommissione preposta al problema delle minoranze, nella seduta sopra citata, approvò<br />
all'unanimità la seguente risoluzione: "Le zone abitate da popolazioni mistilingui formeranno<br />
distinte unità territoriali, ordinate in modo da garantire, in armonia con le istituzioni democratiche<br />
dello Stato, l'uso della lingua e lo sviluppo della cultura, il rispetto e lo sviluppo dei costumi,<br />
delle tradizioni ambientali e degli interessi locali "..."che le unità territoriali mistilingui siano<br />
indicate nella stessa Costituzione" 16 . Le unità di cui si parla potevano essere individuate nelle<br />
seguenti zone: 1) Valle d'Aosta e Valli Valdesi italo-francesi; 2) Alto-Adige italo-tedesco; 3)<br />
Venezia-Giulia italo-slava.<br />
12 In: Alle origini della Costituzione italiana - I lavori preparatori della "Commissione per studi attinenti<br />
alla riorganizzazione dello Stato" (1945-1946), a cura di G. D'Alessio, Bologna, 1979, pag.<br />
208 e segg.<br />
13 In: Ministero per la Costituente, Commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato,<br />
Relazione all'Assemblea Costituente, vol. I, Roma, 1946.<br />
14 In A. Pizzorusso, Minoranze etnico-linguistiche, in "Enciclopedia del diritto", XXVI, Milano, 1976;<br />
C. Lipartiti, Minoranze "Digesto <strong>Italiano</strong>", X, Torino, 1964.<br />
15 Così oggi E. Gizzi, Manuale di diritto regionale, Milano, 1986, pag. 74 e segg.;<br />
P. Cesareo, Bilinguismo, in "Enciclopedia del diritto", Milano, 1959, pag. 478.<br />
16 In: Ministero per la Costituente... cit, pagg. 189-190.<br />
221
Questa risoluzione ha fortemente influenzato il dibattito sulla previsione costituzionale<br />
della tutela delle minoranze linguistiche, avvenuto all'interno dell'Assemblea Costituente in due<br />
distinte sedute: quella del 27 giugno 1947 e quella del 1 luglio 1947.<br />
Nella prima seduta l'Assemblea affrontò la discussione sull'articolo 108, il quale, dopo<br />
un emendamento dell'on. Ambrosini, rimaneva così definito:<br />
"Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati<br />
dalla Costituzione. Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e<br />
alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia con statuti speciali<br />
adottati mediante leggi costituzionali" 17 . Va precisato che le parole "Friuli-Venezia Giulia" furono<br />
aggiunte in seguito ad un emendamento dell'on. Pecorari, il quale, evidenziando l'obbligo morale<br />
dello Stato <strong>Italiano</strong> di tutelare le popolazioni ivi esistenti, proponeva di unire alle Regioni per<br />
le quali già si prevedeva un'autonomia speciale anche la "Regione Giulio-friulana e Zara", espressione<br />
modificata dall'on. Tessitori con la formula "Friuli-Venezia Giulia".<br />
Nella seconda delle sedute sopra citate, quella pomeridiana del 1 luglio 1947, vennero<br />
esaminati alcuni articoli aggiuntivi all'art. 108, tra i quali l'articolo 108/bis, riguardante le minoranze<br />
etniche, la cui elaborazione è opportuno considerare in questa sede essendo divenuto in<br />
seguito art. 6 della Costituzione. L'art. 108/bis venne proposto dall'on. Codignola e così recitava:<br />
"La Repubblica garantisce il pieno e libero sviluppo, nell'ambito della Costituzione, delle minoranze<br />
etniche e linguistiche, esistenti sul territorio dello Stato. Gli enti autonomi regionali non<br />
possono, sotto nessuna forma, limitare o modificare i diritti fondamentali del cittadino sanciti dalla<br />
presente Costituzione, nè emanare norme con essa in contrasto". 18<br />
Questo articolo, secondo le motivazioni del Codignola, sarebbe stato in armonia con<br />
due emendamenti già da lui proposti rispettivamente agli articoli 108 e 123; il primo riguardante<br />
la soppressione dell'art. 108 e il secondo una modifica dell'art. 123, tendente a coordinare con<br />
la Costituzione gli Statuti della Sicilia, della Sardegna e della Valle d'Aosta. Con l'art. 108/bis,<br />
fermo restando l'autonomia speciale della Sicilia e della Sardegna, si sarebbe potuto benissimo<br />
fare a meno degli statuti speciali per le regioni come la Valle d'Aosta, il Friuli, il Trentino e l'Alto<br />
Adige, la cui adozione era giustificata soltanto dalla necessità di proteggere, in sede costituzionale,<br />
le minoranze etniche e linguistiche esistenti nelle zone di confine; l'art. 108/bis, infatti, non<br />
rappresentava altro che la tutela a livello costituzionale delle minoranze di confine e non solo,<br />
poichè esso veniva a proteggere anche gli abitanti delle Valli Valdesi e tutte le altre minoranze<br />
esistenti all'interno del Paese la cui tutela, come risulta da quanto detto, non era mai stata presa<br />
in considerazione.<br />
Per ciò che riguarda il capoverso dell'art. 108/bis, esso veniva giustificato dalla preoccupazione<br />
di salvaguardare la libertà del cittadino da possibili soprusi da parte delle autonomie<br />
regionali e soprattutto delle autonomie speciali.<br />
La Commissione considerò la disposizione dell'on. Codignola accolta in altre parti della<br />
Costituzione: l'art. 2 delle dichiarazioni generali della Costituzione conteneva già il principio generale<br />
di eguaglianza, senza distinzione di razza e di lingua, mentre il capoverso dell'art.<br />
108/bis non avrebbe fatto altro che generare confusione nel sistema di gerarchia delle fonti dell'ordinamento<br />
italiano, infatti non potendo lo Stato modificare con legge i principi costituzionali, a<br />
maggior ragione ciò doveva essere precluso alle leggi regionali.<br />
E' importante rilevare come all'interno dell'Assemblea Costituente erano presenti due<br />
orientamenti su come affrontare il problema delle minoranze etnico-linguistiche: uno che auspicava<br />
una tutela "positiva" nella Costituzione, un altro che considerava la tutela "in negativo" offerta<br />
dall'art. 2 delle dichiarazioni generali della Costituzione, che enunciava il divieto di discriminazioni<br />
tra cittadini per motivi razziali o di lingua, già di per sè sufficiente a garantire lo sviluppo<br />
delle suddette minoranze.<br />
Da quest'ultima opinione si discostavano altri membri della Commissione, la cui preoccupazione<br />
era quella di dar vita ad una norma specifica per tutelare le minoranze etnicolinguistiche;<br />
tra questi l'on. Lussu che presentò un emendamento alla proposta Codignola con il<br />
quale si faceva divieto alle regioni di limitare il diritto del pieno sviluppo delle minoranze etnico-<br />
17 In: Atti dell'Assemblea Costituente: "Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell'Ass.<br />
Cost." - Segretario Generale - Camera dei deputati, 1970, vol. III, pag. 2434.<br />
18 In: Atti dell'Assemblea...cit., Discussioni, pag. 5315.<br />
222
linguistiche 19 . La proposta Codignola veniva così semplificata, ma in seguito alla dichiarazione<br />
del Codignola di voler mantenere il 1 comma del suo emendamento e di rinunciare soltanto al<br />
secondo comma ritenendo esatta l'opinione espressa dalla Commissione, l'on. Lussu ritirò il<br />
proprio emendamento.<br />
Interveniva, a questo punto, l'on. Tosato il quale sottolineava l'opportunità dell'approvazione<br />
del 1 comma dell'emendamento Codignola, in quanto rivelava una lacuna della Costituzione<br />
nella sua prima parte, trattandosi di un problema generale di tutela delle minoranze etnico-linguistiche,<br />
non discusso nella sede opportuna. Ma la decisione sull'art. 108/bis, in seguito<br />
ad un invito dell'on. Tosato, accolto con riserva dall'on. Codignola, venne "temporaneamente"<br />
rinviata per permettere all'Assemblea di esaminarlo con la dovuta attenzione.<br />
La norma venne discussa nella seduta del 22 luglio 1947 dell'Assemblea Costituente. In<br />
apertura di essa l'on. Codignola aveva sostituito il proprio emendamento con il seguente: "La<br />
Repubblica detta norme per la protezione delle minoranze linguistiche 20 . L'art. 108/bis venne<br />
approvato con l'accordo che in sede di coordinamento sarebbe stato collocato nelle sede opportuna<br />
e la parola "protezione" venne sostituita dalla parola "tutela". In sede di coordinamento la<br />
norma trovò collocazione tra i principi fondamentali della Costituzione e divenne, quindi, art. 6, il<br />
quale così recita: " La Repubblica tutela, con apposite norme, le minoranze linguistiche".<br />
19 In: Assemblea Costituente... cit., Discussioni, pag. 5419: "Gli enti autonomi regionali non possono,<br />
sotto nessuna forma, limitare il pieno sviluppo delle minoranze etniche e linguistiche esistenti<br />
nel territorio dello Stato".<br />
20 In: Assemblea Costituente... cit., Discussioni, pag. 6040.<br />
223
ART. 6 DELLA COSTITUZIONE: CONTENUTO NORMATIVO<br />
Tenendo presente quanto fino ad ora detto, possiamo esprimerci in ordine al vero e<br />
proprio contenuto normativo dell'art. 6. Qui resta solo da aggiungere come, rispetto alla prima<br />
proposta del Codignola, nel testo definitivamente approvato viene eliminato l'aggettivo "etniche",<br />
per limitarsi soltanto al riferimento "linguistiche". E' chiaro come la formulazione sia stata<br />
condizionata dalla preoccupazione di limitare al profilo linguistico-culturale la tutela che si intendeva<br />
apportare, evitando di far risaltare i contenuti nazionali; ciò, comunque, non ha diversificato<br />
la portata delle due norme da un punto di vista pratico 21 .<br />
L'art. 6 della Costituzione essendo una disposizione di principio, come tale suscettibile<br />
di specificazione da parte di norme dirette alla sua attuazione, è comunque da solo sufficiente a<br />
produrre effetti giuridici. Le disposizioni di principio, infatti, si pongono da un lato come norme di<br />
"raffronto", in quanto atte a misurare la costituzionalità delle norme gerarchicamente inferiori;<br />
dall'altro come mezzo interpretativo di tali norme 22 . Inoltre, poichè la tutela delle minoranze linguistiche<br />
prevista dall'art. 6 Cost. viene letta da vari autori come "specificazione" o "integrazione"<br />
dei principi espressi dagli artt. 2 e 3 Cost., principi sicuramente supremi, l'articolo in questione<br />
non può non essere anch'esso un principio supremo 23 ; da ciò si deduce che l'art. 6 è dotato<br />
non solo di efficacia costituzionale in senso formale, ma anche in senso materiale e come<br />
tale non derogabile da norme di rango inferiore.<br />
Per valutare l'efficacia concreta dell'art. 6 è importante, infine, rilevare come l'art. 4 dello<br />
Statuto del Trentino-Alto Adige, includendo la "tutela delle minoranze linguistiche" fra gli interessi<br />
nazionali, abbia sovvertito l'orientamento della Corte Costituzionale (dec. n. 46 del 1961;<br />
dec. n. 32 del 1960; dec. n. 128 del 1963), che limitava alla competenza statale la potestà legiferativa<br />
in materia. Il suddetto articolo 4, infatti, sancendo tale limite, implicitamente consentiva<br />
alla Regione la potestà normativa nel rispetto dello stesso, il tutto con evidenti effetti benefici sia<br />
nel campo attuativo che in quello di principio della norma costituzionale 24 .<br />
21<br />
In: A. Pizzorusso, Commento all'art. 6 della Costituzione, in Commentario della Costituzione a<br />
cura di G. Branca, Bologna, 1975, pag. 303 e segg.<br />
22<br />
23<br />
In: C. Lavagna, Istituzioni di diritto pubblico, VI ed., Torino, 1985, pag. 868.<br />
In: A. Pizzorusso, "Il pluralismo linguistico in Italia fra Stato nazionale e autonomie regionali", Pisa,<br />
1975, pag. 27 e segg.<br />
24<br />
Cfr. E. Gizzi, Manuale... cit., pag. 76; A. Pizzorusso, Tutela delle minoranze linguistiche e competenza<br />
legislativa regionale, in "Riv. trimestrale di dir. pubbl.", 1974, pag. 1093 e segg.<br />
224
COORDINAMENTO DELL'ART. 6 CON L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE<br />
Come abbiamo visto emergere dalla discussione dell'Assemblea Costituente sul problema<br />
della tutela delle minoranze linguistiche, due sono i tipi di tutela che possono essere apprestati<br />
alle suddette minoranze: una di tipo "negativo", l'altra di tipo "positivo".<br />
La prima forma di tutela viene offerta dall'art. 3, I comma, della Costituzione, intesa come<br />
divieto di discriminazioni per motivi di lingua e, quindi, come "libertà-facoltà" di parlare la<br />
propria lingua senza subire discriminazioni; essa esiste, quindi, solo a livello individuale ed è<br />
collegata alla libertà di manifestare il proprio pensiero, principio sancito dall'art. 21 della Costituzione.<br />
Il secondo tipo di tutela, intesa come libertà di fare uso di una lingua diversa dall'italiano<br />
e da attuarsi mediante l'emissione di norme particolari, è, invece, prevista dall'art. 6 della Costituzione,<br />
il quale dà origine a situazioni giuridiche collettive 25 .<br />
Inoltre, mentre il principio di uguaglianza formale consente di tutelare le cosiddette minoranze<br />
"necessarie", ossia quelle che tendono ad integrarsi nella più ampia comunità nazionale<br />
in cui sono incluse; per ciò che riguarda le minoranze alloglotte, esse, in quanto minoranze<br />
"volontarie", cioè rivendicanti la salvaguardia delle proprie caratteristiche socio-culturali, necessitano<br />
della tutela "positiva" offerta dall'art. 6 della Costituzione 26 .<br />
Vero è che, in questo modo, si viene a creare una situazione di privilegio nei confronti<br />
delle minoranze linguistiche; ma ciò non è in contrasto con il principio di uguaglianza formale<br />
sancito dall'art. 3, il quale, in coerenza con quanto affermato dalla Corte Costituzionale, può essere<br />
letto nel senso che il legislatore deve trattare in modo uguale situazioni da lui ritenute tali e<br />
differentemente situazioni che si presentano in modo diverso, qual'è, appunto, quella delle minoranze<br />
linguistiche 27 . Anzi, secondo l'opinione di molti autori 28 , la tutela apprestata dall'art. 6<br />
della Costituzione si risolve non solo nell'attuazione del principio di uguaglianza formale, ma<br />
anche e soprattutto di quello sostanziale, eliminando uno degli ostacoli (in questo caso quello<br />
della diversità di lingua) che di fatto "impediscono la partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione<br />
politica, economica e sociale del Paese".<br />
Sembra, così, da respingere l'opinione di quanti affermano il carattere di "eccezione" o<br />
"deroga" della previsione dell'art. 6 della Costituzione rispetto al principio formulato dall'art. 3<br />
della Costituzione, che finirebbe con l'essere privato di una parte della sua sfera di applicazione<br />
29 .<br />
25 In: P. Barile, "Diritti dell'uomo e libertà fondamentali", Bologna, 1984.<br />
26 Per tale distinzione A. Pizzorusso, Minoranze etnico-linguistiche... cit., pag. 531.<br />
27 Sull'argomento A. M. Sandulli, Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale, in<br />
"Diritto e società", 1979; A. Pizzorusso, Commento all'art. 6... cit., pag. 36 e segg.<br />
28 In: C. Lavagna, opera cit., pag. 869, C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico vol. II, ed. IX, Padova<br />
1975/76; F. Finocchiaro, Uguaglianza giuridica e fattore religioso, Milano, 1958, pagg. 65-66.<br />
29 Tra i tanti: L. Paladin, Il principio costituzionale d'uguaglianza, Milano, 1965; C. Esposito, Eguaglianza<br />
e giustizia nell'art. 3 della Costituzione, in Costituzione Italiana , Padova, 1954; M. Udina,<br />
Sull'attuazione dell'art. 6 della Costituzione per la tutela delle minoranze linguistiche, in Giurispr.<br />
Cost., 1974; P. Biscaretti di Ruffia Uguaglianza (Principio di), in Nuovissimo Dig., XIX, 1973, pag.<br />
1091.<br />
225
SAGGI DI NATURA GIURIDICA E SOCIO-CULTURALE<br />
227
MINORANZE LINGUISTICHE ED AMBIENTE - LA DIVERSITÀ CULTURALE COME RISOR-<br />
SA -<br />
Uno dei fenomeni che maggiormente caratterizzano, a livello globale, la società contemporanea<br />
è l’intensificarsi dei rapporti tra popoli diversi per appartenenza etnica, lingua e tradizioni<br />
culturali. Sebbene non si tratti di un fenomeno nuovo, nel senso che la storia documenta<br />
un continuo succedersi di migrazioni, occupazioni, avvicendarsi di civiltà, esso assume attualmente<br />
una valenza particolare a causa sia della rapidità delle comunicazioni che è propria del<br />
mondo contemporaneo sia per le nuove forme di comunicazione che vanno diffondendosi negli<br />
ultimi decenni.<br />
In sostanza, processi che in passato richiedevano secoli e che si svolgevano con una<br />
gradualità che consentiva adattamento reciproco ed osmosi, oggi si compiono nel giro di pochi<br />
decenni o addirittura pochi anni e spesso in maniera unilaterale.<br />
In questo senso, un altro elemento tipico della nostra epoca è la grande forza di attrazione<br />
che la civiltà e la cultura cosiddette “occidentali” esercitano nei confronti delle culture “altre”,<br />
che dunque la assumono come modello al quale uniformarsi.<br />
L’opulenza delle società industriali esercita infatti un fascino irresistibile su popolazioni<br />
che vivono spesso in condizioni di estremo disagio se non di vera e propria povertà e che vedono<br />
nella civiltà occidentale, matrice di queste società, l’unica via per emanciparsi dalla propria<br />
condizione di sottosviluppo e di sofferenza.<br />
La cultura occidentale, del resto, non ha mancato, nel passato ed anche recente, di<br />
svolgere un ruolo attivo in questa direzione proponendo, e talvolta imponendo essa stessa, in<br />
maniera più o meno consapevole, la propria Weltanschauung e dunque i propri schemi interpretativi<br />
della realtà e le proprie esperienze di conoscenza e di sviluppo come le uniche possibili<br />
per risolvere i problemi del sottosviluppo o risollevare dal disastro le economie di intere regioni<br />
del globo.<br />
Quanto questo tipo di visione sia errato lo dimostrano le ormai innumerevoli esperienze<br />
di progetti di sviluppo pensate dal e nel «primo mondo» per essere applicate nel «terzo», senza<br />
tener conto a sufficienza della molteplicità delle variabili locali, sia umane, e dunque culturali e,<br />
proprio per questi motivo, andata incontro a clamorosi quanto imprevisti fallimenti.<br />
In effetti, mentre l’opulenza delle società industriali continua ad attirare a sé milioni di emigrati<br />
dai paesi in via di sviluppo, l’Occidente sembra ormai avviato ad un profondo ripensamento critico<br />
di se stesso, della propria posizione e del proprio ruolo.<br />
Ad un orientamento culturale di tipo omologante, cioè, si va sostituendo una nuova consapevolezza<br />
del valore della diversità, che, sia nel campo biologico che in quello culturale, si<br />
rivela in modo sempre più palese “humus” feconda ed insostituibile in ogni fronte dello sviluppo.<br />
Si tratta, ovviamente di un processo ancora agli albori, che conduce però ad una revisione radicale<br />
di ciò che finora, a livello per così dire «di massa» si è inteso con il termine stesso di «civiltà»<br />
e dunque ad una rivalutazione anche antropologica delle civiltà “altre” che, viste in una prospettiva<br />
non più gerarchica di superiorità su inferiorità, mostrano una enorme gamma di conoscenze<br />
ed esperienze peculiari, che, invece di essere rigettate o confinate nel mito esotico del<br />
“selvaggio”, possono diventare contributo fecondo per la civiltà umana nel suo complesso.<br />
I primi passi di questo cammino sono stati mossi sul piano della diversità biologica, o<br />
«biodiversità», come viene ormai universalmente definita, sulla base di considerazioni empiriche<br />
derivate sia dalla standardizzazione, a volte avanzatissima, delle colture agricole, sia dalla<br />
valutazione sempre più approfondita delle conseguenze a catena delle alterazioni accelerate<br />
degli ecosistemi introdotti dall’intervento dell’uomo.<br />
Si è giunti alla conclusione che, ad esempio, l’impoverimento genetico del patrimonio<br />
delle specie coltivate provocato dalla diffusione su larga scala di sementi selezionate solo in base<br />
al criterio di maggiore produttività, anziché in vantaggio, finisce spesso per tradursi in un<br />
danno, quando tali colture si trovano a fronteggiare fattori ambientali particolari nei cui confronti<br />
non mostrano alcuna resistenza. Contemporaneamente, l’abbandono spesso senza alcun tipo<br />
di precauzione, delle specie “native” a minore redditività finisce spesso per rendere indisponibile<br />
alla stessa ricerca scientifica materiale genetico prezioso per ulteriori selezioni che tengano<br />
conto di fattori aggiuntivi indispensabili per una soddisfacente integrazione ambientale delle<br />
nuove specie coltivate.<br />
229
É evidente nel campo agronomico, che abbiamo assunto ad esempio, che la considerazione<br />
e la utilizzazione di tali fattori va in direzione esattamente opposta a quella perseguita finora<br />
a livello mondiale, portando alla selezione di una molteplicità di nuove specie caratterizzate<br />
da materiale genetico diverso, in modo da rispondere di volta in volta alle peculiarità<br />
dell’ambiente in cui sono e saranno adoperate. Il che equivale, sia pure sul piano «artificiale»<br />
della ricerca, a muoversi in maggior sintonia con quelli che sono i meccanismi evolutivi naturali.<br />
Su un altro piano, sono ormai evidenti le conseguenze spesso catastrofiche<br />
dell’inquinamento, intendendo con tale termine non solo ciò che designa nella comune esperienza<br />
quotidiana, ma qualsiasi intervento che modifichi in modo permanente le caratteristiche<br />
di un ecosistema.<br />
In effetti, l’intima struttura ed il funzionamento degli ecosistemi sono conosciuti negli aspetti<br />
più macroscopici, ma le loro componenti e le reciproche interazioni tra queste ci sfuggono<br />
nella loro essenza, non solo per quelli a noi meno familiari e ancora studiati solo marginalmente<br />
anche a livello scientifico, ma anche per quelli che crediamo di conoscere a fondo, in quanto<br />
costituiscono il nostro ”habitat” quotidiano.<br />
Le esperienze di numerosi paesi dimostrano che spesso una modifica apparentemente<br />
insignificante produce una reazione a catena tale da mutare profondamente le caratteristiche<br />
ecologiche di aree vastissime, con conseguenze di gravità incalcolabile sulla sopravvivenza di<br />
patrimoni biologici ancora in gran parte inesplorati per quel che concerne la loro consistenza, le<br />
loro caratteristiche e le loro potenzialità.<br />
Anche in questo campo, si va affermando un nuovo approccio teorico, che, nella pratica<br />
dovrebbe tradursi in politiche di intervento meno indiscriminate e più attente all’impatto ambientale.<br />
In realtà, dalle stesse considerazioni brevemente esposte risulta chiaro come sia di fatto<br />
impossibile valutare anche solo con sufficiente approssimazione quale sia l’impatto ambientale<br />
di un determinato intervento su un ecosistema, e ciò è tanto più vero in quanto finora tali valutazioni<br />
sono state effettuate quasi sempre senza tener conto dell’esperienze e delle conoscenze<br />
delle popolazioni che in quel determinato ecosistema sono integrate.<br />
In questo senso, la nuova prospettiva dello sviluppo sostenibile che va affermandosi autorevolmente<br />
in luogo dello sviluppo ”tout court” cui erano finora improntate le linee di fondo della<br />
politica internazionale, riscopre nella diversità una risorsa che, mettendo in relazione campi di<br />
ricerca e di interesse troppo a lungo tenuti separati, o addirittura ignorantisi tra loro, promette un<br />
approccio nuovo, paritario, ai rapporti tra culture diverse, e dunque tra popoli diversi e fornisce<br />
una nuova e feconda chiave di lettura dei rapporti tra popolazione umana ed ambiente nel quale<br />
è inserita.<br />
Basti ricordare, a questo proposito, il grande contributo che alla conoscenza scientifica<br />
ed alla scienza medica vanno fornendo le esperienze di alcune popolazioni indigene<br />
dell’America Latina nell’utilizzazione di alcuni principi attivi vegetali, che senza tale apporto sarebbero<br />
rimasti probabilmente sconosciuti per sempre alla terapeutica dell’Occidente industrializzato<br />
(altro problema è la tutela dei diritti di queste popolazioni relativamente allo sfruttamento<br />
di tali sostanze da parte dell’industria farmaceutica).<br />
Non a caso, dunque, il Principio 22 della Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo,<br />
alla cui base vi sono appunto la teoria dello sviluppo sostenibile e il riconoscimento della diversità<br />
come risorsa, recita testualmente: «Le popolazioni indigene e le loro comunità, e altre comunità<br />
locali, hanno un ruolo vitale nella gestione e nello sviluppo dell’ambiente, grazie alle loro<br />
conoscenze e alle loro pratiche tradizionali. Gli Stati dovrebbero riconoscere e sostenere in maniera<br />
adeguata la loro identità, la loro cultura e i loro interessi, permettendo la loro effettiva partecipazione<br />
al conseguimento dello sviluppo sostenibile», mentre nel Principio 23 della stessa si<br />
sottolinea la necessità di «salvaguardare l’ambiente e le risorse naturali delle popolazioni sotto<br />
oppressione, dominazione e occupazione».<br />
Non solo la diversità genetica (biodiversità) è, dunque, una risorsa. Risorsa di pari importanza<br />
è anche la diversità culturale.<br />
Ciascuna popolazione ha una profonda conoscenza dell’ambiente (ecosistema) di cui è<br />
parte integrante ed ha sviluppato competenze e risposte adeguate, che ne costituiscono<br />
l’aspetto fondamentale della cultura come sistema di interpretazione e sviluppo della realtà.<br />
Riconoscendo il ruolo che le culture locali possono e devono svolgere nel perseguimento<br />
di uno «sviluppo sostenibile», cioè rispettoso dell’ambiente e dell’Uomo e non potenzialmente<br />
230
distruttivo, quale quello finora perseguito dalle società industriali, le Dichiarazione di Rio restituisce<br />
loro pari dignità e, mentre le chiama in causa attivamente, chiede ai governi di rinunciare a<br />
politiche più o meno chiaramente tendenti all’omologazione alla cultura dominante, per puntare<br />
piuttosto alla piena valorizzazione di patrimoni di conoscenza «diversi», stimolando le loro potenzialità<br />
intrinseche di sviluppo e non proponendo modelli estranei, che finirebbero giocoforza<br />
per distruggerli.<br />
Ora, l’approccio positivistico che caratterizza la corrente prevalente della cultura occidentale<br />
ha a lungo vilipeso il valore delle esperienze culturali alternative o anche semplicemente<br />
«altre», in nome di uno scientismo esasperato che ha finito per negare ogni valore alle culture<br />
cosiddette «tradizionali».<br />
La portata di tale atteggiamento risulterà più chiara se si riflette sul fatto che la maggior<br />
parte delle culture locali sono appunto anche «tradizionali», nel senso che spesso non sono dotate<br />
di scrittura, per cui la loro modalità di trasmissione è orale, e che il loro sistema di conoscenza<br />
è basato sull’esperienza accumulata nel corso delle generazioni e non sulla riproducibilità<br />
in condizioni controllate dei fenomeni valutati.<br />
Poiché la società industriale è essenzialmente una società positivista, tende intrinsecamente<br />
ad imporre il proprio modello come l’unico possibile, ed a negare dunque la validità di<br />
qualunque altro approccio alla realtà.<br />
Per guardare all’interno stesso del «primo mondo», la cultura contadina «tradizionale»<br />
ha sempre goduto di scarsissima considerazione ed è stata considerata bisognosa di «redenzione»<br />
alla luce dei principi delle scienze esatte assai più che di sviluppo in base alle proprie<br />
intrinseche potenzialità. Ne è derivato che nel breve volgere di due o tre generazioni, un patrimonio<br />
considerevole di conoscenze, maturato nel corso di un rapporto plurisecolare con la terra<br />
e di cui solo ora si comincia ad intravedere la grande proficuità, è stato dissipato, con le gravi<br />
conseguenze ambientali che sono sotto gli occhi di tutti.<br />
D’altra parte, l’immagine monolitica che sembra offrire oggi la cultura occidentale, così<br />
come viene percepita dall’esterno, è solo in parte corrispondente al vero.<br />
Se infatti è innegabile che le correnti egemoni abbiano operato e in gran parte continuino<br />
ad operare in direzione dell’omologazione e dell’appiattimento delle differenze, o, se vogliamo<br />
della standardizzazione dei modelli di comportamento e della domanda, atteggiamento questo<br />
che risponde anche a precise logiche economiche, è esperienza comune che all’interno delle<br />
società occidentali le culture «locali» non siano affatto state cancellate e che anzi, nel continuo<br />
confronto con le tendenze dominanti vadano acquistando nuova consapevolezza di sé e<br />
del ruolo costruttivo e propositivo della propria diversità.<br />
In effetti, una riflessione storica anche superficiale non può non mettere in luce<br />
l’importanza che il fattore diversità ha avuto nello sviluppo della civiltà umana.<br />
L’incontro tra popoli portatori di culture diverse, qualunque ne sia stata la motivazione e<br />
la conclusione ha sempre coinciso con innovazioni significative, talvolta con veri e propri salti da<br />
un livello di civiltà ad un altro, quasi che le diverse esperienze, i diversi approcci di conoscenza<br />
ed intervento sulla realtà sociale ed ambientale interagissero, fecondandosi a vicenda.<br />
Anche sul piano della cultura, dunque, sembra applicabile, con i dovuti aggiustamenti,<br />
quel principio fondamentale della termodinamica secondo cui il progressivo aumento<br />
dell’entropia di un sistema chiuso lo conduce ad uno stato di stabilità nel quale esso non è più<br />
in grado di compiere lavoro utile, stato che coincide con la morte del sistema.<br />
In altri termini, sul piano biologico-genetico, come su quello culturale, la diversità implica<br />
aumento delle possibilità disponibili nel presente e aumento delle possibilità di innovazione nel<br />
futuro, ovvero vitalità del sistema, laddove la standardizzazione, pretendendo di mettere ordine<br />
nel caos della molteplicità, finisce per portare il sistema ad uno stato di staticità, ovvero di impotenza.<br />
Il mutamento di tendenze che va facendosi strada nel mondo occidentale, vede dunque<br />
nelle comunità locali, sia nei Paesi in via di sviluppo che al suo stesso interno, una nuova opportunità,<br />
che va recuperata e promossa, in quanto portatrice di contributi e fermenti propri, che<br />
possono dare apporti importanti nella nuova prospettiva dello sviluppo sostenibile.<br />
Per quel che riguarda il nostro Paese, oltre che suggerire un diverso approccio alle culture<br />
locali sensu lato, e dunque una maggiore attenzione, ove ancora possibile, alle esperienze<br />
della cultura «tradizionale» nei casi in cui questa non abbia già ceduto alla pretesa superiorità di<br />
231
quella «industriale», tale nuova visione pone in primo piano il problema della tutela di patrimoni<br />
culturali particolari, quali sono quelli delle minoranze linguistiche.<br />
L’Italia è, infatti, il Paese dell’UE con il maggior numero di minoranze sul proprio territorio.<br />
Una parte di queste minoranze, come i Friulani, i Ladini dolomitici, i Sardi, sono autoctone<br />
ed abitano aree territorialmente compatte.<br />
Altre, come gli Albanesi, i Catalani, i Croati, gli Sloveni, i Tedeschi si sono invece insediate<br />
sul territorio della penisola in epoca successiva e per motivi diversi, dando luogo a comunità<br />
sparse su ampie aree geografiche a mo’ di isole linguistiche o distese ai confini a mo’ di<br />
penisole.<br />
Tutte queste popolazioni conservano in larghissima misura una propria lingua ed una<br />
propria cultura ed alcune si distinguono anche sul piano religioso, in quanto seguono, in gran<br />
parte, il rito bizantino.<br />
Alcune di esse, che si caratterizzano come minoranze di confine, nel senso che le regioni<br />
da loro abitate sul territorio italiano sono a ridosso dei confini nazionali ed esse riconoscono<br />
come punti di riferimento linguistici e culturali gli Stati esteri immediatamente confinanti, sono<br />
state oggetto nel passato anche recente di aspri contenziosi internazionali e godono attualmente<br />
di una tutela giuridica, che, alla luce anche delle più recenti conquiste internazionali sui diritti<br />
dei popoli e della stessa Dichiarazione di Rio, può essere definita d’avanguardia.<br />
Appositi pacchetti legislativi concedono infatti loro ampia autonomia amministrativa e<br />
culturale e ciascuna popolazione è chiamata direttamente in causa in tutte le decisioni che riguardino<br />
la gestione del territorio in cui è insediata. Ciò consente la migliore valorizzazione e<br />
sfruttamento delle risorse culturali ed economiche delle aree in questione, in una prospettiva<br />
che, in linea di principio, parte dalla peculiarità delle esperienze locali e su questo basa i progetti<br />
di sviluppo culturale ed economico.<br />
Sebbene all’epoca della emanazione di queste legislazioni particolari il problema della<br />
tutela dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile non fosse ancora percepito con la stessa consapevolezza<br />
di oggi, le norme miranti alla tutela linguistica e culturale delle popolazioni minoritarie<br />
in questione, ove vengano ad essere compiutamente applicate, coinvolgono giocoforza nel<br />
processo anche l’ambiente e le modalità di approccio ad esso che sono peculiari di quelle culture.<br />
Sul piano ambientale, l’omologazione di queste culture a quella maggioritaria comporta<br />
una perdita di conoscenze specifiche sulla gestione degli ecosistemi in cui esse sono inserite e<br />
sullo sfruttamento delle risorse, che può avere conseguenze gravi sugli ecosistemi stessi.<br />
Di più; sono sotto gli occhi di tutti le nefaste conseguenze dell’abbandono delle zone<br />
montane e di interventi come la cementificazione selvaggia dei letti dei fiumi fatta senza tenere<br />
in alcun conto le esperienze delle popolazioni che abitavano sulle loro rive.<br />
Ora, è evidente che, in questa prospettiva, qualunque intervento di tutela non può limitarsi<br />
a misure che riguardino in maniera esclusiva il campo linguistico e culturale, ma deve avere<br />
un carattere globale, con implicazioni anche nella sfera economica. Il solo modo di attuare<br />
una tutela reale delle culture minoritarie consiste infatti nel porre argini alla fuga delle popolazioni<br />
dalle aree di insediamento, senza di che qualunque provvedimento è destinato a naufragare<br />
nello stato di bisogno che impone di necessità l’emigrazione, e dunque la disgregazione<br />
della comunità.<br />
A questo proposito, le politiche di sviluppo da adottare non potranno prescindere dalle<br />
caratteristiche e dalle vocazioni ambientali specifiche, che nel corso della storia hanno, se non<br />
proprio condizionato, certamente orientato in alcune direzioni piuttosto che altre lo sviluppo economico<br />
delle popolazioni. incidendo in maniera più o meno significativa anche sul piano più<br />
propriamente sociale ed umano, quindi sui modelli di società e sui rapporti con le popolazioni<br />
vicine.<br />
Se sul piano della organizzazione sociale è abbastanza vicino al vero che all’interno<br />
delle società occidentali si è raggiunto un grado di omologazione pressoché totale, nel senso<br />
che, a parte alcuni elementi marginali, col tempo si è imposto, per forza di cose, il modello standardizzato<br />
dalle leggi e dalle norme dello Stato, le vocazioni ambientali specifiche rimangono un<br />
patrimonio che solo in parte è stato finora valorizzato in tutte le sue potenzialità. In alcun casi,<br />
anzi, anche nel nostro paese, ed in particolare nel meridione, si è tentato di imporre modelli di<br />
232
sviluppo estranei non solo alla cultura locale, ma anche all’ambiente stesso, con risultati fallimentari<br />
sul piano economico e disastrosi su quello ecologico.<br />
Alla luce di queste esperienze e dei risultati positivi di esperienze alternative, che invece<br />
hanno saputo trarre profitto dallo sfruttamento accorto delle vocazioni ambientali sia riorganizzando<br />
attività tradizionali secondo schemi più razionali sia dando vita a nuove attività saldamente<br />
ancorate alle realtà locali (basti citare per tutti, rimanendo in Italia, il caso del Trentino-Alto<br />
Adige), risulta evidente che nella programmazione di futuri interventi economici sia opportuno<br />
tener conto delle esperienze delle popolazioni interessate e della loro cultura, delle relazioni tra<br />
esse e l’ambiente e del contributo originale che, in virtù di questi fattori esse possono offrire alla<br />
progettazione e realizzazione degli interventi stessi. La valutazione dell’impatto ambientale di<br />
un determinato intervento sarà, in tal modo, più approfondita, perché sarà possibile tener conto<br />
di un numero di variabili considerevolmente maggiore.<br />
Ciò equivale ad un coinvolgimento delle popolazioni nei processi decisionali che le riguardano,<br />
salvaguardandone le peculiarità.<br />
Il Patto Internazionale sui diritti civili e politici promosso dall’ONU riconosceva già nel<br />
1966 a tutti popoli il diritto di “disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse<br />
naturali, senza pregiudicare gli obblighi derivanti dalla cooperazione internazionale, fondata sul<br />
principio del mutuo interesse, ed il diritto internazionale” (art. 1, comma 2).<br />
Il principio veniva ribadito con forza, sempre in sede ONU, nel Progetto di dichiarazione<br />
universale sui diritti dei popoli autoctoni elaborato dal Consiglio Economico e Sociale, che afferma:<br />
“I popoli autoctoni hanno il diritto di mantenere i legami particolari e profondi che li uniscono<br />
alle loro terre, territori e risorse – ciò che include l’insieme dell’ambiente: sole, aria ed idrosfera<br />
– che essi occupano o utilizzano tradizionalmente sotto altra forma (…) hanno il diritto<br />
collettivo ed individuale di proprietà, gestione ed uso delle terre e dei territori che essi occupano<br />
o utilizzano tradizionalmente sotto altra forma. Ciò include il diritto a che le loro leggi e costumi,<br />
il loro regime fondiario e le loro istituzioni per la gestione delle risorse siano pienamente riconosciuti,<br />
nonché il diritto a misure efficaci da parte dello Stato, miranti a impedire qualsiasi attentato<br />
a questi diritti (…) hanno diritto alla restituzione o, nella misura in cui essa non sia più possibile,<br />
ad un indennizzo giusto ed equo per le terre ed i territori che gli siano stati confiscati, occupati,<br />
utilizzati o degradati, senza il loro libero consenso dato con cognizione di causa (…) hanno<br />
diritto a che il loro ‘habitat’ e la produttività delle loro terre siano protetti (…)” (Parte Terza).<br />
Ancora in ambito ONU, il Progetto di dichiarazione dei diritti delle persone appartenenti<br />
alle minoranze nazionali od etniche, religiose e linguistiche elaborato nel 1992 dalla Commissione<br />
per i diritti dell’uomo ribadisce: “Le persone appartenenti alle minoranze hanno il diritto di<br />
prendere una parte effettiva, a livello nazionale ed eventualmente a livello regionale, alle decisioni<br />
che riguardano la minoranza alla quale esse appartengono o le regioni nelle quali esse vivono,<br />
secondo modalità compatibili con la legislazione nazionale” (art. 2, comma 3).<br />
Lo stesso principio e con una formulazione molto simile a questa, ma ancora più blanda,<br />
viene affermato in campo europeo, dal documento della riunione di Copenaghen della<br />
CSCE (1990) 30 ,che al punto 35 afferma: “Gli Stati partecipanti rispetteranno i diritti delle persone<br />
appartenenti alle minoranze nazionali di partecipare effettivamente agli affari pubblici, in particolare<br />
agli affari che riguardano la protezione e promozione dell’identità di tali minoranze”.<br />
Allo stesso modo, la proposta per una “Convenzione europea per la protezione delle<br />
minoranze” elaborata nel 1991 in sede di Consiglio d’Europa, afferma, più incisivamente, (art.<br />
14, punto 1) che “Gli Stati favoriranno la partecipazione effettiva delle minorane agli affari pubblici,<br />
ed in particolare alle decisioni riguardanti le regioni nelle quali esse vivono ed agli affari<br />
che le riguardano”, sottolineando nel punto 2 che gli Stati si sforzeranno di tener conto della<br />
presenza delle minoranze nelle suddivisioni amministrative e politiche del territorio.<br />
Accolto nello Strumento della “Iniziativa Centro-Europea” (CEI) per la tutela delle minoranze<br />
nazionali, aperto alla firma degli Stati membri della CEI nel 1994, il principio viene ancora<br />
riformulato, nel senso che gli Stati firmatari si impegnano a garantire alle minoranze di “partecipare<br />
effettivamente alla vita pubblica ed in particolare ai processi decisionali che le riguardano”.<br />
Assai più precisa era al riguardo la proposta per una Convenzione europea per la protezione<br />
delle minoranze elaborata in sede di Consiglio d’Europa dalla Commissione europea per la democrazia<br />
attraverso il diritto (1993), che impegna gli Stati a “favorire la partecipazione effettiva<br />
30 Ora O.S.C.E. “Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa”.<br />
233
delle minoranze agli affari pubblici, in particolare alle decisioni riguardanti le regioni nelle quali<br />
esse vivono e alle questioni che le riguardano”.<br />
Il progetto definitivo di Convenzione-quadro europea per la tutela delle minoranze nazionali<br />
licenziato, in seno al Consiglio d’Europa, dal CAHMIN 31 nel 1994 non ha tuttavia accolto<br />
questa formulazione, preferendo sorvolare sulla questione particolare.<br />
In effetti, ciò che, rispetto anche all’ultima, blanda formulazione contenuta nei progetti<br />
ONU, caratterizza i documenti europei in materia è la assoluta genericità delle affermazioni e la<br />
tendenza, appena mascherata, a limitare i principi di tutela al campo puramente culturale, lasciando<br />
da parte le pur di fatto inevitabili implicazioni economiche che ogni processo di tutela<br />
delle popolazioni minoritarie presenta.<br />
Ora, la prospettiva innovativa contenuta nella Dichiarazione di Rio sullo sviluppo sostenibile<br />
indica le comunità locali come protagoniste della gestione e dello sviluppo dell’ambiente,<br />
e dunque coniuga la tutela di tali culture con la tutela ambientale, suggerendo, come si è visto,<br />
la necessità di una reimpostazione di tutta la materia.<br />
In questo senso, sarebbe opportuno che gli Stati firmatari della Dichiarazione di Rio ed<br />
anche quelli, che per svariati, e talora giustificati motivi, non l’hanno sottoscritta ripensassero<br />
profondamente le proprie politiche in campo ecologico, collegando la tutela dell’ambiente con la<br />
tutela delle culture delle popolazioni locali, che in un determinato ambiente si sono sviluppate,<br />
portando alla liberazione di potenzialità, destinate altrimenti ad andare perdute, con grandi vantaggi<br />
sul piano economico oltre che su quello umano.<br />
Ora, poiché, sia i documenti internazionali in materia di tutela delle minoranze che quelli<br />
in materia di tutela ambientale sono largamente insufficienti allo scopo, perché in genere sulla<br />
separazione dei due fattori, sarebbe estremamente proficuo che, a partire dalla Dichiarazione di<br />
Rio, si promuovesse a livello internazionale una riflessione indirizzata all’elaborazione di un documento<br />
che sintetizzi e renda esplicito l’approccio abbozzato a Rio.<br />
Come prova la progressiva diluizione delle enunciazioni contenute nei documenti internazionali<br />
in materia di tutela delle minoranze quel che riguarda il loro ruolo nella gestione del<br />
territorio e delle risorse, una tale iniziativa incontrerà molte resistenze e richiederà tempi lunghi<br />
per la realizzazione, ma, nell’immediato, servirà a tener vivo il problema e stimolerà anche gli<br />
Stati più recalcitranti ad una riconsiderazione della questione della diversità culturale e della tutela<br />
dell’ambiente, aprendo nel contempo nuove prospettive anche alla soluzione del problema<br />
del sottosviluppo.<br />
31 Cioè il “Comitato ad hoc per la tutela delle minoranze nazionali”.<br />
234
LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI <strong>DIRITTI</strong> LINGUISTICI<br />
A. Premessa<br />
Dal 6 al 9 giugno 1996, si è tenuta a Barcellona la Conferenza mondiale dei diritti linguistici.<br />
L’iniziativa, promossa dal Ciemen di Barcellona e dal Pen club international, con il patrocinio<br />
dell’Unesco, di alcuni uffici della Commissione dell’Ue, della Generalidad della Catalogna<br />
e del Comune di Barcellona, era volta all’approvazione, da parte degli esperti di tutto il<br />
mondo chiamati a parteciparvi, di una “Dichiarazione universale dei diritti linguistici”, che proclamasse<br />
a livello internazionale tali diritti e divenisse documento di riflessione in tutte le sedi<br />
internazionali opportune.<br />
Le problematiche inerenti ai diritti linguistici delle minoranze nazionali e dei gruppi etnici<br />
sono infatti un problema di grande attualità, al quale le varie organizzazioni internazionali,<br />
dall’Onu, all’Ue, alla Osce, al Consiglio d’Europa, dedicano un’attenzione crescente, anche in<br />
relazione al grande potenziale destabilizzante che la questione riveste e che già in parte si sta<br />
manifestando in molte zone del globo, compresa l’Europa.<br />
Non è infatti un caso se il dibattito sempre più approfondito negli ultimi decenni si è<br />
concretizzato in una serie di pronunciamenti sempre più specifici.<br />
In sede Onu, dalle affermazioni generiche, ma comunque fondamentali, sui diritti in materia contenute<br />
nella dichiarazione universale sui diritti dell’uomo del 1948, attraverso la Carta internazionale<br />
dei diritti civili e politici del 1966 e la Carta internazionale per i diritti economici, sociali e<br />
culturali dello stesso anno, si è passati in anni più recenti alla ben più esplicita dichiarazione sui<br />
diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali, etniche, religiose e linguistiche adottata<br />
nel 1992, che tra i diritti riconosciuti alle minoranze annovera, in primo luogo, anche quelli<br />
che rientrano nella definizione di “linguistici”, diritti cioè relativi all’uso della lingua materna e ad<br />
esso collegati.<br />
Tale processo di progressiva focalizzazione del problema si è sviluppato, parallelamente,<br />
anche in sede europea.<br />
In linea di principio, infatti, i diritti riconducibili alla salvaguardia e all’uso della propria<br />
lingua da parte di persone appartenenti a gruppi di popolazione minoritari, rientrano nella sfera<br />
dei diritti fondamentali affermati nella Convenzione europea per la protezione dei diritti umani e<br />
delle libertà fondamentali del 1950.<br />
L’evolversi del dibattito in materia e le situazioni che si venivano via via determinando<br />
nei diversi Stati dei vecchio continente, ove la presenza di popolazioni di etnia, lingua e cultura<br />
è fenomeno estremamente diffuso, ha mostrato ben presto i limiti di una formulazione che non<br />
affrontasse la questione nel suo specifico.<br />
All’elaborazione di strumenti specificamente mirati alla protezione delle minoranze hanno<br />
dato poi impulso decisivo nell’ultimo decennio, da un lato la pressione stessa dei gruppi minoritari,<br />
che ha talvolta assunto forme clamorose, e dall’altro, più di recente, la caduta dei regimi<br />
dell’Est, che ha portato alla ribalta problematiche interetniche apparentemente sopite, con esiti<br />
spesso drammatici.<br />
Alla Carta europea per le lingue regionali e minoritarie adottata dal Consiglio dei Ministri<br />
del Consiglio d’Europa nel 1992, hanno fatto seguito, negli anni successivi, sempre da parte del<br />
Consiglio d’Europa, la Dichiarazione sulle minoranze nazionali del 1993 ed infine, a conclusione<br />
di un lungo e articolato processo che ha visto protagoniste anche organizzazioni non governative<br />
rappresentative delle minoranze, la Convenzione-quadro europea per la protezione delle minoranze<br />
nazionali del 1994.<br />
Ancora in ambito europeo, nel 1994 uno specifico “Strumento” per la protezione delle<br />
minoranze veniva aperto alla firma dei Paesi aderenti all’iniziativa centro europea (cd. Strumento<br />
Cei).<br />
La novità dell’approccio proposta dalla conferenza di Barcellona e rispecchiato nella dichiarazione<br />
che da esso è scaturita è che, mentre in tutti i documenti citati ed in altri qui non<br />
menzionati, il punto di partenza sono i diritti delle minoranze nazionali, o meglio delle persone<br />
appartenenti alle minoranze, alle quali viene riconosciuto, tra l’altro, il diritto all’uso della lingua<br />
235
e a quelli ad esso correlati, qui è la lingua ad essere assunta come punto focale, intorno al quale<br />
ruotano tutti gli altri elementi, al punto che il soggetto dei diritti non è più la minoranza nazionale,<br />
o etnica, o gruppo minoritario, ma la “comunità linguistica” e il “gruppo linguistico”.<br />
La lingua, dunque, non è più vista come uno degli elementi che concorrono alla definizione<br />
dell’identità nazionale od etnica di una popolazione, ma come l’elemento discriminante<br />
fondamentale, quello che, da solo, determina tale identità o addirittura la costituisce. In questo<br />
senso, come vedremo, il diritto fondamentale all’uso della propria lingua si allarga fino a diventare<br />
il fondamento di un ordinamento potenzialmente alternativo delle società contemporanee,<br />
certamente assai suggestivo sul piano teorico, ma anche, per una serie di ragioni giuridiche,<br />
economiche o anche semplicemente pratiche, altrettanto difficilmente praticabile nel concreto<br />
funzionamento delle istituzioni.<br />
B. Il documento<br />
La “Dichiarazione universale dei diritti linguistici” consta di 52 articoli, distribuiti in due titoli<br />
più un titolo preliminare, preceduti da una premessa e da un preambolo e seguiti da due<br />
brevi capitoli di disposizioni integrative e disposizioni finali.<br />
1. Premessa<br />
La premessa contiene i riferimenti a tutti i documenti che, in materia di tutela delle minoranze<br />
nazionali, etniche o linguistiche sono stati adottati dalle organizzazioni internazionali governative<br />
e non governative e che costituiscono la base dalla quale la dichiarazione universale<br />
dei diritti linguistici parte, per portare alle loro conseguenze più avanzate i principi e i diritti in<br />
essi enunciati.<br />
Essa include, inoltre, alcune considerazioni fondamentali sullo stato, si badi, non delle<br />
comunità minoritarie a rischio di assimilazione o di estinzione, ma sulle “lingue a rischio” e sulle<br />
cause dello stato di pericolo in cui esse versano.<br />
In sostanza, tali cause vengono identificate nella mancanza di “sovranità” e di “autogoverno”<br />
da parte delle comunità che le parlano e nella politica di “Stati che impongono le proprie<br />
strutture amministrative e le proprie lingue”.<br />
D’altra parte, viene rilevato anche il ruolo che nel processo di sostituzione linguistica a<br />
danno di lingue deboli hanno giocato storicamente “invasioni, colonizzazioni, occupazioni ed altri<br />
casi di imposizione diretta di una lingua straniera”, tutti elementi che in un grande numero di<br />
casi hanno mutato “la percezione del valore delle lingue” da parte dei loro stessi parlanti e dato<br />
origine ad una sorta di gerarchia delle lingue stesse, per cui il processo di sostituzione linguistica<br />
ai danni delle lingue locali prosegue anche in quei casi in cui altri fattori extralinguistici (in<br />
particolare politici) siano venuti a cessare.<br />
Ciò a cui mira la dichiarazione è, pertanto, creare le condizioni di un universalismo che<br />
si fondi sull’affermazione della diversità linguistica e culturale piuttosto che sulla massificazione<br />
e che, pertanto, individui i mezzi più appropriati per “correggere gli squilibri linguistici, al fine di<br />
garantire a tutte le lingue il rispetto e il pieno sviluppo e di fissare i principi di una pace linguistica<br />
giusta ed equa in tutto il mondo”, condizione questa che viene considerata basilare per il<br />
mantenimento di rapporti sociali non conflittuali tra le varie comunità.<br />
2. Preambolo<br />
Le concezioni sopra esposte riguardo ai fattori che determinano la situazione di una lingua<br />
vengono ulteriormente esplicitate e ribadite nel preambolo.<br />
Viene sottolineato, in particolare, che la situazione di una lingua dipende da una vasta<br />
gamma di fattori extralinguistici, di natura storica, politica, giuridica, economica, demografica,<br />
territoriale, ecc. Tra questi, un ruolo significativo spetta attualmente alla tendenza ancora fortemente<br />
attiva in alcuni Stati, ad imporre una lingua nazionale a spese delle lingue locali eventualmente<br />
parlate in alcune zone limitate del suo territorio.<br />
Non meno influenti appaiono, poi, i motivi di carattere economico, legati al processo di<br />
progressivo e rapida globalizzazione dell’economia, dell’informazione, delle comunicazioni e<br />
della circolazione della cultura, che fanno apparire più vantaggiosa, agli occhi soprattutto dei<br />
grandi gruppi economici che operano a livello internazionale, l’affermazione di grandi modelli<br />
linguistici e culturali fortemente dominanti e la riduzione, invece, delle diversità, il cui mantenimento<br />
comporterebbe una serie di processi di adattamento a universi particolari che, in un mo-<br />
236
dello di sviluppo basato sui criteri puramente economicistici, non possono trovare spazio. Il superamento<br />
delle logiche tradizionali nell’impostazione del problema delle lingue di minoranza,<br />
che nei documenti internazionali attualmente esistenti vengono considerate come oggetti di tutela<br />
da parte degli Stati, che acconsentono ad accordare loro delle garanzie, risulta ancora più<br />
evidente laddove viene affermato esplicitamente che la “dichiarazione considera come punto di<br />
partenza le comunità linguistiche e non gli Stati”.<br />
In sostanza, ciò significa che le lingue parlate da gruppi minoritari di popolazione, per il<br />
solo fatto di esistere sono portatrici di diritti che i parlanti non hanno bisogno di vedersi riconoscere,<br />
ma devono essere messi in condizioni di poter esercitare nella loro interezza, cosa che<br />
può essere realizzata non con la semplice previsione di misure di tutela, ma con il perseguimento<br />
di un modello economico e politico in cui la diversità linguistica non venga considerata un ostacolo,<br />
uno svantaggio, ma risulti vantaggiosa per tutti.<br />
Si tratta, con tutta evidenza, di un discorso dirompente, che presuppone una profonda<br />
revisione delle più consolidate prassi in materia, con conseguenze che, come si vedrà nel seguito,<br />
assumono talora connotazioni utopistiche, nel senso che, pur essendo accettabili sul piano<br />
teorico, come conseguenza logica, seppure estrema, dei principi della tutela dei diritti fondamentali<br />
della persona umana, sul piano della loro traducibilità in pratica comportano diversi<br />
problemi sia sul piano dei rapporti sociali all’interno degli Stati che su quello economicofinanziario,<br />
dal quale non è possibile prescindere, sebbene, da un punto di vista puramente etico,<br />
sia certamente meno nobile<br />
3. Titolo preliminare<br />
Nel titolo preliminare vengono definiti i concetti di “comunità linguistica” e “gruppo linguistico”<br />
e di diritti di cui le due entità sono soggetto.<br />
La “comunità linguistica” viene definita nell’art. 1 come “qualsiasi società umana stabilitasi<br />
storicamente in un particolare spazio territoriale, sia che tale spazio sia riconosciuto o meno,<br />
che identifichi se stessa come popolo ed abbia sviluppato una lingua come mezzo naturale<br />
di comunicazione e di coesione tra i suoi membri” (comma 1). Tale criterio di fondo viene ulteriormente<br />
esplicitato nel comma 3 dello stesso articolo dove si traccia anche una prima distinzione<br />
tra comunità linguistica e gruppo linguistico specificando che un gruppo deve essere considerato<br />
appartenente ad una comunità al verificarsi di una serie di condizioni di natura storicopolitico-amministrativa,<br />
che comprendono la separazione del nucleo centrale della comunità<br />
stessa ad opera di confini politici od amministrativi, l’insediamento remoto sul territorio di attuale<br />
residenza, dove sono circondate da membri di altre comunità, la condivisione di detto territorio<br />
con altre comunità linguistiche aventi antecedenti storici simili. Comunità linguistiche vengono<br />
considerate anche le popolazioni nomadi “all’interno dei loro territori storici di migrazione” ed i<br />
popoli i cui insediamenti storici all’interno di territori abitati da altre comunità non presentino caratteristiche<br />
di continuità territoriale ma siano frammentati (comma 4). Il gruppo linguistico viene<br />
definito, al comma 5, come “qualsiasi gruppo di persone che parlino la stessa lingua e che sia<br />
stabilito nell’ambito territoriale di un’altra comunità linguistica, ma che non abbia trascorsi storici<br />
equivalenti a quelli di detta comunità”, con la specificazione che esempi di tali gruppi sono “gli<br />
immigrati, i profughi, gli esiliati e i membri delle diaspore”.<br />
Il criterio discriminante tra comunità linguistica e gruppo linguistico sembra essere quello<br />
storico.<br />
Non vi è, infatti, né qui né in altra parte del testo alcun accenno ad altri criteri, quale, ad<br />
esempio, quello della consistenza numerica, né si rileva alcuna sostanziale differenza tra le due<br />
entità relativamente agli altri elementi di riferimento della comunità linguistica, che sono la lingua,<br />
il legame con il territorio e l’identificazione dell’individuo con il gruppo.<br />
Anche il criterio storico appare, tuttavia, piuttosto indeterminato, nel senso che<br />
l’espressione “storicamente stabilitasi”, riferita alla comunità, come pure l’altra successiva “storicamente<br />
stabiliti’’, riferita ai gruppi che la costituiscono, pur enunciando un criterio di natura<br />
chiaramente temporale, non fornisce alcuna indicazione sul lasso di tempo che, a partire<br />
dall’epoca dell’insediamento, deve trascorrere perché un gruppo venga considerato comunità.<br />
L’orientamento interpretativo deve allora fare riferimento inevitabilmente al concetto tradizionale<br />
di “minoranze di antico insediamento” e “nuove minoranze” cui sono improntate diverse<br />
legislazioni nazionali e che, a livello internazionale, è stato adottato, ad esempio, dal Consi-<br />
237
glio d’Europa, che, dopo avere adottato la “Convenzione quadro per la protezione delle minoranze<br />
nazionali” ha allo studio una specifica convenzione relativa alle nuove minoranze alla luce<br />
della considerazione che queste presentano, in effetti, problemi di integrazione nel tessuto socioeconomico<br />
che le accoglie, che sono profondamente diversi dalle problematiche relative a<br />
quelle di antico insediamento.<br />
D’altra parte, che tali concetti tradizionali non siano stati adottati nella dichiarazione è<br />
da attribuire, con tutta probabilità, al fatto che essa assume come criterio primario, se non addirittura<br />
unico, d’identificazione della comunità linguistica e del gruppo linguistico l’elemento “lingua”,<br />
prescindendo in materia pressoché totale dall’utilizzazione di altri criteri oggettivi e soggettivi<br />
adottati in altri documenti internazionali in materia (ad es. cultura, religione, tradizioni, ecc..).<br />
Tale scelta discende evidentemente da una concezione che vede la lingua come strumento<br />
di letteratura ed interpretazione della realtà, e che dunque riconduce ad essa tutti gli altri<br />
elementi che di fatto differenziano le culture proprie di comunità umane diverse.<br />
L’accento posto sulla lingua non significa dunque che gli altri elementi non siano presi in<br />
considerazione, in quanto, come risulterà evidente dal seguito del documento, essi sono al contrario<br />
ben presenti ai suoi redattori, ma, piuttosto, che nell’elemento “lingua” essi siano tutti<br />
compresi e sottintesi, in quanto è da esso, che, in larga misura, sono determinati.<br />
Si tratta, di una concezione che, naturalmente, può essere condivisa o meno ma è in<br />
questa prospettiva che il documento va letto e interpretato e che ne vanno considerati i limiti. In<br />
effetti, se in linea di principio è innegabile che le lingue diverse strutturano la realtà in modo diverso<br />
(tipico è l’esempio della profonda diversità del campo cromatico del marrone come identificato<br />
dall’italiano e dall’inglese), è pur vero che i contatti tra culture diverse producono, al livello<br />
della Welktanschaung di ciascuna comunità umana, effetti che possono coinvolgere solo in parte<br />
il sistema linguistico. La pressione culturale della popolazione minoritaria può introdurre nella<br />
comunità minoritaria mutamenti che ne sconvolgono profondamente l’identità culturale, e che, a<br />
livello linguistico, si traducono in un processo di trasformazione del sistema dei significati, per<br />
cui la stessa veste linguistica finisce per esprimere contenuti di una cultura inizialmente “diversa”.<br />
In questo senso, come qualcuno ha già fatto osservare, sarebbe opportuno aggiungere<br />
alla definizione delle comunità e dei gruppi linguistici altri criteri, che concorrano a identificare le<br />
due entità ed a distinguerle tra loro.<br />
In particolare, si potrebbero citare i criteri riguardanti il riconoscimento della comunità o<br />
del gruppo e la sua posizione, la definizione temporale già in parte adottata, e il riferimento alla<br />
cultura diversa da quella della/e comunità o gruppi circostanti.<br />
A ben guardare, tuttavia, l’introduzione di tali ulteriori precisazioni, ed in particolare del<br />
primo dei tre criteri integrativi proposti comporterebbe già un mutamento di prospettiva della dichiarazione.<br />
In effetti, il riconoscimento giuridico della comunità e del gruppo e la sua definizione da<br />
questo punto di vista (minoranza nazionale, minoranza linguistica, ecc.), implica un intervento<br />
normativo preventivo da parte delle autorità istituzionali dello Stato ove la comunità linguistica o<br />
il gruppo linguistico sono insediati, in base al quale poi tale riconoscimento sarà o meno concesso,<br />
che è proprio ciò che i redattori della dichiarazione vogliono evitare, laddove affermano<br />
esplicitamente che una comunità linguistica sia una qualsiasi società umana stabilitasi in un<br />
particolare spazio territoriale, sia che tale spazio sia riconosciuto o meno (…) e che la presente<br />
dichiarazione si basa sul principio che i diritti di tutte le comunità linguistiche sono uguali ed indipendenti<br />
dallo status giuridico derivante dall’essere lingua ufficiale, regionale o di minoranza<br />
(art. 5).<br />
La comunità linguistica, come il gruppo linguistico, cioè, esistono in quanto tali e non<br />
hanno bisogno di alcun riconoscimento formale da parte dello Stato, che deve limitarsi a prendere<br />
atto della loro esistenza e a creare le condizioni perché essi possano esercitare i loro diritti,<br />
dei quali essi godono naturalmente e non perché gli vengono riconosciuti da qualcuno.<br />
Per questi stessi motivi, restando nella prospettiva della dichiarazione, è improponibile<br />
l’adozione di un criterio che faccia riferimento alla consistenza numerica delle comunità o dei<br />
gruppi, in quanto ciò introdurrebbe una discriminante sul piano dei diritti che non è accettabile in<br />
un quadro giuridico fondato sul principio della sostanziale uguaglianza di tutte le lingue, che devono<br />
dunque godere di parità di diritti e di opportunità, a prescindere dal numero dei parlanti.<br />
Tale prospettiva, indubbiamente suggestiva sul piano teorico, costituisce a un tempo il<br />
238
principale pregio ed il principale limite della dichiarazione, perché ne inficia fortemente le possibilità<br />
di traduzione sul piano della pratica.<br />
Oltre a definire i soggetti della dichiarazione, nel titolo primo vengono anche enunciati i<br />
diritti “personali inalienabili” che le persone appartenenti alle comunità linguistiche ed ai gruppi<br />
linguistici devono essere messe in condizione di poter esercitare “in qualsiasi situazione” (art.3)<br />
e che, coma già sottolineato nell’art. 1, comma 2, sono “individuali e collettivi allo stesso tempo’’.<br />
In aggiunta agli altri diritti connessi alla lingua già enunciati dalla Carta internazionale<br />
dei diritti civili e politici (1966) e dalla Carta internazionale sui diritti economici, sociali e culturali<br />
(1966), essi comprendono, per le comunità linguistiche il diritto al riconoscimento in quanto<br />
membro di una comunità linguistica, il diritto all’uso della propria lingua sia in pubblico che in<br />
privato, il diritto di avere relazioni e di associarsi con altri membri della propria comunità, ed il<br />
diritto al mantenimento ed allo sviluppo della propria cultura.<br />
I diritti linguistici collettivi dei gruppi linguistici comprendono, poi, il diritto<br />
all’insegnamento della propria lingua e cultura, l’accesso ai servizi sociali, una “equa” presenza<br />
della loro lingua nei mezzi di comunicazione ed il diritto ad essere sentiti nella propria lingua<br />
dagli interlocutori istituzionali o economico-commerciali.<br />
Da tali diritti fondamentali discendono tutti gli altri enunciati nei titoli successivi e discendono,<br />
per le autorità dei diversi Stati, gli obblighi a garantire le condizioni per il loro esercizio<br />
effettivo, in modo che ciò non sia di ostacolo né alle relazioni tra gruppi e comunità ospiti né<br />
all’integrazione.<br />
A conclusione di questa breve analisi del titolo preliminare, preme osservare, tuttavia,<br />
che, nonostante la distinzione netta che viene posta al principio tra comunità linguistica e gruppo<br />
linguistico, e al di là delle critiche già mosse ai due concetti, una certa incertezza nell’uso dei<br />
due termini sembra notarsi anche negli stessi redattori della dichiarazione, nel senso che si ha<br />
spesso l’impressione di una loro sovrapposizione o comunque di un loro uso non completamente<br />
rispondente alla separazione concettuale proposta.<br />
Titolo I<br />
Nel titolo uno, che comprende gli articoli dal 7 al 14, vengono esplicitati i diritti legati<br />
all’uso delle lingue in pubblico ed in privato.<br />
Partendo dal principio che “tutte le lingue sono l’espressione di una identità culturale e<br />
di un preciso modo di percepire e descrivere la realtà”, si afferma che tutte le lingue devono essere<br />
messe in condizione di sviluppare tutte le loro funzioni, in modo che possano effettivamente<br />
essere “strumento di coesione, identificazione, comunicazione ed espressione creativa” per<br />
la comunità che con esse si esprime (ari. 7).<br />
Ne consegue che le comunità linguistiche devono potersi organizzare al fine di garantire<br />
l’uso della propria lingua a tutti i livelli ed in tutte le sue funzioni nella società oltre che la sua<br />
trasmissione e continuità (art. 8).<br />
A tale fine, esse devono essere lasciate libere di “codificare, standardizzare, preservare,<br />
sviluppare e promuovere il loro sistema linguistico”, al di fuori di ogni forzatura od interferenza<br />
esterna (art. 9).<br />
Da questo e dal contesto delineato in precedenza nel preambolo e nel titolo preliminare,<br />
si evince che “tutte le comunità linguistiche hanno uguali diritti” e che non sono ammissibili discriminazioni<br />
nei loro confronti su qualsiasi criterio esse possano essere basate. In altri termini,<br />
a tutte le lingue viene riconosciuta pari dignità, a prescindere dal loro livello di codificazione,<br />
standardizzazione, sviluppo o dal loro status giuridico all’interno dei singoli Stati, ai quali si<br />
chiede di prendere tutte le misure atte a garantire in modo efficace tale uguaglianza (art. 10).<br />
Come sarà confermato anche dal seguito della dichiarazione, l’estrema conseguenza di<br />
tale impostazione può configurarsi nel rifiuto, o, secondo il punto di vista, nel superamento del<br />
concetto di lingua ufficiale, soprattutto ove si consideri che il successivo art. 10 afferma che, al<br />
fine di garantire l’esercizio effettivo dei diritti enunciati nella dichiarazione, “tutte le comunità linguistiche”<br />
- dunque indipendentemente dal numero degli appartenenti e da qualsiasi altra considerazione<br />
- “hanno il diritto di disporre di tutti i possibili mezzi di traduzione da e per altre lingue”.<br />
239
D’altra parte il diritto all’uso della propria lingua materna viene riconosciuto alle “persone<br />
appartenenti alle minoranze nazionali” da tutti i documenti internazionali in materia di tutela<br />
delle minoranze stesse, i quali però distinguono implicitamente, in linea di principio, diversi livelli<br />
di esercizio di tale diritto, in relazione a diversi fattori tra cui il riconoscimento o meno dello status<br />
di minoranza nazionale alla popolazione interessata e la consistenza numerica della stessa.<br />
Questi distinguo sono invece del tutto estranei alla dichiarazione in esame che, anzi, nel<br />
riconoscere l’uguaglianza formale e sostanziale tra tutte le lingue, arriva ad enunciare il dritto di<br />
“tutti” a conoscere la lingua specifica del territorio di residenza e di essere poliglotti, condizione<br />
quest’ultima che, nel contesto delineato dal documento, è presupposto indispensabile a garantire<br />
il raggiungimento del proprio sviluppo personale e la mobilità sociale (art. 13), in quanto consente<br />
alla persona di muoversi con relativa facilità e senza dover ricorrere alla traduzione, in<br />
uno spazio sociale spiccatamente multilingue. Come emergerà più chiaramente nel seguito, tuttavia,<br />
tra tali affermazioni teoriche, che in linea di principio possono anche trovarci tutti<br />
d’accordo, e la loro attuabilità pratica, la distanza è notevole, per una serie di motivi che vanno<br />
da quelli puramente economico-finanziari, legati al costo che questi processi comporterebbero<br />
per gli Stati, fino a quelli più immediati, relativi ad una eccessiva macchinosità che i meccanismi<br />
di garanzia innescati introdurrebbero in tutti i livelli di rapporto sociale.<br />
Titolo II<br />
Il titolo secondo, articolato in 4 sezioni, comprende gli articoli da 15 a 52, che prendono<br />
in esame nel dettaglio le diverse implicazioni dell’esercizio dei diritti enunciati in precedenza nei<br />
diversi campi della vita sociale.<br />
La sezione I (artt. 15-22) è dedicata ai rapporti tra comunità linguistiche ed amministrazione<br />
ed enti ufficiali.<br />
In sostanza si afferma che le comunità linguistiche hanno il diritto di usare “la propria<br />
lingua nel proprio territorio’’, in tutti i loro rapporti con le autorità e gli enti ufficiali (art. 151), come<br />
pure in quelli con le autorità giudiziarie del loro territorio (art. 20). In quest’ultimo caso, viene<br />
specificato che quando, per qualunque motivo, un procedimento giuridico iniziato in un determinato<br />
territorio ed in una determinata lingua viene spostato altrove, esso deve essere continuato<br />
nella lingua originale (viene ovviamente salvaguardato il diritto dei cittadini di essere processati<br />
in una lingua che conoscono e con l’assistenza gratuita di un interprete).<br />
Ne consegue l’affermazione della piena validità ed efficacia degli atti giuridici ed amministrativi,<br />
come pure dei documenti pubblici e privati redatti nella lingua di una determinata comunità<br />
linguistica, che ha pertanto il diritto che la propria lingua venga usata anche per la stesura<br />
degli atti dei pubblici registri.<br />
Ciò vale anche per tutte le leggi locali e dello Stato, indipendentemente dalla consistenza<br />
numerica delle comunità linguistiche considerate. La sezione 2 (artt. 23-30) affronta un tema<br />
cardine per la salvaguardia e lo sviluppo delle lingue e culture di minoranza, quello<br />
dell’istruzione.<br />
Partendo dall’affermazione che l’istruzione “deve contribuire a promuovere la capacità<br />
di espressione linguistica e culturale della comunità linguistica del territorio dove viene impartita”<br />
e che deve contribuire al mantenimento ed allo sviluppo di tale lingua e cultura, mettendosi al<br />
servizio della comunità e nella prospettiva della realizzazione di un sistema di relazioni armoniose<br />
tra le varie comunità linguistiche viene affermato il principio che “tutti hanno il diritto di imparare<br />
qualsiasi lingua”. Principio che, in sé, è ovviamente ben difficile contestare. Si può obbiettare,<br />
tuttavia, che posto in questa maniera, suscita qualche perplessità non tanto riguardo al<br />
soggetto del diritto, quanto piuttosto riguardo a chi debba creare le condizioni perché tale diritto<br />
possa essere esercitato.<br />
È evidente, infatti, e ciò vale anche per altri diritti enunciati nella dichiarazione , come ad<br />
esempio il diritto già citato ad essere poliglotti, che debba un qualche interlocutore istituzionale,<br />
con tutta la probabilità identificabile con lo Stato, preoccuparsi di creare le condizioni per<br />
l’esercizio del diritto ed al quale dunque il cittadino possa rivolgersi per chiederne l’intervento<br />
ove ritenga che tali condizioni non siano garantite.<br />
Allo stesso modo, ci si può chiedere se garantire le condizioni per l’esercizio di tali diritti<br />
implichi per il cittadino la gratuità della opzione offertagli e dunque, per lo Stato, l’assunzione<br />
degli oneri finanziari relativi. Poiché l’impostazione della dichiarazione tende a fornire a tale do-<br />
240
manda una risposta affermativa, ecco emergere ancor una volta quello che è probabilmente il<br />
principale punto debole del documento, cioè un insufficiente senso della realtà ed una insufficiente<br />
preoccupazione per gli aspetti pratici correlati ai principi, pur teoricamente sacrosanti,<br />
che vengono enunciati.<br />
In sostanza, nessuno Stato sarebbe in grado di farsi carico degli oneri finanziari derivatagli<br />
dai diritti fin qui enunciati, nella forma, in cui gli viene chiesto di garantirne l’esercizio.<br />
La sezione II (art. 23-30) proclama i diritti che le comunità linguistiche godono nel campo<br />
dell’istruzione la quale deve “promuovere la capacità di espressione linguistica e culturale<br />
della comunità linguistica del territorio dove viene impartita” ed a “mantenere e sviluppare la lingua<br />
parlata dalla diversità linguistica e culturale”, nel quadro di un sistema di relazioni armoniose<br />
tra le comunità linguistiche di tutto il mondo (art. 23)”.<br />
Per il perseguimento di questi obiettivi viene lasciato alle comunità linguistiche di decidere<br />
in quale misura la propria lingua debba essere presente a tutti i livelli del sistema di istruzione<br />
del proprio territorio come lingua veicolare e/o di studio (art. 24), fermo restando che devono<br />
essere loro garantite tutte le risorse umane e materiali necessarie a consentire la presenza<br />
della propria lingua nel sistema educativo del proprio territorio, nella misura e secondo le<br />
modalità che avranno liberamente scelto (art. 25).<br />
Gli articoli successivi della sezione sono, in qualche modo, uno sviluppo dei precedenti,<br />
in quanto enunciano il diritto delle comunità linguistiche ad un’istruzione che permetta ai loro<br />
membri una perfetta padronanza della propria lingua in tutti i suoi ambiti d’uso, con la precisazione<br />
che essi membri devono essere posti in condizioni di apprendere qualsiasi altra lingua<br />
che desiderino conoscere (ci si riallaccia, in sostanza, al diritto già enunciato alla poliglossia), la<br />
conoscenza di qualsiasi altra lingua connessa alla propria tradizione culturale, la conoscenza il<br />
più approfondita possibile dei rispettivi patrimoni culturali e di ogni altra cultura che desiderino<br />
conoscere (artt. 26-28).<br />
L’art. 29 appare come una ripetizione dell’art. 24, con un mutamento però di prospettiva:<br />
il soggetto del “diritto a ricevere un’istruzione nella lingua specifica del territorio di residenza”<br />
non è più la comunità linguistica, ma il singolo individuo. Ciò tenderebbe a suggerire una interpretazione<br />
di tale articolo non più incentrata sulle comunità linguistiche o sui loro membri quanto<br />
su ciascun individuo che si trovi a risiedere nel territorio specifico di una determinata comunità<br />
linguistica, indipendentemente dalla sua appartenenza o meno a tale comunità.<br />
Tale interpretazione, che tuttavia non ci sentiamo di sostenere con convinzione, potrebbe<br />
trovare un’ulteriore avallo nel comma2 dello stesso articolo, laddove si afferma che ciò non<br />
esclude il diritto di acquisire la conoscenza orale o scritta di qualsiasi altra lingua utile a comunicare<br />
con altre comunità.<br />
La sezione III tratta dei nomi propri, enunciando i diritti delle comunità linguistiche a<br />
preservare ed usare il proprio sistema di nomi in tutti gli ambiti e le occasioni (art. 31), diritto<br />
questo che viene successivamente esplicitato nel dettaglio come diritto ad usare i toponimi espressi<br />
nella lingua del territorio, a tutti i livelli , anche ufficiali, conservando, istituendo ed aggiornando<br />
i toponimi autoctoni, che non possono essere sostituiti, adattati od aboliti per nessuna<br />
ragione, (art. 32); diritto a definirsi con il proprio nome e non con sue traduzioni od adattamenti<br />
(art. 32); diritto a definirsi con il proprio nome e non con sue traduzioni od adattamenti<br />
(art. 33); diritto di tutti ad usare il proprio nome e cognome nella propria lingua e ad averne,<br />
quando necessario, una precisa trascrizione fonetica (art. 34).<br />
Il contenuto di questa sezione non va, nel concreto, molto al di là di quanto già riconosciuto<br />
dai documenti internazionali già esistenti in materia di tutela delle minoranze nazionali,<br />
etniche culturali o religiose, se non per l’impostazione di fondo.<br />
La sezione IV tratta dei diritti delle comunità linguistiche nel campo dei mezzi di comunicazione<br />
e delle nuove tecnologie.<br />
Viene in primo luogo ribadito, come nel campo dell’istruzione, che spetta alle comunità<br />
linguistiche decidere in quale misura le rispettive lingue debbano essere presenti nei mezzi di<br />
comunicazione dei rispettivi territori, indipendentemente dal tipo di mezzo (art. 35). Perché tale<br />
obiettivo possa essere realizzato, le comunità linguistiche hanno il diritto di poter disporre di tutte<br />
le risorse umane e materiali necessarie (art. 36).<br />
Inoltre, i mezzi di comunicazione devono garantire alle comunità linguistiche<br />
un’informazione approfondita sui rispettivi patrimoni culturali, come pure su qualsiasi altra cultura<br />
che ai loro membri interessi conoscere (art. 37) ed ogni lingua e cultura deve ricevere dai<br />
241
mezzi di comunicazione un trattamento “equo e non discriminatorio”. (art. 38).<br />
Il parziale pleonasmo già rilevato a proposito della sezione sull’istruzione si ripete in<br />
qualche modo anche in questa sede; infatti l’art. 39 ribadisce il diritto delle comunità linguistiche<br />
ad un’equa presenza della rispettiva lingua nei mezzi di comunicazione già ampiamente enunciato,<br />
allargandolo però ora anche ai gruppi linguistici, e precisando che tale diritto deve essere<br />
esercitato “in armonia con i diritti degli altri gruppi o comunità linguistiche presenti sul territorio”.<br />
Facendo riferimento poi alle moderne tecnologie dell’informazione, si afferma il diritto<br />
delle comunità linguistiche a disporre di attrezzature adattate ai propri sistemi linguistici (art.<br />
40).<br />
La sezione V (artt. 41-46) ha per oggetto la cultura e punta a garantire alle comunità<br />
linguistiche l’uso della propria in tutte le forme di espressione culturale, a garantirle dalla egemonia<br />
di lingue e culture straniere (art. 41), ad assicurare loro il pieno sviluppo culturale (art. 43)<br />
e l’accesso alle opere nelle rispettive lingue (art. 44).<br />
Alle comunità linguistiche viene, inoltre, riconosciuto il diritto ad accedere a programmi<br />
interculturali, a godere dei supporti necessari all’insegnamento della propria lingua a stranieri, o<br />
per altre attività quali traduzioni, doppiaggio, ecc., che consentano la fruizione nella propria lingua<br />
di prodotti culturali alloglotti (art. 44), ad occupare con la loro lingua una posizione preminente<br />
nelle manifestazioni e nei servizi culturali (art. 45) ed ovviamente alla conservazione del<br />
proprio patrimonio linguistico e culturale, anche attraverso attività di raccolta di documenti, opere<br />
d’arte, ecc. che riguardino specificamente la loro cultura. I diritti enunciati in questa sezione,<br />
sebbene esplicitati molto in dettaglio, non aggiungono molto di nuovo, se non il punto di vista<br />
riguardante i diritti che in campo culturale vengono riconosciuti alle minoranze nazionali (o linguistiche)<br />
nei documenti internazionali già esistenti in materia.<br />
Nella sezione VI (art. 47-52) viene affrontato il tema dei diritti delle comunità linguistiche<br />
attinenti alla sfera socio-economica.<br />
Anche a questo riguardo, si fa leva soprattutto sul diritto all’uso della propria lingua in<br />
tutte le attività e in tutti i rapporti di tale natura, nel territorio di pertinenza delle comunità linguistiche.<br />
In sostanza, esse devono poter disporre nelle rispettive lingue di tutti i mezzi necessari<br />
allo svolgimento delle attività professionali. Ciò implica che abbiano a disposizione nella propria<br />
lingua documenti, opere di consultazione, istruzioni, attrezzature informatiche, moduli, formulari<br />
e quant’altro sia necessario, essendo l’uso di altre lingue giustificato solo “dalla natura<br />
dell’attività professionale interessata”.<br />
L’art. 47, che contiene queste prescrizioni, recita anche che “in nessun caso l’uso di una<br />
lingua introdotta più di recente può ridurre o sostituire l’uso della lingua specifica del territorio”<br />
nell’espletamento di tali attività.<br />
Ne consegue che alle lingue specifiche di ciascun territorio viene riconosciuta piena validità<br />
giuridica nelle transazioni economiche di tutti i tipi e che tale validità non può essere limitata<br />
da clausole private di alcun genere, come pure che le comunità linguistiche abbiano a propria<br />
disposizione nella propria lingua tutti i documenti e gli strumenti necessari allo scopo (art. 48).<br />
Parimenti, la lingua specifica di un territorio verrà usata in tutti i tipi di organizzazione<br />
socio-economica, da quelle sindacali alle aziende, alle associazioni professionali (art. 49) ed<br />
occuperà uno spazio preminente nella pubblicità, nella segnaletica ed in quant’altro contribuisce<br />
a creare l’immagine del paese. Inoltre le comunità linguistiche hanno il diritto di ricevere nella<br />
propria lingua tutte le informazioni scritte ed orali relative a prodotti e servizi che vengano distribuiti<br />
all’interno del loro territorio, comprendendo in ciò istruzioni per l’uso, elenchi di ingredienti,<br />
etichette, pubblicità, ecc. e nella lingua del territorio, a condizioni non inferiori a quelle di qualsiasi<br />
altra lingua, saranno anche, al suo interno, gli annunci pubblici riguardanti la sicurezza (art.<br />
50).<br />
I due articoli successivi enunciano il diritto di “tutti” ad usare la lingua specifica del territorio<br />
nei rapporti con aziende, imprese commerciali, enti privati ecc. e a ricevere risposta nella<br />
medesima lingua, come pure a ricevere informazioni nella lingua specifica del territorio da parte<br />
degli enti aperti al pubblico (art. 51) e ad espletare le proprie attività professionali nella stessa<br />
lingua, a meno dei casi in cui non venga richiesto diversamente dalle funzioni strettamente inerenti<br />
alla professione svolta (art. 52).<br />
Balza evidente, ad una analisi anche superficiale, l’ampiezza dei diritti che alle lingue<br />
tradizionalmente dette “di minoranza” vengono riconosciuti dalla dichiarazione, e che nel quadro<br />
242
di una autentica democrazia del diritto trova piena e legittima giustificazione.<br />
D’altra parte, come già sottolineato in precedenza, non può essere sottovalutato<br />
l’impatto che una eventuale piena attuazione della dichiarazione avrebbe nella vita sociale ed<br />
economica degli Stati e di tutte le parti coinvolte.<br />
In sostanza, si tratterebbe di ricostruire l’intero sistema di relazioni sociali sulla base di<br />
un plurilinguismo assolutamente radicale, che arriva a mettere in crisi, anche sul piano giuridico,<br />
oltre che su quello pratico, il concetto stesso di lingua ufficiale. Il che potrebbe anche, in linea di<br />
principio, risultare accettabile, se non implicasse un costo economico che difficilmente uno Stato,<br />
per quanto ricco, potrebbe permettersi di sostenere. Senza contare che tale sforzo non viene<br />
richiesto solo al settore pubblico. ma anche alle imprese ed agli enti privati che operano sia su<br />
scala interna che internazionale e che dovrebbero, ad esempio, adattarsi a fornire istruzioni per<br />
l’uso di prodotti e servizi in un numero verosimilmente altissimo di lingue, con un forte aggravio<br />
di costi, che finirebbero per ricadere sul consumatore /utente.<br />
Sul piano più strettamente giuridico, inoltre, obiezioni alla dichiarazione sono già state<br />
sollevate, ad esempio, a proposito della libertà di contratto, che verrebbe in qualche modo limitata<br />
dall’art. 48, relativamente alla libera decisione delle parti sulla lingua da usare nella redazione<br />
dei contratti. Il comma 2 di tale articolo, inoltre, renderebbe inefficace ed addirittura illegittima<br />
la clausola normalmente prevista nei contratti internazionali, secondo la quale, in caso di<br />
vertenza, l’interpretazione di un contratto bilingue si fondi su una sola delle versioni.<br />
Vero è che l’art. 24, a proposito del sistema di istruzione, stabiliva che “tutte le comunità<br />
linguistiche hanno il diritto di decidere in che misura le rispettive lingue devono essere presenti<br />
(...) nel sistema di istruzione nel proprio territorio (...)” e che tale principio di discrezionalità delle<br />
comunità linguistiche può essere esteso ad altri settori, ma è anche lecito supporre che nessuna<br />
comunità linguistica rinuncerebbe di propria iniziativa all’esercizio di un diritto riconosciuto.<br />
Disposizioni integrative<br />
Disposizioni finali<br />
Le disposizioni integrative comprendono tre punti, che stabiliscono quali sono i compiti<br />
che all’atto della sottoscrizione della dichiarazione si assumono le autorità pubbliche.<br />
Impegnandosi a garantire l’esercizio dei diritti proclamati, le autorità pubbliche dovranno<br />
procedere alla costituzione di fondi internazionali, le cui risorse saranno destinate alle comunità<br />
linguistiche, finalizzandole alla creazione delle condizioni che ne consentano l’esercizio, fornendo<br />
anche i supporti necessari alla codificazione, trascrizione, insegnamento ed uso amministrativo<br />
delle lingue, ove ciò non sia già in atto.<br />
Esse inoltre si impegnano ad informare le persone sui diritti e doveri derivanti dalla dichiarazione,<br />
e stabiliscono, infine, le sanzioni relative a violazioni della dichiarazione stessa.<br />
Il primo punto delle disposizioni finali propone la creazione di un “consiglio linguistico” in<br />
seno all’Onu. Di questo è dato mandato all’assemblea generale, che ne stabilirà i compiti e ne<br />
nominerà i membri, come pure provvederà a creare un ente di diritto internazionale, cui sarà<br />
demandata la tutela delle comunità linguistiche rispetto alle violazioni della dichiarazione. Nel<br />
secondo punto, viene raccomandata la creazione di una “Commissione mondiale per i diritti linguistici”,<br />
come ente non ufficiale e consultivo, di cui facciano parte rappresentanti di organizzazioni<br />
non governative e di altre organizzazioni che si occupino di diritto linguistico.<br />
Conclusione<br />
Si è già accennato che la differenza fondamentale tra la dichiarazione universale dei diritti<br />
linguistici e gli altri documenti o convenzioni internazionali in materia di tutela delle minoranze<br />
è l’inversione del punto di vista: non più cioè le autorità che riconoscono diritti e concedono<br />
tutela, ma le comunità linguistiche, in quanto tali, che hanno dei diritti e le autorità che si impegnano<br />
a garantirne l’esercizio.<br />
La portata rivoluzionaria di questo approccio risulterà più evidente ove si osservi che<br />
esso implica la rinuncia al concetto stesso di popolazione maggioritaria e di popolazione minoritaria<br />
e dunque di lingua maggioritaria e di lingua minoritaria, con tutto quello che sul piano teorico<br />
e pratico ne consegue, fino al già accennato superamento del concetto di lingua ufficiale.<br />
Un altro aspetto importante della dichiarazione è che essa afferma che i diritti linguistici<br />
sono a un tempo “individuali e collettivi”, laddove la scelta operata finora dagli organismi internazionali<br />
che si sono occupati di difesa delle minoranze etniche, linguistiche, ecc. è stata di<br />
243
considerare tali diritti di natura esclusivamente individuale. Sul piano dell’espressione, per indicare<br />
il soggetto dei diritti, la dichiarazione universale dei diritti linguistici adotta la formula “le<br />
comunità linguistiche” quando il riferimento è a diritti collettivi, e la formula “tutti”, quando invece<br />
fa riferimento a diritti individuali. In tutti gli altri documenti internazionali riferibili a tale materia, i<br />
soggetti del diritto sono definiti sempre con la formula “le persone appartenenti alle minoranze<br />
nazionali (o etniche, o linguistiche, ecc.)”.<br />
Ciò costituisce un indubbio progresso rispetto ai risultati finora conseguiti dal dibattito<br />
internazionale in materia e formalizzati nelle convenzioni e nei vari documenti sulla tutela delle<br />
minoranze nazionali, etniche ecc., in quanto pone fine ad un equivoco, o meglio rifiuta chiaramente<br />
un espediente diplomatico, quello di porre l’accento sul diritto individuale, ignorando la<br />
natura chiaramente collettiva dei diritti delle popolazioni minoritarie, spesso usato per aggirare<br />
la reticenza di molti Stati ad affrontare apertamente la questione delle minoranze sul proprio territorio.<br />
Poiché, infatti, la questione si pone per la sua stessa forza intrinseca in maniera sempre<br />
più pressante e, in alcune realtà, anche drammatica è utile che venga ricondotta nel suo binario<br />
naturale e su questa base ridiscussa e risolta.<br />
Il documento cerca, inoltre, di coniugare in un unico testo i diritti delle comunità linguistiche<br />
e quelli dei gruppi linguistici.<br />
A questo tentativo di soluzione unica, contrapposto alla scelta fin qui operata dagli organismi<br />
internazionali di procedere alla formulazione di convenzioni od altri atti separati per le<br />
due realtà, non corrisponde però, nella dichiarazione, uniformità di trattamento tra i due tipi di<br />
minoranze. Anzi, mentre la tutela che dai principi enunciati deriva alle comunità linguistiche può<br />
essere legittimamente definita radicale, per i gruppi linguistici non si va oltre i livelli di tutela già<br />
riconosciuti, accettando in questo caso senza alcun tentativo di innovazione il dato esistente.<br />
A conferma di ciò si noti la sproporzione esistente nel numero di citazioni di “comunità<br />
linguistiche” e di “gruppi linguistici”. Oltre che nell’art. 2 comma 5, che li definisce, questi ultimi<br />
vengono menzionati solo nell’art. 2, che definisce i rapporti tra esse e le comunità linguistiche<br />
con cui condividono il territorio, nell’art. 3 comma 2, in cui gli viene riconosciuto il diritto<br />
all’insegnamento della propria lingua (non nella propria lingua), il diritto di accesso ai servizi culturali<br />
e quello alla “presenza equa della propria lingua e cultura nei mezzi di comunicazione” e “<br />
ad essere sentiti nella propria lingua da enti governativi e in rapporti socioeconomici” e nell’art.<br />
39, ancora a proposito della loro lingua nei mezzi di comunicazione del territorio dove sono stabiliti<br />
o dove sono emigrati”.<br />
Di altri lati discutibili del documento, come dei suoi pregi, si è parlato nel corso del suo<br />
esame. Qui si vuole ritornare brevemente su quella che è l’obiezione principale mossa, e che,<br />
vista sul piano dei principi, può anche costituire il suo principale pregio, cioè il suo eccessivo idealismo.<br />
In sostanza, la dichiarazione prescinde in maniera pressoché totale dagli aspetti pratici<br />
legati alla sua applicazione, sia sul piano puramente economico, come aggravio abnorme e insostenibile<br />
di costi a carico delle amministrazioni statali interessate, sia su quello<br />
dell’organizzazione sociale e della convivenza civile, che si può immaginare verrebbero complicate<br />
a dismisura dal radicalismo plurilinguistico.<br />
Sono queste le ragioni principali per cui essa incontrerà verosimilmente molte difficoltà<br />
ad essere accolta nella sua forma attuale dagli organismi internazionali, in primo luogo<br />
l’Unesco, ai quali è stata proposta.<br />
Nonostante questo, la Dichiarazione universale dei diritti linguistici costituisce un passo<br />
fondamentale nel dibattito internazionale sul tema dei diritti linguistici, come primo tentativo di<br />
affrontare in modo nuovo un problema che si affaccia all’attenzione mondiale in modo sempre<br />
più pressante e con sempre nuove implicazioni.<br />
Per tale motivo essa fornisce un’utile base di discussione per ulteriori approfondimenti,<br />
nella prospettiva dell’impostazione di una politica linguistica internazionale più avanzata e veramente<br />
rispettosa dei diritti di tutte le comunità, la quale, per essere veramente tale, e non vana<br />
utopia, non può non tener conto anche del fattore economico sotteso e della necessità di<br />
non caricare di eccessivi aggravi, anche formali, la convivenza civile, oltre che non essere in<br />
conflitto con le norme del diritto internazionale vigenti in altri settori.<br />
244
LE MINORANZE LINGUISTICHE NEL DIRITTO INTERNAZIONALE<br />
1. La protezione internazionale delle minoranze: aspetti generali.<br />
Nel diritto internazionale, a partire dal secolo scorso, si è assistito ad un progressivo fenomeno<br />
di sensibilizzazione verso il problema riguardante la protezione, da parte dei vari Stati,<br />
delle caratteristiche etniche, religiose e linguistiche che distinguono dal resto della popolazione<br />
determinati gruppi etnici 32 .<br />
La mancanza di una definizione universalmente riconosciuta del concetto di minoranze<br />
non è stata di ostacolo alla creazione di norme internazionali, capaci di evitare discriminazioni e<br />
di fornire una adeguata tutela delle minoranze in campo internazionale 33 .<br />
Gli ultimi anni, in particolar modo, hanno registrato in tutta Europa un risveglio del sentimento<br />
nazionale dei popoli, che sono tornati a rivendicare con forza il diritto della propria identità<br />
etnica e culturale, spingendo non di rado le proprie rivendicazioni fino alla richiesta di<br />
un’ampia autonomia amministrativa all’interno delle unità statali in cui sono compresi, o addirittura<br />
alla richiesta di uno stato politico i cui confini siano coincidenti con quelli della nazione etnica.<br />
Sulla scorta dei principi affermati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo,<br />
successivamente ribaditi dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e<br />
delle libertà fondamentali, dai Patti internazionali sui diritti dell’uomo, dagli atti conclusivi della<br />
CSCE di Helsinki e da latri documenti internazionali sulla stessa tematica, è venuta maturando,<br />
a partire dagli ultimi decenni, una concezione diversa da quella precedente.<br />
Nella presenza, all’interno degli Stati, di etnie diverse da quella maggioritaria o comunque<br />
dominante, non si vede più una minaccia all’unità nazionale, ma un patrimonio di cultura<br />
appartenente all’intera collettività e come tale da tutelare contro ogni tentativo di omologazione<br />
forzata. Tutto ciò non solo in virtù dei principi proclamati in tutti i documenti internazionali menzionati,<br />
ma anche per il valore intrinseco che esse rivestono nel patrimonio storico e culturale<br />
dei singoli Stati.<br />
Nonostante i processi scaturiti dalla caduta dei regimi comunisti dell’Est, che hanno assunto<br />
spesso i toni di guerre interetniche, nonostante i fenomeni anche gravi di intolleranza razziale<br />
e la nascita di veri e propri movimenti xenofobi in Occidente, non si può non prendere atto<br />
della costituzione multietnica degli Stati Europei, o quanto meno della presenza sul loro territorio<br />
di più o meno consistenti gruppi etnici minoritari, i cui appartenenti in base ai diritti universalmente<br />
riconosciuti della persona umana hanno diritto alla tutela della loro identità linguistica<br />
e culturale.<br />
Un passo in avanti rispetto ai documenti precedenti è senz’altro costituito dalla Carta<br />
europea delle minoranze, elaborata in sede di Consiglio d’Europa, così come è pure da sottolineare<br />
la proposta avanzata in sede di CSCE di una Carta dei diritti dei popoli, proposta che va<br />
ora concretizzandosi, in sede di Consiglio d’Europa, con l’elaborazione di una Convenzione sui<br />
diritti fondamentali delle minoranze etniche in Europa.<br />
Rimandando ai prossimi paragrafi l’esame di tali documenti e dei principi fondamentali<br />
enunciati nell’ambito delle Nazioni Unite, è importante rilevare come in questa materia, dove la<br />
cooperazione tra i vari Paesi assume un’importanza primaria, spetti ai singoli Stati dare concreta<br />
attuazione ai principi concordati in sede internazionale, tramite gli opportuni strumenti legislativi<br />
e amministrativi.<br />
2. Le minoranze nell’ambito delle Nazioni Unite.<br />
Le Nazioni Unite, pur non rimanendo indifferenti alla problematica della tutela minoritaria,<br />
hanno preferito rinviarne per molto tempo la risoluzione, date le difficoltà “di adottare una<br />
soluzione uniforme di questa questione complessa e delicata, la quale riveste aspetti particolari<br />
in ciascuno degli Stati in cui si pone” 34 . Nella Dichiarazione universale, infatti, non viene fatto<br />
32<br />
Cfr. De Nova R., Protezione internazionale delle minoranze e diritti dell’uomo, in Dir. Intern., 1996, I,<br />
pag. 3 e segg.<br />
33<br />
Per un esame delle varie definizioni di minoranza vedi: Rapporto di sintesi preparato dall’istituto<br />
dell’Enciclopedia Italiana di concerto con la Commissione delle Comunità Europee, “Le minoranze linguistiche<br />
nei Paesi della Comunità Europea”, Lussemburgo, 1985, pag. 10 e segg.<br />
34<br />
Cfr. Risoluzione n. 217 del 10.12.1948 adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU.<br />
245
alcun riferimento alle minoranze, ma ci troviamo di fronte ad una protezione universale dei diritti<br />
dell’uomo 35 ; l’art. 2 della Dichiarazione parla per tutti gli esseri umani di “uguaglianza di trattamento,<br />
indipendentemente dalla loro appartenenza a particolari gruppi religiosi, etnici o linguistici”.<br />
Successivamente fu creato dalle Nazioni Unite un organo ad hoc, la Sottocommissione<br />
per la lotta contro le misure discriminatorie e la protezione delle minoranze della Commissione<br />
dei diritti dell’uomo; tale organo dal 1946 (anno della sua nascita) fino al 1971 è riuscito a produrre<br />
un solo tangibile risultato per ciò che concerne la protezione delle minoranze: creazione<br />
del testo di quello che sarebbe divenuto l’art. 27 del Patto universale sui diritti civili e politici.<br />
L’art. 27 del patto universale (approvato nel 1961 da parte dell’Assemblea Generale<br />
come art. 25), che inserisce una forma di protezione specifica delle minoranze, enuncia chiaramente<br />
che ogni singolo individuo ha il diritto di scegliere se far parte di un gruppo minoritario,<br />
ciò con l’impegno dei vari Stati di non ostacolare, ma anzi d’impegnarsi nella conservazione della<br />
identità religiosa, culturale, etnica e linguistica di tale gruppo. Siamo in presenza di un diritto<br />
non “collettivo”, ma attribuito dalla norma ad ogni individuo appartenente ad una minoranza;<br />
non viene, quindi, tutelata la minoranza come autonomo soggetto di diritti specifici, ma<br />
l’individuo in quanto membro del gruppo minoritario e libero, perciò, di scegliere se avvalersi dei<br />
“privilegi” accordati ai membri di una minoranza.<br />
Nel 1971 fu intrapreso uno studio particolare nel campo delle minoranze, che portò, dopo<br />
vari approfondimenti, alla elaborazione di un “progetto di dichiarazione dei diritti delle persone<br />
appartenenti a minoranze nazionali od etniche, religiose o linguistiche 36 , il quale, approvato il<br />
21 febbraio 1992 dalla Commissione dei diritti dell’uomo, è stato portato in seguito all’attenzione<br />
dell’Assemblea Generale e da questa approvato all’unanimità il 18 dicembre 1992.<br />
3. La Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa.<br />
A partire dal suo primo atto principale, l’Atto di Helsinki del 1975 (il cui VII principio così<br />
recita: “Gli Stati partecipanti, sul cui territorio esistono minoranze nazionali, rispettano il diritto<br />
delle persone che appartengono a queste minoranze, con l’eguaglianza davanti alla legge,<br />
danno ad esse l’intera possibilità di godere effettivamente dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali<br />
e proteggono in tal modo i loro interessi legittimi in questo campo”) la CSCE, anche<br />
se in un’area più circoscritta, si è occupata del problema delle minoranze in maniera analitica e<br />
dettagliata.<br />
Tra gli altri documenti è importante citare quello approvato a Vienna nel 1989 che stabilisce<br />
i principi della protezione delle identità minoritarie, il cui diciannovesimo comma così si esprime:<br />
“Gli Stati proteggeranno l’identità etnica, culturale, linguistica e religiosa delle minoranze<br />
nazionali sul loro territorio ed instaureranno condizioni favorevoli alla promozione di queste identità”.<br />
La sempre maggiore attenzione che la CSCE ha dedicato al problema delle minoranze<br />
nazionali, può essere riassunta nel principio contenuto nel Rapporto di Ginevra e confermato<br />
nel Documento di Mosca, secondo cui “i problemi concernenti le minoranze nazionali, nonché<br />
l’osservazione degli obblighi e degli impegni internazionali sono questioni di legittimo interesse<br />
internazionale e di conseguenza non costituiscono un affare interno del rispettivo Stato”.<br />
La CSCE e gli Stati ad essa partecipanti hanno a disposizione un codice di comportamento<br />
per gli Stati e per i popoli europei e nordamericani, che contiene precisi impegni politici<br />
destinati, ove necessario, a determinare mutamenti importanti nelle istituzioni e nelle strutture<br />
giuridiche degli Stati.<br />
Confrontando le rispettive esperienze maturate in materia di minoranze, l’Italia rappresenta<br />
senza dubbio un caso singolare, come risulta da quanto esposto nei capitoli precedenti.<br />
Qui basta ribadire come nell’ordinamento costituzionale italiano il concetto di “minoranza” è legato<br />
a quello di “lingua” o meglio di “minoranza linguistica” come prevede l’art. 6 della Costituzione.<br />
Come abbiamo visto, in questo quadro istituzionale, riferito alle minoranze linguistiche, si<br />
ravvisano nel territorio italiano tre ordini di realtà diverse con forme differenziate di protezione.<br />
35 Anche lo Statuto dell’ONU, d’altra parte, non contiene alcun cenno ai diritti delle minoranze.<br />
36 L’art. 1, mettendo in evidenza il carattere universale di tale Dichiarazione, stabilisce: “Gli Stati proteggono<br />
l’esistenza e l’identità nazionale od etnica, culturale, religiosa e linguistica delle minoranze neri loro rispettivi<br />
territori e favoriscono lo sviluppo delle condizioni idonee a promuovere queste identità”.<br />
246
4. Consiglio d’Europa: la Carta europea delle lingue regionali e/o minoritarie.<br />
Elaborata in sede di Consiglio d’Europa, la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie<br />
ha costituito senz’altro un notevole passo in avanti rispetto ai documenti precedenti. Essa<br />
è stata approvata nel febbraio 1992, dopo un lungo lavoro di elaborazione da parte di esperti,<br />
sotto forma di convenzione.<br />
L’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa aveva, fin dal 1981, posto in evidenza<br />
l’importanza della tutela delle molteplici lingue come “difesa del patrimonio culturale europeo”,<br />
minacciato nella sua ricchezza e varietà da un processo di “omologazione di usi linguistici”.<br />
La Carta, alla cui elaborazione ha partecipato anche il nostro Paese, è composta da 5<br />
parti e da un preambolo; in quest’ultimo è descritto sinteticamente lo scopo del Consiglio<br />
d’Europa: cercare di realizzare una intesa tra i suoi membri per poter valorizzare il comune patrimonio<br />
culturale e d’idee, nella consapevolezza di una esistenza di pluralità di lingue come<br />
parte essenziale di questo patrimonio; tutto ciò tenendo conto delle diverse situazioni delle lingue<br />
minoritarie e/o regionali. In quest’ottica la Carta contiene, oltre la previsione di non discriminazione<br />
nei confronti dell’uso di tali lingue, misure idonee soprattutto a porsi come promotrici<br />
dell’impiego delle varie lingue minoritarie (ciò soprattutto nel campo scolastico e giudiziario).<br />
Il nostro Paese, che come abbiamo detto è stato partecipe all’elaborazione di tale Carta,<br />
ha recepito nella legge-quadro riguardante “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche”,<br />
più volte menzionata, i principi fondamentali della Carta Europea delle minoranze,<br />
pur discostandosene in alcuni punti.<br />
Infatti, pur ammettendo l’importanza dell’insegnamento, diverse sono le forme previste<br />
nel progetto citato, ma l’unico punto in cui si discosta notevolmente dalle previsioni della Carta è<br />
l’uso delle lingue minoritarie nei processi.<br />
In tale campo la legge-quadro è coerente con il Ministero di Giustizia, che ha rilevato il<br />
carattere eccessivamente macchinoso e di difficile attuazione del dispositivo riguardante l’uso<br />
delle lingue minoritarie nei processi (art. 8 del testo del 1991 della Carta), ritenendo sufficiente<br />
salvaguardia delle minoranze linguistiche il ricorso all’art. 109 del nuovo codice di procedura<br />
penale e la prestazione gratuita dell’interprete ove non ricorrano le condizioni previste per<br />
l’applicazione dell’art. 109 c.p.p. e il cittadino non conosca la lingua italiana.<br />
L’art. 109 prevede, infatti, che il cittadino italiano appartenente ad una minoranza linguistica<br />
riconosciuta ha diritto di esprimersi nella propria lingua davanti all’autorità giudiziaria avente<br />
competenza sul territorio proprio della minoranza, ma non esiste alcun articolo corrispondente<br />
per il processo civile, ed, ove non si pensi di sanare questa disparità di trattamento, intervenendo<br />
sul codice civile, non si può sostenere che tale normativa garantisce la salvaguardia dei<br />
beni che la Carta intende tutelare.<br />
Una specifica menzione va, infine, fatta della elaborazione, in sede di Consiglio<br />
d’Europa, di una Convenzione sui diritti fondamentali delle minoranze etniche in Europa.<br />
In questo documento viene per la prima volta esplicitato il principio della tutela delle minoranze<br />
come diritto collettivo di cui sono titolari i gruppi. Si tratta, in effetti, di un diritto che i<br />
documenti precedenti contenevano in maniera implicita, poiché soggetto titolare di un diritto era<br />
sempre considerato l’individuo, anche quando si trattava di diritti palesemente collettivi. La sua<br />
esplicazione assume, pertanto, i connotati di un atto dovuto, che risponde anche alle conclusioni<br />
di un rapporto del 1977 delle Nazioni Unite sul problema in questione 37 .<br />
L’Italia, dal canto suo, aveva già esplicitamente riconosciuto il principio dell’esistenza di<br />
diritti di natura collettiva, nel suo valore di principio fondamentale ed universale, nell’art. 6 della<br />
Costituzione, che come conosciamo così si esprime: “La Repubblica tutela con apposite norme<br />
le minoranze linguistiche”.<br />
37 Vedi relazione presentata da Capotorti F., pubblicata nel 1977 a cura dell’Onu con la sigla ECN.4/Sub.<br />
2/384.<br />
247
ATTUALITA’ E PROSPETTIVE DELLA CONVENZIONE-QUADRO PER LA TUTELA DELLE<br />
MINORANZE NAZIONALI<br />
Adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 10 novembre 1994<br />
La “Convenzione quadro per la tutela delle minoranze nazionali” è il risultato di una discussione<br />
tra esperti durata dall’ottobre del 1991 (soprattutto nell’ambito della Commissione sui<br />
diritti dell’Uomo) in base alla Raccomandazione n. 1134 del 1990 dell’assemblea parlamentare<br />
del Consiglio d’Europa. La suddetta Commissione aveva incaricato un proprio comitato di esperti<br />
che aveva esaminato una serie di proposte - tra le quali anche la “bozza di Bolzano” della<br />
FUEV (Unione Federalista dei Gruppi Etnici Europei) - ed in data 8 settembre 1993, aveva consegnato<br />
al Consiglio dei Ministri la propria relazione finale.<br />
In data 8 e 9 ottobre 1993 i capi di stato dei 33 Paesi membri del Consiglio d’Europa incontratisi<br />
a Vienna hanno deciso di varare questa Convenzione-quadro, la cui ratifica è consentita<br />
anche a Stati non rappresentati nel Consiglio d’Europa.<br />
Il testo della Convenzione-quadro presentato dal “Comitato ad hoc per la tutela delle<br />
minoranze nazionali” è stato varato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 10 novembre<br />
1994. Dalla fine di gennaio 1994 è a disposizione degli Stati per la ratifica.<br />
La Convenzione-quadro mira a garantire i diritti delle minoranze nazionali esistenti negli<br />
Stati membri del Consiglio d’Europa ed in altri Stati eventualmente firmatari.<br />
Il progetto è strutturato in 5 titoli, per un totale di 32 articoli, preceduti da un preambolo<br />
e seguiti da un commentario, che, oltre a contenere un’introduzione “storica” che illustra il lungo<br />
travaglio che ha portato alla redazione del testo proposto, fornisce la chiave di interpretazione<br />
dei diversi articoli, illustrandone a un tempo le relazioni con i documenti precedenti ai quali il<br />
Progetto in esame si ispira.<br />
Non è chiaro se questo commentario storico-interpretativo debba considerarsi parte integrante<br />
del progetto di Convenzione-quadro, come lo era per altri documenti precedenti di<br />
questo tipo (cfr., ad es., il progetto di Convenzione sui diritti fondamentali dei gruppi etnici in Europa<br />
proposta come Protocollo addizionale alla Convenzione europea sui diritti dell’Uomo e redatta<br />
dall’Accademia europea di Bolzano, 1992) o se, invece, come tendiamo a credere in relazione<br />
al tipo di formulazione, esso sia destinato ad essere utilizzato solo come ausilio nella fase<br />
di esame del progetto da parte del Consiglio e degli Stati membri.<br />
Per quanto riguarda il testo vero e proprio del Progetto, il Titolo I contiene<br />
l’enunciazione di principi di carattere generale, le cui conseguenze applicative vengono poi<br />
specificate negli articoli compresi nel Titolo II.<br />
Il Titolo III contiene disposizioni relative ai meccanismi di controllo, il Titolo IV disposizioni<br />
relative all’interpretazione e all’applicazione della Convenzione-quadro e il Titolo V, infine,<br />
le clausole finali.<br />
I principi fissati nel testo in esame si rifanno in buona parte a documenti internazionali<br />
precedenti sui diritti dell’Uomo, in particolare alla Convenzione europea sui diritti dell’Uomo, alla<br />
dichiarazione di Vienna degli Stati membri del Consiglio d’Europa (1993), alla Dichiarazione dei<br />
diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche, religiose e linguistiche adottata<br />
dall’Assemblea Generale dell’ONU (Risoluzione 47/135 del 18.10.1992) e ad altri documenti sui<br />
diritti dell’Uomo e, più specificamente, relativi al problema delle minoranze nazionali adottati<br />
dall’ONU e dalla CSCE.<br />
I diritti fondamentali riconosciuti alle “minoranze nazionali” possono essere così riassunti:<br />
- diritto all’esistenza (art. 1, implicitamente, e artt. 5 e 16);<br />
- diritto all’appartenenza volontaria (art. 3);<br />
- diritto all’uso della lingua materna (art. 10).<br />
Da questi discendono una serie di diritti correlati, quali, ad esempio, quelli relativi<br />
all’insegnamento della o nella lingua di minoranza, all’accesso ai media, all’uso dei nomi originali<br />
e della toponomastica in lingua.<br />
Il progetto di Convenzione in esame si limita, comunque, a fissare dei principi giuridici di<br />
natura generale, che gli Stati firmatari si impegneranno ad attuare nei confronti delle minoranze<br />
nazionali esistenti sui loro territori nelle forme e nei modi più opportuni, tenendo conto della estrema<br />
differenziazione delle situazioni storiche, sociali, culturali e linguistiche delle minoranze e<br />
dei diversi quadri legislativi entro cui la tutela andrà inquadrata.<br />
248
L’impostazione generalista e la constatazione della estrema difficoltà di trovare una<br />
formula che soddisfi tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa (cfr. commentario, considerazioni<br />
generali, punto 12) fanno sì che il documento si astenga dal fornire una definizione sia pur<br />
generica di ciò che debba essere inteso come “minoranza nazionale”, nè preveda criteri oggettivi<br />
in base ai quali queste possano esser identificate, affidando dunque l’individuazione delle<br />
une e la correlata definizione degli altri ai singoli Stati (cfr., ad es., art. 30, ma il concetto è diffusamente<br />
presente in tutto il testo).<br />
Un tale escamotage può tuttavia rivelarsi un’arma a doppio taglio, nel senso che se, da<br />
un lato, fa della Convenzione uno strumento estremamente flessibile all’atto dell’applicazione e<br />
perciò stesso anche estremamente efficace, ove veramente esista la volontà politica di attenervisi,<br />
la espone, dall’altro, ad ogni sorta di possibile violazione da parte di quegli Stati che, al di là<br />
degli atteggiamenti formali, non avessero in realtà alcuna volontà politica di proteggere le minoranze<br />
eventualmente esistenti nel loro territorio.<br />
Di più: affidare in maniera totale ed esclusiva agli Stati firmatari la definizione dei criteri<br />
in base ai quali una popolazione minoritaria debba essere riconosciuta minoranza nazionale e<br />
come tale tutelata può implicare anche il rischio che si crei, all’interno di un singolo Stato, una<br />
situazione di sperequazione tra minoranze, nel caso che, per motivi che possono anche avere<br />
natura politica una o più minoranze vengano riconosciute e tutelate, mentre altre non lo siano.<br />
Né sembra, in base alla redazione attuale del progetto di Convenzione, che i meccanismi<br />
di controllo previsti nel titolo IV siano in grado, eventualmente di far fronte a situazioni abnormi<br />
di questo tipo, potendo essi esercitarsi solo in relazione a quanto dichiarato dai singoli<br />
Stati firmatari all’atto della sottoscrizione della Convenzione o in momenti successivi circa il numero<br />
e l’identità delle minoranze nei cui confronti opererà la tutela.<br />
Questi rilievi risulteranno forse meno eccessivi qualora si tengano presenti, ad es., alcune<br />
situazioni che si sono create negli Stati post-comunisti dell’Europa orientale, in cui<br />
l’Autorità centrale può avere tutto l’interesse a celare, nel concreto, l’esistenza di realtà etnicamente<br />
molto frammentate.<br />
La tutela dei diritti delle minoranze nazionali viene comunque ricondotta all’ambito della<br />
tutela internazionale dei diritti dell’Uomo (art. 1) e, dunque, riconosciuta questione di diritto internazionale.<br />
Va tuttavia sottolineato che, nonostante l’apertura dell’art. 1 (La tutela delle minoranze<br />
nazionali, etc.) faccia esplicito riferimento alle minoranze, e quindi al gruppo, titolari dei diritti riconosciuti<br />
non sono le minoranze nazionali in quanto tali, ma le persone appartenenti alle minoranze<br />
nazionali (cfr., ad es., artt. 3, 4, 5 passim) che, si specifica (art. 3, comma 2) potranno esercitare<br />
i diritti e le libertà derivanti dai principi enunciati nella presente Convenzione-quadro<br />
individualmente o in comune con altri.<br />
Viene, in sostanza, escluso, come è peraltro esplicitamente affermato nel commentario<br />
(cfr. considerazioni generali, punto 13), il riconoscimento dell’esistenza di diritti collettivi, di cui<br />
siano titolari i gruppi come tali e non solo le singole persone che li costituiscono.<br />
A questo proposito sembra opportuno evidenziare in questa sede che, pur nella piena<br />
comprensione e plausibilità, dal punto di vista diplomatico, dei motivi che possono aver suggerito<br />
una soluzione di questo tipo, la maggior parte dei diritti che nel prosieguo il documento riconosce<br />
alle persone appartenenti alle minoranze nazionali sono di per se stessi, oltre che diritti di<br />
natura individuale, diritti di natura collettiva, in quanto il loro esercizio presuppone l’esistenza di<br />
un gruppo, in assenza del quale essi decadrebbero se non, ovviamente, in via di principio, certamente<br />
in via di fatto.<br />
Tale è, ad esempio, il diritto al libero uso della propria lingua materna esplicitamente garantito<br />
dall’art. 10, comma 1, pur con le limitazioni, ragionevoli, eventualmente derivanti dai<br />
commi 2 e 3 riguardo all’uso della lingua di minoranza nei rapporti con le autorità amministrative<br />
e giudiziarie.<br />
A questo ambito sono pure riconducibili, per obiettive considerazioni di fatto relative alla<br />
possibilità del loro esercizio, i diritti, pure riconosciuti, alla salvaguardia di altri elementi essenziali<br />
della loro identità, che sono la loro religione, la loro lingua, le loro tradizioni e il loro patrimonio<br />
culturale (art. 5, comma 1).<br />
Si può obiettare, a queste osservazioni, che il progetto di Convenzione in esame si attiene<br />
alla linea seguita in tutti i documenti ai quali si ispira ed è precisamente quanto il commentario<br />
allegato specifica (cfr. considerazioni generali, punto 13). Anche in questo caso, tuttavia,<br />
249
non si tratta di osservazioni oziose, nel senso che, nell’impostazione generalista che caratterizza<br />
il testo in esame, anche questa posizione è bifronte, nel senso che può essere interpretata<br />
come estrema difesa della minoranza fino alla singola persona, ma anche, e più probabilmente,<br />
anche in relazione all’estrema discrezionalità lasciata agli Stati sottoscrittori, anche nel determinare<br />
la consistenza reale del numero sufficiente di domande (art. 14, comma 2), necessario per<br />
ottenere l’attuazione di alcune misure di tutela, si presta a interpretazioni restrittive fino al limite<br />
del non riconoscimento delle minoranze.<br />
Per quanto riguarda, più in dettaglio, il contenuto del Titolo II, e quindi i diritti concreti effettivamente<br />
riconosciuti alle persone appartenenti alle minoranze nazionali, il progetto di Convenzione<br />
può considerarsi abbastanza esaustivo, pur con i limiti, derivante dal mancato riconoscimento<br />
di diritti di natura collettiva, quelli, in sostanza che deriverebbero ad esse dal fatto di<br />
non essere considerate semplicemente un insieme di persone titolari ciascuna degli stessi diritti,<br />
ma ciò che sono di fatto: popolo.<br />
Vero è che come diritti di questa natura, che potrebbero avere implicazioni più prettamente<br />
politiche, possono essere intesi, in una interpretazione estensiva quelli alla libertà di riunione<br />
pacifica e alla libertà di associazione, alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione”<br />
che “a tutte le persone appartenenti a una minoranza nazionale vengono riconosciuti dall’art. 7,<br />
diritti che nel commentario si specifica sono stati inseriti perchè considerati di particolare pertinenza<br />
per la protezione delle minoranze nazionali (cfr. punto 52), ma altrettanto inconfutabile è<br />
che si tratta di diritti di carattere assolutamente universale. Più specificamente pertinenti sono,<br />
da questo punto di vista, le possibili implicazioni derivanti dall’art. 15 (cfr. anche il relativo commentario,<br />
punto 80), che, se non disattese, porterebbero, di fatto, al riconoscimento, formalmente<br />
negato, dell’esistenza di diritti di natura collettiva.<br />
Se, tuttavia, si trascurano le puntualizzazioni contenute nel commentario, che non sembra<br />
faccia parte integrante del testo della Convenzione, la formulazione dell’art. 15 è tuttavia<br />
così generica da poter anche non avere alcuna conseguenza pratica specifica, potendosi il suo<br />
contenuto inquadrare pienamente nel diritto di tutti i cittadini all’uguaglianza e alla eguale partecipazione<br />
alla vita culturale, politica e sociale dello Stato.<br />
In questo senso, va pure sottolineato che “riconoscimento” può non significare “garanzia<br />
di tutela”.<br />
Anche in questo caso, infatti, il generalismo che caratterizza il progetto introduce margini<br />
di discrezionalità, che se indubbiamente sono funzionali all’accettazione della Convenzione<br />
da parte di un numero il più ampio possibile di Stati, dall’altro possono tradursi, sul piano pratico,<br />
in violazione effettiva, ma non perseguibile, degli stessi diritti riconosciuti.<br />
In concreto nessuna obiezione sembra potersi muovere, anche riguardo alla formulazione,<br />
agli artt. 4, 5 e 6, in base ai quali gli Stati eventualmente firmatari della Convenzionequadro<br />
si impegnano a garantire la piena uguaglianza di diritti tra maggioranza e minoranze nazionali,<br />
a promuovere le condizioni più opportune a garantire alle persone appartenenti alle minoranze<br />
nazionali di conservare e sviluppare gli elementi fondamentali della loro identità, che<br />
sono la loro religione, la loro lingua, le loro tradizioni e il loro patrimonio culturale (art. 5, comma<br />
1) ad astenersi da ogni politica o pratica che tenda a una assimilazione contraria alla loro volontà<br />
delle persone appartenenti alle minoranze nazionali e a proteggere queste persone da ogni<br />
azione che miri a una tale assimilazione (ibidem, comma 2) e a promuovere lo spirito di tolleranza<br />
e il dialogo interculturale oltre che a prendere le misure efficaci a garantire il rispetto, la<br />
comprensione reciproca e la collaborazione tra tutte le componenti etniche della loro popolazione.<br />
Già nell’art. 9, tuttavia, relativo all’accesso delle persone appartenenti alle minoranze ai<br />
media cominciano a comparire una serie di “distinguo” che possono inficiare di fatto quanto riconosciuto<br />
di diritto. Se infatti è perfettamente consequenziale alla struttura della Convenzionequadro<br />
il fatto che ciascuno Stato eventualmente firmatario attui le misure a favore delle persone<br />
appartenenti alle minoranze linguistiche nel quadro del proprio sistema legislativo, qualche<br />
perplessità suscita, invece, al di là delle intenzioni indubbiamente buone del legislatore, la sottolineatura<br />
che ciò sia fatto nella misura del possibile.<br />
Tali perplessità si rinnovano anche a proposito della medesima sottolineatura contenuta<br />
nell’art. 14, in base al quale (comma 1) gli Stati si impegnano a riconoscere a tutte le persone<br />
appartenenti a una minoranza nazionale il diritto di apprendere la propria lingua materna. Nel<br />
comma 2 di tale articolo si specifica infatti che nelle zone di insediamento delle persone appar-<br />
250
tenenti alle minoranze nazionali, se esiste un numero sufficiente di domande gli Stati eventualmente<br />
firmatari della Convenzione si sforzeranno di assicurare, nella misura del possibile e nel<br />
quadro del loro sistema educativo, che le persone appartenenti a questa minoranza abbiano la<br />
possibilità di apprendere la lingua minoritaria o di ricevere un insegnamento in questa lingua.<br />
Si noti che le clausole potenzialmente limitative contenute in questo comma sono ben<br />
tre.<br />
A proposito della prima di esse, cioè del numero sufficiente di domande necessario ad<br />
ottenere l’insegnamento scolastico della o nella lingua di minoranza, si osserva nel commentario<br />
che una tale formulazione è stata adottata per consentire la massima elasticità di applicazione<br />
(cfr. punto 76), ma nulla vieta che essa si trasformi di fatto in un fattore di violazione non<br />
contestabile della Convenzione stessa, qualora la sufficienza del numero fosse fissata a livelli<br />
troppo alti. Tanto più che gli Stati non sono chiamati a impegnarsi o a garantire, ma semplicemente<br />
a sforzarsi di assicurare l’insegnamento scolastico della o nella lingua di minoranza e<br />
che, nel commentario si specifica che una tale formulazione non impone alcun obbligo di dispensare<br />
l’insegnamento della e nella lingua minoritaria, anche se, bontà loro, non impedisce<br />
agli Stati firmatari di farlo (cfr. punto 77). Anche tale sforzo, poi, sarà esercitato nella misura del<br />
possibile: il che, sostanzialmente, amplia fino all’inverosimile lo spazio di di screzionalità degli<br />
Stati, in quanto il possibile dipende, come specifica il commentario (cfr. punto 75), dai mezzi<br />
della parte in causa e quindi da una serie di fattori di varia natura e in particolar modo finanziari<br />
(cfr. commentario, punto 64, a proposito dell’art. 10, ma è chiaro che l’interpretazione debba essere<br />
estesa a tutti gli altri casi), sui quali sarà alquanto difficile ai meccanismi di controllo sindacare.<br />
In conclusione, se certamente il progetto di Convenzione-quadro in esame può considerarsi,<br />
in via di principio, un passo importante nella direzione del riconoscimento e della tutela dei<br />
diritti delle minoranze nazionali, perchè ne sia anche di fatto strumento efficace sarebbe necessaria<br />
una correzione quanto meno parziale dell’impostazione generalista che la caratterizza.<br />
In particolare, sembra opportuno che il testo della Convenzione comprenda almeno dei<br />
principi oggettivi ai quali gli Stati eventualmente firmatari siano tenuti ad attenersi per<br />
l’identificazione delle minoranze nazionali e che consentirebbero ai meccanismi di controllo di<br />
intervenire, anche in base a ricorsi presentati dalle minoranze che si ritengano ingiustamente<br />
discriminate, anche in ordine alla definizione del numero e della identità delle minoranze che<br />
ogni Stato si impegna a tutelare, contribuendo ad evitare situazioni di sperequazione e l’uso<br />
strumentale della Convenzione stessa a fini di politica etnica.<br />
Allo stesso modo si ritiene opportuna una limitazione oggettivamente controllabile degli<br />
spazi di discrezionalità che il testo attuale lascia ai singoli Stati e che potrebbero, nel concreto,<br />
comportare l’inefficacia della Convenzione stessa.<br />
251
LA CARTA EUROPEA DELLE LINGUE REGIONALI E/O MINORITARIE: PLURALISMO<br />
LINGUISTICO COME PATRIMONIO PREZIOSO CHE APPARTIENE A TUTTI<br />
La Carta europea delle lingue regionali e minoritarie mira alla tutela e allo sviluppo del<br />
pluralismo linguistico come patrimonio culturale condiviso. Un progetto che prende le<br />
mosse da una raccomandazione del Consiglio d’Europa elaborata oltre vent’anni fa.<br />
L’Europa che stiamo costruendo è uno spazio plurilingue per natura, nel quale la varietà<br />
non è una minaccia all’unità ma un arricchimento.<br />
L’approvazione alla Camera dei deputati del disegno di legge di ratifica della “Carta europea<br />
delle lingue regionali o minoritarie” segna un primo decisivo passo dell’Italia nella tutela delle<br />
minoranze linguistiche.<br />
Il testo definitivo del "Progetto di Carta europea delle lingue regionali o minoritarie" - sin<br />
dal 1989 proposto al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per la ratifica dei Paesi membri,<br />
elaborato da un Comitato ad hoc di esperti e definitivamente approvato sotto la forma di<br />
convenzione nel febbraio 1992 - è un documento politico di grande rilevanza, non solo per i<br />
problemi che affronta e gli impegni che definisce, ma, soprattutto, per la precisione con cui disegna<br />
lo spazio politico delle istituzioni europee.<br />
È, inoltre, frutto di un lavoro di approfondimento e di discussione durati un decennio; la<br />
sua elaborazione prende, infatti, l'avvio dalla Raccomandazione 928 dell'Assemblea parlamentare<br />
del Consiglio d'Europa del 1981, con la quale viene assunto come problema di difesa del<br />
patrimonio culturale europeo la tutela delle numerose lingue a cui il processo storico, che ha<br />
condotto alla formazione degli Stati europei, non ha conferito la dignità di lingue nazionali.<br />
L'appassionata denuncia dello stato di degrado, in cui versano tali lingue, e la minaccia<br />
di impoverimento, fino all'assimilazione, che incide su di esse, hanno come riferimento essenziale<br />
una situazione che non è più dominata da quelle politiche discriminatorie di stampo nazionalistico,<br />
miranti a far coincidere identità linguistica ed identità nazionale, che tanto peso hanno<br />
avuto nel nostro comune passato; ma che è piuttosto caratterizzata dalla pressione, che i media<br />
ed i processi di internazionalizzazione dell'economia esercitano in direzione di una omologazione<br />
degli usi linguistici, che insidia la varietà e ricchezza del patrimonio espressivo del linguaggio<br />
di ognuno.<br />
Di conseguenza, la non discriminazione non basta ed è necessaria una politica di tutela<br />
positiva. Composta di 5 parti - Disposizioni generali; Obiettivi e principi; Misure di tutela; Applicazione;<br />
Disposizioni finali - e di un Preambolo, la Carta definisce e delimita con rigore i suoi<br />
obiettivi ed il suo campo di applicazione.<br />
Obiettivo dominante di quella politica è il carattere culturale che nelle lingue vede l'espressione<br />
di un patrimonio culturale ed espressivo, non di identità etniche o politiche. Su questa<br />
base, non concepisce la relazione tra lingue ufficiali e regionali o minoritarie in termini di<br />
concorrenza o di antagonismo, ma adotta un approccio interculturale e plurilingue, nel quale<br />
ogni categoria di lingua trova il posto che le compete. È concepita per assicurare, nei limiti del<br />
possibile, l'impiego delle lingue regionali o minoritarie nell’insegna-mento e nei media e per<br />
permettere il loro uso sia nel mondo giudiziario ed amministrativo sia nella vita economica, sociale<br />
e culturale. Non fa, quindi, riferimento a problemi come l'autodeterminazione sarà applicata.<br />
Le sole distinzioni, che la Carta opera, riguardano le lingue extraeuropee, che cadono<br />
fuori dal suo campo di applicazione e le lingue "prive di territorio" come il sinti/roma e lo yiddish,<br />
a cui le misure di tutela si applicano in modo flessibile e "morbido", compatibilmente con il fatto<br />
che si tratta di insediamenti che non interessano una specifica posizione di territorio, ma sono<br />
irregolarmente sparsi nell'insieme della sua estensione.<br />
I principi generali, che la Carta enuncia nella sua seconda parte si applicano a tutte le<br />
lingue regionali o minoritarie, che gli Stati membri del Consiglio d'Europa, chiamati a ratificare la<br />
Convenzione, indicheranno presenti nel loro territorio.<br />
Le specifiche disposizioni di tutela elencate nella terza parte - insegnamento scolare;<br />
uso nei procedimenti giudiziari; nell'amministrazione locale e regionale e nelle assemblee eletti-<br />
252
ve locali e regionali; presenza nei media; utilizzazione nella vita economica, sociale, nelle attività<br />
culturali e negli scambi transfrontalieri - prevedono, viceversa, alcuni gradi di libertà, entro cui<br />
i singoli Stati possono scegliere il livello di tutela, che ritengono più adeguato a ciascuna lingua.<br />
Ciò per tenere conto non solo della diversità delle situazioni, ma anche dei costi che molte norme<br />
comportano; ed è per tale considerazione che le parti contraenti la Convenzione, sono autorizzate<br />
ad accrescere gli impegni sottoscritti, qualora lo ritengano compatibile con la loro situazione<br />
finanziaria.<br />
Il nostro Paese ha attivamente partecipato alla elaborazione della Carta, e, nel corso<br />
degli ultimi anni, ha messo a punto una normativa che, ispirandosi ai medesimi criteri informatori,<br />
estende l'esigenza di tutela dei tradizionali gruppi linguistici di confine - francese in Val d'Aosta,<br />
tedesco e ladino in Trentino, sloveno in Friuli-Venezia Giulia - variamente tutelati fin dall'immediato<br />
dopoguerra, ad altre dodici lingue. Di queste, nove connotano insediamenti minoritari,<br />
da secoli presenti in specifiche aree del nostro territorio - sono quelle delle popolazioni di<br />
origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e dei parlanti ladino, francese, francoprovenzale,<br />
occitano. Una, quella della popolazione zingara, costituisce il tipico esempio di lingua<br />
priva di un ben circoscritto territorio, e le ultime due, friulano e sardo, sono lingue regionali.<br />
Tutte però, senza alcuna eccezione, oppongono alle valutazioni di ordine glottologico e<br />
grammaticale un'idea della lingua come luogo di identità politica, con il risultato non solo di non<br />
saper vedere la minaccia di impoverimento culturale, che grava su un patrimonio espressivo,<br />
che comincia a perdere voci e suoni, oltre che forme scritte, ma anche di non saper cogliere il<br />
senso proprio dello spazio politico, che le istituzioni europee vanno a costruire e le caratteristiche<br />
delle identità politiche, chiamate ad occuparlo.<br />
L'Europa, che stiamo costruendo, è, infatti, uno spazio naturalmente plurilingue, nel<br />
quale la varietà delle lingue in nessun modo può essere considerata una minaccia all'unità ed<br />
all'identità comune, laddove si vive dentro come ricchezza di una identità storica da difendere e<br />
sviluppare. In questa ottica, la differenza tra lingua regionale e dialetto non può venire appiattita<br />
in ragione del fatto che entrambe le fattispecie esprimono un certo numero di differenze rispetto<br />
alla lingua nazionale, che ha politicamente e socialmente unificato un determinato territorio, ma<br />
va concretamente affidata alle considerazioni di ordine linguistico riguardo alla loro natura ed<br />
identità.<br />
Il preambolo delinea succintamente l'area tematica, che la Carta amministra, e l'intenzionalità<br />
politica che la anima.<br />
Scopo del Consiglio d'Europa è realizzare una unione più stretta tra i suoi membri per<br />
poter valorizzare il comune patrimonio di idee e cultura; di questo patrimonio è parte essenziale<br />
la pluralità delle lingue, delle forme espressive, delle tradizioni dei popoli, che la abitano.<br />
L'identità culturale europea, infatti, non può essere pensata e costruita sulla base di un<br />
modello di omogeneizzazione linguistica, come quello che ha portato alla edificazione, attorno<br />
ad una lingua dominante, degli Stati nazionali.<br />
Suo incontestabile riferimento è piuttosto una realtà sociale pluri e mistilingue, ed il pluralismo<br />
linguistico vale per essa come una ricchezza da tutelare e sviluppare: con ciò viene posto<br />
non solo l'ovvio problema della pari dignità delle lingue ufficiali dei paesi, che concorrono alla<br />
costruzione delle istituzioni europee, ma anche la tutela e la promozione delle lingue, che i<br />
processi di unificazione linguistica delle singole nazioni hanno lasciato ai margini.<br />
I processi storici, che hanno avviato alla formazione degli Stati europei, hanno spesso<br />
portato all'inglobamento di piccole comunità in altre più grandi, linguisticamente disomogenee<br />
ed insediate su determinate porzioni del territorio di molti paesi europei, nei quali si trovano popolazioni<br />
autoctone, che parlano una lingua diversa da quella della maggioranza della popolazione.<br />
La situazione demografica di queste lingue regionali o minoritarie è profondamente differenziata,<br />
con situazioni che vedono talora pochi parlanti, talaltro moltissimi, come diverse sono<br />
le legislazioni statali che le riguardano. Tutte però condividono un certo grado di precarietà e<br />
sono minacciate da un livello di degrado più o meno profondo. Peraltro, ciò che oggi soprattutto<br />
minaccia queste lingue, non è più come nel passato, la politica di assimilazione, che in forme<br />
diverse nei loro confronti molti Stati hanno adottato; è piuttosto la spinta uniformatrice della civilizzazione<br />
moderna, il peso, che in essa hanno i mezzi di comunicazione di massa e la standardizzazione<br />
ed impoverimento, che le incanalano nelle tipiche forme di espressione e comunicazione.<br />
253
Per queste ragioni il Preambolo sottolinea come l'obiettivo dominante della Carta sia di<br />
ordine culturale. Essa è volta a proteggere e a promuovere le lingue regionali o minoritarie, in<br />
quanto aspetti minacciati del nostro patrimonio. Peraltro, in un quadro nel quale il loro degrado<br />
va ascritto prevalentemente alla pressione ambientale, economica e tecnologica più che a specifiche<br />
politiche di discriminazione, la Carta prevede una clausola di non discriminazione nei riguardi<br />
del loro impiego.<br />
In pratica, si propone come obiettivo di assicurare, nei limiti del possibile, l'impiego delle<br />
lingue regionali o minoritarie nell'insegnamento e nei media e di permettere il loro uso nel settore<br />
giudiziario ed amministrativo, nella vita economica e sociale e nelle attività culturali.<br />
Di conseguenza, il Preambolo si riferisce al Patto internazionale relativo ai diritti civili e<br />
politici delle Nazioni Unite ed alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ma cita anche gli<br />
impegni di natura politica, adottati nell'ambito della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione<br />
in Europa (CSCE), sottolineando il peso che per la tematica affrontata hanno l'Atto finale di<br />
Helsinki del 1975 e la riunione di Copenaghen del 1990.<br />
Infatti, tenuto conto dello stato di crisi in cui versano alcune delle lingue minoritarie storiche<br />
dell'Europa, il semplice divieto di discriminazioni nei confronti di quanti ancora le parlano,<br />
non appare una garanzia sufficiente, mentre si impongono come necessarie delle misure speciali,<br />
che riflettano gli interessi ed interpretino i bisogni di chi le usa.<br />
Da molti anni, differenti organi del Consiglio d'Europa hanno segnalato la loro preoccupazione<br />
per la situazione delle lingue regionali o minoritarie. La Convenzione europea per la<br />
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali condanna, da parte sua, con l'articolo<br />
14 ogni discriminazione riguardo al godimento dei diritti e delle libertà, sanciti dalla Convenzione,<br />
che appaia fondata sulla lingua o sull'appartenenza ad una minoranza nazionale. Per<br />
quanto importante, però, sia questa disposizione, sin dal 1957 l'Assemblea consultiva rilevava<br />
nella risoluzione n. 136 che, se con essa si creava il diritto di ognuno di non essere perseguitato<br />
e discriminato, non per questo si definivano le condizioni di una protezione positiva delle lingue<br />
minoritarie e delle comunità, che le usavano.<br />
Nel 1961, l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa richiedeva, con la Raccomandazione<br />
n. 285, l'elaborazione di misure di protezione complementari alla Convenzione europea,<br />
volte a garantire il diritto delle minoranze ad una loro propria vita culturale, all'uso della<br />
propria lingua e delle proprie scuole. È solo, però, con la raccomandazione n. 928<br />
dell’Assemblea parlamentare del 1981 e con la contemporanea risoluzione del Parlamento europeo<br />
sui problemi posti dalle lingue minoritarie in materia di cultura ed educazione che il progetto<br />
di una Carta delle lingue e culture regionali o minoritarie diviene programma di lavoro della<br />
Conferenza permanente dei poteri locali e regionali dell'Europa (CPLRE).<br />
Sviluppatosi attraverso un esame approfondito della situazione effettiva delle lingue in<br />
questione e sostenuto dall'interesse costante manifestato al riguardo dal Parlamento europeo, il<br />
lavoro del CPLRE ha condotto alla redazione nel 1988 di un testo di Carta, destinato ad avere<br />
lo statuto di una Convenzione ed affidato al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.<br />
Sulla base di tale testo, un Comitato ad hoc di esperti sulle lingue regionali o minoritarie<br />
in Europa (CAHLR), nominato dal Comitato dei Ministri, ha prodotto e proposto alla ratifica dei<br />
Paesi membri il testo. L'approccio, sviluppato dalla Carta, rispetta i principi di sovranità nazionale<br />
e di integrità territoriale.<br />
Si tratta, in ogni Stato, di prendere in considerazione una realtà culturale e sociale e<br />
non di rimettere in discussione un ordine politico o istituzionale. Al contrario, è proprio perché gli<br />
Stati membri accettano, per quelle che sono, le strutture territoriali degli Stati ed i loro confini,<br />
che considerano necessario che ogni Stato prenda al suo interno, di concerto con gli altri Stati,<br />
delle misure di protezione delle lingue regionali o minoritarie, presenti nel suo territorio.<br />
Per questo, in senso proprio, la Carta persegue la protezione e promozione delle lingue<br />
regionali o minoritarie e non delle minoranze linguistiche, ed affronta il problema in termini di identità<br />
culturale, non politica. Essa non crea dei diritti individuali o collettivi per i parlanti lingue<br />
regionali o minoritarie. Ciò nondimeno, le obbligazioni delle parti per ciò che concerne lo statuto<br />
di queste lingue, e la legislazione interna, che dovrà essere approntata conformemente a quanto<br />
previsto dalla Carta, dovranno avere un effetto evidente sulla situazione delle comunità interessate<br />
e dei loro membri, individualmente presi.<br />
Se, peraltro, la Carta non si occupa dei problemi delle nazionalità, che aspirano all'indipendenza,<br />
o della modifica di frontiere, essa dovrebbe, però poter aiutare, nei limiti di un misu-<br />
254
ato realismo, ad attenuare il problema delle minoranze, che hanno nella lingua l'elemento costitutivo<br />
dell'identità, permettendo loro di sentirsi a proprio agio nello Stato, nel quale un determinato<br />
processo storico s'è concluso, così da far parte di questo. Ben lontano dal rafforzare le<br />
tendenze alla disgregazione delle compagini statali esistenti e dei confini dati, migliori possibilità<br />
di usare le lingue regionali o minoritarie nei diversi campi della vita associata, potrebbero incoraggiare<br />
i gruppi che le parlano, a mettere in secondo piano i risentimenti del passato, che impediscono<br />
loro di accettare il posto nel paese, in cui vivono e nell'insieme dell'Europa.<br />
Importante conferma di ciò è il considerevole interesse che all'approccio sviluppato dalla<br />
Carta dimostra un numero crescente di Paesi dell'Europa centrale e dell'Est, nonostante la<br />
CPLRE abbia elaborato e presentato il suo progetto prima degli importanti cambiamenti avvenuti<br />
nell'Europa centrale ed orientale, ed avendo a riferimento la situazione ed i bisogni dei paesi,<br />
che all'epoca erano già membri del Consiglio d'Europa.<br />
In questo contesto, va sottolineato come la Carta non affronti la relazione tra le lingue<br />
ufficiali e quelle regionali o minoritarie in termini di concorrenza o di antagonismo. Al contrario,<br />
essa adotta con determinazione un approccio interculturale e plurilingue, nel quale ogni categoria<br />
di lingua trova il posto che le spetta. E' un approccio che corrisponde pienamente ai valori<br />
tradizionalmente difesi dal Consiglio d'Europa ed ai suoi sforzi tesi a promuovere relazioni più<br />
strette tra i popoli, nel quadro di una accresciuta cooperazione europea e di una migliore comprensione<br />
tra i differenti gruppi della popolazione di ogni Stato. Nel momento, d'altronde, in cui il<br />
Preambolo pone l'accento sul valore da perseguire, esso elimina anche ogni malinteso sugli obiettivi<br />
così raggiunti: ciò che è in questione non è in alcun modo l'incoraggiamento alle tendenze<br />
che mirano alla chiusura su se stessi dei gruppi linguistici. Al contrario, è chiaramente riconosciuto<br />
che, in tutti gli Stati, la conoscenza della lingua ufficiale - o di una delle lingue ufficiali -<br />
è una necessità: di conseguenza, nessuna disposizione della Carta potrà essere interpretata<br />
come volta a frapporre ostacoli alla conoscenza delle lingue ufficiali.<br />
255
PARI DIGNITA’ PER LINGUE E CULTURE DI MINORANZA<br />
La possibilità di usare idiomi locali nelle assemblee elettive non solo è prevista dalla legge,<br />
ma è anche riaffermata in molti statuti comunali. Il livello di applicazione di queste<br />
misure è un indice del grado di coscienza che una determinata comunità ha della propria<br />
identità<br />
Il Consiglio comunale può far tradurre nella lingua tutelata gli atti pubblici dello Stato e di<br />
altri enti con oneri a carico del proprio bilancio.<br />
Anche quando le traduzioni non hanno valore legali la prassi ha un alto significato civile<br />
e simbolico.<br />
L’affiancamento della toponomastica locale in lingua a quella ufficiale è un punto qualificante<br />
della salvaguardia delle minoranze.<br />
Nella storia della legge 482 del 15 dicembre 1999, normativa fondamentale in materia di<br />
tutela delle minoranze linguistiche storiche, nella quale per la prima volta viene dichiarato che la<br />
lingua ufficiale della Repubblica è l’italiano, la disposizione più discussa è stato l'art. 7, perché<br />
avrebbe potuto rompere l'unità linguistica del Paese e la stessa unità nazionale. I suoi avversari<br />
hanno sostenuto che esso costituiva di fatto un riconoscimento delle tendenze separatiste ed<br />
inoltre instaurava uno stato di sperequazione tra le varie parlate del paese, dando ad alcune di<br />
esse dignità di lingua pari all'italiano e negandola ad altre. Si faceva inoltre osservare che l'ammissione<br />
dell'uso della lingua di minoranza nelle assemblee elettive e negli organi collegiali avrebbe<br />
costituito una grave complicazione della vita delle assemblee e degli organi stessi, in<br />
considerazione del fatto che si poteva prevedere che, mentre tutti i membri e tutto il pubblico<br />
avevano competenza della lingua italiana, non tutti conoscevano la lingua di minoranza.<br />
Sebbene la successiva evoluzione del dibattito sul tema sia in Italia che in ambito internazionale,<br />
abbia di fatto superato da tempo queste obiezioni, varrà la pena di sottolineare che il<br />
riconoscimento del diritto all'uso della lingua di minoranza nei pubblici consessi è norma inscindibilmente<br />
connessa al riconoscimento stesso di una minoranza linguistica e che, infatti, sempre<br />
accompagna tale riconoscimento negli accordi bilaterali tra Stati per la tutela delle reciproche<br />
minoranze insediate su territori di confine e costituisce un punto qualificante dei documenti O-<br />
NU, UE, OSCE e CEI sulla tutela delle minoranze stesse.<br />
L’art. 7 consente ai Consigli comunali la facoltà di usare la lingua tutelata, la quale può<br />
essere applicata anche negli atti interni dell’amministrazione ma, per il disposto del comma 3,<br />
gli atti pubblici e quelli per i quali si desiderano effetti giuridici (e quindi i verbali del Consiglio e<br />
della Giunta, gli avvisi e tutti gli atti affissi all’Albo comunale) devono essere obbligatoriamente<br />
redatti in italiano e facoltativamente nella lingua tutelata.<br />
D'altra parte, è da osservare che la possibilità dell'uso della lingua locale nelle assemblee<br />
elettive e negli organismi collegiali è norma già prevista in molti statuti comunali e dunque<br />
di fatto già operativa, almeno a livello teorico, in molte realtà locali.<br />
Va sottolineato tuttavia che l'articolo in oggetto, inserito in una legge dello Stato, costituisce<br />
un importante e dovuto riconoscimento formale della pari dignità delle lingue e culture di<br />
minoranza rispetto alla lingua e cultura nazionale.<br />
Data l'importanza di tale riconoscimento, si sottolinea l'opportunità che i membri degli<br />
organismi elettivi dei comuni che rientrano negli ambiti territoriali di cui all'art. 3 si impegnino a<br />
dare alla norma il massimo livello di attuazione, in quanto essa riveste con tutta evidenza un alto<br />
valore civile e simbolico, anche nei confronti delle popolazioni minoritarie e della percezione<br />
che esse hanno della propria identità linguistica e culturale.<br />
L’art. 8 dispone che il Consiglio comunale può far tradurre nella lingua tutelata, con onere<br />
a carico del proprio bilancio, gli atti pubblici dello Stato e di altri Enti.<br />
Lo spirito di questo articolo si muove in piena sintonia con le direttive generali dell’intera<br />
legge e riflette direttamente gli orientamenti riguardanti la materia contenuta nei documenti internazionali<br />
già citati.<br />
256
Esso, inoltre, chiama in causa direttamente gli enti locali più vicini alle realtà minoritarie,<br />
quali sono appunto i comuni, invitandoli a farsi parte attiva del processo di tutela delle lingue e<br />
culture delle popolazioni di cui all'art. 2.<br />
Ad essi è, infatti, demandata la facoltà di inserire nei propri statuti disposizioni che prevedano<br />
la traduzione e la pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato,<br />
degli enti locali e di enti pubblici non territoriali, con spese che, ove non siano disponibili altre<br />
risorse, andranno iscritte nei loro bilanci.<br />
In sostanza, ciò che si chiede alle amministrazioni locali dei comuni interessati è una<br />
precisa assunzione di responsabilità, negli ambiti di loro competenza, che finisce per essere<br />
espressione di una salda consapevolezza della loro identità particolare, e trova fondamento nella<br />
consapevolezza che di ciò ha la popolazione stessa.<br />
Il grado di applicazione, a livello locale, delle misure previste dalla legge di tutela e delegate<br />
ai poteri locali finisce così per essere un indice del grado di coscienza che della propria<br />
identità ha una determinata comunità (la popolazione di un determinato comune) e della sua volontà<br />
di conservarla e svilupparla nei diversi campi, ma può anche, ove l'iniziativa venga dal vertice,<br />
innescare un processo di recupero di tale identità, ove le contingenze storiche e i processi<br />
di assimilazione passiva subiti, in assenza di qualsiasi misura di arginamento, ad opera della<br />
cultura maggioritaria ne abbiano causato l'affievolimento. Esempi positivi ed incoraggianti in<br />
questo senso, abbastanza numerosi e vicini nel tempo, vengono dalle comunità ladine del Trentino-Alto<br />
Adige.<br />
In questo senso, sembra opportuno rilevare che, sebbene le traduzioni suggerite dal<br />
presente articolo non avranno valore legale, la prassi ha tuttavia un alto valore civile e simbolico<br />
ed inoltre costituisce un contributo di primaria importanza per lo sviluppo globale delle lingue<br />
minoritarie, il cui uso, nella situazione attuale, risulta spesso confinato ad ambiti strettamente<br />
familiari, con conseguente grave depauperamento ed involuzione del loro patrimonio lessicale.<br />
Allo scopo di dare all'articolo il massimo livello di attuazione, con una incidenza il più ridotta<br />
possibile sui bilanci comunali spesso in difficoltà, si suggerisce ai comuni interessati la<br />
possibilità di consorziarsi, in modo che la spesa venga ripartita su più soggetti.<br />
A proposito della spesa, si sottolinea, inoltre, che essa grava sui bilanci comunali solo in<br />
mancanza di altre risorse disponibili a questo fine. Tali altre risorse possono essere garantite,<br />
anche parzialmente da enti sovraordinati, quali le province e le regioni, alle quali ultime, in particolare,<br />
si fa invito a tener conto di questo problema nell'ambito dell'emanazione dei provvedimenti<br />
di sua competenza cui all'articolo 3 ed in ambiti connessi, nonché essere ricercate presso<br />
le strutture di organismi internazionali (ad es. UE, UNESCO, ecc.) competenti in materia.<br />
L’art. 9 dispone che nelle amministrazioni pubbliche sia consentito l’uso della lingua<br />
ammessa a tutela. Le forze armate e le forze di polizia sono escluse da quest’applicazione. Per<br />
garantire questa disposizione, sono stanziate lire 9,8 miliardi all’anno, a partire dal 1999. Il 3°<br />
comma dello stesso articolo afferma che la lingua tutelata può essere usata anche davanti al<br />
giudice di pace.<br />
Le norme stabilite dal presente articolo sono tra quelle che nel lungo iter parlamentare<br />
della legge, che attraversa varie legislature ed ha conosciuto diverse redazioni, hanno suscitato<br />
obiezioni molto forti da parte di alcune forze politiche, che in esse vedevano non solo un onere<br />
per la pubblica amministrazione ed una minaccia per la sua funzionalità.<br />
Non prevedendo la legge aumenti di organico miranti a consentire l'attuazione della<br />
norma, si può procedere in via provvisoria a valorizzare, in base a criteri obiettivi, l'eventuale<br />
presenza in organico di personale bilingue nei rapporti con il pubblico, mentre per quel che riguarda<br />
i giudici di pace già in carica, si potrà prevedere, ove non siano bilingue, la presenza di<br />
un traduttore a richiesta anche di una sola delle parti in causa.<br />
Nell'eventualità di nuove assunzioni, la conoscenza oltre che della lingua nazionale,<br />
della lingua minoritaria andrà richiesta come titolo nei bandi di concorso e comunque considerata<br />
titolo preferenziale per l'assunzione. E' opportuno che i bandi di concorso o comunque le<br />
norme riguardanti i colloqui per l'assunzione prevedano anche una prova volta ad accertarne<br />
l'effettiva conoscenza da parte del candidato.<br />
L’articolo 10 consente che, in aggiunta ai toponimi ufficiali, possono essere indicati<br />
quelli delle tradizioni.<br />
L'articolo adegua la legislazione italiana alle norme previste da documenti internazionali<br />
in materia di tutela delle minoranze, quali la Carta Europea delle lingue regionali e minoritarie, la<br />
257
Convenzione-quadro per la tutela delle minoranze nazionali e lo Strumento CEI, delle quali il<br />
nostro paese è firmatario ed è stato tra i principali promotori.<br />
L'affiancamento della toponomastica locale in lingua alla toponomastica ufficiale costituisce,<br />
infatti, per unanime riconoscimento, uno dei punti qualificanti della salvaguardia delle<br />
culture minoritarie, in quanto ne esplicita e riconosce la specifica organizzazione dello spazio<br />
privato e di quello sociale ed il rapporto con le realtà esterne alla comunità, che la toponomastica<br />
ufficiale tende inevitabilmente ad adeguare al modello maggioritario.<br />
Onde consentire la piena realizzazione della tutela garantita dalla presente legge, gli<br />
enti locali coinvolti sono sollecitati a provvedere agli adempimenti richiesti nel più breve tempo<br />
possibile.<br />
Si rilevi che, in conformità allo spirito della legge, la toponomastica locale nella lingua<br />
minoritaria non dovrà in alcun modo essere una traduzione di quella ufficiale in lingua italiana,<br />
ma rispecchiare la denominazione dei luoghi, delle piazze e delle strade propria della tradizione<br />
locale, anche qualora questa si discosti radicalmente da quella ufficiale.<br />
A tal fine, ove lo stato attuale della toponomastica tradizionale dovesse risultare eccessivamente<br />
lacunoso o risponda ad una organizzazione dello spazio troppo diversa da quella<br />
dell'ufficialità corrente e problematica anche sul piano anagrafico, le amministrazioni interessate<br />
possono procedere su due binari paralleli: da un lato avviando progetti di ricerca che mirino alla<br />
ricostruzione il più possibile completa del quadro toponomastico tradizionale da ripristinare, e<br />
dall'altro integrando mediante l'intitolazione di strade e piazza a personalità ed eventi significativi<br />
della storia e della cultura della comunità linguistica in questione, con la raccomandazione<br />
che per quest'ultima operazione non si operi in ambito strettamente localistico, ma tenendo presente<br />
l'intera realtà storico-culturale della minoranza linguistica di appartenenza.<br />
Sempre in relazione alla seconda delle possibilità operative citate, cioè all'intitolazione<br />
di strade e piazze a personaggi ed eventi appartenenti alla storia ed alla cultura delle minoranze<br />
linguistiche, i comuni interessati potranno valutare con la dovuta attenzione anche la possibilità<br />
di una revisione della toponomastica ufficiale in tal senso. Un movimento di questo tipo è, in effetti,<br />
già in atto in molte realtà anche italofone, in cui si assiste ad un rifacimento della toponomastica<br />
in direzione di una riscoperta della storia locale, che, lungi dal rappresentare un ripiegamento<br />
sulla propria realtà particolare, è indice di un processo di riappropriazione e di coscientizzazione<br />
che da un lato restituisce il senso delle proprie radici e della propria identità e consente,<br />
dall'altro, di riscoprire le ragioni profonde dell'unità nazionale.<br />
L’art. 11 prevede la possibilità, per i cittadini che in passato l’abbiano vista rifiutare, di<br />
ripristinare il proprio nome o cognome nella lingua originaria, inoltrando domanda al sindaco.<br />
Questi passa la domanda al prefetto, che emette decreto di ripristino. Ricevuto il decreto, gli uffici<br />
dello stato civile provvedono alle rettifiche.<br />
Le procedure stabilite dal presente articolo relativamente al diritto dei cittadini appartenenti<br />
alle minoranze linguistiche riconosciute di ottenere il ripristino del nome e/o cognome nella<br />
forma originaria, qualora questo/i abbiano documentatamente subito modifiche prima dell'entrata<br />
in vigore della presente legge, sono ricalcate su quelle stabilite dal regio decreto 9 luglio<br />
1939, n. 1238, titolo VIII, capo II, articoli 158 e seguenti, cui si faceva esplicitamente riferimento<br />
nelle redazioni della legge per la tutela delle minoranze discusse in Commissione ed in aula nel<br />
corso di precedenti legislature.<br />
La necessità di riformulare l'articolo nella forma attuale è stata dettata dalla considerazione<br />
che nel regio decreto in questione si fa riferimento in maniera esplicita a cambiamenti di<br />
nome e di cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine illegittima, casistica,<br />
questa, che evidentemente non comprende la condizione prevista dalla presente legge<br />
Per quanto riguarda la procedura in senso stretto una modifica significativa rispetto al<br />
regio decreto 9 luglio 1939, che sottolinea ancora una volta la particolarità del caso in esame, è<br />
il coinvolgimento dei sindaci, ai quali i cittadini interessati devono presentare la domanda relativa<br />
al ripristino del proprio nome e/o cognome nella forma originaria. Il sindaco provvederà a trasmetterla<br />
d'ufficio al prefetto che emette il decreto di ripristino.<br />
La domanda dovrà essere corredata da adeguata documentazione, volta a documentare<br />
l'avvenuto cambiamento del nome e/o cognome del richiedente e documentante la forma attuale<br />
e quella originaria che si intende assumere.<br />
Si noti che il testo non specifica le condizioni (italianizzazione forzata, errori di trascrizione<br />
o altro) che hanno determinato il cambiamento del nome e/o cognome né l'epoca a cui<br />
258
questo possa essere fatto risalire, il che consente la massima elasticità di interpretazione dell'articolo<br />
ed eventualmente il ripristino, in particolare di cognomi, italianizzati anche in tempi relativamente<br />
remoti.<br />
Il ripristino avverrà a mezzo di un provvedimento emesso dal prefetto, che potrà essere<br />
unico per i membri della stessa famiglia ed avrà comunque effetto per il richiedente e, ove questo<br />
sia di sesso maschile, per i suoi figli minorenni.<br />
Perché esso riguardi anche i figli maggiorenni del richiedente, è invece necessario il loro<br />
assenso scritto, da allegare preventivamente alla richiesta di ripristino o da esprimere successivamente<br />
all'emissione del decreto da parte del prefetto.<br />
Ove ciò non avvenga al momento del ripristino del cognome del genitore, nulla osta che<br />
essi avviino successivamente, a loro volta, la procedura di ripristino, così come, al fine di snellire<br />
le procedure, è da valutare, in sede di regolamento applicativo, la possibilità che il loro consenso<br />
possa essere espresso anche a distanza di tempo dall'avvenuto ripristino del cognome<br />
del genitore, senza riavviare tutta la procedura. Ponendo come condizione del ripristino nella<br />
forma originaria di cognomi e/o nomi che abbiano subito modifiche che i cittadini interessati appartengano<br />
alle popolazioni di cui all'art. 2 e siano residenti nei comuni individuati con il procedimento<br />
di cui all'art. 3, la presente legge lascia di fatto irrisolto il problema relativo a cittadini<br />
appartenenti a minoranze linguistiche che, per svariate ragioni, non sono più residenti nei comuni<br />
rientranti nella tutela.<br />
In tali casi, a soluzione per quanto necessariamente parziale e per evitare l'eventualità<br />
di spostamenti fittizi di residenze, si suggerisce di valutare opportunamente la possibilità di una<br />
interpretazione allargata della legge stessa, nel senso di estendere i suoi effetti anche a cittadini<br />
che siano stati residenti alla nascita nei comuni rientranti negli ambiti territoriali che fruiscono<br />
della tutela.<br />
In caso di mancata accettazione della richiesta, entro trenta giorni dal ricevimento della<br />
comunicazione relativa, il richiedente può ricorrere al Ministro di giustizia, che emetterà la decisione<br />
definitiva, previo parere del Consiglio di Stato. Una volta emesso il decreto relativo al ripristino<br />
del cognome e/o del nome del richiedente, gli uffici dello stato civile provvedono automaticamente<br />
alle annotazioni relative all'attuazione del provvedimento. Allo stesso modo, gli uffici<br />
del comune e delle altre amministrazioni provvedono alla rettifica dovuta in tutti gli elenchi e ruoli<br />
nominativi. A differenza da quanto previsto dal regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, l'intero<br />
procedimento è gratuito per tutti i cittadini interessati, qualunque sia la loro condizione economica.<br />
Si noti che in nessun caso il procedimento così come previsto dalla presente norma può<br />
essere utilizzato per mutamenti arbitrari di nomi e/o cognomi, né per i casi previsti dal regio decreto<br />
citato in precedenza.<br />
259
MINORANZE: DALLA SCUOLA LE PRIME RISPOSTE<br />
Gli ultimi anni sono stati caratterizzati, in Italia ed in altri Paesi dell’Unione Europea,<br />
da massicci flussi migratori provenienti prevalentemente dai Paesi dell’Est europeo e<br />
dall’Africa, ed in misura minore da alcuni Paesi asiatici<br />
La caratteristica più saliente di questi flussi migratori è la loro frammentazione etnica,<br />
culturale e linguistica.<br />
La consistenza e la persistenza dei flussi migratori ha indotto gli osservatori a discutere<br />
di “nuove minoranze”, che creano nuovi problemi relativamente alla tutela di alcuni diritti fondamentali<br />
della persona umana. Di tale fenomeno costituiscono esempio, nel nostro Paese, gli<br />
Albanesi, i Polacchi, i Filippini, mentre una consistente minoranza religiosa comprende gli immigrati<br />
di religione musulmana, tra i quali predominanti sono le componenti etniche araba e somala.<br />
Le “nuove minoranze” non hanno sedi di insediamento consolidate e geograficamente<br />
delimitabili. La loro presenza è diffusa su tutto il territorio nazionale, anche se con punte di<br />
maggiore concentrazione in alcune aree, non solo cittadine ed è collegata spesso ad attività<br />
economiche particolari. Si tratta, poi, di “minoranze” instabili, nel senso che il numero degli immigrati<br />
è soggetto a variazioni anche considerevoli. Oltre, infatti, al fenomeno del lavoro stagionale<br />
va sottolineato che un grande numero di immigrati extracomunitari considera la permanenza<br />
in Italia del tutto provvisoria, in attesa di raggiungere altri Paesi; un’altra quota, invece, ha<br />
intenzione di rimanervi il tempo necessario per accumulare la somma occorrente all’avviamento<br />
di attività autonome nei loro Paesi. L’impianto sociale non è del tutto positivo e ciò è dovuto in<br />
primo luogo alla condizione precaria, di sostanziale emarginazione, in cui la maggior parte degli<br />
immigrati vivono, situazione che è ovviamente esasperata nel caso degli irregolari. Un altro aspetto<br />
da evidenziare è la scarsa disponibilità di posti di lavoro insufficienti rispetto all’entità dei<br />
flussi; ciò finisce per costringere una consistente parte di immigrati a vivere di espedienti o di<br />
lavori improvvisati e precari, quando addirittura non li spinge ai margini o fuori dalla legalità, sia<br />
alimentando fenomeni di microcriminalità, sia costituendo manovalanza a basso costo per le<br />
grandi organizzazioni criminali. Né si possono sottovalutare le condizioni di vero e proprio sfruttamento<br />
che un‘altra consistente parte di essi (irregolari) è costretta ad accettare per sopravvivere,<br />
lavorando in nero in particolari settori economici e in agricoltura. Tale problematica richiede<br />
una auspicabile politica di regolamentazione dei flussi, che miri a commisurare i nuovi ingressi<br />
alle reali possibilità di assorbimento nella società italiana, al fine di garantire anche agli<br />
immigrati la piena dignità umana e sociale. È indispensabile sviluppare una presa di coscienza<br />
della connotazione sempre più multiculturale delle società moderne, creando le condizioni per<br />
evitare che ciascuna delle componenti etniche e culturali sia fagocitata semplicemente dalla società<br />
culturale ospite; ma occorre assicurare che ciascuna cultura si esprima secondo le proprie<br />
caratteristiche e i propri modelli. Si rende necessario diffondere un’educazione alla multiculturalità,<br />
che dovrà trovare nella scuola uno dei suoi punti di forza, non solo nel senso di educare alla<br />
comprensione e all’accettazione dell’alterità culturale, ma di consentire anche l’espressione il<br />
più possibile libera, nell’ambito delle possibilità offerte dal sistema e dalla legislazione del settore.<br />
In questa prospettiva, particolarmente interessante è la circolare del Ministero dell’Istruzione<br />
n. 73 del 2 marzo 1994, che ha per oggetto “il dialogo interculturale e la convivenza democratica”.<br />
Essa è strumento di promozione culturale delle “nuove minoranze” attraverso iniziative didattiche<br />
specifiche, anche con il concorso degli enti localI e delle comunità degli immigrati. La<br />
circolare raccomanda tra l’altro che nelle scuole ove vi sia presenza di allevi di provenienza extracomunitaria,<br />
nell’ambito delle singole discipline di insegnamento si creino occasioni di conoscenza,<br />
di approfondimento delle culture “altre” e di confronto con esse, spingendosi fino a<br />
suggerire che nell’ambito di discipline che più si prestano allo scopo, come la storia e la geografia,<br />
vengano individuati spazi didattici da dedicare allo studio delle vicende e delle situazioni di<br />
pertinenza dei Paesi di origine degli alunni stranieri. La circolare ministeriale sottolinea inoltre il<br />
problema del bilinguismo, a proposito del quale non esclude la possibilità di organizzare, in<br />
concorso con gli enti locali e le comunità degli immigrati, corsi di lingua e cultura d’origine, qualora<br />
ciò venga richiesto da gruppi etnici concentrati sul territorio.<br />
Va ricordato che la Costituzione italiana annovera la tutela delle minoranze tra i propri<br />
principi fondamentali. Se è vero, infatti, che gli Atti della Costituente ne suggeriscono una inter-<br />
260
pretazione restrittiva, riferendosi solo alle minoranze storicamente presenti sul territorio italiano,<br />
l’enunciazione sintetica dell’art. 6 della Costituzione (“La Repubblica tutela con apposite norme<br />
le minoranze linguistiche”) non ne impedisce nelle nuove condizioni una interpretazione estensiva,<br />
con la clausola di eventuali “apposite norme” emanate in favore delle “nuove minoranze”.<br />
Per quel che riguarda il diritto all’insegnamento della e nella lingua materna, è auspicabile<br />
un intervento attivo da parte dello Stato italiano in direzione della valorizzazione sociale e<br />
culturale delle comunità degli immigrati attraverso la promozione e il sostegno, all’interno delle<br />
comunità degli immigrati e in collaborazione con l’Autorità competenti dei Paesi di provenienza,<br />
dell’associazionismo di iniziative (apertura di scuole private proprie sostenute, parzialmente, da<br />
finanziamenti pubblici, istituzionali culturali e attività varie anche in collaborazione con enti italiani,<br />
ecc…) che consentano di approfondire la conoscenza e la comprensione reciproca e forniscano<br />
nel contempo il supporto necessario di un processo di integrazione che non si configuri<br />
come perdita di identità. Per tale via si potrà perseguire l’obiettivo dell’arricchimento reciproco<br />
non solo tra la società ospite e le singole comunità di immigrati, ma anche tra le comunità stesse<br />
degli immigrati.<br />
261
L'ALTO COMMISSARIO OSCE PER LE MINORANZE NAZIONALI: ANALISI E PROSPETTI-<br />
VE DI AZIONE PER UNA MAGGIORE TUTELA DELLE MINORANZE<br />
La Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (C.S.C.E., ora O.S.C.E.)<br />
nacque con l'Atto di Helsinki, nel 1965, nel pieno, dunque, della guerra fredda, con lo scopo di<br />
promuovere il dialogo tra l'Occidente, non solo europeo, e l'Est, a quel tempo comunista.<br />
Di tale organismo facevano parte, all'inizio, 35 Stati europei, in pratica tutti tranne l'Albania,<br />
più gli USA ed il Canada. Concepita come una struttura non formalizzata, proprio come<br />
tale riuscì ad aprire tavoli di confronto su temi che ad altre organizzazioni internazionali erano<br />
preclusi da veti di diversa natura e provenienza.<br />
In effetti, dopo l'incontro costitutivo di Helsinki e il relativo Atto sulla difesa dei diritti dell'uomo,<br />
l'attività della C.S.C.E. si è sviluppata molto positivamente attraverso una serie di incontri<br />
che costituirono, dapprima, altrettante tappe fondamentali del processo di distensione e che,<br />
successivamente, con la caduta dei regimi comunisti dell'Est e lo scioglimento del Patto di Varsavia,<br />
hanno dato, e danno tuttora, un contributo di rilevanza fondamentale all'edificazione della<br />
nuova architettura europea .<br />
La nuova situazione, determinatasi in Europa sul finire degli anni '80, suggerì l'istituzionalizzazione<br />
dell'organismo, che fu sancita nel 1990 con la Carta di Parigi per una nuova Europa,<br />
mentre nel 1991, a Berlino, venne stabilito formalmente di farne "l'elemento centrale dell'architettura<br />
europea". Venne, a questo scopo, varato un "meccanismo anticrisi", incaricato di affrontare<br />
le emergenze e di operare per la prevenzione dei conflitti tra gli Stati membri.<br />
Nello stesso anno, con l'adesione dell'Albania e, poi, della Lituania, dell'Estonia e della<br />
Lettonia, gli Stati membri divennero 38, numero che salì successivamente a 52 nel 1992, in seguito<br />
all'adesione delle Repubbliche di Slovenia, Croazia e Bosnia-Erzegovina, nonché di quelle<br />
ex-sovietiche.<br />
Si comprende bene, in questo quadro, come la C.S.C.E., che è andata assumendo una<br />
struttura sempre più formalizzata e che è stata successivamente ribattezzata Organizzazione<br />
per la sicurezza e la cooperazione in Europa (O.S.C.E., in sigla), abbia svolto e svolga un ruolo<br />
sempre più incisivo anche per la difesa dei diritti delle minoranze.<br />
Fin dall'inizio, infatti, il dialogo che essa mirava a promuovere riguardava non solo il<br />
campo economico, sociale e politico ma anche quella che venne definita "la dimensione umana"<br />
e che può essere intesa come il campo relativo alla tutela internazionale dei diritti dell'Uomo.<br />
Non a caso, sono proprio i diritti umani il tema fondamentale del suo atto costitutivo.<br />
“La dimensione umana” di Helsinki, del resto, è andata assumendo un peso sempre<br />
maggiore nel confronto tra gli Stati membri via via che il loro numero cresceva e ancor più via<br />
via che la Conferenza, da sede di promozione del dialogo tra mondi ideologicamente diversi e<br />
contrapposti, si trasformava in sede di promozione di politiche, se non proprio coordinate, almeno<br />
armonizzate tra i vari membri nei diversi campi d'intervento.<br />
Nell'ambito di questa dimensione, il risveglio dei nazionalismi che ha fatto seguito alla<br />
dissoluzione dell'impero sovietico e che ha avuto il suo culmine tragico negli eventi drammatici<br />
dell'ex-Jugoslavia e, più di recente, della Cecenia, ha fatto del problema delle minoranze nazionali<br />
una delle priorità assolute del confronto.<br />
Della estrema delicatezza della questione e dei problemi ad essa sottesi si era già consapevoli,<br />
del resto, nel 1975, quando gli sviluppi che successivamente ebbero gli eventi in Europa<br />
erano del tutto imprevedibili.<br />
Alle minoranze nazionali l'Atto di Helsinki dedica, infatti, uno specifico titolo, l'8° Principio,<br />
che recita: "Gli Stati partecipanti, sul cui territorio esistono minoranze nazionali, rispettano il<br />
diritto delle persone che appartengono a queste minoranze, con l'uguaglianza davanti alla legge<br />
danno ad esse l'intera possibilità di godere effettivamente dei diritti dell'Uomo e delle libertà<br />
fondamentali e proteggono in tal modo i loro legittimi interessi in questo campo".<br />
Diversi anni dopo, nel 1989, quando la grande trasformazione dell'Est era già avviata e<br />
si avevano anche le prime avvisaglie dei rischi connessi con il risveglio dei nazionalismi, nel<br />
corso del vertice di Vienna, la C.S.C.E. approvò uno specifico documento, che sancì i diritti delle<br />
realtà minoritarie e definì i principi per la loro protezione e per la promozione del loro sviluppo.<br />
Tali impegni ed indirizzi furono ulteriormente approfonditi e perfezionati nel 1990, in occasione<br />
del vertice di Parigi, che, con la approvazione della “Carta per una nuova Europa”, get-<br />
262
tava le basi dell'istituzionalizzazione della C.S.C.E. come pilastro per la definizione dei futuri assetti<br />
europei.<br />
Alla luce degli eventi che intanto si andavano profilando in tutta l'area europea, la costante<br />
attenzione che la C.S.C.E. aveva dedicato al problema delle realtà minoritarie, nella con<br />
sapevolezza dell'influenza che la crescente aspirazione delle minoranze al riconoscimento ed<br />
alla tutela della propria peculiare identità è destinata ad assumere nell'attuale momento della<br />
storia europea, ha poi fatto della questione delle minoranze nazionali uno dei temi centrali del<br />
vertice C.S.C.E. di Ginevra (1991).<br />
Infatti, nella prospettiva della terza riunione della Conferenza sulla dimensione umana,<br />
la C.S.C.E. ha indicato nell'adozione di forme di autonomia e di autogoverno e nella istituzionalizzazione<br />
della partecipazione delle minoranze alla gestione dei pubblici poteri una strada utile<br />
per la prevenzione di tensioni e conflitti sia all'interno dei singoli Stati sia nei rapporti tra Stati<br />
diversi dell'area C.S.C.E..<br />
In tale occasione, veniva espressamente ribadito un concetto che già informava i documenti<br />
precedenti, ma che veniva ora proposto con maggiore slancio e consapevolezza, in<br />
una realtà politica ormai mutata che, pur nel persistere di antiche riserve e diffidenze, cominciava<br />
a consentire rapporti più franchi ed aperti tra gli Stati.<br />
Un ruolo fondamentale per la tutela delle realtà minoritarie veniva, cioè, riconosciuto alla<br />
cooperazione ed in particolare agli scambi transfrontalieri relativi alle attività economiche e<br />
culturali, all'informazione e ad ogni altra attività atta a favorire lo scambio di esperienze e la collaborazione<br />
tra gruppi minoritari. La rilevanza di questo assunto sta nel fatto che le minoranze di<br />
frontiera, quelle, cioè, aventi come referente etnico, linguistico e culturale gruppi che sono maggioritari<br />
in Stati confinanti, hanno costituito (ed in parte costituiscono) motivo di tensione interna<br />
ed internazionale.<br />
Su questi temi, che l'evolversi della situazione europea rendeva sempre più visibili, al<br />
punto da imporli come prioritari anche ad altri organismi internazionali, come il Consiglio d'Europa<br />
e l'Iniziativa Centro-Europea, in direzione dell'elaborazione di Convenzioni internazionali<br />
sulla materia, la C.S.C.E. tornò, nel 1992, in occasione del vertice di Helsinki, che si pronunciò<br />
per la creazione di un Alto Commissario per le minoranze nazionali, incaricato di vegliare sulle<br />
situazioni di rischio, al fine di prevenire nell'area C.S.C.E. l'esplosione di crisi e di conflitti legati<br />
a questioni relative alle minoranze nazionali (Dichiarazione del vertice di Helsinki 1992, d'ora in<br />
poi H. 1992, parte I, paragrafo 23).<br />
Le caratteristiche ed il ruolo di questa figura sono individuate in H. 1992, parte II, paragrafi<br />
1, 37.<br />
L'Alto Commissario, nominato dal Consiglio della C.S.C.E. su raccomandazione del<br />
Comitato degli alti funzionari (par. 9), nella persona di una "eminente personalità internazionale<br />
dotata di una lunga e notevole competenza" ed in grado di dare la massima garanzia di imparzialità<br />
(par. 8), agisce sotto l'egida del Comitato degli alti funzionari (CAF); esso è definito come<br />
"strumento per prevenire i conflitti per quanto più possibile nella fase iniziale" (par. 2).<br />
Il suo compito è, cioè, quello di impedire che l'inasprirsi di situazioni di potenziale tensione<br />
relative a questioni concernenti le minoranze nazionali diano luogo a crisi conclamate o a<br />
veri e propri conflitti, mettendo a rischio la pace e la stabilità nell'area C.S.C.E..<br />
Egli agirà assicurando un "preallarme" ed eventualmente una "azione tempestiva" che<br />
mirino ad impedire il degenerare delle tensioni e dunque richiedendo, ove il caso lo renda necessario,<br />
l'intervento del CAF o del Consiglio dei Ministri della C.S.C.E. (par. 3).<br />
Nell'espletamento di questo compito, [per il quale egli si avvarrà dei mezzi dell'Ufficio<br />
per le istituzioni democratiche ed i diritti umani di Varsavia (ODIHR, par. 10) e che svolgerà agendo<br />
in via confidenziale ed indipendente da tutte le parti interessate (par. 4)] tale organo potrà<br />
raccogliere informazioni concernenti le questioni di cui è investito da qualsiasi fonte, ivi compresi<br />
i mezzi di informazione e le Organizzazioni non governative (ad eccezione soltanto delle<br />
persone od organizzazioni di natura terroristica); dalle stesse potrà, su loro iniziativa, ricevere<br />
rapporti sugli sviluppi delle questioni relative alle minoranze nazionali (parr. 23, 25). A questo<br />
proposito, è importante sottolineare che nel par. 23b si sottolinea che tali rapporti possono riguardare<br />
sia "le violazioni degli impegni C.S.C.E." che "altre violazioni nel contesto di questioni<br />
relative a minoranze nazionali".<br />
A tutela dell'imparzialità del suo intervento, il par. 5a specifica che nel caso l'intervento<br />
dell'Alto Commissario sia richiesto in situazioni che si verificano nello Stato di cui egli è cittadino<br />
263
o nelle quali sia coinvolta una minoranza alla quale questi stesso appartiene, lo stesso potrà agire<br />
solo previo consenso di tutte le parti direttamente coinvolte.<br />
Cosa debba intendersi in questo caso come "parti direttamente coinvolte" viene specificato<br />
nei parr. 26, 26b. Esse sono, in primo luogo, i governi degli Stati membri della C.S.C.E. e<br />
gli enti regionali e locali delle aree ove risiedono le minoranze nazionali. A questi si aggiungono<br />
quelle che potremmo definire le controparti, cioè i "rappresentanti delle associazioni, delle organizzazioni<br />
non governative e di altri gruppi delle minoranze nazionali (...) che siano autorizzati a<br />
rappresentarle dalle persone appartenenti a quelle minoranze nazionali".<br />
Con tutte le parti citate l'Alto Commissario si incontrerà e si confronterà nel corso delle<br />
visite che farà nelle aree di crisi, allo scopo di approfondire la conoscenza dei problemi e promuovere<br />
il dialogo, la comprensione e la cooperazione, nella prospettiva di una soluzione non<br />
traumatica delle controversie (parr. 11, 12). Le condizioni di tali visite sono definite nei parr. 27,<br />
30 di H. 1992.<br />
Nell'espletamento delle sue mansioni, egli può fare ricorso all'aiuto di esperti, che abbiano<br />
il gradimento di tutte le parti e che collaborino con lui nella individuazione delle problematiche<br />
e delle possibili soluzioni (parr. 31, 16).<br />
L'Alto Commissario, inoltre, agisce in stretto rapporto con il Presidente, e con questi si<br />
consulta prima di intraprendere missioni esplorative e per il suo tramite informa il CAF dei risultati<br />
raggiunti, emanando, ove lo ritenga opportuno, un preallarme (parr. 13, 15) e chiedendo<br />
eventualmente un ampliamento del mandato consultivo e la facoltà per esperire eventuali soluzioni<br />
(parr. 17, 22 su Responsabilità e par. 16 su Azione tempestiva).<br />
In definitiva, l'Alto Commissario della C.S.C.E. (ora, O.S.C.E.) per le minoranze nazionali<br />
rappresenta in qualche modo il diretto referente dell'organizzazione per le questioni riguardanti<br />
violazioni delle norme in materia di tutela di diritti delle minoranze, ed il tramite, a un tempo,<br />
tra le istanze della base e i livelli istituzionali più alti dell'organizzazione.<br />
Dall'esame di H. 1992, sembra poi di poter dedurre che esso sia dotato di un potere autonomo<br />
di iniziativa, almeno per quel che riguarda le indagini conoscitive generali, fermo restando<br />
il fatto che, ove da queste risultino situazioni che richiedano interventi specifici, è tenuto<br />
previamente a informare delle eventuali ulteriori iniziative il CAF, tramite il suo Presidente.<br />
Le indagini conoscitive, del resto, oltre a far parte dei compiti istituzionalmente propri<br />
dell'Alto Commissario, possono essere sollecitate dall'esterno, in particolare, da quanto si deduce<br />
dai parr. 23b e 24, dai rapporti che gli vengono autonomamente inviati dalle parti direttamente<br />
coinvolte in eventuali contenziosi o situazioni di potenziale crisi.<br />
In sostanza, le minoranze nazionali che ritengano violati i diritti (garantiti loro dai documenti<br />
C.S.C.E. e da altri documenti internazionali sul tema), possono inviare rapporto all'Alto<br />
Commissario, che, in seguito a ciò, avvierà la propria indagine e le proprie consultazioni con le<br />
parti, al fine di approfondire le questioni aperte e comporre positivamente le controversie, ricorrendo,<br />
ove il suo intervento risulti inefficace, alle istanze istituzionali superiori.<br />
La notevole autonomia operativa di cui l'Alto Commissario gode, almeno fino alla emanazione<br />
del preallarme, ne fa uno strumento di intervento tempestivo e flessibile, che dovrebbe<br />
rispondere adeguatamente agli scopi essenzialmente preventivi per i quali è stato istituito.<br />
A ciò contribuisce anche la natura "confidenziale", dunque informale e non impegnativa,<br />
del suo intervento e delle sue consultazioni. Infatti, nelle intenzioni dei redattori del documento,<br />
viene sottolineato più volte in positivo tale caratteristica; in tal modo si è creduto di consentire<br />
un approccio meno formale alle questioni specifiche, dato che si possono battere, eventualmente,<br />
percorsi al di fuori delle formali vie della diplomazia.<br />
Dal quadro fin qui delineato, risulta evidente che la figura dell'Alto Commissario è stata<br />
pensata tenendo presenti le problematiche relative alle grandi minoranze nazionali in grado,<br />
come gli eventi degli ultimi anni hanno più volte drammaticamente dimostrato, di mettere realmente<br />
in pericolo la stabilità, la pace e le relazioni tra gli Stati dell'area O.S.C.E.. Le situazioni in<br />
cui gli viene richiesto di intervenire si configurano, infatti, come situazioni di grave tensione interna<br />
od internazionale, passibili, ove non si intervenga tempestivamente nella maniera adeguata,<br />
di sfociare in conflitti non soltanto diplomatici o verbali.<br />
Va rilevato, peraltro, che in numerosi Paesi dell'area O.S.C.E. - e l'Italia è tra questi -,<br />
accanto alle minoranze di questo tipo, esistono minoranze per così dire "minori", le cui rivendicazioni<br />
non assurgono, in molti casi, alla sfera politica, anche per la obiettiva difficoltà che ad un<br />
approccio di questo tipo oppongono le loro situazioni geografiche e i loro percorsi storici, ma<br />
264
sono, invece, molto forti sul piano linguistico, culturale, religioso e, in quanto pertinenti alla sfera<br />
dei diritti fondamentali della persona, pienamente legittime, come sancito anche dalla Dichiarazione<br />
ONU sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e<br />
linguistiche (1992).<br />
In considerazione della estrema diversificazione delle situazioni relative alle minoranze<br />
sul territorio dei diversi Stati membri, altri organismi internazionali, quali la I.C.E. e il Consiglio<br />
d'Europa, hanno affrontato la questione nei termini di documenti-quadro, che coniugano la<br />
massima estensione della tutela alla estrema adattabilità degli interventi alle diverse situazioni<br />
specifiche.<br />
Tale impostazione estensiva non risulta, forse volutamente, presente in modo esplicito<br />
nella definizione del ruolo dell'Alto Commissario per le minoranze nazionali come definito in H.<br />
1992.<br />
Tenendo presente il cammino compiuto in questa materia in sede C.S.C.E./O.S.C.E., si<br />
può affermare che la figura dell'Alto Commissario è suscettibile di un'interpretazione più ampia<br />
di quanto a un primo impatto possa sembrare.<br />
In effetti, seppure le terminologie adottate suggeriscono in prima istanza scenari di gravi<br />
rischi per la pace e la stabilità interna ed internazionale, che per forza di cose non sarebbero<br />
certamente imputabili alle "piccole" minoranze, nulla vieta, né implicitamente né esplicitamente,<br />
che, nell'autonomo espletamento del proprio mandato istituzionale, l'Alto Commissario assuma<br />
informazioni anche sullo stato di tutela dei diritti di queste ultime, o che queste gli facciano pervenire<br />
rapporti e sollecitino un suo intervento, secondo le procedure descritte da H. 1992, parte<br />
II, parr. (23) - (26b).<br />
Tale interpretazione muove dallo stato di tensione o di crisi, includendo peraltro tra le situazioni<br />
passibili dell'intervento dell'Alto Commissario anche quelle che, pur non recando grave<br />
pregiudizio alla stabilità interna degli Stati o a quella internazionale, si configurino comunque<br />
come stati di violazione dei diritti delle persone appartenenti alle minoranze, che mettono a rischio<br />
la serena convivenza civile nelle zone interessate ed i rapporti delle minoranze con l'autorità.<br />
Una impostazione di questo tipo sembra, peraltro, autorizzata, oltre che dalla mancanza<br />
di impedimenti espliciti, dal paragrafo 23b, laddove si fa riferimento, in modo non a caso generico,<br />
a rapporti "sulle violazioni degli impegni CSCE relative alle minoranze nazionali nonché su<br />
altre violazioni nel contesto di questioni relative a minoranze nazionali".<br />
In suo favore vale anche la constatazione che una interpretazione restrittiva del ruolo<br />
dell'Alto Commissario verrebbe ad istituzionalizzare di fatto una forma di sperequazione tra<br />
gruppi di persone che, pur nella obiettiva diversità delle situazioni e dei rischi ad esse connesse,<br />
sono titolari, in linea di principio, degli stessi diritti, e si porrebbe in contrasto con i risultati che in<br />
materia di tutela delle minoranze sono stati conseguiti in altri ambiti istituzionali di livello internazionale.<br />
265
I WALSER: MINORANZA FIERA<br />
Un gruppo etnico il cui nome deriva da “Valliser” cioè abitanti del Vallese. I primi stanziamenti<br />
erano costituiti da servi della gleba legati ad un feudatario o ad ordini ecclesiastici,<br />
che presto si resero liberi<br />
L’area geografica di interesse comprende i comuni di Gressoney-St. Jean (763 ab.),<br />
Gressoney-La Trinité (285 ab.), Issime (373 ab.), Alagna Valsesia (430 ab.), Macugnaga (626<br />
ab.) e Formazza (461 ab.). Dall'ottavo secolo gli Alemanni, che occupavano le valli inferiori del<br />
Reno e le prealpi svizzere, risalirono l'Oberland bernese e s'affacciarono all'altopiano del Goms.<br />
Incominciò così la colonizzazione tedesca dell'Alto Vallese (mt. 1200-1400 di quota), la più elevata<br />
e straordinaria delle colonizzazioni alpine.<br />
L'altitudine, il clima, le insidie, le valanghe, le difficoltà di collegamento posero problemi<br />
di adattamento e svilupparono la necessità di una minima autosufficienza agricola; l'allevamento<br />
del bestiame, la sola risorsa disponibile, richiese opere di disboscamento, canalizzazione delle<br />
acque, costruzione di sentieri e ponti.<br />
La conca del Goms, trasformatasi così in valle fertile, si popolò di rudi montanari che<br />
aumentarono di numero e non trovavano più i mezzi sufficienti per sopravvivere. Molti lasciarono<br />
allora i loro villaggi e, seguendo l'atavico istinto di emigrare, portarono le loro esperienze in<br />
altre valli altrettanto alte o più ancora, dove nessuno aveva mai tentato di abitare.<br />
Dall'alta valle del Goms si spostarono gradatamente nelle valli laterali del Vallese.<br />
Il nuovo interesse verso lo sfruttamento della montagna sugli alti dorsali e l'istinto di emigrare<br />
portarono poi questa gente oltre le frontiere del Vallese. Questi montanari scesero dal<br />
Furkapass, termine della valle del Goms, lungo la valle del Reno.<br />
Successivamente, si spostarono verso Triesenberg nel Liechtenstein ed il Voralberg,<br />
ove due valli presero il nome dei primi abitanti (cioè Groswalsertal e Kleinwalsertal).<br />
La emigrazione verso l'Italia avvenne in un primo tempo attraverso il valico del Gries<br />
popolando Pomat, l'attuale Val Formazza e la Val Antigorio, ove sorse l'alta terrazza di Salecchio,<br />
poi, attraverso il Sempione sino ad Ornavasso, il più meridionale stanziamento walser in<br />
territorio italiano.<br />
Attraverso il colle del Monte Moro ed il passo del Teodulo, i Walser raggiunsero tutte le<br />
testate delle valli a sud del Monte Rosa (cioè Macugnaga, Campello Monti, Rimella, Rima, Alagna,<br />
la Val Vogna, Gressoney, Issime ed Ayas).<br />
Questi primi colonizzatori, abitanti in comunità chiuse ed in luoghi senza traccia di precedenti<br />
popolazioni, a quota non inferiore ai 1200 metri, si chiamano "Walser", parola che deriva<br />
da "Valliser" cioé abitanti del Vallese.<br />
I Walser, nei loro primi stanziamenti, erano per lo più servi della gleba legati ad un feudatario<br />
o a un ordine ecclesiastico. Presto si resero liberi.<br />
Il Monte Rosa, il gigante a cui gli abitanti della pianura padana diedero i nomi leggendari<br />
di Momboso, Mons Silvius, Gletscher, Roisa, Rosa che vuol dire montagna ghiacciata, ha<br />
raccolto attorno a sé, da tutti i versanti, i Walser. Limitatamente a Gressoney ed Issime, i primi<br />
documenti ufficiali che dimostrano questi insediamenti sono:<br />
Il 9 gennaio 1218 nel Castello di Quart (Valle d'Aosta) Giacomo delle Porta di Sant'Orso<br />
riunì al sua capezzale il rappresentante del Vescovo di Sion, il Vescovo di Aosta e la nobiltà<br />
valdostana per dichiarare di tenere "tutto il feudo da lui posseduto nella Valle sopra Issime, al di<br />
là del Lys, sino alla sommità dei monti, terre colte ed incolte, pascoli, boschi, prati e le Alpi di<br />
Gressoney e Verdoby".<br />
A tale documento conservato, salvo errore, nella Curia Vescovile di Sion, si aggiungono<br />
altri documenti analoghi.<br />
L'8 settembre I377, un gruppo di una trentina di montanari abitanti nella zona di Orsio, a<br />
monte del capoluogo di Gressoney-La Trinitè, dichiarano, con atto notarile, redatto dal notaio<br />
Franqui François, in una casa in frazione Nocesch: "di aver tenuto e di avere ancora in feudo<br />
l'alpe di Orsio direttamente dal signor Ebal di Challant, al prezzo di otto fiorini d'oro di buon peso<br />
e sei libbre di burro all'anno, oltre quattro pecore ad anni alternati". Copia di tale atto è conservato<br />
nell'archivio del Comune di Gressoney-La Trinité.<br />
Con il XVI secolo iniziò un peggioramento climatico che ebbe il suo punto culminante<br />
nel secolo successivo e duró, con fasi alterne, sino alla fine dell'ottocento.<br />
266
I Walser subirono gravi contraccolpi dalla nuova situazione climatica. L'avanzare del<br />
fronte dei ghiacciai interruppe le comunicazioni attraverso i valichi più alti, distrusse pascoli e<br />
culture, in qualche caso arrivò a compromettere le stesse abitazioni. E' sufficiente un raffreddamento<br />
medio di un grado in un arco di un ventennio perchè un ghiacciaio riesca ad allungare<br />
il suo fronte di 300-400 metri. Erano giunti, quindi, i tempi in cui i Walser emigrarono verso città<br />
e paesi della pianura.<br />
Gli abitanti della Valle del Lys, chiamata poi "Krämertal" (Valle dei mercanti) ritornarono<br />
verso città di lingua tedesca (cioè in Svizzera e nella Germania meridionale) ove esercitarono<br />
quasi esclusivamente le attività di mercanti in stoffa.<br />
L'idioma walser, che nella sua stabilità fondamentale ha conservato le sue antiche radici,<br />
è il segno distintivo dei Walser, al punto che ancor oggi permette di riconoscere come tale<br />
chi lo parla, distinguendolo nettamente dagli abitanti della rimanente sfera linguistica tedescoalemanna.<br />
E' pur vero che nel corso del tempo anch'esso, come ogni lingua vivente, ha subito delle<br />
mutazioni, imputabili in massima parte all'isolamento delle colonie e all'allentarsi graduale dei<br />
legami con la madrepatria.<br />
A Gressoney il titsch si è conservato particolarmente bene proprio grazie alla continuità<br />
dei rapporti economici e culturali con la madrepatria, attraverso i Krämer e attraverso le famiglie<br />
gressonare stabilitesi nella Svizzera che mantenevano i contatti con il loro paese d'origine.<br />
Ci sono parecchie testimonianze nel corso dei secoli dell'attaccamento dei Walser alla<br />
loro lingua.<br />
Accanto alla Chiesa, anche la scuola è stata un'istituzione molto attiva per la conservazione<br />
del tedesco (almeno a Gressoney, perché ad Issime veniva insegnato solo il francese).<br />
Nelle numerose scuole della valle infatti si insegnava a leggere, a scrivere e a far di conto in tedesco;<br />
l'italiano venne introdotto solo dopo il 1870, quando l'istruzione pubblica fu regolata dalle<br />
disposizioni del governo italiano.<br />
Ancora dai censimenti del 1901 e del 1921 risulta che piú del 90% degli abitanti di<br />
Gressoney parlava abitualmente il tedesco (ossia il titsch). Oggi la situazione è notevolmente<br />
cambiata! Una volta nelle famiglie si parlava solo il titsch: l'italiano ed il piemontese erano usati<br />
per lo più con i forestieri. Oggi invece si parla spesso italiano anche in quelle famiglie che sono<br />
gressonare da secoli, con l’inevitabile erosione della lingua walser.<br />
Una particolarità della minoranza linguistica walser è l’architettura della casa di abitazione<br />
(puròhus). Essa, infatti, comprendeva il piano terreno adibito a stalla per le bestie e nello<br />
stesso tempo ad abitazione per gli uomini (wòhngade). Per wòhngade si intende quella parte di<br />
locale separata da quella delle mucche per mezzo di una staccionata, parete o paratoia in legno,<br />
allo scopo di poter beneficiare del calore prodotto dagli animali durante l'interminabile inverno.<br />
Tralasciando il wòhngade, troviamo entrando dalla porta principale un ampio corridoio di<br />
disimpegno (questa è una prerogativa della casa gressonara) dal quale si accede alla stalla, alla<br />
cucina (firhus) ed alla sottostante o retrostante cantina (chär). Generalmente in questo ampio<br />
corridoio si trova un camino (trächò) sul quale un tempo cucinavano in grandi paioli; si lavorava<br />
il latte, si preparava il cibo per gli animali e si affumicavano alcuni generi alimentari, quali la carne,<br />
il lardo ed il salame.<br />
Dal corridoio, una scala in pietra oppure in legno dà accesso al piano superiore, la cui<br />
struttura è completamente in legno: essa consiste in grosse travi squadrate (flecke) con l'ascia,<br />
unite perfettamente nella loro lunghezza, distese su di un leggero strato di muschio ed intrecciate<br />
alla loro estremità con intagli regolari, infine rivestite nella parte interna da robuste assi, generalmente<br />
di larice. In questo piano ci sono le camere da letto; un vano con funzione di ripostiglio<br />
per i vari arnesi necessari ai lavori campestri; un altro infine chiamato heizstòbò, cioè una camera<br />
riscaldata dalla stufa in pietra. Anche in questo piano si trova il corridoio di disimpegno,<br />
comunicante, per mezzo di un'altra scala, con il secondo piano. Questo presenta un lungo impiantito<br />
fatto di robuste tavole rese levigatissime dalla trebbiatura della segale e dell'orzo (treschtenn).<br />
Una divisoria trattiene la massa del fieno necessaria durante i sette mesi invernali e<br />
che occupa la maggior parte del piano. Sullo stesso si trova la dispensa (spicher). Questo era<br />
certo il locale più interessante di tutto l'edificio, poiché in esso venivano riposte le provviste per<br />
l'annata, consistenti in pane sistemato in apposite rastrelliere (rächtòliera), in carne macellata<br />
durante il periodo freddo e debitamente salata, in lardo e salame affumicati, appesi a ganci di<br />
267
legno; poi ancora farina, granoturco, riso, ecc... contenuti in ampi cassoni a più scomparti (òcker).<br />
Lo spiovente del tetto è molto ampio lungo tutti i lati della casa, per difendere la stessa<br />
dalle intemperie. Tutto il tetto è coperto da larghe «lose» (blatte) sostenute da una fitta e forte<br />
travatura, tale da resistere all'ingente peso della neve. Sotto la sporgenza della trave maestra di<br />
ogni casa sono incisi la data di costruzione, le iniziali dei proprietari e qualche volta un simbolo<br />
walser.<br />
Il colore originale di questi legnami era il rosso chiaro o il giallognolo, anneriti col tempo<br />
per l'effetto della resina che, trasudando durante l'estate, formava una specie di vernice che<br />
preservava il legno dall'umidità.<br />
268
TRA PUGLIA E CALABRIA VIVONO I GRECI D’ITALIA<br />
La minoranza linguistica si costituì insediandosi nelle due regioni. Oggi vive in alcuni<br />
comuni delle province di Lecce e di Reggio Calabria. Nei centri costieri si è trasferita la<br />
popolazione grecanica albanese<br />
La minoranza linguistica greca si è costituita insediandosi nelle regioni Puglia e Calabria.<br />
In particolare: in provincia di Lecce nei centri di Calimèra, Castrignano dei Greci, Corigiliano<br />
d’Otranto, Martano, Martignano, Sternatìa, Zollino, Melpignano e Soleto; in questi ultimi due<br />
paesi la lingua minoritaria non è più usata, se non da pochissimi anziani, ma nel 1988 tutti i comuni<br />
si sono consorziati per la valorizzazione e lo sviluppo dell’area ellenofona del Salento; in<br />
provincia di Reggio Calabra nei centri di Amendolea (fraz. Di Condofùri), Bova, Roghùdi e Gallicianò<br />
(frazione di Condofùri). Vi sono, poi, i centri costieri (Reggio Calabria, Milito Porto Salvo e<br />
Bova Marina), nei quali, per motivi diversi, negli ultimi anni si è trasferita gran parte della popolazione<br />
grecanica calabrese. Si rileva, altresì, che a Condofùri, Chorìo di Roccaforte e Roccaforte<br />
del Greco la lingua non è più utilizzata.<br />
La minoranza linguistica greca è individuata con il termine di “greco-calabri” e “grecosalentini”<br />
e rappresenta quegli italiani dell’Italia meridionale che parlano, ancora oggi, la lingua<br />
greca. La lingua che questi parlano è detta da loro stessi “grico” in Puglia, forse dall’osco “griko”,<br />
piuttosto che dal latino “grecus”, mentre in Calabria è denominata “greco”.<br />
L’etnonimo “grico” distingue questi greci, che risalgono ad antichissimi insediamenti, dai<br />
greci moderni.<br />
Alcuni studiosi, come il professor Giuseppe Morosi ed il professore Oronzo Parlangeli,<br />
sostengono la tesi secondo cui l’origine va collocata nel periodo bizantino, dal V secolo dopo<br />
Cristo in poi.<br />
Alcuni periodici vengono stampati in lingua greca e due stazioni radio private trasmettono<br />
alcune trasmissioni in lingua greca.<br />
Cenni sulla letteratura<br />
L’Italia meridionale ancora oggi manifesta chiaramente la sua matrice bizantina, sia<br />
nell’architettura sia in alcune forme liturgiche, sia, infine, in alcuni testi letterari.<br />
Pietro Pompilio Rodotà, un italo-albanese del XVIII secolo, scrivendo la sua monumentale<br />
opera “Dell’origine, progresso e stato presente del rito greco in Italia” volle mettere in rilievo<br />
la presenza dell’espressione liturgica bizantina in Italia, ma accanto a ciò evidenziò anche lo<br />
sviluppo della civiltà bizantina nel nostro Paese.<br />
Egli così sintetizza il contenuto dei tre volumi: il primo mette in chiaro l’”origine”, che si<br />
attribuisce ai Greci, nel secolo VIII; il secondo evidenzia il “progresso”, di cui furono autori i monaci,<br />
che lo incrementarono con molto onore; il terzo espone lo “stato presente” che va difeso<br />
con incomparabile accanimento.<br />
Si devono a questa presenza greca il sorgere di una letteratura agiografica di notevole<br />
significato e le prime espressioni poetiche giunte fino a noi.<br />
E’ rilevante ricordare i vetusti codici che venivano scritti nei monasteri della Calabria,<br />
ancora oggi validi documenti di una tradizione culturale agiografica e liturgica.<br />
I manoscritti che risalgono al Medioevo, dal X al XVI secolo, contegno un ricco materiale.<br />
Essi riguardano vite di santi, calendari liturgici, regole della vita monastica, inni dei santi.<br />
Ma la ricchezza creativa di inni dedicati a santi di origine calabrese emerge chiara dagli<br />
“Analecta Hymnica Greca a codicibus eruta Italiane inferioris”, curata dall’istituto di studi bizantini<br />
dell’Università degli studi di Roma.<br />
Non si può parlare di originali opere letterarie; tuttavia, le varie agiografie e le numerose<br />
composizioni innografiche sono testimonianza di un’intensa attività culturale e della consistenza<br />
delle conoscenze degli autori.<br />
Le varie composizioni letterarie riflettono due mondi: quello orientale e quello occidentale,<br />
che hanno dato particolare lustro sia alla civiltà bizantina sia a quella greca classica.<br />
Mentre nel resto dell’Italia la cultura giaceva in una condizione di stasi, in Calabria, ad<br />
esempio, la cultura greca si affermava con vivacità e notevole creatività.<br />
Soprattutto nei secoli X e XI si registra un fiorire della letteratura, dell’innografia, della<br />
melurgia.<br />
269
Tra le personalità che si sono distinte ricordiamo il monaco Cosma che fu precettore di<br />
S. Giovanni Damasceno, Italo Giovanni, nativo della Calabria settentrionale, un filosofo che tentò<br />
di interpretare da un punto di vista cristiano la filosofia di Aristotele. Da segnalare, inoltre, il<br />
filosofo Barlaam, di Seminara di Calabria (1920), uno dei più colti grecisti e ottimo filosofo, maestro<br />
del Tetrarca.<br />
La letteratura orale<br />
La prima segnalazione del patrimonio tradizionale letterario grecanico è stata fatta nel<br />
1821 dallo studioso tedesco Karl Witte, il quale rese noto il canto di Bova “Sole che per tutto il<br />
mondo cammini”.<br />
Sole che per tutto il mondo cammini,<br />
che da levante a ponente vai,<br />
quella che io amo tu la vedi:<br />
salutamela e vedi se ti ride.<br />
Se essa di me ti domanda,<br />
dille che io soffro molti guai;<br />
se essa non ti domanda,<br />
consolazione non abbia mai.<br />
Il sole che per tutto il mondo cammina,<br />
da levante a ponente va;<br />
tu che vai e vieni spesso,<br />
gettami acqua santa se m’ami:<br />
tu che vai e vieni spesso,<br />
salutamelo e vedi se ride:<br />
se succedesse che non ti domandi (di me),<br />
consolazione non abbia mai.<br />
Sole, che tutto il mondo percorri,<br />
da levante a ponente vai;<br />
colui che voglio io, tu lo vedi:<br />
salutamelo e vedi se ti ride;<br />
gli dirai che l’amo moltissimo<br />
e dalla memoria non m’esce mai.<br />
Come colombo ti proto il becchime,<br />
e tu tiranno non mi saluti.<br />
(da “Testi neogreci di Calabria”, a cura di Rossi Taibbi e Girolamo Caracausi, istituto siciliano di<br />
studi bizantini e neogreci, Palermo, 1959, pp. 324-325).<br />
Successivamente nei “Saggi dei dialetti dell’Italia meridionale” (Pisa 1866), lo studioso<br />
Domenico Comparetti pubblicava un ricco materiale di letteratura orlae: 38 canti di Bova, tre di<br />
Corigliano e uno di Martano, oltre alla versione dello “Stabat Mater” e due lettere nel dialetto di<br />
Calmiera.<br />
Altri continuarono le ricerche e nel 1870 un discepolo di Graziadio Isaia Ascoli, Giuseppe<br />
Morosi, pubblicava a Lecce saggi della tradizione letteraria orale dei Greci del Salento: 177<br />
canti, cinque leggende, 62 proverbi, sette indovinelli registrati nelle comunità di Calmiera, Castrignano<br />
dei Greci, Corigliano, Zollino, Soleto, Sternatia, Martignano e Melpignano.<br />
L’attenzione del Morosi si rivolse anche ai Greci di Calabria; infatti, dopo accurate ricerche,<br />
nel 1879, diede alle stampe il lavoro “I dialetti romaici del mandamento di Bova”, in cui inserì<br />
una raccolta di saggi popolari: 40 canti, 134 proverbi, 36 scherzi e motti, 18 similitudini, registrati<br />
a Bova, Roccaforte, Roghudi, Cardeto.<br />
La raccolta continuò a cura degli studiosi Astorre Pellegrini, Ettore Capialbi, Luigi Bruzzano,<br />
Pasquale Candela ed, infine, del tedesco Gerhard Rohlfs.<br />
270
La letteratura colta<br />
La creatività letteraria giunta a noi segna i primi passi a datare dal XVII secolo con<br />
Franceso Antonio De Marco di Bova.<br />
Sindaco di Bova e poeta, il De Marco ci ha lasciato un manoscritto di 216 pagine, in cui<br />
accanto a liriche in dialetto calabrese inserisce sei composizioni in grecanico.<br />
E’ ormai tramontato il sentimento mistico dei monaci, mentre prende piede la passione<br />
romantica, a volte scomposta, che rigflette da un lato sfrenati impulsi e, dall’altro, inquietanti<br />
quadri di panorami paesani.<br />
Anche se nella sua lirica si possono notare espressioni di un romanticismo licenzioso,<br />
tuttavia la cultura religiosa, tramandata durante il periodo bizantino, non scompare nel nulla, ma<br />
lascia tracce significative a testimonianza di un passato che ancora parla.<br />
L’Ottocento è un secolo ricco di nomi che fanno rivivere la tradizione linguistica grecanica.<br />
Anche se pochi sono gli scrittori che presentano opere originali di valore letterario, essi con i<br />
loro scritti di diverso genere danno continuità alla cultura e rivitalizzano l’interesse per la cultura<br />
greca in Italia.<br />
Basta ricordare alcuni nomi: Vincenzo Mesiani (1776-1833) di Bova, ha composto liriche<br />
tanto in italiano che in grecanico; Giuseppe Autelitano (Bova, 1785-1854), prima canonico<br />
nella Cattedrale di Bova e poi vescovo di Nusco, si interessò di studi storici ed ecclesiastici, lasciando<br />
una interessante monografia sulla sotria di Bova con preziose notizie; Giuseppe Viola,<br />
pure di Bova, che tradotto in grecanico parti dell’Antico e del Nuovo Testamento; Francesco<br />
Mario Mandatari (Melito Porto Salvo, 1851-1908), studioso della cultura grecanica con le sue<br />
ricerche storiche contenute in “Biblioteca storico-tipografica delle Calabrie” (postumo, 1928) e i<br />
“Canti del popolo reggino” (1881).<br />
Molti altri diedero un contributo nei diversi campi delle scienze storiche, folcloristiche,<br />
antropologiche e religiose. I loro nomi sono noti perché hanno rappresentato la continuità culturale<br />
e il simbolo della resistenza di una cultura che non si è rassegnata a morire, per cui anche<br />
se i contributi da loro dati possono sembrare a volte limitati, assumono un valore straordinario<br />
se collocati nella dimensione culturale locale grecanica.<br />
Pietro Cutanea (1857-1937), Eugenio Malgari (1865-1937), Domenico Bertone (1865-<br />
1943), Plettro La rizza (1866-1954), Pasquale Natoli (1870-1946), Luigi Borrello (1871-1949),<br />
Andrea Viola (1885-1985) rappresentano i corifei della cultura locale grecanica.<br />
Il Novecento, sulla scia dell’operosità culturale di detti studiosi, segna un vero risveglio<br />
della cultura ed una presa di coscienza relativa al valore della radici storiche.<br />
Gli studi di Gerhard Rohlfs daranno, tra l’altro, u impulso del tutto particolare su un piano<br />
altamente scientifico alla valorizzazione di una cultura e di una lingua millenaria che si tramandano<br />
solo oralmente.<br />
Si assiste al sorgere di circoli, associazioni culturali, che danno vita a iniziative che<br />
promuovono la valorizzazione della cultura grecanica: “La Jonica”, “Jalò tu vua” ecc., e mirano a<br />
dare lo strumento della scrittura proprio alla tradizione orale.<br />
Franceso Numera di Condofuri (1903-1976) con le sue “Rovine di Calabria” cerca, con<br />
protervia, di dare voce a comunità avvolte nel silenzio dei secoli.<br />
Ma è Bruno Casile (Bova, 1923) che dà suono con la sua lirica alla rappresentazione di<br />
linfe le cui origini si perdono nello scorrere del tempo. “Strafonghia sto scotidi” (Barlume nel<br />
buio) è il volume di recente pubblicazione (Jaca Book, 1991), che raccoglie le sue liriche migliori.<br />
Il motivo della madre lontana lo porta riflessioni romantiche che rendono movimentato il<br />
suo verso, introducono il tema dell’emigrazione, e prospettano lo stato della cultura e della lingua<br />
d’origine. La lingua è quella materna, quella della sua terra, quella disprezzata dai colti.<br />
Il suo è un canto alla terra, culla di una cultura millenaria che non bisogna lasciare morire.<br />
I suoi sentimenti sono quelli di tutto il suo popolo che ha combattuto contro la storia,<br />
contro il predominio della cultura egemone, con il solo mezzo della fierezza di appartenere a<br />
una minoranza culturale.<br />
Il suo messaggio non è vuoto, ma si concretizza nella consapevolezza di possedere valori<br />
tradizionali di notevole portata, valori che vengono trasmessi ancora oggi alle nuove generazioni<br />
che la proietteranno in futuri lontani.<br />
Scriverà:<br />
271
To Prozzìmi emì to eccome Il lievito noi lo abbiamo,<br />
Arte meni assà, pedìa, ora spetta a voi, ragazzi,<br />
ti echete to alevri che avete la farina<br />
ce larga ene i jerusìa e lontana (per voi) è la vecchiaia.<br />
I più giovani, infatti, non dovrebbero lasciare cadere nel vuoto le parole di Casile.<br />
Domenico Rodà, di Gallicianò (1947), con piena consapevolezza scrive pregevoli riflessioni<br />
sulla “lingua mozzata”, sull’isolamento della cultura grecanica, ma anche sulla continuità<br />
della sua trasmissione anche di fronte alla sfida dei secoli.<br />
Salvino Numera, di Chorio di Roghùdi (1952), con la sua raccolta di poesie grecaniche<br />
“Agapao na graspo” (Amo scrivere) trasmette un senso di serenità anche di fronte al destino<br />
che sovente si mostra avverso.<br />
La sua poesia riflette le istanze della sua gente, elevandole dal concreto per proiettarle<br />
in una dimensione universale.<br />
La voce della poesia diventa sempre più robusta e da isolata è diventata un coro che<br />
comprende molti altri scrittori: Filippo Condemi, Savino Nucera, Angelo Malsano, Agosrtino Siviglia<br />
e Salvatore Siviglia. Il legame con il passato non solo non si è spezzato ma, addirittura, va<br />
rafforzandosi proprio negli ultimissimi tempi, prospettando un futuro destinato a combattere contro<br />
la disperazione della storia.<br />
272
GLI ELLENOFONI DI PUGLIA NEL CUORE DEL SALENTO<br />
Tra Lecce, Otranto e Gallipoli sono ancora vive lingua, tradizioni, gastronomia, musica<br />
e architettura di origine greca. Una presenza che si fa risalire alla più remota antichità,<br />
collegata in maniera leggendaria a eventi come la guerra di Troia e ai viaggi degli<br />
eroi che la combatterono.<br />
Un’area di forma approssimativamente triangolare, posta nel cuore del Salento, tra<br />
Lecce, Otranto e Gallipoli, denominata Grecìa Salentina, costituisce l’area ellenofona residuale<br />
di Puglia. Un tempo molto più estesa, tanto da coincidere con la Terra d’Otranto (le attuali<br />
provincie di Lecce, Brindisi, Taranto e, in parte, di Matera), è oggi corrispondente ai territori<br />
dei comuni di Calimera, Castrignano dei Greci, Corigliano d’Otranto, Martano, Martignano,<br />
Melpignano, Soleto, Sternatia e Zollino, nei quali sono vive lingua, tradizioni, gastronomia,<br />
musica, architettura di origine greca.<br />
La presenza dei Greci nel Salento si fa risalire alla più remota antichità, collegata in<br />
maniera leggendaria ad eventi come la guerra di Troia ed ai viaggi degli eroi greci che la<br />
combatterono.<br />
Altre fonti collegano la venuta dei greci a Teseo, Diomede o parlano di insediamenti<br />
di genti illiriche e locresi aggregate a Idomeneo.<br />
Può apparire strano che solo Taranto, nel Salento, fosse colonia greca, vista la vicinanza<br />
di quest’area alla Grecia, ma c’è probabilmente da tenere conto sia della scarsità dei<br />
siti idonei alla creazione di insediamenti, che della strategia adottata nella realizzazione degli<br />
stessi, poiché le rotte più frequentate toccavano appena la punta estrema del Salento per<br />
puntare alla Sicilia ed al Tirreno. A ciò si aggiunga che il promontorio japigio era abitato e difeso<br />
da un’altra popolazione, quella dei Messapi, i primi abitanti del Salento storicamente<br />
documentati, giunti probabilmente dall'Illiria o, come recenti studi sembrano indicare, ancor<br />
prima da Creta. I Messapi non furono sottomessi dai Greci. Furono però ellenizzati, tanto<br />
che adottarono l'alfabeto, i culti religiosi, le tecniche di costruzione dei greci e importarono<br />
manufatti preziosi, ritrovati in gran quantità nelle tombe.<br />
Dopo la conquista romana del III sec. a. C., il territorio salentino, dichiarato ager<br />
pubblicus, fu spartito ai veterani romani e sorsero così grandi aziende agricole a conduzione<br />
servile. I grossi centri messapici furono saccheggiati e distrutti. Sorsero innumerevoli villaggi,<br />
che spesso presero il nome del signore romano, come testimonia la terminazione in –ano di<br />
tanti paesi del Salento, mentre altri villaggi greci furono rinominati con lo stesso criterio.<br />
Ma i numerosi villaggi sorti con Roma in tutto il territorio salentino non prosperarono<br />
a lungo. A partire dal III secolo d.C., alle carestie ed alla malaria si aggiunsero le scorrerie<br />
dei pirati illirici.<br />
La lunga guerra greco-gotica (535-553), voluta dall'imperatore d'Oriente Giustiniano,<br />
per ricongiungere l'Italia all'Impero, coinvolse il Salento, che fu ripetutamente saccheggiato<br />
sia dai Goti che dai Bizantini, i quali ne fecero la testa di ponte per la conquista dell’Italia Meridionale.<br />
La guerra finì nel 553 e nel 568 arrivarono i Longobardi, che costituirono il Ducato di<br />
Benevento. Nelle mani dei Bizantini restarono soltanto Otranto e Gallipoli.<br />
I secoli VIII e IX sono stati forse i più tristi della storia del Salento, perché ai dominatori<br />
Bizantini e Longobardi si aggiunsero gli Arabi che, poste salde basi a Taranto e a Bari,<br />
cercarono di sottomettere l'intera regione. La sorte peggiore fu quella del Salento, privo del<br />
tutto di montagne e di difese naturali e più esposto alle incursioni saracene.<br />
Presenza e rilevanza nel monachesimo<br />
Una importante funzione fu svolta dal Monachesimo Bizantino, che favorì la diffusione<br />
della lingua, del culto e della civiltà bizantina. I monaci si dedicavano alla coltivazione della<br />
vite e dell'olivo, alla pesca, all'allevamento di animali, alla bonifica dei terreni, alla trascrizione<br />
di manoscritti. Spesso si sottoponevano a digiuni e privazioni, ma nei magazzini dei<br />
conventi accumulavano provviste, che servivano a sfamare non solo i monaci, ma anche la<br />
popolazione dei villaggi vicini, nei periodi di guerre e carestie.<br />
L'afflusso dei monaci basiliani in Italia Meridionale fu favorito dalla guerra iconoclasta<br />
proclamata dall'imperatore Leone III Isaurico, il quale nel 727 ordinò che in tutte le pro-<br />
273
vince dell'Impero fossero rimosse e distrutte le immagini sacre, sostituite, nelle chiese, da<br />
immagini simboliche e da decorazioni floreali o geometriche. L'editto imperiale provocò gravi<br />
torbidi ovunque e fu avversato soprattutto dai monaci, che preferirono trasferirsi in massa in<br />
Italia per sottrarsi alle persecuzioni a cui furono sottoposti.<br />
Essi si stabilirono dapprima in Sicilia e in Calabria, ma poi, nel corso dei secoli IX e<br />
X, abbandonarono queste regioni, occupate dagli Arabi. Il centro di gravità del monachesimo<br />
orientale si spostò sul golfo di Taranto, in prossimità del quale la presenza di grandi gravine,<br />
risultato dell’erosione carsica, favorì la nascita di numerosi grandi villaggi rupestri.<br />
Il fenomeno fu più ridotto nel Salento pianeggiante, nel quale la presenza di avvallamenti<br />
frutto di erosione carsica si limita all’area otrantina (valle dell’Idro e valle delle Memorie),<br />
al capo di Leuca (canale del Ciolo) e in piccola misura a Torre dell’Orso (canale Brunese).<br />
In queste località nacquero villaggi rupestri di discrete dimensioni, ed altri villaggi sorsero<br />
lungo le coste, favoriti dalla morfologia del terreno. Numerose laure, grotte scavate nella<br />
roccia, isolate o a gruppi, sorsero lungo l'Adriatico, specie a Otranto e a Roca Vecchia.<br />
Nel resto del Salento, nacquero gli insediamenti rupestri ipogei, isolati o a piccoli<br />
gruppi, Accanto alle laure vere e proprie, furono scavati depositi, trappeti, palmenti, ecc. e<br />
molti contadini e pastori innalzarono le loro capanne, creando veri e propri villaggi.<br />
Nell'867 saliva sul trono di Costantinopoli un rozzo ma geniale imperatore, Basilio I,<br />
che voleva riconquistare l'Italia Meridionale. Riuscì nel suo intento, e costituì il Thema di<br />
Longobardìa. L'ellenizzazione dell'Italia Meridionale, e in particolare della Terra d'Otranto, è<br />
opera di Basilio I e dei suoi successori, che nella riconquista si avvalsero del Monachesimo<br />
orientale, chiamato Basiliano da San Basilio, anacoreta vissuto a Cesarea, in Cappadocia.<br />
Alla diffusione del Monachesimo orientale si accompagnò la occupazione militare bizantina.<br />
Migliaia di soldati, terminato il servizio militare, si stabilivano per sempre nel sud<br />
d’Italia. Ad essi si aggiungevano funzionari, impiegati e sacerdoti, provenienti da diverse regioni<br />
dell'Impero.<br />
Nel 968 l'imperatore Niceforo ordinava al patriarca Polyeucto di elevare Otranto alla<br />
dignità metropolitana, assoggettando ad essa tutte le altre chiese e sedi vescovili della Puglia<br />
centro-meridionale e della Basilicata (sedi suffraganee dipendenti da Otranto diventavano<br />
Acerenza, Tursi, Gravina, Matera, Tricarico). Inoltre ordinava di sostituire il rito e i sacerdoti<br />
latini con quelli greci.<br />
Nel corso dei secoli IX-XI, il clero greco, molto numeroso, officiava indistintamente<br />
per le due etnie, alternando il lavoro dei campi con le pratiche religiose.<br />
Monaci e sacerdoti si dedicarono anche a copiare testi sacri e profani, a dipingere<br />
affreschi e icone, a insegnare la lingua greca. Molti manoscritti, prodotti nel Salento si trovano<br />
ora nelle principali biblioteche italiane ed europee. A Nardò nacque una scuola di lettere<br />
greche che assunse sempre maggiore importanza, e fu poi ben nota al Petrarca ed al Boccaccio.<br />
Tra i sec. X e XI, a situazione in Puglia non era omogenea. Pur occupata dai bizantini<br />
sia a nord che a sud, rivelava realtà differenti, coincidenti approssimativamente, dal punto<br />
di vista territoriale, con le aree già occupate o meno dai Longobardi. Mentre nel Gargano<br />
ed in provincia di Bari, si viveva la presenza bizantina come oppressione, nel Salento la presenza<br />
greca aveva l’impronta della cultura, della democrazia, del grande fervore religioso<br />
dovuto anche ai privilegi concessi da Costantinopoli ad Otranto.<br />
Riflesso della realtà diversa in Puglia fu l’atteggiamento dei Normanni, che si comportarono<br />
in maniera differente nel nord e nel sud della Puglia. Nel Salento manifestarono<br />
profondo rispetto per la lingua, le istituzioni e la religione della popolazione, anche se introdussero<br />
il feudalesimo e si riconobbero vassalli della Chiesa cattolica. Favorirono il clero latino<br />
ai danni di quello greco e i monaci benedettini ai danni di quelli basiliani.<br />
I Basiliani col passare dei decenni diminuirono di numero e di importanza. Uno dei<br />
provvedimenti presi dai sovrani normanni fu quello di nominare arcivescovo di Otranto un latino,<br />
fedele alle direttive della Chiesa Romana, a cui i Normanni si erano legati.<br />
Venne poi il tempo delle Crociate, ma l'ambiguo comportamento dei capi crociati fece<br />
nascere una profonda diffidenza nei loro riguardi.<br />
Gli imperatori si resero ben presto conto che i veri nemici dell'Impero Bizantino non<br />
erano i turchi o gli arabi, ma i principi cattolici dell'Occidente. E quanto fossero veri i sospetti<br />
nutriti si vide in occasione della IV Crociata (1202-1204), impresa cinica, organizzata dai ve-<br />
274
neziani, che permise ai signori franchi di impadronirsi di Costantinopoli e di fondare l'effimero<br />
Impero Latino d'Oriente. In questa occasione le sculture dei quattro stupendi leoni di Lisippo<br />
finirono a Venezia, ad abbellire la Basilica di San Marco.<br />
Inevitabilmente, ci fu un irrigidimento tra le Chiese cristiane d’Oriente e d’Occidente<br />
ed i rapporti si inasprirono anche a causa di eventi come il saccheggio operato dai Cristiani<br />
a Costantinopoli.<br />
Ma la situazione nel Salento era molto meno conflittuale. Come già accennato, elemento<br />
essenziale nella società greco salentina era la presenza del monachesimo, nelle sue<br />
diverse forme: gli asceti, gli anacoreti e i cenobiti.<br />
La concezione monastica greca era basata sulla spiritualità, e non prevedeva<br />
l’organizzazione in ordini religiosi. In Oriente ogni monastero era indipendente dall’altro ed<br />
attuava una sua regola basata sui principi generali del diritto monastico. Ciascuna regola si<br />
ispirava ai testi ascetici scritti da S. Basilio, S. Giovanni Climaco, poi S. Gregorio Palamas<br />
(1296-1359) ed altri.<br />
Parlare di monaci basiliani, così come si può parlare di monaci benedettini o francescani,<br />
è improprio. E’ stato il Papato, nel 1500, ad avvertire la necessità di definire un ordine<br />
per i monaci italo-greci, creando così il temine di monaci basiliani.<br />
In Italia ed in Grecia, ogni monastero era governato dalla assemblea dei monaci,<br />
che eleggeva i dirigenti del monastero. Nel monastero vi era uguaglianza tra i monaci sacerdoti<br />
(Jeromonaci) e gli altri Monaci.<br />
In Terra d’Otranto, la presenza dei monaci (e monache) è testimoniata già nel IV secolo<br />
da Paolino da Nola (353-431).<br />
Mancano elementi certi di conoscenza sulla vita monastica nel Salento dal V al IX<br />
secolo, ma è molto probabile che si sia avuta una lenta, continua fase di bizantinizzazione,<br />
con l’alternarsi di comunità cenobitiche e piccoli insediamenti di eremiti, di asceti.<br />
Nella prima parte di questo periodo, fino all’VIII secolo, la formazione dei monaci era<br />
esclusivamente finalizzata alla contemplazione di Dio nella tranquillità e nel silenzio. Il digiuno<br />
era, oltre che atto di mortificazione, anche strumento essenziale per la spiritualizzazione<br />
del corpo, da deificare come l’anima.<br />
Nell’VIII secolo cominciava l’era del monaco dotto. Nel IX secolo Marco da Otranto<br />
detto sapientissimo, primo arcivescovo della città, elaborò i capitoli sull’ordinamento liturgico<br />
che ancora si conservano nel monastero di San Saba, in Palestina, dove egli era stato monaco.<br />
Marco compose inni di buon valore letterario, tra cui l’ Inno di Sabato Santo.<br />
Nel X secolo, ad Otranto, i monaci avevano una scuola, coltivavano le lettere e le insegnavano<br />
ai discepoli.<br />
Ottone I cercò di sradicare i greci da terre a lui ribelli, distruggendo archivi monastici<br />
ed episcopali.<br />
Peggio di lui fecero i Saraceni che, dal’827 al 1032, saccheggiarono il Salento, devastando<br />
soprattutto i monasteri, isolati nella campagna.<br />
Nel 1054 si consumò lo scisma tra la Chiesa d’Oriente e la Chiesa d’Occidente. Leone<br />
IX da una parte e Michele Cerulario dall’altra allontanarono le due Chiese, creando una<br />
frattura poi parzialmente ricomposta solo a conclusione del Concilio Vaticano II da Paolo VI<br />
e Atenagora, con il ritiro delle vicendevoli scomuniche.<br />
Ma era una frattura dei vertici, che non incise più di tanto nelle comunità greche<br />
dell’Italia Meridionale. A Otranto, Massafra, Gallipoli, Sibari si nominavano nella messa sia il<br />
Papa che i Patriarca, si cantavano inni in greco, si celebrava con pane azzimo e lievitato,<br />
ecc..<br />
Furono fatti esterni alle comunità, ed in particolare la politica dei Normanni, a modificare<br />
poi lo stato delle cose.<br />
I Normanni, per molestare il Metropolita di Otranto ed il monachesimo italo-greco,<br />
crearono vescovi latini a Castro ed Alessano e soppressero i calogerati basiliani di Lecce e<br />
Nardò, donandoli ai benedettini. Ma non perseguitarono monaci e clero italo-greco.<br />
Testimonianza importante del Monachesimo in Terra d’Otranto nei secoli a cavallo<br />
del Mille è stato il monastero di San Nicola di Casole, ad Otranto, la cui nascita è controversa.Il<br />
nuovo monastero, sorto nel 1099, fu costruito con l’aiuto determinante del normanno<br />
Boemondo, principe di Taranto e di Antiochia.<br />
275
La costruzione del monastero subdiale in muratura era una novità rispetto alla tradizione<br />
monastica precedente, con i cenobi scavati nella roccia.<br />
Così come gli altri monasteri coevi, il monastero di Casole fu dotato di un corpus di<br />
regole, il typicon, scritto nel 1173 dall’Abate Nicola (Niceta), contenente le norme riguardanti<br />
lo svolgimento della vita religiosa e materiale dei monaci.<br />
Proprio nel tempo in cui Nicola scriveva il Typicon, i monasteri italo-greci, raggiunto<br />
l’apice della loro fioritura, cominciavano a veder diminuire lentamente la loro presenza e la<br />
loro influenza in Terra d’Otranto.<br />
San Nicola di Casole, però, non vide scemare la sua influenza e la sua potenza, anzi,<br />
al cenobio fu associata, sostanzialmente, la prima casa dello studente europea; giungevano<br />
a San Nicola di Casole giovani provenienti da tutte le nazioni che si affacciano sul Mediterraneo,<br />
approfondivano gli studi nelle lettere, la filosofia, le scienze per poi ritornare nei<br />
paesi di origine.<br />
San Nicola di Casole era comunque legata alla chiesa di Roma, come dimostra il<br />
censo pagato e ripetutamente documentato (Rationes Collectoriae Regni Neapolitani, vol<br />
163). Altro elemento indicativo della soggezione di San Nicola di Casole alla Chiesa Romana<br />
è la riconsacrazione, avvenuta nel 1267 da parte del cardinale Randolfo, della chiesa del<br />
Convento.<br />
Il Rodotà pone tra le cause della decadenza dei Basiliani anche la negligenza dei<br />
Vescovi, che badavano molto più ai propri interessi che al bene dei monaci, e la separazione<br />
e indipendenza di un monastero dall’altro, senza vincoli di Congregazione sotto un capo.<br />
Fra il XIII e il XV secolo, il clero greco perdeva le sue posizioni di prestigio. Il clero<br />
latino cominciò ad accusarlo di corruzione, di pratiche idolatriche, di ignoranza, di rapacità.<br />
In realtà, il clero greco, salvo rare eccezioni, non aveva mai praticato una condotta scandalosa.<br />
Nel 1480, Maometto II ordinava alla sua armata navale di assalire Otranto, che non<br />
fu in grado di opporre una valida resistenza.<br />
La città, caduta nelle mani dei turchi il 14 agosto, fu saccheggiata e scomparve virtualmente<br />
dalla storia. Anche il Monastero di Casole fu distrutto e la maggior parte dei paesi<br />
del Salento subì saccheggi e stragi. Per fortuna, Maometto II morì l'anno seguente e i turchi<br />
furono richiamati nei Balcani.<br />
Nel corso del Cinquecento si registravano notevoli contraddizioni nei rapporti tra<br />
Roma e la chiesa greco salentina. Da una parte le bolle papali, i grandi monasteri benedettini,<br />
la sostituzione dei libri greci con quelli latini erano elementi che ostacolavano la chiesa<br />
locale, dall’altra Sergio Stiso prima, Niccolò Majorano poi, entrambi preti greci, ebbero<br />
l’incarico di Bibliotecario presso la Vaticana (Stiso rinuncerà per malattia, mentre Majorano<br />
sarà bibliotecario finché non sarà inviato come vescovo, ormai di rito latino, a Molfetta).<br />
Infine, nel corso del Cinquecento, ci furono il Concilio di Trento e la Controriforma<br />
cattolica, che spinsero la Chiesa romana a prendere drastiche misure in materia di fede. I<br />
sacerdoti greci del Salento, pur essendo ormai incorporati nel clero cattolico, apparivano diversi,<br />
per cui furono considerati quasi eretici, non pericolosi, ma pur sempre diversi dal clero<br />
cattolico.<br />
Un tentativo di regolamentazione fu effettuato con il concilio sinodale tenutosi ad Otranto<br />
tra il 1579 ed il 1585, al quale parteciparono duecento preti greci. In occasione del sinodo,<br />
fu dato incarico al dotto protopapàs di Soleto Antonio Arcudi, originario di Corfù, di<br />
raccogliere in un testo, il Néon Anthologhion, le preghiere della liturgia greca. Il testo fu poi<br />
stampato, dopo la revisione da parte di alcuni vescovi greci, dalla tipografia Vaticana e dedicato<br />
al papa Clemente VIII, a cui fu presentato nel 1598 38 . Ciò fu chiesto e realizzato per evitare<br />
di dover consultare ogni volta i venti libri greci relativi alla liturgia.<br />
38 R. Aprile, op. cit., pag. 72<br />
276
La fine del rito greco<br />
La fine ufficiale del rito greco in Terra d’Otranto si è avuta tra il Cinquecento e la<br />
prima metà del Seicento “Fine ufficiale” non vuol dire che da quel momento non ci siano più<br />
stati preti o chierici di rito greco, perché tale presenza è attestata fino ad oltre la metà del<br />
Settecento. Nelle chiese si alternavano rito greco e rito latino, senza alcuna conflittualità, e<br />
ciò ha creato talvolta indeterminatezza nelle date di cessazione del rito greco.<br />
Alla fine del Quattrocento si estinse il rito greco a Galatina, con Nicola Schinzari ultimo<br />
prete greco. In realtà preti e chierici greci sono presenti a Galatina ancora nel XVII secolo,<br />
così come la lingua greca. Nel Cinquecento si estinse il rito greco a Gallipoli (1513).<br />
Nel Seicento il rito greco era ancora presente in provincia di Brindisi (Tuturano, Mesagne),<br />
in provincia di Taranto (presenza degli albanesi) e nelle varie diocesi di Terra d’Otranto<br />
(tranne Gallipoli): Nardò (Casarano, Galatone, Seclì), Ugento (Ruffano), Castro (Andrano,<br />
Diso, Cerfignano, Marittima, Nociglia e Poggiardo).<br />
Nella diocesi di Otranto, ancora all’inizio del Seicento il rito greco era vivo, oltre che<br />
nei comuni costituenti l’attuale Grecìa Salentina (Calimera, Castrignano, Corigliano, Martano,<br />
Martignano, Melpignano, Soleto, Sternatia e Zollino), anche a Carpignano, Cursi, Cutrofiano,<br />
Sogliano, Cannole, Giuggianello, Giurdignano, Muro Leccese, Palmariggi, Maglie e<br />
Galatina.<br />
Il Battesimo avveniva per immersione, e la formula di rito, riportata nei libri dei battezzati,<br />
recitava : “levolo dalla fonte…”<br />
Ad Otranto, ancora nel 1684, in tre chiese si officiava in greco.<br />
Estinzione del rito greco in alcuni comuni del Salento: Calimera (1621), Soleto<br />
(1611-12), Zollino (1667), Sternatia (1622), Martignano (1650), Corigliano d’O. (1650), Castrignano<br />
d. G. (1622), Melpignano (1611), Martano (1608), Sogliano (1637), Bagnolo<br />
(1611), Cannole (1628).<br />
Come si può notare, il lento passaggio dal rito greco al rito latino mostra la gradualità,<br />
quasi la ineluttabilità del passaggio stesso, più che una forzatura violenta.<br />
Il processo di omologazione<br />
Si è scritto spesso di violenza sul clero greco, fino all’uccisione di alcuni papàdes,<br />
ma in realtà il processo di assimilazione da parte della Chiesa di Roma è stato come la posa<br />
in opera della tessere di un mosaico, processo che aveva nel suo insieme, come obiettivo<br />
ultimo, l’omologazione.<br />
Vediamo in sintesi quali sono stati i principali tasselli del mosaico:<br />
a) il controllo del territorio attraverso grandi chiese e monasteri. La realizzazione delle cattedrali,<br />
iniziata in epoca normanna fu seguita dalla costruzione di grandi monasteri per i Benedettini,<br />
gli Alcantarini, i Domenicani, gli Agostiniani, i Minori Osservanti. La popolazione greca,<br />
abituata alle cripte, alle piccole chiese, veniva a contatto con qualcosa di imponente, di<br />
maestoso, che incuteva timore ed offriva un’idea della potenza della Chiesa latina.<br />
b) Le difficoltà economiche. Sia i normanni che i successivi signori privilegiavano nelle donazioni<br />
le istituzioni religiose latine. A questo si aggiungano le tasse che il clero greco doveva<br />
pagare, attingendo a quel poco che dava l’agricoltura e dalle offerte dei fedeli, in gran parte<br />
poveri.<br />
c) Il culto dei santi. In molte chiese il culto dei santi subì trasformazioni. I santi orientali vennero<br />
spesso sostituiti con santi occidentali. A Lecce, Santa Irene, antica protettrice, fu sostituita<br />
dai Santi Oronzo, Giustino e Fortunato. A Calimera, il profeta Elia venne sostituito nel<br />
1500 da San Brizio, vescovo di Tours, allievo di San Martino.<br />
d) Normativa specifica. Alcune bolle papali favorivano il passaggio del clero greco al rito latino<br />
e mantenere il consenso della popolazione. Circa il clero, una bolla del Papa aggirava<br />
l’ostacolo dello stato laicale. I preti greci sposati potevano passare al rito latino mantenendo<br />
la situazione familiare preesistente.<br />
e) Un’altra bolla papale riguardava la democrazia. Nelle comunità greche, il popolo indicava<br />
al vescovo una terna di preti, tra cui poi veniva scelto l’Archipersbiter responsabile della comunità.<br />
Ciò non avveniva nei centri di rito latino, dove il vescovo decideva autonomamente<br />
l’assegnazione dei parroci. Le comunità greche hanno conservato questo diritto addirittura<br />
fino alla fine dell’Ottocento.<br />
277
f) Il tassello ultimo, ma primo per importanza è stato il taglio del cordone ombelicale con Costantinopoli,<br />
avvenuto sostanzialmente con la presa di Otranto da parte dei turchi, quindi<br />
l’interruzione nell’arrivo di nuovi papàdes, che non erano solo capi religiosi, ma riferimenti<br />
culturali vitali per le comunità greche. Il loro mancato arrivo portò piano piano alla scomparsa<br />
dell’uso della lingua scritta.<br />
A contrastare i motivi di decadenza c’era solo l’immigrazione di greci che, sporadicamente,<br />
continuavano a giungere nel tacco d’Italia. Il fenomeno è continuato fino al Settecento,<br />
quando i greci ancora si rifugiavano nel Salento per sfuggire ai turchi, durante la guerra<br />
di Morea.<br />
Molto probabilmente, la scarsa conflittualità tra la chiesa latina e quella greco salentina<br />
è dovuta al fatto che, per molti secoli, la presenza religiosa nel Salento ha riguardato non tanto<br />
la religione cristiano ortodossa ma cristiano cattolica di rito greco. Venivano accettati i principi<br />
della chiesa cattolica e la liturgia era greca. Furono anzi i vescovi provenienti da Otranto ad essere<br />
ripetutamente inviati dal Papa a Costantinopoli come ambasciatori, nel tentativo di ricucire<br />
lo strappo seguito al concilio di Nicea. Il dipinto nella Cappella della Madonna di Costantinopoli<br />
a Calimera, nel quale ai lati della Madonna sono effigiati i due vescovi, uno con i paramenti di<br />
foggia orientale e l’altro con quelli di foggia occidentale, è la più significativa testimonianza della<br />
convivenza pacifica dei due riti. Oggi, la totalità dei griki del Salento è di rito greco.<br />
Evoluzione delle diocesi<br />
Le prime notizie relativa alle diocesi del Salento vedono questo territorio, in particolare<br />
Gallipoli e Nardò, dipendere gerarchicamente dalla diocesi di Santa Severina, in Calabria. Nel<br />
IX secolo divenne diocesi Gallipoli, finché non fu creata la Metropolìa di Otranto (968), che dipendeva<br />
direttamente da Costantinopoli. Ad Otranto facevano capo le diocesi di gran parte della<br />
Puglia e della Basilicata. Alla fine del Settecento, la Chiesa cattolica fece una grande verifica<br />
della suddivisione territoriale in diocesi. Esse dovevano avere alcuni requisiti, a cominciare da<br />
quello dell’autosostentamento. Si pose il problema della diocesi di Castro, che aveva giurisdizione<br />
su di un territorio abbastanza ristretto e poche entrate. Avvenne che diverse parrocchie<br />
della Diocesi di Otranto si “autotassarono” per cercare di far sopravvivere la diocesi di Castro: si<br />
privavano di alcune chiese, soprattutto rurali e le concedevano a parrocchie della diocesi di Castro.<br />
Calimera cedette così, ad esempio, la chiesetta di San Vito; lo stesso fecero Zollino, Sternatia,<br />
ecc. Ciò che contava nella cessione non era tanto la chiesetta per sé ma i cespiti, le entrate<br />
legate alla chiesa (seminativi, oliveti, ecc). Il tentativo però non sortì l’effetto voluto, tanto è<br />
vero che nel 1818 scomparve la diocesi di Castro, assorbita da quella di Otranto e, in parte, di<br />
Ugento. Le chiesette, ormai traferite alle nuove parrocchie, rimasero affidate ad esse, fino al<br />
1992, quando la Curia di Otranto rimise ordine e riassegnò le chiese alle parrocchie vicine, anche<br />
per evitare trascuratezza ed abbandono.<br />
Chiese greche e chiese latine<br />
Le presenze bizantine più antiche sono, per quanto riguarda l’architettura, la chiesa a<br />
croce greca di San Pietro ad Otranto, simile alla Cattolica di Stilo; per quanto riguarda la pittura,<br />
i cicli di affreschi nella cripta di Santa Marina a Carpignano: per quanto riguarda la scultura, alcuni<br />
portali ed un fonte battesimale a Soleto.<br />
Le chiese subdiali sono state in genere sostituite, nello stesso sito, da chiese a croce latina<br />
e con stili come il romanico pugliese. La pittura continuò ad essere presente per alcuni secoli<br />
nello stile bizantineggiante (vedi S. Stefano a Soleto, S. Niceta a Melendugno, Casaranello,<br />
alcuni cicli di affreschi a San Pietro di Otranto).<br />
Lingua usata nella liturgia<br />
Il latino, utilizzato negli ultimi tre secoli, è stato sostituito dall’italiano dopo il Concilio Vaticano<br />
II. Varî parroci nelle omelie inseriscono talvolta preghiere e saluti in griko.<br />
Documenti religiosi scritti nella lingua minoritaria<br />
Non vi sono documenti scritti nella lingua minoritaria successivi a testi e documenti del<br />
Cinquecento. Una preghiera trasmessa oralmente, un Pater Imon, è stata registrata dalla viva<br />
voce del popolo dal Palumbo, alla fine dell’Ottocento, anche se in forma ormai frammentaria.<br />
Rapporti della cultura minoritaria con la Chiesa<br />
278
Oltre la presenza di alcune preghiere, inni in griko, si sono avuti contatti sporadici con i<br />
Rappresentanti della Chiesa Cattolica di rito greco (da Piana degli Albanesi, da Lungro) e con i<br />
Rappresentanti della Chiesa Ortodossa (da Bivongi, dal Patriarcato di Venezia, dalla Grecia).<br />
Mass media, pubblicazione e diffusione di documenti religiosi<br />
La pubblicazione più rilevante in tal senso è la raccolta di preghiere (Pracàliso min glossa-su,<br />
Prega nella tua lingua) e la liturgia (E Aja Liturghia, la Santa Liturgia), entrambe raccolte<br />
dal monaco cistercense don Mauro Cassoni, prima della metà del secolo scorso.<br />
Manifestazioni e canti religiosi in lingua minoritaria<br />
Non si svolgono manifestazioni religiose di particolare rilievo. Sono collegabili alle origini<br />
greche le feste religiose e laiche dedicate a S. Biagio, S. Giorgio, S. Vito, S. Nicola, la Madonna<br />
di Costantinopoli, S. Niceta, S. Pantaleone.<br />
Tra i canti religiosi, quello più popolare ed antico è il canto a due voci della Passione (E<br />
Passiuna) che si canta nei paesi griki nel giorno precedente la Domenica delle Palme.<br />
E’ da sottolineare la particolarità della venerazione di un santo di origine occidentale, S.<br />
Brizio, Vescovo di Tours ed allievo di S. Martino, Santo Patrono di Calimera a partire dal 1500,<br />
a cui sono dedicati molti canti in griko, a dimostrazione ulteriore della coesistenza pacifica di Oriente<br />
e Occidente nella chiesa greco salentina.<br />
279
NELLA SORTE DEI CIMBRI IL DESTINO DELLE MINORANZE<br />
Gruppi di comunità di origine germanica sono sparsi nelle montagne delle province di<br />
Vicenza, di Verona e di Trento. In corso iniziative per salvaguardare un patrimonio linguistico<br />
e culturale a rischio.<br />
Sono denominati Cimbri gruppi di comunità di origine germanica sparse nelle montagne<br />
della provincia di Vicenza, di Verona e di Trento. La denominazione è impropria, perché<br />
non c’è nessun collegamento storico tra queste popolazioni ed i Cimbri sconfitti da Caio<br />
Mario nel 101 a.C. durante il tempo della Repubblica Romana. Si tratta di gruppi provenienti<br />
dalla Germania durante il medioevo, che si possono collegare ai Longobardi, agli Alemanni,<br />
ai Bavaresi, e che si sono stanziati nelle Prealpi venete, conservando attraverso i secoli lingua,<br />
cultura, forme di autonomia, fino ai nostri giorni. Sull’altopiano di Asiago, i Cimbri dei<br />
Sette Comuni si sono organizzati in una Federazione governata da una Reggenza autonoma<br />
che si è conservata fino al 1806, quando fu sciolta da Napoleone. Oggi poche decine di persone<br />
anziane usano ancora come lingua materna la lingua cimbra. Solo a Luserna, un piccolo<br />
paese in provincia di Trento, tutta la comunità usa questa lingua in modo vivo.<br />
La nostra attenzione si concentra nella zona cimbra dei Sette Comuni Vicentini, che<br />
sembra la più antica e che nel suo destina rappresenta in modo emblematico la situazione di<br />
tante minoranze linguistiche italiane ed europee.<br />
NEL PASSATO<br />
Evoluzione<br />
Il territorio dei Sette Comuni, più noto come altopiano di Asiago, appartenente alla<br />
provincia di Vicenza, fa parte del sec. VIII alla diocesi di Padova. Già nel periodo romano la<br />
montagna dei Sette Comuni era legata al municipium di Patarium.<br />
Creazione<br />
La bonifica di questa montagna condotta dai coloni tedeschi fu guidata dai monaci<br />
benedettini del grande monastero di S. Giustina di Padova. Le parrocchie di Roana e di Enego,<br />
due dei Sette Comuni, sono dedicate ancor oggi a S. Giustina martire padovana in periodo<br />
romano. Altre parrocchie sono dedicate a culti di santi diffusi in terra germanica, come<br />
S. Geltrude e S. Bartolomeo, a cui sono dedicati i due capoluoghi comunali di Rotzo e di<br />
Gallio.<br />
Costruzione<br />
Le prime chiese parrocchiali risalgono al 1200-1300, legate alla nascita e al primo<br />
sviluppo dei comuni e delle comunità parrocchiali. La parrocchia di Asiago, centro dei Sette<br />
Comuni, è dedicata a S. Matteo, protettore dei commerci e degli scambi economici. Dal 1400<br />
le parrocchie dei Sette Comuni sono oggetto di cura pastorale dei Vescovi di Padova, come<br />
è documentato dagli atti delle Visite Pastorali.<br />
Coinvolgimento<br />
Fino al Concilio di Trento (1500) i parroci dei Sette Comuni provenivano dalla Germania<br />
per esigenze di comunicazione linguistica, poi furono sostituiti da sacerdoti formati a<br />
Padova, in possesso dell’uso della lingua cimbra.<br />
Lingua<br />
In questa lingua fu tradotto il catechismo di San Carlo Borromeo dalla fine del 1500<br />
fino all’inizio del 1800, quando la maggior parte della popolazione era venuta in possesso<br />
della lingua italiana, pur conservando in parte l’antica lingua locale.<br />
Abbiamo documentazione di canti, preghiere, prediche scritte nella lingua cimbra dai<br />
sacerdoti che formati a Padova, conservano la lingua locale anche nella vita religiosa. Sono<br />
stati questi sacerdoti che nel 1700 e nel 1800 hanno dedicato un attento interesse culturale<br />
280
alla loro lingua, mettendo le basi scientifiche della tradizione cimbra, oltre il campo strettamente<br />
religioso, con ricerche storiche e linguistiche rigorose.<br />
Nel 1800 e nel 1900 il lento indebolirsi della tradizione cimbra precipitò con<br />
l’intensificarsi del turismo e con il tragico profugato durante la guerra 1915-18 che strappò<br />
per tre anni la popolazione dell’altopiano dalla sua terra. Dopo la grande guerra, la ricostruzione<br />
dei paesi cancellò quasi completamente l’impronta cimbra, anche per il condizionamento<br />
nazionalistico del regime fascista.<br />
NELL’ODIERNO<br />
Rapporto<br />
Verso la metà del 1900, per le condizioni economiche precarie e la massiccia continua<br />
emigrazione, la vita nei Sette Comuni aveva perduto quasi completamente i legami con<br />
la sua tradizione particolare, abbandonata alla dimenticanza e anche al disprezzo. Restava<br />
qualche legame con il passato per merito di qualche sacerdote e di qualche insegnante vicino<br />
alla parrocchia.<br />
Credo<br />
Fu in questo ambito vicino alla parrocchia di Roana che nel 1973 fu fondato l’Istituto<br />
di Cultura Cimbra che ritornò a dare dignità all’antica tradizione, anche nell’ambito della vita<br />
religiosa. Fu tradotta in lingua cimbra la S. Messa che è diventata un momento di preghiera<br />
e di cultura per gruppi sempre più larghi di popolazione. Furono tradotti in lingua cimbra i<br />
Vangeli di Luca, Giovanni, Marco e diverse liturgie furono animate con canti e preghiere in<br />
lingua cimbra. L’uso della lingua cimbra comincia a tornare sulla bocca di qualche giovane.<br />
La situazione è molto difficile, ma molto è stato fatto e molto resta ancora da fare, per fare in<br />
modo che questo millenario patrimonio di lingua e di cultura, di particolare valore anche religioso,<br />
non vada perduto.<br />
----------<br />
La zona cimbra dei sette comuni vicentini sembra la più antica. Le prime chiese parrocchiali<br />
risalgono al 1200.<br />
Verso la metà del 1900 per le condizioni economiche e la continua emigrazione l’area aveva<br />
quasi perduto i legami con la tradizione.<br />
CANTI RELIGIOSI<br />
MARIA DE BIIL TZARTE<br />
Maria de biil tzarte,<br />
se ist an rosengarte,<br />
un en Gott selbor hat gatziart<br />
met sainar hooghen majestat.<br />
Maria de biil raine,<br />
se hatte grosse paine<br />
un ünsarn Heere Jesum Christ,<br />
bon allar belt an tröstar ist.<br />
‘S ghinghet au drai brauen,<br />
se böllent ‘s grap boschaugan,<br />
tzo süshan Heere Jesum Christ,<br />
bon allar belt an hölfar ist.<br />
Se ghinghent allar vrüghe<br />
281<br />
MARIA INFINITAMENTE DOLCE<br />
Maria infinitamente dolce<br />
è come un giardino di rose<br />
che Dio ha riempito di grazia<br />
con la sua santa maestà.<br />
Maria infinitamente dolente<br />
Lei ha una grande sofferenza<br />
e il nostro Signore Gesù Cristo<br />
per tutto il mondo si è sacrificato.<br />
Andarono tre donne,<br />
volevano vedere il sepolcro<br />
per trovare il Signore Gesù Cristo<br />
che è il Salvatore di tutto il mondo.<br />
Andarono tutte presto
un khèerten met dar Meere<br />
dass Christ arstannet bäre,<br />
bon allar belt an braitar ist.<br />
AVE MARIA<br />
Grüssadich, Maria<br />
bolla grazien,<br />
dar Guute Here ist met diar;<br />
gabaighet pist du<br />
bon allen de baibar,<br />
un gabaighet ist dar frütten<br />
bon me dain pauche Gesù.<br />
Holiga Maria,<br />
Muutar me Guuten Heren,<br />
pitt bor ozandare<br />
bolla zünte,<br />
hemmest un in de sait me ügnar toote.<br />
Amen.<br />
AVE MARIA<br />
Gegrüsset seist du Maria, voll der Gnade,<br />
der Herr ist mit dir.<br />
Du bist gebenedeit unter den Frauen,<br />
und gebenedeit ist die Frucht<br />
deines Leibes, Jesus<br />
Heilige Maria, Mutter Gottes,<br />
bitte für uns Sünder,<br />
jetzt und in der Stunde unseres Todes Amen.<br />
282<br />
e incontrarono Maria:<br />
Cristo è risorto veramente,<br />
Egli è il liberatore di tutto il mondo.<br />
AVE MARIA<br />
Ave, o Maria<br />
piena di grazia,<br />
il Signore è cont te,<br />
tu sei benedetta<br />
tra le donne<br />
e benedetto il frutto<br />
del ventre tuo Gesù.<br />
Santa Maria<br />
Madre di Dio,<br />
prega per noi peccatori<br />
adesso e nell’ora<br />
della nostra morte,<br />
Amen
GLI SLOVENI: UNA COMUNITA’ ATTIVA IN TUTTI I CAMPI<br />
La minoranza slava residente in Friuli-Venezia Giulia spicca per la sua presenza oltremodo<br />
significativa nell’ambito dell’economia, della politica, della cultura e<br />
dell’associazionismo.<br />
Numerose ed articolate sono le dimensioni che caratterizzano la comunità minoritaria<br />
slovena in Italia. Pertanto, si è ritenuto opportuno tenere presente, nell’analisi perseguita, almeno<br />
quattro fattori che costituiscono le condizioni di fondo su cui si sono sviluppati in passato, si<br />
stanno tuttora sviluppando e probabilmente si svilupperanno in futuro la struttura e<br />
l’organizzazione interna del gruppo minoritario e conseguentemente pure i rapporti interetnici. In<br />
base a tali fattori gli Sloveni si possono definire una comunità:<br />
autoctona, in quanto insediata in un certo ambito territoriale per un periodo considerato sufficiente<br />
per sperimentare un processo di mutuo adattamento con esso;<br />
minoritaria, poiché i rapporti interetnici di carattere politico, economico, sociale e culturale,<br />
se analizzati sull’asse sovraordinazione/ subordinazione, segnano, rispetto al gruppo dominante<br />
e numericamente maggioritario, dei punti a svantaggio della comunità slovena;<br />
in linea generale mescolata con il gruppo nazionale maggioritario e con gli altri gruppi etnici<br />
presenti nello stesso ambito territoriale;<br />
e infine vivente a ridosso del confine che la separa dalla parte più consistente della comunità<br />
nazionale d’origine, che può rappresentare, mantenendo con essa legami funzionali e<br />
culturali, maggiori possibilità di sopravvivenza e di sviluppo.<br />
Dimensione demografica<br />
Per quanto riguarda la consistenza numerica degli Sloveni in Italia non esistono dati<br />
censuari recenti. L’accertamento di tale consistenza è stato ed è tuttora una questione controversa:<br />
i dati esistenti, che si riferiscono ai passati censimenti e ad una serie di stime, vengono<br />
contestati, di volta in volta, dal gruppo minoritario o da quello maggioritario. Spesso – ma ciò<br />
non è una peculiarità della situazione riguardante gli Sloveni in Italia – il rapporto tra i dati forniti<br />
dalla minoranza e quelli della maggioranza è di 2:1.<br />
Ciò è imputabile alla complessità del fenomeno etnico, alla problematicità delle definizioni,<br />
all’impossibilità di usare numerosi e articolati criteri nelle rilevazioni censuarie e nel calcolo<br />
delle stime per cui emergono numerosi motivi di contestazione. Quando nel corso del censimento<br />
si rileva anche questa dimensione sono di norma presenti una o al massimo due domande<br />
spesso di carattere linguistico: ad esempio, per i Censimenti del 1961 e 1971 erano presenti<br />
soltanto nella provincia di Trieste la domanda sulla lingua usata in famiglia (1961) e sul gruppo<br />
linguistico di appartenenza (1971).<br />
Per fornire qualche dato, anche se approssimativo, sulla consistenza numerica degli<br />
Sloveni si indicano alcune stime elaborate in tempi più o meno recenti dagli studiosi Čermelj<br />
(1958), Valussi (1974), Stranj (1992) e Ballinello (1996), nonché dal Grupo Alpina (1975), e<br />
quelle presenti nel rapporto di questa Amministrazione (1996), ricordando inoltre che altri due<br />
studiosi, Salvi (1975) e Pahor (1980), valutavano la consistenza numerica degli Sloveni, alla fine<br />
degli anni ’70, a circa 100.000 unità. Le stime di Stranj (1992) sono dettagliate per provincia<br />
e per zona, sia con presenza storica degli Sloveni – 36 comuni – sia con insediamenti più recenti<br />
imputabili a più consistenti movimenti migratori per motivi economici nell’ambito della regione<br />
Friuli-Venezia Giulia.<br />
Aspetti socio-economici<br />
La minoranza slovena, pur affrontando numerose difficoltà dovute sia a problemi economici<br />
strutturali e congiunturali sia a quelli derivanti dalla sua posizione minoritaria, ha perseguito<br />
con costanza il mantenimento e il miglioramento della propria base economica. Gli sloveni<br />
sono così riusciti a creare non solo imprese di tipo familiare ed un certo numero di piccole e<br />
medie cooperative e consorzi, specialmente nel settore agricolo, artigianale, del commercio<br />
(all’ingrosso e al dettaglio, locale ed estero), dei trasporti e di altri servizi in funzione<br />
dell’economia transfrontaliera, della ristorazione, dell’agriturismo e di altri servizi (ad esempio,<br />
alcune case editrici), ma anche complessi produttivi e iniziative economiche di carattere colletti-<br />
283
vo di ampiezza più rilevante. Molto importante risulta inoltre la presenza di alcuni istituti finanziario-creditizi<br />
sloveni che operano, con diversi sportelli, in varie località di insediamento sloveno.<br />
Rivestono una grande rilevanza le seguenti organizzazioni di carattere economico:<br />
la Kmečka zveza – Alleanza Contadina di Trieste e Gorizia, che coordina le attività delle diverse<br />
cooperative agricole e svolge un valido sostegno di carattere professionale ed amministrativo<br />
per circa 1.300 membri;<br />
la Slovensko deželno gospodarsko združenje – Unione Regionale Economica Slovena, di<br />
cui fanno parte numerosi operatori economici sloveni della provincia di Trieste e Udine; oltre<br />
all’assistenza sindacale offre ai propri affiliati consulenze di tipo professionale ed amministrativo;<br />
la Slovensko gospodarsko združenje Gorica – Associazione Economica Slovena Gorizia,<br />
che annovera tra i propri membri gli operatori economici della provincia di Gorizia.<br />
Aspetti politici<br />
La presenza di una certa articolazione ideologica tra gli Sloveni in Italia fa si che il loro<br />
voto vada a numerosi partiti. Tra questi va menzionata pure la Slovenska skupnost-Unione Slovena<br />
che si può considerare un partito a carattere etnico, sostanzialmente l’unica associazione<br />
slovena di natura squisitamente politica.<br />
Risulta comunque difficile fornire dati o stime rigorose sul comportamento elettorale degli<br />
Sloveni nel Friuli-Venezia Giulia in quanto non è possibile distinguere i voti in base<br />
all’appartenenza etnica degli elettori.<br />
Quale indicatore di una relativamente alta vitalità della comunità minoritaria anche nella<br />
vita politica si possono considerare i rappresentanti sloveni nei diversi organi elettivi: dalle circoscrizioni<br />
comunali ai consigli comunali e provinciali, dalla Regione al Parlamento, nonché in<br />
altri organismi elettivi quali, ad esempio, le Aziende per i Servizi Sanitari. Questi rappresentanti<br />
sono eletti nelle liste di alcuni partiti o delle coalizioni, nel caso di elezioni con il sistema maggioritario.<br />
Infine, è opportuno ancora ricordare che attualmente a capo di parecchie Amministrazioni<br />
comunali minori si trovano Sindaci sloveni.<br />
A questo proposito si possono pure menzionare alcuni organi appositamente costituiti<br />
per i contatti ed il coordinamento tra la minoranza e gli organi o enti ufficiali, ovvero che hanno,<br />
tra i loro compiti istituzionali, competenze specifiche in questa materia. A Gorizia, nell’ambito<br />
dell’Amministrazione comunale, è stata istituita la “Consulta per i problemi della minoranza etnica<br />
cittadina”. Va menzionata in questo ambito pure l’Enotna delegacija – Delegazione Unitaria<br />
Slovena, espressione delle varie forze politiche, socio-economiche e culturali della minoranza<br />
slovena del Friuli-Venezia Giulia, organo rappresentativo nei confronti delle più alte autorità<br />
pubbliche. Di notevole rilevanza è il “Servizio per le lingue regionali minoritarie”, che fa capo alla<br />
Direzione regionale dell’istruzione e della cultura; sotto la sua competenza ricade attualmente<br />
l’applicazione della legislazione regionale in materia e più precisamente della legge regionale n.<br />
15 del 1996 specificatamente per i Friulani e della legge regionale n. 46 del 1991 per gli Sloveni.<br />
Infine esiste la “Commissione consultiva per le iniziative culturali ed artistiche della minoranza<br />
slovena”, istituita con la predetta legge n. 46 per la gestione dei fondi attribuiti dallo Stato e<br />
che probabilmente sotto altra forma svolgerà tale compito anche in futuro nell’ambito della normativa<br />
prevista dalla legge nazionale n. 38 “Norme per la tutela della minoranza slovena della<br />
regione Friuli-Venezia Giulia”.<br />
Aspetti culturali<br />
Aspetti linguistici e socio-linguistici<br />
Accanto allo sloveno standard, che ha una precisa codificazione grammaticale-sintattica<br />
ed è la lingua ufficiale della vicina Repubblica di Slovenia, gli appartenenti alla comunità minoritaria<br />
usano numerose altre varietà locali. Nella fascia territoriale ove vive la comunità slovena<br />
sono presenti le seguenti varietà/dialetti locali della lingua slovena: le varietà carinziana (ziljsko),<br />
resiana (rezijansko) e quelle delle Valli del Torre e Natisone (Benečija) (tersko e nadiško)<br />
in provincia di Udine, del Collio (briško) e del Carso (kraško) in provincia di Gorizia ed, oltre alla<br />
varietà del Carso (kraško), si riscontrano influenze della parlata della regione della Slovenia che<br />
include Postumia e confina con il Carso (notranjsko) e dell’Istria nord-orientale (brkinsko) in provincia<br />
di Trieste.<br />
284
Tutti i membri della minoranza conoscono qualche varietà del diasistena italiano. La conoscenza<br />
dell’italiano standard varia in relazione allo status sociale e ad altre caratteristiche individuali,<br />
nonché alle tipologie di interazione comunicativa. E’ diffusa la conoscenza dell’italiano<br />
standard, grazie anche all’apprendimento scolastico come all’esposizione ai mass-media. Poco<br />
diffusa è invece la conoscenza dello sloveno fra i membri della maggioranza, e non solo relativamente<br />
alla produzione di lingua, ma anche alla capacità di comprensione.<br />
Istruzione<br />
Istituite già sotto la dominazione austriaca e con alcuni periodi di interruzione – durante<br />
le guerre ed il regime fascista -, le scuole slovene ottennero dopo la seconda guerra mondiale<br />
una regolamentazione normativa da parte dell’Italia solo nel 1961 con la legge n. 1012, che le<br />
riconobbe formalmente con la dizione di “scuole statali con lingua d’insegnamento slovena” esclusivamente<br />
nelle province di Gorizia e di Trieste. Successivamente, ed in particolare tra il<br />
1973 e il 1975, si sono avuti ulteriori provvedimenti normativi che hanno regolamentato le problematiche<br />
non affrontate in precedenza.<br />
Le scuole con lingua d’insegnamento slovena sono parte del sistema scolastico nazionale<br />
e quindi fanno capo agli organi ad esso preposti. La struttura scolastica slovena comprende<br />
tutti i livelli, dalla scuola materna fino alla scuola media superiore. Lo sloveno è lingua veicolare<br />
per l’insegnamento di tutte le materie, tranne dell’italiano. I programmi per i vari insegnamenti<br />
sono ministeriali e, salvo alcune opportune eccezioni come, ad esempio, la lingua slovena<br />
e parzialmente la storia e la geografia, simili a quelli delle scuole italiane di pari grado.<br />
La ricerca sulla rete scolastica slovena in Italia è stata svolta a cura dell’Istituto SLORI<br />
(Bogatec e Bufon, 1996), una struttura dinamica e vitale per la lingua e l’identità degli appartenenti<br />
alla comunità slovena.<br />
L’andamento delle iscrizioni a tutte le scuole statali con lingua d’insegnamento slovena<br />
in Italia tra gli anni scolastici 1991-‘92 e 2001-‘02 presenta una dinamica articolata sia per livelli<br />
sia per provincia. In quasi tutti i casi, comparando il primo e l’ultimo dato della serie temporale,<br />
si nota un decremento spesso anche notevole; le eccezioni riguardano le scuole materne ed elementari<br />
nella provincia di Gorizia e le scuole materne nella provincia di Trieste, che contribuiscono<br />
a ridurre l’andamento decrescente complessivo degli iscritti. In generale, integrando i dati<br />
delle iscrizioni dal 1945-‘46 al 1988-‘89 elaborati da Stranj (1992) con i dati (senza le scuole<br />
materne) relativi a questi ultimi undici anni si nota per i primi 20 anni un continuo calo degli iscritti,<br />
poi l’andamento si inverte per i successivi 15 anni per nuovamente riprendere la tendenza<br />
decrescente fino ai giorni nostri, anche se negli ultimissimi anni con un tasso relativamente<br />
più basso. La popolazione scolastica slovena tende quindi a decrescere nonostante il fenomeno<br />
positivo di un continuo aumento negli ultimi 25 anni degli iscritti di famiglie miste italo-slovene e<br />
persino di quelle che si identificano come italiane: dalla menzionata ricerca Bogatec-Bufon<br />
(1996) emerge, ad esempio, che gli iscritti nelle scuole elementari nell’anno scolastico 1995-‘96<br />
avevano per il 58 per cento entrambi i genitori di nazionalità slovena, il 35 per cento con un genitore<br />
sloveno e 7 per cento con entrambi i genitori di nazionalità non slovena.<br />
L’andamento decrescente della popolazione scolastica, che non colpisce soltanto le<br />
scuole slovene, è certamente imputabile ai fenomeni demografici (inclusa l’emigrazione) più generali,<br />
ma resta l’ipotesi che una certa influenza sia imputabile anche ad un persistente processo<br />
di assimilazione.<br />
Negli anni 1986-‘87 prese l’avvio con la prima classe elementare (ma già da due anni<br />
funzionava la scuola materna) la scuola bilingue privata a S. Pietro al Natisone in provincia di<br />
Udine. Lo Zavod za slovensko izobraževanje (Istituto per l’istruzione slovena), nel cui ambito<br />
operano la scuola materna ed elementare, fu istituito dagli sloveni – con notevoli sforzi ed energie<br />
– per consentire alle giovani generazioni di un’ampia area della provincia di Udine anche<br />
l’apprendimento della lingua slovena. Il lungimirante progetto di questa iniziativa diede i frutti<br />
sperati e con una notevole progressione delle iscrizioni si è arrivati negli anni 1997-‘98 a 130<br />
frequentanti, di cui 51 nella scuola materna e 79 in quella elementare. Dagli anni 1997-‘98 la<br />
scuola è stata parificata dallo Stato italiano e con la legge n. 38 del 2001 (“Norme per la tutela<br />
della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia”) è entrata a pieno titolo<br />
nel sistema scolastico statale.<br />
Il particolare sistema bilingue adottato dall’Istituto comporta l’insegnamento nella lingua<br />
slovena e italiana: ci sono quindi più insegnanti che trattano tutti gli argomenti sia in lingua slo-<br />
285
vena sia in lingua italiana ed ogni insegnante usa un solo codice linguistico (modello un insegnante<br />
- una lingua). Tale sistema richiede ovviamente una particolare cura nella preparazione<br />
degli insegnanti e dei materiali didattici.<br />
Una notevole importanza riveste anche il fatto che dalla fine degli anni settanta sono<br />
stati istituiti in alcuni comuni della provincia di Udine corsi di lingua slovena che tuttora riscuotono<br />
abbastanza interesse.<br />
Per il loro utile e rilevante contributo nel settore dell’istruzione e della formazione vanno<br />
ancora ricordate almeno altre quattro strutture:<br />
Slovenski deželni zavod za poklicno izobraževanje – Istituto Regionale Sloveno per<br />
l’Istruzione Professionale, che è stato istituito nel 1979; da allora ha offerto una serie progressivamente<br />
sempre più ampia di corsi professionali di vario genere nelle province di<br />
Trieste, Gorizia e Udine;<br />
Glasbena matica “E. Kogoj” – Centro Musicale Sloveno “E. Kogoj” e Slovenski center za<br />
glasbeno vzgojo “E. Komel” – Centro Sloveno per l’Educazione Musicale “E. Komel”; sono<br />
due scuole private che operano, con una lunghissima tradizione, nell’ambito<br />
dell’educazione musicale; la Glasbena matica svolge la sua attività educativa nelle province<br />
di Trieste e di Gorizia, nella Benecia e nella Val Canale in provincia di Udine, mentre il Centro<br />
“E. Komel” opera nella provincia di Gorizia; la loro attività non si esaurisce con i corsi di<br />
musica, ma si estende verso l’esterno con la programmazione di concerti per un pubblico<br />
più ampio;<br />
Slovenski dijaški dom “S. Kosovel” – Casa dello Studente “S. Kosovel” a Trieste e Slovenski<br />
dijaški dom “S. Gregorčič” – Casa dello Studente “S. Gregorčič” a Gorizia; in passato fu<br />
grazie a queste ed altre simili strutture che un notevole numero di giovani, provenienti da<br />
diverse aree del Friuli-Venezia Giulia, poterono raggiungere livelli superiori di secolarizzazione,<br />
in generale nella propria lingua madre, ed aumentare così il potenziale intellettuale<br />
della comunità slovena;<br />
il Servizio Socio-Psicopedagogico Sloveno – Slovenska socio-psihopedagoška služba che<br />
fa capo all’Azienda per i Servizi Sanitari di Trieste e segue coloro che sono handicappati,<br />
svolgendo un importante ruolo anche in campo scolastico.<br />
Infine, va ancora ricordato che corsi di lingua e letteratura slovena vengono impartiti<br />
presso le Università di Trieste e di Udine.<br />
Istituzioni, organizzazioni ed associazioni<br />
La vita associativa degli Sloveni viventi in Italia è stata ed è tuttora molto vivace ed articolata.<br />
Ciò vale specialmente, anche se non esclusivamente, nel campo culturale ed artistico.<br />
Gran parte dell’attività associativa in ambito regionale viene coordinato da due organizzazioni,<br />
la Slovenska kulturno gospodarska zveza – SKGZ – Unione culturale economica slovena, di ispirazione<br />
tendenzialmente laica, e la Svet slovenskih organizacij – SSO – Confederazione delle<br />
organizzazioni slovene, di ispirazione cattolica. L’Unione culturale economica slovena, fondata<br />
nel 1954, è un’organizzazione di carattere regionale e di tipo confederativo alla quale sono<br />
affiliate numerose federazioni ed associazioni; caratteristiche simili ha pure la Confederazione<br />
delle Organizzazioni Slovene, sorta nel 1976. Negli ultimi anni queste due organizzazioni hanno<br />
sviluppato una collaborazione molto intensa che risulta positiva per tutta la comunità. Va tenuto<br />
presente che non tutte le associazioni afferenti alle due organizzazioni sono di carattere culturale<br />
o artistico e che alcune associazioni culturali esistenti nella comunità non afferiscono ad esse.<br />
Cultura<br />
Senza avere la pretesa di essere esaustivi, ci sembra opportuno sottolineare l’esistenza<br />
di alcune istituzioni, organizzazioni ed associazioni, che fanno capo alle due confederazioni sopra<br />
menzionate e si possono considerare le “colonne portanti” della vita culturale slovena:<br />
Slovensko stalno gledališce (SSG) – Teatro stabile sloveno, risorto dopo il 1945 sotto la<br />
spinta di una lunga tradizione teatrale, che propone opere di autori sloveni, italiani e stranieri;<br />
Narodna in študijska knjižnica (NŠK) – Biblioteca nazionale e degli studi, dotata di 95.000<br />
volumi nella sede di Trieste e 12.000 volumi nella sede di Gorizia, con la specializzazione<br />
286
per quanto concerne le pubblicazioni degli e sugli Sloveni in Italia; nel suo ambito operano<br />
diverse sezioni, di cui la più importante ed attiva è quella storica; vanno pure menzionate le<br />
biblioteche “D. Černe”, con un consistente fondo librario prodotto dagli emigrati sloveni, e<br />
dell’Istituto Sloveno di Ricerche, specializzata in pubblicazioni relative ai problemi etnici;<br />
Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) – Istituto Sloveno di Ricerche, che svolge un’attività<br />
di analisi, studio e ricerca sia nell’ambito della comunità slovena sia in quello più ampio<br />
(rapporti interetnici, transfrontalieri) e con sedi staccate nelle tre province ove vivono gli<br />
Sloveni;<br />
Kinoatelje, con sede a Gorizia, che rappresenta un importante punto d’incontro internazionale<br />
dell’arte cinematografica;<br />
Zveza slovenskih kulturnih društev (ZSKD) – Unione dei circoli culturali sloveni, di carattere<br />
regionale, con una settantina di circoli ed associazioni culturali divisi in 80 gruppi di interesse;<br />
Slovenska prosveta – Organizzazione culturale slovena, con una ventina di associazioni<br />
della provincia di Trieste, e Zveza slovenske katoliške prosvete – Unione Culturale Cattolica<br />
Slovena, con 15 associazioni culturali della provincia di Gorizia;<br />
Društvo slovenskih izobražencev (DSI) – Associazione degli intellettuali sloveni, che tra le<br />
altre attività organizza, da oltre trenta anni, incontri di studio ai quali partecipano gli Sloveni<br />
appartenenti alle minoranze in Italia e Austria, alla nazione d’origine ed agli emigrati;<br />
Slovenci po svetu – Gli Sloveni nel mondo, con sede a Cividale del Friuli, che associa gli<br />
emigranti del Friuli-Venezia Giulia mantenendo collegamenti tra loro e i luoghi d’origine.<br />
Se è vero che l’associazionismo culturale ed in generale l’attività culturale risulta rilevante<br />
per la vita della comunità minoritaria slovena, ciò è di vitale importanza per il risveglio,<br />
mantenimento e sviluppo dell’identità etnica. Questo ruolo svolgono sicuramente le associazioni<br />
nella provincia di Udine ed in parte di Gorizia; vanno qui, ad esempio, ricordate le associazioni<br />
“Planika” in Val Canale, “Rozajanski dum” in Val Resia e “Jadro” in Bisiacheria. L’articolazione<br />
dell’attività associativa slovena, specie se di tipo culturale, si riflette anche sull’ampia diffusione<br />
delle case di cultura, centri polivalenti, sale parrocchiali e simili.<br />
Sport, ricreazione e assistenza<br />
Gli Sloveni del Friuli-Venezia Giulia hanno dato vita, in base ad una lunga tradizione, a<br />
numerose associazioni sportive. Quasi tutte sono consociate nello Združenje slovenskih športnih<br />
društev (ZSŠD) – Unione dei circoli sportivi sloveni in Italia. All’Unione, di carattere regionale,<br />
sono affiliate 46 associazioni sportive e ricreative, divise in 85 sezioni che nel loro insieme<br />
coprono 20 diverse discipline sportive.<br />
Per quanto concerne l’ambito ricreativo vanno menzionati lo Slovensko planinsko društvo<br />
– Associazione alpina slovena e due raggruppamenti giovanili con forti valenze educative: la<br />
Slovenska zamejska skavtska organizacija – Organizzazione scoutistica slovena e la Taborniška<br />
organizacija Rod modrega vala – Organizzazione campeggiatori sloveni Rod modrega vala.<br />
Queste organizzazioni possono essere considerate “di massa” in quanto contano un numero<br />
elevato di associati.<br />
Rilevanti per la funzione che svolgono sono le associazioni e fondazioni di tipo assistenziale,<br />
che in prevalenza si interessano degli anziani, degli handicappati ed in parte della<br />
popolazione studentesca.<br />
Vita ed attività religiosa<br />
Tanto nella diocesi di Trieste quanto in quella di Gorizia è presente un vicario episcopale<br />
per i fedeli di lingua slovena ed in entrambe le città è stato istituito un Slovensko pastoralno<br />
središče (Centro pastorale sloveno) allo scopo di essere a disposizione dei fedeli di lingua slovena<br />
che ne abbiano bisogno. Esistono due decanati – uno per diocesi -, che si possono considerare<br />
sloveni, in quanto ne fanno parte le parrocchie con una relativamente forte concentrazione<br />
di fedeli sloveni; ad essi sono preposti decani di lingua slovena. Alcuni sacerdoti di lingua<br />
slovena svolgono la loro attività pastorale nelle parrocchie con a capo parroci italiani, dato che<br />
in esse vive anche un rilevante numero di fedeli sloveni.<br />
Mezzi di informazione e di comunicazione di massa<br />
287
Un ulteriore fattore importante per la vita della minoranza slovena è rappresentato dai<br />
mezzi di comunicazione di massa, nel cui ambito si rileva una situazione abbastanza soddisfacente<br />
per quanto riguarda la stampa periodica e le emissioni radiofoniche.<br />
Nel settore della stampa periodica, che vanta una lunga tradizione tra gli Sloveni, esiste<br />
il quotidiano Primorski dnevnik, successore del Partizanski dnevnik che verso la fine del 1943<br />
usciva come unico quotidiano libero nell’Europa occupata. Il Primorski dnevnik esce a Trieste<br />
ed ha una redazione anche a Gorizia. Vanno inoltre menzionati i seguenti periodici: il settimanale<br />
Novi glas, con sede a Gorizia ed una redazione a Trieste, i periodici di taglio politico come in<br />
quindicinnale Novo Delo, l'Iskra e la Skupnost, con sedi nella provincia di Udine il settimanale<br />
Novi Matajur e il quindicinnale Dom, che pubblicano articoli anche nella varietà linguistica locale<br />
(beneško narečje), la rivista mensile Mladika e le due riviste giovanili Galeb, di orientamento più<br />
laico, e Pastirček, di orientamento più cattolico. Esiste inoltre un’ampia serie di pubblicazioni<br />
con diversa periodicità curate dalle scuole, dal partito Slovenska skupnost (Unione Slovena), da<br />
alcune istituzioni (biblioteca, teatro), associazioni e comunità parrocchiali. Tra i periodici con<br />
una lunga tradizione per il fatto che hanno specialmente in passato rivestito una rilevante funzione<br />
socializzante per gli Sloveni in Italia vanno menzionati pure tre almanacchi: il Jadranski<br />
koledar, il Koledar Goriške Mohorjeve družbe ed il Trinkov koledar.<br />
Per quanto concerne il settore radio-televisivo esiste nell’ambito della sede regionale<br />
della RAI una sezione in lingua slovena, denominata Radio Trst A (Radio Trieste A), con trasmissioni<br />
di circa 12 ore giornaliere. Questa sezione è composta da un organico autonomo preposto<br />
alla ideazione, programmazione, realizzazione e messa in onda delle trasmissioni. Pure i<br />
giornalisti sloveni hanno attualmente una redazione autonoma. Tutti i programmi parlati sono<br />
trasmessi, originali o doppiati, in lingua slovena.<br />
Dal 1995, precisamente 20 anni dopo l’emanazione della legge che ne prevedeva<br />
l’istituzione, è iniziata la produzione e trasmissione del programma televisivo sloveno sulla rete<br />
nazionale. Il programma, di circa mezz’ora giornaliera, purtroppo non è visibile neppure<br />
nell’intera area delle province di Trieste e Gorizia, sebbene ciò sia previsto dalla legge e dalla<br />
relativa convenzione. La programmazione sia radiofonica sia televisiva si avvale anche di numerose<br />
collaborazioni esterne.<br />
Va infine menzionata Radio Opčine-Opicina, quale radio privata slovena sorta nel 1983<br />
con sede a Trieste. Gli inserti pubblicitari sono generalmente bilingui (sloveno e italiano) e<br />
spesso i collegamenti telefonici, effettuati con gli ascoltatori nel corso di alcune trasmissioni, sono<br />
pure in lingua italiana.<br />
288
TRADIZIONI E CULTURA DEGLI OCCITANI<br />
La popolazione totale insediata in Italia è stata calcolata in circa 178mila persone. Alcuni<br />
nuclei sono presenti tra le province di Cuneo e Torino, nell’imperiese e nel cosentino. In<br />
Val Maira vi sono numerose testimonianze urbanistiche e architettoniche<br />
Occitani o Provenzali, essi sono da considerare i discendenti dei famosi “troubadours”,<br />
che cantavano le loro canzoni in lingua d’oc nelle terre dell’Occitania francese. La popolazione<br />
totale degli Occitani, insediati nelle zone del nostro Paese, è stata calcolata in circa 178.000<br />
persone; di essi circa 49.000 parlano un “occitano puro” e 100.000, che si ritengono appartenere<br />
alla “zona grigia” parlano un “occitano impuro”. Inoltre, occorre puntualizzare che il 56% della<br />
popolazione (cioè, circa 46.000 abitanti), presente nelle aree territoriali del Piemonte, parlano<br />
un “patois” provenzale. Sono, invece, 3.000 le persone insediate a Guardia Piemontese.<br />
In considerazione del fatto che la lingua occitana, parlata in generale nelle valli del Piemonte,<br />
rientra nel primo dei gruppi linguistici dialettali in cui si suddivide la lingua in questione,<br />
cioè in quello nord-occitano (parlato a Limousin, Alvemia), si deve plausibilmente ritenere che<br />
l’origine del nucleo sia individuabile in tale area del territorio francese. Si riscontra, poi, nelle vallate<br />
a sud del Piemonte (Briga Alta e Olivetta San Michele), un dialetto occitano, che presenta<br />
maggiori affinità con quello meridionale (di provenienza dalla Linguadoca-Tolosa – e dalla Provenza<br />
– Aix en Provence); la stessa origine territoriale si ritiene di poster assegnare al nucleo<br />
insediato a Guardia Piemontese (Cosenza), proveniente, tuttavia, da Bobbio Pellice. Non identificabile<br />
risulta l’epoca in cui si insediarono le popolazioni occitane in Piemonte e Liguria. Invece,<br />
si fanno risalire alla seconda metà del secolo XII le prime emigrazioni dal nord Italia verso la<br />
Calabria. La località in cui si riscontra il primitivo insediamento di popolazione occitana è da individuare<br />
nella “piccola Occitania italiana”, fra le province di Cuneo e Torino (regione Piemonte).<br />
Ulteriori dislocazioni di tale popolazione si hanno nella provincia di Imperia (regione Liguria), in<br />
quell’area detta della “comunità brigasca” e nella provincia di Cosenza (regione Calabria). Alcuni<br />
periodici vengono pubblicati parzialmente o interamente il lingua occitana. Una stazione radio<br />
privata trasmette in occitano programmi culturali.<br />
L’architettura del Val Maira<br />
La Val Maira è una delle numerose valli alpine in provincia di Cuneo; essa comprende i<br />
comuni di Acceglio, Prazzo, Elva, Canosio, Marmora, Stroppo, Macra, Celle, San Damiano,<br />
Cartignano, Dronero, Rocca Bruna, Villar San Costanza e Busca. Come in tutte le altre valli del<br />
cuneese, in quelle occidentali della provincia di Torino e, più a sud, in quelle liguri, la lingua utilizzata<br />
nei rapporti tra i nativi o gli autoctoni è l’occitano.<br />
Aspetti ambientali<br />
Così come esiste una grande varietà di parlate occitane, in queste valli anche le tipologie<br />
architettoniche sono molto varie. Peraltro, è da sottolineare che quella alpina è una delle aree<br />
del continente europeo dove le antiche tradizioni e le forme di cultura locali si sono conservate<br />
meglio, per le difficoltà di comunicazione che esistono con l’esterno. Rispetto alle altre vallate<br />
di questa parte dell’arco alpino, è proprio la Val Maira quella in cui l’accentuato isolamento<br />
ha permesso la migliore conservazione nel tempo delle sue peculiarità e del suo notevole patrimonio<br />
documentario e culturale.<br />
Tale contesto ambientale determina la costruzione di un vero e proprio paesaggio culturale<br />
che costituisce una testimonianza in massima parte fino ad oggi salvaguardata da danni<br />
ecologici; questa, al tempo steso, risulta comunque sottoposta ad un processo di degrado dovuto<br />
all’abbandono da parte della popolazione stabile delle attività produttive tradizionali.<br />
Manufatti primitivi<br />
Espressioni di queste tradizioni le troviamo negli edifici rurali che, fino a poco tempo fa,<br />
erano direttamente costruiti dagli abitanti seguendo, più o meno inconsciamente, le stesse antichissime<br />
forme e tecniche.<br />
In particolare, nella parte più bassa della Valle, tra i boschi di faggio e di castagno, si<br />
trovano le tracce di quelle che forse sono i manufatti più primitivi della zona. Si tratta di effimere<br />
costruzioni in legno e paglia la cui vita non supera alcune decine di anni, costantemente rifatte<br />
289
seguendo lo stile originario. La pianta è generalmente costituita da un quadrato il cui lato varia<br />
da 3 a 5,5 m. La struttura portante è in legno ed è composta da due grandi pali di sostegno della<br />
trave di colmo, da quattro pali più corti agli angoli e, in genere, altri due al centro. I pali, molto<br />
rozzi, sono ricavati da legni biforcuti utilizzando la stessa biforcazione quale sostegno alle travi<br />
orizzontali. Altra caratteristica è la trave di colmo, che è sempre disposta parallelametne alla linea<br />
di massima pendenza del terreno. Le falde del tetto – a copertura di paglia – hanno una inclinazione<br />
tra 40° e 55°, assai più accentuata di quella dei tetti a copertura in pietra.<br />
Fra le abitazioni primitive, il cui stile è rimasto inalterato nel corso dei secoli, troviamo<br />
anche quelle stagionali di alta montagna, dette grange, a circa 2.000 m. di quota.<br />
Le grange – pianta rettangolare, tetto a debole pendenza e coperture in pietra – rappresentano,<br />
nella loro forma più semplice, il tipico elemento di base dello stile di costruzione più<br />
diffuso nella Valle. Quando vi sono due piani, il pavimento intermedio è costituito da assito poggiato<br />
su travi in larice, mentre manca completamente l’uso della volta a botte. Altra caratteristica<br />
è la frequente agglomerazione di queste grange in veri e propri villaggi, che riproducono ad alta<br />
quota la struttura sociale delle abitazioni di fondo valle.<br />
Manufatto tipico<br />
Comunque, l’elemento architettonico fondamentale e più caratteristico è costituito dalla<br />
tipica costruzione in pietra a base rettangolare con tetto a travature di legno a debole inclinazione,<br />
ricoperto da lastre di ardesia, che nella forma originaria più elementare aveva un focolare<br />
senza camino che lasciava uscire il fumo dalle fessure del tetto. Successivamente, essa si sviluppò<br />
in edifici a più locali e più piani dando luogo allo stile tipico della Valle.<br />
Evoluzione storico-culturale<br />
La Val Maira ha subito una serie di influenze culturali nel corso dei millenni ad opera<br />
delle popolazioni celto-liguri, della conquista romana e delle invasioni germaniche dell’alto Medioevo.<br />
L’architettura locale, caratterizzata chiaramente dallo stile italico, rivela, ad esempio,<br />
l’influenza della conquista romana nell’accostamento della volta a botte con una porta centrale<br />
sovrastata da una piccola finestra, utilizzata nella costruzione di molte stalle della Valle; tali caratteri<br />
li ritroviamo nelle antiche case romane ed in identici elementi del foro Traiano di Roma.<br />
Questa Valle ha poi goduto di una certa indipendenza dal Medioevo al 1600. Sotto la tutela del<br />
Marchesato di Saluzzo ha così conosciuto un notevole sviluppo economico ed artistico. Nella<br />
parte più alta della valle si formò una repubblica di 12 comuni, non integrata nella struttura feudale.<br />
Questo fatto ebbe una notevole influenza sull’architettura locale; da un lato non si ebbero i<br />
castelli e le grandi strutture feudali; dall’altro si costruirono un gran numero di abitazioni signorili,<br />
di proprietà delle famiglie più ricche dei vari villaggi, senza che questo desse luogo ad una apprezzabile<br />
differenziazione sociale dei vari tipi di abitazione.<br />
All’interno della Val Maira, pur con una variazione graduale, si notano invece differenze<br />
tra la bassa e l’alta Valle e tra i diversi valloni laterali, dovute anche a ragioni di natura culturale<br />
ed economica. A titolo di esempio si possono citare le borgate della bassa Valle, che gravitano<br />
su centri come Dronero ed erano, quindi, meno autonome dei villaggi dell’alta Valle.<br />
Quest’ultimi, inoltre, usufruivano della ricchezza data dai grandi pascoli d’alta quota.<br />
Tornando alle case signorili più caratteristiche del migliore periodo politico, economico<br />
ed artistico – quello dal 1300 al 1500 – esse mantengono la forma basilare a pianta rettangolare<br />
e sono caratterizzate da un uso “nobile” della pietra, con blocchi accuratamente squadrati e spigoli<br />
smussati, da sgocciolatoi e da architravi nei soffitti e nelle finestre anche ornati. Il rapporto<br />
tra i lati del rettangolo di base varia tra 2 e 3/2 e, nella maggior parte dei casi, corrisponde alla<br />
cosiddetta “sezione aurea” (il rapporto tra il lato maggiore e il minore è uguale a quella tra la<br />
somma dei due ed il maggiore).<br />
Il muro di facciata, detto “a vela”, corrisponde al lato minore del rettangolo di base che<br />
continua al di sopra del livello del tetto e termina orizzontalmente coperto da un proprio tetto in<br />
lastre di pietra.<br />
Il colmo del tetto è disposto, nell’alta Valle, secondo la linea di massima pendenza del<br />
terreno, mentre nella bassa, parallelamente alle linee di livello del terreno.<br />
Da ciò, se ne deduce che, nella Val Maira, le case sono orientate seguendo unicamente<br />
la pendenza del terreno, a prescindere dall’esposizione solare. Nella parte più bassa della Valle<br />
290
– per le caratteristiche del terreno – l’elemento di base che si è sviluppato con prevalenza corrisponde<br />
alla facciata laterale, la quale non supera lo spiovente del tetto.<br />
L’accostamento di piccole case diede origine a lunghi edifici con numerose scale esterne<br />
e balconi in legno per l’accesso ai piani superiori. Di fronte a questi edifici si trova normalmente<br />
un’aia, mentre una strada passa a monte dietro le case, che da quel lato hanno un solo<br />
piano fuori terra. Sovente si accede d queste strade all’aia attraverso un passaggio coperto.<br />
Sempre in queste parti della Valle, le varie funzioni di abitazione, stalla, fienile, ecc.<br />
tendono ad essere disperse in edifici separati. Tali infrastrutture, strettamente integrate nella<br />
struttura della borgata, sono utilizzate da più famiglie.<br />
Nell’alta Valle le case sono più grandi, in quanto accentrano in un unico edificio le varie<br />
funzioni. Il fienile, in particolare, fa parte integrante della casa occupandone tutto il piano superiore<br />
e dominandola come dimensione.<br />
Inoltre, queste grandi costruzioni – vere e proprie case-villaggio – sono frutto di aggiunte<br />
successive ed hanno normalmente ospitato più di un nucleo familiare, con spazi coperti che<br />
fungono da passaggio o da area di lavoro comune.<br />
In questa parte della Valle gli edifici più antichi non possiedono ne scale ne balconi ed<br />
hanno in genere tre piani cui si accede rispettivamente da valle, da lato e da monte, sfruttando<br />
le pendenze del terreno.<br />
Influenze nordiche<br />
Nei valloni di Marmora ed Elva si possono rilevare le maggiori influenze nordiche, in costruzione<br />
isolate di grandi dimensioni e forma regolare.<br />
In genere esse sono assai grandi, con prevalenza della facciata frontale e con molti<br />
balconi.<br />
Questi ultimi, sovrapposti, sono uniti fra loro da aste di legno verticali che formano una<br />
intelaiatura entro cui viene messo a seccare il fieno, che nella tarda estate copre le facciate<br />
conferendo un aspetto ed un colore caratteristici alle borgate delle zone. Per quanto attiene alle<br />
differenziazioni culturali, si può notare che l’aspetto linguistico tra la Val Maira e la Valle Stura è<br />
assai meno importante di quello architettonico, a riprova che le tradizioni architettoniche sono<br />
più durature di quelle linguistiche. D’altro canto, il crinale tra la Val Maira e la Valle Stura segna<br />
una netta frontiera stilistica. La Valle Stura offre chiaramente un valico più agevole; quindi, è più<br />
soggetta alle influenze delle migrazioni germaniche.<br />
Un altro tipo di manufatto di origine germanica, di cui troviamo alcuni esempi nella Valle,<br />
sono le costruzioni a blocchi dette “Blockbau”, in cui l’elemento portante è costituito dal legno.<br />
La tecnica di costruzione consiste nel realizzare le pareti impilando uno sopra l’altro dei<br />
tronchi incastrati all’estremità. L’uso è in genere destinato a fienile di case costruite in pietra.<br />
Evoluzioni architettoniche<br />
Le numerose case signorili, che ancora si vedono nella maggior parte delle borgate della<br />
Val Maira, sono quelle il cui elemento di base si arricchì di portali e finestre in pietra e facciate<br />
più alte del tetto.<br />
Al contrario, l’arco e la volta stentarono ad introdursi nello stile della Valle. Anche nella<br />
costruzione delle stalle, dove l’uso della volta a botte è assai generalizzato, si nota che i più antichi<br />
edifici dell’alta valle hanno soffitti in assiti di larice.<br />
Nello stesso periodo si costruirono forni con un pronao costituito da una volta a botte<br />
sovrastata da un tetto in ardesia; essi ricordano la struttura di certe cappelle.<br />
Successivamente, l’architrave piano fu sostituito da un arco monolitico, utilizzando in tal<br />
modo lo stile dell’arco senza adottarne la tecnica. Solo in periodo posteriore si cominciarono a<br />
costruire portali con un arco fatto di blocchi separati di pietra. E’, invece, difficile definire il periodo<br />
in cui si diffuse nella valle l’uso delle caratteristiche colonne rotonde in murature di pietra –<br />
elemento tipico dell’architettura romana – usate come supporto parziale o principale del tetto.<br />
Questo elemento è universalmente presente nella valle, come nei vari tipi di costruzione.<br />
Le colonne assumono di volta in volta diverse funzioni architettoniche, sia come semplice<br />
sostegno di falde sporgenti dal tetto, sia come elemento principale delle più importanti costruzioni<br />
della valle. Le più grandi hanno un diametro alla base di circa m. 1.30, che si restringe<br />
verso l’alto, ed un’altezza di una dozzina di metri.<br />
291
L’uso delle colonne, che manca nelle costruzioni più antiche della valle, fu la sua grande<br />
comparsa in aggiunte databili tra il 1400 ed il 1600. Dopo il 1700, esse furono lentamente<br />
sostituite da pilastri a base quadrata. Proseguendo nell’evoluzione storica, si evince che la Valle<br />
fu ridotta ad un’estrema povertà nel periodo successivo alla conquista dei Savoia, per cui manca<br />
quasi ogni traccia dell’arte barocca nelle case private.<br />
Mentre, nell’epoca migliore della Valle, la pietra era l’ornamento delle costruzioni signorili,<br />
l’intonaco ai muri fu introdotto in forma generalizzata a partire dall’inizio del secolo XIX e divenne<br />
l’ornamento delle case povere di quel periodo. A partire da questo momento, però, lo stile<br />
delle costruzioni è andata sempre più uniformandosi.<br />
E’ alla fine dell’800 ed all’inizio del ‘900 che la popolazione raggiunse il suo massimo livello<br />
di densità. Questo fenomeno provocò l’abitazione permanente di certi alpeggi, l’aggiunta di<br />
piccoli locali a costruzioni preesistenti ed una piena utilizzazione delle case stesse oltre che dei<br />
terreni. In sintesi, si può affermare che le tecniche di costruzione usate furono diverse a seconda<br />
del tipo di destinazione dell’edificio, senza, peraltro, che le stesse si influenzassero a vicenda.<br />
Aspetto urbanistico<br />
Anche da un punto di vista urbanistico, come ad esempio, nella forma dei villaggi, si<br />
possono notare delle differenziazioni da una zona all’altra della Val Maira. La bassa Valle è di<br />
tipo più mediterraneo con piccole costruzioni le cui forme si adattano agli spazi disponibili tra<br />
strade e piazzette: muri ricurvi, camere su archi che coprono le mulattiere, piccole finestre e<br />
balconi a livelli diversi e irregolari. Al contrario, nell’alta Valle i villaggi spesso sono il frutto del<br />
semplice accostamento ordinato di grandi costruzioni edificate ed orientate come se fossero<br />
isolate, dando origine a villaggi non urbanizzati, frutto di un’architettura spontanea, nati lungo<br />
una strada o attorno ad un elemento centrale, quale una fontana, un forno o un pilone votivo.<br />
Altro aspetto importante, nell’analisi delle strutture architettoniche e del rapporto stabilito<br />
dall’uomo con l’ambiente che lo circonda, è la verifica dei materiali utilizzati nella costruzione<br />
delle case e nelle altre strutture necessarie alle varie attività. Il materiale indubbiamente più<br />
usato nella Val Maira è la pietra. Per la costruzione dei muri viene normalmente usata quella<br />
reperita in loco, nei terreni alluvionali della parte bassa della valle.<br />
Vengono utilizzati anche i ciottoli arrotondati del greto dei fiumi, che nelle costruzioni più<br />
accurate sono disposti accuratamente in file orizzontali. La parte più interna dei muri di grande<br />
spessore è spesso costituita da pietre ammassate caoticamente e tenute insieme da due parti<br />
esterne costruite in modo assai accurato. Negli spigoli vengono sovente utilizzate pietre squadrate<br />
e disposte con una certa armonia. Nelle grange più isolate i muri sono costruiti a secco.<br />
Altrove, specialmente nella bassa valle, si è normalmente utilizzata una malta prodotta<br />
localmente in piccoli forni a calce; a seconda del materiale disponibile risulta rozza ma assai robusta,<br />
oppure di scarsa resistenza e talvolta mista ad argilla. A parte le costruzioni “Blockbau” e<br />
le primitive capanne, il legno viene utilizzato raramente quale struttura portante dell’architettura<br />
della valle. Il legno viene largamente usato in assiti esterni per la chiusura dei fienili, e interni<br />
per pareti divisorie. Per aumentare la stabilità dei muri in pietra, vengono utilizzate travi squadrate<br />
o tiranti in legno. Il legno viene anche impiegato per le travature del tetto e dei soffitti nei<br />
casi in cui non viene usata la volta, oppure per costruire i balconi, ovvero per le grondaie, per i<br />
cardini delle porte, o per fare i chiodi e le serrature. Molto limitato è, invece, l’uso del metallo a<br />
causa della necessità di doverlo importare.<br />
Per la classificazione dei diversi stitici architettonici è necessario sottolineare alcuni elementi<br />
architettonici e decorativi principali. Il primo di essi è sicuramente il tetto, che nella Val<br />
Maira è essenzialmente caratterizzato da elementi di base di tipo mediterraneo. Hanno una<br />
struttura basata su una grande trave orizzontale di colmo che, nel caso di grandi falde, è affiancata<br />
da altre grosse travi disposte parallelamente a questa, a metà del livello della falda. La copertura<br />
maggiormente utilizzata nella Valle è quella in pietra che richiede una debole pendenza<br />
per evitare lo scivolamento delle lastre di ardesia che qui non sono ancorate.<br />
Altra copertura utilizzata, anche se in misura minore e per le sole capanne con struttura<br />
in legno, è quella in paglia che richiede una forte pendenza perché non sopportano i pesanti carichi<br />
di neve. Il secondo elemento da prendere in esame sono i balconi, che, come abbiamo già<br />
visto, sono rari nelle costruzioni più antiche. Quelli più tradizionali sono esclusivamente in legno.<br />
I parapetti – ancorati a dei puntoni verticali che uniscono la cima dei modiglioni a quella dei mo-<br />
292
diglioni del balcone sovrastante – hanno di norma una forma a rastrelliera e sono disposti diagonalmente<br />
o parallelamente al balcone. In alcuni casi i parapetti sono costituiti da assicelle sagomate<br />
secondo vari disegni ornamentali. Nelle case più antiche le finestre sono molto piccole,<br />
ma per catturare il massimo della luce possibile sono spesso strombate verso l’esterno con angoli<br />
irregolari in base alla esposizione solare. La svasatura può essere rinforzata nella parte superiore<br />
da una trave o un asse, oppure, come in alcune finestre medioevali, è rinforzata disponendo<br />
accuratamente le pietre del muro in modo degradante. Nelle case signorili medioevali<br />
esse hanno un architrave monolitico normalmente a forma di arco a pieno sesto o a sesto acuto.<br />
Non è raro trovare in queste case delle bifore, talvolta con capitelli e sculture. Le porte sono<br />
costituite da assi verticali di larice tenute assieme da tre traverse orizzontali bloccate con chiodi<br />
di legno. Esse sono disposte a valle per il piano inferiore, sulla facciata laterale per il piano intermedio<br />
e sul lato a monte per il piano superiore. Nelle zone più elevate e fredde vengono usate<br />
doppie porte, sovrapponendo all’esterno una seconda porta a quella principale. Nelle case<br />
signorili sono comuni e caratteristici i portali in pietra. Con i camini possiamo considerare un altro<br />
elemento caratteristico, nella cui forma più semplice e primitiva non crea distinzione con il<br />
locale principale dell’abitazione, formando le cosiddette camere-focolare trattate a proposito delle<br />
tipiche grange d’alta montagna. Nella sua evoluzione naturale troviamo la cappa quale elemento<br />
di separazione deal resto della stanza. Il focolare resta aperto su di una base di pietra<br />
alta da una ventina di centimetri a un metro, costituendo la forma di base delle cucine. Questa<br />
cappa in muratura di pietra poggia su travi di larice squadrato incastrate da un lato del muro e<br />
ancorate dall’altro al soffitto con una staffa di ferro. Nelle case signorili, più volte prese in considerazione,<br />
i camini sono posti all’angolo tra due muri e vicino ad una finestra; solo raramente<br />
sono posti al centro di una parete, ed hanno le cappe sorrette con travi di sostegno ornate da<br />
scanalature orizzontali. Il difetto di questi camini era il tiraggio dei fumi che sovente veniva risolto<br />
inchiodando, al bordo in legno della cappa, una striscia di stoffa alta circa un metro.<br />
A partire dal 1700, i camini subiscono un’ulteriore evoluzione assumendo un aspetto<br />
meno imponente. Le sue dimensioni vennero considerevolmente ridotte, la cappa fu abbassata<br />
e due muretti rinchiusero i lati del focolare che venne parzialmente incassato nel muro.<br />
Fra manufatti della Val Maira, il fienile è un elemento molto importante considerando la<br />
rilevanza che esso assume per l’allevamento del bestiame in zone in cui la lunga copertura nevosa<br />
rende necessario l’immagazzinamento di grandi quantità di foraggio. Nella bassa Valle si<br />
vede sovente il fienile aperto sulla facciata frontale, con l’apertura chiusa da pareti amovibili<br />
formate da rami di nocciolo intrecciati. Nell’alta e media Valle esso è posto sotto il tetto in camere<br />
o in soppalchi poggiati su colonne e con i muri di sostegno del tetto che lasciano spazi vuoti<br />
per permettere la circolazione dell’aria. La stalla è, invece, seminterrata per conservare meglio il<br />
calore. Lo spazio era suddiviso in zone ben definite destinate ai vari tipi di allevamenti; solo le<br />
pecore erano tenute in stalle a parte. A causa della funzione centrale di questo locale la sua<br />
porta era posta sulla facciata più importante e meglio esposta della casa. Come la maggior parte<br />
degli elementi architettonici, anche l’aspetto dei forni varia considerevolmente da una zona<br />
all’altra della Valle. Nella parte più alta si usavano forni di grandi dimensioni, di proprietà di tutta<br />
la borgata, con diametro interno superiore ai 3 m. In queste borgate la panificazione avveniva<br />
una sola volta nell’anno e dava luogo a vere e proprie cerimonie. Di dimensioni notevolmente<br />
inferiori sono quelli della bassa Valle o delle case private. Qui il forno è a base circolare con una<br />
cupola in pietra. La bocca è a forma di arco a sesto acuto, chiusa da una lastra di pietra. La<br />
forma esterna è rettangolare nella parte anteriore e ricurva in quella posteriore. Sopra l’apertura<br />
anteriore si trova il camino. A causa delle già citate difficoltà nelle comunicazioni, si utilizzavano<br />
anche forni per la cottura della calce. Unico esempio di architettura industriale della zona sono i<br />
mulini e le forge, ormai quasi tutti distrutti e per i quali nessuno stanziamento pubblico per fini di<br />
recupero sembra essere stato progettato. Essi sorgevano lungo tutti i corsi d’acqua e gli ingranaggi<br />
erano in legno. Anche le fontane avevano assunto varie forme. Nelle borgate dell’alta valle<br />
erano costituite da un grande tronco di larice scavato, a volte diviso in scomparti per<br />
l’abbeveramento del bestiame.<br />
Nella altre zone della Valle il materiale usato è l’ardesia. Le fontane in pietra del 1400-<br />
1500 avevano sculture di reminiscenza celtica. Costruzioni ed edifici adibiti a difesa li troviamo<br />
esclusivamente a Dronero, sul promontorio formato dalla confluenza del Maira con il torrente di<br />
Roccabruna.<br />
293
Costruiti intorno al 1100, in questi ultimi anni, le mura hanno subito un grande processo<br />
di erosione.<br />
La “torrazza” – un antico torrione rotondo di difesa – è ancora ben conservato presso la<br />
frazione Monastero. L’unico vero castello feudale della Valle fu il castello di Cartignano, costruito<br />
intorno al 1460 e bruciato nel 1944. La sua torre più antica mostra due facciate a vela del tipo<br />
già descritto e comune nelle case signorili del tempo.<br />
Tra le opere di difesa troviamo anche il muro costruito lungo tutto il colle del Preit, nel<br />
1744, dalle truppe sabaude.<br />
Possiamo, poi, citare il castello di Montemale, al confine tra la Val Maira e la Val Grana.<br />
Gli ornamenti della Val Maira sono di fattura severa e povera. Essi consistono in sculture in pietra<br />
– portali, acquasantiere, fonti battesimali, ecc. – o semplici lavorazioni delle travature. Durante<br />
il periodo di massimo splendore artistico, tra il 1400 ed il 1500, molte sculture su pietra ornavano<br />
le finestre ed i portali delle case signorili. Esse rappresentano motivi floreali, simboli solari,<br />
serpenti, o angeli o teste umane stilizzate. In particolare, questa rappresentazione delle teste<br />
umane la troviamo anche nelle fontane, nei capitelli e nelle chiese.<br />
Successivamente si diffuse anche l’affresco che aveva essenzialmente carattere religioso.<br />
Molto diffuse sono poi le meridiane, affrescate su pareti di cappelle o di case. I tipi più antichi<br />
risalgono al 1600-1700, con linee che indicano particolari riferimenti astronomici, mentre le<br />
meridiane più recenti, costruite nel 1800 e all’inizio del ‘900, sono assai meno complesse e meno<br />
precise.<br />
La caratteristica della meridiana è quella di indicare l’ora solare del luogo in cui è costruita.<br />
Il valore attuale di queste meridiane – a parte il loro pregio artistico – consiste<br />
nell’essere la testimonianza di una profonda conoscenza di astronomia e di un uso sicuro di<br />
complessi procedimenti geometrici per tenere conto dell’orientamento della parete e della latitudine<br />
del luogo nella loro costruzione. Tutto ciò fa pensare che fossero opera di professionisti itineranti<br />
piuttosto che di artigiani locali. Degli attrezzi è difficile farne un’elencazione: quelli più<br />
tipici di questa valle sono legati alla produzione dei formaggi.<br />
Questi ultimi avevano la forma di sgabelli con il piano solcato da scanalature o scavato<br />
a forma di vasca e con un beccuccio sotto cui veniva posto un secchiello per raccogliere il siero.<br />
Su di essi venivano essiccati i formaggi in forme di legno sotto il peso di alcune pietre. In sintesi<br />
si può affermare che l’architettura, come la lingua, è una delle forme espressive più caratteristiche<br />
della cultura di un popolo o di una comunità. Se pure è vero che la distribuzione geografica<br />
dei vari elementi architettonici della Val Maira mostra come diverse influenze culturali abbiano<br />
agito nella zona, altrettanto vero è che queste si sono susseguite nei secoli passati con estrema<br />
lentezza ed hanno finito per divenire parte integrante della stessa cultura occitana, caratterizzandola<br />
ulteriormente rispetto a quella di altre vallate alpine. Tale cultura è, inoltre, rimasta<br />
maggiormente integra dalle influenze più recenti, grazie alle difficoltà di comunicazione ed allo<br />
scarso interesse turistico della valle. Tuttavia un forte fenomeno migratorio della popolazione,<br />
alla ricerca di una occupazione più stabile e remunerativa, unita alla frantumazione delle proprietà,<br />
causa della mancanza della struttura feudale, ha provocato l’abbandono ed il degrado<br />
dei manufatti.<br />
294
GLI ALBANESI D’ITALIA: LA MAPPA E LA CULTURA<br />
L’arbëresh è parlato da circa 70mila persone sparse in sette regioni. Le comunità più folte<br />
di trovano in Calabria e in Sicilia. Tutte hanno conservato un ricco patrimonio di usanze<br />
e di trazioni antichissime<br />
La cultura popolare esercita un’influenza diretta e significativa sulla letteratura che si ispira<br />
a temi della madrepatria e della diaspora.<br />
La compattezza e il senso d’identità della comunità sono dovute alla lingua comune e a<br />
una riconosciuta eredità culturale.<br />
Nonostante la crisi della civiltà contadina e la perdita delle simbologie cosmologiche le<br />
feste del ciclo dell’anno sono ancora diffuse.<br />
Si calcola che l’albanese (arbëresh) sia parlato oggi in Italia da circa 70.000 persone<br />
sparse nelle regioni del Molise, dell’Abruzzo, della Campania, della Puglia, della Basilicata, della<br />
Calabria e della Sicilia. Le comunità maggiormente consistenti si trovano in Calabria ed in Sicilia.<br />
Senza tenere conto delle numerose e notevoli colonie recenti, formatesi in conseguenza<br />
dell’emigrazione di moltissimi Albanesi nei grandi centri urbani di Palermo, Roma, Milano e Torino,<br />
che hanno costituito isole linguistiche albanofone, dette il “Mezzogiorno del Mezzogiorno”, i<br />
comuni in cui si parla l’albense (la cosiddetta “Arberia”) sono 41, che qui di seguito si elencano:<br />
Acquaformosa (CS), Barile (PZ), Campomarino (CB), Caraffa (CZ), Carfizzi (KR), Casalvecchio<br />
(FG), Castroregio (CS), Cerzeto (CS), Civita (CS), Contessa Entellina (PA), Falconara Albanese<br />
(CS), Firmo (CS), Frascineto (CS), Ginestra (PZ), Greci (AV), Lungro (CS), Maida (CZ), Maschito<br />
(PZ), Mongrassano (CS), Montecilfone (CB), Palazzo Adriano (PA), Pallagorio (KR), Piana<br />
degli Albanesi (PA), Plataci (CS), Portocannone (CB), San Basile (CS), San Benedetto Ullano<br />
(CS), Santa Caterina Albanese (CS), S. Cosmo Albanese (CS), S. Costantino Albanese (PZ),<br />
Santa Cristina Gela (PA), S. Demetrio Corone (CS), San Giorgio Albanese (CS), San Martino di<br />
Finita (CS), S. Marzano di San Giuseppe (TA), San Nicola dell’Alto (KR), San Paolo Albanese<br />
(PZ), Santa Sofia d’Epiro (CS), Spezzano Albanese (CS), Ururi (CB), Vaccarizzo Albanese<br />
(CS). A questi vanno aggiunti i cinque comuni di Andali (CZ), Brindisi di Montagna (PZ), Cervicati<br />
(CS), Mezzoiuso (PA), Rosciano (PE), delimitati dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, ma<br />
ove la lingua non viene parlata.<br />
Alcune associazioni private si occupano della diffusione della cultura albanese. Nella<br />
biblioteca provinciale di Cosenza vi sono circa 1.000 volumi nella lingua albanese. Alcune stazioni<br />
radio private trasmettono anche in lingua albanese.<br />
Vengono pubblicati alcuni periodici in lingua albanese. La chiesa cattolica consente<br />
l’uso della lingua albanese nella liturgia.<br />
La letteratura orale<br />
La cultura degli Albanesi d’Italia può considerarsi ancora oggi di tipo prevalentemente<br />
orale, nel senso che, essendo la maggior parte degli Arbëreshë analfabeti nei confronti della<br />
propria lingua materna, l’unico patrimonio culturale, di cui possono fruire direttamente, è quello<br />
tramandato oralmente dalla lingua stessa alle diverse forme espressive, che essa media.<br />
E del resto la cultura popolare ha esercitato, e in parte esercita ancora, una influenza<br />
diretta e assai significativa sulla letteratura riflessa, che spesso si ispira a temi e modalità caratteristici<br />
di un letteratura orale ancora saldamente radicata sia nella madrepatria d’origine che<br />
nelle comunità della diaspora.<br />
La letteratura popolare arbëreshë è stata, peraltro, vitale e creativa fino a tempi recentissimi<br />
ed è ancora viva la memoria degli ultimi verseggiatori popolari, le cui composizioni fanno<br />
ormai parte del patrimonio della comunità.<br />
Essa configura un patrimonio che si presenta quanto mai ricco e vario e che, dal punto<br />
di vista tematico, soprattutto per quel che riguarda alcuni generi letterari, identifica immediatamente<br />
una entità etnico-culturale, che ha radici profondamente diverse dalle popolazioni italofone<br />
circostanti; nonostante, poi, la frammentazione, che caratterizza la distribuzione geografica<br />
degli Arbëreshë sul territorio italiano, essa conserva una propria compattezza e una forte identi-<br />
295
tà, le cui ragioni, oltre che nella lingua riconosciuta comune, tenuto conto anche delle variazioni<br />
dialettali, risiedono nella reciproca identificazione della medesima eredità culturale. Nel cosiddetto<br />
“giaku ynë i shprishur” (“Il sangue nostro disperso”) gli Arbëreshë in Italia comprendono se<br />
stesi ed anche tutti gli Albanesi in madrepatria o dispersi nel mondo.<br />
Si è accennato al fatto che la letteratura popolare Arbëreshë ha influenzato significativamente<br />
la letteratura colta.<br />
In effetti, quasi tutti i maggiori autori Arbëreshë sono stati anche raccoglitori e studiosi<br />
del folclore del proprio popolo, dal quale hanno saputo trarre ispirazione e linfa per la loro attività<br />
creativa.<br />
Una raccolta di canti popolari, con poche aggiunte creative, è, infatti, uno dei primi documenti<br />
dell’ Arbëresh scritto, il cosiddetto “Manoscritto di Chiesti”.<br />
Vivi echi di canti popolari religiosi si ritrovano nell’opera “Gjella e Sh. Mëris Virgjër” di<br />
Giulio Varibobba, e canti popolari sono ancora raccolti nel manoscritto cosiddetto di Michele<br />
Bellusci, di incerta datazione e attribuzione.<br />
Ma è con Girolamo de Rada, massimo esponente del romanticismo arbëresh, che la<br />
raccolta del patrimonio letterario popolare diventa progetto consapevole e finalizzato<br />
all’affermazione della identità della Nazione albanese nel suo significato più vasto, etnico, culturale<br />
e politico.<br />
Le “Rapsodie d’u poema albanese raccolte nelle colonie del Napoletano” (Firenze,<br />
1866) propongono un patrimonio vastissimo raccolto dalle fonti più diverse e fuso nel disegno<br />
unitario di una ipotizzata grande epopea nazionale sul modello dei poemi omerici.<br />
Il poema della stirpe, dunque, che, ricostituito nella sua ideale originalità, veniva restituito<br />
al popolo perché ne risuscitasse l’orgoglio e nutrisse la coscienza etnica delle generazioni<br />
future.<br />
Né diversa ispirazione ha uno dei gioielli più preziosi della letteratura albanese “L’ultimo<br />
canto di Bala” di Gabriele Dara Jr., che l’autore stesso presenta come un insieme di canti popolari<br />
raccolti dai suoi predecessori e che costituisce in pratica la dilatazione, tramite elementi<br />
sempre tratti dal folclore, di una notissima ballata sul tema della trasformazione degli amanti in<br />
piante.<br />
L’attenzione degli intellettuali arbëreshë verso la letteratura popolare continuò, poi, con<br />
Giuseppe Schirò senior, albanese di Sicilia, che, agli esordi della sua feconda produzione letteraria,<br />
fu autore di due raccolte di canti popolari, l’una di carattere profano e l’altra di carattere<br />
sacro, e don Antonio Scura, autore dell’ampia raccolta di canti epici e lirici, né si è ancora, ai<br />
nostri giorni, esaurita come dimostrano la pubblicazione, sotto gli auspici dell’istituto di Studi Albanesi<br />
dell’Università di Roma, di un amplissimo corpus, riguardante la novellistica popolare e il<br />
copioso materiale, soprattutto poetico, pubblicato, spesso con interessanti commenti, nelle riviste<br />
italo-albanesi.<br />
Mentre, però, lo studio della novellistica popolare attende ancora di essere affrontato,<br />
per cui, al di là di impressioni superficiali, non è possibile allo stato attuale fornire elementi sui<br />
suoi contenuti e sulle sue relazioni con la tradizione favolistica d’oltre Adriatico, con la quale esistono,<br />
peraltro, fondamentali identità, e con quella italiana, che vi ha, comunque, esercitato<br />
indubbie e spesso significative influenze, numerosi sono, invece, gli studi sulla poesia, soprattutto<br />
per quel che riguarda le ballate di carattere leggendario, che sono il genere che maggiormente<br />
ha attratto l’attenzione degli studiosi.<br />
Si tratta, in generale, di testi destinati ad essere cantati in occasioni particolari (feste del<br />
ciclo dell’anno o dell’uomo) e accompagnati, nella maggior parte dei casi, dalla danza.<br />
Una testimonianza tipica in questo senso sono le cosiddette “Vallje” pasquali di Civita e<br />
Frascineto, in provincia di Cosenza, di cui si parlerà ampiamente più avanti.<br />
Le rapsodie<br />
I temi di questi canti, conosciuti in tutte le comunità albanofone e specifici, in origine, di<br />
ogni singola festa, si differenziano significativamente da quelli del folclore italo-meridionale e<br />
trovano i loro corrispettivi nel folclore balcanico e albanese in particolare, così come spesso oltre<br />
Adriatico sono rintracciabili i riferimenti geografici e ambientali contenuti in alcuni di essi, il<br />
che rivela che la loro origine è anteriore alla venuta degli Arbëreshë in Italia.<br />
Tra i temi più caratteristici, vale la pena di ricordare la resurrezione dalla tomba per<br />
mantenere la parola data (besa), che si esplicita nella ballata Arbëreshë di “Costantino e Garen-<br />
296
tina” (o Jurendina) e nel ciclo shqipetaro di “Aga Imeri”, quello del riconoscimento fra due individui<br />
in un momento critico dopo una lunga separazione, su cui sono imperniate la ballata Arbëreshë<br />
di “Costantino il Piccolo” (Kostantini i voglith), in cui protagonisti del riconoscimento sono<br />
due sposi separati dalla guerra pochi giorni dopo il matrimonio e quella, finora registrata solo a<br />
Civita, del riconoscimento tra fratello e sorella, che presenta, invece, nel corrispondente ciclo<br />
albanese un ventaglio assai più vasto di possibilità.<br />
Altro tema rilevante e produttivo, anche sul piano della letteratura riflessa, è quello della<br />
trasformazione in piante simboliche e abitualmente viventi in associazione dei protagonisti di<br />
una storia d’amore contrastata e conclusa tragicamente, tema che è alla base del già citato poemetto<br />
“Kënga e sprasme e Balës” di Gabriele Dara Jr., al quale corrisponde nel folclore<br />
d’Albania il ciclo di “Mëmeri e Merima”.<br />
Né mancano ballate di carattere storico che rievocano le gesta dell’Eroe della lunga lotta<br />
contro i Turchi, Giorgio Castriosta Skanderbeg e di altri personaggi storici e leggendari suoi<br />
contemporanei alleati o avversari. Si tratta di un’epica più recente, nata all’epoca delle migrazioni<br />
o addirittura in un periodo successivo, come prova la diffusione più limitata dei testi.<br />
La lirica<br />
Assai cospicua è anche la letteratura popolare di tipo lirico: canti d’amore estemporanei<br />
nei quali, tuttavia, ricorrono spesso formule codificate e figure retoriche comuni ad aree albanofone<br />
anche molto distanti tra loro, che denunciano, pertanto, una origine molto remota.<br />
La donna amata viene cantata come Natura, paragonata al lucido e profumato turgore<br />
della mela matura, alla ricchezza celata e accattivante del melograno, al candore splendente<br />
della neve, alla dolce e timida violetta, i suoi occhi sono bacche di lentisco dall’aroma intenso, o<br />
promettenti nere olive incastonate come gioielli nella cornice del volto.<br />
Sul piano esecutivo, questi canti si distinguono in tre varianti tipologiche:<br />
- “Këngë e Kangjel”, che può essere paragonata alla canzone propriamente detta, eseguita per<br />
intero da un unico coro; sul piano metrico è formata da distici endecasillabi;<br />
- “Graxeta e zgarxeta” in cui si alternano due cori, il secondo dei quali ripete gli stessi versi del<br />
primo, variandone il motivo nel finale, che viene in genere allungato sul piano metrico; i versi<br />
sono in questo caso settenari o ottonari e vengono eseguiti ad uno ad uno;<br />
- “Vjershi”, che viene intonato da un solista, cui subentra successivamente il coro. I versi sono,<br />
in genere, endecasillabi, di cui il solista esegue il primo emistichio, mentre il secondo è eseguito<br />
dal coro che poi ripete l’intero verso.<br />
All’interno della struttura sociale rivestono un ruolo importante, una sorta di funzione catartica,<br />
anche i canti di scherno, a volte anche molto feroci, che caratterizzano rituali tipici di alcune<br />
ricorrenze, come il Carnevale, le feste locali, i falò di maggio e quelli di dicembre, ma che<br />
potevano anche costituire risposte immediate e pubbliche a torti subiti o supposti.<br />
I canti religiosi<br />
Un discorso a parte meritano i canti popolari di natura religiosa, le cosiddette “Kalimere”,<br />
termine questo di origine greca che vuole dire, “Buon giorno” e che costituisce probabilmente<br />
la formula di esordio di questi canti, nati presumibilmente in area greca o passati attraverso la<br />
Grecia, e comunque legati, almeno in origine, a rituali religiosi di tipo bizantino.<br />
Si tratta di canti di tipo narrativo – episodi della vita di Cristo (in genere la Natività, la<br />
Passione, la Resurrezione di Lazzaro), o di alcuni santi – nei quali la narrazione, nella forma tipica,<br />
è compresa tra una formula di saluto iniziale e una formula augurale conclusiva, entrambe<br />
rivolte ad un soggetto identificato talvolta esplicitamente come “padrone di casa”.<br />
Tali canti venivano, infatti, eseguiti, in passato, da gruppi di persone, che, alla vigilia<br />
della festa o durante la Grande e Santa Settimana giravano di casa in casa come a portare<br />
l’annuncio dell’evento.<br />
Tale uso permane, oggi, solo in alcune comunità e per alcune festività, in particolare a<br />
Piana degli Albanesi (PA) e San Benedetto Ullano (CS) per il Sabato di Lazzaro, mentre, per il<br />
resto, i canti vengono di solito eseguiti durante le processioni relative alle diverse ricorrenze religiose.<br />
Vi sono elementi per supporre che la loro forma attuale rappresenti l’evoluzione di testi<br />
augurali e propiziatori più antiche legati a rituali pagani, successivamente cristianizzati in seguito<br />
alla trasformazione delle antiche feste pagane e, poi, ulteriormente caratterizzati in questo<br />
297
senso, mediante l’allargamento della parte narrativa, a spese della parte augurale in origine<br />
prevalente.<br />
Alcuni di essi sono noti in diverse comunità, presupponendo quindi una origine più remota<br />
o quanto meno una notevole circolazione dei testi ad opera probabilmente dei Papades.<br />
Altri hanno, invece, diffusione più circoscritta e addirittura locale, essendo legati a festività<br />
caratteristiche o particolarmente sentite in certe aree o comunità.<br />
Della loro origine si discute ancora molto. E’ un fatto che i tre testi più conosciuti, relativi<br />
alla Passione, sono contenuti nella “Gjella e Sh. Mëris Virgiër” del Varibobba, ma non è affatto<br />
sicuro che egli ne sia veramente l’autore.<br />
Così come è invece appurato che altri testi religiosi, non tutti tipicamente classificabili,<br />
però, come “Kalimere”, siano da attribuire a Francesco A. Santori, sacerdote di S. Caterina Albanese,<br />
uno degli scrittori arbëresh più fecondi.<br />
E del resto, un ruolo certamente fondamentale nella loro composizione e diffusione<br />
l’ebbero i sacerdoti, cosa che non desta alcuna meraviglia se si considera che per secoli questi<br />
canti hanno costituito uno strumento prezioso di catechesi e di preghiera all’interno della comunità,<br />
in cui le funzioni religiose venivano celebrate in greco, lingua del tutto incomprensibile ai<br />
fedeli.<br />
Le feste popolari<br />
Nonostante l’inevitabile erosione, dovuta all’abbandono della civiltà contadina o comunque<br />
alla perdita delle simbologie cosmologiche, che ne erano all’origine, diverse e con aspetti<br />
particolarmente interessanti sono le feste del ciclo dell’anno, ancora vive tra gli Arbëreshë.<br />
La più significativa di esse, cronologicamente legata alla Pasqua, è senz’altro quella<br />
generalmente nota come “Festa delle Vallje” (per gli Arbëreshë Vallet o Vallet e Pashkvet), festa<br />
dalle origini molto remote, che ha subito, nel corso della storia, una serie di reinterpretazioni,<br />
che le hanno consentito di conservare una vitalità e un valore simbolico, sconosciuti ad altre ricorrenze.<br />
La “Festa delle Vallje”, dunque, si celebrava nei secoli passati in tutte le comunità albanesi<br />
d’Italia e durava tre giorni, iniziando la Domenica di Pasqua e terminando la sera del martedì<br />
successivo.<br />
In alcune comunità essa andò esaurendosi, con tutta probabilità, spontaneamente, ma<br />
particolarmente significativo è il fatto che, per quanto riguarda i paesi Arbëreshë della Presila<br />
cosentina, nel sec. XVIII essa fu proibita dal Vescovo di Rossano, per motivi legati alle modalità<br />
del suo svolgimento, in particolare perché giudicata “promiscua”.<br />
In effetti, alcuni elementi presenti nei canti tipici della “Festa” consentono di connotarla<br />
come originariamente legata alle feste della primavera e ai riti propiziatori della fertilità ad essi<br />
collegati. Data, però, la coincidenza con il periodo pasquale non fu difficile, in ambiente cristiano,<br />
riproporla come festa religiosa di celebrazione della Resurrezione di Cristo, celebrazione<br />
che, peraltro, ancora nel XVIII secolo doveva conserve tracce non trascurabili dell’originaria paganità.<br />
In un periodo successivo, la festa subì una seconda reinterpretazione, di natura storicistica,<br />
che fu di nuovo favorita da una coincidenza cronologica con un evento, in cui gli Albanesi<br />
dell’epoca dovettero riconoscere un valore simbolico equivalente a quello della primavera e della<br />
Resurrezione. La riconquista di Cruja, antica capitale dell’Albania, ad opera delle truppe di<br />
Skanderbeg, avvenne, infatti, il 27 aprile 1467, esattamente il martedì successivo alla Domenica<br />
di Pasqua.<br />
Vuole le tradizione che lo stesso Eroe abbia indetto tre giorni di festeggiamenti.<br />
La “Festa” consiste attualmente in danze, che gruppi di persone eseguono per le vie del<br />
paese, tenendosi per mano e cantando le ballate storiche o leggendarie, tipiche di questa ricorrenza.<br />
Tali gruppi, denominati appunto “Vallje”, possono essere femminili, guidati però alle due<br />
estremità da uomini, oppure esclusivamente maschili. In quest’ultimo caso assumono il nome<br />
caratteristico di “Plezit” o “Pjelzit”, termini controversi tradotti nei dialetti italiani circostanti come<br />
“vecchiareddi”, e vengono comunemente interpretati in modo probabilmente improprio come<br />
rappresentazione dei guerrieri di Skanderbeg.<br />
Le “Vallje” avanzano con movimenti circolari, avvolgenti, formando delle spire in cui<br />
vengono imprigionati i forestieri, che, per essere liberati, devono pagare un simbolico riscatto.<br />
298
Secondo la tradizione, questo rituale sarebbe una memoria della strategia, che Skanderbeg<br />
usava nella sua lunga lotta contro i Turchi. Si tratta in realtà di un tipo di danze corali,<br />
diffusissime nei Balcani, che trovano i loro antecedenti nelle danze pirriche e deleutiche, ma la<br />
particolare interpretazione, che ne viene data, si inquadra nel significato etnico di cui venne a<br />
caricarsi la festa dopo la migrazione degli arbëreshë in Italia, significato che in qualche caso<br />
viene sottolineato anche da altri rituali. A Frascineto, ad esempio, è consuetudine segnare di<br />
nero tutte le persone che risultino non albanesi.<br />
La “Festa delle Vallje” sopravvive, oggi, concentrata quasi esclusivamente nel martedì,<br />
che ne ha sempre costituito la giornata culminante, nelle tre comunità calabro-albanesi di Civita,<br />
Frascineto ed Eianina e, in forma notevolemtne diversa, nella comunità siculo-albanense di<br />
Piana degli Albanesi, dove però si celebra la domenica.<br />
In anni abbastanza recenti essa ha subito, tuttavia, una nuova interpretazione, che da<br />
festa celebrata a livello esclusivamente paesana l’ha trasformata in occasione d’incontro degli<br />
arbëreshë di tutte le comunità sparse in Italia.<br />
Accentuandone il carattere di festa nazionale già insito nella predente interpretazione<br />
storicistica, questo ne fa oggi, per tutti gli arbëreshë, un momento consapevole di autoriconoscimento<br />
e di affermazione della propria identità etnica nei confronti del pericolo sempre più<br />
grave dell’omologazione culturale.<br />
La “Festa delle Vallje”, peraltro, può essere letta come conclusione, di un periodo rituale,<br />
che iniziava con quello che è attualmente denominato “Sabato di Labaro”, alla vigilia del quale,<br />
come già accennato, era tradizione che gruppi di giovani, portanti in mano rami di alloro o<br />
“palme” artificiali di canna, cariche di dolciumi, andassero di casa in casa, eseguendo un canto<br />
rituale sacro, la “Kalimera” di Lazzaro.<br />
Si tratta con ogni probabilità di un’usanza precristiana, successivamente reinterpretata<br />
secondo la nuova religione. I canti ad essa relativi sono, infatti, noti con nome di “Lazoret” anche<br />
nei territori albanofoni dei Balcani, dove tuttavia, hanno struttura diversa da quelli arbëreshë.<br />
Mentre in questi ultimi, con l’eccezione del testo relativo alla tradizione di S. Benedetto Ullano<br />
(CS) è prevalente la parte narrativa relativa alla descrizione della resurrezione di Lazzaro,<br />
nei testi d’oltre Adriatico predomina la parte augurale-propiziatoria, fino al punto che nella maggior<br />
parte dei casi Lazzaro viene menzionato di sfuggita solo di nome. Spostando questi dati sul<br />
piano diacronico, si può ipotizzare un processo di progressiva cristianizzazione del rito, che ha<br />
raggiunto il culmine a Piana degli Albanesi, dove il gruppo dei cantori è capeggiato di solito da<br />
un sacerdote. Particolare rilievo aveva fino a pochi decenni or sono anche il Carnevale, per il<br />
quale sono ancora noti in alcune comunità canti speciali, uno dei quali menziona l’eroe nazionale<br />
Giorgio Castriota Skanderbeg e loda l’opulenza della sua mensa. Attualmente l’importanza di<br />
questa festa è ovunque decaduta, insieme ai suoi tratti più tipici, con l’unica eccezione di Lungro<br />
(CS), dove, invece, costituisce l’evento culminante dell’anno, quello al quale l’intera comunità<br />
tende, in una preparazione che dura un intero anno e ricomincia non appena la festa è finita<br />
e per il quale i lungresi lontani tornano al paese, come altrove succede per le feste patronali. Il<br />
Carnevale è a Lungro una festa di popolo, che non ha spettatori, perché tutta la comunità scende<br />
per le strade del paese ed è, ogni anno, una festa a tema, nel senso che a suo soggetto viene<br />
scelto un argomento o un personaggio, che nel corso dell’anno ha avuto particolare rilevanza<br />
a livello locale o nazionale.<br />
299
LA TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA CROATA IN ITALIA: SEGNO DI CIVILTÀ<br />
NELLA NUOVA EUROPA<br />
Il 5 novembre 1996, il Ministro degli Esteri italiano Lamberto Dini ed il suo omologo croato<br />
Mate Granic hanno firmato un trattato bilaterale sui diritti delle minoranze, che impegna reciprocamente<br />
Croazia ed Italia a tutelare le minoranze rispettivamente di lingua italiana e croata.<br />
Tra i Paesi dell’Ue, l’Italia è quello che presenta il maggior numero di minoranze linguistiche<br />
sul proprio territorio.<br />
Avendo ben presente questo quadro, la Costituzione italiana sancisce tra i suoi principi<br />
fondamentali che “La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche” (art.6).<br />
Di fatto, alcune di queste, situate in vicinanza del confine con altri Stati e collegate, sul<br />
piano linguistico e culturale, alla lingua ed alla cultura che in questi ultimi sono maggioritarie,<br />
godono fin dagli albori della Repubblica (minoranza di lingua tedesca e - ma per motivi di ordine<br />
diverso - ladina dell’Alto Adige, minoranza francofona della Valle d’Aosta e minoranza di lingua<br />
slovena nel Friuli Venezia Giulia) di una tutela che è andata via via perfezionandosi nel corso<br />
degli anni, fino a raggiungere livelli esemplari.<br />
La minoranza di lingua croata in Italia, oggetto, insieme a quella italiana in Croazia,<br />
dell’accordo bilaterale firmato a Zagabria dai Ministri Dini e Granic appartiene al gruppo della<br />
minoranze cosiddette “di antico insediamento”.<br />
Il suo insediamento, in una zona attualmente compresa entro i confini amministrativi<br />
della Regione Molise, risale a circa cinque secoli fa, all’epoca dell’invasione dei Balcani da parte<br />
dei Turchi.<br />
Attualmente, la popolazione di lingua croata in Italia conta, secondo stime non ufficiali,<br />
circa 1650 unità ed è concentrata nei tre Comuni di San Felice del Molise, Acquaviva Collecroce<br />
e Montemitro, tutte in Provincia di Campobasso.<br />
E ad essa che si riferisce l’art. 8 del “Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica<br />
croata concernente i diritti delle minoranze”.<br />
Il Trattato è il risultato di una lunga fase negoziale apertasi subito dopo la dissoluzione<br />
dell’ex-Jugoslavia e che si è sviluppata attraverso fasi alterne e momenti di grande tensione;<br />
esso è volto a risolvere, in primo luogo, il contenzioso relativo alla minoranza di origine italiana<br />
croata ed è infatti a questo che sono dedicati i primi sette articoli del testo.<br />
In sostanza, da parte croata, si dà attuazione al Memorandum d’intesa del 1992, che<br />
stabilisce l’unicità ed il carattere autoctono della minoranza italiana in lstria e Dalmazia, e di<br />
conseguenza la necessità che essa riceva un trattamento uniforme nei due Stati nati dalla dissoluzione<br />
dell’ex-Jugoslavia, Slovenia e Croazia, nella quale si trova attualmente stanziata, divisa<br />
in due tronconi da confini non più amministrativi ma politici. Ai suoi membri viene, inoltre,<br />
garantita libertà di movimento e di lavoro tra i due Stati exjugoslavi.<br />
Per quel che concerne la parte italiana e dunque la protezione della minoranza di lingua<br />
croata stanziata nel nostro Paese, la formulazione degli impegni è assai più sfumata, ma comunque<br />
abbastanza precisa da indicare l’effettiva volontà che misure volte a tutelare peculiarità<br />
linguistiche e culturali della comunità croata saranno effettivamente prese.<br />
L’art. 8 del Trattato recita, infatti, testualmente: “Senza pregiudizio all’attuazione da entrambe<br />
le parti di tutte le norme inserite nel presente Trattato, e tenendo conto delle norme contenute<br />
nello statuto della Regione Molise, la Repubblica italiana s’impegna a garantire alla minoranza<br />
autoctona croata nel territorio di insediamento tradizionale, dove ne è stata accertata la<br />
presenza, di preservare ed esprimere liberamente la loro identità e il patrimonio culturale, di usare<br />
la loro madre lingua in privato e in pubblico e di stabilire e mantenere le loro istituzioni ed<br />
associazioni culturali”.<br />
L’evidente sproporzione tra il numero di articoli molto dettagliati dedicato alla tutela della<br />
minoranza italiana in Croazia e l’unico articolo avente come oggetto l’apparente contropartita<br />
della tutela della minoranza croata in Italia si spiega agevolmente con la consistenza ben diversa<br />
delle due popolazioni, con le diverse caratteristiche del loro insediamento, da cui discendono<br />
esigenze obiettivamente diverse di tutela e, infine, dal diverso peso interno ed internazionale<br />
delle problematiche correlate.<br />
Nell’ultimo decennio, sia in sede di Ue, di Consiglio d’Europa, di Osce (Organizzazione<br />
per la sicurezza e la cooperazione in Europa) e di Cei (Iniziativa Centro Europea), l’Italia è stata<br />
300
tra i promotori ed i sostenitori principali di una serie di iniziative miranti appunto a garantire i diritti<br />
delle minoranze nazionali, etniche e linguistiche.<br />
I risultati di questo impegno si sono concretati, oltre che in diversi documenti Osce sul<br />
tema specifico, nel cosiddetto Strumento Cei per la protezione dei diritti delle minoranze adottato<br />
dai Paesi aderenti all’Iniziativa, tra cui anche Italia e Croazia, e nella Convenzione quadro europea<br />
sulla protezione delle minoranze nazionali approvata dal Consiglio d’Europa e ratificata<br />
dal nostro Paese.<br />
É evidente che, sommandosi gli impegni derivanti da tali documenti a quelli legati ad altri<br />
atti internazionali sui diritti dell’Uomo sottoscritti dal nostro Paese, la soluzione globale del<br />
problema delle minoranze in Italia è stata ed è in corso di attuazione mediante i progetti di tutela<br />
finanziati con i fondi della legge – quadro 15 dicembre 1999, n. 482. La legge-quadro demanda<br />
alcuni compiti alle Regioni in cui le minoranze ammesse a tutela sono stanziate, riservando allo<br />
Stato un controllo sull’ordinamento scolastico, per quel che riguarda in particolare i programmi e<br />
gli orari d’insegnamento, in accordo con la normativa vigente del settore.<br />
É estremamente importante che la tutela delle minoranze venga a trovarsi collegata ad<br />
una questione di rapporti con paesi esteri; resta ugualmente importante, peraltro, la necessità<br />
che questa tutela sia assicurata sul piano del diritto interno. Il termine “autoctono”, riferimento<br />
puntuale e collegato al territorio di insediamento tradizionale, dove ne è stata accertata la presenza<br />
(della minoranza, ndr.)”, mira a distinguere la minoranza croata storica di antico insediamento<br />
dalle nuove minoranze che vanno formandosi nel nostro Paese in seguito ai consistenti<br />
flussi immigratori degli ultimi anni e che, nel caso specifico dei Croati, è già probabilmente assai<br />
più numerosa di quella presente in Molise. In accordo con gli orientamenti emersi in materia<br />
presso tutti gli organismi internazionali e rispecchiati nei documenti adottati, ivi compresi la<br />
Convenzione quadro europea per la tutela delle minoranze nazionali e lo strumento Cei, le cosiddette<br />
“nuove minoranze” restano, in questa fase, escluse dai provvedimenti di tutela riservati<br />
alle minoranze storiche, in attesa di un approccio specifico, essendo le loro problematiche assolutamente<br />
nuove e peculiari rispetto a quelle tradizionali.<br />
Relativamente al primo punto, invece, gioverà sottolineare che per la prima volta una<br />
minoranza non di confine e numericamente molto piccola, che non ha mai avuto aspirazioni autonomistiche<br />
o separatistiche e non ha mai costituito problema per lo Stato italiano, al punto da<br />
poter essere perfino tranquillamente “ignorata”, venga ora a trovarsi, di colpo, oggetto di un trattato<br />
internazionale, posta, sul piano del diritto, accanto ad una minoranza italiana assai consistente,<br />
avente radici storiche diverse e ben più antiche, e che ha costituito per decenni oggetto<br />
di negoziazione internazionale e di contenzioso anche grave tra l’Italia e la Repubblica federativa<br />
di Jugoslavia prima e tra l’Italia e le Repubbliche di Croazia e Slovenia poi.<br />
Ciò rappresenta un indubbio progresso ed è certamente frutto di una scelta meditata e<br />
maturata in primo luogo sul piano interno, di cui l’art. 8 del Trattato italo-croato sui diritti delle<br />
minoranze è, dunque, la conseguenza e non il movente.<br />
Oggi, in una società che tende globalmente ad un livellamento che rischia di isterilirla<br />
pericolosamente, la tutela delle minoranze è un segno di civiltà in una nuova Europa in cui ciascun<br />
popolo, nel rispetto delle proprie peculiarità, è chiamato a dare ancora una volta il proprio<br />
contributo per la comune crescita umana e civile.<br />
301
MINORANZE E CULTURA<br />
Ciascun popolo si riconosce in un sistema peculiare di relazioni con l’ambiente naturale<br />
ed umano, dal quale origina e si evolve una particolare eredità fenomenologica espressiva e<br />
rappresentativa che costituisce ciò che in genere si intende con «cultura». Tale fenomenologia<br />
costituisce l’aspetto percettibile e immediatamente evidente del sistema di valori e temi che sottendono<br />
i modelli culturali nei quali i popoli individuano la particolarità ed esclusività della loro<br />
posizione in rapporto alla realtà che li circonda.<br />
La cultura, nei diversi livelli in cui si manifesta, è un insieme di elementi sui quali un determinato<br />
gruppo fonda l’autoriconoscimento da un lato ed il riconoscimento reciproco dall’altro.<br />
Il termine assume il suo significato più ampio, cioè di quello che copre tutte le espressioni della<br />
vita sociale di una comunità e ne delinea la Weltanschauung che le è propria. Rientrano in questa<br />
definizione gli usi e i costumi, l’organizzazione delle attività economiche, la strutturazione dei<br />
rapporti oggetti e gli utensili di uso quotidiano o rituale, la cucina, la struttura delle abitazioni, dei<br />
quartieri, e più ampiamente dei centri abitati.<br />
In un certo senso, e in particolare nel caso di culture illetterate o « analfabete» va compresa<br />
nel concetto di cultura anche la lingua, che è l’elemento più immediatamente percettibile<br />
di differenza o identità e viene per questo considerata elemento fondamentale di riconoscimento.<br />
Su questo insieme di fattori ciascun gruppo costruisce una immagine di sé, ed insieme<br />
un’immagine degli altri gruppi, per riconoscerli come uguali o diversi da sé.<br />
In questo processo, non tutti i fattori hanno di fatto lo stesso peso: ad alcuni viene attribuito<br />
un ruolo essenziale, altri vengono considerati di minore importanza, altri ancora possono<br />
esser ritenuti trascurabili ed alcuni, pure individuabili dallo studioso o dall’estraneo al gruppo,<br />
possono addirittura non essere affatto percepiti all’interno di questo.<br />
Uno dei fattori essenziali di riconoscimento è indubbiamente, come già accennato, la<br />
lingua, che, al di là delle differenze dialettali che individuano all’interno di ciascun gruppo sottogruppi<br />
ben delimitati, sembra in grado più di ogni altro elemento di assumere il ruolo di fattore<br />
primario, al quale tutti gli altri, in misura maggiore o minore, sono subordinati.<br />
Di fronte all’identità linguistica, che consente l’apertura di un canale di comunicazione<br />
privilegiato e dunque l’accesso agli altri gradi del processo altri fattori, che pure il gruppo stesso<br />
ritiene oggettivamente importanti, possono essere considerati secondari, così come solo la concorrenza<br />
di più fattori secondari viene considerata sufficiente per il riconoscimento, laddove<br />
manchi l’identità linguistica.<br />
Tuttavia, la lingua, pur essendo essa stessa lo strumento formativo della realtà, nel<br />
senso che ne fornisce e tende a perpetuarne la interpretazione propria di ciascuna cultura, non<br />
può essere assunta ad elemento unico di identificazione etnica, in quanto la semantica del codice<br />
linguistico minoritario mostra di solito una forte tendenza all’adeguamento alla semantica<br />
del codice dominante.<br />
Tale tendenza si è fatta più marcata negli ultimi decenni per una serie di motivi riconducibili<br />
nel loro complesso agli effetti della scolarizzazione di massa anche al livello medio e superiore<br />
e alla diffusione capillare dei mezzi di comunicazione di massa.<br />
In effetti, il primo di questi fattori, affermando il primato della parola scritta su quella parlata,<br />
ha di fatto provocato l’interruzione della trasmissione orale della cultura, mentre il secondo<br />
ha agito in sinergia per la definitiva affermazione della superiorità del modello linguistico e culturale<br />
dominante su quello minoritario.<br />
Sul piano linguistico, ciò si traduce potenzialmente in un pesante impoverimento lessicale,<br />
spesso con la perdita di intere terminologie non più funzionali alle nuove realtà socioeconomiche,<br />
delle lingue minoritarie, non sostenute a livello scolastico, e nel progressivo adeguamento<br />
semantico al modello dominante del lessico residuo. In sostanza la lingua in sé può,<br />
al limite, non essere più significativa di una cultura, ma esprimere Weltanschauung proprie di<br />
culture che originariamente le erano aliene.<br />
A questa tendenza le minoranze oppongono, più o meno consapevolmente, una forza<br />
contraria alla conservazione che, più che sul piano linguistico, trova forse espressione sul terreno<br />
culturale, o meglio sul terreno delle espressioni culturali e si concreta in una accentuazione<br />
del valore di alcuni tratti identificativi considerati peculiari e particolarmente significativi, nel ten-<br />
302
tativo di recuperare, almeno a livello di conoscenza, alcuni tratti perduti, ed in uno sforzo di ricostruzione<br />
della propria memoria storica.<br />
Si potrebbe obiettare, con Levi Strauss, che « nella misura in cui le altre culture cercano<br />
di preservare qualcosa della loro eredità tradizionale, questo tentativo si riduce di solito alle sovrastrutture,<br />
cioè agli aspetti più fragili », ma, se questo è indubbiamente vero, vero è anche<br />
che la fenomenologia pone di per sé una serie di interrogativi, di perché e per come, che possono<br />
aprire finestre interessanti su contenuti e messaggi culturali ancora fecondi.<br />
Le minoranze presenti in Italia sono quasi tutte fortemente minoritarie, non solo in ambito<br />
nazionale, ma anche nelle regioni di insediamento. Esse sono quasi tutte popolazioni allogene.<br />
provenienti. cioè, da territori posti al di fuori dei confini nazionali, o meglio, con riferimento ai<br />
tempi (diversi) del loro insediamento, fuori della penisola italiana. Alcune di esse ad (es., gli Albanesi)<br />
conservano forte memoria delle loro origini e delle ragioni dell’emigrazione, che sono<br />
oggetto di epopee popolari ancora vive: per altre (ad es., i Greci) si dibatte ancora sui tempi e i<br />
motivi del loro insediamento nella penisola. Tutte, però, sono caratterizzate da uno spiccato<br />
senso della loro identità nei confronti della cultura maggioritaria italiana, attualmente, e delle<br />
culture romanze che erano ad esse limitrofe nel passato.<br />
In effetti, in quanto allogene, esse sono anche portatrici di un retaggio culturale fortemente<br />
differenziato nei confronti delle culture romanze con cui, insediandosi in Italia, sono venute<br />
a contatto. Le radici delle loro culture in altri termini, vanno ricercate nei rispettivi territori e<br />
culture di provenienza a cui esse stesse fanno consapevole riferimento Anche a distanza di secoli<br />
infatti molti e molto significativi sono gli elementi intrinseci e fenomenologici che accomunano<br />
la cultura delle minoranze insediate in Italia alle culture delle rispettive madrepatrie d’origine.<br />
Sarebbe sbagliato, come pure si è fatto e in parte si continua a fare, vedere in ogni loro<br />
espressione culturale l’autenticità e la purezza incontaminata delle origini. Accanto ad elementi<br />
indubbiamente comuni e che hanno avuto sviluppi analoghi, esistono, infatti, anche elementi<br />
che, sotto l’influsso di condizioni storico-ambientali diverse, hanno avuto sviluppi divergenti ed,<br />
ancora, elementi che le minoranze hanno mutuato dalle culture romanze limitrofe, sia pure attraverso<br />
un processo di integrazione nel loro sistema, che ne comporta una rilettura secondo<br />
parametri specifici. Si tratta, in sostanza, di un fenomeno tipico delle culture in contatto, tra le<br />
quali si stabilisce un flusso reciproco di elementi, finché esistono condizioni di parità di peso<br />
specifico e di prestigio.<br />
In effetti, nel caso delle popolazioni minoritarie in questione, tale condizione non si è<br />
mai realizzata almeno in uno dei suoi aspetti, quello numerico, nel senso che la popolazione<br />
romanza è sempre stata comunque maggioritaria nelle loro aree di insediamento; a favore<br />
dell’elemento romanzo hanno giocato anche le situazioni ambientali ed economiche consolidate<br />
delle varie aree, che hanno verosimilmente imposto alle popolazioni di nuovo insediamento, anche<br />
nei periodi di supposto totale isolamento, un precoce adattamento alle nuove condizioni,<br />
con conseguente modifica di assetto economico e di abitudini precedenti.<br />
Sul piano del prestigio linguistico e culturale, tuttavia, le popolazioni romanze autoctone<br />
e le popolazioni allogene, entrambe legate all’oralità, hanno vissuto una condizione di parità di<br />
fatto, scandita da un atteggiamento reciproco caratterizzato da una proclamata ostilità, di cui si<br />
trovano ampie tracce nella tradizione orale dei rispettivi gruppi, ma che nella realtà, anche nei<br />
casi non frequenti in cui la prassi quotidiana era caratterizzata da precise norme isolazionistiche,<br />
non ha mai costituito un serio ostacolo agli scambi e alla comunicazione. Tale condizione,<br />
che ha garantito la salvaguardia delle specificità linguistiche e culturali delle minoranze, pur<br />
nell’ambito di un processo continuo di interscambio in cui per motivi « ambientali » tendeva a<br />
prevalere la direzionalità cultura romanza-cultura minoritaria, è venuta meno con l’affermazione<br />
di una cultura maggioritaria « nazionale », quella italiana, immediatamente percepita come «<br />
prestigiosa » in quanto legata al codice scritto, supportata dalla scuola e capace, essa soltanto,<br />
di garantire promozione sociale ed economica<br />
Questa affermazione ha mutato, in qualche modo, la direzionalità delle influenze linguistiche<br />
e culturali, nel senso che, via via che il processo progrediva e che l’accesso alla cultura «<br />
nazionale » veniva ad allargarsi a fasce sempre più ampie di popolazione, veniva progressivamente<br />
a diminuire l’influsso dei dialetti e delle culture locali sulle lingue e culture delle minoranze,<br />
mentre si accentuava, di pari passo, l’interferenza della lingua e della cultura nazionali.<br />
303
Ciò trova riscontro, nella diacronia linguistica, nella sostituzione di numerosi prestiti dai<br />
dialetti romanzi con neoprestiti dall’italiano e, nella prassi comportamentale nella assunzione di<br />
modelli mutuati da quelli proposti dalla fonte più « prestigiosa ».<br />
Mentre però, nella situazione precedente elementi percepiti come equivalenti sul piano<br />
del prestito venivano, quando assunti, integrati in un sistema solido che li ricollocava all’interno<br />
di sé stesso secondo i propri parametri ed esigenze, nella nuova situazione caratterizzata da un<br />
flusso assolutamente unidirezionale cultura nazionale-culture minoritarie, gli elementi linguistici<br />
e culturali « prestigiosi » irrompono nelle realtà minoritarie imponendo se stessi e non vengono<br />
più integrati in maniera indolore nel sistema culturale che li riceve, ma lo scompaginano minandolo<br />
alle fondamenta.<br />
Sul piano linguistico, questo si traduce non solo in una progressiva, evidente italianizzazione<br />
del lessico delle lingue minoritarie ma anche in un processo di snaturamento morfosintattico<br />
di esse, che non supportate dall’insegnamento scolastico e dunque dalla pratica scritta<br />
a livello di massa, vanno trasformandosi in strani ibridi senza fisionomia, sempre più confluenti<br />
verso l’italiano. Sul piano culturale, l’abbandono della modalità di trasmissione orale della<br />
cultura, non accompagnato da un accesso alla tradizione letteraria scritta nelle lingue di minoranza,<br />
nei confronti delle quali la maggior parte di coloro che ancora le usano continuano ad<br />
essere analfabeti, ha di fatto alienato le minoranze, privandole del proprio retaggio e della propria<br />
storia e dettando loro un retaggio ed una storia che le ignora.<br />
Le culture minoritarie (o locali), a contatto con l’ambiente romanzo in cui si sono insediate,<br />
sono state sottoposte ad una certa sovrapposizione fenomenologica tra le espressioni<br />
culturali delle popolazioni autoctone e di quelle allogene, sovrapposizione che si può far risalire<br />
almeno in parte ad un patrimonio comune già ab origine o comunque in epoche abbastanza<br />
remote. A tale situazione di « contaminazione », recente o remota che sia, non si deve tuttavia<br />
attribuire una valenza negativa, nel senso romantico di perdita della purezza delle origini. Essa<br />
va inquadrata, piuttosto, nella intrinseca dinamicità dei processi culturali, che elaborano continuamente<br />
nuove soluzioni, per rispondere alle esigenze che via via emergono dal divenire storico.<br />
L’identità di una cultura non va, dunque, confusa con la sua staticità, né va ricercata solo<br />
negli elementi di « diverso » che in essa permangono rispetto ad altre culture, considerando<br />
spuri quelli in comune. Essa è da riferire, piuttosto alle caratteristiche strutturali dell’intero sistema,<br />
definito come insieme di relazioni tra gli elementi che lo costituiscono.<br />
Si chiarisce, in questa maniera, la tendenza spesso manifestata dalle culture ad assolutizzare<br />
le proprie fenomenologie, tendenza che le induce a considerare del tutto peculiari, e<br />
dunque discriminanti, anche elementi che in realtà, da tempi remoti o relativamente recenti, sono<br />
condivisi con altre culture. Non saranno dunque i singoli elementi a dare l’immagine di una<br />
cultura, ma la casella che essi occupano nel sistema, che ne definisce il valore reciproco e il significato,<br />
a loro volta passibili di variazioni, qualora, per interferenza di nuovi elementi o semplicemente<br />
per processi di sviluppo interni, le relazioni precedenti abbiano a modificarsi.<br />
Va sottolineato ancora una volta che la multiculturalità è un patrimonio nazionale positivo<br />
che va salvaguardato in maniera attiva e che, nella situazione attuale di grave rischio per le<br />
culture minoritarie, ciò può e deve essere fatto con urgenza, dotando le minoranze degli stessi<br />
mezzi moderni di trasmissione e diffusione della cultura di cui usufruisce la cultura maggioritaria:<br />
la scuola, l’editoria, i media radiotelevisivi e telematici.<br />
304
CLASSIFICAZIONE ED ELENCAZIONE<br />
DELLE MINORANZE PRESENTI IN ITALIA<br />
305
CLASSIFICAZIONE E DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA<br />
Sono presenti nel nostro Paese diverse realtà minoritarie:<br />
a) quella relativa a comunità stanziate in zone di confine che, per vicende storiche, sono<br />
portatrici di tradizioni culturali e linguistiche comuni a quelle delle popolazioni dei Paesi confinanti<br />
(mistilingui): si tratta della minoranza di lingua francese nella Valle d’Aosta, di quella di<br />
lingua tedesca nel Trentino-Alto Adige e di quella di lingua slovena nel Friuli-Venezia Giulia;<br />
b) quella relativa a gruppi di popolazione insediati da lungo tempo in località del Paese e di<br />
natura del tutto eterogenea (cosiddetti gruppi di antico insediamento: albanesi, catalani, germanici,<br />
greci, croati, franco-provenzali, ladini, occitani); in tale realtà vi sono anche casi in<br />
cui si registra una coincidenza tra esigenza di tutela di una specificità linguistica e culturale e la<br />
gran parte della popolazione di determinate regioni (friulani e sardi).<br />
Tali minoranze sono state individuate dall’art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.<br />
1) GLI ALBANESI<br />
REGIONE DI RESIDENZA PROVINCIA<br />
Abruzzo Pescara<br />
Basilicata Potenza<br />
Calabria Catanzaro, Cosenza, Crotone<br />
Campania Avellino<br />
Molise Campobasso<br />
Puglia Foggia, Taranto<br />
Sicilia Palermo<br />
2) I CATALANI<br />
REGIONE DI RESIDENZA PROVINCIA<br />
Sardegna Sassari<br />
3) I CROATI<br />
REGIONE DI RESIDENZA PROVINCIA<br />
Molise Campobasso<br />
4) I FRANCOFONI<br />
REGIONE DI RESIDENZA PROVINCIA<br />
Piemonte Torino<br />
Valle d'Aosta Aosta<br />
5) I FRANCOPROVENZALI<br />
REGIONE DI RESIDENZA PROVINCIA<br />
Piemonte Torino<br />
Puglia Foggia<br />
Valle d'Aosta Aosta<br />
6) I FRIULANI<br />
REGIONE DI RESIDENZA PROVINCIA<br />
Friuli-Venezia Giulia Gorizia, Pordenone e Udine<br />
Veneto Venezia<br />
307
7) I GERMANOFONI<br />
REGIONE DI RESIDENZA PROVINCIA<br />
Friuli-Venezia Giulia Udine<br />
Piemonte Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli<br />
Trentino-Alto Adige Bolzano, Trento<br />
Valle d'Aosta Aosta<br />
Veneto Belluno, Verona, Vicenza<br />
8) I GRECI<br />
REGIONE DI RESIDENZA PROVINCIA<br />
Calabria Reggio Calabria<br />
Puglia Lecce<br />
9) I LADINI<br />
REGIONE DI RESIDENZA PROVINCIA<br />
Trentino-Alto Adige Bolzano, Trento<br />
Veneto Belluno<br />
10) GLI OCCITANI<br />
REGIONE DI RESIDENZA PROVINCIA<br />
Calabria Cosenza<br />
Liguria Imperia<br />
Piemonte Cuneo, Torino<br />
11) I SARDI<br />
REGIONE DI RESIDENZA PROVINCIA<br />
Sardegna Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari<br />
12) GLI SLOVENI<br />
REGIONE DI RESIDENZA PROVINCIA<br />
Friuli-Venezia Giulia Gorizia, Trieste, Udine<br />
308
AREA GEOGRAFICA E LINGUA DELLE MINORANZE<br />
ALTOATESINI<br />
I tedeschi dell’Alto Adige sono presenti nella provincia di Bolzano.<br />
ARBËRESHË<br />
La minoranza linguistica albanese si è costituita insediandosi nelle regioni Abruzzo, Basilicata,<br />
Campania, Calabria, Molise, Puglia e Sicilia.<br />
In particolare:<br />
- il comune di Greci, in provincia di Avellino;<br />
- i comuni di Campomarino, Montecilfone, Portocannone e Ururi, in provincia di Campobasso;<br />
- i comuni di Andali, Caraffa di Catanzaro, e Maida - per fraz. di Vena -, in provincia di Catanzaro;<br />
- i comuni di Acquaformosa, Castroregio, Cervicati, Cerzeto, Civita, Falconara Albanese,<br />
Firmo, Frascineto, Lungro, Mongrassano, Plataci, Santa Caterina Albanese, San Basile,<br />
San Benedetto Ullano, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese,<br />
San Martino di Finita, Santa Sofia d'Epiro, Spezzano Albanese e Vaccarizzo Albanese,<br />
in provincia di Crotone;<br />
- i comuni di Carfizzi, Pallagorio e San Nicola dell'Alto Cosenza, in provincia di Crotone;<br />
- i comuni di Casalvecchio di Puglia e Chieuti, in provincia di Foggia;<br />
- i comuni di Contessa Entellina, Mezzojuso, Palazzo Adriano, Piana degli Albanesi e Santa<br />
Cristina Gela, in provincia di Palermo;<br />
- il comune di Rosciano – per la frazione di Villa Badessa -, in provincia di Pescara;<br />
- i comuni di Barile, Brindisi di Montagna, Ginestra, Maschito, San Costantino Albanese e<br />
San Paolo Albanese, in provincia di Potenza.<br />
La minoranza è individuata con l’etnonimo arbëresh, che significa appunto ‘albanese’,<br />
prendendo origine dal termine arbër/arbëri con il quale s'individuava la nazione ‘Albania’ tra il<br />
XV e XVI secolo, nel periodo, cioè, delle migrazioni dall'Albania. Attualmente, infatti, l'etnonimo<br />
è shqipëri e non più arbëri.<br />
La lingua parlata è l'arbërisht, una forma dialettale che si collega con la variante linguistica<br />
del sud dell'Albania, da dove ha avuto origine la diaspora.<br />
Quella albanese appartiene al gruppo di minoranze di antico insediamento che non hanno<br />
alcuna contiguità territoriale con il ceppo d'origine; è, infatti, una vera isola linguistica di antica tradizione,<br />
che ha tramandato, attraverso i secoli, e perlopiù oralmente, il patrimonio linguistico, culturale<br />
e religioso.<br />
Oggi che la lingua letteraria d'Albania si basa prevalentemente sulla variante meridionale,<br />
il cosiddetto tosco, l'arbërisht è favorito nella comprensione anche dopo cinque secoli di<br />
quasi totale separazione dalla stirpe originaria ed è ancora considerata lingua madre perché,<br />
nella comunità minoritaria, il veicolo orale di comunicazione permane a livello familiare.<br />
CARINZIANI<br />
La minoranza linguistica carinziana si è costituita insediandosi nelle province di Udine e<br />
di Belluno.<br />
In particolare:<br />
nei comuni di Sauris e Paluzza – per la frazione di Timau -, in provincia di Udine;<br />
nel comune di Sappada, in provincia di Belluno;<br />
nei comuni di Malborghetto Valbruna e Tarvisio, in Val Canale, provincia di Udine. Nelle predette<br />
aree della Val Canale si è in presenza di un quadrilinguismo o tetraglossia: il tedesco<br />
carinziano, l'italiano, lo sloveno ed il friulano.<br />
309
Le comunità carinziane risalgono alla colonizzazione bavarese dell’arco alpino dei secoli<br />
X - XIII e costituiscono isole o gruppi linguistici di antico insediamento, ove si parlano varietà<br />
tedesche simili a quelle usate al di là del crinale delle Alpi Carniche.<br />
Le aree in questione sono tradizionalmente abitate da popolazioni di lingua latina o neolatina.<br />
Considerato che il dialetto germanico parlato è lo stesso di quello utilizzato nella vicina<br />
regione austriaca della Carinzia, si può parlare di minoranza carinziana con la precisazione che<br />
la stessa rientra nella ben più ampia famiglia delle minoranze germanofone sparse in diverse<br />
aree geografiche del nostro Paese.<br />
La lingua parlata dagli appartenenti alla minoranza è la sub-varietà carinziana del tedesco<br />
meridionale, che viene usata nei rapporti quotidiani e familiari.<br />
Sin dal XIV secolo la parlata locale fu sottoposta ad interferenze del mondo romanzo.<br />
Tale processo si è protratto nel tempo e le comunità carinziane si presentano oggi come vere e<br />
proprie isole plurilinguistiche, in cui, accanto all’italiano e alla lingua minoritaria, ancora viva e<br />
dinamica, si parlano, a seconda degli interlocutori, il friulano o il tedesco, passando con facilità<br />
da un codice linguistico all’altro.<br />
È da evidenziare che il saurano (zahrisch) è ormai entrato nell’unico istituto scolastico presente<br />
in zona (scuola elementare) quale materia di studio organicamente strutturata nell’orario settimanale.<br />
A Sappada il tedesco viene insegnato nella scuola media.<br />
Le attività legate al recupero della lingua e cultura di Timau, in ambito scolastico, sono<br />
varie (friulano – carnico per i bambini della frazione di Cleulis e tedesco – carinziano per quelli<br />
della frazione di Timau).<br />
CATALANI<br />
La minoranza linguistica catalana si è costituita insediandosi nella regione Sardegna.<br />
I catalani o algheresi, insediatisi esclusivamente nella città di Alghero, sono un gruppo<br />
di antico insediamento che risale al XIV secolo, periodo in cui un presidio militare catalano si<br />
stabilì in Sardegna.<br />
La città è situata nella provincia di Sassari, a sud-ovest del capoluogo; il comune si estende<br />
per circa 225 Kmq.<br />
L’algherese è riconosciuto come uno dei dialetti della lingua catalana, a sua volta appartenente,<br />
come lo spagnolo e l’italiano, alle lingue romanze; continua ad essere utilizzato come<br />
parlata corrente, anche se l’emigrazione, da un lato, e lo sviluppo del turismo, dall’altro,<br />
hanno contribuito a rompere l’isolamento e a destinarlo alla comunicazione familiare, peraltro<br />
mescolato con alcuni vocaboli italiani e sardo-logudoresi.<br />
Pur non essendo codificata, la variante algherese prende a modello la grafia catalana.<br />
La fine del dominio spagnolo sulla Sardegna, nei primi anni del XVIII secolo, non ha impedito<br />
ad Alghero di mantenere i contatti con la Catalogna; tanto che la lingua minoritaria è stata<br />
utilizzata in città anche quando in Spagna l’unità politica aveva elevato il castigliano a lingua<br />
ufficiale, considerando il catalano un dialetto.<br />
La Chiesa cattolica, sino alla fine del 1700, ha redatto in catalano la documentazione<br />
d’archivio dell’amministrazione episcopale e del capitolo della Cattedrale. Oggi, la lingua è utilizzata<br />
in occasione di cerimonie religiose solenni, come la Pasqua ed il Natale, nella cui notte<br />
si canta un inno chiamato Canto della Sibilla.<br />
Alcuni sacerdoti, dal 1980, hanno ottenuto dal vescovo di celebrare una messa domenicale<br />
in catalano, agevolati in questo dall’esistenza di testi liturgici già approvati dalla Santa Sede.<br />
Dal 1988 è disponibile un dizionario monolingue, Diccionari Català de l'Alguer, curato<br />
dal prof. Giuseppe Sanna, che prende in considerazione il solo lessico utilizzato ad Alghero.<br />
La regione Sardegna ha previsto la possibilità dell'insegnamento nelle scuole elementari,<br />
sia pure a titolo sperimentale; il comune di Alghero, avvalendosi di giovani professori di lingua<br />
catalana, organizza corsi per lo studio della lingua, all’interno di accordi tra lo stesso comune<br />
e le Università di Valencia e delle isole Baleari, mentre presso le Università di Cagliari e di<br />
Sassari sono stati attivati insegnamenti di lingua e letteratura catalana.<br />
310
CIMBRI<br />
La minoranza linguistica cimbra si è costituita insediandosi nelle regioni Trentino e Veneto.<br />
In particolare:<br />
- nel comune di Luserna, in Alta Valsugana, provincia di Trento;<br />
- nei Tredici comuni veronesi della Lessinia (Badia Calavena, Boscochiesanuova, Cerro Veronese,<br />
Erbezzo, Roverè Veronese, San Mauro di Saline, Selva di Progno – per la frazione<br />
Giazza -, Velo Veronese), in provincia di Verona;<br />
- nel Piano o Foresta del Consiglio con i comuni di Farra d’Alpago e Tambre, in provincia di<br />
Belluno.<br />
La lingua cimbra ha le caratteristiche tipiche del dialetto bavarese meridionale.<br />
Per quanto riguarda la provincia di Trento, dal 1992, con la creazione dell'Istituto Culturale<br />
Mòcheno-Cimbro, si è dato inizio ad un codice di scrittura della lingua cimbra.<br />
Nelle aree menzionate di questa provincia sono previste attività integrative con la presenza<br />
di insegnanti appartenenti alla minoranza, mentre nel Veneto sono promosse attività a carattere<br />
culturale e ricreativo.<br />
Nel Trentino, l’unica comunità dove il cimbro è ancora parlato dalla maggioranza della<br />
popolazione è quella di Luserna, mentre negli altri due comuni il vecchio idioma è completamente<br />
scomparso.<br />
Per quanto riguarda l’area vicentina dell’altopiano d’Asiago l’unica oasi rimane Roana, più<br />
precisamente la frazione di Mezzaselva, dove tuttora una minima percentuale della popolazione<br />
conserva la lingua.<br />
Nei Tredici comuni veronesi la parlata cimbra è presente soltanto a Giazza, frazione del<br />
comune di Selva di Progno. La stessa località è sede dell'unico museo della zona, dove sono<br />
conservati reperti di arte scultorea popolare nonché il dipinto murale denominato La Madonna lauretana;<br />
vi sono conservati, altresì, oggetti, attrezzi e arnesi che si riferiscono alle attività lavorative<br />
della minoranza.<br />
Nella Foresta del Cansiglio la lingua minoritaria è oggi estinta, avendo lasciato solo alcuni<br />
termini nel dialetto bellunese locale.<br />
Il più antico documento cimbro di cui si è a conoscenza è il catechismo del 1602 Christlike<br />
unt korze dottrina, traduzione in cimbro dell’opera curata dal Card. Ballarmino.<br />
CROATI<br />
La minoranza linguistica croata si è costituita insediandosi nel Molise, più precisamente<br />
in provincia di Campobasso, nel territorio compreso tra i fiumi Biferno e Trigno.<br />
Si tratta in particolare dei tre comuni di Acquaviva Collecroce, Montemitro e San Felice<br />
del Molise, mentre è storicamente accertata la colonizzazione da parte di profughi croati dei<br />
comuni di Palata, Tavenna, Mafalda, San Biase, San Giacomo degli Schiavoni, Montelongo e<br />
Petacciato, sempre in provincia di Campobasso.<br />
Soltanto nei primi tre paesi si conservano, ancora oggi, la lingua, gli usi ed i costumi<br />
della stirpe d’origine.<br />
L’idioma parlato dalla minoranza è sostanzialmente l’antica lingua croata del tipo štòkavo-ìkavo,<br />
in uso nella Dalmazia centrale fra i fiumi Cettina e Narenta, nel retroterra croato ed in<br />
Erzegovina.<br />
«... Si tratta di un idioma conservato da circa 400 anni, con una fisionomia eminentemente<br />
pratica, appunto perchè parlato in prevalenza da contadini; lo dimostra anche il fatto che<br />
non vi sono in esse parole astratte» 39 .<br />
Secondo ricerche e lavori di studiosi e studenti locali, il patrimonio linguistico dei Croati<br />
del Molise è stato valutato sulle 3.000 parole, che arriverebbero a circa 5.000 vocaboli, in base<br />
alle catalogazioni più recenti 40 .<br />
39 Giancristoforo E., Tradizioni culturali albanesi e slave nel Molise, estratto della relazione tenuta ad Acquaviva<br />
Collecroce il 12.11.1991, Centro Studi Molise 2000.<br />
311
L’antica lingua croata è, oggi, usata nei rapporti familiari e nelle relazioni interpersonali.<br />
Essa è stata trasmessa per cinque secoli con la sola tradizione orale; non esistono infatti tracce<br />
di scritti, se si escludono alcune poesie del prof. Giovanni De Rubertis (1813-1889) di Acquaviva<br />
Collecroce inviate, insieme ad aneddoti e proverbi, in un lungo scambio di lettere col poeta<br />
raguseo Orsatto Pozza, dal 6 aprile al 23 giugno 1853, nonché una sua traduzione di una novella<br />
di Giovanni Boccaccio, pubblicata a Firenze nel 1875 in occasione del quinto centenario<br />
della morte del grande certaldese, ed infine un telegramma redatto «nell’antica lingua dei padri»<br />
inviato nel 1896 dal Consiglio comunale di Acquaviva Collecroce alla principessa montenegrina<br />
Elena Petrovi-Njegoš in occasione delle nozze col futuro re d’Italia Vittorio Emanuele III 41 .<br />
Gli abitanti delle colonie croate del Molise sono sempre stati cattolici di rito latino, a differenza<br />
delle vicine colonie albanesi che erano abitate da cattolici di rito greco; la messa, quindi,<br />
è stata celebrata sempre in lingua latina sino al Concilio Ecumenico Vaticano II quando fu<br />
permessa la celebrazione delle funzioni religiose nelle lingue locali.<br />
Purtroppo, per mancanza di sacerdoti del posto e per la difficoltà di tradurre in un linguaggio<br />
semplice e concreto la complessa terminologia liturgica, si è passati direttamente alle<br />
celebrazioni religiose in italiano, anche se sopravvivono nella comunità minoritaria dei canti e<br />
delle tradizioni in croato.<br />
La più consistente testimonianza scritta della lingua croata si ebbe a partire dal 1967<br />
quando fu pubblicata la prima rivista bilingue italo-croata intitolata “Naša rič / La nostra parola”,<br />
diventata poi “Naš jezik/La nostra lingua”, che aveva per motto la frase dell’eroe dei Croati del<br />
Molise, Nicola Neri (medico insigne nato ad Acquaviva Collecroce nel 1761, professore di fisiologia,<br />
commissario alla guerra durante la Repubblica Partenopea, impiccato a Napoli nel 1799):<br />
«Non dimenticate la nostra bella lingua!».<br />
FRANCOFONI<br />
Località di residenza: la Valle d’Aosta, fatta eccezione per i comuni germanofoni di Issime,<br />
Gressoney St. Jean, Gressoney la Trinité nell’Alta Valle del Lys.<br />
Le Valli del Pellice, della Dora Riparia, delle Valli Varaita e Germanesca, della Val Chisone,<br />
in provincia di Torino.<br />
In tutta l’area, le chiese, quella valdese e quella cattolica, adottano il francese come lingua di<br />
cultura, per la formazione del clero e per la comunicazione esterna.<br />
FRANCOPROVENZALI<br />
I francoprovenzali presenti in Italia, si trovano in Valle d’Aosta, in provincia di Torino:<br />
Valle dell’Orco, Val Soana, le Valli di Lanzo, Val Cenischia, la media e bassa Valle di Susa, la<br />
Val Sangone e nelle due colonie di Faeto e di Celle San Vito in provincia di Foggia.<br />
La presenza dei nuclei alloglotti riguarda i seguenti comuni della provincia di Torino:<br />
Ala dei Stura; Almese; Alpette; Balme; Bruzolo; Bussoleno; Cantoira; Carema; Ceresole<br />
Reale; Cialamberto; Chianocco; Chiusa S. Michele; Coassolo Torinese; Coazze; Condove;<br />
Frassinetto; Germagnano; Giaglione; Giaveno; Gravere; Groscavallo; Ingria; Lemie; Locana;<br />
Viù; Meana di Susa; Mezzenile; Mompantero; Moncenisio; Noasca; Novalese; Pessinetto; Ribordone;<br />
Ronco Canavese; Rubiana; San Didero; San Giorgio di Susa; S. Antonino di Susa;<br />
Mattie; Sparone; Susa; Traves, Usseglio; Vaie; Valgioie; Alprato Soana; Venaus; Villar Dora;<br />
Villar Focchiardo; Ceres.<br />
La provincia di Torino è caratterizzata nella sua fascia alpina dalla presenza - similmente<br />
a quanto avviene per la Val d'Aosta - di nuclei alloglotti appartenenti al gruppo gallo-romanzo<br />
40 Sammartino A., Ali tagliate – Parole di un libro incompiuto/Podrezana krila – Riječ i nedovršene knjige<br />
(volumetto bilingue, in italiano e croato, a ricordo di Agostina Piccoli), Cannarsa Editore, Vasto 1999, pag.<br />
63.<br />
41 Cfr. Registro delle deliberazioni consiliari del Comune di Acquaviva Collecroce per l'anno 1896, esisten-<br />
te presso il locale archivio comunale.<br />
312
che occupa l'opposto versante alpino: parlanti il provenzale alpino (o occitano) ed il francoprovenzale,<br />
entrambe lingue appartenenti al ramo occidentale delle lingue neo-latine.<br />
Sono francoprovenzali - vale a dire appartenenti allo stesso gruppo linguistico del delfinese<br />
settentrionale, del savoiardo e delle parlate della Svizzera cosiddetta romanda (o francese)<br />
- la Val Cenischia, la media e la bassa Val di Susa, la Val Sangone, le tre valli di Lanzo e la<br />
Valle dell'Orco con la Val Soana.<br />
Quest'ultima area costituisce una diretta continuazione, verso Mezzogiorno, di quella<br />
occupata dalle parlate valdostane.<br />
Nei comuni di Luserna San Giovanni, Pinasca, Torre Pellice, Almese, Bussoleno, Coassolo,<br />
Condove, i nuclei collegati sono presenti soltanto nelle frazioni di Germagnano, Giaveno,<br />
Susa e Villar Dora.<br />
L'entità numerica di tali insediamenti è peraltro difficilmente calcolabile, sebbene possa<br />
ipotizzarsi che il numero dei parlanti il "patois" (termine comune che definisce la lingua dei due<br />
gruppi alloglotti) si sia ridotto negli anni, a causa delle migrazioni verso la pianura e della progressiva<br />
perdita del medesimo fra le nuove generazioni.<br />
In ogni caso, la consistenza dei nuclei varia da vallata a vallata.<br />
In territorio francese il francoprovenzale è parlato in Savoia, nel lionese, nel Delfinato<br />
(Grenoble e Vienne), in una parte della Francia contea, nel Bugey e nella metà meridionale della<br />
Bresse.<br />
Nella Svizzera romanda, eccettuato il Giura bernese, è parlato nei cantoni di Neuchatel,<br />
Vaud, Ginevra, Friburgo e nel Vallese.<br />
FRIULANI<br />
Località di residenza: l'estremo nord-orientale della penisola italiana, fra l'Adriatico e le<br />
Alpi Carniche, comprendente il territorio geograficamente compatto delle tre province del Friuli –<br />
Udine, Pordenone e Gorizia - che, con l'unione di Trieste (1947) costituirono, nel 1963, la Regione<br />
autonoma Friuli-Venezia Giulia.<br />
I comuni ove insiste la minoranza linguistica sono quelli di: Aiello del Friuli, Amaro, Ampezzo,<br />
Aquileia, Arta Terme, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinicco, Bordano,<br />
Buia, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo al Torre, Carlino, Cassacco,<br />
Castions di Strada, Cavazzo Carnico, Cercivento, Cervignano, Chiopris Viscone, Chiusaforte,<br />
Cividale, Codroipo, Colloredo di Montealbano, Comeglians, Corno di Rosazzo, Coseano,<br />
Dignano, Dogna, Enemonzo, Faedis, Fagagna, Fiumicello, Flaibano, Forgaria, Forni Avoltri,<br />
Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Gonars, Latisana, Lauco, Lestizza, Lignano<br />
Sabbiadoro, Ligosullo, Magnano in Riviera, Maiano, Manzano, Martignacco, Mereto di Tomba,<br />
Moggio Udinese, Moimacco, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana del Turgnano, Nimis,<br />
Osoppo, Ovaro, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Paluzza, Pasian di Prato, Paularo,<br />
Pavia di Udine, Pocenia, Pontebba, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano,<br />
Prato Carnico, Precenicco, Premariacco, Preone, Prepotto, Ragogna, Ravascletto, Raveo, Reana<br />
del Rojale, Remanzacco, Resiutta, Rigolato, Rive d’Arcano, Rivignano, Ronchis, Ruda, San<br />
Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Vito al Torre, San Vito<br />
di Fagagna, Santa Maria la Longa, Sauris, Sedegliano, Socchieve, Sutrio, Talmassons, Tapogliano,<br />
Tarcento, Tarvisio, Tavagnacco, Teor, Terzo d’Aquileia, Tolmezzo, Torreano, Torviscosa,<br />
Trasaghis, Treppo Carnico, Treppo Grande, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Varmo,<br />
Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Villa Vicentina, Visco, Zuglio.<br />
L'area linguistica friulana conta un gruppo molto numeroso di persone in quanto rappresentato<br />
dalla maggior parte della popolazione della intera regione.<br />
I friulanofoni formano infatti una minoranza-maggioranza, in quanto sono minoritari in<br />
Italia rispetto alla lingua italiana, ma maggioritari all'interno della loro regione, comprendendo un<br />
numero consistente di residenti nelle province di Udine, Gorizia e Pordenone, e si collocano, dal<br />
punto di vista numerico, nell'ambito dello Stato italiano, subito dopo la minoranza sarda.<br />
Tutta la popolazione friulana conosce anche l'italiano; un dialetto veneto viene parlato<br />
nell'area occidentale (città di Pordenone e Sacile) e nella parte più meridionale della stessa<br />
provincia.<br />
GRECI<br />
313
La minoranza linguistica greca si è costituita insediandosi nelle regioni Puglia e Calabria.<br />
In particolare:<br />
- nei comuni di Calimèra, Castrignano dei Greci, Corigliano d'Otranto, Martano, Martignano, Melpignano,<br />
Soleto, Sternatìa e Zollino, tutti in provincia di Lecce; negli ultimi due paesi la lingua<br />
minoritaria non è più usata, se non da pochissimi anziani, ma dal 1988 tutti i comuni si sono<br />
consorziati per la valorizzazione e lo sviluppo dell'area ellenofona del Salento;<br />
- nei comuni di Bova, Bova Marina, Condofùri – per la frazione di Gallicianò -, Palazzi, Roccaforte<br />
del Greco e Roghùdi, in provincia di Reggio Calabria. Vi sono, poi, alcuni centri costieri (Mèlito<br />
Porto Salvo, Reggio Calabria, ecc.) nei quali, per motivi diversi, negli ultimi anni si è trasferita<br />
gran parte della popolazione grecanica calabrese. Si rileva, altresì, che a Condofùri, Chorìo di<br />
Roccaforte e Roccaforte del Greco la lingua non è più utilizzata.<br />
La minoranza è individuata con i termini di greco-calabra e greco-salentina ed utilizza, ancora<br />
oggi, la lingua greca. Questa lingua è chiamata grico in Puglia, forse dall'osco griko piuttosto che<br />
dal latino graecus, e greco in Calabria.<br />
Il periodo di insediamento in Italia può considerarsi compreso tra la formazione della<br />
Magna Grecia (VIII - VI secolo a.C.) e la dominazione bizantina (VIII - XI secolo d.C.).<br />
Su tale periodo sono state elaborate diverse ipotesi, tutte fondate sullo studio della lingua<br />
grecanica. La prima, sostenuta dal Rohlfs, afferma che quell'idioma, contenendo parole,<br />
suoni e forme sintattiche così arcaiche da non essere state riscontrate neppure nei dialetti<br />
della Grecia, rappresenta la continuazione dell'antica Magna Grecia. Il Morosi ritiene, invece,<br />
che le colonie risalgano al Medio Evo e che la migrazione possa essere avvenuta in epoca<br />
bizantina. C'è, infine, l'ipotesi del filologo Comparetti, avvalorata anche da alcuni studiosi<br />
greci, come Karanastasis, che affermava come molto probabile la sovrapposizione di colonie<br />
greche più recente su altre già presenti sul territorio.<br />
Di certo il declino delle comunità elleniche della Magna Grecia nell'Italia meridionale<br />
provocò la quasi totale estinzione del greco, sostituito dal latino; la lingua greca, probabilmente,<br />
continuò ad essere utilizzata dai pastori e dai contadini che vivevano isolati.<br />
La successiva diffusione del cristianesimo, sotto la sovranità di Bisanzio, contribuì a far<br />
rifiorire le comunità grecofone, che ebbero la loro massima vitalità nell'VIII secolo con la presenza<br />
di numerosi monasteri.<br />
In Calabria, la Chiesa continuò ad utilizzare il rito bizantino fino al 1572, anno in cui ufficialmente<br />
si passò al rito latino. Nella grecìa salentina il rito greco scomparve ufficialmente nella<br />
prima metà del 1600, anche se, per altri due secoli, nelle stesse chiese si celebrò nei due riti.<br />
La lingua, nel tempo e a causa della notevole distanza dalla madrepatria, si è logorata,<br />
ha perso quasi interamente i nomi astratti, ha assottigliato il numero degli aggettivi e degli stessi<br />
nomi concreti, ha apportato elisioni e scambi di lettere, ha accolto in sé numerosi prestiti da altre<br />
lingue e, in particolare, dai dialetti italofoni, dando loro desinenza greca e, per così dire, grecizzandoli,<br />
mantenendo, però, vivi alcuni suoni, forme e vocaboli che in Grecia sono andati persi<br />
nel corso dei secoli.<br />
Pur tuttavia, nella grecìa salentina sono state realizzate diverse iniziative di carattere<br />
culturale che, nel contesto delle attività a sostegno della lingua grecanica, con i contributi della<br />
Comunità Europea, hanno interessato l'ambito scolastico (corsi di lingua, produzione di libri, video,<br />
etc.).<br />
LADINI<br />
E’ necessario distinguere il territorio ladino in senso stretto (Gardena, Badia-Marebbe,<br />
Fassa, Livinallongo, Ampezzo) dove si è sviluppata da secoli la coscienza della ladinità, dalle<br />
cosiddette “anfizone” ovvero le zone con parlate “ a fondo ladino” (Comelico, Agordino, Cadore)<br />
dove la riscoperta di una certa ladinità è un fatto recente.<br />
Nel Trentino-Alto Adige i comuni ove insiste la minoranza linguistica sono quelli di comuni<br />
di Campitello di Fassa, Canazei, Mazzin, Moena, Pozza di Fassa, Soraga e Vigo di Fassa.<br />
Merita precisare che le varietà ladine “centrali” parlate nelle tre province di Bolzano,<br />
Trento e Belluno sono raggruppabili in tre gruppi linguistici principali la cui estensione non corrisponde<br />
agli attuali confini amministrativi: ladino atesino in Val Badia (BZ), Val Gardena (BZ),<br />
314
Val di Fassa (TN), Livinallongo (BL), Rocca Pietore (BL) e Colle S. Lucia (BL); ladino cadorino<br />
in tutta l’area del Cadore “storico” (BL) compresa la conca di Cortina d’Ampezzo (BL) 42 e la Val<br />
Comelico (BL); ladino veneto in Agordino centro meridionale (BL) e in Val di Zoldo (BL). Non<br />
esiste un “ladino comune” usato come “lingua tetto” o “lingua ufficiale” dalle diverse varietà.<br />
MOCHENI<br />
La minoranza linguistica mòchena si è costituita insediandosi nella regione Trentino-<br />
Alto Adige. La piccola comunità tedescofona è insediata nella valle del torrente Fèrsina, affluente<br />
di destra dell’Adige, detta anche valle dei Mòcheni, per l’idioma particolare dei suoi abitanti<br />
denominato, appunto, mòcheno (bersntolerisch).<br />
I comuni ove insiste la minoranza linguistica sono quelli di Palú del Férsina, sulla sponda<br />
destra, Fierozzo e Frassilongo con la frazione di Roveda, sulla sponda sinistra.<br />
In essi è ancora viva la lingua e sono mantenuti, tuttora, usi e costumi della tradizione<br />
peculiari e caratteristici. La lingua minoritaria, che si può definire antico alto tedesco con evoluzione<br />
autonoma ed isolata da quella germanica, integrata con parole del dialetto trentino, non è<br />
mai stata tramandata in forma scritta ma solo oralmente.<br />
Sino al secolo scorso circa, l’area mòchena comprendeva anche i paesi di Falesina, Vignola<br />
e i masi della montagna di Roncegno, in Valsugana: di ciò esiste testimonianza in molte<br />
opere dell’800 che riguardano questa zona.<br />
Benché fino al 1950 e in certi casi anche dopo venissero indicati con il termine mòcheni<br />
tutti gli abitanti della Valle del Férsina e, quindi, anche quelli del comune di Sant’Orsola con la<br />
frazione di Mala, e di Viarago e Canezza (frazioni del comune di Pergine Valsugana), questi<br />
paesi non fanno parte della minoranza linguistica in quanto sono di origine e di lingua romanza.<br />
Con legge della provincia autonoma di Trento (n. 18 del 31 agosto 1987) è stato attivato<br />
l’Istituto culturale mòcheno-cimbro (Kulturinstitut Bersntol - Lusérn) con sede a Palù del Férsina,<br />
e sede staccata a Luserna. La finalità di tutelare e salvaguardare le isole minoritarie, mochèna<br />
e cimbra, di lingua tedesca del Trentino orientale, si sviluppa attraverso la cura e la promozione<br />
di iniziative per lo studio, la conservazione e la valorizzazione della lingua, della storia, della<br />
cultura e delle tradizioni della popolazione mòchena e cimbra.<br />
In particolare il predetto Istituto ha realizzato, attraverso il restauro conservativo di uno<br />
dei pochi immobili che ha mantenuto le caratteristiche architettoniche di un tempo, un punto<br />
museale che ripropone due abitazioni tipiche di epoche distinte (fine 1800 e prima metà del<br />
1900), al cui interno sono conservati oggetti ed attrezzi della cultura popolare locale.<br />
OCCITANI<br />
La minoranza linguistica occitana si è costituita insediandosi in numerose valli del Piemonte,<br />
nella provincia di Imperia ed in quella di Cosenza.<br />
Più precisamente:<br />
- In provincia di Cuneo: Aisone, Argentera, Barge, Bernezzo, Boves, Briga Alta, Brondello,<br />
Canosio, Caraglio, Cartignano, Castellar, Castelmagno, Celle di Macra, Cervasca, Chiusa<br />
di Pesio, Com. Montana Valle Stura, Crissolo, Demonte, Dronero, Envie, Frabosa Soprana,<br />
Frabosa Sottana, Frassino, Gaiola, Gambasca, Isasca, Limone Piemonte, Macra, Marmora,<br />
Moiola, Montemale, Monterosso Grana, Oncino, Ostana, Paesana, Peveragno, Pietraporzio,<br />
Pradleves, Revello, Roaschia, Roccabruna, Roccaforte Mondovì, Roccasparvera, Roccavione,<br />
Sambuco, Sampeyre, Sanfront, Stroppo, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Venasca,<br />
Vernante, Vignolo, Villanova Mondovì, Villar S. Costanzo, Vinadio;<br />
- nelle valli Alta Susa, Chisone, Germanasca e Pellice (Torino);<br />
- nel comune di Olivetta San Michele (Imperia);<br />
- nel comune di Guardia Piemontese (Cosenza).<br />
Ciò che unisce queste comunità è la lingua d'oc, parlata, nella sua evoluzione storica, in<br />
tutte le località su indicate.<br />
42 Alcuni studiosi associano i ladini di Cortina d’Ampezzo ai “ladini dolomitici” enucleandoli dai “ladini cado-<br />
rini”<br />
315
L'occitano, detto anche lingua d'oc o provenzale, è una lingua indoeuropea appartenente<br />
al gruppo occidentale delle lingue neolatine, formatasi dalle parlate iberiche e celto-liguri, latinizzate<br />
dalla successiva conquista romana.<br />
Le parlate occitaniche delle valli alpine appartengono al gruppo occitano settentrionale<br />
alpino – delfinatese, mentre quella di Olivetta San Michele presenta espressioni linguadociane<br />
e provenzali.<br />
La realtà linguistica occitanica si presenta molto frammentaria, tanto che sono riscontrabili<br />
variazioni di rilievo non soltanto da valle a valle, ma tra villaggi limitrofi. Proprio in conseguenza<br />
di ciò si può affermare che non esiste una koinè, una lingua comune.<br />
Nell'ambito della lingua occitana si è sviluppata una parlata, quella brigasca, con affinità<br />
alla parlata di Olivetta San Michele. I territori interessati sono quelli comprendenti la zona dell'ex<br />
comune di Briga Marittima, diviso, alla fine della seconda guerra mondiale, tra il comune di La<br />
Brigue, in territorio francese, Realdo e Verdeggia, frazioni del comune di Triora in provincia di<br />
Imperia, e Piàggia, Ùpega e Carnino, frazioni del comune di Briga Alta, in provincia di Cuneo,<br />
oltre che a Viozène, frazione del comune di Ormea, anch'esso in provincia di Cuneo.<br />
La civiltà occitana si sviluppò nel medioevo, realizzando una raffinata cultura che condizionò<br />
tutta l'Europa, interessando il campo della letteratura e della musica. È a tutti ben noto, ad<br />
esempio, il tributo che la nascente cultura italiana del XIII secolo, con Dante 43 e la Scuola del<br />
dolce stil novo deve ai trovatori occitani, alla loro lirica ed alla loro poetica.<br />
Nel settore musicale fu copiosa la produzione di canzoni in lingua d'oc da parte dei trovatori.<br />
L'apogeo fu raggiunto nel primo periodo Angioino, ma tutta questa ricchezza di pensiero<br />
e di cultura, allora egemone nel mondo occidentale, andrà a poco a poco indebolendosi già dopo<br />
la crociata contro gli Albigesi, nel XIII secolo.<br />
Nel 1539, con l'editto di Villers-Cotterêts, almeno a livello ufficiale, l'occitano fu relegato<br />
al ruolo di dialetto locale, perdendo la caratteristica di lingua di cultura universalmente riconosciuta.<br />
La lingua minoritaria ebbe, poi, una notevole ripresa nella seconda metà del secolo<br />
scorso, vuoi per merito del poeta Frederì Mistràl, premio Nobel per la letteratura nel 1904, vuoi<br />
per l'affermazione della corrente letteraria denominata Felibrìge, che contribuì allo studio ed alla<br />
razionalizzazione della linguistica.<br />
Nelle valli e nei centri menzionati si è in presenza di casi tipici di tetraglossia, quadrilinguismo<br />
o plurilinguismo. La lingua minoritaria è utilizzata nella comunicazione tra nativi o autoctoni,<br />
mentre la parlata locale è utilizzata nei rapporti commerciali; il francese e/o l'italiano sono<br />
presenti quali lingue ufficiali dell'amministrazione, della scuola, della cultura e dei mass-media.<br />
Nelle vallate i confini linguistici tra l'area occitana e quella piemontese non sono netti<br />
ma esistono zone linguisticamente grigie, in cui alla piemontesizzazione del lessico si contrappongono<br />
tratti fonetici inconfondibilmente occitani.<br />
SARDI<br />
Località di residenza: Regione Sardegna.<br />
La minoranza di lingua sarda può essere considerata, insieme a quella friulana, la più<br />
consistente numericamente tra tutte quelle del territorio italiano; e questo a maggior ragione se<br />
si considerano anche gli isolani emigrati nel continente o all'estero, e probabilmente in larga<br />
parte ancora sardofoni.<br />
SLOVENI<br />
Località di residenza: province di Gorizia, Trieste e Udine<br />
43 Nel XXVI Canto del Purgatorio vi sono otto versi (136-148) in lingua occitana in cui si esprime Arnaldo<br />
Daniello, poeta trovatore contemporaneo di Dante.<br />
316
Sloveni in provincia di Gorizia<br />
La dislocazione territoriale della popolazione di lingua slovena in provincia di Gorizia si<br />
sviluppa principalmente su tre aree: la città capoluogo, il Carso goriziano e la zona collinare del<br />
Collio.<br />
Nella città di Gorizia sono dislocati principalmente nei quartieri di Piedimonte del Calvario<br />
(Podgora), Piuma - S. Mauro - Oslavia (Pevma - Stmaver - Oslavje) e S. Andrea (Standrez).<br />
Nei comuni di S. Floriano del Collio (Steverjan), Doberdò del Lago (Doberdob) e Savogna<br />
d'Isonzo (Sovodnje ob Soci), la popolazione alloglotta rappresenta la maggioranza.<br />
Altre comunità, di consistenza decisamente minore, sono presenti nei territori dei comuni<br />
di Cormons (specie nelle località di Plessiva, Novali e Zegla), Ronchi dei Legionari, Sagrado,<br />
Monfalcone e Dolegna del Collio; in ciascuna di queste località la consistenza numerica<br />
si attesta sulle poche centinaia di unità.<br />
Sloveni in provincia di Trieste<br />
Altopiano carsico, in particolare nei comuni di Monrupino, Sgonico, S. Dorligo, Duino-<br />
Aurisina.<br />
Sloveni in provincia di Udine<br />
W ALSER<br />
La popolazione di etnia slovena è presente nella provincia di Udine.<br />
La minoranza linguistica walser si è costituita insediandosi nelle regioni Piemonte e Valle<br />
d'Aosta.<br />
Più precisamente:<br />
- nei comuni di Gressoney-Saint Jean, Gressoney-La Trinitè e Issime (Aosta);<br />
- nei comuni di Alagna Valsesia, Carcoforo, Rima San Giuseppe, Rimasco, Rimella e Riva<br />
Valdobbia (Vercelli);<br />
- nei comuni di Baceno, Formazza, Macugnaga, Ornavasso, Premia e Valstrona (Verbano-Cusio-<br />
Ossola).<br />
La lingua walser è una parlata alemanna di tipo svizzero-vallesano, non omogenena,<br />
che, oltre alle caratteristiche generali alemanne, possiede un certo numero di specialità proprie<br />
che la distinguono dalle altre parlate tedescofone delle zone alpine.<br />
In particolare essa è detta titsch a Gressoney Saint-Jean, Gressoney-La Trinitè, Alagna,<br />
Formazza e Macugnaga, töitschu ad Issime e tittschu a Rimella; con essa, convivendo il tedesco,<br />
l'italiano ed il francese, si è in presenza di un caso di tetraglossia o quadrilinguismo.<br />
L'idioma walser ha conservato le sue antiche radici ed è il segno distintivo della minoranza;<br />
ma è pur vero che, nel corso del tempo, esso ha subito delle mutazioni, imputabili in<br />
massima parte all'isolamento delle colonie ed all'allentarsi graduale dei legami con la madrepatria.<br />
A Gressoney il titsch si è conservato particolarmente bene, grazie alla continuità dei<br />
rapporti economici e culturali con la madrepatria, attraverso i mercanti e le famiglie gressonare<br />
stabilitesi nella Svizzera.<br />
Si rileva che nelle scuole di quasi tutti i centri delle predette comunità sono stati istituiti<br />
corsi di lingua walser.<br />
317
APPENDICE<br />
319
NORMATIVA E DOCUMENTI INTERNAZIONALI<br />
SULL’INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE<br />
NELL’AMBITO DELLE MINORANZE<br />
321
DOCUMENTI DELL'ORGANIZZAZIONE<br />
DELLE NAZIONI UNITE<br />
323
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI <strong>DIRITTI</strong> DELL’UOMO<br />
(Adottata dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948)<br />
omissis<br />
Articolo 19<br />
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere<br />
molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere diffondere informazioni e idee attraverso<br />
ogni mezzo e senza riguardo di frontiere.<br />
omissis<br />
CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULL’ELIMINAZIONE DI OGNI FORMA DI DISCRIMI-<br />
NAZIONE RAZZIALE (Adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 21 dicembre 1965)<br />
omissis<br />
Articolo 7<br />
Gli Stati contraenti si impegnano ad adottare immediate ed efficaci misure, in particolare nei<br />
campi dell’insegnamento, dell’educazione, della cultura e dell’informazione, per lottare contro i<br />
pregiudizi che portano alla discriminazione razziale e a favorire la comprensione, la tolleranza e<br />
l’amicizia tra le nazioni ed i gruppi razziali ed etnici, nonché a promuovere gli scopi ed i princìpi<br />
dello Statuto delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, della Dichiarazione<br />
delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e<br />
della presente Convenzione.<br />
omissis<br />
PATTO INTERNAZIONALE SUI <strong>DIRITTI</strong> CIVILI E POLITICI<br />
(Adottato dall’Assemblea Generale dell’ONU il 16 dicembre 1966)<br />
omissis<br />
Articolo 19<br />
omissis<br />
2. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare,<br />
ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente,<br />
per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua<br />
scelta.<br />
omissis<br />
325
CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI <strong>DIRITTI</strong> DELL’INFANZIA<br />
(Approvata dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata<br />
dall’Italia con legge del 27 maggio 1991 n. 176 depositata presso le Nazioni Unite il 5 settembre<br />
1991)<br />
omissis<br />
Articolo 17 (Educazione)<br />
1. Gli Stati parti riconoscono l’importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano<br />
affinché il fanciullo possa accedere a una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali<br />
e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale spirituale<br />
e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:<br />
a) incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale<br />
e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell’art. 29;<br />
b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare<br />
informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazionali e internazionali;<br />
c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l’infanzia;<br />
d) incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei<br />
fanciulli autoctoni o appartenenti a un gruppo minoritario;<br />
omissis<br />
DICHIARAZIONE SUI <strong>DIRITTI</strong> DELLE PERSONE APPARTENENTI ALLE MINORANZE NA-<br />
ZIONALI O ETNICHE, RELIGIOSE E LINGUISTICHE<br />
(Approvata dall’Assemblea Generale con Risoluzione 47035 del 18 dicembre 1992)<br />
L’Assemblea generale,<br />
omissis<br />
Articolo 6<br />
Gli Stati dovranno cooperare sulle questioni relative alle persone appartenenti a minoranze, in<br />
particolar modo scambiando informazioni e dati d’esperienza al fine di promuovere la comprensione<br />
reciproca e la fiducia.<br />
omissis<br />
DICHIARAZIONE DI VIENNA E PROGRAMMA D’AZIONE<br />
(Conferenza Mondiale sui Diritti dell’Uomo, Vienna, 14-25 giugno 1993)<br />
omissis<br />
Parte I<br />
omissis<br />
39. Nel sottolineare l’importanza di un’informazione obiettiva, responsabile ed imparziale relativamente<br />
ai diritti dell’uomo e alle problematiche umanitarie, la Conferenza Mondiale sui Diritti<br />
dell’Uomo incoraggia un maggiore coinvolgimento dei media la cui libertà e tutela dovrebbe essere<br />
garantita in forza del diritto interno.<br />
Omissis<br />
326
ISTITUZIONI NAZIONALI PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEI <strong>DIRITTI</strong> <strong>UMANI</strong><br />
(Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 20 dicembre 1993)<br />
omissis<br />
Allegato<br />
Principi relativi allo status delle istituzioni nazionali. Competenze e responsabilità<br />
1. Una istituzione nazionale sarà investita della competenza di promuovere e proteggere i diritti<br />
umani.<br />
2. Ad una istituzione nazionale sarà affidato un mandato il più ampio possibile, che sarà chiaramente<br />
esposto in un testo legislativo o costituzionale, specificando la composizione e la sfera<br />
di competenza.<br />
3. Un’istituzione nazionale avrà, inter alia, i seguenti compiti:<br />
omissis<br />
g) Pubblicizzare i diritti umani e gli sforzi per combattere tutte le forme di discriminazione, in particolare<br />
la discriminazione razziale, incrementando la consapevolezza collettiva, specialmente<br />
attraverso l’informazione e l’educazione e facendo uso di tutti gli organi di stampa.<br />
omissis<br />
327
Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL)<br />
329
CONVENZIONE N. 107 SULLE POPOLAZIONI INDIGENE E TRIBALI<br />
(Convenzione concernente la protezione e l’integrazione delle popolazioni indigene, tribali<br />
e semitribali in Paesi indipendenti, adottata dall’Organizzazione Internazionale del<br />
Lavoro - OIL, il 26.06.1957)<br />
omissis<br />
Parte VI. Educazione e mezzi d’informazione<br />
omissis<br />
Articolo 26<br />
omissis<br />
2. Ove necessario, saranno utilizzate a tal fine traduzioni scritte ed informazioni ampiamente<br />
diffuse nelle lingue di dette popolazioni.<br />
omissis<br />
CONVENZIONE N. 169 CONCERNENTE LE POPOLAZIONI INDIGENE E TRIBALI IN PAESI<br />
INDIPENDENTI<br />
(adottata il 27.06.1989)<br />
omissis<br />
2. A tale fine, si ricorrerà, se necessario, a traduzioni scritte e all’utilizzo di mezzi di comunicazioni<br />
di mass nelle lingue di detti popoli.<br />
omissis<br />
331
Unesco<br />
333
RACCOMANDAZIONE SULL’EDUCAZIONE ALLA COMPRENSIONE, ALLA COOPERA-<br />
ZIONE E ALLA PACE INTERNAZIONALE E SULL’EDUCAZIONE RELATIVA AI <strong>DIRITTI</strong><br />
DELL’UOMO E ALLE LIBERTA’ FONDAMENTALI<br />
(Adottata nel corso della XVIII Sessione della Conferenza Generale dell’UNESCO Parigi,<br />
19 novembre 1974)<br />
omissis<br />
La Conferenza Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e<br />
la cultura, riunitasi a Parigi dal 17 ottobre al 23 novembre 1974, nella sua diciottesima sessione,<br />
Consapevole della responsabilità che incombe agli Stati di raggiungere attraverso l’educazione<br />
gli obiettivi enunciati dalla Carta delle Nazioni Unite, l’Atto costitutivo dell’Unesco, la Dichiarazione<br />
universale dei diritti dell’uomo e le Convenzioni di Ginevra per la protezione delle vittime<br />
di guerra del 12 agosto 1949, al fine di promuovere la comprensione, la cooperazione e la pace<br />
internazionali ed il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,<br />
omissis<br />
VIII Mezzi e materiali educativi<br />
omissis<br />
39. Gli Stati membri dovrebbero favorire l’adozione delle misure appropriate affinché i materiali<br />
educativi, ed in modo particolare i libri di testo, non contengano elementi atti a suscitare<br />
l’incomprensione, la diffidenza, le reazioni razziste, il disprezzo o l’odio riguardo altri gruppi o<br />
popoli. Tali materiali dovrebbero fornire ampie conoscenze di base che aiutino gli allievi a distinguere<br />
tra le informazioni e le idee diffuse dai mezzi di comunicazione quelle che sembrano<br />
andare contro i fini di questa raccomandazione.<br />
40. Ogni Stato membro dovrebbe creare o contribuire a creare, a misura delle sue necessità e<br />
delle sue possibilità uno o più centri di comunicazione scritta e audiovisiva concepita secondo<br />
gli obiettivi della presente raccomandazione e adattata alle diverse forme ed ai diversi stadi educativi.<br />
Tali centri dovrebbero essere concepiti in modo tale da promuovere la riforma<br />
dell’educazione a vocazione internazionale particolarmente grazie all’elaborazione ed alla diffusione<br />
di idee e di materiale innovativo, e dovranno inoltre organizzare e facilitare gli scambi di<br />
informazioni con gli altri paesi.<br />
omissis<br />
RACCOMANDAZIONE SULLA PARTECIPAZIONE E L’APPORTO DI TUTTA LA POPOLA-<br />
ZIONE ALLA VITA CULTURALE<br />
(adottata dalla Conferenza generale nel corso della diciannovesima sessione, Nairobi, 26<br />
novembre 1976)<br />
omissis<br />
Considerando che l’accesso e la partecipazione, che devono offrire ad ognuno la possibilità non<br />
solo di ricevere ma anche di esprimersi in tutti i campi della vita sociale, implicano la libertà e la<br />
tolleranza più ampie nella formazione, nella creazione e nella diffusione culturali,<br />
Considerando che la partecipazione alla vita culturale presume l’affermazione dell’individuo,<br />
della sua dignità e del suo valore, e la materializzazione delle libertà e dei diritti fondamentali<br />
dell’uomo, come sono sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e dagli strumenti giuridici internazionali<br />
adottati in materia di diritti umani, che il progresso culturale dell’individuo è ostacolato<br />
dalla politica di aggressione, dal colonialismo, dal neo colonialismo, dal fascismo e dal razzismo<br />
in ogni sua forma ed in tutte le sue manifestazioni, nonché da altre azioni,<br />
335
Considerando che la partecipazione alla vita culturale si traduce in una affermazione<br />
dell’identità, dell’autenticità e della dignità; che l’identità è minacciala nella sua integrità da molteplici<br />
cause di erosione, che attengono in particolare alla divulgazione di modelli inadeguati o<br />
di tecniche non correttamente gestite,<br />
Considerando che l’affermazione dell’identità culturale non potrebbe indurre all’isolamento dei<br />
gruppi ma deve al contrario essere associata ad ampie e frequenti comunicazioni fra gli stessi;<br />
che tali comunicazioni rappresentano un’esigenza fondamentale in mancanza della quale gli obiettivi<br />
della presente raccomandazione non potrebbero essere raggiunti,<br />
Tenuto conto del ruolo fondamentale svolto dall’insegnamento nel suo insieme, l’educazione<br />
culturale e la formazione artistica, nonché l’utilizzo del tempo di lavoro e del tempo libero in favore<br />
di un pieno sviluppo culturale, in un’ottica di formazione permanente,<br />
Considerando che i mezzi di comunicazione di massa possono fungere da strumenti di arricchimento<br />
culturale, sia offrendo opportunità senza precedenti allo sviluppo culturale, contribuendo<br />
alla liberazione del potenziale culturale degli individui, alla salvaguardia e alla diffusione<br />
delle forme tradizionali della cultura nonché alla creazione e alla diffusione di forme nuove, sia<br />
trasformandosi in mezzi di comunicazione di gruppo e favorendo l’intervento diretto delle popolazioni,<br />
omissis<br />
o. dotare i mezzi di comunicazione di massa di uno statuto che ne garantisca l’autonomia, facendo<br />
in modo da rendere effettiva la partecipazione dei creatori come del pubblico; tali mezzi<br />
non dovrebbero minacciare l’autenticità delle culture né degradarne la qualità, essi non dovrebbero<br />
costituire strumenti di dominio culturale, bensì contribuire alla comprensione reciproca e<br />
alla pace;<br />
omissis<br />
DICHIARAZIONE SULLA RAZZA ED I PREGIUDIZI RAZZIALI<br />
(adottata dalla Conferenza generale nel corso della ventesima sessione, Parigi, 27 novembre<br />
1978)<br />
omissis<br />
Articolo 5<br />
omissis<br />
3. I grandi mezzi di informazione e coloro che li controllano o se ne servono, nonché qualsiasi<br />
gruppo organizzato in seno alle comunità nazionali, sono chiamati – tenendo in debita considerazione<br />
i principi formulati nella Dichiarazione dei diritti dell’uomo e in particolare del principio<br />
della libertà di espressione - a promuovere la comprensione, la tolleranza e l’amicizia tra gli individui<br />
ed i gruppi umani e a contribuire all’eliminazione del razzismo, della discriminazione razziale<br />
e dei pregiudizi razziali, evitando in particolare di dare ad individui e diversi gruppi umani<br />
una rappresentazione stereotipata, parziale, unilaterale o capziosa. La comunicazione tra i<br />
gruppi razziali ed etnici deve essere un processo reciproco, che consenta loro di esprimersi e di<br />
farsi capire pienamente ed in tutta libertà. I grandi mezzi di informazione dovrebbero quindi aprirsi<br />
alle idee degli individui e dei gruppi che agevolano tale comunicazione.<br />
omissis<br />
336
DICHIARAZIONE DI CITTA’ DEL MESSICO SULLE POLITICHE CULTURALI<br />
(adottata dalla Conferenza Mondiale sulle politiche culturali di Città del Messico, 6 agosto 1982)<br />
omissis<br />
36. Una diffusione libera e una più ampia ed equilibrata divulgazione delle idee e delle conoscenze<br />
relative all’informazione, che rientrano tra i principi di un nuovo ordine mondiale nel<br />
campo dell’informazione e della comunicazione, implicano per tutte le nazioni il diritto non solo<br />
a ricevere ma anche a trasmettere informazioni nel campo della cultura, dell’istruzione, della<br />
scienza e della tecnica.<br />
37. I moderni mezzi di comunicazione devono facilitare un’informazione obiettiva relativamente<br />
alle tendenze culturali nei vari paesi, senza che questo sia di ostacolo alla libertà della creatività<br />
e dell’identità culturale delle nazioni.<br />
omissis<br />
40. Attualmente i moderni mezzi di comunicazione svolgono un ruolo fondamentale nel settore<br />
dell’istruzione e per quanto riguarda la diffusione della cultura. La società, pertanto, deve sviluppare<br />
modi e mezzi che permettano di sfruttare le nuove tecnologie della produzione e della<br />
comunicazione, al fine di realizzare un effettivo sviluppo individuale e collettivo nonché di promuovere<br />
l’indipendenza delle nazioni, preservandone la sovranità e rafforzando la pace nel<br />
mondo.<br />
omissis<br />
CONFERENZA INTERGOVERNATIVA SULLE POLITICHE CULTURALI PER LO SVILUPPO<br />
(Organizzazione delle Nazioni Unite per l’istruzione , la scienza e la cultura – UNESCO)<br />
(Stoccolma, Svezia, 30 marzo-2 aprile 1998)<br />
Bozza di Piano d’Azione<br />
sulle Politiche Culturali per lo Sviluppo<br />
omissis<br />
Obiettivo 5: Sostenere la diversità culturale all’interno e per la società dell’informazione<br />
Al fine di raggiungere questo obiettivo, la Conferenza invita gli Stati membri ad adottare le seguenti<br />
linee di azione:<br />
Fornire un servizio pubblico radiotelevisivo in grado di soddisfare le esigenze culturali e legate<br />
all’istruzione quali la promozione delle culture e delle lingue locali, regionali e nazionali nonché<br />
garantire l’indipendenza editoriale dei media appartenenti al servizio pubblico.<br />
Facilitare il rilascio di licenze per la diffusione radiotelevisiva a gruppi comunitari e linguistici e<br />
ad altri tipi di gruppi minoritari, in particolare a livello locale.<br />
omissis<br />
337
DOCUMENTI DEL CONSIGLIO D'EUROPA<br />
339
CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI <strong>DIRITTI</strong> DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ<br />
FONDAMENTALI (conclusa a Roma il 4 novembre 1950)<br />
omissis<br />
Articolo 10<br />
1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la<br />
libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da<br />
parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce<br />
agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema<br />
o di televisione.<br />
2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto<br />
alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono<br />
misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per l’integrità territoriale<br />
o per la pubblica sicurezza, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la<br />
protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per<br />
impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere<br />
giudiziario.<br />
omissis<br />
CONVENZIONE EUROPEA SULLA TELEVISIONE TRANSFRONTALIERA<br />
(Strasburgo, 5 maggio 1989)<br />
omissis<br />
Articolo 4 – Libertà di ricezione e di ritrasmissione<br />
Le Parti assicurano libertà di espressione e di informazione, in conformità con l’art. 10 della<br />
Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali ed assicurano libertà<br />
di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul proprio territorio di servizi di programmi<br />
televisivi conformi alle disposizioni della presente Convenzione.<br />
omissis<br />
Articolo 10 – Obiettivi culturali<br />
omissis<br />
3. Le Parti si impegnano a ricercare insieme gli strumenti e le procedure più appropriate per appoggiare,<br />
senza discriminazioni tra le emittenti televisive, l’attività e lo sviluppo della produzione<br />
europea, in particolare nelle Parti aventi una scarsa capacità di produzione audiovisiva oppure<br />
una zona linguistica limitata.<br />
CARTA EUROPEA DELLE LINGUE REGIONALI E/O MINORITARIE (1992)<br />
omissis<br />
Mezzi di comunicazione<br />
Articolo 11<br />
1. Le Parti s’impegnano, per i locutori di lingue regionali o minoritarie, sui territori in cui queste<br />
lingue sono praticate, secondo la situazione di ciascuna lingua, nella misura in cui le autorità<br />
pubbliche hanno direttamente o indirettamente competenza, poteri o un ruolo in questo settore,<br />
nel rispetto dei principi d’indipendenza e d’autonomia dei mezzi di comunicazione:<br />
341
a) nella misura in cui la radio e la televisione hanno una missione di servizio pubblico:<br />
i) a garantire la creazione di almeno una stazione radiofonica e di un canale televisivo<br />
nelle lingue regionali o minoritarie; oppure<br />
ii) ad incoraggiare e/o facilitare la creazione di almeno una stazione radiofonica e di un<br />
canale televisivo nelle lingue regionali o minoritarie; oppure<br />
iii) a prendere adeguati provvedimenti affinché gli emittenti programmino trasmissioni nelle<br />
lingue regionali o minoritarie;<br />
b) i) a incoraggiare e/o facilitare la creazione di almeno una stazione radiofonica nelle lingue<br />
regionali o minoritarie; oppure<br />
ii) ad incoraggiare e/o facilitare la trasmissione di programmi radiofonici nelle lingue regionali<br />
o minoritarie, su base regolare;<br />
c) i) ad incoraggiare e/o facilitare la creazione di almeno un canale televisivo nelle lingue regionali<br />
o minoritarie; oppure<br />
ii) ad incoraggiare e/o facilitare la diffusione di programmi televisivi nelle lingue regionali o<br />
minoritarie, su base regolare;<br />
d) ad incoraggiare e/o facilitare la produzione e la diffusione di opere audio ed audiovisive<br />
nelle lingue regionali o minoritarie;<br />
e) i) ad incoraggiare e/o facilitare la creazione e/o il mantenimento di almeno un organo<br />
stampa nelle lingue regionali o minoritarie; oppure<br />
ii) ad incoraggiare e/o facilitare la pubblicazione di articoli stampa nelle lingue regionali o<br />
minoritarie, su base regolare;<br />
f) i) ad accollarsi i costi supplementari dei mezzi di comunicazione che utilizzano lingue regionali<br />
o minoritarie, quando la legge prevede in linea di massima un’assistenza finanziaria<br />
per i mezzi di comunicazione; oppure<br />
ii) ad estendere le esistenti misure di assistenza finanziaria alle produzioni audiovisive in<br />
lingue regionali o minoritarie;<br />
g) a sostenere la formazione professionale dei giornalisti, e dell’altro personale dei mezzi<br />
di comunicazione che si avvalgono di lingue regionali o minoritarie;<br />
2. Le parti s’impegnano a tutelare la libertà di ricevere direttamente le trasmissioni radiofoniche<br />
e televisive dei paesi vicini in una lingua praticata in forma identica o affine ad una lingua regionale<br />
o minoritaria, e a non opporsi alla ritrasmissione dai paesi vicini di programmi radiofonici e<br />
televisivi in detta lingua, Inoltre esse s’impegnano a vigilare che non siano imposte alla stampa<br />
scritta limitazioni alla libertà di espressione ed alla libera circolazione dell’informazione in una<br />
lingua praticata in forma identica o affine ad una lingua regionale o minoritaria. L’esercizio delle<br />
suddette libertà, comportante doveri e responsabilità, può essere sottoposto a talune formalità,<br />
condizioni, limitazioni o sanzioni previste dalle leggi, che rappresentano misure necessarie in<br />
una società democratica ai fini della sicurezza nazionale, dell’integrità territoriale o della pubblica<br />
sicurezza, della difesa dell’ordine pubblico e della prevenzione della criminalità, della protezione<br />
della sanità o della morale, della tutela della reputazione e dei diritti altrui, per impedire la<br />
divulgazione d’informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.<br />
3. Le parti s’impegnano a vigilare affinché gli interessi dei locatori di lingue regionali o minoritarie<br />
siano rappresentati o fatti valere nell’ambito di strutture eventualmente create in conformità<br />
della legge, finalizzate a garantire la libertà ed il pluralismo dei mezzi di comunicazione.<br />
342
RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE-QUADRO PER LA PROTEZIONE<br />
DELLE MINORANZE NAZIONALI (Strasburgo 1° febbraio 1995)<br />
omissis<br />
Articolo 9<br />
1. Le Parti s’impegnano a riconoscere che il diritto alla libertà di espressione di ogni persona<br />
appartenente ad una minoranza nazionale comporta la libertà di opinione e la libertà di ricevere<br />
o di comunicare informazioni o idee nella sua lingua minoritaria, senza che vi sia ingerenza di<br />
una pubblica autorità e senza badare a frontiere.<br />
Le parti faranno in modo nell’ambito del loro ordinamento legislativo, che le persone appartenenti<br />
ad una minoranza nazionale non siano discriminate per quanto attiene l'accesso ai mezzi<br />
d’informazione.<br />
2. Il paragrafo 1 non impedisce alle Parti di sottoporre ad un regime di autorizzazione non discriminatorio<br />
e fondato su criteri obiettivi, le emittenti radiofoniche e televisive o le imprese cinematografiche.<br />
3. Le Parti non frapporranno impedimenti alla fondazione e all'uso di mezzi di stampa da parte<br />
di persone appartenenti a minoranze nazionali. Nell’ambito legale delle emittenti radiofoniche e<br />
televisive esse concederanno alle persone che appartengono a minoranze nazionali, in tutta la<br />
misura del possibile ed in considerazione delle disposizioni del primo paragrafo, la possibilità di<br />
creare e di utilizzare propri mezzi d’informazione.<br />
4. Nell’ambito del loro sistema legislativo, le Parti adotteranno adeguati provvedimenti per agevolare<br />
alle persone appartenenti a minoranze nazionali l'accesso ai mezzi d’informazione, in vista<br />
di promuovere la tolleranza e di consentire il pluralismo culturale.<br />
omissis<br />
343
Assemblea Parlamentare<br />
345
RACCOMANDAZIONE N. 1067 RELATIVA ALLA DIMENSIONE CULTURALE DELLA RA-<br />
DIO DIFFUSIONE IN EUROPA (1987)<br />
L’Assemblea,<br />
omissis<br />
8. Insistendo sulla necessità per i governi di affermare in modo efficace la vocazione del servizio<br />
pubblico di radiodiffusione pubblica o privata, nonché il ruolo politico, educativo e culturale<br />
dei media, e convinta che la loro funzione di strumenti di creazione, di espressione della diversità<br />
culturale e di comunicazione sul scala europea debba essere rafforzata;<br />
omissis<br />
13. Richiamando inoltre la sua Raccomandazione 928 (1981) relativa ai problemi di istruzione e<br />
della cultura posti dalle lingue minoritarie e dai dialetti in Europa, come pure la sua Raccomandazione<br />
1043 (1986) relativa al patrimonio linguistico e culturale d’Europa e sottolineando il ruolo<br />
che cinema e media possono svolgere nella salvaguardia della diversità linguistica e<br />
nell’estensione della capacità di valutazione culturale;<br />
omissis<br />
20. Raccomanda il Comitato dei Ministri:<br />
omissis<br />
c. di adottare una dichiarazione che affermi la responsabilità delle autorità pubbliche nei confronti<br />
dei media e la vocazione del servizio pubblico di radiodiffusione, in cui sarà in particolare<br />
sottolineato il ruolo della televisione come mezzo di conoscenza delle diverse culture e di rafforzamento<br />
della diversità delle identità culturali e linguistiche;<br />
d. di definire proposte di intervento tese a preservare e a favorire il pluralismo linguistico nei<br />
media, in articolare attraverso:<br />
i. la creazione di un fondo comune destinato alla produzione, e che sarebbe anche a disposizione<br />
dei paesi di lingua minoritaria,<br />
ii. l’inserimento nei notiziari di interviste nelle lingue minoritarie;<br />
omissis<br />
iv. la garanzia del diritto per le lingue nazionali, e se del caso per lingue minoritarie locali e regionali,<br />
di farsi capire sulle reti nazionali, regionali e locali;<br />
omissis<br />
347
RACCOMANDAZIONE N. 1134 RELATIVA AI <strong>DIRITTI</strong> DELLE MINORANZE (1990)<br />
omissis<br />
Minoranze linguistiche<br />
12. Inoltre, per quanto attiene alle minoranze linguistiche, l’Assemblea adotta i due seguenti<br />
principi:<br />
omissis<br />
ii. le minoranze linguistiche devono avere il diritto di ricevere, fornire, detenere, riprodurre, diffondere<br />
e scambiare informazioni nella loro lingua madre a prescindere dalle frontiere.<br />
omissis<br />
RACCOMANDAZIONE N. 1201 RELATIVA AD UN PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA<br />
CONVENZIONE EUROPEA SUI <strong>DIRITTI</strong> <strong>UMANI</strong> E SUI <strong>DIRITTI</strong> DELLE MINORANZE NAZIO-<br />
NALI (1993)<br />
omissis<br />
Titolo 3 – Diritti sostanziali<br />
omissis<br />
Articolo 7<br />
Ogni appartenente ad una minoranza nazionale ha il diritto di usare liberamente la propria lingua<br />
madre in privato ed in pubblico, come pure verbalmente e per iscritto. Tale diritto si applica<br />
altresì all’uso della propria lingua nelle pubblicazioni e nel settore audiovisivo.<br />
omissis<br />
RACCOMANDAZIONI N. 1255 RELATIVA ALLA TUTELA DEI <strong>DIRITTI</strong> DELLE MINORANZE<br />
NAZIONALI (1995)<br />
omissis<br />
Disposizioni della Raccomandazione n. 1201 (1993) sulle minoranze nazionali che potrebbero<br />
essere incluse in protocollo addizionale sui diritti culturali<br />
omissis<br />
4. Diritto di usare la lingua minoritaria<br />
Ogni appartenente ad una minoranza nazionale ha il diritto di usare liberamente la propria lingua<br />
madre in privato ed in pubblico, come pure verbalmente e per iscritto. Tale diritto si applica<br />
altresì all’uso della propria lingua nelle pubblicazioni e nel settore audiovisivo.<br />
Omissis<br />
348
RACCOMANDAZIONE N. 1353 RELATIVA ALL’ACCESSO DELLE MINORANZE<br />
ALL’ISTRUZIONE SUPERIORE (1998)<br />
omissis<br />
x. Sarebbe opportuno fare un più ampio utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione e della<br />
comunicazione poiché sono particolarmente idonee all’insegnamento dei gruppi minoritari e degli<br />
studenti delle regioni geograficamente decentrate.<br />
omissis<br />
349
DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA<br />
351
RISOLUZIONE SU UNA CARTA COMUNITARIA DELLE LINGUE E CULTURE REGIONALI E<br />
UNA CARTA DEI <strong>DIRITTI</strong> DELLE MINORANZE ETNICHE<br />
(Risoluzione elaborata da Gaetano Arfè e adottata dal Parlamento Europeo il 16 ottobre 1981)<br />
Il Parlamento europeo,<br />
omissis<br />
1. si rivolge ai governi nazionali e ai poteri regionali e locali perché, pur nella grande diversità<br />
delle situazioni e nel rispetto delle rispettive autonomie, pongano in opera una politica in questo<br />
campo che abbia una comune ispirazione e tenda agli stessi fini, e li invita:<br />
omissis<br />
b) nel campo dei mezzi di comunicazione di massa:<br />
- a consentire e a rendere possibile l’accesso alla radio ed alla televisione locali in forme tali<br />
da garantire la continuità e l’efficacia della comunicazione a livello delle singole comunità e<br />
a favorire la formazione di operatori culturali specializzati;<br />
- a far sì che le minoranze beneficino per le loro manifestazioni culturali, nelle dovute proporzioni,<br />
di aiuti organizzativi e finanziari equivalenti a quelli di cui dispongono le maggioranze;<br />
omissis<br />
RISOLUZIONE SULLE LINGUE E LE CULTURE DELLE MINORANZE ETNICHE E REGIO-<br />
NALI NELLA COMUNITA’ EUROPEA<br />
(Risoluzione elaborata da Willy Kuijpers e adottata dal Parlamento europeo il 30 ottobre 1987)<br />
Il Parlamento europeo,<br />
omissis<br />
7. chiede agli Stati membri, in ordine ai mezzi di comunicazione di massa:<br />
omissis<br />
- di sostenere la formazione del personale operante nei mezzi di comunicazione di massa e<br />
dei giornalisti necessari per la realizzazione dei provvedimenti di cui sopra,<br />
omissis<br />
12. invita la Commissione:<br />
omissis<br />
- a riservare il necessario tempo di trasmissione alle culture minoritarie nel quadro della televisione<br />
europea,<br />
- a prestare l’attenzione necessaria all’informazione sulle minoranze linguistiche nelle pubblicazioni<br />
informative della Comunità;<br />
omissis<br />
353
RISOLUZIONE SULLA PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA IN EUROPA (1992)<br />
Il Parlamento europeo,<br />
omissis<br />
6. è del parere che la produzione e la distribuzione editoriale, in tutta la sua diversità, sia economica<br />
che culturale, debba essere sostenuta e incoraggiata onde garantire la libertà di espressione<br />
e la pluralità linguistica da essa rappresentate;<br />
omissis<br />
16. propone di incentivare mostre tematiche, come organizzato nell’ambito delle campagne di<br />
sensibilizzazione per il libro e la lettura a promozione dei testi scolastici; sottolinea l’interesse di<br />
promuovere la lettura nella più giovane età e propone di organizzare in Europa una mostra dei<br />
libri scolastici in tutti i dodici Stati membri onde consentire ai visitatori di recepire la diversità culturale<br />
dell’Europa,<br />
omissis<br />
- di creare reti europee di biblioteche itineranti, onde promuovere l’accesso alla lettura tra persone<br />
che ne sono praticamente escluse per motivi di emarginazione sociale e/o funzionale;<br />
omissis<br />
RISOLUZIONE SULLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE CONCERNENTE LE<br />
NUOVE PROSPETTIVE PER L’AZIONE DELLA COMUNITA’ NEL SETTORE CULTURALE<br />
(1992)<br />
Il Parlamento europeo,<br />
omissis<br />
k) crede, che, malgrado l’insieme degli atti assunti nel settore dell’audiovisivo, tra i quali di particolare<br />
importanza il sostegno a programmi per la televisione ed alta definizione, resti ancora<br />
molto da fare per valorizzare tutte le articolazioni produttive nelle quali l’industria audiovisiva si<br />
esprime e garantire un reale pluralismo non dominato dalla televisione e dai grandi gruppi che<br />
ne guidano le sorti, secondo quanto alla summenzionata risoluzione del 16 settembre 1992,<br />
l) sollecita la Commissione a difendere energicamente gli interessi delle emittenti pubbliche<br />
senza scopo di lucro, che sono da considerarsi primari veicoli di cultura,<br />
m) ritiene giunto il momento di fare il punto sull’applicazione negli Stati membri della Direttiva<br />
del Consiglio 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari<br />
e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive, soprattutto<br />
per verificarne gli effetti circa la diffusione di opere di origine europea, anche istituendo<br />
l’Osservatorio sull’audiovisivo,<br />
n) considera il Programma MEDIA lo strumento principale per l’incentivazione da parte della<br />
Comunità di una concatenata serie di progetti atti a creare migliori condizioni nel campo della<br />
produzione, della distribuzione, del plurilinguismo, della preparazione professionale e manageriale<br />
e mette in guardia contro un eventuale sviamento dagli obiettivi originari, che porterebbe a<br />
dare preminenza alla ricerca tecnologica o ad affievolirne l’autonomo ruolo nei confronti di altre<br />
meritevoli iniziative (EURISMAGES) con le quali è giusto intessere legami di convergente collaborazione,<br />
o) si aspetta proposte incisive per affrontare non solo attraverso le risorse di MEDIA il problema<br />
gravissimo della circolazione del cinema europeo nelle sale, passaggio ineludibile per il rilancio<br />
effettivo di una fase di distribuzione storicamente vitale e costituiva della stessa cultura cinematografica,<br />
354
p) ravvisa tra le altre possibili attività di coordinamento l’importanza di promuovere, nel settore<br />
del cinema come in altri settori, un calendario dei Festival cadenzato in modo da non provocare<br />
dannosi ostacoli o sovrapposizioni,<br />
q) ritiene urgente avviare un’opportuna azione di sostegno per la radio nelle sue varie articolazioni,<br />
tenendo conto in modo specifico delle stazioni non commerciali,<br />
r) ribadisce l’importanza fondamentale e strategica della dimensione europea dell’audiovisivo<br />
nel campo dell’informazione ed in questo quadro il ruolo decisivo che è chiamato a svolgere il<br />
progetto EURONEWS, operativo dal 1993;<br />
omissis<br />
RISOLUZIONE SULLE MINORANZE LINGUISTICHE E CULTURALI NELLA COMUNITA’<br />
EUROPEA<br />
(Risoluzione elaborata da Mark Killilea e approvata dal Parlamento Europeo Il 9 febbraio 1994)<br />
Il Parlamento europeo,<br />
omissis<br />
10. esorta la Commissione a:<br />
a) contribuire, entro i limiti delle sue competenze, all’esecuzione delle azioni intraprese dagli<br />
Stati membri in questo settore;<br />
b) tenere in debito conto le lingue meno diffuse e le relative culture nell’elaborazione di vari aspetti<br />
della politica comunitaria, al fine di provvedere pariteticamente alle esigenze specifiche di<br />
coloro che parlano lingue minoritarie, in tutti i programmi concernenti l’istruzione e la cultura,<br />
come ad esempio, Giovani per l’Europa, Erasmus, Tempus, European Dimension, Platform Europe,<br />
Media e progetti relativi alla traduzione di opere letterarie contemporanee;<br />
c) incoraggiare l’impiego delle lingue meno diffuse nell’ambito della politica audiovisiva della<br />
Comunità, per esempio per quanto riguarda la televisione ad alta definizione, nonché assistere<br />
le case di produzione e le emittenti che utilizzano lingue minoritarie nel produrre nuovi programmi<br />
nel formato 16:9;<br />
e) impostare quanto prima un programma ispirato a LINGUA per le lingue meno usate, avvalendosi<br />
eventualmente delle reti già sviluppate nel quadro delle attività dell’Ufficio per le lingue<br />
meno usate, quali la rete di formazione Mercator;<br />
omissis<br />
355
RISOLUZIONE SUL “LIBRO VERDE SULLA LIBERALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTU-<br />
RE DI TELECOMUNICAZIONE E DELLE RETI TELEVISIVE VIA CAVO” (PARTE II) (19 GIU-<br />
GNO 1995)<br />
Il Parlamento Europeo,<br />
omissis<br />
15. Chiede la creazione di reti di informazione pubblica interamente attrezzate ed aggiornate<br />
nelle 11 lingue ufficiali e la creazione di uno “spazio pubblico” economicamente accessibile così<br />
da rendere tali servizi universalmente accessibili, nonché l’istituzione di fondi nazionali ed europei<br />
da destinare alle lingue meno diffuse dell’UE;<br />
omissis<br />
26. Chiede che la Commissione consideri tutti gli aspetti, sia culturali che economici e sociali,<br />
prevedendo una qualche forma di regolamento a tutela sia della diversità e del pluralismo culturali<br />
che dell’identità europea; chiede inoltre che la Commissione svolga studi sugli effetti della<br />
liberalizzazione delle comunicazioni sul piano culturale, linguistico ed anche occupazionale.<br />
omissis<br />
RISOLUZIONE SUL PARERE DEL PARLAMENTO EUROPEO SULLA CONVOCAZIONE<br />
DELLA CONFERENZA INTERGOVERNATIVA, LA VALUTAZIONE DEI LAVORI DEL<br />
GRUPPO DI RIFLESSIONE E LA PRECISAZIONE DELLE PRIORITÀ POLITICHE DEL PAR-<br />
LAMENTO EUROPEO IN VISTA DELLA CONFERENZA INTERGOVERNATIVA (1996)<br />
Il Parlamento europeo,<br />
omissis<br />
10. Informazione<br />
10.1. L’Unione promuove gli scambi di informazione in tutte le loro forme e agevola l’accesso<br />
dei cittadini a tali informazioni. L’Unione salvaguarda il pluralismo nel settore dei media e della<br />
cultura eliminando gli ostacoli che vi si oppongono.<br />
10.2. L’Unione deve favorire la cooperazione tra società radiofoniche e televisive nonché lo sviluppo<br />
del settore multimediale, in particolare mediante l’elaborazione di programmi concepiti a<br />
livello europeo.<br />
omissis<br />
356
DIRETTIVA 97/36/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 89/552/CEE SUL<br />
COORDINAMENTO DI DETERMINATE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E<br />
AMMINISTRATIVE NEGLI STATI MEMBRI E CONCERNENTI L’ESERCIZIO DELLE ATTIVI-<br />
TÀ TELEVISIVE (1997)<br />
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea<br />
omissis<br />
(15) considerando che l’articolo F, paragrafo 2 del trattato sull’Unione europea dispone che<br />
l’Unione rispetti i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia<br />
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in quanto principi generali del diritto<br />
comunitario; che qualsiasi provvedimento volto a limitare la ricezione e/o sospendere la ritrasmissione<br />
di emittenti televisive preso ai sensi dell’articolo 2 bis della presente direttiva deve<br />
essere compatibile con tali principi;<br />
omissis<br />
(31) considerando che, per promuovere la produzione di opere europee, è essenziale che la<br />
Comunità, tenendo conto della capacità audiovisiva di ciascuno Stato membro e dell’esigenza<br />
di tutelare le lingue meno utilizzate dell’Unione europea promuova l’attività dei produttori indipendenti;<br />
omissis<br />
(44) considerando che l’approccio adottato nella direttiva 89/552/CEE e nella presente direttiva<br />
tende a conseguire l’armonizzazione necessaria e sufficiente per assicurare la libera circolazione<br />
delle trasmissioni televisive nella Comunità; che gli Stati membri conservano la facoltà di applicare,<br />
per le emittenti soggette alla loro giurisdizione, norme più dettagliate o più rigorose nei<br />
settori coordinati dalla presente direttiva ivi comprese, tra l’altro, norme riguardanti il conseguimento<br />
di obiettivi di politica linguistica, di tutela del pubblico interesse nella funzione<br />
d’informazione, di istruzione, di cultura e di intrattenimento della televisione, la salvaguardia del<br />
pluralismo nell’industria dell’informazione e nei mezzi di comunicazione e la salvaguardia della<br />
concorrenza al fine di evitare l’abuso di posizione dominante e/o l’instaurazione o il rafforzamento<br />
di posizioni dominanti tramite fusioni, accordi, acquisizioni o iniziative analoghe; che tali<br />
norme devono essere compatibili con il diritto comunitario;<br />
omissis<br />
hanno adottato la seguente direttiva:<br />
omissis<br />
28) E’ inserito il seguente articolo:<br />
“Articolo 22 bis<br />
Gli Stati membri fanno si che le trasmissioni non contengano alcun incitamento all’odio basato<br />
su differenze di razza, sesso, religione o nazionali”.<br />
omissis<br />
357
DOCUMENTI DELLA O.S.C.E.<br />
359
DOCUMENTO DEL SIMPOSIO DI CRACOVIA SUL RETAGGIO CULTURALE DEGLI STATI<br />
PARTECIPANTI ALLA CSCE (6 giugno 1991)<br />
omissis<br />
I rappresentanti degli Stati partecipanti alla Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in<br />
Europa,<br />
omissis<br />
6.2 Essi esprimono la propria convinzione che l’esistenza, nel campo artistico e culturale, di una<br />
varietà di mezzi di diffusione indipendenti dallo Stato, quali le case editrici, le emittenti radiofoniche,<br />
le case cinematografiche e gli enti televisivi, i teatri e le gallerie, contribuisce ad assicurare<br />
il pluralismo e la libertà di espressione artistica e culturale.<br />
7. Gli Stati partecipanti ricordano i propri impegni per il libero accesso alla cultura, e concordano<br />
quanto segue:<br />
7.1 Pur rispettando debitamente i diritti di proprietà intellettuale, ogni persona od organizzazione<br />
indipendente ha il diritto di possedere privatamente, usare e riprodurre ogni genere di materiale<br />
culturale, quali libri, pubblicazioni e registrazioni audiovisive, nonché i mezzi per riprodurli.<br />
omissis<br />
22.1 Al fine di accrescere nell’opinione pubblica la consapevolezza in materia di preservazione<br />
del retaggio culturale, gli Stati partecipanti renderanno disponibili informazioni atte ad aiutare le<br />
stazioni radiotelevisive e la stampa a promuovere l’informazione in tale settore.<br />
omissis<br />
RAPPORTO DELLA RIUNIONE CSCE DI ESPERTI SULLE MINORANZE NAZIONALI<br />
(Ginevra, luglio 1991)<br />
omissis<br />
VII<br />
Convinti che la tutela dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali richiede il libero<br />
flusso di informazioni e lo scambio di idee, gli Stati partecipanti sottolineano l’importanza delle<br />
comunicazioni fra le persone appartenenti a minoranze nazionali senza interferenze da parte<br />
delle pubbliche autorità e indipendentemente dalle frontiere. L’esercizio di tali diritti potrà essere<br />
soggetto soltanto alle restrizioni previste dalla legge e che siano compatibili con le norme internazionali.<br />
Essi riaffermano che nessuna persona appartenente a una minoranza nazionale sarà<br />
soggetta, semplicemente in quanto appartenente a tale minoranza, a sanzioni penali o amministrative<br />
per avere avuto contatti all’interno o al di fuori del proprio paese.<br />
Per quanto riguarda l’accesso ai media, essi non faranno discriminazioni contro alcuno sulla<br />
base di motivi etnici, culturale, linguistici o religiosi. Essi renderanno disponibili le informazioni<br />
utili per consentire ai mass media elettronici di tenere conto, nei loro programmi, dell’identità etnica,<br />
culturale, linguistica e religiosa delle minoranze nazionali.<br />
omissis<br />
361
RACCOMANDAZIONI DI OSLO SUI <strong>DIRITTI</strong> LINGUISTICI DELLE MINORANZE E NOTA IL-<br />
LUSTRATIVA (1998)<br />
omissis<br />
Mezzi di informazione<br />
8) Gli appartenenti a minoranze nazionali hanno il diritto di creare e conservare mezzi di informazione<br />
nella propria lingua minoritaria. La normativa nazionale sulla radiodiffusione si baserà<br />
su obiettivi e criteri non discriminatori e non sarà utilizzata per limitare il godimento dei diritti delle<br />
minoranze.<br />
9) Gli appartenenti a minoranze nazionali dovrebbero avere accesso alla programmazione radiotelevisiva<br />
nella propria lingua nell’ambito dei mezzi di informazione del servizio pubblico. A<br />
livello nazionale, regionale e locale la quantità e la qualità del tempo assegnato alle trasmissioni<br />
nella lingua di una minoranza dovrebbero essere rapportate alla consistenza numerica ed alla<br />
concentrazione della stessa ed essere adeguate alla sua situazione ed alle sue esigenze.<br />
10) Deve essere salvaguardata l’indipendenza della programmazione dei mezzi di informazione<br />
pubblici e privati nella/e lingua/e delle minoranze nazionali. I comitati editoriali dei mezzi di informazione<br />
pubblici che vigilano sul contenuto e l’orientamento della programmazione dovrebbero<br />
essere indipendenti ed includere appartenenti alle minoranze nazionali che operino godendo<br />
di una piena autonomia.<br />
11) Non sarà impropriamente limitato l’accesso ai mezzi di informazione originari di paesi stranieri.<br />
Tale accesso non dovrebbe giustificare una diminuzione del tempo di trasmissione assegnato<br />
alla minoranza nell’ambito dei mezzi di informazione del servizio pubblico del paese di<br />
residenza delle minoranze interessate.<br />
omissis<br />
362
DOCUMENTI DELL’INIZIATIVA CENTRO EUROPEA<br />
363
STRUMENTO CEI PER LA TUTELA DEI <strong>DIRITTI</strong> DELLE MINORANZE (1994)<br />
omissis<br />
Articolo 19<br />
1. Gli Stati garantiscono il diritto delle persone che appartengono ad una minoranza nazionale a<br />
servirsi dei mezzi di comunicazione nella propria lingua, in conformità alle norme dello Stato in<br />
materia e ricorrendo ad eventuali finanziamenti.<br />
2. Nel caso di tv e radio di proprietà pubblica, gli Stati garantiscono, quando ciò è opportuno e<br />
possibile, che le persone, che appartengono alle minoranze nazionali, abbiano diritto ad avere<br />
libero accesso a detti mezzi di comunicazione, compresa la produzione di detti programmi nella<br />
propria lingua.<br />
omissis<br />
365
DOCUMENTI DELL’U.F.G.E.E.<br />
367
CONVENZIONE SUI <strong>DIRITTI</strong> FONDAMENTALI DEI GRUPPI ETNICI IN EUROPA<br />
(Progetto di Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea sui diritti dell'Uomo)<br />
omissis<br />
Diritto all'informazione<br />
Articolo 10<br />
1. Le persone appartenenti a gruppi etnici hanno il diritto di diffondere e scambiare informazioni<br />
nella propria madrelingua (lingua del gruppo etnico) tramite stampati e media audiovisivi: hanno<br />
inoltre il diritto a libero accesso a queste informazioni, all'interno e al di fuori del proprio paese.<br />
2. In particolare essi hanno il diritto ad un accesso equiparato ai mass-media statali e agli altri<br />
mass-media pubblici, nonché a mezzi di comunicazione propri con adeguati finanziamenti pubblici<br />
a tal fine.<br />
3. Il diritto all'informazione include la ricezione di programmi radiofonici e televisivi dall'estero,<br />
dove si parla la stessa lingua.<br />
369
NORMATIVA E DOCUMENTI INTERNAZIONALI<br />
SULLA DISCRIMINAZIONE IN TEMA DI MINORANZE<br />
371
DOCUMENTI DELL'ORGANIZZAZIONE<br />
DELLE NAZIONI UNITE<br />
373
CARTA DELLE NAZIONI UNITE<br />
(Firmata da 51 membri originari ed adottata per acclamazione a S. Francisco il 26 giugno 1945 -<br />
Entrata in vigore con il deposito del ventinovesimo strumento di ratifica il 24 ottobre 1945 - Ratificata<br />
dall’Italia con legge 17 agosto 1957 n. 848 in Suppl. Ord. G.U. n. 238 del 25 settembre<br />
1957)<br />
Noi, popoli delle Nazioni Unite,<br />
decisi<br />
a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di<br />
questa generazione ha portato indicibili afflizioni all’umanità, a riaffermare la fede nei diritti<br />
fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza<br />
dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole,<br />
a creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e<br />
dalle altri fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti,<br />
a promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà,<br />
e per tali fini<br />
a praticare la tolleranza ed a vivere in pace l’uno con l’altro in rapporti di buon vicinato,<br />
ad unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale,<br />
ad assicurare, mediante l’accettazione di principi e l’istituzione di sistemi, che la forza<br />
delle armi non sarà usata, slavo che nell’interesse comune, ad impiegare strumenti internazionali<br />
per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli,<br />
abbiamo deciso di unire i nostri sforzi per il raggiungimento di tali fini.<br />
In conseguenza, i nostri rispettivi Governi, per mezzo dei loro rappresentanti riuniti nella città di<br />
San Francisco e muniti di pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato il<br />
presente Statuto delle Nazioni Unite ed istituiscono con ciò un’organizzazione internazionale<br />
che sarà denominata le Nazioni Unite.<br />
Capitolo I<br />
Fini e principi<br />
Articolo 1<br />
I fini delle Nazioni Unite sono:<br />
omissis<br />
3. Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere<br />
economico, sociale, culturale od umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto<br />
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di<br />
lingua o di religione;<br />
omissis<br />
Articolo 13<br />
1. L’Assemblea Generale intraprende studi e fa raccomandazioni allo scopo di:<br />
omissis<br />
b. sviluppare la cooperazione internazionale nei campi economico, sociale, culturale, educativo<br />
e della sanità pubblica, e promuovere il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali<br />
per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione.<br />
omissis<br />
375
Capitolo IX<br />
Cooperazione internazionale economica e sociale<br />
Articolo 55<br />
Allo scopo di creare le condizioni di stabilità e di benessere che sono necessarie per avere rapporti<br />
pacifici ed amichevoli fra le nazioni, basate sul rispetto del principio dell’uguaglianza dei<br />
diritti o dell’autodecisione dei popoli, le Nazioni Unite promuoveranno:<br />
omissis<br />
c. il rispetto o l’osservanza universale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti,<br />
senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.<br />
omissis<br />
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI <strong>DIRITTI</strong> DELL’UOMO<br />
(Adottata dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948)<br />
Preambolo<br />
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e<br />
dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della<br />
pace nel mondo;<br />
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie<br />
che offendono la coscienza dell’umanità, e che l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani<br />
godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato<br />
proclamato come la più alta aspirazione dell’uomo;<br />
Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole<br />
evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia<br />
e l’oppressione;<br />
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;<br />
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti<br />
umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell’uguaglianza dei diritti<br />
dell’uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore<br />
di vita in una maggiore libertà;<br />
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni<br />
Unite, il rispetto e l’osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;<br />
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza<br />
per la piena realizzazione di questi impegni;<br />
L’Assemblea Generale proclama<br />
la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da<br />
tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo<br />
costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e<br />
l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive<br />
di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto<br />
tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro<br />
giurisdizione.<br />
omissis<br />
Articolo 2<br />
1. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione,<br />
senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di<br />
376
opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra<br />
condizione.<br />
omissis<br />
Articolo 7<br />
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale<br />
tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione<br />
che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.<br />
omissis<br />
Articolo 16<br />
1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna<br />
limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio,<br />
durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento.<br />
omissis<br />
Articolo 18<br />
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la<br />
libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune,<br />
e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle<br />
pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.<br />
omissis<br />
Articolo 26<br />
1. Ogni individuo ha diritto all’istruzione. L’istruzione deve essere gratuita almeno per quanto<br />
riguarda le classi elementari e fondamentali. L’istruzione elementare deve essere obbligatoria.<br />
L’istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l’istruzione superiore<br />
deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.<br />
2. L’istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento<br />
del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione,<br />
la tolleranza, l’amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire<br />
l’opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.<br />
omissis<br />
CONVENZIONE RELATIVA ALLO STATUS DEI RIFUGIATI<br />
(Ginevra, 28 luglio 1951)<br />
Preambolo<br />
Le Alte Parti Contraenti,<br />
Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite e la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo,<br />
approvata il 10 dicembre 1948 dalla Assemblea Generale, hanno affermato il principio che gli<br />
esseri umani senza distinzione debbano usufruire dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;<br />
Considerato che l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha, a più riprese, manifestato il suo<br />
profondo interesse per i rifugiati e la sua preoccupazione affinché ad essi venga garantito<br />
l’esercizio dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nel senso più ampio possibile;<br />
Considerato che sarebbe auspicabile rivedere e codificare gli accordi internazionali precedenti<br />
relativi allo status dei rifugiati ed estendere l’applicazione di questi strumenti e la protezione da<br />
essi garantita a mezzo di un nuovo accordo;<br />
Considerato che dalla concessione del diritto di asilo possono derivare obblighi eccezionalmente<br />
gravosi per determinati Paesi e che la soluzione più soddisfacente dei problemi, di cui<br />
377
l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha riconosciuto la portata ed il carattere internazionale,<br />
non potrebbe essere raggiunta, quindi, se non attraverso una cooperazione internazionale;<br />
Auspicato che tutti gli Stati, in considerazione del carattere sociale ed umanitario del problema<br />
dei rifugiati, facciano quanto è in loro potere per evitare che detto problema diventi causa di<br />
tensione tra gli Stati;<br />
Preso atto del fatto che l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha per scopo di<br />
sorvegliare l’applicazione delle Convenzioni internazionali che provvedono alla protezione dei<br />
rifugiati, e riconoscendo che l’effettivo coordinamento dei provvedimenti adottato per risolvere<br />
questo problema dipenderà dalla cooperazione tra gli Stati e l’Alto Commissario;<br />
Hanno convenuto quanto segue:<br />
CAPITOLO I<br />
DISPOSIZIONI GENERALI<br />
Articolo 1<br />
Definizione del termine “rifugiato”<br />
Ai fini della presente Convenzione, il termine “rifugiato” si applicherà a colui:<br />
1) che sia stato considerato rifugiato ai sensi degli Accordi del 12 maggio 1926 e del 30 giugno<br />
1928, o ai sensi delle Convenzioni del 28 ottobre 1933 e del 10 febbraio 1938 e del Protocollo<br />
del 14 settembre 1939, o in applicazione della Costituzione della Organizzazione Internazionale<br />
per i Rifugiati;<br />
Le decisioni di “non-eleggibilità”, prese dalla Organizzazione Internazionale per i Rifugiati nel<br />
periodo del suo mandato, non escludono che la qualifica di rifugiato possa venire accordata a<br />
persone in possesso dei requisiti previsto al paragrafo 2 della presente sezione;<br />
2) che, a seguito di avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951, temendo a ragione<br />
di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato<br />
gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese, di cui è cittadino e<br />
non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese: oppure<br />
che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale<br />
a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra. Nel<br />
caso di persona con più di una cittadinanza, ‘espressione “del paese di cui è cittadino” indica<br />
ognuno dei Paesi di cui la persona è cittadino. Pertanto non sarà più considerato privato della<br />
protezione del paese di cui è cittadino colui che, senza valido motivo fondato su timore giustificato,<br />
non abbia richiesto la protezione di uno dei Paesi di cui ha la cittadinanza.<br />
omissis<br />
Articolo 33<br />
Divieto di espulsione o di respingimento (refoulement)<br />
1) Nessuno Stato contraente potrà espellere o respingere (refouler) – in nessun modo – un rifugiato<br />
verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a causa<br />
della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua appartenenza ad una determinata<br />
categoria sociale o delle sue opinioni politiche.<br />
omissis<br />
378
CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULL’ELIMINAZIONE DI OGNI FORMA DI DISCRIMI-<br />
NAZIONE RAZZIALE<br />
(Adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 21 dicembre 1965)<br />
Preambolo<br />
Gli Stati Parti della presente Convenzione,<br />
Considerando che lo Statuto delle Nazioni Unite è basato sui principi della dignità e<br />
dell’eguaglianza di tutti gli esseri umani, e che tutti gli Stati membri si sono impegnati ad agire,<br />
sia congiuntamente sia separatamente in collaborazione con l’Organizzazione, allo scopo di<br />
raggiungere uno degli obiettivi delle Nazioni Unite, e precisamente: sviluppare ed incoraggiare il<br />
rispetto universale ed effettivo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza<br />
distinzione di razza, sesso, lingua o religione,<br />
Considerando che la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo proclama che tutti gli esseri<br />
umani nascono liberi ed uguali per dignità e diritti e che ciascuno può valersi di tutti i diritti e di<br />
tutte le libertà che vi sono enunciate, senza alcuna distinzione di razza, colore od origine nazionale,<br />
Considerando che tutti gli uomini sono uguali davanti alla legge ed hanno diritto ad una uguale<br />
protezione legale contro ogni discriminazione ed ogni incitamento alla discriminazione,<br />
Considerando che le Nazioni Unite hanno condannato il colonialismo e tutte le pratiche segregazionistiche<br />
e discriminatorie che lo accompagnano, sotto qualunque forma e in qualunque<br />
luogo esistano, e che la Dichiarazione sulla concessione dell’indipendenza ai paesi ed ai popoli<br />
coloniali, del 14 dicembre 1960 (Risoluzione n. 1514 [XV] dell’Assemblea Generale) ha asserito<br />
e proclamato solennemente la necessità di porvi rapidamente ed incondizionatamente fine,<br />
Considerando che la Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione<br />
razziale del 20 novembre 1963 (Risoluzione n. 1904 [XVIII] dell’Assemblea Generale)<br />
asserisce solennemente la necessità di eliminare rapidamente tutte le forme e tutte le manifestazioni<br />
di discriminazione razziale in ogni parte del mondo, nonché di assicurare la comprensione<br />
ed il rispetto della dignità della persona umana,<br />
Convinti che qualsiasi dottrina di superiorità fondata sulla distinzione tra le razze è falsa scientificamente,<br />
condannabile moralmente ed ingiusta e pericolosa socialmente, e che nulla potrebbe<br />
giustificare la discriminazione razziale, né in teoria né in pratica,<br />
Riaffermando che la discriminazione tra gli esseri umani per motivi fondati sulla razza, il colore<br />
o l’origine etnica costituisce un ostacolo alle amichevoli e pacifiche relazioni tra le Nazioni ed è<br />
suscettibile di turbare la pace e la sicurezza tra i popoli nonché la consistenza armoniosa degli<br />
individui che vivono all’interno di uno stesso Stato,<br />
Convinti che l’esistenza di barriere razziali è incompatibile con gli ideali di ogni società umana,<br />
Allarmati dalle manifestazioni di discriminazione razziale che hanno ancora luogo in certe regioni<br />
del mondo e dalle politiche dei governi fondate sulla superiorità o sull’odio razziale, quali le<br />
politiche di “apartheid”, di segregazione o di separazione,<br />
Risoluti ad adottare tutte, le misure necessarie al eliminazione di ogni forma e di ogni manifestazione<br />
di discriminazione razziale, nonché a prevenire ed a combattere le dottrine e le pratiche<br />
razziali allo scopo di favorire il buon accordo tra le razze ed a costruire una comunità internazionale,<br />
libera da ogni forma di segregazione e di discriminazione razziale,<br />
Ricordando la Convenzione sulla discriminazione in materia di impiego e di professione adottata<br />
dall’Organizzazione nazionale del lavoro nel 1958 e la Convenzione sulla lotta contro la discriminazione<br />
in materia di insegnamento adottata nel 1960 dall’Organizzazione delle Nazioni<br />
Unite per l’educazione la scienza e la cultura,<br />
Desiderosi di dare esecuzione ai principi enunciati nella Dichiarazione delle Nazioni Unite e relativi<br />
all’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale nonché di assicurare il più rapidamente<br />
possibile l’adozione di misure pratiche a tale scopo,<br />
Hanno convenuto quanto segue:<br />
379
Parte I<br />
Articolo 1<br />
1. Nella presente Convenzione, l’espressione “discriminazione razziale” sta ad indicare ogni distinzione,<br />
restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale<br />
o etnica, che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il<br />
godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in<br />
campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica.<br />
omissis<br />
4. Le speciali misure adottate al solo scopo di assicurare convenientemente il progresso di alcuni<br />
gruppi razziali od etnici o di individui cui occorra la protezione necessaria per mettere loro il<br />
godimento e l’esercizio dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in condizioni di eguaglianza<br />
non sono considerate misure di discriminazione razziale, a condizione tuttavia che tali<br />
misure non abbiano come risultato conservazione di diritti distinti per speciali gruppi razziali e<br />
che non vengano tenute in vigore una volta che siano raggiunti gli obiettivi che si erano prefisse.<br />
Articolo 2<br />
1. Gli Stati contraenti condannano la discriminazione razziale e si impegnano a continuare, con<br />
tutti i mezzi adeguati e senza indugio, una politica tendente ad eliminare ogni forma di discriminazione<br />
razziale ed a favorire l’intesa tra tutte le razze, e, a tale scopo:<br />
a) Ogni Stato contraente si impegna a non porre in opera atti o pratiche di discriminazione<br />
razziale a danno di individui, gruppi di individui od istituzioni ed a fare in modo che tutte le<br />
pubbliche attività e le pubbliche istituzioni nazionali e locali si uniformino a tale obbligo;<br />
b) Ogni Stato contraente si impegna a non incoraggiare, difendere ed appoggiare la discriminazione<br />
razziale praticata da qualsiasi individuo od organizzazione;<br />
c) Ogni Stato contraente deve adottare delle efficaci misure per rivedere le politiche governative<br />
nazionali e locali e per modificare, abrogare o annullare ogni legge ed ogni disposizione<br />
regolamentare che abbia il risultato di creare la discriminazione o perpetuarla ove esista;<br />
d) Ogni Stato contraente deve, se le circostanze lo richiedono, vietare e porre fine con tutti i<br />
mezzi più opportuni, provvedimenti legislativi compresi, alla discriminazione, praticata da<br />
singoli individui, gruppi od organizzazioni;<br />
e) Ogni Stato contraente s’impegna, ove occorra, a favorire le organizzazioni ed ì movimenti<br />
integrazionisti multirazziali e gli altri mezzi atti ad eliminare le barriere che esistono tra le<br />
razze, nonché a scoraggiare quanto tende a rafforzare la separazione razziale.<br />
2. Gli Stati contraenti, se le circostanze lo richiederanno, adotteranno delle speciali e concrete<br />
misure in campo sociale, economico, culturale o altro, allo scopo di assicurare nel modo dovuto<br />
lo sviluppo o la protezione di alcuni gruppi razziali o di individui appartenenti a tali gruppi per garantire<br />
loro, in condizioni di parità, il pieno esercizio dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.<br />
Tali misure non potranno avere, in alcun caso, il risultato di mantenere i diritti disuguali o<br />
distinti per speciali gruppi razziali, una volta che siano stati raggiunti gli obiettivi che si erano<br />
prefissi.<br />
omissis<br />
Articolo 4<br />
Gli Stati contraenti condannano ogni propaganda ed ogni organizzazione che s’ispiri a concetti<br />
ed a teorie basate sulla superiorità di una razza o di un gruppo di individui di un certo colore o di<br />
una certa origine etnica, o che pretendano di giustificare o di incoraggiare ogni forma di odio e<br />
di discriminazione razziale, e si impegnano ad adottare immediatamente misure efficaci per eliminare<br />
ogni incitamento ad una tale discriminazione od ogni atto discriminatorio, tenendo conto,<br />
tale scopo, dei principi formulati nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dei diritti<br />
chiaramente enunciati nell’art. 5 della presente Convenzione, ed in particolare:<br />
380
a) a dichiarare crimini punibili dalla legge, ogni diffusione di idee basate sulla superiorità o<br />
sull’odio razziale, ogni incitamento alla discriminazione razziale, nonché ogni atto di violenza,<br />
od incitamento a tali atti diretti contro ogni razza o gruppo di individui di colore diverso o<br />
di diversa origine etnica, come ogni aiuto portato ad attività razzistiche, compreso il loro finanziamento;<br />
b) a dichiarare illegali ed a vietare le organizzazioni e le attività di propaganda organizzate<br />
ed ogni altro tipo di attività di propaganda che incitino alla discriminazione razziale e che<br />
l’incoraggino, nonché a dichiarare reato punibile dalla legge la partecipazione a tali organizzazioni<br />
od a tali attività;<br />
c) a non permettere né alle pubbliche autorità, né alle pubbliche istituzioni, nazionali o locali,<br />
l’incitamento o l’incoraggiamento alla discriminazione razziale.<br />
Articolo 5<br />
In base agli obblighi fondamentali di cui all’art. 2 della presente Convenzione, gli Stati contraenti<br />
si impegnano a vietare e ad eliminare la discriminazione razziale in tutte le forme ed a garantire<br />
a ciascuno il diritto alla eguaglianza dinanzi alla legge senza distinzione di razza, colore od origine<br />
nazionale o etnica, nel pieno godimento, in particolare, dei seguenti diritti:<br />
a) Diritto ad un eguale trattamento avanti i tribunali ed a ogni altro organo che amministri la<br />
giustizia;<br />
b) Diritto alla sicurezza personale ed alla protezione dello Stato contro le violenze o le sevizie<br />
da parte sia di funzionari governativi, sia di ogni individuo, gruppo od istituzione;<br />
c) Diritti politici, ed in particolare il diritto di partecipare alle elezioni, di votare e di presentarsi<br />
candidato in base al sistema del suffragio universale ed eguale per tutti, il diritto di partecipare<br />
al governo ed alla direzione degli affari pubblici, a tutti i livelli, nonché il diritto di accedere,<br />
a condizioni di parità, alle cariche pubbliche;<br />
d) Altri diritti civili quali:<br />
i) il diritto di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza all’interno dello Stato;<br />
ii) Il diritto di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di tornare nel proprio paese;<br />
iii) Il diritto alla nazionalità;<br />
iv) Il diritto a contrarre matrimonio ed alla scelta del proprio coniuge;<br />
v) Il diritto alla proprietà di qualsiasi individuo, sia in quanto singolo sia in società con altri;<br />
vi) Il diritto all’eredità;<br />
vii) Il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;<br />
viii) Il diritto alla libertà di opinione e di espressione;<br />
ix) Il diritto alla libertà di riunione e di pacifica associazione;<br />
e) I diritti economici, sociali e culturali, ed in particolare:<br />
i) I diritti al lavoro, alla libera scelta del proprio lavoro, a condizioni di lavoro eque e<br />
soddisfacenti, alla protezione dalla disoccupazione, ad un salario uguale a parità di lavoro<br />
uguale, ad una remunerazione equa e soddisfacente;<br />
ii) Il i diritto di fondare dei sindacati e di iscriversi a sindacati;<br />
iii) Il diritto all’alloggio;<br />
iv) Il diritto alla sanità, alle cure mediche, alla previdenza sociale ed ai servizi sociali:<br />
v) Il diritto all’educazione ed alla formazione professionale;<br />
vi) Il diritto di partecipare in condizioni di parità attività culturali;<br />
f) Il diritto di accesso a tutti i luoghi e servizi destinati ad uso pubblico, quali i mezzi di trasporto,<br />
gli alberghi, i ristoranti, i caffé, gli spettacoli ed i parchi.<br />
omissis<br />
Articolo 7<br />
Gli Stati contraenti si impegnano ad adottare immediate ed efficaci misure, in particolare nei<br />
campi dell’insegnamento, dell’educazione, della cultura e dell’informazione, per lottare contro i<br />
pregiudizi che portano alla discriminazione razziale e a favorire la comprensione, la tolleranza e<br />
l’amicizia tra le nazioni ed i gruppi razziali ed etnici, nonché a promuovere gli scopi ed i princìpi<br />
381
dello Statuto delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, della Dichiarazione<br />
delle Nazioni Unite sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, e<br />
della presente Convenzione.<br />
omissis<br />
PATTO INTERNAZIONALE SUI <strong>DIRITTI</strong> CIVILI E POLITICI<br />
(Adottato dall’Assemblea Generale dell’ONU il 16 dicembre 1966)<br />
Gli Stati Parti del presente Patto,<br />
Considerato che, in conformità ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento<br />
della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e<br />
inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;<br />
Riconosciuto che, in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, l’ideale<br />
dell’essere umano libero, che goda delle libertà civili e politiche e della libertà dal timore e dalla<br />
miseria, può essere conseguito soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad<br />
ognuno di godere dei propri diritti civili e politici, nonché dei propri diritti economici, sociali e culturali;<br />
Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l’obbligo di promuovere il rispetto<br />
e l’osservanza universale dei diritti e delle libertà dell’uomo;<br />
Considerato infine che l’individuo, in quanto ha dei doveri verso gli altri e verso la collettività alla<br />
quale appartiene, è tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente<br />
Patto;<br />
Hanno convenuto quanto segue:<br />
omissis<br />
Articolo 2<br />
1. Ciascuno degli Stati Parti del presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli<br />
individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti<br />
nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso,<br />
la lingua, la religione, l’opinione politica o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale o sociale,<br />
la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.<br />
omissis<br />
Articolo 20<br />
omissis<br />
2. Qualsiasi appello all’odio nazionale, razziale o religioso che costituisca incitamento alla discriminazione,<br />
all’ostilità o alla violenza deve essere vietato dalla legge.<br />
omissis<br />
Articolo 26<br />
Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad<br />
una eguale tutela da parte della legge. A questo riguardo, la legge deve proibire qualsiasi discriminazione<br />
e garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva contro ogni discriminazione,<br />
sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l’opinione politica<br />
o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o<br />
qualsiasi altra condizione.<br />
Articolo 27<br />
382
In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli individui appartenenti<br />
a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria,<br />
di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri<br />
membri del proprio gruppo.<br />
omissis<br />
PATTO INTERNAZIONALE SUI <strong>DIRITTI</strong> ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI<br />
(Adottato dall’Assemblea Generale dell’ONU il 16 dicembre 1966)<br />
Preambolo<br />
Gli Stati Parti del presente Patto,<br />
Considerando che, in conformità ai principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite, il riconoscimento<br />
della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali e<br />
inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;<br />
Riconosciuto che questi diritti derivano dalla dignità inerente alla persona umana;<br />
Riconosciuto che, in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, l’ideale<br />
dell’essere umano libero, che goda della libertà dal timore e dalla miseria può essere conseguito<br />
soltanto se vengono create condizioni le quali permettano ad ognuno di godere dei propri diritti<br />
economici, sociali e culturali, nonché dei propri diritti civili e politici;<br />
Considerato che lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l’obbligo di promuovere il rispetto<br />
e l’osservanza universale dei diritti e delle libertà dell’uomo;<br />
Considerato infine che l’individuo, in quanto ha dei doveri verso gli altri e verso la collettività alla<br />
quale appartiene, è tenuto a sforzarsi di promuovere e di rispettare i diritti riconosciuti nel presente<br />
Patto;<br />
Hanno convenuto quanto segue:<br />
omissis<br />
Articolo 2<br />
omissis<br />
2. Gli Stati Parti del presente Patto si impegnano a garantire che i diritti in esso enunciati verranno<br />
esercitati senza discriminazione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la<br />
lingua, la religione, l’opinione politica o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale o sociale, la<br />
condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.<br />
omissis<br />
Articolo 13<br />
1. Gli Stati Parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all’istruzione. Essi<br />
convengono sul fatto che l’istruzione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana e<br />
del senso della sua dignità e rafforzare il rispetto per i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali.<br />
Essi convengono inoltre che l’istruzione deve porre tutti gli individui in grado di partecipare in<br />
modo effettivo alla vita di una società libera, deve promuovere la comprensione, la tolleranza e<br />
l’amicizia fra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali, etnici o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo<br />
delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.<br />
omissis<br />
383
RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI <strong>DIRITTI</strong> ECO-<br />
NOMICI, SOCIALI E CULTURALI, NONCHE’ DEL PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI<br />
<strong>DIRITTI</strong> CIVILI E POLITICI, CON PROTOCOLLO FACOLTATIVO<br />
(L. 25 ottobre 1977, n. 881)<br />
omissis<br />
Articolo 2<br />
omissis<br />
2. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a garantire che i diritti in esso enunciati verranno<br />
esercitati senza discriminazione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la<br />
lingua, la religione, l’opinione politica o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale o sociale, la<br />
condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.<br />
omissis<br />
CONVENZIONE SULL’ELIMINAZIONE DI OGNI FORMA DI DISCRIMINAZIONE NEI CON-<br />
FRONTI DELLA DONNA<br />
(New York, 18 dicembre 1979)<br />
Preambolo<br />
Gli Stati parti della presente Convenzione,<br />
omissis<br />
Vista la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo che afferma il principio della non discriminazione<br />
e dichiara che tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritto e che a<br />
ciascuno spettano tutti i diritti e le libertà ivi enunciate senza diminuzione alcuna, in particolare<br />
basata sul sesso,<br />
omissis<br />
Preoccupati tuttavia di constate che nonostante l’esistenza di tali strumenti le donne continuano<br />
ad essere oggetti di gravi discriminazioni,<br />
Ricordato che la discriminazione nei confronti della donna viola i principi dell’uguaglianza dei<br />
diritti e del rispetto della dignità dell’uomo, ostacola la partecipazione della donna, alle stesse<br />
condizioni dell’uomo alla vita politica, sociale, economica e culturale del suo paese, rende più<br />
difficoltosa la crescita del benessere della società e della famiglia ed impedisce alle donne di<br />
servire il loro paese e l’umanità tutta nella misura delle loro possibilità,<br />
omissis<br />
Sottolineato che l’eliminazione dell’apartheid, di ogni forma di razzismo, di discriminazione razziale<br />
di colonialismo, di neo-colonialismo, d’aggressione, d’occupazione, dominio straniero o ingerenza<br />
negli affari interni degli Stati è indispensabile perché uomini e donne possano pienamente<br />
godere dei loro diritti,<br />
omissis<br />
Risoluti a mettere in opera i principi enunciati sulla Dichiarazione sull’eliminazione della discriminazione<br />
nei confronti della donna e, a questo fine, ad adottare le misure necessarie a sopprimere<br />
tale discriminazione in ogni sua forma e ogni sua manifestazione,<br />
384
Convengono quanto segue:<br />
PARTE PRIMA<br />
Articolo 1<br />
Ai fini della presente Convenzione, l’espressione “discriminazione nei confronti della donna”<br />
concerne ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza,<br />
o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, o il godimento o<br />
l’esercizio, da parte delle donne, quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti dell’uomo e<br />
delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro<br />
campo, su base di parità tra l’uomo e la donna,<br />
omissis<br />
DICHIARAZIONE SULL’ELIMINAZIONE DI TUTTE LE FORME D’INTOLLERANZA E DI DI-<br />
SCRIMINAZIONE FONDATE SULLA RELIGIONE O IL CREDO<br />
(25 novembre 1981)<br />
L’Assemblea generale,<br />
Considerato che uno dei principi fondamentali dello Statuto delle Nazioni Unite è quello della<br />
dignità e dell’uguaglianza inerenti a tutti gli esseri umani e che tutti gli Stati membri si sono impegnati<br />
ad agire, sia congiuntamente che separatamente, in collaborazione con<br />
l’Organizzazione delle Nazioni Unite, al fine di promuovere e di incoraggiare il rispetto universale<br />
ed effettivo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzioni di razza,<br />
di sesso, di lingua o di religione,<br />
Considerato che la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ed i Patti Internazionali relativi ai<br />
Diritti Umani proclamano i principi di non discriminazione e di uguaglianza di fronte alla legge e<br />
il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo;<br />
Considerato che l’inosservanza e la violazione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,<br />
in particolare del diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione o di credo, sono stati<br />
direttamente o indirettamente all’origine di guerre e di grandi sofferenze inflitte all’umanità, in<br />
special modo qualora siano serviti come mezzo d’ingerenza esterna negli affari interni di altri<br />
Stati e per attizzare l’odio tra i popoli e le nazioni;<br />
Considerato che la religione o il credo costituiscono per colui che li professi, uno degli elementi<br />
fondamentali della sua concezione della vita è che la libertà di religione o di credo debbono essere<br />
integralmente rispettati e garantiti;<br />
Considerato che è essenziale contribuire alla comprensione, alla tolleranza e al rispetto per<br />
quanto concerne la libertà di religione o di credo ed assicurarsi che risulti inammissibile l’utilizzo<br />
della religione o del credo ai fini incompatibili con lo Statuto delle Nazioni Unite, gli altri strumenti<br />
pertinenti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ed i fini ed i principi della presente Dichiarazione;<br />
Convinta che la libertà di religione o di credo dovrebbe altresì contribuire alla realizzazione degli<br />
obiettivi di pace mondiale, di giustizia sociale e di amicizia tra i popoli e all’eliminazione delle ideologie<br />
o delle pratiche del colonialismo e della discriminazione razziale;<br />
Preso nota con soddisfazione dell’adozione, sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni<br />
Unite delle agenzie specializzate, di varie convenzioni, tese ad eliminare diverse forme di discriminazione,<br />
e dell’entrata in vigore di alcune di esse;<br />
Preoccupata per le manifestazioni di intolleranza e per l’esistenza di pratiche discriminatorie in<br />
materia di religione o di credo che si riscontrano ancora in certe parti del mondo;<br />
Decisa ad adottare ogni misura necessaria per eliminare rapidamente ogni forma e manifestazione<br />
di questa intolleranza e a prevenire e combattere qualsiasi discriminazione fondata sulla<br />
religione o il credo;<br />
Proclama la presente Dichiarazione sulla eliminazione di tutte le forma di intolleranza e di discriminazione<br />
fondate sulla regione o il credo;<br />
385
Articolo 1<br />
1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Questo diritto include<br />
la libertà di professare una religione o qualunque altro credo di propria scelta, nonché la<br />
libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo, sia a livello individuale che in comune<br />
con altri, sia in pubblico che in privato, per mazzo del culto e dell’osservanza di riti, della pratica<br />
e dell’insegnamento.<br />
2) Nessun individuo sarà soggetto a coercizioni di sorta che pregiudichino la sua libertà di professare<br />
una religione o un credo di propria scelta.<br />
3) La libertà di professare la propria religione o il proprio credo potrà essere soggetta alle sole<br />
limitazioni prescritte dalla legge e che risultino necessarie alla tutela della sicurezza pubblica,<br />
dell’ordine pubblico e della sanità pubblica o della morale o delle libertà e dei diritti fondamentali<br />
altrui.<br />
Articolo 2<br />
1) Nessun individuo può essere soggetto a discriminazioni di sorta da parte di uno Stato,<br />
un’istituzione, di un gruppo o di un qualsiasi individuo sulla base della propria religione o del<br />
proprio credo.<br />
2) Ai fini della presente Dichiarazione, l’espressione “intolleranza e discriminazione fondate sulla<br />
religione o il credo” sta a significare ogni forma di distinzione, di esclusione, di restrizione o di<br />
preferenza basate sulla religione o il credo, avente per scopo e per effetto la soppressione la<br />
limitazione del riconoscimento, del godimento o dell’esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali<br />
su una base di eguaglianza.<br />
Articolo 3<br />
La discriminazione tra gli esseri umani per motivi di religione o di credo costituisce un affronto<br />
alla dignità umana ed un disconoscimento dei principi dello Statuto delle Nazioni Unite, e dovrà<br />
essere condannata in quanto violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamati<br />
nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ed enunciati in dettaglio nei Patti Internazionali<br />
relativi ai Diritti Umani, e viene altresì condannata come un ostacolo alle relazioni amichevoli e<br />
pacifiche tra le nazioni.<br />
Articolo 4<br />
1) Tutti gli Stati dovranno adottare misure efficaci per prevenire ed eliminare qualsiasi discriminazione<br />
fondata sulla religione o il credo, nel riconoscimento, nell’esercizio e nel godimento dei<br />
diritti umani e delle libertà fondamentali in tutti i campi della vita civile, economica, politica, sociale<br />
e culturale.<br />
2) Tutti gli Stati si sforzeranno di adottare misure legislative o di revocare, all’occorrenza, quelle<br />
che sono in vigore, al fine di proibire ogni forma di discriminazione, di questo tipo, e di adottare<br />
ogni misura appropriata per combattere l’intolleranza fondata sulla religione o il credo.<br />
Articolo 5<br />
1) I genitori o, all’occorrenza, i tutori legali di un fanciullo hanno il diritto di organizzare la vita in<br />
seno alla famiglia in conformità alla propria religione o al loro credo e tenuto dell’educazione<br />
morale secondo cui ritengono che il fanciullo debba essere allevato.<br />
2) Ogni fanciullo dovrà godere del diritto di ricevere un’educazione in materia di religione o di<br />
credo secondo i desideri dei genitori o, all’occorrenza, dei suoi tutori legali, e non dovrà essere<br />
costretto a ricevere un’educazione religiosa contraria ai desideri dei suoi genitori e dei suoi tutori<br />
legali, sulla base del principio ispirativi dell’interesse del fanciullo.<br />
3) Il fanciullo dovrà essere protetto contro ogni forma di discriminazione fondata sulla religione o<br />
il credo. Egli dovrà essere allevato in uno spirito di comprensione, di tolleranza, di amicizia tra i<br />
popoli, di pace e di fraternità universale, di rispetto della religione o del credo altrui e nella piena<br />
consapevolezza che la sua energia ed i suoi talenti debbono essere dedicati al servizio dei propri<br />
simili.<br />
4) Qualora un fanciullo non si trovi né sotto la tutela dei genitori, né sotto quella di tutori legali, i<br />
desideri espressi da questi ultimi, o qualunque testimonianza raccolta sui loro desideri in materia<br />
di religione o di credo, saranno tenuti in debita considerazione, sulla base del principio ispirativi<br />
dell’interesse del fanciullo.<br />
386
5) Le pratiche di una religione o di un credo in cui è allevato un fanciullo non devono recare<br />
danno alla sua salute fisica o mentale e al suo completo sviluppo, tenuto conto del paragrafo 3<br />
dell’articolo 3 dell’articolo 1 della presente Dichiarazione.<br />
Articolo 6<br />
In conformità all’articolo 1 della presente Dichiarazione e previa riserva delle disposizioni del<br />
paragrafo 3 del suddetto articolo, il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, di religione, di<br />
credo include, tra l’altro, le libertà seguenti:<br />
a) La libertà di professare un culto e di tenere riunioni connesse ad una religione o a un credo,<br />
e di istituire e mantenere luoghi a tali fini;<br />
b)La libertà di fondare e di mantenere appropriate istituzioni di tipo caritativo o umanitario;<br />
c) La libertà di produrre, acquistare ed usare, in misura adeguata, gli oggetti necessari ed i materiali<br />
relativi ai riti e alle tradizioni di una religione o di un credo;<br />
d) La libertà di insegnare una religione o un credo in luoghi adatti a tale scopo;<br />
e) La libertà di sollecitare e di ricevere contributi volontari, di natura finanziaria e di altro tipo, da<br />
parte di privati e di istituzioni;<br />
f) La libertà di formare, di nominare, di eleggere, di designare per successione gli appropriati<br />
leaders, in conformità ai bisogni e alle norme di qualsiasi religione o credo;<br />
g La libertà di rispettare i giorni di riposo e di celebrare le festività ed i riti di culto secondo i precetti<br />
della propria religione o credo;<br />
h) La libertà di istituire e di mantenere comunicazioni con individui e comunità in materia di religione<br />
o di credo, a livello nazionale ed internazionale.<br />
Articolo 7<br />
I diritti e le libertà proclamati nella presente Dichiarazione sono accordati nella legislazione nazionale,<br />
in modo che ciascuno sia in grado di fruire di tali diritti e libertà nella pratica.<br />
Articolo 8<br />
Nessuna disposizione della presente Dichiarazione sarà interpretata come restrizione o deroga<br />
ai diritti enunciati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nei Patti Internazionali relativi<br />
ai Diritti Umani.<br />
DICHIARAZIONE SUL DIRITTO ALLO SVILUPPO<br />
(4 dicembre 1986)<br />
L’Assemblea Generale,<br />
Esaminata la questione del diritto allo sviluppo,<br />
ha convenuto di adottare la Dichiarazione sul Diritto allo Sviluppo enunciata nell’annesso alla<br />
presente risoluzione<br />
97ma seduta plenaria, 4 Dicembre 1986<br />
Annesso<br />
DICHIARAZIONE SUL DIRITTO ALLO SVILUPPO<br />
L’Assemblea Generale,<br />
Tenuto conto dei fini e dei principi dello Statuto delle Nazioni Unite relativi alla realizzazione della<br />
cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di ordine economico,<br />
sociale, culturale e umanitario e nella promozione e nell’incoraggiamento del rispetto dei diritti<br />
umani e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione;<br />
Consapevole del fatto che lo sviluppo costituisce un processo globale, economico, sociale, culturale<br />
e politico, mirante a migliorare incessantemente il benessere dell’insieme della popola-<br />
387
zione e di tutti gli individui, sulla base della loro partecipazione attiva, libera e significativa allo<br />
sviluppo, all’equa compartecipazione e ai benefici che ne derivano;<br />
omissis<br />
Consapevole dell’obbligo che lo Statuto impone agli Stati di promuovere il rispetto universale ed<br />
effettivo dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione alcuna, per ragioni<br />
di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, d’opinione politica o di altro genere, di<br />
origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione;<br />
omissis<br />
Articolo 1<br />
1. Il diritto allo sviluppo è un diritto inalienabile dell’uomo in virtù del quale ogni persona umana<br />
e tutti i popoli hanno il diritto di partecipare e di contribuire ad uno sviluppo economico, sociale,<br />
culturale e politico, in cui tutti i diritti dell’uomo e tutte le libertà fondamentali possano venire<br />
pienamente realizzati, e beneficiare di tale sviluppo.<br />
2. Il diritto dell’uomo allo sviluppo presuppone altresì la piena realizzazione del diritto dei popoli<br />
all’autodeterminazione, che comprende, previa riserva delle disposizioni pertinenti dei due Patti<br />
Internazionali relativi ai Diritti Umani, l’esercizio del loro diritto inalienabile alla piena sovranità<br />
su ogni loro ricchezza e risorsa naturale.<br />
omissis<br />
Articolo 5<br />
Gli Stati adotteranno misure decisive per eliminare le violazioni massicce e flagranti dei diritti<br />
fondamentali dei popoli e degli esseri umani sperimentate nel contesto di situazioni quali quelle<br />
derivanti dall’apartheid, da ogni forma di razzismo e di discriminazione razziale, dal colonialismo,<br />
dal dominio e dall’occupazione straniera e da minacce contro la sovranità nazionale,<br />
l’unità nazionale e l’integrità territoriale, dalla minaccia di guerra nonché dal rifiuto di riconoscere<br />
il diritto fondamentale dei popoli all’autodeterminazione.<br />
Articolo 6<br />
1. Tutti gli Stati devono collaborare al fine di promuovere, di incoraggiare e di rafforzare il rispetto<br />
universale ed effettivo di tutti i diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione<br />
di razza, di sesso, di lingua o di religione.<br />
2. Gli Stati debbono prendere misure per eliminare gli ostacoli allo sviluppo derivanti dal non rispetto<br />
dei diritti civili e politici, nonché dei diritti economici, sociali e culturali.<br />
omissis<br />
CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUI <strong>DIRITTI</strong> DELL’INFANZIA<br />
Approvata dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata<br />
dall’Italia con legge del 27 maggio 1991 n. 176 depositata presso le Nazioni Unite il 5 settembre<br />
1991<br />
Preambolo<br />
Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento<br />
della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l’uguaglianza e il<br />
carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace<br />
nel mondo,<br />
Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la loro fede nei diritti<br />
fondamentali dell’uomo e nella dignità e nel valore della persona umana e hanno risolto di<br />
favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,<br />
388
Riconoscendo che le Nazioni Unite nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e nei<br />
Patti internazionali relativi ai Diritti dell’Uomo hanno proclamato e hanno convenuto che ciascuno<br />
può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di<br />
sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di<br />
ogni opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,<br />
omissis<br />
Articolo 2 (identità)<br />
1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli<br />
a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere<br />
da ogni considerazione di razza, di colore, si sesso, di lingua, di religione, di opinione<br />
politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale,<br />
etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da<br />
ogni altra circostanza.<br />
2. Gli Stati Parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente<br />
tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale,<br />
dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o<br />
dei suoi familiari.<br />
omissis<br />
Articolo 29 (Educazione)<br />
1. Gli Stati parti convengono che l’educazione del fanciullo deve avere come finalità:<br />
omissis<br />
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito<br />
di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli<br />
e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona;<br />
omissis<br />
Articolo 30 (identità)<br />
1. Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine<br />
autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere<br />
privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione<br />
o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.<br />
omissis<br />
CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULLA PROTEZIONE DEI <strong>DIRITTI</strong> DI TUTTI I LAVO-<br />
RATORI MIGRANTI E DEI MEMBRI DELLE LORO FAMIGLIE<br />
(18 dicembre 1990)<br />
Preambolo<br />
Gli Stati aderenti alla presente Convenzione,<br />
Tenendo conto dei principi contenuti nei documenti fondamentali delle Nazioni Unite relativi ai<br />
diritti umani, in particolare la Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo, la Convenzione internazionale<br />
sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione internazionale sui diritti civili<br />
e politici, la Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione<br />
razziale, la Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione<br />
contro le donne e la Convenzione sui diritti del bambino,<br />
389
omissis<br />
Parte II<br />
Non – discriminazione in materia di diritti<br />
Articolo 7<br />
Gli Stati membri si impegnano, in accordo con i documenti internazionali relativi ai diritti umani,<br />
a rispettare e ad assicurare a tutti i lavoratori migranti e ai membri delle loro famiglie nell’ambito<br />
del loro territorio o soggetti alla loro giurisdizione i diritti previsti nella presente Convenzione<br />
senza alcuna distinzione di sorta rispetto a sesso, razza, colore, lingua, religione o convinzione,<br />
opinione politica o di altro tipo, origine nazionale, etnica o sociale, nazionalità, età, condizione<br />
economica, proprietà, stato civile, nascita o altro stato giuridico.<br />
omissis<br />
DICHIARAZIONE SUI <strong>DIRITTI</strong> DELLE PERSONE APPARTENENTI ALLE MINORANZE NA-<br />
ZIONALI O ETNICHE, RELIGIOSE E LINGUISTICHE<br />
(Approvata dall’Assemblea Generale con Risoluzione 47035 del 18 dicembre 1992)<br />
L’Assemblea generale,<br />
Ribadendo che uno degli scopi fondamentali delle Nazioni Unite, quali proclamati nella sua Carta,<br />
è di promuovere e incoraggiare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti,<br />
senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione,<br />
Riaffermando la fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità della persona umana, negli eguali<br />
diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole,<br />
Desiderando promuovere la realizzazione dei principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite,<br />
nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, nella Convenzione sulla prevenzione e la<br />
punizione del crimine di genocidio, nella Convenzione internazionale sulla eliminazione di ogni<br />
forma di discriminazione razziale, nel Patto internazionale sui diritti civili e politici, nel Patto internazionale<br />
sui diritti economici, sociali e culturali, nella Dichiarazione sulla eliminazione di ogni<br />
forma di intolleranza e discriminazione basata sulla religione o la fede, e nella Convenzione sui<br />
diritti del bambino, nonché negli altri pertinenti strumenti internazionali che sono stati adottati sul<br />
piano universale o regionale e in quelli stipulati tra singoli Stati membri e le Nazioni Unite,<br />
Ispirandosi alle previsioni dell’articolo 27 del Patto internazionale sui diritti civili e politici riguardanti<br />
i diritti delle persone appartenenti a minoranza etnica religiosa o linguistica,<br />
Considerando che la promozione e la protezione dei diritti delle persone appartenenti a minoranza<br />
nazionale o etnica, religiosa e linguistica contribuiscono alla stabilità politica e sociale degli<br />
Stati in cui esse vivono,<br />
Sottolineando che la costante promozione e realizzazione dei diritti delle persone appartenenti<br />
a minoranza nazionale o etnica, religiosa e linguistica, come parte integrante dello sviluppo della<br />
società nel suo insieme e in un contesto democratico basato sullo stato di diritto, è tale da<br />
contribuire al rafforzamento dell’amicizia e della cooperazione tra i popoli e tra gli Stati,<br />
Considerando che le Nazioni Unite hanno un importante ruolo da svolgere riguardo alla protezione<br />
delle minoranze,<br />
Ricordando il lavoro fin qui svolto nel sistema delle Nazioni Unite, in particolare dalla Commissione<br />
dei diritti dell’uomo, dalla sottocommissione sulla prevenzione della discriminazione e la<br />
protezione delle minoranze e dagli organismi stabiliti ai sensi dei Patti internazionali sui diritti<br />
umani e dagli altri strumenti internazionali sui diritti umani nel promuovere e proteggere i diritti<br />
delle persone appartenenti a minoranza nazionale o etnica, religiosa e linguistica,<br />
Tenendo in considerazione l’importante lavoro che è realizzato da organizzazioni intergovernative<br />
e non-governative nel proteggere le minoranze e nel promuovere e proteggere i diritti delle<br />
persone appartenenti a minoranza nazionale o etnica, religiosa e linguistica,<br />
Riconoscendo la necessità di garantire una più effettiva realizzazione degli strumenti internazionali<br />
avuto riguardo ai diritti delle persone appartenenti a minoranza nazionale o etnica, religiosa<br />
e linguistica,<br />
390
Proclama questa Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranza nazionale o<br />
etnica, religiosa e linguistica:<br />
Articolo 1<br />
1. Gli Stati proteggeranno l’esistenza e l’identità nazionale o etnica, culturale, religiosa e linguistica<br />
delle minoranze all’interno dei rispettivi territori e favoriranno le condizioni per la promozione<br />
di tale identità.<br />
2. Gli Stati adotteranno idonee misure legislative ed altre allo scopo di conseguire questi obiettivi.<br />
Articolo 2<br />
1. Le persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche (d’ora in<br />
avanti chiamate persone appartenenti a minoranza) hanno il diritto di beneficiare della loro cultura,<br />
di professare e praticare la loro religione e di usare il loro linguaggio, in privato e in pubblico,<br />
liberamente e senza interferenza o qualsiasi altra forma di discriminazione.<br />
2. Le persone appartenenti a minoranza hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita<br />
culturale, religiosa, sociale, economica e pubblica.<br />
3. Le persone appartenenti a minoranza hanno il diritto di partecipare effettivamente alla presa<br />
delle decisioni sul piano nazionale e, ove opportuno, sul piano regionale quando riguardino la<br />
minoranza alla quale esse appartengono o le regioni in cui esse vivono, in maniera non incompatibile<br />
con la legislazione nazionale.<br />
4. Le persone appartenenti a minoranza hanno il diritto di costituire e mantenere proprie associazioni.<br />
5. Le persone appartenenti a minoranza hanno il diritto di costituire e mantenere, senza alcuna<br />
discriminazione, contatti liberi e pacifici con altri membri di altri gruppi e con persone appartenenti<br />
ad altre minoranze, nonché contatti al di là dei confini con cittadini di altri Stati ai quali esse<br />
siano collegate da legami nazionali o etnici, religiosi o linguistici.<br />
Articolo 3<br />
1. Le persone appartenenti a minoranza possono esercitare i loro diritti, compresi quelli enunciati<br />
nella presente Dichiarazione, sia individualmente sia in comunità con gli altri membri del<br />
proprio gruppo, senza discriminazione alcuna.<br />
2. Nessuno svantaggio dovrà risultare per qualsiasi persona appartenente a minoranza come<br />
conseguenza dell’esercizio o del non esercizio dei diritti enunciati nella presente Dichiarazione.<br />
Articolo 4<br />
1. Gli Stati adotteranno misure, ove necessario, per assicurare che le persone appartenenti a<br />
minoranza possano esercitare pienamente ed effettivamente tutti i loro diritti umani e libertà<br />
fondamentali senza alcuna discriminazione e in piena eguaglianza davanti alla legge.<br />
2. Gli Stati adotteranno misure allo scopo di creare condizioni favorevoli a far sì che le persone<br />
appartenenti a minoranza possano esprimere le proprie caratteristiche e sviluppare la loro cultura,<br />
lingua, religione, tradizioni, tranne quando specifiche pratiche sono in violazione della legge<br />
nazionale e contrarie agli standard internazionali.<br />
3. Gli Stati adotteranno appropriate misure in modo che, quando possibile, le persone appartenenti<br />
a minoranza abbiano adeguate possibilità di apprendere la loro madrelingua o di essere<br />
istruite nella loro madrelingua.<br />
4. Gli Stati, ove necessario, adotteranno misure nel campo dell’educazione, al fine di incoraggiare<br />
la conoscenza della storia, delle tradizioni, della lingua e della cultura delle minoranze esistenti<br />
nel proprio territorio. Le persone appartenenti a minoranza dovranno avere adeguate<br />
possibilità di acquisire la conoscenza della società nel suo insieme.<br />
5. Gli Stati prenderanno in considerazione appropriate misure in modo che le persone appartenenti<br />
a minoranza possano partecipare pienamente al progresso economico e allo sviluppo nel<br />
proprio paese.<br />
Omissis<br />
391
DICHIARAZIONE DI VIENNA E PROGRAMMA D’AZIONE<br />
(Conferenza Mondiale sui Diritti Umani, Vienna, 14-25 giugno 1993)<br />
La Conferenza Mondiale sui diritti umani,<br />
Considerando che la promozione e la protezione dei diritti umani è un problema prioritario per la<br />
comunità internazionale, e che la Conferenza offre un’opportunità unica di condurre a termine<br />
un’analisi globale del sistema internazionale dei diritti umani e del meccanismo per la protezione<br />
dei diritti umani, al fine di accrescere e quindi promuovere una piena osservanza di questi<br />
diritti, in un modo giusto ed equilibrato;<br />
omissis<br />
Sottolineando le responsabilità di tutti gli Stati, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite,<br />
nello sviluppare ed incoraggiare il rispetto dei diritti umani e delle fondamentali libertà per tutti,<br />
senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.<br />
omissis<br />
Adottiamo solennemente la Dichiarazione di Vienna e il Programma d’azione.<br />
Parte I<br />
omissis<br />
1. La Conferenza Mondiale sui diritti umani riafferma il solenne impegno di tutti gli Stati di assolvere<br />
i loro obblighi per promuovere l’universale rispetto, l’osservanza e la protezione di tutti i diritti<br />
umani e le libertà fondamentali per tutti, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, gli<br />
altri strumenti internazionali relativi ai diritti umani e al diritto internazionale. La natura universale<br />
di tali diritti e libertà è al di là di ogni questione.<br />
omissis<br />
I diritti umani e le libertà fondamentali sono i diritti innati di tutti gli esseri umani; la loro protezione<br />
e promozione è la principale responsabilità dei governi.<br />
omissis<br />
15. Il rispetto per i diritti umani e le libertà fondamentali senza alcuna distinzione è una regola<br />
fondamentale del diritto internazionale dei diritti umani. L’immediata e completa eliminazione di<br />
tutte le forme di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza è un obiettivo<br />
prioritario della comunità internazionale. I governi dovrebbero assumere effettive misure per<br />
prevenire e combattere tali fenomeni. E’ urgente che i gruppi, le istituzioni, le organizzazioni intergovernative<br />
e non-governative, gli individui intensifichino i loro sforzi nella cooperazione e nel<br />
coordinamento delle proprie attività contro questi mali.<br />
omissis<br />
19. Considerando l’importanza della promozione e protezione dei diritti delle persone che fanno<br />
parte di minoranze e il contributo che questa protezione e promozione può dare alla stabilità politica<br />
e sociale degli Stati nei quali queste persone vivono, la Conferenza Mondiale sui diritti<br />
umani riafferma il dovere degli Stati di assicurare che gli appartenenti a minoranze possano esercitare<br />
pienamente e effettivamente tutti i diritti umani e le libertà fondamentali senza alcuna<br />
discriminazione e secondo il principio di uguaglianza davanti alla legge, secondo quanto dispone<br />
la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali<br />
o etniche, religiose o linguistiche.<br />
392
Le persone appartenenti a minoranze hanno il diritto di godere della propria cultura, di professare<br />
e praticare la propria religione e di usare la propria lingua sia in privato che in pubblico liberamente<br />
e senza interferenze od ogni altra forma di discriminazione.<br />
omissis<br />
30. La Conferenza Mondiale sui diritti umani esprime anche la propria costernazione e condanna<br />
per il fatto che gravi e sistematiche violazioni e situazioni che costituiscono serio ostacolo al<br />
pieno godimento di tutti i diritti umani continuano a verificarsi in diverse parti del mondo. Tali<br />
violazioni ed ostacoli includono la tortura e i trattamenti o le punizioni crudeli, disumani e degradanti,<br />
le esecuzioni sommarie ed arbitrarie, le sparizioni, le detenzioni arbitrarie, tutte le forme di<br />
razzismo, discriminazione razziale ed apartheid, di occupazione e dominazione straniera, di xenofobia,<br />
povertà, fame e altre forme di negazione dei diritti economici, sociali e culturali, di intolleranza<br />
religiosa, di terrorismo, di discriminazione contro le donne e di mancanza delle garanzie<br />
dello stato di diritto.<br />
omissis<br />
33. La Conferenza Mondiale sui diritti umani ribadisce che gli Stati sono tenuti, come stipulato<br />
nella Dichiarazione universale dei diritti umani e nel Patto internazionale sui diritti economici,<br />
sociali e culturali ed in altri strumenti internazionali sui diritti umani, ad assicurare che<br />
l’istruzione sia diretta a rafforzare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. La Conferenza<br />
Mondiale sui diritti umani sottolinea l’importanza di incorporare nei programmi educativi<br />
l’argomento dei diritti umani, e rivolge un appello agli Stati affinché lo si faccia. L’educazione<br />
dovrebbe favorire la comprensione, la tolleranza, la pace e le relazioni amichevoli tra le nazioni<br />
e tutti i gruppi razziali o religiosi ed incoraggiare lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite al<br />
fine di perseguire tali obiettivi. Per questo l’educazione ai diritti umani e la diffusione di informazioni<br />
corrette, sia teoriche che pratiche, giocano un ruolo fondamentale nella promozione e nel<br />
rispetto dei diritti umani per tutti gli individui, senza distinzione di alcun tipo come la razza, il<br />
sesso, la lingua o la religione e questa dovrebbe essere integrata nelle politiche per<br />
l’educazione sia a livello nazionale che internazionale. La Conferenza Mondiale sui diritti umani<br />
nota come la mancanza di fondi e l’inadeguatezza delle istituzioni possa impedire l’immediata<br />
realizzazione di questi obiettivi.<br />
omissis<br />
Parte II<br />
omissis<br />
B. Uguaglianza, dignità e tolleranza.<br />
1. Razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e altre forme di intolleranza.<br />
19. La Conferenza Mondiale sui diritti umani considera l’eliminazione del razzismo e della discriminazione<br />
razziale, in particolare nelle loro forme istituzionalizzate come l’apartheid, le dottrine<br />
sulla superiorità e l’esclusività razziale o le attuali forme e manifestazioni di razzismo, un<br />
obiettivo primario per la comunità internazionale e per un programma mondiale di promozione<br />
nel settore dei diritti umani. Gli organi delle Nazioni Unite e le agenzie dovrebbero aumentare gli<br />
sforzi per attuare tale programma d’azione, riferita al terzo decennio per combattere il razzismo<br />
e la discriminazione razziale, come pure i successivi mandati per la stesso fine. La Conferenza<br />
Mondiale sui diritti umani rivolge con forza un appello alla comunità internazionale, perché generosamente<br />
contribuisca al Fondo Fiduciario per il programma del decennio per combattere il<br />
razzismo e la discriminazione razziale.<br />
20. La Conferenza Mondiale sui diritti umani fa pressione su tutti i Governi, affinché prendano<br />
immediate misure e sviluppino politiche forti per prevenire e combattere tutte le forme e le manifestazioni<br />
di razzismo, xenofobia o intolleranza, dove necessario, per mezzo della promulgazione<br />
di una legislazione appropriata che includa sanzioni penali e per mezzo della costituzione di<br />
istituzioni nazionali volte a combattere tali fenomeni.<br />
393
omissis<br />
22. La Conferenza Mondiale sui diritti umani si appella a tutti i Governi, affinché prendano misure<br />
appropriate, in conformità agli obblighi internazionali e col dovuto rispetto dei propri sistemi<br />
giuridici, per contrastare l’intolleranza e la violenza ad essa connessa, basata sulla religione o<br />
sul credo, comprese le pratiche di discriminazione contro le donne, la profanazione dei luoghi<br />
sacri, riconoscendo che ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, coscienza, espressione<br />
e religione. La Conferenza invita anche tutti gli Stati a mettere in pratica le clausole della Dichiarazione<br />
sull’eliminazione di tutte le forme di intolleranza e discriminazione basate sulla religione<br />
a sul credo.<br />
omissis<br />
2. Persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche<br />
25. La Conferenza Mondiale sui diritti umani rivolge un appello alla Commissione per i diritti<br />
umani, affinché esamini modi e mezzi per promuovere e tutelare efficacemente i diritti delle persone<br />
che appartengono alle minoranze, come espresso nella Dichiarazione sui diritti delle persone<br />
appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche. In questo contesto la<br />
Conferenza Mondiale sui diritti umani fa appello al Centro per i diritti umani perché fornisca, su<br />
richiesta dei governi interessati e quale parte del suo programma di servizi di consulenza e assistenza<br />
tecnica, esperti qualificati sulle questioni delle minoranze e dei diritti umani, così come<br />
sulla prevenzione e risoluzione delle controversie, affinché essi diano assistenza in situazioni<br />
esistenti o potenziali che coinvolgono le minoranze.<br />
26. La Conferenza Mondiale sui diritti umani sollecita gli Stati e la comunità internazionale a<br />
promuovere e proteggere i diritti di persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose<br />
e linguistiche in accordo con la Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze<br />
nazionali o etniche, religiose e linguistiche.<br />
27. Le misure da prendersi, ove richiesto, dovrebbero includere facilitazioni per la piena partecipazione<br />
delle minoranze a tutti gli aspetti della vita politica, economica, sociale, religiosa e culturale<br />
della società e per il progresso economico e lo sviluppo del loro paese”.<br />
omissis<br />
ISTITUZIONI NAZIONALI PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEI <strong>DIRITTI</strong> <strong>UMANI</strong><br />
(Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 20 dicembre 1993)<br />
L’Assemblea Generale,<br />
Richiamando le pertinenti risoluzioni concernenti le istituzioni nazionali per la protezione e la<br />
promozione dei diritti umani, particolarmente le sue risoluzioni 41/129 del 4 dicembre 1986 e<br />
46/124 del 17 dicembre 1991 e le risoluzioni della Commissione per i diritti umani 1987/40 del<br />
10 marzo 1987, 1988/72 del 10 marzo 1988, 1989/52 del 7 marzo 1989, 1990/73 del 7 marzo<br />
1990, 1991/27 del 5 marzo 1991 e 1992/54 del 3 marzo 1992, prendendo nota della risoluzione<br />
della Commissione 1993/55 del 9 marzo 1993,<br />
omissis<br />
(g) Pubblicizzare i diritti umani e gli sforzi per combattere tutte le forme di discriminazione, in<br />
particolare la discriminazione razziale, incrementando la consapevolezza collettiva, specialmente<br />
attraverso l’informazione e l’educazione e facendo uso di tutti gli organi di stampa.<br />
omissis<br />
(g) In considerazione del ruolo fondamentale svolto dalle organizzazioni non governative<br />
nell’espandere l’operato delle istituzioni nazionali, svilupperà relazioni con tali organizzazioni,<br />
impegnate della promozione e nella protezione dei diritti umani, nello sviluppo sociale ed eco-<br />
394
nomico, nella lotta contro il razzismo, nella protezione di gruppi particolarmente vulnerabili<br />
(specialmente bambini, lavoratori migranti, rifugiati, persone sofferenti fisicamente e mentalmente)<br />
o in particolari aree.<br />
omissis<br />
PROGETTO DI DICHIARAZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI <strong>DIRITTI</strong> DELLE POPOLAZIO-<br />
NI INDIGENE (1994)<br />
Affermando che i popoli indigeni sono uguali per dignità e diritti a tutti gli altri popoli, riconoscendo<br />
inoltre il diritto di tutti gli individui e popoli ad essere differenti, a considerare se stessi<br />
differenti, e ad essere rispettati come tali,<br />
omissis<br />
Ribadendo che tutte le dottrine, le politiche e le pratiche basate sul razzismo e sulla superiorità<br />
razziale, religiosa, etnica o culturale sono scientificamente false, giuridicamente infondate, moralmente<br />
condannabili e socialmente ingiuste,<br />
Affermando ancora che i popoli indigeni, nell’esercizio dei propri diritti, devono essere liberi dalla<br />
discriminazione di ogni genere,<br />
omissis<br />
Accogliendo con favore il fatto che i popoli indigeni si organizzino per promuovere la loro crescita<br />
politica, sociale, economica e culturale e per porre fine a tutte le forme di discriminazione ed<br />
oppressione laddove esse si verifichino,<br />
omissis<br />
Parte I<br />
omissis<br />
Articolo 2<br />
Gli individui e i popoli indigeni sono liberi e uguali per dignità e diritti a tutti gli altri individui e popoli<br />
ed hanno il diritto di essere liberi da ogni genere di discriminazione, in particolare quella basata<br />
sulla loro origine o identità indigena.<br />
omissis<br />
Parte II<br />
omissis<br />
Articolo 9<br />
I popoli e gli individui indigeni hanno il diritto di appartenere ad una comunità o ad una nazione<br />
indigena, nel rispetto delle tradizioni e dei costumi della comunità o nazione interessata.<br />
Dall’esercizio di tale diritto no può derivare alcuno svantaggio.<br />
Parte III<br />
Articolo 12<br />
I popoli indigeni hanno il diritto di praticare e far rivivere le proprie tradizioni culturali. Ciò include<br />
il diritto a mantenere, proteggere e sviluppare le manifestazioni passate, presenti e future delle<br />
loro culture, quali siti archeologici e storici, manufatti, modelli, cerimonie, tecnologie, arti visive e<br />
rappresentative e le letterature, così come il diritto alla restituzione della proprietà culturale, in-<br />
395
tellettuale, religiosa e spirituale sottratta senza il loro consenso libero ed informato o in violazione<br />
alle loro leggi, usi e tradizioni.<br />
Articolo 13<br />
I popoli indigeni hanno il diritto di manifestare, praticare ed insegnare le proprie tradizioni spirituali<br />
e religiose, i loro usi e cerimonie; hanno il diritto di mantenere, proteggere, ed avere accesso<br />
in privato ai propri siti religiosi e culturali; il diritto all’uso e al controllo degli oggetti cerimoniali;<br />
e il diritto al rimpatrio di resti umani.<br />
Gli Stati adotteranno misure concrete, in collegamento con i popoli indigeni interessati, per assicurare<br />
che i luoghi sacri indigeni, incluse le sedi sepolcrali, siano preservati, rispettati e protetti”.<br />
omissis<br />
Parte IV<br />
omissis<br />
Articolo 16<br />
I popoli indigeni hanno diritto a che la dignità e la diversità delle loro culture, tradizioni, storie ed<br />
aspirazioni si riflettano adeguatamente in tutte le forme di istruzione e di informazione pubblica.<br />
Gli Stati adotteranno misure concrete, in consultazione con i popoli indigeni interessati, per eliminare<br />
il pregiudizio e la discriminazione e promuovere la tolleranza, la comprensione e le buone<br />
relazioni tra i popoli indigeni e tutti i segmenti della società.<br />
omissis<br />
Parte VI<br />
omissis<br />
Articolo 30<br />
I popoli indigeni hanno il diritto di definire ed elaborare priorità e strategie per lo sviluppo o<br />
l’utilizzo delle loro terre, territori e risorse, incluso il diritto di esigere che gli Stati ottengano il loro<br />
libero ed informato consenso prima dell’avvio di qualsiasi progetto sulle loro terre, territori e risorse,<br />
particolarmente in connessione con lo sviluppo, l’utilizzo o lo sfruttamento delle risorse<br />
minerarie, acquifere o altre. Nella ricerca di un accordo con i popoli indigeni in questione, si<br />
provvederà ad una giusta ed adeguata compensazione per qualsiasi attività o misura presa per<br />
contenere l’impatto ambientale, economico, sociale, culturale o spirituale negativo.<br />
Parte VII<br />
Articolo 31<br />
I popoli indigeni, come forma specifica di esercizio del loro diritto di autodeterminazione, hanno<br />
il diritto all’autonomia e all’autogoverno nelle materie relative ai loro affari interni e locali, includendo<br />
cultura, religione, educazione, informazione, media, salute, alloggio, impiego, welfare,<br />
attività economiche, gestione della terra e delle risorse, ambiente ed accesso da parte di soggetti<br />
esterni, nonché in materia di procedure e strumenti di finanziamento di tali funzioni autonome.<br />
omissis<br />
Articolo 35<br />
I popoli indigeni, in particolare quelli divisi da frontiere internazionali, hanno il diritto di mantenere<br />
e sviluppare contatti, relazioni e cooperazione, incluse le attività di interesse spirituale, culturale,<br />
politico, economico e sociale, con altre popolazioni al di là dei confini.<br />
Gli Stati adottano misure concrete per assicurare l’esercizio e l’attuazione di questo diritto.<br />
396
omissis<br />
Articolo 38<br />
I popoli indigeni hanno diritto ad accedere ad un’adeguata assistenza finanziaria e tecnica, da<br />
parte degli Stati e attraverso la cooperazione internazionale, per perseguire liberamente il loro<br />
sviluppo politico, economico, sociale, culturale e spirituale, e per il godimento dei diritti e delle<br />
libertà riconosciute in questa Dichiarazione.<br />
omissis<br />
DECENNIO PER L’EDUCAZIONE AI <strong>DIRITTI</strong> <strong>UMANI</strong><br />
(14 dicembre 1994)<br />
L’Assemblea Generale,<br />
Guidata dai principi fondamentali e universali enunciati nella Carta delle Nazioni Unite e nella<br />
Dichiarazione universale dei diritti umani;<br />
omissis<br />
Convinta inoltre che l’educazione ai diritti umani è l’elemento costituivo di una concezione dello<br />
sviluppo rispettoso della dignità delle donne e degli uomini di ogni età, con particolare riguardo<br />
a gruppi sociali quali bambini, popoli indigeni, minoranze e disabili;<br />
omissis<br />
2. Proclama, a partire dal 1° gennaio 1995, il Decennio delle Nazioni Unite per l’educazione ai<br />
diritti umani;<br />
3. Adotta il Piano d’Azione per il Decennio delle Nazioni Unite per l’educazione ai diritti umani,<br />
1995-2005, così come illustrato nel rapporto del Segretario Generale, e invita i governi a formulare<br />
proprie considerazioni allo scopo di fornire contributi al Piano d’azione per il Decennio;<br />
4. Invita il Segretario Generale ad avanzare proposte, alla luce delle osservazioni espresse dai<br />
governi, per le finalità indicate al paragrafo precedente;<br />
5. Fa appello a tutti i governi affinché contribuiscano all’attuazione del Piano d’azione e assumano<br />
iniziative per sradicare l’analfabetismo e orientare l’educazione al pieno sviluppo della<br />
personalità umana e al rafforzamento della tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali;<br />
omissis<br />
DICHIARAZIONE SUL DIRITTO E LA RESPONSABILITA’ DEGLI INDIVIDUI, DEI GRUPPI E<br />
DEGLI ORGANI DELLA SOCIETA’ DI PROMUOVERE E PROTEGGERE LE LIBERTA’<br />
FONDAMENTALI E I <strong>DIRITTI</strong> <strong>UMANI</strong> UNIVERSALMENTE RICONOSCIUTI<br />
(8 marzo 1999)<br />
L’Assemblea Generale, riaffermando l’importanza dell’osservanza dei fini e dei princìpi della<br />
Carta delle Nazioni Unite per la promozione e la protezione di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali<br />
per tutti, in tutti i paesi del mondo, riaffermando inoltre l’importanza della Dichiarazione<br />
Universale dei diritti umani e dei Patti Internazionali sui diritti umani quali elementi portanti<br />
dell’impegno internazionale per promuovere il rispetto e l’osservanza universale dei diritti umani<br />
e delle libertà fondamentali e l’importanza degli altri strumenti per i diritti umani adottati<br />
all’interno del sistema delle Nazioni Unite, così come di quelli adottati a livello regionale, sottolineando<br />
che tutti i membri della comunità internazionale devono adempiere, insieme e separatamente,<br />
l’obbligo solenne di promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti umani e delle libertà<br />
fondamentali per tutti senza distinzioni di sorta, incluse quelle fondate sulla razza, sul colore,<br />
sul sesso, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o su di altro genere, sull’origine<br />
397
nazionale o sociale, sulla proprietà, sulla nascita o su altro status, e riaffermando la particolare<br />
importanza di una effettiva cooperazione internazionale per adempiere tale obbligo secondo<br />
quanto previsto dalla Carta delle Nazioni Unite, riconoscendo l’importante ruolo della cooperazione<br />
internazionale e l’apprezzabile lavoro di individui, gruppi e associazioni nel contribuire<br />
all’effettiva eliminazione di tutte le violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali dei popoli<br />
e degli individui, incluse le violazioni massicce, flagranti e sistematiche come quelle risultanti<br />
dall’apartheid, da tutte le forme di discriminazione razziale, dal colonialismo, dal dominio o<br />
dall’occupazione straniera; dall’aggressione o dalle minacce alla sovranità nazionale, all’unità<br />
nazionale o all’integrità territoriale, e dal rifiuto di riconoscere il diritto di autodeterminazione dei<br />
popoli ed il diritto di ogni popolo di esercitare la piena sovranità sulle proprie ricchezze e risorse<br />
naturali, riconoscendo la relazione tra la pace e la sicurezza internazionale e la possibilità di<br />
godere i diritti umani e le libertà fondamentali, e consapevoli del fatto che la mancanza di pace<br />
e sicurezza internazionale non giustifica l’inadempienza, ribadendo che tutti i diritti umani e le<br />
libertà fondamentali sono universali, indivisibili, interdipendenti e correlati e dovrebbero essere<br />
promossi ed attuati in maniera giusta ed equa, senza pregiudicare l’attuazione di ciascuno di tali<br />
diritti e libertà, sottolineando che la responsabilità e il dovere primario di promuovere i diritti umani<br />
e le libertà fondamentali risiede nello Stato, riconoscendo il diritto e la responsabilità degli<br />
individui, dei gruppi e delle associazioni di promuovere il rispetto e la conoscenza dei diritti umani<br />
e delle libertà fondamentali a livello nazionale e internazionale,<br />
Dichiara:<br />
omissis<br />
Articolo 12<br />
1. Tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di partecipare ad attività pacifiche<br />
contro le violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali.<br />
2. Lo Stato deve prendere tutte le misure necessarie per assicurare la protezione, da parte delle<br />
autorità competenti, di chiunque, individualmente ed in associazione con altri, contro violenze,<br />
minacce, ritorsioni, discriminazione vessatorie di fatto o di diritto, pressioni o altre azioni arbitrarie<br />
conseguenti al legittimo esercizio dei diritti di cui alla presente Dichiarazione.<br />
3. A questo riguardo, tutti hanno diritto, individualmente ed in associazione con altri, di essere<br />
protetti efficacemente dalla legislazione nazionale ove reagiscano o si oppongano, con mezzi<br />
pacifici, ad attività ad atti, incluse le omissioni, che, attribuibili allo Stato, provochino violazioni<br />
dei diritti umani e delle libertà fondamentali, così come ad atti di violenza perpetrati da gruppi o<br />
individui che influenzino il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali.<br />
omissis<br />
Articolo 16<br />
Gli individui, le organizzazioni non governative e le istituzioni competenti giocano un importante<br />
ruolo nel contribuire ad una maggiore consapevolezza pubblica delle questioni relative a tutti i<br />
diritti umani e le libertà fondamentali, attraverso attività quali l’educazione, la formazione e la<br />
ricerca in questi campi per rafforzare ulteriormente, tra l’altro, la comprensione, la tolleranza, la<br />
pace e le relazioni amichevoli tra le nazioni e tra tutti i gruppi razziali e religiosi, tenendo conto<br />
dei diversi contesti sociali e comunitari in cui svolgono le proprie attività.<br />
omissis<br />
398
DICHIARAZIONE PER UNA CULTURA DI PACE<br />
(13 settembre 1999)<br />
L’Assemblea Generale,<br />
omissis<br />
Riconoscendo la necessità di eliminare tutte le forme di discriminazione e intolleranza, comprese<br />
quelle basate su razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altro<br />
genere, nazionalità, origine etnica o sociale, proprietà, disabilità, nascita o altra condizione,<br />
omissis<br />
Articolo 1<br />
Una cultura di pace è un insieme di valori, attitudini, tradizioni e modi di comportamento e sistemi<br />
di vita basati:<br />
omissis<br />
g. sul rispetto e sulla promozione dell’uguaglianza di diritti e opportunità per donne e uomini;<br />
omissis<br />
i. sull’adesione ai principi di libertà, giustizia, democrazia, tolleranza, solidarietà, cooperazione,<br />
pluralismo, diversità culturale, dialogo e comprensione a tutti i livelli della società, e<br />
fra le nazioni;<br />
omissis<br />
Articolo 3<br />
Il pieno sviluppo di una cultura di pace è totalmente legato:<br />
omissis<br />
c. alla promozione della democrazia, dello sviluppo, del rispetto e della pratica universale di<br />
tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali;<br />
d. a mettere in grado le persone di ogni condizione di sviluppare capacità di dialogo, negoziazione,<br />
costruzione del consenso e risoluzione pacifica delle differenze;<br />
omissis<br />
l. all’eliminazione di tutte le forme di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e delle<br />
manifestazioni di intolleranza ad esse collegate;<br />
m. all’aumentare la comprensione, la tolleranza e la solidarietà fra tutte le civiltà, i popoli e le<br />
culture, comprendendo all’interno di questo processo anche le minoranze etniche, religiose<br />
linguistiche;<br />
omissis<br />
399
DICHIARAZIONE DEL MILLENNIO CINQUANTACINQUESIMA SESSIONE DELL’AS-<br />
SEMBLEA GENERALE<br />
(Settembre 2000 – Settembre 2001)<br />
L’Assemblea Generale<br />
Adotta la seguente Dichiarazione:<br />
Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite<br />
I. Valori e Principi<br />
1. Noi, capi di Stato e di <strong>Governo</strong>, ci siamo riuniti presso il Quartier Generale delle Nazioni<br />
Unite a New York dal 6 all’8 Settembre 2000, all’alba di un nuovo millennio, per riaffermare<br />
la nostra fede nell’Organizzazione e nel suo Statuto quali indispensabili fondamenta di<br />
un mondo più pacifico, prospero e giusto.<br />
2. Noi riconosciamo che, oltre alle nostre personali responsabilità verso le rispettive società<br />
di appartenenza, condividiamo una responsabilità collettiva nell’affermare i principi della<br />
dignità umana, dell’uguaglianza e dell’equità a livello globale. In qualità di leader, pertanto,<br />
abbiamo un dovere verso tutti i popoli del pianeta, specialmente quelli più vulnerabili e, in<br />
particolare, verso i bambini del mondo intero, ai quali appartiene il futuro.<br />
omissis<br />
4. Noi siamo determinati a costruire una pace giusta e duratura in tutto il mondo, in conformità<br />
con gli scopi e i principi dello Statuto. Per questo riconsacriamo noi stessi a favorire tutti gli<br />
sforzi tesi ad affermare la sovrana uguaglianza di tutti gli Stati, il rispetto della loro integrità<br />
territoriale e indipendenza politica, la soluzione delle controversie con mezzi pacifici e in<br />
conformità con i principi della giustizia e del diritto internazionale, il diritto<br />
all’autodeterminazione dei popoli che rimangono sotto il dominio coloniale e l’occupazione<br />
straniera, la non interferenza negli affari interni degli altri Stati, il rispetto per i diritti umani e<br />
le libertà fondamentali, il rispetto per l’uguaglianza di diritti di tutti senza distinzioni di razza,<br />
sesso, lingua o religione e per la cooperazione internazionale nel risolvere i problemi internazionali<br />
di carattere economico, sociale, culturale o umanitario.<br />
omissis<br />
V. Diritti umani, democrazia e buon governo<br />
omissis<br />
25. Noi decidiamo pertanto:<br />
omissis<br />
Di assumere provvedimenti per garantire il rispetto per i diritti umani dei migranti, e la loro<br />
protezione, dei lavoratori migranti e delle rispettive famiglie, per eliminare il crescente numero<br />
di atti di razzismo e xenofobia che si sta verificando in numerose società e per promuovere<br />
una maggiore armonia e tolleranza in tutte le società.<br />
omissis<br />
400
Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL)<br />
401
CONVENZIONE N. 107 SULLE POPOLAZIONI INDIGENE E TRIBALI<br />
(Convenzione concernente la protezione e l’integrazione delle popolazioni indigene, tribali<br />
e semitribali in Paesi indipendenti, adottata dall’Organizzazione Internazionale del<br />
Lavoro - OIL, il 26.06.1957)<br />
La Conferenza Generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro,<br />
Convocata a Ginevra dal Comitato esecutivo dell’OIL e qui riunita nella sua 40ma sessione il 5<br />
giugno 1957;<br />
Avendo deciso di adottare varie proposte in relazione alla tutela e integrazione delle popolazioni<br />
indigene e di altre popolazioni tribali e semitribali nei Paesi indipendenti, tema che costituisce il<br />
sesto punto all’ordine del giorno della sessione;<br />
Avendo determinato che queste proposte prenderanno la forma di una Convenzione Internazionale;<br />
Considerando che la Dichiarazione di Filadelfia afferma che tutti gli uomini hanno il diritto di<br />
perseguire sia il loro benessere materiale che quello spirituale in condizione di libertà e di dignità<br />
, di sicurezza economica e di uguale opportunità,<br />
Considerando che esistono in vari Paesi indipendenti, popolazioni tribali e semitribali che non<br />
sono ancora integrate nelle comunità nazionali e la cui situazione sociale, economica e culturale,<br />
impedisce di beneficiare appieno dei diritti e dei vantaggi di cui godono gli altri elementi della<br />
popolazione nazionale,<br />
Considerando desiderabile sia per motivi umanitari che per l’interesse delle Nazioni, promuovere<br />
continue iniziative per migliorare le condizioni di vita e di lavoro di queste popolazioni, agendo<br />
simultaneamente su tutti i fattori che hanno finora prevenuto dal condividere appieno il progresso<br />
nella Comunità Nazionale di cui fanno parte,<br />
Considerando che l’adozione di norme generali internazionali sulla materia, può facilitare<br />
l’azione di assicurare la protezione delle popolazioni interessate, la loro progressiva integrazione<br />
nelle loro rispettive Comunità Nazionali e il miglioramento delle loro condizioni di vita e di lavoro,<br />
Notando che queste regole sono state formulate con la cooperazione dell’ONU, della FAO,<br />
dell’UNESCO e dell’OMS ad appropriati livelli e nei loro rispettivi campi, si propone di chiedere<br />
la loro continua collaborazione nella promozione e nel controllo dell’applicazione di queste norme,<br />
Adotta il 26 giugno 1957 la seguente Convenzione denominata come la Convenzione sulle popolazioni<br />
indigene e tribali 1957”.<br />
Parte I<br />
omissis<br />
Articolo 3<br />
omissis<br />
3. Il godimento dei diritti generali di cittadinanza senza discriminazioni, non dovrà essere pregiudicato<br />
in nessun caso dalle speciali misure di protezione.<br />
omissis<br />
Articolo 10<br />
1. Le persone appartenenti alle popolazioni interessate dovranno godere di una tutela particolare<br />
contro il ricorso illegittimo alla detenzione preventiva e disporre di vie legali per garantire<br />
l’effettiva tutela dei loro diritti fondamentali.<br />
omissis<br />
403
CONVENZIONE N. 111 SULLA DISCRIMINAZIONE IN MATERIA DI IMPIEGO E DI PRO-<br />
FESSIONE<br />
(adottata il 28.06.1958)<br />
La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro,<br />
Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, ed<br />
ivi riunitasi il 4 giugno 1958, nella sua quarantaduesima sessione,<br />
Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla discriminazione in materia d’impiego e<br />
di professione, questione che costituisce il quarto punto all’ordine del giorno della sessione,<br />
Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale,<br />
Considerato che la Dichiarazione di Filadelfia afferma che tutti gli esseri umani, indipendentemente<br />
dalla razza, dalla fede, dal sesso, hanno diritto di perseguire il proprio progresso materiale<br />
e il proprio sviluppo spirituale in condizioni di libertà e di dignità, di sicurezza economica e<br />
con uguali possibilità,<br />
Considerato inoltre che la discriminazione costituisce una violazione dei diritti enunciati nella<br />
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo,<br />
Adotta oggi venticinque giugno millenovecentocinquantotto, la seguente convenzione, che sarà<br />
denominata Convenzione sulla discriminazione (impiego e professione), 1958.<br />
Articolo 1<br />
1. Ai fini della presente convenzione, il termine «discriminazione» comprende:<br />
a. ogni distinzione, esclusione o preferenza fondata sulla razza, il colore, il sesso, la religione,<br />
l’opinione politica, la discendenza nazionale o l’origine sociale, che ha per effetto di negare o di<br />
alterare l’uguaglianza di possibilità o di trattamento in materia d’impiego o di professione;<br />
omissis<br />
Articolo 2<br />
Ogni Stato membro per il quale la presente convenzione è in vigore s’impegna a formulare e ad<br />
applicare una politica nazionale tendente a promuovere, con metodi adatti alle circostanze e agli<br />
usi nazionali, l’uguaglianza di possibilità e di trattamento in materia d’impiego e di professione,<br />
al fine di eliminare qualsiasi discriminazione in questa materia.<br />
omissis<br />
Articolo 4<br />
Non sono considerate discriminazioni tutte le misure riguardanti una persona che sia legittimamente<br />
sospettata di dedicarsi ad una attività dannosa alla sicurezza dello Stato o che effettivamente<br />
svolga detta attività, purché essa abbia il diritto di ricorrere ad un organismo competente<br />
stabilito secondo la prassi nazionale.<br />
Articolo 5<br />
1. Le misure speciali di protezione o di assistenza previste nelle altre convenzioni o raccomandazioni<br />
adottate dalla Conferenza Internazionale del Lavoro non sono considerate discriminazioni.<br />
2. Ogni Stato membro, sentite le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori,<br />
se ne esistono, può definire non discriminatorie tutte le altre misure speciali tendenti a tener<br />
conto dei bisogni particolari di individui nei confronti dei quali è riconosciuta necessaria una protezione<br />
o una assistenza particolare per ragioni quali il sesso, l’età, l’invalidità, gli impegni di<br />
famiglia o il livello sociale o culturale.<br />
omissis<br />
404
CONVENZIONE N. 169 CONCERNENTE LE POPOLAZIONI INDIGENE E TRIBALI IN PAESI<br />
INDIPENDENTI<br />
(adottata il 27.06.1989)<br />
La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,<br />
Convocata a Ginevra dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e<br />
riunitasi il 7 giugno 1989 nella sua settantaseiesima sessione,<br />
Considerando le norme internazionali enunciate nella convenzione e nella raccomandazione del<br />
1957, riguardanti le popolazioni aborigene e tribali;<br />
Ricordando i termini della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, del Patto internazionale<br />
sui diritti economici, sociali e culturali, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, e dei numerosi<br />
strumenti internazionali sulla prevenzione della discriminazione;<br />
Considerando, alla luce dell'evoluzione del diritto internazionale posteriore al 1957, e dei mutamenti<br />
della situazione dei popoli indigeni e tribali, intervenuti in tutte le regioni del mondo, l'opportunità<br />
di adottare nuove norme internazionali in argomento, allo scopo di eliminare l'orientamento,<br />
mirante all'assimilazione, della precedente normativa;<br />
Prendendo atto dell'aspirazione dei popoli in questione al controllo delle istituzioni, dei modi di<br />
vita e di sviluppo economico loro propri, nonché alla conservazione e sviluppo della propria identità,<br />
della propria lingua e della propria religione, nell'ambito degli Stati in cui vivono;<br />
Considerando che, in molte parti del mondo, questi popoli non riescono a godere i diritti fondamentali<br />
dell'uomo nella stessa misura della restante popolazione degli Stati in cui vivono; e che<br />
le loro leggi, i loro valori, le loro consuetudini e le loro prospettive hanno di sovente subito un'erosione;<br />
Richiamando l'attenzione sul peculiare contributo dei popoli indigeni e tribali alla diversità culturale<br />
ed all'armonia sociale ed ecologica dell'umanità, come pure alla cooperazione ed alla comprensione<br />
internazionali;<br />
Considerando che le disposizioni seguenti sono state scritte con la collaborazione delle Nazioni<br />
Unite, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, dell'Organizzazione<br />
delle nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura, e dell'Organizzazione mondiale<br />
della sanità; come pure dell'Istituto Indigenista Interamericano, ai livelli confacenti e negli ambiti<br />
loro rispettivi, e che s'intende proseguire questa cooperazione al fine di promuoverne e<br />
d'assicurarne l'applicazione;<br />
Avendo deciso l'adozione di diverse mozioni riguardanti la parziale revisione della convenzione<br />
(n. 107) riguardante le popolazioni aborigene e tribali, questione costituente il quarto punto all'ordine<br />
del giorno della sessione;<br />
Avendo deciso che tali mozioni prenderanno la forma di una convenzione internazionale modificante<br />
la convenzione sulle popolazioni aborigene e tribali del 1957,<br />
Adotta in questo giorno ventisette del mese di giugno del millenovecentottantanove, la seguente<br />
convenzione, che sarà denominata Convenzione del 1989 relativa ai popoli indigeni e tribali.<br />
Parte I<br />
omissis<br />
Articolo 2<br />
1. È compito dei governi, con la partecipazione dei popoli interessati, sviluppare un'azione coordinata<br />
e sistematica finalizzata alla tutela dei diritti di questi popoli ed alla garanzia del rispetto<br />
della loro integrità.<br />
2. Questa azione deve comprendere misure miranti:<br />
a) ad assicurare che i membri di detti popoli beneficino, su un piano di uguaglianza, dei diritti e<br />
delle opportunità che la legislazione nazionale accorda agli altri componenti della popolazione;<br />
b) a promuovere la piena realizzazione dei diritti sociali, economici e culturali di questi popoli,<br />
nel rispetto della loro identità sociale e culturale, delle loro consuetudini e tradizioni e delle loro<br />
istituzioni;<br />
c) ad aiutare i membri di detti popoli ad eliminare gli svantaggi socio-economici che possono<br />
esservi fra componenti indigeni ed altri componenti della comunità nazionale, in modo compatibile<br />
con le loro aspirazioni ed il loro modo di vivere.<br />
405
Articolo 3<br />
1. I popoli indigeni e tribali devono godere pienamente dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,<br />
senza limiti né discriminazioni. Le disposizioni di questa convenzione devono essere<br />
applicate senza discriminazioni ad uomini e donne di questi popoli.<br />
2. Non si deve utilizzare alcuna forma di violenza e coercizione in violazione dei diritti dell'uomo<br />
e delle libertà fondamentali dei popoli interessati, ivi compresi i diritti previsti dalla presente convenzione.<br />
omissis<br />
Articolo 5<br />
1. Nell'applicare le disposizioni della presente convenzione, si dovrà:<br />
a) riconoscere e tutelare i valori e le usanze sociali, culturali, religiosi e spirituali di questi popoli<br />
e tenere nella dovuta considerazione la natura dei problemi con cui essi si confrontano, sia collettivamente<br />
che individualmente;<br />
b) rispettare l'integrità dei valori, delle usanze e delle istituzioni di questi popoli;<br />
omissis<br />
Articolo 13<br />
1. Nell'applicazione delle disposizioni di questa parte della convenzione, i Governi devono rispettare<br />
l'importanza speciale, per la cultura e per i valori spirituali dei popoli interessati, della<br />
relazione che essi intrattengono con le terre od i territori (o, a seconda dei casi, con entrambi)<br />
che essi occupano od altrimenti utilizzano; ed in particolare gli aspetti collettivi di questa relazione.<br />
omissis<br />
406
Unesco<br />
407
CONVENZIONE SULLA LOTTA CONTRO LA DISCRIMINAZIONE NELL’EDUCAZIONE<br />
(adottata dalla Conferenza generale nel corso dell’undicesima sessione, Parigi, 14 dicembre<br />
1960)<br />
La Conferenza generale dell’ONU per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), riunitasi<br />
a Parigi dal 14 novembre al 15 dicembre 1960, nella sua undicesima sessione,<br />
Ricordando che la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo afferma il principio della nondiscriminazione<br />
e proclama il diritto di ogni persona all’educazione,<br />
Considerando che la discriminazione in materia di insegnamento costituisce una violazione dei<br />
diritti enunciati nella detta Dichiarazione,<br />
Considerando che ai termini del suo Atto costitutivo l’organizzazione dell’ONU per l’educazione,<br />
la scienza e la cultura si propone d’istituire la collaborazione delle nazioni, al fine di assicurare<br />
per tutti il rispetto universale dei diritti dell’uomo e uguali possibilità di educazione,<br />
Conscia del fatto che è conseguente compito dell’Organizzazione per l’educazione, la scienza e<br />
la cultura, nel rispetto della diversità dei sistemi nazionali d’educazione, non solo di proscrivere<br />
ogni forma di discriminazione in materia d’insegnamento, ma anche di promuovere<br />
l’uguaglianza di possibilità e di trattamento per tutte le persone in questo campo,<br />
omissis<br />
Adotta, in questo quattordicesimo giorno di dicembre, la presente Convenzione:<br />
Articolo 1<br />
l. Ai sensi della presente Convenzione, il termine “discriminazione” comprende qualsiasi distinzione,<br />
esclusione, limitazione o preferenza che, basandosi su razza, colore, sesso, lingua, religione,<br />
opinione politica o qualsiasi altra opinione, origine nazionale o sociale, condizione economica<br />
o di nascita, abbia per oggetto o per effetto di distruggere o alterare la parità di trattamento<br />
in materia di insegnamento e, in particolare<br />
omissis<br />
d di mettere una persona o un gruppo in una situazione incompatibile con la dignità dell’uomo.<br />
omissis<br />
Articolo 2<br />
Ai sensi dell’articolo 1 della presente Convenzione non saranno considerate discriminanti le seguenti<br />
situazioni, qualora siano permesse in uno Stato:<br />
omissis<br />
b) La creazione o il mantenimento, per motivi d’ordine religioso o linguistico, di sistemi o di istituzioni<br />
separate che corrispondono alla scelta dei genitori o dei tutori legali degli allievi, se<br />
l’adesione a questi sistemi o il frequentare tali istituzioni resta facoltativo e se l’insegnamento<br />
dispensato è conforme alle norme che possono essere state prescritte o approvate dalle autorità<br />
competenti, in particolare per l’insegnamento dello stesso grado;<br />
omissis<br />
Articolo 5<br />
1. Gli Stati parte delle presente Convenzione concordano:<br />
a) che l’educazione deve tendere al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento<br />
del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e che deve favorire la comprensione, la<br />
tolleranza e l’amicizia tra tutte le nazioni e tutti i gruppi razziali o religiosi, e inoltre lo sviluppo<br />
delle attività dell’ONU per il mantenimento della pace;<br />
b) che occorre rispettare la libertà dei genitori e, se del caso, dei tutori legali di:<br />
409
1° scegliere per i loro figli istituti di istruzione diversi da quelli pubblici, ma conformi alle norme<br />
minime che possono essere imposte o approvate dalle autorità competenti,<br />
2° di far sì che sia garantita, secondo le modalità di attuazione previste dalla legislazione di ciascuno<br />
Stato, l’educazione religiosa e morale dei figli nel rispetto delle proprie convinzioni religiose<br />
ed inoltre che nessuna persona o gruppo debbano essere costretti a ricevere<br />
un’istruzione religiosa incompatibile con le loro convinzioni.<br />
omissis<br />
RACCOMANDAZIONE SULL’EDUCAZIONE ALLA COMPRENSIONE, ALLA COOPERA-<br />
ZIONE E ALLA PACE INTERNAZIONALE E SULL’EDUCAZIONE RELATIVA AI <strong>DIRITTI</strong><br />
DELL’UOMO E ALLE LIBERTA’ FONDAMENTALI<br />
(Adottata dall’UNESCO – Parigi, 19-23 novembre 1974)<br />
La Conferenza Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e<br />
la cultura, riunitasi a Parigi dal 17 ottobre al 23 novembre 1974, nella sua diciottesima sessione,<br />
Consapevole della responsabilità che incombe agli Stati di raggiungere attraverso l’educazione<br />
gli obiettivi enunciati dalla Carta delle Nazioni Unite, l’Atto costitutivo dell’Unesco, la Dichiarazione<br />
universale dei diritti dell’uomo e le Convenzioni di Ginevra per la protezione delle vittime<br />
di guerra del 12 agosto 1949, al fine di promuovere la comprensione, la cooperazione e la pace<br />
internazionali ed il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,<br />
omissis<br />
III. PRINCIPI DIRETTIVI<br />
3. L’educazione dovrebbe ispirarsi ai fini enunciati dalla Carta delle Nazioni Unite, dall’Atto costitutivo<br />
dell’Unesco e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, in particolare<br />
nell’articolo 26, comma 2, di quest’ultima si dichiara: “L’educazione deve mirare al pieno sviluppo<br />
della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà<br />
fondamentali. Essa deve favorire la comprensione, la tolleranza e l’amicizia tra tutte le nazioni e<br />
tutti i gruppi razziali o religiosi, così come lo sviluppo delle attività delle Nazioni Unite per il mantenimento<br />
della pace”.<br />
4. Al fine di mettere ognuno in grado di contribuire attivamente alla realizzazione dei fini di cui al<br />
paragrafo 3, e di promuovere la solidarietà e la cooperazione internazionali, indispensabili per<br />
risolvere i problemi mondiali riguardanti la vita degli individui e delle comunità e l’esercizio delle<br />
libertà e dei diritti fondamentali, gli obiettivi seguenti dovrebbero essere considerati come principi<br />
direttivi della politica educativa:<br />
a) una dimensione internazionale ed un prospettiva mondiale dell’educazione a tutti i livelli<br />
e sotto tutte le sue forme;<br />
b) la comprensione ed il rispetto di tutti i popoli, delle loro civiltà, dei loro valori e dei loro<br />
stili di vita, comprese le culture delle etnie nazionali e quelle delle altre nazioni;<br />
c) la consapevolezza della crescente interdipendenza mondiale dei popoli e delle nazioni;<br />
d) la capacità di comunicare con gli altri;<br />
omissis<br />
6. L’educazione dovrà mettere l’accento sull’inammissibilità del ricorso alla guerra di espansione,<br />
di aggressione e di dominazione, alla forza e alla violenza repressive ed indurre ogni persona<br />
a comprendere ed assumere le responsabilità che le incombono per il mantenimento della<br />
pace. Essa dovrà contribuire alla comprensione internazionale, al rafforzamento della pace<br />
mondiale e alle attività nella lotta contro il colonialismo ed il neo-colonialismo sotto tutte le loro<br />
forme e in tutte le loro manifestazioni e contro tutte le forme e varietà di razzismo, di fascismo e<br />
di apartheid così come di ogni altra ideologia che ispirano l’odio nazionale o razziale e che sono<br />
contrari agli obiettivi di questa raccomandazione.<br />
omissis<br />
410
11. Gli Stati membri dovranno fare in modo che i principi della Dichiarazione universale dei diritti<br />
dell’uomo e quelli della Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione<br />
razziale divengano parte integrante della personalità di ogni bambino, adolescente,<br />
giovane o adulto, man mano che cresce, applicando questi principi nella realtà quotidiana<br />
dell’educazione a tutti i suoi livelli ed in tutte le sue forme, permettendo così ad ogni individuo di<br />
contribuire, nel proprio ambito, a rinnovare e a diffondere l’educazione nel senso indicato.<br />
omissis<br />
18. L’educazione dovrebbe tendere sia all’eliminazione dei fattori che perpetuano ed aggravano<br />
i grandi problemi che riguardano la sopravvivenza e il benessere della specie umana – disuguaglianza,<br />
ingiustizia, relazioni internazionali fondate sull’uso della forza – sia a misure di cooperazione<br />
internazionale atte a facilitarne la soluzione. L’educazione che, al riguardo deve essere<br />
necessariamente interdisciplinare, dovrebbe contemplare ad esempio le seguenti questioni:<br />
omissis<br />
c) l’azione mirante ad assicurare l’esercizio ed il rispetto dei diritti dell’uomo compresi quelli<br />
dei rifugiati; il razzismo e la sua eliminazione; la lotta contro la discriminazione sotto tutte<br />
le sue diverse forme;<br />
omissis<br />
RACCOMANDAZIONE SULLA PARTECIPAZIONE E L’APPORTO DI TUTTA LA POPOLA-<br />
ZIONE ALLA VITA CULTURALE<br />
(adottata dalla Conferenza generale nel corso della diciannovesima sessione, Nairobi, 26<br />
novembre 1976)<br />
La Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e<br />
la cultura, riunitasi a Nairobi dal 26 ottobre al 30 novembre 1976, in occasione della sua diciannovesima<br />
sessione,<br />
Rammentando che ai sensi dell’articolo 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo<br />
“ogni persona ha il diritto di prendere liberamente parte alla vita culturale della comunità, di godere<br />
delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai benefici che ne derivano”,<br />
Rammentando che l’Atto costitutivo dell’Unesco, nel suo Preambolo, dichiara che la dignità<br />
dell’uomo richiede la diffusione della cultura e l’educazione di tutti per la giustizia, la libertà e la<br />
pace,<br />
Richiamando le disposizioni della Dichiarazione dei principi della cooperazione culturale internazionale<br />
adottata dalla Conferenza generale dell’Unesco nel corso della sua quattordicesima<br />
sessione, il 4 novembre 1966, in particolare l’articolo primo in base al quale “ogni cultura ha una<br />
dignità ed un valore che vanno rispettati e salvaguardati” e l’articolo IV, ai sensi del quale una<br />
delle finalità della cooperazione culturale internazionale è “consentire ad ogni uomo di accedere<br />
alla conoscenza, di godere delle arti e delle lettere di tutti i popoli, di partecipare ai progressi<br />
compiuti dalla scienza in ogni parte del mondo ed ai relativi benefici, nonché di contribuire per<br />
conto suo all’arricchimento della vita culturale”, come pure le disposizioni dell’Atto finale della<br />
Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa in cui si afferma che gli Stati partecipanti,<br />
“desiderosi di contribuire al rafforzamento della pace e della comprensione tra i popoli<br />
nonché all’arricchimento spirituale della personalità umana, senza alcuna distinzione per razza,<br />
sesso, lingua o religione” si prefiggono come obiettivo di favorire l’accesso di tutti alle rispettive<br />
opere culturali,<br />
omissis<br />
411
II. Misure legislative e regolamentari<br />
4. Si raccomanda agli Stati, qualora non abbiano ancora provveduto, di adottare, conformemente<br />
alle procedure costituzionali nazionali, misure di carattere legislativo o regolamentare e di<br />
modificare le prassi vigenti con le seguenti finalità:<br />
a. garantire, come diritti dell’uomo, i diritti in materia di accesso e partecipazione alla vita culturale,<br />
negli intenti della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, del Patto Internazionale sui<br />
diritti economici, sociali e culturali e del Patto Internazionale sui diritti civili e politici e nel rispetto<br />
degli ideali e degli obiettivi definiti nella Carta delle Nazioni Unite e l’Atto costitutivo dell’Unesco;<br />
b. garantire effettivamente il libero accesso alle culture nazionali e mondiali di tutti i membri della<br />
società, senza alcuna distinzione né discriminazione fondata sulla razza, il colore, il sesso, la<br />
lingua, la religione, le convinzioni politiche, l’origine nazionale o sociale, la situazione materiale<br />
o qualsiasi altra considerazione ed incoraggiare altresì la libera partecipazione di tutti gli strati<br />
della popolazione al processo di creazione dei valori culturali;<br />
omissis<br />
f. Garantire l’uguaglianza fra le culture nella loro diversità, comprese le culture delle minoranze<br />
nazionali e delle minoranze straniere – laddove presenti – come facenti parte del patrimonio<br />
comune dell’umanità ed assicurandone la promozione a tutti i livelli senza alcuna discriminazione;<br />
garantire alle minoranze nazionali ed alle minoranze straniere l’accesso e l’effettiva partecipazione<br />
alla vita culturale dei paesi in cui si trovano al fine di arricchire i loro contributi specifici,<br />
pur mantenendo il diritto di salvaguardare la propria identità culturale;<br />
omissis<br />
s. Rifiutare le concezioni che, col pretesto di azione culturale, sono fondate sulla violenza e<br />
l’aggressione, la dominazione e il disprezzo, i pregiudizi razziali nonché idee o pratiche degradanti;<br />
omissis<br />
DICHIARAZIONE SULLA RAZZA ED I PREGIUDIZI RAZZIALI<br />
(adottata dalla Conferenza generale nel corso della ventesima sessione, Parigi, 27 novembre<br />
1978)<br />
La Conferenza Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e<br />
la cultura, riunita a Parigi per la sua ventesima sessione, ha adottato, il 27 novembre 1978, all'unanimità<br />
e per acclamazione la seguente Dichiarazione:<br />
Preambolo<br />
La Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e<br />
la cultura, riunita a Parigi per la sua ventesima sessione, dal 24 ottobre al 28 novembre 1978.<br />
Rammentando che nel preambolo dell'Atto costitutivo dell'Unesco, adottato il 16 novembre<br />
1945, si dichiara che "la grande e terribile guerra finita recentemente è stata resa possibile dal<br />
disconoscimento dell'ideale democratico di dignità, di uguaglianza e di rispetto della persona<br />
umana e dalla volontà di sostituirlo, facendo leva sull'ignoranza e i pregiudizi, con il dogma dell'ineguaglianza<br />
delle razze e degli uomini" e che, in base al primo articolo del suddetto Atto costitutivo,<br />
l'Unesco "Si propone di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza rendendo<br />
più stretta, attraverso l'educazione, la scienza e la cultura, la collaborazione tra le nazioni<br />
al fine di assicurare il rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti dell'uomo e delle<br />
libertà fondamentali per tutti, senza distinzione per razza, sesso, lingua o religione, che la Carta<br />
delle Nazioni Unite riconosce a tutti i popoli”,<br />
Riconoscendo che, dopo più di tre decenni dalla fondazione dell'Unesco questi principi hanno la<br />
stessa validità di quando sono stati inseriti nel suo Atto costitutivo,<br />
Consapevole del processo di decolonizzazione e degli altri mutamenti storici che hanno permesso<br />
alla maggior parte dei popoli, per lungo tempo dipendenti, di riottenere la loro sovranità<br />
412
facendo della comunità internazionale un insieme universale, ma diversificato e creando nuove<br />
possibilità di eliminare il flagello del razzismo e di porre fine alle sue deprecabili manifestazioni<br />
su ogni piano della vita sociale e politica, nell'ambito nazionale e internazionale,<br />
Convinta che l'unità intrinseca della specie umana e, per conseguenza, l'uguaglianza innata di<br />
tutti gli esseri umani e di tutti i popoli, riconosciuta dalle espressioni più elevate della filosofia,<br />
della morale e della religione, riflettono un ideale verso il quale convergono oggi l'etica e la<br />
scienza,<br />
Convinta che tutti i popoli e tutti i gruppi umani, quale che sia la loro composizione o la loro origine<br />
etnica, contribuiscono secondo il loro proprio genio al progresso della civiltà e delle culture<br />
che, nella loro pluralità e grazie alla loro compenetrazione, costituiscono il patrimonio comune<br />
dell'umanità,<br />
Confermando la sua adesione ai principi proclamati dallo Statuto delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione<br />
Universale dei diritti dell'uomo e la sua volontà di promuovere l'attuazione dei Patti<br />
internazionali relativi ai diritti dell'uomo e della Dichiarazione relativa all'instaurazione di un nuovo<br />
ordine economico internazionale,<br />
Decisa a promuovere ugualmente l’attuazione della Dichiarazione e della Convenzione internazionale<br />
delle Nazioni Unite per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale,<br />
Tenuta presente la Convenzione internazionale per la prevenzione e la repressione del crimine<br />
di genocidio, la Convenzione internazionale per l'eliminazione e la repressione del crimine di<br />
apartheid e la Convenzione sull'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità,<br />
Rammentando altresì gli strumenti internazionali già adottati dall’Unesco e in particolare la<br />
Convenzione e la Raccomandazione relativa alla lotta contro la discriminazione razziale nel<br />
campo dell'istruzione, la Raccomandazione relativa alla condizione del personale insegnante, la<br />
Dichiarazione dei principi della cooperazione culturale internazionale, la Raccomandazione sull'educazione<br />
per la comprensione, la cooperazione e la pace internazionali e l'educazione relativa<br />
ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali, la Raccomandazione riguardante la condizione<br />
dei ricercatori scientifici e la Raccomandazione riguardante la partecipazione e il contributo<br />
delle masse popolari alla vita culturale,<br />
Tenute presenti le quattro dichiarazioni sulla questione razziale adottate dagli esperti riuniti dall'Unesco,<br />
Riaffermata la sua volontà di associarsi decisamente e costruttivamente all’attuazione del programma<br />
del decennio per la lotta contro il razzismo, la discriminazione razziale, definito dall'Assemblea<br />
generale delle Nazioni Unite nel corso della sua ventesima sessione,<br />
Constatando con la più viva preoccupazione che il razzismo, la discriminazione razziale, il colonialismo<br />
e l'apartheid continuano a imperversare nel mondo in sempre nuove forme, sia mantenendo<br />
disposizioni legislative e comportamenti governativi e amministrativi contrari ai principi<br />
dei diritti dell'uomo, sia lasciando persistere strutture politiche e sociali, relazioni e comportamenti<br />
improntati all'ingiustizia e al disprezzo della persona umana, che hanno come conseguenza<br />
l’esclusione, l'umiliazione, lo sfruttamento o l'assimilazione forzata dei membri dei gruppi<br />
svantaggiati,<br />
Esprimendo la sua indignazione dì fronte a questi attentati alla dignità dell'uomo, deplorando gli<br />
ostacoli che essi oppongono alla reciproca comprensione tra i popoli e preoccupandosi dei gravi<br />
rischi che possono derivarne per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali,<br />
Adotta e proclama solennemente la presente Dichiarazione sulla razza e i pregiudizi razziali:<br />
Articolo 1<br />
1) Tutti gli esseri umani appartengono alla stessa specie e provengono dallo stesso ceppo. Essi<br />
nascono uguali in dignità e diritti e fanno tutti parte integrante dell'umanità.<br />
2) Tutti gli individui e tutti i gruppi hanno diritto di essere diversi, di ritenersi e di essere accertati<br />
come tali. Nondimeno la diversità delle forme di vita e il diritto alla differenza non possono in alcun<br />
caso costituire un pretesto per i pregiudizi razziali, non possono legittimare, né in linea di<br />
diritto né di fatto, qualsiasi comportamento discriminatorio né servire da presupposto alla politica<br />
dell'apartheid, che costituisce la forma estrema del razzismo.<br />
3) L'identità di origine non può condizionare la facoltà degli esseri umani di vivere diversamente,<br />
così come non lo possono le differenze basate sulla diversità delle culture, dell'ambiente e della<br />
storia, né può ledere il diritto di mantenere la propria identità culturale.<br />
413
4) Tutti i popoli del mondo sono dotati delle stesse facoltà che permettono loro di raggiungere la<br />
pienezza dello sviluppo intellettuale, tecnico, sociale, economico, culturale e politico.<br />
5) Le differenze tra le realizzazioni dei diversi popoli sono determinate da fattori geografici, storici,<br />
politici, economici, sociali e culturali. Queste diversità non possono, in alcun modo, costituire<br />
un pretesto per una qualsivoglia gerarchizzazione delle nazioni e dei popoli.<br />
Articolo 2<br />
1) Ogni teoria che, sostenendo la superiorità o l'inferiorità intrinseca di gruppi razziali etnici, assegna<br />
agli uni il diritto di dominare o eliminare gli altri, presunti inferiori, o che fonda criteri di valore<br />
su una differenza razziale, non ha alcun fondamento scientifico ed è contraria ai principi<br />
morali ed etici dell'umanità.<br />
2) Rientrano nel concetto di razzismo le ideologie razziste, i comportamenti basati sui pregiudizi<br />
razziali, i comportamenti discriminatori, le disposizioni strutturali e le prassi istituzionalizzate che<br />
determinano la disuguaglianza razziale, come l'idea fallace che le relazioni discriminatorie tra<br />
gruppi sono moralmente e scientificamente giustificabili; esso si esprime in disposizioni legislative<br />
o regolamenti e in prassi discriminatorie, ed anche in credenze e comportamenti antisociali;<br />
esso intralcia lo sviluppo delle sue vittime, perverte coloro che agiscono con criteri razziali; crea<br />
divisioni all'interno delle nazioni, costituisce un ostacolo per la cooperazione internazionale e<br />
crea tensioni politiche tra i popoli; esso è contrario ai principi fondamentali del diritto internazionale<br />
e, di conseguenza, turba gravemente la pace e la sicurezza internazionali.<br />
3) Il pregiudizio razziale, legato storicamente a ineguaglianze di potere, che si rafforzano in ragione<br />
delle differenze economiche e sociali tra gli individui e i gruppi umani, e che tende ancor<br />
oggi a giustificare tali ineguaglianze, è totalmente ingiustificato.<br />
Articolo 3<br />
E’ incompatibile con le esigenze di un ordine internazionale giusto e garante del rispetto dei diritti<br />
dell'uomo ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore,<br />
l'origine etnica o nazionale o sull'intolleranza religiosa motivata da considerazioni razziste, che<br />
distrugge o compromette l'uguaglianza sovrana degli Stati e il diritto dei popoli all'autodeterminazione<br />
o che limita in modo arbitrario o discriminatorio il diritto allo sviluppo integrale di ogni<br />
essere e gruppo umano; questo diritto implica un accesso, in condizioni di assoluta uguaglianza,<br />
ai mezzi che favoriscono il progresso e il pieno sviluppo collettivo e individuale nel rispetto<br />
dei valori di civiltà e delle culture nazionali e universali.<br />
omissis<br />
Articolo 6<br />
1) Lo Stato assume delle responsabilità primordiali nell'esigere l'applicazione dei diritti umani e<br />
delle libertà fondamentali in piena uguaglianza per dignità e diritto, da tutti gli individui e da tutti i<br />
gruppi umani.<br />
2) Nell'ambito delle sue competenze e in conformità alle sue norme costituzionali, lo Stato dovrebbe<br />
adottare tutte le disposizioni appropriate, comprese quelle legislative, specialmente nei<br />
settori dell'educazione, della cultura e dell'informazione per prevenire, interdire ed eliminare il<br />
razzismo, la propaganda razziale, la segregazione razziale e l'apartheid e incoraggiare la diffusione<br />
delle conoscenze e dei risultati delle ricerche scientifiche, naturali e sociali sulle cause e<br />
la prevenzione dei pregiudizi razziali e dei comportamenti razzisti, tenendo nel dovuto conto i<br />
principi formulati nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e nel Patto internazionale<br />
relativo ai diritti civili e politici.<br />
3) Poiché la legislazione che vieta la discriminazione razziale potrebbe risultare insufficiente,<br />
spetta ugualmente allo Stato integrarla con un apparato amministrativo che svolga sistematicamente<br />
inchieste sui casi di discriminazione razziale, con un esauriente insieme di norme giuridiche<br />
contro gli atti di discriminazione razziale, con importanti programmi educativi e di ricerca<br />
per la lotta contro i pregiudizi razziali e la discriminazione razziale, con programmi di norme positive<br />
di ordine politico, sociale, educativo e culturale idonei a promuovere un vero rispetto reciproco<br />
tra i gruppi umani. Quando le circostanze lo richiedano devono essere effettuati programmi<br />
speciali per promuovere il miglioramento della situazione dei gruppi in condizione di<br />
414
svantaggio: se si tratta di unità di gruppi nazionali, essi devono partecipare al processo decisionale<br />
della comunità.<br />
Articolo 7<br />
Insieme alle norme politiche, economiche e sociali, il diritto costituisce uno dei mezzi principali<br />
per assicurare l'uguaglianza, in diritto e dignità, degli individui; esso può reprimere ogni propaganda,<br />
organizzazione e pratica che si ispirano a idee o teorie fondate sulla pretesa superiorità<br />
di gruppi razziali o etnici o che pretendono giustificare o incoraggiare ogni forma di odio e di discriminazione<br />
razziale. Gli Stati dovrebbero adottare disposizioni giuridiche idonee e assicurare<br />
la loro attuazione e la loro applicazione da parte dei loro organi, tenendo nel dovuto conto i<br />
principi formulati nella Dichiarazione Universale dei diritti umani. Queste disposizioni giuridiche<br />
devono inserirsi in un quadro politico, economico e sociale atto a favorire la loro applicazione.<br />
Gli individui e le altre entità giuridiche, pubbliche e private, devono conformarvisi e contribuire<br />
con mezzi idonei a farle comprendere e praticare da tutta la popolazione.<br />
Articolo 8<br />
1) Poiché l’individuo ha il diritto, sul piano nazionale ed internazionale, ad un ordine economico,<br />
sociale, culturale e giuridico che gli garantisca la possibilità di esplicare le sue capacità in piena<br />
uguaglianza di diritti e di possibilità, esso ha di conseguenza i doveri corrispondenti verso i suoi<br />
simili, verso la società nella quale vive e verso la comunità internazionale. Egli ha dunque il dovere<br />
di promuovere l’armonia dei popoli, di lottare contro il razzismo ed i pregiudizi razziali e di<br />
contribuire con tutti i mezzi di cui dispone all’eliminazione di tutte le forme di discriminazione<br />
razziale.<br />
omissis<br />
DICHIARAZIONE DI CITTA’ DEL MESSICO SULLE POLITICHE CULTURALI<br />
(adottata dalla Conferenza Mondiale sulle politiche culturali di Città del Messico, 6 agosto<br />
1982)<br />
omissis<br />
La Conferenza conviene:<br />
che, nel suo senso più ampio, la cultura può essere considerata oggi come l’insieme delle connotazioni<br />
spirituali e materiali, intellettuali ed affettive che caratterizzano una società o un gruppo<br />
sociale. Tale cultura comprende, oltre le arti e le lettere, i modus vivendi, i diritti fondamentali<br />
dell’essere umano, i sistemi di valori, le fedi e le tradizioni.<br />
omissis<br />
Identità culturale<br />
1. Ogni cultura rappresenta un insieme di valori unico e insostituibile poiché, attraverso le sue<br />
tradizioni e forme di espressione, un popolo può manifestare nel modo più compiuto la propria<br />
presenza nel mondo.<br />
2. L’affermazione dell’identità culturale contribuisce quindi alla liberazione dei popoli. Al contrario,<br />
ogni forma di dominio nega o compromette tale identità.<br />
3. L’identità culturale è una ricchezza stimolante che accresce le possibilità di realizzazione della<br />
specie umana incentivando ogni popolo, ogni gruppo a non dimenticare il proprio passato, ad<br />
accettare gli apporti esterni compatibili con le proprie caratteristiche ed a continuare così il processo<br />
della propria creazione.<br />
4. Tutte le culture fanno parte del patrimonio comune dell’umanità. L’identità culturale di un popolo<br />
si rinnova e si arricchisce a contatto con le tradizioni ed i valori degli altri popoli. La cultura<br />
è dialogo, scambio di idee e di esperienze, apprezzamento di altri valori e tradizioni;<br />
nell’isolamento essa si esaurisce e muore.<br />
415
5. L’universale non può essere enunciato da nessuna cultura in particolare; può soltanto emergere<br />
dall’esperienza di tutti i popoli del mondo che affermino la propria identità. Identità culturale<br />
e diversità culturale sono indissociabili.<br />
6. Lungi dall’ostacolare la comunione nei valori universali che uniscono i popoli, le caratteristiche<br />
culturali non fanno altro che agevolarla. La consapevolezza che le identità culturali multiple<br />
coesistono laddove sono presenti tradizioni differenti costituisce l’essenza stessa del pluralismo<br />
culturale.<br />
7. La comunità internazionale considera suo dovere tutelare e difendere l’identità culturale di<br />
ogni popolo.<br />
8. Tutto ciò richiede politiche culturali atte a proteggere, incentivare ed arricchire l’identità ed il<br />
patrimonio culturale di ogni popolo e ad instaurare il massimo rispetto e stima per le minoranze<br />
culturali e le altre culture del mondo. L’umanità si impoverisce quando la cultura di un determinato<br />
gruppo è poco conosciuta o annientata.<br />
9. E’ necessario riconoscere l’eguaglianza della dignità di tutte le culture ed il diritto di ogni popolo<br />
e di ogni comunità culturale di affermare, di tutelare e di vedere rispettata la propria identità<br />
culturale.<br />
omissis<br />
Cultura e democrazia<br />
omissis<br />
22. Al fine di garantire la partecipazione di tutti gli individui alla vita culturale, occorre eliminare<br />
le ineguaglianze derivanti in particolare dall’origine e dalla posizione sociale, dall’istruzione, dalla<br />
cittadinanza, dall’età, dalla lingua, dal sesso, dalle fedi religiose, dallo stato di salute o<br />
dall’appartenenza a gruppi etnici minori o marginali.<br />
Patrimonio culturale<br />
23. Il patrimonio culturale di un popolo si estende alle opere dei propri artisti, architetti, musicisti,<br />
scienziati nonché alle creazioni anonime, scaturite dall’animo popolare e all’insieme dei valori<br />
che danno un senso alla vita. Tale patrimonio comprende le opere materiali e non materiali<br />
che rappresentano la creatività di un popolo: lingua, riti, fedi, luoghi e monumenti storici, letteratura,<br />
opere d’arte, archivi e biblioteche.<br />
omissis<br />
416
DOCUMENTI DEL CONSIGLIO D'EUROPA<br />
417
CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI <strong>DIRITTI</strong> DELL’UOMO E DELLE LIBERTÀ<br />
FONDAMENTALI<br />
(conclusa a Roma il 4 novembre 1950)<br />
omissis<br />
Articolo 9<br />
1. Tutti godono del diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione. Tale diritto comprende la<br />
libertà di cambiare la propria religione o il proprio credo e la libertà di professare la propria religione<br />
o il proprio credo attraverso l’insegnamento la pratica e l’osservanza religiosi, sia da solo<br />
che assieme ad altri, sia in pubblico che in privato.<br />
2. La libertà di professare la propria religione o il proprio credo è subordinata solo alle limitazioni<br />
previste dalla legge e che sono necessarie in una società democratica ai fini della sicurezza<br />
pubblica per la salvaguardia dell’ordine, della salute o della morale pubblici, oppure per la salvaguardia<br />
dei diritti e delle libertà di altri.<br />
omissis<br />
Articolo 14<br />
Il godimento dei diritti e delle libertà stabiliti nella presente Convenzione deve essere garantito<br />
senza discriminazione per motivi quali il sesso, la razza, il colore della pelle, la lingua, la religione,<br />
le opinioni politiche o di altro tipo, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza ad una minoranza<br />
nazionale, la proprietà di beni, la nascita o altro status.<br />
omissis<br />
RACCOMANDAZIONE N. R(87) 3 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI<br />
SULLE NORME EUROPEE IN MATERIA DI DETENZIONE<br />
(adottata dal Comitato dei Ministri il 12 febbraio 1987, nel corso della 404^ riunione dei<br />
Delegati dei Ministri)<br />
omissis<br />
ALLEGATO<br />
(Versione europea riveduta del pacchetto di regole minime per il trattamento dei detenuti)<br />
omissis<br />
Parte Prima<br />
omissis<br />
2. Le regole devono essere applicate imparzialmente. Non si deve operare alcuna discriminazione<br />
per razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altro tipo, origini sociali o<br />
nazionali, nascita, condizione economica o di altro tipo. Le credenze religiose e i principi morali<br />
del gruppo al quale appartiene il detenuto devono essere rispettati.<br />
omissis<br />
Parte Seconda<br />
omissis<br />
419
Assistenza religiosa e morale<br />
46. Ogni detenuto deve essere autorizzato, nella misura del possibile, a soddisfare le esigenze<br />
della propria vita religiosa, spirituale e morale, partecipando alle funzioni o riunioni organizzate<br />
nell’istituto e possedendo i libri e le pubblicazioni necessarie.<br />
47. 1. Se nell’istituto vi è un numero sufficiente di detenuti appartenenti alla stessa religione, un<br />
rappresentante qualificato di questa religione deve essere nominato o riconosciuto. Se il numero<br />
dei detenuti lo giustifica e le circostanze lo permettono. l’intervento dovrebbe essere di tipo<br />
permanente.<br />
2. Il rappresentante qualificato nominato o riconosciuto ai sensi del paragrafo 1 deve essere<br />
autorizzato ad organizzare periodicamente i servizi e le attività religiose e ad effettuare visite<br />
pastorali particolari, negli orari a ciò riservati, ai detenuti appartenenti alla sua religione.<br />
3. Il contatto con un rappresentante qualificato di una religione non deve essere rifiutato ad<br />
alcun detenuto. Se un detenuto si oppone alla visita di un rappresentante di una religione, la<br />
sua volontà deve essere rispettata.<br />
omissis<br />
Istruzione<br />
omissis<br />
79. L'istruzione dei giovani detenuti, in particolare di quelli di origine straniera o aventi particolari<br />
bisogni culturali o connessi alla loro etnia, dovrebbe attirare particolarmente l'attenzione delle<br />
Amministrazioni penitenziarie.<br />
omissis<br />
CARTA EUROPEA DELLE LINGUE REGIONALI E/O MINORITARIE<br />
(1992)<br />
Preambolo<br />
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Carta,<br />
omissis<br />
Considerando che il diritto di praticare una lingua regionale o minoritaria nella vita privata e<br />
pubblica è un diritto imprescrittibile, in conformità ai principi contenuti nel Patto internazionale<br />
relativo ai diritti civili e politici delle Nazioni Unite ed in conformità allo spirito della Convenzione<br />
di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del Consiglio d’Europa;<br />
omissis<br />
Parte II – Obiettivi e principi perseguiti in conformità al paragrafo 1 dell’articolo 2<br />
Articolo 7 – Obiettivi e principi<br />
omissis<br />
3. Le Parti s’impegnano a promuovere, per mezzo di provvedimenti appropriati, una reciproca<br />
comprensione fra tutti i gruppi linguistici del paese, adoperandosi affinché il rispetto, la comprensione<br />
e la tolleranza nei confronti di lingue regionali o minoritarie figurino fra gli obiettivi<br />
dell’istruzione e della formazione professionale impartite nel paese, e ad incoraggiare i mezzi di<br />
comunicazione di massa a perseguire il medesimo obiettivo.<br />
omissis<br />
420
DICHIARAZIONE DI VIENNA<br />
(adottata in occasione del Summit del Consiglio d’Europa a Vienna il 9 ottobre 1993)<br />
omissis<br />
Nell’ottica politica fin qui tracciata, noi, Capi di Stato e di <strong>Governo</strong> degli Stati membri del Consiglio<br />
d’Europa, decidiamo:<br />
omissis<br />
- di avviare una politica di lotta contro il razzismo, la xenofobia, l’antisemitismo e l’intolleranza e<br />
di adottare al tal fine una Dichiarazione nonché un piano d’azione<br />
omissis<br />
ALLEGATO II “Le minoranze nazionali”<br />
omissis<br />
Gli Stati dovrebbero creare condizioni atte a consentire alle persone appartenenti a minoranze<br />
nazionali di sviluppare la propria cultura nel rispetto della loro religione, delle loro tradizioni e dei<br />
loro costumi. Tali persone devono poter utilizzare la propria lingua in privato come in pubblico e<br />
dovrebbero poterlo fare, a determinate condizioni, nei loro rapporti con le autorità pubbliche.<br />
omissis<br />
Pertanto, noi decidiamo di demandare al Comitato dei Ministri il compito di:<br />
- elaborare misure affidabili atte ad accrescere la tolleranza e la comprensione fra i popoli;<br />
omissis<br />
ALLEGATO III “Dichiarazione e Piano d’azione contro il razzismo, la xenofobia, l’antisemitismo<br />
e l’intolleranza”<br />
omissis<br />
Allarmati dall’attuale crescita dei fenomeni di razzismo, xenofobia ed antisemitismo, dallo sviluppo<br />
di un clima di intolleranza, dal moltiplicarsi di atti di violenza, in particolare nei confronti di<br />
migranti e di persone immigrate, di trattamenti degradanti e di pratiche discriminatorie ad essi<br />
associati;<br />
Allarmati altresì dalla crescita di nazionalismi aggressivi e di etnocentrismi che costituiscono<br />
nuove espressioni di xenofobia;<br />
Preoccupati per il degrado delle condizioni economiche che minacciano la coesione delle società<br />
europee generando forme di emarginazione suscettibili di favorire le tensioni sociali e le manifestazioni<br />
xenofobe.<br />
omissis<br />
- Condanniamo fermamente il razzismo in ogni sua forma, la xenofobia, l’antisemitismo e<br />
l’intolleranza nonché qualsiasi forma di discriminazione religiosa;<br />
omissis<br />
- Ci impegniamo a contrastare qualsiasi ideologia, politica e prassi che inciti all’odio razziale,<br />
alla violenza ed alla discriminazione nonché contro qualsiasi azione o linguaggio tali da rafforzare<br />
l’odio e le tensioni fra gruppi di diversa appartenenza razziale, etnica, nazionale, religiosa<br />
o sociale.<br />
421
- Lanciamo un appello pressante ai popoli, ai gruppi, ai cittadini europei ed in particolare ai giovani<br />
affinché si impegnino con determinazione nella lotta contro ogni forma di intolleranza ed<br />
affinché partecipino attivamente alla costruzione di una società europea democratica, tollerante<br />
e solidale, sulla base di valori comuni.<br />
omissis<br />
PIANO D’AZIONE<br />
1. Avvio di una vasta campagna europea della gioventù per la mobilitazione del pubblico in favore<br />
di una società della tolleranza, fondata sulla pari dignità di tutti i suoi membri e contro le<br />
manifestazioni di razzismo, xenofobia, antisemitismo ed intolleranza.<br />
omissis<br />
2. Invito agli Stati membri a rafforzare le garanzie contro qualsiasi forma di discriminazione fondata<br />
sulla razza, l’origine nazionale o etnica o sulla religione e a tal fine:<br />
- riesaminare subito la propria legislazione e regolamentazione allo scopo di eliminare le disposizioni<br />
suscettibili di generare discriminazioni fondate su uno dei citati motivi o di far sussistere<br />
dei pregiudizi;<br />
- garantire la concreta attuazione delle normative in materia di lotta contro il razzismo e la discriminazione;<br />
- rafforzare ed attuare misure di prevenzione contro il razzismo, la xenofobia, l’antisemitismo e<br />
l’intolleranza rivolgendo un’attenzione particolare alle misure destinate ad accrescere la consapevolezza<br />
di simili fenomeni ed a creare fiducia.<br />
3. Creazione di un Comitato di esperti governativi incaricati di:<br />
- esaminare le legislazioni, le politiche e le altre misure adottate dagli Stati membri per contrastare<br />
il razzismo, la xenofobia, l’antisemitismo e l’intolleranza nonché la loro efficacia;<br />
omissis<br />
4. Rafforzamento della comprensione reciproca e della fiducia tra i popoli attraverso programmi<br />
di cooperazione e di assistenza del Consiglio d’Europa. I lavori in tale settore dovrebbero riguardare<br />
in particolare:<br />
- lo studio delle cause profonde dell’intolleranza e dei rimedi da apportarvi, nello specifico attraverso<br />
un seminario ed il sostegno a programmi di ricerca;<br />
- lo sviluppo dell’istruzione nel campo dei diritti umani e ed in quello del rispetto delle diversità<br />
culturali;<br />
- il rafforzamento dei programmi finalizzati ad eliminare i pregiudizi attraverso l’insegnamento<br />
della storia mettendo in evidenza le positive influenze reciproche fra paesi, religioni ed idee fra<br />
loro diversi nell’evoluzione storica dell’Europa;<br />
- l’incoraggiamento alla cooperazione transfrontaliera fra collettività locali, allo scopo di accrescere<br />
la fiducia;<br />
- l’intensificazione del lavoro di cooperazione nei settori delle relazioni intercomunitarie e delle<br />
pari opportunità;<br />
- lo sviluppo di politiche contro l’emarginazione sociale e la grande povertà.<br />
5. Richiesta rivolta ai professionisti dell’informazione di presentare i loro reportages sugli atti di<br />
razzismo ed intolleranza in modo fattivo e responsabile e di portare avanti l’elaborazione di codici<br />
deontologici di categoria che riflettano tali esigenze.<br />
omissis<br />
422
RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE-QUADRO PER LA PROTEZIONE<br />
DELLE MINORANZE NAZIONALI<br />
(Strasburgo, 1 novembre 1995)<br />
omissis<br />
considerando che uno dei mezzi per raggiungere questo fine consiste è la salvaguardia e<br />
l’ulteriore sviluppo dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali;<br />
omissis<br />
considerando che una società che si vuole pluralista e genuinamente democratica deve non solo<br />
rispettare l'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa di ogni persona appartenente ad<br />
una minoranza nazionale ma anche creare delle condizioni appropriate che le consentano di<br />
esprimere, di preservare e di sviluppare questa identità;<br />
omissis<br />
Articolo 1<br />
La protezione delle minoranze nazionali e dei diritti e libertà delle persone appartenenti a queste<br />
minoranze è parte integrante della protezione internazionale dei diritti dell'Uomo e, in quanto<br />
tale, rientra nella portata della cooperazione internazionale.<br />
omissis<br />
Articolo 4<br />
1. Le Parti si impegnano a garantire ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale<br />
il diritto all'uguaglianza davanti alla legge e ad una uguale protezione della legge. A tal fine è<br />
vietata ogni discriminazione fondata sull'appartenenza ad una minoranza nazionale.<br />
2. Le Parti si impegnano ad adottare, se del caso, misure adeguate al fine di promuovere in tutti<br />
i settori della vita economica, sociale, politica e culturale l’uguaglianza completa ed effettiva fra<br />
le persone appartenenti ad una minoranza nazionale e quelle appartenenti alla maggioranza. A<br />
tale riguardo, esse terranno debitamente conto delle specifiche condizioni delle persone che<br />
appartengono a minoranze nazionali.<br />
3. Le misure adottate in conformità con il paragrafo 2 non sono considerate come atti discriminatori.<br />
Articolo 5<br />
1. Le Parti si impegnano a promuovere condizioni tali da consentire alle persone che appartengono<br />
a minoranze nazionali, di conservare e di sviluppare la loro cultura e di preservare gli elementi<br />
essenziali della loro identità quali la religione, la lingua, le tradizioni ed il patrimonio culturale.<br />
omissis<br />
Articolo 6<br />
1. Le Parti incoraggeranno lo spirito di tolleranza ed un dialogo interculturale, ed adotteranno<br />
misure effettive per promuovere il rispetto e la comprensione reciproca, nonché la cooperazione<br />
tra tutte le persone che vivono sul loro territorio, a prescindere dalla loro identità etnica, culturale,<br />
linguistica o religiosa, in particolare nel settori dell'istruzione, della cultura e dei mezzi<br />
d’informazione.<br />
2. Le Parti s’impegnano ad adottare ogni misura appropriata per proteggere le persone che potrebbero<br />
essere vittime di minacce o di atti di discriminazione, di ostilità o di violenza in ragione<br />
della loro identità etnica, culturale, linguistica o religiosa.<br />
423
Articolo 7<br />
Le Parti assicureranno che per ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale siano<br />
rispettati i diritti alla libertà di riunione pacifica, alla libertà di espressione ed alla libertà di pensiero,<br />
di coscienza e di religione.<br />
Articolo 8<br />
Le Parti s’impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale<br />
il diritto di manifestare la sua religione o le sue convinzioni, nonché il diritto di creare istituzioni<br />
religiose, organizzazioni ed associazioni.<br />
omissis<br />
Articolo 12<br />
1. Le Parti adotteranno se del caso misure nel settore dell'istruzione e della ricerca per promuovere<br />
la conoscenza della cultura, della storia, della lingua e della religione delle loro minoranze<br />
nazionali e della maggioranza.<br />
omissis<br />
Articolo 17<br />
1. Le Parti si impegnano a non interferire con il diritto delle persone appartenenti a minoranze<br />
nazionali di stabilire e di mantenere, liberamente e pacificamente, dei contatti al di là delle frontiere<br />
con persone che soggiornano regolarmente in altri Stati, in particolare con persone con cui<br />
hanno in comune l'identità etnica, culturale, linguistica o religiosa, o un patrimonio culturale.<br />
omissis<br />
Articolo 22<br />
Nessuna disposizione della presente Convenzione quadro sarà interpretata nel senso di limitare<br />
o di pregiudicare i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali eventualmente riconosciute dalle<br />
leggi delle Parti Contraenti o a norma di ogni altra convenzione di cui una Parte contraente è<br />
parte.<br />
omissis<br />
CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DEI <strong>DIRITTI</strong> DELL’UOMO E DELLA DIGNITA’<br />
DELL’ESSERE UMANO NEI CONFRONTI DELLE APPLICAZIONI DELLA BIOLOGIA E<br />
DELLA MEDICINA: CONVENZIONE SUI <strong>DIRITTI</strong> DELL’UOMO E LA BIOMEDICINA<br />
(4 aprile 1997)<br />
Preambolo<br />
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, gli altri Stati e la Comunità Europea firmatari della presente<br />
Convenzione,<br />
omissis<br />
Convinti della necessità di rispettare l’essere umano sia come individuo che nella sua appartenenza<br />
alla specie umana e riconoscendo l’importanza di assicurare la sua dignità;<br />
omissis<br />
Articolo 1 – Oggetto e finalità<br />
424
Le Parti di cui alla presente Convenzione proteggono l’essere umano nella sua dignità e nella<br />
sua identità e garantiscono ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità<br />
e dei suoi diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina.<br />
Ogni Parte prende nel suo diritto interno le misure necessarie per rendere effettive le disposizioni<br />
della presente Convenzione.<br />
omissis<br />
Articolo 11 – Non discriminazione<br />
Ogni forma di discriminazione nei confronti di una persona in ragione del suo patrimonio genetico<br />
è vietata.<br />
omissis<br />
IMPEGNO DI BARCELLONA PER I <strong>DIRITTI</strong> <strong>UMANI</strong><br />
(17 dicembre 1998)<br />
Nessuna città è un’isola. La rete delle città percorre il mondo attuale facendone un organismo<br />
vivente, agile, continuamente attivo. Tuttavia noi sappiamo che umori differenti possono scorrere<br />
nelle sue vene. La città è stata ed è spesso uno strumento di liberazione, un’autentica macchina<br />
di riduzione della povertà e lo spazio dove sono nati i diritti delle persone. Ma noi sappiamo<br />
anche che lo spazio urbano può giocare il ruolo di una potente macchina di esclusione sociale<br />
e che, nel corso di questo XX secolo che sta finendo, la barbarie si è accanita contro le città<br />
e ha lasciato nella nostra memoria un rosario di nomi che vanno da Verdum, Genica, Berlino<br />
e Hiroshima a Vukovar, Sarajevo e Srebrenica.<br />
E’ per questa ragione che, in occasione del cinquantesimo anniversario della Dichiarazione universale<br />
dei diritti umani, desideriamo affermare la nostra volontà che questi diritti arricchiscano<br />
la vita delle nostre città. Il loro carattere universale possiede uno straordinario valore quando<br />
opera per unire le città del mondo intero in una alleanza destinata a creare una nuova cultura<br />
dei diritti umani. I valori di uguaglianza e solidarietà, di giustizia, di democrazia nella vicinanza,<br />
di partecipazione, di trasparenza e di buon governo ispirano l’attuazione dei diritti umani<br />
nell’ambito delle città. E questi valori fanno in modo che, ovunque, le città possano unirsi per<br />
difendere un medesimo concetto della dignità umana e che la cittadinanza possa appropriarsi<br />
dell’antico motto: “l’aria della città ci rende liberi”.<br />
Lo sguardo posato sul secolo che viene, in un contesto di globalizzazione, di urbanizzazione<br />
crescente e di fratture sociali, ci rendiamo conto che l’interrelazione è un tratto fondamentale<br />
del nostro mondo che rende indissolubile la soddisfazione dei bisogno minimi dell’insieme della<br />
popolazione mondiale, la protezione dell’ambiente e il rispetto dei diritti delle future generazioni.<br />
In questo mondo futuro la città è chiamata a divenire uno dei principali attori per la promozione<br />
dello sviluppo duraturo e per la difesa dei diritti umani interdipendenti e indivisibili. In un mondo<br />
globalizzato la città è più vicina alle cittadine e ai cittadini, e di conseguenza capace di assicurare<br />
la visibilità delle situazioni di vulnerabilità dei diritti e di agire legittimamente di fronte ai cittadini.<br />
La cultura della comunicazione, che dà luogo alla trasmissione del sapere fra ambiti differenti e<br />
alla capillarità delle azioni e delle idee, fa emergere progressivamente le città come una nuova<br />
voce nella vita internazionale. Attraversale numerose iniziative della società civile e delle politiche<br />
comunali, la città gioca attualmente un ruolo nelle politiche attive di difesa dei diritti umani,<br />
nella cooperazione internazionale, è un baluardo per le vittime delle violazioni dei diritti, sui può<br />
mostrare generosa nell’accoglienza dei rifugiati. In un contesto di scambi sotto vari aspetti, diventa<br />
un imperativo incoraggiare con tutte le nostre forze l’Alleanza Mondiale delle Città contro<br />
la Povertà, per sottolineare i diritti economici, sociali e culturali, che sono una parte intrinseca<br />
dei diritti umani.<br />
425
Per una cultura dei diritti umani nella città<br />
Noi, sindaci delle città e delle capitali europee e rappresentanti dei poteri locali, ci assumiamo<br />
l’eredità dei cinquant’anni di sviluppo della Dichiarazione universale dei diritti umani e la sfida<br />
dei nuovi contesti in cui vivono gli uomini le donne di oggi. In virtù del principio della sussidiarietà<br />
e della vicinanza dell’amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e delle cittadine,<br />
affermiamo la nostra volontà di promuovere la cultura dei diritti umani e la responsabilità umana<br />
nella città e, di fronte alle nuove realtà, ci assumiamo i seguenti impegni:<br />
Vogliamo l’estensione del diritto di partecipazione politica, il diritto di voto e la libertà di associazione<br />
nell’ambito municipale per tutti i cittadini e le cittadine, inclusi tutti coloro che, residenti in<br />
città da un certo periodo in poi, non abbiano la nazionalità dello Stato. In questo senso occorrerà<br />
senza indugio lavorare con gli organismi o istanze che hanno le competenze per cambiare, in<br />
modo appropriato, le leggi elettorali. Bisognerà intanto creare, nelle nostre città, meccanismi<br />
che faciliteranno la partecipazione reale ed effettiva di tutti i cittadini e soprattutto dei membri<br />
dei gruppi politicamente più esclusi.<br />
I diritti umani sono indivisibili e i diritti sociali, economici e culturali ne sono una parte inalienabile.<br />
Il principio di prossimità fa sì che l’amministrazione municipale sia più sensibile alle realtà<br />
dove questi diritti sono particolarmente vulnerabili. Sosteniamo quindi che le politiche urbane<br />
contro l’esclusione sociale, le politiche per l’impiego, la promozione del diritto ad un alloggio adeguato<br />
e le azioni cittadine che mirino a proteggere i gruppi vulnerabili (i bambini, le donne,<br />
agli anziani, gli individui portatori di handicap…), così come le politiche che mirano a riconoscere<br />
agli immigrati in situazioni irregolari i diritti di accesso ai servizi sociali, all’educazione e alla<br />
sanità pubblica, fanno della città un baluardo dei diritti umani.<br />
La promozione dei diritti sociali e lo sviluppo economico sono ai giorni nostri indissolubili dalla<br />
protezione dell’ambiente. Dobbiamo intraprendere azioni prevenzione contro gli attentati<br />
all’ambiente ma allo stesso tempo sanzionare i responsabili del degrado ecologico e ambientale<br />
e cooperare con le autorità locali dei paesi dell’Est e del Sud in una alleanza destinata a proteggere<br />
il clima, l’acqua, la terra e la biodiversità. Per questo scopo vogliamo impegnare le città<br />
a realizzare e applicare i programmi locali Agenda 21 tenendo conto dell’articolo 28 del programma<br />
Generale Agenda 21 e della Carta Europea d’Aalborg.<br />
Radicate nella cultura dei loro paesi, le città sono anche un polo d’attrazione per le persone e le<br />
comunità di altre culture. La città deve proteggere il pluralismo e la convivialità. Deve rispettare<br />
la cultura di ciascuno mediante la prospettiva di una azione politica diversificata che comprenda:<br />
la difesa dei diritti delle comunità linguistiche che vivono nel paese e dei diritti linguistici di<br />
ciascuno, l’adozione di politiche multiculturali, la promozione del dialogo fra le religioni, l’azione<br />
permanente contro la discriminazione etnica e la creazione di centri d’assistenza comunitaria ai<br />
rifugiati.<br />
Prospettiamo il bisogno di attivare meccanismi di protezione e monitoraggio dei diritti umani in<br />
tutte le città europee – grandi, medie, piccole – mediante istituzioni obiettive ed indipendenti dal<br />
potere locale, incaricate di difendere i cittadini e di sostenerli per quanto riguarda i loro diritti in<br />
materia di competenza comunale.<br />
Constatiamo il ruolo attuale delle città nella promozione della cultura dei diritti umani su scala<br />
internazionale. Lanciamo dunque un appello alle istituzioni internazionali perché aprano degli<br />
spazi che permettano di far sentire la nostra voce. In questo nuovo contesto noi desideriamo<br />
favorire la cooperazione fra le città di differenti culture, con differenti situazioni economiche e<br />
soprattutto con le città in zone di conflitto. Ciascuna città deve assumere la propria responsabilità<br />
nella cooperazione internazionale e nalla partecipazione alle reti delle città per la difesa dei<br />
diritti umani.<br />
omissis<br />
426
PROTOCOLLO ADDIZIONALE N. 12 ALLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVA-<br />
GUARDIA DEI <strong>DIRITTI</strong> DELL’UOMO E DELLE LIBERTA’ FONDAMENTALI<br />
(4 novembre 2000)<br />
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente protocollo,<br />
omissis<br />
Determinati ad adottare nuove misure per promuovere l’uguaglianza di tutti attraverso la garanzia<br />
collettiva di un divieto generale di discriminazione mediante la Convenzione per la salvaguardia<br />
dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950<br />
(in appresso denominata “Convenzione”);<br />
Ribadendo che il principio di non discriminazione non impedisce agli Stati parte di adottare misure<br />
atte a promuovere una piena ed effettiva uguaglianza, a condizione che le stesse rispondano<br />
ad una obiettiva e ragionevole giustificazione,<br />
hanno concordato quanto segue:<br />
Articolo 1 – Divieto generale di discriminare<br />
1. Il godimento di qualsiasi diritto stabilito per legge deve essere garantito senza discriminazioni<br />
legate a motivi quali il sesso, la razza, il colore della pelle, la lingua, la religione, le convinzioni<br />
politiche o altro tipo di opinione, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza ad una minoranza<br />
nazionale, la situazione patrimoniale, la nascita o altro status.<br />
2. Nessuno può essere discriminato da alcuna autorità pubblica per nessuna motivazione quali<br />
quelli di cui al precedente comma 1.<br />
Omissis<br />
427
Assemblea Parlamentare<br />
429
RAPPORTO PER L’INTRODUZIONE DI UNA GARANZIA COLLETIVA RELATIVA ALLE LI-<br />
BERTA’ ESSENZIALI E AI <strong>DIRITTI</strong> FONDAMENTALI<br />
(5 settembre 1949)<br />
“Misure da adottare per il perseguimento della finalità dichiarata del Consiglio d’Europa”<br />
Rapporto presentato dal relatore TEITGEN<br />
omissis<br />
Titolo primo<br />
Articolo 2<br />
Nella Convenzione, gli Stati Membri si impegneranno a garantire ad ogni persona residente sul<br />
loro territorio:<br />
omissis<br />
5°. La libertà di pensiero, di coscienza e di religione, conformemente all’articolo 18 della Dichiarazione<br />
delle Nazioni Unite.<br />
omissis<br />
Articolo 5<br />
Le libertà e i diritti fondamentali sopra elencati saranno garantiti senza alcuna distinzione per<br />
razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o qualsiasi altra opinione, origine nazionale<br />
o sociale, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio o nascita.<br />
omissis<br />
Appendice<br />
omissis<br />
Articolo 18<br />
Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto implica la<br />
libertà di cambiare religione o credo, nonché la libertà di manifestare la propria religione o il<br />
proprio credo, individualmente o in comune, sia in pubblico che in privato, nell’insegnamento,<br />
nelle pratiche , nel culto e nell’osservanza dei riti.<br />
omissis<br />
RAPPORTO SUI <strong>DIRITTI</strong> DELLE MINORANZE NAZIONALI<br />
(26 aprile 1961)<br />
“Progetto di Raccomandazione sui diritti delle minoranze nazionali”<br />
Rapporto presentato dal Relatore Hermod LANNUNG<br />
omissis<br />
Progetto di articolo sulla tutela delle minoranze nazionali da inserire nel secondo Protocollo addizionale<br />
alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo<br />
e delle libertà fondamentali:<br />
Articolo<br />
Le persone appartenenti ad una minoranza nazionale non possono essere private del diritto, in<br />
comune con gli altri membri del gruppo di appartenenza e nei limiti consentiti per esigenze di<br />
ordine pubblico, di avere una propria vita culturale, di utilizzare la propria lingua, di aprire propri<br />
431
istituti scolastici e di ricevere l’insegnamento nella lingua di loro scelta o di professare e praticare<br />
la propria religione.<br />
omissis<br />
II. Motivazioni formulate dal Relatore Hermod LANNUNG<br />
omissis<br />
Significato del termine minoranza nazionale<br />
10. La Commissione ha preferito il termine “minoranza nazionale” a quello di “minoranza etnica,<br />
religiosa o linguistica” utilizzate nell’articolo 25 del progetto di Patto. Il motivo principale di tale<br />
preferenza risiede nel fatto che il termine “minoranza nazionale” già figura all’articolo 14 della<br />
Convenzione. Non risulta che nei lavori preparatori relativi all’articolo 14 tale termine sia stato<br />
messo in questione, e non si avverte l’esigenza di una definizione più precisa. La commissione<br />
ha inoltre deciso che ai fini del progetto di articolo in questione il termine “minoranza nazionale”<br />
dovrà essere intesa come stante ad indicare unicamente “gruppi separati o distinti, ben definiti e<br />
di antico insediamento sul territorio di uno Stato”, come le minoranze della provincia di Bolzano<br />
e dello Schleswig e che tale termine non si applicherà ai gruppi di persone che, invocando i diritti<br />
speciali indicati nel progetto di articolo, cercassero di costituire delle entità distinte<br />
nell’ambito dello Stato.<br />
omissis<br />
(a) Il termine “minoranza” si applicherà unicamente ai gruppi della popolazione non dominanti<br />
che possiedono e desiderano conservare tradizioni o caratteristiche etniche, religiose o linguistiche<br />
stabili, che si differenziano nettamente da quelle del resto della popolazione;<br />
omissis<br />
RACCOMANDAZIONE N. 285 RELATIVA AI <strong>DIRITTI</strong> DELLE MINORANZE NAZIONALI<br />
(1961)<br />
omissis<br />
Atteso che l’articolo 14 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo già garantisce alle persone appartenenti<br />
a minoranze nazionali una certa tutela, dal momento che li protegge da ogni discriminazione<br />
nel godimento dei diritti e delle libertà riconosciute dalla Convenzione;<br />
omissis<br />
Progetto di articolo sulla tutela delle minoranze nazionali, da inserire nel secondo Protocollo<br />
addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo<br />
e delle libertà fondamentali<br />
Articolo<br />
Le persone appartenenti ad una minoranza nazionale non possono essere private del diritto,<br />
individualmente o in comune con gli altri membri del gruppo di appartenenza e nei limiti consentiti<br />
per esigenze di ordine pubblico, di avere una propria vita culturale, di utilizzare la propria lingua,<br />
di aprire propri istituti scolastici e di ricevere l’insegnamento nella lingua di loro scelta o di<br />
professare e praticare la propria religione.<br />
432
RACCOMANDAZIONE N. 1134 RELATIVA AI <strong>DIRITTI</strong> DELLE MINORANZE<br />
(1990)<br />
Osservazioni generali<br />
1. In Europa esistono numerose categorie di minoranze. Esse presentano certe caratteristiche<br />
etniche, linguistiche, religiose o di altro genere che le contraddistinguono dalla maggioranza<br />
degli abitanti di una data regione o di un dato paese.<br />
omissis<br />
4. Il rispetto dei diritti delle minoranze e di coloro che ne fanno parte è un fattore essenziale per<br />
la pace, la giustizia, la stabilità e la democrazia.<br />
omissis<br />
Principi fondamentali sui diritti delle minoranze<br />
omissis<br />
10. ii) nella presente Convenzione deve essere introdotta una clausola generale di nondiscriminazione;<br />
omissis<br />
Minoranze nazionali<br />
omissis<br />
11. iii) le minoranze nazionali devono avere il diritto di disporre di proprie istituzioni educative,<br />
religiose e culturali. A tal fine, esse devono avere il diritto di richiedere contributi volontari, di carattere<br />
finanziario e di altro genere, compresa l’assistenza pubblica,<br />
omissis<br />
Obblighi per gli Stati<br />
13. Per quanto riguarda gli Stati europei, essi dovrebbero<br />
i) impegnarsi a garantire la tutela dei diritti delle minoranze nazionali e di coloro che vi<br />
appartengono nonché la possibilità di esercitare effettivamente tali diritti,<br />
omissis<br />
iv) astenersi altresì dal perseguire politiche d’assimilazione forzata o dall’adottare misure<br />
amministrative che incidano sulla composizione della popolazione nelle zone<br />
abitate da dette minoranze nazionali confinandole in “ghetti” geografici e culturali,<br />
v) dare piena attuazione alle disposizioni dell’articolo 27 del Patto internazionale sui<br />
diritti civili e politici, che recita come segue:<br />
Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione,<br />
ad una eguale tutela da parte della legge. A questo riguardo, la legge<br />
deve proibire qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli individui una tutela eguale<br />
ed effettiva contro ogni discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore,<br />
il sesso, la lingua, la religione, l’opinione politica o qualsiasi altra opinione,<br />
l’origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra<br />
condizione.<br />
omissis<br />
433
15. Essa (l’Assemblea) richiama inoltre l’attenzione sulla sugli obblighi derivanti dall’adozione<br />
degli strumenti internazionali in materia di minoranze nazionali, etniche, religiose e linguistiche,<br />
che vincolano gli Stati partecipanti al processo della CSCE.<br />
omissis<br />
RACCOMANDAZIONE N. 1177 RELATIVA AI <strong>DIRITTI</strong> DELLE MINORANZE<br />
(1992)<br />
omissis<br />
4. All’interno di tale cittadinanza comune, cittadini che condividono con altri caratteristiche specifiche<br />
– in particolare di tipo culturale, linguistico o religioso – possono tuttavia desiderare di<br />
vedersi riconosciuta e garantita la possibilità di esprimerle.<br />
omissis<br />
6. Le petizioni e le dichiarazioni di principio di autorità governative ed internazionali in favore di<br />
un riconoscimento, di una tutela, ossia di una promozione dei diritti delle “minoranze” sono oggigiorno<br />
numerose, siano esse nazionali, etniche e culturali, linguistiche o religiose.<br />
omissis<br />
RACCOMANDAZIONE N. 1201 RELATIVA A UN PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CON-<br />
VENZIONE EUROPEA SUI <strong>DIRITTI</strong> <strong>UMANI</strong> RIGUARDANTE I <strong>DIRITTI</strong> DELLE MINORANZE<br />
NAZIONALI (1993)<br />
omissis<br />
Proposta di Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle<br />
libertà fondamentali riguardante le persone appartenenti a minoranze nazionali<br />
omissis<br />
Titolo 2 – Principi generali<br />
omissis<br />
Articolo 3<br />
1. Ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale ha il diritto di esprimere, preservare<br />
e sviluppare in tutta libertà la propria identità religiosa, etnica, linguistica e/o culturale, senza<br />
subire contro la propria volontà alcun tentativo di assimilazione.<br />
omissis<br />
Articolo 4<br />
Ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale ha diritto all’uguaglianza innanzi alla<br />
legge. E vietata qualsiasi discriminazione fondata sull’appartenenza di una persona ad una minoranza<br />
nazionale.<br />
omissis<br />
Titolo 3 – Diritti sostanziali<br />
434
omissis<br />
Articolo 10<br />
Ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale ha il diritto, nella stretta osservanza<br />
dell’integrità territoriale dello Stato, di avere contatti liberi e senza ostacoli con i cittadini di un<br />
altro paese con i quali tale minoranza condivide caratteristiche etniche, religiose o linguistiche o<br />
un’identità culturale.<br />
omissis<br />
Titolo 4 – Condizioni di attuazione del Protocollo<br />
omissis<br />
Articolo 12<br />
omissis<br />
2. Le misure adottate unicamente allo scopo di tutelare le minoranze nazionali, di favorirne un<br />
adeguato sviluppo e garantire loro l’uguaglianza dei diritti e di trattamento con il resto della popolazione<br />
nei settori amministrativo, politico, economico, sociale, culturale e di altro genere non<br />
saranno considerate discriminatorie.<br />
omissis<br />
RACCOMANDAZIONE N. 1255 RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI <strong>DIRITTI</strong> DELLE MINO-<br />
RANZE NAZIONALI (1995)<br />
omissis<br />
2. Ad oggi l’Assemblea conferma i principi indicati nella Raccomandazione 1201 (1993) ed il<br />
protocollo aggiuntivo allora proposto, in particolare la definizione di “minoranza nazionale” che<br />
deve designare “un gruppo di persone in uno Stato che:<br />
omissis<br />
c. presentino specifiche caratteristiche etniche, culturali, religiose o linguistiche;<br />
omissis<br />
e. siano animate dalla volontà di preservare insieme ciò che costituisce la loro identità comune,<br />
in particolare la loro cultura, le loro tradizioni, la loro religione o la loro lingua.<br />
omissis<br />
Disposizioni della Raccomandazione 1201 (1993) sulle minoranze nazionali che potrebbero essere<br />
inserite in un protocollo aggiuntivo sui diritti culturali<br />
1. Diritto di esprimere, preservare e sviluppare la propria identità culturale<br />
435
Articolo 3<br />
Ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale ha il diritto di esprimere, preservare e<br />
sviluppare in tutta libertà la propria identità religiosa, etnica, linguistica e/o culturale, senza subire<br />
contro la propria volontà alcun tentativo di assimilazione.<br />
omissis<br />
3. Uguaglianza innanzi alla legge e non discriminazione<br />
Articolo 4<br />
Ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale ha diritto all’uguaglianza innanzi alla<br />
legge. E’ vietata qualsiasi discriminazione fondata sull’appartenenza di una persona ad una minoranza.<br />
omissis<br />
436
Progetto Melting Pot Europa<br />
437
CARTA EUROPEA DEI <strong>DIRITTI</strong> DELL’UOMO NELLA CITTA’ (18 maggio 2000)<br />
A favore delle donne e degli uomini delle città<br />
Perché elaborare, all’alba del 21° secolo, una carta europea dei diritti dell’uomo nella città? La<br />
Dichiarazione dei diritti dell’uomo (1948) è universale. Non è stata successivamente rafforzata e<br />
completata da numerosi altri impegni che hanno accentuato la tutela di certi diritti la cui portata<br />
è variabile? La Convenzione europea (1950) offre la cosiddetta garanzia giurisdizionale. Nondimeno,<br />
numerosi diritti non sono sempre “effettivi” e i cittadini mal si riconoscono nelle intricate<br />
procedure amministrative e giuridiche. Come garantire meglio? Come agire meglio? Come predisporre<br />
in modo migliore le condizioni pubbliche necessarie all’appagamento del desiderio di<br />
felicità privata di ciascuno? E’ qui che emerge il ruolo della Città. Dappertutto, laddove il popolo<br />
delle campagne prosegue la sua lunga marcia verso le città ed esse accolgono un numero<br />
sempre maggiore di viaggiatori di passaggio, ma ugualmente e soprattutto di stranieri alla ricerca<br />
della libertà, di un lavoro e di scambi di conoscenze, la città è diventata il futuro dell’umanità.<br />
E’ oggi il luogo di ogni incontro e pertanto di tutti i possibili. E’ ugualmente il terreno di tutte le<br />
contraddizioni, e quindi di tutti i pericoli: è entro lo spazio urbano dalle frontiere mal definite che<br />
si ritrovano le discriminazioni legate alla disoccupazione, ala povertà, al disprezzo delle differenze<br />
culturali, ma nel contempo è lì che si delineano e si moltiplicano delle prassi civiche e sociali<br />
di solidarietà. E’ pur vero che la città oggi ci impone di precisare meglio certi diritti, perché è<br />
il luogo dove abitiamo, dove cerchiamo del lavoro, dove ci spostiamo. Impone ugualmente di<br />
riconoscere nuovi diritti: il rispetto dell’ambiente, la garanzia di un cibo sano, di tranquillità, di<br />
possibilità di scambi e di svaghi, ecc. E’ poi vero che, di fronte alla crisi che colpisce la concezione<br />
delegataria della democrazia a livello degli Stati nazionali e all’inquietudine che suscitano<br />
le burocrazie europee, la città appare come la risorsa di un nuovo spazio politico e sociale. Là si<br />
prospettano le condizioni di una democrazia di prossimità. Là viene offerta l’occasione di una<br />
partecipazione al diritto di cittadinanza di tutti gli abitanti: una cittadinanza a livello cittadino. Se<br />
è vero che viene riconosciuto ad ogni persona ognuno dei diritti definiti, spetta ugualmente a<br />
ciascun cittadino, libero e solidale, di garantirli tutti. L’impegno che noi affermiamo qui è rivolto<br />
alle donne e agli uomini del nostro tempo. Non pretende di essere esauriente e la sua portata<br />
dipenderà dal modo in cui gli abitanti delle città se ne sentiranno investiti. Si presenta come una<br />
risposta alle aspettative dei cittadini, per le quali le città costituiscono sia l’ambito naturale in cui<br />
si manifestano, che l’elemento rivelatore. La presente Carta sarà per loro, come per quelli che li<br />
governano a livello comunale, quindi in base al principio di sussidiarietà, un insieme di costanti<br />
di riferimento sulle quali far poggiare i loro diritti, riconoscerne le eventuali violazioni e farle cessare.<br />
Tali costanti sono altrettante occasioni di superare le difficoltà e di conciliare le logiche talvolta<br />
contraddittorie che si ritrovano all’interno della vita stessa della città.<br />
Una volontà: inserire il legame sociale, in modo duraturo, nello spazio pubblico.<br />
Un principio: l’uguaglianza.<br />
Un obiettivo: l’accresciuta consapevolezza pubblica di tutti gli abitanti.<br />
Le città firmatarie,<br />
Riconoscendo che la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, il Patto Internazionale dei<br />
Diritti Civili e Politici, il Patto internazionale dei Diritti Economici, Sociali e Culturali, la Convenzione<br />
Europea per la salvaguardia dei Diritti Dell’Uomo e delle libertà fondamentali, la Carta<br />
Sociale Europea e gli altri strumenti internazionali di tutela dei diritti dell’uomo si applicano agli<br />
abitanti delle città, come a qualsiasi altra persona;<br />
Ricordando che i Diritti dell’Uomo sono universali, indivisibili ed interdipendenti, che tutti i pubblici<br />
poteri sono responsabili della loro garanzia, ma che il loro riconoscimento e i meccanismi<br />
che ne consentono l’applicazione e la protezione sono ancora insufficienti, segnatamente per<br />
quanto riguarda i diritti sociali, economici e culturali;<br />
Persuase che la buona amministrazione delle città esige il rispetto e la garanzia dei Diritti<br />
dell’uomo per tutti gli abitanti, senza esclusione, e che mira alla promozione dei valori di coesione<br />
sociale e di protezione dei più vulnerabili;<br />
Convinte per tali ragioni della necessità di una Carta europea dei diritti dell’uomo nella città che<br />
proclami solennemente e chiaramente i diritti fondamentali e le libertà pubbliche riconosciute<br />
agli abitanti delle città e l’impegno delle autorità comunali a garantirli, nel rispetto delle competenze<br />
e di poteri da esse legalmente detenuti, conformemente alle loro legislazioni nazionali;<br />
439
Ribadendo la loro approvazione della Carta europea dell’autonomia locale, in virtù della quale è<br />
necessario rendere l’amministrazione comunale maggiormente efficace e più vicina al cittadino,<br />
e in base alle raccomandazioni dell’Impegno di Barcellona, firmato il 17 ottobre 1998 dalle città<br />
che hanno partecipato alla Conferenza europea delle città per i diritti dell’uomo, volta al miglioramento<br />
dello spazio pubblico collettivo per tutti i cittadini senza distinzione di alcun genere;<br />
Hanno deciso di comune accordo di assumere i seguenti impegni:<br />
Parte I – Disposizioni generali<br />
Art. I – Diritto alla città<br />
1. La città è uno spazio collettivo che appartiene a tutti gli abitanti, i quali hanno il diritto di trovarvi<br />
le condizioni necessarie per appagare le proprie aspirazioni dal punto di vista politico, sociale<br />
ed ambientale, assumendo nel contempo i loro doveri di solidarietà.<br />
2. Le autorità comunali agevolano con ogni mezzo a loro disposizione il rispetto della dignità di<br />
tutti e la qualità della vita dei loro abitanti.<br />
Art. II – Principio di uguaglianza dei diritti e di non discriminazione<br />
1. I diritti enunciati in questa Carta sono riconosciuti a tutte le persone che vivono nelle città firmatarie,<br />
indipendentemente dalla loro nazionalità. Sono qui di seguito designate in quanto cittadini<br />
delle città.<br />
2. Tali diritti sono garantiti dalle autorità comunali, senza alcuna discriminazione legata<br />
all’origine, al colore, all’età, al sesso o alle scelte sessuali, alla lingua, alla religione, all’opinione<br />
politica, all’origine etnica, nazionale o sociale, o al reddito.<br />
Art. III – Diritto alla libertà culturale, linguistica e religiosa<br />
1. Tutti i cittadini delle città hanno il diritto di esercitare la loro libertà culturale, linguistica e religiosa.<br />
Le autorità comunali, in collaborazione con le altre amministrazioni, fanno sì che i bambini<br />
appartenenti a dei gruppi linguistici minoritari possano strusciare la loro lingua materna.<br />
2. La libertà di coscienza e di religione individuale e collettiva è garantita dalle autorità comunali<br />
a tutti i cittadini delle città. Nei limiti imposti dalla loro legislazione nazionale, si adoperano per<br />
garantire tale diritto, avendo cura di evitare la creazione di ghetti.<br />
3. Nel rispetto della laicità, le città favoriscono la reciproca tolleranza tra i credenti e i non credenti,<br />
come pure tra le diverse religioni.<br />
4. Le autorità comunali coltivano la storia delle loro popolazioni e rispettano la memoria dei cittadini<br />
defunti, garantendo il rispetto e la dignità dei cimiteri.<br />
Art. IV – Protezione dei gruppi e dei cittadini maggiormente vulnerabili<br />
1. I gruppi di cittadini maggiormente vulnerabili hanno diritto a misure specifiche di protezione.<br />
2. Le autorità comunali adottano le misure necessarie perché le persone portatrici di handicap<br />
siano pienamente integrate nella vita della città. Gli alloggi, i luoghi di lavoro e di svago devono<br />
per questo essere conformi a certe esigenze. I trasporti pubblici devono essere accessibili a tutti.<br />
3. Le città firmatarie adottano delle politiche attive di sostegno alle popolazioni maggiormente<br />
vulnerabili, garantendo a ciascuno il diritto alla cittadinanza.<br />
4. Le città adottano tute le misure per facilitare l’integrazione sociale di tutti i cittadini, qualunque<br />
sia la causa della loro vulnerabilità, evitando di raggrupparli in modo discriminatorio.<br />
omissis<br />
440
DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA<br />
441
RISOLUZIONE SULLA MOLTEPLICITA’ CULTURALE ED I PROBLEMI DELLA FORMAZIO-<br />
NE SCOLASTICA DEI FIGLI DEI LAVORATORI MIGRANTI NELLA COMUNITA’ EUROPEA<br />
(1992)<br />
Il Parlamento europeo,<br />
omissis<br />
L. considerando che un’istruzione moderna nella Comunità deve essere orientata sul principio<br />
della parità di opportunità in vista delle possibilità di partecipazione di tutti alla vita politica, economica,<br />
sociale e culturale della società, indipendentemente dal sesso, dalla nazionalità,<br />
dall’appartenenza a gruppi etnici, religiosi o culturali,<br />
omissis<br />
19. sollecita la Commissione, dopo la ratifica del Trattato sull’Unione europea, a sottoporre al<br />
Consiglio l’approvazione di un programma d’azione sulla promozione dell’educazione interculturale<br />
avente come obiettivo l’integrazione dei figli degli immigrati nei sistemi scolastici e di formazione<br />
dei paesi di accoglienza e l’ampliamento dell’esperienza didattica di tutti i bambini, affinché<br />
omissis<br />
- attraverso la promozione della formazione interculturale si migliorino le premesse di comprensione<br />
e tolleranza fra gruppi etnici e culturali aumentando il contributo dell’istruzione scolastica<br />
volto a combattere il razzismo e la xenofobia;<br />
omissis<br />
TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA (firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992)<br />
omissis<br />
Articolo 128<br />
omissis<br />
2. L’azione della Comunità è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri e, se<br />
necessario, ad appoggiare e ad integrare l’azione di questi ultimi nei seguenti settori:<br />
- miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei;<br />
omissis<br />
443
PROGETTO DI RELAZIONE SULLA TUTELA A LIVELLO DI DIRITTO COMUNITARIO DEI<br />
<strong>DIRITTI</strong> DEI GRUPPI ETNICI STANZIATI NEGLI STATI MEMBRI<br />
(14 maggio 1993)<br />
Il Parlamento europeo,<br />
omissis<br />
1. invita i governi degli Stati membri a sancire, a garantire in modo vincolante e a tutelare durevolmente,<br />
mediante l’inserimento di un titolo corrispondente nel Trattato sull’Unione europea in<br />
occasione della nuova conferenza governativa sulla modifica dei trattati prevista entro il 1996, i<br />
diritti dei gruppi etnici e dei loro appartenenti definiti come segue:<br />
Articolo 1<br />
Tutela dei gruppi etnici<br />
1. La tutela dei diritti dei gruppi etnici e dei diritti dei loro appartenenti è una componente fondamentale<br />
della tutela dei diritti umani a livello internazionale, e pertanto un fattore essenziale<br />
per la pace, la giustizia, la stabilità e la democrazia.<br />
2. Tale tutela rappresenta una legittima aspirazione di portata internazionale, e non costituisce<br />
quindi esclusivamente una questione interna del singolo Stato.<br />
Articolo 2<br />
Definizioni e campo d’applicazione<br />
1. Ai sensi della presente Carte si intende per “gruppo etnico” l’insieme di tutti quei cittadini di<br />
uno Stato membro della Comunità europea che:<br />
- presentano caratteristiche etniche, linguistiche, storiche, culturali e/o religiose che li distinguono<br />
dalle altre popolazioni.<br />
omissis<br />
Articolo 4<br />
Diritto all’esistenza<br />
1. Gli Stati membri tutelano l’esistenza delle minoranze nonché la loro identità nazionale, etnica,<br />
culturale, religiosa e linguistica, e assicurano le condizioni necessarie per la promozione di tale<br />
identità.<br />
2. I gruppi etnici e i loro appartenenti hanno diritto ad essere protetti da ogni pericolo che minacci<br />
la loro esistenza e a veder preservata la loro ragione etnica, in modo da non rischiare trasferimenti<br />
o trasporti forzati e da non essere vittime di altre misure volte a modificare, a loro detrimento,<br />
la situazione demografica della loro regione di appartenenza.<br />
3. I gruppi etnici e i loro appartenenti hanno diritto ad un territorio quale elemento inalienabile<br />
della loro identità etnica e del loro sviluppo, e in particolare alla tutela delle loro regioni di insediamento<br />
e delle loro condizioni di vita tradizionali.<br />
4. I diritti sanciti della presente Carta implicano anche la promozione dei gruppi etnici in quanto<br />
tali.<br />
Articolo 5<br />
Diritto alla non discriminazione e al pari trattamento<br />
1. Gli appartenenti ad un gruppo etnico hanno il diritto, sul territorio dello Stato di cui sono cittadini:<br />
- di esercitare pienamente ed efficacemente i propri diritti umani e libertà fondamentali, senza<br />
subire discriminazione alcuna e in totale parità con i loro concittadini della popolazione maggioritaria;<br />
- di beneficiare, allo stesso titolo e nella stessa misura degli alti cittadini, dei diritti sociali ed economici<br />
generali;<br />
- di partecipazione liberamente a tutti gli aspetti della vita sociale della popolazione maggioritaria.<br />
444
2. I gruppi etnici e i loro appartenenti devono essere equamente associati a beneficiare delle<br />
risorse naturali della loro regione etnica.<br />
3. Le misure specifiche a tutela dei gruppi etnici e dei loro appartenenti sono conformi al principio<br />
di eguaglianza e di non discriminazione rispetto agli altri cittadini dello Stato membro interessato,<br />
e non devono essere considerate come un atto discriminatorio nei confronti della popolazione<br />
maggioritaria.<br />
4. I diritti specifici dei gruppi etnici e dei loro appartenenti non trascendono, per contenuto e portata,<br />
gli analoghi diritti della popolazione maggioritaria e dei suoi appartenenti.<br />
Articolo 6<br />
Diritto a riconoscersi in un gruppo etnico<br />
Ogni appartenente ad un gruppo etnico ha il diritto di proclamare liberamente la sua appartenenza<br />
a quest’ultimo senza che lo Stato eserciti costrizioni o operi un controllo a tale proposito,<br />
e non deve essere a ciò costretto né in maniera diretta né indirettamente.<br />
omissis<br />
Articolo 11<br />
Diritto al libero esercizio della religione<br />
I gruppi etnici e i loro appartenenti che appartengono ad una confessione religiosa diversa da<br />
quella della popolazione maggioritaria hanno il diritto di esercitare liberamente la loro religione,<br />
di fondare le proprie comunità e istituzioni religiose e di utilizzare la loro lingua e le forme loro<br />
proprie per i riti e l’insegnamento religiosi.<br />
Articolo 12<br />
Diritto alla libertà di contatto<br />
I gruppi etnici e i loro appartenenti hanno il diritto, al fine di promuovere e rafforzare le loro specificità<br />
comuni, di stabilire e mantenere liberamente contatti tra loro all’interno del loro paese<br />
nonché, oltre frontiera, con i cittadini di altri Stati appartenenti alla stessa comunità etnica o alla<br />
stessa confessione religiosa.<br />
omissis<br />
DECISIONE N. 819/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO CHE ISTITUISCE IL PROGRAM-<br />
MA D’AZIONE COMUNITARIO “SOCRATE”<br />
(14 marzo 1995)<br />
Il Parlamento europeo ed il Consiglio dell’Unione europea,<br />
omissis<br />
considerando che la Comunità e gli Stati membri dovrebbero promuovere l’accesso in particolare<br />
per le persone più svantaggiate, alle iniziative organizzate come parte del presente programma<br />
SOCRATE lottando in questo modo contro l’esclusione sociale;<br />
omissis<br />
considerando che occorre promuovere la dimensione interculturale dell’insegnamento per gli<br />
studenti dell’Unione europea, per prepararli a vivere in una società sempre più caratterizzata<br />
dalla diversità culturale e linguistica; che occorre adottare misure per migliorare la qualità<br />
dell’insegnamento impartito ai figli dei lavoratori migranti, degli zingari, delle persone che esercitano<br />
professioni itineranti e delle persone che viaggiano per lavoro, nonché per combattere il<br />
razzismo e la xenofobia;<br />
omissis<br />
445
Articolo 3<br />
Obiettivi<br />
Il presente programma promuove la cooperazione tra gli Stati membri nel settore dell’istruzione;<br />
ne sostiene e integra l’azione nel pieno rispetto delle rispettive responsabilità per quanto concerne<br />
il contenuto dell’insegnamento e l’organizzazione del sistema di istruzione, nonché della<br />
loro diversità culturale e linguistica.<br />
omissis<br />
b) promuovere un miglioramento quantitativo e qualitativo della conoscenza delle lingue<br />
dell’Unione europea, in particolare di quelle meno diffuse e meno insegnate, al fine di rafforzare<br />
la comprensione e la solidarietà tra i popoli che costituiscono l’Unione stessa, nonché di promuovere<br />
la dimensione interculturale dell’insegnamento;<br />
omissis<br />
RISOLUZIONE SUL FUNZIONAMENTO DEL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA IN VI-<br />
STA DELLA CONFERENZA INTERGOVERNATIVA DEL 1996 - REALIZZAZIONE E SVI-<br />
LUPPO DELL’UNIONE -<br />
(17 maggio 1995)<br />
Il Parlamento Europeo,<br />
A. atteso che l’integrazione europea che, fin dagli inizi, è stata sinonimo di pace, stabilità politica<br />
ed armonioso sviluppo economico e sociale a beneficio di tutti i cittadini, ora affronta nuove<br />
sfide, nate al termine della Guerra Fredda, a seguito sia della globalizzazione dell’economia, dei<br />
danni all’ambiente e della rivoluzione informatica che della crescente rilevanza assunta dal tema<br />
della parità fra uomo e donna; considerato che tali sfide richiedono iniziative da parte<br />
dell’Unione Europea in grado di:<br />
omissis<br />
(d) garantire a tutti i cittadini la possibilità di esercitare i propri diritti e le<br />
proprie libert à e di contribuire al manteniment o della sicurezza dell’individuo,<br />
salvaguardando le ident ità culturali nazionali e regionali,<br />
omissis<br />
D. Maggiori diritti per i cittadini dell’UE e migliore tutela dei diritti fondamentali di tutti coloro che<br />
risiedono sul territorio dell’UE<br />
7. Occorre conferire maggiore rilevanza al concetto di cittadinanza UE mediante lo sviluppo dei<br />
diritti speciali ad essa connessi, in particolare attraverso:<br />
omissis<br />
- la salvaguardia della diversità dell’Europa prevedendo speciali tutele per le tradizionali minoranze<br />
nazionali in termini di diritti umani, democrazia e legalità;<br />
omissis<br />
446
RISOLUZIONE SUL PARERE DEL PARLAMENTO EUROPEO SULLA CONVOCAZIONE<br />
DELLA CONFERENZA INTERGOVERNATIVA, LA VALUTAZIONE DEI LAVORI DEL<br />
GRUPPO DI RIFLESSIONE E LA PRECISAZIONE DELLE PRIORITÀ POLITICHE DEL PAR-<br />
LAMENTO EUROPEO IN VISTA DELLA CONFERENZA INTERGOVERNATIVA (1996)<br />
Il Parlamento europeo,<br />
omissis<br />
Le priorità essenziali per il futuro dell’Europa<br />
2. conferma e ribadisce la sua risoluzione summenzionata del 17 maggio 1995 quale base della<br />
sua posizione sulla CIG; ritiene che vi sia un certo numero di priorità essenziali, cui la CIG deve<br />
dare valida risposta se si vuole che i risultati della Conferenza meritino di essere ratificati:<br />
I. una cittadinanza europea meglio definita e un maggiore rispetto dei diritti dell’uomo, grazie ad<br />
un ampliamento dei diritti specifici riconosciuti ai cittadini europei nel contesto del trattato, alla<br />
protezione dei diritti umani fondamentali e dei principi della parità di trattamento e della non discriminazione<br />
nonché al raggruppamento, in un unico capitolo sulla cittadinanza europea, dei<br />
diritti riguardanti i cittadini, attualmente disseminati nel trattato, e infine con l’introduzione, tramite<br />
la Corte di giustizia europea, di una tutela giuridica integrale per gli organi dell’Unione, gli<br />
Stati membri e ci cittadini; il rafforzamento della dimensione culturale e delle opportunità di<br />
scambio all’interno dell’Unione avranno un considerevole impatto sulla sua legittimità democratica.<br />
omissis<br />
Una strategia, una dinamica istituzionale e degli strumenti al servizio di queste priorità essenziali<br />
4. Una cittadinanza europea meglio definita e un maggiore rispetto dei diritti dell’uomo<br />
omissis<br />
4.5 L’Unione europea dovrebbe introdurre in questo speciale capitolo il principio della parità di<br />
trattamento e della non discriminazione, a prescindere, in particolare, dalla razza, dal sesso,<br />
dalla tendenza sessuale, dall’età, dalla religione o dall’handicap.<br />
4.6 In questo stesso capitolo dovrebbe figurare un riferimento esplicito all’abolizione della pena<br />
capitale e alla repressione di ogni atto di violenza, vessazioni e soprusi a sfondo razziale o antisemita;<br />
omissis<br />
4.16. Nel trattato vanno riconosciuti ai cittadini di Stati terzi che risiedono legalmente<br />
nell’Unione il rispetto dei diritti umani, la parità di trattamento e la non discriminazione in materia<br />
di diritti sociali, economici e culturali nonché il diritto di voto alle elezioni locali, in conformità della<br />
Convenzione del Consiglio d’Europa.<br />
omissis<br />
7.4. Il trattato deve prevedere un chiaro obbligo, per l’Unione, di sviluppare una politica volta a<br />
vincere l’ingiustizia sociale, l’esclusione, la discriminazione e la povertà e dovrebbe attribuire<br />
alla Commissione le competenze necessarie per attuare tale politica.<br />
omissis<br />
447
TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA E CONFERENZA INTERGOVERNATIVA (1996)<br />
Il Parlamento europeo,<br />
omissis<br />
A. considerando che l’integrazione europea, che dalle sue origini è sinonimo di pace, di stabilità<br />
politica e di armonioso sviluppo economico e sociale a beneficio di tutti i cittadini, deve confrontarsi<br />
oggigiorno con una serie di nuove sfide, nate alla fine della “guerra fredda”, che scaturiscono<br />
dalla mondializzazione dell’economia e dalle aggressioni all’ecologia, dalla rivoluzione<br />
informatica e dalle sue ripercussioni sull’occupazione, nonché dalla crescente importanza della<br />
parità tra uomo e donna; considerando che queste sfide richiedono all’Unione europea iniziative<br />
che le consentono di:<br />
omissis<br />
d) garantire ai cittadini l’esercizio dei loro diritti e libertà e contribuire al mantenimento della sicurezza<br />
di ciascuno, salvaguardando nel contempo le identità culturali, nazionali o regionali,<br />
omissis<br />
D. Accrescere i diritti dei cittadini dell’Unione e migliorare la protezione dei diritti fondamentali di<br />
tutte le persone in essa residenti<br />
7. Occorre dare maggiore sostanza al concetto di cittadinanza dell’UE attraverso lo sviluppo dei<br />
diritti speciali collegati alla cittadinanza dell’Unione, segnatamente mediante<br />
omissis<br />
- la consacrazione della diversità dell’Europa, anche mediante la particolare tutela delle minoranze<br />
nazionali di antico insediamento, nel quadro dei diritti dell’uomo, della democrazie e dello<br />
stato di diritto;<br />
omissis<br />
Inoltre, il trattato dovrebbe contenere un chiaro rifiuto del razzismo, della xenofobia, delle discriminazioni<br />
basate sulle tendenze sessuali, dell’antisemitismo, del revisionismo e di ogni altra<br />
forma di discriminazione e garantire un’adeguata protezione giuridica di tutte le persone residenti<br />
nel territorio dell’Unione europea contro la discriminazione.<br />
omissis<br />
11. Occorre conservare l’identità e la diversità culturale dell’Europa e riconoscere esplicitamente<br />
l’importanza della ricchezza fornita dalla diversità culturale e linguistica nazionale e regionale<br />
in seno all’Unione europea.<br />
Va esclusa qualsiasi restrizione riguardante il numero delle lingue ufficiali e di lavoro dell’Unione<br />
europea.<br />
Di fronte al carattere multiculturale della società europea, va esplicitata la necessità di promuovere<br />
il dialogo interculturale che mira a rafforzare la comprensione e la tolleranza reciproca.<br />
omissis<br />
448
DIRETTIVA 97/36/CE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 89/552/CEE SUL<br />
COORDINAMENTO DI DETERMINATE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E<br />
AMMINISTRATIVE NEGLI STATI MEMBRI E CONCERNENTI L’ESERCIZIO DELLE ATTIVI-<br />
TÀ TELEVISIVE (1997)<br />
Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea<br />
omissis<br />
hanno adottato la seguente direttiva:<br />
omissis<br />
28) E’ inserito il seguente articolo:<br />
“Articolo 22 bis<br />
Gli Stati membri fanno si che le trasmissioni non contengano alcun incitamento all’odio basato<br />
su differenze di razza, sesso, religione o nazionali”.<br />
omissis<br />
CARTA DEI <strong>DIRITTI</strong> FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA<br />
(Nizza 7 dicembre 2000)<br />
Preambolo<br />
1. I popoli europei nel creare tra loro un’unione sempre più stretta hanno deciso di condividere<br />
un futuro di pace fondato su valori comuni.<br />
2. Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l’Unione si fonda sui valori indivisibili e<br />
universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l’Unione si basa sui principi<br />
di democrazia e dello stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo<br />
la cittadinanza dell’Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.<br />
omissis<br />
Capo III - Uguaglianza<br />
omissis<br />
Articolo 21 – Non discriminazione<br />
1. E’ vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore<br />
della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le<br />
convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza<br />
nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali.<br />
2. Nell’ambito d’applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato<br />
sull’Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le<br />
disposizioni particolari contenute nei trattati stessi.<br />
Articolo 22 – Diversità culturale, religiosa e linguistica<br />
L’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.<br />
omissis<br />
449
COSTITUZIONE EUROPEA<br />
(28 ottobre 2004)<br />
omissis<br />
Parte II<br />
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione<br />
Preambolo<br />
I popoli d’Europa, nel creare tra loro un’unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere<br />
un futuro di pace fondato su valori comuni.<br />
Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l’Unione si fonda sui valori indivisibili e universali<br />
della dignità umana, della libertà, dell’uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul<br />
principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto. Pone la persona al centro della<br />
sua azione istituendo la cittadinanza dell’Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e<br />
giustizia.<br />
L’Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della<br />
diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli d’Europa, nonché dell’identità nazionale degli<br />
Stati membri e dell’ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale;<br />
essa si sforza di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione<br />
delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali, nonché la libertà di stabilimento.<br />
A tal fine è necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, alla luce dell’evoluzione della<br />
società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più visibili<br />
in una Carta.<br />
La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell’Unione e del principio<br />
di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi<br />
internazionali comuni agli Stati membri, dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti<br />
dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dall’Unione e dal Consiglio<br />
d’Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e da quella<br />
della Corte europea dei diritti dell’uomo. In tale contesto, la Carta sarà interpretata dai giudici<br />
dell’Unione e degli Stati membri tenendo in debito conto le spiegazioni elaborate sotto l’autorità<br />
del praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilità<br />
del praesidium della Convenzione europea.<br />
Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure<br />
della comunità umana e delle generazioni future.<br />
Pertanto, l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi enunciati in appresso.<br />
omissis<br />
Articolo II-81<br />
Non discriminazione<br />
1. E’ vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore<br />
della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o<br />
convinzione personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza<br />
nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.<br />
2. Nell’ambito d’applicazione della Costituzione e fate salve disposizioni specifiche in essa contenute,<br />
è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.<br />
Articolo II-82<br />
Diversità culturale, religiosa e linguistica<br />
L’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.<br />
omissis<br />
450
DOCUMENTI DELLA O.S.C.E.<br />
451
ATTO FINALE DELLA CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EU-<br />
ROPA (Helsinki, 1975)<br />
omissis<br />
VII. Rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, inclusa la libertà di pensiero, coscienza,<br />
religione o credo<br />
Gli Stati partecipanti rispettono i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali, inclusa la libertà di<br />
pensiero, coscienza, religione o credo, per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.<br />
Essi promuovono e incoraggiano l’esercizio effettivo delle libertà e dei diritti civili, politici, economici,<br />
sociali, culturali ed altri che derivano tutti dalla dignità inerente alla persona umana e<br />
sono essenziali al suo libero e pieno sviluppo.<br />
In questo contesto gli Stati partecipanti riconoscono e rispettano la libertà dell’individuo di professare<br />
e praticare, solo o in comune con altri, una religione o un credo agendo secondo i dettami<br />
della propria coscienza.<br />
Gli Stati partecipanti nel cui territorio esistono minoranze nazionali rispettano il diritto delle persone<br />
appartenenti a tali minoranze all’uguaglianza di fronte alla legge, offrono la loro piena possibilità<br />
di godere effettivamente dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e, in tal modo i<br />
loro legittimi interessi in questo campo.<br />
Gli stati partecipanti riconscono il significato universale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,<br />
il cui rispetto è un fattore essenziale della pace, della giustizia e del benessere necessari<br />
ad assicurare lo sviluppo di relazioni amichevoli e della cooperazione fra loro, come fra<br />
tutti gli Stati.<br />
Essi rispettano costantemente tali diritti e libertà nei loro reciproci rapporti e si adoperano congiuntamente<br />
e separatamente, nonché in cooperazione con le Nazioni Unite, per promuoverne<br />
il rispetto universale ed effettivo.<br />
Essi confermano il diritto dell’individuo di conoscere i propri diritti e doveri in questo campo e di<br />
agire in conseguenza.<br />
Nel campo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, gli Stati partecipanti agiscono conformemente<br />
ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite e alla Dichiarazione universale<br />
dei diritti dell’uomo. Inoltre adempiono i loro obblighi quali sono enunciati nelle dichiarazioni e<br />
negli accordi internazionali pertinenti, ivi compresi fra l’altro i Patti internazionali diritti<br />
dell’uomo, da cui siano vincolati.<br />
omissis<br />
Cooperazione nel settore umanitario e in altri settori<br />
Gli Stati partecipanti,<br />
desiderosi si contribuire al rafforzamento della pace e della comprensione tra i popoli ed<br />
all’arricchimento spirituale della personalità umana senza distinzione di razza, sesso, lingue o<br />
religione,<br />
omissis<br />
hanno adottato quanto segue:<br />
omissis<br />
3. e 4. Cooperazione e scambi nel campo della cultura e dell’educazione<br />
omissis<br />
Minoranze nazionali o culture regionali.<br />
453
Gli Stati partecipanti, riconoscendo il contributo che le minoranze nazionali o le culture regionali<br />
possono apportare alla cooperazione tra di essi in diversi campi dell’educazione, si propongono,<br />
laddove esistano sul loro territorio tali minoranze o culture, e tenendo conto degli interessi<br />
legittimi dei loro membri, di facilitare questo contributo.<br />
DOCUMENTO CONCLUSIVO DELLA RIUNIONE DI MADRID (1980 - 1983)<br />
Questioni relative alla sicurezza in Europa<br />
omissis<br />
Gli Stati partecipanti ribadiscono la loro determinazione di promuovere e incoraggiare l’esercizio<br />
effettivo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, che derivano tutti dalla dignità inerente<br />
alla persona umana e sono essenziali al suo libero e pieno sviluppo, e di assicurare un progresso<br />
costante e tangibile conformemente all’Atto Finale, mirando ad un ulteriore e continuo<br />
sviluppo in questo campo in tutti gli stati partecipanti indipendentemente dai loro sistemi politici,<br />
economici e sociali.<br />
Essi ribadiscono parimenti la loro determinazione di sviluppare le loro leggi e regolamenti nel<br />
campo dei diritti civili, politici, economici, sociali, culturali e degli altri diritti dell’uomo e delle libertà<br />
fondamentali; inoltre ribadiscono la loro determinazione di garantire l’esercizio effettivo di<br />
tali diritti e libertà.<br />
omissis<br />
Gli Stati partecipanti riaffermano che riconosceranno e rispetteranno ed inoltre concordano di<br />
intraprendere le azioni necessarie a garantire la libertà dell’individuo di professare e praticare,<br />
solo o in comune con altri, una religione o un credo agendo secondo i dettami della propria conoscenza.<br />
omissis<br />
DOCUMENTO CONCLUSIVO DELLA RIUNIONE DI VIENNA (1986-1989)<br />
Questioni relative alla sicurezza in Europa<br />
omissis<br />
Principi<br />
omissis<br />
19. Essi proteggeranno e creeranno le condizioni per la promozione dell'identità etnica, culturale,<br />
linguistica e religiosa delle minoranze nazionali nel loro territorio. Essi rispetteranno il libero<br />
esercizio dei diritti delle persone che appartengono a tali minoranze e assicureranno la loro piena<br />
uguaglianza con le altre persone.<br />
omissis<br />
59. Essi assicureranno che le persone appartenenti a minoranze nazionali o a culture regionali<br />
che si trovano nel loro territorio abbiano ogni opportunità di mantenere e sviluppare la propria<br />
cultura in tutti i suoi aspetti, comprese la lingua, la letteratura, la religione, e che possano preservare<br />
i propri monumenti e oggetti culturali e storici.<br />
omissis<br />
454
68. Essi assicureranno che le persone appartenenti a minoranze nazionali o a culture regionali<br />
che si trovano nei loro territori possano impartire o ricevere un'istruzione sulla propria cultura,<br />
fra l’altro, tramite la trasmissione dai genitori ai figli della lingua, della religione e dell’identità culturale.<br />
omissis<br />
DOCUMENTO DELLA RIUNIONE DI COPENAGHEN DELLA CONFERENZA SULLA DI-<br />
MENSIONE UMANA DELLA CSCE (29 GIUGNO 1990)<br />
omissis<br />
Parte IV<br />
30) Gli Stati partecipanti riconoscono che le questioni relative alle minoranze nazionali possono<br />
essere risolte in maniera soddisfacente solo in un quadro politico democratico basato sullo Stato<br />
di diritto, con un sistema giudiziario indipendente e funzionante. Tale quadro garantisce il<br />
pieno rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, diritti e condizioni uguali per tutti i<br />
cittadini, la libera espressione di tutti i loro interessi ed aspirazioni legittimi, il pluralismo politico,<br />
la tolleranza sociale e l'applicazione di norme giuridiche che pongano efficaci limitazioni all'abuso<br />
del potere governativo.<br />
Essi riconoscono inoltre l'importante ruolo delle organizzazioni non governative, ivi compresi i<br />
partiti politici, i sindacati, le organizzazioni e i gruppi religiosi, che si occupano dei diritti dell'uomo,<br />
per la promozione della tolleranza, delle diversità culturali, e per la soluzione delle questioni<br />
relative alle minoranze nazionali.<br />
Essi inoltre riaffermano che il rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali,<br />
in quanto parte dei diritti dell'uomo universalmente riconosciuti, è un fattore essenziale per la<br />
pace, la giustizia, la stabilità e la democrazia negli Stati partecipanti.<br />
31) Le persone appartenenti a minoranze nazionali hanno il diritto di esercitare pienamente ed<br />
effettivamente i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali senza discriminazione di alcun genere<br />
e in piena eguaglianza dinanzi alla legge. Gli Stati partecipanti adotteranno, ove necessario,<br />
misure speciali allo scopo di garantire alle persone appartenenti a minoranze nazionali piena<br />
uguaglianza rispetto agli altri cittadini nell’esercizio e nel godimento dei diritti dell’uomo e delle<br />
libertà fondamentali.<br />
32) L'appartenenza ad una minoranza nazionale costituisce una scelta propria di ciascuna persona<br />
e nessuno svantaggio può derivare dall'esercizio di tale scelta.<br />
Le persone appartenenti a minoranze nazionali hanno il diritto di esprimere liberamente, preservare<br />
e sviluppare la propria identità etnica, culturale, linguistica o religiosa e di mantenere e<br />
sviluppare la propria cultura in tutti i suoi aspetti, al riparo da ogni tentativo di assimilazione contro<br />
la loro volontà. In particolare esse hanno il diritto:<br />
omissis<br />
32.2.) - di creare e conservare proprie istituzioni, organizzazioni o associazioni educative, culturali<br />
e religiose, che possano richiedere contributi volontari e di altro genere, nonché l'assistenza<br />
pubblica conformemente alla legislazione nazionale;<br />
32.3.) - di professare e praticare la propria religione, ivi compresi l'acquisizione, il possesso e<br />
l'uso di materiali religiosi, nonché di svolgere attività educative religiose nella propria lingua;<br />
32.4.) - di stabilire e mantenere liberi contatti fra loro nel proprio paese nonché oltre frontiera<br />
con cittadini degli altri Stati con i quali essi hanno in comune l'origine nazionale o etnica, il retaggio<br />
culturale o le convinzioni religiose;<br />
32.5.) - di diffondere, avere accesso e scambiare informazioni nella propria madrelingua;<br />
32.6.) - di costituire e mantenere organizzazioni o associazioni all'interno del proprio paese e di<br />
partecipare ad organizzazioni internazionali non governative.<br />
omissis<br />
455
33) Gli Stati partecipanti tuteleranno l’identità etnica, culturale, linguistica e religiosa delle minoranze<br />
nazionali sul loro territorio e creeranno condizioni per la promozione di tale identità. Essi<br />
adotteranno le misure necessarie a tale scopo una volta effettuate le debite consultazioni, ivi<br />
compresi i contatti con organizzazioni o associazioni di tali minoranze, conformemente alla procedura<br />
decisionale di ciascuno Stato. Tali misure saranno conformi ai principi di uguaglianza e<br />
non discriminazione nei confronti degli altri cittadini dello Stato partecipante interessato.<br />
omissis<br />
35) Gli Stati partecipanti rispettano il diritto delle persone appartenenti al minoranze nazionali di<br />
partecipare effettivamente agli affari pubblici, ivi compresa la partecipazione alle questioni relative<br />
alla tutela e alla promozione dell'identità di tali minoranze.<br />
Gli Stati partecipanti rilevano gli sforzi intrapresi per tutelare e creare condizioni idonee alla<br />
promozione dell'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa di determinate minoranze nazionali<br />
mediante la costituzione, come uno dei mezzi possibili per conseguire tali finalità, di amministrazioni<br />
locali o autonome adeguate, rispondenti ai fattori specifici storici e territoriali relativi a<br />
tali minoranze e conformi alle politiche dello Stato in questione.<br />
36) Gli Stati partecipanti riconoscono la particolare importanza di una maggiore cooperazione<br />
costruttiva tra loro sulle questioni relative a minoranze nazionali. Tale cooperazione cerca di<br />
promuovere la comprensione e la fiducia reciproche, relazioni amichevoli e di buon vicinato, la<br />
pace, la sicurezza e la giustizia internazionali.<br />
Ciascuno Stato partecipante promuove un clima di mutuo rispetto, comprensione, cooperazione<br />
e solidarietà tra tutte le persone che vivono nel suo territorio, senza distinzione di origine etnica<br />
o nazionale o di religione e incoraggia la soluzione dei problemi attraverso il dialogo fondato sui<br />
principi dello Stato di diritto.<br />
omissis<br />
40) Gli Stati partecipanti condannano chiaramente e inequivocabilmente il totalitarismo, l'odio<br />
razziale ed etnico, l'antisemitismo, la xenofobia e la discriminazione contro qualsiasi persona,<br />
nonché le persecuzioni per motivi religiosi o ideologici. In tale contesto, essi riconoscono inoltre<br />
i particolari problemi dei Rom (zingari).<br />
Essi dichiarano la propria ferma intenzione di intensificare gli sforzi per combattere questi fenomeni<br />
in tutte le loro forme e pertanto essi:<br />
40.1.) - prenderanno misure efficaci, inclusa l'adozione, conformemente ai propri sistemi costituzionali<br />
e ai loro obblighi internazionali, delle leggi che si rendano necessarie per assicurare la<br />
tutela contro qualsiasi atto che costituisca incitamento alla violenza contro persone o gruppi sulla<br />
base di discriminazione, ostilità od odio nazionale, razziale, etnico o religioso, ivi compreso<br />
l'antisemitismo,<br />
40.2.) - si impegneranno ad adottare misure appropriate e adeguate per tutelare persone o<br />
gruppi che possono essere soggetti a minacce o ad atti di discriminazione, di ostilità o di violenza<br />
a seguito della loro identità razziale, etnica, culturale, linguistica o religiosa e a proteggerne<br />
la proprietà,<br />
40.3.) - adotteranno, conformemente ai loro sistemi costituzionali, misure efficaci, a livello nazionale,<br />
regionale e locale, per favorire la comprensione e la tolleranza, particolarmente nei settori<br />
dell'educazione, della cultura e dell'informazione,<br />
40.4.) - si adopereranno per assicurare che tra i fini dell'educazione sia compreso quello di prestare<br />
particolare attenzione al problema del pregiudizio e dell'odio razziale e dello sviluppo del<br />
rispetto delle culture e civiltà diverse,<br />
40.5.) - riconosceranno il diritto degli individui a ricorsi efficaci e si adopereranno per riconoscere,<br />
conformemente alla legislazione nazionale, il diritto delle persone e dei gruppi interessati ad<br />
avviare e sostenere ricorsi contro atti di discriminazione, ivi compresi atti razzisti e xenofobi,<br />
40.6.) - prenderanno in considerazione l'adesione, qualora non lo abbiano ancora fatto, agli<br />
strumenti internazionali che contemplano il problema della discriminazione e garantiranno la<br />
piena attuazione degli obblighi ivi contenuti, compresi quelli relativi alla presentazione di rapporti<br />
periodici,<br />
456
(40.7.) - considereranno inoltre l'opportunità di accettare i meccanismi internazionali che consentono<br />
agli Stati e agli individui di presentare comunicazioni concernenti la discriminazione<br />
dinnanzi ad organismi internazionali.<br />
omissis<br />
CARTA DI PARIGI PER UNA NUOVA EUROPA (21 NOVEMBRE 1990)<br />
omissis<br />
Diritti dell’Uomo, Democrazia e Stato di Diritto<br />
Ci impegniamo a edificare, consolidare e rafforzare la democrazia quale unico sistema di governo<br />
delle nostre nazioni. Nel perseguire questo fine, ci atterremo a quanto segue.<br />
I diritti dell’uomo e le libertà fondamentali sono diritti innati di ogni essere umano, sono inalienabili<br />
e garantiti dalla legge. Responsabilità primaria del governo è tutelarli e promuoverli. Il loro<br />
rispetto costituisce una salvaguardia indispensabile contro gli eccessi di potere di uno stato. La<br />
loro osservanza e il loro pieno esercizio sono il fondamento della libertà, della giustizia e della<br />
pace.<br />
Il governo democratico si basa sulla volontà del popolo, espressa regolarmente attraverso elezioni<br />
libere e corrette. Fondamento della democrazia è il rispetto della persona umana e dello<br />
stato di diritto. La democrazia è la migliorare salvaguardia della libertà di espressione, della tolleranza<br />
di tutti i gruppi della società, e dell’uguaglianza di opportunità per ogni persona.<br />
La democrazia, con il suo carattere rappresentativo e pluralistico, comporta responsabilità nei<br />
confronti dell’elettorato, l’obbligo delle autorità pubbliche di osservare la legge e la giustizia<br />
amministrata imparzialmente. Nessuno deve essere al di sopra della legge.<br />
Affermiamo che, senza discriminazioni, ogni persona ha il diritto:<br />
alla libertà di pensiero, coscienza e religione o credo,<br />
alla libertà di espressione,<br />
alla libertà di associazione e di riunione pacifica,<br />
alla libertà di movimento;<br />
nessuno sarà:<br />
arbitrariamente arrestato o detenuto,<br />
sottoposto a tortura o ad altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;<br />
ciascuno ha inoltre il diritto:<br />
di conoscere i propri diritti e di esercitarli,<br />
di partecipare ad elezioni libere e corrette,<br />
ad un procedimento giudiziario imparziale e pubblico se imputato di un reato,<br />
di possedere beni individualmente o in comune con altri e di gestire imprese individuali,<br />
di godere dei propri diritti economici, sociali e culturali.<br />
Affermiamo che l’identità etnica, culturale, linguistica e religiosa delle minoranze sarà tutelata e<br />
che le persone appartenenti a minoranze nazionali hanno il diritto di esprimere liberamente,<br />
preservare e sviluppare tale identità senza discriminazioni di alcun genere e di in piena uguaglianza<br />
di fronte alla legge.<br />
Garantiremo che ognuno possa disporre di efficaci strumenti di ricorso in sede nazionale o internazionale,<br />
contro qualsiasi violazione dei suoi diritti.<br />
Il pieno rispetto di tali precetti costituisce il fondamento su cui cercheremo di costruire la nuova<br />
Europa.<br />
I nostri Stai coopereranno e si sosterranno l’un l’altro con l’obiettivo di rendere irreversibili tali<br />
conquiste democratiche.<br />
omissis<br />
Dimensione Umana<br />
omissis<br />
457
Decisi a promuovere il prezioso contributo delle minoranze nazionali alla vita delle nostre società,<br />
ci impegniamo a migliorare ulteriormente la loro condizione. Riaffermiamo la nostra profonda<br />
convinzione che le relazioni amichevoli fra i nostri popoli, nonché la pace, la giustizia, la stabilità<br />
e la democrazia, richiedono che venga tutelata l’identità etnica, culturale, linguistica e religiosa<br />
delle minoranze nazionali e che vengano create le condizioni per la promozione di tale identità.<br />
Dichiariamo che le questioni relative alle minoranze nazionali possono essere risolte soddisfacentemente<br />
soltanto in un contesto politico democratico. Riconosciamo inoltre che i diritti delle<br />
persone appartenenti a minoranze nazionali devono essere pienamente rispettati quale parte<br />
dei diritti universali dell’uomo. Consapevoli dell’urgente esigenza di una maggiore cooperazione<br />
per quanto riguarda le minoranze nazionali, nonché di una loro migliore tutela, decidiamo di<br />
convocare una riunione di esperti sulle minoranze nazionali da tenersi a Ginevra dall’1 al 19 luglio<br />
1991. Esprimiamo la nostra determinazione di combattere tutte le forme di odio razziale ed<br />
etnico, l’antisemitismo, la xenofobia e la discriminazione contro chiunque nonché la persecuzione<br />
per motivi religiosi o ideologici.<br />
omissis<br />
RAPPORTO DELLA RIUNIONE CSCE DI ESPERTI SULLE MINORANZE NAZIONALI<br />
(GINEVRA 19 LUGLIO 1991)<br />
omissis<br />
Parte I<br />
Riconoscendo che la loro osservanza ed il pieno esercizio dei diritti dell'uomo e delle libertà<br />
fondamentali, inclusi quelli delle persone appartenenti alle minoranze nazionali, sono il fondamento<br />
della nuova Europa,<br />
Riaffermando la loro profonda convinzione che relazioni amichevoli fra i loro popoli, nonché la<br />
pace, la giustizia, la stabilità e la democrazia, richiedono che l'identità etnica, culturale, linguistica<br />
e religiosa delle minoranze nazionali sia tutelata, e che siano create condizioni per la promozione<br />
di tale identità,<br />
Convinti che, negli Stati con minoranze nazionali, la democrazia richiede che tutte le persone,<br />
incluse quelle appartenenti a minoranze nazionali, godano della piena ed effettiva uguaglianza<br />
dei diritti e delle libertà fondamentali e beneficino dello stato di diritto e delle istituzioni democratiche,<br />
omissis<br />
I rappresentanti degli Stati partecipanti hanno preso come base fondamentale del proprio lavoro<br />
gli impegni da essi assunti in merito alle minoranze nazionali e contenuti nei pertinenti documenti<br />
adottati dalla CSCE, in particolare quelli contenuti nella Carta di Parigi per una nuova Europa<br />
e il Documento della Riunione di Copenaghen della Conferenza sulla dimensione umana<br />
della CSCE, che essi hanno pienamente riaffermato.<br />
Parte II<br />
Gli Stati partecipanti sottolineano la costante importanza di un riesame approfondito dell'attuazione<br />
dei loro impegni CSCE relativi alle persone appartenenti a minoranze nazionali.<br />
Essi mettono in rilievo che i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali sono la base per la tutela e<br />
la promozione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali. Essi riconoscono inoltre<br />
che le questioni relative alle minoranze nazionali possono essere risolte in modo soddisfacente<br />
solo in un quadro politico democratico basato sullo stato di diritto, con una magistratura<br />
indipendente funzionante. Tale quadro garantisce il pieno rispetto dei diritti dell'uomo e delle<br />
libertà fondamentali, diritti e status uguali per tutti i cittadini, incluse le persone appartenenti a<br />
minoranze nazionali, la libera espressione di tutti i loro legittimi interessi ed aspirazioni, il pluralismo<br />
politico, la tolleranza sociale e l'attuazione delle norme giuridiche che pongono limiti efficaci<br />
agli abusi del potere governativo.<br />
458
I problemi concernenti le minoranze nazionali, nonché l’osservanza degli obblighi e degli impegni<br />
internazionali concernenti i diritti delle persone che vi appartengono, sono questioni di legittimo<br />
interesse internazionale e di conseguenza non costituiscono esclusivamente un affare interno<br />
del rispettivo Stato.<br />
Essi rilevano che non tutte le differenze etniche, culturali, linguistiche o religiose portano necessariamente<br />
alla creazione di minoranze nazionali.<br />
omissis<br />
Parte III<br />
omissis<br />
Gli Stati partecipanti considerano inoltre che il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali<br />
deve essere garantito su una base non discriminatoria in tutta la società. Nelle zone<br />
abitate principalmente da persone appartenenti ad una minoranza nazionale, i diritti dell'uomo e<br />
le libertà fondamentali delle persone appartenenti a tale minoranza, delle persone appartenenti<br />
alla maggioranza della popolazione del rispettivo Stato, e delle persone appartenenti ad altre<br />
minoranze nazionali residenti in tali zone, saranno ugualmente tutelati.<br />
Essi riconfermano che le persone appartenenti a minoranze nazionali hanno il diritto di esprimere<br />
liberamente, preservare e sviluppare la propria identità etnica, culturale, linguistica o religiosa<br />
e di mantenere e sviluppare la propria cultura in tutti i suoi aspetti, al riparo da ogni tentativo di<br />
assimilazione contro la loro volontà.<br />
omissis<br />
Parte IV<br />
omissis<br />
Gli Stati partecipanti riconfermano l’importanza di adottare, ove necessario, speciali misure al<br />
fine di assicurare alle persone appartenenti a minoranze nazionali piena uguaglianza con gli altri<br />
cittadini nell’esercizio e nel godimento dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Essi<br />
inoltre ricordano l’esigenza di adottare le misure necessarie per tutelare l’identità etnica, culturale,<br />
linguistica e religiosa delle minoranze nazionali nel loro territorio e creare le condizioni per la<br />
promozione di tale identità; ciascuna di queste misure sarà conforme ai principi dell’uguaglianza<br />
e della non discriminazione nei confronti degli altri cittadini dello Stato partecipante interessato.<br />
omissis<br />
Parte V<br />
omissis<br />
Gli Stati partecipanti riaffermano e non ostacoleranno l’esercizio del diritto delle persone appartenenti<br />
al minoranze nazionali di creare e conservare proprie istituzioni, organizzazioni e associazioni<br />
educative, culturali e religiose.<br />
omissis<br />
Parte VI<br />
Gli Stati partecipanti, preoccupati per la proliferazione gli atti di odio razziale, etnico e religioso,<br />
antisemitismo, xenofobia e discriminazione, sottolineano la propria determinazione di condannare<br />
costantemente tali atti perpetrati contro chicchessia.<br />
459
In tale contesto, essi riaffermano il proprio riconoscimento dei particolari problemi dei Rom (zingari).<br />
Essi sono disposti ad adottare misure efficaci al fine di conseguire la piena uguaglianza di<br />
opportunità fra le persone appartenenti ai Rom solitamente residenti nel loro Stato e il resto della<br />
popolazione residente. Essi inoltre incoraggeranno la ricerca e studi riguardanti i Rom nonché<br />
i particolari problemi che li confrontano.<br />
Essi adotteranno misure efficaci per promuovere la tolleranza, la comprensione, l’uguaglianza<br />
di opportunità e buone relazioni fra individui di origini differenti nei loro paesi.<br />
Inoltre, gli Stati partecipanti adotteranno misure efficaci, inclusa l’adozione, conformemente al<br />
proprio diritto costituzionale e ai propri obblighi internazionali, qualora non lo abbiano già fatto,<br />
di leggi che vietino atti che costituiscano incitamento alla violenza sulla base della discriminazione<br />
nazionale, razziale, etnica o religiosa, dell’ostilità o dell’odio, ivi compreso l’antisemitismo,<br />
nonché di politiche atte a far rispettare tali leggi.<br />
Inoltre, per accrescere la pubblica consapevolezza del pregiudizio e dell’odio, per migliorare<br />
l’applicazione delle leggi contro i crimini connessi con l’odio e per promuovere in altro modo gli<br />
sforzi miranti ad affrontare l’odio e il pregiudizio nella società, essi compieranno sforzi per raccogliere,<br />
pubblicare regolarmente e rendere disponibili al pubblico i dati concernenti i crimini<br />
perpetrati sui propri rispettivi territori che si basino su pregiudizi riguardanti la razza, l'identità<br />
etnica o la religione, incluse le direttive utilizzate per raccogliere tali dati. Tali dati non dovrebbero<br />
contenere alcuna informazione personale.<br />
Essi si consulteranno e scambieranno pareri e informazioni a livello internazionale, incluse future<br />
riunioni della CSCE, sui crimini che siano prova di pregiudizio e odio.<br />
Parte VII<br />
omissis<br />
Per quanto riguarda l’accesso ai media, essi non faranno discriminazioni contro alcuno sulla<br />
base di motivi etnici, culturali, linguistici o religiosi. Essi renderanno disponibili le informazioni<br />
utili per consentire ai mass media elettronici di tenere conto, nel loro programmi, dell’identità etnica,<br />
culturale, linguistica e religiosa delle minoranze nazionali.<br />
Essi riaffermano che la creazione e la conservazione di liberi contatti fra le persone appartenenti<br />
a una minoranza nazionale nonché di contatti oltre le frontiere da parte di persone appartenenti<br />
a una minoranza nazionale con persone con le quali esse condividano una comune origine<br />
etnica e nazionale, il retaggio culturale o il credo religioso, contribuiscono alla mutua comprensione<br />
e promuovono relazioni di buon vicinato.<br />
omissis<br />
DOCUMENTO DEL SIMPOSIO DI CRACOVIA SUL RETAGGIO CULTURALE DEGLI STATI<br />
PARTECIPANTI ALLA CSCE<br />
(Cracovia 6 giugno 1991)<br />
omissis<br />
Gli Stati partecipanti esprimono la loro ben radicata convinzione di condividere i valori comuni<br />
forgiati dalla storia e basati, tra l’altro, sul rispetto dell’individuo, sulla libertà di coscienza, religione<br />
o credo, sulla libertà di espressione, sul riconoscimento dell’importanza dei valori spirituali<br />
e culturali, sull’impegno per lo stato di diritto, sulla tolleranza e apertura nel dialogo con altre<br />
culture.<br />
omissis<br />
Gli Stati partecipanti rispettano l'insostituibile unicità di tutte le loro culture e si adopereranno<br />
per promuovere un continuo dialogo culturale fra loro e con il resto del mondo. Essi riaffermano<br />
il proprio convincimento che il rispetto delle diversità culturali promuove la comprensione e la<br />
tolleranza tra individui e gruppi.<br />
460
omissis<br />
Riaffermando il proprio impegno per la piena attuazione delle disposizioni relative alla dimensione<br />
culturale contenute nell’Atto Finale di Helsinki e in altri documenti CSCE, gli Stati partecipanti<br />
concordano su quanto segue:<br />
I. Cultura e libertà<br />
1. Gli Stati partecipanti sottolineano che il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali<br />
è essenziale per il pieno sviluppo della creatività culturale.<br />
omissis<br />
18. Le associazioni fra i diversi gruppi a livello locale, regionale e nazionale, del settore pubblico<br />
e privato, sono atte ad assicurare un’effettiva e significativa preservazione del retaggio culturale.<br />
La preservazione ed il significato dei valori e del retaggio culturale di gruppi diversi saranno<br />
valorizzati con il coinvolgimento di tali gruppi, il che contribuisce alla tolleranza e al rispetto delle<br />
diverse culture che sono elementi di importanza fondamentale.<br />
omissis<br />
32. Il significato dei luoghi carichi di memorie dolorose può validamente contribuire a promuovere<br />
la tolleranza e la compresnione fra i popoli tenendo conto dele diversità sociali e culturali.<br />
omissis<br />
PROPOSTA DELL’ESAGONALE<br />
Preambolo<br />
omissis<br />
2. Le minoranze nazionali, con la loro diversità etnica, linguistica, culturale e religiosa, fanno<br />
parte della comune storia e cultura dei popoli degli Stati partecipanti. Tale diversità è espressione<br />
della ricchezza del retaggio culturale comune degli Stati partecipanti. La sua preservazione e<br />
tutela contribuiscono ad edificare un’Europa democratica, pacifica e unita.<br />
3. Le minoranze nazionali e le persone che vi appartengono godono di tutti i diritti sai sensi del<br />
diritto internazionale, dei documenti CSCE e della legislazione nazionale dei loro rispettivi Stati,<br />
per il semplice fatto che esse hanno un’identità etnica, religiosa, linguistica o culturale diversa<br />
dal resto della popolazione dello Stato in cui esse vivono.<br />
Il rispetto dell’esistenza delle minoranze espresso dalle garanzie costituzionali degli Stati partecipanti<br />
contribuirà sostanzialmente allo sviluppo della cooperazione in campo umanitario, alla<br />
stabilità, alla coesione, alla democrazia, alla fiducia, alla sicurezza e alla pace.<br />
omissis<br />
6. Gli Stati partecipanti tuteleranno parimenti, nelle zone abitate principalmente da persone appartenenti<br />
a una minoranza nazionale, dalla discriminazione le persone appartenenti alla maggioranza<br />
della popolazione del rispettivo Stato partecipante o a gruppi di minoranze locali.<br />
7. La tutela e la promozione dell’identità delle minoranze nazionali e dei diritti delle persone che<br />
vi appartengono, quale parte dei diritti dell’uomo universalmente riconosciuti, sono considerate<br />
dagli Stati partecipanti un importante fattore della stabilità, della sicurezza e della pace nazionali,<br />
regionali e continentali, e di conseguenza non costituiscono esclusivamente un affare interno<br />
del rispettivo Stato.<br />
461
8. La tutela e la promozione dell’identità etnica, linguistica, religiosa e culturale delle minoranze<br />
nazionali nonché dei diritti delle persone che vi appartengono costituiscono una parte esenziale<br />
della cooperazione internazionale.<br />
omissis<br />
II. Disposizioni normative<br />
1. Gli Stati partecipanti si asterranno da politiche miranti all’assimilazione di persone appartenenti<br />
a minoranze nazionali contro la loro volontà e dal modificare in modo arbitrario la composizione<br />
percentuale della popolazione nelle regioni abitate da minoranze allo scopo di pregiudicare<br />
o limitare i loro diritti. Essi inoltre contrasteranno qualsiasi attività mirante alla assimilazione<br />
coatta di minoranze nazionali.<br />
omissis<br />
3. Al fine di mantenere e sviluppare la cultura delle minoranze nazionali, gli Stati partecipanti:<br />
- incoraggeranno la produzione di materiali culturali creati o riprodotti da membri delle loro rispettive<br />
minoranze,<br />
- assicureranno la libera circolazione di tali materiali oltre le frontiere nazionali,<br />
- incoraggeranno la creazione e il funzionamento di istituzioni culturali che si occupino della storia,<br />
del retaggio culturale delle minoranze nazionali e della produzione artistica contemporanea<br />
delle persone che vi appartengono.<br />
omissis<br />
III. Misure miranti a rafforzare la fiducia<br />
omissis<br />
2. Nel caso di amministrazioni locali o autonome esistenti in zone di Stasi vicini, abitate principalmente<br />
da persone aventi la stessa identità etnica, linguistica, culturale o religiosa, tali amministrazioni<br />
saranno coinvolte nella preparazione e attuazione di accordi sulla cooperazione<br />
transfrontaliera.<br />
omissis<br />
DOCUMENTO DELLA RIUNIONE DI MOSCA DELLA CONFERENZA SULLA DIMENSIONE<br />
UMANA DELLA CSCE<br />
(ottobre 1991)<br />
Gli Stati partecipanti<br />
omissis<br />
In particolare, essi hanno deplorato gli atti di discriminazione, ostilità e violenza contro persone<br />
o gruppi per motivi nazionali, etnici o religiosi. Gli Stati partecipanti hanno espresso pertanto<br />
l’opinione che per la piena attuazione dei loro impegni relativi alla dimensione umana sono ancora<br />
necessari sforzi continui che dovrebbero trarre sostanziale vantaggio dai profondi mutamenti<br />
politici verificatisi.<br />
Gli Stati partecipanti sottolineano che le questioni relative ai diritti dell’uomo, alle libertà fondamentali,<br />
alla democrazia ed allo stato di diritto rivestono un interesse internazionale, in quanto il<br />
rispetto di tali diritti e libertà costituisce uno dei fondamenti dell’ordine internazionale.<br />
omissis<br />
462
1. Gli Stati partecipanti sottolineano che il meccanismo della dimensione umana descritto nei<br />
paragrafi da 1 a 4 del Capitolo sulla Dimensione umana della CSCE del Documento conclusivo<br />
di Vienna costituisce una conquista essenziale del processo CSCE, avendo dimostrato la sua<br />
validità quale metodo per favorire il rispetto dei diritti dell’uomo, delle libertà fondamentali, della<br />
democrazia e dello Stato di diritto mediante il dialogo e la cooperazione e per contribuire alla<br />
soluzione di questioni specifiche pertinenti. Al fine di migliorare ulteriormente l’attuazione degli<br />
impegni CSCE nel campo della dimensione umana, essi decidono di accrescere l’efficacia di<br />
tale meccanismo e rafforzarlo e ampliarlo come esposto nei paragrafi seguenti.<br />
omissis<br />
42. Gli Stati partecipanti,<br />
42.1 affermano che l’istruzione nel campo dei diritti dell’uomo è fondamentale e che pertanto è<br />
essenziale che i loro cittadini siano istruiti sui diritti dell’uomo e sulle libertà fondamentali e<br />
sull’impegno di rispettare tali diritti e libertà nella legislazione nazionale e negli strumenti internazionali<br />
di cui essi possano essere parti;<br />
42.2 riconoscono che un’efficace istruzione nel campo dei diritti dell’uomo contribuisce a combattere<br />
l’intolleranza, i pregiudizi e l’odio religiosi, razziali ed etnici, anche contro i Rom (zingari),<br />
la xenofobia e l’antisemitismo;<br />
omissis<br />
DICHIARAZIONI DEL VERTICE DI HELSINKI. LE SFIDE DEL CAMBIAMENTO (1992)<br />
omissis<br />
Minoranze nazionali<br />
Gli Stati partecipanti<br />
23) Riaffermano nei termini più energici la loro determinazione di attuare in maniera sollecita e<br />
fedele tutti i loro impegni CSCE, compresi quelli contenuti nel Documento Conclusivo di Vienna,<br />
nel Documento di Copenhagen e nel Rapporto di Ginevra, riguardanti questioni relative alle minoranze<br />
nazionali e ai diritti delle persone ad esse appartenenti.<br />
24) In tale contesto intensificheranno i loro sforzi per assicurare il libero esercizio, da parte delle<br />
persone appartenenti a minoranze nazionali, individualmente o in comunità o con altri, dei loro<br />
diritti umani e delle libertà fondamentali, incluso il diritto di partecipare pienamente, conformemente<br />
alle procedure democratiche decisionali di ciascuno Stato, alla vita politica, economica,<br />
sociale e culturale di loro stessi paesi, anche mediante la partecipazione democratica agli organi<br />
decisionali e consultivi a livello nazionale, regionale e locale, fra l’altro, tramite i partiti politici<br />
e le associazioni.<br />
25) Proseguiranno ad esplorare con sforzi unilaterali, bilaterali e multilaterali, nuove vie per una<br />
più efficace attuazione dei loro pertinenti impegni CSCE, inclusi quelli relativi alla tutela e alla<br />
creazione di condizioni atte a promuovere l’identità etnica, culturale, linguistica e religiosa delle<br />
minoranze nazionali.<br />
26) Affronteranno le questioni relative alle minoranze nazionali in maniera costruttiva, con mezzi<br />
pacifici e tramite il dialogo fra tutte le parti interessate sulla base dei principi e degli impegni della<br />
CSCE.<br />
27) Si asterranno dal reinsediare e condanneranno tutti i tentativi di reinsediamento di persone,<br />
mediante la minaccia o l’uso della forza, al fine di cambiare la composizione etnica di zone<br />
all’interno dei loro territori.<br />
28) Danno istruzione all’ODIHR di organizzare, nella primavera del 1993, un seminario relativo<br />
ala Dimensione umana della CSCE su studi di casi relativi alle questioni delle minoranze nazionali.<br />
Popolazioni autoctone<br />
463
Gli Stati partecipanti<br />
29) Rilevando che le persone appartenenti a popolazioni autoctone possono incontrare particolari<br />
problemi nell’esercizio dei propri diritti, concordano che i loro impegni CSCE relativi ai diritti<br />
dell’uomo e alle libertà fondamentali si applichino a tali persone pienamente e senza discriminazioni.<br />
Tolleranza e non discriminazione<br />
Gli Stati partecipanti<br />
30) Esprimono la loro preoccupazione per le recenti e flagranti manifestazioni d’intolleranza, discriminazione,<br />
nazionalismo aggressivo, xenofobia, antisemitismo e razzismo e sottolineano il<br />
ruolo vitale della tolleranza, della comprensione e della cooperazione per il conseguimento e il<br />
mantenimento di società democratiche e stabili.<br />
31) Danno istruzione all’ODIHR di organizzare, nell’autunno del 1992, un Seminario relativo alla<br />
Dimensione Umana della CSCE sulla tolleranza.<br />
32) Essi prenderanno in considerazione l’adesione alla Convenzione Internazionale<br />
sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, qualora non lo abbiano già fatto.<br />
33) Essi prenderanno in considerazione l’adozione di misure appropriate nell’ambito della loro<br />
struttura costituzionale e conformemente ai loro obblighi internazionali per assicurare a ciascuno<br />
sul loro territorio la protezione contro la discriminazione per motivi razziali, etnici e religiosi<br />
nonché per proteggere tutti gli individui, compresi gli stranieri, contro atti di violenza, anche per<br />
uno qualsiasi di tali motivi. Inoltre essi utilizzeranno pienamente le loro procedure giuridiche nazionali,<br />
compresa l’applicazione delle leggi esistenti a tale riguardo.<br />
34) Esamineranno lo sviluppo di programmi per creare le condizioni atte a promuovere la non<br />
discriminazione e la comprensione transculturale che si focalizzeranno sull’educazione ai diritti<br />
dell’uomo, su un’azione radicale e su una formazione e ricerca transculturali.<br />
35)Riaffermano, in tale contesto, l’esigenza di intraprendere programmi appropriati che affrontino<br />
problemi dei loro rispettivi cittadini appartenenti ai Rom e ad altri gruppi tradizionalmente identificati<br />
come zingari e di creare condizioni perché essi abbiano uguali opportunità di partecipare<br />
pienamente alla vita della società, ed esamineranno come cooperare a tal fine.<br />
omissis<br />
DICHIARAZIONE FINALE DI HELSINKI<br />
(9 luglio 1993)<br />
omissis<br />
L’Assemblea Parlamentare della CSCE,<br />
omissis<br />
36. Esprime la propria determinazione a prestare assistenza per la piena attuazione degli impegni<br />
della CSCE aventi rilevanza in questo settore compresi tra gli altri quelli relativi alle persone<br />
appartenenti alle minoranze nazionali, alle donne, alla formazione in materia di diritti umani ed<br />
alla promozione della tolleranza e della non-discriminazione;<br />
omissis<br />
DOCUMENTO CONCLUSIVO DEL VERTICE DI BUDAPEST “VERSO UNA VERA<br />
PARTNERSHIP IN UNA NUOVA ERA” (1994)<br />
omissis<br />
Dimensione umana<br />
464
Introduzione<br />
1. Nel riesaminare l’attuazione degli impegni CSCE nel campo della dimensione umana, gli Stati<br />
partecipanti hanno basato la discussione sulla comunanza di valori che si è stabilita fra loro e<br />
che si riflette negli standard elevati nell’ambito della CSCE. Nel corso della discussione, si è rilevato<br />
che sono stati compiuti notevoli progressi nel rispetto degli impegni relativi alla dimensione<br />
umana. Gli Stati partecipanti hanno riconosciuto, tuttavia, che in alcune aree si è registrato<br />
un grave deterioramento e che si è manifestata l’esigenza di iniziative volte a contrastare e le<br />
costanti violazioni dei diritti dell’uomo e le manifestazioni di nazionalismo aggressivo, quale<br />
l’espansionismo territoriale, nonché di razzismo, sciovinismo, xenofobia e antisemitismo che<br />
continuano a provocare sofferenze umane.<br />
omissis<br />
22. Gli Stati partecipanti accolgono con favore le iniziative internazionali miranti ad una migliore<br />
tutela dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali. Essi prendono atto<br />
dell’adozione, nell’ambito del Consiglio d’Europa, di una Convenzione quadro sulla tutela delle<br />
minoranze nazionali, basata sulle norme CSCE al riguardo. Essi hanno sottolineato che la Convenzione<br />
è anche aperta, su invito, alla firma degli Stati che non sono membri del Consiglio<br />
d’Europa i quali potranno prendere in considerazione la possibilità di aderire a tale Convenzione.<br />
RACCOMANDAZIONI DE L’AJA RIGUARDANTI IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE DELLE MI-<br />
NORANZE NAZIONALI (1996)<br />
Introduzione<br />
omissis<br />
Dal momento che la normativa vigente sui diritti delle minoranze fa parte dei diritti umani, le<br />
consultazioni hanno preso avvio nell’ipotesi che gli Stati rispettino tutti gli altri obblighi nel settore<br />
dei diritti umani compresa in particolare la libertà da ogni forma di discriminazione. Si è inoltre<br />
ipotizzato che l’obiettivo ultimo di tutti i diritti umani sia lo sviluppo pieno e libero della personalità<br />
individuale dell’uomo in condizioni di uguaglianza. Si è pertanto ritenuto che la società civile<br />
deve essere aperta e flessibile e che quindi debba integrare tutte le persone, compresi gli appartenenti<br />
alle minoranze nazionali.<br />
omissis<br />
Raccomandazioni de L’Aja sui diritti all’istruzione delle minoranze nazionali<br />
omissis<br />
2) In attuazione degli strumenti internazionali che possono offrire dei vantaggi agli appartenenti<br />
alle minoranze nazionali, gli Stati dovrebbero aderire con coerenza ai principi fondamentali di<br />
uguaglianza e non-discriminazione.<br />
omissis<br />
Nota esplicativa alle Raccomandazioni de L’Aja sui diritti all’istruzione<br />
delle minoranze nazionali<br />
omissis<br />
Gli strumenti internazionali sui diritti umani relativi all’istruzione nella lingua minoritaria restano<br />
alquanto vaghi e generici. Essi non fanno specifico riferimento ai livelli di accesso né stabili-<br />
465
scono quali livelli dell’istruzione nella lingua madre debbano essere disponibili per le minoranze<br />
e con quali mezzi. Nozioni come “adeguate opportunità” di ricevere l’insegnamento o istruzioni<br />
nella lingua minoritaria, come definito nell’articolo 14 della Convenzione quadro per la protezione<br />
delle minoranze nazionali del Consiglio d’Europa, dovrebbero essere considerate alla luce di<br />
altri elementi. Questi ultimi prevedono la necessità di creare condizioni vantaggiose che favoriscano<br />
la salvaguardia, il mantenimento e lo sviluppo della lingua e della cultura come previsto<br />
all’articolo 5 della Convenzione stessa oppure l’esigenza di adottare le misure necessarie atte a<br />
tutelare l’identità etnica, culturale , linguistica e religiosa delle minoranze nazionali come previsto<br />
dal comma 33 del Documento della Riunione della Conferenza sulla dimensione umana della<br />
CSCE, tenutasi a Copenhagen.<br />
omissis<br />
RACCOMANDAZIONI DI OSLO SUI <strong>DIRITTI</strong> LINGUISTICI DELLE MINORANZE NAZIONALI<br />
E NOTA ILLUSTRATIVA<br />
(febbraio 1998)<br />
omissis<br />
Nella misura in cui le vigenti norme sui diritti delle minoranze attengono alla sfera dei diritti umani,<br />
le consultazioni sono state avviate partendo dall’assunto che gli Stati osservano tutti gli<br />
altri obblighi connessi al rispetto dei diritti umani, tra cui, in particolare, l’uguaglianza, il rifiuto<br />
della discriminazione, la libertà di espressione, la libertà di riunione e di associazione, nonché<br />
tutti i diritti e le libertà delle persone appartenenti a minoranze nazionali.<br />
omissis<br />
Religione<br />
4) Nel professare o praticare la propria religione individualmente o in comune con altri, ogni individuo<br />
avrà il diritto di usare la/e lingua/ di sua scelta.<br />
5) Per le cerimonie o funzioni religiose aventi rilevanza anche sul piano civile nello Stato in questione,<br />
quest’ultimo può esigere che la relativa certificazione attestante lo status giuridico sia<br />
prodotta anche nella/e lingua/e dello Stato. Lo Stato può richiedere che i registri contenenti i dati<br />
relativi allo stato civile siano conservati dalle autorità religiose anche nella/e lingua/e dello Stato.<br />
omissis<br />
Nota illustrativa relativa alle raccomandazioni<br />
omissis<br />
Religione<br />
4) L’articolo 27 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici afferma che: “Negli Stati dove esistono<br />
minoranze etniche, religiose o linguistiche, alle persone ad esse appartenenti non sarà<br />
negato il diritto, in comune con gli altri membri del gruppo di appartenenza ... di professare e<br />
praticare la propria religione o di utilizzare la propria lingua”. L’articolo 3(1) della Dichiarazione<br />
sui Diritti delle Persone appartenenti a Minoranze Nazionali, Etniche, Religiose e Linguistiche<br />
sancisce che “Le persone appartenenti a minoranze possono esercitare i loro diritti ... sia individualmente<br />
che in comune con altri membri del proprio gruppo, senza alcuna discriminazione.<br />
Il credo religioso e le relative funzioni “in comunità” è un aspetto di rilevante importanza per<br />
molte persone appartenenti a minoranze nazionali. In tale contesto giova osservare che il diritto<br />
alla propria religione è illimitato e garantito dall’articolo 18(1) del Patto Internazionale sui Diritti<br />
Civili e Politici e dall’articolo 9(1) della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei dritti<br />
dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali. Tuttavia, la libertà di manifestare la propria religione ed<br />
il proprio credo, compresa la libertà di professarlo pubblicamente, è soggetta ad alcune limita-<br />
466
zioni enumerate in paragrafi sussidiari riferiti agli stessi articoli. Tali limitazioni devono essere<br />
stabilite per legge ed essere motivate da esigenze di ordine e sicurezza pubblica, di incolumità<br />
personale, di morale e salvaguardia dei diritti fondamentali e delle libertà fondamentali nonché<br />
dal rispetto dei diritti altrui. Dette limitazioni devono essere ragionevoli e proporzionale alla finalità<br />
perseguita e gli Stati non possono invocarle con l’intento di soffocare le legittime aspirazioni<br />
spirituali, linguistiche o religiose di coloro che appartengono a minoranze nazionali.<br />
Nelle realtà minoritarie, le pratiche religiose sono spesso in stretta correlazione con la preservazione<br />
dell’identità culturale e linguistica. Il diritto di utilizzare la lingua minoritaria durante le<br />
funzioni religiose pubbliche ha di per sé il valore intrinseco di diritto a creare istituzioni religiose<br />
e professare pubblicamente il credo religioso. Ne consegue che le autorità pubbliche non possono<br />
imporre alcuna limitazione eccessiva alla professione del credo religioso né all’uso di<br />
qualsiasi lingua durante tale prassi, sia essa la lingua madre della minoranza nazionale in questione<br />
o la lingua liturgica in uso nella comunità minoritaria.<br />
5) In alcuni paesi le cerimonie religiose come matrimoni o funerali possono costituire atti giuridici<br />
che determinano lo stato civile. In simili casi, si deve tener conto dell’interesse pubblico. Tenendo<br />
a mente il principio secondo cui le considerazioni di natura amministrativa non dovrebbero<br />
impedire il godimento dei diritti umani, è opportuno che le autorità pubbliche non impongano<br />
alcuna limitazione linguistica alle comunità religiose. Analogamente, ciò dovrebbe applicarsi a<br />
qualsiasi funzione amministrativa svolta dalle comunità religiose che possa sovrapporsi alla giurisdizione<br />
civile. Lo Stato, pertanto, può richiedere alla comunità religiosa di registrare gli atti civili<br />
che è autorizzato ad emanare anche nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato, così da consentire<br />
a quest’ultimo di assolvere le proprie funzioni regolamentari ed amministrative.<br />
467
DOCUMENTI DELL’INIZIATIVA CENTRO EUROPEA<br />
469
STRUMENTO CEI PER LA TUTELA DEI <strong>DIRITTI</strong> DELLE MINORANZE<br />
(15 novembre 1994)<br />
Gli Stati membri dell’Iniziativa per l’Europa Centrale, qui firmatari,<br />
omissis<br />
considerando che il rispetto per i diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali, quale<br />
parte dei diritti umani universalmente riconosciuti, è un fattore essenziale per la pace, la giustizia,<br />
la stabilità e la democrazia negli Stati,<br />
omissis<br />
esprimendo la loro condanna del nazionalismo aggressivo, dell’odio razziale ed etnico,<br />
dell’antisemitismo, della xenofobia e della discriminazione contro ogni persona o gruppo e della<br />
persecuzione per motivi religiosi o ideologici,<br />
si sono accordati come segue:<br />
Articolo 1<br />
omissis<br />
2. Ai fini del presente strumento, il termine “minoranza nazionale” indicherà un gruppo che sia di<br />
numero minore rispetto al resto della popolazione dello Stato, i cui membri siano cittadini di<br />
quello Stato, e abbiano caratteri etnici, religiosi o linguistici differenti da quelli del resto della popolazione,<br />
e sino guidati dalla volontà di salvaguardare la propria cultura, le proprie tradizioni, la<br />
propria religione e la propria lingua.<br />
omissis<br />
Articolo 3<br />
1. Gli Stati riconoscono che le persone appartenenti alle minoranze nazionali hanno diritto di<br />
esercitare pienamente e totalmente i loro diritti umani e le libertà fondamentali, individualmente<br />
o in comune con altre persone, senza alcuna discriminazione e in piena uguaglianza di fronte<br />
alla legge.<br />
omissis<br />
Articolo 4<br />
Gli Stati garantiscono il diritto delle persone appartenenti alle minoranze nazionali di esprimere,<br />
preservare e sviluppare la propria identità etnica, culturale, linguistica o religiosa, e di mantenere<br />
e sviluppare la propria cultura in tutti i suoi aspetti.<br />
Articolo 5<br />
Non è da considerare come atto discriminatorio l’adozione di misure speciali in favore di persone<br />
che appartengono alle minoranze nazionali, dirette a promuovere l’uguaglianza tra dette minoranze<br />
ed il resto della popolazione, nonché a considerare in modo adeguato le loro condizioni<br />
specifiche.<br />
Articolo 6<br />
Gli Stati devono adottare delle misure operative atte a fornire contro un qualsiasi atto che possa<br />
costituire un incitamento alla violenza contro persone o gruppi per motivi di discriminazione nazionale,<br />
razziale, etica o religiosa, ostilità e odio, compreso l’antisemitismo.<br />
Articolo 7<br />
Gli Stati riconoscono i problemi particolari dei Rom (zingari).<br />
471
Essi si impegnano ad adottare tutte le misure giuridiche in materia amministrativa o scolastica<br />
come previsto nel presente atto, al fine di conservare o sviluppare l’identità rom; a facilitare con<br />
misure specifiche l’integrità sociale delle persone che appartengono ai Rom (zingari), nonché<br />
ad eliminare qualsiasi forma di intolleranza nei confronti di dette persone.<br />
omissis<br />
Articolo 14<br />
Qualsiasi persona che appartiene ad una minoranza nazionale che gode di libertà di credo religioso,<br />
deve avere diritto ad usare la propria lingua nel professare detto credo, nell’insegnarlo,<br />
nel praticarlo o osservarlo.<br />
omissis<br />
Articolo 22<br />
In conformità alle politiche degli Stati interessati, gli stessi dovranno rispettare il diritto delle persone<br />
che appartengono alle minoranze nazionali a partecipare effettivamente alla vita pubblica,<br />
in particolare ai processi decisionali che li riguardano. Gli Stati rilevano quindi gli impegni assunti<br />
per proteggere e creare condizioni adatte per la promozione dell’identità etnica, culturale,<br />
linguistica e religiosa di dette minoranze nazionali, adottando delle misure adeguate che corrispondono<br />
alle circostanze specifiche di dette minoranze come previsto nel documento della<br />
CSCE.<br />
Articolo 23<br />
Ogni persona che appartiene ad una minoranza nazionale, pur rispettando l’integrità territoriale<br />
dello Stato, deve avere diritto di allacciare contatti liberi e senza ostacoli con i cittadini di un altro<br />
paese con i quali detta minoranza condivide le caratteristiche etniche, religiose o linguistiche,<br />
nonché l’identità culturale. Gli Stati non possono limitare in modo iniquo il libero esercizio<br />
di detti diritti. Gli Stati, inoltre, devono incoraggiare gli accordi oltre frontiera a livello nazionale.<br />
omissis<br />
472
DOCUMENTI DELL’U.F.G.E.E.<br />
473
CONVENZIONE SUI <strong>DIRITTI</strong> FONDAMENTALI DEI GRUPPI ETNICI IN EUROPA<br />
(Progetto di Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea sui diritti dell'Uomo)<br />
omissis<br />
PARTE II<br />
<strong>DIRITTI</strong> FONDAMENTALI GENERALI<br />
omissis<br />
Diritto alla non discriminazione, alla parità di trattamento<br />
e alla parità di opportunità<br />
Articolo 5<br />
1. Persone appartenenti a gruppi etnici hanno il diritto di esercitare pienamente ed effettivamente<br />
i loro diritti dell'Uomo e le libertà fondamentali senza discriminazione di alcun genere e in<br />
piena uguaglianza dinanzi alla legge.<br />
2. Oltre alla parità di trattamento formale alle persone appartenenti a gruppi etnici è da garantire<br />
l'uguaglianza effettiva davanti alla legge nel senso di vera parità di opportunità.<br />
3. La parità di opportunità è da garantire tramite misure di tutela speciali; queste misure sono da<br />
considerare in accordo con il principio dell'uguaglianza e della non discriminazione con rispetto<br />
alla popolazione restante e non come atto di discriminazione.<br />
4. Queste misure di tutela speciali per creare e mantenere la parità di opportunità delle persone<br />
appartenenti a gruppi etnici sono da adottare dagli Stati contraenti in particolare in riferimento al<br />
diritto:<br />
a) alla lingua;<br />
b) alla scuola e all'educazione;<br />
c) alle proprie organizzazioni;<br />
d) ai liberi contatti e alla libera circolazione;<br />
e) alla libertà di informazione (ricezione e trasmissione);<br />
f) all'accesso proporzionale agli uffici pubblici;<br />
g) alla rappresentanza politica;<br />
h) ad adeguate forme di autonomia.<br />
5. L'omissione di tali misure di tutela è da considerare e da trattare come atto di discriminazione<br />
illegittimo.<br />
6. Servizi compensativi per migliorare la parità di opportunità, specialmente in ambito culturale,<br />
da parte di uno Stato contraente dirette a persone appartenenti a gruppi etnici connazionali in<br />
uno Stato contraente non sono da considerare come intromissione illecita negli affari interni di<br />
questo Stato.<br />
omissis<br />
<strong>DIRITTI</strong> DI AUTONOMIA DEI GRUPPI ETNICI IN EUROPA<br />
(Progetto di discussione per una convenzione speciale)<br />
Gli Stati contraenti di questa Convenzione<br />
confermano che uno degli scopi fondamentali delle Nazioni Unite, come sono riportati nella Carta,<br />
è la promozione e l'incentivazione del rispetto dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali<br />
di ciascuno, senza differenza di razza, di sesso, di lingua e di religione;<br />
omissis<br />
conoscendo la dichiarazione della Declarazione sopra citata, che gli Stati gestiscono i loro affari<br />
rispettando il principio dei diritti uguali e dell'autodeterminazione dei popoli e che quindi hanno<br />
475
un governo che rappresenta l'intera popolazione indipendentemente dalla razza, dalla religione<br />
e dal colore;<br />
omissis<br />
Principi fondamentali<br />
Articolo 3<br />
omissis<br />
2. L'appartenenza ad un gruppo etnico è una questione di scelta individuale della persona e non<br />
può arrecarle alcun pregiudizio. Gli Stati contraenti sono obbligati a creare i presupposti giuridici,<br />
politici, culturali e sociali per questa libera scelta individuale.<br />
omissis<br />
476
BIBLIOGRAFIA<br />
477
BIBLIOGRAFIA<br />
AA.VV., L'identità regionale in Europa, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, Trento, 1991.<br />
AA.VV., Radici d’Europa, Roma, 1985<br />
ALLARD E., Le minoranze etniche nell'Europa occidentale: una ricerca comparata, in "Rivista italiana<br />
di scienza politica", n. 1, 1981.<br />
ALFIERI V.E. (e altri), Libertà e cultura. Conversazioni di v.e. Alfieri e altri, Milano, Istituto Lombardo di<br />
Scienze e Lettere, 1979.<br />
ARFE' G., La carta di Strasburgo e le culture minoritarie in Città e Regione, n. 1, 1982.<br />
BARTOLE S., Iniziative per l'adozione di strumenti internazionali di protezione delle minoranze e tutela<br />
dei diritti culturali, Trieste 1992.<br />
BARTOLE S., Minoranze nazionali, Novissimo Digesto <strong>Italiano</strong>, Appendice IV, UTET, 1985.<br />
BOREJSZA J. W., L'integrazione culturale nell'Europa contemporanea tra mito e realtà (le tesi), Trieste<br />
1992.<br />
BOURMEYSTER A., Le minoranze etniche e la loro tutela. Una sintesi storico-comparativa, Trieste<br />
1992.<br />
BOURMEYSTER A., Minorités ethniques en Europe: une cause humanitaire ou une menace de destabilisation?,<br />
Trieste 1992.<br />
BRANCA G., "Commentario alla Costituzione". Bologna, Zanichelli, Roma, Soc. Ed. del Foro <strong>Italiano</strong>,<br />
1975.<br />
BRUNETTI C., La condizione giuridica delle minoranze linguistiche: esame antologico di un diritto negato,<br />
1993.<br />
BUONOMO V., Etnie, Culture e Unità dell'Europa, 1992, Angeli editore.<br />
BURCKHARAT J., Considerazioni sulla storia universale, cap. 2<br />
BURDEAU G., Trattato di scienza politica, vol. II, Parigi, 1949 - 1956<br />
CARROZZA P., Lingue (uso delle) - Novissimo Digesto <strong>Italiano</strong>, Appendice IV, UTET, 1985.<br />
CELI N.A., Il problema delle lingue tagliate in Italia, in Rivista giuridica della scuola, 1983.<br />
COMMISSIONE CASSANDRO 1, Relazione (dattilo-scritto)<br />
CONETTI G., La condizione delle minoranze etniche e linguistiche secondo gli accordi internazionali a<br />
carattere generale, in Nota trimestrale di diritto europeo, 1982.<br />
CRISAFULLI V. - D. NOCILLA, Nazione, in “Enciclopedia del diritto”, pagg. 787 - 814.<br />
CSCE/SCHC.7/Rev. 1 Cracovia, 5 giugno 1991, Simposio sul retaggio culturale - Proposta presentata<br />
dalle delegazioni dell'Austria, della Repubblica Federativa Ceca e Slovacca, dell'Italia, della ex Jugoslavia<br />
e dell'Ungheria, Cracovia, 1991.<br />
DIMITROV T.D., Remarques historiques et méthodologiques sur le rôle culturel des minorités nationales<br />
en Europe, Trieste 1992.<br />
479
DE MAURO T., (a cura di) Atti della conferenza internazionale sulle minoranze, Trieste 1980 e 1981.<br />
DEPANGHER G., Minoranze e cultura, Istituto Gramsci del Friuli-Venezia Giulia, Trieste, 1991.<br />
DUSAN SIDJANSKI, L'avvenire federalista dell'Europa - Europa anni 90 collana diretta da Dario Velo,<br />
Pirola editore.<br />
ECO U., “La ricerca della lingua perfetta”, ed. Laterza, Bari, 1993<br />
ELIAS N., Il processo di civilizzazione, Il Mulino - 1992.<br />
ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO, Stato, Nazione e Minoranze.<br />
FORTINO I. C., Profilo storico della letteratura degli Albanesi d'Italia, in Minoranze etniche in Calabria<br />
e Basilicata, Di Mauro editore, Cava dei Tirreni, 1988, pp. 176-197.<br />
FRANCESCATO G., (a cura di) Minoranze Linguistiche in Italia, in Sociologia della comunicazione, Milano<br />
1982.<br />
FREDDI G., Maggioranze, minoranze e plurilinguismo nella provincia di Bolzano, in I quaderni di Villa<br />
Falconieri: L'educazione plurilingue in Italia, n. 2 Frascati 1983.<br />
GASPARINI A., Esplorazioni etniche nella nuova Europa: etnie che vengono, etnie che vanno, vale a<br />
dire etnia come realtà mutabile fondata sull'autolegittimazione, Trieste 1992<br />
GIOACCHINI MOLININI, Cittadini d'Europa, Gioacchini Molinini & Orazio Parisotto, Torino: Nuova ERI<br />
- 1989.<br />
HOMUTH K., "Società multiculturale, progetto di egemonia", in l'Indice dei libri del mese, Roma, febbraio<br />
1990, pp. 33-34.<br />
HOMUTH K., "Normalizzazione senza normalità: l'integrazione nella società multiculturale", in: Nuove<br />
minoranze in Europa: quale formazione, eds. Karl Homuth-Luigi Za, traduzione dei testi dal tedesco<br />
Margrit Zubler, Lecce, Capone editore, 1991, pp. 87-92 (Migrazioni; 1).<br />
HRUSKA F., La cultura delle minoranze è/e la cultura della convivenza, Trieste 1992.<br />
KELEMEN J., Il diritto ad essere se stessi: i diritti delle minoranze visti come diritti dell'uomo, Trieste,<br />
1992.<br />
KLUCKHOHN C. - KROEBER A.L., Il concetto di cultura, Il Mulino.<br />
LAURIA F., Manuale di Diritto delle Comunità Europee, Terza edizione, UTET - 1992.<br />
LEXERT P., La minorité: du ferment de discorde au levain de culture, Trieste 1992.<br />
LIBRO VERDE SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI PARIGI, 5 settembre 1946, fra il <strong>Governo</strong><br />
italiano e quello austriaco (De Gasperi-Gruber), Roma 1954.<br />
MARCHIANO' V., Uso della lingua nei procedimenti giudiziari e principi costituzionali, in Giurisprudenza<br />
italiana, 1982.<br />
MARONGIU BUONAIUTI C., Coscienza d'Europa attraverso i secoli, Istituto di Studi Europei A. De<br />
Gasperi, Roma, 1987.<br />
480
NASCIMBENE B., Trattato CEE e Norme complementari, Seconda edizione, C. Giappichelli Editore -<br />
Torino.<br />
NORDIO M., Per uno statuto civile delle minoranze non territoriali, Trieste 1992.<br />
NOVISSIMO DIGESTO, Stato, Nazione e Minoranze.<br />
ORSELLO G.P., Ordinamento comunitario e Unione europea, Giuffrè - 1994.<br />
PALADIN L., Il divieto di discriminazione e la convenzione europea dei diritti dell'uomo, in Rivista di Diritto<br />
Internazionale, 1974.<br />
PALICI DI SUNI E., Corte Costituzionale e minoranze linguistiche: la sentenza n. 28 del 1982 fra tradizione<br />
e innovazione, in Giurisprudenza Costituzionale, 1982.<br />
PAN C. e PFEIL B. S., Le minoranze in Europa, Editor Südtiroler Volksgruppen Institut/Istituto Sudtirolese<br />
dei Gruppi Etnici.<br />
PERINI NEREO (ed.), Atti del Convegno Europeo “Problemi e proposte delle comunità di lingua minoritaria”,<br />
Udine, Università degli Studi di Udine, CONFEMILI, 1991, 270 p.<br />
PIZZORUSSO A., Problemi giuridici dell'uso delle lingue in Italia, in Le Regioni, 1977.<br />
PIZZORUSSO A., Problemi giuridici dell'uso delle lingue in Italia (con particolare riferimento alla situazione<br />
delle minoranze linguistiche non riconosciute), in Le Regioni, 1977.<br />
PIZZORUSSO A., Minoranze etnico-linguistiche, in Enciclopedia del Diritto, Milano 1976.<br />
PIZZORUSSO A., Articolo 6, in Commentario alla Costituzione, Roma 1975.<br />
PIZZORUSSO A., La tutela delle minoranze in Italia, in Il Mulino, 1974.<br />
SAFRAN W., "Pluralisme, démocratie et droits linguistiques aux États-Unis", in: Les minorités en Europe:<br />
droits linguistiques et droits de l'homme, éd. Henri Giordan, Paris, Kimé (diffusion PUF), 1992,<br />
pp. 537-556.<br />
SCALIA G. M., La tutela delle minoranze linguistiche, Editrice Galatea, 1993.<br />
TOMIZZA F., Soggezione, il destino delle minoranze, Trieste, 1992.<br />
TOSATO E, Stato, in “Enciclopedia del diritto”, pp. 759 - 786.<br />
TURCO L. e TAVELLA P., I nuovi italiani – L’immigrazione, i pregiudizi, la convivenza, Arnoldo Mondadori<br />
Editore, 2005.<br />
UDINA M., Sull'attuazione dell'art. 6 della Costituzione per la tutela delle minoranze linguistiche, in<br />
Giurisprudenza Costituzionale, 1974.<br />
UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI TRIESTE, Facoltà di Giurisprudenza, Società Italiana per l'Organizzazione<br />
Internazionale, La Comunità Internazionale - QUADERNI N. 4 - Tipologia e protezione delle minoranze<br />
in Europa, Atti del Colloquio Internazionale - Trieste, 3-4 Novembre 1990, CEDAM - Padova -<br />
1991.<br />
VEDOVATO G., Il problema dell’autonomia per la minoranza di lingua tedesca dell’Alto Adige, Firenze,<br />
s.e., 1968, pp. 79-93. In: “RSPI”. A. XXXV, 1968, n. 1.<br />
481
VEDOVATO G., Tutela delle minoranze linguistiche: 29 progetti di legge al Parlamento italiano. I.,<br />
Comunità ladine, Comunità slavofone. Firenze, s.e., 1986, pp. 41-112. In: “RSPI”, A. LIII, 1986, n. 1.<br />
VEDOVATO G., Tutela delle minoranze linguistiche: 29 progetti di legge al Parlamento italiano. II.<br />
Comunità friulane, Comunità sarda, Comunità di parlata occitana, Comunità tedescofona Walser, Comunità<br />
albanese, Tutela della lingua veneta, Comunità rom e sinti e delle diverse etnie nomadi. Firenze,<br />
s.e., 1986, pp. 253-310. In: “RSPI”, A. LIII, 1986, n. 2.<br />
VEDOVATO G., Tutela generale delle minoranze linguistiche. Un primo esame ed alcuni risultati in un<br />
testo unificato della Commissione affari costtituzionali della Camera. Firenze, s.e., 1986, pp. 445-464.<br />
In: “RSPI”, A. LIII, 1986, n. 3.<br />
VEDOVATO G., In tema di minoranze linguistiche. Firenze, Istituto di studi per l’Alto Adige, 1986, pp.<br />
192. Estr. da: “Archivio per l’Alto Adige. Rivista di studi alpini”, A. LXXX, 1986.<br />
VEDOVATO G., Tutela delle minoranze linguistiche: Progetti di legge al Parlamento italiano. Tutela<br />
generale delle minoranze linguistiche, Comunità slavofone, Comunità ladine, Comunità friulane, Comunità<br />
sarda, Comunità tedescofona Walser, Toponomastica bilingue. Una considerazione conclusiva.<br />
Firenze, s.e., 1989, pp. 593-648. In: “RSPI”, A. LVI, 1989, n. 4<br />
VEDOVATO G., Ancora in tema di minoranze linguistiche. Firenze, Istituto di studi per l’Alto Adige,<br />
1989, pp. 87. Estr. da: “Archivio per l’Alto Adige. Rivista di studi alpini”, A. LXXXIII, 1989.<br />
VEDOVATO G., Verso l’Europa integrata delle regioni transfrontaliere. Firenze, s.e., 1995, pp. 505-<br />
554. In: “Archivio per l’Alto Adige. Rivista di studi alpini”, A. LXXXIII-LXXXIX, 1994-1995.<br />
VEDOVATO G., The Carpathian Euroregion as a means for reducing possible tensions between ethnic<br />
communities. Firenze, s.e., 1996, pp. 498-504. In : “RSPI”, A. LXIII, 1996, n. 4.<br />
VEDOVATO G., Cooperazione transfrontaliera tra Italia e Francia. Firenze, s.e., 1996, pp. 371-389. In:<br />
“RPSI”, A: LXIII. 1996, n. 3.<br />
VEDOVATO G., L’Eurorégion des Carpates comme “modèle” pour d’autres projets transfrontaliers en<br />
Europe Centrale et Orientale et l’atténuation d’éventuelles tensions interethniques. Rapport à la Conférence<br />
parlementaire sur une politique paneuropéen des Régions de montagne. Rodez, 11-13 septembre<br />
1997. (Pubbl. anche in trad. inglese dal Council of Europe, Parliamentary Assembly, 1997).<br />
VEDOVATO G., La coopéation transfrontalière, les Eurorégions et le Conseil de l’Europe. In: “Annuire<br />
Européen”, Vol. XLII (1995), 1997, pp. 1-23.<br />
ZACCARI C., Cultura europea e le minoranze, 1994.<br />
482
INDICE<br />
Presentazione pag. I<br />
Premessa pag. 1<br />
Introduzione pag. 3<br />
I CONCETTI- BASE pag. 5<br />
La lingua pag. 7<br />
La cultura pag. 8<br />
Le minoranze pag. 12<br />
La nazione pag. 15<br />
Lo Stato pag. 17<br />
Il rapporto tra Stato e cultura pag. 19<br />
LA TUTELA DELLA CULTURA DELLE MINORANZE<br />
DEGLI STATI DELL’UNIONE EUROPEA pag. 21<br />
La costruzione della “Nazione” Europea pag. 27<br />
La mappa delle minoranze pag. 28<br />
LA TUTELA INTERNAZIONALE DELLE MINORANZE IN EUROPA pag. 31<br />
Introduzione pag. 33<br />
Preambolo pag. 34<br />
GLI INTERVENTI DELL’ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE pag. 37<br />
Premessa pag. 39<br />
L’art. 27 del Patto internazionale sui diritti civili e politici pag. 40<br />
La Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali<br />
o etniche, religiose e linguistiche pag. 43<br />
GLI INTERVENTI DEL CONSIGLIO D’EUROPA pag. 45<br />
Premessa pag. 47<br />
La Carta europea delle lingue regionali e/o minoritarie pag. 49<br />
La proposta per una Convenzione europea per la protezione delle minoranze pag. 57<br />
La Convenzione-quadro per la tutela delle minoranze nazionali – Diritti da tutelare pag. 60<br />
Le Raccomandazioni dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa pag. 64<br />
GLI INTERVENTI DELLA CONFERENZA/ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA<br />
E LA COOPERAZIONE IN EUROPA pag. 69<br />
Premessa pag. 71<br />
Atto finale della C.S.C.E. di Helsinki pag. 71<br />
Documento conclusivo della Conferenza sui seguiti della C.S.C.E. di Madrid pag. 72<br />
Documento conclusivo della Conferenza sui seguiti della C.S.C.E. di Vienna pag. 73<br />
Documenti conclusivi delle Riunioni della Conferenza sulla Dimensione Umana<br />
della C.S.C.E. di Copenaghen e Mosca pag. 75<br />
Carta di Parigi per una Nuova Europa pag. 77<br />
483
Rapporto della Riunione di Ginevra della C.S.C.E. di esperti sulle minoranze nazionali pag. 78<br />
Documento conclusivo del Vertice di Helsinki - “Le sfide del cambiamento” pag. 80<br />
Documento conclusivo del Vertice di Budapest - “Verso una vera partnership<br />
in una nuova era” pag. 81<br />
GLI INTERVENTI DELL’UNIONE EUROPEA pag. 83<br />
Premessa pag. 85<br />
Le Risoluzioni del Parlamento Europeo pag. 85<br />
GLI INTERVENTI DELL’INIZIATIVA CENTRO-EUROPEA pag. 91<br />
Premessa pag. 93<br />
Lo Strumento CEI per la tutela dei diritti delle minoranze pag. 93<br />
IL CONTRIBUTO DELL’UNIONE FEDERALISTA<br />
DEI GRUPPI ETNICI EUROPEI (U.F.G.E.E.) pag. 97<br />
Premessa pag. 99<br />
Progetto di Convenzione per la tutela dei gruppi etnici in Europa dell’Unione<br />
Federalista dei Gruppi Ernici in Europa pag. 99<br />
LE MINORANZE IN EUROPA pag. 105<br />
Classificazione e normativa pag. 107<br />
Denominazione delle minoranze, consistenza numerica e norme di tutela giuridica pag. 108<br />
L’INTEGRAZIONE: ASPETTI GENERALI pag. 153<br />
Natura e concetto di integrazione pag. 155<br />
L’integrazione difficile degli immigrati in Europa pag. 155<br />
L’immigrazione tra cittadinanza negata e incertezza della situazione<br />
immigratoria in Europa pag. 156<br />
Prospettive di sviluppo dell’integrazione pag. 156<br />
Misure di integrazione pag. 156<br />
Politiche culturali e società multiculturale pag. 159<br />
Il grado di inserimento degli immigrati nelle diverse aree italiane pag. 159<br />
La situazione migratoria al Nord pag. 160<br />
Disposizioni in materia di alloggio e di assistenza sociale pag. 160<br />
Immigrazione e istruzione pag. 161<br />
Nuovi mestieri nell’ottica dell’integrazione pag. 163<br />
Immigrati e comunicazione pag. 164<br />
La componente femminile nell’ambito della fenomenologia migratoria pag. 166<br />
L’impegno della Chiesa per l’inserimento degli stranieri pag. 167<br />
LINEE DI INTERVENTO SULL’INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE<br />
DEI 32 PAESI EUROPEI IN APPLICAZIONE ALLA CONVENZIONE-QUADRO<br />
PER LA PROTEZIONE DELLE MINORANZE NAZIONALI pag. 169<br />
Schede illustrative dei 32 Paesi europei pag. 171<br />
484
LE MINORANZE LINGUISTICHE NELLA COSTITUZIONE ITALIANA pag. 219<br />
Cenni storici: momenti preparatori e origine della tutela<br />
costituzionale delle minoranze linguistiche pag. 221<br />
Art. 6 della Costituzione: contenuto normativo pag. 224<br />
Coordinamento del’art. 6 con l’art. 3 della Costituzione pag. 225<br />
SAGGI DI NATURA GIURIDICA E SOCIO-CULTURALE pag. 227<br />
Minoranze linguistiche ed ambiente – La diversità culturale come risorsa pag. 229<br />
La Dichiarazione universale dei diritti linguistici pag. 235<br />
Le minoranze linguistiche nel diritto internazionale pag. 245<br />
Attualità e prospettive della Convenzione-quadro per la tutela delle minoranze nazionali pag. 248<br />
La Carta europea delle lingue regionali e/o minoritarie: pluralismo linguistico<br />
come patrimonio prezioso che appartiene a tutti pag. 252<br />
Pari dignità per lingue e culture di minoranza pag. 256<br />
Minoranze: dalla scuola le prime risposte pag. 260<br />
L’Alto Commissario OSCE per le minoranze nazionali: analisi e prospettive<br />
di azione per una maggiore tutela delle minoranze pag. 262<br />
I Walser: minoranza fiera pag. 266<br />
Tra Puglia e Calabria vivono i Greci d’Italia pag. 269<br />
Gli Ellenofoni di Puglia nel cuore del Salento pag. 273<br />
Nella sorte dei Cimbri il destino delle minoranze pag. 280<br />
Gli Sloveni: una comunità attiva in tutti i campi pag. 283<br />
Tradizioni e cultura degli Occitani pag. 289<br />
Gli Albanesi d’Italia: la mappa e la cultura pag. 295<br />
La tutela della minoranza linguistica croata in Italia: segno di civiltà nella nuova Europa pag. 300<br />
Minoranze e cultura pag. 302<br />
CLASSIFICAZIONE ED ELENCAZIONE DELLE MINORANZE PRESENTI IN ITALIA pag. 305<br />
Classificazione e distribuzione geografica pag. 307<br />
Area geografica e lingua delle minoranze pag. 309<br />
APPENDICE pag. 319<br />
NORMATIVA E DOCUMENTI INTERNAZIONALI SULL’INFORMAZIONE<br />
E LA COMUNICAZIONE NELL’AMBITO DELLE MINORANZE pag. 321<br />
Documenti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite pag. 323<br />
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948) pag. 325<br />
Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione<br />
razziale (1965) pag. 325<br />
Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966) pag. 325<br />
Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (1989) pag. 326<br />
Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali<br />
o etniche, religiose e linguistiche (1992) pag. 326<br />
Dichiarazione di Vienna e Programma d'azione (1993) pag. 326<br />
Istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani (1993) pag. 327<br />
Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) pag. 329<br />
485
Convenzione n. 107 (1957) concernente la protezione e integrazione<br />
delle popolazioni indigene, tribali e semi-tribali in paesi indipendenti pag. 331<br />
Convenzione n. 169 (1989) concernente le popolazioni indigene e tribali<br />
in Paesi indipendenti pag. 331<br />
Unesco pag. 333<br />
Raccomandazione sull’educazione alla comprensione, alla cooperazione e alla<br />
pace internazionale e sull’educazione relativa ai diritti dell’uomo e alle libertà<br />
fondamentali (1974) pag. 335<br />
Raccomandazione sulla partecipazione e l'apporto di tutta la popolazione<br />
alla vita culturale (1976) pag. 335<br />
Dichiarazione sulla razza e sui pregiudizi razziali (1978) pag. 336<br />
Dichiarazione di Città del Messico sulle politiche culturali (1982) pag. 337<br />
Conferenza intergovernativa sulle politiche culturali per lo sviluppo (1998) pag. 337<br />
Documenti del Consiglio d’Europa pag. 339<br />
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950) pag. 341<br />
Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera (1989) pag. 341<br />
Carta europea delle lingue regionali e/o minoritarie (1992) pag. 341<br />
Ratifica ed esecuzione della Convenzione-quadro per la protezione delle<br />
minoranze nazionali (1995) pag. 343<br />
Assemblea Parlamentare pag. 345<br />
Raccomandazione n. 1067 relativa alla Dimensione culturale delle emissioni<br />
radiotelevisive in Europa (1987) pag. 347<br />
Raccomandazione n. 1134 relativa ai diritti delle minoranze (1990) pag. 348<br />
Raccomandazione n. 1201 relativa a un Protocollo addizionale alla Convenzione<br />
europea dei diritti dell'uomo sui diritti delle minoranze nazionali (1993) pag. 348<br />
Raccomandazione n. 1255 relativa alla protezione dei diritti delle minoranze (1995) pag. 348<br />
Raccomandazione n. 1353 relativa all’accesso delle minoranze all’istruzione<br />
superiore (1998) pag. 349<br />
Documenti dell’Unione Europea pag. 351<br />
Risoluzione su una Carta comunitaria delle lingue e culture regionali<br />
e una Carta dei diritti delle minoranze etniche (1981) pag. 353<br />
Risoluzione sulle lingue e le culture delle minoranze etniche e regionali<br />
nella Comunità europea (1987) pag. 353<br />
Risoluzione sulla promozione del libro e della lettura in Europa (1992) pag. 354<br />
Risoluzione sulla comunicazione della Commissione concernente le nuove<br />
prospettive per l’azione della Comunità nel settore culturale (1992) pag. 354<br />
Risoluzione sulle minoranze linguistiche e culturali nella Comunità europea (1994) pag. 355<br />
Risoluzione sul libro verde sulla liberalizzazione delle infrastrutture di<br />
telecomunicazione e delle reti televisive via cavo Parte II (1995) pag. 356<br />
Risoluzione sul parere del Parlamento europeo sulla convocazione della<br />
Conferenza Intergovernativa, la valutazione dei lavori del Gruppo di riflessione<br />
e la precisazione delle priorità politiche del Parlamento europeo in vista<br />
della Conferenza Intergovernativa (1996) pag. 356<br />
Direttiva 97/36/CE che modifica la Direttiva del Consiglio 89/552/CEE sul coordi-<br />
namento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative<br />
negli Stati membri e concernenti l’esercizio delle attività televisive (1997) pag. 357<br />
486
Documenti della O.S.C.E. pag. 359<br />
Documento del Simposio di Cracovia sul retaggio culturale degli Stati<br />
partecipanti alla CSCE (1991) pag. 361<br />
Rapporto della riunione CSCE di esperti sulle minoranze nazionali – Ginevra<br />
(luglio 1991) pag. 361<br />
Raccomandazioni di Oslo riguardanti i diritti linguistici delle minoranze nazionali (1998) pag. 362<br />
Documenti dell’Iniziativa Centro Europea pag. 363<br />
Strumento CEI per la tutela dei diritti delle minoranze (1994) pag. 365<br />
Documenti dell’Unione Federalista dei Gruppi Etnici Europei (U.F.G.E.E.) pag. 367<br />
Convenzione sui diritti fondamentali dei gruppi etnici in Europa pag. 369<br />
NORMATIVA E DOCUMENTI INTERNAZIONALI SULLA DISCRIMINAZIONE<br />
IN TEMA DI MINORANZE pag. 371<br />
Documenti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite pag. 373<br />
Carta delle Nazioni Unite (1945) pag. 375<br />
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948) pag. 376<br />
Convenzione relativa allo status dei rifugiati (1951) pag. 377<br />
Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione<br />
razziale (1965) pag. 379<br />
Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966) pag. 382<br />
Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966) pag. 383<br />
Ratifica ed esecuzione del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e<br />
culturali, nonché del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con<br />
Protocollo facoltativo (1977) pag. 384<br />
Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti<br />
della donna (1979) pag. 384<br />
Dichiarazione sull’eliminazione di tutte le forme d’intolleranza e di discriminazione<br />
fondate sulla religione o il credo (1981) pag. 385<br />
Dichiarazione sul diritto allo sviluppo (1986) pag. 387<br />
Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia (1989) pag. 388<br />
Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori emigranti<br />
e dei membri delle loro famiglie (1990) pag. 389<br />
Dichiarazione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali<br />
o etniche, religiose e linguistiche (1992) pag. 390<br />
Dichiarazione di Vienna e Programma d'azione (1993) pag. 392<br />
Istituzioni nazionali per la promozione e la protezione dei diritti umani (1993) pag. 394<br />
Progetto di dichiarazione sui diritti dei popoli indigeni (1994) pag. 395<br />
Decennio per l’educazione ai diritti umani (1994) pag. 397<br />
Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi<br />
della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani<br />
universalmente riconosciuti (1999) pag. 397<br />
Dichiarazione per una cultura di pace (1999) pag. 399<br />
Dichiarazione del Millennio (2000) pag. 400<br />
Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) pag. 401<br />
Convenzione n. 107 (1957) concernente la protezione e integrazione delle<br />
popolazioni indigene, tribali e semi-tribali in paesi indipendenti pag. 403<br />
Convenzione n. 111 (1958) concernente la discriminazione in materia di impiego<br />
e di professione pag. 404<br />
487
Convenzione n. 169 (1989) concernente le popolazioni indigene e tribali<br />
in Paesi indipendenti pag. 405<br />
Unesco pag. 407<br />
Convenzione sulla lotta contro la discriminazione nell'educazione (1960) pag. 409<br />
Raccomandazione sull’educazione alla comprensione, alla cooperazione e alla pace<br />
internazionale e sull’educazione relativa ai diritti dell’uomo e alle libertà<br />
fondamentali (1974) pag. 410<br />
Raccomandazione sulla partecipazione e l'apporto di tutta la popolazione<br />
alla vita culturale (1976) pag. 411<br />
Dichiarazione sulla razza e sui pregiudizi razziali (1978) pag. 412<br />
Dichiarazione di Città del Messico sulle politiche culturali (1982) pag. 415<br />
Documenti del Consiglio d’Europa pag. 417<br />
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950) pag. 419<br />
Raccomandazione n. R[87] 3 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri<br />
sulle Norme Europee in materia di Detenzione (1987) pag. 419<br />
Carta europea delle lingue regionali e/o minoritarie (1992) pag. 420<br />
Dichiarazione di Vienna (1993) pag. 421<br />
Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze<br />
nazionali (1994) pag. 423<br />
Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano<br />
nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina (1997) pag. 424<br />
Impegno di Barcellona per i diritti umani (1998) pag. 425<br />
Protocollo addizionale n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo<br />
e delle libertà fondamentali (2000) pag. 427<br />
Assemblea Parlamentare pag. 429<br />
Rapporto per l’introduzione di una garanzia collettiva relativa alle libertà<br />
essenziali e ai diritti fondamentali (1949) pag. 431<br />
Rapporto sui diritti delle minoranze nazionali (1961) pag. 431<br />
Raccomandazione n. 285 (1961) relativa ai diritti delle minoranze nazionali pag. 432<br />
Raccomandazione n. 1134 relativa ai diritti delle minoranze (1990) pag. 433<br />
Raccomandazione n. 1177 relativa ai diritti delle minoranze (1992) pag. 434<br />
Raccomandazione n. 1201 relativa a un Protocollo addizionale alla Convenzione<br />
europea dei diritti dell'uomo sui diritti delle minoranze nazionali (1993) pag. 434<br />
Raccomandazione n. 1255 relativa alla protezione dei diritti delle minoranze<br />
nazionali (1995) pag. 435<br />
Progetto Melting Pot Europa pag. 437<br />
Carta europea dei diritti dell’uomo nella città (2000) pag. 439<br />
Documenti dell’Unione Europea pag. 441<br />
Risoluzione sulla molteplicità culturale ed i problemi della formazione scolastica<br />
dei figli dei lavoratori migranti nella Comunità europea (1992) pag. 443<br />
Trattato sull'Unione Europea (firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992) pag. 443<br />
Progetto di relazione sulla tutela a livello di diritto comunitario dei diritti dei gruppi<br />
etnici stanziati negli stati membri (1993) pag. 444<br />
Decisione n. 819 che istituisce il programma d'azione Comunitario "Socrate" (1995) pag. 445<br />
Risoluzione sul funzionamento del Trattato sull'Unione Europea in vista della Confe-<br />
renza Intergovernativa del 1996 – Realizzazione ed evoluzione dell'Unione (1995) pag. 446<br />
Risoluzione sul parere del Parlamento europeo sulla convocazione della Conferenza<br />
Intergovernativa, la valutazione dei lavori del Gruppo di riflessione e la precisazione<br />
delle priorità politiche del Parlamento europeo in vista della Conferenza<br />
Intergovernativa (1996) pag. 447<br />
488
Trattato sull’Unione europea e Conferenza intergovernativa (1996) pag. 448<br />
Direttiva 97/36/CE che modifica la Direttiva del Consiglio 89/552/CEE sul<br />
coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative<br />
negli Stati membri e concernenti l’esercizio delle attività di televisive (1997) pag. 449<br />
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Nizza, 7 dicembre 2000) pag. 449<br />
Costituzione europea (2004) pag. 450<br />
Documenti dell’ O.S.C.E. pag. 451<br />
Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa<br />
Helsinki (1975) pag. 453<br />
Documento conclusivo della riunione di Madrid (1980-1983) pag. 454<br />
Documento conclusivo della riunione di Vienna (1986-1989) pag. 454<br />
Documento della riunione di Copenhagen della Conferenza sulla dimensione<br />
umana della CSCE (giugno 1990) pag. 455<br />
Carta di Parigi per una Nuova Europa (novembre 1990) pag. 457<br />
Rapporto della riunione CSCE di esperti sulle minoranze nazionali<br />
- Ginevra (luglio 1991) pag. 458<br />
Documento del Simposio di Cracovia sul retaggio culturale degli Stati<br />
partecipanti alla CSCE (1991) pag. 460<br />
Proposta dell'Esagonale pag. 461<br />
Documento della riunione di Mosca della conferenza sulla dimensione umana<br />
della CSCE (ottobre 1991) pag. 462<br />
Dichiarazione del vertice di Helsinki - Le sfide del cambiamento (1992) pag. 463<br />
Dichiarazione finale di Helsinki (1993) pag. 464<br />
Documento conclusivo del Vertice di Budapest - "Verso una vera partnership<br />
in una nuova era" (1994) pag. 464<br />
Raccomandazioni dell'Aja riguardanti il diritto all'istruzione delle minoranze<br />
nazionali (1996) pag. 465<br />
Raccomandazioni di Oslo riguardanti i diritti linguistici delle minoranze nazionali<br />
e nota illustrativa(1998) pag. 466<br />
Documenti dell’Iniziativa Centro Europea pag. 469<br />
Strumento CEI per la tutela dei diritti delle minoranze (1994) pag. 471<br />
Documenti dell’U.F.G.E.E. pag. 473<br />
Convenzione sui diritti fondamentali dei gruppi etnici in Europa pag. 475<br />
Diritti di autonomia dei gruppi etnici in Europa pag. 475<br />
Bibliografia pag. 477<br />
489