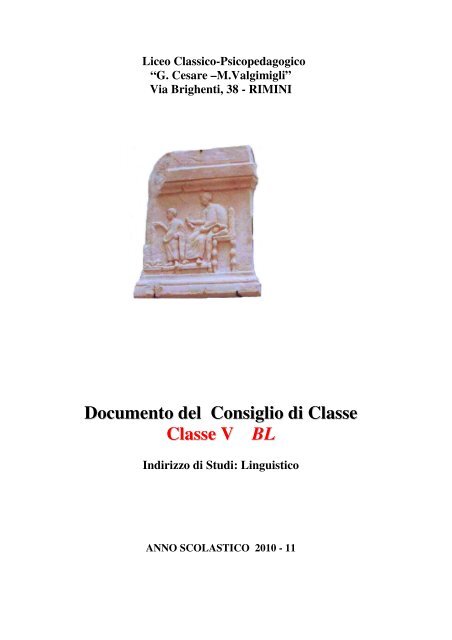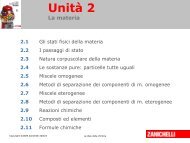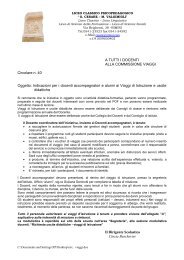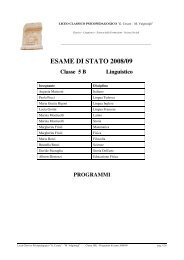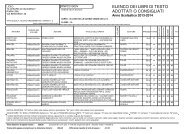Classe 5B - Linguistico - Liceo Classico Psicopedagogico Cesare ...
Classe 5B - Linguistico - Liceo Classico Psicopedagogico Cesare ...
Classe 5B - Linguistico - Liceo Classico Psicopedagogico Cesare ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong>-<strong>Psicopedagogico</strong><br />
“G. <strong>Cesare</strong> –M.Valgimigli”<br />
Via Brighenti, 38 - RIMINI<br />
Documento del Consiglio di <strong>Classe</strong><br />
<strong>Classe</strong> V BL<br />
Indirizzo di Studi: <strong>Linguistico</strong><br />
ANNO SCOLASTICO 2010 - 11
LICEO CLASSICO-PSICOPEDAGOGICO<br />
“G. CESARE –M.VALGIMIGLI”<br />
RIMINI<br />
Indice<br />
Finalità generali del corso di studi<br />
Membri del Consiglio di classe<br />
Profilo della classe<br />
Storia della classe<br />
Uscite didattiche, viaggi d’istruzione ed altre attività didattiche<br />
Obiettivi didattici trasversali perseguiti e raggiunti<br />
Simulazioni terza prova<br />
Strumenti e criteri di valutazione<br />
Attribuzione credito scolastico<br />
Allegati:<br />
• Copia delle simulazioni di prima, seconda e terza prova assegnate durante l’anno<br />
scolastico<br />
• Copia delle griglie di valutazione utilizzate per la correzione delle simulazioni<br />
• Programmi svolti<br />
2
Finalità generali del corso di studi<br />
• L’offerta formativa del liceo linguistico mira alla padronanza delle competenze linguistiche attraverso<br />
l’insegnamento di tre lingue straniere.<br />
• La dimensione formativa è assicurata per tutto il triennio dal contributo dei tre assi fondamentali<br />
(linguistico-letterario-artistico, storico-filosofico matematico-scientifico), dalla metodologia che ne<br />
caratterizza l’insegnamento e dall’analisi della cultura occidentale, in particolare europea, attraverso<br />
l’apprendimento delle lingue.<br />
• L’asse culturale del liceo linguistico si fonda sul linguaggio inteso quale oggetto privilegiato di<br />
riflessione e centro di riferimenti culturali e di dinamiche conoscitive e propositive. In tale contesto<br />
vanno valorizzati sia gli aspetti specifici dei singoli linguaggi sia il concetto di lingua nelle sue diverse<br />
valenze di strumento di comunicazione e di relazione, di veicolo di conoscenza, di fattore culturale.<br />
• Il profilo formativo dell’allievo al termine del quinquennio risulta quello di persona consapevole della<br />
propria identità culturale, aperta nei riguardi di altre culture e disponibile a confrontarsi con esse, dotata<br />
quindi della capacità di riflettere in modo critico su altri sistemi culturali, partendo dal proprio.<br />
3
Membri del Consiglio di <strong>Classe</strong><br />
La composizione del Consiglio di classe della quinta BL per l’anno scolastico 2010/11 è riportata nella tabella<br />
sottostante.<br />
Nel corso del triennio si sono registrati alcuni avvicendamenti tra gli insegnanti. In particolare ciò si è verificato<br />
per i docenti di francese e tedesco. In quest’ultimo caso la mancata continuità didattica ha determinato una<br />
maggiore fragilità nella preparazione generale degli alunni che, inoltre, hanno iniziato lo studio della terza<br />
lingua straniera (tedesco) dalla classe terza.<br />
Insegnante Materia<br />
Religione Francesco Perez<br />
Italiano Ambra Magalotti<br />
Latino Augusta Matteoni<br />
Storia Augusta Matteoni<br />
Inglese Fernanda Casablanca- Rosanna Ferrara<br />
Francese Maddalena Lodesani-Christine Dinh<br />
Tedesco Sigrid Kohn-Baerbel Mueller<br />
Filosofia Maria Borzi<br />
Scienze Brunella Renzi<br />
Matematica Stefania Binotti<br />
Fisica Stefania Binotti<br />
Storia dell’arte Pazzaglia Davide<br />
Educazione fisica Bertozzi Alberto<br />
4
Profilo della classe<br />
La classe, attualmente formata da 19 alunni, 13 femmine ed 6 maschi, nasce dalla fusione, nell’A. S. 2007/08,<br />
in seconda, fra l’originaria IB (13 alunni) ed un folto gruppo, 15, di studenti di IC, soppressa dal CSA nel<br />
progetto di razionalizzazione delle classi previsto dal Ministero della Pubblica Istruzione. Nel corso degli anni,<br />
successivi inserimenti e/o trasferimenti (gli ultimi due alla fine del passato A.S.) hanno progressivamente<br />
modificato la fisionomia della classe e impegnato i docenti in un costante lavoro di integrazione e fusione fra le<br />
diverse componenti, attività piuttosto impegnativa, anche per la presenza di alcuni alunni particolarmente<br />
refrattari ad adeguarsi alle regole.<br />
Nell’arco del triennio un notevole salto di qualità a livello relazionale e cognitivo è stato compiuto a partire dal<br />
quarto anno di corso, quando una serie di situazioni contingenti favorevoli, non ultimo un maggiore<br />
affiatamento e una migliore integrazione tra gli allievi, ma anche una certa selezione operata all’interno della<br />
classe, ha permesso agli insegnanti di lavorare in un clima positivo e disponibile ad accogliere le proposte di<br />
lavoro e gli stimoli offerti.<br />
La fisionomia della classe ha mantenuto nel corso del quinquennio alcune caratteristiche costanti che possono<br />
essere così sintetizzate:<br />
una generale vivacità intellettuale, mostrata in classe, durante i momenti di lavoro comune, attraverso<br />
una partecipazione attiva, e quasi sempre costruttiva, al dialogo educativo;<br />
la presenza di un gruppo consistente di alunni desiderosi di emergere e di raggiungere risultati<br />
apprezzabili, i quali, nel corso del quinquennio, hanno potenziato le proprie capacità e competenze,<br />
rafforzato la motivazione e la curiosità nei confronti dello studio e della comprensione della realtà<br />
attuale;<br />
il sopravvivere di fratture e conflitti interni non del tutto superati;<br />
la difficoltà di alcuni studenti, in corrispondenza dei momenti di più intensa attività o di pressione<br />
emotiva, a tenere fede e a rispondere con regolarità e puntualità alle scadenze dell’attività didattica;<br />
un approccio allo studio, specie nello discipline tecniche e scientifiche, non sempre sistematico e<br />
supportato da una metodologia rigorosa che alle volte è risultato dispersivo e ha provocato rallentamenti<br />
nello sviluppo del lavoro scolastico.<br />
Considerando complessivamente il percorso triennale, e in alcuni casi quinquennale, le finalità educative<br />
formulate nella programmazione del Consiglio di classe sono da considerarsi raggiunte ad un livello<br />
soddisfacente, rispetto alle diverse situazioni di partenza, per quanto attiene:<br />
• una maggiore disponibilità all’ascolto;<br />
• una maggiore capacità di controllare e moderare il proprio atteggiamento e comportamento;<br />
• una partecipazione più omogenea al dialogo educativo;<br />
• l’ampliamento degli interessi culturali;<br />
• lo sviluppo del senso estetico come capacità di riconoscere e gustare il bello nelle sue forme.<br />
Sul piano delle conoscenze e delle competenze acquisite i risultati non sono omogenei nelle singole discipline e<br />
fra i singoli allievi ed evidenziano anche situazioni di consistente divario:<br />
• Emerge un buon numero di alunni che hanno raggiunto una preparazione ampia e consapevole in tutte o<br />
in quasi tutte le discipline e, grazie all’applicazione di una volontà costante, hanno sviluppato, secondo<br />
livelli discreti, buoni ed anche ottimi, l’attitudine ad organizzare il proprio lavoro, a reperire ed<br />
utilizzare in modo adeguato materiale di studio e di approfondimento, la capacità di utilizzare e<br />
applicare le competenze acquisite nei vari campi del sapere e di rielaborare i contenuti.<br />
• In altri casi una maggiore fragilità sia emotiva sia delle capacità ha permesso agli allievi di raggiungere<br />
una preparazione sufficiente o più che sufficiente, ma essenziale nella qualità e nella quantità della<br />
conoscenze.<br />
5
La classe è composta dai seguenti alunni:<br />
Cognome Nome<br />
1 Boffa Elisabetta<br />
2 Casadei Giada<br />
3 Contri Tommaso<br />
4 Faedi Eugenia<br />
5 Garuffi Gaia<br />
6 Gattei Giorgia<br />
7 Ghinelli Gianni<br />
8 Maddalena Nicole<br />
9 Mastelleri Alex<br />
10 Moreno Nicholas<br />
11 Navez Sarah<br />
12 Pop Oana Bianca<br />
13 Paci Irene Aurora<br />
14 Paglierani Greta<br />
15 Tommasi Nicole<br />
16 Tagliavini Alberto<br />
17 Tonni Mafalda<br />
18 Veronesi Jacopo<br />
19 Zanni Alessandra<br />
6
Storia della classe<br />
La tabella riporta i dati numerici relativi agli iscritti e all’esito finale dei cinque anni di studi.<br />
Anno<br />
scolastico<br />
1° anno<br />
2006/2007<br />
2° anno<br />
2007/08<br />
(Inserimento 15<br />
alunni di IC)<br />
3° anno<br />
2008/09<br />
4° anno<br />
2009/10<br />
5° anno<br />
2010/11<br />
Iscritti<br />
19<br />
29<br />
25<br />
21<br />
19<br />
Ritirati o<br />
trasferiti<br />
2<br />
1<br />
1<br />
2<br />
/<br />
Respinti<br />
4<br />
3<br />
3<br />
/<br />
Promossi<br />
13<br />
(6 con debito)<br />
25<br />
(8 con debito)<br />
21<br />
(6 con debito)<br />
Uscite didattiche, viaggi d’istruzione ed altre attività didattiche<br />
Nel corso del triennio la classe è stata coinvolta nelle seguenti iniziative:<br />
1. Viaggio di istruzione a Firenze.<br />
2. Visita a mostre e musei cittadini.<br />
3. Soggiorni linguistici in Inghilterra, Francia e in Germania.<br />
4. Scambio classe/gemellaggio con una scolaresca olandese (in quarta e quinta).<br />
5. Visione di rappresentazioni teatrali in lingua francese e/o inglese (“Cyrano de Bergerac”; “Lady Windermere’s<br />
fan”; …)<br />
6. Certificazioni esterne per le lingue straniere: PET e FIRST per inglese; DELF 1° e 2° livello per francese; FIT<br />
2, ZD per tedesco con relativi corsi pomeridiani di preparazione.<br />
7. DNA Finger printing, progetto curriculare di scienze.<br />
8. Partecipazione ad un concorso indetto dall’AVIS.<br />
9. AVIS progetto di sensibilizzazione alla donazione del sangue.<br />
10. Associazione Marino Golinelli: “La scienza in piazza”.<br />
11. Attività di orientamento universitario in vari atenei.<br />
12. Festa dell’Europa: Inclusione sociale e lotta alla povertà (Bologna 24-27 novembre, due alunni).<br />
13. Concorso CARITAS: La scuola azzera la povertà (tutta la classe).<br />
14. Partecipazione al “Progetto Memoria” organizzato dal Comune di Rimini e viaggio premio a Berlino (alcuni<br />
alunni).<br />
15. Cineforum: “I 150 dell’Unità d’Italia” (alcuni alunni).<br />
…<br />
19<br />
…<br />
7
Simulazioni Terza prova<br />
Il Consiglio di classe, nella seduta del 5 ottobre 2010 ha deliberato di utilizzare, nelle simulazioni di terza<br />
prova scritta, la tipologia B indicata come “quesiti a risposta sintetica” (tre domande per ogni disciplina).<br />
Sono state eseguite 2 simulazioni:<br />
- La prima, in data 4 dicembre 2010, relativa alle seguenti discipline: inglese, storia dell’arte, scienze,<br />
francese.<br />
- La seconda, in data 4 maggio 2011, relativa alle seguenti discipline: francese, tedesco, matematica, storia<br />
dell’arte.<br />
In allegato vengono riportati i testi delle simulazioni assegnate agli alunni e i criteri di valutazione utilizzati.<br />
Per lo svolgimento delle prove è stato assegnato un tempo di quattro ore.<br />
Sono state inoltre svolte una simulazione relativa alla prima prova scritta d’esame (18 aprile 2011) ed una<br />
relativa alle seconda prova (19 aprile 2011). Anche per le rispettive griglie di valutazione si rimanda agli<br />
allegati.<br />
8
Obiettivi cognitivi e educativi trasversali<br />
Strumenti e criteri di valutazione<br />
Obiettivi comportamentali: Strumenti /metodi Modalità di verifica<br />
• Consolidare – acquisire corrette capacità<br />
relazionali nei rapporti con i docenti, con i<br />
compagni, con i soggetti esterni<br />
eventualmente coinvolti nelle attività<br />
didattiche curriculari ed extracurriculari;<br />
• Rafforzare la consapevolezza delle proprie<br />
responsabilità ed impegni;<br />
• Consolidare - ampliare gli interessi culturali;<br />
• Consolidare la motivazione sottesa alla scelta<br />
del corso di studi anche in vista di future<br />
scelte di studio o di lavoro;<br />
• Arrivare ad una prima consapevolezza della<br />
complessità del reale;<br />
• Educare alla tolleranza e all’accettazione<br />
della diversità.<br />
• Attività disciplinari e<br />
multidisciplinari<br />
• Lavori di gruppo<br />
• Dibattiti<br />
• Visite guidate e<br />
viaggio di istruzione;<br />
• Promozione della<br />
lettura;<br />
• Promozione della<br />
partecipazione ad<br />
attività culturali<br />
• Partecipazione e<br />
interesse rispetto<br />
alle attività svolte in<br />
classe;<br />
• Discussione e<br />
dibattiti;<br />
• Partecipazione alle<br />
assemblee di classe;<br />
• Assiduità e<br />
motivazione nella<br />
partecipazione alle<br />
attività svolte<br />
Obiettivi/competenze Modalità di verifica Indicatori di livello Valutazione<br />
Conoscenza: consolidare la capacità<br />
di rievocare all’interno delle singole<br />
discipline<br />
• elementi specifici<br />
• modi e mezzi per usarli<br />
• dati universali<br />
Comprensione: consolidare la<br />
facoltà di afferrare il senso di una<br />
informazione per<br />
• trasformare<br />
• interpretare<br />
• estrapolare<br />
Consolidare - acquisire capacità di<br />
analisi: saper distinguere e separare<br />
gli elementi costitutivi di una<br />
comunicazione per evidenziarne<br />
• elementi<br />
• relazioni<br />
• principi organizzativi<br />
• Colloqui<br />
• Relazioni<br />
• Analisi testuali<br />
• Prove strutturate e/o<br />
semistrutturate<br />
• Produzioni di varia<br />
tipologia utilizzando<br />
codici diversi<br />
• Colloqui<br />
• Relazioni<br />
• Analisi testuali<br />
• Prove strutturate e/o<br />
semistrutturate<br />
• Costruzione di mappe<br />
concettuali<br />
• Risoluzione di problemi<br />
• Colloqui<br />
• Relazioni<br />
• Analisi testuali<br />
• Prove strutturate e/o<br />
semistrutturate<br />
• Costruzione di mappe<br />
concettuali<br />
• Scarsa<br />
• Limitata<br />
• Sufficiente<br />
• Ampia<br />
• Esauriente<br />
• Approssimativa<br />
• Superficiale<br />
• Corretta<br />
• Consapevole<br />
• Completa<br />
• Confusa<br />
• Superficiale<br />
• Essenziale<br />
• Articolata<br />
• Profonda<br />
• 2 – 4<br />
• 4 – 5<br />
• 6<br />
• 7 – 8<br />
• 9 - 10<br />
• 2 – 4<br />
• 4 – 5<br />
• 6<br />
• 7 – 8<br />
• 9 - 10<br />
• 2 – 4<br />
• 4 – 5<br />
• 6<br />
• 7 – 8<br />
• 9 – 10<br />
9
Obiettivi/competenze Modalità di verifica Indicatori di livello Valutazione<br />
Consolidare - acquisire capacità di<br />
sintesi organica e personale: saper<br />
riunire elementi al fine di formare,<br />
in modo coerente,<br />
• comunicazioni uniche<br />
• piani di azione<br />
• insieme di relazioni astratte<br />
Applicazione: acquisire o<br />
consolidare la capacità di utilizzare<br />
dati o procedimenti conosciuti<br />
riuscendo a<br />
• collegare<br />
• organizzare<br />
• generalizzare<br />
Consolidare precisare le competenze<br />
linguistico espressive: capacità di<br />
esprimere/comunicare il proprio<br />
pensiero in modo<br />
• Corretto<br />
• Aderente<br />
• Coerente<br />
• Fluido<br />
• Colloqui<br />
• Relazioni e saggio breve<br />
• Analisi testuali<br />
• Prove strutturate e/o<br />
semistrutturate<br />
• Costruzione di mappe<br />
• Risoluzione di problemi<br />
• Relazioni orali e scritte<br />
• Analisi testuali<br />
• Risoluzione di problemi<br />
• Costruzione di mappe<br />
• Costruzione di tabelle<br />
• Produzioni di varia<br />
tipologia utilizzando<br />
codici diversi<br />
• Colloqui<br />
• Relazioni orali e scritte<br />
• Produzione di varia<br />
tipologia utilizzando<br />
codici diversi.<br />
Obiettivi verificati nelle prove scritte di matematica<br />
Saper gestire il calcolo algebrico<br />
Collegare l’aspetto algebrico con l’aspetto grafico<br />
Saper studiare una funzione<br />
• Confusa<br />
• Frammentaria<br />
• Coerente<br />
• Efficace<br />
• Personale,<br />
originale<br />
• Errata<br />
• Incerta<br />
• Accettabile<br />
• Sicura<br />
• Autonoma<br />
• Scorretta/confusa<br />
• Incerta<br />
• Corretta<br />
• Chiara<br />
• Disinvolta<br />
Obiettivi verificati nelle prove scritte di italiano<br />
a) ADERENZA ALLA TRACCIA E CONOSCENZA DEI SUOI CONTENUTI<br />
b) COERENZA NELLA COSTRUZIONE DEL DISCORSO<br />
c) APPROFONDIMENTO CRITICO<br />
d) CORRETTEZZA GRAMMATICALE E SINTATTICA<br />
VOTI PER CIASCUNA VOCE:<br />
BUONO 2,5 / DISCRETO 2 / SUFFICIENTE 1, 5 / SCARSO 1 / INSUFFICIENTE 0, 5 - 0<br />
• 2 – 4<br />
• 4 – 5<br />
• 6<br />
• 7 – 8<br />
• 9 – 10<br />
• 2 – 4<br />
• 4 – 5<br />
• 6<br />
• 7 – 8<br />
• 9 – 10<br />
• 2 – 4<br />
• 4 – 5<br />
• 6<br />
• 7 – 8<br />
• 9 – 10<br />
Punteggio<br />
1 - 10<br />
1 - 10<br />
1 - 10<br />
10
Obiettivi verificati nelle prove scritte di lingua straniera e<br />
latino<br />
Comprensione<br />
Contenuto<br />
Esposizione<br />
Correttezza<br />
Frequenza<br />
Impegno<br />
Partecipazione<br />
Comportamento<br />
Griglia di valutazione per l’area comportamentale<br />
molto irregolare<br />
scarso<br />
marginale<br />
poco responsabile<br />
discontinua<br />
diligente<br />
costruttiva<br />
corretto<br />
regolare<br />
rigoroso<br />
trainante<br />
Punteggio<br />
1 - 10<br />
1 - 10<br />
1 - 10<br />
1 - 10<br />
responsabile<br />
Attribuzione del credito scolastico<br />
Per l’attribuzione del credito scolastico il Collegio ha fissato i seguenti criteri.<br />
• Il punteggio relativo al credito scolastico verrà determinato in sede di scrutinio finale, tenendo conto:<br />
a) della media dei voti del secondo quadrimestre, per determinare la banda di oscillazione;<br />
b) del curricolo, se in crescita o costantemente positivo;<br />
c) della assiduità alla frequenza, dell’interesse, dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo e<br />
alle attività complementari e integrative;<br />
d) dei crediti formativi certificati.<br />
• L’attività svolta deve avere contenuti omogenei con i contenuti tematici del corso di studi e deve essere<br />
certificata da un ente esterno alla scuola:<br />
tra le attività culturali sono riconosciute la patente europea del computer (ECDL), e le<br />
certificazioni internazionali di conoscenza della lingua (PET;DELF; FIRST…);<br />
tra le attività artistiche sono riconosciute, per la musica un diploma rilasciato dal Conservatorio;<br />
per la pitturala partecipazione a concorsi e mostre organizzati da enti qualificati; per la danza la<br />
partecipazione a stages di rilevanza nazionale e/o internazionale;<br />
le attività ricreative e di volontariato sono riconosciute se l’alunno dimostra di lavorare nei<br />
settori indicati con un incarico di responsabile;<br />
le attività sportive sono riconosciute se praticate a livello agonistico;<br />
11
se si tratta di attività lavorativa coerente con l’indirizzo di studio la certificazione deve indicare<br />
l’ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni<br />
normative che escludano l’obbligo dell’adempimento contributivo;<br />
le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero devono essere convalidate dall’autorità<br />
diplomatica; le certificazioni attestanti la frequenza di corsi di lingue all’estero saranno<br />
riconosciute valide se rilasciate da scuole riconosciute dal British Council (per l’inglese) o<br />
Membri Souffle (per il francese).<br />
Sarà inoltre attribuita un’integrazione extra in casi di particolare impegno e merito scolastico dimostrati<br />
nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti, in relazione a situazioni<br />
familiari o personali dell’alunno, che ne avessero determinato un minor rendimento.<br />
Terzultimo anno Penultimo anno Ultimo anno di corso<br />
Media<br />
Scrutinio<br />
finale<br />
Credito<br />
scolastico<br />
Media<br />
Scrutinio<br />
finale<br />
Credito<br />
scolastico<br />
Media<br />
Scrutinio<br />
finale<br />
Credito<br />
scolastico<br />
6 3-4 6 3-4 6 4-5<br />
6+ 7 4-5 6+ 7 4-5 6+ 7 5-6<br />
7+ 8 5-6 7+ 8 5-6 7+ 8 6-7<br />
8+ 9 6-7 8+ 9 6-7 8+ 8,5 8<br />
9+ 10 7-8 9+ 10 7-8 8,5 - 10 9<br />
Programmi effettivamente svolti<br />
Le pagine che seguono in allegato riportano, per ciascuna disciplina, gli argomenti effettivamente svolti.<br />
Rimini 15 Maggio 2011<br />
Il segretario verbalizzante e coordinatore della classe<br />
Prof. Ambra Magalotti<br />
12
A L L E G A T I<br />
• Copia delle simulazioni di<br />
prima, seconda e terza prova<br />
assegnate durante l’anno<br />
scolastico<br />
• Copia delle griglie di valutazione<br />
utilizzate per la correzione delle<br />
simulazioni<br />
• Copia dei programmi svolti<br />
nelle singole discipline<br />
13
LICEO LINGUISTICO<br />
“G. CESARE – M. VALGIMIGLI”<br />
SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO<br />
A.S. 2010/11<br />
CLASSE: V AL – V BL LICEO LINGUISTICO 18/04/11<br />
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO<br />
Dante Alighieri, Paradiso, canto XI, versi 43-63 e 73-87: nel cielo del Sole Dante incontra san Tommaso<br />
d’Aquino, che gli narra la vita di san Francesco e ne esalta l’opera.<br />
43 «Intra Tupino e l’acqua che discende<br />
44 del colle eletto dal beato Ubaldo<br />
45 fertile costa d’alto monte pende,<br />
46 onde Perugia sente freddo e caldo<br />
47 da Porta Sole; e di rietro le piange<br />
48 per grave giogo Nocera con Gualdo.<br />
49 Di questa costa, là dov’ella frange<br />
50 più sua rattezza, nacque al mondo un sole,<br />
51 come fa questo talvolta di Gange.<br />
Intra Tupino…..Nocera con Gualdo: ampia<br />
descrizione del territorio, tra i fiumi Topino e<br />
Chiascio, il monte Subasio (scelto come luogo<br />
di eremitaggio dal beato Ubaldo), Perugia,<br />
Nocera e Gualdo, al centro del quale sorge<br />
Assisi, città natale di san Francesco<br />
un sole, / come fa questo talvolta di Gange:<br />
nacque un essere umano pieno di luce e calore,<br />
come talvolta ci appare il vero sole appena<br />
sorto in Oriente (dalle parti del fiume Gange)<br />
52 Però chi d’esso loco fa parole, Però: perciò<br />
53 non dica Ascesi, ché direbbe corto, Ascesi: forma locale antica del nome di Assisi<br />
54 ma Orïente, se proprio dir vuole.<br />
55 Non era ancor molto lontan da l’orto, l’orto: la nascita (dal latino ortus)<br />
56 ch’el cominciò a far sentir la terra la terra: al mondo<br />
57 de la sua gran virtute ogni conforto;<br />
58 ché per tal donna, giovinetto, in guerra<br />
59 del padre corse, a cui, come a la morte,<br />
60 la porta del piacer nessun diserra;<br />
61 e dinanzi a la sua spirital corte<br />
62 et coram patre le si fece unito;<br />
63 poscia di dì in dì l’amò più forte.<br />
per tal donna…a cui,…la porta del piacer<br />
nessun diserra: venne in lite con suo padre a<br />
causa di una donna alla quale, come alla<br />
morte, nessuno apre volentieri la porta<br />
spirital corte et coram patre: davanti alla corte<br />
ecclesiastica (il vescovo e il clero) e in<br />
presenza del padre<br />
73 Ma perch’io non proceda troppo chiuso<br />
74 Francesco e Povertà per questi amanti<br />
75 Prendi oramai nel mio parlar diffuso.<br />
76 La lor concordia e i lor lieti sembianti,<br />
77 amore e maraviglia e dolce sguardo<br />
78 facìeno esser cagion di pensier santi; facìeno esser cagion di pensier santi: facevano<br />
nascere santi pensieri in altre persone<br />
79 tanto che ‘l venerabile Bernardo<br />
venerabile Bernardo: Bernardo d’Assisi, primo<br />
80 si scalzò prima, e dietro a tanta pace<br />
seguace di san Francesco, e quindi primo a<br />
vestire come lui, che, imitando gli Apostoli,<br />
camminava scalzo<br />
14
81 corse e, correndo, li parve esser tardo.<br />
82 Oh ignota ricchezza! Oh ben ferace!<br />
83 Scalzasi Egidio, scalzasi Silvestro Egidio …. Silvestro: anche loro di Assisi e tra i<br />
primi seguaci del santo<br />
84 dietro a lo sposo, sì la sposa piace.<br />
85 Indi sen va quel padre e quel maestro Indi sen va: allude agli incontri con i pontefici<br />
per ottenerne l’approvazione, e alle future<br />
predicazioni di Francesco e dei seguaci in<br />
Italia e fuori<br />
86 con la sua donna e con quella famiglia<br />
87 che già legava l’umile capestro» che già legava l’umile capestro: già si cingeva<br />
con il rozzo cordone sulla tonaca, tipico<br />
dell’Ordine francescano<br />
Nel quarto cielo, quello del Sole, Dante, guidato sempre da Beatrice, ha incontrato una corona di dodici «fulgori»,<br />
che sono le anime di altrettanti celebri sostenitori della fede religiosa. Uno di questi, san Tommaso d’Aquino, gli<br />
descrive in particolare le figure di san Francesco di Assisi, fondatore dell’Ordine dei Francescani, e san Domenico<br />
di Guzman, fondatore dell’Ordine dei Domenicani: l’uno e l’altro Ordine di fondamentale importanza nella storia<br />
della Chiesa a partire dal secolo XIII. La figura del primo viene presentata, nel discorso di san Tommaso,<br />
attraverso una distesa descrizione realistica dei suoi luoghi di origine e una precisa ricostruzione della sua vicenda<br />
biografica: giovanetto e figlio di un mercante, rifiutò l’agiatezza della famiglia e pubblicamente, davanti al<br />
vescovo della sua città, si spogliò di tutti i beni e dei vestiti per fare voto di povertà e in questo modo subito<br />
attrasse a sé altri giovani. Era nato così l’Ordine dei frati francescani, riconosciuto poi dall’autorità papale.<br />
1. Comprensione del testo<br />
Individua nei versi riportati le tre parti della ricostruzione dell’evento: l’ambiente geografico, la scena iniziale<br />
della dedizione di Francesco alla vita religiosa, l’effetto di trascinamento sugli altri. Fai una parafrasi distinta<br />
delle tre parti, in non più di 20 righe complessive.<br />
2. Analisi del testo<br />
2.1. Anche senza dare una precisa spiegazione della descrizione topografica dei versi 43-51, rileva nell’insieme<br />
e commenta, per il suo effetto di plasticità e di realismo paesaggistico, la frequenza dei nomi di luogo e dei<br />
termini geografici e climatici.<br />
2.2. Per Perugia si nomina, al v. 47, la Porta Sole, così detta perché rivolta a Levante, da dove entrava in città sia<br />
il freddo (proveniente dalle vicine montagne nevose d’inverno), sia il caldo (al sorgere del sole). Il sole<br />
richiama il vero Oriente geografico (specificato mediante il nome del grande fiume indiano, il Gange) e<br />
diventa anche simbolo per indicare la figura del santo, che «nacque al mondo» proprio come un sole.<br />
Commenta questo passaggio da una scena di ambiente naturale all’immissione di elementi simbolici.<br />
2.3. Interpreta letteralmente l’espressione dei versi 49-50 «questa costa, là dov’ella frange / più sua rattezza»,<br />
con la quale si indica la posizione topografica di Assisi.<br />
2.4. Dante usa la forma locale antica del nome di Assisi, cioè «Ascesi». In questo modo, può ricavare dal nome<br />
un significato allegorico, derivato da un verbo e da un sostantivo che si adattano chiaramente ai valori della<br />
vita del santo: quale verbo e quale sostantivo?<br />
2.5. Nei versi da 58 fino alla fine la scelta della povertà come ideale di vita viene illustrata ripetutamente con<br />
una terminologia particolare: individuala e commentala.<br />
2.6. L’ardore ascetico genera anche foga e concitazione di movimenti. In quali versi e con quali termini Dante<br />
descrive questo effetto, generato nei seguaci dall’esempio di Francesco? Bada anche al ritmo di alcuni versi<br />
e alla presenza di esclamazioni.<br />
3. Interpretazione complessiva e approfondimenti<br />
15
Nella ricostruzione della vicenda di san Francesco, Dante ha condensato un ampio capitolo di storia religiosa del<br />
nostro Medioevo. Né va dimenticato che il poeta ha messo questa ricostruzione in parallelo a quella dell’opera di<br />
san Domenico, altro campione di quella storia, e che tutto l’episodio è affidato alle parole di san Tommaso,<br />
massimo teologo dell’epoca. Attraverso queste veloci scene ideate dalla sua fantasia, Dante evoca importanti<br />
questioni di assetto che andava assumendo al suo tempo la struttura della Chiesa, bisognosa di organismi<br />
controllati da regole. Richiamandoti anche, se lo ritieni, ad illustrazioni figurative del santo, che ricordi, esprimi le<br />
tue considerazioni sull’importanza degli ordini religiosi, francescano e domenicano, nella storia della Chiesa e<br />
nella diffusione del messaggio evangelico nel mondo.<br />
TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE”<br />
(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti)<br />
CONSEGNE<br />
Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o<br />
in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti.<br />
Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue<br />
conoscenze ed esperienze di studio.<br />
Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi.<br />
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi<br />
che l’articolo debba essere pubblicato.<br />
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo.<br />
1.. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO<br />
ARGOMENTO: La percezione dello straniero nella letteratura e nell’arte.<br />
DOCUMENTI<br />
“Non lederai il diritto dello straniero o dell’orfano e non prenderai in pegno la veste dalla vedova; ma ti ricorderai che sei<br />
stato schiavo in Egitto e che di là ti ha redento l’Eterno, il tuo Dio; perciò ti comandò di fare questo. Quando fai la<br />
mietitura nel tuo campo e dimentichi nel campo un covone, non tornerai indietro a prenderlo; sarà per lo straniero, per<br />
l’orfano e per la vedova, affinché l’Eterno, il tuo Dio, ti benedica in tutta l’opera delle tue mani. Quando bacchierai i tuoi<br />
ulivi, non tornerai a ripassare sui rami; le olive rimaste saranno per lo straniero, per l’orfano e per la vedova. Quando<br />
vendemmierai la tua vigna, non ripasserai una seconda volta; i grappoli rimasti saranno per lo straniero, per l’orfano e per<br />
la vedova. E ti ricorderai che sei stato schiavo nel paese d’Egitto; perciò ti comando di fare questo.”<br />
DEUTERONOMIO, 24, 17-22<br />
“Così Odisseo stava per venire in mezzo a fanciulle dalle belle chiome, pur nudo com’era: la dura necessità lo spingeva.<br />
Terribile apparve loro, era tutto imbrattato di salsedine. E fuggirono via, chi qua chi là, sulle spiagge dove più sporgevano<br />
dentro il mare. Sola restava la figlia di Alcinoo: Atena le mise in cuore ardimento e tolse dalle membra la paura. Rimase<br />
ferma di fronte a lui, si tratteneva. Ed egli fu incerto, Odisseo, se supplicare la bella fanciulla e abbracciarle le ginocchia,<br />
oppure così di lontano pregarla, con dolci parole, che gl’indicasse la città e gli desse vesti. Questa gli parve, a pensarci, la<br />
cosa migliore, pregarla con dolci parole di lontano. Temeva che a toccarle i ginocchi si sdegnasse, la fanciulla. Subito le<br />
rivolse la parola:…E a lui rispondeva Nausicaa dalle bianche braccia: «Straniero, non sembri uomo stolto o malvagio, ma<br />
Zeus Olimpio, che divide la fortuna tra gli uomini, buoni e cattivi, a ciascuno come lui vuole, a te diede questa sorte, e tu<br />
la devi ad ogni modo sopportare.»…Così disse, e diede ordini alle ancelle dalle belle chiome: «Fermatevi, ancelle, per<br />
favore. Dove fuggite al veder un uomo? Pensate forse che sia un nemico? Non c’è tra i mortali viventi, né mai ci sarà, un<br />
uomo che venga alla terra dei Feaci a portar la guerra: perché noi siamo molto cari agli dei. Abitiamo in disparte, tra le<br />
onde del mare, al confine del mondo: e nessun altro dei mortali viene a contatto con noi. Ma questi è un infelice, giunge<br />
qui ramingo. Bisogna prendersi cura di lui, ora: ché vengono tutti da Zeus, forestieri e mendichi, e un dono anche piccolo<br />
è caro. Su, ancelle, date all’ospite da mangiare e da bere, e lavatelo prima nel fiume, dove c’è un riparo dal vento.»<br />
OMERO, Odissea, VI, vv. 135-148 e vv. 186-209<br />
“Afflitto della nuova, e arrabbiato della maniera, Renzo afferrò ancora il martello, e, così appoggiato alla porta, andava<br />
stringendolo e storcendolo, l’alzava per picchiar di nuovo alla disperata, poi lo teneva sospeso. In quest’agitazione, si<br />
voltò per vedere se mai ci fosse d’intorno qualche vicino, da cui potesse forse aver qualche informazione più precisa,<br />
qualche indizio, qualche lume. Ma la prima, l’unica persona che vide, fu un’altra donna, distante forse un venti passi; la<br />
quale, con un viso ch’esprimeva terrore, odio, impazienza e malizia, con cert’occhi stravolti che volevano insieme<br />
guardar lui, e guardar lontano, spalancando la bocca come in atto di gridare a più non posso, ma rattenendo anche il<br />
16
espiro, alzando due braccia scarne, allungando e ritirando due mani grinzose e piegate a guisa d’artigli, come se cercasse<br />
d’acchiappar qualcosa, si vedeva che voleva chiamar gente, in modo che qualcheduno non se n’accorgesse. Quando<br />
s’incontrarono a guardarsi, colei, fattasi ancor più brutta, si riscosse come persona sorpresa…lasciò scappare il grido che<br />
aveva rattenuto fin allora: «l’untore, dagli! dagli! dagli all’untore!» Allo strillar della vecchia, accorreva gente di qua e di<br />
là;…abbastanza per poter fare d’un uomo solo quel che volessero.”<br />
A. MANZONI, I Promessi Sposi, XXXIV, 1842<br />
B.<br />
Lo straniero<br />
“A chi vuoi più bene, enigmatico uomo, di?A tuo<br />
padre, a tua madre, a tua sorella o a tuo fratello?”<br />
“Non ho né padre, né madre, né sorella, né<br />
fratello.”<br />
“Ai tuoi amici?”<br />
“Adoperate una parola di cui fino a oggi ho<br />
ignorato il senso.”<br />
“Alla tua patria?”<br />
“Non so sotto quale latitudine si trovi.”<br />
“Alla bellezza?”<br />
“L’amerei volentieri, ma dea e immortale.”<br />
“All’oro?”<br />
“Lo odio come voi odiate Dio.”<br />
“Ma allora che cosa ami, straordinario uomo?”<br />
“Amo le nuvole…le nuvole che vanno…laggiù,<br />
laggiù…le meravigliose nuvole!”<br />
C. BAUDELAIRE, Poemetti in prosa, 1869<br />
“L’infermo teneva gli occhi chiusi: pareva un Cristo di cera, deposto dalla croce. Dormiva o era morto? Si fecero un po’<br />
più avanti; ma al lieve rumore, l’infermo schiuse gli occhi, quei grandi occhi celesti, attoniti. Le due donne si strinsero<br />
vieppiù tra loro; poi, vedendogli sollevare una mano e far cenno di parlare, scapparono via con un grido, a richiudersi in<br />
cucina. Sul tardi, sentendo il campanello della porta, corsero ad aprire; ma, invece di don Pietro, si videro davanti quel<br />
giovane straniero della mattina. La zitellona corse ranca ranca a rintanarsi di nuovo; ma Venerina, coraggiosamente, lo<br />
accompagnò nella camera dell’infermo già quasi al bujo, accese una candela e la porse allo straniero, che la ringraziò<br />
chinando il capo con un mesto sorriso; poi stette a guardare, afflitta: vide che egli si chinava su quel letto e posava lieve<br />
una mano su la fronte dell’infermo, sentì che lo chiamava con dolcezza: - Cleen…Cleen…Ma era il nome, quello, o una<br />
parola affettuosa? L’infermo guardava negli occhi il compagno, come se non lo riconoscesse; e allora ella vide il corpo<br />
gigantesco di quel giovane marinajo sussultare, lo sentì piangere, curvo sul letto, e parlare angosciosamente, tra il pianto,<br />
in una lingua ignota. Vennero anche a lei le lagrime agli occhi. Poi lo straniero, voltandosi, le fece segno che voleva<br />
scrivere qualcosa. Ella chinò il capo per significargli che aveva compreso e corse a prendergli l’occorrente. Quando egli<br />
ebbe finito, le consegnò la lettera e una borsetta. Venerina non comprese le parole ch’egli le disse, ma comprese bene dai<br />
gesti e dall’espressione del volto, che le raccomandava il povero compagno. Lo vide poi chinarsi di nuovo sul letto a<br />
baciare più volte in fronte l’infermo, poi andar via in fretta con un fazzoletto su la bocca per soffocare i singhiozzi<br />
irrompenti.”<br />
L. PIRANDELLO, Lontano, in “Novelle per un anno”, 1908<br />
“Un giorno di gennaio dell’anno 1941, un soldato tedesco di passaggio, godendo di un pomeriggio di libertà, si trovava,<br />
solo, a girovagare nel quartiere di San Lorenzo, a Roma. Erano circa le due del dopopranzo, e a quell’ora, come d’uso,<br />
poca gente circolava per le strade….S’era scordato dell’uniforme; per un buffo interregno sopravvenuto nel mondo,<br />
l’estremo arbitrio dei bambini adesso usurpava la legge militare del Reich! Questa legge è una commedia, e Gunther se ne<br />
infischia. In quel momento, qualsiasi creatura femminile capitata per prima su quel portone…che lo avesse guardato con<br />
occhio appena umano, lui sarebbe stato capace di abbracciarla di prepotenza, magari buttato ai piedi come un innamorato,<br />
chiamandola: meine mutter! E allorché di lì a un istante vide arrivare dall’angolo un’inquilina del caseggiato, donnetta<br />
d’apparenza dimessa ma civile, che in quel punto rincasava, carica di borse e di sporte, non esitò a gridarle: «Signorina!<br />
Signorina!» (era una delle 4 parole italiane che conosceva). E con un salto le si parò davanti risoluto, benché non sapesse,<br />
nemmeno lui, cosa pretendere. Colei però, al vedersi affrontata da lui, lo fissò con occhio assolutamente disumano, come<br />
davanti all’apparizione propria e riconoscibile dell’orrore.”<br />
E. MORANTE, La Storia, Einaudi, 1974<br />
“Risate e grida si levarono. «Fuori! Fuori della fontana! Fuori!» Erano anche voci di uomini. La gente, poco prima<br />
intorpidita e molle, si era tutta eccitata. Gioia di umiliare quella ragazza spavalda che dalla faccia e dall’accento si capiva<br />
ch’era forestiera. «Vigliacchi!» gridò Anna, voltandosi d’un balzo. E con un fazzolettino cercava di togliersi di dosso la<br />
fanghiglia. Ma lo scherzo era piaciuto. Un altro schizzo la raggiunse a una spalla, un terzo al collo, all’orlo dell’abito. Era<br />
diventata una gara.…Qui Antonio intervenne, facendosi largo…Antonio era forestiero e tutti, là, parlavano in dialetto. Le<br />
17
sue parole ebbero un suono curioso, quasi ridicolo….Niente ormai tratteneva il buttare fuori il fondo dell’animo: il sozzo<br />
carico di male che si tiene dentro per anni e nessuno si accorge di avere.”<br />
D. BUZZATI, Non aspettavamo altro, in “Sessanta racconti”, Mondadori, 1958<br />
“Era bagnato fradicio e coperto di fango e aveva fame e freddo ed era lontano cinquantamila anni-luce da casa… Il primo<br />
contatto era avvenuto vicino al centro della Galassia, dopo la lenta e difficile colonizzazione di qualche migliaio di<br />
pianeti; ed era stata la guerra, subito;…Stava all’erta, il fucile pronto. Lontano cinquantamila anni-luce dalla patria, a<br />
combattere su un mondo straniero e a chiedersi se ce l’avrebbe mai fatta a riportare a casa la pelle. E allora vide uno di<br />
loro strisciare verso di lui. Prese la mira e fece fuoco. Il nemico emise quel verso strano, agghiacciante, che tutti loro<br />
facevano, poi non si mosse più. Il verso e la vista del cadavere lo fecero rabbrividire. Molti, col passare del tempo,<br />
s’erano abituati, non ci facevano più caso; ma lui no. Erano creature troppo schifose, con solo due braccia e due gambe,<br />
quella pelle d’un bianco nauseante, e senza squame.”<br />
F. BROWN, Sentinella, in “Tutti i racconti”, Mondadori, 1992<br />
Tempo verrà<br />
in cui, con esultanza,<br />
saluterai te stesso arrivato<br />
alla tua porta, nel tuo proprio<br />
specchio,<br />
e ognun sorriderà al benvenuto<br />
dell’altro,<br />
Galata morente (I secolo a.C.)<br />
2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO<br />
e dirà: Siedi qui. Mangia.<br />
Amerai di nuovo lo straniero che era il tuo Io.<br />
Offri vino. Offri pane. Rendi il cuore<br />
a se stesso, allo straniero che ti ha amato<br />
per tutta la vita, che hai ignorato…<br />
D. WALCOTT, Amore dopo amore, in “Mappa del nuovo Mondo”, trad.<br />
it., Adelphi, Milano, 1992<br />
È una scultura romana del I secolo a.C., che<br />
raffigura un soldato galata morente. Il guerriero,<br />
straniero ai Romani, è colto in punto di morte<br />
mentre il corpo si accascia sullo scudo, con il<br />
quale i Celti si opponevano al nemico celando il<br />
corpo nudo. Dallo scudo si staglia il combattente<br />
con il torso flesso e ruotato verso destra a far<br />
risaltare l’incisione della ferita.<br />
ARGOMENTO: Città e periferie: paradigmi della vita associata, fattori di promozione della identità personale e<br />
collettiva.<br />
DOCUMENTI<br />
«Quale uso fare della città? Quale uso se ne è fatto nella Storia? Quante utopie hanno attraversato il concetto sfumato ai<br />
bordi di “città ideale”? E quanti abusi? Se rivolgiamo i nostri pensieri alle città europee così come ci sono state<br />
consegnate dalla Storia, ecco che i confronti con l’attualità diventano subito un atto dovuto e altrettanto ineludibili i<br />
riferimenti ai disagi metropolitani di cui siamo testimoni oltre che recalcitranti vittime designate…I due problemi con i<br />
quali ci siamo trovati a fare i conti nelle città europee negli ultimi decenni sono il traffico automobilistico e il degrado o la<br />
manomissione dei Centri Storici»<br />
L. MALERBA, Città e dintorni, Milano 2001<br />
«La città tradizionale dell’Europa mediterranea, che viene generalmente presa come modello…, è un organismo a tre<br />
elementi attorno ai quali si ripartiscono le sue attività e si definisce il suo ruolo. Il primo è l’elemento sacro, che<br />
simbolizza la protezione degli dei e impone dei doveri collettivi, generatori di disciplina. Il secondo è l’elemento militare,<br />
o della sovranità, rappresentativo del potere e del possesso dello spazio dominato dalla città…Il terzo è il mercato con i<br />
suoi annessi artigianali, luoghi dove si realizza l’economia specificamente cittadina…Nella misura in cui il mercato<br />
18
appresenta il luogo della riunione funzionale della popolazione attiva della città, esso può divenire simbolo di<br />
democrazia..., ma può anche essere simbolo dell’affermazione dell’autorità del sovrano…Dovunque si presenti, la città<br />
ripropone sempre i tre elementi mediterranei unendo il sacro, il politico e l’economico…All’inizio del XX secolo le città<br />
europee sono, di fatto, delle città socialmente settorializzate, esclusivamente su basi qualitative: quartieri di lusso e<br />
quartieri operai, o quartieri poveri…Nella nostra epoca la prima spinta di crescita urbana che spezza i ritmi lenti e unitari<br />
del passato è quella del periodo che intercorre tra le due guerre mondiali…<br />
A questo punto il quadro urbano risulta superato e le città tendono a scoppiare…L’unità spaziale tra lavoro, tempo libero<br />
e vita privata, e abitazione, che era caratteristica della città del passato, è ormai rotta…»<br />
Dalla voce Città, curata da P. GEORGE, nella “Enciclopedia delle scienze sociali”,<br />
Istituto dell’Enciclopedia Italiana, vol.I, Roma, 1991<br />
«Il sopravvento della periferia ha sdoppiato l’identità urbana tra un centro strutturato, sedimentato e riconoscibile e<br />
un “resto” per molti aspetti casuale (Vittorini). L’anomalia periferica si presenta in termini relativi come “altro dalla<br />
città”, e in termini assoluti, come incompiutezza, disordine, irriconoscibilità, bruttezza: “un nuovo oggetto storico” senza<br />
limiti, né soglie; un “dappertutto che è nessun luogo” (Rella)»<br />
F. PEREGO, “Europolis e la variabile della qualità urbana” in AA.VV. Europolis –<br />
La riqualificazione delle città in Europa. Periferie oggi, Roma-Bari, 1990<br />
«Le periferie non sono dei “non luoghi”. Con l’espressione “non luogo” caratterizzo un certo tipo di spazio dentro la<br />
nostra società contemporanea. Il “luogo” per un antropologo è uno spazio nel quale tutto fa segno. O, più esattamente, è<br />
un luogo nel quale si può leggere attraverso l’organizzazione dello spazio tutta la struttura sociale…Oggi viviamo in un<br />
mondo nel quale lo spazio dei “non luoghi” si è di molto accresciuto. “Non luoghi” sono gli spazi della circolazione, del<br />
consumo, della comunicazione, eccetera. Sono spazi di solitudine…Prendiamo l’esempio di un supermercato. Ha tutti gli<br />
aspetti di un “non luogo”. Ma un supermercato può diventare anche un luogo di appuntamento per i giovani. Talvolta,<br />
anzi, è il solo “luogo”. Da questo punto di vista si può dire che le banlieues sono dei “non luoghi” per la gente che viene<br />
da fuori…Ma sono, viceversa , dei “luoghi” di vita per molte persone»<br />
M. AUGÉ, L’incendio di Parigi, “MicroMega” n. 7/2005<br />
«Se le nostre città non si riqualificano, a cominciare dalle periferie, consegneremo alle nuove generazioni un futuro di<br />
barbarie…La più grave malattia delle città si chiama esplosione urbana - dice Piano - una crescita forsennata, che<br />
dobbiamo correggere con interventi mirati per integrare il tessuto urbanistico e sociale delle periferie con il resto della<br />
città». Quindi, demolire o riqualificare i mostri in cemento nelle periferie? «La demolizione è un rimedio estremo, al<br />
quale ricorrere soltanto quando mancano i requisiti minimi della vivibilità, per esempio la luce e la tutela della salute». La<br />
seconda proposta riguarda le funzioni dei quartieri periferici. «La loro vita non può ridursi solo alla dimensione<br />
residenziale, così sono condannati a trasformarsi in giganteschi dormitori - afferma Piano - non a caso, quando ho<br />
progettato l’auditorium a Roma, ho voluto definirlo la fabbrica della musica. Attorno alle sale, in un’area di venti ettari,<br />
ho ipotizzato un parco pubblico, negozi, residenze e perfino un albergo». Il terzo punto decisivo del «manifesto» di Renzo<br />
Piano riguarda proprio gli architetti e il loro modo di lavorare. «Ogni angolo di territorio urbano che torna a vivere è<br />
anche un’opportunità economica. Per tutti - ... - a cominciare dagli architetti. Noi abbiamo bisogno di competenza e di<br />
umiltà. Pensare in grande, ma accontentarsi anche di piccoli progetti. E avere sempre una bussola etica perché attraverso<br />
la microchirurgia sul territorio può passare anche un nuovo umanesimo della vita urbana. Nelle periferie, l’immigrazione<br />
diventa più sostenibile se si impedisce che alla separazione sociale si sovrapponga quella etnica. Come accade, purtroppo,<br />
nei quartieri dormitorio»<br />
A. GALDO, Periferie: la profezia di Piano, IL MATTINO, 16/11/2005<br />
«La città è anzitutto lo sguardo che la osserva e l’animo che la vive; …La Città dell’antichità, anche quando è il centro di<br />
un potente impero, appare in una luce di gloria inseparabile dalla caducità, dall’eterno destino di vanità delle cose umane:<br />
Ninive, Persepoli o Babilonia evocano grandezza e rovina, indissolubili come le due facce di una moneta; …Atene, culla<br />
della civiltà e della politica mondiale, è la Polis, la città in cui i rapporti umani sono personali e concreti e tutto è visibile e<br />
tangibile, pure il meccanismo della vita sociale e del potere. Solo Roma - la Roma imperiale e promiscua del Satyricon - è<br />
una metropoli nel senso moderno, più simile a Londra o a New York che alle città greche, egizie od orientali<br />
dell’antichità. Nella modernità, la città si identifica con la borghesia - più tardi col proletariato industriale…la città, con le<br />
sue trasformazioni che sventrano e smontano il passato, è il movimento stesso delle sorti e dei sentimenti umani, il ritmo<br />
della vita e della storia che la racconta. La metropoli...cambia la sensibilità e la percezione dell’individuo, diviene una sua<br />
pelle sensibilissima che reagisce, anche e soprattutto subliminalmente, al continuo bombardamento di stimoli veloci ed<br />
effimeri»<br />
19
C. MAGRIS, Amori, speranze, morte, le città della nostra vita, CORRIERE DELLA SERA, 9/9/2005<br />
«La periferia, lo si voglia o no, è la città moderna, è la città che abbiamo costruito…Se non sapremo di questa città<br />
cogliere non solo gli aspetti negativi, che sono tanti e indiscutibili, ma anche gli aspetti positivi, difficilmente riusciremo a<br />
rovesciare un processo che minaccia di travolgere il senso profondo della città, quella funzione di cui così chiaramente<br />
parla Aristotele quando dice che gli uomini hanno fondato la città per vivere meglio insieme… Secondo me la periferia è<br />
soprattutto una città non finita o meglio che non ha ancora raggiunto il momento della qualità, ma i famosi centri<br />
storici...sono stati anch’essi, prima di raggiungere questa condizione di equilibrio che ne sancisce l’intoccabilità, delle<br />
opere non compiute...Perché allora non guardare alla periferia non soltanto con il giusto sdegno che meritano i suoi<br />
particolari slegati, le sue caratteristiche di incompiutezza e di mancanza di significato, ma anche con umanistica “pietas” e<br />
cioè con amore, come una realtà da affrontare, di cui aver cura, in cui rispecchiare noi stessi in quanto essa è bene o male<br />
il prodotto delle nostre illusioni, delle nostre buone intenzioni non realizzate?»<br />
P. PORTOGHESI, Riprogettare la città, in AA.VV. Europolis –<br />
La riqualificazione delle città in Europa. Periferie oggi, Roma-Bari, 1990<br />
«È delle città come dei sogni: tutto l’immaginabile può essere sognato ma anche il sogno più inatteso è un rebus che<br />
nasconde un desiderio, oppure il suo rovescio, una paura. Le città come i sogni sono costruite di desideri e di paure, anche<br />
se il filo del loro discorso è segreto, le loro regole assurde, le prospettive ingannevoli, e ogni cosa ne nasconde<br />
un’altra...Anche le città credono d’essere opera della mente o del caso, ma né l’una né l’altro bastano a tener su le loro<br />
mura. D’una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma la risposta che dà a una tua domanda. – O la domanda<br />
che ti pone obbligandoti a rispondere, come Tebe per bocca della Sfinge»<br />
I. CALVINO, Le città invisibili, 1972, III<br />
I.<br />
3. AMBITO STORICO-POLITICO<br />
Argomento: Il terrore e la repressione politica nei sistemi totalitari del Novecento<br />
DOCUMENTI<br />
Scheda:<br />
Il fascismo italiano fece centinaia di prigionieri politici e di confinati in domicilio coatto, migliaia di esiliati e<br />
fuoriusciti politici.<br />
• Il nazismo tedesco dal 1933 al 1939 ha eliminato circa 20.000 oppositori nei campi di concentramento e nelle<br />
prigioni; tra il 1939 e il 1941 ha sterminato nelle camere a gas 70.000 tedeschi vittime di un programma di<br />
eutanasia. Durante la guerra si calcola che siano stati uccisi circa 15 milioni di civili nei paesi occupati, circa 6<br />
milioni di ebrei; 3.300.000 prigionieri di guerra sovietici, più di un milione di deportati e decine di migliaia di<br />
zingari sono morti nei campi di concentramento; più di 8 milioni sono stati inviati ai lavori forzati.<br />
• Nella Russia comunista la prima epurazione la pagarono gli iscritti al partito; tra il 1936?38 furono eliminati<br />
30.000 funzionari su 178.000; nell'Armata rossa in due anni furono giustiziati 271 tra generali, alti ufficiali e<br />
commissari dell'esercito. Nei regimi comunisti del mondo (URSS, Europa dell'Est, Cina, Corea del Nord,<br />
Vietnam, Cambogia, Cuba, ecc.) si calcola che sono stati eliminati circa 100 milioni di persone contrarie al<br />
regime.<br />
• Né bisogna dimenticare le "foibe" istriane e, più di recente, i crimini nei territori della ex Jugoslavia, in Algeria,<br />
in Iraq, ecc. Amnesty International ha segnalato 111 Paesi dove sono state applicate torture su persone per reati<br />
d'opinione.<br />
"Con il terrore si assiste a una doppia mutazione: l'avversario, prima nemico e poi criminale, viene trasformato in<br />
'escluso'. Questa esclusione sfocia quasi automaticamente nell'idea di sterminio. Infatti la dialettica amico/nemico è ormai<br />
insufficiente a risolvere il problema fondamentale del totalitarismo: si tratta di costruire un'umanità riunificata e<br />
purificata, non antagonista [...]. Da una logica di lotta politica si scivola presto verso una logica di esclusione, quindi<br />
verso un'ideologia dell'eliminazione e, infine, dello sterminio di tutti gli elementi impuri".<br />
S. COURTOIS, "Perché?", in Il libro nero del comunismo, Milano, Mondadori, 2000<br />
"Per genocidio si intende uno qualunque dei seguenti atti, commessi con l'intenzione di distruggere completamente o in<br />
parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale: a) assassinio di membri del gruppo; b) grave<br />
attentato all'incolumità fisica o mentale di membri del gruppo; c) imposizione intenzionale al gruppo di condizioni di vita<br />
destinate a provocarne la distruzione fisica totale o parziale; d) misure volte a ostacolare le nascite all'interno del gruppo;<br />
20
e) trasferimenti coatti dei figli di un gruppo a un altro".<br />
Convenzione delle Nazioni Unite del 9/12/1948<br />
"Dolore per la nostra patria [il Cile] soggiogata e convertita in un immenso carcere; per il nostro popolo martoriato dalla<br />
fame e dalla miseria; per i nostri compagni ed amici caduti nel combattimento, o assassinati, torturati o incarcerati dal<br />
fascismo. Speranza che questo incubo di orrore avrà una fine non lontana, e la certezza che i colpevoli riceveranno il<br />
castigo esemplare".<br />
C. ALTAMIRANO, "Saluto di capodanno: I gennaio 1975", in Tutte le forme di lotta, Milano, 1975, (L'autore era<br />
segretario generale del Partito socialista cileno)<br />
"I regimi totalitari del XX secolo hanno rivelato l'esistenza di un pericolo prima insospettato: quello di una<br />
manomissione completa della memoria".<br />
T. TODOROV, Memoria del male, tentazione del bene. Inchiesta su un secolo tragico, Milano, Garzanti, 2001<br />
4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO<br />
ARGOMENTO: Quale idea di scienza nello sviluppo tecnologico della società umana.<br />
DOCUMENTI<br />
“Quando la nostra vita umana giaceva per terra/turpemente schiacciata da una pesante religione/che mostrava dal cielo<br />
l’orribile faccia/sopra i mortali, per la prima volta un uomo mortale,/un Greco, osò contro di quella alzare lo sguardo/e per<br />
primo resisterle contro; né la fama dei Numi/né il fulmine lo distrusse né la minaccia del cielo/strepitoso lo spaventò; ché<br />
anzi il desiderio/gli crebbe più forte e più acre lo strinse,/di rompere egli per primo/le porte serrate della natura. E vinse/la<br />
forza dell’animo; e andò lontano, solo,/di là dalle fiammanti barriere dell’universo/e tutto l’immenso attraversò con la<br />
mente/illesa, e a noi vittorioso ritorna e ci svela/il segreto dei corpi che nascono e come alle cose/è fisso un termine e<br />
limitato il potere./Così la religione fu calpestata/sotto i piedi mortali/e quella vittoria ci solleva alle stelle./”<br />
LUCREZIO, De Rerum Natura, I, vv. 62-79, trad. E. Cetrangolo, Sansoni, Firenze, 1969<br />
“Nel corso della storia è sempre accaduto che l’uomo si sia trovato in una situazione di incertezza di fronte a due modi<br />
profondamente diversi di interpretare la realtà. Fu senza dubbio questo il caso che si verificò alla fine del Seicento,<br />
quando gli scienziati e i filosofi razionalisti – Isaac Newton, John Locke, René Descartes e altri – misero in discussione<br />
alcuni dogmi della Chiesa, fra i quali anche una dottrina fondamentale: quella che considerava la terra come una<br />
creazione di Dio e, quindi, dotata di valore intrinseco. I nuovi pensatori propendevano per una visione più materialistica<br />
dell’esistenza, fondata sulla matematica e sulla «ragione». Meno di un secolo dopo, gli insorti delle colonie americane e i<br />
rivoluzionari francesi scalzarono il potere monarchico, che sostituirono con la forma di governo repubblicana,<br />
proclamando «il diritto inalienabile» dell’uomo «alla vita, alla libertà, alla felicità e alla proprietà». Alla vigilia della<br />
Rivoluzione americana, James Watt brevettò la macchina a vapore, istituendo un nesso fra il carbone e lo spirito<br />
prometeico della nuova era; l’umanità mosse così i suoi primi, malfermi passi verso lo stile di vita industriale che, nei due<br />
secoli successivi, avrebbe radicalmente cambiato il mondo.”<br />
J. RIFKIN, Economia all’idrogeno, Mondadori, 2002<br />
“Nel suo New Guide to Science, Isaac Asimov disse che la ragione per cercare di spiegare la storia della scienza ai non<br />
scienziati è che nessuno può sentirsi veramente a proprio agio nel mondo moderno e valutare la natura dei suoi problemi -<br />
e le possibili soluzioni degli stessi - se non ha un’idea esatta di cosa faccia la scienza. Inoltre, l’iniziazione al<br />
meraviglioso mondo della scienza è fonte di grande soddisfazione estetica, di ispirazione per i giovani, di appagamento<br />
del desiderio di sapere e di un più profondo apprezzamento delle mirabili potenzialità e capacità della mente umana.…La<br />
scienza è una delle massime conquiste (la massima, si può sostenere) della mente umana, e il fatto che il progresso sia<br />
stato in effetti compiuto, in grandissima parte, da persone di intelligenza normale procedendo passo dopo passo a<br />
cominciare dall’opera dei predecessori rende la vicenda ancor più straordinaria, e non meno.”<br />
J. GRIBBIN, L’avventura della scienza moderna, Longanesi, 2002<br />
“Francesco Bacone concepì l’intera scienza come operante in vista del benessere dell’uomo e diretta a produrre, in ultima<br />
analisi, ritrovati che rendessero più facile la vita dell’uomo sulla terra. Quando nella Nuova Atlantide volle dare<br />
l’immagine di una città ideale, non si fermò a vagheggiare forme perfette di vita sociale o politica ma immaginò un<br />
paradiso della tecnica dove fossero portati a compimento le invenzioni e i ritrovati di tutto il mondo.…La tecnica, sia<br />
nelle sue forme primitive sia in quelle raffinate e complesse che ha assunto nella società contemporanea, è uno strumento<br />
indispensabile per la sopravvivenza dell’uomo. Il suo processo di sviluppo appare irreversibile perché solo ad esso rimane<br />
21
affidata la possibilità della sopravvivenza del numero sempre crescente degli esseri umani e il loro accesso a un più alto<br />
tenore di vita.”<br />
N. ABBAGNANO, Dizionario di Filosofia, Torino, UTET, 1971<br />
“Vi sono due modi secondo cui la scienza influisce sulla vita dell’uomo. Il primo è familiare a tutti: direttamente e ancor<br />
più indirettamente la scienza produce strumenti che hanno completamente trasformato l’esistenza umana. Il secondo è per<br />
sua natura educativo, agendo sullo spirito. Per quanto possa apparire meno evidente a un esame frettoloso, questa seconda<br />
modalità non è meno efficiente della prima. L’effetto pratico più appariscente della scienza è il fatto che essa rende<br />
possibile l’invenzione di cose che arricchiscono la vita, anche se nel contempo la complicano.”<br />
A. EINSTEIN, Pensieri degli anni difficili, trad. ital. L. Bianchi, Torino, Boringhieri, 1965<br />
“Questa idea dell’incremento tecnico come onda portante del progresso è largamente diffusa; qualcuno l’ha chiamata<br />
«misticismo della macchina». Noi ci vediamo vivere nell’era del computer o nell’era nucleare, succedute all’era del<br />
vapore del XIX secolo. Si pensa a ogni periodo nei termini della tecnologia dominante, risalendo fino alla storia primitiva<br />
dell’uomo. Pensiamo allora allo sviluppo dagli utensili di pietra a quelli di bronzo, e poi al sopravvenire d’un’età del<br />
ferro, quasi una logica progressione tecnica che trascina nella propria corrente l’evoluzione sociale. Pensiamo a ciascuna<br />
età nei termini dell’impatto della tecnica sulle faccende umane, e raramente indaghiamo sul processo contrario.…Così<br />
nello sviluppo della tecnologia moderna, non occorre intendere solamente l’influenza degli strumenti e delle tecniche<br />
sulla società, bensì l’intero ventaglio delle «forze reciprocamente interagenti» che ha dato luogo agli spettacolari passi<br />
avanti del nostro tempo. Come si è espresso un altro studioso dell’evoluzione umana [Solly Zuckerman], «la tecnologia è<br />
sempre stata con noi. Non è qualcosa al di fuori della società, qualche forza esterna dalla quale veniamo sospinti…la<br />
società e la tecnologia sono…riflessi l’una dell’altra».”<br />
A. PACEY, Vivere con la tecnologia, Roma, 1986<br />
“Non intendo certo sbrogliare l’intricatissimo rapporto tra scienza e tecnologia, ma solo rilevare che oggi, soprattutto<br />
grazie all’impiego delle tecnologie informatiche e della simulazione, la nostra capacità di agire ha superato di molto la<br />
nostra capacità di prevedere.…La tecnologia è importante per ciò che ci consente di fare, non di capire.…A cominciare<br />
dalla metà del Novecento la tecnologia ha assunto una velocità tale da non permettere a volte alla scienza di giustificare e<br />
spiegare teoricamente, neppure a posteriori, il funzionamento dei ritrovati tecnologici. La scienza si è così ridotta a<br />
difendere posizioni via via più difficili, tanto più che le radici dell’accelerazione tecnologica non sono da ricercarsi<br />
all’interno dello sviluppo scientifico, bensì nell’ambito della tecnologia stessa. Infatti è stata l’informatica che, con il<br />
calcolatore, ha fornito all’innovazione uno strumento, o meglio un metastrumento, flessibile e leggero che ha impresso<br />
un’accelerazione fortissima alle pratiche della progettazione.”<br />
G. O. LONGO, Uomo e tecnologia: una simbiosi problematica, Ed. Univ. Trieste, 2006<br />
“Le aziende subiranno più cambiamenti nei prossimi dieci anni di quanti ne abbiano sperimentati negli ultimi cinquanta.<br />
Mentre stavo preparando il discorso che avrei dovuto tenere al nostro primo summit dei CEO (Chief Executive Officer),<br />
nella primavera del 1997, meditavo sulla natura specifica dei mutamenti che l’era digitale avrebbe imposto al mondo<br />
imprenditoriale. Volevo che il mio discorso non si fermasse agli strepitosi vantaggi offerti dalla tecnologia, ma<br />
affrontasse anche i problemi con i quali i dirigenti di un’azienda devono combattere tutti i giorni. In che modo la<br />
tecnologia può contribuire a migliorare la gestione di un’impresa? In che modo trasformerà le aziende? In che modo può<br />
aiutarci a mettere a punto una strategia vincente per i prossimi cinque o dieci anni?”<br />
B. GATES, Business @lla velocità del pensiero, Mondadori, 1999<br />
TIPOLOGIA C - TEMA DI ORDINE STORICO<br />
I due volti del Novecento.<br />
Da un lato esso è secolo di grandi conquiste civili, economiche, sociali, scientifiche, tecniche; dall'altro è secolo<br />
di grandi tragedie storiche.<br />
Rifletti su tale ambivalenza del ventesimo secolo, illustrandone i fatti più significativi.<br />
TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE<br />
«L’industrializzazione ha distrutto il villaggio, e l’uomo, che viveva in comunità, è diventato folla solitaria nelle<br />
megalopoli. La televisione ha ricostruito il «villaggio globale», ma non c’è il dialogo corale al quale tutti<br />
22
partecipavano nel borgo attorno al castello o alla pieve. Ed è cosa molto diversa guardare i fatti del mondo<br />
passivamente, o partecipare ai fatti della comunità.»<br />
G. TAMBURRANO, Il cittadino e il potere, in “In nome del Padre”, Bari, 1983<br />
Discuti l’affermazione citata, precisando se, a tuo avviso, in essa possa ravvisarsi un senso di “nostalgia” per il<br />
passato o l’esigenza, diffusa nella società contemporanea, di intessere un dialogo meno formale con la comunità<br />
circostante.<br />
___________________________<br />
Durata massima della prova: 6 ore.<br />
È consentito soltanto l’uso del dizionario italiano.<br />
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.<br />
23
Criteri di valutazione della prima prova scritta di: Italiano – Tipologia C – D<br />
Candidato_____________________________________________________ <strong>Classe</strong>: V<br />
INDICATORI PUNTEGGIO<br />
MASSIMO<br />
1. Padronanza della<br />
lingua, capacità<br />
linguisticoespressive<br />
2. Conoscenze<br />
relative<br />
all’argomento<br />
scelto e al quadro<br />
di riferimento<br />
generale.<br />
3. Capacità di<br />
organizzare un<br />
testo<br />
4. Capacità di<br />
elaborazione<br />
critica, originalità<br />
e/creatività<br />
4 punti<br />
5 punti<br />
3 punti<br />
3 punti<br />
LIVELLI DI<br />
VALUTAZIONE<br />
Scarso<br />
Mediocre<br />
Sufficiente<br />
Discreto<br />
Buono/Ottimo<br />
Scarso<br />
Mediocre<br />
Sufficiente<br />
Discreto<br />
Buono/Ottimo<br />
Scarso<br />
Mediocre<br />
Sufficiente<br />
Discreto<br />
Buono/Ottimo<br />
Scarso<br />
Mediocre<br />
Sufficiente<br />
Discreto<br />
Buono/Ottimo<br />
DESCRITTORI PUNTEGGIO<br />
CORRISPONDEN<br />
TE AI DIVERSI<br />
-Espressione scorretta, lessico improprio<br />
-Espressione generica, lessico povero<br />
-Espressione abbastanza chiara e corretta, lessico<br />
essenziale.<br />
-Espressione chiara e corretta, lessico appropriato<br />
-Espressione corretta ed efficace, lessico ricco<br />
-Conoscenza lacunosa e priva di contestualizzazione<br />
-Conoscenza superficiale/contestualizzazione parziale<br />
-Conoscenza e contestualizzazione essenziali<br />
-Conoscenza adeguata/contestualizzazione corretta<br />
-Conoscenza approfondita/contestualizzazione articolata<br />
-Argomentazione disorganica e incoerente<br />
-Argomentazione generica e parzialmente pertinente<br />
-Argomentazione semplice, ma organica e coerente<br />
-Argomentazione organica e abbastanza articolata<br />
-Argomentazione organica, coerente, articolata ed<br />
esauriente<br />
-Assenza di rielaborazione<br />
-Rielaborazione confusa<br />
-Rielaborazione semplice ed essenziale, ma non molto<br />
approfondita<br />
- Rielaborazione corretta nell’impianto concettuale,<br />
approfondita, ma non molto originale<br />
-Rielaborazione efficace e motivata<br />
LIVELLI<br />
1<br />
2<br />
3<br />
3,5<br />
4<br />
2<br />
2,5<br />
3<br />
4<br />
5<br />
1<br />
1,5<br />
2<br />
2,5<br />
3<br />
1<br />
1,5<br />
2<br />
2,5<br />
3<br />
VOTO<br />
ATTRIBUITO<br />
ALL’INDICA<br />
TORE<br />
Voto complessivo attribuito alla prova _____________/15<br />
Rimini, _______________________________________________<br />
Criteri di valutazione della prima prova scritta di: Italiano – Articolo di giornale<br />
Candidato_____________________________________________________ <strong>Classe</strong>: V<br />
INDICATORI PUNTEGGIO<br />
MASSIMO<br />
LIVELLI DI<br />
VALUTAZIONE<br />
DESCRITTORI PUNTEGGIO<br />
CORRISPONDEN<br />
VOTO<br />
ATTRIBUITO
1. Padronanza della<br />
lingua, capacità<br />
linguisticoespressive<br />
2. Conoscenze<br />
relative<br />
all’argomento<br />
scelto e al quadro<br />
di riferimento<br />
generale.<br />
3. Capacità di<br />
organizzare un<br />
testo<br />
4. Capacità di<br />
elaborazione<br />
critica, originalità<br />
e/creatività<br />
4 punti<br />
2 punti<br />
3 punti<br />
6 punti<br />
Scarso<br />
Mediocre<br />
Sufficiente<br />
Discreto<br />
Buono/Ottimo<br />
Scarso<br />
Mediocre<br />
Sufficiente<br />
Discreto<br />
Buono/Ottimo<br />
Scarso<br />
Mediocre<br />
Sufficiente<br />
Discreto<br />
Buono/Ottimo<br />
Scarso<br />
Mediocre<br />
Sufficiente<br />
Discreto<br />
Buono/Ottimo<br />
-Espressione scorretta, lessico improprio<br />
-Espressione generica, lessico povero<br />
-Espressione abbastanza chiara e corretta, lessico<br />
essenziale.<br />
-Espressione chiara e corretta, lessico appropriato<br />
-Espressione corretta ed efficace, lessico rcco<br />
-Conoscenza lacunosa e priva di contestualizzazione<br />
-Conoscenza superficiale/contestualizzazione parziale<br />
-Conoscenza e contestualizzazione essenziali<br />
-Conoscenza adeguata/contestualizzazione corretta<br />
-Conoscenza approfondita/contestualizzazione articolata<br />
-Argomentazione disorganica e incoerente<br />
-Argomentazione generica e parzialmente pertinente<br />
-Argomentazione semplice, ma organica e coerente<br />
-Argomentazione organica e abbastanza articolata<br />
-Argomentazione organica, coerente, articolata ed<br />
esauriente<br />
-Assenza di rielaborazione<br />
-Rielaborazione confusa<br />
-Rielaborazione semplice ed essenziale, ma non molto<br />
approfondita<br />
- Rielaborazione corretta nell’impianto concettuale,<br />
approfondita, ma non molto originale<br />
-Rielaborazione efficace e motivata<br />
TE AI DIVERSI<br />
LIVELLI<br />
1<br />
1,5<br />
Voto complessivo attribuito alla prova _____________/15<br />
Rimini, _______________________________________________<br />
Criteri di valutazione della prima prova scritta di: Italiano – Saggio breve<br />
Candidato_____________________________________________________ <strong>Classe</strong>: V<br />
INDICATORI PUNTEGGIO<br />
MASSIMO<br />
1. Padronanza della<br />
lingua, capacità<br />
linguistico-<br />
LIVELLI DI<br />
VALUTAZIONE<br />
Scarso<br />
Mediocre<br />
Sufficiente<br />
2<br />
3<br />
4<br />
0<br />
0,5<br />
1<br />
1,5<br />
2<br />
1<br />
1,5<br />
2<br />
2,5<br />
3<br />
3<br />
4<br />
5<br />
5,5<br />
6<br />
DESCRITTORI PUNTEGGIO<br />
CORRISPONDEN<br />
TE AI DIVERSI<br />
-Espressione scorretta, lessico improprio<br />
-Espressione generica, lessico povero<br />
-Espressione abbastanza chiara e corretta, lessico<br />
LIVELLI<br />
1<br />
2<br />
ALL’INDICATO<br />
RE<br />
VOTO<br />
ATTRIBUITO<br />
ALL’INDICATO<br />
RE<br />
25
espressive<br />
2. Conoscenze<br />
relative<br />
all’argomento<br />
scelto e al quadro<br />
di riferimento<br />
generale.<br />
3. Capacità di<br />
organizzare un<br />
testo<br />
4. Capacità di<br />
elaborazione<br />
critica, originalità<br />
e/creatività<br />
4 punti<br />
4 punti<br />
5 punti<br />
2 punti<br />
Discreto<br />
Buono/Ottimo<br />
Scarso<br />
Mediocre<br />
Sufficiente<br />
Discreto<br />
Buono/Ottimo<br />
Scarso<br />
Mediocre<br />
Sufficiente<br />
Discreto<br />
Buono/Ottimo<br />
Scarso<br />
Mediocre<br />
Sufficiente<br />
Discreto<br />
Buono/Ottimo<br />
essenziale.<br />
-Espressione chiara e corretta, lessico appropriato<br />
-Espressione corretta ed efficace, lessico rcco<br />
-Conoscenza lacunosa e priva di contestualizzazione<br />
-Conoscenza superficiale/contestualizzazione parziale<br />
-Conoscenza e contestualizzazione essenziali<br />
-Conoscenza adeguata/contestualizzazione corretta<br />
-Conoscenza approfondita/contestualizzazione articolata<br />
-Argomentazione disorganica e incoerente<br />
-Argomentazione generica e parzialmente pertinente<br />
-Argomentazione semplice, ma organica e coerente<br />
-Argomentazione organica e abbastanza articolata<br />
-Argomentazione organica, coerente, articolata ed<br />
esauriente<br />
-Assenza di rielaborazione<br />
-Rielaborazione confusa<br />
-Rielaborazione semplice ed essenziale, ma non molto<br />
approfondita<br />
- Rielaborazione corretta nell’impianto concettuale,<br />
approfondita, ma non molto originale<br />
-Rielaborazione efficace e motivata<br />
Voto complessivo attribuito alla prova _____________/15<br />
Rimini, _______________________________________________<br />
Criteri di valutazione della prima prova scritta di: Italiano – Analisi del testo<br />
Candidato_____________________________________________________ <strong>Classe</strong>: V<br />
INDICATORI PUNTEGGIO<br />
MASSIMO<br />
1. Padronanza della<br />
lingua, registro<br />
linguistico<br />
adeguato<br />
2. Comprensione e<br />
capacità di<br />
4 punti<br />
LIVELLI DI<br />
VALUTAZIONE<br />
Scarso<br />
Mediocre<br />
Sufficiente<br />
Discreto<br />
Buono/Ottimo<br />
Scarso<br />
Mediocre<br />
3<br />
3,5<br />
4<br />
1<br />
2<br />
3<br />
3,5<br />
4<br />
1,5<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
0<br />
0,5<br />
DESCRITTORI PUNTEGGIO<br />
CORRISPONDEN<br />
TE AI DIVERSI<br />
-Espressione scorretta, lessico improprio<br />
-Espressione generica, lessico povero<br />
-Espressione abbastanza chiara e corretta, lessico essenziale.<br />
-Espressione chiara e corretta, lessico appropriato<br />
-Espressione corretta ed efficace, lessico ricco<br />
-Argomentazione disorganica e incoerente<br />
-Argomentazione generica e parzialmente pertinente<br />
1<br />
1,5<br />
2<br />
LIVELLI<br />
1<br />
2<br />
3<br />
3,5<br />
4<br />
1<br />
2<br />
VOTO<br />
ATTRIBUITO<br />
ALL’INDICATO<br />
RE<br />
26
organizzare un<br />
testo<br />
3. Capacità di<br />
elaborazione<br />
critica,<br />
approfondimento<br />
contenuti,<br />
originalità/creativ<br />
ità<br />
5punti Sufficiente<br />
Discreto<br />
Buono/Ottimo<br />
6 punti<br />
Scarso<br />
Mediocre<br />
Sufficiente<br />
Discreto<br />
Buono/Ottimo<br />
Rimini, _______________________________________________<br />
-Argomentazione semplice, ma organica e coerente<br />
-Argomentazione organica e abbastanza articolata<br />
-Argomentazione organica, coerente, articolata ed esauriente<br />
-Assenza di rielaborazione<br />
-Rielaborazione confusa<br />
-Rielaborazione semplice ed essenziale, ma non molto<br />
approfondita<br />
- Rielaborazione corretta nell’impianto concettuale,<br />
approfondita, ma non molto originale<br />
-Rielaborazione efficace e motivata<br />
3<br />
4<br />
5<br />
1<br />
2<br />
Voto complessivo attribuito alla prova _____________/15<br />
4<br />
5<br />
6<br />
27
LICEO CLASSICO – LICEO PEDAGOGICO SOCIALE<br />
G. CESARE – M. VALGIMIGLI<br />
INDIRIZZO LICEO LINGUISTICO<br />
RIMINI<br />
SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DELL’ESAME DI STATO<br />
A. S. 2010/11<br />
ALUNNO: CLASSE: V BL 4/12/10<br />
DISCIPLINE COINVOLTE: INGLESE, STORIA DELL’ARTE, FRANCESE, SCIENZE<br />
TEMPO A DISPOSIZIONE: QUATTRO ORE<br />
Simulazione terza prova INGLESE
VAL 4/12/2010 NAME________________________________<br />
1. Explain why, in ‘The Importance of Being Ernest’ the two main characters assume false<br />
identities and lead a double life.<br />
..........................................................................................................................................................<br />
..........................................................................................................................................................<br />
..........................................................................................................................................................<br />
..........................................................................................................................................................<br />
..........................................................................................................................................................<br />
..........................................................................................................................................................<br />
..........................................................................................................................................................<br />
..........................................................................................................................................................<br />
..........................................................................................................................................................<br />
..........................................................................................................................................................<br />
..........................................................................................................................................................<br />
..........................................................................................................................................................<br />
..........................................................................................................................................................<br />
2. What theory influenced Stevenson in creating the character of Mr Hyde?<br />
……………………………………………………………………………………………………..<br />
……………………………………………………………………………………………………..<br />
……………………………………………………………………………………………………..<br />
……………………………………………………………………………………………………..<br />
……………………………………………………………………………………………………..<br />
……………………………………………………………………………………………………..<br />
……………………………………………………………………………………………………..<br />
……………………………………………………………………………………………………..<br />
……………………………………………………………………………………………………..<br />
……………………………………………………………………………………………………..<br />
……………………………………………………………………………………………………..<br />
29
3. What is the link between English Empiricism and Positivism. What does Positivism assert?<br />
……………………………………………………………………………………………………..<br />
……………………………………………………………………………………………………..<br />
……………………………………………………………………………………………………..<br />
……………………………………………………………………………………………………..<br />
……………………………………………………………………………………………………..<br />
……………………………………………………………………………………………………..<br />
……………………………………………………………………………………………………..<br />
……………………………………………………………………………………………………..<br />
……………………………………………………………………………………………………..<br />
……………………………………………………………………………………………………..<br />
……………………………………………………………………………………………………..<br />
……………………………………………………………………………………………………..<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> / Pedagogico - G.<strong>Cesare</strong> / M.Valgimigli – Rimini<br />
30
Simulazione terza prova Storia dell’arte 4 dicembre 2010<br />
<strong>Classe</strong> alunno<br />
Quali idee pone Johann Joachim Winckelmann alla base dell’estetica neoclassica?<br />
Qual è il fatto di cronaca a cui Théodore Géricault s’ispira nel quadro La<br />
zattera della Medusa? Perché sceglie tale soggetto?<br />
Quali effetti ebbe l’invenzione della fotografia sulla pittura ottocentesca?<br />
31
<strong>Classe</strong> V B l Alunna/o ……………………………………………… Rimini 4/12/2010<br />
32
QUESITI DI SCIENZE NATURALI a risposta singola<br />
1)Spiega in che modo l’emoglobina interviene nella regolazione del pH del sangue ( massimo 15<br />
righe)<br />
…………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………..<br />
…………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………<br />
……………………………………………………………………………………………….<br />
2)La versatilità dello scheletro dei vertebrati è in gran parte dovuta alla presenza delle articolazioni,<br />
classifica le articolazioni dello scheletro dell’uomo. (Massimo 15 righe)<br />
…………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………<br />
33
…………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………<br />
………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………<br />
3)Un panino con burro e marmellata contiene carboidrati, proteine e grassi. Descrivi che cosa accade<br />
al panino una volta mangiato, soffermandoti sulle varie fasi di ingestione, digestione, assorbimento<br />
(massimo 15 righe)<br />
……………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………<br />
……………………………………………………………………………………………….<br />
…………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………<br />
……………………………………………………………………………………………….<br />
…………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………<br />
34
…………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………<br />
…………………………………………………………………………………………………<br />
LICEO CLASSICO – LICEO PEDAGOGICO SOCIALE<br />
G. CESARE – M. VALGIMIGLI<br />
INDIRIZZO LICEO LINGUISTICO<br />
RIMINI<br />
35
SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA DELL’ESAME DI STATO<br />
A. S. 2010/11<br />
ALUNNO: CLASSE: V BL 4/05/11<br />
DISCIPLINE COINVOLTE: STORIA DELL’ARTE, FRANCESE, TEDESCO, MATEMATICA<br />
TEMPO A DISPOSIZIONE: QUATTRO ORE<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Classico</strong> / Pedagogico - G.<strong>Cesare</strong> / M.Valgimigli – Rimini<br />
Simulazione terza prova Storia dell’arte 4 maggio 2011<br />
<strong>Classe</strong> alunno<br />
36
Nel 1886 Georges Seurat espone all’ottava e ultima mostra impressionista il<br />
dipinto Un dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte adottando una nuova<br />
tecnica pittorica. Descrivila.<br />
Quali sono i caratteri più importanti dell’Art Nouveau?<br />
Impressionismo ed Espressionismo esprimono due visioni dell’arte contrapposte,<br />
descrivi tale contrapposizione.<br />
LICEO LINGUISTICO “G.CESARE - M.VALGIMIGLI” - RIMINI<br />
37
Materia: FRANCESE<br />
Data: 04/05/11<br />
SIMULAZIONE DI TERZA PROVA<br />
1) Décrivez le tableau “Déjeuner sur l’herbe” de Manet et les émotions qu’il suscite en vous (max 15<br />
lignes)<br />
________________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________________<br />
2) Etablissez un lien entre le mouvement artistique de l’impressionnisme et la littérature (max. 15 lignes)<br />
________________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________________<br />
________________________________________________________________________________________________________<br />
Simulazione Terza Prova <strong>Classe</strong> 5 BL<br />
T e d e s c o<br />
Candidato: _____________________________<br />
38
Mit den Leiden des jungen Werthers schrieb Goethe ein Werk, das für eine neue Konzeption des Romans exemplarisch ist. Welches<br />
sind die innovativen Aspekte dieses Werkes?<br />
___________________________________________________________________________________________________________<br />
___________________________________________________________________________________________________________<br />
___________________________________________________________________________________________________________<br />
___________________________________________________________________________________________________________<br />
___________________________________________________________________________________________________________<br />
___________________________________________________________________________________________________________<br />
___________________________________________________________________________________________________________<br />
___________________________________________________________________________________________________________<br />
___________________________________________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
Die Epoche 1815 – 1848 besitzt eine deutliche Ambivalenz. Erkläre bitte, worum es geht!<br />
___________________________________________________________________________________________________________<br />
___________________________________________________________________________________________________________<br />
___________________________________________________________________________________________________________<br />
___________________________________________________________________________________________________________<br />
___________________________________________________________________________________________________________<br />
___________________________________________________________________________________________________________<br />
___________________________________________________________________________________________________________<br />
___________________________________________________________________________________________________________<br />
___________________________________________________________________________________________________________<br />
_____________________________________________________________________________<br />
Charakterisiere in groben Zügen die wichtigsten Merkmale des deutschen Realismus.<br />
___________________________________________________________________________________________________________<br />
___________________________________________________________________________________________________________<br />
___________________________________________________________________________________________________________<br />
___________________________________________________________________________________________________________<br />
___________________________________________________________________________________________________________<br />
___________________________________________________________________________________________________________<br />
___________________________________________________________________________________________________________<br />
___________________________________________________________________________________________________________<br />
___________________________________________________________________________________________________________<br />
__________________________________________________________________________________________________________<br />
LICEO LINGUISTICO “G.CESARE - M.VALGIMIGLI” - RIMINI<br />
39
Materia: MATEMATICA<br />
Data: 04/05/11<br />
SIMULAZIONE DI TERZA PROVA<br />
- 1 -<br />
Si definisca la continuità di una funzione in un punto e in un intervallo.<br />
Data la funzione<br />
3<br />
x<br />
y<br />
= 2<br />
x −1<br />
si determinino i suoi punti di discontinuità. A quali valori tende la funzione nell’intorno di tali<br />
punti?<br />
Quali sono i punti di stazionarietà di una funzione e con quale criterio possono essere<br />
determinati?<br />
Trovare le coordinate dei punti stazionari della funzione data.<br />
Si completi il grafico della funzione data individuandone altre particolari caratteristiche.<br />
- 2 -<br />
- 3 -<br />
SIMULAZIONE SECONDA PROVA<br />
Criteri di valutazione utilizzati per la valutazione della prova di<br />
40
COMPRENSIONE<br />
Capacità di focalizzare il messaggio del testo<br />
rispondendo in modo puntuale alle domande<br />
• Completa<br />
• Buona<br />
• Discreta<br />
• Parziale<br />
• nulla<br />
Capacità di rielaborare in modo personale i contenuti<br />
del testo e di argomentare efficacemente le proprie<br />
affermazioni/risposte<br />
• ottima<br />
• buona<br />
• discreta<br />
• sufficiente<br />
• scarsa<br />
• nulla<br />
Capacità di riproporre sinteticamente gli elementi<br />
essenziali di un testo (riassunto)<br />
• sintesi efficace ed essenziale<br />
• " ridondante, ma efficace<br />
• " incompleta<br />
• " assente<br />
Correttezza formale<br />
• padronanza nell'uso delle strutture<br />
grammaticali, qualche lieve errore<br />
• alcuni errori non gravi/ di scelta lessicale che<br />
non compromettono l'efficacia espressiva<br />
• qualche errore circoscritto ad alcune aree<br />
grammaticali<br />
• alcuni gravi errori che compromettono<br />
l'efficacia espressiva<br />
• numerosi errori gravi attinenti alle strutture<br />
grammaticali di base<br />
voto<br />
LINGUA STRANIERA<br />
3<br />
2<br />
1.5<br />
1<br />
0<br />
4<br />
3<br />
2.5<br />
2<br />
1<br />
0<br />
SIMULAZIONE SECONDA PROVA<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
4<br />
3,5<br />
3<br />
2<br />
1<br />
/15<br />
41
PRODUZIONE<br />
Aderenza al "tema" proposto come oggetto di analisi/<br />
riflessione<br />
• completa<br />
• parziale<br />
• incompleta<br />
• nulla<br />
Correttezza formale<br />
• padronanza nell'uso delle strutture<br />
grammaticali, qualche lieve errore<br />
• alcuni errori non gravi/di scelta lessicale che<br />
non compromettono l'efficacia espressiva<br />
• qualche errore circoscritto ad alcune aree<br />
grammaticali<br />
• alcuni gravi errori che compromettono<br />
l'efficacia espressiva<br />
• numerosi errori gravi attinenti alle strutture<br />
grammaticali di base<br />
Ricchezza lessicale<br />
• lessico ricco ed appropriato<br />
• lessico abbastanza appropriato, ma limitato<br />
• lessico limitato e talvolta inappropriato<br />
• lessico molto limitato e quasi sempre<br />
inadeguato<br />
Articolazione del discorso<br />
• coerente ed efficace<br />
• coerente, ma poco analitica<br />
• schematica<br />
• qualche incongruenza<br />
• incoerente e disordinata<br />
Criteri utilizzati per la valutazione della prova di<br />
voto<br />
LINGUA STRANIERA<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
4<br />
3,5<br />
3<br />
2<br />
1<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
3<br />
2.5<br />
2<br />
1<br />
0.5<br />
/15<br />
Terza Prova Scritta – Materia: Arte<br />
42
Griglia di valutazione con uso descrittori<br />
(valutazione in 15esimi)<br />
Candidato ______________________________________________________<strong>Classe</strong>_________________<br />
Indicatori Punteggio massimo<br />
attribuibile<br />
all’indicatore<br />
1) Conoscenza dei<br />
contenuti e capacità di<br />
analizzare l’argomento<br />
nei suoi aspetti<br />
essenziali.<br />
2) Capacità di<br />
organizzare in modo<br />
coerente e sintetico le<br />
informazioni e i<br />
concetti.<br />
3) Correttezza e<br />
proprietà linguistica.<br />
8 punti<br />
5 punti<br />
2 punti<br />
Livelli di valore/ valutazione Voto attribuito all’indicatore<br />
4 - Scarso<br />
5 - Mediocre<br />
6 - Sufficiente<br />
7 - Discreto<br />
8 - Buono/Ottimo<br />
1 - Scarso<br />
2 - Mediocre<br />
3 - Sufficiente<br />
4 - Discreto<br />
5 - Buono/Ottimo<br />
0 - Scarso<br />
0,5 - Mediocre<br />
1 - Sufficiente<br />
1,5 - Discreto<br />
2 - Buono/Ottimo<br />
_____________________ il _____________ Voto Complessivo attribuito alla prova _______ / 15<br />
N.B. – Il voto complessivo risultante dalla somma dei<br />
punteggi attribuiti ai singoli indicatori, in presenza di<br />
numeri decimali, viene approssimato in eccesso<br />
all’unità superiore. La sufficienza è corrispondente al<br />
voto di ≥ 10/15.<br />
Il Presidente<br />
I Commissari:<br />
SIMULAZIONE TERZA PROVA<br />
Criteri di valutazione utilizzati per la prova scritta di Matematica, Scienze<br />
43
Indicatori<br />
Padronanza del codice<br />
linguistico specifico<br />
Conoscenze e<br />
competenze riferite agli<br />
argomenti proposti<br />
Capacità di sintesi e/o di<br />
collegamento e<br />
articolazione delle<br />
conoscenze e competenze<br />
Punteggio massimo<br />
attribuito all’indicatore<br />
N.B. – Il voto complessivo risultante dalla somma dei<br />
punteggi attribuiti ai singoli indicatori, in presenza di<br />
numeri decimali, viene approssimato in eccesso<br />
all’unità superiore. La sufficienza è corrispondente al<br />
voto di ≥ 10/15.<br />
Il Presidente<br />
5 punti scarso<br />
mediocre<br />
sufficiente<br />
discreto<br />
buono/ottimo<br />
6 punti scarso<br />
mediocre<br />
sufficiente<br />
discreto<br />
Livello di valore Punteggio<br />
corrispondente ai<br />
buono/ottimo<br />
4 punti scarso/mediocre<br />
sufficiente<br />
discreto<br />
buono/ottimo<br />
I Commissari:<br />
diversi livelli<br />
<strong>Liceo</strong> “G. <strong>Cesare</strong> – M. Valgimigli” - Rimini<br />
<strong>Classico</strong> – Formazione – Sociale – <strong>Linguistico</strong><br />
Anno scolastico 20010 / 2011<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
1-2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
44
• CLASSE V B liceo <strong>Linguistico</strong><br />
• MATERIA: Italiano<br />
• DOCENTE: Magalotti Ambra<br />
PROGRAMMA SVOLTO<br />
Testi in adozione: Luperini-Cataldi, La scrittura e l’interpretazione, vol. 2, 3 Palumbo;<br />
Dante Alighieri, Divina Commedia, Paradiso<br />
COMPETENZE CONTENUTI E STRUMENTI METODOLOGIA E<br />
DIBATTITO CULTURALE E POETICHE FRA OTTOCENTO E NOVECENTO (storicoletterario;trasversale<br />
durante l’anno)<br />
Conoscere le<br />
tendenze letterarie e<br />
culturali del periodo;<br />
conoscere luoghi e<br />
soggetti della<br />
produzione<br />
culturale;<br />
comprendere gli<br />
elementi di<br />
continuità e di<br />
innovazione nella<br />
storia delle idee;<br />
saper costruire un<br />
quadro di<br />
riferimento storico<br />
culturale;<br />
saper commentare,<br />
interpretare,<br />
contestualizzare testi<br />
in prosa e in poesia;<br />
saper collegare le<br />
tematiche del<br />
passato ai dibattiti<br />
attuali<br />
riconoscere,<br />
attraverso la lettura<br />
diretta dei testi, le<br />
differenti valutazioni<br />
e reazioni di fronte<br />
al medesimo<br />
avvenimento storico<br />
L’ermetismo.<br />
Il complesso quadro culturale del Secondo Ottocento:<br />
• dal Romanticismo al Naturalismo e Verismo: il<br />
romanzo sperimentale, l’approccio scientifico alla<br />
Letteratura; G Verga, Dedicatoria a Salvatore<br />
farina; Prefazione a “I Malavoglia”.<br />
• il Simbolismo e la nascita della lirica moderna: C.<br />
Baudelaire, riferimento a Corrispondenze;<br />
L’albatro; Perdita dell’aureola (Lett. Francese)<br />
• il Decadentismo.<br />
Le poetiche delle avanguardie del primo Novecento:<br />
Crepuscolari e F uturismo:<br />
- F. T. Marinetti, Il primo manifesto del Futurismo;<br />
Manifesto tecnico della letteratura futurista.<br />
Relativismo gnoseologico e scoperta dell’inconscio;<br />
Bergson e la nuova concezione del tempo:<br />
- L. Pirandello, da L’Umorismo: La “forma” e la<br />
“vita”; Umorismo e comicità.<br />
La poesia ermetica.<br />
La rinascita del romanzo nel Neorealismo: I. Calvino,<br />
Un ricordo del Neorealismo.<br />
Chi scrive e perché: immagine del poeta tra impegno<br />
evasione ed emarginazione.<br />
• Veggente, superuomo ed esteta; il fanciullino, il<br />
poeta “malato”e la vergogna della poesia; il<br />
saltimbanco:<br />
- G. Pascoli, passi dalle prose de Il fanciullino;<br />
- A. Palazzeschi, Chi sono, Lasciatemi divertire.<br />
- S. Corazzini, Desolazione del povero poeta<br />
sentimentale.<br />
Letterati e poeti di fronte alla “grande guerra”:<br />
• Futurismo, esaltazione della guerra e rivoluzione<br />
formale.<br />
• Ungaretti e “l’unanimismo” .<br />
- da l’Allegria: I fiumi, S. Martino del Carso,<br />
Natale, Veglia , Soldati, Commiato;<br />
- da Sentimento del tempo: Caino.<br />
- da Il dolore: Non gridate più.<br />
Strumenti<br />
letture tratte dal libro di testo; materiale fornito<br />
dall’insegnante.<br />
VERIFICA<br />
Lezione frontale per<br />
introdurre e collegare;<br />
lezione dialogata per la<br />
lettura e il commento di<br />
brani significativi;<br />
lettura autonoma a casa con<br />
approfondimento di alcune<br />
tematiche.<br />
esercizi di comprensione e<br />
analisi del testo in classe e a<br />
casa;<br />
relazione degli alunni su<br />
ricerche individuali<br />
riferimento/collegamento al<br />
Naturalismo francese: E.<br />
Zola, Prefazione a “La<br />
fortuna dei Rougon”; Il<br />
romanzo sperimentale.<br />
riferimento interdisciplinare<br />
a C. Baudelaire, La perdita<br />
dell’aureola; A. Rimbaud,<br />
Lettera del veggente.<br />
riferimento/collegamento ai<br />
romanzi del Decadentismo<br />
europeo: O. Wilde, “Il<br />
ritratto di Doryan Gray”;<br />
Huysmans, da “ A ritroso”.<br />
Verifica<br />
colloquio orale (in itenere);<br />
saggio breve e/o articolo;<br />
analisi del testo<br />
COMPETENZE CONTENUTI E STRUMENTI METODOLOGIA E<br />
VERIFICA<br />
45
IL VOLTO DELL’EROE (tematico)<br />
Conoscere i tratti<br />
distintivi dell’eroe e<br />
le sue trasformazioni<br />
nell’immaginario<br />
letterario;<br />
conoscere i contesti<br />
storico culturali di<br />
riferimento;<br />
saper collegare i<br />
mutamenti di<br />
concezione alle<br />
mutate<br />
caratteristiche<br />
culturali;<br />
saper operare<br />
confronti;<br />
saper storicizzare il<br />
tema,<br />
comprendendone la<br />
funzione<br />
nell’immaginario<br />
collettivo;<br />
saper fare l’analisi di<br />
un testo<br />
distinguendo le<br />
peculiarità di<br />
ciascun autore, nei<br />
contenuti e nello<br />
stile, nell’esprimere<br />
la tematica presa in<br />
esame.<br />
Dall’eroe romantico alla figura “dell’inetto”<br />
• Il cammino di formazione del “cercatore di giustizia”:<br />
- Renzo ne “I promessi sposi”;<br />
- Dante, Divina Commedia, Paradiso. Lettura, analisi e<br />
commento dei canti: I, III, VI, VIII, XI, XII, XVII, XXX<br />
(vv. 37-148), XXXIII.<br />
• L’esteta e il superuomo nei romanzi di D’Annunzio<br />
(notizie sull’autore): da “Il piacere”, Ritratto di Andrea<br />
Sperelli, Il verso è tutto, Conclusione del romanzo; da<br />
“Il trionfo della morte”, Il verbo di Zarathustra,<br />
Ippolita, la “Nemica”.<br />
• Il vinto verghiano ne “I Malavoglia” e nelle novelle:<br />
Verga (notizie sull’autore), la rivoluzione stilistica e<br />
tematica nei romanzi e nelle novelle; il tema<br />
dell’esclusione e lo straniamento; il “Ciclo dei vinti”: -<br />
- Dedicatoria a Salvatore Farina; da Vita dei campi:<br />
Rosso Malpelo; da Novelle rusticane: Libertà, La roba;<br />
da Mastro-don Gesualdo: La morte di Gesualdo.<br />
- I Malavoglia, la vicenda del romanzo; riflessione sul<br />
tempo e lo spazio della storia, la struttura; il sistema<br />
dei personaggi; la lingua e lo stile: Prefazione a “I<br />
Malavoglia”; L’inizio dei “Malavoglia”; Mena,<br />
compare Alfio e le “stelle amiccavano più forte”<br />
(cap.II); Alfio e Mena: simbolismo e linguaggio<br />
negato (cap.V); La rivoluzione per il dazio sulla pece<br />
(cap.VII); L’addio di ‘Ntoni (cap. XV).<br />
• La dissoluzione del personaggio e la crisi del soggetto<br />
in Pirandello e Svevo:<br />
• L. Pirandello (notizie sull’autore), avvertimento e<br />
sentimento del contrario; maschera e forma; la<br />
percezione del progresso; il teatro nel teatro; il tema<br />
della follia; flusso di coscienza e monologo interiore.<br />
- da L’Umorismo: La “forma” e la “vita”;<br />
Umorismo e comicità.<br />
- Narrativa: Il treno ha fischiato;<br />
- Il fu Mattia Pascal” (lettura integrale): la vicenda<br />
del romanzo; riflessione sulla struttura, i<br />
personaggi, il tempo e lo spazio e particolare<br />
riferimento alla Premessa seconda (“maledetto sia<br />
Copernico”); al cap. XII (Uno strappo nel cielo di<br />
carta), XIII (il lanternino), XV e XVIII;<br />
- da “I quaderni di Serafino Gubbio operatore”: Le<br />
macchine e la modernità.<br />
- Teatro: Così è (se vi pare), atto III, scene 7°, 9°;<br />
Enrico IV, atto III, scena conclusiva.<br />
• I. Svevo (notizie sull’autore): l’eroe inetto; flusso di<br />
coscienza e monologo interiore.<br />
- “La coscienza di Zeno”(lettura integrale): la<br />
vicenda del romanzo; riflessione sulla struttura, la<br />
dimensione dell’io narrato e dell’io narrante, il<br />
tempo e lo spazio; il significato della conclusione:<br />
Il fumo; Lo schiaffo del padre; La proposta di<br />
matrimonio; La vita è una malattia.<br />
Strumenti<br />
letture tratte dal libro di testo;<br />
materiale fornito dall’insegnante<br />
Lezione frontale lezione<br />
dialogata per la lettura e il<br />
commento di brani<br />
significativi;<br />
lettura e analisi dei testi;<br />
lettura autonoma di alcune<br />
opere in versione integrale.<br />
relazione degli alunni su<br />
ricerche individuali<br />
riferimento/collegamento ai<br />
romanzi del Decadentismo<br />
europeo: O. Wilde, “Il<br />
ritratto di Doryan Gray”;<br />
Huysmans, da “ A ritroso”.<br />
riferimento/collegamento al<br />
Naturalismo francese: E.<br />
Zola, Prefazione a “La<br />
fortuna dei Rougon”; Il<br />
romanzo sperimentale.<br />
riferimenti al contesto<br />
europeo: J. Joyce, flusso di<br />
coscienza e monologo<br />
interiore<br />
Verifica<br />
colloquio orale;<br />
saggio breve e/o articolo;<br />
analisi del testo.<br />
COMPETENZE CONTENUTI E STRUMENTI METODOLOGIA E<br />
VERIFICA<br />
46
IDEE DELLA NATURA (tematico)<br />
INCONTRO CON L’OPERA<br />
INCONTRO CON L’AUTORE<br />
Descrivere il tema in<br />
un determinato testo;<br />
saper storicizzare il<br />
tema,<br />
comprendendone la<br />
funzione<br />
nell’immaginario<br />
collettivo;<br />
saper distinguere le<br />
peculiarità di<br />
ciascun autore, nei<br />
contenuti e nello<br />
stile, nell’esprimere<br />
la tematica presa in<br />
esame.<br />
Conoscere la genesi<br />
e la struttura del<br />
testo;<br />
saper collocare<br />
l’opera nel contesto<br />
storico culturale;<br />
saper applicare<br />
analisi tematiche,<br />
stilistiche,<br />
narratologiche;<br />
saper formulare un<br />
giudizio motivato.<br />
Comprendere<br />
l’intreccio di fattori<br />
individuali e sociali<br />
nella formazione<br />
dello scrittore;<br />
riconoscere le fasi<br />
evolutive nell’opera<br />
di un autore;<br />
orientarsi nel<br />
rapporto tra<br />
influenze della<br />
tradizione e<br />
originalità<br />
G. Pascoli, Il simbolismo pascoliano e il mito del nido<br />
(notizie sull’autore):<br />
• La lettura: da Myricae, Lavandare, X Agosto,<br />
L’assiuolo, Novembre;<br />
- da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino Notturno;<br />
- dalle prose, Il fanciullino.<br />
• L’interpretazione: G. Contini, La tecnica del<br />
simbolismo espressivo ne L’assiuolo e ne Il<br />
gelsomino notturno<br />
D’Annunzio,Il mito panico dell’Alcyone dannunziano:<br />
sensualità e novità stilistiche.<br />
- dalle Laudi, Alcyone: La sera fiesolana; Stabat<br />
nuda aestas; La pioggia nel pineto.<br />
Strumenti<br />
letture tratte dal libro di testo;<br />
materiale fornito dall’insegnante<br />
“Il sentiero dei nidi di ragno” di Italo Calvino:<br />
• La rinascita del romanzo nel Neorealismo: I.<br />
Calvino, Un ricordo del Neorealismo;<br />
• notizie sull’autore;<br />
• lettura integrale del romanzo<br />
Strumenti<br />
letture tratte dal libro di testo;<br />
opera dell’autore<br />
E. Montale (notizie sull’autore)<br />
La lettura<br />
da Ossi di seppia: Corno inglese, Non chiederci la<br />
parola, Spesso il male di vivere, Meriggiare pallido e<br />
assorto.<br />
da Le occasioni: La casa dei doganieri, Nuove stanze;<br />
da La bufera e altro: Il gallo cedrone;<br />
da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, …; L’alluvione<br />
ha sommerso il pack dei mobili.<br />
L’interpretazione<br />
Il programma di torcere il collo all’eloquenza; La<br />
poetica delle Occasioni; Una totale disarmonia; E’<br />
ancora possibile la poesia?;<br />
Montale simbolico o allegorico nella posizione di<br />
Anceschi e Jacomuzzi.<br />
Strumenti<br />
letture tratte dal libro di testo;<br />
materiale fornito dall’insegnante<br />
Lezione frontale per<br />
introdurre, stabilire raccordi<br />
e guidare alla lettura dei<br />
brani;<br />
lettura e analisi del testo<br />
riferimento/ collegamento ai<br />
moduli già trattati (storico<br />
letterario; l’eroe)<br />
Verifica<br />
colloquio orale (in itenere);<br />
analisi del testo<br />
Verifica<br />
colloquio orale (in itenere)<br />
lettura e analisi dei testi in<br />
classe;<br />
lettura autonoma a casa;<br />
riferimento/collegamento al<br />
romanzo di Vercors, Il<br />
silenzio del mare (francese);<br />
alle tematiche storiche (II<br />
guerra mondiale, resistenza)<br />
approfondimenti sul<br />
Neorealismo<br />
cinematografico: R.<br />
Rossellini, Gemania anno<br />
zero<br />
Lezione frontale per<br />
introdurre e collegare;<br />
lezione dialogata per la<br />
lettura e il commento di<br />
brani significativi;<br />
lettura autonoma a casa con<br />
approfondimento di alcune<br />
tematiche.<br />
esercizi di comprensione e<br />
analisi del testo in classe e a<br />
casa.<br />
Verifica<br />
colloquio orale (in itenere)<br />
Criteri di valutazione<br />
Per i criteri di valutazione ho fatto riferimento alla griglia riportata sul registro che prende in considerazione i seguenti ambiti<br />
cognitivi ed operativi: conoscenza, comprensione, espressione, applicazione, analisi, sintesi, secondo una gradualità che è compresa<br />
tra la votazione minima di tre / quattro ed la massima di nove / dieci. La valutazione sarà basata su un congruo numero di prove scritte<br />
e orali, non inferiori, comunque, a due sia per lo scritto sia per l’orale.<br />
47
I rappresentanti di classe<br />
Rimini, 15 maggio 2011<br />
LICEO CLASSICO-PEDAGOGICO<br />
Giulio <strong>Cesare</strong> Manara Valgimigli<br />
L’insegnante<br />
Ambra Magalotti<br />
48
PROGRAMMA SVOLTO NELL’A.S. 2010-2011<br />
DOCENTE: Matteoni Augusta<br />
CLASSE: VBL<br />
MATERIA: LATINO<br />
Testo in adozione: Conte, Pianezzola, Il libro della letteratura latina: la storia e i testi, Le<br />
Monnier.<br />
STORIA DELLA LETTERATURA LATINA<br />
L’età imperiale da Tiberio ai Flavi.<br />
1. Seneca<br />
De brevitate vitae, lettura integrale in italiano.<br />
2. Lucano.<br />
Passaggio del Rubicone, Farsalia I, 183-227<br />
L'uccisione di Pompeo, Farsalia, VIII, 610-635.<br />
3. Petronio.<br />
Presentazione di Trimalcione, Satyricon, XXVI, 7, XVIII,9<br />
Fortunata, la padrona di casa nel ritratto di un commensale, Satyricon,<br />
XXXVII, 1, 10.<br />
La novella della matrona di Efeso, Satyricon, CX, 6, CXIII, 2.<br />
4. La satira sotto il principato: Persio e Giovenale.<br />
Giovenale, La suocera, VI, 231-241.<br />
La moglie ha sempre ragione, VI, 434-436.<br />
Vita grama di poeta, VII, 1-97.<br />
5. Plinio il vecchio e il sapere specialistico.<br />
L'uomo e la natura matrigna, VII, 3-5.<br />
6. Marziale e l'epigramma.<br />
La scelta del genere epigrammatico, X, 6.<br />
Che cosa non e' un epigramma, XXXIV, 1, 2.<br />
La piccola Erotion, Epicedio, V, 34.<br />
7. Quintiliano.<br />
Eccellenza di Virgilio, X 1 85-88.<br />
Giudizio su Cicerone oratore, X 1 105-110.<br />
L’età degli imperatori per adozione.<br />
1. Plinio il giovane.<br />
Che fare con i cristiani, X, 96-97.<br />
Risponde l'imperatore, X, 97.<br />
2. Tacito.<br />
Le donne dei Germani, Germania, 19.<br />
Il quadro drammatico degli avvenimenti, Historiae, I, 2.<br />
Il suicidio di Otone, Historiae, II, 49.<br />
49
L'obbiettività dello storico, Annales, I, 1.<br />
Rumore sulla morte di Druso, Annales, IV, 10-11.<br />
L'incendio di Roma, Annales, XV, 38.<br />
3. Apuleio.<br />
Metamorfosi di Panfilia, Metamorfosi, III, 21-22.<br />
Psiche alla ricerca dello sposo, Metamorfosi, I, 5.<br />
La tarda età imperiale.<br />
La letteratura latina cristiana.<br />
1. Agostino.<br />
La conversione, Confessioni, VII, 12, 28-30.<br />
Il tempo, Confessioni, XI, 14, 17, 18, 23, 28, 36.<br />
o AUTORI LATINI<br />
Orazio: Satira I, 9.<br />
Odi I, 9, 11, 37.<br />
III, 13, 30.<br />
Seneca: Lettere a Lucilio, Epistola V 47(1-8).<br />
Epistola III 22(1-2), 23(1-3), 24(20), 25(1-2).<br />
Rimini, 15 maggio 2011<br />
L’insegnante I rappresentanti di classe<br />
50
LICEO CLASSICO-PEDAGOGICO<br />
Giulio <strong>Cesare</strong> Manara Valgimigli<br />
PROGRAMMA SVOLTO NELL’A.S. 2010-2011<br />
DOCENTE: Matteoni Augusta<br />
CLASSE: VBL<br />
MATERIA: STORIA<br />
Testo in adozione: Feltri, Bertazzoni, Neri, I giorni e le idee, SEI.<br />
La prima guerra mondiale<br />
1. Le origini del conflitto.<br />
2. La dinamica militare del conflitto.<br />
3. La guerra vissuta.<br />
4. Rivolte e ammutinamenti.<br />
L'Italia dal 1914 al 1918.<br />
2. Il problema dell'intervento.<br />
3. L'Italia in guerra.<br />
4. L'ultimo anno di guerra.<br />
5. Gli italiani in guerra.<br />
Il comunismo in Russia.<br />
1. Le conseguenze della prima guerra mondiale.<br />
2. La questione del socialismo.<br />
3. La concezione dello stato.<br />
4. I diritti dell'uomo e del cittadino.<br />
5. Economia e società.<br />
Il fascismo in Italia.<br />
1. Le conseguenze della prima guerra mondiale.<br />
2. La questione del socialismo.<br />
3. La concezione dello stato.<br />
4. I diritti dell'uomo e del cittadino.<br />
5. Economia e società.<br />
Il nazionalsocialismo in Germania<br />
1. Le conseguenze della prima guerra mondiale.<br />
2. La questione del socialismo.<br />
3. La concezione dello stato.<br />
4. I diritti dell'uomo e del cittadino.<br />
5. Economia e società.<br />
51
Democrazia e liberalismo in Europa e negli Stati Uniti.<br />
1. La questione del socialismo<br />
2. Le conseguenze della prima guerra mondiale.<br />
3. Economia e società.<br />
4. La concezione dello stato.<br />
5. I diritti dell'uomo e del cittadino.<br />
La seconda guerra mondiale.<br />
1. Le origini del conflitto.<br />
2. La dinamica della guerra..<br />
3. L'Italia nella seconda guerra mondiale.<br />
Lo sterminio degli ebrei.<br />
1. Il processo di distruzione.<br />
2. L'annientamento pianificato.<br />
L'ordine bipolare.<br />
1. Le conseguenze della prima guerra mondiale.<br />
2. La questione del socialismo.<br />
3. La concezione dello stato.<br />
4. I diritti dell'uomo e del cittadino.<br />
5. Economia e società.<br />
La Chiesa cattolica.<br />
1. La questione del socialismo.<br />
2. Le conseguenze della prima guerra mondiale.<br />
L'Italia repubblicana.<br />
1. La nascita della repubblica.<br />
2. Gli anni Cinquanta e Sessanta.<br />
3. Gli anni di piombo.<br />
4. La fine delle ideologie.<br />
Rimini, 15 maggio 2011<br />
L’insegnante I rappresentanti di classe<br />
52
• CLASSE V A liceo linguistico<br />
• MATERIA: Inglese<br />
• DOCENTE: Fernanda Casablanca<br />
• Testo in adozione<br />
<strong>Liceo</strong> “G. <strong>Cesare</strong> – M. Valgimigli” - Rimini<br />
<strong>Classico</strong> – Formazione – Sociale – <strong>Linguistico</strong><br />
Anno scolastico 2010 / 2011<br />
PROGRAMMA SVOLTO<br />
Only Connect Vol. E /F/G Spiazzi/ Tavella Zanichelli<br />
Nel corso dell'anno si è cercato di far acquisire agli studenti una sufficiente competenza comunicativa,<br />
lavorando sulle abilità di comprensione e di produzione orale e scritta di testi di argomento prevalentemente<br />
letterario. Il lavoro in classe e a casa ha avuto inoltre lo scopo di migliorare la precisione morfo-sintattica<br />
scritta e orale, con risultati diversi nei singoli alunni.<br />
OBIETTIVI:<br />
- Capacità di leggere e decifrare testi di interesse culturale e storico<br />
- Sviluppo e potenziamento della capacità di sintesi e rielaborazione di un testo<br />
- Sviluppo e potenziamento dell’abilità di ricezione e produzione orale<br />
- Saper esprimere un’opinione personale o effettuare un commento critico<br />
OBIETTIVI RAGGIUNTI<br />
CONOSCITIVI<br />
a) Progressivo ampliamento della conoscenza delle funzioni e strutture linguistiche;<br />
b) Affinamento della capacità comunicativa;<br />
c) Conoscenza dei contenuti di un testo letterario ed indicazioni delle idee principali e<br />
dello stile.<br />
OPERATIVI<br />
a) Comprensione ed interpretazione di testi letterari, ordinata e coerente al<br />
pensiero dell’autore e/o al movimento letterario;<br />
b) Capacità di analisi testuale ancora più autonoma e critica;<br />
c) Esatta collocazione dei contenuti letterari nel contesto storico-culturale, in un’ottica di<br />
comparazione con analoghe esperienze di lettura di testi italiani e inglesi;<br />
d) Produzione di testi ben strutturati sintatticamente e rielaborati in maniera personale;<br />
e) Capacità di esposizione in un linguaggio autonomo, relativamente<br />
al testo studiato o ad un ampia gamma di situazioni comunicative, in modo adeguato al<br />
53
contesto e alle circostanze.<br />
FORMATIVI<br />
a) Sviluppo delle modalità generali del pensiero attraverso la riflessione sulla lingua;<br />
b) Riflessione sulla propria lingua e cultura attraverso l’analisi comparativa con la lingua e<br />
cultura anglofona.<br />
CONTENUTI DISCIPLINARI<br />
Il primo periodo vittoriano era già stato preso in esame alla fine dell’anno scolastico precedente. All’inizio di<br />
questo anno si è ritenuto opportuno riprendere l’argomento e approfondire lo studio dell’opera di Dickens e del<br />
contesto socio-culturale della prima metà del 19° secolo per affrontare,<br />
sulle basi di conoscenze più ampie, lo studio del tardo periodo vittoriano e delle nuove tendenze letterarie.<br />
Positivism:<br />
Key ideas, influence on society<br />
Utilitarianism a moral doctrine<br />
“ Laissez faire” an economic doctrine<br />
Education in the Victorian Age<br />
Charles Dickens<br />
- Life and features of his novels<br />
- The ‘ Bildungsroman’ novel<br />
From ‘David Copperfield’ chapter VII<br />
Visione film BBC in lingua originale<br />
From ‘ Bleak House’ chapter I<br />
Robert Louis Stevenson<br />
- The theme of ‘the double’<br />
From ‘The Strange Case of Doctor Jekyll and Mr. Hyde’ Chapter I, Chapter X<br />
Fin de Siècle<br />
- Aestheticism. Decadentism and Symbolism<br />
- The archetypal decadent : Huysmans, Wilde and D’Annunzio<br />
Oscar Wilde : the rebel and the dandy, “art for art’s sake”<br />
Film in English : Wilde ( Brian Gilbert 1997)<br />
The Picture of Dorian Gray : plot and main themes<br />
The Double Life in The Importance of Being Earnest<br />
Social Roles in British society<br />
From ‘The Importance of Being Earnest ‘ ‘ Lady Bracknell’s interview’<br />
‘ Deceits, tea and muffins’<br />
54
The Historical and social context<br />
- The Edwardian Age<br />
- Britain and World War I<br />
The Age of anxiety<br />
The transition from traditional to modern novel<br />
- Man and psyche<br />
- Subjective time<br />
- Freud’s new model of the mind<br />
Joseph Conrad<br />
- Life and main works<br />
Darkness and light<br />
From ‘ Hearth of Darkness’ Chapter I, Chapter III<br />
Modernism<br />
- The breakdown of traditional literary genres<br />
- The fragmentation of the traditional idea of time and place ( Bergson and James)<br />
- The collapse of traditional plot<br />
- The use of language<br />
- The use of myth<br />
- The free verse in poetry<br />
- The new literary techniques<br />
James Joyce and T. S. Eliot:<br />
- the mythical method and the concept of history<br />
- The correlative objective<br />
- The role of the artist<br />
From Dubliners<br />
- ‘ Eveline’<br />
- ‘ The Dead’<br />
From Ulysses<br />
- ‘The Funeral’<br />
- Molly’s monologue’<br />
Joyce and Pirandello : shared view on art<br />
Modernism in poetry: T.S.Eliot<br />
- Life and main works<br />
From ‘ The Waste Land’<br />
- “ The Burial of the dead”<br />
55
- ‘ The Fire Sermon’<br />
- ‘What The Thunder said’ ( from L. 1 to 38 )<br />
From Poems ( 1925)<br />
“ The hollow men “<br />
Eliot and Montale: a shared sensitiveness<br />
A comparison between “ Meriggiare pallido e assorto “ and “ What the thunder said”<br />
The role of the poet : “ Non chiederci la parola” ( E. Montale “ Ossi di Seppia”)<br />
Dystopian novels<br />
Geoge Orwell and Aldous Huxley<br />
The importance of memory<br />
From “1984” chapter I, chapter V part I , chapter III part II<br />
Brave New World : a study of dehumanization<br />
- attitude towards progress<br />
- Attitude towards history<br />
- Totalitarian systems<br />
- The use of technology to control society<br />
- The consumer society<br />
From ‘ Brave New World’ Chapter II, III<br />
Historical and social context<br />
- The Second World War<br />
The fifties<br />
The theatre of the absurd<br />
The Angry Young Men<br />
The Beat Generation<br />
Samuel Beckett : The disintegration of language<br />
From “ Waiting for Godot” Act I, II<br />
John Osborne: Existential failure<br />
From “ Look back in anger” Act I scene I<br />
Poetry<br />
Philip Larkin and the rejection of intellectualism<br />
‘ Annus Mirabilis’,<br />
‘ MCMXIV’<br />
Argomenti che si intende svolgere dopo il 15 maggio:<br />
Youth Culture and Street Style in Britain in the post-war period.<br />
56
Docente Alunni<br />
_________________ __________________________<br />
Rimini 15 /5/2011<br />
__________________________<br />
57
DOCENTE: MADDALENA LODESANI<br />
CLASSE: VBL<br />
LICEO LINGUISTICO G.CESARE-VALGIMIGLI<br />
ANNO SCOLASTICO 2010/2011<br />
Libro di testo adottato: “Kaléidoscope C” di Bonini e jamet – Valmartina Editore<br />
OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI:<br />
- approfondimento delle conoscenze della lingua e della letteratura francese<br />
- potenziamento dell’espressione orale per poter esprimere consapevolmente concetti relativi a tematiche<br />
socio-letterarie<br />
- capacità di sintesi e commento personale<br />
- capacità di analisi<br />
- riflessione culturale attraverso il confronto con la realtà e la letteratura francese<br />
METODO E STRUMENTI :<br />
approccio comunicativo attraverso lezione frontale e uso di documenti autentici; uso dei libri di testo; attività di<br />
débat; lezione aperta all’intervento degli allievi, percorso interdisciplinare con le letterature europee, la storia e<br />
la filosofia, lavori individuali di lettura, approfondimento e presentazione di un’opera integrale alla classe.<br />
METODI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:<br />
Sono state svolte 3 verifiche scritte nel primo trimestre e tre nel quadrimestre, utilizzando i testi di esame degli<br />
anni precedenti: comprensione, riassunto e analisi di un testo di letteratura o di attualità, tema su traccia,<br />
questionari di letteratura (trattazione sintetica di argomenti).<br />
CONTENUTI:<br />
- Le réalisme de Gustave Flaubert : vita e opere. Madame Bovary. Lettura e analisi dei seguenti brani<br />
antologici : « une jeune fille romanesque », « Le mirage du grand monde », « L’empoisonnement d’Emma ».<br />
L’Education sentimentale<br />
- E. Zola et le roman naturaliste : vita e opere. Lettura e analisi dei seguenti brani antologici : « Une existence<br />
impossible » (l’Assomoir), « Une masse affamée (Germinal). « J’accuse ».<br />
- La poésie de la modernité : Baudelaire et Les fleurs du mal<br />
Lettura e analisi delle seguenti poesie : : Spleen – L’invitation au voyage –– l’horloge – le parfum exotique – le<br />
jeu – l’albatros – correspondances – Au lecteur<br />
-L’école parnassienne et le symbolisme<br />
- Verlaine : Poèmes saturniens : « Mon rêve familier ». Sagesse : « le ciel est, par-dessus le toit »<br />
- Rimbaud : Les illuminations : « Aube ». Poésies : « Le dormeur du val », « Le bateau ivre »<br />
58
LE XX SIECLE : transgression et engagement<br />
- Le mouvement surréaliste<br />
- Apollinaire : Alcools : « Le pont Mirabeau », « Et combien j’en ai vu » , « Zone ».<br />
- La psychanalyse dans le roman : Marcel Proust, « A la recherche du temps perdu ». Lettura e analisi<br />
dei seguenti brani antologici : « la petite madeleine » (Du côté de chez Swann), « Le clan des<br />
Verdurin » (Un amour de Swann), « La vraie vie » (Le temps retrouvé).<br />
- Céline : Voyage au bout de la nuit lettura e analisi dei brani « Voyage vers l’Afrique », « Le travail à la<br />
chaine », « la dispute » (Voyage au bout de la nuit).<br />
- Le théâtre de l’absurde : Ionesco. Un gruppo di tre studenti ha letto e illustrato alla classe le opere :<br />
Rhinocéros, La leçon, La cantatrice Chauve (trama, analisi dei personaggi, i temi affrontati, il<br />
significato).<br />
- L’existentialisme de Camus et de Sartre<br />
- A. Camus : l’étranger (lettura integrale del romanzo) ; La peste (lettura e analisi da parte di uno<br />
studente e presentazione a tutta la classe : la trama, i personaggi, il significato).<br />
- I principi del Nouveau roman e l’opera di Marguerite Duras : Moderato cantabile<br />
- ARGOMENTI DI ATTUALITA TRATTI DAI PRINCIPALI QUOTIDIANI E SETTIMANALI<br />
FRANCESI SONO STATI AFFRONTATI DURANTE LE ORE DI COMPRESENZA<br />
- La classe, nel corso dell’anno ha letto e analizzato il romanzo di Vercors Le silence de la mer.<br />
Le insegnanti<br />
Maddalena Lodesani<br />
Christine Dinh<br />
Rimini, 10 maggio 2011<br />
59
LICEO LINGUISTICO “G. CESARE – M. VALGIMIGLI” – RIMINI<br />
CLASSE 5 B LINGUISTICO<br />
PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA TEDESCA A.S. 2010/11<br />
Prendere in mano due classi quinte di 3^ lingua che avevano cambiato insegnante, e quindi metodo ogni<br />
anno, ha significato affrontare le oggettive difficoltà di una base linguistica limitata da una preparazione solo<br />
biennale. Gran parte del breve trimestre è quindi stata dedicata al ripasso, consolidamento e completamento<br />
delle strutture morfo-sintattiche fondamentali della lingua. Successivamente a questo lavoro di natura più<br />
cognitiva, si è passati alla trattazione di alcune epoche,correnti letterarie, autori e opere.<br />
Su richiesta degli alunni è stata inserita una unità didattica su Johann Wolfgang von Goethe, allacciandosi in<br />
questo modo al programma dell’anno precedente. Altre modifiche, rispetto al programma preventivato, si sono<br />
rese necessarie per il ridotto monte ore a disposizione, causato da contingenze varie (festività, uscite didattiche,<br />
iniziative della scuola). Il programma preventivo si è rivelato troppo ricco ed articolato per i tempi a<br />
disposizione che hanno costretto a rinunciare alla trattazione dell’espressionismo e della letteratura del dopoguerra.<br />
Si è affrontato un percorso nella storia della letteratura tedesca che va dal romanticismo alla prima metà del<br />
20° secolo, privilegiando i caratteri principali dei movimenti trattati e delle opere di singoli autori. Con le scelte<br />
didattiche effettuate si è cercato di dare una visione d’insieme. Per facilitare l’apprendimento dal libro di testo,<br />
è stato, per tanti degli argomenti svolti, aggiunto del materiale elaborato dall’insegnante.<br />
In tutte le attività si è cercato di accrescere la competenza comunicativo-relazionale degli alunni attraverso<br />
un uso quasi costante della lingua 2, disincentivando una acquisizione meramente mnemonica. Il percorso fatto<br />
è indubbiamente stato impegnativo per questi studenti di 3^ lingua, sia per il carattere degli argomenti trattati,<br />
sia per la complessità lessicale ad essi correlata.<br />
In particolare l’ultima parte dell’anno è stata caratterizzata da un impegno intenso e un crescente interesse<br />
degli studenti nei confronti delle tematiche proposte, nonostante la diversità di attitudine, motivazione, impegno<br />
e profitto raggiunto.<br />
Libri di testo adottati:<br />
Grammatik direkt. Grammatica tedesca con esercizi. Giorgio Motta (Loescher editore);<br />
Leitfaden durch die deutsche Literatur. Luisa Martinelli Stelzer (ed. Bulgarini-Innocenti).<br />
Il programma svolto si è così articolato:<br />
A completamento del programma base di<br />
GRAMMATICA:<br />
-il futuro<br />
-il passivo<br />
-la frase infinitiva<br />
-la frase finale<br />
-la frase concessiva (obwohl – trotzdem – trotz)<br />
-la frase relativa<br />
60
-il congiuntivo II<br />
PROGRAMMA DI LETTERATURA:<br />
Johann Wolfgang von Goethe (su richiesta degli alunni)<br />
Biografie<br />
Die Leiden des jungen Werthers: Brief vom 16. Juli<br />
Die zeitgenössische Rezeption des Werther.<br />
Die Romantik<br />
Die theoretisch-philosophischen Grundlagen<br />
Frühromantik<br />
Novalis (Friedrich von Hardenberg) Heinrich von Ofterdingen) (stralcio)<br />
Spätromantik<br />
(Kurze Charakterisierung der literarischen Phase)<br />
Joseph Freiherr von Eichendorff Mondnacht<br />
Unterschiede zwischen Frühromantik und Spätromantik im Überblick<br />
Die Zeit der Restauration (historischer Hintergrund)<br />
(historischer Hintergrund)<br />
Das Biedermeier<br />
(Charakterisierung der literarischen Bewegung)<br />
Junges Deutschland und Vormärz<br />
(Merkmale der literarischen Strömung)<br />
Heinrich Heine (Kurzinformation zum Autor)<br />
Heinrich Heine Das Fräulein stand am Meer, Die schlesischen Weber<br />
Georg Büchner (Kurzinformation zum Autor und zum Hessischen Landboten)<br />
Der poetische oder bürgerliche Realismus<br />
(Charakteristika der literarischen Epoche)<br />
Theodor Fontane (Kurzinformation zum Autor)<br />
Theodor Fontane Effie Briest (stralci selezionati del cap. 27)<br />
Der Naturalismus<br />
(Merkmale der literarischen Bewegung)<br />
Gerhart Hauptmann (Kurzinformationen zum Autor)<br />
Gerhart Hauptmann Die Weber (stralci selezionati dall’atto 2)<br />
Realismus und Naturalismus: ein Vergleich<br />
Die Jahrhundertwende:<br />
Impressionismus<br />
(Kurzinformationen)<br />
Symbolismus<br />
(Charakterisierung der Bewegung)<br />
Stefan George (Kurzinformationen zum Autor)<br />
Stefan George Die Spange<br />
Hugo von Hofmannsthal (Kurzinformationen zum Autor)<br />
Hugo von Hofmannsthal Brief des Lord Chandos (cenno)<br />
Rainer Maria Rilke (Kurzinformationen zum Autor)<br />
61
Rainer Maria Rilke Der Panther<br />
Der Roman in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts<br />
(Ein Überblick)<br />
Thomas Mann (Kurzinformationen zum Autor) *<br />
Thomas Mann Der Tod in Venedig (stralci) *<br />
Franz Kafka (Informationen zum Autor) *<br />
Franz Kafka Gibs auf, Vor dem Gesetz *<br />
Bertolt Brecht (Kurzinformationen zum Autor) *<br />
Bertolt Brecht: das „epische“ Theater *<br />
Bertolt Brecht An die Nachgeborenen*<br />
Literatur der Nachkriegszeit<br />
Die Kurzgeschichte<br />
(Merkmale der Kurzgeschichte)<br />
Marie Luise Kaschnitz Das letzte Buch, Ein ruhiges Haus<br />
Gli argomenti contrassegnati da * sono al momento della stesura del documento ancora da svolgere<br />
Rimini, 12.05.2011<br />
L’INSEGNANTE: GLI ALUNNI:<br />
(Sigrid Kohn)<br />
<strong>Liceo</strong> <strong>Linguistico</strong> “<strong>Cesare</strong>/Valgimigli” di Rimini<br />
62
CONTENUTI DISCIPLINARI<br />
Documento del 15 maggio<br />
Anno scolastico 2010-2011<br />
<strong>Classe</strong> <strong>5B</strong>l<br />
Programma di Conversazione in lingua straniera Tedesco<br />
Docente: Bärbel Irma Müller<br />
„Der Schimmelreiter“ Cideb Editore Lesen und Üben, Niveau 3/B1, Zusammenfassung der einzelnen Kapitel,<br />
Nordfriesland, das Leben auf den Halligen; als weiterführendes Thema „Wie abergläubisch sind Sie“; Was bringt<br />
Glück – was Unglück?<br />
Mobbing: LV „Es reicht“ aus „Erzählungen – racconti di vite“ mit Multiple-Choise-Übung zum Wortschatz, Fragen<br />
zum Text und weiterführende Fragen zum Thema „Mobbing“<br />
Thema „Armut“: Wird der soziale Abstieg zur Normalität in Deutschland, Kluft zwischen Arm und Reich; „Hartz<br />
IV: Leben am Existenzminimum“; „Die Deutschen Tafeln – Wir übernehmen die Aufgaben des Staates“<br />
Deutsche Geschichte: Versailler Vertrag, Weimarer Republik, der Weg zur Nazi-Diktatur, die Nürnberger<br />
Gesetze, Das Dritte Reich und der Zweite Weltkrieg, Gründung der BRD und DDR.<br />
Da svolgere nel mese di Maggio e Giugno:<br />
BRD und DDR im Vergleich, von der Teilung bis zur Deutschen Einheit, „Wessis=Ossis“?<br />
Rimini, 13 Maggio 2011<br />
Bärbel Irma Müller<br />
63
<strong>Liceo</strong> “G. <strong>Cesare</strong> – M. Valgimigli” - Rimini<br />
____________________________________________________________________________<br />
<strong>Classico</strong> – <strong>Linguistico</strong> – Scienze Umane – Scienze Umane/Economico Sociali<br />
LICEO CLASSICO G. CESARE-M. VALGIMIGLI<br />
LICEO LINGUISTICO<br />
PROGRAMMAZIONE DELLA PROF.essa BORZI MARIA<br />
CONTENUTI EFFETIVAMENTE SVOLTI<br />
ANNO SCOLASTICO 2010-2011<br />
DISCIPLINA:FILOSOFIA<br />
CLASSE <strong>5B</strong><br />
Modulo1<br />
Il problema conoscitivo:<br />
La filosofia di G. W. Hegel e l’apogeo del soggetto; il sistema; l’identità di reale e razionale; la dialettica;la filosofia della storia .<br />
Il problema conoscitivo in I. Kant; l’impianto teorico della “Critica della ragion pura”.<br />
Il problema etico nella “Critica della ragion pratica”.<br />
Modulo 2<br />
Filosofia e politica:<br />
La filosofia come praxis rivoluzionaria : il pensiero di K.Marx; l’influenza hegeliana; il materialismo storico.<br />
Modulo 3 :<br />
La crisi dei paradigmi occidentali:<br />
Il pensiero di F. Nietzsche; la morte di Dio e dei valori ; la teoria dell’oltreuomo;<br />
la filosofia di A.Schopenhauer e S. Kierkegaard.<br />
Modulo 4<br />
La frantumazione dell’io e la crisi del soggetto e della metafisica : S. Freud e la psicanalisi : “Lettura di “Psicopatologia della vita<br />
quotidiana.”<br />
Filosofia ed etica.<br />
Modulo 5<br />
Il pensiero di J.P Sartre : Lettura di “L’esistenzialismo è un umanesimo”.<br />
Metodi e strumenti :<br />
Lezione frontale, dibattiti, lavori di gruppo verifiche.<br />
Libro di testo : M. De Bartolomeo V. Magni “ I sentieri della ragione” ed. Atlas.<br />
Testo in uso : M. De Bartolomeo V. Magni “I sentieri della ragione” ed.Atlas.<br />
Rimini 11/05/11<br />
Firma_________<br />
64
• CLASSE VB liceo <strong>Linguistico</strong><br />
• MATERIA: Storia dell’arte<br />
• DOCENTE: Davide Pazzaglia<br />
• Testo in adozione<br />
<strong>Liceo</strong> “G. <strong>Cesare</strong> – M. Valgimigli” - Rimini<br />
<strong>Classico</strong> – Formazione – Sociale – <strong>Linguistico</strong><br />
Anno scolastico 2010 / 2011<br />
PROGRAMMA SVOLTO<br />
• ARTI VISIVE 3A ATLAS edizioni<br />
Prof. Davide Pazzaglia – Storia dell’arte – classe VAL<br />
Programma svolto<br />
_________________________________________<br />
Nello svolgimento del programma si sono privilegiati i caratteri principali delle epoche trattate e delle poetiche dei singoli autori. Si è<br />
scelta una trattazione sintetica per permettere ai discenti di orientarsi correttamente tra gli autori, le correnti artistiche, confrontandole,<br />
quando possibile, per evidenziare analogie e differenze. Per mantenere fede a tali obiettivi mai si è scesi in una trattazione<br />
nozionistica. Si sono invece privilegiati, attraverso riflessioni e discussioni in classe, la comprensione delle problematiche artistiche<br />
nella loro progressione storica e le ragioni poetiche dei singoli artisti.<br />
Di seguito l’elenco delle epoche, degli autori, delle correnti, delle opere e dei nuclei tematici svolti.<br />
Ragione e forma<br />
DALLA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE ALLA RIVOLUZIONE FRANCESE<br />
L'ILLUMINISMO<br />
«Abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza». L’ Encyclopèdie. L’autonomia dell’arte.<br />
IL NEOCLASSICISMO<br />
«Una nobile semplicità e una quieta grandezza», Winckelmann e l’antico.<br />
ANTONIO CANOVA<br />
La bellezza ideale, i sepolcri.<br />
Amore e Psiche; Paolina Borghese: Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria<br />
JACQUES-LOUIS DAVID<br />
La pittura epico-celebrativa al servizio della Rivoluzione e poi dell’Imperatore.<br />
La morte di Marat<br />
Impeto e tempesta<br />
L'EUROPA DELLA RESTAURAZIONE<br />
IL ROMANTICISMO<br />
Genio e sregolatezza. L’individualità nazionale. Il paesaggio come specchio dell’anima. Il sublime.<br />
NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO<br />
I due volti dell'Europa borghese tra Settecento e Ottocento. Dalla regola al sentimento. Il rapporto con il passato, il rapporto con la<br />
natura.<br />
THÉODORE GÉRICAULT<br />
«Se gli ostacoli e le difficoltà scoraggiano un uomo mediocre, al contrario al genio sono necessari». L’uomo al limite della sua<br />
umanità. I Salons.<br />
65
IL REALISMO<br />
La zattera della Medusa<br />
EUGÈNE DELACROIX<br />
L’arte nel proprio tempo, tra suggestioni del passato e ideali romantici.<br />
La Libertà che guida il popolo<br />
GUSTAVE COURBET<br />
La poetica del vero, lo scandalo del Realismo.<br />
Fanciulle sulle rive della Senna; L’atelier del pittore<br />
GIOVANNI FATTORI<br />
La poetica della “macchia”, Diego Martelli e il Caffè Michelangelo, il ruolo marginale dell’Italia nel dibattito artistico dell‘800<br />
Soldati francesi del ’59; la rotonda di Palmieri<br />
La rivoluzione del colore<br />
LA STAGIONE DELL'IMPRESSIONISMO<br />
L'IMPRESSIONISMO<br />
La rivoluzione dell'attimo fuggente. La giustapposizione cromatica, la luce, la pittura en plein air, i soggetti moderni, le stampe<br />
giapponesi.<br />
LA FOTOGRAFIA<br />
L'invenzione del secolo. Lo strumento che costringe la pittura a ridefinire se stessa.<br />
EDOUARD MANET<br />
La nuova pittura e lo scandalo della verità. La pittura d’atelier.<br />
La colazione sull’erba; Olympia; Il bar delle Folies-Bergères<br />
CLAUDE MONET<br />
La pittura delle impressioni, la luce nel suo divenire.<br />
Impressione, sole nascente; La cattedrale di Rouen<br />
EDGAR DEGAS<br />
La sintesi visiva attraverso il disegno e la memoria. Il taglio fotografico.<br />
Le stiratrici; Ballerine sulla scena<br />
AUGUSTE RENOIR<br />
La gioia di vivere. La mobilità della luce e gli svaghi nella Parigi degli impressionisti<br />
Moulin de la Galette; Bagnanti<br />
ALLA RICERCA DI NUOVE VIE<br />
TENDENZE POST-IMPRESSIONISTE<br />
Il superamento della superficialità dell’impressionismo<br />
PAUL CÉZANNE<br />
«Trattare la natura secondo il cilindro, la sfera e il cono». La rappresentazione dello spazio senza prospettiva geometrica.<br />
La casa dell’impiccato a Ouvers-sur-Oise; La montagna Sainte-Victoire.<br />
GEORGES SEURAT<br />
Il Neoimpressionismo o Impressionismo scientifico o cromo-luminismo o Pointillisme o Divisionismo<br />
Un dimanche après-midi à l’Île de la Grande Jatte<br />
PAUL GAUGUIN<br />
Una visione antinaturalista: la ricerca di un’espressività primitiva.<br />
Il Cristo giallo; Da dove veniamo? Chi siamo? Dove Andiamo?<br />
VINCENT VAN GOGH<br />
«Se un quadro di contadini sa di pancetta, fumo, vapori... va bene, non è malsano». Il colore come espressione interiore.<br />
I mangiatori di patate; Autoritratto con cappello di feltro grigio<br />
LA NUOVA ARCHITETTURA DEL FERRO<br />
La rivoluzione dell’acciaio e del vetro, le esposizioni universali.<br />
66
J. Paxton, Il palazzo di cristallo; G.A. Eiffel, Torre Eiffel<br />
Il tramonto delle certezze<br />
VERSO IL CROLLO DEGLI IMPERI CENTRALI<br />
L'EUROPA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO, DALLA BELLE ÉPOQUE ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE<br />
I PRESUPPOSTI DELL'ART NOUVEAU<br />
La «Arts and Crafts Exhibition Society» di William Morris<br />
ART NOUVEAU<br />
Il nuovo gusto borghese. Caratteri generali.<br />
GUSTAV KLIMT<br />
La secessione. Oro, linea, colore. Arte e decorativismo tra eros e thanatos.<br />
La giovinezza; Giuditta I; Danae<br />
FAUVES E HENRI MATISSE<br />
Il colore sbattuto in faccia. L’espressività pura del colore e della linea.<br />
La stanza rossa<br />
L'ESPRESSIONISMO<br />
L'esasperazione della forma. Impressione ed espressione.<br />
EDVARD MUNCH<br />
Il grido della disperazione. L’angoscia dell’uomo di fronte alla morte.<br />
La fanciulla malata; Il grido<br />
JAMES ENSOR<br />
Una voce contro l’ipocrisia<br />
L’ingresso di Cristo a Bruxelles<br />
ERNST LUDWIG KIRCHNER<br />
Il gruppo Die brücke «Una fune sopra un abisso». L’angoscia dell’uomo nella città. Il rapporto con la natura.<br />
Cinque donne per la strada<br />
L'INIZIO DELL'ARTE CONTEMPORANEA<br />
IL CUBISMO<br />
IL NOVECENTO DELLE AVANGUARDIE STORICHE<br />
Un secolo di grandi speranze e di straordinarie delusioni.<br />
IL CUBISMO<br />
Cézanne, l’arte primitiva, la nuova rappresentazione spaziale. Fase analitica e sintetica.<br />
Lo stabilimento “Rio Tinto” all’Estaque di Georges Braque<br />
PABLO PICASSO<br />
Il grande patriarca del Novecento. Il periodo Blu e Rosa.<br />
Poveri in riva al mare; Fabbrica; Les demoiselles d’Avignon; Natura morta con sedia impagliata; Guernica.<br />
GEORGES BRAQUE<br />
Lo sguardo analitico e il lirismo.<br />
Il portoghese, suonatore di fisarmonica.<br />
Dopo il 15 maggio se possibile si svilupperanno le seguenti tematiche:<br />
L'estetica dello schiaffo<br />
LA STAGIONE ITALIANA DEL FUTURISMO<br />
ZANG TUMB TUMB<br />
Filippo Tommaso Marinetti e l'estetica futurista. Il Manifesto.<br />
UMBERTO BOCCIONI<br />
Il rapporto con il divisionismo, linee-forza, dinamismo e simultaneità. La pittura degli stati d'animo<br />
La città che sale; Forme uniche della continuità nello spazio<br />
ANTONIO SANT'ELIA<br />
Le architetture impossibili, la città nuova.<br />
67
LA RICOSTRUZIONE FUTURISTA DELL'UNIVERSO<br />
Dall’arte meccanica all’aeropittura<br />
L’ARTE TRA PROVOCAZIONE E SOGNO<br />
“Bello come l’incontro casuale di una macchina per cucire e di un ombrello su un tavolo operatorio”<br />
DADA<br />
Il Dadaismo e la guerra. Arte come provocazione. Il nonsenso e l’ironia.<br />
MARCEL DUCHAMP<br />
Il ready-made, il ready-made rettificato. L’arte come atto concettuale.<br />
Fontana; LHOOQ.<br />
Rimini 15 maggio 2011<br />
I rappresentanti della classe il docente<br />
68
LICEO LINGUISTICO “G.CESARE - M.VALGIMIGLI” - RIMINI<br />
PROGRAMMA DI MATEMATICA SVOLTO NELLA CLASSE V Al<br />
Prof. Binotti Stefania A.S. 2010/11<br />
Testo adottato:<br />
Dodero, Barboncini, Manfredi – “Lineamenti di matematica” – Ghisetti e Corvi<br />
All'inizio dell'anno è stato effettuato un breve ripasso delle funzioni esponenziale e logaritmica e delle<br />
principali funzioni goniometriche studiate nella classe quarta.<br />
Lo studio dell’analisi infinitesimale si è articolato attraverso i seguenti contenuti:<br />
• Insiemi numerici; intervalli; intorni.<br />
• Funzioni: definizione e terminologia. Classificazione delle funzioni matematiche.<br />
• Limiti e continuità delle funzioni: definizioni di limiti, teoremi generali sui limiti (unicità e permanenza del<br />
segno); funzioni continue.<br />
• Teoremi sul calcolo dei limiti e forme indeterminate.<br />
• Funzioni continue: discontinuità, proprietà delle funzioni continue.<br />
• Derivata di una funzione: definizioni e nozioni fondamentali; derivate fondamentali; teoremi sul calcolo<br />
delle derivate; derivata di una funzione di funzione e di una funzione inversa. Regola di De L’Hospital.<br />
• Significato geometrico della derivata.<br />
• Teorema di Lagrange; funzioni crescenti e decrescenti; definizione di punti di massimo, di minimo e di<br />
flesso; ricerca dei punti stazionari con la derivata prima; concavità e ricerca dei flessi; tangente<br />
inflessionale.<br />
• Asintoti orizzontali, verticali e obliqui.<br />
• Studio di funzioni.<br />
• Cenni alle applicazioni del concetto di derivata in fisica: velocità e accelerazione istantanee; intensità di<br />
corrente; forza elettromotrice indotta.<br />
I teoremi sono stati solo enunciati. I vari argomenti sono stati introdotti dapprima in maniera intuitiva, con la<br />
presentazione di esempi appropriati e facendo seguire solo in un secondo momento la formulazione rigorosa. Le<br />
applicazioni sono state di modesto livello di difficoltà, valorizzando maggiormente gli aspetti concettuali<br />
piuttosto che la complessità del calcolo.<br />
RAPPRESENTANTI DI CLASSE DOCENTE<br />
69
LICEO LINGUISTICO “G.CESARE - M.VALGIMIGLI” - RIMINI<br />
PROGRAMMA DI FISICA SVOLTO NELLA CLASSE V Al<br />
Prof. Binotti Stefania A.S. 2010/11<br />
Testo adottato: U. Amaldi – “Corso di fisica”- Zanichelli<br />
Rispetto al programma preventivato non è stata effettuata la trattazione di argomenti di fisica moderna:<br />
piuttosto che accennarvi in maniera affrettata e superficiale ho preferito consolidare lo studio<br />
dell'elettromagnetismo attraverso la sintesi fornita dalle equazioni di Maxwell.<br />
La trattazione dell'elettromagnetismo si è articolata attraverso i seguenti contenuti:<br />
• carica elettrica, elettrizzazione, isolanti e conduttori: legge di Coulomb nel vuoto e in un dielettrico;<br />
distribuzione della carica sulla superficie di un conduttore<br />
• campo elettrico: vettore campo elettrico, campo di una carica puntiforme, di due cariche, di una<br />
distribuzione uniforme di cariche, rappresentazione mediante linee di campo; flusso del campo elettrico e<br />
teorema di Gauss; lavoro del campo elettrico, energia potenziale elettrica, potenziale elettrico, potenziale di<br />
un conduttore sferico; circuitazione del campo elettrico; capacità di un conduttore; condensatori, capacità<br />
di un condensatore<br />
• corrente elettrica continua: conduzione nei solidi, intensità di corrente, circuito elementare; leggi di Ohm;<br />
forza elettromotrice; effetto Joule<br />
• conduzione elettrica nei liquidi: soluzioni elettrolitiche; pila di Volta<br />
• fenomeni magnetici fondamentali: interazioni tra magneti; campo magnetico; interazioni corrente-magnete<br />
e interazione tra correnti<br />
• forza esercitata su un filo percorso da corrente e intensità del campo magnetico; campo magnetico generato<br />
da un filo rettilineo, da una spira, da un solenoide<br />
• forza di Lorentz; moto di una carica elettrica in un campo magnetico uniforme<br />
• flusso di B e teorema di Gauss per il magnetismo; circuitazione di B e teorema di Ampère<br />
• induzione elettromagnetica: esperienze sulle correnti indotte; forza elettromotrice indotta; legge di Faraday-<br />
Neumann; legge di Lenz<br />
• campo elettrico indotto e sua circuitazione; corrente di spostamento; equazioni di Maxwell.<br />
RAPPRESENTANTI DI CLASSE DOCENTE<br />
70
PROGRAMMA DI SCIENZE<br />
SVOLTO NELL’ ANNO SCOLASTICO 2010/11<br />
CLASSE V BL<br />
TESTO ADOTTATO : Campbell Recce Taylor Simon<br />
Volume C D seconda edizione Zanichelli<br />
Capitolo 15 STRUTTURE E FUNZIONI DEGLI ANIMALI<br />
Gli animali sono dotati di un’organizzazione strutturale gerarchica . I tessuti sono gruppi di cellule<br />
con struttura e funzioni comuni. Tessuto epiteliale .tessuto connettivo. Tessuto muscolare. Tessuto<br />
nervoso .Gli organi sono formati da tessuti. Gli animali regolano il proprio ambiente interno.<br />
L’omeostasi è regolata da meccanismi di feedback negativo.<br />
Capitolo 16 L’ALIMENTAZIONE E LADIGESTIONE<br />
Il sistema digerente umano. La cavità orale, la faringe l’esofago lo stomaco .Intestino tenue e<br />
intestino crasso, fegato e pancreas .Demolizione meccanica e chimica degli alimenti. L’assorbimento<br />
dei prodotti della digestione.<br />
Capitolo 17 LA RESPIRAZIONE E GLI SCAMBI GASSOSI<br />
Gli animali scambiano ossigeno e anidride carbonica attraverso superfici corporee umide. Nei<br />
vertebrati lo scambio dei gas avviene in tre fasi. Lo scambio gassoso in ambiente acquatico: lo<br />
scambio controcorrente. Il sistema respiratorio umano. La ventilazione polmonare. Il controllo della<br />
respirazione polmonare. Scambi gassosi fra sangue e tessuti. L’emoglobina e il trasporto di ossigeno<br />
e anidride carbonica e la regolazione del pH.<br />
Capitolo 18 IL SANGUE E LA CIRCOLAZIONE<br />
Il sistema cardiovascolare umano. La struttura dei vasi sanguigni. Il ciclo cardiaco. La regolazione del<br />
battito cardiaco. Pressione e velocità del sangue nei vasi sanguigni. Il controllo della distribuzione del<br />
sangue. Scambio di sostanze fra sangue e liquido interstiziale. Composizione e proprietà del sangue.<br />
La coagulazione del sangue.<br />
Capitolo 19 IL SISTEMA IMMUNITARIO<br />
Difese innate contro le infezioni. La risposta infiammatoria. Il sistema linfatico. La risposta<br />
immunitaria. Selezione clonale dei linfociti B nella risposta immunitaria. Come gli anticorpi<br />
distruggono gli antigeni. Il sistema immunitario e le nostre “impronte” molecolari. I linfociti T helper<br />
organizzano la difesa mediata da cellule e favoriscono l’immunità umorale. I linfociti T citotossici e le<br />
cellule infette. Le allergie disturbi determinati dallo scorretto funzionamento del sistema immunitario.<br />
71
Capitolo 20 IL CONTROLLO DELL’AMBIENTE INTERNO<br />
La termoregolazione e gli adattamenti che bilanciano l’assorbimento e la perdita di calore. Come gli<br />
animali eliminano le sostanze azotate. Il sistema escretore umano. Le funzioni di base del sistema<br />
escretore . Il processo di trasformazione del filtrato in urina.<br />
Capitolo 21 Il SISTEMA ENDOCRINO<br />
I messaggeri chimici . Come agiscono gli ormoni sulle cellule bersaglio. Ipotalamo e ipofisi. Gli<br />
ormoni prodotti dalla tiroide e dalle paratiroidi regolano l’omeostasi del calcio. Il pancreas e la<br />
regolazione del glucosio nel sangue. Le gonadi e gli ormoni sessuali .Le ghiandole surrenali e la<br />
risposta corporea allo stress.<br />
Capitolo 22 LA RIPRODUZIONE<br />
Anatomia del sistema riproduttore femminile. Anatomia del sistema riproduttore maschile.<br />
Spermatogenesi e oogenesi. Ciclo ovario e ciclo mestruale.<br />
Capitolo 23 IL SISTEMA NERVOSO<br />
Struttura e funzione del sistema nervoso. I neuroni le unità funzionali del sistema nervoso. Il<br />
potenziale di riposo e il suo mantenimento. In che modo si genera e si propaga il potenziale d’azione.<br />
Le sinapsi. Sinapsi elettrica e sinapsi chimica. La funzione dei neurotrasmettitori. Sistema nervoso<br />
centrale e sistema nervoso periferico. L’encefalo umano. La corteccia cerebrale . Regolazione del<br />
sonno e della veglia.<br />
Capitolo 25 IL SISTEMA SCHELETRICO<br />
Lo scheletro umano . Le articolazioni.<br />
Meccanismo di contrazione del muscolo scheletrico, filamenti di actina e miosina. I neuroni motori<br />
stimolano la contrazione muscolare.<br />
Nello svolgimento del programma si è cercato di trattare i vari apparati non solo dal punto di vista<br />
anatomico ma anche fisiologico, benché in modo semplice,dando così agli studenti la possibilità di<br />
comprendere meglio le relazioni fra struttura e funzione. A questo proposito è stato di grande utilità<br />
l’apparato iconografico del testo, il cui uso è stato permesso ai ragazzi anche durante le verifiche<br />
orali. Le verifiche sono state sia scritte che orali dato l’esiguo numero di ore settimanali e la vastità<br />
del programma da svolgere. Nel corso dell’anno la classe ha dimostrato nel complesso interesse per<br />
questa disciplina, partecipando alle lezioni in maniera costruttiva.<br />
Rimini li 15 maggio 20011 Professoressa<br />
Brunella Renzi<br />
Gli studenti<br />
72
PROGRAMMA E RELAZIONE FINALE PER MATERIA<br />
ANNO SCOLASTICO 2010/11<br />
MATERIA D’INSEGNAMENTO: EDUCAZIONE FISICA<br />
CLASSE:5°B liceo linguistico<br />
PROF:Bertozzi Alberto<br />
ORE ANNUALI D’INSEGNAMENTO: 58<br />
OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA:<br />
Potenziamento fisiologico. Miglioramento delle grandi funzioni organiche e delle qualità fisiche.<br />
Rielaborazione degli schemi motori: accomodamento psico-fisico e psico-motorio. Consolidamento del<br />
carattere, sviluppo della socialità. Conoscenza e pratica delle attività sportive come mezzo di difesa della salute<br />
e come veicolo di socializzazione. Informazioni sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli infortuni.<br />
OBIETTIVI RAGGIUNTI:<br />
Gli obiettivi sono stati completamente raggiunti, improntando le attività in base alle esigenze motorie dei/delle<br />
ragazzi/e , molti/e dei/delle quali non svolgono attività fisica organizzata, per cui gli esercizi più usati sono stati<br />
quelli a corpo libero , con l’uso di piccoli attrezzi(palloni, elastici e piccoli pesi)) e con l’ausilio della musica<br />
(aerobica);il tutto consente una partecipazione globale da parte di tutte le/gli alunne/i. Particolare attenzione è<br />
stata rivolta ai giochi sportivi come elementi di socializzazione e collaborazione fra gli/ le allievi/e.<br />
METODI E MEZZI:<br />
Si è utilizzato il metodo globale soprattutto nelle attività di approccio, ove non si pretende l’acquisizione di una<br />
capacità tecnica particolarmente fine; si è usato il metodo analitico per quei compiti ove è necessario acquistare<br />
una capacità psico-motoria che permetta la padronanza dei movimenti più difficoltosi. Si sono proposte<br />
situazioni motorie che portano le/gli allieve/i alla comprensione ed alla scoperta di se stesse/i, del proprio corpo<br />
e delle proprie capacità, in modo che l’apprendimento è diventato padronanza mentale del singolo, quindi<br />
conquista e non semplice riproduzione di esperienze già note..<br />
STRUMENTI DI VERIFICA:<br />
Le verifiche hanno tenuto conto dei risultati raggiunti in relazione ai punti di partenza,e dell’impegno<br />
personale, della costanza nell‘applicazione, della capacità di apprendimento e delle caratteristiche<br />
antropometriche delle/dei ragazze/i.<br />
CRITERI PER LA VALUTAZIONE:<br />
E stata valutata la conoscenza delle varie discipline sportive, la partecipazione, la costanza dell’applicazione; il<br />
senso di responsabilità nel lavoro in palestra.<br />
CONTENUTI DISCIPLINARI:<br />
Lavoro in aerobia ed anaerobia.<br />
Lavoro sulla trasmissione neuro-muscolare.<br />
73
Esercizi di mobilizzazione articolare e allungamento muscolare.<br />
Esercizi di trofismo muscolare a carico naturale e con sovraccarico.<br />
Esercizi di rilassamento neuro-muscolare.<br />
Lavoro di abilità psico-motoria<br />
Giochi ed attività sportiva: conoscenza delle regole di gioco, fondamentali individuali collettivi con o senza<br />
palla del basket, pallavolo, pallamano, baseball,calcetto, badminton e freesbe.<br />
Esercitazioni atte ad affinare la tecnica di movimento e la tattica nelle varie situazioni motorie, con l’intento di<br />
raggiungere quei meccanismi neuro muscolari utili ad arricchire il proprio bagaglio psico-motorio.<br />
RIMINI, 14/05/2011 Prof. Bertozzi Alberto<br />
74