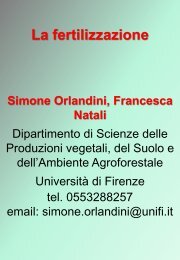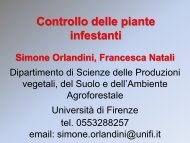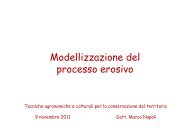(Microsoft PowerPoint - LMFOR 04\) parametri agrometeorologici ...
(Microsoft PowerPoint - LMFOR 04\) parametri agrometeorologici ...
(Microsoft PowerPoint - LMFOR 04\) parametri agrometeorologici ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
I <strong>parametri</strong> <strong>agrometeorologici</strong><br />
e gli strumenti di misura<br />
seconda parte (precipitazioni,<br />
evapotraspirazione, vento)<br />
Simone Orlandini<br />
Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali, del Suolo<br />
e dell’Ambiente Agroforestale - Università di Firenze
Precipitazioni<br />
o Le precipitazione possono essere classificate in relazione allo stato<br />
fisico dell'acqua ed alle dimensioni delle singole particelle in: rugiada,<br />
brina, pioviggine, pioggia, neve, nevischio, grandine e nebbia.<br />
o Le precipitazioni sono la conseguenza della presenza di nubi, che a loro<br />
volta dipendono dalla circolazione generale dell’atmosfera e<br />
dall'interazione delle masse d’aria con la superficie della terra e con<br />
quella del mare. La loro distribuzione durante l’anno è funzione della<br />
zona climatica e varia grandemente da una regione all’altra. Anche la<br />
variazione tra un anno e l’altro, per uno stesso periodo (variabilità<br />
interannuale), può essere assai marcata.<br />
o Oltre al valore cumulato di pioggia, per un ogni singolo evento, si può<br />
anche misurare l’intensità, che viene espressa in mm h-1. Nei riepiloghi<br />
giornalieri si riporta il solo valore totale, mentre nei riepiloghi mensili,<br />
oltre al valore totale, si riporta anche il numero di giorni nei quali si è<br />
verificata la pioggia.<br />
o Importante considerare anche la frequenza, la durata ed i tempi di<br />
ritorno che permettono di quantificare la probabilità che un certo<br />
evento si ripeta nel tempo in una data località.
Classificazione<br />
delle<br />
precipitazioni
Caratteristiche delle piogge: la quantità<br />
o Si esprime in millimetri di acqua caduta nell’intervallo di<br />
tempo pari alla durata dell’evento.<br />
o In media cadono su tutta la terra 1.000 mm di acqua,<br />
ma vi sono zone dove si raggiungono i 12.000 mm ed<br />
altre dove non piove mai.<br />
o In Italia varia da 2.500-3.000 mm nelle Alpi orientali e<br />
nelle Apuane, a meno di 500 mm nel Tavoliere pugliese,<br />
nelle coste sud-occidentali della Sicilia ed in provincia<br />
di Cagliari.<br />
o La quantità consente solo una stima grossolana delle<br />
potenzialità agricole di una area, in quanto altri<br />
<strong>parametri</strong> influiscono sulla sua capacità di soddisfare le<br />
esigenze evapotraspirative della coltura.
Caratteristiche delle piogge: l’intensità<br />
o E’ espressa in quantità nell’unità di tempo (mm h -1 ).<br />
o Ha grande importanza in idrologia per la previsione<br />
delle piene e nel campo della conservazione del suolo in<br />
quanto il fenomeno del ruscellamento in collina o del<br />
ristagno in pianura si verificano quando l’intensità è<br />
superiore alla velocità di infiltrazione nel terreno.<br />
o Le piogge intense hanno quindi una efficacia molto<br />
limitata e possono provocare gravi danni alla<br />
conservazione del suolo ed anche alle colture (asfissia<br />
radicale, etc.)<br />
o Dall’intensità dipende l’erosività, cioè la capacità di una<br />
pioggia di provocare erosione.<br />
o La maggiore efficacia si ha con piogge di leggera<br />
intensità, attorno ai 2 mm h -1
Distribuzione stagionale delle<br />
precipitazioni
Regime<br />
pluviometrico in<br />
Italia<br />
1<br />
3<br />
5<br />
2<br />
4
La pioggia utile<br />
o La determinazione della pioggia utile presenta<br />
numerose difficoltà legate al fatto che l'efficacia<br />
dell'evento piovoso varia in funzione:<br />
o della quantità di acqua precipitata<br />
o della sua intensità<br />
o delle caratteristiche del terreno<br />
o Nel quaderno FAO n. 25 sono riportati diversi metodi<br />
empirici, formule e relazioni semi-empiriche ed<br />
empiriche per la stima delle piogge efficaci.
La misura<br />
o La pioggia viene misurata in millimetri, che esrpimono lo<br />
spessore che raggiungerebbe l’acqua caduta se si<br />
depositasse su di una superficie piana, impermeabile e<br />
senza evaporazione.<br />
o Si ottiene quindi una misura unidimensionale, non riferita a<br />
nessuna unità di superficie.<br />
o Si precisa che:<br />
1 mm di pioggia corrisponde a 1 l m-2 ed a 10 m3 ha-1
Pluviometro Totalizzatore<br />
o E’ costituito da un<br />
contenitore (che può<br />
avere forma e<br />
dimensioni variabili)<br />
con una bocca tarata<br />
o Sulle pareti è<br />
segnata una scala per<br />
la lettura diretta<br />
della quantità di<br />
pioggia caduta<br />
o In altri tipi insieme<br />
al contenitore è<br />
fornito un recipiente<br />
graduato in cui<br />
versare l’acqua<br />
raccolta
• Il contenitore può<br />
avere dimensioni<br />
variabili<br />
• Il sistema di<br />
raccolta è simile a<br />
quello del<br />
pluviografo<br />
• Il sensore è un<br />
piccolo interruttore<br />
magnetico che a ogni<br />
movimento delle<br />
vaschette invia un<br />
impulso al sistema di<br />
acquisizione<br />
Pluviometro
La grandine<br />
o La grandine è considerare una idrometeora<br />
estremamente dannosa. Apporta infatti pochissima<br />
acqua al terreno, provocando al contempo ingenti danni<br />
a seguito dell’impatto del chicco con la vegetazione.<br />
o E’ particolarmente frequente nei mesi primaverili<br />
estivi, quando può compromettere completamente la<br />
produzione.<br />
o E’ il risultato della condensazione di acqua negli elevati<br />
strati dell’atmosfera con temperature di molti gradi<br />
sotto lo zero, attorno a nuclei di condensazione<br />
generalmente costituti da pulviscolo atmosferico. Ogni<br />
granulo può permettere la formazione di un chicco di<br />
grandine che sotto l’azione della forza di gravità cade<br />
al suolo.<br />
o Un elevato numero di nuclei permette la formazione di<br />
molti chicchi di piccole dimensioni che non determinano<br />
danni alla vegetazione
La grandine<br />
o La grandine è considerare una idrometeora estremamente<br />
dannosa. Apporta infatti pochissima acqua al terreno,<br />
provocando al contempo ingenti danni a seguito<br />
dell’impatto del chicco con la vegetazione.<br />
o E’ particolarmente frequente nei mesi primaverili estivi,<br />
quando può compromettere completamente la produzione.<br />
o E’ il risultato della condensazione di acqua negli elevati<br />
strati dell’atmosfera con temperature di molti gradi sotto<br />
lo zero, attorno a nuclei di condensazione generalmente<br />
costituti da pulviscolo atmosferico. Ogni granulo può<br />
permettere la formazione di un chicco di grandine che<br />
sotto l’azione della forza di gravità cade al suolo.<br />
o Un elevato numero di nuclei permette la formazione di<br />
molti chicchi di piccole dimensioni che non determinano<br />
danni alla vegetazione
Evaporazione ed evapotraspirazione<br />
o L’evaporazione consiste nel passaggio dell’acqua dallo stato liquido allo<br />
stato di vapore. In natura l'entità di tale fenomeno dipende dalle<br />
condizioni fisiche dell’ambiente (radiazione, temperatura, umidità, vento) e<br />
dalla disponibilità d'acqua, che può essere a "pelo libero" (mari, laghi, fiumi<br />
ecc.) o trattenuta in mezzo poroso (terreno e superfici varie).<br />
o La traspirazione consiste nel passaggio dell’acqua contenuta negli<br />
organismi (piante ed animali) dallo stato liquido allo stato di vapore. Tale<br />
processo è regolato sia dalle condizioni dell’atmosfera sia da una serie di<br />
meccanismi biologici (apertura-chiusura di stomi, pori cutanei, etc) che<br />
tendono a mantenere gli organismi nelle condizioni migliori di idratazione.<br />
o L’evapotraspirazione (ET) è l’effetto cumulato dell'evaporazione dalla<br />
superficie bagnata, terreno e foglie, e della traspirazione d'acqua dalle<br />
piante presenti su tale terreno.
Evaporazione ed evapotraspirazione (cont.)<br />
o Quando ci si riferisce ad una superficie coperta da una coltura od in<br />
genere da vegetazione sarebbe estremamente difficile distinguere le<br />
due componenti ed il fenomeno viene considerato nel suo insieme.<br />
o Sia l’evaporazione che la traspirazione sono funzione della quantità<br />
d'energia che arriva alla superficie (radiazione solare), delle condizioni<br />
dell’atmosfera (temperatura, umidità dell’aria , vento) e della<br />
disponibilità d'acqua. L'ET segue l’andamento della radiazione solare e<br />
della temperatura, sia nel corso del giorno che durante l'arco<br />
dell'anno.<br />
o L’evapotraspirazione è una componente essenziale del bilancio idrico e<br />
viene utilizzata in combinazione con le precipitazioni per la<br />
programmazione dell'irrigazione delle colture agrarie. A livello di<br />
bacino l'ETR è impiegata per calcolare la perdita d'acqua, per stimare<br />
le portate dei corsi d’acqua, per la progettazione dei bacini artificiali.<br />
Nei modelli di produzione delle colture agrarie è impiegata come<br />
elemento di base per il calcolo dei rendimenti.
Evapotraspirazione potenziale<br />
o L'evapotrapirazione potenziale (ETP) rappresenta la quantità d'acqua<br />
dispersa nell'atmosfera da una superficie di riferimento, quando l'acqua<br />
non costituisce un fattore limitante. Ne consegue che le sole variabili<br />
considerate sono quelle atmosferiche e, pertanto, può essere utilizzata<br />
come indice ambientale.<br />
o Per la stima della ETP possono essere applicate numerose formule a<br />
partire dai dati meteorologici di comune reperibilità Tali formule possono<br />
avere sia carattere empirico, che essere basate sul processo fisico della<br />
evapotraspirazione.<br />
o Nella pratica, poiché la misura diretta della ET è assai complessa, si<br />
ricorre al calcolo giornaliero della ETP e, con l’applicazione di coefficienti<br />
che tengano conto del tipo di coltura, si stima l'ETP delle colture<br />
ETP coltura = ETP riferimento X Kc<br />
o L’obiettivo dell’irrigazione è quindi quello di apportare acqua affinché i<br />
valori di ETP coltura ed ETR siano uguali, evitando così alla coltura di<br />
incorrere in periodi di stress idrico.
I periodi in<br />
cui la<br />
quantità di<br />
pioggia è<br />
uguale o<br />
superiore<br />
all’ETP sono<br />
considerati<br />
periodi<br />
umidi,<br />
mentre gli<br />
altri periodi<br />
di deficit<br />
idrico.<br />
Stagione di crescita<br />
La FAO definisce periodo utile per la crescita quello durante il quale<br />
le piogge sono uguali o superiori a 0.5 ETP. Si tratta di un sistema<br />
valido nei climi tropicali, quando la crescita non è mai limitata dalle<br />
basse temperature.
Valori di ETP
ETP della coltura<br />
o L’ETP rappresenta in definitiva la domanda evaporativa<br />
dell’atmosfera. Nelle reali condizioni di campo la situazione è<br />
diversa da quella standard di riferimento e quindi i valori di<br />
ETP devono essere raccordati con quelli della coltura<br />
analizzata.<br />
o Si utilizzano allora i coefficienti colturali (Kc) che<br />
moltiplicati per (ETPo) forniscono i valori di ETP della<br />
coltura (ETPc)<br />
ETPc=ETPo x Kc<br />
o I valori di ETPc rappresentano i fabbisogni idrici della<br />
coltura e permettono di calcolare l’ET di punta, su cui è<br />
necessario effettuare i calcoli delle portate irrigue per<br />
evitare che si possano verificare insufficienze.
Relazione fra ETPo ed ETPc<br />
o Le differenze fra le<br />
colture sono<br />
prevalentemente<br />
dovute ad una maggiore<br />
resistenza alla<br />
traspirazione,<br />
conseguente, ad<br />
esempio, ad una<br />
chiusura degli stomi<br />
durante il giorno<br />
(ananas) od alla<br />
presenza di cera sulle<br />
foglie (agrumi).
o Stadio iniziale: comprende la<br />
geminazione, l’emergenza ed il<br />
primo sviluppo fogliare, con il<br />
terreno quasi del tutto scoperto<br />
di vegetazione (0.3).<br />
o Stadio di copertura: il rapido<br />
sviluppo fogliare porta al<br />
ricoprimento quasi completo del<br />
terreno (fra 0.3 ed 1).<br />
o Stadio di pieno sviluppo: la<br />
copertura vegetale è al suo<br />
massimo (>1).<br />
o Stadio di maturazione: inizia con<br />
la formazione dei semi e dei frutti<br />
e con la senescenza del fogliame e<br />
progredisce fino alla maturazione<br />
piena (fra 1 e 0.3-0.5).<br />
Valori di Kc
La misura<br />
o Evaporazione, traspirazione ed evapotraspirazione si<br />
misurano su base oraria (mm h-1) o su base giornaliera<br />
(mm d-1).<br />
o Per la misura dell'evaporazione si usano l’evaporimetro<br />
o la vasca evaporimetrica,<br />
o L’evapotraspirazione viene misurata con il lisimetro.<br />
Data la laboriosità ed il costo dello strumento, l’ET è<br />
spesso calcolata a partire dall'ETP, per la quale è<br />
necessario conoscere variabili agrometeorologiche<br />
standard.
Fattori influenti<br />
o L’ET è un passaggio di stato e dipende dai seguenti fattori:<br />
o Energetico, consistente nella disponibilità di energia per<br />
il processo evaporativo<br />
o Aerodinamico, relativo alla rimozione del vapore acqueo<br />
dalle superfici evaporanti<br />
o Oltre a questi fattori climatici generali, devono poi essere<br />
aggiunti fattori che considerano le condizioni del terreno e<br />
della vegetazione.<br />
o Per cercare di descrivere l’ET in modo standardizzato, è<br />
stata quindi introdotta l’evapotraspirazione potenziale (ETP)<br />
che descrive al meglio i rapporti pianta-clima-atmosfera.
o I metodi seguenti sono stati modificati dalla FAO per<br />
calcolare la ETP sulla base di medie su un periodo di 10-<br />
30 giorni. Il valore ottenuto rappresenta la media<br />
giornaliera di quel periodo.
Evaporimetro di classe A pan<br />
• La vasca di classe “A”<br />
americana è costituita da un<br />
cilindro in acciaio galvanizzato<br />
di 25,4 cm di profondità e di<br />
120.7 cm di diametro e 0.8 cm<br />
di spessore<br />
• Il livello dell’acqua è misurato<br />
tramite una sonda collegata a<br />
un galleggiante, situata in un<br />
pozzetto di calma per<br />
diminuire l’effetto<br />
dell’increspatura superficiale<br />
dovuta al vento
Lisimetro
Vento<br />
o Il vento è prodotto dallo spostamento di una massa d’aria. Tale<br />
spostamento è determinato, sia alla scala della circolazione generale<br />
dell’atmosfera sia a scala locale, da differenze di pressione<br />
dell’atmosfera, che componendosi con il moto terrestre e con l’attrito<br />
delle superfici danno luogo al vento.<br />
o Il vento è una componente importante dei fenomeni meteorologici e la sua<br />
distribuzione nel corso dell’anno segue degli schemi relativamente<br />
ripetitivi, che rappresentano la circolazione generale dell’atmosfera.<br />
o Nei riepiloghi giornalieri, il vento è indicato mediante il valore medio della<br />
velocità (m s-1) o come vento sfilato (km), corrispondente alla distanza che<br />
avrebbe percorso nel giorno una massa d’aria avente uguale velocità.<br />
o Importante anche la conoscenza della direzione di provenienza, che può<br />
essere espressa in termini di frequenza, considerando ad esempio una<br />
misura ogni tre ore (8 misure il giorno). In questo caso la misura viene<br />
espressa in gradi on in base la quadrante di provenienza (N, NE, SO).
Rapporti con le colture<br />
o I principali effetti sulle colture sono: aumento della<br />
evapotraspirazione, aumento del ricambio della CO2,<br />
impollinazione e disseminazione, alterazioni<br />
morfologiche, allettamento, stroncamento e<br />
sradicamento, trasporto di sali, abrasione. Importante<br />
anche il ruolo nella erosione eolica.<br />
o Per la difesa dal vento si utilizzano i frangivento che<br />
hanno lo scopo di proteggere interi appezzamenti o<br />
comprensori intercettando le masse d’aria e deviandole<br />
verso l’alto.
La misura<br />
o Il vento è descritto da due componenti: l’intensità, che<br />
si misura in metri al secondo o in nodi (1 nodo=0.514 m<br />
s-1) e la direzione, che si esprime in gradi ed indica la<br />
direzione di provenienza, posto il nord geografico<br />
uguale a zero e il sud pari a 180°. Per indicare la<br />
direzione del vento si usa quella di provenienza delle<br />
masse d’aria.<br />
o L’intensità del vento si misura con l’anemometro e la<br />
direzione con il gonioanemometro (anemoscopio o<br />
banderuola).
La velocità del vento – anemometro<br />
o Si basa sulla rotazione di coppe o eliche che<br />
raggiungono l’equilibrio cinetico con l’aria circostante<br />
o Può essere costruito in alluminio o in plastica<br />
o Due diversi tipi di trasduzione possono essere<br />
impiegati: analogici o digitali<br />
o Nel primo il moto è trasmesso a una bobina che produce<br />
una tensione elettrica proporzionale alla velocità<br />
o Nel secondo un dispositivo ottico o magnetico rileva il<br />
numero di giri compiuti
a coppe a mulinello
La direzione del vento<br />
Gonioanemometro o Anemoscopio<br />
o E’ costituito da un sensore che viene<br />
orientato nella direzione in cui si<br />
muove la massa d’aria e da un<br />
sistema di trasduzione<br />
o Il sensore è costituito da una<br />
banderuola, di varia foggia, ad asse<br />
di rotazione verticale<br />
o Il sistema di trasduzione è<br />
normalmente costituito da un<br />
potenziometro, ovvero una<br />
resistenza il cui valore dipende dalla<br />
posizione di un cursore, collegato<br />
all’albero della banderuola, che si<br />
muove lungo i contatti elettrici
Anemometro a filo caldo<br />
o E’ un trasduttore termico capace di<br />
rilevare la velocità del flusso<br />
tramite una variazione di<br />
temperatura, utilizzando un filo<br />
riscaldato.<br />
o Il trasduttore tipico è composto da<br />
un filo di tungsteno o Platino<br />
o Il filo è mantenuto a temperatura<br />
costante. Il circuito produce una<br />
corrente elettrica che varia in<br />
funzione della velocità del vento, per<br />
mantenere una temperatura<br />
costante del trasduttore (150°C o<br />
125°C)<br />
o Se la velocità del vento aumenta, il<br />
tasso di raffreddamento del filo<br />
aumenta proporzionalmente. Così la<br />
corrente di riscaldamento dovrà<br />
aumentare per mantenere la<br />
temperatura al livello desiderato
o Si basa sulla modifica delle<br />
proprietà delle onde acustiche,<br />
emesse da una trasmittente, in<br />
relazione al moto dell’aria<br />
o Una parte ricevente analizza<br />
questa modifica e la converte<br />
in un valore di velocità del<br />
vento<br />
o Esiste la versione<br />
bidimensionale e<br />
tridimensionale<br />
Anemometro Sonico
Rappresentazione polare del vento
Scala di<br />
Beaufort
Effetti del vento sulle piante (I)<br />
o Aumento della evapotraspirazione. In aria ferma l’evaporazione è un<br />
fenomeno di semplice diffusione, mentre se l’aria è in movimento il<br />
processo viene fortemente accentuato in quanto vengono rimossi gli<br />
strati di aria umida che altrimenti tenderebbero ad accumularsi sulle<br />
superfici evaporanti.<br />
o Inoltre il vento, deformando le foglie, causa alternate contrazioni ed<br />
espansioni degli spazi intercellulari ed in particolare delle camere<br />
sottostomatiche forzando il ricambio dell’aria interna con quella esterna<br />
più secca. Si accentua così la traspirazione.<br />
o Venti caldi invernali possono determinare l’appassimento dei boschi di<br />
montagna. Lo scirocco è il responsabile della stretta dei cereali. Venti<br />
caldi e secchi possono devitalizzare foglie, germogli ed anche il polline.<br />
o Le piante arboree sono più esposte al vento e quindi deve essere scelta<br />
opportunamente la loro ubicazione, l’orientamento dei filari, i sistemi di<br />
allevamento, etc.
Effetti del vento sulle piante (II)<br />
o Aumento della evaporazione. Analogamente all’effetto precedente, il<br />
vento accelera la maturazione e l’essiccamento dei semi, l’essiccamento<br />
dell’erba durate la fienagione, il prosciugamento superficiale del<br />
terreno, etc.<br />
o Aumento del ricambio della CO2. Con lo stesso meccanismo sopra<br />
descritto, il vento favorisce il ricambio della CO 2 sia entro il mesofillo<br />
che all’interno della canopy, con vantaggi per la fotosintesi.<br />
o Impollinazione e disseminazione. I movimenti d’aria assicurano il<br />
trasporto, su un raggio più o meno lungo, del polline, assicurando<br />
l’impollinazione, e dei semi, assicurando la disseminazione.<br />
o Alterazioni morfologiche. Le piante che si accrescono sotto l’influenza<br />
di venti secchi non raggiungono mai un grado di turgidità tale da far<br />
espandere lo loro cellule fino alla dimensione normale. Gli organi<br />
risultano così ridotti, anche senza essere deformati. Lungo le coste od<br />
in alta montagna la dimensione degli alberi è ridotta. In caso di venti<br />
dominanti costanti, i tronchi risultano asimmetrici, per la formazione di<br />
legno di compressione con anelli più sviluppati nella parte sottovento. La<br />
chioma assume la forma a bandiera.
Tipica chioma a bandiera
Effetti del vento sulle piante (III)<br />
o Allettamento. Fenomeno dannoso causato del vento su<br />
piante erbacce, consistente nel coricamento degli steli<br />
per piegatura o per allentamento delle radici.<br />
o Stroncamento e sradicamento. Importante anche negli<br />
alberi ed in certe piante erbacee; caduta di fiori.<br />
o Trasporto di sali. Venti provenienti dal mare e che<br />
trasportano particelle di cloruro di sodio sono molto<br />
frequenti in Italia e provocano gravi danni alla<br />
vegetazione data la forte tossicità del sale.<br />
o Abrasione. Quando il vento trasporta particelle di<br />
ghiaccio o di sabbia esercita una potente azione<br />
abrasiva. Le cortecce possono essere abrase,<br />
soprattutto pochi centimetri sopra il suolo.
Non<br />
efficace<br />
Efficace<br />
Strutture dei frangivento