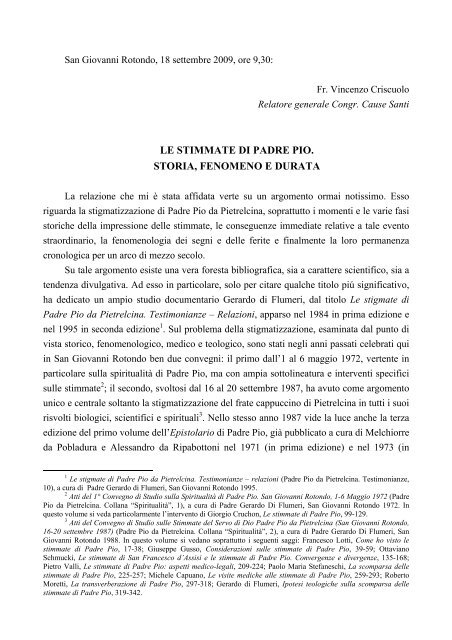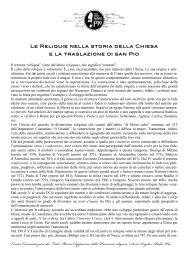Vincenzo Criscuolo - Cappuccinifoggia.It
Vincenzo Criscuolo - Cappuccinifoggia.It
Vincenzo Criscuolo - Cappuccinifoggia.It
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
San Giovanni Rotondo, 18 settembre 2009, ore 9,30:<br />
LE STIMMATE DI PADRE PIO.<br />
STORIA, FENOMENO E DURATA<br />
Fr. <strong>Vincenzo</strong> <strong>Criscuolo</strong><br />
Relatore generale Congr. Cause Santi<br />
La relazione che mi è stata affidata verte su un argomento ormai notissimo. Esso<br />
riguarda la stigmatizzazione di Padre Pio da Pietrelcina, soprattutto i momenti e le varie fasi<br />
storiche della impressione delle stimmate, le conseguenze immediate relative a tale evento<br />
straordinario, la fenomenologia dei segni e delle ferite e finalmente la loro permanenza<br />
cronologica per un arco di mezzo secolo.<br />
Su tale argomento esiste una vera foresta bibliografica, sia a carattere scientifico, sia a<br />
tendenza divulgativa. Ad esso in particolare, solo per citare qualche titolo piú significativo,<br />
ha dedicato un ampio studio documentario Gerardo di Flumeri, dal titolo Le stigmate di<br />
Padre Pio da Pietrelcina. Testimonianze – Relazioni, apparso nel 1984 in prima edizione e<br />
nel 1995 in seconda edizione 1 . Sul problema della stigmatizzazione, esaminata dal punto di<br />
vista storico, fenomenologico, medico e teologico, sono stati negli anni passati celebrati qui<br />
in San Giovanni Rotondo ben due convegni: il primo dall’1 al 6 maggio 1972, vertente in<br />
particolare sulla spiritualità di Padre Pio, ma con ampia sottolineatura e interventi specifici<br />
sulle stimmate 2 ; il secondo, svoltosi dal 16 al 20 settembre 1987, ha avuto come argomento<br />
unico e centrale soltanto la stigmatizzazione del frate cappuccino di Pietrelcina in tutti i suoi<br />
risvolti biologici, scientifici e spirituali 3 . Nello stesso anno 1987 vide la luce anche la terza<br />
edizione del primo volume dell’Epistolario di Padre Pio, già pubblicato a cura di Melchiorre<br />
da Pobladura e Alessandro da Ripabottoni nel 1971 (in prima edizione) e nel 1973 (in<br />
1 Le stigmate di Padre Pio da Pietrelcina. Testimonianze – relazioni (Padre Pio da Pietrelcina. Testimonianze,<br />
10), a cura di Padre Gerardo di Flumeri, San Giovanni Rotondo 1995.<br />
2 Atti del 1° Convegno di Studio sulla Spiritualità di Padre Pio. San Giovanni Rotondo, 1-6 Maggio 1972 (Padre<br />
Pio da Pietrelcina. Collana “Spiritualità”, 1), a cura di Padre Gerardo Di Flumeri, San Giovanni Rotondo 1972. In<br />
questo volume si veda particolarmente l’intervento di Giorgio Cruchon, Le stimmate di Padre Pio, 99-129.<br />
3 Atti del Convegno di Studio sulle Stimmate del Servo di Dio Padre Pio da Pietrelcina (San Giovanni Rotondo,<br />
16-20 settembre 1987) (Padre Pio da Pietrelcina. Collana “Spiritualità”, 2), a cura di Padre Gerardo Di Flumeri, San<br />
Giovanni Rotondo 1988. In questo volume si vedano soprattutto i seguenti saggi: Francesco Lotti, Come ho visto le<br />
stimmate di Padre Pio, 17-38; Giuseppe Gusso, Considerazioni sulle stimmate di Padre Pio, 39-59; Ottaviano<br />
Schmucki, Le stimmate di San Francesco d’Assisi e le stimmate di Padre Pio. Convergenze e divergenze, 135-168;<br />
Pietro Valli, Le stimmate di Padre Pio: aspetti medico-legali, 209-224; Paolo Maria Stefaneschi, La scomparsa delle<br />
stimmate di Padre Pio, 225-257; Michele Capuano, Le visite mediche alle stimmate di Padre Pio, 259-293; Roberto<br />
Moretti, La transverberazione di Padre Pio, 297-318; Gerardo di Flumeri, Ipotesi teologiche sulla scomparsa delle<br />
stimmate di Padre Pio, 319-342.
seconda edizione) 4 . I dati piú importanti di tutta questa documentazione sono<br />
definitivamente confluiti nella Positio super virtutibus di Padre Pio, e in modo particolare<br />
nella Biografia documentata, pubblicata nel marzo 1997 5 . Da tale data ben poco di<br />
assolutamente nuovo è emerso, sia a livello documentario, sia a livello interpretativo 6 .<br />
Il mio intervento, a parte qualche recentissima pubblicazione che permette di meglio<br />
chiarificare qualche punto di non centrale importanza, non offre quindi molte novità<br />
sull’argomento della stigmatizzazione di Padre Pio, soprattutto in relazione alla storia<br />
dell’impressione delle stigmate, alla loro morfologia e fenomenologia, e alla permanenza<br />
cronologica delle piaghe. Esso si limita, sulla base dei documenti e degli studi principali,<br />
alla presentazione storica dei fatti, relativi all’impressione e all’incisione prima temporanea<br />
e in modo prevalentemente non visibile, poi chiara e definitiva delle stimmate, avvenuta la<br />
mattina del 20 settembre 1918, alla loro realtà vitale e sanguinante per cinquant’anni, e<br />
quindi alla loro scomparsa poco prima della morte. A questa rapida esposizione farà seguito<br />
una breve appendice, che invece ha una certa rilevanza soprattutto per la sua novità<br />
documentaria, se non altro come possibilità di percorrere una nuova pista di indagine<br />
archivistica, riguardante rapporti finora non ancora ben noti, anzi bibliograficamente ancora<br />
del tutto sconosciuti, tra Padre Pio da Pietrelcina e una stigmatizzata tedesca sua<br />
contemporanea.<br />
La vicenda storica dell’impressione delle stigmate<br />
La prima manifestazione delle stimmate, parziale e cronologicamente limitata e<br />
circoscritta, secondo la testimonianza dello stesso Padre Pio si verificò poco dopo la sua<br />
ordinazione sacerdotale 7 , probabilmente tra l’agosto e il settembre 1910 8 . Nella lettera dell’8<br />
settembre 1911 al suo direttore spirituale Benedetto da San Marco in Lamis 9 egli cosí<br />
4<br />
Padre Pio da Pietrelcina, Epistolario, I: Corrispondenza coi i direttori spirituali (1910-1922), a cura di<br />
Melchiorre da Pobladura e Alessandro da Ripabottoni. III edizione riveduta e corretta da Padre Gerardo di Flumeri, San<br />
Giovanni Rotondo 1987 [in seguito: Epistolario].<br />
5<br />
Congregatio de Causis Sanctorum, Sipontina, Beatificationis et canonizationis Servi Dei Pii a Pietrelcina<br />
sacerdotis professi OFMCap. (Francesco Forgione) (1887-1968) Positio super virtutibus, vol. III/1: Biografia<br />
documentata: Alessandro da Ripabottoni, Vita del Servo di Dio Padre Pio da Pietrelcina dei Frati Minori Cappuccini<br />
(1887-1968), Roma 1997 [in seguito: Positio].<br />
6<br />
Tra le numerose biografie di Padre Pio, che trattano specificamente della stigmatizzazione, si può fare sicuro<br />
riferimento a Luigi Peroni, Padre Pio da Pietrelcina, Roma 1991 (I ediz.), 1994 (II ediz.) e 2002 (III ediz.); e a Gerardo<br />
Di Flumeri, Il beato Padre Pio da Pietrelcina, San Giovanni Rotondo 2001.<br />
7<br />
Come è noto, Padre Pio venne ordinato sacerdote nella cattedrale di Benevento il 10 agosto 1910: cf. Positio,<br />
81-93.<br />
8<br />
Cf. Le stigmate di Padre Pio da Pietrelcina, 6.<br />
9<br />
Nato il 16 marzo 1872, entrò tra i cappuccini l’11 dicembre 1890; dopo il corso gli studi filosofici e teologici,<br />
effettuato nella Provincia Toscana, fu ordinato sacerdote l’11 aprile 1898. Dal 1903 al 1919 si dedicò alla predicazione<br />
e all’insegnamento. Definitore provinciale nel 1903 e nel 1906, resse la Provincia cappuccina di Foggia come ministro<br />
provinciale dal febbraio 1908 al luglio 1919. Si spense a San Severo il 22 luglio 1942. Un buon profilo bio-bibliografico<br />
su di lui si incontra in Epistolario, 51-54.<br />
2
scriveva: “Ieri sera poi mi è successo una cosa che io non so né spiegarmi e né<br />
comprendere. In mezzo alla palma delle mani è apparso un po’ di rosso quasi quanto la<br />
forma di un centesimo, accompagnato anche da un forte ed acuto dolore in mezzo a quel po’<br />
di rosso. Questo dolore era più sensibile in mezzo alla mano sinistra, tanto che dura ancora.<br />
Anche sotto i piedi avverto un po’ di dolore”. E aggiungeva: “Questo fenomeno è quasi da<br />
un anno che si va ripetendo, però adesso era da un pezzo che più non si ripeteva. Non<br />
s’inquieti però se adesso per la prima volta glielo dico; perché mi son fatto vincere sempre<br />
da quella maledetta vergogna. Anche adesso se sapesse quanta violenza ho dovuto farmi per<br />
dirglielo!” 10 .<br />
Dall’agosto-settembre 1910 e forse fino al 1915, o molto piú probabilmente fino alla<br />
stigmatizzazione visibile e permanente nel settembre 1918, le stimmate rimasero per lo piú<br />
invisibili: procuravano cioè dolori spasimanti, soprattutto in alcuni giorni della settimana, in<br />
genere nella giornata del martedí e nel periodo dal giovedì sera al sabato mattina, ma non<br />
erano sempre visivamente percepibili, o in qualche caso erano visibili solo parzialmente e<br />
riguardavano solo qualcuna di esse 11 .<br />
Vari accenni al riguardo si incontrano nell’Epistolario di Padre Pio. Il 21 marzo 1912<br />
egli scriveva da Pietrelcina a padre Agostino da San Marco in Lamis 12 : “Dal giovedí sera<br />
fino al sabato, come anche il martedí è una tragedia dolorosa per me. Il cuore, le mani ed i<br />
piedi sembrami che siano trapassati da una spada; tanto è il dolore che ne sento” 13 . Il 4<br />
settembre 1915 scriveva allo stesso padre Agostino: “Sento dislogarmi tutte le ossa ed in<br />
pari tempo come se venissero stritolate e maciullate […]. Chi vi è che possa indovinare<br />
quanto sia profonda la ferita che si è aperta dalla parte del cuore? […] Per me non c’è alcun<br />
balsamo, che valga a disacerbare questa piaga crudele, se non quello di rassegnarmi, per<br />
piacere anche in questo al mio dolce Signore” 14 . E il 10 ottobre successivo, in seguito a<br />
precise domande formulate per ben due volte da padre Agostino 15 , cosí gli scriveva riguardo<br />
alla seconda di esse: “La seconda dimanda è se l’ha concesso il dono ineffabile delle sue<br />
sante stimmate. A ciò devesi rispondere affermativamente e la prima volta di quando Gesù<br />
volle degnarla di questo suo favore, furono visibili, specie in una mano e poiché<br />
quest’anima a tal fenomeno rimase assai esterrefatta, pregò il Signore che avesse ritirato un<br />
tal fenomeno visibile. D’allora non apparsero più; però, scomparse le trafitture, non per<br />
10<br />
Epistolario, 234; Le stigmate di Padre Pio da Pietrelcina, 45-46; Positio, 168.<br />
11<br />
Cf. al riguardo Le stigmate di Padre Pio da Pietrelcina, 6.<br />
12<br />
Nato il 9 gennaio 1880, il 19 agosto 1897 dopo gli studi ginnasiali entrò tra i cappuccini; dopo il novizio fu<br />
inviato a completare gli studi nella Provincia Toscana; tornato nella sua Provincia di Foggia, svolse una feconda attività<br />
apostolica, a cui uní l’attività didattica con l’insegnamento della filosofia; partecipò alla guerra del 1915-1918 e stimó<br />
di cuore Pio da Pietrelcina, di cui fu per vario tempo direttore spirituale; dal 1944 al 1953 fu anche guardiano di San<br />
Giovanni Rotondo, ove si spense il 14 maggio 1963. Su di lui cf. Epistolario, 54-57.<br />
13<br />
Epistolario, 266; Le stigmate di Padre Pio da Pietrelcina, 46; Positio, 168.<br />
14<br />
Epistolario, 640-641.<br />
15<br />
Cf. Epistolario, 657-660 e 663-666; cf. anche 670-673.<br />
3
questo scomparve il dolore acutissimo che si fa sentire, specie in qualche circostanza ed in<br />
determinati giorni” 16 .<br />
Nel gennaio dello stesso anno 1915 forse ebbero luogo anche episodi di<br />
trasverberazione, che forse si erano verificati già tre anni prima, quando Padre Pio,<br />
rivolgendosi a padre Agostino ed esprimendosi in lingua francese, parlava di un “javelot de<br />
feu” (lancia di fuoco) che Gesú aveva ritirato dalla sua anima, ma la cui ferita si era rivelata<br />
mortale (“la blessure est mortelle”) 17 . Il 24 gennaio 1915 cosí scriveva a Padre Benedetto:<br />
“Sembrami come se tutte le ossa mi si scerpassero. Sentomi, senza punto vederlo con gli<br />
occhi del corpo, ma ben vedendolo io con quelli dello spirito, immergermi da costui a volta<br />
a volta un coltello, con una punta ben affilata e quasi gettando fuoco, attraverso il cuore che<br />
lo approfonda fino nelle viscere, indi a viva forza lo ritrae per poi di lì a poco ripetere<br />
l’operazione. Il tutto lascia, al moltiplicarsi di questi colpi, sempre maggiormente divampar<br />
l’anima di grandissimo amore di Dio. Il dolore intanto che producemi tal ferita, che da lui<br />
mi viene aperta, e la soavità che in pari tempo mi si fa sentire, sono così vivi che adombrarli<br />
mi torna impossibile” 18 . Il 18 maggio seguente, in due distinte lettere inviate ai suoi due<br />
direttori spirituali, Benedetto e Agostino da San Marco in Lamis, Padre Pio riconosceva<br />
apertamente: “Sono crocifisso d’amore” 19 .<br />
La vera trasverberazione, che deve essere considerata un preludio ormai prossimo alla<br />
stigmatizzazione, ebbe luogo a San Giovanni Rotondo il 5 agosto 1918, mentre Padre Pio<br />
era intento ad ascoltare la confessione dei seminaristi, e si protrasse fino a tutto il giorno<br />
successivo e alla mattina seguente. Il frate di Pietrelcina cosí la descriveva a Benedetto da<br />
San Marco in Lamis nella sua lettera del 21 agosto 1918: “In forza di questa mi induco a<br />
manifestarvi ciò che avvenne in me dal giorno cinque a sera, a tutto il sei del corrente mese.<br />
Io non valgo a dirvi ciò che avvenne in questo periodo di superlativo martirio. Me ne stavo<br />
confessando i nostri ragazzi la sera del cinque, quando tutto d’un tratto fui riempito di un<br />
estremo terrore alla vista di un personaggio celeste che mi si presenta dinanzi all’occhio<br />
dell’intelligenza. Teneva in mano una specie di arnese, simile ad una lunghissima lamina di<br />
ferro con una punta ben affilata, e che sembrava da essa punta che uscisse fuoco. Vedere<br />
tutto questo ed osservare detto personaggio scagliare con tutta violenza il suddetto arnese<br />
nell’anima, fu tutto una cosa sola. A stento emisi un lamento, mi sentivo morire. Dissi al<br />
ragazzo che si fosse ritirato, perché mi sentivo male e non sentivo più la forza di continuare.<br />
Questo martirio durò, senza interruzione, fino al mattino del giorno sette. Cosa soffrii in<br />
questo periodo sì luttuoso io non so dirlo. Persino le viscere vedevo che venivano strappate<br />
16 Epistolario, 669; Le stigmate di Padre Pio da Pietrelcina, 47. Cf. anche Gerardo Di Flumeri, La<br />
transverberazione di Padre Pio da Pietrelcina, San Giovanni Rotondo 1985.<br />
17 Epistolario, 300.<br />
18 Epistolario, 522.<br />
19 Epistolario, 545 e 547.<br />
4
e stiracchiate dietro di quell’arnese, ed il tutto era messo a ferro e a fuoco. Da quel giorno in<br />
qua io sono stato ferito a morte. Sento nel più intimo dell’anima una ferita che è sempre<br />
aperta, che mi fa spasimare assiduamente” 20 .<br />
La stessa esperienza veniva ribadita quindici giorni dopo, quando Padre Pio scriveva<br />
allo stesso padre Benedetto: “Io mi veggo sommerso in un oceano di fuoco, la ferita che mi<br />
venne riaperta sanguina e sanguina sempre. Dessa sola basterebbe a darmi mille e più volte<br />
la morte” 21 . Il 20 dicembre successivo Padre Pio parlava ancora di “una cosa simile ad una<br />
lamina di ferro che dalla parte bassa del cuore si estende sino a sotto la spalla destra in linea<br />
trasversale. Mi causa dolore acerbissimo e non mi lascia prendere un po’ di riposo” 22 .<br />
La definitiva impressione delle stimmate nel corpo del frate di Pietrelcina, che doveva<br />
perdurare visibilmente fino al termine della sua vita, si verificò la mattina del 20 settembre<br />
1918 e condizionò tutta la sua esistenza. La migliore descrizione dell’evento, della cui<br />
autenticità e veridicità non si può dubitare, ci viene ancora una volta offerta dallo stesso<br />
Padre Pio, nella lettera che egli scrisse il 22 ottobre seguente a Benedetto da San Marco in<br />
Lamis, dal quale era stato esplicitamente sollecitato a fornire un resoconto preciso di quanto<br />
era avvenuto. Si tratta di una pagina che i devoti dello stigmatizzato del Gargano conoscono<br />
a memoria e che vale la pena rileggere per intero: “Era la mattina del 20 dello scorso mese<br />
in coro – scriveva Padre Pio – dopo la celebrazione della santa messa, allorché venni<br />
sorpreso dal riposo, simile ad un dolce sonno. Tutti i sensi interni ed esterni, non che le<br />
stesse facoltà dell’anima si trovarono in una quiete indescrivibile. In tutto questo vi fu totale<br />
silenzio intorno a me e dentro di me; vi subentrò subito una grande pace ed abbandono alla<br />
completa privazione del tutto e una posa nella stessa rovina. Tutto questo avvenne in un<br />
baleno. E mentre tutto questo si andava operando, mi vidi dinanzi un misterioso<br />
personaggio, simile a quello visto la sera del 5 agosto, che differenziava in questo solamente<br />
che aveva le mani ed i piedi ed il costato che grondava sangue. La sua vista mi atterrisce:<br />
ciò che sentivo in quell’istante in me non saprei dirvelo. Mi sentivo morire e sarei morto se<br />
il Signore non fosse intervenuto a sostenere il cuore, il quale me lo sentivo sbalzare dal<br />
petto. La vista del personaggio si ritira ed io mi avvidi che mani, piedi e costato erano<br />
traforati e grondavano sangue. Immaginate lo strazio che io esperimentai allora e che vado<br />
esperimentando continuamente quasi tutti i giorni. La ferita del cuore gitta assiduamente del<br />
sangue, specie dal giovedì a sera sino al sabato. Padre mio, io muoio di dolore per lo strazio<br />
e per la confusione susseguente che io provo nell’intimo dell’anima. Temo di morire<br />
dissanguato, se il Signore non ascolta i gemiti del mio povero cuore e col ritirare da me<br />
questa operazione. Mi farà questa grazia Gesù che è tanto buono? Toglierà almeno da me<br />
20 Epistolario, 1065; Positio, 166.<br />
21 Epistolario, 1072; Positio, 167.<br />
22 Epistolario, 1106; Positio, 167.<br />
5
questa confusione che io esperimento per questi segni esterni? Innalzerò forte la mia voce a<br />
lui e non desisterò dal scongiurarlo, affinché per sua misericordia ritiri da me non lo strazio,<br />
non il dolore perché lo veggo impossibile ed io sento di volermi inebriare di dolore, ma<br />
questi segni esterni che mi sono di una confusione e di una umiliazione indescrivibile ed<br />
insostenibile. Il personaggio di cui intendevo parlare nell’altra mia precedente non è altro<br />
che quello stesso di cui vi parlai in un’altra mia, visto il 5 agosto. Egli segue la sua<br />
operazione senza posa, con superlativo strazio dell’anima. Io sento nell’interno un continuo<br />
rumoreggiare, simile ad una cascata, che gitta sempre sangue” 23 .<br />
Il racconto dell’evento della stigmatizzazione, pur cosí semplice nel suo svolgimento,<br />
presenta almeno due punti interrogativi, tra i tanti sui quali la storiografia teologica e<br />
medica successiva ha avuto modo di riflettere a lungo e di fornire risposte non sempre<br />
univoche.<br />
La prima domanda può essere cosí formulata: chi era quel “misterioso personaggio” o<br />
quel “personaggio celeste” a cui Padre Pio accenna come autore e promotore o causa prima<br />
sia della trasverberazione, sia della stigmatizzazione? Qual è la sua precisa identità? A<br />
questa domanda fu dedicata una particolare attenzione nello scorso convegno sulle<br />
stimmate, celebrato qui a San Giovanni Rotondo nel settembre 1987. Nell’ambito di una<br />
relazione, riguardante la possibilità di stabilire convergenze e divergenze tra le stimmate di<br />
Padre Pio da Pietrelcina e quelle di Francesco d’Assisi, il relatore – si tratta del cappuccino<br />
svizzero Ottaviano Schmucki – affrontò esplicitamente l’argomento; dopo aver esaminato<br />
tutte le fonti al riguardo, egli asseriva: “Chi fosse questo ‘misterioso’ o ‘grande<br />
personaggio’ è difficile a dirsi con certezza” 24 . Egli riteneva infatti che lo stesso Padre Pio si<br />
esprimesse al riguardo in termini non chiari e che in vari casi fosse vittima di amnesia. Cosí<br />
infatti si esprime lo studioso cappuccino: “È risaputo che i mistici, di fronte ad<br />
un’esperienza che trascende totalmente l’ordine creaturale, provino un’immensa fatica ad<br />
esprimersi adeguatamente. Nel riferirla ad altri, inevitabilmente, devono ricorrere a concetti<br />
ed immagini naturali che, a loro volta rischiano piú di occultare che di rivelare la piena<br />
realtà del fatto sperimentato. In questo senso, mi pare un’evidente, benché involontaria<br />
trasposizione, condizionata dalla notevole distanza di tempo dall’evento, se Padre Pio nel<br />
1966 identificò sic et simpliciter questo personaggio con Cristo crocifisso, mentre ad appena<br />
un mese dall’evento (22 ottobre 1918), costui gli è sembrato ‘misterioso’, cioè non<br />
riconoscibile. Questo fenomeno – continua Padre Schmucki – va, forse, spiegato con il<br />
sovrapporsi, nella memoria del mistico, di ricordi di molteplici esperienze interiori,<br />
avvenute in diversi tempi e circostanze, che insensibilmente si fondono in un’immagine<br />
composita. D’altro canto, non è improbabile che, di fronte all’esperienza centrale, cioè la<br />
23 Epistolario, 1093-1095; Le stigmate di Padre Pio da Pietrelcina, 51-52; Positio, 168-169.<br />
24 O. Schmucki, Le stimmate di san Francesco d’Assisi, 154.<br />
6
visione del ‘personaggio misterioso’ che produsse le stimmate, altre visioni che la<br />
precedettero abbiano perso il loro rilievo psicologico e lo abbiano portato ad una parziale<br />
amnesia” 25 .<br />
Benché formulate con molta prudenza e cautela, tali asserzioni sono state<br />
recentissimamente ritenute prive di valore da parte di Francesco Castelli, che lo scorso anno<br />
ha potuto pubblicare gli atti, ancora inediti e finora praticamente non utilizzati, della visita<br />
apostolica effettuata nel giugno 1921, a meno di tre anni quindi dall’impressione delle<br />
stimmate, dall’allora vescovo di Volterra e piú tardi cardinale Carlo Raffaello Rossi 26 , di cui<br />
è in corso dal 1976 la causa di canonizzazione 27 . “La prima deposizione resa da P. Pio a<br />
Mons. Rossi – cosí osserva don Castelli – getta ora una luce definitiva su questo argomento.<br />
Rispondendo al Visitatore che gli chiede di parlare delle stimmate, P. Pio, a meno di tre anni<br />
dall’evento 28 gli rivela: ‘Il 20 settembre 1918 dopo la celebrazione della Messa<br />
trattenendomi a fare il dovuto ringraziamento nel Coro tutt’a un tratto fui preso da un forte<br />
tremore, poi subentrò la calma e vidi Nostro Signore in atteggiamento di chi sta in croce’.<br />
Alla breve distanza di tre anni, dunque – conclude Francesco Castelli – P. Pio sa identificare<br />
perfettamente chi ha visto: Nostro Signore in atteggiamento di chi sta in croce. L’ipotesi di<br />
un’amnesia a causa della ‘notevole distanza di tempo’ viene cosí a cadere perché P. Pio<br />
25 O. Schmucki, Le stimmate di san Francesco d’Assisi, 154-155. Cf. al riguardo anche la nota 19, ove si<br />
riportano vari passi dal Diario di padre Agostino da San Marco in Lamis, dove si dice che “gli apparve Gesú sotto la<br />
figura d’un Personaggio celeste”. Si può vedere anche la testimonianza di padre Raffaele da Sant’Elia a Pianisi, a cui<br />
padre Pio il 31 maggio 1966 riferì: “Il 20 settembre, poi, sempre del 1918, dalle ore 9 alle ore 10, mentre i collegiali<br />
stavano a fare la ricreazione nell’orto, ero solo in coro al banchino a posto del Vicario a fare il ringraziamento della S.<br />
Messa, e là, in un momento di assopimento e profonda contemplazione sul Cristo Crocifisso, ebbi le stimmate alle mani<br />
e ai piedi da lance o frecce luminose che si partirono dal Crocifisso, trasformato in un grande personaggio e che si<br />
venera tutt’ora nel coro della piccola chiesa vecchia”: Le stigmate di Padre Pio da Pietrelcina, 103. E ancora, il 6<br />
febbraio 1967: “Stavo in coro il 20 settembre 1918 a fare il ringraziamento dopo la Messa al posto del Vicario e nell’ora<br />
dalle 9 alle 10, in un profondo assopimento (estasi) dal Crocifisso, trasformatosi in un grande personaggio tutto<br />
sanguinante, che sta in coro, partono fasci di luce con frecce e fiamme che vengono a ferirmi le mani e i piedi, perché il<br />
costato era già stato ferito il 5 agosto dello stesso anno. Ero solo, non c’era nessuno ed i collegiali stavano in giardino a<br />
fare ricreazione essendo giorni di vacanza. Il Padre Guardiano, Padre Paolino da Casacalenda, stava a San Matteo,<br />
vicino convento dei Frati Minori, per aiutare a confessare i pellegrini”: ivi, 107.<br />
26 Nato a Pisa il 28 ottobre 1876, entrò nell’Ordine carmelitano il 10 dicembre 1898 e fu ordinato sacerdote il 21<br />
dicembre 1901. Chiamato a Roma come consultore del Santo Ufficio e della Congregazione Concistoriale, fu nominato<br />
vescovo di Volterra il 22 aprile 1920; di nuovo a Roma nel 1923 a servizio di varie congregazioni, fu creato cardinale il<br />
30 giugno 1930; si spense a Crespano del Grappa il 17 settembre 1948. Su di lui cf. Hierarchia catholica medii et<br />
recentioris aevi…, vol. IX, a cura di Zenone Pięta, Patavii MMII [Padova 2002], 395<br />
27 Congregatio de Causis Sanctorum, Index ac status causarum, Città del Vaticano 1999, 356.<br />
28 Testimonianza resa il 15 giugno 1921 alle ore 17: Francesco Castelli, Padre Pio sotto inchiesta.<br />
L’“autobiografia” segreta (Smeraldi, 10), Milano 2008, 220. Questo il testo della risposta alla richiesta di monsignor<br />
Carlo Raffaello Rossi di narrare “partitamente circa le cosidette stimmate”: “Il 20 settembre 1918, dopo la celebrazione<br />
della Messa trattenendomi a fare il dovuto ringraziamento nel Coro tutt’ad un tratto fui preso da un forte tremore, poi<br />
subentrò la calma e vidi Nostro Signore in atteggiamento di chi sta in croce, ma non mi ha colpito se avesse la Croce,<br />
lamentandosi della mala corrispondenza degli uomini, specie di coloro consacrati a Lui e piú da lui favoriti. Di piú di<br />
manifestava che lui soffriva e che desiderava di associare delle anime alla sua passione. M’invitava a compenetrarmi<br />
nei suoi dolori e a meditarli: nello stesso tempo occuparmi per la salute dei fratelli. In seguito a questo mi sentii pieno di<br />
compassione per i dolori del Signore e chiedevo a lui che cosa potevo fare. Udii questa voce: ‘Ti associo alla mia<br />
Passione’. E in seguito a questo, scomparsa la visione, sono entrato in me, mi son dato ragione e ho visto questi segni<br />
qui, dai quali gocciolava il sangue. Prima nulla avevo”.<br />
7
dichiara di sapere chi lo ha stimmatizzato. Di qui in avanti, alla luce delle parole stesse di P.<br />
Pio, il ‘misterioso personaggio’ possiede un’identità precisa e sicura: è Gesú Crocifisso” 29 .<br />
La fenomenologia delle stigmate<br />
Alla prima domanda sull’identità del “misterioso personaggio” o “personaggio<br />
celeste”, segue una seconda, relativa al carattere morfologico e all’aspetto medicofisiologico<br />
delle stimmate di Padre Pio. Essa fa riferimento cioè alla forma, alla struttura,<br />
alla fenomenologia e forse ad eventuali modifiche o cambiamenti di forma delle cinque<br />
piaghe, e in modo particolare di quella del costato, verificatisi nel corso degli anni. Anche a<br />
questo riguardo le testimonianze sono abbondanti e diversificate, ben presentate e<br />
criticamente esaminate soprattutto negli studi di padre Gerardo Di Flumeri. Sulla base delle<br />
numerose visite mediche, oltre che sulle testimonianze di vari confratelli che ebbero la<br />
possibilità di vedere e controllare personalmente lo stato e la forma delle stimmate, si può<br />
tracciare, pur con alcune sempre possibili varianti, un breve e preciso profilo morfologico di<br />
ognuna di esse 30 .<br />
Nella regione palmare della mano destra e della mano sinistra, le piaghe si trovavano<br />
al livello del terzo metacarpo o a metà dello stesso terzo metacarpo: avevano forma<br />
circolare, del diametro di poco piú di due centimetri. Erano ricoperte da una membrana<br />
lucente pigmentata di color rosso viscoso, alquanto sollevata nel centro, ove formava un<br />
piccolissimo bottoncino, da cui partivano tante sottili strie piú oscure e tendenti quasi al<br />
centro, con contorni lievemente frangiati. Nella regione dorsale delle mani le stigmate si<br />
presentavano con le stesse caratteristiche e la stessa configurazione della regione palmare.<br />
Divergenze esistono riguardo al vuoto o a un foro esistente nella zona sottostante le<br />
membrane. A questo proposito non esiste omogeneità di vedute. Il dottor Luigi Romanelli<br />
afferma che “quelle zone pigmentate non sono altro che membrane, che ricoprono un foro,<br />
che si origina in una parte e termina nell’altra” 31 . Lo stesso dottore riferisce del suo<br />
esperimento fatto applicando il pollice nella zona palmare e l’indice in quella dorsale: si<br />
aveva la percezione del vuoto esistente fra le due dita, e quindi dell’interruzione del<br />
metacarpo. “Alla palpazione, delicatamente fatta – osservava il dottor Romanelli – non si<br />
percepiva alcuna resistenza ossea” 32 . I dottori Amico Bignami e Giorgio Festa 33 non ebbero<br />
29<br />
F. Castelli, Padre Pio sotto inchiesta, 67.<br />
30<br />
Cf. al riguardo Le stigmate di Padre Pio da Pietrelcina, 7-22.<br />
31<br />
Ivi, 8 e 149. L’intera relazione del dott. Luigi Romanelli è alle pag. 147-151<br />
32<br />
Ivi, 8.<br />
33<br />
Per la relazione del prof. Amico Bignami cf. ivi, 173-179; del dott. Giorgio Festa possediamo tre relazioni, per<br />
le quali cf. ivi, 179-273.<br />
8
la stessa impressione, e in ogni caso le radiografie effettuate dal dottor Alberto Caserta di<br />
Foggia il 14 ottobre 1954 non rivelarono alcuna interruzione ossea 34 .<br />
Anche per quanto riguarda le stigmate dei piedi non esiste assoluta convergenza nei<br />
risultati delle visite mediche. Esse, sia nella regione dorsale che plantare, apparivano di<br />
forma circolare, del diametro di poco piú di due centimetri, ricoperte di membrane di color<br />
rosso vivo e di aspetto lucente, con contorni netti e precisi, circondate da tessuti normali.<br />
Erano situate all’altezza del secondo metatarso o in corrispondenza della metà del secondo<br />
metatarso. Riguardo all’eventuale foro o vuoto, i risultati medici presentarono le stesse<br />
osservazioni divergenti: per il dottor Romanelli era presente un vuoto tra le membrane<br />
dorsale e palmare, normale era invece lo sviluppo osseo per Bignami e Festa, cosí come<br />
nessuna interruzione ossea segnalavano le radiografie eseguite nel 1954 35 .<br />
Varie e piú diversificate si presentano invece le descrizioni della piaga del costato,<br />
tanto che il Di Flumeri ammette per essa vistose o, come egli dice, “gravi e radicali<br />
modificazioni” 36 nell’arco di cinquant’anni, arrivando a identificare, sulla base delle visite<br />
mediche e delle osservazioni di confratelli testimoni de visu, ben quattordici varianti, molto<br />
bene delineate e descritte sia verbalmente sia graficamente, varianti che passano dalla ferita<br />
lacera lineare, della lunghezza di circa sette centimetri, a margini netti e leggermente<br />
accartocciati, alla ferita a forma di croce adagiata tra la quinta e la nona costola, o alla ferita<br />
a “forma quasi di una X” 37 , con misurazioni approssimative per l’asta longitudinale e<br />
verticale e con altre varianti di vario tipo, riguardanti anche l’esatta ubicazione della stessa<br />
piaga del costato. Oltre che sulla forma, le osservazioni divergono anche sulla profondità di<br />
essa, considerata a tratti piú o meno profonda, da cui defluiva sangue arterioso o liquido<br />
siero ematico 38 . Come si vede, pur essendo certi della ferita, non si è del tutto<br />
oggettivamente sicuri della sua forma né delle sue possibili modificazioni e mutamenti in un<br />
arco cronologico piuttosto lungo 39 .<br />
34<br />
Cf. ivi, tav. 17, 18, 19 e 20.<br />
35<br />
Cf. ivi, 9-10.<br />
36<br />
Ivi, 10.<br />
37<br />
Ivi, 11.<br />
38<br />
Cf. ivi, 10-22.<br />
39<br />
Sull’argomento cf. P. Valli, Le stimmate di Padre Pio: aspetti medico-legali, 211-212.<br />
9