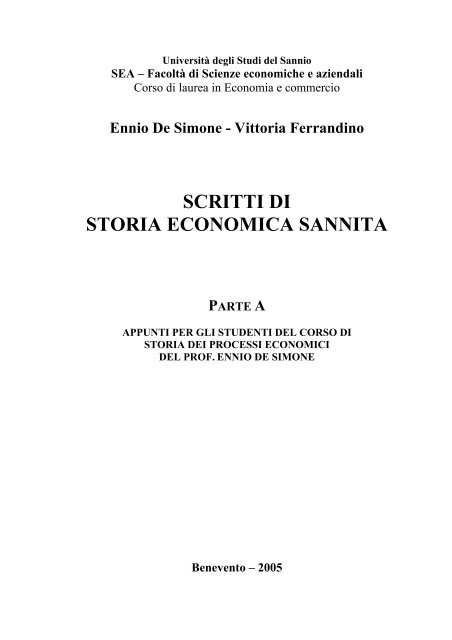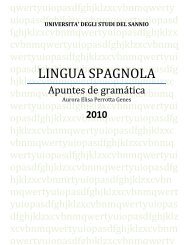Facoltà di Scienze Economiche ed Aziendali - Università degli Studi ...
Facoltà di Scienze Economiche ed Aziendali - Università degli Studi ...
Facoltà di Scienze Economiche ed Aziendali - Università degli Studi ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Università</strong> <strong>degli</strong> Stu<strong>di</strong> del Sannio<br />
SEA – <strong>Facoltà</strong> <strong>di</strong> <strong>Scienze</strong> economiche e aziendali<br />
Corso <strong>di</strong> laurea in Economia e commercio<br />
Ennio De Simone - Vittoria Ferran<strong>di</strong>no<br />
SCRITTI DI<br />
STORIA ECONOMICA SANNITA<br />
PARTE A<br />
APPUNTI PER GLI STUDENTI DEL CORSO DI<br />
STORIA DEI PROCESSI ECONOMICI<br />
DEL PROF. ENNIO DE SIMONE<br />
Benevento – 2005
SOMMARIO<br />
Economia e società nel Sannio durante il secolo XX<br />
1. Premessa 1<br />
2. Popolazione e agricoltura 2<br />
2.1. L’Inchiesta agraria Jacini sulla provincia <strong>di</strong> Benevento 2<br />
2.2. L’agricoltura sannita nella prima metà del secolo XX 3<br />
2.3. Il secondo dopoguerra 5<br />
2.4. La modernizzazione dell’agricoltura 7<br />
2.5. Popolazione e agricoltura alla fine del secolo XX 9<br />
3. Il mancato sviluppo industriale 11<br />
3.1. Le con<strong>di</strong>zioni del settore industriale all’inizio del secolo XX 11<br />
3.2. Guerra e dopoguerra 12<br />
3.3. Le iniziative <strong>degli</strong> anni Venti 13<br />
3.4. Dalla crisi alla seconda guerra mon<strong>di</strong>ale 14<br />
3.5. Il secondo dopoguerra 15<br />
3.6. Un settore in <strong>di</strong>fficoltà 17<br />
4. Lo sviluppo del settore terziario 18<br />
4.1. Il cre<strong>di</strong>to fra Otto e Novecento 18<br />
4.2. Cre<strong>di</strong>to e commercio fra le due guerre mon<strong>di</strong>ali 19<br />
4.3. Il settore terziario nel secondo dopoguerra 21<br />
4.4. La terziarizzazione dell’economia a fine secolo XX 23<br />
La Banca Sannitica (1889-1995)<br />
1. Dalle origini alla prima guerra mon<strong>di</strong>ale 25<br />
1.1. Il cre<strong>di</strong>to a Benevento a fine Ottocento 25<br />
1.2. La nascita della Banca Sannitica 26<br />
1.3. Le <strong>di</strong>fficoltà iniziali 27<br />
1.4. Il consolidamento della Banca nei primi anni del Novecento 28<br />
2. La grande guerra e l’espansione <strong>degli</strong> anni Venti 29<br />
2.1. Gli impieghi negli anni <strong>di</strong> guerra 29<br />
2.2. I «gran<strong>di</strong> affari» del primo dopoguerra 30<br />
2.3. La legge bancaria del 1926 e l’ispezione alla Sannitica 32<br />
3. La crisi e il <strong>di</strong>fficile risanamento 34<br />
3.1. La crisi bancaria <strong>degli</strong> anni Trenta nel Beneventano 34<br />
3.2. La crisi della Banca Sannitica 35<br />
3.3. Un faticoso risanamento 36<br />
4. La Banca Sannitica dalla guerra alla fusione con la Banca Popolare <strong>di</strong> Novara 37<br />
4.1. La Banca negli anni <strong>di</strong> guerra e nel dopoguerra 37<br />
4.2. La Banca sostiene l’agricoltura 38<br />
4.3. Modernizzazione <strong>ed</strong> espansione della Sannitica 40<br />
4.4. Il grande sviluppo della Banca 40<br />
4.5. La fusione con la Popolare <strong>di</strong> Novara 42
1. Premessa<br />
ECONOMIA E SOCIETÀ NEL SANNIO<br />
DURANTE IL SECOLO XX<br />
Gli scritti sull’economia sannita del ventesimo secolo sono veramente pochi e in genere<br />
riguardano particolari momenti e situazioni dell’economia locale. Pochi sono anche<br />
gli stu<strong>di</strong> che hanno un più ampio respiro, capaci cioè <strong>di</strong> tracciare l’evoluzione<br />
dell’economia e della società sannita per un periodo almeno secolare. Oltre alle pregevoli<br />
opere <strong>di</strong> Gianni Vergineo (Storia <strong>di</strong> Benevento e <strong>di</strong>ntorni, 4 voll., Benevento, 1985-<br />
89) e <strong>di</strong> Filippo Bencar<strong>di</strong>no (Benevento. Funzioni urbane e trasformazioni territoriali<br />
tra XI e XX secolo, Napoli, 1991), che trattano perio<strong>di</strong> molto lunghi e hanno scopi più<br />
ampi, solo <strong>di</strong> recente sono apparse pubblicazioni sulla storia dell’economia sannita nel<br />
ventesimo secolo, ad opera <strong>di</strong> Ennio De Simone e Vittoria Ferran<strong>di</strong>no (L’economia sannita<br />
nel ventesimo secolo, Milano, 2003), i quali già si erano occupati <strong>di</strong> alcuni aspetti<br />
particolari della storia economica locale, ricostruendo, in particolare, le vicende<br />
dell’azienda <strong>degli</strong> Alberti (V. Ferran<strong>di</strong>no) e della Banca sannitica (E. De Simone). I capitoli<br />
<strong>di</strong> questi appunti sono tratti, a cura <strong>degli</strong> autori, dagli stu<strong>di</strong> citati ad esclusivo uso<br />
<strong>degli</strong> studenti della <strong>Facoltà</strong> <strong>di</strong> <strong>Scienze</strong> economiche e aziendali della <strong>Università</strong> <strong>degli</strong><br />
Stu<strong>di</strong> del Sannio e perciò non contengono le note a piè <strong>di</strong> pagina, per le quali si rimanda<br />
agli stu<strong>di</strong> originali, basati su fonti archivistiche e su pubblicazioni ufficiali, che tentano<br />
una prima ricostruzione dell’evoluzione economica e sociale della provincia <strong>di</strong> Benevento.<br />
Restano tuttavia ancora da approfon<strong>di</strong>re <strong>di</strong>versi aspetti dell’economia locale, in particolare<br />
quelli riguardanti alcune zone e alcuni paesi più importanti della provincia. Così<br />
come restano da approfon<strong>di</strong>re alcuni legami, che sicuramente vi furono, almeno in certe<br />
epoche storiche, fra potere politico e forze economiche, anche se in qualche modo essi<br />
emergono dagli stu<strong>di</strong> sopra citati e anche se la storia politica è stata ricostruita, con dovizia<br />
<strong>di</strong> particolari, dal Vergineo.<br />
L’evoluzione economica della provincia può essere letta da <strong>di</strong>versi punti <strong>di</strong> vista.<br />
Quello più ovvio è l’esame cronologico, secondo il quale la storia economica della provincia,<br />
come del resto quella dell’intero Paese, si può <strong>di</strong>videre in alcuni perio<strong>di</strong> che<br />
hanno spiccate caratteristiche comuni: a) il periodo che va fino alla prima guerra mon<strong>di</strong>ale,<br />
caratterizzato dall’avvio della rivoluzione industriale, che poco o niente interessò<br />
la provincia sannita; b) il periodo fra le due guerre mon<strong>di</strong>ali, che fra numerose <strong>di</strong>fficoltà,<br />
dovute anche alla crisi dell’economia mon<strong>di</strong>ale, vide alcuni tentativi, non sempre<br />
riusciti, da dare impulso all’economia locale; c) il secondo dopoguerra, in cui si realizzò<br />
una profonda trasformazione dell’economia e della società italiane, che toccò anche il<br />
Sannio.<br />
1
Un altro modo per affrontare lo stu<strong>di</strong>o dell’economia provinciale è quello che tiene<br />
principalmente conto dell’evoluzione strutturale, ossia delle trasformazioni realizzate<br />
nei <strong>di</strong>versi settori produttivi: agricoltura, industria e settore terziario. In questa s<strong>ed</strong>e saranno<br />
sviluppate alcune considerazioni proprio guardando alle mo<strong>di</strong>fiche strutturali, sulla<br />
base <strong>degli</strong> stu<strong>di</strong> sull’economia locale prima ricordati.<br />
2.Popolazione e agricoltura<br />
2.1. L’Inchiesta agraria Jacini sulla provincia <strong>di</strong> Benevento - Una particolarità della<br />
provincia <strong>di</strong> Benevento, nel corso <strong>di</strong> tutto il secolo ventesimo, è stata l’importanza del<br />
settore agricolo. Infatti, la provincia, che all’inizio del secolo era, come molte altre province<br />
meri<strong>di</strong>onali, una provincia conta<strong>di</strong>na, con almeno i quattro quinti della popolazione<br />
attiva de<strong>di</strong>ta all’agricoltura, continuava ad essere, a fine secolo, una provincia conta<strong>di</strong>na,<br />
nel senso che la popolazione attiva in agricoltura era ancora particolarmente elevata.<br />
In un secolo, però, furono fatti molti passi avanti, anche se spesso troppo lenti <strong>ed</strong> incerti.<br />
Il periodo che va fino alla seconda guerra mon<strong>di</strong>ale, tuttavia, fu caratterizzato da<br />
una crescita modestissima, quasi senza alcuna mo<strong>di</strong>fica della struttura produttiva, tanto<br />
che nel 1951 ancora i tre quarti della popolazione attiva erano addetti all’agricoltura.<br />
Dalla fine del conflitto ai nostri giorni, viceversa, sono stati realizzati indubbi progressi,<br />
sull’onda delle profonde trasformazioni subite dal Paese e dal mondo occidentale, anche<br />
se essi sono risultati in <strong>di</strong>versi settori inferiori a quelli realizzati da altre province meri<strong>di</strong>onali.<br />
La provincia <strong>di</strong> Benevento era nata, all’indomani dell’Unità, in modo alquanto artificiale,<br />
con l’aggregazione alla ex città pontificia <strong>di</strong> comuni sottratti alle antiche province<br />
del Regno <strong>di</strong> Napoli. Il rapporto fra la città e la provincia, composta esclusivamente <strong>di</strong><br />
zone <strong>di</strong> collina e <strong>di</strong> montagna e in parte notevolmente arretrata e isolata, non fu sempre<br />
facile. Molti intraprendenti provinciali, tuttavia, si trasferirono nel capoluogo dove si <strong>di</strong><strong>ed</strong>ero<br />
ai più svariati traffici e rimpiazzarono gradualmente l’antica aristocrazia. Essi accrebbero<br />
sicuramente i loro patrimoni me<strong>di</strong>ante l’acquisto <strong>di</strong> case e terreni delle casate<br />
nobili bisognose <strong>di</strong> danaro e delle corporazioni religiose soppresse (numerosissime in città)<br />
e cominciarono a de<strong>di</strong>carsi, oltre che alle tra<strong>di</strong>zionali professioni liberali (erano avvocati,<br />
notai, me<strong>di</strong>ci, farmacisti, ecc.) anche ad attività commerciali e a nuove e più moderne<br />
forme d’impiego dei loro capitali.<br />
All’alba del nuovo secolo, l’agricoltura provinciale era ancora molto arretrata. Quasi<br />
nessun progresso era stato realizzato dall’epoca dell’Inchiesta agraria Jacini, pubblicata<br />
all’inizio <strong>degli</strong> anni Ottanta dell’Ottocento. Quell’inchiesta, o meglio la Monografia agraria<br />
sulla provincia <strong>di</strong> Benevento pre<strong>di</strong>sposta per l’Inchiesta, che però non fu mai<br />
pubblicata, aveva messo in luce come la popolazione della provincia vivesse in centri<br />
abitati <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni non piccole, dal momento che quasi l’88 per cento dei comuni contava<br />
fra mille e seimila abitanti. I conta<strong>di</strong>ni, perciò, erano costretti a lunghi e faticosi<br />
spostamenti per recarsi al lavoro, anche perché il ricordo del recente brigantaggio e<br />
l’insicurezza dei luoghi non invogliavano a inse<strong>di</strong>amenti sparsi, <strong>di</strong> cui peraltro non<br />
sempre si avvertiva l’utilità dal momento che le coltivazioni erano estensive e in genere<br />
non molto varie, sicché il lavoro dei campi si concentrava solo in alcuni perio<strong>di</strong><br />
dell’anno.<br />
2
Le piante più <strong>di</strong>ffuse erano il frumento e il granturco, alternate fra <strong>di</strong> loro, coltivate<br />
con strumenti tra<strong>di</strong>zionali e facendo ricorso, per ridare fertilità al terreno, a concimi naturali<br />
o alla pratica del sovescio, me<strong>di</strong>ante l’interramento <strong>di</strong> piante erbacee al momento<br />
della fioritura per arricchire il terreno <strong>di</strong> sostanze organiche. Anche la vite era coltivata<br />
dovunque, ma il vino, prodotto quasi sempre con proce<strong>di</strong>menti primitivi, era utilizzato<br />
prevalentemente per il consumo locale. Un’insufficiente capacità <strong>di</strong> commercializzazione<br />
ne limitava l’esportazione, che pure avrebbe avuto qualche possibilità, trattandosi <strong>di</strong><br />
vini da taglio a buon mercato. L’olivo era un’altra pianta molto <strong>di</strong>ffusa e dava frutti <strong>di</strong><br />
buona qualità, ma l’olio, prodotto con mole trainate da muli o cavalli, spesso lasciava<br />
molto a desiderare. Una produzione molto importante era quella del tabacco, coltivato<br />
nei <strong>di</strong>ntorni <strong>di</strong> Benevento in gran quantità, nella varietà «Brasile», introdotta verso il<br />
1840 e poi detta «Beneventano», che consentiva <strong>di</strong> ottenere un ottimo tabacco da fumo,<br />
che ormai andava sostituendo quello da fiuto nei gusti dei consumatori. Diffusi erano<br />
pure gli alberi da frutta, le patate, l’avena, gli ortaggi e le leguminose; rare, invece, le<br />
piante foraggiere. L’allevamento del bestiame, <strong>di</strong>fatti, non rivestiva particolare importanza<br />
e gli animali erano tenuti più per necessità domestiche e <strong>di</strong> lavoro che per ricavarne<br />
prodotti destinati alla ven<strong>di</strong>ta. Pochi i bovini e in <strong>di</strong>minuzione anche gli ovini, che un<br />
tempo avevano fatto la ricchezza <strong>di</strong> molte comunità. Qualche rilievo assumeva<br />
l’allevamento dei suini, i cui prodotti servivano non solo al consumo delle famiglie ma<br />
erano talvolta venduti nei mercati <strong>di</strong> Maddaloni e <strong>di</strong> Campobasso.<br />
La gente dei campi abitava case anguste, in promiscuità con gli animali, senza rispettare<br />
alcuna norma igienica e con un vitto insufficiente, specialmente nei mesi invernali.<br />
La donna era a<strong>di</strong>bita a lavori pesanti e la sua con<strong>di</strong>zione era tale da far affermare ad un<br />
contemporaneo che ella «in tutti i rapporti <strong>di</strong> famiglia [era] sempre la schiava<br />
dell’uomo». Né esistevano particolari industrie domestiche in grado <strong>di</strong> integrare gli<br />
scarsi guadagni dei lavoratori della terra, se si escludono i quasi 1.800 telai che tessevano<br />
specialmente il lino e la canapa per uso domestico. I conta<strong>di</strong>ni erano in genere analfabeti<br />
e poco propensi alle innovazioni agricole. La mancanza <strong>di</strong> capitali destinati<br />
all’agricoltura era, infine, una delle carenze maggiormente lamentate, anche se, secondo<br />
un contemporaneo, non vi era «<strong>di</strong> valsente scarsezza», bensì «enormità nei saggi <strong>di</strong> interesse»,<br />
per via del «sodalizio <strong>degli</strong> usurai e dei monopolizzatori della pecunia».<br />
2.2. L’agricoltura sannita nella prima metà del secolo XX - Qualche impulso<br />
all’agricoltura beneventana venne all’inizio del nuovo secolo dal Consorzio agrario cooperativo<br />
<strong>di</strong> Benevento, proprio allora sorto, che arrivò, ben presto a contare 215 soci<br />
tra proprietari <strong>ed</strong> agricoltori. Il Consorzio promosse l’istituzione della Catt<strong>ed</strong>ra ambulante<br />
<strong>di</strong> agricoltura, che in un paio d’anni istituì nella provincia ben tre<strong>di</strong>ci campi sperimentali.<br />
Si tentò pure <strong>di</strong> favorire la mutualità agraria e la cooperazione, anche se permaneva<br />
un rapporto <strong>di</strong> reciproca sfiducia fra coloro che si sarebbero dovuti associare.<br />
Tale atteggiamento causò il fallimento <strong>di</strong> alcune iniziative, come la Lega dei lavoratori<br />
della terra, che giunse a raccogliere più <strong>di</strong> duecento iscritti, e la Società anonima cooperativa<br />
<strong>di</strong> miglioramento fra i lavoratori della terra.<br />
L’ecc<strong>ed</strong>enza <strong>di</strong> manodopera in agricoltura provocò un massiccio esodo <strong>di</strong> conta<strong>di</strong>ni<br />
poveri, costretti a prendere la via dell’emigrazione. Fra il 1886 e il 1914, partirono quasi<br />
160 mila persone, <strong>di</strong> cui i due terzi nei primi quattor<strong>di</strong>ci anni del secolo. La popolazione,<br />
però, continuò ad aumentare, passando da 236 mila residenti nel 1881 a 276 mila nel<br />
3
1921, perché molti emigranti ritornarono al loro paese <strong>di</strong> origine per acquistare, coi sudati<br />
risparmi, una casa oppure un pezzo <strong>di</strong> terra da coltivare in proprio.<br />
Oltre alla coltivazione <strong>di</strong>retta del fondo, una qualche <strong>di</strong>ffusione aveva avuto il contratto<br />
<strong>di</strong> mezzadria, tanto che all’epoca si fece un gran parlare dei vantaggi <strong>di</strong> tale contratto.<br />
Un contemporaneo, autore <strong>di</strong> una monografia sull’agricoltura dell’agro beneventano,<br />
sosteneva l’utilità della mezzadria, che avrebbe prodotto numerosi vantaggi, perché<br />
la «durata indefinita» del contratto e il bisogno che le parti sentivano l’una dell’altra<br />
portavano il mezzadro – secondo lui – a identificarsi col fondo e con la famiglia del padrone.<br />
Dove la mezzadria era più <strong>di</strong>ffusa, come in Toscana, proprio in quegli anni, però,<br />
il malcontento dei mezzadri stava sfociando in scioperi che compromettevano la tanto<br />
decantata «pace nelle campagne» e stimolavano numerose <strong>di</strong>scussioni sulle riforme da<br />
apportare al patto colonico. Forse le continue richieste <strong>di</strong> adozione del contratto <strong>di</strong> mezzadria<br />
nel Beneventano erano anche legate al tentativo della Catt<strong>ed</strong>ra ambulante <strong>di</strong> agricoltura<br />
<strong>di</strong> favorire l’immigrazione <strong>di</strong> coloni delle province romagnole, per sopperire alla<br />
mancanza <strong>di</strong> braccia causata dall’emigrazione.<br />
Ma l’introduzione della mezzadria era <strong>di</strong>fficile in una zona in cui la produzione era<br />
quasi soltanto destinata all’autoconsumo, sicché il conta<strong>di</strong>no, non dovendo pagare un<br />
affitto, si sarebbe limitato a produrre soltanto il necessario per vivere e la metà del raccolto<br />
ottenuta dal proprietario sarebbe stata quasi sempre molto inferiore a quanto egli<br />
sarebbe riuscito a percepire se avesse affittato la sua terra. In realtà, il nocciolo della<br />
questione era proprio nella durata dei contratti. La mezzadria era un contratto annuale<br />
tacitamente rinnovabile, a meno che non fosse intervenuta la <strong>di</strong>sdetta <strong>di</strong> una delle parti.<br />
Il contratto <strong>di</strong> affitto praticato nel Beneventano, viceversa, continuava ad avere una durata<br />
troppo breve e l’affittuario si limitava allo sfruttamento continuo del fondo, non<br />
preoccupandosi <strong>di</strong> conservarne o accrescerne la fertilità, anche perché non si sarebbe visto<br />
riconoscere alcun compenso per le migliorie apportate al fondo alla scadenza del<br />
contratto. Più che introdurre la mezzadria, che era in crisi nelle sue stesse terre <strong>di</strong> elezione,<br />
era necessario, perciò, aumentare la durata del contratto <strong>di</strong> affitto, ma la soluzione<br />
non era gra<strong>di</strong>ta ai proprietari, che così non avrebbero potuto aumentare il canone ad<br />
ogni breve rinnovo contrattuale.<br />
Negli anni compresi fra le due guerre mon<strong>di</strong>ali l’agricoltura sannita non riuscì a progre<strong>di</strong>re<br />
in maniera significativa. Privi <strong>di</strong> cognizioni tecniche e <strong>di</strong> capitali da investire, gli<br />
affittuari, pur attendendo <strong>di</strong>rettamente alla coltura dei fon<strong>di</strong>, non contribuivano molto al<br />
progresso agrario. La classe dei me<strong>di</strong> proprietari, che <strong>di</strong> regola risi<strong>ed</strong>eva in paese, era<br />
rappresentata in genere da professionisti, che affittavano i terreni oppure continuavano a<br />
darli a colonia con contratti misti <strong>di</strong> mezzadria e affitto. La produzione agraria restava<br />
affidata, quin<strong>di</strong>, alla capacità <strong>degli</strong> affittuari. D’altra parte, il pagamento del canone in<br />
grano, previsto in <strong>di</strong>verse zone, determinava la necessità <strong>di</strong> destinare molta terra a questo<br />
prodotto, specialmente quando la produttività naturale dei terreni era modesta e<br />
l’estensione del fondo era grande. La folla dei piccoli proprietari coltivatori, aumentata<br />
notevolmente nei primi anni Venti, concorreva alla produzione agraria quasi esclusivamente<br />
con il fattore lavoro. Si continuava a fare uso della zappa e a praticare<br />
l’avvicendamento granturco-grano, talvolta con il sovescio <strong>di</strong> leguminose concimato<br />
chimicamente. Le macchine agricole erano quasi sconosciute: nel 1928 si contavano,<br />
nell’intera provincia, appena 26 trattrici, <strong>di</strong>ventate 45 nel 1935, per balzare, poi, a 72 nel<br />
1939 e superare il centinaio nel 1942.<br />
4
2.3. Il secondo dopoguerra - L’agricoltura subì le conseguenze del secondo conflitto<br />
mon<strong>di</strong>ale, forse in modo meno apparente <strong>di</strong> altri settori produttivi, ma più incisivo. La<br />
mobilitazione sottrasse più <strong>di</strong> un milione e mezzo <strong>di</strong> unità lavorative alle campagne italiane,<br />
mentre le esigenze della produzione bellica fecero ridurre drasticamente la produzione<br />
<strong>di</strong> fertilizzanti chimici e minerali e privarono molte macchine agricole del combustibile<br />
necessario. L’agricoltura sannita risentì <strong>di</strong> queste circostanze, perché, pur se faceva<br />
scarso ricorso alle macchine agricole, consumava un certo quantitativo <strong>di</strong> fertilizzanti<br />
azotati e fosfatici e <strong>di</strong> antiparassitari. Tuttavia, come avveniva dappertutto, i conta<strong>di</strong>ni<br />
che vendevano i loro prodotti al mercato libero riuscirono a realizzare buoni guadagni,<br />
anche perché la produzione agricola, specie dei cereali, crollò durante la guerra e<br />
i prezzi per conseguenza aumentarono.<br />
Nel 1947, l’estensione me<strong>di</strong>a delle aziende agricole della provincia risultava <strong>di</strong> poco<br />
superiore a 1,5 ettari, con prevalenza <strong>di</strong> quelle fino a 10 ettari (piccola proprietà), che da<br />
sole costituivano il 98,4 per cento del totale e riguardavano il 60,5 per cento della superficie,<br />
con un’ampiezza me<strong>di</strong>a per azienda inferiore a un ettaro. Il contratto agrario più<br />
<strong>di</strong>ffuso continuava ad essere quello <strong>di</strong> affitto, al quale ricorrevano in genere i gran<strong>di</strong><br />
proprietari, con pagamento dei relativi canoni in contanti, in natura o in forma mista.<br />
Nella contingenza del dopoguerra, i proprietari continuavano a sostenere e a preferire il<br />
contratto <strong>di</strong> mezzadria perché, riscuotendo la loro parte in natura, non risentivano della<br />
per<strong>di</strong>ta del valore della moneta, come avveniva per i canoni in contanti, i quali si adeguavano<br />
con ritardo all’aumentato costo della vita. In decadenza era il contratto <strong>di</strong> enfiteusi,<br />
derivante dalla quotizzazione dei beni ex ecclesiastici, mentre limitato a pochi casi<br />
era il grande affitto capitalistico.<br />
Nel 1949, la <strong>di</strong>sastrosa alluvione del fiume Calore provocò gravi danni all’agricoltura,<br />
che già soffriva per una forte contrazione dei prezzi dei prodotti agricoli, con l’unica eccezione<br />
del tabacco. Secondo le rilevazioni dell’Ispettorato dell’agricoltura, i danni<br />
dell’alluvione al settore agricolo ammontarono a 3,2 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> lire e si prev<strong>ed</strong>eva che<br />
molti ettari <strong>di</strong> terreno sarebbero rimasti sterili per parecchio tempo.<br />
Esaurita la fase della ricostruzione, l’economia italiana visse, nel corso <strong>degli</strong> anni<br />
Cinquanta, un periodo <strong>di</strong> rapido sviluppo, realizzato in un quadro <strong>di</strong> espansione dei<br />
mercati e <strong>di</strong> relativa stabilità monetaria, e culminato con il cosiddetto «miracolo economico».<br />
Mentre veniva effettuato lo «storico sorpasso» dell’occupazione industriale su<br />
quella agricola, il problema del sottosviluppo meri<strong>di</strong>onale s’impose prepotentemente<br />
come non più elu<strong>di</strong>bile e <strong>di</strong>venne oggetto <strong>di</strong> un accanito <strong>di</strong>battito e <strong>di</strong> numerosi e <strong>di</strong>scussi<br />
interventi pubblici. L’Italia era allora impegnata in un progressivo inserimento<br />
nel mercato mon<strong>di</strong>ale, affidato alle industrie delle regioni settentrionali, sicché venne<br />
scartata, in un primo momento, una politica <strong>di</strong> industrializzazione del Mezzogiorno, nella<br />
convinzione che le industrie meri<strong>di</strong>onali non avrebbero retto alla concorrenza dei<br />
mercati esteri. Si preferì, viceversa, puntare sulle opere pubbliche per consolidare le infrastrutture<br />
civili, rafforzare il settore agricolo e favorire lo sviluppo del turismo. La<br />
provincia <strong>di</strong> Benevento fu coinvolta nel processo <strong>di</strong> trasformazione dell’economia e della<br />
società italiane, subendone più gli effetti negativi, ampliati dalla sua natura <strong>di</strong> provincia<br />
interna a carattere agricolo, che profittando dei vantaggi che potevano derivarle dalla<br />
fase <strong>di</strong> sviluppo economico e sociale senza prec<strong>ed</strong>enti che il Paese stava conoscendo.<br />
Un primo intervento <strong>di</strong> grande rilievo fu la riforma fon<strong>di</strong>aria, <strong>di</strong> cui si parlava da<br />
tempo e che riguardò principalmente il Mezzogiorno. La riforma, come altre leggi approvate<br />
in quegli anni, tendeva in sostanza, a incrementare la piccola proprietà conta<strong>di</strong>-<br />
5
na e perciò non ebbe pratica applicazione nella provincia <strong>di</strong> Benevento, dove tale forma<br />
<strong>di</strong> proprietà era già prevalente e dove in sostanza non esistevano latifon<strong>di</strong> incolti che potessero<br />
rientrare nei casi previsti dalla riforma. Viceversa, altre <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge del<br />
1952 e del 1956, che introducevano agevolazioni fiscali per l’acquisto <strong>di</strong> terre da parte<br />
dei conta<strong>di</strong>ni, ebbero maggiore successo e numerose furono le richieste per ottenere le<br />
agevolazioni previste. Proprio in quegli anni, <strong>di</strong>fatti, in tutta la provincia, piccoli proprietari<br />
e affittuari coltivatori <strong>di</strong>retti stavano acquistando fon<strong>di</strong> <strong>di</strong> limitate <strong>di</strong>mensioni.<br />
Erano terreni appartenenti a professionisti, commercianti e piccoli industriali, che cominciavano<br />
ad alienarli per investire il ricavato in impieghi più proficui e «<strong>di</strong> più <strong>di</strong>fficile<br />
rilevazione da parte del fisco».<br />
Nel 1950 fu anche istituita la Cassa per il Mezzogiorno, che doveva provv<strong>ed</strong>ere alla<br />
realizzazione delle infrastrutture nel settore agricolo e in quello industriale. La riforma<br />
fon<strong>di</strong>aria e l’intervento della Cassa per il Mezzogiorno agevolarono la creazione <strong>di</strong> una<br />
vasta rete <strong>di</strong> piccole aziende conta<strong>di</strong>ne. Nel settore agricolo, fallito l’obiettivo <strong>di</strong> accrescere<br />
l’occupazione, si passò a interventi tendenti a migliorarne l’efficienza, me<strong>di</strong>ante la<br />
meccanizzazione, con la conseguenza <strong>di</strong> accelerare l’esodo dalle campagne, soprattutto<br />
dalle zone più interne.<br />
Fra le misure che maggiormente ebbero un’influenza positiva vi fu indubbiamente il<br />
cosiddetto «piano dodecennale», approvato con legge del 1952, che prev<strong>ed</strong>eva finanziamenti<br />
agevolati agli agricoltori, da destinare all’acquisto <strong>di</strong> macchine agricole <strong>di</strong> produzione<br />
italiana, alla costruzione <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> irrigazione e alla costruzione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici<br />
rurali. La provincia <strong>di</strong> Benevento beneficiò <strong>di</strong> mutui per almeno un miliardo, destinati<br />
per circa il 60 per cento all’acquisto <strong>di</strong> macchine agricole e per il resto quasi esclusivamente<br />
alla costruzione <strong>di</strong> fabbricati rurali, risultando del tutto irrilevante la quota assegnata<br />
alle opere <strong>di</strong> irrigazione.<br />
A partire dal dopoguerra si registrò un grande esodo <strong>di</strong> masse conta<strong>di</strong>ne dal Mezzogiorno,<br />
dapprima verso l’estero e poi verso le regioni dell’Italia settentrionale che costituivano<br />
il cosiddetto «triangolo industriale» (Piemonte, Liguria e Lombar<strong>di</strong>a). Fino al<br />
1957, le mete preferite furono gli Stati Uniti, l’Argentina e il Brasile, ma anche il Venezuela,<br />
il Canada e l’Australia; in seguito si cominciarono a preferire i paesi europei, come<br />
la Germania F<strong>ed</strong>erale e la Svizzera. La migrazione dal Sud al Nord del Paese dovette<br />
coinvolgere almeno due <strong>di</strong> milioni <strong>di</strong> persone nel ventennio compreso fra il 1951 e il<br />
1971. L’esodo dalle campagne portò con sé gli inevitabili problemi che accompagnano<br />
questi fenomeni. Siccome a partire erano i giovani, la struttura demografica <strong>di</strong> molti<br />
comuni delle zone interne ne risultò mo<strong>di</strong>ficata e i centri abitati videro il prevalere delle<br />
persone anziane, che alimentavano un limitato flusso <strong>di</strong> consumi. La popolazione residente<br />
nella provincia risultava, al censimento del 1951, <strong>di</strong> quasi 332 mila abitanti, con un<br />
aumento <strong>di</strong> circa 29 mila unità rispetto alla prec<strong>ed</strong>ente rilevazione censuaria del 1936.<br />
Nei venti anni successivi, essa subì una forte contrazione, portandosi, nel 1971, a poco<br />
più <strong>di</strong> 286 mila abitanti. La provincia sannita perdette, fra il 1951 e il 1971, ben 114 mila<br />
in<strong>di</strong>vidui, che emigrarono all’estero o si spostarono in altre province italiane. Ciò significa<br />
che se non vi fosse stata emigrazione, la provincia avrebbe avuto almeno altri 114 mila<br />
abitanti, o ancora <strong>di</strong> più, se si considera il naturale incremento <strong>di</strong> questo gruppo per<br />
l’ecc<strong>ed</strong>enza delle nascite sulle morti, portando la popolazione intorno ai 400 mila abitanti.<br />
È facile comprendere quale sarebbe stata la sorte della provincia se avesse dovuto<br />
mantenere una popolazione così numerosa.<br />
6
2.4. La modernizzazione dell’agricoltura - La città <strong>di</strong> Benevento conservava la caratteristica<br />
<strong>di</strong> città semirurale, perché ancora nel 1951 un terzo della popolazione era costituita<br />
da ceti agricoli, mentre la popolazione de<strong>di</strong>ta alle attività industriali, raggiunto il<br />
suo punto massimo nel 1961, con quasi il 30 per cento, cominciò a <strong>di</strong>minuire per portarsi<br />
al 20 per cento trent’anni più tar<strong>di</strong>. Un elemento che rende evidente la natura delle<br />
trasformazioni economiche e sociali in atto in quei decenni è costituito dai mutamenti<br />
nella <strong>di</strong>stribuzione della popolazione attiva per settori produttivi. Il primo censimento<br />
del dopoguerra fotografava una provincia rimasta sostanzialmente ferma ai valori<br />
dell’anteguerra, con una nettissima prevalenza del settore agricolo, che interessava più<br />
dei tre quarti della popolazione attiva: il 77,5 per cento nel 1936 e il 76,2 per cento nel<br />
1951. Anche negli altri settori la situazione restava immutata. Nel ventennio successivo,<br />
invece, si registrò il crollo della popolazione attiva in agricoltura, che si portò al 48,6<br />
per cento. Si trattava comunque <strong>di</strong> un valore ancora molto elevato, pari a più del doppio<br />
<strong>di</strong> quello della Campania e a quasi il triplo <strong>di</strong> quello italiano. Contemporaneamente si<br />
assisteva ad una crescita parallela sia del settore industriale che <strong>di</strong> quello terziario. Fra il<br />
1951 e il 1971, <strong>di</strong>fatti, la popolazione attiva nell’industria passò dal 12 al 26 per cento<br />
del totale e quella impiegata nel settore terziario da quasi il 12 a più del 25 per cento,<br />
anche se entrambe si mantennero molto al <strong>di</strong> sotto dei dati regionali e nazionali.<br />
Se si prende in considerazione sviluppo del r<strong>ed</strong><strong>di</strong>to provinciale, si nota come esso,<br />
pur facendo registrare un consistente incremento, risultasse, nel 1970, ancora intorno ai<br />
quattro quinti <strong>di</strong> quello regionale e alla metà <strong>di</strong> quello nazionale. La provincia, inoltre,<br />
continuava a occupare uno <strong>degli</strong> ultimi posti nella graduatoria delle province italiane per<br />
r<strong>ed</strong><strong>di</strong>to pro-capite. Nel 1959, per esempio, essa era al settantanovesimo posto fra le novantadue<br />
province italiane e prec<strong>ed</strong>eva, in Campania, quelle <strong>di</strong> Caserta <strong>ed</strong> Avellino. Nel<br />
1970, era scesa al novantesimo posto (su novantatré province) e fra quelle campane riusciva<br />
a prec<strong>ed</strong>ere soltanto Avellino, che occupava l’ultimo posto. Tuttavia, il miglioramento<br />
delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> vita della popolazione era evidente, come si può ricavare<br />
dall’incremento <strong>di</strong> alcuni consumi. Per citare solo qualche esempio, le autovetture circolanti<br />
nella provincia, che erano appena un migliaio nel 1952, erano passate a oltre 2.600<br />
cinque anni più tar<strong>di</strong> per balzare a più <strong>di</strong> 26 mila nel 1969. Gli apparecchi telefonici installati<br />
crebbero ad un ritmo più lento: appena 1.100 nel 1952, oltre 2.500 nel 1957 e più<br />
<strong>di</strong> 16 mila nel 1969.<br />
La provincia era stata trascinata, nel corso <strong>degli</strong> anni Cinquanta e Sessanta dalla crescita<br />
economica e dalle trasformazioni sociali in atto in tutto il Paese e, per la prima volta<br />
nella sua storia, stava subendo mo<strong>di</strong>ficazioni profonde e irreversibili. Pur rimanendo<br />
ancora troppo legata all’agricoltura, la sua popolazione non affidava più quasi esclusivamente<br />
al settore primario le sue speranze <strong>di</strong> sopravvivenza e <strong>di</strong> miglioramento delle<br />
proprie con<strong>di</strong>zioni materiali. La gente sannita cominciò ad emigrare in gran numero.<br />
Quella che non poté o non volle farlo fu in grado <strong>di</strong> trovare qualche occupazione<br />
nell’e<strong>di</strong>lizia e nel settore terziario, in particolare nel pubblico impiego e nel commercio.<br />
Certo, le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> vita migliorarono considerevolmente, anche grazie alle rimesse<br />
<strong>degli</strong> emigrati e alla crescita del numero dei pensionati, ma la provincia rimaneva fra le<br />
più arretrate della Campania e dell’Italia. Come in molte altre zone interne del Mezzogiorno,<br />
si perpetuava da tempo una sorta <strong>di</strong> persistenza dell’agricoltura, che teneva legate<br />
alla terra masse consistenti <strong>di</strong> persone, le quali in una società tra<strong>di</strong>zionale, con scarsi<br />
consumi, riuscivano appena a sopravvivere. L’evoluzione <strong>di</strong> quegli anni, con<br />
l’incremento dei consumi <strong>di</strong> beni durevoli e con nuove esigenze, emarginò il mondo ru-<br />
7
ale, tanto che gli agricoltori cominciarono anche ad avere <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> trovare moglie,<br />
perché le ragazze mostravano <strong>di</strong> preferire semmai un operaio e la vita della città piuttosto<br />
che il duro e incerto lavoro dei campi.<br />
Uno dei fattori più importanti della modernizzazione dell’agricoltura sannita fu indubbiamente<br />
la meccanizzazione, favorita dal ricordato «piano dodecennale» e dalle<br />
successive provvidenze governative previste dai cosiddetti «Piani Verde» <strong>degli</strong> anni<br />
Sessanta, destinati a finanziare in particolare l’acquisto <strong>di</strong> macchine agricole e<br />
l’ampliamento delle coltivazioni intensive, fissando nuove proc<strong>ed</strong>ure per l’accesso al<br />
cre<strong>di</strong>to agevolato. La meccanizzazione fece registrare, nel Beneventano, una crescita<br />
superiore a quella delle altre province della regione, anche perché qui si partiva da con<strong>di</strong>zioni<br />
<strong>di</strong> maggiore ritardo. Prendendo in considerazione le trattrici, che costituiscono la<br />
macchina forse più significativa, si nota come esse, che nel 1948 si erano ridotte ad appena<br />
62, nel 1952 fossero arrivate a 94 e nel 1961 a 782, per poi balzare a 5.964 nel<br />
1970. D’altra parte, in presenza <strong>di</strong> un massiccio esodo dalle campagne e <strong>di</strong> un incremento<br />
del costo della manodopera, il ricorso alle macchine era il modo più appropriato per<br />
abbattere i costi <strong>di</strong> produzione.<br />
Verso la metà <strong>degli</strong> anni Sessanta, un sostegno alla produzione agricola venne dalla<br />
politica agraria comunitaria. Com’è noto, la Comunità fissava ogni anno i prezzi <strong>di</strong> riferimento<br />
per il mercato e si impegnava a ritirare le derrate che i produttori non riuscivano a<br />
collocare. Questa politica ebbe un’influenza notevole su una delle produzioni più importanti<br />
del Beneventano: il tabacco, allora in forte espansione. La Comunità europea decise<br />
la liberalizzazione della coltura e si impegnò a ritirare qualunque quantitativo <strong>di</strong> tabacco<br />
invenduto ad un prezzo prestabilito, nonché a fornire aiuti finanziari per promuovere la<br />
specializzazione delle colture e un premio del 15 per cento sul prezzo ai produttori che<br />
compravano tabacco comunitario, in modo da scoraggiare l’importazione <strong>di</strong> tabacchi da<br />
paesi esterni alla Comunità. Nel 1970, il monopolio statale dei tabacchi fu abolito, ma le<br />
ex Agenzie continuarono ad acquistare il tabacco dai produttori in regime <strong>di</strong> concorrenza,<br />
obbligandoli a organizzarsi per non subire una riduzione dei prezzi.<br />
La produzione <strong>di</strong> vino, che agli inizi <strong>degli</strong> anni Cinquanta si manteneva sui 400 mila<br />
ettolitri, si attestò, a metà anni Settanta, intorno al milione <strong>di</strong> ettolitri. I meto<strong>di</strong> <strong>di</strong> produzione<br />
erano molto migliorati rispetto agli anni del dopoguerra e la produzione si cominciava<br />
ad affermare come produzione <strong>di</strong> qualità, anche se continuava ad essere praticata<br />
da aziende <strong>di</strong> modeste <strong>di</strong>mensioni e l’uva si seguitava a vendere a compratori <strong>di</strong> altre<br />
province. Nel corso <strong>degli</strong> anni Sessanta iniziarono a sorgere, in questo ramo <strong>di</strong> attività,<br />
alcune cooperative che, se non erano le prime in senso assoluto nel Sannio, furono certamente<br />
quelle che <strong>di</strong><strong>ed</strong>ero i frutti più maturi. Nel 1960 fu fondata, a Guar<strong>di</strong>a Sanframon<strong>di</strong>,<br />
la cantina sociale «La Guar<strong>di</strong>ense», seguita, qualche anno più tar<strong>di</strong>, dalla Cantina<br />
sociale <strong>di</strong> Solopaca, il cui vino aveva ottenuto la denominazione <strong>di</strong> origine controllata, e<br />
dalla Cantina sociale del Taburno a Foglianise.<br />
La maggiore partecipazione alla formazione della produzione lorda ven<strong>di</strong>bile, tuttavia,<br />
derivava, negli anni Sessanta, dalla zootecnia e in particolare dalla produzione <strong>di</strong><br />
carne e uova. Anche nella zootecnia, comunque, lo sviluppo fu favorito dal sostegno dei<br />
prezzi da parte della Comunità europea, nonché dalle provvidenze governative contenute<br />
nei Piani Verde e in altre <strong>di</strong>sposizioni, come la «legge ponte» per la montagna, che<br />
prev<strong>ed</strong>eva, fra l’altro, mutui per l’acquisto <strong>di</strong> bestiame. Incoraggiato da questi interventi<br />
e per impulso delle organizzazioni e <strong>degli</strong> uomini più vicini ai problemi <strong>degli</strong> allevatori,<br />
8
sia pure tra molte <strong>di</strong>fficoltà, cominciò a svilupparsi, verso la fine <strong>degli</strong> anni Sessanta, il<br />
movimento cooperativo per l’allevamento razionale del bestiame.<br />
Una novità <strong>di</strong> grande rilievo per il mondo conta<strong>di</strong>no fu l’introduzione, nel 1954,<br />
dell’assistenza sanitaria. Da sempre, per i conta<strong>di</strong>ni, la malattia era una sorta <strong>di</strong> male<strong>di</strong>zione,<br />
contro la quale era <strong>di</strong>fficile combattere, perché me<strong>di</strong>ci, me<strong>di</strong>cine, visite specialistiche<br />
e ricoveri in osp<strong>ed</strong>ale erano in genere fuori della loro portata economica e, per<br />
conseguenza, avevano finito per essere estranei alla loro formazione culturale. Perciò,<br />
l’apertura della Cassa mutua dei coltivatori <strong>di</strong>retti costituì un evento epocale, e come tale<br />
fu avvertito dalle masse rurali.<br />
La <strong>di</strong>stribuzione della proprietà fon<strong>di</strong>aria subì, nel corso <strong>degli</strong> anni Cinquanta, mo<strong>di</strong>ficazioni<br />
<strong>di</strong> qualche rilievo, senza tuttavia che la struttura incentrata sulla prevalenza<br />
della piccola proprietà risultasse mo<strong>di</strong>ficata <strong>di</strong> molto. Fra la fine della guerra e il 1961 si<br />
assistette alla contrazione del numero complessivo delle aziende e all’aumento della loro<br />
ampiezza me<strong>di</strong>a, che era tuttavia ancora molto limitata. La proprietà fon<strong>di</strong>aria era e<br />
rimaneva frazionata, anche se non più ai livelli prec<strong>ed</strong>enti. Ma la piccola proprietà continuava<br />
a costituire il 94 per cento delle aziende e ad occupare oltre il 60 per cento della<br />
superficie agricola e forestale. E nulla cambiò nel corso <strong>degli</strong> anni Sessanta, quando si<br />
assistette ad un’ulteriore riduzione del numero delle aziende e della superficie coltivata.<br />
La conduzione <strong>di</strong>retta del fondo <strong>di</strong>venne la forma prevalente <strong>di</strong> conduzione della terra.<br />
Essa riguardava all’incirca i nove decimi delle aziende e i tre quarti della superficie, con<br />
una tendenza, nel corso <strong>degli</strong> anni Sessanta, ad un leggero rafforzamento della sua presenza.<br />
In <strong>di</strong>minuzione, viceversa, erano le aziende condotte a mezzadria, già in verità <strong>di</strong><br />
modesta consistenza, e quasi immutata la presenza delle aziende condotte con salariati<br />
e/o compartecipanti.<br />
Intanto, il ruolo della Cassa per il Mezzogiorno si stava progressivamente esaurendo,<br />
anche perché la normativa della Comunità europea, per tutelare la concorrenza e la parità<br />
<strong>di</strong> trattamento fra le imprese, vietava ai governi nazionali <strong>di</strong> accordare forme <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>o<br />
a singole imprese o ad aree geografiche. A metà <strong>degli</strong> anni Ottanta la Cassa venne<br />
messa in liquidazione e nel 1992 fu sancita la fine dell’intervento straor<strong>di</strong>nario nel Mezzogiorno,<br />
sostituito con forme <strong>di</strong> intervento generale a favore <strong>di</strong> tutte le aree in <strong>di</strong>fficoltà<br />
del Paese, in stretto coor<strong>di</strong>namento con la Comunità europea, <strong>di</strong>ventata ormai Unione<br />
Europea. Tali interventi si basavano sul sistema del cofinanziamento, vale a <strong>di</strong>re sul<br />
concorso <strong>di</strong> fon<strong>di</strong> comunitari e fon<strong>di</strong> nazionali.<br />
2.5. Popolazione e agricoltura alla fine del secolo XX - Il <strong>di</strong>vario fra il Mezzogiorno<br />
e il Centro-Nord, in termini <strong>di</strong> r<strong>ed</strong><strong>di</strong>to me<strong>di</strong>o per abitante, che si era ridotto durante il<br />
miracolo economico, cominciò <strong>di</strong> nuovo ad allargarsi a partire dagli anni Ottanta e a ritornare<br />
ai livelli del dopoguerra. La forte <strong>di</strong>soccupazione delle aree meri<strong>di</strong>onali e la <strong>di</strong>ffusione<br />
del lavoro nero portarono ad una ripresa dell’emigrazione, che si era prec<strong>ed</strong>entemente<br />
ridotta <strong>ed</strong> anzi era stata accompagnata da un lieve flusso <strong>di</strong> ritorno. Questa volta,<br />
però, al contrario <strong>di</strong> quanto era avvenuto negli anni successivi alla fine della guerra,<br />
l’emigrazione non riguardò lavoratori generici, ma lavoratori qualificati. Tuttavia è innegabile<br />
che, nell’arco <strong>di</strong> mezzo secolo, il Mezzogiorno uscì dalla stretta della povertà<br />
materiale, anche se restavano irrisolti numerosi problemi, come quello della <strong>di</strong>soccupazione,<br />
della scarsità <strong>di</strong> risorse idriche, dell’inefficienza della pubblica amministrazione,<br />
della bassa qualità dei servizi da essa offerti e della criminalità organizzata.<br />
9
La provincia <strong>di</strong> Benevento non poteva non essere influenzata da questi rivolgimenti<br />
economici che riguardavano il mondo e l’Italia. Un primo elemento che caratterizzò il<br />
periodo compreso fra i censimenti del 1971 e del 2001 fu la stazionarietà della popolazione<br />
provinciale. Anche la popolazione del capoluogo non aumentò, al contrario <strong>di</strong><br />
quanto era sempre avvenuto nel passato. Negli ultimi decenni del secolo, il capoluogo<br />
sannita, che continuò ad ospitare più del 21 per cento della popolazione provinciale,<br />
perdette definitivamente la caratteristica <strong>di</strong> città semirurale, che aveva sempre avuto, per<br />
assumere la caratteristica <strong>di</strong> città legata al terziario e in particolare al commercio, ai servizi<br />
e alla pubblica amministrazione. Il grado d’istruzione della popolazione provinciale<br />
continuava, intanto a crescere. Gli analfabeti, che erano ancora il 13,6 per cento nel<br />
1971, si erano <strong>di</strong>mezzati venti anni dopo. La loro percentuale, purtroppo, non riusciva a<br />
portarsi al livello <strong>di</strong> quella nazionale (2,1 per cento nel 1991) né al livello <strong>di</strong> quella regionale<br />
(4,2 per cento). In <strong>di</strong>minuzione erano anche le persone in possesso della licenza<br />
elementare, a vantaggio <strong>di</strong> coloro che riuscivano a conseguire la licenza <strong>di</strong> scuola me<strong>di</strong>a<br />
inferiore, il <strong>di</strong>ploma e la laurea. All’inizio <strong>degli</strong> anni Novanta, la provincia ebbe anche<br />
la sua università, sorta come s<strong>ed</strong>e gemmata dell’<strong>Università</strong> <strong>degli</strong> Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> Salerno e <strong>di</strong>ventata<br />
autonoma solo più tar<strong>di</strong>, nel 1998, con il nome <strong>di</strong> <strong>Università</strong> <strong>degli</strong> Stu<strong>di</strong> del<br />
Sannio.<br />
L’agricoltura continuò a costituire un settore molto importante per l’economia beneventana<br />
e a svolgere un ruolo economico e sociale <strong>di</strong> rilievo anche negli ultimi decenni<br />
del ventesimo secolo, anche se all’inizio <strong>degli</strong> anni Novanta il r<strong>ed</strong><strong>di</strong>to me<strong>di</strong>amente percepito<br />
da ciascun addetto agricolo era ancora meno del 40 per cento <strong>di</strong> quello <strong>degli</strong> addetti<br />
in altri settori e la forza lavoro impiegata in agricoltura era superiore <strong>di</strong> almeno un<br />
terzo a quella effettivamente occorrente. La meccanizzazione conobbe un ulteriore balzo<br />
in avanti nel corso <strong>degli</strong> anni Settanta, quando il numero <strong>di</strong> trattrici raddoppiò e quello<br />
dei motocoltivatori arrivò quasi a quadruplicarsi, mentre le rese agricole si portarono<br />
a livelli molto più vicini a quelli nazionali. La trasformazione dell’agricoltura era evidente<br />
anche nella <strong>di</strong>stribuzione della proprietà fon<strong>di</strong>aria, che, fra il 1970 e il 1990, mostrò<br />
una continua <strong>di</strong>minuzione sia della superficie agraria e forestale complessiva sia del<br />
numero <strong>di</strong> aziende. Nel 1990, la conduzione <strong>di</strong>retta del coltivatore interessava ormai il<br />
98,9 per cento delle aziende e i fon<strong>di</strong> erano condotti, nella stragrande maggioranza, soltanto<br />
con manodopera familiare.<br />
La coltivazione dei cereali seguitò a rivestire un’importanza notevole, anche se la superficie<br />
ad essi destinata fu in costante <strong>di</strong>minuzione, non solo in valori assoluti ma principalmente<br />
in valori percentuali. Le piante industriali ebbero una notevole <strong>di</strong>ffusione.<br />
La produzione lorda ven<strong>di</strong>bile fece registrare una crescita <strong>di</strong> rilevanti proporzioni, tanto<br />
che, nella seconda metà <strong>degli</strong> anni Ottanta, in appena un quinquennio, il suo valore<br />
giunse quasi a triplicarsi e la sua percentuale <strong>di</strong> partecipazione alla produzione totale<br />
raddoppiò. Tali risultati furono raggiunti grazie all’estensione della coltivazione del tabacco,<br />
anche se non va taciuto il contributo della coltivazione del girasole, che da poco<br />
era stata introdotta nella provincia sannita.<br />
I contributi della Comunità europea portarono ad una forte estensione della tabacchicoltura,<br />
che si spinse anche in terreni poco adatti, come quelli dell’alto Tammaro e del<br />
Fortore, e assunse forme intensive <strong>di</strong> coltivazione nelle zone vallive, provocando talvolta<br />
l’impoverimento dei suoli. Sorsero anche numerose cooperative, impegnate sia<br />
nell’assistenza e nella promozione della produzione sia nella raccolta, lavorazione e<br />
commercializzazione del prodotto, in modo da poter meglio <strong>di</strong>fendere gli interessi dei<br />
10
coltivatori. La nuova normativa comunitaria, introdotta negli anni Novanta, però, mise<br />
in crisi tale coltivazione. La Comunità mo<strong>di</strong>ficò le sue modalità <strong>di</strong> sostegno, non intervenendo<br />
più per garantire un prezzo prestabilito ai produttori <strong>di</strong> tabacco, ma impegnandosi<br />
ad integrare i loro ricavi con un premio. A rendere più <strong>di</strong>fficile la situazione dei<br />
produttori, si aggiunse, oltre alla normativa comunitaria, la competizione internazionale,<br />
che v<strong>ed</strong>eva la forte concorrenza <strong>di</strong> alcuni paesi del Terzo Mondo, in cui il costo della manodopera<br />
era bassissimo, e la <strong>di</strong>minuzione dei consumi <strong>di</strong> tabacco, in conseguenza <strong>di</strong><br />
nuovi stili <strong>di</strong> vita. Negli ultimi anni del ventesimo secolo, perciò, si assistette ad una forte<br />
contrazione della superficie destinata a questa coltivazione, con un conseguente crollo<br />
della produzione.<br />
La produzione <strong>di</strong> vino, che aveva superato il milione <strong>di</strong> ettolitri a metà anni Settanta,<br />
si mantenne su tali livelli anche successivamente. Ormai ci si orientava verso la produzione<br />
<strong>di</strong> qualità, sancita, nel 1986, dall’ottenimento della denominazione <strong>di</strong> origine controllata<br />
per il vino <strong>di</strong> Solopaca e per l’Aglianico del Taburno, ai quali si aggiunsero in<br />
seguito il Guar<strong>di</strong>olo e il S. Agata dei Goti. Tuttavia, nonostante la presenza <strong>di</strong> numerose<br />
aziende vitivinicole moderne, la produzione <strong>di</strong> qualità riguardava ancora una piccola<br />
quantità del vino prodotto in provincia. Fu osservato che l’estensione delle aziende era<br />
ancora troppo piccola, anche <strong>di</strong> mezzo ettaro, e l’introduzione <strong>di</strong> nuovi vitigni aveva a<br />
volte snaturato l’antico assetto delle varietà che garantivano pregio e tipicità alla produzione<br />
locale, ma indubbiamente il comparto vitivinicolo fu uno <strong>di</strong> quelli «strategici» che<br />
<strong>di</strong><strong>ed</strong>e i migliori risultati. Pure l’olivicoltura conobbe un periodo <strong>di</strong> notevole espansione,<br />
grazie al sostegno comunitario, tanto che la superficie coltivata finì col rappresentare oltre<br />
il 20 per cento della superficie destinata ad olivo nella regione Campania.<br />
L’allevamento del bestiame, dopo l’incremento registrato nei decenni prec<strong>ed</strong>enti, fu sostanzialmente<br />
stazionario negli anni Settanta e Ottanta, nonostante gli interventi pubblici<br />
a favore del settore.<br />
Ma ormai la trasformazione dell’agricoltura e del mondo rurale del Sannio era avviata<br />
e finalmente i conta<strong>di</strong>ni erano riusciti a sollevarsi dalle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> miseria in cui<br />
erano vissuti per secoli, anche se ciò aveva comportato duri sacrifici e aveva costretto<br />
molti <strong>di</strong> loro a sra<strong>di</strong>carsi dalle campagne e troppo spesso a prendere la via<br />
dell’emigrazione.<br />
3. Il mancato sviluppo industriale<br />
3.1. Le con<strong>di</strong>zioni del settore industriale all’inizio del secolo XX - Il secolo ventesimo<br />
ha assistito alla forzata industrializzazione dell’Italia e successivamente alla sua<br />
deindustrializzazione, nel senso che all’affermazione della grande impresa industriale ha<br />
fatto seguito il suo declino, a vantaggio della piccola e me<strong>di</strong>a impresa, mai scomparsa,<br />
ma <strong>di</strong> recente assurta a effettivo nerbo dell’attività industriale nazionale. Il Sannio ha<br />
tentato in varie occasioni <strong>di</strong> agganciare lo sviluppo industriale italiano, senza tuttavia<br />
riuscirvi, sicché ha finito, in qualche modo, per saltare la fase dell’industrializzazione e<br />
passare <strong>di</strong>rettamente alla terziarizzazione della sua economia. Eppure qualche tentativo<br />
è stato fatto e <strong>di</strong> esso si tenterà <strong>di</strong> rendere conto.<br />
A fine Ottocento erano censiti, in provincia <strong>di</strong> Benevento, oltre 4.300 operai occupati<br />
nelle industrie, molti dei quali, però, riuscivano a lavorare soltanto qualche mese<br />
all’anno. Si trattava spesso <strong>di</strong> conta<strong>di</strong>ni momentaneamente <strong>di</strong>stolti dalle loro consuete<br />
11
occupazioni, sicché non più <strong>di</strong> duemila operai si potevano considerare stabilmente impiegati<br />
negli opifici della provincia. L’attività industriale, come in molte parti del Mezzogiorno,<br />
aveva prevalentemente carattere artigianale <strong>ed</strong> era strettamente collegata al<br />
mondo agricolo circostante, non soltanto per la fornitura <strong>di</strong> materie prime, quanto e soprattutto<br />
per i legami che gran parte della forza lavoro industriale conservava con la famiglia<br />
conta<strong>di</strong>na <strong>di</strong> origine.<br />
Il censimento delle imprese industriali del 1911 registrò oltre 5.000 lavoranti e quasi<br />
1.900 esercizi, con un numero me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> addetti per esercizio <strong>di</strong> 2,8 unità. È evidente che<br />
si trattava <strong>di</strong> attività a carattere prevalentemente artigianale. I più numerosi, <strong>di</strong>fatti, erano<br />
gli addetti alla lavorazione <strong>di</strong> cuoio e pelli, vale a <strong>di</strong>re semplici calzolai che erano<br />
presenti anche nei paesi più piccoli. Ad essi seguivano i lavoratori del legno e della fabbricazione<br />
<strong>di</strong> mobili, fra i quali prevalevano i falegnami, quelli dell’abbigliamento e<br />
biancheria, dove erano numerosissimi i sarti e le sarte, o ancora gli addetti ai frantoi da<br />
olio, che però riuscivano a lavorare solo uno o due mesi all’anno.<br />
Pochissimi erano gli stabilimenti e gli opifici <strong>di</strong> qualche rilievo, in genere concentrati<br />
nel capoluogo, che assorbivano solo un limitato numero <strong>di</strong> operai. Qui, nel clima postunitario<br />
si erano sviluppate alcune delle iniziative economiche più durature della provincia,<br />
ancora oggi in attività, come la fabbrica <strong>di</strong> liquori <strong>degli</strong> Alberti e il pastificio dei<br />
Rummo, oltre al mobilificio Russo, sorto qualche anno prima. La Ditta Alberti utilizzava<br />
i nuovi ritrovati della scienza enologica e moderne attrezzature, riuscendo, perciò, a<br />
produrre scelti vini da pasto e spumanti, oltre ai vari tipi <strong>di</strong> liquori, tra cui riscuoteva un<br />
notevole successo lo Strega. Anche lo stabilimento Rummo si serviva <strong>di</strong> macchine<br />
all’avanguar<strong>di</strong>a per la macinazione dei cereali e per la fabbricazione delle paste alimentari.<br />
Grossi miglioramenti si registravano anche nella produzione del torrone, dove primeggiavano<br />
la Ditta Giuseppe Sifo e le Fabbriche Riunite <strong>di</strong> Torrone, sorte nel 1908 intorno<br />
al nucleo originario della Ditta Giambattista Galasso. A San Marco dei Cavoti, infine,<br />
operava fin dal 1891 la fabbrica fondata da Innocenzo Borrillo, ancora oggi in attività.<br />
Altre attività <strong>di</strong> tipo industriale erano rivolte, per esempio, alla lavorazione <strong>di</strong> oggetti<br />
in metallo e alle costruzioni e<strong>di</strong>lizie e stradali.<br />
3.2. Guerra e dopoguerra - Il primo conflitto mon<strong>di</strong>ale non ebbe effetti negativi sulla<br />
fragile economia beneventana. Anzi, qualche impulso derivò dalla possibilità per alcune<br />
aziende <strong>di</strong> collocare nelle zone <strong>di</strong> guerra alcuni suoi prodotti, come il torrone e i<br />
liquori, che venivano anche acquistati dall’Esercito per essere <strong>di</strong>stribuiti alla truppa.<br />
Purtroppo alla fine del conflitto, qualche produttore si trovò in <strong>di</strong>fficoltà per la fine delle<br />
commesse e anche perché non riuscì a farsi pagare dai clienti dell’Italia settentrionale.<br />
L’alto prezzo del carbone consentì pure <strong>di</strong> sfruttare, nell’imme<strong>di</strong>ato dopoguerra, il<br />
giacimento <strong>di</strong> lignite presente nella piana <strong>di</strong> Morcone, ad opera <strong>di</strong> una Società Anonima<br />
delle Ligniti <strong>di</strong> Morcone, con s<strong>ed</strong>e a Roma. La Camera <strong>di</strong> commercio, sorta nel<br />
1902, superati i primi momenti <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà, cominciò ad interessarsi attivamente dei<br />
problemi economici della provincia, già durante la guerra, quando promosse, assieme<br />
all’amministrazione provinciale e ad alcune amministrazioni comunali, la costituzione<br />
del Consorzio granario provinciale, che doveva favorire l’approvvigionamento e la <strong>di</strong>stribuzione<br />
<strong>di</strong> cereali e farina in tutta la provincia.<br />
Nel dopoguerra, la Camera <strong>di</strong> Commercio istituì una Commissione per avanzare al<br />
Governo una serie <strong>di</strong> richieste atte a favorire il rilancio dell’economia. L’interesse della<br />
Commissione, come quello <strong>di</strong> altre indagini e relazioni dell’Ente camerale <strong>degli</strong> anni<br />
12
successivi, si rivolse principalmente al settore industriale e alle possibilità <strong>di</strong> un suo sviluppo,<br />
mentre un’attenzione più limitata fu rivolta alle problematiche agrarie. Evidentemente<br />
era chiara la consapevolezza dell’importanza del settore secondario per assorbire<br />
quella manodopera che non poteva più cercare lavoro all’estero, per via delle forti limitazioni<br />
poste all’emigrazione transoceanica, in particolare da parte <strong>degli</strong> Stati Uniti.<br />
Perciò, la Commissione in<strong>di</strong>viduò alcuni settori da sostenere e da sviluppare, come<br />
quello della lavorazione dei marmi <strong>di</strong> Cautano, della produzione <strong>di</strong> laterizi, della industria<br />
del legno, dell’e<strong>di</strong>lizia, delle miniere <strong>di</strong> bauxite <strong>di</strong> Cusano Mutri e della lignite <strong>di</strong><br />
Morcone, dei liquori, del torrone e delle conserve alimentari. Non mancò nemmeno <strong>di</strong><br />
sollecitare la costruzione <strong>di</strong> nuove strade e l’ampliamento della stazione ferroviaria. Il<br />
miglioramento dell’apparato produttivo locale era possibile – ad avviso della Commissione<br />
– per la presenza della materia prima (quasi tutta derivante dall’agricoltura e dalle<br />
poche risorse minerarie esistenti) ma doveva essere accompagnato da altri due fattori: la<br />
formazione delle maestranze e l’utilizzazione della forza motrice, resa possibile dalla<br />
presenza <strong>di</strong> numerosi corsi d’acqua.<br />
3.3. Le iniziative <strong>degli</strong> anni Venti - Gli anni Venti furono caratterizzati da un insieme<br />
<strong>di</strong> iniziative, dovute a un gruppo <strong>di</strong> industriali e <strong>di</strong> uomini <strong>di</strong> affari, sostenuti dalla locale<br />
Camera <strong>di</strong> commercio, ma che non sempre <strong>di</strong><strong>ed</strong>ero buoni frutti. Essi, finanziati spesso<br />
dalle banche locali e in primo luogo dalla Banca Sannitica, si impegnarono in <strong>di</strong>versi<br />
rami produttivi. Nel campo meccanico, il giovane industriale Raffaele De Caterina aveva<br />
impiantato uno stabilimento per la costruzione e la riparazione dei carri ferroviari,<br />
che viveva <strong>di</strong> commesse delle Ferrovie dello Stato, non sempre facile da procurarsi. Fu<br />
anche aperta l’officina <strong>di</strong> Mario Zolli, in collaborazione con il meccanico svizzero Oddone<br />
Ziegler, per la produzione <strong>di</strong> pezzi meccanici e per la costruzione e riparazione <strong>di</strong><br />
macchine elettriche. Si <strong>di</strong>ffuse, inoltre, la produzione e la <strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> energia elettrica,<br />
grazie anche all’attività della Società Elettrica del Sannio, costituita nel 1919 dalla<br />
Società Elettrica <strong>di</strong> Benevento, operante fin dal 1900, e dalla Società Meri<strong>di</strong>onale <strong>di</strong> Elettricità.<br />
La maggiore produzione <strong>di</strong> energia elettrica favorì lo sviluppo della lavorazione<br />
meccanica del legno, cui si erano de<strong>di</strong>cate le stesse Officine De Caterina, specializzate<br />
nella lavorazione della parte in legno del materiale mobile rotabile delle ferrovie, e<br />
la <strong>di</strong>tta Domenico Russo, che si de<strong>di</strong>cava alla costruzione <strong>di</strong> infissi, mobili e casse da<br />
imballaggio.<br />
Nel settore minerario, le miniere <strong>di</strong> lignite <strong>di</strong> Morcone furono costrette a chiudere,<br />
nel 1922, per la <strong>di</strong>minuzione del prezzo del carbone che non ne rendeva conveniente<br />
l’estrazione. L’anno prima era stata fondata una società anonima, la Monte Mutri, per lo<br />
sfruttamento delle miniere <strong>di</strong> bauxite <strong>di</strong> Cusano Mutri, nella quale furono riposte molte<br />
speranze per la vastità e la bontà del giacimento. L’alluminio, estratto dalla bauxite, aveva<br />
ormai cominciato a sostituire alcune parti in ferro nella fabbricazione <strong>di</strong> aerei, navi,<br />
automobili, biciclette e utensili e il rame negli impianti elettrici. In particolare, la<br />
bauxite <strong>di</strong> Cusano Mutri, la cui produzione annua si aggirava intorno ai 4 milioni <strong>di</strong><br />
tonnellate, era particolarmente adatta per la produzione <strong>di</strong> abrasivi e <strong>di</strong> materiale refrattario.<br />
La società, che ottenne la partecipazione e i finanziamenti della Banca Sannitica,<br />
si dotò <strong>di</strong> moderne attrezzature e sostenne ingenti spese d’impianto. Dopo pochi anni,<br />
però, durante i quali pure era riuscita ad esportare il prodotto fin negli Stati Uniti, dovette<br />
sospendere l’attività perché non risultava più conveniente. Finanche il trasporto del<br />
minerale al vicino centro <strong>di</strong> lavorazione <strong>di</strong> Bussi, in Abruzzo, risultava particolarmente<br />
13
costoso. Solo la Società anonima Industrie Minerarie per lo sfruttamento delle miniere<br />
<strong>di</strong> Altavilla Irpina, nella vicina provincia <strong>di</strong> Avellino (ma la s<strong>ed</strong>e legale era a Benevento),<br />
ebbe successo e arrivò ad impiegare 600 operai, perché lo zolfo e i suoi derivati erano<br />
utilizzati in agricoltura e nella produzione <strong>di</strong> fiammiferi, alla quale si de<strong>di</strong>cavano, nel<br />
capoluogo sannita, ben sei fabbriche. Lo sfruttamento dei giacimenti marmiferi <strong>di</strong> Cautano,<br />
Vitulano e Pietraroia, nonché delle cave <strong>di</strong> travertino <strong>di</strong> Pietrelcina, era reso <strong>di</strong>fficile<br />
dalla insufficiente viabilità e dalla scarsa utilizzazione <strong>di</strong> forza motrice. La produzione<br />
<strong>di</strong> laterizi, viceversa, dava buoni risultati e si costituì una società, la Sanvito, che<br />
gestiva uno stabilimento con due o trecento operai. Nel campo tessile venne fondato un<br />
moderno cotonificio da parte <strong>di</strong> Alessandro Perlingieri, con annessa tintoria, per la produzione<br />
<strong>di</strong> tessuti e sacchi, che impiegava una novantina <strong>di</strong> operai. Tra le industrie chimiche,<br />
si possono ricordare una fabbrica <strong>di</strong> sapone a Montesarchio e un piccolo stabilimento<br />
per la produzione del cremore <strong>di</strong> tartaro a Foglianise.<br />
La fabbricazione <strong>di</strong> torroni e <strong>di</strong> liquori continuava a costituire la parte più consistente<br />
delle industrie alimentari beneventane. Si contavano una decina <strong>di</strong> fabbriche, provviste<br />
<strong>di</strong> macchinari mossi da forza motrice elettrica, che producevano oltre 4.000 quintali <strong>di</strong><br />
torrone all’anno, fra le quali quella dei Sifo, le Fabbriche Riunite, la <strong>di</strong>tta Profeta e la<br />
Ferrannini. Questo ramo produttivo era in espansione e gli opifici qualche volta non riuscivano<br />
ad evadere tutte le richieste. La maggior parte del torrone era venduto fuori città<br />
oppure esportato. Anche la produzione dello Strega era in aumento e la Ditta Alberti<br />
continuava a vendere centinaia <strong>di</strong> migliaia <strong>di</strong> bottiglie all’anno. Alla lavorazione su vasta<br />
scala <strong>di</strong> biscotti, caramelle e confetti si de<strong>di</strong>cava la <strong>di</strong>tta Cosimo Serino che era dotata<br />
<strong>di</strong> due forni e <strong>di</strong> moderni macchinari t<strong>ed</strong>eschi. Vi erano poi quattro mulini a cilindro,<br />
due pastifici e numerosi mulini a palmenta. I mulini più importanti continuavano ad essere<br />
quelli dei Rummo, con l’omonimo pastificio, e dei Lamparelli. Il torrone trovava<br />
vasto mercato negli Stati Uniti e in Egitto, nonostante l’esportazione fosse gravata da un<br />
dazio del 25 per cento sul valore del prodotto. Il liquore, in particolare lo Strega, era<br />
venduto in quasi tutti i paesi non protetti da leggi proibitive, ma soprattutto<br />
nell’America meri<strong>di</strong>onale.<br />
Molte delle iniziative ricordate erano, tranne qualcuna, <strong>di</strong> modeste <strong>di</strong>mensioni e<br />
spesso si trattava <strong>di</strong> imprese artigianali già esistenti che estesero la loro attività. Esse<br />
non riuscirono a dare un impulso significativo all’economia beneventana e spesso ebbero<br />
breve vita, anche perché qualcuna fu forse troppo ambiziosa o non dovette essere<br />
guidate da persone esperte e capaci. La provincia non era dotata <strong>di</strong> maestranze preparate,<br />
tranne che in qualche settore tra<strong>di</strong>zionale, né sempre si trovavano capitali <strong>di</strong>sposti a<br />
<strong>di</strong>rigersi verso investimenti <strong>di</strong> rischio. Perciò proliferarono molte banche, che si legarono<br />
a personaggi <strong>ed</strong> imprese poco solide e furono trascinate al <strong>di</strong>ssesto. Solo le industrie<br />
dei settori tra<strong>di</strong>zionali (paste alimentari, legno e infissi, liquori e torrone, e<strong>di</strong>lizia) continuavano<br />
a reggere, ma senza conoscere slanci particolari.<br />
3.4. Dalla crisi alla seconda guerra mon<strong>di</strong>ale - Durante la crisi <strong>degli</strong> anni Trenta un<br />
certo sollievo venne dalla ripresa dell’attività e<strong>di</strong>lizia, dovuta all’incremento demografico<br />
e alla ricostruzione successiva al terremoto del 1930. In appena quin<strong>di</strong>ci anni, fra il<br />
1921 e il 1936, la popolazione provinciale era cresciuta <strong>di</strong> quasi il 10 per cento e aveva<br />
superato la soglia dei 300 mila residenti, mentre il capoluogo aveva conosciuto un processo<br />
accentuato <strong>di</strong> inurbamento. La popolazione citta<strong>di</strong>na, <strong>di</strong>fatti, era aumentata del<br />
41 per cento, portandosi da meno <strong>di</strong> 27 mila a quasi 38 mila abitanti, con un centro sto-<br />
14
ico ad elevata densità abitativa e molto degradato. Ciò comportò una spinta all’attività<br />
e<strong>di</strong>lizia che, alla vigilia della guerra occupava quasi 1.600 persone. L’e<strong>di</strong>lizia <strong>di</strong>venne<br />
così il settore trainante dell’economia beneventana, assieme ad un gran numero <strong>di</strong> piccole<br />
imprese artigiane ad essa collegate e alla produzione <strong>di</strong> laterizi. La provincia <strong>di</strong><br />
Benevento mostrava, perciò, alla vigilia della seconda guerra mon<strong>di</strong>ale, una certa crescita<br />
nel settore industriale. Alcune <strong>di</strong>tte trassero vantaggio da commesse statali collegate,<br />
in qualche modo, con l’attività bellica, come la <strong>di</strong>tta Vincenzo Tresca, che fornì mobilio<br />
e infissi all’amministrazione coloniale dell’Etiopia e ad alcune caserme in Italia, o la società<br />
Domenico Russo e figli, che si aggiu<strong>di</strong>cò numerose forniture <strong>di</strong> infissi e <strong>di</strong> cassette<br />
per munizioni all’Esercito e ad altre amministrazioni. Nel 1939 era anche nata<br />
l’Aeronautica Sannita, costituita dalla Macchi <strong>di</strong> Varese, che aveva rilevato gli stabilimenti<br />
della società De Caterina, trovatasi in <strong>di</strong>fficoltà e costretta a chiudere.<br />
L’importante società aeronautica varesina aveva rilevato lo stabilimento beneventano<br />
per de<strong>di</strong>carsi alla produzione e alla riparazione <strong>di</strong> aerei da guerra, nonché alla produzione<br />
<strong>di</strong> parti <strong>di</strong> ricambio <strong>di</strong> aeroplani. Nel giro <strong>di</strong> sei mesi erano stati eretti i capannoni e i<br />
fabbricati <strong>ed</strong> erano stati allestiti i macchinari, sicché nei primi mesi del 1940, la nuova<br />
società aveva potuto iniziare l’attività, grazie ad importanti commesse ottenute dalla<br />
Regia Aeronautica. Durante la guerra la sua efficienza produttiva raggiunse il punto<br />
massimo <strong>ed</strong> essa arrivò ad impiegare oltre trecento operai.<br />
I bombardamenti dell’estate del 1943 su Benevento, protrattisi dal 20 agosto al primo<br />
ottobre, lasciarono circa 18 mila persone senza casa, su una popolazione <strong>di</strong> 40 mila abitanti,<br />
e <strong>di</strong>strussero parecchi stabilimenti industriali, nella parte bassa della città, nei<br />
pressi della stazione ferroviaria, come la <strong>di</strong>stilleria Alberti, lo stabilimento<br />
dell’Aeronautica Sannita, il biscottificio <strong>di</strong> Cosimo Serino, la fabbrica <strong>di</strong> ghiaccio <strong>di</strong><br />
Adolfo Basile, la Manifattura Tabacchi, il mobilificio Tresca e il mulino e pastificio<br />
Rummo. I T<strong>ed</strong>eschi, prima <strong>di</strong> ritirarsi dalla città, abbatterono numerosi ponti, razziarono<br />
le scarse riserve alimentari e il bestiame dei conta<strong>di</strong>ni e <strong>di</strong>strussero <strong>di</strong>versi opifici che<br />
non volevano lasciare nelle mani <strong>degli</strong> Alleati, fra cui il pastificio Rummo, già colpito<br />
dalle bombe.<br />
3.5. Il secondo dopoguerra - La ricostruzione <strong>degli</strong> impianti industriali fu resa possibile<br />
quasi esclusivamente con le risorse impiegate dagli impren<strong>di</strong>tori locali, che fecero<br />
scarso ricorso alle provvidenze pubbliche, non sempre facili da ottenere e a volte del<br />
tutto insufficienti. L’Aeronautica Sannita ottenne dalla Regia Aeronautica il compito <strong>di</strong><br />
riparare numerosi aeroplani Macchi e fabbricare parti <strong>di</strong> ricambio, oltre ad alcune commesse<br />
dalle Ferrovie dello Stato, che le consentirono <strong>di</strong> alimentare il lavoro del reparto<br />
meccanico, tanto che nel marzo del 1945 occupava circa 250 persone. Ma nel gennaio<br />
dell’anno successivo iniziò a licenziare gli operai per mancanza <strong>di</strong> commesse e poi sospese<br />
l’attività, decidendo <strong>di</strong> de<strong>di</strong>carsi alla riparazione <strong>di</strong> vagoni ferroviari, lavoro per il<br />
quale vi era una forte richiesta. Siccome non riuscì ad ottenere il finanziamento necessario,<br />
fu costretta a c<strong>ed</strong>ere lo stabilimento alla F<strong>ed</strong>erconsorzi che vi impiantò una fabbrica<br />
<strong>di</strong> macchine agricole.<br />
La Camera <strong>di</strong> commercio, in occasione dell’emanazione del decreto del 1947 che<br />
prev<strong>ed</strong>eva benefici per l’industrializzazione dell’Italia meri<strong>di</strong>onale e insulare, preparò<br />
una sorta <strong>di</strong> piano <strong>di</strong> sviluppo dell’economia locale, nel quale in<strong>di</strong>viduò i settori da sostenere.<br />
Oltre allo sviluppo delle industrie tra<strong>di</strong>zionali, la strategia <strong>di</strong>segnata nella relazione<br />
dell’Ente camerale prev<strong>ed</strong>eva il potenziamento <strong>di</strong> alcuni comparti, come quello<br />
15
enologico, o l’impianto <strong>di</strong> nuovi, come quello delle industrie conserviere, ripetendo in<br />
qualche modo le proposte già avanzate nel primo dopoguerra.<br />
Gli anni successivi alla fine del conflitto, comunque, <strong>di</strong><strong>ed</strong>ero un certo impulso<br />
all’economia beneventana, anche se permaneva una con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> miseria <strong>di</strong>ffusa per<br />
tanta parte della popolazione. La ricostruzione delle infrastrutture e delle abitazioni <strong>di</strong>strutte<br />
o danneggiate dai bombardamenti stimolò l’e<strong>di</strong>lizia e le attività connesse. Gli<br />
stabilimenti che producevano beni <strong>di</strong> prima necessità, come i mulini, ripresero rapidamente<br />
a funzionare, come pure le miniere <strong>di</strong> lignite <strong>di</strong> Morcone, per via dell’alto prezzo<br />
del carbone. I trasporti su gomma, sia <strong>di</strong> merci che <strong>di</strong> passeggeri, si svilupparono notevolmente<br />
per il permanere delle <strong>di</strong>fficoltà nei collegamenti ferroviari e perché era possibile<br />
acquistare a basso prezzo gli automezzi <strong>di</strong>smessi dalle truppe alleate. Ma si trattò <strong>di</strong><br />
una ripresa effimera che si sgonfiò appena i prezzi si stabilizzarono (le miniere <strong>di</strong> Morcone,<br />
per esempio, dovettero chiudere <strong>di</strong> nuovo e definitivamente), mostrando tutte le<br />
profonde ferite che la guerra aveva inferto all’economia. Perciò, nel momento in cui la<br />
ricostruzione del Paese era sostanzialmente conclusa, la provincia sannita mostrava profon<strong>di</strong><br />
segni <strong>di</strong> arretratezza. La sua struttura produttiva rimaneva legata all’agricoltura,<br />
mentre la fragile struttura industriale risentiva ancora dei danni subiti dalla guerra e<br />
dall’alluvione prodotta dallo straripamento del fiume Calore.<br />
Il censimento generale dell’industria e del commercio del 1951 confermò la presenza<br />
<strong>di</strong> un modesto apparato industriale nella provincia, con un numero <strong>di</strong> addetti <strong>di</strong> poco superiore<br />
a <strong>di</strong>ecimila, che però comprendevano anche gli artigiani. Nel ventennio fra il<br />
1951 e il 1971, la provincia sannita non riuscì ad agganciare lo sviluppo industriale che<br />
stava interessando molte parti d’Italia e della stessa Campania. Mentre in tutta la penisola<br />
aumentavano le unità locali e gli addetti, in provincia <strong>di</strong> Benevento si registrò una<br />
<strong>di</strong>minuzione <strong>di</strong> unità locali (ma questo fenomeno era comune anche alle altre province<br />
campane, con l’eccezione <strong>di</strong> Napoli) e un’impressionante stazionarietà <strong>degli</strong> addetti,<br />
bloccati attorno alle <strong>di</strong>ecimila unità. Se però il numero <strong>degli</strong> addetti non aumentava, esso<br />
si ri<strong>di</strong>stribuiva fra i <strong>di</strong>versi settori, provocando una trasformazione dell’apparato industriale,<br />
con la <strong>di</strong>minuita incidenza del comparto manifatturiero e l’accresciuta presenza<br />
<strong>di</strong> quello delle costruzioni. La riduzione interessò quasi tutti i principali rami manifatturieri,<br />
come l’alimentare, quello del vestiario e dell’abbigliamento e quello della lavorazione<br />
del legno. Solo le industrie meccaniche aumentarono, per via del forte incremento<br />
delle officine meccaniche, grazie alla <strong>di</strong>ffusione delle automobili. Andavano<br />
scomparendo, cioè, alcune delle attività più tra<strong>di</strong>zionali a vantaggio <strong>di</strong> altre, connesse<br />
con i con i nuovi consumi e con i nuovi modelli <strong>di</strong> comportamento. All’inizio <strong>degli</strong> anni<br />
Settanta, le attività industriali continuavano ad essere concentrate nel comune capoluogo,<br />
anche se si poteva notare una certa <strong>di</strong>stribuzione nell’ambito provinciale, ma senza<br />
l’affermazione <strong>di</strong> un centro che potesse fungere da richiamo per altre attività produttive.<br />
Fra i comuni della provincia con qualche inse<strong>di</strong>amento industriale <strong>di</strong> una certa consistenza<br />
vi erano Airola (produzioni meccaniche), Montesarchio (lavorazione <strong>di</strong> minerali<br />
non metalliferi) e Telese (stabilimenti oleari). Nei due decenni compresi fra il 1951 e il<br />
1971, l’attività industriale della provincia sannita era cresciuta a ritmi più lenti delle altre<br />
province campane. L’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> industrializzazione che nel 1951, con 31 addetti ogni<br />
mille abitanti, prec<strong>ed</strong>eva, sia pure <strong>di</strong> poco, quelli delle province <strong>di</strong> Avellino e <strong>di</strong> Caserta,<br />
venti anni più tar<strong>di</strong>, pur essendo passato a 36 addetti, era finito all’ultimo posto.<br />
16
3.6. Un settore in <strong>di</strong>fficoltà - Nella seconda metà <strong>degli</strong> anni Cinquanta, proprio quando<br />
si avviava il miracolo economico italiano, alcune importanti attività industriali della<br />
provincia entrarono in crisi, fra cui le principali fabbriche <strong>di</strong> fiammiferi, che pure erano<br />
state ammodernate e occupavano circa 250 lavoratori, l’Agromeccanica, e alcune aziende<br />
che si occupavano della lavorazione del legno. In particolare l’Agromeccanica, la<br />
fabbrica <strong>di</strong> macchine agricole della F<strong>ed</strong>erconsorzi, nata sulle ceneri dell’Aeronautica<br />
Sannita, dovette vendere lo stabilimento alla Fiat, società legata da una convenzione con<br />
la stessa F<strong>ed</strong>erconsorzi per la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> macchine e attrezzi agricoli. La Fiat, nel 1955,<br />
chiuse la fabbrica e licenziò i 300 <strong>di</strong>pendenti, motivando tale decisione con la cattiva<br />
qualità delle macchine costruite e con gli alti costi <strong>di</strong> produzione. Se alcune industrie si<br />
trovarono in <strong>di</strong>fficoltà, altre vennero aperte, in particolare attorno a Benevento e lungo<br />
due <strong>di</strong>rettrici: la prima a ovest del capoluogo, verso Montesarchio e Airola, e l’altra a<br />
sud, verso San Giorgio del Sannio, Calvi e San Nicola Manfre<strong>di</strong>. Tra i comuni <strong>di</strong> Benevento<br />
e quello <strong>di</strong> Paduli, in località Ponte Valentino, sorse, nel 1968, il Nucleo industriale,<br />
trasformatosi, qualche anno più tar<strong>di</strong>, nel 1974, in Area <strong>di</strong> sviluppo industriale.<br />
Nel corso <strong>degli</strong> anni Cinquanta e Sessanta, comunque, si svilupparono nel capoluogo e<br />
nelle sue imme<strong>di</strong>ate vicinanze altre iniziative industriali, riguardanti la fabbricazione <strong>di</strong><br />
mobili metallici, la manifattura <strong>di</strong> guanti, la lavorazione <strong>di</strong> marmi, la produzione <strong>di</strong> latticini,<br />
la produzione <strong>di</strong> manufatti <strong>di</strong> cemento in monocottura e la produzione <strong>di</strong> cavi telefonici,<br />
alcuni delle quali, però, non ebbero lunga vita.<br />
Nel ventennio successivo, la popolazione attiva nell’industria fu in <strong>di</strong>minuzione sia a<br />
livello regionale che a livello nazionale, per effetto della trasformazione e della ristrutturazione<br />
che stavano avvenendo nel settore industriale. Nella provincia <strong>di</strong> Benevento,<br />
viceversa, dopo una riduzione dal 26 al 23 per cento fra il 1961 e il 1971, la popolazione<br />
attiva nell’industria risalì al 24 per cento nel decennio successivo, ripresa tanto più significativa<br />
in quanto non solo andava in senso inverso all’andamento regionale e nazionale,<br />
ma anche perché segnò proprio allora la minore <strong>di</strong>stanza con quelle due realtà <strong>di</strong><br />
riferimento. In altre parole, la provincia <strong>di</strong> Benevento, pur rimanendo una provincia<br />
conta<strong>di</strong>na, aveva una percentuale <strong>di</strong> popolazione attiva nell’industria non più eccessivamente<br />
<strong>di</strong>stante da quella registrata a livello nazionale e regionale. Infatti, l’industria<br />
beneventana, che non era riuscita ad agganciare il decollo industriale dell’Italia negli<br />
anni del miracolo economico, conobbe, nei decenni successivi, un incremento abbastanza<br />
consistente. Gli addetti al settore industriale, che si erano tenuti intorno alle 10 mila<br />
unità negli anni Cinquanta e Sessanta, si portarono a più <strong>di</strong> 13 mila nel 1981 e a 17 mila<br />
<strong>di</strong>eci anni più tar<strong>di</strong>. L’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> industrializzazione salì, nel 1991, a 58 addetti ogni mille<br />
abitanti, dato molto vicino a quello regionale, ma ancora pari a meno della metà <strong>di</strong> quello<br />
nazionale.<br />
Il comparto industriale più importante continuò ad essere il manifatturiero, che fece<br />
registrare un incremento sia <strong>di</strong> unità locali che <strong>di</strong> addetti, anche se il suo peso continuava<br />
a <strong>di</strong>minuire, a tutto vantaggio delle industrie delle costruzioni. Si trattava, comunque,<br />
<strong>di</strong> attività modeste, caratterizzate dalla forte presenza <strong>di</strong> imprese artigiane, che tuttavia erano<br />
in grado <strong>di</strong> assicurare un certo sviluppo occupazionale. Le botteghe artigiane erano<br />
ancora presenti in gran numero, specialmente in alcune attività, come quella antica della<br />
lavorazione del legno, in cui esistevano moltissime piccole falegnamerie (meno <strong>di</strong> due<br />
addetti ciascuna); quella della fabbricazione <strong>di</strong> prodotti in metallo e quella<br />
dell’abbigliamento. Anche la maggioranza delle industrie alimentari era costituito da<br />
17
otteghe artigiane e lo stesso comparto delle costruzioni era caratterizzato da imprese <strong>di</strong><br />
modeste <strong>di</strong>mensioni, tenute in vita dalla ricostruzione seguita al terremoto del 1980.<br />
Negli ultimi decenni del secolo ventesimo nuove attività e nuovi inse<strong>di</strong>amenti, anche<br />
grazie a contributi pubblici, sorsero in alcune zone della periferia <strong>di</strong> Benevento o in altre<br />
località. Ma altre entrarono in crisi e scomparvero quasi del tutto, come le fabbriche <strong>di</strong><br />
fiammiferi e la stessa Alfacavi <strong>di</strong> Airola, che era una delle poche industrie <strong>di</strong> qualche<br />
consistenza sorte nella provincia. Altre ancora, come uno stabilimento della Piaggio, <strong>di</strong><br />
cui si parlò all’inizio <strong>degli</strong> anni Novanta, non sorsero mai. Qualche novità si segnalò, a<br />
partire dagli anni Ottanta, nel comparto tessile-abbigliamento, per l’affermazione, in alcune<br />
località della Valfortore, <strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> piccole aziende, per lo più artigiane, che<br />
iniziarono a lavorare come terzisti per aziende esterne, assumendo in taluni casi le caratteristiche<br />
dell’economia sommersa.<br />
4. Lo sviluppo del settore terziario<br />
4.1. Il cre<strong>di</strong>to fra Otto e Novecento - All’inizio del ventesimo secolo, il settore terziario<br />
era poca cosa in provincia <strong>di</strong> Benevento. Esso era caratterizzato da un modesto<br />
commercio locale, in cui qualche importanza avevano le fiere, e dalla presenza <strong>di</strong> piccole<br />
banche che cercavano <strong>di</strong> raccogliere fon<strong>di</strong> per finanziare qualche limitata attività impren<strong>di</strong>toriale<br />
e più spesso gli agricoltori, che costituivano la classe più numerosa. I<br />
commercianti erano riusciti, tuttavia, ad aggregarsi attorno al deputato Gaetano Rummo<br />
nel cosiddetto «partito dei commercianti», che nelle elezioni amministrative del 1902,<br />
riuscì a far eleggere ben sei consiglieri comunali, a testimonianza del loro peso in città.<br />
Due anni dopo, sempre per impulso <strong>di</strong> questa categoria, veniva fondata, a Benevento, la<br />
Banca Commerciale Beneventana, <strong>di</strong> cui Gaetano Rummo <strong>di</strong>venne presidente onorario<br />
assieme a Giovanni Battista Bosco Lucarelli, che guidava l’Amministrazione provinciale.<br />
Questa banca, sorta con un capitale sociale <strong>di</strong> centomila lire, si aggiungeva ad altri<br />
piccoli istituti nati in città e in provincia, con lo scopo <strong>di</strong> tentare <strong>di</strong> intercettare i modesti<br />
risparmi della popolazione, in genere depositati presso le casse <strong>di</strong> risparmio postali, che<br />
erano in forte crescita anche per le rimesse <strong>degli</strong> emigrati.<br />
Nella seconda metà <strong>degli</strong> anni Ottanta nel Beneventano non esistevano casse <strong>di</strong> risparmio<br />
or<strong>di</strong>narie né società or<strong>di</strong>narie <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to, ma soltanto cinque piccole banche popolari,<br />
ossia cooperative <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to senza scopo <strong>di</strong> lucro, che si rivolgevano prevalentemente<br />
ai soci e avevano un capitale sottoscritto <strong>di</strong> poco superiore alle 230 mila lire. Di<br />
esse, soltanto una operava nel capoluogo, mentre le altre si trovavano nei comuni <strong>di</strong> S.<br />
Agata dei Goti, Solopaca, Faicchio e Ceppaloni. Quella beneventana, la Banca del Popolo<br />
e Cassa <strong>di</strong> risparmio, era stata fondata nel 1877 da Pasquale Capilongo, già sindaco<br />
della città e allora consigliere provinciale e deputato della sinistra costituzionale, che in<br />
seguito assunse il nome <strong>di</strong> Banca <strong>di</strong> Benevento. Essa prosperò e <strong>di</strong><strong>ed</strong>e buoni risultati, ma<br />
nel 1895 fu chiusa dal Capilongo che non era stato rieletto per «ven<strong>di</strong>carsi dei suoi avversari»<br />
e per mostrare quanto egli fosse potente. Vi erano, inoltre, numerosi Monti pecuniari<br />
e Monti frumentari, che nel Beneventano erano <strong>di</strong> origine molto antica, essendo<br />
stati fondati sul finire del Seicento per impulso del car<strong>di</strong>nale arcivescovo della città,<br />
Vincenzo Maria Orsini, poi <strong>di</strong>ventato papa Ben<strong>ed</strong>etto XIII. Essi si de<strong>di</strong>cavano al prestito<br />
su pegno in denaro o in natura (frumento) ai ceti meno abbienti e in particolare a<br />
quelli conta<strong>di</strong>ni. La loro decadenza, già iniziata prima dell’Unità si era accentuata suc-<br />
18
cessivamente, quando erano passati sotto il controllo e la gestione delle amministrazioni<br />
comunali. A fine Ottocento, in provincia <strong>di</strong> Benevento erano rimasti in attività una trentina<br />
<strong>di</strong> Monti frumentari. La più antica e gloriosa <strong>di</strong> tali istituzioni era il Monte Orsini,<br />
fondato a Benevento dal car<strong>di</strong>nale Orsini nel 1694, dalla trasformazione <strong>di</strong> un prec<strong>ed</strong>ente<br />
Monte <strong>di</strong> Pietà.<br />
Nel 1889, per iniziativa <strong>di</strong> un altro uomo politico, Enrico Corrado, parlamentare e<br />
consigliere provinciale, nacque la più longeva fra le banche beneventane, la Banca Sannitica,<br />
con un capitale <strong>di</strong> centomila lire. Agli inizi del nuovo secolo vennero fondate parecchie<br />
altre istituzioni cre<strong>di</strong>tizie, quasi sempre <strong>di</strong> modeste <strong>di</strong>mensioni. Nel capoluogo,<br />
già nel 1898, sorgeva una Cassa Cooperativa <strong>di</strong> Prestiti e Risparmi fra Impiegati <strong>ed</strong> Agenti<br />
Ferroviari. In seguito, il Consorzio agrario cooperativo aprì una Cassa <strong>di</strong> Risparmio<br />
e <strong>di</strong> Prestanza Agraria, per accettare piccoli depositi e conc<strong>ed</strong>ere prestiti in natura o in<br />
contanti ai soci, che ebbe un buon successo. Un’altra cooperativa fu la Cassa Cattolica S.<br />
Bartolomeo Apostolo, che intendeva rivolgersi, oltre che ai propri soci, anche alle Società<br />
cattoliche, alle Casse rurali cattoliche, agli agricoltori, agli operai e ai lavoratori cattolici<br />
in genere. Molto più modesta era la Cassa Cooperativa Democratica Cristiana <strong>di</strong> Prestiti<br />
e Risparmi, che iniziò l’attività nel 1903, seguita, due anni più tar<strong>di</strong>, dalla Cassa Cooperativa<br />
<strong>di</strong> Prestiti e Risparmi tra i R<strong>ed</strong>uci «Italia e Casa Savoia» <strong>ed</strong> ex Militari e dalla<br />
Cassa Agricola Cooperativa <strong>di</strong> Prestiti e Risparmi dell’Associazione pel miglioramento<br />
fra gli agricoltori. Come si nota, erano le varie categorie (ferrovieri, agricoltori, militari e<br />
r<strong>ed</strong>uci) che si organizzavano con proprie istituzioni, le quali in genere non ebbero lunga<br />
vita, ma che testimoniano <strong>di</strong> un fervore <strong>di</strong> iniziative nel settore del cre<strong>di</strong>to cooperativo.<br />
Anche in provincia nacquero piccole banche, in genere sotto forma cooperativa, a S.<br />
Giorgio la Montagna (oggi S. Giorgio del Sannio), a Paduli, a Bonea e ad Airola, oltre a<br />
numerose casse rurali a Campolattaro, Castelpagano, Ceppaloni, Bonea, S. Menna <strong>di</strong><br />
Vitulano, Fragneto Monforte, Pietrelcina, S. Martino Sannita, S. Leucio e Vitulano. Le<br />
banche ricordate, assieme alle filiali della Banca d’Italia e del Banco <strong>di</strong> Napoli, dovevano<br />
far fronte alle esigenze <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to <strong>di</strong> una provincia con pochi capitali <strong>di</strong>sponibili per<br />
impieghi <strong>di</strong> rischio. Né va <strong>di</strong>menticata la costituzione, nel 1912, del Cre<strong>di</strong>to Sannite,<br />
una società anonima per azioni, che si proponeva <strong>di</strong> esercitare in particolare il cre<strong>di</strong>to<br />
agrario. Probabilmente fu proprio l’accresciuto numero <strong>di</strong> banche operanti nella provincia<br />
a determinare un consistente aumento dei depositi, assieme alle rimesse <strong>degli</strong> emigrati,<br />
<strong>di</strong> cui non è possibile conoscere la consistenza a livello provinciale, ma che certamente<br />
aumentarono a mano a mano che crescevano le partenze, proprio nei primi anni<br />
del nuovo secolo. Molte delle banche ricordate erano legate ad uomini politici, i quali,<br />
tramite l’esercizio del cre<strong>di</strong>to, tentavano <strong>di</strong> costruire e consolidare la loro base elettorale.<br />
Per questo, in genere, tali iniziative non <strong>di</strong><strong>ed</strong>ero sempre buoni frutti e comunque si<br />
mantennero entro <strong>di</strong>mensioni limitate, senza riuscire a dare un consistente impulso alle<br />
modeste attività economiche locali.<br />
4.2. Cre<strong>di</strong>to e commercio fra le due guerre mon<strong>di</strong>ali - Nel dopoguerra l’attività bancaria<br />
fece registrare un’espansione non solo a Benevento, ma in tutto il Paese. Già nel<br />
1917, la Cassa Cattolica S. Bartolomeo Apostolo si era trasformata in società anonima<br />
con un capitale <strong>di</strong> 500 mila lire, assumendo la denominazione <strong>di</strong> Banca Cattolica del<br />
Sannio, <strong>ed</strong> aveva esteso la sua attività anche fuori provincia. Nel 1921 essa si fuse con<br />
una banca del Casertano per dare vita al Cre<strong>di</strong>to Meri<strong>di</strong>onale, con s<strong>ed</strong>e a Napoli e con<br />
un capitale sociale <strong>di</strong> cinque milioni. Nel 1920 venne fondata la Banca Agricola Indu-<br />
19
striale del Sannio, emanazione della Banca Italiana <strong>di</strong> Sconto, allora uno dei maggiori<br />
istituti <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to italiani, che aprì una cinquantina <strong>di</strong> filiali e riuscì a raccogliere oltre 14<br />
milioni <strong>di</strong> depositi. La Banca, oltre a sostenere forti spese d’impianto e ad acquistare<br />
mobili costosi e ben quattro automobili, concesse fi<strong>di</strong> e prestiti a commercianti <strong>di</strong> dubbia<br />
solvibilità e agli stessi amministratori. Ma quando, alla fine del 1921, la Banca Italiana<br />
<strong>di</strong> Sconto andò in <strong>di</strong>ssesto, anche la BAIS rimase coinvolta e dovette far fronte ad<br />
un massiccio ritiro <strong>di</strong> depositi, che riuscì a fronteggiare solo grazie all’aiuto della Banca<br />
d’Italia e del Banco <strong>di</strong> Napoli. Ma non si riprese più e qualche tentativo <strong>di</strong> salvarla non<br />
riuscì, sicché nel 1924, su istanza <strong>di</strong> un cre<strong>di</strong>tore <strong>di</strong> Montesarchio, ne fu <strong>di</strong>chiarato il<br />
fallimento, che coinvolse oltre duemila clienti. Un’altra azienda <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to, la Banca del<br />
Lavoro e del Piccolo Risparmio, <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni molto modeste, ma sopravvissuta fino ai<br />
nostri giorni, venne fondata nel 1921 a Benevento, per trasferirsi, nel 1938, forse anche<br />
per ragioni <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne politico, nel vicino centro agricolo <strong>di</strong> Foglianise, dove visse stentatamente<br />
fino al suo rilancio nel corso <strong>degli</strong> anni Sessanta. Nel 1925, infine, videro la luce<br />
altre due banche: la Banca <strong>di</strong> Cre<strong>di</strong>to Provinciale, subito finita in <strong>di</strong>ssesto, e la Banca<br />
<strong>di</strong> Benevento, sopravvissuta fino agli anni Sessanta, essendo riuscita a superare indenne,<br />
nonostante qualche per<strong>di</strong>ta, le <strong>di</strong>fficoltà dei primi anni Trenta.<br />
Nel 1928 la città assistette al fallimento del Cre<strong>di</strong>to Meri<strong>di</strong>onale <strong>di</strong> Napoli, che<br />
l’anno prima aveva assunto anche l’esercizio della Banca Commerciale Beneventana, la<br />
quale tuttavia sopravvisse fino al suo fallimento nel 1933. Il Cre<strong>di</strong>to Meri<strong>di</strong>onale aveva<br />
esteso in modo incre<strong>di</strong>bile la rete <strong>di</strong> filiali, arrivandone ad averne ben 122, oltre a 184<br />
uffici <strong>di</strong> rappresentanza, e a raccogliere depositi per quasi 176 milioni. Un’ispezione<br />
della Banca d’Italia mise in luce numerose irregolarità contabili e la concessione <strong>di</strong> fi<strong>di</strong><br />
d’importo elevato senza la necessaria autorizzazione, spesso a società controllate o i cui<br />
amministratori erano gli stessi della Banca. La nuova legge bancaria del 1926, che aveva<br />
sottoposto al controllo dell’istituto <strong>di</strong> emissione l’intero sistema bancario nazionale,<br />
e la fine dell’euforia bancaria <strong>degli</strong> anni prec<strong>ed</strong>enti, avevano lasciato a numerosi istituti<br />
<strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to l’ere<strong>di</strong>tà <strong>degli</strong> immobilizzi, portandone molti al fallimento, anche perché si<br />
trovarono <strong>di</strong>nanzi ad un atteggiamento <strong>di</strong> rigore della Banca d’Italia, al quale non erano<br />
abituati. La chiusura del Cre<strong>di</strong>to Meri<strong>di</strong>onale e della Banca Commerciale Beneventana<br />
lasciò, sulla piazza <strong>di</strong> Benevento, accanto alla Banca Sannitica, che pure dovette superare<br />
momenti molto <strong>di</strong>fficili, che stavano per portarla al fallimento, solo pochi altre aziende<br />
<strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to. Le più consistenti erano il Cre<strong>di</strong>to Sannite e la Banca <strong>di</strong> Benevento, alle<br />
quali si affiancavano la Banca del Lavoro e del Piccolo risparmio, la Banca <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to<br />
provinciale, che sarà messa in liquidazione poco dopo, e il Consorzio agrario cooperativo,<br />
che esercitò l’attività bancaria fino al 1938, quando non poté più farlo in seguito al<br />
rior<strong>di</strong>namento dei consorzi agrari.<br />
Sul finire <strong>degli</strong> anni Venti, il commercio all’ingrosso, in provincia <strong>di</strong> Benevento, in<br />
particolare <strong>di</strong> tessuti e prodotti chimici, v<strong>ed</strong>eva la partecipazione <strong>di</strong> poco più del 5 per<br />
cento <strong>degli</strong> operatori commerciali della provincia, mentre quello al dettaglio interessava<br />
il 60 per cento del totale <strong>degli</strong> addetti. Dal 1927 alla vigilia della guerra, le aziende<br />
commerciali aumentarono <strong>di</strong> un migliaio <strong>di</strong> unità, con la presenza <strong>di</strong> un’azienda commerciale<br />
ogni 92 abitanti, contro una me<strong>di</strong>a nazionale <strong>di</strong> una ogni 55 abitanti. Ciò era<br />
dovuto al carattere rurale della provincia, che portava molti agricoltori a vendere <strong>di</strong>rettamente<br />
le derrate alimentari ai consumatori, senza interme<strong>di</strong>ari, partecipando ai due<br />
mercati settimanali che si tenevano a Benevento. Qui essi si recavano per vendere erbaggi,<br />
frutta, ovini, polli, uova <strong>ed</strong> altri prodotti, e rifornirsi, a loro volta, presso le azien-<br />
20
de commerciali, <strong>di</strong> altri generi alimentari, <strong>di</strong> merci <strong>di</strong> uso corrente e <strong>di</strong> prodotti industriali.<br />
Altri mercati <strong>di</strong> una certa importanza si tenevano settimanalmente a Montesarchio,<br />
Airola e S. Giorgio del Sannio. La maggior parte delle aziende commerciali sannite<br />
era interessata, verso la fine <strong>degli</strong> anni Trenta, alla ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> generi alimentari, con<br />
circa 1.500 esercizi, e alla ven<strong>di</strong>ta dei prodotti tessili e dell’abbigliamento con circa 500<br />
unità, oltre che ai pubblici servizi, con circa 600 aziende. Nel capoluogo, il numero <strong>di</strong><br />
ristoranti e trattorie e quello <strong>degli</strong> alberghi non era adeguato al movimento <strong>di</strong> forestieri.<br />
4.3. Il settore terziario nel secondo dopoguerra - Nel secondo dopoguerra il traffico<br />
interprovinciale che faceva capo a Benevento risultava abbastanza consistente. In città,<br />
secondo il <strong>di</strong>rettore della filiale della Banca d’Italia, esisteva un’adeguata organizzazione<br />
<strong>di</strong> commercianti all’ingrosso, bene attrezzati in fatto <strong>di</strong> automezzi e forniti <strong>di</strong> buone <strong>di</strong>sponibilità<br />
finanziarie. Essi acquistavano vino, olio e sapone in Puglia, latticini e legumi<br />
nel Molise, frutta, verdure, conserve alimentari e prodotti della pesca in Campania, carni<br />
da macello e castagne nella vicina Irpinia, prodotti che poi collocavano non solo in provincia<br />
<strong>di</strong> Benevento ma anche in altre province della penisola. In particolare il commercio<br />
del vino rivestiva una certa importanza <strong>ed</strong> era esercitato da alcune <strong>di</strong>tte specializzate,<br />
come quelle <strong>di</strong> Giuseppe Ocone e <strong>di</strong> Rinaldo Iannaccone.<br />
I finanziamenti alle imprese <strong>di</strong>vennero, nel dopoguerra, più <strong>di</strong>fficili e costosi. A Benevento<br />
essi erano già insufficienti, come lamentavano gli operatori economici e come<br />
veniva riconosciuto persino dalla stessa filiale della Banca d’Italia, che aveva suggerito<br />
l’apertura <strong>di</strong> altri sportelli da affiancare a quelli, inadeguati, del Banco <strong>di</strong> Napoli e delle<br />
poche e modeste aziende <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to locali. Anzi, forti rilievi venivano mossi proprio al<br />
Banco <strong>di</strong> Napoli, accusato <strong>di</strong> investire in provincia molto meno <strong>di</strong> quanto vi raccogliesse.<br />
Il mondo produttivo beneventano, inoltre, muoveva all’importante istituto napoletano<br />
l’addebito <strong>di</strong> operare «in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> monopolio» sia per quanto riguardava il tasso<br />
d’interesse e le valute sia per l’atteggiamento rigido tenuto nei confronti della clientela.<br />
Le banche locali, per conseguenza, erano in qualche modo costrette a svolgere<br />
un’attività «innaturale» <strong>di</strong> finanziamento alle imprese. La più cospicua <strong>di</strong> tali aziende, la<br />
Banca Sannitica, apparteneva ormai ad un ramo della famiglia Perlingieri, in mano al<br />
quale erano più dei due terzi dell’intero pacchetto azionario. Anche la Banca <strong>di</strong> Benevento,<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni più modeste, era una banca carattere familiare, i cui amministratori<br />
risultavano interessati in parecchie imprese commerciali da essa finanziate, e lo stesso<br />
Cre<strong>di</strong>to Sannite, ancora più piccolo, finanziava quasi soltanto la <strong>di</strong>tta Domenico Russo e<br />
figli.<br />
Dopo la guerra, il censimento del 1951 rilevò circa 9.000 addetti al settore terziario,<br />
con una me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> 1,9 addetti per unità locale. Venti anni più tar<strong>di</strong> gli addetti erano <strong>di</strong>ventati<br />
quasi 13.000, vale a <strong>di</strong>re oltre 2.300 in più <strong>di</strong> quelli del settore industriale. La<br />
crescita fu evidentissima nel commercio e nelle attività e servizi vari e meno significativa<br />
nei trasporti e nel cre<strong>di</strong>to. Il commercio al minuto costituiva, da solo, all’incirca i tre<br />
quarti del totale e sia il numero <strong>di</strong> unità locali che quello <strong>degli</strong> addetti era in costante<br />
aumento. Ma mentre nelle altre attività commerciali (commercio all’ingrosso, commercio<br />
ambulante, alberghi e pubblici esercizi e attività ausiliarie) le unità locali, pur restando<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni molto piccole, andavano tuttavia ingrandendosi, nel commercio al<br />
minuto continuavano e prevalere le aziende a carattere familiare. Esso continuava ad essere<br />
costituito principalmente da esercizi <strong>di</strong> generi alimentari (quasi la metà delle unità<br />
locali nel 1961), seguiti dagli esercizi <strong>di</strong> prodotti tessili, vestiario e abbigliamento e dai<br />
21
prodotti meccanici. Il commercio all’ingrosso ebbe sempre una presenza limitata a un<br />
paio <strong>di</strong> centinaia <strong>di</strong> unità locali, ma con un consistente incremento <strong>degli</strong> addetti, segno<br />
che le <strong>di</strong>mensioni aziendali cercavano <strong>di</strong> adeguarsi alle esigenze dei tempi, pur restando<br />
in<strong>di</strong>etro rispetto alla Campania e all’Italia.<br />
Limitata rimase la presenza <strong>di</strong> alberghi e <strong>di</strong> pubblici esercizi, vale a <strong>di</strong>re ristoranti,<br />
trattorie, osterie, caffè, bar e gelaterie, tanto che nel 1961, se si escludeva la città capoluogo<br />
e Sant’Agata dei Goti, nessun comune aveva più <strong>di</strong> una ventina <strong>di</strong> unità locali e<br />
qualcuno ne era ad<strong>di</strong>rittura privo. In particolare, l’attrezzatura alberghiera lasciava molto<br />
a desiderare. La provincia contava, nel 1957, una decina <strong>di</strong> alberghi, <strong>di</strong> cui uno soltanto<br />
<strong>di</strong> prima categoria e tre <strong>di</strong> seconda categoria. Le camere <strong>di</strong>sponibili erano complessivamente<br />
appena 178, con 288 letti e 60 bagni. Il turismo era quasi sconosciuto in<br />
una provincia con poche, anche se interessanti, attrattive. Mentre la Campania era investita<br />
dal movimento turistico, tanto da trovarsi, a metà <strong>degli</strong> anni Sessanta, al nono<br />
posto fra le regioni italiane per affluenza <strong>di</strong> turisti e al primo posto fra quelle dell’Italia<br />
meri<strong>di</strong>onale, la provincia <strong>di</strong> Benevento costituiva il fanalino <strong>di</strong> coda della regione, assicurava<br />
appena poco più dell’un per cento del movimento turistico regionale. Né la<br />
struttura alberghiera era granché migliorata se confrontata con quella <strong>di</strong> qualche anno<br />
prima. In alcuni comuni venivano anche affittate, nel periodo estivo, case private ai turisti,<br />
che in genere erano persone del luogo trasferite altrove o emigrati che ritornavano<br />
nel paese d’origine per la villeggiatura. Molto si era sempre <strong>di</strong>scusso sulle possibilità <strong>di</strong><br />
sviluppo del turismo nella provincia e ancora si continuava a <strong>di</strong>scutere. In genere, chi<br />
se ne è occupato ha sempre previsto, con affermazioni generiche e forse senza molta<br />
convinzione, buone possibilità <strong>di</strong> sviluppo turistico, che però non c’è mai stato, se si<br />
esclude il recentissimo flusso <strong>di</strong> turismo religioso legato alla devozione popolare per<br />
Padre Pio da Pietrelcina. Anche la viabilità lasciava a desiderare e non favoriva certamente<br />
l’arrivo dei turisti. La provincia sannita non era riuscita, inoltre, fra le proteste <strong>di</strong><br />
molti, a far passare per il suo territorio l’autostrada che collegava Napoli a Bari, costruita<br />
negli anni Sessanta, sicché finì con l’essere l’unica provincia della regione a non<br />
essere attraversata da autostrade.<br />
Per ciò che riguarda il cre<strong>di</strong>to, bisogna osservare che la formazione del risparmio<br />
provinciale ebbe un andamento crescente, grazie alla capacità <strong>di</strong> risparmiare della categoria<br />
<strong>degli</strong> agricoltori e alle rimesse <strong>degli</strong> emigrati, anche se a metà <strong>degli</strong> anni Cinquanta<br />
il risparmio per abitante in provincia era ancora meno della metà <strong>di</strong> quello nazionale.<br />
La preferenza dei sanniti, inoltre, continuava ad andare alle casse postali, anche se la<br />
percentuale <strong>di</strong> risparmio da esse raccolte era in lenta <strong>di</strong>minuzione. A Benevento, oltre<br />
alla filiale della Banca d’Italia, operavano, a metà <strong>degli</strong> anni Cinquanta, la filiale del<br />
Banco <strong>di</strong> Napoli, che aveva sei <strong>di</strong>pendenze nella provincia, quella della Banca Nazionale<br />
del Lavoro, aperta nel 1951, e tre aziende <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to locali. In provincia, oltre a qualche<br />
cassa rurale <strong>di</strong> scarsa importanza, lavoravano solo un paio <strong>di</strong> banche locali,<br />
anch’esse <strong>di</strong> modesta rilevanza. La più importante banca beneventana, la Banca Sannitica,<br />
conobbe nel dopoguerra una fase <strong>di</strong> sviluppo operativo e territoriale, durante la quale<br />
mostrò particolare attenzione al settore agricolo, che sostenne nel suo sforzo <strong>di</strong> modernizzazione.<br />
Le filiali passarono da tre<strong>di</strong>ci, quante erano nel dopoguerra, a <strong>di</strong>ciassette nel<br />
1962, quando la Banca impiantò anche una filiale a Napoli, che <strong>di</strong>venne la s<strong>ed</strong>e principale<br />
dell’istituto. Di minor rilievo continuavano ad essere le altre due banche, ossia il<br />
Cre<strong>di</strong>to Sannite e la Banca <strong>di</strong> Benevento. Quest’ultima si trovò, all’inizio <strong>degli</strong> anni<br />
Sessanta, in serie <strong>di</strong>fficoltà fino a giungere al <strong>di</strong>ssesto. Un’ispezione della Banca d’Italia<br />
22
accertò, nel 1963, gravi irregolarità contabili e amministrative, tanto che ne venne chiesto<br />
il commissariamento. La notizia provocò un grande allarme in città e in provincia,<br />
non solo presso i depositanti, che rischiavano <strong>di</strong> perdere i loro risparmi, ma anche per le<br />
ripercussioni che si temevano sulle altre aziende <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to. Alla fine la Banca venne rilevata<br />
dal Banco <strong>di</strong> Santo Spirito. La struttura cre<strong>di</strong>tizia locale, come si è potuto notare,<br />
era fragile e la sua capacità <strong>di</strong> espansione si basava più sull’impegno e sulla volontà <strong>di</strong><br />
alcuni uomini, quasi sempre <strong>di</strong>ventati banchieri per caso, che su una solida struttura organizzativa<br />
e sulla presenza <strong>di</strong> salde e chiare competenze manageriali. Quando questi<br />
uomini furono capaci e intraprendenti, le aziende riuscirono a vivere e a prosperare,<br />
conservando tuttavia un’organizzazione che con il tempo avrebbe mostrato i propri limiti.<br />
Quando ciò non avvenne, le banche furono costrette a passare <strong>di</strong> mano.<br />
4.4. La terziarizzazione dell’economia a fine secolo XX - Negli ultimi decenni del secolo<br />
nella provincia sannita fu registrato un accentuato processo <strong>di</strong> terziarizzazione, secondo<br />
una tendenza già emersa nei decenni prec<strong>ed</strong>enti. All’inizio <strong>degli</strong> anni Novanta,<br />
<strong>di</strong>fatti, la quota <strong>di</strong> r<strong>ed</strong><strong>di</strong>to prodotta dai servizi, pubblici e privati, aveva superato la soglia<br />
del 70 per cento. Il r<strong>ed</strong><strong>di</strong>to prodotto dai servizi della pubblica amministrazione, inoltre,<br />
costituiva un quarto <strong>di</strong> quello provinciale, contro un quinto della Campania e del<br />
Mezzogiorno e il 14 per cento dell’Italia. Il r<strong>ed</strong><strong>di</strong>to derivante dai servizi rivolti al mercato,<br />
viceversa, si manteneva sotto la soglia del 50 per cento. L’economia beneventana<br />
appariva, così, sbilanciata verso il terziario pubblico, che arrivava a produrre un r<strong>ed</strong><strong>di</strong>to<br />
molto più elevato <strong>di</strong> quello industriale, contrariamente a quanto si verificava in altre aree.<br />
Il settore terziario era <strong>di</strong>ventato il settore più importante anche per numero <strong>di</strong> addetti<br />
e per r<strong>ed</strong><strong>di</strong>to prodotto. Il processo <strong>di</strong> terziarizzazione, com’è noto, era da tempo in atto in<br />
tutti i paesi economicamente progre<strong>di</strong>ti, ma si presentava con caratteristiche <strong>di</strong>verse, perché<br />
interessava sia aree fortemente sviluppate sia aree depresse. Esso, perciò, non fu<br />
sempre in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> modernizzazione, specialmente quando non riguardava i servizi alle<br />
imprese, capaci <strong>di</strong> provocare altra crescita, ma settori più tra<strong>di</strong>zionali, come il commercio<br />
e la pubblica amministrazione. Nel Mezzogiorno, per esempio, si riscontrava, agli inizi<br />
<strong>degli</strong> anni Novanta, un’impresa del terziario avanzato ogni 8,1 imprese industriali,<br />
mentre nell’Italia centro-settentrionale se ne contava una ogni 4,8.<br />
Le unità locali e gli addetti relativi ai rami del commercio, dei trasporti, del cre<strong>di</strong>to e<br />
<strong>degli</strong> altri servizi (esclusi quelli forniti dalla pubblica amministrazione), furono in costante<br />
aumento fra le date censuarie del 1971 e del 1991. Le prime passarono da poco<br />
più <strong>di</strong> 6.500 a quasi 9.400 e gli addetti crebbero da circa 13.500 a oltre 21 mila. Il numero<br />
me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> addetti per unità locale, per conseguenza, rimase sostanzialmente bloccato<br />
intorno a 2,2 addetti, e anche in queste attività continuarono a prevalere imprese <strong>di</strong><br />
piccole <strong>di</strong>mensioni. Il commercio seguitò a costituire l’attività principale, anche se accusò<br />
una <strong>di</strong>minuzione, in termini percentuali sul totale, <strong>di</strong> 5 o 6 punti. Le caratteristiche<br />
dell’attività commerciale variarono <strong>di</strong> poco. Il commercio al minuto, svolto da aziende<br />
familiari, rimase quello pr<strong>ed</strong>ominante, ma al suo interno <strong>di</strong>minuì il peso <strong>degli</strong> esercizi <strong>di</strong><br />
generi alimentari, che nel 1971 erano ancora più della metà del totale e venti anni più<br />
tar<strong>di</strong> erano scesi a meno <strong>di</strong> un quarto. Il commercio all’ingrosso riuscì a raddoppiare il<br />
numero <strong>di</strong> addetti e a far crescere ancora <strong>di</strong> più le unità locali, che perciò si rimpicciolirono,<br />
con un numero me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> addetti passato, nell’arco del ventennio, da 3,4 a 2,9 persone.<br />
23
Un peso notevole acquisì la pubblica amministrazione, che fu fonte <strong>di</strong> occupazione e<br />
<strong>di</strong> r<strong>ed</strong><strong>di</strong>to per molte persone. Nel censimento dell’industria e dei servizi del 1981, per<br />
esempio, si contavano oltre 8.800 addetti all’istruzione e altri 3.400 alle amministrazioni<br />
pubbliche e alla giustizia. Dieci anni più tar<strong>di</strong>, se i primi erano rimasti sostanzialmente<br />
invariati, i secon<strong>di</strong> erano ulteriormente cresciuti e avevano superato le 5.500 unità. La<br />
partecipazione della pubblica amministrazione al r<strong>ed</strong><strong>di</strong>to provinciale aumentò, fra il<br />
1980 e il 1990, dal 21 a quasi il 25 per cento del totale, ponendo la provincia sannita ai<br />
primi posti fra quelle in cui il ruolo della pubblica amministrazione era più rilevante.<br />
La provincia, per le caratteristiche della sua economia, continuò ad avere scarsi rapporti<br />
commerciali con l’estero e ad occupare l’ultimo posto fra le province campane per<br />
valore delle esportazioni, che riguardavano, per circa il 60 per cento, prodotti della filiera<br />
agroalimentare (prodotti agricoli, prodotti alimentari e tabacco), e per un altro 15 per<br />
cento prodotti tessili. Esse si rivolgevano per oltre la metà verso i paesi dell’Unione Europea<br />
e per un altro quinto circa verso l’America settentrionale.<br />
Nel settore del cre<strong>di</strong>to si assistette alla scomparsa <strong>di</strong> quasi tutte le aziende locali, con<br />
l’eccezione delle poche casse rurali e della Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio,<br />
che aveva ripreso in pieno la sua attività a partire dagli anni Sessanta e che, sul finire<br />
<strong>degli</strong> anni Novanta, riportò la sua s<strong>ed</strong>e da Foglianise a Benevento. Nel 1977, il piccolo<br />
Cre<strong>di</strong>to Sannite venne assorbito dalla Banca <strong>di</strong> Calabria e tre anni più tar<strong>di</strong> l’antico<br />
Monte Orsini fu rilevato dalla Cassa <strong>di</strong> Risparmio Molisana. La Banca Sannitica, la<br />
maggiore delle istituzioni cre<strong>di</strong>tizie beneventane, che aveva continuato a svilupparsi, attirò<br />
l’attenzione della più grande banca popolare italiana, quella <strong>di</strong> Novara, alla quale<br />
l’azionista <strong>di</strong> maggioranza, Mario Perlingieri, c<strong>ed</strong>ette il suo pacchetto azionario. Nel<br />
1996 la fusione per incorporazione da parte della Banca Popolare <strong>di</strong> Novara, pose fine<br />
al secolare istituto <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to beneventano. La sua scomparsa segnò, quasi simbolicamente,<br />
la chiusura <strong>di</strong> un periodo, durante il quale l’economia della provincia era riuscita,<br />
sia pure lentamente e fra alterne vicende, a crescere e a trovare un suo ruolo<br />
nell’economia regionale, principalmente grazie ai sacrifici e agli sforzi della sua gente.<br />
24
1. Dalle origini alla prima guerra mon<strong>di</strong>ale<br />
LA BANCA SANNITICA<br />
(1889 – 1995)<br />
1.1. Il cre<strong>di</strong>to a Benevento a fine Ottocento - La Banca Sannitica venne fondata a<br />
Benevento nel 1889, in un clima <strong>di</strong> euforia bancaria che, in quegli anni, stava interessando<br />
le province campane. Come si espresse un osservatore qualche anno più tar<strong>di</strong>,<br />
sembrava «fiorita l’età dell’oro» e «ogni paesuccio poss<strong>ed</strong>eva e ambiva avere la sua<br />
banca cooperativa», presso la quale «la borghesia, allegramente, sottoscriveva cambiali<br />
per non minorarle [estinguerle parzialmente alla scadenza] e tantomeno estinguerle»,<br />
ma rinnovandole continuamente. Le banche popolari sorgevano per iniziativa <strong>di</strong> qualche<br />
benestante ma coinvolgevano centinaia <strong>di</strong> soci, provenienti dalla possidenza terriera e<br />
dai ceti produttivi agricoli, artigianali e delle professioni. I legami <strong>di</strong> parentela e <strong>di</strong> amicizia<br />
e, molto spesso, la comune militanza politica erano i vincoli che tenevano uniti i<br />
soci.<br />
Accanto alle molte banche popolari, cominciavano a sorgere anche alcune società<br />
or<strong>di</strong>narie <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to, fra le quali rientra la Banca Sannitica, la prima <strong>di</strong> questo tipo fondata<br />
a Benevento, con un numero molto più ristretto <strong>di</strong> soci, che si proponevano chiaramente<br />
un fine <strong>di</strong> lucro. In entrambi i casi, ma più fra le banche popolari che fra le altre,<br />
spiccava la presenza <strong>di</strong> personaggi legati alla politica e all’attività amministrativa, specialmente<br />
dopo l’allargamento della base elettorale nel 1882, quando il numero <strong>degli</strong> elettori,<br />
nella città <strong>di</strong> Benevento, salì dal 2 al 10,7 per cento della popolazione. Si tentava<br />
<strong>di</strong> mantenere rapporti con il proprio elettorato anche attraverso l’esercizio del cre<strong>di</strong>to,<br />
prevalentemente riservato ai soci e a loro parenti <strong>ed</strong> amici, e potendo contare sul risconto<br />
assicurato dagli istituti <strong>di</strong> emissione. Ancora nel 1913, <strong>di</strong>fatti, gli ispettori della Banca<br />
d’Italia rilevavano che le quattro banche locali <strong>di</strong> Benevento erano «emanazioni <strong>di</strong><br />
quattro <strong>di</strong>versi partiti politici», i quali «si manten[eva]no strettamente avvinti i propri<br />
aderenti con la concessione del cre<strong>di</strong>to».<br />
Benevento, contava, sul finire <strong>degli</strong> anni Ottanta del secolo XIX, intorno a 22.000 abitanti<br />
e l’intera provincia, composta <strong>di</strong> 73 comuni, 256.000. L’antica città pontificia (Benevento<br />
era appartenuta per otto secoli allo Stato Pontificio) andava consolidando la sua<br />
funzione <strong>di</strong> centro burocratico-mercantile, ma con una forte presenza dei ceti agricoli,<br />
che aveva assunto con l’Unità, quando era <strong>di</strong>ventata capoluogo <strong>di</strong> una provincia costituita<br />
con comuni sottratti alle province dell’ex Regno <strong>di</strong> Napoli (Principato Ultra, Terra <strong>di</strong><br />
Lavoro, Molise e Capitanata). Le numerose amministrazioni comunali che si erano succ<strong>ed</strong>ute<br />
avevano posto mano ad una serie <strong>di</strong> lavori pubblici, ancora in corso a fine secolo,<br />
che stavano mutando il volto della città, come lo «sventramento» e l’allargamento della<br />
Via Magistrale (oggi Corso Garibal<strong>di</strong>); la costruzione del viale che congiungeva il ponte<br />
sul Calore alla stazione ferroviaria, attorno alla quale si stavano concentrando alcuni sta-<br />
25
ilimenti industriali; la costruzione della «Villa Comunale» e del nuovo acqu<strong>ed</strong>otto; il<br />
riattamento <strong>di</strong> parecchi e<strong>di</strong>fici appartenuti agli or<strong>di</strong>ni religiosi per sistemarvi uffici pubblici<br />
e caserme. L’«abbellimento» del centro citta<strong>di</strong>no non risolveva, però, i problemi del<br />
sovraffollamento dei quartieri popolari e il bisogno <strong>di</strong> civili abitazioni . Anche nella viabilità<br />
si erano registrati notevoli progressi. I lavori pubblici avviati, compresa la costruzione<br />
<strong>di</strong> alcuni tratti ferroviari, che collegarono Benevento a Napoli, a Foggia, a Campobasso<br />
e ad Avellino, avevano messo in moto una considerevole massa <strong>di</strong> denaro e creato<br />
opportunità <strong>di</strong> lavoro per parecchie persone.<br />
Nella seconda metà <strong>degli</strong> anni Ottanta, i depositi nelle casse <strong>di</strong> risparmio postali e<br />
nelle poche banche della provincia erano raddoppiati, passando da 725 mila lire a quasi<br />
1,5 milioni, <strong>di</strong> cui oltre il 60 per cento presso le casse postali. Era un incremento molto<br />
superiore a quello nazionale, che nello stesso arco <strong>di</strong> tempo aveva fatto registrare una<br />
crescita inferiore al 33 per cento. La <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> risparmi era, quin<strong>di</strong>, in forte aumento<br />
a livello provinciale, ma si trattava pur sempre <strong>di</strong> risparmi modesti in rapporto<br />
alla popolazione: appena 6 lire per abitante nel 1889 rispetto alle 39 lire della Campania<br />
e alle 22 dell’intero Regno. Vi era, comunque, un certo mercato del cre<strong>di</strong>to, che v<strong>ed</strong>eva<br />
sicuramente la presenza <strong>di</strong> molti prestatori privati e nel quale si erano inserite le poche<br />
banche della provincia. Nel 1886 esistevano soltanto cinque piccole banche popolari e<br />
numerosi Monti pecuniari e frumentari, oltre alla filiale del più importante istituto <strong>di</strong><br />
emissione italiano, la Banca Nazionale nel Regno d’Italia, aperta nel 1869, che dovevano<br />
far fronte alle esigenze <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to <strong>di</strong> una provincia essenzialmente agricola e con pochi<br />
capitali <strong>di</strong>sponibili per impieghi <strong>di</strong> rischio.<br />
1.2. La nascita della Banca Sannitica - Nell’aprile del 1889, <strong>di</strong>nanzi al notaio Serafino<br />
Capilongo, in casa <strong>di</strong> Enrico Corrado a Benevento, veniva stilato l’atto <strong>di</strong> costituzione<br />
della Banca Sannitica, una società anonima per azioni, che si proponeva <strong>di</strong> «dare un<br />
maggiore incremento alle operazioni commerciali, <strong>ed</strong> industriali» della provincia. Non<br />
si sa molto dei fondatori della Banca. Promotore dell’impresa fu certamente Enrico Corrado,<br />
nato a Montesarchio nel 1836, avvocato, ex deputato al Parlamento, appartenente<br />
a quel gruppo <strong>di</strong> intraprendenti famiglie, molte delle quali provenienti appunto dalla<br />
provincia, che dopo l’Unità avevano gradualmente rimpiazzato, nella vita politica, amministrativa<br />
<strong>ed</strong> economica <strong>di</strong> Benevento, l’antica aristocrazia legata al ricordo dei benefici<br />
<strong>di</strong> cui aveva goduto all’epoca del governo pontificio. Corrado fu costantemente presente<br />
nella vita politica citta<strong>di</strong>na per un quarto <strong>di</strong> secolo, sia come parlamentare in due<br />
legislature (dal 1882 al 1886 e dal 1900 al 1904) sia come consigliere provinciale.<br />
Un altro socio, Giuseppe Mazzella, proprietario, apparteneva ad un’antica famiglia<br />
prelatizia della vicina Vitulano, <strong>di</strong> cui allora facevano parte un car<strong>di</strong>nale e un paio <strong>di</strong> vescovi.<br />
Specialmente il figlio Giovanni, avvocato e genero del Corrado, avrà un ruolo <strong>di</strong><br />
primo piano nella vita della Banca e sarà presente nelle contese politiche locali dalla<br />
parte dei clericali moderati, che si accoglievano attorno a Nazzareno Cosentini. I due<br />
maggiori azionisti, che avevano sottoscritto duecentocinquanta azioni ciascuno, erano<br />
Enrico Angiulli, che veniva da Napoli, convinto dal Corrado ad investire un cospicuo<br />
capitale nella società, e Gian Battista Pagano, ingegnere capo del Genio civile (e in tale<br />
veste era stato in servizio per qualche tempo a Benevento) e ricco proprietario <strong>di</strong> Quadrelle,<br />
piccolo centro dell’Avellinese, nella parte della provincia che degrada verso la<br />
pianura napoletana, non <strong>di</strong>stante da Domicelle, da dove veniva un altro socio, Francesco<br />
Ferrante, anch’egli possidente e imparentato con il Pagano.<br />
26
Il ristretto gruppo <strong>di</strong> do<strong>di</strong>ci soci che <strong>di</strong><strong>ed</strong>e vita alla Banca Sannitica era abbastanza<br />
composito, ma più per provenienza (i maggiori sottoscrittori <strong>di</strong> azioni non risi<strong>ed</strong>evano<br />
nella provincia) che per estrazione sociale. Essi, comunque, gravitavano attorno al Corrado,<br />
che aveva da poco superato la cinquantina e che assunse la carica <strong>di</strong> presidente del<br />
Consiglio <strong>di</strong> amministrazione, pur avendo sottoscritto appena il cinque per cento delle<br />
azioni. Fra <strong>di</strong> loro vi erano possidenti, professionisti e qualche impren<strong>di</strong>tore, che misero<br />
assieme la non rilevante cifra <strong>di</strong> cinquantamila lire, ossia la metà del capitale sociale <strong>di</strong><br />
centomila lire, senza essere più chiamati a completare il versamento fino al primo dopoguerra.<br />
1.3. Le <strong>di</strong>fficoltà iniziali - L’ambiente economico e sociale in cui la Banca si trovò ad<br />
operare non era certamente dei più stimolanti, sia per la povertà della provincia, sia per<br />
il momento in cui nacque. L’Italia stava attraversando, infatti, la fase più acuta della crisi<br />
agraria, che si manifestava con una consistente <strong>di</strong>minuzione dei prezzi agricoli per la<br />
forte concorrenza dei grani americani e russi, provocata dai minori costi <strong>di</strong> trasporto.<br />
Era stata, inoltre, investita da una crisi che aveva coinvolto l’intero sistema bancario nazionale,<br />
il quale ne era uscito profondamente ristrutturato, con la nascita della Banca<br />
d’Italia e delle due gran<strong>di</strong> «banche miste», la Banca Commerciale Italiana e il Cre<strong>di</strong>to<br />
Italiano.<br />
I primi tempi della Sannitica furono, perciò, particolarmente <strong>di</strong>fficili, con utili modesti<br />
e comunque inferiori alle aspettative, tanto che per qualche anno gli azionisti dovettero<br />
rinunziare al <strong>di</strong>videndo e alcuni uscirono dalla società, sostituiti da nuovi soci locali.<br />
Vi era evidentemente qualche <strong>di</strong>fficoltà nella formazione <strong>di</strong> un gruppo che potesse<br />
guidare la Banca, anche per l’assenza <strong>di</strong> competenze specifiche in materia bancaria, se<br />
si eccettua forse il primo consigliere delegato, Enrico Angiulli, che rimase alla <strong>di</strong>rezione<br />
dell’istituto solo per qualche anno. Non è improbabile che alcuni soci avessero sottoscritto<br />
le azioni più per amicizia verso Corrado che per convinzione nella bontà<br />
dell’iniziativa. La compagine sociale, comunque, si andò amalgamando, con la presenza<br />
in Consiglio <strong>di</strong> amministrazione, accanto al Corrado, <strong>di</strong> alcuni avvocati beneventani,<br />
impegnati nella vita politica e amministrativa dalla parte dei clericali moderati, come<br />
Giovanni Mazzella, genero del fondatore, che <strong>di</strong>venne vice presidente del Consiglio <strong>di</strong><br />
amministrazione, e Ilario Iorio, ex sindaco <strong>di</strong> Benevento, che assunse le funzioni <strong>di</strong> consigliere<br />
delegato della Banca. Ad essi si aggiunse, sul finire del secolo, l’avvocato Domenico<br />
Cangiano, poi <strong>di</strong>ventato sindaco della città, particolarmente interessato al settore<br />
cre<strong>di</strong>tizio, dal momento che fece parte, negli anni successivi, <strong>di</strong> altre due banche. Per<br />
molto tempo, queste persone si trovarono contemporaneamente a far parte del Consiglio<br />
comunale, <strong>di</strong> quello provinciale o, come nel caso <strong>di</strong> Corrado, della Camera dei deputati,<br />
a testimonianza <strong>degli</strong> stretti legami fra amministrazioni locali, attività politica e mondo<br />
<strong>degli</strong> affari. D’altro canto, alcuni <strong>di</strong> essi erano presenti come amministratori anche in altre<br />
banche, fra le quali, perciò, vi doveva essere piuttosto un certo collegamento che un<br />
forte spirito <strong>di</strong> concorrenza.<br />
La Banca Sannitica raccolse, nei primi anni, depositi che si mantennero intorno alle<br />
150 mila lire, per superare la soglia delle 200 mila lire solo nel 1897, quando la crisi<br />
economica che aveva interessato l’intero Paese si era ormai esaurita. Anche se lo statuto<br />
prev<strong>ed</strong>eva <strong>di</strong>verse forme <strong>di</strong> impiego, la Banca si limitò quasi esclusivamente allo<br />
sconto delle cambiali, che venivano normalmente rinnovate per un importo pari all’80<br />
per cento del debito originario. Qualche per<strong>di</strong>ta, dovuta all’insolvenza dei primi clienti,<br />
27
e il ridotto numero delle operazioni, contribuirono a determinare i deludenti risultati<br />
dei primi anni.<br />
1.4. Il consolidamento della Banca nei primi anni del Novecento - Con il nuovo secolo,<br />
la Banca iniziò una fase <strong>di</strong> crescita e la fiducia si <strong>di</strong>ffuse fra gli amministratori.<br />
L’economia beneventana stava migliorando sensibilmente e fece registrare un forte incremento<br />
della produzione agricola e l’ampliamento <strong>di</strong> alcune attività industriali nei rami<br />
della fabbricazione dei liquori, della lavorazione del torrone, della macinazione dei<br />
cereali e della produzione <strong>di</strong> paste alimentari. Nacquero anche altre banche <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to<br />
or<strong>di</strong>nario in città e in provincia, in genere <strong>di</strong> modeste <strong>di</strong>mensioni e non tutte destinate ad<br />
affermarsi in modo duraturo, ma sicuro in<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> un risveglio economico dopo anni <strong>di</strong><br />
gravi <strong>di</strong>fficoltà, delle quali si è già detto nel capitolo prec<strong>ed</strong>ente a proposito del settore<br />
terziario.<br />
Presso la Banca Sannitica i depositi affluirono copiosi, portandosi, alla vigilia della<br />
grande guerra, a quasi 1,8 milioni <strong>di</strong> lire, anche grazie alle rimesse <strong>degli</strong> emigrati della<br />
provincia, che allora partivano numerosi per le Americhe. Si ebbe ad<strong>di</strong>rittura qualche<br />
<strong>di</strong>fficoltà ad impiegare i fon<strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibili, tanto che si dovette ridurre il saggio<br />
d’interesse sui prestiti per cercare <strong>di</strong> allocare le risorse ecc<strong>ed</strong>enti. Allo sconto delle<br />
cambiali si preferì una forma d’impiego meno rischiosa, quella dei «fi<strong>di</strong> ipotecari», consistente<br />
nello sconto <strong>di</strong> effetti assistiti da garanzia ipotecaria, con possibilità <strong>di</strong> rimborso<br />
graduale me<strong>di</strong>ante il rinnovo parziale delle cambiali. Beneficiarono <strong>di</strong> questo tipo <strong>di</strong> finanziamento<br />
specialmente i proprietari terrieri della provincia e qualche commerciante<br />
del capoluogo. Prestiti <strong>di</strong> una certa consistenza andarono anche agli stessi soci e amministratori<br />
della Banca o a loro parenti <strong>ed</strong> amici, come quel Gennaro Zolli, seguace<br />
dell’onorevole Nazzareno Cosentini, che era stato sindaco <strong>di</strong> S. Angelo a Cupolo e che<br />
fu finanziato più volte anche per importi rilevanti.<br />
Intanto, i vertici della Banca avevano subito un assestamento definitivo. Nel 1904 era<br />
entrato un nuovo socio, Pietro Perlingieri, anch’egli genero <strong>di</strong> Corrado, che rilevò un<br />
consistente pacchetto azionario e <strong>di</strong>venne il principale azionista con il 32,5 per cento del<br />
capitale sociale. Eletto nel Consiglio <strong>di</strong> amministrazione nel 1907 con i suoi soli voti,<br />
<strong>di</strong>venne consigliere delegato nel 1911, mentre il cognato Giovanni Mazzella assumeva<br />
la funzione <strong>di</strong> presidente, in sostituzione del suocero, ritiratosi nel 1909 e scomparso<br />
due anni più tar<strong>di</strong>. Perlingieri, un affermato avvocato beneventano, proveniva da una<br />
famiglia <strong>di</strong> impren<strong>di</strong>tori, con interessi in molti campi. Oltre ad una sorella, aveva tre fratelli,<br />
due dei quali, Alessandro e F<strong>ed</strong>erico, <strong>di</strong>ventarono in seguito soci della Banca.<br />
Pietro, Alessandro e F<strong>ed</strong>erico, seguendo le orme del padre Raffaele, si impegnarono<br />
con successo anche negli affari, che furono sempre molteplici e vari. Prima della grande<br />
guerra, Pietro fu consigliere e assessore comunale, appaltatore del dazio comunale, oltre<br />
che maggiore azionista della Sannitica, in nome della quale prese parte a numerose iniziative<br />
industriali, commerciali e agricole, acquistando in proprio anche una vasta tenuta<br />
alle porte <strong>di</strong> Benevento. F<strong>ed</strong>erico, laureato in scienze agrarie, esperto in viticoltura <strong>ed</strong><br />
enologia, gestì per qualche tempo una piccola fabbrica <strong>di</strong> fiammiferi che era stata del<br />
padre, da lui ammodernata nel primo dopoguerra, e fu interessato, assieme al fratello<br />
Pietro, in una vasta azienda agricola <strong>di</strong> Dugenta (l’attuale «Torre Gaia»), <strong>di</strong> cui <strong>di</strong>venne<br />
in seguito amministratore unico, oltre che nella Società Elettrochimica del Sannio. Alessandro,<br />
infine, dopo essere passato per la carriera militare e un impiego presso la Banca<br />
Commerciale Italiana, impiantò, dopo la prima guerra mon<strong>di</strong>ale, un moderno cotonificio<br />
28
che dava lavoro ad una novantina <strong>di</strong> operai. I Perlingieri avevano ovviamente una vasta<br />
rete <strong>di</strong> rapporti con i maggiori impren<strong>di</strong>tori e commercianti, che risultò rafforzata dalla<br />
posizione che almeno due <strong>di</strong> loro, Pietro e F<strong>ed</strong>erico, assunsero nella Banca Sannitica.<br />
Proprio il desiderio <strong>di</strong> impegnarsi più <strong>di</strong>rettamente negli affari, pur senza abbandonare<br />
l’attività forense, dovette indurre Pietro Perlingieri ad assumere il controllo della Banca,<br />
non senza qualche resistenza da parte <strong>degli</strong> altri soci. Perciò, il nuovo azionista <strong>di</strong> maggioranza<br />
ebbe l’appoggio, nel Consiglio <strong>di</strong> amministrazione, più che dal cognato Mazzella,<br />
da Domenico Cangiano e da due esponenti <strong>di</strong> famiglie <strong>di</strong> produttori <strong>di</strong> torrone:<br />
Edoardo Sifo e Giovanni Imperlino.<br />
2. La grande guerra e l’espansione <strong>degli</strong> anni Venti<br />
2.1. Gli impieghi negli anni <strong>di</strong> guerra - Lo scoppio della guerra, nell’estate del 1914,<br />
creò serie <strong>di</strong>fficoltà al sistema bancario italiano. Anche se l’Italia non era ancora coinvolta<br />
nel conflitto, vi fu una corsa agli sportelli <strong>di</strong> banche e casse <strong>di</strong> risparmio per ritirare<br />
i depositi. Fu perciò necessario adottare alcuni provve<strong>di</strong>menti, al pari <strong>di</strong> quanto stavano<br />
facendo i governi dei paesi in guerra, per evitare ulteriori <strong>di</strong>fficoltà alle banche. Il<br />
saggio ufficiale <strong>di</strong> sconto fu elevato dal 5 al 6 per cento e fu <strong>di</strong>chiarata la «moratoria»,<br />
con la quale la scadenza delle cambiali venne prorogata <strong>di</strong> venti giorni e gli istituti <strong>di</strong><br />
cre<strong>di</strong>to, tranne quelli <strong>di</strong> emissione, furono autorizzati a limitare i rimborsi dei depositi al<br />
5 per cento (poi elevato al 10) dell’ammontare <strong>di</strong> ciascun conto, esclusi quelli destinati<br />
al pagamento <strong>di</strong> salari e stipen<strong>di</strong>.<br />
La Banca Sannitica, come rilevarono gli amministratori, non risentì della «conflagrazione<br />
europea», che aveva «messo a dura prova la soli<strong>di</strong>tà degl’Istituti <strong>di</strong> Cre<strong>di</strong>to». Certo,<br />
la marginalità dell’economia beneventana fece avvertire <strong>di</strong> meno gli effetti imme<strong>di</strong>ati<br />
della guerra, come la rarefazione <strong>di</strong> materie prime e <strong>di</strong> generi alimentari, con conseguente<br />
aumento dei loro prezzi, le <strong>di</strong>fficoltà dei trasporti marittimi, il turbamento dei<br />
mercati monetari e finanziari e, appunto, il ritiro dei depositi bancari da parte dei risparmiatori<br />
impauriti. Ma fu comunque motivo <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfazione per gli amministratori<br />
riferire ai soci che il loro istituto, «sorretto dalla fiducia costante della sua clientela»,<br />
aveva potuto continuare «il suo normale andamento» senza avvalersi delle facoltà concesse<br />
dai decreti sulla moratoria. Anche l’entrata in guerra dell’Italia, nel maggio del<br />
1915, non ebbe alcun effetto sulla Banca Sannitica. Negli anni successivi tutti i valori <strong>di</strong><br />
bilancio della Banca furono in rapida crescita e nel 1918 la raccolta fu <strong>di</strong> quasi 3 milioni<br />
<strong>di</strong> lire e gli utili continuarono ad assicurare <strong>di</strong>viden<strong>di</strong> dell’8 per cento del capitale versato<br />
e un cospicuo incremento delle riserve. Bisogna, però, tenere presente l’inflazione <strong>di</strong><br />
quegli anni, dovuta anche all’eccessiva emissione <strong>di</strong> moneta cartacea, e la conseguente<br />
forte riduzione del potere d’acquisto della moneta. Il costo della vita, che era aumentato<br />
<strong>di</strong> appena il 7,30 per cento nei venticinque anni intercorsi fra la nascita della Banca<br />
Sannitica e il 1914, si moltiplicò, da allora al 1918, per 2,6 volte <strong>ed</strong> entro il 1921 per<br />
quasi 4,2 volte. Trasformando i valori correnti delle principali voci <strong>di</strong> bilancio in valori<br />
costanti (lire del 1913), si nota come nel 1918 la raccolta si fosse ridotta, rispetto al<br />
1914, del 44 per cento e gli impieghi del 29 per cento.<br />
La Banca sottoscrisse, fin dalla prima emissione, i titoli dei sei prestiti nazionali, con<br />
i quali si tentava <strong>di</strong> fare fronte alle spese <strong>di</strong> guerra, collocati da un consorzio <strong>di</strong> banche<br />
guidato dalla Banca d’Italia. Essi furono ben accolti da enti e privati sia per il particola-<br />
29
e clima patriottico, tenuto vivo da una martellante propaganda, sia perché fu tacitamente<br />
garantito ai sottoscrittori che i titoli non sarebbero stati gravati <strong>di</strong> ulteriori imposte e<br />
perché gli istituti <strong>di</strong> emissione, come avveniva negli altri paesi belligeranti, conc<strong>ed</strong>evano<br />
su <strong>di</strong> essi anticipazioni a con<strong>di</strong>zioni favorevoli. La Banca Sannitica non solo acquistò<br />
tali titoli per proprio conto (nel 1916 ne poss<strong>ed</strong>eva per 234.500 lire), ma raccolse anche<br />
sottoscrizioni fra la clientela e, per consentire «alle più modeste fortune» <strong>di</strong> partecipare<br />
all’acquisto, decise <strong>di</strong> istituire speciali libretti a risparmio, vincolati al pagamento dei<br />
titoli sottoscritti dai clienti <strong>ed</strong> acquistati dalla Banca per loro conto, che fruttavano un<br />
interesse del 5 per cento. La novità del tempo <strong>di</strong> guerra fu il passaggio dai più sicuri fi<strong>di</strong><br />
ipotecari alle aperture <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to in conto corrente (anche se comunque garantiti dal deposito<br />
<strong>di</strong> valori), decise <strong>di</strong>rettamente dal consigliere delegato Pietro Perlingieri.<br />
Nel 1920 i beneficiari <strong>di</strong> scoperto in conto corrente erano appena se<strong>di</strong>ci e fra essi si<br />
annoveravano: la <strong>di</strong>tta Carmine Profeta, produttrice <strong>di</strong> torrone (481 mila lire), i fratelli<br />
Massa, che stavano eseguendo i lavori <strong>di</strong> sistemazione del fiume Sabato (139 mila lire),<br />
la <strong>di</strong>tta Giovanni Napolitano <strong>di</strong> Airola, che commerciava in grano e granone (98 mila<br />
lire), il presidente della Banca Giovanni Mazzella, che era anche produttore <strong>di</strong> olio <strong>di</strong><br />
oliva (42 mila lire), Gennaro Zolli (35 mila lire) e la <strong>di</strong>tta Sifo e Barbieri, produttrice <strong>di</strong><br />
torrone (24 mila lire).<br />
La <strong>di</strong>tta Carmine Profeta era debitrice da sola <strong>di</strong> più della metà delle somme prestate.<br />
Essa era stata finanziata, nel 1917, con 200 mila lire, per consentirle <strong>di</strong> produrre un<br />
grande quantitativo <strong>di</strong> torrone «collocato in zona <strong>di</strong> operazione», ossia dove erano concentrato<br />
l’Esercito. Giunto l’armistizio, i «ricompratori dell’Alta Italia» non pagarono<br />
«sotto vari pretesti», per cui la <strong>di</strong>tta dovette iniziare i proce<strong>di</strong>menti giu<strong>di</strong>ziari nei loro<br />
confronti e non poté restituire i prestiti ottenuti. Il consigliere delegato della Banca, per<br />
evitarne il fallimento, si fece promotore della costituzione <strong>di</strong> una società anonima, alla<br />
quale vennero trasferite tutte le attività e passività della <strong>di</strong>tta Profeta. Per conto della<br />
Banca, egli sottoscrisse 160 mila lire <strong>di</strong> azioni su un capitale <strong>di</strong> 250 mila lire «per poter<br />
controllare l’azienda», con la facoltà dei fratelli Profeta <strong>di</strong> riscattare le azioni nel termine<br />
<strong>di</strong> tre anni, e finanziò in seguito la società «per metterla in grado <strong>di</strong> lavorare e pagare<br />
il suo debito». Nel 1917 fu anche assunta dalla Banca, allora sistemata nel palazzo Bosco<br />
Lucarelli, la prima donna, che solo tre anni più tar<strong>di</strong> venne inquadrata in pianta stabile<br />
con la qualifica <strong>di</strong> contabile, ma con uno stipen<strong>di</strong>o inferiore a quello del contabile<br />
<strong>di</strong> sesso maschile.<br />
2.2. I «gran<strong>di</strong> affari» del primo dopoguerra - Il dopoguerra fu un periodo <strong>di</strong> euforia,<br />
specialmente nel settore del cre<strong>di</strong>to, già cresciuto <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>natamente durante il conflitto,<br />
che spinse molte banche sulla strada arrischiata <strong>degli</strong> impieghi poco sicuri, pur <strong>di</strong> collocare<br />
i fon<strong>di</strong> che affluivano copiosi. Anche a Benevento sorsero altre banche, fra le quali<br />
le già ricordate Banca Agricola Industriale del Sannio (BAIS), Banca del Lavoro e del<br />
Piccolo Risparmio e Banca <strong>di</strong> Benevento. La Banca Sannitica dovette prendere atto che<br />
l’inflazione e l’espansione <strong>degli</strong> affari non le consentivano <strong>di</strong> poter continuare l’attività<br />
con un capitale versato <strong>di</strong> appena 50 mila lire e con l’unica s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong> Benevento. Nel<br />
1921, il capitale fu aumentato a 500 mila lire, <strong>di</strong> cui versate soltanto 200 mila lire, e lo<br />
statuto venne mo<strong>di</strong>ficato per consentire altre operazioni, come l’assunzione <strong>di</strong> partecipazioni<br />
in società <strong>di</strong> qualsiasi tipo, peraltro già iniziate dal consigliere delegato Perlingieri<br />
con l’ingresso nella società anonima Carmine Profeta e con l’acquisto <strong>di</strong> azioni<br />
30
dell’Ansaldo e del Banco <strong>di</strong> Roma, ossia <strong>di</strong> due società allora in forte espansione, ma<br />
che entrarono in crisi negli anni successivi.<br />
Con l’aumento del capitale sociale, il pacchetto azionario <strong>di</strong> Pietro Perlingieri si portò<br />
a circa il 27 per cento del totale, mentre entravano nella Banca e nel Consiglio <strong>di</strong><br />
amministrazione nuovi soci appartenenti al ceto impren<strong>di</strong>toriale e commerciale citta<strong>di</strong>no,<br />
come Domenico Napolitano, Salvatore Meomartini e Salvatore Barbieri, che rafforzarono<br />
il gruppo <strong>di</strong>rigente riunito attorno al consigliere delegato. Furono anche aperte le<br />
prime quattro agenzie in provincia (Montesarchio, Solopaca, Cusano Mutri e Pontelandolfo)<br />
e l’attività della Banca conobbe una forte espansione, con la raccolta giunta, nel<br />
1926, a oltre 15 milioni <strong>di</strong> lire e gli impieghi a più <strong>di</strong> 11 milioni, mentre gli investimenti<br />
in titoli si avvicinavano a 1,5 milioni e gli utili a 65 mila lire.<br />
Tutto il sistema cre<strong>di</strong>tizio italiano era cresciuto <strong>di</strong>sor<strong>di</strong>natamente durante la guerra e<br />
nei primi anni Venti. La favorevole congiuntura economica seguita alla crisi <strong>di</strong> riconversione<br />
postbellica e l’assenza <strong>di</strong> vincoli allo svolgimento dell’attività bancaria, priva<br />
<strong>di</strong> barriere all’entrata e <strong>di</strong> efficaci forme <strong>di</strong> controllo, portarono infatti ad un’espansione<br />
dell’attività e dei profitti. I dati evidenziano, per l’intero Paese, fra il 1922 e il 1925, una<br />
crescita <strong>degli</strong> sportelli bancari da seimila a più <strong>di</strong> un<strong>di</strong>cimila.<br />
Di particolare rilievo per il futuro della Banca fu l’assunzione della Ricevitoria e<br />
Cassa provinciale, che procurò buoni guadagni, consentendole <strong>di</strong> realizzare utili elevati,<br />
senza i quali la crisi <strong>degli</strong> anni Trenta sarebbe stata molto più <strong>di</strong>fficile. Proficui risultarono<br />
anche i rapporti <strong>di</strong> corrispondenza, allora intrapresi, con alcuni importanti istituti<br />
<strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to nazionali, quali la Banca Commerciale Italiana (da tempo in rapporti d’affari<br />
con la Sannitica), il Cre<strong>di</strong>to Italiano e il Banco <strong>di</strong> Napoli.<br />
Fu questo un periodo in cui la Banca, per impulso del consigliere delegato, partecipò<br />
a numerosi «gran<strong>di</strong> affari», tralasciando le piccole operazioni. Durante e dopo la guerra,<br />
<strong>di</strong>fatti, alcuni uomini intraprendenti tentarono <strong>di</strong> dare un impulso all’economia beneventana,<br />
avviando e rafforzando iniziative in vari rami, dall’alimentare al minerario, dal<br />
tessile alla produzione <strong>di</strong> liquori, torrone e dolciumi, dall’e<strong>di</strong>lizia alla lavorazione del<br />
legno. Si trattò <strong>di</strong> imprese, talvolta <strong>di</strong> modeste <strong>di</strong>mensioni, che puntavano sulle poche<br />
risorse locali, spesso collegate con la prevalente attività agricola. Alcune non ebbero<br />
successo <strong>ed</strong> altre si trovarono in <strong>di</strong>fficoltà più o meno gravi con la crisi <strong>degli</strong> anni Trenta.<br />
Le élites produttive locali non sempre si mostrarono capaci <strong>di</strong> perseguire gli obiettivi<br />
prefissati, forse anche per assenza <strong>di</strong> maestranze preparate, e finirono con l’adagiarsi<br />
sulle commesse pubbliche, ricorrendo alla protezione dei nuovi governanti. La Banca<br />
sostenne alcune <strong>di</strong> queste iniziative, acquistando quote <strong>di</strong> capitale e conc<strong>ed</strong>endo finanziamenti,<br />
principalmente fra il 1921 e il 1925. Della partecipazione nella società anonima<br />
Carmine Profeta si è già detto. Questa società era esposta verso la Banca per quasi<br />
1,2 milioni <strong>di</strong> lire e il consigliere delegato, che l’aveva sostenuta, doveva riconoscere<br />
che qualche per<strong>di</strong>ta era purtroppo possibile, ma si <strong>di</strong>chiarò <strong>di</strong>sposto ad assumere su <strong>di</strong> sé<br />
ogni per<strong>di</strong>ta superiore a 300 mila lire. Il Consiglio <strong>di</strong> amministrazione, preso atto della<br />
garanzia offerta, fissò in <strong>di</strong>eci anni il termine massimo per recuperare il cre<strong>di</strong>to.<br />
Anche Salvatore Massa <strong>di</strong> Campolattaro era debitore, assieme ai fratelli, <strong>di</strong> 561 mila<br />
lire. La sua <strong>di</strong>tta era stata finanziata per i lavori <strong>di</strong> sistemazione del fiume Sabato e per<br />
altri lavori pubblici. Il consigliere delegato aveva dapprima pattuito una compartecipazione<br />
della Banca ad un terzo <strong>degli</strong> utili netti della <strong>di</strong>tta, ma poi si era ritirato dall’affare.<br />
Ora, la Banca si impegnava a finanziare tutti i lavori entro il 1925 per l’importo minimo<br />
<strong>di</strong> tre milioni, percependo una provvigione del 5 per cento sui mandati <strong>di</strong> oltre 400 mila<br />
31
lire e l’interesse <strong>di</strong> sportello sulle somme prestate. Il Massa ottenne in seguito un altro<br />
finanziamento, essendosi aggiu<strong>di</strong>cati i lavori per l’acqu<strong>ed</strong>otto <strong>di</strong> Circello. L’esposizione<br />
più rilevante, però, era quella <strong>di</strong> F<strong>ed</strong>erico Perlingieri, fratello del consigliere delegato,<br />
che ammontava a 1,7 milioni <strong>di</strong> lire. F<strong>ed</strong>erico Perlingieri gestiva la fabbrica <strong>di</strong> fiammiferi<br />
appartenuta al padre, nella quale aveva introdotto, proprio nel 1922, la lavorazione<br />
meccanica e perciò aveva avuto bisogno <strong>di</strong> così rilevanti finanziamenti. Siccome non<br />
riuscì a restituire il debito entro i termini fissati, fu costretto a trasformare la sua azienda<br />
in società anonima, che avrebbe assunto come obbligo principale la sod<strong>di</strong>sfazione integrale<br />
del debito, <strong>ed</strong> a consentire che i pagamenti a suo favore da parte del Consorzio Industrie<br />
Fiammiferi <strong>di</strong> Roma, acquirente dei fiammiferi prodotti, fossero fatti alla Banca.<br />
Il debito fu completamente estinto entro il 1927.<br />
Un altro intervento riguardò la costituzione, nel 1921, della Società Anonima Mineraria<br />
Monte Mutri, per lo sfruttamento del «banco bauxitico» <strong>di</strong> Cusano Mutri, che appariva<br />
- secondo gli amministratori della Sannitica - «uno dei più importanti d’Italia» e<br />
perciò si <strong>di</strong>cevano lieti <strong>di</strong> contribuire a valorizzare una delle poche ricchezze minerarie<br />
della provincia. La Società, sorta con la partecipazione della Banca, che aveva sottoscritto<br />
parte del capitale sociale <strong>di</strong> 2,3 milioni <strong>di</strong> lire, e <strong>di</strong> alcuni amici dell’istituto, ottenne,<br />
agli inizi del 1923, l’apertura <strong>di</strong> un conto corrente con un fido <strong>di</strong> 500 mila lire per<br />
consentirle <strong>di</strong> completare gli impianti. Anche se dotata <strong>di</strong> tutte le attrezzature per una<br />
razionale coltivazione e <strong>di</strong> una teleferica per il trasporto del materiale dal monte al piano,<br />
l’attività della miniera non durò molto. Nel 1925 si era iniziata la spe<strong>di</strong>zione negli<br />
Stati Uniti del minerale, poi interrotta per la rivalutazione della lira e per la <strong>di</strong>minuzione<br />
della domanda del paese americano. Né fu possibile collocare la bauxite estratta in Italia<br />
per i proibitivi costi del trasporto ferroviario, sicché la coltivazione della miniera fu sospesa.<br />
La Banca subirà, come v<strong>ed</strong>remo, forti per<strong>di</strong>te per aver sostenuto questa iniziativa,<br />
in cui una parte <strong>di</strong> rilievo aveva avuto il consigliere delegato.<br />
Un ultimo finanziamento, anch’esso non conclusosi positivamente, fu concesso, nel<br />
1924, all’ingegnere Antonio Fabrizio, giunto a Benevento da Tufo proprio quell’anno e<br />
che si impegnò nel settore e<strong>di</strong>lizio. Acquistato un terreno dai marchesi Roscio al corso<br />
Garibal<strong>di</strong>, <strong>di</strong> fronte alla Prefettura, chiese alla Banca Sannitica un’apertura <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to <strong>di</strong><br />
350 mila lire per costruirvi uno stabile destinato ad abitazioni, obbligandosi a corrispondere,<br />
oltre all’interesse, anche una provvigione del due per cento sul prezzo <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta<br />
<strong>degli</strong> appartamenti.<br />
Da quanto detto emerge, con tutta evidenza, che la Banca si era fortemente impegnata<br />
con pochi grossi clienti, partecipando anche <strong>di</strong>rettamente ai loro affari, e cominciava<br />
a trovare <strong>di</strong>fficoltà nel recupero <strong>di</strong> alcuni cre<strong>di</strong>ti. Tre debitori, Profeta, Massa e F<strong>ed</strong>erico<br />
Perlingieri, avevano accumulato debiti per quasi 3,3 milioni <strong>di</strong> lire, pari a circa la metà<br />
<strong>degli</strong> impieghi della Banca in sconti e conti correnti. È facile comprendere, quin<strong>di</strong>, come<br />
la situazione della Banca fosse particolarmente delicata e sarebbe stata ancora più<br />
grave se nel frattempo non fosse riuscita ad aggiu<strong>di</strong>carsi il servizio <strong>di</strong> Ricevitoria provinciale<br />
e a stringere rapporti con altre banche, per conto delle quali curava l’emissione<br />
<strong>di</strong> assegni e l’incasso <strong>degli</strong> effetti.<br />
2.3. La legge bancaria del 1926 e l’ispezione alla Sannitica - Una svolta al sistema<br />
bancario italiano fu dato dalla legge del 1926, che <strong>di</strong>sciplinò l’attività cre<strong>di</strong>tizia e la sottopose<br />
al controllo della Banca d’Italia. Le banche furono costrette a rispettare determinati<br />
rapporti fra patrimonio sociale, raccolta e fi<strong>di</strong>, e la loro espansione territoriale, che<br />
32
era stata incontrollata e frenetica negli anni prec<strong>ed</strong>enti, fu sottoposta ad autorizzazione.<br />
La Banca Sannitica, come altre aziende <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to, cercò <strong>di</strong> profittare della situazione<br />
prima dell’entrata in vigore della legge e aprì agenzie in trentatré comuni della provincia,<br />
che ne contava poco più <strong>di</strong> settanta. Ma si trattava, in molti casi, <strong>di</strong> semplici recapiti<br />
<strong>di</strong> scarso rilievo. La nuova legge stabiliva che il patrimonio sociale (capitale versato e<br />
riserve) delle aziende <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to non potesse essere inferiore ad un ventesimo dei depositi<br />
e che il fido massimo da accordare ad un solo cliente non potesse superare il quinto<br />
del patrimonio senza una preventiva autorizzazione della Banca d’Italia. Per rispettare<br />
questi rapporti, la Banca Sannitica dovette aumentare il capitale sociale a un milione. Il<br />
numero <strong>di</strong> soci aumentò, ma le azioni si ritrovarono concentrate in poche mani: due soli<br />
soci, i fratelli Pietro e F<strong>ed</strong>erico Perlingieri, ebbero il 30 e il 17 per cento del capitale. Il<br />
primo conservò la funzione <strong>di</strong> consigliere delegato, mentre il secondo <strong>di</strong>venne vice presidente<br />
del Consiglio <strong>di</strong> amministrazione, esercitando <strong>di</strong> fatto le funzioni <strong>di</strong> presidente<br />
per la continua assenza dei titolari della carica. Ormai la famiglia Perlingieri teneva saldamente<br />
nelle proprie mani le re<strong>di</strong>ni della Banca, che si trovò ad affrontare momenti<br />
molto <strong>di</strong>fficili sul finire <strong>degli</strong> anni Venti, non dal punto <strong>di</strong> vista economico, visto che gli<br />
utili non erano mai stati così elevati, ma dal punto <strong>di</strong> vista dei rapporti interni e con<br />
l’ambiente circostante.<br />
Fra il 1927 e il 1928, la Prefettura <strong>di</strong> Benevento mosse un duro attacco alla Banca e<br />
al suo consigliere delegato, chi<strong>ed</strong>endo alla Banca d’Italia un’ispezione alla Sannitica e<br />
contestando la regolare istituzione della filiale <strong>di</strong> Airola. Nel frattempo furono messe in<br />
circolazione voci infondate <strong>di</strong> una forte multa inflitta alla Banca per infrazioni fiscali e<br />
fu presentato al procuratore del Re un esposto che insinuava una sottrazione indebita <strong>di</strong><br />
fon<strong>di</strong> da parte dell’amministratore delegato. L’esposto non ebbe seguito e l’ispezione<br />
mise in luce solo lievi irregolarità. Un duplice intervento del Ministero delle finanze,<br />
che <strong>di</strong><strong>ed</strong>e ragione alla Banca, mise fine alla questione. Ma la vicenda lasciò qualche<br />
strascico interno, costringendo alle <strong>di</strong>missioni due consiglieri, sospettati <strong>di</strong> comportamento<br />
sleale nei confronti della Banca. I legami della Banca con il nuovo regime, anche<br />
se non così stretti come lo erano stati quelli con il prec<strong>ed</strong>ente ceto politico e amministrativo<br />
della città, furono comunque molto forti, visto l’intervento in suo favore del<br />
Ministero delle finanze, che fu salutato con sod<strong>di</strong>sfazione, anche se l’istituto fu subito<br />
chiamato a conc<strong>ed</strong>ere alla F<strong>ed</strong>erazione provinciale fascista un’apertura <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to, che<br />
giunse a 60 mila lire, mai restituite, anzi successivamente integrate con altre 40 mila<br />
lire a titolo <strong>di</strong> elargizione gratuita.<br />
Sino alla fine <strong>degli</strong> anni Venti, l’attività della Banca Sannitica continuò ad espandersi,<br />
tanto da richi<strong>ed</strong>ere un aumento del personale, al quale furono concessi perio<strong>di</strong>ci aumenti<br />
<strong>di</strong> stipen<strong>di</strong>o. Alla fine del 1926, dovevano essere in servizio nella s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong> Benevento<br />
non meno <strong>di</strong> una quin<strong>di</strong>cina <strong>di</strong> persone. Negli anni successivi furono assunte altre<br />
tre o quattro unità, comprese due donne. Una <strong>di</strong> esse, però, fu licenziata nel 1932, in seguito<br />
a «vivi solleciti» del Sindacato dei bancari, perché la Banca «in omaggio ai desideri<br />
delle Superiori Gerarchie che intend[eva]no impiegare soprattutto elemento maschile»<br />
rispettasse la <strong>di</strong>sposizione in tal senso <strong>di</strong>ramata a tutte le aziende <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to.<br />
L’orario <strong>di</strong> lavoro era <strong>di</strong> 44 ore settimanali per gli impiegati e <strong>di</strong> 50 per i commessi,<br />
mentre la cassa restava aperta cinque ore al giorno dal lun<strong>ed</strong>ì al venerdì e tre ore il sabato.<br />
3. La crisi e il <strong>di</strong>fficile risanamento<br />
33
3.1. La crisi bancaria <strong>degli</strong> anni Trenta nel Beneventano - Alla fine del 1928 si registrò<br />
il fallimento del Cre<strong>di</strong>to Meri<strong>di</strong>onale, che aveva raccolto in provincia <strong>di</strong> Benevento<br />
qualcosa come 40 milioni <strong>di</strong> lire e che trascinò con sé la Banca Commerciale Beneventana.<br />
Nella relazione al bilancio del 1928, prendendo lo spunto dal <strong>di</strong>ssesto del Cre<strong>di</strong>to<br />
Meri<strong>di</strong>onale, gli amministratori della Sannitica esposero alcune considerazioni su un argomento<br />
allora molto <strong>di</strong>battuto e che li riguardava da vicino, vale a <strong>di</strong>re sull’utilità delle<br />
banche locali. Essi erano contrari all’opinione <strong>di</strong> chi sosteneva la necessità <strong>di</strong> giungere<br />
alla fusione <strong>di</strong> piccole banche per dare vita a istituti più gran<strong>di</strong>, perché ritenevano fallace<br />
la convinzione che una banca più grande e con un raggio <strong>di</strong> azione più vasto potesse<br />
eliminare i pericoli <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssesti e giovare alla tutela del risparmio. E riprendendo<br />
un’immagine più volte usata dagli economisti del passato, che assimilavano la circolazione<br />
monetaria assicurata dalle banche a quella del sangue, affermavano che i gran<strong>di</strong><br />
istituti a base nazionale costituiscono le «gran<strong>di</strong> arterie della circolazione bancaria», le<br />
banche regionali e provinciali ne costituiscono «le me<strong>di</strong>e arterie» e le agenzie delle banche<br />
provinciali e gli istituti locali costituivano «le piccole arterie e i vasi capillari». Tutti<br />
erano necessari, anche i piccoli istituti, che, ben amministrati, esplicavano la loro benefica<br />
azione senza alcun pericolo del risparmio e con vantaggio del cre<strong>di</strong>to. Perciò, non<br />
era con la concentrazione che si poteva garantire l’incolumità del risparmio, ma solo<br />
con la buona amministrazione. Ricordavano, infine, come istituti <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to sorti dalla<br />
fusione <strong>di</strong> più istituti locali e provinciali − e forse pensavano proprio al Cre<strong>di</strong>to Meri<strong>di</strong>onale<br />
− erano finiti miseramente «sia perché creati con la fusione <strong>di</strong> banche già tarate,<br />
e quin<strong>di</strong> col germe della <strong>di</strong>ssoluzione, sia perché creati con una bardatura costosa,<br />
scimmiottante quella <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> istituti, superiore alle loro forze». Gli amministratori riconoscevano,<br />
tuttavia, che talvolta il numero <strong>degli</strong> istituti in un piccolo centro poteva<br />
essere eccessivo e dare luogo ad una sfrenata concorrenza che li portava ad offrire ai<br />
depositanti tassi elevati e quin<strong>di</strong> ad impiegare il denaro raccolto a tassi ancora più elevati<br />
con clienti sui quali non si poteva fare sicuro affidamento per la restituzione dei prestiti.<br />
La grave crisi che colpì l’Italia nei primi anni Trenta fu segnata dal crollo della produzione,<br />
sia agricola che industriale, e da una forte crescita della <strong>di</strong>soccupazione, con<br />
conseguente riduzione del r<strong>ed</strong><strong>di</strong>to nazionale e peggioramento delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> vita<br />
della popolazione. Le banche, fortemente legate all’industria, si trovarono in grosse <strong>di</strong>fficoltà<br />
e fu necessario l’intervento del governo per salvare quelle maggiormente immobilizzate,<br />
come la Banca Commerciale Italiana, il Cre<strong>di</strong>to Italiano e il Banco <strong>di</strong> Roma,<br />
me<strong>di</strong>ante la creazione dapprima dell’IMI e poi dell’IRI.<br />
La Banca Sannitica continuò a v<strong>ed</strong>ere aumentare la raccolta, che nel 1928 raggiunse<br />
il punto massimo del periodo fra le due guerre mon<strong>di</strong>ali: oltre 20 milioni <strong>di</strong> lire.<br />
Dall’anno successivo, però, la depressione si fece sentire anche a Benevento e i fon<strong>di</strong><br />
raccolti cominciarono a <strong>di</strong>minuire, portandosi a 12,6 milioni <strong>di</strong> lire nel 1933. In quegli<br />
anni, la Banca si mostrò molto più accorta nel conc<strong>ed</strong>ere fi<strong>di</strong>, anche perché non riusciva<br />
a riscuotere molte cambiali in scadenza. Alla fine <strong>degli</strong> anni Venti, la Banca Sannitica<br />
assunse anche il concordato fallimentare della BAIS, impegnandosi a rilevare tutte le<br />
attività della banca fallita e a pagare i cre<strong>di</strong>ti privilegiati per intero e quelli chirografari<br />
al 20 per cento. Gli utili realizzati sulla liquidazione della BAIS ammontavano, a fine<br />
1932, a 345 mila lire e se ne prev<strong>ed</strong>evano ancora per 600 mila lire, ma vennero tutti destinati<br />
alla copertura <strong>di</strong> per<strong>di</strong>te verso altri clienti.<br />
34
3.2. La crisi della Banca Sannitica - Nella seconda metà <strong>degli</strong> anni Trenta, proprio<br />
mentre la congiuntura economica, sia nazionale che locale, tendeva al miglioramento,<br />
mostrando una ripresa della produzione e dei prezzi, la Banca Sannitica dovette affrontare<br />
gli anni più <strong>di</strong>fficili della sua esistenza, che avrebbero potuto portarla alla rovina.<br />
Nella relazione all’esercizio del 1933, gli amministratori furono costretti a proporre che<br />
l’utile, che non raggiungeva le 35 mila lire, invece <strong>di</strong> essere ripartito fra gli azionisti,<br />
venisse «riportato a nuovo», ossia rinviato all’esercizio successivo per coprire eventuali<br />
per<strong>di</strong>te. Anche negli anni successivi gli utili non vennero ripartiti e gli azionisti rimasero<br />
senza <strong>di</strong>videndo per ben otto anni, dal 1933 al 1940. La crisi economica che interessava<br />
la provincia rendeva sempre più <strong>di</strong>fficile il recupero dei cre<strong>di</strong>ti della Banca e faceva<br />
emergere forti per<strong>di</strong>te, la cui copertura non era più possibile rinviare. Fu perciò necessario<br />
avviare un’opera <strong>di</strong> risanamento contabile, cancellando o riducendo numerosi<br />
cre<strong>di</strong>ti. Una prima consistente svalutazione dei cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> oltre 1,2 milioni <strong>di</strong> lire fu decisa<br />
nel mese <strong>di</strong> <strong>di</strong>cembre del 1932 e riguardò alcuni importanti clienti. Le per<strong>di</strong>te furono<br />
coperte con gli utili derivanti dalla liquidazione della BAIS. L’anno successivo, impiegando<br />
il fondo <strong>di</strong> riserva straor<strong>di</strong>naria <strong>di</strong> 700 mila lire appositamente costituito, si <strong>di</strong>minuirono<br />
<strong>di</strong> 200 mila lire ciascuno i debiti <strong>di</strong> Salvatore Massa e <strong>di</strong> Antonio Fabrizio e si<br />
ridussero o annullarono numerose cambiali ritenute ormai inesigibili per altre 200 mila<br />
lire. Nel 1934, infine, si svalutarono altri cre<strong>di</strong>ti per cinquantamila lire. Le numerose<br />
agenzie aperte prima dell’approvazione della legge del 1926 dovettero essere in parte<br />
chiuse perché si rivelarono troppo costose e poco proficue, lasciandone in vita una<br />
quin<strong>di</strong>cina, le più importanti delle quali erano le agenzie <strong>di</strong> Apice, Montesarchio, Pannarano<br />
e S. Giorgio del Sannio.<br />
Fra il 1933 e il 1935, la raccolta della Sannitica <strong>di</strong>minuì da 12,6 a 9,6 milioni <strong>di</strong> lire,<br />
in parte compensata dal ricorso alle anticipazioni passive presso altri istituti. Anche gli<br />
impieghi, molti dei quali costituiti da cre<strong>di</strong>ti ormai inesigibili, <strong>di</strong>minuirono da 10,8 a 9,5<br />
milioni. Gli amministratori stavano abbandonando le operazioni <strong>di</strong> concessione <strong>di</strong> aperture<br />
<strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to in conto corrente, per ritornare allo sconto <strong>degli</strong> effetti, in particolare <strong>di</strong><br />
quelli <strong>di</strong> piccolo importo, che presentavano un maggior grado <strong>di</strong> sicurezza. Perciò avevano<br />
cominciato a rivolgersi alla Banca d’Italia per riscontare effetti in portafoglio che<br />
dovevano garantire personalmente. Ma era necessaria una più drastica opera <strong>di</strong> risanamento,<br />
peraltro sollecitata dalla stessa Banca d’Italia. Purtroppo gli equilibri interni che<br />
avevano retto la Banca fino a quel momento si stavano spezzando <strong>ed</strong> emersero profon<strong>di</strong><br />
contrasti fra i principali componenti del Consiglio <strong>di</strong> amministrazione, con un lungo<br />
strascico <strong>di</strong> liti giu<strong>di</strong>ziarie. Già nell’aprile del 1934, in occasione del rinnovo delle cariche<br />
sociali, il consigliere delegato Pietro Perlingieri aveva messo a <strong>di</strong>sposizione il suo<br />
mandato, proponendo come successore Domenico Napolitano, il quale aveva rifiutato.<br />
Qualche mese più tar<strong>di</strong> fu proprio Napolitano a rassegnare le <strong>di</strong>missioni da consigliere.<br />
Secondo il <strong>di</strong>rettore della succursale <strong>di</strong> Benevento della Banca d’Italia, questa decisione<br />
ebbe conseguenze negative sulla Sannitica, perché provocò un calo dei depositi (quasi<br />
1,2 milioni nel corso del 1935), non solo per il ritiro dei depositi dei fratelli Napolitano,<br />
ma anche per gli effetti che il manifestarsi dei <strong>di</strong>ssi<strong>di</strong> interni ebbe sul pubblico.<br />
La Banca d’Italia stava seguendo con particolare attenzione le vicende della Banca<br />
Sannitica. Il <strong>di</strong>rettore Luigi Topi aveva fatto pressione sui fratelli Perlingieri perché<br />
giungessero ad un accordo per ripianare le molte partite ormai non più recuperabili e<br />
salvare la Banca, che poteva contare sui buoni utili provenienti dalla gestione della Ri-<br />
35
cevitoria provinciale. Alla fine, nel 1936, i fratelli Perlingieri e i fratelli Napolitano firmarono<br />
un accordo, con il quale si impegnavano a contribuire al risanamento della Banca<br />
versando, in parti uguali, 800 mila lire in azioni della Società italiana per le Strade<br />
Ferrate Sovvenzionate. Il risanamento prev<strong>ed</strong>eva la cancellazione <strong>di</strong> effetti in portafoglio,<br />
<strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti in conto corrente, <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti per i quali pendeva un giu<strong>di</strong>zio e <strong>di</strong> azioni<br />
private, per complessive 2,7 milioni <strong>di</strong> lire. Furono annullati cre<strong>di</strong>ti verso i fratelli Massa,<br />
la Monte Mutri, la società De Martini, le Fornaci Telesine, la società Zolfi e gessi<br />
agricoli, Antonio Fabrizio e altri. In pochi anni, quin<strong>di</strong>, la Banca aveva dovuto cancellare<br />
cre<strong>di</strong>ti per oltre 4,6 milioni <strong>di</strong> lire, subendo una per<strong>di</strong>ta che superava <strong>di</strong> quattro volte<br />
e mezzo il suo capitale sociale e <strong>di</strong> più del doppio il patrimonio sociale del 1932.<br />
Dell’accordo per il risanamento della Banca faceva parte anche la sostituzione del consigliere<br />
delegato Pietro Perlingieri, al quale si imputava il cattivo risultato <strong>degli</strong> affari da<br />
lui proposti, con il fratello F<strong>ed</strong>erico. Fu necessaria una svalutazione del capitale sociale<br />
da un milione a 500 mila lire, subito reintegrato con l’emissione <strong>di</strong> nuove azioni, che furono<br />
sottoscritte, in parti uguali, solo da Pietro e F<strong>ed</strong>erico Perlingieri, non essendovi state<br />
richieste da parte <strong>degli</strong> altri soci. In tal modo, fra il 1932 e il 1936, i due fratelli erano<br />
intervenuti, per salvare la Banca, con ben 2,1 milioni. Una scrittura privata del 15 luglio<br />
1936 prev<strong>ed</strong>eva anche che Pietro avrebbe dovuto c<strong>ed</strong>ere oltre 1.800 azioni della Banca<br />
al fratello F<strong>ed</strong>erico, il quale risultò, così, titolare <strong>di</strong> 5.165 azioni, vale a <strong>di</strong>re del 51,65<br />
per cento del pacchetto azionario della Banca, mentre Pietro conservò 2.200 azioni, pari<br />
al 22 per cento del totale.<br />
3.3. Un faticoso risanamento - La sistemazione, pure concordata, non fu facile da attuare<br />
per i ricordati contrasti fra i principali azionisti, in particolare per il <strong>di</strong>ssi<strong>di</strong>o tra i<br />
fratelli Perlingieri. Dopo trent’anni, <strong>di</strong> cui ventisei nelle vesti <strong>di</strong> consigliere delegato,<br />
usciva dal Consiglio Pietro Perlingieri, il quale, deluso e a<strong>di</strong>rato, non prese più parte<br />
nemmeno alle adunanze dell’Assemblea dei soci. Il gruppo che l’aveva appoggiato (Napolitano,<br />
Barbieri, Meomartini) era ormai minoritario e il suo posto veniva preso da altri,<br />
che elessero presidente e consigliere delegato F<strong>ed</strong>erico Perlingieri. Gli anni che seguirono<br />
furono caratterizzati da un impegno quasi puntiglioso della Banca nel recuperare<br />
i cre<strong>di</strong>ti, sia <strong>di</strong> quelli più cospicui sia <strong>di</strong> quelli più modesti, in maniera molto più puntuale<br />
e decisa <strong>di</strong> quanto si era fatto prec<strong>ed</strong>entemente. Fra gli smobilizzi più importanti vi<br />
fu quello della Monte Mutri, <strong>di</strong> cui la Banca era l’unica cre<strong>di</strong>trice, conclusosi, sul finire<br />
del 1939, con la cessione <strong>di</strong> tutte le attività e gli impianti, per 554.300 lire, alla Montecatini,<br />
che intendeva riprendere l’estrazione della bauxite. Diverse pendenze furono sistemate<br />
con l’assegnazione alla Banca <strong>di</strong> terreni e fabbricati ipotecati, successivamente<br />
alienati. Un altro elemento della nuova politica <strong>di</strong> gestione fu lo spostamento<br />
dell’attività della Banca dai gran<strong>di</strong> affari, che avevano caratterizzato la prec<strong>ed</strong>ente amministrazione,<br />
alle «piccole operazioni <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to», volendo lasciare «ad altri Istituti<br />
all’uopo più idonei le operazioni <strong>di</strong> finanziamento <strong>di</strong> una certa entità». Si ritornò principalmente<br />
allo sconto <strong>di</strong> cambiali, «limitando l’entità delle singole operazioni e quin<strong>di</strong><br />
frazionando il Portafoglio», sicché gli amministratori potevano affermare, con un certo<br />
orgoglio, che non un solo effetto era passato in contenzioso nel corso del 1937 e del<br />
1938, conseguenza <strong>di</strong> una «serietà amministrativa» che stava facendo crescere la fiducia<br />
del pubblico.<br />
Gli utili, dopo il crollo del 1936, ripresero a salire. Anche la raccolta e gli impieghi<br />
crebbero, portandosi rispettivamente a quasi 15 e 6 milioni <strong>di</strong> lire nel 1940. Siccome la<br />
36
accolta aumentò più <strong>degli</strong> impieghi, i depositi investiti continuarono ad essere meno<br />
del 50 per cento <strong>di</strong> quelli affluiti presso la Banca e calarono ancora fino al 40 per cento<br />
l’anno dell’entrata in guerra dell’Italia. Continuavano a crescere, viceversa, gli impieghi<br />
in titoli. La Banca, quin<strong>di</strong>, aveva ridotto, durante la lunga fase <strong>di</strong> risanamento, la<br />
sua funzione <strong>di</strong> interme<strong>di</strong>azione del cre<strong>di</strong>to, per rivolgersi agli investimenti finanziari,<br />
che davano utili più modesti, ma sicuri, potendo contare anche sui guadagni derivanti<br />
dalla Tesoreria provinciale e da quelli ottenuti dal servizio <strong>di</strong> incasso e <strong>di</strong> emissione <strong>di</strong><br />
assegni per conto <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> banche. Fra gli impieghi più consistenti sono da ricordare i<br />
finanziamenti concessi ad alcune <strong>di</strong>tte beneventane, impegnate in forniture pubbliche,<br />
me<strong>di</strong>ante lo sconto <strong>di</strong> effetti (poi sistematicamente riscontati presso la Banca d’Italia), e<br />
la cessione dei cre<strong>di</strong>ti verso i committenti. Fra queste <strong>di</strong>tte erano quella <strong>di</strong> Vincenzo<br />
Tresca, che produceva mobili e infissi, alla quale furono accordati sconti per oltre 6,4<br />
milioni <strong>di</strong> lire, e la società anonima Domenico Russo e figli, che forniva infissi, cassette<br />
per munizioni e casse <strong>di</strong> imballaggio all’Esercito e ad altre amministrazioni pubbliche,<br />
alla quale andarono quasi sette milioni <strong>di</strong> lire.<br />
Nel 1939 vi fu un nuovo assestamento della compagine sociale, che portò F<strong>ed</strong>erico<br />
Perlingieri a <strong>di</strong>sporre del 61,14 per cento del capitale sociale. La Banca era ormai saldamente<br />
nelle sue mani, proprio mentre ricorreva il cinquantesimo anniversario della<br />
fondazione, peraltro quasi passato sotto silenzio.<br />
4. La Sannitica dalla guerra alla fusione con la Banca Popolare <strong>di</strong> Novara<br />
4.1. La Banca negli anni <strong>di</strong> guerra e nel dopoguerra - I primi anni <strong>di</strong> guerra, fino<br />
all’estate del 1943, ebbero effetti <strong>di</strong>versi sui vari settori dell’economia italiana. Alcune<br />
industrie, in particolare quella meccanica, impegnate nella produzione bellica fecero registrare<br />
un forte incremento produttivo; altre furono negativamente con<strong>di</strong>zionate dalla<br />
penuria <strong>di</strong> combustibili e <strong>di</strong> materie prime e dal ridotto livello della domanda. Molto penalizzata<br />
fu l’agricoltura, la cui produzione cominciò subito a <strong>di</strong>minuire per via della<br />
scarsità <strong>di</strong> fertilizzanti, <strong>di</strong> macchine e <strong>di</strong> combustibile e del richiamo alle armi <strong>di</strong> oltre un<br />
milione e mezzo <strong>di</strong> unità lavorative. Intanto cresceva l’in<strong>di</strong>ce del costo della vita, sia pure<br />
in misura ancora modesta rispetto all’incremento che si registrò negli anni successivi.<br />
La Banca Sannitica continuò, nei primi anni <strong>di</strong> guerra, a svolgere il suo lavoro con<br />
regolarità, senza risentire in modo particolare della congiuntura bellica, anzi v<strong>ed</strong>endo<br />
crescere sia la raccolta, passata, fra il 1939 e il 1942, da 11 a 26 milioni <strong>di</strong> lire.<br />
L’incremento fu consistente anche se si tiene conto dell’inflazione e si esprimono i valori<br />
in lire costanti, ma i depositi superavano <strong>di</strong> molto gli impieghi e gli amministratori<br />
furono costretti a investire le somme <strong>di</strong>sponibili in titoli <strong>di</strong> Stato. L’afflusso <strong>di</strong> depositi<br />
presso le banche fu allora un fenomeno abbastanza <strong>di</strong>ffuso nei paesi belligeranti. Il riassorbimento<br />
della <strong>di</strong>soccupazione, per via della ripresa produttiva e del richiamo alle armi<br />
<strong>di</strong> milioni <strong>di</strong> uomini, assicurava un r<strong>ed</strong><strong>di</strong>to alle famiglie, che non erano in grado <strong>di</strong><br />
spendere per la mancanza <strong>di</strong> molte merci e perciò depositavano i loro risparmi in banca<br />
o presso le casse postali.<br />
L’inflazione, com’è noto, esplose dopo l’armistizio (8 settembre 1943), per via<br />
dell’eccessiva emissione <strong>di</strong> biglietti <strong>di</strong> banca e per la penuria <strong>di</strong> molte merci. Essa fu<br />
particolarmente grave al Sud, dove fu anche alimentata dalle spese delle truppe alleate,<br />
che misero in circolazione una nuova moneta, le amlire. Fra il 1943 e il 1945 l’in<strong>di</strong>ce<br />
37
del costo della vita aumentò <strong>di</strong> quasi <strong>di</strong>eci volte e la raccolta della Banca Sannitica balzò<br />
da 28 a quasi 125 milioni <strong>di</strong> lire, mentre gli impieghi passavano da 17 a 53 milioni.<br />
Se però si considerano i valori espressi in lire del 1938 si nota come la raccolta si fosse<br />
<strong>di</strong>mezzata e gli impieghi e gli utili si fossero ridotti <strong>di</strong> due terzi. Per ritornare ai livelli<br />
reali del 1943 bisognò attendere ancora tre anni.<br />
La <strong>di</strong>latazione dei valori monetari aveva reso del tutto inadeguato il capitale sociale<br />
della Sannitica (appena un milione), che dovette essere portato dapprima a tre e poi a<br />
trenta milioni, mentre la Banca puntava su operazioni «<strong>di</strong> sicuro realizzo», preferendo<br />
«affari strettamente commerciali» <strong>ed</strong> evitando <strong>di</strong> sostenere iniziative <strong>di</strong> carattere speculativo.<br />
E siccome seguitava ad esserci abbondanza <strong>di</strong> fon<strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibili, più della metà<br />
dei depositi fu investita in titoli <strong>di</strong> Stato, che peraltro costituivano una buona riserva per<br />
fronteggiare in qualsiasi momento la situazione. Questa politica, se da un lato consentì<br />
alla Banca <strong>di</strong> non correre molti rischi e <strong>di</strong> consolidare il patrimonio sociale, dall’altro<br />
scontentò gli impren<strong>di</strong>tori locali, i quali, secondo una relazione della locale Camera <strong>di</strong><br />
commercio del giugno 1948, avevano dovuto sacrificare «i propri risparmi e il capitale<br />
circolante per far risorgere gli stabilimenti», senza essere assistiti nel loro sforzo da<br />
«provvidenze cre<strong>di</strong>tizie» e senza aver nemmeno beneficiato, «per motivi vari», dei finanziamenti<br />
per la ricostruzione. Essi, perciò, come riferivano gli ispettori della Banca<br />
d’Italia, mettevano sotto accusa le banche, e in particolare il Banco <strong>di</strong> Napoli, che agiva<br />
«in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> vero monopolio» e con criteri molto restrittivi, costringendoli a rivolgersi<br />
alle aziende <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to delle piazze vicine, dal momento che le tre banche beneventane<br />
non si mostravano in grado <strong>di</strong> sostenere adeguatamente le «sane iniziative economiche<br />
della provincia». In effetti, il presidente del Consiglio <strong>di</strong> amministrazione della<br />
Sannitica riconosceva, nel 1948, che le aziende rivolgevano numerose e «pressanti» richieste<br />
<strong>di</strong> finanziamento alle banche che non potevano essere sod<strong>di</strong>sfatte per non compromettere<br />
la loro liqui<strong>di</strong>tà.<br />
La Banca aveva ripreso a sostenere i suoi principali clienti, specie quelli impegnati<br />
nella ricostruzione, che trattavano materiali per l’e<strong>di</strong>lizia, come le Cementerie Meri<strong>di</strong>onali,<br />
oppure infissi e serramenta, con la consueta proc<strong>ed</strong>ura della cessione del cre<strong>di</strong>to<br />
e dello sconto <strong>di</strong> cambiali, normalmente riscontate alla Banca d’Italia. Un finanziamento<br />
<strong>di</strong> ben tre milioni fu accordato alla <strong>di</strong>tta Tresca, per consentirle, dopo la parziale<br />
<strong>di</strong>struzione del mobilificio, <strong>di</strong> allargare l’attività alla produzione <strong>di</strong> torrone e <strong>di</strong> altre<br />
specialità dolciarie con l’impianto <strong>di</strong> un moderno laboratorio, e un fido fino al massimo<br />
consentito fu concesso alla Società Agricola Sannite (SAS), <strong>di</strong> cui era amministratore<br />
unico F<strong>ed</strong>erico Perlingieri, proprietaria, a Dugenta, del fondo «Bosco Cupo» <strong>di</strong> 150 ettari,<br />
valutato almeno trenta milioni. L’aumentato costo della vita portò anche ad una<br />
prima vertenza con il personale che, come si espresse F<strong>ed</strong>erico Perlingieri, rompeva «una<br />
lunga tra<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> cor<strong>di</strong>alità e <strong>di</strong> reciproca comprensione». Dopo una prima posizione<br />
<strong>di</strong> chiusura del presidente, il quale richiamava la «<strong>di</strong>fficile situazione industriale e<br />
commerciale in cui versa[va] il capoluogo», venne accordato un aumento del 15 per<br />
cento agli impiegati e del 20 per cento ai capi ufficio.<br />
4.2. La Banca sostiene l’agricoltura - Agli inizi del 1948 entrò a far parte del Consiglio<br />
<strong>di</strong> amministrazione Mario Perlingieri, figlio trentunenne <strong>di</strong> F<strong>ed</strong>erico, che subito assunse<br />
una posizione <strong>di</strong> rilievo nella Banca, promuovendo, in particolare, la meccanizzazione<br />
dei servizi, e assumendo, l’anno successivo, la funzione <strong>di</strong> amministratore delegato<br />
con ampi poteri. Proprio mentre l’economia citta<strong>di</strong>na cominciava a riprendersi, anche<br />
38
grazie al fermento <strong>di</strong> attività connesse con la ricostruzione, il capoluogo fu investito dalla<br />
piena del fiume Calore, che ruppe gli argini la mattina del 2 ottobre 1949, inondando<br />
la parte bassa della città, intorno alla stazione ferroviaria, ossia quella più duramente<br />
provata dai bombardamenti <strong>di</strong> sei anni prima.<br />
A Benevento continuavano a operare, oltre alla Banca Sannitica, le altre due banche<br />
locali sopravvissute alla crisi <strong>degli</strong> anni Venti e Trenta, vale a <strong>di</strong>re la Banca <strong>di</strong> Benevento<br />
e il Cre<strong>di</strong>to Sannite, alle quali si era aggiunto, nel 1938, il Monte Orsini, che aveva<br />
avuto il riconoscimento <strong>di</strong> monte <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to su pegno <strong>di</strong> prima categoria. Nel 1950, però,<br />
i prestiti concessi dal Monte Orsini non raggiungevano i cinque milioni <strong>di</strong> lire, sicché la<br />
sua importanza fra le aziende <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to locali era marginale. La maggior parte delle operazioni<br />
<strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to del capoluogo era comunque concentrata nella succursale del Banco<br />
<strong>di</strong> Napoli, alla quale si era aggiunta, nel dopoguerra, una filiale della Banca Nazionale<br />
del Lavoro. Il Banco <strong>di</strong> Napoli raccoglieva, all’inizio <strong>degli</strong> anni Cinquanta, quasi il 60<br />
per cento dei depositi affluiti presso le aziende <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to operanti nella provincia. La<br />
Banca Sannitica si poneva subito dopo il grande istituto napoletano, con una quota <strong>di</strong><br />
raccolta che oscillò intorno al 32-34 per cento nei primi anni, per salire a quasi il 43 per<br />
cento nel 1956.<br />
La Banca Sannitica, che aveva dovuto realizzare un doloroso risanamento <strong>ed</strong> era passata<br />
attraverso una guerra <strong>di</strong>sastrosa e un <strong>di</strong>fficile dopoguerra, si apprestava, all’inizio<br />
<strong>degli</strong> anni Cinquanta, a vivere un periodo <strong>di</strong> forte espansione operativa e territoriale, durante<br />
il quale mostrò particolare attenzione al settore agricolo, che sostenne nel complesso<br />
sforzo <strong>di</strong> modernizzazione. Con il 1952, anno in cui la raccolta <strong>di</strong> depositi superò<br />
il miliardo <strong>di</strong> lire, gli amministratori della Sannitica ritennero «definitivamente chiuso»<br />
il dopoguerra e ravvisarono l’avvio <strong>di</strong> un nuovo ciclo economico, caratterizzato dal passaggio<br />
da una fase <strong>di</strong> prevalenza <strong>degli</strong> investimenti pubblici ad una fase «<strong>di</strong> armonica<br />
inter<strong>di</strong>pendenza tra investimenti pubblici e privati». A farli parlare in tal modo era<br />
l’approvazione, proprio quell’anno, <strong>di</strong> due leggi che interessavano particolarmente<br />
l’istituto: la legge a favore delle imprese danneggiate o <strong>di</strong>strutte a seguito <strong>di</strong> pubbliche<br />
calamità e il cosiddetto «piano dodecennale agricolo». La prima, <strong>di</strong> cui potevano avvalersi<br />
le imprese beneventane colpite dall’alluvione del 1949, <strong>di</strong>sponeva contributi statali<br />
e finanziamenti agevolati <strong>di</strong> durata quadriennale da parte delle banche, alle quali lo Stato<br />
avrebbe fornito i fon<strong>di</strong> necessari al mo<strong>di</strong>co saggio d’interesse dell’un per cento.<br />
L’altro provve<strong>di</strong>mento istituiva un fondo <strong>di</strong> rotazione per anticipazioni agli istituti <strong>di</strong><br />
cre<strong>di</strong>to chiamati a conc<strong>ed</strong>ere prestiti agli agricoltori, al tasso del tre per cento e <strong>di</strong> durata<br />
variabile, da destinare all’acquisto <strong>di</strong> macchine agricole <strong>di</strong> produzione italiana, alla realizzazione<br />
<strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> irrigazione e alla costruzione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici rurali.<br />
La Sannitica si occupò <strong>di</strong> entrambe le forme <strong>di</strong> finanziamento, ottenendo i relativi<br />
fon<strong>di</strong> statali, in particolare quelli previsti dal piano dodecennale. La Banca ebbe, in questa<br />
forma <strong>di</strong> intervento pubblico, un ruolo importantissimo, arrivando ad erogare, nel<br />
1957, il 73 per cento dei finanziamenti concessi nella provincia <strong>di</strong> Benevento. Fino al<br />
1958 il Consiglio <strong>di</strong> amministrazione deliberò 555 finanziamenti per un ammontare <strong>di</strong><br />
oltre 740 milioni, la maggior parte dei quali, pari al 58 per cento del totale, servì a finanziare<br />
l’acquisto <strong>di</strong> macchine agricole, dalle costose trattrici alle più economiche<br />
motopompe. Il resto dei prestiti andò quasi soltanto a finanziare la costruzione <strong>di</strong><br />
fabbricati rurali, risultando del tutto inconsistente (meno del 2 per cento) la quota<br />
destinata alle opere <strong>di</strong> irrigazione.<br />
39
4.3. Modernizzazione <strong>ed</strong> espansione della Sannitica - La raccolta della Banca, che<br />
nel 1951 superava <strong>di</strong> poco gli 800 milioni <strong>di</strong> lire, aumentò fino a 8,6 miliar<strong>di</strong> nel 1962.<br />
In un<strong>di</strong>ci anni, quin<strong>di</strong>, mentre il costo della vita cresceva solo del 39 per cento, essa si<br />
era più che decuplicata. Fino al 1959, all’incirca il 40 per cento <strong>degli</strong> impieghi andò<br />
all’agricoltura. Ma negli anni seguenti crebbero notevolmente gli impieghi a favore <strong>di</strong><br />
enti pubblici e della clientela non commerciale, ossia delle famiglie. Costante, intorno al<br />
20 per cento, si tennero gli investimenti destinati all’industria e al commercio, e quelli<br />
rivolti al finanziamento <strong>di</strong> opere e servizi pubblici. Il settore agricolo fu ulteriormente<br />
sostenuto con il cre<strong>di</strong>to agrario <strong>di</strong> esercizio, che la Banca ottenne <strong>di</strong> poter esercitare a<br />
partire dal 1956. Era una forma <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to coerente con l’in<strong>di</strong>rizzo fino ad allora seguito<br />
dall’istituto <strong>di</strong> «contribuire nel miglior modo alla ripresa del settore agricolo», nel quale<br />
si fondava, secondo il parere <strong>degli</strong> amministratori, «qualsiasi premessa <strong>di</strong> futuro benessere»<br />
per il Sannio.<br />
Le filiali della Banca rimaste in attività nel dopoguerra erano tre<strong>di</strong>ci. Nel corso <strong>degli</strong><br />
anni Cinquanta si provvide alla loro riorganizzazione e all’ampliamento della rete. Nel<br />
1962 fu aperta una filiale a Napoli e due sportelli a Maddaloni e a Santa Maria a Vico, in<br />
provincia <strong>di</strong> Caserta. In tal modo la Banca Sannitica era uscita della provincia <strong>di</strong> Benevento<br />
<strong>ed</strong> assumeva le caratteristiche <strong>di</strong> una banca regionale. Ormai essa contava <strong>di</strong>ciassette<br />
filiali più la s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong> Benevento, che erano <strong>di</strong>slocate, oltre che nei centri attorno al capoluogo,<br />
come San Giorgio del Sannio <strong>ed</strong> Apice, prevalentemente nelle due valli più prospere<br />
della provincia, la Cau<strong>di</strong>na, che si apre verso Caserta e Napoli, e la Telesina, fino a<br />
Telese e Amorosi. Con l’ampliamento dell’attività, cresceva anche il personale, passato<br />
da poco più <strong>di</strong> una ventina <strong>di</strong> unità dopo la guerra a oltre un centinaio verso la fine <strong>degli</strong><br />
anni Cinquanta. Specialmente fra il 1953 e il 1957, il consigliere delegato Mario Perlingieri<br />
decise <strong>di</strong>verse assunzioni, <strong>di</strong> volta in volta ratificate dal Consiglio, per una sessantina<br />
<strong>di</strong> persone con varie qualifiche. Nel 1961 iniziò anche l’impianto <strong>di</strong> un nuovo Centro<br />
meccanografico a sch<strong>ed</strong>e perforate. L’anno successivo, il Centro contabile e amministrativo,<br />
appena organizzato, fu collocato nella filiale <strong>di</strong> Napoli, che quin<strong>di</strong> cominciava ad assumere<br />
un ruolo particolare nell’organizzazione della Banca Sannitica, <strong>di</strong>ventando la s<strong>ed</strong>e<br />
principale dell’istituto. Nel 1963 la Banca Sannitica decise un aumento del capitale sociale<br />
da 30 a 600 milioni <strong>di</strong> lire. Ma l’anno non fu particolarmente positivo, anche perché<br />
l’istituto risentì <strong>degli</strong> effetti del <strong>di</strong>ssesto della Banca <strong>di</strong> Benevento, rilevata dal Banco <strong>di</strong><br />
Santo Spirito, che creò apprensione e allarme nei risparmiatori.<br />
4.4. Il grande sviluppo della Banca - Dal 1965 la crescita riprese con regolarità e a<br />
ritmi elevati, portando la raccolta a 82 miliar<strong>di</strong> nel 1974, riuscendo a decuplicarsi ancora<br />
una volta in do<strong>di</strong>ci anni. Anche gli impieghi crebbero regolarmente, sia pure con minore<br />
intensità. I depositi impiegati con la clientela, che all’inizio <strong>degli</strong> anni Sessanta superavano<br />
l’80 per cento del totale, scesero, una <strong>di</strong>ecina d’anni dopo, a poco più del 60<br />
per cento, e la Banca fu costretta ad investire le sue <strong>di</strong>sponibilità in titoli, per lo più <strong>di</strong><br />
Stato. Per il periodo 1965-1972 si confermò la tendenza, già affiorata prec<strong>ed</strong>entemente,<br />
verso la riduzione del peso dei finanziamenti all’agricoltura e al commercio alimentare,<br />
e verso un aumento <strong>degli</strong> impieghi rivolti all’industria e al commercio, assestati intorno<br />
a un terzo del totale, e <strong>di</strong> quelli alle opere e ai servizi pubblici, in cui era compresa anche<br />
l’e<strong>di</strong>lizia. Una tale mo<strong>di</strong>fica della destinazione <strong>degli</strong> impieghi della Banca fu sicuramente<br />
influenzata dall’espansione territoriale verso un’area, come quella fra Napoli e<br />
Caserta, molto più ricca <strong>di</strong> attività industriali. Gli sforzi organizzativi e il necessario<br />
40
aumento del personale, raddoppiato fra il 1958 e il 1968, quando raggiunse le 200 unità,<br />
non consentirono buoni risultati <strong>di</strong> esercizio, nonostante la politica <strong>di</strong> «rigoroso contenimento»<br />
dei tassi passivi. Negli anni compresi fra il 1963 e il 1968, gli utili furono<br />
modesti, sicché i <strong>di</strong>viden<strong>di</strong> poterono rimunerare il capitale sociale con il 5 per cento solo<br />
in un paio <strong>di</strong> anni, rimanendo a un livello più basso negli altri.<br />
L’espansione della Banca continuò ininterrotta anche nel decennio successivo. Sembra<br />
che, dal dopoguerra, vi fosse una specie <strong>di</strong> «regola del <strong>di</strong>eci» della raccolta, in virtù<br />
della quale essa riusciva ad aumentare <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci volte in poco più <strong>di</strong> un decennio. Questa<br />
eccezionale crescita si era già registrata fra il 1951 e il 1962 e fra il 1962 e il 1974, quando<br />
aveva raggiunto l’ammontare <strong>di</strong> 82 miliar<strong>di</strong>, per portarsi a 873 miliar<strong>di</strong> nel 1985, anno<br />
in cui pure gli impieghi si erano più che decuplicati rispetto al 1974. Fra il 1968 e il<br />
1978 il personale aumentò da 200 a quasi 380 unità e l’anno successivo fu inaugurata<br />
una moderna filiale ad Avellino, consentendo alla Banca <strong>di</strong> avviare operazioni in una<br />
provincia che, sebbene contigua a quella <strong>di</strong> Benevento, non aveva ancora attirato la sua<br />
attenzione. Fu anche acquistata una prestigiosa villa con un vasto parco (Villa dei Papi)<br />
nella parte alta <strong>di</strong> Benevento, in località «Pace Vecchia», dove, nel 1980, la Banca trasferì<br />
la sua s<strong>ed</strong>e legale e dove, cinque anni più tar<strong>di</strong>, fu collocato il Centro formazione<br />
dell’istituto, nonché la sua vasta biblioteca giuri<strong>di</strong>co-economica, in seguito donata alla<br />
neonata <strong>Università</strong> del Sannio.<br />
Sul finire del 1973, fu deciso l’aumento del capitale sociale da 600 a 1.100 milioni,<br />
me<strong>di</strong>ante l’emissione <strong>di</strong> azioni a pagamento da offrire in opzione ai soci. La compagine<br />
sociale rimase comunque immutata. Mario Perlingieri, che conservava la carica <strong>di</strong> amministratore<br />
delegato, mantenne il controllo della Banca con oltre i due terzi del pacchetto<br />
azionario, mentre il numero dei soci aumentava per l’ingresso nella società <strong>degli</strong><br />
ere<strong>di</strong> dei soci scomparsi. Gli utili della Banca si mantennero intorno ad alcune centinaia<br />
<strong>di</strong> milioni per tutti gli anni Settanta. I soci, però, dovettero rinunziare al <strong>di</strong>videndo, per<br />
ben tre volte, nel 1973, nel 1975 e nel 1979, anni in cui gli utili non furono molto elevati<br />
e si preferì non ridurre la quota da destinare alle riserve or<strong>di</strong>narie e straor<strong>di</strong>narie. Nel<br />
1980 gli utili balzarono a quasi 3,9 miliar<strong>di</strong>, grazie ad un forte incremento <strong>degli</strong> interessi<br />
attivi, per mantenersi intorno ad alcuni miliar<strong>di</strong> negli anni successivi, consentendo<br />
l’accumulazione <strong>di</strong> consistenti riserve. Perciò quell’anno fu deciso un nuovo aumento<br />
del capitale, portato a 3,85 miliar<strong>di</strong>, me<strong>di</strong>ante l’aumento del valore <strong>di</strong> ciascuna azione<br />
da 500 a 1.000 lire e la collocazione fra i soci <strong>di</strong> altri 1,65 miliar<strong>di</strong> <strong>di</strong> lire. La Banca stava<br />
anche investendo in titoli azionari, in qualche caso arrivando a controllare o a detenere<br />
l’intero pacchetto azionario <strong>di</strong> alcune società, come la SERI (Servizio Riscossione<br />
Imposte), poss<strong>ed</strong>uta all’80 per cento, la El<strong>di</strong>talia Srl (Elaborazione Dati Italia), una società<br />
informatica costituita nel 1979 e <strong>di</strong> cui la Sannitica aveva sottoscritto il 99 per cento<br />
del capitale, e la Società Agricola Sannite, appartenuta alla famiglia Perlingieri e ora<br />
interamente <strong>di</strong> proprietà della Banca. In seno all’assemblea dei soci non mancò qualche<br />
rilievo all’amministrazione dell’istituto per le risorse profuse nel risanamento della Società<br />
Agricola Sannite, per le forti spese che comportava la s<strong>ed</strong>e della Pace Vecchia e<br />
per il modo in cui venivano gestiti i rapporti con il personale, il cui organico aveva superato<br />
le 550 unità verso la metà <strong>degli</strong> anni Ottanta.<br />
4.5. La fusione con la Popolare <strong>di</strong> Novara - La Banca continuava comunque ad ampliare<br />
la sua attività, portando, nel 1989, la raccolta a 1.263 miliar<strong>di</strong> e gli impieghi a 707<br />
miliar<strong>di</strong>, <strong>ed</strong> estendendo la sua presenza alla provincia <strong>di</strong> Salerno, con l’apertura delle fi-<br />
41
liali <strong>di</strong> Sarno e <strong>di</strong> Salerno, che portavano il numero delle agenzie a ventidue. La clientela<br />
dell’istituto si era estesa e <strong>di</strong>versificata. La maggior parte <strong>degli</strong> impieghi era destinata<br />
al settore industriale che, nella seconda metà <strong>degli</strong> anni Ottanta, assorbiva intorno a un<br />
terzo <strong>di</strong> quelli complessivi. Buona era la presenza, fra i clienti, delle famiglie, alle quali<br />
andava il 13-14 per cento <strong>degli</strong> impieghi, seguite dal settore agricolo con il 12-13 per<br />
cento, dal commercio all’ingrosso con il 10-11 per cento e da quello al minuto con l’8-9<br />
per cento. La Banca Sannitica, data la sua <strong>di</strong>mensione e nonostante la presenza sul territorio<br />
<strong>di</strong> gran<strong>di</strong> banche, prime fra tutte il Banco <strong>di</strong> Napoli, era giunta a conquistare una<br />
quota <strong>di</strong> mercato pari al 3 per cento della raccolta e al 4 per cento <strong>degli</strong> impieghi del sistema<br />
bancario campano. Nel 1988 essa occupava il quinto posto fra le banche della regione.<br />
Mentre si andava verso la formazione <strong>di</strong> un mercato europeo del cre<strong>di</strong>to, le spinte alla<br />
concentrazione bancaria si fecero molto forti e l’Italia, come altri paesi, fu interessata<br />
da una serie <strong>di</strong> fusioni, che videro le banche più piccole assorbite dai gruppi bancari più<br />
forti, in cerca <strong>di</strong> espansione sul territorio nazionale. La Banca Sannitica si trovava, evidentemente,<br />
nelle migliori con<strong>di</strong>zioni per lasciarsi incorporare da un grande istituto, essendo<br />
<strong>di</strong>ventata, <strong>di</strong> fatto, una banca che apparteneva ad una sola famiglia, o meglio ad<br />
un ramo della famiglia che l’aveva dapprima fatta prosperare e poi salvata nei momenti<br />
<strong>di</strong>fficili. Negli ultimi ottant’anni, comunque, essa era stata guidata da sole tre persone,<br />
l’ultima delle quali l’aveva retta ininterrottamente per un quarantennio, senza alcun contrasto<br />
interno. Era <strong>di</strong>fficile continuare una gestione <strong>di</strong> questo tipo, mentre l’attività si faceva<br />
sempre più complessa, come era <strong>di</strong>fficile formare un nuovo gruppo <strong>di</strong>rigente fra gli<br />
azionisti o un management capace <strong>di</strong> affrontare la sfida dei tempi. Si comprende, così,<br />
la decisione <strong>di</strong> passare la mano ad un istituto <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni come la Banca Popolare<br />
<strong>di</strong> Novara, alla quale Mario Perlingieri c<strong>ed</strong>ette il suo pacchetto azionario. Così nel<br />
1992, l’Assemblea dei soci della Sannitica deliberava la fusione per incorporazione nella<br />
Banca Popolare <strong>di</strong> Novara, che <strong>di</strong>venne effettiva con il gennaio del 1996, ponendo fine<br />
ad un’esperienza bancaria durata oltre un secolo.<br />
42