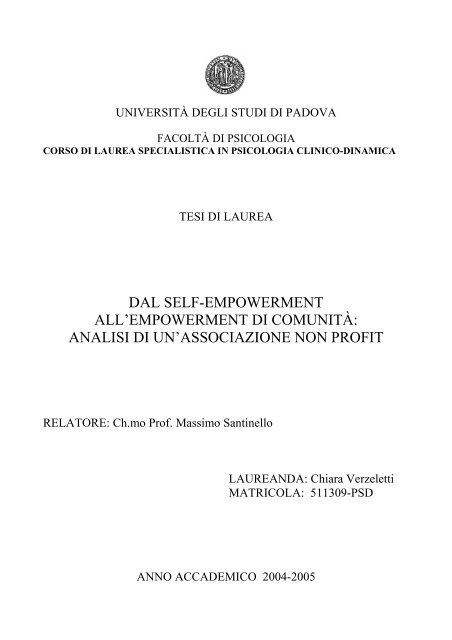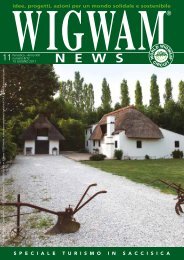tesi laurea chiara verzeletti.pdf - Wigwam
tesi laurea chiara verzeletti.pdf - Wigwam
tesi laurea chiara verzeletti.pdf - Wigwam
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA<br />
FACOLTÀ DI PSICOLOGIA<br />
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN PSICOLOGIA CLINICO-DINAMICA<br />
TESI DI LAUREA<br />
DAL SELF-EMPOWERMENT<br />
ALL’EMPOWERMENT DI COMUNITÀ:<br />
ANALISI DI UN’ASSOCIAZIONE NON PROFIT<br />
RELATORE: Ch.mo Prof. Massimo Santinello<br />
LAUREANDA: Chiara Verzeletti<br />
MATRICOLA: 511309-PSD<br />
ANNO ACCADEMICO 2004-2005
INDICE<br />
INTRODUZIONE................................................................................ 9<br />
PRIMA PARTE.................................................................................... 13<br />
1. L’ASSOCIAZIONE WIGWAM............................................................15<br />
1.1 Le origini.................................................................................................18<br />
1.2 Cosa vuol dire <strong>Wigwam</strong>?........................................................................19<br />
1.3 Cos’e’ <strong>Wigwam</strong> ......................................................................................20<br />
1.4 Il metodo <strong>Wigwam</strong> e i suoi progetti........................................................21<br />
1.5 La formazione .........................................................................................23<br />
1.6 Caratteristiche dei progetti ......................................................................24<br />
1.7 La rete <strong>Wigwam</strong>......................................................................................26<br />
2. L’EMPOWERMENT .............................................................................29<br />
2.1 Caratteristiche dell’empowerment ..........................................................30<br />
2.2 Com’e’ nato l’empowerment?.................................................................34<br />
2.3 L’empowerment psicologico...................................................................36<br />
2.4 L’empowerment nelle organizzazioni.....................................................39<br />
2.5 La leadership empowering ......................................................................44<br />
2.6 Gli empowerment work group ................................................................46<br />
2.7 Conclusioni .............................................................................................48<br />
3. I CIRCOLI DI QUALITÀ......................................................................51<br />
3.1 Verso un management partecipativo.......................................................53<br />
3.2 Lo sviluppo dei circoli di qualità ............................................................56<br />
3.3 La diffusione dei circoli al di fuori del Giappone ..................................57<br />
3
3.4 I concetti di base......................................................................................60<br />
3.5 L’avvio e le metodologie dei circoli di qualità .......................................61<br />
3.6 L’organizzazione dei circoli....................................................................65<br />
3.7 I benefici..................................................................................................69<br />
3.8 Conclusioni .............................................................................................70<br />
SECONDA PARTE ............................................................................. 73<br />
4. L’INTERVISTA......................................................................................75<br />
4.1 Descrizione dell’intervista ......................................................................77<br />
4.2 L’analisi del contenuto............................................................................80<br />
4.3 L’applicazione dell’analisi del contenuto ...............................................82<br />
4.4 L’analisi delle corrispondenze lessicali ..................................................83<br />
4.5 Lo SPAD.t ...............................................................................................84<br />
4.6 Obiettivi dell’analisi................................................................................85<br />
4.7 Ipo<strong>tesi</strong> di partenza ...................................................................................86<br />
4.8 Scelta e organizzazione del testo ............................................................88<br />
4.9 Il pre-trattamento del testo ......................................................................89<br />
4.10 Il file corte.............................................................................................90<br />
4.11 Il taglio di frequenza .............................................................................90<br />
4.12 L’analisi delle corrispondenze: la procedura ASPAR ..........................91<br />
4.13 Scelta dei fattori da analizzare ..............................................................92<br />
4.14 Descrizione del campione .....................................................................94<br />
5. RISULTATI............................................................................................99<br />
5.1 Caratteristiche associative generali.........................................................99<br />
5.1.1 Com’e’ nato il suo progetto?.....................................................99<br />
5.1.2 Qual’ e’ l’obiettivo generale del progetto? ...............................103<br />
4
5.1.3 Chi sono i beneficiari ................................................................108<br />
5.1.4 Quale tipo di supporto le ha offerto l’associazione per la<br />
realizzazione del suo progetto? .........................................................109<br />
5.1.5 Secondo lei quali sono gli aspetti più importanti di cui tiene conto<br />
l’organizzazione quando qualcuno propone un progetto? ................112<br />
5.1.6 Com’è entrato a far parte di quest’associazione? .....................116<br />
5.1.7 Perché rimane all’interno di quest’associazione? .....................117<br />
5.1.8 Conclusioni ...............................................................................120<br />
5.2 I circoli di qualità ....................................................................................121<br />
5.2.1 Quali sono i problemi principali che affrontate all’interno del<br />
vostro club? ........................................................................................121<br />
5.2.2 Effettuate incontri periodici per discutere e risolvere i problemi?<br />
con quale frequenza?..........................................................................125<br />
5.2.3 Conclusioni ...............................................................................123<br />
5.3 L’empowerment ......................................................................................129<br />
5.3.1 Secondo lei l’associazione si avvale e prende in considerazione le<br />
idee che vengono dai suoi soci? .........................................................129<br />
5.3.2 Sente di poter influenzare l’andamento dell’organizzazione? ..133<br />
5.3.3 All’interno dell’associazione come è gestito il potere? ............135<br />
5.3.4 Conclusioni................................................................................135<br />
5.4 I valori <strong>Wigwam</strong> .....................................................................................137<br />
5.4.1 Secondo lei Quali sono i principi guida di questa associazione?<br />
............................................................................................................137<br />
5.4.2 All’interno di questa associazione, ci sono valori in cui si<br />
identifica in prima persona? ...............................................................141<br />
5.4.3 Cosa intende lei per qualità di vita? ..........................................144<br />
5
5.4.4 Secondo lei Quali sono i punti di forza di questa associazione?<br />
............................................................................................................148<br />
5.4.5 Secondo lei quali sono gli aspetti in cui l’associazione dovrebbe<br />
migliorare? .........................................................................................150<br />
5.4.6 Conclusioni................................................................................153<br />
6. CONCLUSIONI ......................................................................................155<br />
APPENDICE A............................................................................................163<br />
APPENDICE B............................................................................................167<br />
BIBLIOGRAFIA.........................................................................................187<br />
6
INTRODUZIONE<br />
Negli ultimi decenni, nelle società occidentali hanno cominciato a costituirsi<br />
associazioni non profit, proponendo una cultura caratterizzata dall’incontro con<br />
gli altri, dall’accettazione dei propri limiti e di quelli altrui e dalla<br />
valorizzazione delle diversità. Si tratta di una cultura della tolleranza e<br />
dell’interdipendenza, che favorisce il riconoscimento e l’accettazione di una<br />
pluralità intrapsichica e sociale (Pearce, 1997).<br />
In generale, le associazioni non profit, cercano di curarsi del benessere e della<br />
crescita delle persone che ne fanno parte (a differenza delle associazioni<br />
profit), ma con una continua attenzione all’efficienza e alla qualità (aspetti<br />
spesso trascurati dalle associazioni di volontariato).<br />
In tale ottica, i ruoli associativi non sono immutabili, ma variano in funzione<br />
del progetto, a seconda delle competenze, abilità e disponibilità individuali.<br />
Questo elaborato, ha come obiettivo lo studio, in una chiave di lettura<br />
psicologica, di una particolare associazione non profit: i <strong>Wigwam</strong>.<br />
Quest’associazione racchiude al suo interno circa ottantamila soci, con sedi nel<br />
territorio nazionale ed internazionale e può essere collocata all’interno<br />
dell’ottica sopra citata, ovvero all’interno di una visione che cerca di<br />
“congiungere” l’uomo, i suoi bisogni e l’ambiente in cui vive anziché<br />
“disgiungere”.<br />
<strong>Wigwam</strong> fa parte di quelle che vengono definite “reti secondarie informali” e<br />
ha come obiettivo principale l’incremento della qualità di vita e del benessere.<br />
Questo obiettivo è perseguito sia attraverso l’attuazione di progetti sostenibili<br />
che portino ad un miglioramento della “qualità sociale” (De Leonardis, 1998),<br />
sia offrendo la possibilità di instaurare rapporti interpersonali caratterizzati da<br />
scambio, collaborazione, confronto e solidarietà.<br />
7
Nella prima parte di questo elaborato verranno descritte le basi teoriche che<br />
sottendono il funzionamento associativo.<br />
Il primo capitolo è dedicato alla descrizione dell’associazione: la nascita, i<br />
meccanismi di funzionamento, i progetti attuati, i valori guida e<br />
l’organizzazione. I capitoli successivi invece sono dedicati ad un<br />
approfondimento dei modelli teorici cui l’associazione si ispira:<br />
l’empowerment e i circoli di qualità.<br />
<strong>Wigwam</strong>, infatti, ha tra i suoi obiettivi la responsabilizzazione dei soggetti, in<br />
modo che tutti possano percepire che è possibile creare un rapporto migliore<br />
con la comunità e il territorio (un mondo sostenibile), sentirsi responsabili<br />
della propria vita e portare ad un miglioramento della qualità di vita propria ed<br />
altrui. Per questo motivo il secondo capitolo analizza i più recenti modelli<br />
teorici di empowerment presenti in letteratura. Il costrutto è stato analizzato da<br />
diverse prospettive, ponendo l’attenzione sia sulla componente individuale<br />
(self-empowerment) sia sulla componente gruppale (empowerment di<br />
comunità e organizzativo). Infatti, se le singole persone empowered<br />
contribuiscono a rendere più competenti i gruppi e le reti a cui partecipano,<br />
queste a loro volta diventano setting ambientali che offrono nuovi stimoli alle<br />
persone che li frequentano (Francescato, Leone, Traversi, 1993). Questa<br />
prospettiva implica che si debbano ricercare i fondamenti psicologici<br />
concettuali dell’empowerment, sia all’interno di una prospettiva psicologica<br />
individuale (e personologica), sia di una sociale (e interazionista). Il capitolo<br />
oltre ad approfondire i diversi livelli di empowerment, pone attenzione anche<br />
ai risvolti pragmatici che i diversi modelli propongono, al ruolo della<br />
leadership, e al funzionamento degli empowerment work group.<br />
Il terzo capitolo analizza i circoli di qualità, infatti, l’associazione propone<br />
attività progettuali eterogenee, e avendo come obiettivo la qualità in senso lato<br />
8
(dei servizi, del prodotto, della vita) si ispira a questa modalità di gestione<br />
delle risorse. I circoli di qualità fanno perno sulla valorizzazione della persona<br />
(espressione della creatività, partecipazione decisionale..) e si pongono come<br />
uno strumento utile per il raggiungimento di una gestione partecipativa delle<br />
questioni associative ed organizzative (sviluppando coinvolgimento, adesione,<br />
capacità decisionali e motivazione). Il capitolo descrive la nascita dei circoli,<br />
la loro filosofia, le fasi di sviluppo, gli obiettivi, i punti di forza e di debolezza.<br />
Nella seconda parte dell’elaborato, invece, verranno esposti i risultati ottenuti<br />
attraverso la somministrazione di un’intervista a 21 soci. L’intervista,<br />
audioregistrata, è stata analizzata attraverso il software SPAD.t, secondo il<br />
modello teorico dell’analisi delle corrispondenze lessicali (Benzécri, 1973). Lo<br />
studio, di carattere esplorativo, ha lo scopo di conoscere l’associazione<br />
(evidenziare i meccanismi di funzionamento, le motivazioni dei soci, come<br />
nascono i progetti...), di chiarire le costanti metodologiche ed esplicitarne i<br />
valori giuda.<br />
La metodologia utilizzata è di tipo qualitativo, questa scelta è dettata dal<br />
desiderio di individuare nuclei tematici che descrivano la realtà associativa,<br />
attraverso l’individuazione di classi di risposte non precostituite, ma ricavate a<br />
posteriori, osservando le associazioni discorsive fornite spontaneamente dai<br />
soggetti.<br />
Le aggregazioni spontanee di persone, la ricerca attiva di soluzioni per un<br />
disagio vissuto o percepito, l’opposizione all’isolamento e alla passività, il<br />
desiderio di migliorare la qualità di vita propria ed altrui, i tentativi di attuare<br />
soluzioni concrete per un miglioramento della propria quotidianità, sono stati<br />
per me un importante spunto di riflessione.<br />
Io credo che la nascita spontanea di reti sociali di questo tipo sia di estremo<br />
interesse per chi desidera occuparsi di “benessere”, esse infatti svolgono un<br />
9
uolo supportivo e di sostegno, creano aggregazione, ma allo stesso tempo<br />
portano contributi migliorativi alla società, spostando l’attenzione da una<br />
dimensione singolare ad una plurale e soprattutto promuovendo una cultura del<br />
desiderio, del benessere, del tendere in modo piacevole verso una meta, della<br />
progettualità, del raggiungimento collettivo ed individuale di risultati<br />
desiderati.<br />
10
PRIMA PARTE<br />
11
CAPITOLO 1: L’ASSOCIAZIONE WIGWAM<br />
Le organizzazioni che compongono il variegato ambito raccolto all’interno del<br />
concetto di non profit (o terzo settore), hanno acquisito negli ultimi anni una<br />
posizione rilevante nei paesi occidentali. Queste associazioni si collocano in<br />
un “ambito intermedio rispetto alle istituzioni pubbliche e al mercato”. Non è<br />
obiettivo di questo elaborato analizzare le cause che hanno portato a uno<br />
sviluppo così imponente di questo settore (crisi delle forme tradizionali di<br />
partecipazione, crisi del welfare, crescente complessità sociale…). Va<br />
comunque sottolineato che alcuni autori (in Colozzi, Bassi, 1995) lo<br />
definiscono come “l’economia del desiderio”, accezione che propone di<br />
enfatizzare la centralità delle relazioni, e la volontà di conferire al settore non<br />
profit il senso di un’economia basata sullo scambio e sulla pratica dei rapporti<br />
interpersonali.<br />
La grande varietà del non profit (Bassi, 1994, p.259) è esemplificata dalla<br />
compresenza di organizzazioni per le quali prevalgono interessi conservativi,<br />
come la difesa dei valori e gli stili di vita tradizionali, con altre che sostengono<br />
invece interessi innovativi (come per esempio promozione di modalità<br />
postcapitalistiche). Nel caso dell’associazione <strong>Wigwam</strong> si può parlare di una<br />
sin<strong>tesi</strong> di questi due macro interessi, infatti emerge il desiderio e la volontà di<br />
considerare come operativamente innovativo il recupero mirato di valori e stili<br />
di vita legati alla tradizione. Si tratta di un recupero che porta al confronto<br />
dialettico tra il presente e alcuni elementi tradizionali. Con questo medito<br />
viene stimolata la riflessione e l’operatività sull’attualità, in vista di progetti<br />
che portino ad un miglioramento della qualità di vita. La metodologia<br />
<strong>Wigwam</strong>, si pone come un anello di congiunzione tra passato (non inteso<br />
come ricordo statico, rimpianto) e futuro (inteso come progettabile e<br />
13
modificabile insieme), per la costruzione di un presente dinamico e<br />
migliorabile.<br />
Nonostante le differenze nelle finalità, le diverse associazioni non profit sono<br />
accomunate:<br />
- dal fatto di svolgere azioni organizzate di rilevanza sociale e con<br />
finalità solidaristiche;<br />
- dalla produzione di “beni collettivi o comuni” (Wagner, 1990) o “beni<br />
relazionali” (Donati, 1996), che richiedono una compartecipazione su<br />
base volontaria, dal momento che possono essere prodotti solo insieme;<br />
beni cioè che si creano nella relazione sociale con altri, e che<br />
“migliorano la qualità di vita di chi li offre e di chi ne beneficia e che<br />
allo stesso tempo offrono identità, mettono in campo soggettività<br />
(umane, culturali, politiche) che non hanno spazio nei rapporti di<br />
mercato e costruiscono nuove relazioni tra produttori e consumatori, tra<br />
“attivisti” e gruppi sociali di riferimento, producendo in questo modo<br />
socialità e senso, comunità e integrazione” (Marcon, Merlini, Pianta,<br />
1997, p.23);<br />
- dall’operare in un mercato sociale, sia come “mezzo” che come “fine”<br />
(De Leonardis, 1998).<br />
Le diverse realtà non profit, pur avendo connotazioni diverse possono essere<br />
sinteticamente suddivise in (Donati, 1996):<br />
1. Volontariato organizzato: presenta motivazioni altruistiche, tende ad<br />
operare nel campo dei “problemi sociali”; solitamente interviene con azioni<br />
sostitutive e supportive, dove lo Stato non ha controllo;<br />
2. La cooperazione sociale: presenta una cultura associativa professionale,<br />
diretta alla costruzione e al consolidamento dell’impresa sociale; ha alcune<br />
caratteristiche in comune con le aziende for profit, ad eccezione dell’utilità<br />
14
sociale e dalla non distribuzione degli utili. Ne sono un esempio le cooperative<br />
di tipo A e B.<br />
3. L’associazionismo pro-sociale: nella maggior parte dei casi riguarda la sfera<br />
delle attività sociali, culturali, dello sport, del tempo libero e dell’advocacy<br />
(difesa e promozione dei diritti della cittadinanza).<br />
Le forme miste sono in realtà molto frequenti, ma è possibile affermare che<br />
l’associazione <strong>Wigwam</strong> appartiene prevalentemente alla terza categoria:<br />
quella dell’associazionismo pro-sociale.<br />
Rientrano in quest’ambito tutte le organizzazioni non partitiche, non sindacali,<br />
non categoriali, che i cittadini costituiscono per dare espressione alla loro<br />
voglia di stare insieme, di incontrarsi, di socializzare; per conseguire obiettivi<br />
a loro giudizio rilevanti e per poter esprimere una parte della propria<br />
personalità.<br />
La rilevanza di queste associazioni risiede, prima ancora che nelle opere<br />
realizzate (advocacy o produzione di servizi), nella trama di relazioni che<br />
intessono, nella produzione di significati, norme e valori condivisi che<br />
derivano dal consolidamento e dall’estensione delle reti di relazioni<br />
interpersonali. Il risultato principale dell’associazionismo sociale è costituito<br />
infatti dalla creazione di una microsocietà. Esso rappresenta inoltre un luogo<br />
di educazione, di sostegno economico, un mezzo di promozione per le<br />
iniziative che si svolgono e un luogo di affiancamento e sostegno.<br />
Nei prossimi paragrafi si cercherà di fornire un quadro generale<br />
dell’associazione <strong>Wigwam</strong>, soggetto della ricerca.<br />
15
1.1 LE ORIGINI<br />
<strong>Wigwam</strong> è un’associazione che opera dal 1972, stimolando aggregazioni di<br />
progetti non profit volti al miglioramento della qualità di vita, realizzati<br />
attraverso l’applicazione del metodo “Club di progetto <strong>Wigwam</strong>”.<br />
Il primo Club di progetto <strong>Wigwam</strong> (Comunità Ecologica <strong>Wigwam</strong>), nasce il 4<br />
dicembre 1972 a Bovolenta con l’intento di giungere ad un’azione concreta<br />
nel campo dell’educazione ambientale, in un momento storico pervaso da<br />
dibattiti e discussioni spesso fini a se stessi che non si traducevano in azioni<br />
concrete. Questa prima comunità era composta da circa 5 studenti con lo<br />
scopo di avviare un concreto discorso ecologico, messo in atto con l’esempio,<br />
il lavoro, ma anche attraverso corsi serali e dibattiti.<br />
In realtà già nel 1971, gruppi di giovani avevano cominciato a riunirsi nei mesi<br />
estivi per effettuare campi di lavoro di rimboschimento: i ragazzi<br />
collaboravano con il Gruppo Forestale dello Stato offrendo entusiasmo e<br />
buona volontà ma uniti spesso ad inesperienza. La minore resa lavorativa era<br />
però compensata dal fattore educativo, dalla formazione umana; i giovani<br />
avevano infatti in comune un profondo interesse etico e morale verso<br />
l’ecologia e il territorio. Il presupposto di base era che educare i giovani<br />
significasse istruire tutta la popolazione, e questo implicava il raggiungimento<br />
di molteplici vantaggi: di ordine sociale, economico ma soprattutto civile.<br />
A questi campi partecipavano circa 150 persone; che in quest’esperienza sono<br />
riuscite a conciliare il lavoro, la vita in comune, le esigenze di studio,<br />
realizzando un esempio di autentica vita democratica e creando un profondo<br />
spirito comunitario.<br />
Dall’entusiasmo e dai risultati ottenuti da queste prime esperienze, alcuni<br />
giovani hanno fondato la Comunità Ecologica <strong>Wigwam</strong>; questa iniziativa<br />
aveva come scopo principale la realizzazione di un modello di vita alternativa,<br />
16
iproponendo i valori ambientali, del territorio, del lavoro in comune, in<br />
opposizione all’individualismo sfrenato e al consumismo. Da allora la storia di<br />
<strong>Wigwam</strong> prosegue attraverso l’attuazione di progetti ed esperienze realizzate<br />
in ambiti estremamente eterogenei.<br />
Un aspetto importante da sottolineare, che rappresenta il filo conduttore<br />
dell’associazione di allora e di quella odierna, è una profonda e sincera<br />
volontà operativa. Non ci si è limitati a lanciare una serie di accuse e di<br />
critiche, ma si è cercato di tralasciare la fase polemica e distruttiva, le facili<br />
demagogie, per giungere, pur rispettando le differenze individuali, ad un’unità<br />
di base che pone le sue radici nel lavoro in comune, nella semplicità, nella<br />
concretezza, impostando rapporti personali di amicizia e collaborazione<br />
concreta, riscoprendo il valore del rapporto umano, della discussione e dello<br />
scambio di idee.<br />
1.2 COSA VUOL DIRE WIGWAM?<br />
<strong>Wigwam</strong> è il nome della grande capanna circolare dei nativi dei grandi laghi<br />
canadesi. Questa capanna stava al centro di ogni villaggio, ed era il punto<br />
d’incontro di tutta la comunità, il luogo dove si svolgevano assemblee,<br />
incontri, feste e tutti i momenti importanti per la comunità. Tale visione della<br />
vita corrisponde pienamente alla filosofia dell’associazione <strong>Wigwam</strong>, che<br />
vuole essere un luogo d’incontro, di aggregazione, discussione, convergenza e<br />
decisione, rispettando un equilibrato rapporto con l’ambiente e<br />
salvaguardando l’unicità delle culture autoctone, pur non rinunciando<br />
all’evoluzione, al miglioramento e alle innovazioni tecnologiche.<br />
Il logo <strong>Wigwam</strong>, invece, rappresenta la foglia stilizzata del castagno. Esso<br />
simboleggia la risorsa ambientale rinnovabile per eccellenza: si tratta di un<br />
17
albero che richiede poche cure e può essere utilizzato in tutte le sue parti,<br />
rappresentando per molte generazioni una risorsa di vitale importanza.<br />
1.3 COS’E’ WIGWAM<br />
“Un’ idea rimane tale finché qualcuno non decide di realizzarla”, questo è ciò<br />
che cerca di fare l’associazione <strong>Wigwam</strong>. Si tratta di una risposta organizzata<br />
e strutturata all’immobilità, alla passività, in favore della soluzione (anche<br />
parziale) di un problema per il miglioramento della qualità di vita di tutti.<br />
L’associazione cerca di stimolare aggregazioni non profit e di attuare<br />
concretamente progetti volti al miglioramento della qualità di vita. Chiunque<br />
può dare vita ad un progetto <strong>Wigwam</strong>: una persona, un’associazione, una<br />
cooperativa, un comune….<br />
Quello che l’associazione propone, è un metodo che possa portare alla<br />
realizzazione di progetti che abbiano due caratteristiche:<br />
1. La sostenibilità;<br />
2. Un miglioramento della qualità di vita.<br />
L’idea di base è quella di realizzare un’idea con costanza, attraverso tante<br />
piccole azioni coerenti con l’obiettivo; il raggiungimento dei risultati si ottiene<br />
suddividendo gli obiettivi in piccoli step, a cui tutti possono contribuire.<br />
La filosofia dell’associazione può essere così sintetizzata:<br />
Alla base di ogni azione ci deve essere una forte motivazione;<br />
I limiti possono (e devono) essere trasformati in opportunità;<br />
Le tensioni possono (e devono) essere sfruttate come risorse;<br />
Tradizione ed innovazione, rigore e creatività, possono (e devono)<br />
convivere in una sin<strong>tesi</strong> organica;<br />
18
Le proprie esperienze possono (e devono) essere trasferibili e<br />
riproducibili; l’emulazione può (e deve) essere utilizzata come<br />
catalizzatore e stimolo.<br />
Attualmente in Italia sono attivi circa 300 Club, ma fanno parte<br />
dell’associazione circa 80000 soci; essa inoltre è presente a livello<br />
internazionale in 16 paesi.<br />
1.4 IL METODO WIGWAM E I SUOI PROGETTI<br />
<strong>Wigwam</strong> è principalmente la filosofia di vita di chi, di fronte ad un problema o<br />
ad un’opportunità, realizza o almeno prova a realizzare un’azione concreta che<br />
possa contribuire alla soluzione e seppure in piccola parte al miglioramento<br />
della qualità di vita sua e di tutti.<br />
I vari progetti attuati all’interno dell’associazione derivano da un metodo che<br />
si ispira alla filosofia dell’empowerment e dei circoli di qualità, che può essere<br />
applicato in qualsiasi ambito, permettendo di superare i limiti di un approccio<br />
spontaneistico.<br />
Il metodo del club di progetto <strong>Wigwam</strong> parte dalla convinzione che risultati<br />
completi possano essere raggiunti solo attraverso un lavoro di gruppo che<br />
però sappia valorizzare il contributo individuale di ognuno; esso inoltre è<br />
costantemente arricchito ed aggiornato sulla base di nuove esperienze e<br />
tecniche.<br />
Molti progetti dell’associazione <strong>Wigwam</strong> riguardano il mondo rurale, le<br />
tradizioni territoriali e lo sviluppo locale. In realtà, il metodo e l’associazione<br />
sono flessibili; infatti sono stati attuati progetti estremamente eterogenei che<br />
riguardano: l’area del turismo sostenibile, dei bambini (per esempio ludoteche,<br />
mostre, fattorie didattiche), dell’handicap, della pet-terapy, della<br />
19
comunicazione, delle nuove tecnologie, degli scambi interculturali, del<br />
reinserimento sociale relazionale e/o recupero lavorativo.<br />
Il metodo <strong>Wigwam</strong>, può essere visto come un percorso, che aiuta i soci a<br />
procedere in modo più sistematico ed efficace nella realizzazione del loro<br />
progetto, grazie alle esperienze realizzate da altri club, alle sinergie presenti<br />
all’interno del circuito e ai servizi messi in rete.<br />
I club di progetto <strong>Wigwam</strong> sono distinguibili in due grandi categorie:<br />
1. IL CLUB DI PROGETTO WIGWAM DI PRIMO LIVELLO: opera in<br />
modo non formalizzato dal punto di vista giuridico-istituzionale, e si<br />
configura come un gruppo di persone accomunate dalla realizzazione di<br />
un progetto. Per costituire un club di progetto <strong>Wigwam</strong> di primo livello<br />
è necessario che almeno uno dei soci abbia frequentato il corso base di<br />
formazione di primo livello “Operare nel circuito <strong>Wigwam</strong>”.<br />
2. IL CLUB DI PROGETTO WIGWAM DI SECONDO LIVELLO:<br />
opera in modo formalizzato dal punto di vista giuridico-istituzionale<br />
(registrazione presso l’Ufficio Registro, organizzazione contabile e<br />
fiscale, raccolta di quote di iscrizione…). Si configura come una vera e<br />
propria associazione senza scopo di lucro, che ha però tutti i requisiti<br />
per avviare collaborazioni con imprese pubbliche e private o altre<br />
associazioni. Per costituire un club di progetto <strong>Wigwam</strong> di secondo<br />
livello è necessario che almeno uno dei soci abbia frequentato il corso<br />
di formazione di secondo livello “Creare lavoro nel non profit<br />
costituendo un Club <strong>Wigwam</strong>”.<br />
Realizzare un progetto contribuisce non solo a migliorare la vita di tutti, ma<br />
anche di chi si impegna a realizzarlo. Studiare la situazione, individuare punti<br />
di forza e di debolezza, reperire risorse umane, economiche e logistiche, creare<br />
coinvolgimento e partecipazione nei soggetti, riuscire a lavorare in gruppo,<br />
20
portare a termine un impegno che ci si è assunti; sono tutte occasioni di<br />
apprendimento e un buono stimolo per mettersi alla prova. Per questi motivi,<br />
la realizzazione di un progetto ben si adatta a diverse tipologie di persone,<br />
costituendo:<br />
- un’esperienza formativa per i giovani, permettendo un arricchimento delle<br />
esperienze lavorative;<br />
- una formula flessibile per coloro che desiderano lavorare nel terzo settore;<br />
- un approccio strutturato e creativo per gli operatori del volontariato e del<br />
sociale;<br />
- uno strumento di comunicazione più efficace e di crescita interna, per<br />
associazioni e aziende che vogliono valorizzare la propria immagine con<br />
iniziative concrete, mirate alla qualità e al benessere della collettività.<br />
1.5 LA FORMAZIONE<br />
La formazione è uno dei temi che maggiormente hanno impegnato<br />
l’associazione <strong>Wigwam</strong>. Soprattutto nell’ultimo anno, all’aspetto formativo è<br />
stata dedicata una forte attenzione, infatti sono state avviate alcune iniziative<br />
in collaborazione con enti esterni con lo scopo di aumentare il livello<br />
qualitativo dell’offerta didattico-formativa.<br />
L’obiettivo è quello di promuovere un iter formativo capace di produrre nel<br />
territorio, elementi dinamici che portino ad un miglioramento della qualità<br />
della vita, ma cercando di fornire delle risposte concrete alla crescente<br />
richiesta di competenze presente nel terzo settore nell’interpretazione e nella<br />
lettura delle dinamiche territoriali, degli interventi possibili e della<br />
sostenibilità.<br />
Il fulcro dell’attività formativa è rappresentato dal corso di primo livello, che<br />
dura un weekend e si svolge presso la sede storica dell’associazione. Il corso<br />
21
offre le istruzioni di base per costituire un proprio club di progetto, per<br />
utilizzare al meglio le risorse presenti nel circuito, dà informazioni sui valori<br />
di base e sulla storia associativa. Permette inoltre di acquisire il titolo di<br />
“Operatore <strong>Wigwam</strong> Qualificato” e la “Route Patent”, offrendo così<br />
all’operatore la possibilità di cogliere tutte le possibilità presenti nel circuito,<br />
di potersi referenziare, di avere una licenza d’uso del marchio <strong>Wigwam</strong> per<br />
una propria iniziativa progettuale e di poter promuovere e gestire un <strong>Wigwam</strong><br />
Club.<br />
Altri importanti esempi di attività formativa sono rappresentati dal corso sulla<br />
gestione dei team in azienda, il corso di media relations management, il<br />
progetto di formazione “buon territorio”, il corso per il turismo sostenibile.<br />
A queste occasioni, si aggiungono frequenti incontri a tema, in cui sono<br />
invitati esperti e a cui tutti i soci possono partecipare.<br />
1.6 CARATTERISTICHE DEI PROGETTI<br />
Se i diversi progetti si distinguono per l’eterogeneità delle tematiche<br />
affrontate, esistono comunque dei “valori” e delle linee guida a cui tutti fanno<br />
riferimento, con l’obiettivo comune di portare ad un miglioramento della<br />
qualità di vita.<br />
1. LA SOSTENIBILITA’: il concetto di sviluppo sostenibile è di difficile<br />
delimitazione, in questo contesto si fa riferimento alla definizione di Daly<br />
(1996), secondo cui sviluppo sostenibile significa crescita, evoluzione,<br />
espansione di potenzialità che portano ad un miglioramento qualitativo del<br />
sistema. Il concetto di sostenibilità infatti si può riferire all’eco-sistema, al<br />
socio-sistema ma anche alla dimensione individuale. Lo sviluppo sostenibile<br />
consiste nell’amministrare e conservare il patrimonio di risorse naturali, e<br />
nell’indirizzare lo sviluppo tecnologico ed istituzionale, al fine di assicurare il<br />
22
mantenimento ed il soddisfacimento dei bisogni umani relativi alle<br />
generazioni presenti e future. Tale sviluppo deve quindi preservare le risorse,<br />
non degradare l’ambiente, essere tecnologicamente appropriato,<br />
economicamente valido e socialmente accettabile.<br />
I diversi progetti cercano di proporre attraverso l’esempio personale, uno stile<br />
di vita sostenibile, che porti la persona a vivere in modo più armonico con<br />
l’ambiente che la circonda; in questo senso il territorio è visto come una fonte<br />
inesauribile di risorse. L’obiettivo è la diffusione di un modello di sviluppo<br />
diverso da quello attuale, che sia legato alla qualità e all’equità.<br />
Per sviluppare questo aspetto l’associazione fa riferimento da un punto di vista<br />
teorico ai principi dell’empowerment. Essa cerca di sensibilizzare e<br />
responsabilizzare i soggetti in modo che tutti si sentano coinvolti nella<br />
creazione di un rapporto migliore con la comunità e il territorio (un mondo<br />
sostenibile), per un miglioramento della qualità di vita propria ed altrui.<br />
2. LA QUALITA’: all’interno delle organizzazioni non profit, la qualità è<br />
definita da alcuni autori come “qualità sociale”, rimandando alla capacità di<br />
queste organizzazioni di promuovere cittadinanza attiva (De Leonardis, 1998).<br />
La qualità del servizio è pertanto definita come la misura in cui i cittadini sono<br />
in grado di partecipare alla vita sociale ed economica della propria comunità in<br />
condizioni che accrescono il benessere loro, della società e il loro potenziale<br />
individuale (Beck et al. 1997, p.9). La qualità sociale è pertanto legata a quei<br />
servizi che sostengono la dimensione proattiva delle persone; essa dipende sia<br />
dal livello tecnico e qualitativo dei servizi erogati, ma anche dal fatto che<br />
questi servizi si caratterizzano come luogo di incontro di persone e come<br />
veicolo di socialità e di solidarietà consapevole e operante.<br />
La rete <strong>Wigwam</strong> ha come obiettivo primario la qualità, intesa in senso lato<br />
(dei servizi, del prodotto, della vita) e da un punto di vista teorico si ispira alla<br />
23
filosofia proposta dai circoli di qualità, ovvero ad una modalità partecipativa<br />
di gestione delle risorse (Capitolo 3).<br />
1.7 LA RETE WIGWAM<br />
L’associazione <strong>Wigwam</strong> presenta le caratteristiche di una rete sociale;<br />
l’organizzazione di rete è un modello concettuale in cui i diversi soggetti (o<br />
nodi del sistema), convergono su obiettivi comuni. Ogni soggetto, si<br />
concepisce come parte o nodo di una rete di scambi in cui il proprio risultato<br />
diventa servizio o materia prima per un altro nodo e tutti i risultati parziali<br />
confluiscono verso un risultato globale.<br />
Questo aspetto è sottolineato dal fatto che:<br />
- tutti gli operatori hanno accesso alle risorse presenti nel circuito<br />
<strong>Wigwam</strong>;<br />
- sono frequenti i contatti informali diretti tra operatori;<br />
- l’associazione organizza durante l’anno incontri formali (come per<br />
esempio le assemblee di bilancio), in cui esistono spazi aperti al<br />
confronto e soprattutto alla condivisione di strategie e risultati;<br />
- l’associazione (come già esplicitato in precedenza) valorizza il<br />
confronto come catalizzatore e stimolo.<br />
- sono presenti iniziative e progetti realizzati da più club, attraverso una<br />
condivisione di esperienze, risorse e risultati.<br />
L’associazione <strong>Wigwam</strong> si colloca all’interno di quelle che vengono definite<br />
“reti secondarie informali”, ovvero quelle organizzazioni e gruppi che si sono<br />
sviluppati per far fronte a determinati bisogni ed esigenze delle persone. Essa<br />
presenta le caratteristiche di una rete sociale frammentata, in cui esistono<br />
diversi sottogruppi indipendenti gli uni dagli altri. I contatti diretti tra i vari<br />
24
gruppi sono piuttosto frequenti; questo aspetto si è sviluppato ulteriormente<br />
negli ultimi anni grazie al sito internet.<br />
In sin<strong>tesi</strong>, possiamo affermare che la rete <strong>Wigwam</strong> presenta le seguenti<br />
caratteristiche:<br />
Ampiezza: sono presenti nel territorio nazionale circa 80.000 soci, e<br />
sono attivi circa 300 club;<br />
Densità: molte persone della rete si conoscono tra loro e hanno un<br />
contatto frequente;<br />
Intimità o vicinanza: tra i soci, grazie ai frequenti contatti, si sono<br />
create situazioni di coinvolgimento affettivo e di amicizia; esse sono<br />
estremamente rilevanti in quanto svolgono un ruolo supportivo per la<br />
persona sia a livello personale che sociale e associativo.<br />
A livello grafico, la struttura associativa può essere così schematizzata<br />
SEDE STORICA:<br />
E’ il punto di<br />
riferimento di tutti i<br />
soci, qui vengono<br />
svolti i corsi per<br />
diventare operatore<br />
<strong>Wigwam</strong>.<br />
Si è cercato di fornire un quadro associativo esaustivo, sottolineando<br />
maggiormente le peculiarità e i valori di base che contraddistinguono<br />
<strong>Wigwam</strong>. Nella seconda parte dell’elaborato, grazie alla somministrazione di<br />
alcune interviste, sarà possibile comprendere in modo più approfondito alcune<br />
caratteristiche associative.<br />
CLUB WIGWAM:<br />
Sono l’essenza<br />
dell’associazione. Sono<br />
gestiti da soci che hanno<br />
svolto il corso di base<br />
(operatori) e che svolgono<br />
un ruolo associativo<br />
“attivo”. Ogni club ha un<br />
presidente, che si occupa<br />
della coordinazione e<br />
gestione dello stesso con<br />
gli altri operatori.<br />
25<br />
SOCI ORDINARI:<br />
Si tratta di associati, essi<br />
possono partecipare a tutte<br />
le iniziative proposte dai<br />
vari club e<br />
dall’associazione, ma non<br />
svolgono un ruolo attivo e<br />
non gestiscono e<br />
partecipano a progetti<br />
specifici.
CAPITOLO 2: L’EMPOWERMENT<br />
La confusione attuale che caratterizza l’uso del termine empowerment, deriva<br />
dal suo essere stato adottato per denotare fenomeni diversi, identificando<br />
contemporaneamente un modello culturale (per esempio un insieme di valori o<br />
di principi), un costrutto psicologico, una caratteristica del soggetto, un<br />
processo operativo ed un approccio applicativo (Bruscaglioni, 1994).<br />
Sviluppare una teoria dell’empowerment è un obiettivo saliente e distintivo<br />
della psicologia di comunità, ma in realtà, l’approccio empowering è diffuso<br />
in una pluralità di aree (area pedagogica, politico-economica, medica,<br />
psicoterapeutica).<br />
Pur essendo tali ambiti distinti, la comune matrice di significato da cui<br />
scaturiscono rende ardua una netta separazione degli stessi; infatti, nonostante<br />
si parta da tematiche associative e professionali, il successo di un approccio<br />
empowering dipende anche dal complesso insieme di aspirazioni, risorse e<br />
caratteristiche dei soggetti.<br />
In generale, un intervento di empowerment agisce sulla dimensione<br />
psicologica personale del singolo, proponendosi di affrontare i suoi problemi<br />
partendo dai suoi punti di forza e rafforzando le sue competenze, ma anche<br />
sulla dimensione sociale dell’esperienza umana, secondo una prospettiva<br />
circolare: se le singole persone empowered contribuiscono a rendere più<br />
competenti i gruppi e le reti a cui partecipano, queste a loro volta diventano<br />
setting ambientali che offrono nuovi stimoli alle persone che li frequentano<br />
(Francescato, Leone, Traversi, 1993).<br />
Ciò implica che si debbano ricercare i fondamenti psicologici concettuali<br />
dell’empowerment sia all’interno di una prospettiva psicologica individuale (e<br />
personologica) sia di una sociale (e interazionista).<br />
27
Il focus di questo capitolo, per ragioni di ampiezza, privilegerà<br />
l’empowerment come costrutto organizzativo e di comunità.<br />
Letteralmente, empowerment significa “attribuire potere”, incrementare in un<br />
soggetto la percezione di controllo su ciò che accade; ma esso ha anche il<br />
significato di “autorizzare, permettere, mettere nelle condizioni di”,<br />
rimandando in quest’ultima accezione all’azione dello sviluppo, del potenziale<br />
che si trova, in un momento dato, ad uno stato latente.<br />
2.1 CARATTERISTICHE DELL’EMPOWERMENT<br />
Secondo Francescato (1996), l’empowerment globale (quello che agisce nel<br />
reale), è frutto dell’integrazione tra:<br />
- L’empowerment psicologico individuale, che è una caratteristica di una<br />
persona nel suo rapporto con oggetti specifici, ambiti, aree della propria<br />
vita (per esempio il rapporto di un soggetto nei confronti della propria<br />
associazione);<br />
- L’empowerment permesso/fornito da uno specifico setting in cui il<br />
soggetto si trova (per esempio l’associazione di cui il soggetto è parte);<br />
- L’empowerment permesso/fornito dall’ambiente sociale globale, dalla<br />
comunità.<br />
In quest’ottica, il concetto di empowerment contiene in sé, sia il riferimento<br />
all’autodeterminazione individuale che alla partecipazione alla vita di<br />
comunità; traducendosi, dunque, sia nel senso di controllo personale sia<br />
nell’influenza sociale (Rappaport, 1987). Per comprenderne il significato<br />
occorre pertanto andare oltre l’individuo, considerando come sia<br />
intrinsecamente implicata nel concetto di empowerment una relazione di<br />
potere/influenza con l’ambiente, con l’altro, con la comunità, con un oggetto<br />
di investimento, esterno o interno. Per tale ragione, le teorie<br />
28
sull’empowerment sono per definizione ecologiche, orientate ad una<br />
comprensione contestuale e relazionale, piuttosto che intrapsichica dei<br />
fenomeni.<br />
In letteratura sono presenti molte definizioni di empowerment (Perkins e<br />
Zimmerman, 1995), ma tutte concordano nel considerarlo qualcosa di più e di<br />
diverso da alcuni costrutti psicologici tradizionali, con i quali talvolta è<br />
confuso (autoefficacia, autostima, locus of control..). Tutte le definizioni<br />
comunque sono coerenti con quella fornita dal Cornell Empowerment Group<br />
(1989), che lo definisce come: “un processo intenzionale e permanente<br />
fondato nella comunità locale, che implica mutuo rispetto, riflessione critica,<br />
cura e partecipazione di gruppo, attraverso il quale le persone che non hanno a<br />
disposizione una quota di risorse di valore pari a quelle degli altri guadagnano<br />
maggiore accesso e controllo su di esse” (cit. in Perkins et Zimmerman, 1995,<br />
p.570).<br />
Rappaport (1987) e Zimmerman (1999, 2000) tracciano, a questo proposito,<br />
delle linee guida che circoscrivono il concetto di empowerment:<br />
E’ un concetto multilivello, che si applica agli individui, ai gruppi, alle<br />
organizzazioni, alle comunità locali; tali livelli sono tra loro in un<br />
rapporto di influenza reciproca, i cui effetti combinati contribuiscono a<br />
creare l’empowerment come risultato;<br />
Indica sia il processo verso la consapevolezza e lo sviluppo delle<br />
potenzialità, sia il risultato ottenuto. I risultati possono tradursi: per gli<br />
individui, nella partecipazione organizzata; per le organizzazioni, in<br />
una leadership e un processo decisionale condiviso; per le comunità in<br />
azioni collettive. I risultati si riferiscono all’operazionalizzazione<br />
dell’empowerment che consente di rilevare e misurare le conseguenze<br />
dei processi empowering (Perkins e Zimmerman, 1995). In figura 1,<br />
29
sono sintetizzati i processi e i risultati dell’empowerment per i diversi<br />
livelli di analisi. Nella seconda parte dell’elaborato, attraverso<br />
un’intervista sarà indagato prevalentemente il secondo livello;<br />
E’ una variabile continua, si dà a diversi gradi e livelli;<br />
E’ una variabile dinamica, muta nel tempo e non necessariamente si<br />
sviluppa con sequenze lineari; richiede pertanto di essere studiata<br />
longitudinalmente;<br />
Punti cardine dell’empowerment sono a tutti i livelli: la percezione di<br />
controllo, la consapevolezza critica e la partecipazione;<br />
Si specifica rispetto al contesto storico e culturale, e alla popolazione;<br />
per questo motivo, soluzioni specifiche sono maggiormente<br />
empowering rispetto a soluzioni preconfezionate applicate con criteri<br />
generali.<br />
Come già accennato in precedenza, oltre ad essere un modello teorico,<br />
l’empowerment è un valore, o meglio, una concezione dell’uomo e della<br />
realtà, una Weltanschaung, una cultura, che spesso ha superato in psicologia di<br />
comunità, la filosofia dell’intervento ispirata alla prevenzione (soddisfazione<br />
dei bisogni) e all’advocacy, preferendo un modello basato sullo sviluppo delle<br />
competenze (Rappaport, 1981).<br />
Un approccio basato sull’ empowerment – sia esso di natura clinica o di natura<br />
organizzativa – predilige i setting della normalità, ed è orientato non tanto a<br />
colmare un deficit, quanto a sviluppare delle risorse. Se, per esempio, alla<br />
condizione di powerlessness di un soggetto, contribuiscono condizioni di<br />
contesto che gli impediscono di utilizzare il capitale a propria disposizione,<br />
facilitare il suo utilizzo rappresenta già una chiave di svolta per il successo del<br />
soggetto stesso. In questa prospettiva, svolgono un ruolo cruciale le strutture<br />
intermedie che si pongono tra l’individuo e la società (per esempio<br />
30
l’associazione <strong>Wigwam</strong>, i gruppi di vicinato, la famiglia..), che hanno il ruolo<br />
di sistemi naturali di sostegno, e sono considerate come una parte<br />
fondamentale del pool di risorse da cui gli individui possono attingere.<br />
Fig 1: Processi e risultati dell’empowerment per i diversi livelli di analisi.<br />
(Fonte: Zimmerman 2000).<br />
LIVELLO DI<br />
ANALISI<br />
INDIVIDUO<br />
ORGANIZZAZIONE<br />
COMUNITA’<br />
PROCESSO<br />
(Empowering)<br />
Apprendere abilità<br />
decisionali<br />
Gestire risorse<br />
Lavorare con gli altri<br />
Coinvolgimento nelle<br />
decisioni<br />
Responsabilità condivisa<br />
Leadership condivisa<br />
Accesso alle risorse<br />
Struttura di governo<br />
aperta<br />
Tolleranza alla diversità<br />
31<br />
RISULTATO<br />
(Empowered)<br />
Senso di controllo<br />
Consapevolezza critica<br />
Partecipazione<br />
Competere per le risorse<br />
Fare rete con altre<br />
organizzazioni<br />
Influenzare i piani<br />
d’azione politici<br />
Coalizioni organizzative<br />
Leadership pluralistica<br />
Competenze<br />
partecipative dei<br />
residenti
2.2 COM’E’ NATO L’EMPOWERMENT?<br />
All’interno di questo paragrafo verranno esposte le principali teorie<br />
psicologiche da cui nasce il concetto di empowerment. Partendo da una<br />
prospettiva individuale i contributi più significativi vengono da Rotter (1966)<br />
e Bandura (1996).<br />
Entrambe attribuiscono la motivazione del comportamento ad un complesso<br />
sistema di scopi e aspettative secondo cui il comportamento dell’individuo è<br />
regolato dal sistema di aspettative che il soggetto si formula al riguardo. 1 La<br />
personalità, in quest’ottica, risulta dal determinarsi di particolari interazioni tra<br />
l’ambiente e la persona, che producono il consolidarsi di esperienze che<br />
formeranno il bagaglio comportamentale dell’individuo. Va sottolineato che le<br />
esperienze apprese, non sono solo una risposta a stimoli ambientali e<br />
situazionali, ma dipendono anche dalla persona che attribuisce senso<br />
all’ambiente e in esso si muove.<br />
Rotter (1966), parla in questo senso di locus of control interno, inteso come la<br />
capacità dell’individuo di porre internamente a sé il controllo, di considerarsi<br />
responsabile degli eventi che lo vedono coinvolto.<br />
Bandura (1996), invece, parla di self-efficacy, intesa come la capacità<br />
dell’individuo di percepirsi come un attore efficace di azioni con esito<br />
positivo. Questa capacità permetterà al soggetto di rappresentarsi un ventaglio<br />
di possibilità circa le conseguenze del proprio agire e, quindi, eviterà alla<br />
persona di vivere una prospettiva univoca, tendenzialmente passivizzante.<br />
Secondo le teorie dell’empowerment, la personalità non sarebbe una struttura<br />
cristallina, relativamente stabile nel tempo, ma sarebbe soggetta a<br />
1 Secondo gli autori il sistema motivazionale non coincide automaticamente con il sistema di rinforzo<br />
visto dai comportamentisti classici (premio-punizione). Entrambi gli autori possono essere ricondotti<br />
alla corrente dell’apprendimento sociale (social learning), essi quindi pongono enfasi sull’importanza<br />
dell’apprendimento e la medesima prospettiva situazionista, ma individuano anche importanti punti di<br />
attenzione nell’interazionismo e nella necessità di porsi in una prospettiva fenomenologica per<br />
cogliere e interpretare correttamente la relazione esistente tra l’individuo e la situazione.<br />
32
cambiamenti all’interno di un processo di apprendimento continuo, in un<br />
rapporto dinamico con l’ambiente di riferimento. Rotter intendeva il concetto<br />
di locus of control come un tratto relativamente stabile di personalità; altri<br />
autori (Hiroto e Seligman, 1975), più recentemente hanno messo il locus of<br />
control in relazione con la motivazione e “il senso di impotenza acquisito”.<br />
Pertanto se il senso di impotenza è acquisito, è acquisibile anche un<br />
sentimento di potenza (self-empowerment).<br />
La prospettiva interazionista dell’empowerment, invece, trova il suo<br />
fondamento principale nel lavoro di Kurt Lewin (1951) e nella sua teoria di<br />
campo.<br />
Nella concezione lewiniana, per campo si intende la totalità dei fatti<br />
coesistenti nella loro interdipendenza; questo comporta che il campo sia<br />
regolato non tanto dalle caratteristiche degli elementi che contiene, quanto<br />
dalle loro relazioni. Quindi le proprietà di un evento, di un oggetto, derivano<br />
dalla relazione con tutti gli altri eventi ed oggetti presenti (nel presente,<br />
passato e futuro) nella percezione del soggetto. Secondo l’approccio<br />
lewiniano, il comportamento umano dev’essere visto in relazione al contesto<br />
in cui si attua; questo implica che i comportamenti possano essere trasformati<br />
attraverso la modifica della disponibilità di risorse. In quest’ottica,<br />
l’empowerment è importante perché incoraggia la ricerca e l’uso di risorse<br />
interne ed esterne al soggetto, più che la ricerca di interventi che tentino di<br />
modificare il soggetto stesso.<br />
2.3 L’EMPOWERMENT PSICOLOGICO<br />
33
La condizione psicologica opposta a quella dell'empowerment è definita come<br />
"impotenza appresa" (learned helplessness, Seligman, 1990). Il concetto fa<br />
riferimento al fenomeno per il quale le persone che sperimentano l'inefficacia<br />
o la fallacia delle proprie azioni rispetto ad un particolare evento, sviluppano<br />
un determinato tipo di aspettativa rispetto a se stessi: imparano che, qualunque<br />
cosa faranno in futuro relativamente a quell'evento, esso non produrrà l'effetto<br />
desiderato.<br />
La percezione sistematica di non avere possibilità di controllo delle<br />
circostanze della vita, pone gli individui in una posizione psicologica<br />
caratterizzata da: locus of control tendenzialmente esterno, comportamenti di<br />
coping non orientati al compito, immagine di sé non particolarmente positiva.<br />
Collocando ipoteticamente il concetto di empowerment lungo un continuum<br />
che va da un minimo ad un massimo, tale condizione mentale di deprivazione,<br />
in particolare se unita ad un limitato accesso alle risorse sociali,<br />
rappresenterebbe “il punto zero”.<br />
Le teorie dell'empowerment e della learned helplessness sono state sviluppate<br />
indipendentemente; entrambe però riconoscono la necessità di esaminare le<br />
realtà oggettive e soggettive degli individui per comprenderne e spiegarne i<br />
comportamenti; includono dimensioni similari, ritenendo che gli stili<br />
interpretativi e attribuzionali e le valutazioni globali derivanti dalle esperienze<br />
pregresse influenzino l'umore e il comportamento.<br />
Si può dunque proporre un modello integrato delle due teorie, come suggerito<br />
da Campbell e Martinko (1998) per comprendere al meglio la situazione di un<br />
soggetto disempowered. Più in dettaglio, i due costrutti psicologici si basano<br />
sulle seguenti componenti:<br />
- cognizioni (attribuzioni, interpretazioni): la teoria dell'impotenza appresa<br />
considera quattro dimensioni che caratterizzano l'attribuzione di causalità: il<br />
34
locus (interno vs esterno), la stabilità (permanente vs transitoria), la globalità<br />
(generale vs specifico) e la controllabilità;<br />
- stati emotivi: associate alla condizione di helplessness si presentano:<br />
depressione, ansia, stress, frustrazione, ostilità, stanchezza, rabbia, vergogna<br />
e alienazione; si possono, quindi, attribuire alle persone empowered stati<br />
affettivi opposti;<br />
- aspettative: nelle condizioni di impotenza gli individui credono che gli<br />
eventi futuri non siano in relazione con i comportamenti messi in atto. Al<br />
contrario, i soggetti empowered si aspettano che le proprie azioni producano<br />
un effetto nel futuro;<br />
- comportamento: come risultato dell'interpretazione degli eventi. I soggetti<br />
empowered si pongono attivamente, concentrandosi sul compito, prendendo<br />
l'iniziativa e dimostrandosi capaci di fronteggiare le difficoltà; le persone<br />
disempowered, al contrario, sono descritte come passive, scarsamente<br />
produttive, ritirate in se stesse, insoddisfatte.<br />
In sin<strong>tesi</strong>, l'empowerment psicologico si fonda su tre fattori (Zimmerman,<br />
1995):<br />
a) la percezione del controllo personale (componente intrapersonale):<br />
questa dimensione si riferisce al modo in cui le persone pensano a se<br />
stesse. Include la percezione di controllo e di autoefficacia nelle diverse<br />
sfere di vita (lavoro, famiglia..), la motivazione al controllo e la<br />
competenza percepita;<br />
b) l'accesso alle risorse e la comprensione critica dell'ambiente circostante<br />
(componente interpersonale): corrisponde alla comprensione che le<br />
persone hanno del loro ambiente sociale, delle risorse necessarie per<br />
raggiungere un certo obiettivo, delle cause dei problemi, della capacità<br />
di mobilitazione delle risorse;<br />
35
c) i comportamenti (componente comportamentale): questa dimensione<br />
comprende le azioni intraprese per raggiungere un risultato: il<br />
coinvolgimento nella comunità, la partecipazione organizzata, i<br />
comportamenti di coping.<br />
L’empowerment si configura dunque come un costrutto complesso, derivante<br />
dall’integrazione di tutte queste dimensioni. Le persone, infatti, contribuiscono<br />
a generare gli eventi, ma non li determinano del tutto; pertanto la loro<br />
possibilità di azione si colloca in una struttura causale costituita da diversi<br />
fattori: intrapersonali, comportamentali e ambientali.<br />
Per questi motivi, l’empowerment psicologico consiste in un processo di<br />
accrescimento del potere interno dei soggetti, del loro protagonismo e della<br />
loro capacità di incidere, con azioni concrete, sui contesti di vita; allo stesso<br />
tempo, è la risultante della combinazione di complessi processi cognitivi e<br />
motivazionali.<br />
Un'ulteriore accentuazione del carattere intra-individuale del costrutto è<br />
implicata nel modello teorico-operativo proposto da Bruscaglioni (1994), che<br />
ridefinisce l'empowerment come un processo attraverso il quale ampliare il<br />
ventaglio delle possibilità di scelta a disposizione degli individui. Il concetto<br />
chiave è rappresentato dalla "pensabilità" delle opzioni e degli eventi, che<br />
rappresenta il primo passo per la loro realizzabilità. Dal punto di vista<br />
operativo, il processo si scompone nelle seguenti fasi (Bruscaglioni, 2003):<br />
l’emergere di un nuovo desiderio (la persona sperimenta la propria possibile<br />
influenza), la costruzione di una pensabilità positiva supportata da una<br />
rappresentazione mentale (aumento dell’autoefficacia intesa come fiducia<br />
nelle risorse di cui la persona dispone) e la costruzione di una nuova<br />
possibilità (tendenza ad investire energie e azioni sulle risorse disponibili e<br />
36
non sui vincoli e risorse mancanti). Questo processo porta la persona a<br />
sperimentare un senso di padronanza sulla propria vita.<br />
Riformulato in altri termini, alla base dell'empowerment c'è una<br />
ristrutturazione del campo cognitivo di un determinato oggetto (per esempio:<br />
una situazione contingente in una sfera di vita), che implica una "disponibilità"<br />
dei soggetti a vedere e rappresentare sé e le situazioni in modi molteplici e<br />
insoliti rispetto agli schemi di pensiero abituali. In un certo senso, quindi,<br />
l'empowerment può essere inteso anche come negative capability, ovvero<br />
come capacità di produrre e sperimentare nuovi pattern di pensiero e di azione<br />
in condizioni "anomale" (Lanzara, 1993).<br />
In accordo con quanto sostenuto da Zimmerman e Rappaport (1987),<br />
l’empowerment psicologico fa riferimento alla percezione di controllo sulla<br />
propria vita del soggetto e alla partecipazione alla vita del proprio territorio,<br />
qualificando il cittadino come “membro attivo”. Pertanto, essendo<br />
l’empowerment un concetto multilivello, l’aspetto individuale si realizza solo<br />
in rapporto all’aspetto gruppale o comunitario.<br />
2.4 L’EMPOWERMENT NELLE ORGANIZZAZIONI<br />
Il trasferimento e l’uso del costrutto dell’empowerment in ambito<br />
organizzativo avviene nel 1977, per opera della sociologa americana Rosabeth<br />
Moss Kanter, ma in realtà esso comincia a diffondersi agli inizi degli anni ’80<br />
grazie agli studi di Peters e Waterman (1982).<br />
In generale, il concetto di empowerment, a livello organizzativo e associativo,<br />
pone l’accento sul valore della responsabilità di tutti i soggetti coinvolti.<br />
Questo è ancora più rilevante per le organizzazioni e associazioni (come<br />
<strong>Wigwam</strong>), che si basano sul servizio, sulla qualità e sulla ricerca della<br />
37
soddisfazione per i propri clienti/utenti e in cui ogni componente della<br />
struttura ha una quota di autonomia decisionale.<br />
In letteratura esiste un’ampia gamma di definizioni di empowerment<br />
organizzativo, che per ragioni di ampiezza non potranno essere approfondite<br />
in questa sede 2 . In generale, esso è considerato un processo di ampliamento<br />
del potere del soggetto sul proprio lavoro, un’appropriazione soggettiva, un<br />
modo per utilizzare al meglio le risorse potenziali e operative presenti in<br />
ciascuno, un trasferimento del potere che offre la possibilità di sperimentare<br />
padronanza del proprio ruolo lavorativo.<br />
Le organizzazioni che mettono in atto dei processi basati sull’empowerment,<br />
pongono l’accento su due grandi valori:<br />
1. La responsabilizzazione a tutti i livelli: quest’aspetto è già stato<br />
approfondito nei paragrafi precedenti, va però sottolineato che il<br />
processo di responsabilizzazione, oltre ad un’accezione positiva,<br />
possiede anche una componente fortemente ansiogena, implicando oltre<br />
la possibilità di maggior controllo sul proprio lavoro, anche la necessità<br />
di rendere conto delle proprie decisioni a se stessi e agli altri.<br />
2. La socialità, la relazione con l’altro: la prospettiva di un lavoro di<br />
squadra, di gruppo, implica una forte interdipendenza tra i soggetti, che<br />
si rapportano tra loro in una struttura di tipo reticolare (e non più<br />
piramidale). Questo processo contiene molti aspetti gratificanti e anti-<br />
alienanti, ma allo stesso tempo obbliga l’individuo ad una costante<br />
esposizione, correndo il rischio di attivare processi di competizione.<br />
Come per il livello individuale, anche sul piano organizzativo possono essere<br />
riscontrate le stesse componenti dell’empowerment psicologico:<br />
2 Altre definizioni significative: Bruscaglioni (1994, p. 124), Conger e Kaningo (1988, p. 474),<br />
Johnson (1993, p.13), Thomas e Velthouse (1990, p. 667), Lolli (1993, p. 4), Fisher (1992, p.14),<br />
Shipper e Manz (1992, p.49), Block (1987, p.68). Per una rassegna Piccardo, 1995.<br />
38
o controllo: presenza di strutture e procedure di tipo orizzontale,<br />
coinvolgimento nelle decisioni, condivisione della responsabilità;<br />
o consapevolezza critica: mobilitazione delle risorse interne;<br />
o partecipazione: condivisione e allargamento nei processi decisionali,<br />
delega, accesso e controllo delle risorse, decentramento del potere.<br />
L’importanza del controllo per la soddisfazione e il benessere lavorativo, è<br />
dimostrata dagli studi sullo stress. Il modello “domanda/controllo” di Karasek<br />
e Theorell (1990) sostiene che ciò che genera stress è una condizione di<br />
domanda psicologica elevata (intesa come impegno psicologico e fisico),<br />
associata ad un basso controllo del lavoratore sul processo lavorativo (dove<br />
per controllo si intende sia la capacità individuale di svolgere il compito, sia la<br />
discrezionalità nell’organizzarlo).<br />
Situazioni connotate da un alto grado di controllo e discrezionalità,<br />
accompagnate da un elevato livello di domanda psicologica, sono definite<br />
“lavoro attivo”; esse sono quelle in cui si realizza maggiore motivazione ad<br />
apprendere e maggior senso di competenza e di autoefficacia.<br />
Le principali aree di applicazione dell’empowerment nelle organizzazioni,<br />
riguardano i modelli di management, le forme di articolazione del lavoro (per<br />
esempio il lavoro in gruppo), la leadership e la cultura organizzativa<br />
(Bruscaglioni, 1995). Quest’ultima in realtà costituisce la cornice generale di<br />
senso entro cui si realizzano tutti gli aspetti organizzativi. Essa, ha pertanto un<br />
potere normativo (Etzioni, 1961) che, sulla base della filosofia<br />
dell’empowerment, fa leva sul coinvolgimento morale dei soggetti, ai quali si<br />
richiede di condividere un insieme comune di norme e valori.<br />
Un’organizzazione empowering richiede inevitabilmente che i suoi membri<br />
condividano i valori dell’empowerment, perché questa corrispondenza<br />
incrementa l’efficacia collettiva.<br />
39
L’efficacia organizzativa si manifesta dunque, come esito del grado di<br />
partecipazione e coinvolgimento dei membri, non solo rispetto ai propri<br />
compiti specifici, ma anche relativamente a questioni organizzative di<br />
carattere più ampio (processi decisionali, progettazione degli obiettivi..).<br />
Per tale ragione, la cultura e la filosofia dell’empowerment rappresentano una<br />
proposta valoriale, teorica e metodologica che risponde positivamente ad<br />
alcune delle esigenze delle organizzazioni contemporanee, ponendosi come un<br />
superamento della cultura di tipo gerarchico. Fig 2.<br />
Fig. 2: Cultura gerarchica vs cultura dell’empowerment. (Randolph, 2002).<br />
CULTURA GERARCHICA<br />
40<br />
CULTURA<br />
DELL’EMPOWERMENT<br />
Pianificazione Vision<br />
Comando e controllo Partnership per prestazione<br />
Monitoraggio Auto-monitoraggio<br />
Responsabilità individuale Responsabilità di gruppo<br />
Strutture piramidali Strutture trasversali per funzioni<br />
Flusso di lavoro Progetti<br />
Manager Team leader<br />
Impiegati Membri dei team<br />
Management partecipativo Team autodiretti<br />
Eseguire gli ordini Appropriarsi del proprio lavoro<br />
Adesione Valutazione ragionata<br />
E’ importante inoltre effettuare una distinzione tra organizzazioni empowered<br />
e empowering (Zimmerman, 2000). Le prime sono identificate come<br />
organizzazioni di successo, competitive, ed in grado di far fronte alle richieste
ambientali. Le seconde, invece, forniscono ai propri membri strumenti per<br />
incrementare il controllo, centrando i processi lavorativi sulla<br />
responsabilizzazione, sulla capacità di ciascun individuo di risolvere i<br />
problemi e sulla partecipazione. Esse hanno, in altri termini, la capacità di<br />
promuovere e mantenere un alto grado di benessere psicosociale dei propri<br />
membri 3 . A livello applicativo, le organizzazioni empowering presentano tre<br />
caratteristiche:<br />
- Sviluppo dell’autonomia operativa dei gruppi (self directed work teams<br />
o gruppi autogestiti);<br />
- Sviluppo dei gruppi in formazione, non solo per l’apprendimento ma<br />
anche per la risoluzione dei problemi e per l’innovazione;<br />
- Leader come facilitatore e stile di leadership teso a diffondere<br />
l’empowerment.<br />
L’associazione <strong>Wigwam</strong> si può collocare all’interno di questa categoria.<br />
Propone infatti al suo interno una cultura dell’empowerment, caratterizzata da:<br />
lavoro per progetti, team autodiretti (circoli di qualità), incentivi a favore della<br />
partecipazione, appropriazione del proprio lavoro (il soggetto ha la possibilità<br />
di realizzare una sua idea). Nella seconda parte dell’elaborato, saranno<br />
indagati alcuni degli aspetti sopra citati.<br />
3 In questa sede intendiamo per benessere organizzativo, sia lo stato soggettivo di coloro che lavorano<br />
in uno specifico contesto organizzativo, sia l’insieme di fattori che determinano o contribuiscono a<br />
determinare il benessere di chi lavora. (Avallone e Bonaretti, 2003).<br />
41
2.5 LA LEADERSHIP EMPOWERING<br />
Secondo Pearlstein (1991), è la leadership che incoraggia e consente di<br />
lavorare al massimo delle proprie possibilità, facendo sentire le persone capaci<br />
e autonome. Secondo Ripley e Ripley (1992), la leadership rafforza il proprio<br />
sentimento di autoefficacia e scoraggia i comportamenti passivi e non<br />
assertivi.<br />
Il “capo” empowering ha una concezione del potere di tipo integrativo, non<br />
pone se stesso al vertice del proprio gruppo: è un allenatore, un consulente nel<br />
senso che costruisce una relazione tale da riuscire ad aiutare l’altro a liberare<br />
tutta la sua intelligenza e creatività (Burdett, 1991). 4<br />
Il tema dell’apprendimento individuale e organizzativo, definito “management<br />
by learning”, attraversa tutti gli scritti sull’empowerment, evidenziando alcune<br />
caratteristiche che dovrebbero contraddistinguere il comportamento del leader:<br />
incoraggiare i propri collaboratori e identificare i loro bisogni formativi,<br />
fornire e richiedere feed-back, condividere informazioni, creare un clima di<br />
sperimentazione e ricerca, aiutare a vedere le opportunità di apprendimento,<br />
tollerare gli errori, incoraggiare discussioni, combinare riflessioni e azioni….<br />
E’ diffusa la consapevolezza della profonda rivoluzione mentale richiesta agli<br />
individui per creare un modello di leadership empowering. Il primo passo<br />
verso quest’attuazione è cominciare da se stessi. Secondo May e Kruger<br />
(1988), ci sono quattro principi che caratterizzano il primo passo verso<br />
l’empowerment di se stessi:<br />
1. Profonda conoscenza di sé: comprendere quali sono i modi con cui<br />
attribuiamo significati agli eventi. Secondo May e Kruger infatti, solo<br />
4 Anche in questo caso, esistono in letteratura numerosi contributi sul ruolo della leadership<br />
nell’empowerment, che per motivi di ampiezza non possono essere riportati. Si rimanda comunque ad<br />
alcuni contributi significativi come: Burke, 1996; May e Kruger, 1988; Vogt e Murrel, 1990;<br />
Srivastva e Cooperrider, 1990; Byham, 1990; Burdett, 1991; Pearlstein, 1991; Scott e Jaffe, 1991;<br />
Werner, 1992; Belasco e Stayer, 1994. Per una rassegna: Piccardo C., 1995.<br />
42
la chiarezza e l’esplicitazione dei propri schemi mentali di riferimento<br />
consente di padroneggiare gli eventi, soprattutto quelli problematici,<br />
massimizzando le opportunità da essi offerte.<br />
2. Integrità: percepirsi come completi e integrati (sia a livello mentale, che<br />
fisico e psicologico).<br />
3. Comunicazione efficace (attenzione e ascolto): porre profonda<br />
attenzione alle relazioni interpersonali e all’ascolto.<br />
4. Partnership: impegno individuale, nei confronti di se stessi equivalente<br />
all’impegno verso gli altri, volto a creare un ambiente egalitario, in cui<br />
ci si senta “pari”, soci, ugualmente contributori ai successi, ai risultati e<br />
alle responsabilità.<br />
L’empowerment per Block (1987), è un atto della leadership, un processo<br />
promosso dall’azione del leader che consente il passaggio da una cultura<br />
burocratica (che genera dipendenza), a una cultura che favorisce l’autonomia e<br />
l’assunzione di responsabilità rispetto a se stessi e all’organizzazione. Secondo<br />
Block (1987) un leader dovrebbe: credere di essere l’artefice della propria<br />
storia, incoraggiare l’espressività, assumere impegni, usare sempre un<br />
linguaggio concreto, creare compiti non parcellizzati ma dotati di un senso il<br />
più possibile globale.<br />
Un ultimo lavoro significativo che vorrei citare è quello proposto da Nielsen<br />
(1993), secondo cui la finalità di relazioni empowered è quella di accrescere la<br />
salute organizzativa insieme al benessere fisico e psichico degli individui che<br />
vi lavorano. Per l’autore quindi, empowerment è la costruzione di relazioni di<br />
partnership, ovvero di reciprocità e di mutuo vantaggio, di condivisione del<br />
potere e di responsabilità reciproca.<br />
Egli pone l’accento anche sul concetto di autostima, inteso come percezione<br />
del proprio valore nel lavoro. Si perviene al sentimento di autostima quando si<br />
43
porta a termine con soddisfazione un compito significativo, cioè importante<br />
per sé e per l’organizzazione. Per Nielsen, la maggior parte delle persone sul<br />
lavoro non soddisfa i bisogni collocabili ai livelli più alti della gerarchia dei<br />
bisogni, quelli che Herzberg (1959) definisce “bisogni motivatori” o desideri.<br />
In sin<strong>tesi</strong>, i valori della leadership empowering si traducono in specifici<br />
comportamenti, che possono essere così riassunti:<br />
- garantire la trasparenza;<br />
- promuovere la collaborazione;<br />
- delegare l’autorità;<br />
- gestire le prestazioni;<br />
- sviluppare le persone;<br />
- riconoscere i meriti;<br />
- comunicare efficacemente;<br />
- gestire i problemi;<br />
- incoraggiare l’innovazione.<br />
Tali comportamenti di base si manifesteranno in termini di sviluppo delle<br />
competenze, creazione del sentimento di essere importanti, spirito di gruppo e<br />
soddisfazione.<br />
2.6 GLI EMPOWERMENT WORK GROUP<br />
L’approccio organizzativo che si concentra sulla creazione di gruppi autonomi<br />
o semiautonomi (in genere chiamati empowered work groups, EWG), trae<br />
origine dai risultati degli studi del Tavistock Institute di Londra. L’idea di base<br />
era che i lavoratori fossero capaci di organizzare le attività del proprio gruppo<br />
di lavoro, e che consentire loro di farlo comportava un certo numero di<br />
vantaggi, sia a livello di efficienza che di salute psicologica del personale.<br />
44
Alla fine degli anni ’40, alcuni autori hanno contribuito in maniera<br />
significativa all’ introduzione di forme partecipative nell’ambiente lavorativo.<br />
Tra questi autori possiamo citare: Lewin (1972), Maslow (1954) e McGregor<br />
(1983) che cominciarono a promuovere modelli più partecipativi nei processi<br />
decisionali di gruppo. E’ importante sottolineare che i circoli di qualità, si<br />
basano sugli stessi modelli teorici e sugli stessi autori sopra citati; per questo<br />
motivo possono essere visti come una forma di EWG.<br />
Per Rothwell (1993), l’empowerment è l’esperienza di ownership e di<br />
controllo sul proprio lavoro, i gruppi di lavoro autonomi (EWG), consentono<br />
che il potere vada a tutti partecipanti, rendendoli in questo modo più<br />
responsabili. Tanto più sarà elevato il grado di empowerment tanto più sarà<br />
alto il livello di responsabilizzazione.<br />
I modelli di lavoro di gruppo derivano dall’incrocio di due dimensioni: la<br />
durata (permanente/temporaneo) e la struttura (formale/informale). Essi si<br />
distinguono in: gruppi di progetto, gruppi di lavoro, gruppi di “alleanza” e<br />
gruppi “network”.<br />
All’interno dell’associazione <strong>Wigwam</strong> sono utilizzati due modelli di lavoro di<br />
gruppo: i gruppi progetto e i gruppi di lavoro (nello specifico i circoli di<br />
qualità), entrambi, in concordanza con gli EWG, sono gruppi di lavoro<br />
formali, permanenti e autogestiti: pianificano autonomamente il loro lavoro,<br />
prendono decisioni e condividono la responsabilità della leadership, la cui<br />
funzione è prevalentemente di coordinamento e guida.<br />
I principi per il funzionamento degli EWG derivano dalla teoria sistemica<br />
dell’impresa (Trist, 1981), e si riferiscono alla metafora ologrammatica<br />
dell’organizzazione e sono:<br />
- Specificazione minima: deve esserci il minimo investimento possibile<br />
in definizione e formalizzazione di regole, ruoli e procedure.<br />
45
- Multifunzionalità: è importante che ogni membro del gruppo sia in<br />
grado di svolgere tutti i lavori eseguiti dagli altri membri del team.<br />
- Comunicazione aperta: deve esserci disponibilità per tutti di tutte le<br />
informazioni.<br />
- Coerenza dei sistemi di supporto: i sistemi di selezione, formazione e<br />
retributivi, devono essere di supporto e coerenti con il funzionamento<br />
di gruppo.<br />
- Evoluzione: è necessaria una continua verifica del modello di<br />
funzionamento di gruppo.<br />
Alcuni autori come Fisher (1992), sottolineano l’importanza del ruolo del<br />
leader nel creare e sostenere gli EWG. Egli infatti ha tre ruoli principali:<br />
1. Sostenere i bisogni degli individui per renderli capaci di svolgere<br />
efficacemente il proprio ruolo (il leader deve quindi insegnare, allenare<br />
ed essere un consulente).<br />
2. Stabilire e mantenere un ambiente che stimoli un efficiente<br />
funzionamento del team (il leader deve quindi stimolare la fiducia, il<br />
lavoro di gruppo e la collaborazione, la comunicazione aperta, la<br />
valorizzazione delle diversità).<br />
3. Assicurare l’appropriato posizionamento del team nel più ampio<br />
contesto organizzativo, integrando i risultati del gruppo con gli obiettivi<br />
e i valori globali dell’organizzazione.<br />
2.7 CONCLUSIONI<br />
Come già esplicitato all’inizio di questo capitolo, il termine empowerment è<br />
diventato negli ultimi anni un concetto “ombrello”, acquisendo la capacità di<br />
adattarsi a molte situazioni e contesti. E’ stato perciò necessario circoscrivere<br />
gli argomenti trattati, selezionando gli autori che maggiormente si interessano<br />
46
di empowerment organizzativo e associativo. In generale, le organizzazioni<br />
che hanno deciso di adottare questo approccio, presentano profili di grande<br />
dinamicità: in esse la lealtà, la simmetria, l’imparzialità, l’equilibrio e la<br />
condivisione, sono principi su cui si basa il processo di umanizzazione della<br />
struttura, che è considerato il punto di partenza per ottenere una maggiore<br />
efficacia.<br />
E’ stato inoltre dedicato ampio spazio al rapporto di integrazione e di<br />
interconnessione tra leadership empowering e gli Empowered Work Group,<br />
proprio perché questo aspetto riveste particolare importanza all’interno<br />
dell’associazione <strong>Wigwam</strong>. Attraverso la somministrazione dell’intervista<br />
(Cap. 6), si cercherà di comprendere meglio come l’associazione ha adattato e<br />
applicato i principi dell’empowerment alla propria realtà.<br />
L’associazione <strong>Wigwam</strong>, infatti, propone un modello di empowerment molto<br />
aderente alla definizione di empowerment di comunità fornita da Kiefer<br />
(1984), che enfatizza l’aspetto politico della consapevolezza e del potere: è<br />
empowered chi è in grado di esercitare un controllo sulla propria vita e,<br />
partecipando alle attività di organizzazioni e associazioni, acquisisce potere<br />
aumentando il proprio grado di consapevolezza sul sistema circostante. Egli<br />
considera l’empowerment come un processo tridimensionale, che include: lo<br />
sviluppo del senso di sé in rapporto con il mondo, la costruzione di una<br />
comprensione critica delle forze politiche e sociali che influiscono sulla<br />
propria quotidianità e l’elaborazione di strategie funzionali al raggiungimento<br />
di scopi e obiettivi personali e socio-politici, aspetti che verranno approfonditi<br />
nella seconda parte dell’elaborato.<br />
47
CAPITOLO 3: I CIRCOLI DI QUALITA’<br />
Da un punto di vista concettuale i circoli di qualità nascono in America negli<br />
anni ’50, nell’ambito della scuola organizzativa delle “relazioni umane”.<br />
A differenza che in Europa, in Giappone, erano presenti determinate<br />
condizioni culturali, che offrivano un terreno fertile perché si radicassero e si<br />
sviluppassero tecniche tendenti a coinvolgere ed informare i lavoratori, dando<br />
un maggior significato al lavoro svolto ed una migliore coscienza di<br />
partecipazione.<br />
Negli anni ’70, l’economia giapponese visse una fase di forte sviluppo; tra i<br />
meccanismi gestionali che hanno favorito questo successo possiamo<br />
individuare i circoli di qualità, che hanno permesso un miglioramento sia della<br />
produttività, sia dei rapporti verticali ed orizzontali all’interno di diversi tipi di<br />
organizzazioni e associazioni.<br />
I circoli di qualità si possono definire come un piccolo gruppo di persone,<br />
appartenenti alla stessa area lavorativa e con mansioni simili, che si riuniscono<br />
periodicamente e volontariamente sotto la guida di un coordinatore per<br />
imparare ad identificare ed analizzare i problemi legati al proprio lavoro, per<br />
proporre soluzioni, metterle in atto, verificandone e misurandone gli effetti.<br />
Non esiste un sistema di circoli di qualità unico e valido per una qualunque<br />
organizzazione. Essi in realtà non presentano nulla di rivoluzionario, ma fanno<br />
perno sulla valorizzazione della persona. I lavoratori possono proporre<br />
soluzioni a problemi specifici, migliorando in questo modo (come effetto<br />
indiretto) la produttività.<br />
I circoli di qualità permettono al lavoratore di portare dei contributi<br />
migliorativi proprio nelle aree in cui opera, e contribuiscono a rendere il suo<br />
ruolo più qualificante e motivante. In sin<strong>tesi</strong>, si può affermare che essi si<br />
49
pongono come una tappa per il raggiungimento di una gestione partecipativa<br />
dei lavoratori alle problematiche dell’azienda.<br />
In questa sede, quando parliamo di qualità ci riferiamo alla definizione data da<br />
JUSE (Union of Japanaise Scientists and Engineers, 1981), secondo cui “la<br />
qualità di un prodotto o di un servizio è la sua attitudine a soddisfare i bisogni<br />
degli utenti”. In questo senso, un’organizzazione orientata alla qualità dovrà<br />
affrontare sia il problema della qualità dei prodotti e dei servizi, sia il<br />
problema della qualità della vita sul lavoro. L’approccio di gestione della<br />
qualità è quindi innanzitutto un approccio alla responsabilizzazione e al<br />
coinvolgimento.<br />
Avere la qualità come obiettivo, significa sviluppare una logica di innovazione<br />
a tutti i livelli, e cercare di creare strutture generatrici di innovazione (come<br />
per esempio i circoli stessi). Essi infatti permettono di attuare un processo di<br />
innovazione e di miglioramento continuo orientato a quattro macro obiettivi,<br />
che verranno successivamente approfonditi nel corso del capitolo: migliorare<br />
la qualità dei prodotti e dei processi, migliorare la qualità di vita sul lavoro,<br />
migliorare la produttività e migliorare l’organizzazione del lavoro e i suoi<br />
metodi.<br />
Chi decide di utilizzare i circoli crede che questi obiettivi possano essere<br />
raggiunti principalmente sviluppando l’adesione, il coinvolgimento, la<br />
motivazione del personale, considerato il principale attore del cambiamento.<br />
Concludendo questa breve introduzione ai circoli, è importante sottolineare<br />
che sono uno strumento flessibile, che si può adattare a diverse realtà, non solo<br />
lavorative; infatti possono essere applicati anche all’interno di realtà non<br />
organizzative come le associazioni non profit. Nella seconda parte di questo<br />
elaborato, si valuterà come l’associazione <strong>Wigwam</strong> ha adottato questo<br />
50
approccio, e in che modo lo applica per renderlo maggiormente aderente alla<br />
propria realtà.<br />
3.1 VERSO UN MANAGEMENT PARTECIPATIVO<br />
Una delle caratteristiche principali dei circoli di qualità è quella di favorire la<br />
partecipazione. La teoria classica delle organizzazioni, il taylorismo, ha<br />
considerato per molto tempo la presenza delle persone soltanto per eseguire un<br />
compito, considerando già questo come una forma di partecipazione: “fare il<br />
proprio lavoro è partecipare”.<br />
I circoli di qualità propongono invece al lavoratore una modalità partecipativa<br />
che richiede una sua riflessione e un suo apporto personale volto a un<br />
miglioramento del lavoro e dell’organizzazione stessa. Si tratta di un<br />
approccio partecipativo, che può esistere solo se c’è adesione agli obiettivi, ai<br />
valori dell’organizzazione (o dell’associazione nel caso dei <strong>Wigwam</strong>) e alla<br />
cultura aziendale proposta.<br />
Alla base di questo processo vi sono la filosofia e le esperienze della scuola<br />
delle relazioni umane 5 , secondo cui è importante tenere conto dell’opinione<br />
del personale per modificare il funzionamento organizzativo, per migliorare<br />
l’efficienza, accrescere la produttività e aumentare la soddisfazione degli<br />
interessati.<br />
A partire dagli anni ’50, il concetto di management partecipativo è stato<br />
sviluppato cercando di cogliere le motivazioni dell’individuo sul lavoro.<br />
L’analisi dei bisogni, delle motivazioni, dei fattori che agiscono sulla<br />
soddisfazione lavorativa hanno portato allo sviluppo di importanti azioni di<br />
5 Non è obiettivo di questo elaborato fornire un quadro dettagliato delle varie teorie che hanno portato<br />
allo sviluppo di un approccio partecipativo, come per esempio quelle proposte da Elton Mayo negli<br />
anni ’30. L’obiettivo di questo paragrafo è quello di fornire alcune linee guida che permettano di<br />
comprendere meglio l’importanza della partecipazione per un buon funzionamento dei circoli di<br />
qualità, ecco perché alcuni importanti contributi (per esempio l’approccio umanistico di Mc Gragor o<br />
l’approccio produttivistico) non verranno approfonditi in questa sede.<br />
51
formazione e di numerose metodologie tra cui i circoli di qualità. In sin<strong>tesi</strong> si<br />
può affermare che il management partecipativo ha quattro macro obiettivi:<br />
a) Mobilitare il personale facendo appello alle sue capacità inutilizzate,<br />
per migliorare l’efficienza dell’organizzazione;<br />
b) Diminuire la resistenza ai cambiamenti partecipando il più possibile ai<br />
cambiamenti stessi. L’appropriazione (seppur parziale) dei<br />
cambiamenti ne faciliterà l’accettazione e porterà ad una diminuzione<br />
dei conflitti;<br />
c) Soddisfare uno dei bisogni fondamentali dell’uomo: il bisogno di<br />
completamento e di realizzazione di sé. Poter agire sul proprio lavoro<br />
porta ad un incremento della responsabilizzazione. La partecipazione<br />
mira perciò ad una migliore integrazione della persona con<br />
l’organizzazione; con il risultato di un miglior uso delle risorse creative<br />
e di sviluppo;<br />
d) Avvicinare gli obiettivi di ogni attore a quelli dell’organizzazione.<br />
Il management partecipativo propone una cultura organizzativa basata su uno<br />
stato d’animo di apertura verso gli altri, di messa in causa dei propri<br />
comportamenti. E’ un reale processo di crescita che va attuato attraverso lo<br />
sviluppo di una politica di educazione e di formazione.<br />
I vantaggi di una politica partecipativa si manifestano a diversi livelli:<br />
- Conseguenze per l’individuo: permette di sperimentare un vissuto di<br />
padronanza del proprio lavoro e una capacità di controllo sul proprio<br />
ambiente, di vivere un processo di apprendimento e di crescita<br />
culturale;<br />
- Conseguenze sull’organizzazione: il management partecipativo richiede<br />
un sistema informativo e di comunicazione particolarmente fluido<br />
basato su relazioni di fiducia tra i membri. Lo spirito di cooperazione<br />
52
che diffonde permette un’umanizzazione delle strutture che ha come<br />
conseguenza un effetto positivo sull’ambiente lavorativo; permettendo<br />
alla persona di vivere l’organizzazione come un valido supporto<br />
dell’azione e non come un ambiente ostile;<br />
- Conseguenze sul funzionamento e sulle relazioni: la partecipazione crea<br />
incontro, ascolto, spinge a considerare i limiti e gli obiettivi di ognuno;<br />
è un fattore fondamentale di miglioramento delle relazioni<br />
interprofessionali e tra gruppi, che porta ad un miglioramento<br />
dell’efficienza.<br />
Secondo Wegge (2000), esiste un duplice rapporto di causalità in una<br />
ricorrenza a feedback dalla modalità partecipatoria al benessere organizzativo,<br />
e dal benessere organizzativo alla modalità partecipatoria. I gruppi di lavoro<br />
autogestiti (come i circoli) promuovono la comunicazione, la coordinazione<br />
flessibile tra i membri, motivano all’innovazione e all’apprendimento.<br />
Secondo Wegge infatti, l’ottimale bilancio tra un’efficace<br />
autoregolamentazione e le richieste organizzative può essere, in linea di<br />
principio, ottenuto solo mediante l’impiego di tecniche partecipative. I<br />
processi motivazionali che fungono da motore per le attività organizzative si<br />
arricchiscono di complessità nella dimensione gruppale 6 . La partecipazione ha<br />
quindi il potere di ridurre l’ansia sociale e di migliorare la motivazione al<br />
lavoro: l’aumento dell’implicazione personale o commitment e il senso di<br />
identificazione con il gruppo, in una specie di forma collettiva di self efficacy<br />
(Wegge, 2000), ne rappresentano solo alcuni esempi.<br />
6 Nel gruppo infatti, le teorie sulla motivazione individuale si arricchiscono delle teorizzazioni<br />
“collettive” della motivazione. La teoria individualistica della motivazione al lavoro (Karau e<br />
Williams, 1993) secondo la quale la motivazione muove dall’edonistico appagamento dei bisogni<br />
dettati dall’interesse personale (in un bilancio di costi-benefici), nel gruppo interagisce con le teorie<br />
che fanno risalire il concetto di motivazione all’identità di appartenenza di gruppo (Bandura, 1996) e<br />
al sentimento di self che ne deriva, non semplicemente riconducibile a valutazioni di costi-benefici.<br />
53
3.2 LO SVILUPPO DEI CIRCOLI DI QUALITA’<br />
Nel periodo immediatamente seguente la seconda guerra mondiale, in<br />
Giappone fu fatto uno sforzo a livello nazionale per migliorare la qualità,<br />
ponendo particolare enfasi alla formazione sulle problematiche legate alla<br />
qualità dei prodotti ed alla sua gestione.<br />
In quegli anni, non solo il Giappone si interessava alle tecniche di gestione<br />
della qualità, ma la differenza rispetto ad altri paesi consisteva nei destinatari<br />
dei corsi. Nel mondo occidentale erano diretti agli specialisti, mentre in<br />
Giappone erano diretti a diversi livelli di lavoratori, tanto che nei primi anni<br />
’60, si decise di ricorrere alla radio nazionale per estendere a tutti il<br />
programma di formazione sui concetti della qualità. Gli scopi principali di<br />
questi corsi erano incoraggiare i lavoratori al miglioramento attraverso<br />
l’autosviluppo, aumentare il coinvolgimento contribuendo alla nascita di un<br />
ambiente nel quale ciascuna persona fosse cosciente ed attenta ai problemi<br />
della qualità e creare un nucleo d’azione che coinvolgesse tutta l’azienda per<br />
un miglioramento del controllo di qualità del prodotto.<br />
Il risultato fu lo sviluppo di circoli che includono la selezione dei problemi,<br />
l’analisi e la soluzione degli stessi. La diffusione di questa prassi lavorativa<br />
ebbe un forte sviluppo, tanto che dopo trent’anni dalla loro introduzione in<br />
Giappone erano registrati circa un milione di circoli di qualità.<br />
Il lavoro dei circoli, attraverso gli organi di coordinamento, tende ad essere<br />
coerente ed in sintonia con le politiche organizzative. Essi hanno contribuito al<br />
successo dei prodotti giapponesi nel mondo, ma il loro contributo a livello<br />
economico e di miglioramento della qualità non va sopravvalutato, ed è<br />
stimabile intorno al 10% del risultato globale.<br />
Il motivo principale del successo dei circoli in Giappone, sembra essere<br />
costituito dal notevole impegno individuale del lavoratore giapponese, e della<br />
54
particolare etica del lavoro secondo cui “l’azienda è vista come una famiglia”.<br />
Queste precisazioni non tolgono nulla all’innovazione introdotta dai circoli sui<br />
temi della cooperazione, partecipazione e sviluppo personale.<br />
Secondo una ricerca (Inumaru, 1985), in Giappone, la partecipazione ai circoli<br />
è spesso obbligatoria (86,74%), mentre solo nel 13,3% la partecipazione è su<br />
base volontaria.<br />
All’obbligatorietà della partecipazione corrisponde anche un maggior impegno<br />
da parte della direzione, che non solo è la promotrice delle attività, ma le<br />
segue con aiuti ed indicazioni “attive”. Uno dei maggiori ostacoli all’attività<br />
dei circoli in Giappone, sembra essere la formazione percepita dai lavoratori<br />
come insufficiente. Dalla stessa ricerca emerge che il rapporto costi benefici<br />
dei circoli di qualità è molto positivo e che i benefici maggiori sono quelli non<br />
monetari, come il miglioramento delle relazioni interpersonali e una maggiore<br />
consapevolezza dei problemi.<br />
3.3 LA DIFFUSIONE DEI CIRCOLI AL DI FUORI DEL GIAPPONE<br />
Inizialmente, si riteneva che la pratica dei circoli di qualità potesse diffondersi<br />
solamente in quei paesi affini alla cultura e allo spirito giapponese. Dopo oltre<br />
un ventennio dall’introduzione dei circoli in Giappone, quest’opinione si è<br />
rivelata errata; un grosso impulso alla diffusione a livello mondiale di questa<br />
pratica si ebbe nel momento in cui gli Stati Uniti iniziarono a sperimentare la<br />
tecnica e a diffonderla.<br />
Nonostante la peculiarità dei valori tradizionali giapponesi, ci si è resi conto<br />
che alla base dei circoli esistevano quattro grandi valori, che potevano essere<br />
“esportati” ed applicati anche in culture diverse da quella giapponese:<br />
l’appartenenza ad un gruppo, il lavoro d’equipe per prendere decisioni<br />
collettive su un dato tema, la ricerca di un miglioramento della qualità e<br />
55
l’attaccamento all’impresa inteso come volontà di agire per il bene della<br />
collettività.<br />
In Europa le prime notizie sui circoli arrivarono nel 1966 grazie a Juran;<br />
bisognerà però attendere la fine degli anni ’70 prima di vederne le prime<br />
applicazioni.<br />
In Italia i primi corsi sui circoli possono essere collocati intorno al 1972. 7 Le<br />
prime organizzazioni in cui i circoli sono stati applicati erano filiali italiane di<br />
aziende multinazionali che all’estero utilizzavano già questa metodologia. Si<br />
trattava in linea di massima di organizzazioni medio - grandi che non avevano<br />
il problema di aumentare la produzione, ma quello di recuperare la<br />
motivazione dei lavoratori. I tempi per l’avvio sono stati mediamente lunghi,<br />
un anno e mezzo circa; inoltre, nella maggior parte dei casi, si è presentato il<br />
problema di preparare la struttura ad un tipo di delega alla quale non era<br />
abituata. Va precisato che i circoli fanno leva sulla motivazione delle persone;<br />
i loro sforzi sarebbero vanificati se prima non venissero rimosse le cause<br />
strutturali che creano problemi alla qualità, esse, infatti, comprometterebbero<br />
il successo dei circoli. Questi interventi iniziali sono una condizione<br />
indispensabile e necessaria per l’adozione dei circoli.<br />
Complessivamente in Italia nel 1985 erano presenti circa 460 circoli di qualità<br />
(Galgano, 1985). Su 46 organizzazioni italiane che applicavano i circoli,<br />
emerge che la maggior parte (70%) opera in organizzazioni con oltre mille<br />
dipendenti. Nelle situazioni esaminate è stata riscontrata una buona adesione e<br />
disponibilità da parte della direzione aziendale. La maggior parte del<br />
campione si rivela soddisfatto del rapporto costi/benefici (stimato tra il 2 e<br />
4%). Inoltre al di là dei benefici economici sono sottolineati altri vantaggi,<br />
7 La Alberto Galgano e Associati è la prima società che ha organizzato in Italia corsi sui circoli di<br />
qualità nel 1972. Altri enti se ne sono interessati successivamente come Varvelli, 1973, Triverio,<br />
1981.<br />
56
come un miglioramento della qualità del lavoro, dei rapporti interpersonali,<br />
della motivazione, sia per i partecipanti che per l’organizzazione. Il 60% dei<br />
dipendenti non coinvolti direttamente mostra curiosità e desiderio di<br />
partecipazione. In, generale il motivo determinante che spinge le<br />
organizzazioni ad introdurre i circoli, è prima di tutto il desiderio di migliorare<br />
la qualità dei prodotti e di ridurre i costi, seguito da considerazioni di tipo<br />
socio-motivazionali, come lo sviluppo delle risorse umane e il miglioramento<br />
delle comunicazioni.<br />
La ricerca rileva inoltre una tendenza generale dei circoli a dare segni di<br />
cedimento dopo un certo periodo di attività (intorno ai quattro anni); a questa<br />
tendenza si può reagire per esempio ampliandone le responsabilità. Nelle<br />
organizzazioni esaminate, nel 44% dei casi i circoli si riunivano all’interno<br />
dell’orario lavorativo, nel 29% dei casi al di fuori dell’orario e nel restante<br />
27% dei casi le riunioni avvenivano con una modalità mista. Quando si<br />
riunivano fuori orario, nel 65% dei casi i membri erano retribuiti.<br />
L’attività è premiata nel 48% dei casi con dei piccoli premi in denaro o<br />
omaggi simbolici. La molla che però spinge i lavoratori a partecipare è più che<br />
altro psicologica: la gratificazione di far parte di un gruppo “vincente”, e la<br />
sensazione di svolgere un lavoro che ha un senso e un significato.<br />
Le riunioni dei circoli sono mediamente a cadenza settimanale, con una durata<br />
compresa tra i 60 e 90 minuti e con un tasso di presenza dell’88%.<br />
Si è approfondita questa ricerca proprio perché fornisce una fotografia reale<br />
del funzionamento dei circoli in Italia, mettendo in evidenza alcune<br />
caratteristiche che differenziano il modello europeo dal modello giapponese.<br />
57
3.4 I CONCETTI DI BASE<br />
Secondo Ishikawa (1984), massimo esponente giapponese dei circoli di qualità<br />
in Europa, essi si basano su tre idee principali:<br />
1. Contribuire al miglioramento e allo sviluppo dell’azienda;<br />
2. Rispettare la persona e costruire un ambiente di lavoro aperto e sereno<br />
dove il lavoro abbia un significato;<br />
3. Evidenziare tutte le capacità umane ed utilizzare al massimo le loro<br />
infinite potenzialità.<br />
Nella situazione italiana, non cambiano sostanzialmente i concetti alla base dei<br />
circoli. Si è visto infatti, che i meccanismi organizzativi di tipo esclusivamente<br />
procedurale possono creare problemi, perché vissuti come troppo lontani<br />
dall’esperienza. Il tema della qualità globale e le tecniche dei circoli di qualità,<br />
contribuiscono invece al coinvolgimento ed alla crescita degli individui.<br />
Secondo Bussini (1985), i circoli in Italia hanno permesso di sviluppare un<br />
processo di integrazione dei lavoratori ai valori organizzativi, e hanno<br />
permesso di portare l’attenzione ad uno stile di gestione più partecipativo,<br />
orientato alla qualità e disponibile a puntare sulle risorse umane.<br />
Il concetto di base dei circoli di qualità, nella realtà italiana, è l’integrazione<br />
tra l’istituzione e il personale; in questo processo, i circoli hanno avuto un<br />
importante ruolo, e hanno permesso di passare da un modello tayloristico di<br />
gestione del lavoro ad un modello partecipativo.<br />
I circoli nascono come operazione culturale, radicandosi su importanti teorie<br />
di gestione aziendale come la teoria dei bisogni di Maslow (1954), i metodi di<br />
menagement di McGragor (1983), il concetto di soddisfazione lavorativa di<br />
Herzberg (1959) e il controllo della qualità di Juran (1974).<br />
I circoli sono fondamentalmente sperimentazioni non di cambiamenti<br />
strutturali ma delle relazioni tra vertici organizzativi e personale. Queste si<br />
58
attuano in primo luogo attraverso un miglioramento del processo di<br />
comunicazione, del flusso informativo interno, e sono dirette a favorire<br />
l’integrazione dello sviluppo delle risorse umane e ad un più efficiente<br />
impiego del patrimonio di conoscenze disponibili. Per questi motivi i<br />
principali studiosi dei circoli di qualità in Italia sono concordi nell’affermare<br />
che, nella nostra realtà, essi si basano su tre principi:<br />
o Il lavoro di gruppo;<br />
o L’autocontrollo: non inteso in senso passivo di autoverifica, ma in<br />
senso attivo di miglioramento del prodotto e del processo. Il principio<br />
dell’autocontrollo si basa sul recupero della motivazione dell’operatore,<br />
in particolare nell’ambito del lavoro di gruppo, attuato attraverso una<br />
ricomposizione del lavoro che porti ad una responsabilizzazione sulla<br />
qualità del proprio lavoro;<br />
o L’integrazione: con l’introduzione di concetti come la garanzia della<br />
qualità, diventa sempre più necessaria l’integrazione di tutti gli attori<br />
sull’efficacia del prodotto. In particolare i circoli di qualità rientrano tra<br />
le strategie che permettono di creare numerosi rapporti laterali,<br />
ottenendo così un aumento della capacità di trattamento delle<br />
informazioni.<br />
3.5 L’AVVIO E LE METODOLOGIE DEI CIRCOLI DI QUALITA’<br />
La nascita e i primi sviluppi costituiscono per i circoli di qualità un momento<br />
particolarmente delicato, è perciò importante prendere una serie di precauzioni<br />
per permetterne una crescita corretta. Si tratta innanzitutto di definire<br />
opportunamente e <strong>chiara</strong>mente gli obiettivi che si intendono perseguire con<br />
questa attività (esistono infatti delle forti connessioni tra obiettivi e<br />
metodologia di intervento). Va inoltre specificato che la fattibilità dei circoli<br />
59
va determinata all’interno di ogni specifica realtà organizzativa, molto spesso<br />
infatti, le organizzazioni avviano i circoli senza aver svolto uno studio formale<br />
di fattibilità. Da una ricerca svolta da Bussini (1985), emerge che le<br />
organizzazioni attraverso l’introduzione dei circoli perseguono tre tipi di<br />
obiettivi: il primo è il miglioramento della qualità (linea tecnica), il secondo è<br />
il miglioramento del clima organizzativo (linea sociale), il terzo è la riduzione<br />
dei costi (linea economica). Dall’analisi dei dati emerge inoltre che gli<br />
obiettivi di tipo “sociale” abbiano un peso pari a quello degli obiettivi tecnici<br />
ed economici.<br />
I circoli possono essere utilizzati correttamente per diversi scopi. L’obiettivo<br />
che si desidera raggiungere determina abbastanza precisamente come si<br />
dovrebbe affrontare il programma e soprattutto definisce come va presentato il<br />
programma ai partecipanti. Secondo King e Tan (1986), prima dell’avvio è<br />
importante:<br />
- Stabilire perché si vogliono introdurre i circoli: il successo o<br />
l’insuccesso degli stessi può essere strettamente collegato ai motivi<br />
dell’introduzione;<br />
- Provarli su se stessi: partecipando direttamente ad un circolo come<br />
membro prima di gestirlo;<br />
- Gestire le aspettative, incluse le proprie;<br />
- Indicare <strong>chiara</strong>mente i limiti del programma: è opportuno che coloro<br />
che hanno introdotto i circoli controllino periodicamente l’avanzamento<br />
del programma, e prendano eventuali decisioni di interruzione.<br />
In Figura 1, sono rappresentate le tappe essenziali del processo di attuazione<br />
dei circoli di qualità. Si tratta di uno schema generico che va adattato ad ogni<br />
specifica situazione.<br />
60
Un ulteriore fattore di successo dei circoli, necessario anche se non sufficiente,<br />
è una buona formazione dei partecipanti. La formazione deve orientare il<br />
personale a due grandi obiettivi: l’innovazione e la partecipazione. Per questo<br />
oltre ad una formazione specifica sui circoli di qualità e il lavoro in gruppo, è<br />
importante introdurre corsi che si occupino delle metodologie e delle tecniche<br />
che possano permettere ai partecipanti di raggiungere gli obiettivi che si sono<br />
prefissi.<br />
Esistono in generale tre livelli importanti che la formazione deve affrontare<br />
per un buon successo dei circoli:<br />
1. Formazione orientata alla sensibilizzazione e all’informazione delle<br />
attività e problematiche dei circoli. L’obiettivo è informare e far<br />
prendere coscienza ai partecipanti dei fattori evolutivi collegati ai<br />
circoli;<br />
2. Formazione sui concetti della qualità totale;<br />
3. Addestramento sulle metodologie della risoluzione dei problemi:<br />
brainstorming, diagrammi causa – effetto o di Ishikawa, analisi ABC,<br />
istogrammi, carte di controllo, studio di casi, piani di campionamento,<br />
albero dei difetti, analisi delle modalità, diagramma di flusso o flow –<br />
chart, analisi di correlazione… Si tratta di un aiuto metodologico che<br />
fornisce ai partecipanti un sostegno concreto per il raggiungimento<br />
degli obiettivi.<br />
61
fig. 1: Processo di attuazione dei circoli di qualità<br />
Azioni di<br />
informazione e di<br />
sensibilizzazione<br />
Azioni di<br />
preparazione<br />
Pre-studio: analisi<br />
preliminare, progetto<br />
d’impresa<br />
Diagnosi<br />
preliminare<br />
Decisione di<br />
avviamento<br />
Elaborazione della<br />
struttura: circolo,<br />
comitato guida<br />
animatori<br />
Formazione degli<br />
animatori<br />
62<br />
Azioni di formazione<br />
per la direzione<br />
Identificazione dei<br />
settori pilota<br />
Gruppi di lavoro Preparazione Formazioni degli<br />
degli strumenti animatori<br />
Identificazione dei<br />
volontari<br />
Formazione dei<br />
membri<br />
Apertura dei primi<br />
circoli pilota<br />
Informazione<br />
del personale
3.6 L’ORGANIZZAZIONE DEI CIRCOLI<br />
I circoli sono costituiti da un piccolo gruppo di persone, che svolgono un<br />
lavoro simile, e si incontrano regolarmente su base volontaria per identificare i<br />
problemi, analizzarne le cause e proporre soluzioni. Generalmente si tratta di<br />
problemi che si incontrano nel lavoro quotidiano.<br />
Lo stimolo principale al raggiungimento di buoni risultati da parte dei circoli è<br />
costituito dall’impegno individuale, questo è maggiormente facilitato nella<br />
società giapponese per la loro particolare etica del lavoro.<br />
Il numero dei membri di un circolo è variabile, ma generalmente rientra in un<br />
numero compreso tra i 4 e i 15 partecipanti. La maggior parte delle<br />
organizzazioni utilizza un approccio puramente volontario di partecipazione.<br />
Le riunioni possono avvenire fuori o durante l’orario di lavoro; durano circa<br />
una o due ore e hanno una frequenza regolare (settimanale o bisettimanale).<br />
Nell’ambito delle riunioni del circolo vengono utilizzate delle specifiche<br />
metodologie, che i lavoratori hanno appreso nella fase di formazione. Spesso,<br />
per problemi più complessi, è richiesto il supporto di un consulente<br />
specializzato.<br />
I problemi affrontati sono di solito collegati al microcosmo operativo dei<br />
partecipanti. Generalmente ci si concentra sui problemi della qualità collegati<br />
al proprio lavoro; è importante che i problemi siano ben circoscritti<br />
(dovrebbero essere inquadrabili e risolvibili in un arco di tempo compreso tra i<br />
tre e i dodici mesi).<br />
I problemi maggiormente affrontati dai circoli, riguardano soprattutto<br />
l’efficienza e l’economicità, ci sono casi però in cui i problemi affrontati<br />
riguardano la sicurezza del lavoratore, le condizioni ambientali e di salute. Per<br />
i membri del circolo, quest’attività è un modo per far nascere stimoli ed<br />
interessi, per imparare e partecipare. Tutto ciò si traduce per il lavoratore in<br />
63
una maggiore autonomia, libertà di pensiero ed azione, ma soprattutto in una<br />
maggiore possibilità di realizzazione. I circoli, infatti, non sono discussioni<br />
guidate, anzi il valore dell’attività deriva proprio dalla capacità che ciascun<br />
partecipante ha di esprimere liberamente le proprie idee e creatività. Le fasi<br />
fondamentali che caratterizzano il lavoro di un circolo sono sette:<br />
1. Fase preliminare: i membri identificano e definiscono i problemi da<br />
risolvere, in alcuni casi sono gli animatori a proporli, si stabilisce anche<br />
il periodo di tempo per la risoluzione.<br />
2. Fase di preparazione: il gruppo fissa un obiettivo di miglioramento e<br />
cerca di quantificarlo. Si definisce un programma dettagliato di lavoro<br />
per la risoluzione del problema.<br />
3. Fase di informazione: si effettuano studi per inquadrare e definire<br />
esattamente lo stato attuale del problema. In questa fase è<br />
indispensabile l’uso di metodologie statistiche (può essere necessario<br />
contattare un consulente). Si cerca di raccogliere tutti i dati disponibili<br />
in modo da porre tutti i membri su uno stesso piano di conoscenza.<br />
4. Fase di analisi: il circolo propone delle soluzioni efficaci. Utilizza<br />
tecniche per la risoluzione dei problemi. Si lavora in gruppo,<br />
valorizzando l’apporto di esperienze e conoscenze diverse.<br />
5. Fase di valutazione: vengono selezionate le proposte generate nella<br />
fase precedente.<br />
6. Fase di sviluppo: si realizzano e sperimentano le idee migliori.<br />
7. Fase di presentazione e di realizzazione: alcuni lavori vengono<br />
selezionati e presentati alla direzione che ne decide la realizzazione.<br />
In Figura 2, sono rappresentate schematicamente le varie fasi di risoluzione<br />
dei problemi adottate dai circoli di qualità.<br />
64
Un ultima precisazione sull’organizzazione dei circoli va fatta relativamente<br />
all’importanza che hanno i coordinatori ed animatori del circolo. Essi, spesso<br />
diretti superiori dei membri del circolo, devono avere una notevole capacità di<br />
relazione con tutti i membri; anche se tutte le parti coinvolte hanno un ruolo<br />
fondamentale per un buon funzionamento del circolo (comitato guida,<br />
coordinatori, membri, consulenti, posizione organizzativa..).<br />
65
Figura 2: Approccio risolutivo dei problemi adottato dai circoli di qualità<br />
Fase preliminare<br />
e di preparazione<br />
Politiche e obiettivi<br />
organizzativi<br />
Sperimentazi<br />
one e verifica<br />
Fase di<br />
informazione e di<br />
analisi<br />
Fase di<br />
valutazione<br />
Fase di sviluppo,<br />
presentazione e<br />
realizzazione<br />
Piano di<br />
lavoro<br />
Formulazione del problema,<br />
Localizzazione, identificazione<br />
e analisi. Relazioni con<br />
l’ambiente esterno.<br />
DIAGNOSI<br />
Ricerca ed elaborazione delle<br />
possibili soluzioni<br />
ANALISI<br />
delle soluzioni<br />
SCELTA<br />
ESECUZIONE<br />
DELLA<br />
DECISIONE<br />
CONTROLLO<br />
66<br />
Metodologia e strumenti<br />
di analisi.<br />
Innovazione e<br />
creatività<br />
Metodologia<br />
e strumenti<br />
Misurazione dei<br />
risultati
3.7 I BENEFICI<br />
L’introduzione dei circoli richiede almeno tre anni, prima che possa dare<br />
risultati apprezzabili. I tempi lunghi sono legati sia alla progettazione del<br />
modello, sia al cambiamento nello stile di gestione. I benefici connessi con la<br />
loro introduzione rientrano in due grosse categorie: il miglioramento dei<br />
rapporti tra i lavoratori e l’organizzazione e i risparmi quantitativi derivati dai<br />
progetti, anche se gli ultimi non sono in genere particolarmente rilevanti. Ma i<br />
circoli di qualità, se ben gestiti possono contribuire in maniera significativa al<br />
miglioramento del clima organizzativo. Un clima maggiormente partecipativo,<br />
infatti, può creare nell’organizzazione quella flessibilità e coesione che sono le<br />
radici per un miglioramento ben più significativo.<br />
A fronte di questi benefici, i circoli presentano anche dei rischi, se infatti, i<br />
suggerimenti dei membri del circolo non vengono utilizzati si può generare un<br />
meccanismo perverso, che alimenta un sentimento di scetticismo nella<br />
possibilità di un miglioramento concreto.<br />
I circoli tendono ad utilizzare tutte le capacità individuali, migliorando le<br />
relazioni tra i singoli individui, e permettendo di costruire rapporti più<br />
costruttivi con l’organizzazione. I benefici possono essere così sintetizzati:<br />
1. Migliorano i rapporti dei singoli individui con l’organizzazione: si<br />
richiede la partecipazione di tutti per migliorare la situazione esistente e<br />
a tutti è riconosciuta la capacità di proporre cambiamenti;<br />
2. Riducono la conflittualità nell’ambiente di lavoro, portando ad un<br />
miglioramento generale delle relazioni interpersonali;<br />
3. Aiutano i lavoratori a comprendere i motivi per cui molti problemi non<br />
possono essere risolti velocemente;<br />
67
4. Coinvolgono i lavoratori più attivamente nel proprio lavoro spingendoli<br />
a ricercare occasioni di miglioramento, e permettendo a tutti di<br />
influenzare il proprio lavoro;<br />
5. Migliorano la comunicazione verticale trasferendola sul piano del<br />
miglioramento piuttosto che su quello della trasmissione di ordini;<br />
6. Migliorano la qualità dei prodotti.<br />
3.8 CONCLUSIONI<br />
Il risultato potenzialmente più interessante dei circoli di qualità, è la creazione<br />
di un dialogo continuo tra i lavoratori e l’organizzazione su problemi di<br />
interesse comune. Questo porta ad un maggior coinvolgimento personale, ad<br />
un aumento del senso di appartenenza, ad una migliore conoscenza del proprio<br />
lavoro, ad una crescita del grado di soddisfazione professionale e ad un<br />
miglioramento generale delle prestazioni di gruppo. Si tratta prevalentemente<br />
di argomentazioni sul piano motivazionale, ma questo ben si accorda con la<br />
filosofia dei circoli: ottenere un miglioramento della qualità dei prodotti e<br />
dell’ambiente lavorativo, partendo dall’ipo<strong>tesi</strong> che l’ambiente condiziona<br />
fortemente i risultati dei processi e delle attività che si svolgono.<br />
La filosofia dei circoli di qualità è fondata sulla fiducia, sul rispetto delle<br />
persone. Considerare l’altro, ammettere la sua volontà d’identità<br />
nell’organizzazione, la sua esigenza di esistere e di realizzarsi, significa<br />
proporre un’attività lavorativa di più ampio respiro che concilia efficienza<br />
economica e progresso sociale.<br />
Va evidenziato che il materiale più recente trovato in letteratura risale ai primi<br />
anni novanta. E’ naturale e corretto che con il tempo, cambiando le esigenze,<br />
altre tecniche e metodologie acquistino maggiore rilevanza, perciò quelle<br />
passate tendono a scomparire negli articoli di ricerca. I circoli, grazie al loro<br />
68
potenziale innovativo, hanno permesso la creazione di molte tecniche<br />
partecipative basate sul lavoro di gruppo e sulla responsabilizzazione della<br />
persona; essi dunque non sono scomparsi, ma hanno subito un’evoluzione a<br />
livello applicativo in forme gestionali simili ma meno rigide. Esiste inoltre un<br />
naturale processo storico, per cui vi è un continuo affinamento delle tecniche e<br />
delle metodologie, grazie all’accrescere di esperienze e di conoscenze. Un<br />
esempio è il modello PGGS (Partecipative Group Goal Setting), proposto da<br />
Wegge (2000). Si tratta di un modello per il lavoro di gruppo basato su una<br />
modalità partecipatoria, che ha molti aspetti in comune con i circoli di qualità.<br />
Un’ulteriore carenza va sottolineata relativamente alla mancanza di follow-up<br />
sui circoli di qualità. Nonostante in letteratura i circoli di qualità vengano<br />
considerati un concetto superato, nella realtà concreta esistono comunque<br />
applicazioni recenti di questa metodologia: ad esempio in ambito scolastico e<br />
ospedaliero 8 .<br />
L’esempio più significativo a riguardo è l’applicazione dei circoli a partire dal<br />
2003 del Psn (piano statistico nazionale). L’Istat ha deciso di utilizzare i<br />
circoli per monitorare il programma statistico nazionale, creando gruppi di<br />
lavoro permanenti che lavoreranno a diversi progetti fino al 2005.<br />
Si è cercato in questo capitolo di fornire una panoramica ampia sui circoli di<br />
qualità, mettendone in evidenza i vantaggi, le problematiche e le applicazioni<br />
più recenti, nonostante la carenza di ricerche a riguardo negli ultimi anni. Le<br />
caratteristiche dei circoli di qualità presenti all’interno dell’associazione<br />
<strong>Wigwam</strong>, verranno indagate successivamente attraverso un’apposita sezione<br />
presente all’interno dell’intervista (capitolo 4).<br />
8 Ne sono un esempio i circoli di qualità friburghesi, recentemente adottati in Svizzera, in cui medici e<br />
farmacisti si riuniscono regolarmente per coordinare in modo migliore i servizi sanitari offerti e per<br />
conseguire un risparmio sulle prescrizioni dei farmaci. Tramite questo circolo e con la collaborazione<br />
dei pazienti, nel cantone Friburgo si è conseguito un risparmio di circa 40000 franchi all’anno per<br />
studio medico. Si tratta ancora di un esperimento pilota che però, per il suo successo verrà presto<br />
imitato in tutta la Svizzera.<br />
69
SECONDA PARTE<br />
71
CAPITOLO 4: L’INTERVISTA<br />
Da un colloquio preliminare con il presidente dell’associazione <strong>Wigwam</strong>, è<br />
emerso che questa ha la struttura di una rete sociale, e cerca di applicare al suo<br />
interno alcuni principi teorici come i circoli di qualità e l’empowerment.<br />
Si è deciso di somministrare uno strumento qualitativo a soci che svolgono un<br />
ruolo attivo all’interno dell’associazione, sia come operatori, sia come<br />
presidenti di un club di progetto. Questa scelta è stata fatta ipotizzando che le<br />
persone, che hanno proposto e realizzato un progetto, abbiano un maggior<br />
investimento emotivo e temporale nei confronti dell’associazione, e che,<br />
proprio per questo, ne conoscano meglio i meccanismi e le dinamiche.<br />
In sin<strong>tesi</strong>, l’intervista si pone l’obiettivo di indagare le seguenti aree:<br />
4. Altro:<br />
- Principi e valori guida<br />
- Punti di forza e di<br />
debolezza<br />
1. Caratteristiche del<br />
progetto<br />
ASSOCIAZIONE<br />
WIGWAM<br />
3. Applicazione dei<br />
principi<br />
dell’empowerment<br />
73<br />
2. Applicazione dei<br />
circoli di qualità<br />
Macro obiettivo<br />
comune: fare in modo<br />
che le persone si<br />
assumano la<br />
responsabilità del<br />
progredire e dei risultati<br />
del proprio lavoro.
Lo strumento è stato costruito appositamente per lo studio delle caratteristiche<br />
dell’associazione <strong>Wigwam</strong>, ed è composto da venticinque domande aperte<br />
(Appendice A).<br />
Molti autori (Zammuner, 1998) sottolineano che domande troppo generali, sono<br />
maggiormente soggette a distorsioni innescate da fattori contestuali, ed inoltre<br />
producono risposte generalmente poco informative e poco predittive del<br />
comportamento effettivamente messo in atto dal soggetto.<br />
Nello specifico, lo strumento è caratterizzato da:<br />
1. Modalità di somministrazione faccia a faccia: intervistatore e intervistato<br />
sono compresenti in uno stesso spazio fisico; entrambi gli attori, possono<br />
contare su due canali comunicativi: quello uditivo e quello visivo.<br />
2. Domande aperte: tutte le domande sono completamente predefinite, sia per<br />
quanto riguarda la formulazione linguistica che l’ordine di somministrazione.<br />
Questa scelta, rende i ruoli dei partecipanti abbastanza rigidi e ben definiti.<br />
Per verificare la chiarezza delle domande e il tempo necessario alla<br />
somministrazione, è stato chiesto ad otto persone di immaginarsi membri di<br />
un’associazione non profit, e di rispondere alle domande.<br />
Questa fase ha permesso di capire che l’intera somministrazione richiede circa venti<br />
minuti, e soprattutto ha portato alla modifica di alcune domande che si sono rivelate<br />
inadeguate, sia per chiarezza che per lunghezza.<br />
Le interviste sono state somministrate a ventuno soggetti e audioregistrate.<br />
74
4.1 DESCRIZIONE DELL’INTERVISTA<br />
La prima parte dello strumento (item 1-9), ha lo scopo di raccogliere alcune<br />
informazioni relative al progetto che il soggetto ha attuato o a cui partecipa. Queste<br />
informazioni permetteranno di formulare delle ipo<strong>tesi</strong> sulla presenza di un<br />
denominatore comune ai vari progetti, di comprendere meglio come il soggetto ha<br />
conosciuto l’associazione e le motivazioni che lo spingono a continuare.<br />
Si tratta di una parte introduttiva, che consente al soggetto di raccontarsi e offre<br />
l’opportunità di prendere confidenza con lo strumento:<br />
1. Com’è nato il suo progetto?<br />
2. Qual’ è l’obiettivo generale del suo progetto?<br />
3. Chi sono i beneficiari?<br />
4. Quale tipo di supporto le ha offerto l’associazione per la realizzazione del suo<br />
progetto (aiuto economico, sostegno, informazioni pratiche…)?<br />
5. Secondo lei quali sono gli aspetti più importanti di cui tiene conto<br />
l’organizzazione quando qualcuno propone un progetto?<br />
6. Da quanto tempo svolge attività in questa associazione?<br />
7. Quante ore effettive alla settimana dedica ad attività che riguardano<br />
l’associazione?<br />
8. Com’è entrato a far parte di questa associazione?<br />
9. Perché rimane all’interno di quest’associazione?<br />
L’intervista ha come secondo obiettivo quello di verificare se all’interno dei<br />
diversi club <strong>Wigwam</strong> vengano applicati i circoli di qualità. Le domande<br />
pertanto indagheranno le principali caratteristiche che contraddistinguono i<br />
circoli (Cap. 3):<br />
10. Quali sono i problemi principali che dovete affrontare all’interno del<br />
vostro circolo?<br />
11. All’interno del vostro circolo effettuate degli incontri periodici per<br />
discutere e risolvere i problemi? Se si: Con quale frequenza?<br />
75
12. Indicativamente quante persone partecipano a questi incontri?<br />
13. Esiste una persona incaricata di coordinare, gestire queste riunioni? Se si,<br />
chi è?<br />
14. Le persone che partecipano alle riunioni, lo fanno volontariamente o la<br />
partecipazione è obbligatoria?<br />
15. Da chi e in che modo vengono scelti i problemi da analizzare nei vari<br />
incontri?<br />
16. Secondo lei l’associazione fornisce sufficienti possibilità di formazione per<br />
i soci?<br />
17. Sono previsti compensi o riconoscimenti per chi partecipa a questi<br />
incontri?<br />
Il terzo obiettivo dello strumento è verificare se all’interno dell’associazione<br />
<strong>Wigwam</strong> vengano effettivamente applicati i principi dell’empowerment.<br />
Considerando l’ampiezza della letteratura è stato necessario circoscrivere il<br />
concetto, e si è deciso di fare riferimento al modello teorico proposto da<br />
Bruscaglioni (2003, Cap. 2).<br />
Nell’intervista qui proposta, gli aspetti relativi all’empowerment vengono<br />
indagati dai seguenti item:<br />
18. Secondo lei l’associazione si avvale e prende in considerazione le idee che<br />
vengono dai suoi soci?<br />
19. Lei sente di poter influenzare l’andamento dell’organizzazione?<br />
20. All’interno dell’associazione come è gestito il potere?<br />
Va precisato, che molti aspetti relativi all’empowerment si sovrappongono ai<br />
concetti indagati nella sezione relativa ai circoli di qualità (per esempio il<br />
lavoro di gruppo, l’importanza della formazione e la modalità con cui vengono<br />
affrontati i problemi).<br />
76
L’ultima sezione dell’ intervista ha lo scopo di raccogliere diverse<br />
informazioni relative a:<br />
a. I principi e i valori guida dell’associazione, il grado di identificazione<br />
personale del soggetto con essi e cosa intende il soggetto per qualità di vita.<br />
21. Secondo lei quali sono i principi guida di questa associazione?<br />
22. All’interno di questa associazione, ci sono valori in cui si identifica in<br />
prima persona?<br />
23. Cosa intende lei per qualità di vita?<br />
b. Informazioni sui punti di forza e di debolezza dell’associazione secondo il<br />
soggetto.<br />
24. Secondo lei quali sono i punti di forza di questa associazione?<br />
25. Secondo lei quali sono gli aspetti in cui l’associazione dovrebbe<br />
migliorare?<br />
Tutte le interviste sono state analizzate attraverso il software statistico SPADt,<br />
basandosi sul modello dell’analisi di contenuto e più specificatamente<br />
sull’analisi delle corrispondenze lessicali, che verranno esposte nei paragrafi<br />
successivi. L’analisi del discorso collettivo, infatti, è uno dei metodi utilizzati<br />
per lo studio delle reti sociali (Besson, 1992); attraverso l’analisi del contenuto<br />
è possibile scoprire le parole chiave, i discorsi collettivi e la cultura espressa<br />
dai diversi ambiti della rete.<br />
77
4.2 L’ANALISI DEL CONTENUTO<br />
L’analisi del contenuto è una tecnica di analisi di messaggi comunicativi che<br />
consente di scomporre qualunque tipo di messaggio in elementi costitutivi più<br />
semplici (Amaturo, 1993). Di questa tecnica, il cui primo esempio viene<br />
solitamente identificato in un’analisi di tipo quantitativo effettuata su una<br />
raccolta di inni religiosi in Svezia nel XVII secolo, sono state date diverse<br />
definizioni, anche in relazione allo sviluppo avuto dalla tecnica stessa nel<br />
corso del tempo.<br />
A partire dagli anni ’60, all’analisi manuale viene affiancata quella fatta<br />
attraverso il computer, che consente di semplificare gli aspetti quantitativi<br />
della ricerca e di gestire una maggiore quantità di dati, anche se questo non<br />
risolve i problemi teorici e metodologici, che restano invece legati alla<br />
necessità di una buona integrazione tra teoria ed empiria (Losito, 1993). Oggi<br />
l’analisi del contenuto può essere definita come “un insieme di metodi che<br />
sono orientati al controllo di determinate ipo<strong>tesi</strong> su fatti di comunicazione<br />
(emittenti, messaggi, destinatari e loro relazioni) e che, a tale scopo, utilizzano<br />
procedure di scomposizione analitica a destinazione statistica, di testi e di altri<br />
insiemi simbolici” (Amaturo, 1993, p. 31). Da questa definizione, si vede<br />
come l’analisi del contenuto sia finalizzata non a cogliere il significato più<br />
profondo e ultimo della comunicazione, ma semplicemente a cercare, nel<br />
materiale analizzato, la risposta agli interrogativi posti dalla ricerca,<br />
selezionando le parti rilevanti rispetto alle ipo<strong>tesi</strong> fatte, per cui l’inferenza<br />
deve rimanere vincolata al messaggio stesso e al contesto di dati in cui questo<br />
si trova. Oggi la consapevolezza che i messaggi non hanno un solo significato<br />
non è più qualcosa di paralizzante nell’analisi del contenuto, anzi, spinge a<br />
tenere maggiormente in considerazione il contesto all’interno del quale i dati<br />
vengono prodotti e l’inevitabile intervento del ricercatore nelle diverse fasi di<br />
78
analisi 9 . L’analisi del contenuto si struttura come un processo di acquisizione,<br />
sin<strong>tesi</strong> e restituzione delle informazioni che fanno parte di una comunicazione,<br />
tutte operazioni che finiscono inevitabilmente per essere influenzate dalla<br />
discrezionalità del ricercatore, che sceglie quali informazioni prendere in<br />
considerazione e a partire da quale teoria leggere i risultati. L’analisi del<br />
contenuto finisce per diventare un metodo nel quale le scelte del ricercatore<br />
sono il vero punto di forza, e non un punto debole (Tuzzi, 2003) nel momento<br />
in cui egli è in grado di giustificare il percorso di acquisizione delle<br />
informazioni, le scelte fatte nell’organizzazione del testo e la restituzione dei<br />
risultati ottenuti.<br />
A partire da questi presupposti, anche la contrapposizione tra l’uso di metodi<br />
quantitativi e qualitativi si ridimensiona, in quanto le due forme di ricerca si<br />
trovano a coesistere. Se da una parte, sia lo scopo, cioè la possibilità di<br />
generare inferenze valide e replicabili, sia i metodi utilizzati, cioè metodi ed<br />
analisi statistiche, restano prettamente quantitativi, dall’altra parte, l’oggetto di<br />
studio, cioè il linguaggio e la comunicazione, rimangono inevitabilmente sul<br />
versante qualitativo (Tuzzi, 2003). Ciò che viene computerizzato è l’aspetto<br />
meccanico, ma l’uso che viene fatto dei risultati rimane ad un livello<br />
qualitativo e l’analisi è comunque parzialmente influenzata dalla<br />
discrezionalità del ricercatore. Fondamentale è quindi la costante attenzione ed<br />
aderenza al tipo di ricerca che si intende svolgere e ai suoi presupposti teorici.<br />
9 A questo proposito, si può osservare che Perez-Amat individua come progenitori dell’analisi del<br />
contenuto la retorica, la logica e l’ermeneutica (Tuzzi, 2003), antenata quest’ultima che<br />
inevitabilmente rimanda ad una dimensione di discrezionalità e di interpretazione soggettiva, ma<br />
comunque valida, del messaggio.<br />
79
4.3 L’APPLICAZIONE DELL’ANALISI DEL CONTENUTO<br />
Per quel che riguarda il processo di analisi del contenuto, questo si divide<br />
essenzialmente in tre fasi: la scelta dell’unità statistica di analisi, cioè la<br />
porzione più piccola in cui si scompone il corpus 10 ; la scelta della variabile e<br />
delle sue modalità; la scelta del criterio di organizzazione del corpus, cioè il<br />
modo in cui i vari testi che lo compongono vengono organizzati.<br />
La scelta dell’unità di analisi è una delle questioni centrali. In seguito<br />
all’avvento dell’uso del computer e quindi delle procedure di codifica<br />
automatica, l’unità di analisi che viene utilizzata è la forma grafica, cioè una<br />
sequenza di caratteri appartenenti all’alfabeto della lingua, delimitata da due<br />
separatori (Tuzzi, 2003), in genere gli spazi bianchi o i segni di interpunzione.<br />
La codifica operata in questo modo porta con sé alcuni svantaggi, in quanto<br />
non consente di distinguere tra loro forme che potrebbero essere ambigue,<br />
perde i riferimenti al contesto, e non tiene conto dei casi in cui le parole<br />
acquistano un senso diverso se unite ai termini a loro contigui. Per ovviare a<br />
questo problema è possibile trasformare le singole parole in lemmi, dove per<br />
“lemma” si intende la forma canonica della parola, così come è contenuta nel<br />
dizionario della lingua (Bolasco, 1995). Nonostante questo accorgimento<br />
possa essere d’aiuto, può far perdere informazioni importanti riguardo il<br />
termine stesso, è quindi importante scegliere le varie unità d’analisi e le forme<br />
testuali in modo ragionato, riferendosi continuamente al contesto del corpus di<br />
cui fanno parte.<br />
Qualsiasi operazione di questo tipo dipende direttamente dalle scelte<br />
soggettive del ricercatore e dalla congruenza con gli obiettivi della sua ricerca,<br />
in quanto sono finalizzate all’aumento della portata informativa dei dati stessi.<br />
10 Per corpus si intende “un qualsiasi insieme di informazioni composto da uno o più testi, ognuno dei<br />
quali è suddiviso in vari frammenti da considerarsi come unità di analisi” (Bolasco, 1995, p. 88). I<br />
testi contenuti nel corpus vengono considerati coerenti con gli scopi della ricerca e che quindi<br />
vengono sottoposti all’analisi.<br />
80
Gran parte dei risultati ottenuti dipenderà, oltre che dal testo, da queste<br />
decisioni preliminari; l’importante è che nell’operare queste scelte ci si basi<br />
sulla conoscenza del materiale da analizzare e non su semplici esigenze di<br />
rappresentatività statistica (Amaturo, 1993).<br />
Nonostante questo, si può dire che anche l’utilizzo delle forme testuali rischia<br />
di diventare fuorviante, in quanto finisce per perdere il contesto all’interno del<br />
quale le forme sono inserite. Per eliminare questo problema è possibile<br />
esaminare il contesto in cui le forme ricorrono, utilizzare unità di analisi più<br />
lunghe, cioè i segmenti, oppure, in modo più efficace, utilizzare l’analisi delle<br />
corrispondenze lessicali.<br />
4.4 L’ANALISI DELLE CORRISPONDENZE LESSICALI<br />
L’analisi delle corrispondenze lessicali (ACL) consiste nell’applicazione a dati<br />
testuali dell’analisi fattoriale delle corrispondenze, ideata da Benzecri negli<br />
anni ’60. Questa è una forma di analisi fattoriale per variabili qualitative che<br />
consente di rappresentare graficamente (su un piano car<strong>tesi</strong>ano) le associazioni<br />
tra le righe e le colonne di una tabella di contingenza. In questo modo si ha la<br />
possibilità di ottenere una prima sin<strong>tesi</strong> dell’informazione contenuta nei dati,<br />
in quanto la similarità tra i profili delle modalità della stessa variabile viene<br />
tradotta in distanze sul grafico (Tuzzi, 2003). La metrica su cui ci si basa per<br />
stabilire le associazioni è quella del chi quadro, per cui si può parlare soltanto<br />
di associazioni tra le modalità della variabile e non di correlazioni come<br />
avviene nell’analisi fattoriale (Cemin, Collini, 1999-2000). Questo tipo di<br />
analisi consente di tradurre la similarità tra le variabili in un grafico a<br />
dispersione, all’interno del quale i rapporti di similarità o di differenza tra le<br />
modalità vengono tradotti in vicinanza o distanza reciproca sul grafico<br />
81
(distanza che comunque mantiene una rilevanza puramente qualitativa, in<br />
quanto espressione di una tendenza e non di una misura) (Bolasco, 1999).<br />
Lo stesso procedimento viene attuato dall’analisi della corrispondenze<br />
lessicali, che consente di utilizzare come variabili qualitative le parole ed i<br />
testi, producendo una sin<strong>tesi</strong> dell’informazione in essi contenuta (Amaturo,<br />
1993). Il testo, è strutturato in una matrice di dati che consente di calcolare la<br />
presenza concomitante di più parole nel testo, cioè il modo in cui queste si<br />
associano all’interno del testo. Attraverso questa tecnica è possibile<br />
individuare dei fattori, dati dall’associazione tra le diverse parole, che si<br />
configurano come dimensioni latenti di senso, come “sintagmi ideali”<br />
(Bolasco, 1997, p. 193), in un certo senso “enunciati” che già sono presenti nel<br />
testo, ma che rimangono latenti, non visibili e rilevabili dalla semplice lettura,<br />
sot<strong>tesi</strong> al testo ed al modo in cui le parole si associano tra loro. Oltre a questo,<br />
l’ACL consente anche di connettere ai dati testuali dati di contesto, dando la<br />
possibilità di associare ad ogni testo informazioni esterne.<br />
4.5 LO SPAD.t<br />
Il software SPAD.t (Systeme portable pour l’analyse des donnèes textuelles) è<br />
un programma creato nel 1989 da Lebart, Morineau, Becue, Haeusler, e<br />
pubblicato nel 1993. Attraverso questo programma è possibile effettuare su<br />
dati testuali di vario genere (risposte a domande aperte, articoli di giornale,<br />
brani di prosa o di poesia…) diversi tipi di analisi (tra cui anche l’ACL),<br />
attraverso procedure che è possibile concatenare in percorsi diversi in base alle<br />
esigenze della ricerca (Cemin, Collini, 1999-2000). I principali risultati che<br />
questo programma consente di ottenere sono:<br />
82
La sin<strong>tesi</strong> delle informazioni contenute nei dati: questo avviene tramite<br />
i procedimenti di conteggio delle parole, delle frequenze e la selezione<br />
di parole e segmenti caratteristici.<br />
La connessione tra dati testuali e dati di contesto: ad ogni testo è<br />
possibile associare informazioni che derivano dal suo contesto,<br />
procedura particolarmente utile nel caso di analisi di risposte a<br />
domande aperte.<br />
La visualizzazione delle associazioni tra le parole tramite l’utilizzo<br />
dell’analisi delle corrispondenze lessicali.<br />
4.6 OBIETTIVI DELL’ANALISI<br />
Parlando di reti sociali Laing e Esterson (1970), sostengono che: “ogni persona non è<br />
semplicemente un oggetto nel mondo degli altri, bensì una posizione nel tempo e<br />
nello spazio, dalla quale vive il suo mondo, lo rappresenta e vi agisce…ed è<br />
precisamente la prospettiva comune che essa condivide con gli altri ciò che è<br />
interessante studiare. L’interesse va rivolto alle persone che sono in rapporto tra loro,<br />
e sempre nel contesto del loro gruppo”. Partendo da questa prospettiva, nasce l’idea<br />
di studiare la rete <strong>Wigwam</strong>, ovvero dall’esigenza di approfondire i discorsi collettivi<br />
dei soci in modo da fornire una “fotografia” reale dell’associazione.<br />
Obiettivo fondamentale dell’intervista è evidenziare le costanti metodologiche<br />
che sottostanno al funzionamento di questa rete sociale, indagando 4 ambiti<br />
principali:<br />
1. Conoscere in modo più approfondito l’associazione, così come è descritta<br />
dai vari soci: come nascono i progetti, a chi si rivolgono… cercando di<br />
evidenziarne i meccanismi di funzionamento;<br />
2. Verificare se all’interno dell’associazione vengono applicati i principi dei<br />
circoli di qualità. Essa infatti, proponendo attività diverse per progetti e<br />
83
avendo come obiettivo la qualità in senso lato (dei servizi, del prodotto, della<br />
vita) si ispira a questa modalità di gestione delle risorse;<br />
3. Verificare se c’è o meno aderenza ai principi dell’empowerment. <strong>Wigwam</strong><br />
ha come obiettivi la responsabilizzazione dei soggetti, in modo che tutti<br />
possano percepire che è possibile creare un rapporto migliore con la comunità<br />
e il territorio (un mondo sostenibile) e portare ad un miglioramento della<br />
qualità di vita propria ed altrui;<br />
4. Esplicitare i valori guida dell’associazione, i suoi punti di forza e di<br />
debolezza;<br />
Sinteticamente, lo scopo primario della ricerca è sistematizzare alcuni aspetti<br />
associativi (da sempre presenti), ma che fino a questo momento non erano mai<br />
stati esplicitati, partendo dall’opinione di coloro che permettono<br />
all’associazione stessa di funzionare ed esistere: i soci.<br />
4.7 IPOTESI DI PARTENZA<br />
In letteratura, diverse ricerche (sia qualitative che quantitative) sull’analisi e<br />
valutazione di associazioni non profit, considerano tre variabili principali: il<br />
genere, l’età e il ruolo associativo 11 .<br />
Inizialmente si era deciso di impostare la ricerca facendo un confronto<br />
intergruppale all’interno dell’associazione <strong>Wigwam</strong>, analizzando le interviste<br />
secondo la modalità “con variabili associate” che nel caso specifico erano<br />
suddivise in:<br />
- GENERE: maschio, femmina;<br />
- ETA’: 20-40, 41-60, 61-80;<br />
- RUOLO ASSOCIATIVO: presidente di club, socio-operatore e ruoli<br />
amministrativi.<br />
11 Diversi esempi sono riportati in dettaglio in Pearce, 1997; Converso e Piccardo, 2003.<br />
84
Si è svolta un’ analisi statistica per tutte le domande attraverso la procedura<br />
MOCAR, presente all’interno del programma SPAD.t. Questa procedura<br />
fornisce, attraverso l’utilizzo dei punti z, delle “misure di specificità”, ovvero<br />
indica quanto una parola sia tipica o specifica di una variabile testuale<br />
associata (per esempio facendo un confronto tra maschi e femmine).<br />
L’analisi quantifica lo scarto tra il profilo di una risposta e il profilo medio<br />
della classe a cui la risposta appartiene, in modo da valutare come si<br />
differenziano i discorsi dei soggetti in funzione della variabile scelta di volta<br />
in volta.<br />
Con un livello di significatività di p = 0,05, per nessuna delle tre variabili, in<br />
nessuna risposta esistono delle differenze intergruppali significative a livello<br />
statistico.<br />
Questa prima analisi ci permette di affermare che il campione è estremamente<br />
omogeneo, e che non esistono delle differenze nelle risposte dovute al genere,<br />
all’età o al ruolo associativo.<br />
E’ difficile dare una spiegazione se non a livello ipotetico di ciò, ma è<br />
comunque possibile effettuare due considerazioni:<br />
1. Tutti gli intervistati hanno svolto (come previsto dall’associazione) il<br />
corso di base per operatore <strong>Wigwam</strong>; a differenza di altre realtà, tutti i<br />
soci hanno una conoscenza associativa comune e un background molto<br />
simile;<br />
2. Essendo la partecipazione volontaria, è ipotizzabile, in quanto scelta<br />
consapevole, che i soggetti conoscano bene e si identifichino in modo<br />
simile ai valori e alle proposte associative.<br />
Si tratta soltanto di ipo<strong>tesi</strong>, che non possono essere approfondite in questa sede<br />
per mancanza di dati a tal proposito.<br />
85
In ogni caso, questa constatazione ha portato a una modifica dell’impostazione<br />
con cui si volevano analizzare le interviste, senza però modificare gli obiettivi<br />
e le ipo<strong>tesi</strong> di partenza dell’analisi testuale.<br />
Tutte le risposte sono state rianalizzate considerando il campione come<br />
omogeneo, e ignorando le variabili sopracitate in quanto non significative. I<br />
diversi grafici pertanto vanno letti come rappresentativi delle risposte di tutti i<br />
soggetti che non possono essere differenziati in alcun modo. Le variabili sono<br />
comunque state descritte nel paragrafo 5.11, in modo da permettere una<br />
maggiore conoscenza del campione.<br />
4.8 SCELTA E ORGANIZZAZIONE DEL TESTO<br />
Il testo è stato organizzato secondo la modalità “texte”. Ogni domanda è stata<br />
sottoposta singolarmente ad analisi. Data la strutturazione dell’intervista, non<br />
è stato possibile accorpare più domande, perché ciascuna richiedeva una<br />
risposta specifica, il cui contenuto non poteva essere analizzato insieme ad<br />
altre.<br />
Per ciascuna domanda è stato creato un file di testo che conteneva tutte le<br />
risposte dei soggetti date a quella domanda. Ad eccezione di alcune domande<br />
(che richiedevano una risposta eccessivamente breve), le restanti domande<br />
sono state sottoposte ad analisi delle corrispondenze lessicali attraverso la<br />
procedura ASPAR, senza variabili associate.<br />
L’ACL così ottenuta permette di ottenere una sin<strong>tesi</strong> delle informazioni<br />
testuali maggiormente significative, rappresentate su un piano car<strong>tesi</strong>ano e<br />
sottoposte ad analisi fattoriale.<br />
4.9 IL PRE-TRATTAMENTO DEL TESTO<br />
86
Con questa operazione si intendono tutte quelle operazioni preliminari che non<br />
modificano il senso del testo esaminato, permettendo però una maggiore<br />
comprensione delle forme d’uso, ovvero di come le parole vengono utilizzate<br />
all’interno del testo stesso. Il criterio fondamentale indicato da Bolasco è di<br />
“conservare distinte nel testo le variazioni significative in termini semantici e<br />
fondere insieme le forme che costituiscono degli invarianti semantici”<br />
(Bolasco, 1999, p.213). Lo scopo dell’operazione è quello di ridurre il più<br />
possibile le ambiguità presenti nel corpus testuale e accrescere così il livello<br />
informativo, migliorando la qualità del dato linguistico.<br />
Il pre-trattamento, è stato effettuato in considerazione dell’obiettivo della<br />
ricerca, consentendo di attribuire ad ogni forma grafica un significato che<br />
possa essere chiaro ed univoco in relazione al testo stesso in cui è contenuto.<br />
Alla luce di queste considerazioni, il pre-trattamento è stato mantenuto il più<br />
“leggero” possibile 12 , per evitare di modificare eccessivamente la struttura del<br />
testo. Gli interventi riguardano prevalentemente:<br />
- forme linguistiche che, se tenute separate, perderebbero il loro significato<br />
linguistico come: “di solito”, “per esempio”, “all’incirca”..;<br />
- forme che tenute insieme determinano un significato diverso da quello della<br />
singola forma grafica come le negazioni di verbi.<br />
12 Per pre-trattamento “leggero” si intende un intervento ridotto sul testo, che tenda a modificare il<br />
meno possibile le forme grafiche del testo, lasciandone inalterata la struttura di base (Cemin, Collini,<br />
1999-2000).<br />
87
4.10 IL FILE CORTE<br />
Dopo aver ottenuto una lista di forme grafiche che, in seguito agli interventi<br />
operati tramite il pre-trattamento, hanno un significato univoco rispetto al<br />
contesto 13 , il programma prevede la possibilità di apportare correzioni ai dati<br />
testuali tramite la procedura CORTE. Questa consente di eliminare (DELET)<br />
termini ritenuti di scarsa rilevanza per le analisi e di compattare (EQUIV)<br />
termini importanti per l’analisi in macrocategorie, in modo tale da aumentarne<br />
la frequenza.<br />
Per quel che riguarda i DELET sono stati inseriti articoli, congiunzioni e<br />
preposizioni (quando non inseriti in altre stringhe di parole dal pre-<br />
trattamento), caratterizzati da una frequenza molto alta e da scarso significato<br />
a livello di analisi. Sono stati eliminati anche alcuni avverbi e pronomi<br />
personali.<br />
Per quel che riguarda le Equivalenze, invece, le categorie sono state create:<br />
- tra le forme grafiche che erano espresse con genere e numero diversi,<br />
sulla base dell’appartenenza allo stesso contesto discorsivo (per<br />
esempio: informazione = informazioni, persona = persone);<br />
- tra sinonimi (per esempio: finalità = scopo).<br />
4.11 IL TAGLIO DI FREQUENZA<br />
Dal momento che le analisi finali compiute tramite il programma sono di tipo<br />
statistico, diventa necessario lavorare su forme grafiche che non abbiano una<br />
frequenza troppo bassa. Per questo motivo, dopo aver accorpato (quando<br />
possibile) le forme testuali in macrocategorie si effettua un taglio di frequenza,<br />
attraverso il quale vengono eliminate dalla lista tutte le forme che presentano<br />
una frequenza inferiore alla soglia stabilita.<br />
13 Da precisare è il fatto che il significato non è univoco in senso assoluto, ma in relazione al testo in<br />
cui la forma grafica è inserita ed in relazione alle scelte fatte durante il pre-trattamento.<br />
88
In questo caso la soglia di frequenza è stata stabilita a 1 (sono state tenute tutte<br />
le forme grafiche aventi frequenza maggiore o uguale a 2); questa scelta deriva<br />
dal fatto che, non essendo il campione eccessivamente ampio, si ha la<br />
possibilità di analizzare una maggiore porzione di testo, senza correre il<br />
rischio di eliminare informazioni.<br />
4.12 L’ANALISI DELLE CORRISPONDENZE: LA PROCEDURA<br />
ASPAR<br />
L’analisi delle corrispondenze è un metodo fattoriale che riassume il testo in<br />
una tabella di contingenza, dando come risultato una rappresentazione grafica,<br />
in cui la vicinanza tra i punti indica la presenza di un’associazione tra righe e<br />
colonne della tabella di contingenza. Il calcolo delle distanze tra i punti<br />
utilizza la metrica del chi-quadro. La procedura ASPAR, consente di costruire<br />
una tabella di contingenza del tipo: “risposte per parole”: in cui sono presenti<br />
in riga le risposte, in colonna le forme grafiche distinte.<br />
Questa procedura è utilizzata soprattutto per analizzare le risposte individuali<br />
(per esempio le risposte a domande aperte, come nel nostro caso).<br />
Gli elementi attivi utilizzati dall’ASPAR per la formazione degli assi<br />
car<strong>tesi</strong>ani sono soltanto le forme grafiche, ad ognuna delle quali viene<br />
assegnata una posizione, in relazione alle associazioni con le altre forme<br />
grafiche. È stata scelta questa procedura in quanto consente di ottenere una<br />
sin<strong>tesi</strong> ed una rappresentazione dei contenuti nel testo, facendo così emergere i<br />
nuclei tematici intorno ai quali il testo è costruito.<br />
L’istogramma dei valori propri (presente nei risultati) consente di stabilire il<br />
numero di fattori da prendere in considerazione nell’analisi. Il valore proprio<br />
di un fattore, espresso in percentuale, corrisponde alla quantità della varianza<br />
89
generale spiegata da quel fattore; in altri termini esplicita la quota di inerzia<br />
spiegata da ciascun fattore.<br />
La scelta delle forme grafiche da prendere in considerazione per<br />
l’identificazione dei fattori, si basa sull’osservazione del contributo assoluto<br />
(CA). Questo esprime la parte di inerzia totale del fattore spiegata da ciascuna<br />
forma grafica; rappresenta cioè l’importanza di ciascuna forma grafica nella<br />
costruzione dei diversi assi. Gli elementi selezionati sono quelli che hanno un<br />
CA superiore al valore medio, dato da 100/numero delle forme grafiche<br />
distinte. Le forme grafiche così selezionate sono quelle che verranno utilizzate<br />
(distinguendo tra la polarità positiva e quella negativa espressa dalle<br />
coordinate corrispondenti) per la costruzione dei diversi fattori.<br />
4.13 SCELTA DEI FATTORI DA ANALIZZARE<br />
Lo scopo primario dell’analisi delle corrispondenze è quello di scoprire le dimensioni<br />
di senso presenti in un testo oggetto di studio, basandosi sul confronto di differenti<br />
profili lessicali. Al fine di utilizzare strumenti di analisi più completi e precisi, il<br />
testo viene numerizzato e strutturato in opportune matrice di dati, in modo da<br />
impostare lo studio delle co-occorrenze (ovvero della presenza concomitante di più<br />
parole nel testo) e dei sintagmi di discorso (ovvero della ricostruzione del senso di<br />
frasi o frammenti di testo) mediante il confronto di differenti profili lessicali.<br />
In ogni caso, l’oggetto di studio, il linguaggio naturale, è per natura di carattere<br />
qualitativo; anche se viene elaborato e processato con una logica numerica (analisi<br />
fattoriale) essa si ferma ad un livello di identificazione, cioè ad un trattamento<br />
assolutamente qualitativo, nel senso che non viene sovrapposto a priori alcun livello<br />
di misurazione di ordine superiore all’informazione di base.<br />
Va sottolineato che sotto la denominazione “metodi fattoriali” sono compresi<br />
approcci assai diversi: le tecniche fattoriali, qui utilizzate, hanno carattere esplorativo<br />
e non probabilistico. Esulano dagli obiettivi di questo elaborato alcuni metodi di<br />
90
factor analysis, che ricercano fattori comuni e specifici, basati su modelli a priori di<br />
relazioni esistenti tra variabili e fattori.<br />
Nell’ambito dell’analisi testuale a carattere esplorativo, i metodi fattoriali sono<br />
utilizzati come strumenti di base per lo studio delle co-occorrenze osservate nel<br />
contesto globale, come un modello di ricostruzione sintagmatica del discorso. I<br />
sintagmi rappresentano dimensioni latenti di testo; in questo modo ogni asse<br />
fattoriale costituisce un modello per la rappresentazione di polarizzazioni tematiche,<br />
si tratta di una specie di supporto per la misurazione di “gradienti di senso” (Ricolfi,<br />
1997).<br />
Ai fini dell’interpretazione dei fattori, si può limitare la ricerca degli elementi<br />
significativi ai soli punti con una buona qualità di rappresentazione. Un criterio per<br />
risolvere il problema, è quello di considerare solo gli assi associati ad autovalori<br />
superiori all’unità (Bolasco, 1999). Nel caso in cui i valori fossero inferiori ci si<br />
limita all’analisi dei fattori che assorbono la maggior quota di informazione,<br />
generalmente i primi due (Bolasco, 1999), l’obiettivo infatti è quello di disporre di<br />
poche variabili sintetiche, che racchiudano la maggior quota di inerzia possibile.<br />
Nel nostro caso, considerando la quantità di testo, è stato seguito questo secondo<br />
criterio, e sono stati considerati i primi due assi, ovvero le dimensioni fattoriali che<br />
racchiudevano la maggior quota di inerzia presente nel testo. Nel caso di alcune<br />
domande (in cui la differenza tra secondo e terzo fattore era esigua), è stato preso in<br />
considerazione anche il terzo fattore. In nessun caso il terzo fattore evidenziava aree<br />
semantiche differenti da quelle presenti nei primi due, ma per chiarezza esplicativa i<br />
contributi assoluti e le coordinate dei punti sono riportate in appendice B. Secondo<br />
Lanzetti (1998) inoltre, nel caso di testi non eccessivamente lunghi, i fattori<br />
successivi ai primi racchiudono più “rumore” che informazione.<br />
Questa scelta metodologica è stata effettuata in conformità con le ipo<strong>tesi</strong> di partenza,<br />
ovvero il desiderio di evidenziare caratteristiche associative senza utilizzare assunti a<br />
priori circa la natura dei dati. Inoltre non essendo mai stata svolta un’indagine di tipo<br />
esplorativo all’interno dell’associazione quest’approccio si è rivelato il più esaustivo.<br />
Si rimanda a ricerche successive la possibilità, con riferimento alle ipo<strong>tesi</strong> qui<br />
91
presentate, di formulare modelli maggiormente esplicativi, utilizzando tecniche più<br />
potenti sotto l’aspetto inferenziale e statistico.<br />
4.14 DESCRIZIONE DEL CAMPIONE<br />
Il campione di intervistati è composto da 21 soggetti, 12 maschi e 9 femmine.<br />
I soggetti hanno un’età media di 50,62 anni. Più in dettaglio, suddiviso per<br />
genere e fasce d’età, esso è così caratterizzato:<br />
TABELLA 1: Rappresentazione grafica del campione per le variabile: genere<br />
ed età.<br />
20-40 41-60 61-80 TOTALE<br />
MASCHI 1 7 4 12<br />
FEMMINE 3 6 0 9<br />
TOTALE 4 13 4 21<br />
Si può affermare che il campione è equamente suddiviso per genere (57,14%<br />
maschi, 42,86% femmine), mentre per quanto riguarda la suddivisione per<br />
fasce d’età il 61,9% del campione si concentra nella fascia d’età centrale (41-<br />
60 anni), il 19,05% si colloca nella fascia d’età compresa tra i 20 e 40 anni e il<br />
restante 19,05% (composto esclusivamente da uomini) si colloca nella fascia<br />
d’età superiore ai 61 anni.<br />
In generale le femmine hanno un’età media inferiore (44,89 anni) rispetto agli<br />
uomini (54,75 anni).<br />
Per quanto riguarda il ruolo associativo, tutti i soggetti intervistati svolgono un<br />
ruolo attivo all’interno dell’associazione <strong>Wigwam</strong> e possono essere suddivisi<br />
in tre categorie:<br />
92
- presidente di un club di progetto: si tratta di soggetti che hanno ideato,<br />
proposto e stanno realizzando un loro progetto all’interno<br />
dell’associazione;<br />
- socio-operatore: si tratta di soggetti che partecipano attivamente alla<br />
realizzazione e attuazione di un progetto in atto;<br />
- amministrativo: si tratta di soggetti che non partecipano ad un progetto<br />
specifico, ma si occupano di fornire un supporto amministrativo,<br />
burocratico all’interno dell’associazione; essi hanno un ruolo attivo ma<br />
trasversale ai diversi progetti in atto.<br />
I soggetti sono così suddivisi (Tabella 2):<br />
RUOLO ASSOCIATIVO FREQUENZA PERCENTUALE<br />
PRESIDENTE CLUB 12 57,14%<br />
SOCIO-OPERATORE 7 33,33%<br />
AMMINISTRATIVO 2 9,52%<br />
Un altro aspetto da considerare è il numero di ore che i soci dedicano ad<br />
attività che riguardano l’associazione o il loro progetto. In generale la media è<br />
di 13,05 ore la settimana. Relativamente a questo aspetto, non esistono<br />
differenze significative in base all’età e al genere (Tabella 3).<br />
TABELLA 3: Descrizione delle ore che i soci dedicano in media<br />
all’associazione.<br />
VARIABILE MEDIA ORE<br />
93
ETA’<br />
GENERE<br />
RUOLO<br />
20-40 15<br />
41-60 12,03<br />
61-80 13,5<br />
M 11<br />
F 15,77<br />
PRESIDENTE CLUB 15,92<br />
SOCIO-OPERATORE 9,71<br />
AMMINISTRATIVO 7,5<br />
Esiste invece una differenza nell’investimento temporale relativamente al<br />
ruolo associativo, infatti i presidenti di club dedicano più tempo ad attività<br />
associative rispetto ai soci operatori e a chi svolge un ruolo amministrativo:<br />
Questa differenza può essere parzialmente spiegata con il fatto che per 9<br />
presidenti di club di progetto l’attività associativa coincide parzialmente o<br />
totalmente con l’attività lavorativa, e questo comporta inevitabilmente un<br />
maggior investimento rispetto ai soci che invece partecipano a progetti<br />
<strong>Wigwam</strong> solo nel tempo libero. 14<br />
Tutti gli intervistati hanno messo in evidenza due aspetti:<br />
- Il tempo dedicato ad attività associative non è costante durante l’anno,<br />
si tratta di una media indicativa, in quanto aumenta considerevolmente<br />
in occasioni di spettacoli, eventi…;<br />
14 Su 12 presidenti di club, 9 sostengono che esista una corrispondenza tra attività lavorativa e<br />
associativa. Questo aspetto non è presente in nessuno degli intervistati con altri ruoli associativi<br />
(socio-operatore e amministrativo).<br />
94
- Il tempo dedicato ad attività associative è fortemente influenzato da<br />
problemi lavorativi e personali, non corrisponde al tempo che<br />
effettivamente molti soggetti vorrebbero dedicare a <strong>Wigwam</strong>. Ne sono<br />
un esempio due affermazioni tratte dalle interviste date come risposta<br />
alla domanda: “Quante ore dedica alla settimana ad attività che<br />
riguardano l’associazione?”: “Purtroppo poche, ma non dipende da<br />
me”, “Un paio d’ore, ma ci penso continuamente”.<br />
Per quanto riguarda gli anni di appartenenza all’associazione, i soggetti fanno<br />
parte di <strong>Wigwam</strong> da 3,44 anni in media, con un intervallo di valori molto<br />
ampio, che va dai 3 mesi ai 16 anni di appartenenza. I maschi hanno<br />
“un’anzianità” associativa leggermente maggiore delle femmine; mentre per<br />
quanto riguarda la variabile età, i soci che fanno parte da più anni<br />
dell’associazione sono quelli che hanno un’età compresa tra i 41 e i 60 anni,<br />
mentre i giovani (20-40 anni), sono coloro che ne fanno parte da meno tempo.<br />
Rispetto al ruolo associativo, i presidenti di club di progetto fanno parte da più<br />
tempo dell’associazione rispetto ai soci operatori. Coloro che hanno una media<br />
molto superiore rispetto alle altre categorie sono i soci che hanno un ruolo<br />
amministrativo. Questo valore in realtà è poco rappresentativo in quanto la<br />
categoria è costituita da soli due soggetti. 15 Le tabelle sottostanti riassumono<br />
brevemente gli anni di appartenenza associativa, rilevati dalle risposte alla<br />
domanda numero 6: “Da quanto tempo svolge attività in questa associazione?”<br />
TABELLA 4: Descrizione degli anni di appartenenza associativa (media) del<br />
campione.<br />
15 La categoria soci con un ruolo amministrativo è costituita da soli due soggetti che fanno parte<br />
rispettivamente dell’associazione da un anno e da sedici anni.<br />
95
VARIABILE MEDIA ANNI<br />
ETA’<br />
GENERE<br />
RUOLO<br />
20-40 1,12<br />
41-60 4,37<br />
61-80 2,75<br />
M 4,06<br />
F 3,61<br />
PRESIDENTE CLUB 3,36<br />
SOCIO-OPERATORE 2,14<br />
AMMINISTRATIVO 8,5<br />
96
CAPITOLO 5: RISULTATI<br />
I risultati hanno lo scopo di evidenziare attraverso un’analisi di contenuto le parole<br />
chiave, i discorsi collettivi e in generale la cultura espressa dai vari soggetti<br />
relativamente alla loro associazione.<br />
Come riportato precedentemente, lo SPAD.t, attraverso l’analisi delle<br />
corrispondenze sui dati testuali, consente di proiettare le forme grafiche del<br />
testo su un piano car<strong>tesi</strong>ano e di prenderne in considerazione le associazioni.<br />
All’interno del grafico è possibile distinguere aree semantiche diverse,<br />
costituite da forme grafiche che si associano tra di loro; esse, per questioni di<br />
chiarezza metodologica, in questo elaborato sono evidenziate da dei cerchi.<br />
Ogni area verrà brevemente spiegata, riferendosi al significato che quei<br />
termini assumono nel contesto delle risposte fornite. Ogni vocabolo è ricercato<br />
nel testo, in modo da fornire una spiegazione delle risposte molto aderente al<br />
contesto in cui è emersa. In alcuni casi, per esemplificare sono riportate alcune<br />
parti di intervista, che sono citate testualmente e riportate in carattere corsivo.<br />
5.1 CARATTERISTICHE ASSOCIATIVE GENERALI<br />
Questa è la prima sezione di intervista e ha lo scopo di indagare caratteristiche<br />
associative generali (Domande 1-7).<br />
5.1.1 COM’E’ NATO IL SUO PROGETTO?<br />
Relativamente a questa domanda la procedura ASPAR ha consentito di individuare la<br />
presenza di due fattori intorno ai quali si concentrano le risposte dei soggetti. Il<br />
vocabolario iniziale era composto da 424 parole distinte (43,3% sul vocabolario<br />
totale), ridotto a 91 vocaboli dopo il file CORTE ed il taglio di soglia. Il valore del<br />
contributo medio è dato da 100/91; essendo questo rapporto uguale a 1,09, sono state<br />
considerate come significative per ogni fattore, le forme grafiche con un contributo<br />
assoluto maggiore o uguale a 1 (Appendice B, Tab. 1). La tabella A raffigura<br />
97
l’istogramma ottenuto attraverso l’analisi fattoriale, che ha consentito di individuare<br />
la presenza di due fattori significativi 16 che spiegano il 18,88% della varianza<br />
totale 17 .<br />
Tabella A: Istogramma dei valori propri della domanda 1.<br />
Fattore Valore<br />
proprio %<br />
1 0,533 9,61 ********************************************************************************<br />
2 0,5135 9,26 ******************************************************************************<br />
3 0,4662 8,41 **********************************************************************<br />
4 0,4252 7,67 ****************************************************************<br />
5 0,4112 7,42 **************************************************************<br />
6 0,3854 6,95 **********************************************************<br />
7 0,3658 6,6 *******************************************************<br />
8 0,3361 6,06 ***************************************************<br />
9 0,3005 5,42 **********************************************<br />
10 0,2509 4,52 **************************************<br />
11 0,2377 4,29 ************************************<br />
12 0,2256 4,07 **********************************<br />
13 0,1915 3,45 *****************************<br />
14 0,1757 3,17 ***************************<br />
15 0,1613 2,91 *************************<br />
Il primo fattore individuato “Recupero valori tradizionali”, è saturato principalmente<br />
da aree tematiche come il recupero delle tradizioni (C.A.=3,4) 18 , della storia<br />
territoriale (C.A.=6,8), dalla possibilità di dedicarsi ad alcune problematiche sociali<br />
come i disabili (C.A.=5,2) e la solidarietà (C.A.=3,3).<br />
Se la prima dimensione fattoriale è riconducibile al concetto di “recupero”, la<br />
seconda evidenzia l’aspetto della “promozione”. Si tratta di due aspetti<br />
apparentemente antitetici, ma che in realtà nelle risposte fornite dai soggetti sono<br />
complementari. Il secondo fattore chiamato “promozione e scambi di cultura” è<br />
16<br />
I fattori sono da considerarsi significativi in relazione alla modalità di strutturazione del grafico e<br />
non in senso statistico trattandosi di un’indagine descrittiva. Per approfondimenti si veda pag. 92 del<br />
presente elaborato.<br />
17<br />
Per approfondimenti sulla scelta dei fattori da analizzare si rimanda al Capitolo 4, paragrafo 4.13, p.<br />
92.<br />
18<br />
I contributi assoluti dei vocaboli e le relative coordinate sono riportati in Appendice B.<br />
98
saturato principalmente dai termini: promuovere (C.A.=17,4), scambi (C.A.=26) e<br />
europei (C.A.=17,4). La nascita dei progetti, si articola dunque in due dimensioni di<br />
senso principali che riguardano il recupero di valori tradizionali, la promozione di<br />
scambi e la diffusione di cultura. Il Grafico 1 rappresenta le principali aree tematiche<br />
emerse su un piano car<strong>tesi</strong>ano, in cui i due fattori si incrociano.<br />
Grafico 1: grafico ottenuto dall’incrocio di F1 e F2<br />
F2: Promozione di scambi e cultura<br />
2,0<br />
0,0<br />
-2,0<br />
-4,0<br />
-6,0<br />
cavalli solidarietà<br />
forte disabile 1<br />
-2,00<br />
4<br />
persona<br />
esigenza<br />
europea scambi<br />
promuovere5<br />
-1,00<br />
wigwam2<br />
avevo<br />
occupare<br />
problema<br />
giovani<br />
attraverso<br />
formazione<br />
99<br />
0,00<br />
F1: Recupero valori tradizionali<br />
anni<br />
creatività<br />
recupero<br />
artisti<br />
territorio lavoro tradizioni<br />
riguarda<br />
storia corsi vissuta<br />
cultura 3<br />
Come evidenziato dal grafico, alla domanda numero uno emergono principalmente<br />
cinque aree tematiche:<br />
1. Partendo dall’area 1, i soggetti hanno evidenziato un’area che potremmo definire<br />
“solidarietà”, sottolineando come la nascita del loro progetto parta da esigenze e<br />
1,00<br />
2,00
interessi per l’ambito sociale che i soci definiscono come “forti”. Alcuni<br />
progetti nascono da una rilevante attenzione alle tematiche sociali che i soggetti<br />
vivevano già prima di poter realizzare il loro progetto. L’attenzione a queste<br />
tematiche si rivolge prevalentemente all’area della disabilità in generale, ma<br />
anche all’utilizzo dell’ippoterapia come possibile strategia riabilitativa.<br />
2. La seconda area tematica emersa, può essere definita come l’area della<br />
“possibilità associativa”; i soggetti evidenziano come i loro progetti siano nati<br />
dalla percezione di una carenza, di un problema non affrontato a livello sociale. I<br />
progetti dunque nascono: “per aiutare chi ha questi problemi”, “perché le<br />
istituzioni non affrontavano realmente il problema di …”.<br />
<strong>Wigwam</strong> dunque per i soggetti ha rappresentato l’opportunità di occupare il<br />
proprio tempo in modo costruttivo, dando la possibilità alle persone di occuparsi<br />
di problemi che percepiscono come importanti a livello personale. Si può<br />
affermare che questa è forse l’area più significativa, perché non soffermandosi<br />
su un contenuto specifico, sottolinea come l’associazione sia, per le persone, il<br />
mezzo che ha permesso di trasformare un problema percepito in una soluzione<br />
possibile.<br />
3. Tra il secondo e il terzo quadrante, lungo l’asse del primo fattore, si colloca la<br />
più numerosa area tematica, che potremmo chiamare l’area dell’ “interesse per le<br />
tradizioni territoriali”. Il fatto che i vocaboli si collochino molto vicino all’asse,<br />
ci dà la possibilità di affermare che si tratta di discorsi piuttosto frequenti e<br />
comuni tra i vari soci. Essi sottolineano infatti come i loro progetti nascano<br />
dall’interesse per le tradizioni, il rispetto del territorio, il recupero culturale e la<br />
storia vissuta. Si tratta per molti soci di un interesse nato molti anni prima, e che<br />
dà loro l’opportunità di usare la creatività e di incontrare artisti, poeti che si<br />
occupano di queste tematiche.<br />
4. La quarta area tematica si colloca all’interno del quarto quadrante, vicino<br />
all’asse del primo fattore, e può essere definita come l’area dell’ “attenzione alle<br />
persone”. Alcuni progetti nascono dall’esigenza di incontrare, creare<br />
100
aggregazione e comunicare alle persone, con una particolare attenzione alle<br />
esigenze formative e ai giovani come risorsa.<br />
5. Un’ultima area tematica, si colloca all’interno del quarto quadrante ma distante<br />
dagli assi; si tratta quindi di un’area significativa, ma altrettanto specifica e non<br />
comune tra i vari soci. I vocaboli che costituiscono quest’area saturano<br />
principalmente il secondo fattore. Quest’area può essere definita come “scambio<br />
culturale”. Alcuni progetti nascono per promuovere scambi culturali e<br />
promuovere l’integrazione tra giovani di diverse nazionalità, soprattutto europei.<br />
Lo scopo è dunque quello di promuovere scambi culturali ma anche personali.<br />
5.1.2 QUAL’ E’ L’OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO?<br />
Relativamente a questa domanda la procedura ASPAR ha consentito di individuare la<br />
presenza di tre fattori intorno ai quali si concentrano le risposte dei soggetti. Il<br />
vocabolario iniziale era composto da 244 parole distinte (57,4% sul vocabolario<br />
totale), ridotto a 44 vocaboli dopo il file CORTE ed il taglio di soglia. Il valore del<br />
contributo medio è dato da 100/44; essendo questo rapporto uguale a 2,27, sono state<br />
considerate come significative per ogni fattore le forme grafiche con un contributo<br />
assoluto maggiore-uguale a 2 (Appendice B, Tab. 2). La tabella B, raffigura invece<br />
l’istogramma ottenuto attraverso l’analisi fattoriale, che ha consentito di individuare<br />
la presenza di tre fattori significativi, che spiegano il 29,13% della varianza totale.<br />
Tabella B: Istogramma dei valori propri della domanda 2.<br />
Fattore Valore proprio %<br />
1 0,7951 10,72 ********************************************************************************<br />
2 0,6946 9,36 **********************************************************************<br />
3 0,6719 9,06 ********************************************************************<br />
4 0,5764 7,77 **********************************************************<br />
5 0,5445 7,34 *******************************************************<br />
6 0,5068 6,83 ***************************************************<br />
7 0,4731 6,38 ************************************************<br />
8 0,4376 5,9 *********************************************<br />
9 0,3839 5,17 ***************************************<br />
10 0,3562 4,8 ************************************<br />
101
11 0,3365 4,54 **********************************<br />
12 0,3257 4,39 *********************************<br />
13 0,2711 3,65 ****************************<br />
14 0,2454 3,31 *************************<br />
15 0,2152 2,9 **********************<br />
Il primo fattore individuato “incremento della qualità di vita”, evidenzia una<br />
dimensione tematica piuttosto specifica e precisa, senza però fare riferimento ad<br />
attività concrete, sottolinea un obiettivo generale che si intende perseguire ed è<br />
saturato principalmente dai termini: migliorare (C.A.=7,6) e qualità (C.A.=5,8). Il<br />
secondo fattore evidenzia invece aree tematiche connesse con la “promozione e<br />
creazione di attività”. Esso è saturato principalmente da termini come: promuovere<br />
(C.A.=8,8), fare (C.A.=8,5), ragazzi (C.A.=7,9) e creare (C.A.=7,1). Questo fattore a<br />
differenza del primo evidenzia una modalità attraverso cui raggiungere determinati<br />
obiettivi. Il Grafico 2 rappresenta le principali aree tematiche emerse su un piano<br />
car<strong>tesi</strong>ano, in cui F1 e F2 si incrociano.<br />
Grafico 2: grafico ottenuto dall’incrocio di F1 e F2<br />
102
F2: Promozione e creazione di attività<br />
1,00<br />
0,00<br />
-1,00<br />
-2,00<br />
1<br />
persone<br />
rispetto maggior<br />
migliorare<br />
disabili<br />
qualità<br />
2<br />
costruire<br />
6<br />
-2,00<br />
educare<br />
andare<br />
crea<br />
-1,00<br />
F1: Incremento qualità di vita<br />
103<br />
stesso<br />
professionale<br />
0,00<br />
memoria<br />
3<br />
raccoglie<br />
fare<br />
gente<br />
storia<br />
dare<br />
attraverso<br />
solitamente<br />
vari<br />
turismo<br />
promuovere<br />
5 ragazzi<br />
1,00<br />
piacere<br />
conoscere<br />
Il grafico 2 è il risultato della proiezione delle forme grafiche derivate dall’incrocio<br />
di F1 con F2. I soci parlano degli obiettivi dei loro progetti divedendo le risposte in<br />
sei macro aree semantiche. Come si può notare, i vocaboli sono distribuiti in tutto il<br />
piano car<strong>tesi</strong>ano, ciò significa che gli obiettivi dei progetti sono piuttosto specifici ed<br />
eterogenei; infatti ad eccezione dei termini “qualità” e “conoscere”, i vocaboli hanno<br />
una collocazione grafica non a ridosso degli assi car<strong>tesi</strong>ani. I temi più comuni (sia<br />
per collocazione grafica che per frequenza) all’interno delle interviste relativamente<br />
alla domanda numero 2 sono: la qualità e la conoscenza.<br />
1. Partendo dal quadrante in alto a sinistra, si evidenzia una prima area semantica,<br />
che potremmo definire “l’area delle persone”. L’obiettivo dei progetti è quello di far<br />
incontrare persone, creare un punto di incontro e discussione, con lo scopo di<br />
“educarle” ad un maggior rispetto di sé stesse e di ciò che le circonda. Questo aspetto<br />
4
è ben esplicitato da una risposta di un socio secondo cui “lo scopo del progetto è<br />
dare la possibilità alle persone di trovare un luogo di discussione e confronto per<br />
realizzare dei modi migliori di condurre la propria esistenza.”.<br />
2. La seconda area semantica si colloca, molto vicino all’asse X. E’ un’area molto<br />
comune tra le risposte date dai vari soggetti, e potrebbe essere definita l’area della<br />
“qualità di vita”. Per molti progetti, l’obiettivo generale è un miglioramento della<br />
qualità in generale, ma soprattutto della qualità della vita di tutte le persone, con una<br />
particolare attenzione a chi ha problemi di handicap.<br />
Il fatto che questo aspetto sia caro ai soci, evidenzia l’esistenza di una sintonia tra gli<br />
obiettivi associativi (in generale) e gli obiettivi dei progetti realizzati; infatti<br />
l’obiettivo che <strong>Wigwam</strong> si pone è proprio questo: portare ad un miglioramento della<br />
qualità di vita.<br />
3. In alto a destra, troviamo una terza area semantica che potremmo chiamare l’area<br />
della “memoria”, si tratta di progetti che hanno come obiettivo il recupero della<br />
memoria storica, delle tradizioni, e cercano di dare spazio a tutte quelle persone che<br />
raccolgono materiale, leggono, scrivono e sono interessate al recupero della storia<br />
vissuta. Anche quest’area è forse spiegata nel modo migliore dalle parole di un<br />
intervistato: “lo scopo è quello di creare una memoria collettiva che sia cosciente<br />
delle cose andate perdute”.<br />
4. Sempre nello stesso quadrante è presente un’altra area semantica, vicina a quella<br />
sopracitata sia a livello spaziale che di contenuto, l’area “storica”. Si tratta di progetti<br />
che hanno lo scopo di divulgare la storia, i valori tradizionali ma soprattutto le<br />
usanze tipiche e i patrimoni territoriali. Come si può notare è un’area fortemente<br />
interconnessa con la precedente.<br />
5. La quinta area semantica è abbastanza numerosa, potrebbe essere definita l’area<br />
della “promozione”; riguarda tutti quei progetti che hanno lo scopo di promuovere un<br />
turismo più sostenibile, la presenza di figure professionali sul territorio,<br />
l’integrazione tra giovani. Un soggetto risponde in questo modo: “dare<br />
un’alternativa, promuovere realtà differenti da quelle solitamente conosciute e che<br />
siamo abituati a considerare”.<br />
104
6. L’ultima area semantica potrebbe essere definita l’area “dell’attività”. Infatti essa<br />
è costituita interamente da verbi, che sottolineano le azioni che i progetti cercano di<br />
svolgere e che riguardano principalmente l’area dell’educazione (per esempio<br />
educare i non disabili), della possibilità di creare (per esempio creare alternative), di<br />
costruire qualcosa “con le proprie mani” e di andare incontro alle esigenze delle<br />
persone.<br />
Per quanto riguarda l’incrocio tra F1 e F3, F2 e F3, non verranno riportati qui i<br />
grafici, in quanto non sono presenti aree semantiche che già non fossero presenti<br />
nell’incrocio tra F1 e F2. Comunque, per chiarezza metodologica, in Appendice B<br />
(tabelle 3 e 4) è riportato il vocabolario e le coordinate derivate dall’incrocio con il<br />
terzo fattore, con un C.A. di 2,27 (100/44).<br />
5.1.3 CHI SONO I BENEFICIARI<br />
Questa domanda prevedeva una risposta molto breve, pertanto non è stata sottoposta<br />
ad analisi fattoriale, ma si è semplicemente fatto un conteggio del vocabolario<br />
presente nelle risposte.<br />
I beneficiari dei progetti <strong>Wigwam</strong> si dividono in due grandi categorie:<br />
1. Progetti che si rivolgono a chiunque sia interessato, indistintamente;<br />
2. Progetti che si rivolgono prevalentemente ai soci, ma con una forte<br />
apertura a chiunque ne sia interessato.<br />
TIPO DI PROGETTO FREQUENZA<br />
1. Per tutti 19<br />
2. Per i soci 4<br />
105
Emerge la tendenza dell’associazione ad investire in progetti che coinvolgano<br />
tutti, indistintamente. Nello specifico tra i 19 progetti della categoria 1:<br />
- uno rivolge una particolare attenzione alle persone con disabilità,<br />
- due si rivolgono prevalentemente ai giovani,<br />
- due si rivolgono prevalentemente alle scuole e ai bambini.<br />
Il fatto che il 25% dei progetti proposti ponga particolare attenzione ai bambini e ai<br />
giovani si rivela in stretta sintonia con la filosofia associativa, che fin dalle sue<br />
origini ha posto una particolare attenzione al fattore educativo (Cap 1, p.5). Si può<br />
pertanto ipotizzare, dalle risposte a questa domanda, un senso di continuità nei valori<br />
e nelle proposte associative.<br />
5.1.4 . QUALE TIPO DI SUPPORTO LE HA OFFERTO L’ASSOCIAZIONE PER<br />
LA REALIZZAZIONE DEL SUO PROGETTO?<br />
Relativamente a questa domanda la procedura ASPAR ha consentito di individuare la<br />
presenza di due fattori significativi, intorno ai quali si concentrano le risposte dei<br />
soggetti. Il vocabolario iniziale era composto da 162 parole distinte (53,8% sul<br />
vocabolario totale), ridotto a 23 vocaboli dopo il file CORTE ed il taglio di soglia. Il<br />
valore del contributo medio non è stato considerato, vista l’esiguità del vocabolario,<br />
pertanto nel grafico sono state proiettate tutte le 23 forme grafiche derivate<br />
dall’analisi fattoriale (Appendice B, Tab. 5). La tabella C raffigura l’istogramma<br />
ottenuto attraverso l’analisi fattoriale, che ha consentito di individuare la presenza di<br />
due fattori significativi, che spiegano il 29,42% della varianza totale.<br />
Tabella C: Istogramma dei valori propri della domanda 4.<br />
Fattore Valore proprio %<br />
1 0,7427 14,81 ********************************************************************************<br />
2 0,6823 13,61 **************************************************************************<br />
106
3 0,6088 12,14 ******************************************************************<br />
4 0,5187 10,35 ********************************************************<br />
5 0,4761 9,49 ****************************************************<br />
6 0,3786 7,55 *****************************************<br />
7 0,3609 7,2 ***************************************<br />
8 0,3204 6,39 ***********************************<br />
9 0,2344 4,67 **************************<br />
10 0,1751 3,49 *******************<br />
11 0,1617 3,22 ******************<br />
12 0,0955 1,9 ***********<br />
13 0,0771 1,54 *********<br />
14 0,065 1,3 ********<br />
15 0,0537 1,07 ******<br />
Lungo il primo fattore individuato “sostegno concreto” si evidenziano aree tematiche<br />
connesse con aiuti pratici ricevuti dall’associazione. Esso è saturato principalmente<br />
dai termini: sostegno (C.A.=20,3), informazioni (C.A.=35), rapporti (C.A.=5,9). Il<br />
secondo fattore “sostegno generico e ideativo” evidenzia invece aree tematiche<br />
collegate ad aspetti più indefiniti come le idee (C.A.=44,4), l’aiuto generale (C.A.=<br />
12,7), gli obiettivi (C.A.=5,1). Il Grafico 3 rappresenta le principali aree tematiche<br />
emerse, su un piano car<strong>tesi</strong>ano, in cui F1 e F2 si incrociano.<br />
Grafico 3: grafico ottenuto dall’incrocio di F1 e F2<br />
107
F2: Sostegno generico e ideativo<br />
2,00<br />
1,00<br />
0,00<br />
-1,00<br />
-2,00<br />
-3,00<br />
-4,00<br />
1<br />
avere<br />
sostegno<br />
rapporti<br />
informazioni<br />
7<br />
-2,00<br />
-1,00<br />
F1: Sostegno concreto<br />
obiettivi ampio<br />
2<br />
supporto<br />
pubblicazione<br />
pubblicità 4<br />
principale visibilità<br />
3<br />
conoscenza<br />
possibilità fare<br />
108<br />
0,00<br />
circoli<br />
aiuto<br />
I vocaboli più significativi, che presentano una frequenza più alta e un contributo<br />
assoluto particolarmente elevato sono: sostegno, visibilità, informazioni, supporto e<br />
aiuto. Sono queste le aree che i soci hanno citato più frequentemente, in cui<br />
l’associazione ha fornito maggiore supporto. In generale, dal grafico emergono 7<br />
aree:<br />
1. Nella prima area i soci sottolineano il fatto che l’associazione ha fornito loro un<br />
forte sostegno, soprattutto grazie alla possibilità di avere rapporti personali<br />
significativi e con persone autentiche;<br />
2.Nella seconda area i soci sottolineano che l’associazione è stata di ampio supporto<br />
soprattutto perché c’è una condivisione degli obiettivi, sono presenti finalità comuni;<br />
3.La terza area, si colloca al centro del grafico, vicina al punto zero, è l’area citata<br />
più comunemente dai soci. Il supporto principale che l’associazione ha fornito<br />
1,00<br />
6<br />
5<br />
idee<br />
2,00
iguarda la visibilità. La diffusione del proprio progetto è quindi l’area in cui i soci si<br />
sentono maggiormente supportati;<br />
4.La quarta area è strettamente interconnessa con la terza, e riguarda il supporto<br />
ricevuto dall’associazione relativamente all’aspetto pubblicitario e alla possibilità di<br />
pubblicare alcuni lavori (come raccolte di poesie, racconti popolari..);<br />
5.La quinta area riguarda soprattutto l’aiuto ricevuto per la creazione del proprio<br />
circolo. Si tratta di un aiuto prevalentemente logistico, di consigli a livello giuridico e<br />
normativo;<br />
6.La sesta area riguarda le idee, si differenzia dalle altre in quanto sottolinea il ruolo<br />
attivo svolto dall’associazione; per alcuni soci il maggior supporto ricevuto riguarda<br />
il fatto che l’associazione ha proposto alcune idee che sono state effettivamente<br />
attuate;<br />
7. L’ultima area riguarda le informazioni, si tratta di un supporto associativo<br />
rilevante visto che è stata citata dal 28,57% dei soci.<br />
5.1.5 SECONDO LEI QUALI SONO GLI ASPETTI PIÙ IMPORTANTI DI<br />
CUI TIENE CONTO L’ORGANIZZAZIONE QUANDO QUALCUNO<br />
PROPONE UN PROGETTO?<br />
Relativamente a questa domanda la procedura ASPAR ha consentito di individuare la<br />
presenza di tre fattori intorno ai quali si concentrano le risposte dei soggetti. Il<br />
vocabolario iniziale era composto da 194 parole distinte (47,4% sul vocabolario<br />
totale), ridotto a 28 vocaboli dopo il file CORTE ed il taglio di soglia. Il valore del<br />
contributo medio non è stato considerato vista l’esiguità del vocabolario, pertanto,<br />
nel grafico sono state proiettate tutte le forme grafiche derivate dall’analisi fattoriale<br />
(Appendice B, Tab. 6). La tabella D, raffigura l’istogramma ottenuto attraverso<br />
l’analisi fattoriale che ha consentito di individuare la presenza di tre fattori<br />
significativi. Dall’analisi fattoriale e dall’incrocio tra F1 e F3, e tra F2 e F3, non<br />
emergono aree semantiche differenti da quelle presenti nel grafico ottenuto<br />
dall’incrocio tra F1 e F2; per questo motivo verrà analizzato soltanto il primo<br />
grafico. In Appendice B (Tabella 7 e 8) sono presenti per chiarezza metodologica le<br />
109
coordinate e i relativi contributi assoluti derivati dall’incrocio di tutti e tre i fattori. I<br />
fattori che qui consideriamo (1 e 2) spiegano il 22,7% della varianza totale.<br />
110
Tabella D: Istogramma dei valori propri della domanda 5.<br />
Fattore<br />
Valore<br />
proprio %<br />
1 0,8042 12,62 ********************************************************************************<br />
2 0,6885 10,8 *********************************************************************<br />
3 0,6637 10,41 *******************************************************************<br />
4 0,6066 9,52 *************************************************************<br />
5 0,5785 9,08 **********************************************************<br />
6 0,4738 7,44 ************************************************<br />
7 0,4236 6,65 *******************************************<br />
8 0,3678 5,77 *************************************<br />
9 0,3161 4,96 ********************************<br />
10 0,2818 4,42 *****************************<br />
11 0,241 3,78 ************************<br />
12 0,1938 3,04 ********************<br />
13 0,1512 2,37 ****************<br />
14 0,135 2,12 **************<br />
15 0,1266 1,99 *************<br />
Entrambe le dimensioni fattoriali individuate evidenziano criteri decisionali<br />
abbastanza specifici, e sono fortemente saturate (in entrambe i casi) da<br />
un’unica forma verbale:<br />
- Gli obiettivi, ovvero la compatibilità degli obiettivi progettuali con quelli<br />
associativi, presentano un CA del 31,5% per F1,<br />
- La sostenibilità, che presenta un CA del 42,5% per F2.<br />
111
Grafico 4: grafico ottenuto dall’incrocio di F1 e F2<br />
F2: Sosenibilità<br />
6,00<br />
4,00<br />
2,00<br />
0,00<br />
-2,00<br />
-4,0<br />
società<br />
1<br />
-3,0<br />
obiettivi<br />
tempi<br />
-2,0<br />
F1: Compatibilità degli obiettivi<br />
compatibilità<br />
6<br />
coerenza<br />
112<br />
risorse<br />
-1,0<br />
proposta<br />
voglia<br />
validità<br />
associativi<br />
valori<br />
qualità<br />
progetto<br />
insieme<br />
valutare<br />
rispettati<br />
vita<br />
territorio<br />
club<br />
0,0<br />
1,0<br />
sostenibilità<br />
Dal punto di vista delle frequenze, i vocaboli più significativi sono “qualità del<br />
progetto”; si tratta dell’aspetto che più frequentemente è stato riportato dagli<br />
intervistati, infatti 10 soggetti su 21, lo indicano come uno dei criteri fondamentali di<br />
scelta relativamente all’attuazione di un progetto.<br />
Emerge che l’associazione utilizza, come criterio generale di scelta per l’attuazione<br />
di un progetto, la compatibilità e la coerenza con i valori associativi, con particolare<br />
attenzione alla qualità e alla sostenibilità.<br />
Questi aspetti significativi si possono evincere anche dal grafico:<br />
1. Dall’area 1 emerge come criterio importante di scelta la compatibilità degli<br />
obiettivi progettuali con i valori dell’associazione <strong>Wigwam</strong>, definita dai soci<br />
come una specie di “società”;<br />
2<br />
5<br />
3<br />
4<br />
2,0
2. L’area 2 sottolinea nuovamente l’importanza della coerenza del progetto con<br />
i valori proposti, che però dev’essere associata ad un’idea, un’iniziativa<br />
valida;<br />
3. La terza area, come già citato in precedenza, evidenzia l’importanza della<br />
sostenibilità;<br />
4. La quarta area sottolinea l’importanza per i progetti, di rispettare i valori<br />
territoriali e realizzare iniziative che “rispettino la vita” e che portino ad una<br />
valorizzazione delle persone. Un socio risponde: “La cosa principale è<br />
l’aspetto umano, se è un progetto che avvalora la persona, se coinvolge la<br />
gente, crea scambio e incontro; insomma soprattutto l’aspetto comunicativo<br />
con le persone”.<br />
5. La quinta area è estremamente significativa, in quanto tratta aspetti<br />
frequentemente citati dai soci, che considerano un prerequisito fondamentale<br />
il fatto che il progetto porti ad un miglioramento della qualità di vita delle<br />
persone e del territorio. In quest’area viene anche evidenziato il criterio di<br />
selezione dei progetti: “si valuta e se ne discute insieme”. Non esiste un<br />
criterio rigido, ma si valuta di volta in volta discutendo in gruppo. C’è<br />
pertanto un approccio democratico che però non è formalmente definito.<br />
Questo aspetto è estremamente importante ai fini della ricerca in questione,<br />
che cerca di evidenziare le costanti metodologiche che contraddistinguono<br />
<strong>Wigwam</strong>;<br />
6. L’ultima area evidenzia l’importanza che il progetto sia compatibile con le<br />
risorse a disposizione e abbia dei tempi di attuazione chiari e non<br />
eccessivamente lunghi. Si evidenzia dunque l’importanza della realizzabilità<br />
effettiva di un progetto, in modo da limitare i fallimenti dovuti ad una carente<br />
progettazione.<br />
5.1.6 COM’È ENTRATO A FAR PARTE DI QUEST’ASSOCIAZIONE?<br />
113
Questa domanda non è stata analizzata attraverso la procedura ASPAR, in<br />
quanto richiedeva una risposta molto breve. E’ stata quindi creata una<br />
procedura SPADt in modo da poterne analizzare il vocabolario. Come si può<br />
notare dalla Tabella E, i soci hanno conosciuto l’associazione prevalentemente<br />
attraverso il passaparola (10 persone attraverso un socio, 4 attraverso un amico<br />
comune che conosceva <strong>Wigwam</strong>), 3 attraverso Civitas, mentre le altre<br />
modalità hanno una frequenza molto bassa. Possiamo affermare che si conosce<br />
l’associazione non tanto grazie alla pubblicità o al sito internet, ma per mezzo<br />
di conoscenze personali e rapporti interpersonali (66,67%); va inoltre<br />
specificato che il 19% dei soggetti conosceva <strong>Wigwam</strong> (per nome, o per le<br />
attività proposte) ancora prima di farne parte.<br />
Tabella E: vocabolario domanda 8.<br />
VOCABOLI FREQ<br />
membro_già_socio 10<br />
amico_comune 4<br />
conoscevo_già 4<br />
civitas 3<br />
rivista 1<br />
per_lavoro 1<br />
per_caso 1<br />
sito_internet 1<br />
114
5.1.7 . PERCHÉ RIMANE ALL’INTERNO DI QUEST’ASSOCIAZIONE?<br />
Questa domanda indaga le motivazioni che spingono i soci a continuare la vita<br />
associativa. Il vocabolario è composto da 171 parole distinte, corrispondenti al<br />
50,6% del vocabolario totale. Le parole sono state ridotte a 33 dopo il file<br />
corte e il taglio di soglia. Il contributo medio è di 3,03, per questo motivo nel<br />
grafico sono state proiettate le forme grafiche con un contributo maggiore o<br />
uguale a tre (Appendice B, Tabella 9).<br />
L’analisi fattoriale (Tabella F) ha permesso l’individuazione di due fattori<br />
significativi, attorno ai quali si collocano le motivazioni che spingono le<br />
persone a restare all’interno di <strong>Wigwam</strong> (Grafico 5) e che spiegano il 21,78%<br />
della varianza totale.<br />
Tabella F: Istogramma dei valori propri della domanda 9.<br />
Valore<br />
proprio %<br />
Fattore<br />
1 0,7796 11,72 ********************************************************************************<br />
2 0,7048 10,6 *************************************************************************<br />
3 0,6476 9,74 *******************************************************************<br />
4 0,5835 8,77 ************************************************************<br />
5 0,543 8,17 ********************************************************<br />
6 0,4953 7,45 ***************************************************<br />
7 0,4266 6,42 ********************************************<br />
8 0,3932 5,91 *****************************************<br />
9 0,3549 5,34 *************************************<br />
10 0,3492 5,25 ************************************<br />
11 0,2962 4,45 *******************************<br />
12 0,27 4,06 ****************************<br />
13 0,1988 2,99 *********************<br />
14 0,1928 2,9 ********************<br />
15 0,0645 0,97 *******<br />
Le motivazioni che spingono a rimanere all’interno dell’associazione sono<br />
riconducibili a due fattori che evidenziano:<br />
- Motivi legati all’associazione: all’interno di F1 (chiamato “valori proposti”)<br />
emergono principalmente aree tematiche connesse con l’interesse dei valori<br />
115
F2: Possibilità di coltivare interessi<br />
proposti dall’associazione. Esso è saturato principalmente dai termini valore<br />
(C.A.=8,8) e propongono (C.A.=7,2).<br />
- Motivi intrapersonali: all’interno di F2 (chiamato “possibilità di coltivare<br />
interessi”) emergono principalmente aree tematiche connesse alla possibilità<br />
di coltivare interessi personali. Esso è saturato principalmente dai termini<br />
interesse (C.A.=17,3) e permette (C.A.=17,5). Il grafico 5 sintetizza le aree<br />
tematiche emerse dall’incrocio di F1 e F2.<br />
2,00<br />
1,00<br />
0,00<br />
-1,00<br />
propongono<br />
-2,00<br />
progetto<br />
bene<br />
F1: Valori proposti<br />
idea<br />
valore<br />
utile molto<br />
-1,00<br />
momento<br />
credo<br />
interesse<br />
trovo<br />
piacevole<br />
116<br />
contatto<br />
Grafico 5: grafico ottenuto dall’incrocio di F1 e F2.<br />
condivido<br />
0,00<br />
permette<br />
confronto<br />
3<br />
possibilità<br />
vedere<br />
finalità<br />
fare<br />
desidero<br />
1,00<br />
continuando<br />
rete<br />
vita<br />
sento<br />
5<br />
sono<br />
Il grafico evidenzia come le motivazioni dei soci si organizzino in sette aree<br />
semantiche:<br />
1<br />
7<br />
2<br />
6<br />
4
1. Uno degli aspetti che spinge i soci a restare all’interno di <strong>Wigwam</strong> è considerare i<br />
progetti in atto “utili”; l’attività proposta non è fine a se stessa, ma presenta aspetti<br />
che i soci valutano come progetti di rilevanza sociale.<br />
2. La seconda area riguarda la sfera dei rapporti interpersonali, che costituiscono un<br />
collante importante per i soci. Una delle motivazioni che spinge i soci a continuare a<br />
far parte di <strong>Wigwam</strong> è il fatto che permette loro di trascorrere momenti piacevoli<br />
grazie alla possibilità di instaurare rapporti e scambi con persone interessanti.<br />
3. La terza area presenta aspetti di similarità con la seconda, e riguarda l’importanza<br />
del confronto. Alcuni soci sottolineano l’esistenza di confronti costruttivi all’interno<br />
dell’associazione per ricercare di volta in volta le soluzioni qualitativamente migliori.<br />
4. La quarta area riguarda la rete sociale. Il sentirsi parte di una rete sociale è una<br />
delle motivazioni più importanti che spinge i soci a continuare a far parte di<br />
<strong>Wigwam</strong>. Un socio risponde: “il sentirsi parte di una rete sociale permette di non<br />
sentirsi soli”. Non si tratta però di una rete qualunque, essa permette alle persone di<br />
continuare a fare ciò che desiderano, di essere in contatto con persone che hanno lo<br />
stesso modo di “vedere la vita”, e questa assonanza di fondo spinge a sua volta le<br />
persone a fare maggiormente rete.<br />
5. La quinta area riguarda il sentirsi bene all’interno dell’associazione, la possibilità<br />
di essere sé stessi e l’avere una visione comune della vita. Quest’area è ben spiegata<br />
dalle parole di un soggetto: “Di fondo c’è assonanza, mi trovo bene, sto bene con le<br />
persone, sto bene con la tipologia di progetti che attuano, mi appaga..”.<br />
6. La sesta area riguarda la condivisione delle finalità e degli obiettivi che<br />
l’associazione propone.<br />
7. L’ultima area il percepire come “positive” le attività proposte, e il credere<br />
personalmente nei valori e nelle idee proposte.<br />
5.1.8 CONCLUSIONI<br />
Dall’analisi della prima area di intervista emerge che:<br />
117
- I progetti nascono da interessi o desideri che i soggetti avvertivano già prima<br />
di conoscere l’associazione, ma anche dalla percezione di un deficit o di una<br />
carenza a livello sociale. Le aree principali di cui si occupano i progetti sono:<br />
la solidarietà, l’handicap, le tradizioni territoriali, il recupero culturale,<br />
l’incontro tra persone e i giovani.<br />
- Il ruolo dell’associazione relativamente alla nascita dei progetti è quello di<br />
fornire un gruppo di supporto con cui i soggetti si identificano e si propone<br />
come un mezzo per la realizzazione di un desiderio, per l’approfondimento di<br />
un interesse o per colmare un deficit che i soggetti percepivano come<br />
importante a livello personale o sociale.<br />
- Gli obiettivi progettuali sono eterogenei, ma gli aspetti che risultano<br />
maggiormente significativi sono: il miglioramento della qualità di vita e la<br />
possibilità di conoscere nuove prospettive. Da questa risposta è possibile<br />
ipotizzare una sintonia e una continuità tra gli obiettivi associativi e gli<br />
obiettivi progettuali.<br />
- I progetti si rivolgono a chiunque, senza alcun tipo di preclusione (né<br />
ideologica, né politica né sociale.<br />
- Per quanto riguarda il supporto ricevuto dall’associazione, l’aspetto più<br />
frequentemente sottolineato è quello della visibilità, ma anche l’aspetto<br />
informativo, il sostegno e il supporto ricevuto grazie alla possibilità di avere<br />
rapporti interpersonali significativi e la condivisione di obiettivi comuni.<br />
- Per decidere l’attuazione di un progetto, non esistono criteri decisionali<br />
formalmente definiti. Secondo i soci, la scelta di attuazione dipende sia dalla<br />
compatibilità e coerenza con i valori associativi, sia dalla qualità e sostenibilità<br />
del progetto.<br />
- I soci conoscono l’associazione prevalentemente attraverso il passaparola,<br />
ma continuano a farne parte perché percepiscono i progetti come utili, perché<br />
118
traggono gratificazione dai rapporti interpersonali instaurati, perché ne<br />
condividono finalità e valori e perché rappresenta un luogo di scambio e<br />
confronto. L’essere parte di un gruppo e di una rete sociale con cui è possibile<br />
identificarsi è la motivazione più importante che spinge i soci a restare<br />
all’interno dell’associazione. Al di là dei risvolti pragmatici dei progetti, i soci<br />
evidenziano soprattutto l’importanza di fare parte di una realtà gruppale con<br />
cui si identificano.<br />
5.2 I CIRCOLI DI QUALITA’<br />
L’intervista ha come secondo obiettivo quello di verificare se all’interno dei<br />
diversi club <strong>Wigwam</strong> vengano applicati i circoli di qualità. Le domande<br />
pertanto indagano le principali caratteristiche che contraddistinguono i circoli<br />
(Cap.3).<br />
5.2.1 QUALI SONO I PROBLEMI PRINCIPALI CHE AFFRONTATE<br />
ALL’INTERNO DEL VOSTRO CLUB?<br />
Questa domanda è stata analizzata attraverso la procedura ASPAR che ha consentito<br />
l’individuazione di due fattori intorno ai quali si concentrano le risposte dei soggetti.<br />
Il vocabolario iniziale è composto da 168 parole distinte (54,4% sul vocabolario<br />
totale), ridotto a 23 vocaboli dopo il file CORTE ed il taglio di soglia. Il valore del<br />
contributo medio non è stato considerato vista l’esiguità del vocabolario, e nel<br />
grafico sono state proiettate tutte le forme grafiche derivate dall’analisi fattoriale<br />
(Appendice B, Tab. 10). La tabella G raffigura l’istogramma ottenuto attraverso<br />
l’analisi fattoriale che ha consentito di individuare la presenza di due fattori<br />
significativi che spiegano il 23,72% della varianza totale. La proiezione grafica delle<br />
forme verbali è riportata nel grafico 6.<br />
Tabella G: Istogramma dei valori propri della domanda 12.<br />
Fattore Valore proprio %<br />
119
1 0,6117 12,13 ********************************************************************************<br />
2 0,5848 11,59 *****************************************************************************<br />
3 0,5579 11,06 *************************************************************************<br />
4 0,5109 10,13 *******************************************************************<br />
5 0,4953 9,82 *****************************************************************<br />
6 0,414 8,21 *******************************************************<br />
7 0,3693 7,32 *************************************************<br />
8 0,2854 5,66 **************************************<br />
9 0,2694 5,34 ************************************<br />
10 0,2445 4,85 ********************************<br />
11 0,2103 4,17 ****************************<br />
12 0,1513 3 ********************<br />
13 0,115 2,28 ****************<br />
14 0,078 1,55 ***********<br />
15 0,0653 1,29 *********<br />
Il primo fattore individuato “diffusione e valorizzazione delle iniziative” è<br />
saturato principalmente dai vocaboli valorizzazione (C.A.=11,3), diffondere<br />
(C.A.=12,1) e diffidenza (C.A.=8,8). Esso riguarda principalmente lemmi e<br />
aree tematiche che sottolineano difficoltà nel farsi conoscere e nel divulgare<br />
maggiormente le iniziative. Il secondo fattore invece “difficoltà concrete e<br />
organizzative” evidenzia problemi di tipo logistico e gestionale. Le parole con<br />
il contributo assoluto più alto per il secondo fattore sono: mancanze<br />
(C.A.=13,4), organizzativi (C.A.=11,2), logistici (C.A.=10,4), fare rete<br />
(C.A.=6,9).<br />
Indipendentemente dall’analisi fattoriale, a livello di frequenze, i problemi principali<br />
che devono affrontare i soci sono di tipo economico (riportati da 15 soggetti, 71,43%<br />
del campione), seguiti da quelli amministrativi e logistici (riportati dal 38% del<br />
campione).<br />
Grafico 6: grafico ottenuto dall’incrocio di F1 e F2.<br />
120
F2: Difficoltà concrete e organizzative<br />
1,0<br />
0,0<br />
-1,0<br />
-2,0<br />
-3,00<br />
essere<br />
1<br />
valorizzazione<br />
riconoscimenti<br />
amministrativi<br />
-2,00<br />
conoscenza<br />
-1,00<br />
121<br />
problema<br />
0,00<br />
F1: Diffusione e valorizzazione delle iniziative<br />
3<br />
diffondere<br />
comunicazione<br />
relativi<br />
progetti<br />
sforzi<br />
economici<br />
iniziativa<br />
attività<br />
persone<br />
organizzativi<br />
logistici<br />
mancanza_tempo<br />
fare_rete<br />
aiuto<br />
1,00<br />
diffidenza<br />
mancanza<br />
In generale il grafico evidenzia 9 macro aree di problemi incontrati dai soci:<br />
2<br />
1. La prima area sottolinea la difficoltà ad esistere, a continuare nelle attività<br />
proposte, il semplice “esserci” per alcuni circoli risulta problematico.<br />
2. La seconda area riguarda i problemi amministrativi, e la difficoltà nel valorizzare i<br />
riconoscimenti e i successi ottenuti.<br />
3. La terza area, riguarda la comunicazione, ma non in senso interpersonale o intraassociativa,<br />
ma nei rapporti con l’esterno. Alcuni soci sottolineano la difficoltà nel<br />
divulgare le iniziative, nel coinvolgere persone nuove, nel far conoscere i progetti in<br />
atto. Trattandosi di progetti che si autofinanziano, quest’area di criticità risulta<br />
estremamente importante, in quanto sono i rapporti extra associativi che permettono<br />
ai progetti di continuare nelle loro attività.<br />
7<br />
4<br />
9<br />
6<br />
8<br />
5<br />
2,00
4. La quarta area evidenzia la presenza di difficoltà logistiche in alcuni circoli, che<br />
percepiscono come problematici alcuni aspetti di gestione organizzativa.<br />
5. La quinta area è strettamente interconnessa con la terza, in quanto per alcuni<br />
progetti il problema principale è lo scontro con la diffidenza delle persone,<br />
proponendo valori diversi da quelli proposti dalla società odierna.<br />
6. La sesta area riguarda la mancanza di tempo da dedicare alle attività associative,<br />
sia per questioni lavorative che personali.<br />
7. La settima area è quella più frequentemente riportata dai soci, e riguarda le<br />
difficoltà economiche che vivono i Club di progetto. Viene sottolineato come non<br />
esista una corrispondenza tra gli sforzi messi in atto, le energie investite e i risultati<br />
economici. Si tratta di un’area che merita una riflessione, in quanto pur trattandosi di<br />
un’associazione non profit, una mancata corrispondenza tra sforzi e risultati può<br />
portare a demotivazione (Karasek e Theorell, 1990) 19 .<br />
8. L’ottava area riguarda la difficoltà nel fare rete. Alcuni soci sottolineano che<br />
alcune iniziative avrebbero bisogno di aiuto, che a volte risulta carente per le<br />
difficoltà nel fare rete.<br />
9. L’ultima area riguarda la carenza di aiuto percepito soprattutto a livello<br />
istituzionale.<br />
5.2.2 EFFETTUATE INCONTRI PERIODICI PER DISCUTERE E RISOLVERE I<br />
PROBLEMI? CON QUALE FREQUENZA?<br />
Questa domanda rappresenta un prerequisito fondamentale per poter parlare di circoli<br />
di qualità; come già esplicitato in precedenza i circoli hanno lo scopo di identificare e<br />
risolvere i problemi della propria area di lavoro attraverso incontri periodici. A<br />
questa domanda soltanto due intervistati hanno risposto in modo affermativo,<br />
sostenendo di effettuare costantemente incontri per la risoluzione delle difficoltà<br />
incontrate ogni dieci giorni circa.<br />
19<br />
Il modello “domanda/controllo” di Karasek e Theorell, e altri studi sullo stress sono approfonditi nel<br />
Cap.2, p.29.<br />
122
I restanti 19 soggetti hanno risposto in modo negativo. Nello specifico tutti i soggetti<br />
hanno sostenuto di avere frequenti contatti informali tra loro. La gestione dei<br />
problemi si colloca dunque ad un livello informale, affrontando le difficoltà “quando<br />
si presentano”. La mancata presenza di strutturazione nella risoluzione dei problemi<br />
limita gli approcci di risoluzione ad incontri informali e questo non consente di<br />
affermare che all’interno di <strong>Wigwam</strong> vengano applicati i principi dei circoli di<br />
qualità.<br />
Va però specificato che nessuno dei soggetti percepisce questo aspetto come<br />
problematico (Par 5.2.1, p.40), e ad un livello descrittivo ogni circolo gestisce i<br />
propri problemi e ricerca delle soluzioni in modo autonomo, proponendo soluzioni di<br />
volta in differenti. L’approccio quindi da un punto di vista teorico si avvicina molto<br />
alla filosofia proposta dai circoli.<br />
I circoli di qualità si sono sviluppati in ambito lavorativo 20 , e la loro applicazione in<br />
associazioni (come quella qui considerata) probabilmente richiede una maggiore<br />
elasticità, in quanto si tratta di un’attività a cui i soggetti possono dedicare una<br />
quantità di tempo limitata, trattandosi di una partecipazione di tipo volontario che<br />
non coincide con l’attività lavorativa.<br />
E’ altrettanto vero che, in vista di possibili ampliamenti associativi, fornire ai<br />
soggetti partecipanti degli strumenti per la gestione dei problemi, probabilmente<br />
renderebbe più solido l’apparato metodologico dell’associazione.<br />
Queste ultime considerazioni si collocano solamente ad un livello ipotetico, in<br />
quanto con i dati a nostra disposizione è solo possibile affermare che all’interno di<br />
<strong>Wigwam</strong> non vengono applicati i circoli di qualità, ma è altrettanto importante a mio<br />
avviso contestualizzare la realtà in cui si colloca questa affermazione.<br />
Per completezza descrittiva, di seguito sono riportate altre caratteristiche degli<br />
incontri che svolgono tra loro i soci, anche se non si tratta di incontri costanti e con<br />
modalità strutturata.<br />
20 Non esistono in letteratura esempi di applicazioni di circoli di qualità in associazioni non profit.<br />
123
Quando questi incontri vengono svolti partecipano in media 9,2 persone, con un<br />
range compreso tra i tre e i venti soggetti. Questa variabilità è dovuta al fatto che i<br />
diversi club di progetto sono composti da un numero di soggetti estremamente<br />
variabile.<br />
La persona che si occupa di informare i soci e di gestire l’incontro è sempre il<br />
presidente del circolo, che svolge il ruolo di coordinatore e animatore (domanda<br />
numero 15).<br />
La partecipazione è sempre volontaria (domanda numero 16), in quanto all’interno<br />
dell’associazione, per filosofia, non esiste nulla di obbligatorio, e in nessun caso sono<br />
presenti ricompense o remunerazioni per questo tipo di attività (domanda numero<br />
19).<br />
Per quanto riguarda la domanda numero 17 “da chi e in che modo vengono scelti i<br />
problemi da analizzare?”, tutti i soggetti hanno risposto che tutti possono proporre<br />
questioni da analizzare, chiunque incontra una difficoltà può richiedere un incontro.<br />
Risulta estremamente esplicativa la risposta data da un soggetto: “Tutti possono<br />
chiedere un incontro per la discussione dei problemi, e compatibilmente con le<br />
esigenze quotidiane lo si fa; c’è molta disponibilità nell’aiutarsi”.<br />
Un dato che emerge dall’analisi descrittiva di queste domande è che c’è un approccio<br />
estremamente omogeneo nell’affrontare i problemi tra i vari circoli. Pur occupandosi<br />
di attività diverse, tutti i soggetti (100%) hanno risposto in modo uguale, dunque<br />
l’approccio seppur non esplicitato, è comune a tutti, senza eccezioni.<br />
L’ultimo aspetto considerato in quest’area dell’intervista è la domanda numero 18: la<br />
soddisfazione per le attività formative proposte. Quest’area indaga un aspetto<br />
rilevante sia per i circoli di qualità che per l’empowerment. I soggetti hanno risposto<br />
attraverso tre categorie principali (Tabella H):<br />
Tabella H: risposte dei soggetti alla domanda 18:<br />
RISPOSTA NUMERO<br />
SOGGETTI<br />
%<br />
Si, sono pienamente soddisfatto 9 42,86%<br />
124
Si, sono abbastanza soddisfatto 8 38,09%<br />
Altro 3 14,28%<br />
Come esposto in tabella il 42,86% dei soggetti è pienamente soddisfatto delle<br />
attività formative proposte, non modificherebbe nulla. Il 38, 09% dei soggetti<br />
invece, si di<strong>chiara</strong> abbastanza soddisfatto, anche se sostiene che queste attività<br />
andrebbero potenziate ed ampliate. La terza categoria di risposta, pur non<br />
essendo numerosa, descrive molto bene le difficoltà che un’associazione può<br />
incontrare in ambito formativo. Al riguardo sono esplicative due risposte<br />
fornite: “si, ma ogni club propone cose così diverse che l’associazione, non<br />
può essere esaustiva con la formazione”; “esistono delle possibilità, non<br />
sufficienti perché il panorama offerto da <strong>Wigwam</strong> è talmente ampio che essere<br />
specialistici in tutti gli ambiti non è possibile, non è un’associazione che si<br />
occupa solo di una cosa, quindi è impossibile coprire tutto lo spettro di<br />
attività, è difficile essere informati e informare su tutto, però si cerca di fare il<br />
possibile.”<br />
Un dato da evidenziare è il fatto che nessun soggetto si di<strong>chiara</strong> insoddisfatto<br />
dell’aspetto formativo, e che le risposte della categoria “altro”, esplicitano<br />
molto bene la difficoltà nel trovare un’attività comune a tutti i soci, visto che<br />
la peculiarità dell’associazione si colloca proprio nell’eterogeneità progettuale.<br />
5.2.3 CONCLUSIONI<br />
Dall’analisi della seconda area di intervista emerge che:<br />
- I problemi principali che i club di progetto devono affrontare riguardano<br />
principalmente la sfera economica e amministrativa.<br />
- Non è possibile affermare che all’interno di <strong>Wigwam</strong> vengono applicati i circoli di<br />
qualità, in quanto manca il prerequisito fondamentale, ovvero la presenza di incontri<br />
periodici per identificare, analizzare, risolvere e valutare i problemi che emergono<br />
dalla propria attività.<br />
125
- All’interno dell’associazione c’è un approccio informale per la risoluzione dei<br />
problemi, che non è vissuto in modo problematico dai soggetti (Dom. 10).<br />
Anche se la modalità operativa proposta dai circoli di qualità non è applicata, vi sono<br />
comunque delle aree di similarità:<br />
1. ogni club è indipendente nella scelta e risoluzione delle difficoltà,<br />
2. i soggetti sono soddisfatti delle attività formative proposte,<br />
3. c’è un approccio partecipativo, e ogni apporto personale è considerato<br />
importante,<br />
4. a livello motivazionale c’è adesione agli obiettivi e valori associativi<br />
(Domanda 22),<br />
5. la comunicazione tra soci è considerata soddisfacente.<br />
5.3 L’EMPOWERMENT<br />
Questa sezione di intervista composta da tre domande indaga alcuni aspetti relativi<br />
all’applicazione dei principi dell’empowerment all’interno dell’associazione<br />
<strong>Wigwam</strong>. Si tratta di una divisione prevalentemente metodologica, in quanto, come<br />
già esplicitato nella prima parte (Cap.2), i circoli di qualità e il lavoro di gruppo per<br />
progetti possono essere visti come una forma di empowerment work group.<br />
5.3.1 SECONDO LEI L’ASSOCIAZIONE SI AVVALE E PRENDE IN<br />
CONSIDERAZIONE LE IDEE CHE VENGONO DAI SUOI SOCI?<br />
Relativamente a questa domanda la procedura ASPAR ha consentito di individuare la<br />
presenza di due fattori, intorno ai quali si concentrano le risposte dei soggetti. Il<br />
vocabolario iniziale è composto da 57 parole distinte (42,1% sul vocabolario totale),<br />
ridotto a 10 vocaboli dopo il file CORTE ed il taglio di soglia. Il valore del<br />
contributo medio, data l’esiguità del vocabolario, non è stato considerato, sono state<br />
dunque proiettate nel grafico tutte le forme verbali (Appendice B, Tab. 11). La<br />
tabella I raffigura l’istogramma ottenuto attraverso l’analisi fattoriale che ha<br />
126
consentito di individuare la presenza di due fattori, che spiegano il 46,42% della<br />
varianza totale. La proiezione grafica delle forme verbali è riportata nel grafico 7.<br />
Tabella I: : Istogramma dei valori propri della domanda 18.<br />
Valore<br />
Proprio<br />
Fattore<br />
%<br />
1 0,667 26,23 ********************************************************************************<br />
2 0,5134 20,19 **************************************************************<br />
3 0,4511 17,74 *******************************************************<br />
4 0,2919 11,48 ************************************<br />
5 0,2777 10,92 **********************************<br />
6 0,2038 8,01 *************************<br />
7 0,1376 5,41 *****************<br />
8 0 0 *<br />
Il primo fattore individuato “compatibilità con i valori associativi” evidenzia una<br />
dimensione di senso secondo cui le idee sono considerate se possiedono una<br />
caratteristica: la compatibilità (C.A.=30,3) con i valori (C.A.=30,3) che <strong>Wigwam</strong><br />
propone.<br />
Il secondo fattore evidenzia invece la modalità decisionale utilizzata per l’attuazione<br />
di eventuali proposte: la discussione in gruppo (C.A.=50,2).<br />
127
Grafico 7: grafico ottenuto dall’incrocio di F1 e F2.<br />
F2: Modalità decisionale<br />
2,5<br />
2,0<br />
1,5<br />
1,0<br />
,5<br />
0,0<br />
-,5<br />
-1,0<br />
-1,5<br />
-2,5<br />
valori<br />
se_compatibili<br />
-2,0<br />
aperti_proposte<br />
-1,5<br />
-1,0<br />
F1: Compatibilità con i valori associativi<br />
128<br />
-,5<br />
0,0<br />
discute_insieme<br />
flessibile<br />
si<br />
se_valide<br />
molto_ascolto<br />
non_sempre_attuate<br />
A questa domanda 20 soggetti hanno risposto in modo affermativo, soltanto un<br />
intervistato ha risposto “non so, è troppo presto per dirlo”. E’ dunque possibile<br />
affermare che il 95,24% degli intervitati sostiene che è possibile influenzare<br />
l’andamento della propria associazione. Osservando le frequenze l’aspetto che i soci<br />
,5<br />
1,0
iportano più spesso è “l’ascolto di tutte le proposte”, considerato fondamentale nel<br />
33,3% delle risposte. Dal punto di vista dell’analisi fattoriale emergono quattro aree<br />
semantiche principali:<br />
1. Partendo dal primo quadrante, a ridosso dell’asse delle ascisse alcuni soci<br />
sottolineano come l’associazione sia molto aperta alle proposte di tutti, purché<br />
compatibili con gli obiettivi e i valori associativi. Una risposta esemplificativa di<br />
quest’area è “si, se riconosciute all’interno dei valori associativi; c’è una forte<br />
apertura sia per quanto riguarda le critiche che i suggerimenti”.<br />
2. La seconda area semantica è collocata in alto nel secondo quadrante, e riguarda la<br />
modalità decisionale utilizzata all’interno dell’associazione. I soci sottolineano che<br />
se vengono proposte idee valide, sono attuate. La validità di una proposta si stabilisce<br />
attraverso la discussione di gruppo. Le risposte fornite dai soggetti in quest’area<br />
chiarificano l’approccio associativo nel prendere decisioni: “Ne discutiamo insieme e<br />
si decide di volta in volta se attuarle o no”, “si, c’è un buon ascolto delle proposte,<br />
non ci si sente soli ma parte di un gruppo che decide insieme”. Ciò che emerge da<br />
quest’area è che l’approccio decisionale dell’associazione non è basato su una<br />
gerarchia, ma è il gruppo che è responsabile delle decisioni e che contribuisce a<br />
crearle. Nonostante la mancata applicazione dei circoli di qualità, quest’area fa<br />
emergere un approccio molto in sintonia con la filosofia dei circoli (Cap. 3): è il<br />
gruppo che propone soluzioni, decide se attuarle o meno e ne è responsabile.<br />
3. La terza area semantica (vicina al punto zero), evidenzia un’altra caratteristica<br />
associativa. I soci considerano l’approccio dell’associazione alle proposte che<br />
provengono dai soci come “flessibile”. Secondo i soggetti, l’associazione ha un<br />
approccio “aperto”, “è molto flessibile perché è in grado di adattarsi alle esigenze<br />
che si presentano”.<br />
4. La quarta area semantica è collocata nel terzo quadrante e riguarda l’attuazione<br />
delle proposte. Se da un lato l’ascolto è sempre presente, nei confronti di tutti, è<br />
altrettanto vero che l’attuazione non sempre è possibile. L’ascolto e la realizzabilità,<br />
sono due aspetti che non sempre coincidono; ne è un esempio la risposta fornita da<br />
un soggetto: “Si, credo di poter influenzare l’associazione sia a livello formale che<br />
129
informale, le proposte vengono sempre considerate e poi valutate perché magari<br />
sono molto più impegnative da realizzare di quello che sembrano; ma se la proposta<br />
è realizzabile e utile viene sempre accettata”.<br />
5.3.2 SENTE DI POTER INFLUENZARE L’ANDAMENTO<br />
DELL’ORGANIZZAZIONE?<br />
Questa domanda non è stata analizzata attraverso la procedura ASPAR, in quanto<br />
richiedeva una risposta molto breve. E’ stata creata una procedura SPADt in modo da<br />
poter analizzare il vocabolario. La tabella L riassume brevemente le categorie di<br />
risposta fornite dai soggetti:<br />
Tabella L: Categorie di risposta alla domanda 19.<br />
RISPOSTA FREQ MOTIVAZIONE FREQ<br />
Si_molto 8<br />
Si 8<br />
No 5<br />
- Si, mi sento molto ascoltato e preso in<br />
considerazione<br />
- Si molto, alcune mie idee sono state prese<br />
in considerazione<br />
3<br />
- Se volessi potrei farlo, ma non mi interessa 4<br />
- Si, ma non molto, direi parzialmente 4<br />
- Ne faccio parte da troppo poco tempo 1<br />
- No per la distanza dalla sede centrale 2<br />
- No perché non mi interessa 2<br />
A questa domanda 8 soggetti (38,09%) hanno risposto di “sentire di poter influenzare<br />
molto” l’andamento associativo, sia perché si sentono molto considerati ed ascoltati<br />
(5 soggetti), sia perché alcune delle idee da loro proposte sono state attuate.<br />
130<br />
5
Altri 8 soggetti (38,09%) hanno risposto “si”; più in dettaglio 4 percepiscono di poter<br />
influenzare la loro associazione solo parzialmente, mentre altri 4 sostengono di poter<br />
influenzare l’andamento associativo, ma che “non è nel loro interesse farlo”.<br />
I restanti 5 soggetti (23,81%) hanno risposto in modo negativo. Essi dunque,<br />
percepiscono di non poter influenzare l’andamento della propria associazione sia<br />
perché ne fanno parte da troppo poco tempo (1 soggetto), sia perché il loro club è<br />
eccessivamente distante dalla sede centrale (2 soggetti), sia perché non è nel loro<br />
interesse farlo (2 soggetti).<br />
Indipendentemente dalla categoria di risposta (si/no), 6 soggetti (28,57%) di<strong>chiara</strong>no<br />
di non essere interessati ad influenzare l’andamento della propria associazione. Si<br />
tratta di un dato che probabilmente meriterebbe un maggior approfondimento, ma<br />
che non è possibile giustificare con i dati attuali. Infatti, se alla domanda numero 18,<br />
tutti i soggetti hanno sostenuto che l’associazione prende in considerazione le idee<br />
che provengono dai suoi soci, ed è disponibile ad attuare modifiche e all’ascolto, a<br />
questa domanda 5 soggetti (23,81%) hanno risposto di “sentire di non influenzare<br />
l’andamento della propria associazione”, e 6 soggetti di non avere interesse a farlo.<br />
Non si tratta di informazioni necessariamente antitetiche, ma che certamente<br />
meriterebbero di essere approfondite in eventuali ricerche successive.<br />
131
5.3.3 ALL’INTERNO DELL’ASSOCIAZIONE COME È GESTITO IL POTERE?<br />
Questa domanda non è stata analizzata attraverso il programma SPADt, in<br />
quanto i soggetti hanno sostenuto che parlare di potere all’interno<br />
dell’associazione <strong>Wigwam</strong> non ha significato. Hanno esplicitato come non<br />
esista una gerarchia ed un’organizzazione formale, infatti anche chi è<br />
presidente di un club svolge il ruolo di coordinatore.<br />
Non è possibile parlare di gestione del potere, in quanto esso non è percepito;<br />
ne sono esempi esplicativi alcune risposte fornite dai soggetti: “Non c’è un<br />
vero e proprio potere, anche chi ha compiti istituzionali come il presidente<br />
coordina non c’è imposizione, in fondo siamo un gruppo che condivide”;“Il<br />
potere in questa filosofia è un concetto ironico, nei vari club c’è un referente,<br />
c’è un potere di carisma, determinato dalla qualità e quantità di energie che si<br />
possono dedicare alle iniziative, dalla presenza concreta”;“Nei diversi gruppi<br />
di lavoro si decide insieme, in base alla disponibilità, non c’è un vero e<br />
proprio responsabile, lo siamo tutti, i compiti vengono decisi insieme in base<br />
alle esigenze, e alla disponibilità di ciascuno”.<br />
5.3.4 CONCLUSIONI<br />
Dall’analisi della terza area di intervista emerge che:<br />
- L’associazione è considerata come molto flessibile ed aperta all’ascolto di tutte le<br />
proposte che provengono dai soci.<br />
- Gli intervistati sostengono che è possibile influenzare l’andamento associativo.<br />
Anche in questo caso non c’è un approccio decisionale “formale” ed esplicito:<br />
l’attuazione di un progetto è valutata “discutendone insieme”. L’approccio non è<br />
gerarchico, ma fonda le sue radici nella realtà gruppale.<br />
- Il 76,19% dei soggetti sostiene di poter influenzare l’andamento associativo, ma il<br />
28,57% del campione sostiene di non avere interesse a farlo.<br />
132
- Non esiste un potere e una gerarchia a livello formale, i rapporti sono di tipo<br />
paritetico ed orizzontale.<br />
- C’è adesione tra ciò che propone l’associazione e il concetto di empowerment<br />
organizzativo proposto da Zimmerman (2000, Cap.2, p.21). Nello specifico,<br />
all’interno dell’associazione è presente sia un processo empowering che un risultato<br />
empowered. A livello di processo empowering nell’associazione è presente:<br />
coinvolgimento decisionale (Dom. 18), responsabilità e leadership condivisa (Dom.<br />
20). A livello di risultato empowered è presente la possibilità di fare rete con altre<br />
realtà (nello specifico con altri club di progetto), e la percezione di poter influenzare<br />
l’andamento associativo (Dom. 19).<br />
C’è quindi sintonia con la filosofia dell’empowerment organizzativo, in quanto<br />
<strong>Wigwam</strong> ha una struttura reticolare (non piramidale), che favorisce in questo modo:<br />
la responsabilizzazione soggettiva, la socialità, la percezione di controllo, la<br />
consapevolezza critica e la partecipazione (p. 29).<br />
Questo aspetto è ulteriormente avvalorato dal fatto che uno dei punti di forza<br />
dell’associazione, più frequentemente riportato dai soci è il sentirsi responsabili della<br />
creazione di un mondo migliore e più sostenibile (Domanda 21).<br />
133
5.4 I VALORI WIGWAM<br />
Questa sezione conclusiva dell’intervista, ha lo scopo di esplicitare i valori<br />
associativi, e di mettere in evidenza quali siano secondo i soci i punti di forza e di<br />
debolezza di <strong>Wigwam</strong>.<br />
5.4.1 SECONDO LEI QUALI SONO I PRINCIPI GUIDA DI QUESTA<br />
ASSOCIAZIONE?<br />
Relativamente a questa domanda la procedura ASPAR ha consentito di individuare la<br />
presenza di due fattori principali, intorno ai quali si concentrano le risposte dei<br />
soggetti. Il vocabolario iniziale è composto da 226 parole distinte (52,7% sul<br />
vocabolario totale), ridotto a 27 vocaboli dopo il file CORTE ed il taglio di soglia. Il<br />
valore del contributo medio non è stato considerato vista l’esiguità del vocabolario,<br />
pertanto, nel grafico sono state proiettate tutte le forme grafiche derivate dall’analisi<br />
fattoriale (Appendice B, Tab. 12). La tabella L, raffigura l’istogramma ottenuto<br />
attraverso l’analisi fattoriale che ha consentito di individuare la presenza di due<br />
fattori che spiegano il 24,36% della varianza totale.<br />
134
Tabella L : Istogramma dei valori propri della domanda 18<br />
Fattor<br />
e<br />
Valore Proprio %<br />
1 0,8509 12,71 ********************************************************************************<br />
2 0,7801 11,65 **************************************************************************<br />
3 0,7527 11,24 ***********************************************************************<br />
4 0,7309 10,91 *********************************************************************<br />
5 0,6774 10,11 ****************************************************************<br />
6 0,5556 8,3 *****************************************************<br />
7 0,4892 7,3 **********************************************<br />
8 0,4521 6,75 *******************************************<br />
9 0,3938 5,88 **************************************<br />
10 0,2484 3,71 ************************<br />
11 0,1768 2,64 *****************<br />
12 0,066 0,99 *******<br />
13 0,0513 0,77 *****<br />
14 0,0364 0,54 ****<br />
15 0,03 0,45 ***<br />
La prima dimensione fattoriale individuata (Valori) descrive i valori tipici proposti<br />
dall’associazione: valori (C.A.=8,8), tradizioni (C.A.=38,6), recupero (C.A.=12,3). Il<br />
secondo fattore invece descrive, come dimensione valoriale associativa, i rapporti<br />
interpersonali: rapporto (C.A.=30,7) e altri (C.A.=15,2).<br />
135
Grafico 8: grafico ottenuto dall’incrocio di F1 e F2.<br />
F2: Rapporti interpersonali<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
-1<br />
-2<br />
-2<br />
1<br />
sostenibile<br />
vita<br />
vivere<br />
territorio<br />
F1: Valori<br />
qualità<br />
-1<br />
solidarietA<br />
2<br />
possibilità<br />
amicizia<br />
unione<br />
0<br />
rapporto<br />
136<br />
altri<br />
stile<br />
1<br />
valore<br />
miglioramento<br />
mondo persone<br />
promozione<br />
idea<br />
progetti 5<br />
7<br />
3<br />
conviviale<br />
amore<br />
recupero<br />
2<br />
tradizioni<br />
Dal grafico emergono sette aree che esplicitano quali siano secondo i soci i valori<br />
guida dell’associazione. Dal punto di vista delle frequenze i vocaboli più<br />
frequentemente riportati dai soci sono: miglioramento (28,57%), e qualità della vita<br />
(30,09%). Per quanto riguarda i contributi assoluti, il primo fattore è saturato<br />
principalmente dal concetto di tradizione (CA=38,6), il secondo fattore è saturato<br />
principalmente dai termini rapporto e altri (rispettivamente: CA= 30,7; CA=15,2).<br />
Dall’analisi del grafico (partendo dal primo quadrante) emerge che:<br />
4<br />
6<br />
3<br />
4
1. Uno dei valori guida più frequentemente riportato dai soci è la possibilità di<br />
portare un miglioramento nella qualità di vita, il sentirsi responsabili della creazione<br />
di un mondo migliore e più sostenibile. Le risposte dei soci in quest’area sono in<br />
stretta sintonia con ciò che propone l’associazione (Cap 1), ovvero l’importanza<br />
dell’impegno di ciascuno per portare ad un miglioramento nella vita di tutti, il<br />
sentirsi responsabili e fautori di queste modifiche; ne è un esempio esplicito la<br />
risposta fornita da un soggetto:<br />
“Innanzitutto lo spirito di un mondo sostenibile, ed è fondamentale perché il<br />
mondo cambi in una direzione migliore, quindi bisogna riconsiderare molti<br />
aspetti del nostro stile di vita. Poi l’attenzione alla qualità della vita, nostra e<br />
di chi ci sta intorno”.<br />
2. La seconda area riguarda i valori interpersonali, l’importanza di poter<br />
stabilire rapporti di amicizia che vengono definiti “autentici” e la solidarietà.<br />
Ne sono un esempio due risposte fornite dai soggetti: “l’altruismo, la<br />
solidarietà, il sentirsi presi in considerazione, l’ascolto, la parità e il rapporto<br />
di amicizia che c’è tra tutti, ci aiutiamo molto e aiutiamo gli altri”; “la<br />
solidarietà, la proposta di uno stile di vita alternativo, la semplicità,<br />
l’amicizia che c’è tra di noi”.<br />
3. La terza area è quella che satura maggiormente il secondo fattore; il<br />
contenuto è molto simile alla seconda area, infatti i soci sottolineano come un<br />
valore dell’associazione l’essere parte di un gruppo e il rapporto con le altre<br />
persone.<br />
4. La quarta area evidenzia come lo stile con cui si propone l’associazione sia<br />
un valore, si tratta di uno stile conviviale. Un valore importante è proporsi con<br />
gioia: per i soci questo approccio permette di “dare valore alle persone” e di “<br />
trasmettere il valore dell’amore per le persone”.<br />
5. La quinta area sottolinea come valore la promozione di progetti diversi, che<br />
“permettano di recuperare ed evidenziare le potenzialità locali e personali”e<br />
137
di “mettere in attività idee”. Un soggetto risponde: “il valore principale è<br />
spingere all’autogioco, l’idea che ognuno ha una sua importanza e può<br />
proporre progetti e idee che sono utili ed importanti, il non essere passivi”.<br />
6. La sesta area riguarda il recupero delle tradizioni, la valorizzazione delle<br />
tipicità locali.<br />
7. La settima area riguarda la possibilità di unire in modo migliore l’uomo con<br />
il proprio territorio, il rispetto dell’ambiente. Il valore proposto è quello di<br />
collaborazione, di essere gruppo per portare ad un miglioramento concreto del<br />
territorio in cui si vive.<br />
5.4.2 ALL’INTERNO DI QUESTA ASSOCIAZIONE, CI SONO VALORI IN CUI<br />
SI IDENTIFICA IN PRIMA PERSONA?<br />
Questa domanda è strettamente connessa con la precedente, e riguarda<br />
l’identificazione personale con i valori associativi sopra citati.<br />
La procedura ASPAR ha consentito di individuare la presenza di due fattori<br />
significativi intorno ai quali si concentrano le risposte dei soggetti. Il vocabolario<br />
iniziale era composto da 25 parole distinte (45,5% sul vocabolario totale), ridotto a<br />
23 vocaboli dopo il file CORTE ed il taglio di soglia. Il valore del contributo medio,<br />
data l’esiguità del vocabolario, non è stato considerato, sono state dunque proiettate<br />
nel grafico tutte le forme verbali (Appendice B, Tab. 13). La tabella M, raffigura<br />
l’istogramma ottenuto attraverso l’analisi fattoriale che ha consentito di individuare<br />
la presenza di due fattori, che spiegano il 15,02% della varianza totale. La proiezione<br />
grafica delle forme verbali è riportata nel grafico 9.<br />
Tabella M: Istogramma dei valori propri della domanda 22.<br />
Fattore Valore Proprio %<br />
1 0,7561 13 ********************************************************************************<br />
2 0,6992 12,02 **************************************************************************<br />
3 0,6067 10,43 *****************************************************************<br />
4 0,5341 9,18 *********************************************************<br />
138
5 0,5 8,6 *****************************************************<br />
6 0,5 8,6 *****************************************************<br />
7 0,5 8,6 *****************************************************<br />
8 0,5 8,6 *****************************************************<br />
9 0,5 8,6 *****************************************************<br />
10 0,3649 6,27 ***************************************<br />
11 0,2498 4,29 ***************************<br />
12 0,105 1,81 ************<br />
13 0 0 *<br />
14 0 0 *<br />
15 0 0 *<br />
Il primo fattore individuato evidenzia aree semantiche relative al grado di<br />
identificazione personale. E’ saturato principalmente dalle parole: corrispondono,<br />
scelte e vita (C.A.=23,8).<br />
Il secondo fattore “valori” riguarda i valori in cui i soggetti si identificano più<br />
frequentemente: essere gruppo, comunanza di interessi, amicizia e solidarietà<br />
(C.A.=8,4).<br />
139
Grafico 9: grafico ottenuto dall’incrocio di F1 e F2.<br />
F2: Tipo di valori<br />
2,0<br />
1,5<br />
1,0<br />
,5<br />
0,0<br />
-,5<br />
-1,0<br />
-1,5<br />
-4<br />
solidarietà<br />
1 vita Scelta<br />
amicizia<br />
2<br />
essere_gruppo<br />
corrispondono comunanza_interessi<br />
-3<br />
F1: G rado di identificazione personale<br />
-2<br />
reciproco_scambio sviluppo_sostenibile<br />
eco-compatibile Possibilita_confronto<br />
non_essere_passivi<br />
140<br />
-1<br />
si<br />
semplicità<br />
autenticità<br />
ci_credo_molto sento_molto_<br />
molto<br />
totalmente<br />
4<br />
non_del_tutto<br />
A questa domanda tutti i soggetti (100%) hanno risposto “si”; c’è quindi<br />
un’identificazione personale con i valori associativi, aspetto che era<br />
ipotizzabile, considerando che la partecipazione dei soci è “volontaria”. In<br />
generale, le quattro aree semantiche che emergono dal grafico esplicitano<br />
maggiormente le motivazioni di questa identificazione.<br />
1. Nella prima area alcuni soggetti sottolineano che si identificano con i valori<br />
associativi perché essi corrispondono alla loro scelta di vita.<br />
2. La seconda area evidenzia come le motivazioni che spingono a identificarsi<br />
con i valori associativi sono l’essere parte di un gruppo che ha una comunanza<br />
di interessi e l’amicizia, il rapporto di solidarietà e il supporto che si è creato<br />
3<br />
0<br />
1<br />
2
tra persone. E’ l’aspetto umano ed interpersonale che spinge gli intervistati ad<br />
identificarsi maggiormente con i valori associativi.<br />
3. La terza area evidenzia quali siano i valori con cui i soci si identificano<br />
maggiormente: la semplicità e l’autenticità, la possibilità di scambio e di<br />
confronto, la proposta di uno sviluppo sostenibile ed eco-compatibile, l’essere<br />
attivi e propositivi nei confronti della vita.<br />
4. La quarta area descrive “quanto” i soggetti si identificano con i valori<br />
dell’associazione: 6 soggetti sostengono di identificarsi “totalmente” o<br />
“molto”, 2 soggetti sostengono di “sentirsi molto coinvolti” e di “crederci<br />
molto”, mentre 3 soggetti sostengono di identificarsi con i valori associativi<br />
ma “non del tutto”.<br />
5.4.3 COSA INTENDE LEI PER QUALITÀ DI VITA?<br />
Essendo uno degli obiettivi dell’associazione portare ad un miglioramento<br />
della qualità di vita, ed essendo anche uno dei valori più importanti per i soci<br />
(Domanda 22), è stato chiesto loro cosa intendessero per “qualità di vita”.<br />
La procedura ASPAR che ha consentito l’individuazione di due fattori significativi<br />
intorno ai quali si concentrano le risposte dei soggetti. Il vocabolario iniziale è<br />
composto da 201 parole distinte (50,5% sul vocabolario totale), ridotto a 30 vocaboli<br />
dopo il file CORTE ed il taglio di soglia. Il valore del contributo medio è di 3,33<br />
(100/30), pertanto, nel grafico sono state proiettate le 20 forme grafiche derivate<br />
dall’analisi fattoriale con CA maggiore o uguale a 3 (Appendice B, Tab. 14). La<br />
tabella N, raffigura l’istogramma ottenuto attraverso l’analisi fattoriale che ha<br />
consentito di individuare la presenza di due fattori che spiegano il 23,66% della<br />
varianza totale. Vista l’esigua differenza dei valori propri tra F2 e F3, inizialmente è<br />
stato considerato anche questo fattore, ma dall’incrocio tra F1 e F3, e tra F2 e F3,<br />
non emergono aree semantiche differenti da quelle presenti nel grafico ottenuto<br />
dall’incrocio tra F1 e F2; per questo motivo verrà analizzato soltanto il primo<br />
141
grafico. In Appendice B (Tabella 15 e 16) sono presenti per chiarezza metodologica<br />
le coordinate e i relativi contributi assoluti derivati dall’incrocio di tutti e tre i fattori.<br />
Tabella N: Istogramma dei valori propri della domanda 23.<br />
Fatt<br />
ore<br />
Valore Proprio %<br />
1 0,7162 12,16 ********************************************************************************<br />
2 0,6775 11,5 ****************************************************************************<br />
3 0,6357 10,79 ************************************************************************<br />
4 0,5685 9,65 ****************************************************************<br />
5 0,554 9,41 **************************************************************<br />
6 0,48 8,15 ******************************************************<br />
7 0,4298 7,3 *************************************************<br />
8 0,3651 6,2 *****************************************<br />
9 0,3119 5,3 ***********************************<br />
10 0,245 4,16 ****************************<br />
11 0,2156 3,66 *************************<br />
12 0,1728 2,93 ********************<br />
13 0,1558 2,65 ******************<br />
14 0,1343 2,28 ****************<br />
15 0,0736 1,25 *********<br />
Il primo fattore “qualità interna”, individua aree semantiche che riconducono la<br />
qualità di vita a caratteristiche soggettive “interne” come i pensieri (C.A.=11,4) e i<br />
desideri (C.A.=6,1); il fattore è saturato principalmente dal vocabolo “nostre”<br />
(C.A.=41,8).<br />
Il secondo fattore invece “qualità esterna”, individua aree semantiche che<br />
riconducono la qualità di vita a caratteristiche esterne, migliorabili e modificabili. I<br />
lemmi con il contributo maggiore sono: diverso (C.A.=11,7), meglio (C.A.=5,5),<br />
miglioramento (C.A.=5,1). Già dall’analisi dei fattori (che decrescono molto<br />
gradualmente), si evince la difficoltà che i soggetti hanno avuto nel rispondere a<br />
questa domanda. Molti infatti hanno sottolineato come il concetto di qualità di vita<br />
sia estremamente complesso e quindi di difficile definizione.<br />
142
Grafico 10: grafico ottenuto dall’incrocio di F1 e F2.<br />
F2: Qualià interna<br />
3,00<br />
2,00<br />
1,00<br />
0,00<br />
-1,00<br />
possibilità<br />
piace<br />
miglioramento<br />
riuscire<br />
meglio<br />
-1,00<br />
lavori<br />
F1: Qualità esterna<br />
cercare<br />
pensieri<br />
qualità<br />
0,00<br />
desideri<br />
143<br />
nostre<br />
bene<br />
4<br />
benessere<br />
radici<br />
1,00<br />
livello<br />
rispetto<br />
porsi<br />
3<br />
portare<br />
diverse<br />
Dal grafico emergono 5 principali aree semantiche intorno alle quali si<br />
concentrano le risposte dei soggetti:<br />
1<br />
5<br />
1. La qualità di vita corrisponde alla qualità dei desideri, dei pensieri che<br />
influenzano il nostro agire e il nostro modo di vivere. In quest’area, i soggetti<br />
evidenziano come la qualità di vita non sia qualcosa di concreto e di tangibile,<br />
ma sia collegato ad aspetti più astratti ed intrapsichici, come i pensieri e i<br />
desideri.<br />
2. La qualità di vita è per alcuni soggetti l’amore e l’attenzione per il territorio<br />
e le tradizioni, che rappresentano le nostre radici, ne è un esempio la risposta<br />
2<br />
2,00
di un soggetto: “è una vita legata al territorio che è il luogo dove noi poniamo<br />
le nostre radici, ed è con le radici che una pianta vive.”<br />
3. La qualità di vita, dipende per alcuni soggetti dal modo in cui ci si pone nei<br />
confronti della vita e della società attuale, una buona qualità è collegata al<br />
proporre alternative diverse, che portino ad uno stile di vita più sano e ad uno<br />
sviluppo sostenibile. La risposta fornita da un soggetto ne è un esempio: “dal<br />
ben avere al benessere, porsi in modo diverso rispetto al consumismo, trovare<br />
delle soluzioni e delle risposte diverse che portino al benessere e non al ben<br />
avere che è fine a se stesso”.<br />
4. La qualità di vita viene considerata in quest’area come la possibilità di<br />
vivere bene e di far vivere bene gli altri, portando rispetto per tutto ciò che ci<br />
circonda (persone e ambiente). La possibilità di vivere bene è collegata, in<br />
alcune risposte, al poter fare ciò che si desidera. Come per la prima area<br />
semantica, anche qui è esplicitato come la qualità di vita sia connessa con i<br />
desideri più intimi di una persona e sia collegata ai rapporti interpersonali. Un<br />
esempio molto chiaro di questo aspetto è fornito da questa risposta: “e’ sia a<br />
livello interiore, cioè non avere un anima pessimista che critica e si lamenta<br />
senza portare attenzione agli aspetti positivi della vita, e questo non vuol dire<br />
non avere problemi, ma significa portare attenzione alle cose che ci<br />
interessano. Poi a livello sociale la percezione di essere un po’ padroni della<br />
propria vita”.<br />
5. Rispetto alle altre aree, la quinta collega la qualità di vita all’agire,<br />
all’attività, al fare “ciò che piace”, al ricercare abitudini “che permettano di<br />
stare meglio”, fare “un lavoro che soddisfi e ti permetta di vivere bene facendo<br />
ciò che desideri”, “trovare tempo per se stessi, facendo attività che ti<br />
appagano”. La qualità della vita è quindi connessa con la possibilità di stare<br />
144
meglio con sé stessi ma soprattutto con gli altri riuscendo a svolgere attività<br />
appaganti.<br />
5.4.4 SECONDO LEI QUALI SONO I PUNTI DI FORZA DI QUESTA<br />
ASSOCIAZIONE?<br />
Relativamente a questa domanda la procedura ASPAR ha consentito di individuare la<br />
presenza di due fattori significativi intorno ai quali si concentrano le risposte dei<br />
soggetti. Il vocabolario iniziale è composto da 44 parole distinte (62% sul<br />
vocabolario totale), ridotto a 15 vocaboli dopo il file CORTE ed il taglio di soglia. Il<br />
valore del contributo medio non è stato considerato vista l’esiguità del vocabolario,<br />
pertanto, nel grafico sono state proiettate tutte le forme grafiche derivate dall’analisi<br />
fattoriale (Appendice B, Tab. 17). La tabella O, raffigura invece l’istogramma<br />
ottenuto attraverso l’analisi fattoriale che ha consentito di individuare la presenza di<br />
due fattori che spiegano il 30,14% della varianza totale.<br />
Le risposte dei soggetti si articolano lungo due dimensioni:<br />
- Gli aspetti interpersonali: F1 è saturato principalmente dai termini<br />
persone (C.A.=12,8), autenticità (C.A.=20,3), semplicità (C.A.=28,7).<br />
- Gli aspetti valoriali: F2 è saturato principalmente dai termini apolitica<br />
(C.A.= 35,3), idee (C.A.=12,3).<br />
Tabella O: Istogramma dei valori propri della domanda 24.<br />
Fattore Valore proprio %<br />
1 0,9382 16,05 ********************************************************************************<br />
2 0,8707 14,9 ***************************************************************************<br />
3 0,7724 13,22 ******************************************************************<br />
4 0,6594 11,28 *********************************************************<br />
5 0,6019 10,3 ****************************************************<br />
La presenza di un vocabolario piuttosto ridotto fa riflettere sull’omogeneità delle<br />
risposte. Gli aspetti positivi di <strong>Wigwam</strong> sono percepiti e descritti in modo simile tra i<br />
soggetti. Il grafico 11, sintetizza le risposte fornite dai soggetti.<br />
145
Grafico 11: grafico ottenuto dall’incrocio di F1 e F2.<br />
F2: Aspetti valoriali e ideativi<br />
2<br />
1<br />
0<br />
-1<br />
-2<br />
-3<br />
-1,5<br />
entusiasmo<br />
convinzione<br />
qualità<br />
persone<br />
-1,0<br />
attività<br />
amicizia obiettivi<br />
valori<br />
condivisione<br />
4<br />
idee<br />
-,5<br />
apolitica<br />
0,0<br />
F1: Aspetti interpersonali<br />
146<br />
,5<br />
spiritofilosofia<br />
1,0<br />
autenticità<br />
semplicità<br />
I punti di forza dell’associazione sono sintetizzati in 5 aree:<br />
1<br />
5<br />
1. La prima area evidenzia come punto di forza la qualità, che può essere<br />
riferita sia alle persone che fanno parte dell’associazione sia alle attività e ai<br />
servizi proposti. Le attività sono considerate dai soci come un punto di forza<br />
sia per la loro qualità, sia perché sono proposte con entusiasmo e convinzione.<br />
2. La seconda area evidenzia come punti di forza l’autenticità e la semplicità<br />
dell’associazione, aspetti già emersi nella domanda 19 (p.57).<br />
3. La terza area evidenzia come un punto di forza dell’associazione sia lo<br />
spirito conviviale e gioioso con cui si propone, che trova una corrispondenza<br />
2<br />
3<br />
1,5<br />
2,0
nella filosofia di vita che hanno alcuni soci; anche in questo caso si tratta di un<br />
aspetto già emerso nella domanda 19 (p.57).<br />
4.La quarta area, è quella più frequentemente riportata dai soci, ed è l’area<br />
della “condivisione” (il 38,09% dei soggetti utilizza il termine condivisione).<br />
Punto di forza dell’associazione è quello di fornire opportunità di amicizia e di<br />
rapporti interpersonali con cui poter condividere finalità, idee e valori.<br />
5. L’ultima area evidenzia come sia positivo per i soci che l’associazione non<br />
abbia alcun tipo di preclusione né a livello politico, né religioso né sociale.<br />
5.4.5 SECONDO LEI QUALI SONO GLI ASPETTI IN CUI L’ASSOCIAZIONE<br />
DOVREBBE MIGLIORARE?<br />
La procedura ASPAR ha individuato la presenza di due fattori intorno ai quali si<br />
concentrano le risposte dei soggetti. Il vocabolario iniziale è composto da 35 parole<br />
distinte (51,5% sul vocabolario totale), ridotto a 14 vocaboli dopo il file CORTE ed<br />
il taglio di soglia. Il valore del contributo medio non è stato considerato vista<br />
l’esiguità del vocabolario, pertanto, nel grafico sono state proiettate tutte le forme<br />
grafiche derivate dall’analisi fattoriale (Appendice B, Tab. 18). La tabella P,<br />
raffigura l’istogramma ottenuto attraverso l’analisi fattoriale che ha consentito di<br />
individuare la presenza di due fattori che spiegano il 41,17% della varianza totale.<br />
Tabella P: Istogramma dei valori propri della domanda 25.<br />
Fattore Valore proprio %<br />
1 0,9757 21,14 ********************************************************************************<br />
2 0,9245 20,03 ****************************************************************************<br />
3 0,7747 16,78 ****************************************************************<br />
4 0,6559 14,21 ******************************************************<br />
5 0,5649 12,24 ***********************************************<br />
Le risposte dei soggetti si articolano lungo due dimensioni fattoriali:<br />
147
- Riconoscimento successi e divulgazione: F1 è saturato principalmente dai<br />
termini evidenziare, successi (C.A.= 16,6) e farsi conoscere di più<br />
-<br />
(C.A.=22,4);<br />
Aspetti burocratici e tecnici: F2 è saturato principalmente dai termini:<br />
burocratico (C.A.= 18,33) e assistenza (C.A.=22).<br />
Grafico 12: grafico ottenuto dall’incrocio di F1 e F2.<br />
F2: Aspetti burocratici e tecnici<br />
1,5<br />
1,0<br />
,5<br />
0,0<br />
-,5<br />
-1,0<br />
-1,5<br />
-1,5<br />
assistenza<br />
burocratica<br />
-1,0<br />
1<br />
comunicazione<br />
diff_iniz_liv_naz fare_rete<br />
carenza<br />
fondi<br />
-,5<br />
professionali<br />
0,0<br />
F1: Riconoscimento successi e divulgazione<br />
148<br />
,5<br />
progetti<br />
successi<br />
evidenziare<br />
conoscere_di<br />
1. La prima area evidenziata è una carenza di assistenza burocratica e<br />
amministrativa, sia da parte dell’associazione che delle istituzioni. Si tratta di<br />
uno dei problemi più frequentemente riportato dai soci (28,57%), che<br />
nuovi<br />
riferiscono difficoltà nella gestione di questi aspetti problematici.<br />
5<br />
4<br />
2<br />
3<br />
1,0<br />
1,5<br />
2,0
2. Nella seconda area i soci sostengono che l’associazione dovrebbe farsi<br />
conoscere di più, soprattutto cercando di divulgare maggiormente i successi e i<br />
riconoscimenti ottenuti nel tempo.<br />
3. La terza area evidenzia che secondo alcuni soci l’associazione dovrebbe<br />
aprirsi ad esperienze progettuali nuove, che aumentino lo spettro di attività<br />
proposte.<br />
4. La quarta area evidenzia carenze a livello di comunicazione. Il 33,3% degli<br />
intervistati sostiene che la comunicazione andrebbe migliorata, sia cercando di<br />
diffondere di più le iniziative a livello nazionale, sia cercando di fare maggiormente<br />
rete. Relativamente a quest’area, va sottolineato che la comunicazione non è vissuta<br />
come problematica all’interno dei singoli club di progetto (domanda numero 10, solo<br />
il 9,5% dei soggetti riportano problemi di comunicazione), ma è vissuta come tale a<br />
livello associativo (33,3% dei soggetti). E’ pur vero che la comunicazione a livello di<br />
club è di tipo informale e tra un numero limitato di persone, ma questa discrepanza,<br />
trattandosi di una rete sociale, meriterebbe un maggiore approfondimento.<br />
5. La quarta area evidenzia come aspetto associativo problematico la carenza<br />
di fondi, che secondo alcuni soci potrebbe essere ovviata attraverso un<br />
aumento della professionalità. Facendo un confronto con la domanda 10, i<br />
problemi economici a livello di club sono riportati nel 71,43% dei casi, mentre<br />
per quel che riguarda l’associazione solo nel 9,52% dei casi. Anche questo<br />
aspetto, come il precedente, meriterebbe un maggiore approfondimento che<br />
non è possibile effettuare con i dati a disposizione.<br />
5.4.6 CONCLUSIONI<br />
Dall’analisi della quarta sezione di intervista emerge che:<br />
- I principi giuda dell’associazione sono considerati principalmente: la<br />
possibilità di portare contributi migliorativi (soprattutto per quanto riguarda la<br />
qualità di vita) e la gratificazione ottenuta dai rapporti interpersonali. Sono<br />
149
considerati importanti anche lo stile con cui si propongono le attività e la<br />
valorizzazione delle tipicità locali.<br />
- Tutti i soggetti si identificano personalmente con i valori associativi sia<br />
perché c’è una corrispondenza tra ciò che l’associazione propone e il modo dei<br />
soggetti di percepire la vita, sia perché si sentono parte di un gruppo che ha<br />
una comunanza di valori e di interessi.<br />
- Secondo i soggetti la qualità della vita ha due componenti: una sociale e una<br />
intrapsichica. A livello personale la qualità di vita è collegata ai propri<br />
pensieri e desideri, al modo in cui ci si pone nei confronti della vita. A livello<br />
sociale, è collegata al territorio, al proporre alternative più sane e più<br />
sostenibili, sia per se stessi che per gli altri, ma anche al poter svolgere attività<br />
piacevoli e appaganti.<br />
- Per quanto riguarda i punti di forza, gli aspetti più frequentemente citati dai<br />
soci sono i valori associativi proposti, lo spirito e la filosofia <strong>Wigwam</strong>. Ciò<br />
che è maggiormente apprezzato sono i valori guida dell’associazione e i<br />
rapporti interpersonali. Va evidenziato che i punti di forza dell’associazione<br />
coincidono con gli aspetti con cui i soci si identificano di più (Domanda 22).<br />
- Se i punti di forza dell’associazione si collocano ad un livello valoriale ed<br />
astratto, i punti di debolezza hanno risvolti pragmatici e si collocano ad un<br />
livello concreto. Gli aspetti vissuti come più problematici sono: l’assistenza<br />
burocratica, la valorizzazione dei riconoscimenti, la comunicazione, la<br />
maggior diffusione delle iniziative a livello nazionale e la carenza di fondi.<br />
- Rispetto alla domanda numero 10, i soggetti percepiscono come più<br />
problematica la comunicazione a livello associativo rispetto alla realtà dei<br />
club, e percepiscono invece come più rilevanti i problemi economici a livello<br />
di club che non a livello associativo.<br />
150
CAPITOLO 6: CONCLUSIONI<br />
Il presente elaborato ha analizzato le caratteristiche e le modalità di<br />
funzionamento di un’associazione non profit. Come già esplicitato (Cap. 1)<br />
l’associazione ha la struttura di una rete sociale e cerca di raggiungere due<br />
obiettivi principali:<br />
1. lavoro per progetti con una costante attenzione alla qualità (ispirandosi<br />
alla filosofia dei circoli di qualità);<br />
2. attivazione dei soggetti per la creazione di progetti sostenibili che<br />
portino ad un miglioramento della qualità di vita (ispirandosi ai principi<br />
dell’empowerment).<br />
Il concetto di empowerment nasce nell’ambito della psicologia di comunità,<br />
che presenta due caratteristiche fondamentali: quella di considerare la persona<br />
nel contesto del proprio ambiente di vita, e quella di porre attenzione alle<br />
competenze psicologiche della persona per promuovere un cambiamento (sia<br />
ambientale che personale) finalizzato ad un miglioramento della qualità di<br />
vita. Questo macro obiettivo comune costituisce il movente della ricerca: quali<br />
sono le metodologie che <strong>Wigwam</strong> utilizza per portare ad un miglioramento<br />
della qualità di vita?<br />
Oltre alla finalità comune, l’approccio associativo si ispira ad alcuni aspetti<br />
della psicologia di comunità, infatti considera l’uomo come legato da un<br />
rapporto imprescindibile con il proprio territorio, e cerca di favorire la<br />
partecipazione con una costante attenzione alla “qualità sociale” (De<br />
Leonardis, 1998, Cap. 1 p.12).<br />
L’esempio che <strong>Wigwam</strong> propone è l’immagine di una persona che può agire<br />
sulla realtà con efficacia e responsabilità per portare allo sviluppo di un mondo<br />
qualitativamente migliore e più sostenibile.<br />
151
In questa prospettiva, molto simile ad alcuni modelli di empowerment (Cap.2),<br />
la percezione di uno svantaggio o di un problema non ha più l’accezione di un<br />
limite sociale o individuale, ma ha il ruolo di una difficoltà che può essere<br />
superata, non nella direzione proposta dal superuomo nietzschiano, ma<br />
dall’apertura di nuove possibilità, prima non considerate dal soggetto o<br />
ritenute pregiudizialmente impossibili.<br />
La prima parte dell’elaborato è stata dedicata all’approfondimento teorico dei<br />
principali modelli teorici su cui si basa il funzionamento associativo.<br />
Per quanto riguarda i circoli di qualità è stato evidenziato sia il loro sviluppo,<br />
sia le loro modalità di funzionamento e attuazione, ma soprattutto è stato posto<br />
l’accento sulla loro matrice teorica: favorire la partecipazione e<br />
responsabilizzazione del soggetto, in modo che possa portare a contributi<br />
migliorativi nell’area in cui opera, aumentando in questo modo sia il livello<br />
qualitativo che la motivazione intrinseca. L’approccio gestionale proposto dai<br />
circoli è innanzitutto un approccio alla responsabilizzazione e al<br />
coinvolgimento che considera la persona come principale attore del<br />
cambiamento.<br />
I circoli si sviluppano a partire dalle teorie proposte da Lewin (1972), Maslow<br />
(1954) e McGragor (1983), che cominciarono a promuovere modelli più<br />
partecipativi nei processi decisionali di gruppo. In queste stesse teorie fondano<br />
le loro radici gli empowerment work group. Tra i circoli di qualità e gli<br />
approcci empowerment oriented esistono aree in comune, sia per quanto<br />
riguarda le finalità (coinvolgimento, partecipazione e responsabilizzazione)<br />
che i metodi (creazione di gruppi autonomi e semiautonomi).<br />
Per quanto riguarda l’empowerment, si è approfondita la nascita e lo sviluppo<br />
del concetto riferendosi ai principali modelli teorici presenti in letteratura<br />
152
(Cap. 2) e analizzando tutti i livelli in cui un processo empowered può<br />
esplicitarsi (individuale, organizzativo e di comunità).<br />
Il funzionamento e le metodologie associative sono state studiate attraverso la<br />
somministrazione a 21 soggetti di un’intervista.<br />
Lo strumento è composto da 25 domande aperte che indagano le aree sopra<br />
citate (Cap.4), ed è stato sottoposto ad analisi di contenuto attraverso il<br />
software SPADt.<br />
Dall’analisi dei dati emerge che il campione è estremamente omogeneo, e non<br />
esiste alcuna differenza in base al genere, all’età e al ruolo associativo. I<br />
soggetti pertanto vivono e narrano la loro esperienza associativa in modo<br />
simile (Cap.4, paragrafo 4.7).<br />
I progetti <strong>Wigwam</strong> nascono dalla percezione soggettiva di un interesse, un<br />
desiderio, ma anche di un problema sociale da risolvere. L’associazione in<br />
questa fase svolge la funzione di un mezzo che permette di soddisfare i propri<br />
bisogni e desideri. (Cap.5, paragrafo 5.1)<br />
Il ruolo associativo è principalmente quello di fornire un gruppo di supporto<br />
con cui è possibile identificarsi, condividere valori, esigenze e instaurare<br />
rapporti interpersonali significativi.<br />
In sintonia con quanto sostiene Brodeur (1984), parlando di reti sociali,<br />
l’agente del cambiamento non è tanto la persona quanto la stessa comunità di<br />
vita, la rete sociale. Essa è competente nel leggere i propri bisogni, elaborare<br />
un progetto per condividerli e, possibilmente risolverli. Perciò in presenza di<br />
un problema, non punta essenzialmente alla soluzione di esso, quanto ad una<br />
condivisione del bisogno, e quindi ad un cambiamento dei rapporti delle<br />
persone implicate. Perciò se il desiderio può emergere ad un livello<br />
individuale, il cambiamento avviene all’interno della rete sociale che<br />
incoraggia un movimento di trasformazione dall’individuale al collettivo.<br />
153
Gli obiettivi progettuali proposti dai soci coincidono con quelli associativi e<br />
riguardano principalmente il miglioramento della qualità di vita, la possibilità<br />
di far incontrare persone creando spazi per il confronto e la discussione e la<br />
promozione di progetti sostenibili (Cap.5, paragrafo 5.1.2).<br />
Non esistono criteri decisionali formalmente definiti e rigidi, né per quanto<br />
riguarda l’attuazione di nuovi progetti, né per eventuali modifiche al lavoro in<br />
atto; la modalità operativa è quella della discussione di gruppo. Se a livello<br />
esplicito non esistono criteri definiti, a livello implicito i soci hanno fornito<br />
risposte molto simili, proponendo come criteri di attuazione/non attuazione la<br />
compatibilità e coerenza con i valori associativi (qualità e sostenibilità) e la<br />
realizzabilità progettuale (Cap.5, paragrafo 5.1.5).<br />
Dall’analisi dei dati emerge che l’associazione non applica i circoli di qualità<br />
(Cap.5, paragrafo 5.2.2)., ma ogni gruppo è indipendente nella gestione dei<br />
problemi, l’approccio è di tipo partecipativo ed ogni apporto personale è<br />
considerato importante. A livello operativo ci sono molte similarità con il<br />
modello proposto da Trist (1981) relativamente alla creazione di<br />
empowerment work group (Cap. 2, p.34).<br />
L’associazione richiede al soggetto un ruolo attivo ed un contributo personale,<br />
che in questo contesto è possibile sia perché la partecipazione è volontaria, sia<br />
perché c’è identificazione e adesione personale ai valori associativi (Cap.5,<br />
paragrafo 5.4.2).<br />
A livello di empowerment c’è corrispondenza tra ciò che l’associazione<br />
propone e il modello di empowerment organizzativo proposto da Zimmerman<br />
(2000), sia a livello di processo che di risultato (Cap.2, p.21).<br />
Nello specifico, all’interno dell’associazione è presente sia un processo<br />
empowering che un risultato empowered. A livello di processo<br />
nell’associazione è presente: coinvolgimento decisionale, responsabilità e<br />
154
leadership condivisa; a livello di risultato empowered invece, è presente la<br />
possibilità di fare rete con altre realtà (nello specifico altri club di progetto) e<br />
la percezione di poter influenzare l’andamento associativo. 21<br />
La possibilità di influenzare l’andamento associativo è possibile secondo la<br />
maggior parte dei soci, proprio perché i rapporti sono di scambio paritetico e<br />
non esiste una gerarchia formalmente definita. Come esplicitato in precedenza,<br />
c’è coinvolgimento nelle decisioni e la responsabilità è condivisa (Cap.5,<br />
paragrafo 5.3.2); i soggetti stessi di<strong>chiara</strong>no di sentirsi personalmente<br />
responsabili della creazione di un mondo migliore e più sostenibile (Cap.5,<br />
paragrafo 5.4.1).<br />
I punti di forza dell’associazione (Cap.5, paragrafo 5.4.4) sono considerati i<br />
valori proposti e i rapporti interpersonali instaurati; mentre i punti di<br />
debolezza (Cap.5, paragrafo 5.4.5), si collocano ad un livello concreto, come<br />
per esempio la necessità di un maggiore supporto per questioni burocratiche.<br />
Come si può notare, in tutta la seconda parte dell’elaborato, l’aspetto più<br />
frequentemente riportato dalle persone riguarda la gratificazione ottenuta dai<br />
rapporti interpersonali. Ciò che motiva principalmente i soggetti ad un<br />
impegno attivo e alla partecipazione, è dunque l’essere parte di una rete<br />
sociale, e la percezione che esiste una corrispondenza tra ciò che<br />
l’associazione propone e il proprio modo di “vedere la vita”.<br />
Sentirsi parte di un gruppo che condivide valori, interessi ed esigenze, spinge i<br />
soggetti a sentirsi più responsabili delle loro azioni, ma anche meno soli,<br />
perché fornisce sostegno e supporto. Questo aspetto è ulteriormente avvalorato<br />
dal fatto che questa identificazione si riflette anche a livello pragmatico,<br />
attraverso l’attuazione di progetti che i soggetti percepiscono e definiscono<br />
come “utili” (Cap.5, paragrafo 5.1.7).<br />
21 Per approfondimenti si vedano le analisi presenti ai paragrafi 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3.<br />
155
Ciò che emerge dai dati raccolti è che l’associazione <strong>Wigwam</strong> cerca di portare<br />
ad un miglioramento della qualità di vita attraverso una metodologia basata<br />
sull’empowerment.<br />
Nello specifico il processo si struttura attraverso il passaggio da un modello<br />
basato sul self-empowerment (Bruscaglioni, 2000) ad un modello di<br />
empowerment organizzativo (Zimmerman, 2000).<br />
Inizialmente, prima che il soggetto entri a far parte dell’associazione, è già in<br />
atto un processo di self-empowerment, in quanto egli percepisce l’esigenza di<br />
soddisfare un bisogno o un desiderio. E’ dunque la persona che inizialmente<br />
attiva quella funzione definita da Bruscaglioni come “Io desiderante”, infatti<br />
anche uno stato di bisogno, di necessità o di insoddisfazione può essere<br />
utilizzato come molla iniziale di questo processo, purché la persona lo elabori<br />
in termini di energia desiderante.<br />
Dopo questa prima fase (in cui emerge un desiderio), il modello ne propone<br />
una seconda, in cui è possibile costruire una nuova pensabilità dello stesso. In<br />
questa seconda fase sono molto importanti alcune caratteristiche di personalità<br />
come locus of control interno e self-efficacy (Cap.2, p.22).<br />
La terza fase proposta dal modello è definita come “apertura alla nuova<br />
possibilità”, ed è proprio a questo livello che si colloca l’intervento<br />
dell’associazione <strong>Wigwam</strong>.<br />
Il soggetto conosce un gruppo che condivide i suoi stessi bisogni e desideri, e<br />
che gli offre supporto, sia per quanto riguarda la sperimentazione operativa<br />
(progetto), sia perché è in grado di fornire sostegno a due livelli: il<br />
reperimento di risorse esterne (informazioni, visibilità…), e l’elaborazione di<br />
risorse interne (grazie all’instaurarsi di rapporti interpersonali).<br />
Successivamente, il processo empowering è sostenuto da un atteggiamento<br />
associativo basato sul coinvolgimento decisionale, sulla responsabilità e<br />
156
leadership condivisa, in conformità con il modello di empowerment<br />
organizzativo proposto da Zimmerman (2000). L’identificazione personale<br />
implica inoltre una maggiore partecipazione, consapevolezza critica e<br />
controllo (Cap.2, p.29).<br />
Una metodologia così strutturata, conferma l’ipo<strong>tesi</strong> proposta da Rappaport<br />
(1987), secondo cui il concetto di empowerment contiene in sé sia il<br />
riferimento all’autodeterminazione individuale (nel nostro caso self-<br />
empowerment), sia alla partecipazione alla vita di comunità (appartenenza<br />
associativa); traducendosi tanto nel senso di controllo personale quanto nella<br />
percezione di influenza sociale (Cap.2, p.18).<br />
Occorre pertanto andare oltre l’individuo, considerando come sia<br />
intrinsecamente implicata nel concetto di empowerment una relazione di<br />
potere/influenza con l’ambiente, la comunità, con un oggetto di investimento<br />
esterno o interno.<br />
In conclusione, l’orientamento proposto dall’associazione si ricongiunge ai<br />
modelli collettivi di empowerment e di rete sociale: l’accentuazione del ruolo<br />
di attore della persona e del suo collettivo; la trasformazione del rapporto con<br />
l’ambiente, la valorizzazione della persona, l’invito all’espressione e<br />
all’organizzazione più autonoma possibile sottendono l’idea che le persone<br />
siano capaci di assumersi responsabilità sociali e di difendere gli interessi<br />
propri ed altrui. I valori sociali esaltati sono la cooperazione, la solidarietà,<br />
l’aiuto reciproco, la responsabilità individuale e collettiva e la mobilitazione<br />
attorno ad un progetto comune.<br />
L’associazione propone dunque un miglioramento della qualità di vita<br />
innescando un movimento che sposta il focus di interesse dalla dimensione<br />
individuale a quella collettiva.<br />
157
E’ il gruppo, alla cui base esistono presupposti valoriali condivisi che permette<br />
alle persone di ottimizzare le risorse per il raggiungimento di obiettivi, e che<br />
permette a ciascun soggetto di realizzare un desiderio, ovvero il poter<br />
contribuire alla creazione di qualcosa di significativo e importante per sé e per<br />
gli altri, enfatizzando l’idea che è possibile essere artefici della propria storia e<br />
cultura.<br />
158
APPENDICE A<br />
La seguente intervista ha lo scopo di raccogliere dati per fornire una<br />
fotografia dettagliata della vostra vita associativa. Abbiamo deciso di<br />
richiedere la sua collaborazione perché crediamo che i soci siano le<br />
persone che conoscono meglio l’associazione <strong>Wigwam</strong>.<br />
L’intervista è composta da venticinque domande, ed è anonima, i dati<br />
saranno elaborati collettivamente e non sarà possibile risalire alle<br />
risposte individuali. Per questo motivo le chiediamo la massima<br />
sincerità, in modo da poter avere un quadro realistico della sua<br />
associazione.<br />
GRAZIE PER LA GENTILE COLLABORAZIONE<br />
159<br />
Università degli Studi di Padova<br />
DPSS / Dipartimento di Psicologia<br />
dello Sviluppo e della Socializzazione<br />
via Belzoni, 80 - 35131 PADOVA (ITALY)<br />
fax 8278451
INTERVISTA<br />
SESSO:<br />
ETA:<br />
PROFESSIONE:<br />
TITOLO DI STUDIO:<br />
RUOLO ALL’INTERNO DELL’ASSOCIAZIONE:<br />
Per cominciare vorrei avere delle informazioni sul suo progetto:<br />
1.Com’ è nato il suo progetto?<br />
3. Chi sono i beneficiari?<br />
2.Qual è l’obiettivo generale del suo progetto?<br />
4. Quale tipo di supporto le ha offerto l’associazione per la realizzazione del suo<br />
progetto? (Aiuto economico, sostegno, informazioni pratiche…)<br />
160
5. Secondo lei quali sono gli aspetti più importanti di cui tiene conto<br />
l’organizzazione quando qualcuno propone un progetto?<br />
6. Da quanto tempo svolge attività in questa associazione?<br />
7. Quante ore effettive alla settimana dedica ad attività che riguardano<br />
l’associazione?<br />
8. Com’è entrato a far parte di quest’associazione?<br />
9. Perché rimane all’interno di quest’associazione?<br />
Ora vorrei farle qualche domanda un po’ più specifica sul suo club:<br />
10. Quali sono i problemi principali che affrontate all’interno del vostro club?<br />
11. All’interno del vostro club effettuate degli incontri periodici per discutere e<br />
risolvere i problemi?Se si, con quale frequenza?<br />
12. Indicativamente quante persone partecipano a questi incontri?<br />
13. Esiste una persona incaricata di coordinare, gestire queste riunioni? Se si, chi è?<br />
14. Le persone che partecipano alle riunioni, lo fanno volontariamente o la<br />
partecipazione è obbligatoria?<br />
15. Da chi e in che modo vengono scelti i problemi da analizzare nei vari incontri?<br />
16. Secondo lei l’associazione fornisce sufficienti possibilità di formazione per i<br />
soci?<br />
17. Sono previsti compensi o riconoscimenti per chi partecipa a questi incontri?<br />
18. Secondo lei l’associazione si avvale e prende in considerazione le idee che<br />
vengono dai suoi soci?<br />
19. Lei, sente di poter influenzare l’andamento dell’organizzazione?<br />
20. All’interno dell’associazione come è gestito il potere?<br />
Per concludere le propongo ancora qualche domanda sui valori che guidano la sua<br />
associazione:<br />
161
21. Secondo lei quali sono i principi guida di questa associazione?<br />
22. All’interno di questa associazione, ci sono valori in cui si identifica in prima<br />
persona?<br />
23. Cosa intende lei per qualità di vita?<br />
24. Secondo lei quali sono i punti di forza di questa associazione?<br />
25. Secondo lei quali sono gli aspetti in cui l’associazione dovrebbe migliorare?<br />
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE<br />
162
163
APPENDICE B<br />
TABELLA 1: coordinate e contributi assoluti delle forme grafiche<br />
significative per F1 e F2 (domanda 1).<br />
Forme Grafiche F1coordF2coord F1 CA F2 CA<br />
anni 0,57 0,1 1,1 0<br />
avevo -0,06 0,25 0 1,1<br />
giovani -0,1 -0,98 0 2,3<br />
agriturismo -1,87 1,22 3,3 1,5<br />
amore 1,11 -0,08 1,8 0<br />
artisti 1,79 0,15 3 0<br />
attraverso -0,76 -1,14 0,8 1,9<br />
bambini 0,88 -0,06 1,1 0<br />
cavalli -1,87 1,22 3,3 1,5<br />
corsi 1,3 -0,44 1,6 0,2<br />
costruire 0,76 0,06 1,1 0<br />
creare 1,01 0,11 1,4 0<br />
creatività 1,34 0,04 1,7 0<br />
cui -1,01 0,35 1,4 0,2<br />
cultura 0,61 -0,97 1,1 2,8<br />
disabile -1,25 0,68 5,2 1,6<br />
esigenza -0,82 -1 1,3 2<br />
europea -1,72 -4,21 2,8 17,4<br />
formazione -0,88 -2,41 0,7 5,7<br />
forte -1,87 1,22 5 2,2<br />
gente 1,6 -0,45 2,4 0,2<br />
giocavano 0,88 -0,06 1,1 0<br />
gruppo 1,09 -0,25 1,1 0,1<br />
informazione -0,9 0,5 1,9 0,6<br />
lavoro 0,88 -0,15 1,8 0,1<br />
linguaggio 1,3 -0,44 2,4 0,3<br />
occupare -0,95 0,69 2,2 1,2<br />
parte 1,54 -0,15 2,3 0<br />
persona -0,88 -0,61 1,8 0,9<br />
piaceva 1,01 0,11 1 0<br />
problema -0,73 0,2 1,3 0,1<br />
promuovere -1,72 -4,21 2,8 17,4<br />
recupero 0,63 0,11 1,1 0<br />
164
iguarda 0,96 -0,48 1,7 0,5<br />
scambi -1,72 -4,21 4,2 26<br />
solidarietà -1,87 1,22 3,3 1,5<br />
storia 1,26 -0,33 6,8 0,5<br />
territorio 0,79 -0,21 1,5 0,1<br />
tradizioni 1,54 -0,4 3,4 0,2<br />
turismo -0,9 0,77 1,5 1,1<br />
usare -1,22 0,92 1,4 0,8<br />
vissuta 1,6 -0,45 2,4 0,2<br />
wigwam -0,94 0,78 1,3 0,9<br />
165
TABELLA 2: coordinate e contributi assoluti delle forme grafiche<br />
significative per F1 e F2 (domanda 2).<br />
Forme Grafiche F1 coord F2 coord F1 CA F2 CA<br />
andare -1,37 -0,84 3,7 1,6<br />
attraverso 0,15 -0,71 0,1 2,3<br />
conoscere 0,91 -0,11 4,1 0,1<br />
costruire -1,72 -0,77 5,8 1,3<br />
crea -0,76 -1,44 1,7 7,1<br />
dare 0,7 0,11 2,5 0,1<br />
disabili -2,06 0,03 12,6 0<br />
educare -1,83 -0,5 9,9 0,9<br />
fare 0,66 1,22 2,2 8,5<br />
gente 0,58 0,83 1 2,3<br />
ragazzi 0,96 -1,87 1,8 7,9<br />
maggior -1,67 0,51 5,5 0,6<br />
memoria 0,59 1,19 0,7 3,2<br />
migliorare -1,24 0,25 7,6 0,4<br />
persone -0,37 0,86 0,8 5<br />
piacere 1,07 1,18 2,2 3,2<br />
professionali 0,8 -1,1 1,3 2,7<br />
promuovere 1,1 -1,61 3,6 8,8<br />
qualità -1,71 -0,03 5,8 0<br />
raccoglie 0,47 1,2 0,4 3,3<br />
rispetto -1,67 0,51 5,5 0,6<br />
solitamente 1,37 -1,09 3,7 2,7<br />
stesso 0,11 1,23 0 3,5<br />
storia 0,62 0,48 1,9 1,3<br />
turismo 0,53 -1,56 0,6 5,5<br />
vari 1,23 -1,41 3 4,5<br />
166
TABELLA 3: coordinate e contributi assoluti delle forme grafiche<br />
significative per F2 e F3 (domanda 2).<br />
Forme grafiche F2 coord F3 coord F2 CA F3 CA<br />
alimentari -0,19 1,76 0,2 14,5<br />
attraverso -0,71 1,34 2,3 8,4<br />
capire -0,9 1,03 1,8 2,5<br />
crea -1,44 -0,31 7,1 0,3<br />
disabili 0,03 -1,05 0 3,9<br />
educare -0,5 -0,78 0,9 2,1<br />
fare 1,22 -0,41 8,5 1<br />
gente 0,83 0,19 2,3 0,1<br />
ragazzi -1,87 -0,37 7,9 0,3<br />
handicap -1,76 -0,05 7 0<br />
memoria 1,19 0,11 3,2 0<br />
mie 0,41 -0,67 0,8 2,1<br />
persone 0,86 0,15 5 0,2<br />
piacere 1,18 -1,21 3,2 3,4<br />
professionali -1,1 -0,65 2,7 1<br />
promuovere -1,61 -0,66 8,8 1,5<br />
pubblicazioni 0,28 1,31 0,2 4<br />
raccoglie 1,2 0,1 3,3 0<br />
solitamente -1,09 -1,23 2,7 3,6<br />
stare -0,29 3,02 0,3 32,1<br />
stesso 1,23 -0,19 3,5 0,1<br />
tradizioni -0,01 1,14 0 4,5<br />
trova 0,47 0,79 0,7 2,2<br />
turismo -1,56 -0,17 5,5 0,1<br />
vari -1,41 -0,86 4,5 1,7<br />
167
TABELLA 4: coordinate e contributi assoluti delle forme grafiche<br />
significative per F1 e F3 (domanda 2).<br />
Forme grafiche F1 coord F3 coord F1 CA F3 CA<br />
alimentari -0,55 1,76 1,2 14,5<br />
andare -1,37 -0,02 3,7 0<br />
attraverso 0,15 1,34 0,1 8,4<br />
capire -0,83 1,03 1,3 2,5<br />
conoscere 0,91 -0,45 4,1 1,2<br />
costruire -1,72 -0,64 5,8 1<br />
dare 0,7 -0,57 2,5 1,9<br />
disabili -2,06 -1,05 12,6 3,9<br />
educare -1,83 -0,78 9,9 2,1<br />
vita -0,56 -0,19 1,8 0,2<br />
fare 0,66 -0,41 2,2 1<br />
maggior -1,67 -0,74 5,5 1,3<br />
mie 0,74 -0,67 2,1 2,1<br />
migliorare -1,24 -0,5 7,6 1,5<br />
piacere 1,07 -1,21 2,2 3,4<br />
promuovere 1,1 -0,66 3,6 1,5<br />
pubblicazioni 0,2 1,31 0,1 4<br />
qualità -1,71 -0,43 5,8 0,4<br />
rispetto -1,67 -0,74 5,5 1,3<br />
solitamente 1,37 -1,23 3,7 3,6<br />
stare -0,32 3,02 0,3 32,1<br />
tradizioni 0,22 1,14 0,1 4,5<br />
trova 0,11 0,79 0 2,2<br />
168
TABELLA 5: coordinate e contributi assoluti delle forme grafiche<br />
significative per F1 e F2 (domanda 4).<br />
Forme grafiche F1coordF2 coordF1CA F2CA<br />
aiuto 0,85 -1,89 2,4 12,7<br />
ampio 0,61 0,93 1,2 3,1<br />
associazione 0,74 1,1 1,8 4,3<br />
avere -0,93 0,2 4,2 0,2<br />
circoli 0,77 -1,16 3,8 9,5<br />
condivido 0,46 0,75 0,7 2<br />
confrontare 0,62 0,53 1,3 1<br />
conoscenza 0,47 0,02 1,4 0<br />
diffusione 0,93 0,59 4,2 1,9<br />
fare 0,28 -0,09 0,9 0,1<br />
obiettivi 0,14 0,98 0,1 5,1<br />
idee 1,3 -3,54 5,5 44,4<br />
rapporti -1,1 0,12 5,9 0,1<br />
informazioni -1,9 -0,29 35 0,9<br />
possibilità 0,09 -0,02 0,1 0<br />
principale -0,7 0,07 1,6 0<br />
pubblicazione 1,01 1,03 3,3 3,7<br />
pubblicità 0,87 0,91 3,7 4,3<br />
sostegno -1,34 -0,16 20,3 0,3<br />
supporto 0,57 0,73 2,6 4,8<br />
visibilità 0,02 0 0 0<br />
169
TABELLA 6: coordinate e contributi assoluti delle forme grafiche<br />
significative per F1 e F2 (domanda 5).<br />
Forme grafiche F1coordF2coordF1CA F2 CA<br />
ambiente 0,5 -0,44 0,8 0,7<br />
associativi 0,28 1,05 0,3 4,2<br />
attuazione -0,36 -0,15 0,4 0,1<br />
club -0,02 -1,05 0 2,8<br />
coerenza -1,52 0,89 5 2<br />
compatibilità -1,91 -0,07 16 0<br />
discute 0,41 0,31 0,4 0,2<br />
idea 0,63 -0,36 0,9 0,3<br />
insieme 0,24 -0,16 0,1 0,1<br />
miglioramento 0,26 -0,69 0,4 3<br />
obiettivi -2,69 0,38 31,5 0,7<br />
persona 0,52 -0,42 1,7 1,3<br />
progetto 0,38 0,23 1,7 0,8<br />
proposta 0,52 1,71 0,6 7,5<br />
qualità 0,5 0,3 2,7 1,2<br />
realizzarlo 0,11 0,26 0 0,2<br />
risorse -0,75 -0,36 1,2 0,3<br />
rispettati 0,65 -0,28 1,8 0,4<br />
società -3,12 0,74 21,2 1,4<br />
sostenibilità 1,06 4,1 2,5 42,8<br />
tempi -1,65 -0,19 6 0,1<br />
territorio 0,43 -0,59 0,8 1,8<br />
validità 0,41 0,31 0,4 0,2<br />
valori 0,37 0,96 0,4 3,5<br />
valutare 0,19 -0,49 0,1 0,6<br />
vita 0,52 -0,33 1,4 0,7<br />
voglia 0,32 1,33 0,2 4,5<br />
170
TABELLA 7: coordinate e contributi assoluti delle forme grafiche<br />
significative per F1 e F3 (domanda 5).<br />
Forme grafiche F1 coord F2 coord F1 CA F3 CA<br />
ambiente 0,5 -0,44 0,8 0,7<br />
associativi 0,28 1,05 0,3 4,2<br />
attuazione -0,36 -0,15 0,4 0,1<br />
club -0,02 -1,05 0 2,8<br />
coerenza -1,52 0,89 5 2<br />
compatibilità -1,91 -0,07 16 0<br />
discute 0,41 0,31 0,4 0,2<br />
idea 0,63 -0,36 0,9 0,3<br />
insieme 0,24 -0,16 0,1 0,1<br />
miglioramento 0,26 -0,69 0,4 3<br />
obiettivi -2,69 0,38 31,5 0,7<br />
persona 0,52 -0,42 1,7 1,3<br />
progetto 0,38 0,23 1,7 0,8<br />
proposta 0,52 1,71 0,6 7,5<br />
qualità 0,5 0,3 2,7 1,2<br />
realizzarlo 0,11 0,26 0 0,2<br />
risorse -0,75 -0,36 1,2 0,3<br />
rispettati 0,65 -0,28 1,8 0,4<br />
società -3,12 0,74 21,2 1,4<br />
sostenibilità 1,06 4,1 2,5 42,8<br />
tempi -1,65 -0,19 6 0,1<br />
territorio 0,43 -0,59 0,8 1,8<br />
validità 0,41 0,31 0,4 0,2<br />
valori 0,37 0,96 0,4 3,5<br />
valutare 0,19 -0,49 0,1 0,6<br />
vita 0,52 -0,33 1,4 0,7<br />
voglia 0,32 1,33 0,2 4,5<br />
171
TABELLA 8: coordinate e contributi assoluti delle forme grafiche<br />
significative per F2 e F3 (domanda 5).<br />
Forme Grafiche F2coordF3coordF2 CA F3 CA<br />
ambiente -0,44 -0,06 0,7 0<br />
associativi 1,05 -1,5 4,2 8,9<br />
attuazione -0,15 0,26 0,1 0,3<br />
club -1,05 0,56 2,8 0,8<br />
coerenza 0,89 -0,74 2 1,4<br />
compatibilità -0,07 0,27 0 0,4<br />
discute 0,31 0,24 0,2 0,1<br />
idea -0,36 -0,03 0,3 0<br />
insieme -0,16 0,11 0,1 0<br />
miglioramento -0,69 0,29 3 0,6<br />
obiettivi 0,38 0,1 0,7 0,1<br />
persona -0,42 0,01 1,3 0<br />
progetto 0,23 0,08 0,8 0,1<br />
proposta 1,71 -2,49 7,5 16,4<br />
qualitA 0,3 -0,16 1,2 0,3<br />
realizzarlo 0,26 -0,65 0,2 1,1<br />
risorse -0,36 0,21 0,3 0,1<br />
rispettati -0,28 -0,18 0,4 0,2<br />
società 0,74 -0,14 1,4 0<br />
sostenibilità 4,1 4,16 42,8 45,9<br />
tempi -0,19 0,39 0,1 0,4<br />
territorio -0,59 0,16 1,8 0,1<br />
validità 0,31 0,24 0,2 0,1<br />
valori 0,96 -1,49 3,5 8,9<br />
valutare -0,49 0,12 0,6 0<br />
vita -0,33 -0,04 0,7 0<br />
voglia 1,33 -1,78 4,5 8,4<br />
172
TABELLA 9: coordinate e contributi assoluti delle forme grafiche<br />
significative per F1 e F2 (domanda 9).<br />
Forme grafiche F1 coord F2 coord F1 CA F2 CA<br />
bene -1,39 -0,43 10,8 1,1<br />
condivido -0,14 -0,82 0,1 3,1<br />
confronto 0,65 1,41 1,2 6,1<br />
contatto -0,28 1,56 0,2 7,5<br />
continuando 1,14 0,62 3,6 1,2<br />
credo -0,97 -0,56 3,9 1,4<br />
desidero 1,07 0,91 3,2 2,6<br />
fare 0,93 0,5 3,6 1,2<br />
finalità 0,54 -0,97 2,1 7,2<br />
idea -1,32 -0,82 4,8 2,1<br />
interesse -0,7 1,93 2,1 17,3<br />
molto -0,87 0,27 4,2 0,5<br />
momento -0,37 1,31 0,4 5,3<br />
permette 0,29 1,95 0,4 17,5<br />
piacevole -0,05 1,34 0 5,5<br />
possibilità 0,64 0,16 2,9 0,2<br />
valore -1,45 -0,9 8,8 3,8<br />
progetto -1,15 0,03 3,7 0<br />
propongono -1,61 -0,81 7,2 2<br />
rete 1,28 -0,17 4,5 0,1<br />
sento 1,41 -1,04 5,6 3,3<br />
sono 1,31 -1,04 4,8 3,3<br />
trovo -0,72 0,04 4,3 0<br />
utile -0,96 0,08 3,9 0<br />
vedere 0,83 -0,16 2,9 0,1<br />
vita 1,09 -0,8 5 2,9<br />
173
TABELLA 10: coordinate e contributi assoluti delle forme grafiche<br />
significative per F1 e F2 (domanda 12).<br />
Forme grafiche F1 coord F2coordF1 CA F2 CA<br />
aiuto 0,44 -2,4 0,7 22,3<br />
amministrativi -0,59 0,28 2,6 0,6<br />
attività 0,33 0,73 0,4 2,1<br />
economici 0,15 -0,31 0,6 2,7<br />
comunicazione -0,26 -0,17 0,2 0,1<br />
conoscenza -0,92 -0,05 3,2 0<br />
diffondere -1,27 0,35 12,1 0,9<br />
diffidenza 1,25 0,73 8,8 3,1<br />
essere -3 0,63 33,4 1,5<br />
fare_rete 0,18 -1,33 0,1 6,9<br />
sforzi 0,21 -0,25 0,2 0,2<br />
iniziativa -0,35 -1,02 0,7 6<br />
riconoscimenti -0,01 0,36 0 0,5<br />
logistici 0,91 1,16 6,1 10,4<br />
mancanza 0,99 -1,31 7,2 13,4<br />
mancanza_tempo 0,36 0,19 1 0,3<br />
organizzativi 0,81 1,38 3,7 11,2<br />
persone 0,44 0,69 1,8 4,6<br />
problema 0,11 0,31 0,2 1,8<br />
progetti -0,2 -0,07 0,3 0<br />
relativi 0,2 0,64 0,1 1,6<br />
valorizzazione -1,75 0,42 11,3 0,7<br />
174
TABELLA 11: coordinate e contributi assoluti delle forme grafiche<br />
significative per F1 e F2 (domanda 18).<br />
Forme grafiche F1coord F2coord F1 CA F2 CA<br />
flessibile 0,24 0,11 0,4 0,1<br />
aperti_proposte -1,66 -0,02 18,9 0<br />
discute_insieme 0,57 1,95 3,3 50,2<br />
molto_ascolto 0,63 -0,77 8,1 15,6<br />
non_sempre_attuate 0,66 -1,31 4,4 22,7<br />
se_compatibili -2,11 -0,04 30,3 0<br />
se_valide 0,71 1,13 3,4 11,2<br />
si 0,11 0,02 0,9 0<br />
valori -2,11 -0,04 30,3 0<br />
175
TABELLA 12: coordinate e contributi assoluti delle forme grafiche<br />
significative per F1 e F2 (domanda 21).<br />
Forme grafiche F1 coord F2 coord F1CA F2 CA<br />
altri 0,79 2,21 1,8 15,2<br />
altro 0,16 0,55 0,1 0,9<br />
amore 0,82 0,67 1,9 1,4<br />
amicizia -0,47 0,36 0,6 0,4<br />
aspetti -0,69 -0,29 2 0,4<br />
conviviale 0,82 0,99 1,9 3,1<br />
idea 0,3 -0,34 0,3 0,4<br />
miglioramento -0,63 -0,17 3,4 0,3<br />
mondo -0,62 -0,06 1,6 0<br />
persone 0,05 -0,22 0 0,3<br />
possibilità 0,16 0,55 0,1 0,9<br />
progetti 0,33 -0,53 0,5 1,3<br />
promozione 0,58 -0,27 1 0,2<br />
qualità -0,66 -0,2 4,4 0,4<br />
rapporto 0,52 3,13 0,8 30,7<br />
recupero 2,08 -1,51 12,3 7,1<br />
solidarietà -0,06 1,3 0 8<br />
sono 0,21 0,25 0,2 0,3<br />
sostenibile -0,56 -0,1 1,3 0<br />
stile -0,48 0,27 1 0,4<br />
territorio -1,32 -1,13 7,5 6<br />
tradizioni 3 -1,66 38,6 13<br />
unione -0,73 -0,89 1,5 2,5<br />
valore 1,24 0,38 8,8 0,9<br />
visto 0,3 -0,34 0,3 0,4<br />
vita -0,53 0,01 3,2 0<br />
vivere -1,3 -1,32 4,9 5,4<br />
176
TABELLA 13: coordinate e contributi assoluti delle forme grafiche<br />
significative per F1 e F2 (domanda 22).<br />
Forme grafiche F1 coord F2 coord F1 CA F2 CA<br />
amare_la_vita -0,19 -1,22 0,1 4,1<br />
amicizia 1,19 1,75 3,6 8,4<br />
autenticità 0,63 0,43 1 0,5<br />
ci_credo_molto -0,15 -0,82 0,1 1,9<br />
comunanza_interessi 1,19 1,75 3,6 8,4<br />
corrispondono -3,06 1,61 23,8 7,2<br />
eco-compatibile 0,63 0,43 1 0,5<br />
essere_gruppo 1,19 1,75 3,6 8,4<br />
molto -0,15 -0,82 0,1 1,9<br />
non_del_tutto -0,15 -0,82 0,2 5,6<br />
non_essere_passivi 0,51 0,31 0,6 0,3<br />
possibilità_confronto 0,63 0,43 1 0,5<br />
reciproco_scambio 0,63 0,43 1 0,5<br />
scelta -3,06 1,61 23,8 7,2<br />
semplicità 0,63 0,43 1 0,5<br />
sento_molto_coinvolto -0,15 -0,82 0,1 1,9<br />
si -0,07 -0,33 0,3 6,2<br />
solidarietà 1,19 1,75 3,6 8,4<br />
soprattutto 0,72 0,67 6,5 6,2<br />
sviluppo_sostenibile 0,63 0,43 1 0,5<br />
totalmente -0,16 -1,01 0,3 13,9<br />
vita -3,06 1,61 23,8 7,2<br />
177
TABELLA 14: coordinate e contributi assoluti delle forme grafiche<br />
significative per F1 e F2 (domanda 23).<br />
Forme Grafiche F1 coord F2 coord F1 CA F2 CA<br />
ben 1,07 -0,55 10,2 2,8<br />
benessere 1,1 -0,96 3,5 2,9<br />
cercare -0,72 -0,77 3,8 4,6<br />
desideri -0,03 1,4 0 6,1<br />
diverse 2 -0,95 11,7 2,8<br />
lavori -0,69 0,06 1,4 0<br />
livello 1,2 -0,74 4,2 1,7<br />
meglio -0,97 -0,67 5,5 2,8<br />
miglioramento -1,07 -0,25 5,1 0,3<br />
nostre 0,59 2,32 2,5 41,8<br />
pensieri -0,18 1,92 0,1 11,4<br />
piace -1,11 -0,22 5,5 0,2<br />
porsi 1,47 0,38 6,4 0,4<br />
portare 1,6 -0,84 7,5 2,2<br />
possibilità -0,98 0 2,8 0<br />
qualità -0,08 0,8 0 3<br />
radici 0,95 1,71 2,7 9,1<br />
rispetto 1,49 -0,83 6,5 2,1<br />
riuscire -1 -0,58 2,9 1<br />
178
TABELLA 15: coordinate e contributi assoluti delle forme grafiche<br />
significative per F1 e F3 (domanda 23).<br />
Forme grafiche F1 coord F3 coord F1 CA F3 CA<br />
ben 1,07 0,25 10,2 0,6<br />
benessere 1,1 0,65 3,5 1,4<br />
cercare -0,72 0,22 3,8 0,4<br />
desideri -0,03 0,21 0 0,1<br />
diverse 2 0,51 11,7 0,9<br />
fare -0,73 -0,01 7,8 0<br />
livello 1,2 -2,6 4,2 22,3<br />
meglio -0,97 0,17 5,5 0,2<br />
miglioramento -1,07 -0,62 5,1 1,9<br />
nostre 0,59 -0,07 2,5 0<br />
pensieri -0,18 0,37 0,1 0,5<br />
piace -1,11 -0,48 5,5 1,1<br />
porsi 1,47 0,16 6,4 0,1<br />
portare 1,6 -1,04 7,5 3,6<br />
possibilità -0,98 -0,78 2,8 2<br />
qualità -0,08 -0,31 0 0,5<br />
radici 0,95 -0,2 2,7 0,1<br />
rispetto 1,49 1,39 6,5 6,4<br />
riuscire -1 0,45 2,9 0,7<br />
179
TABELLA 16: coordinate e contributi assoluti delle forme grafiche<br />
significative per F2 e F3 (domanda 23).<br />
Forme grafiche F2 coord F3 coord F2 CA F3 CA<br />
ben -0,55 0,25 2,8 0,6<br />
benessere -0,96 0,65 2,9 1,4<br />
cercare -0,77 0,22 4,6 0,4<br />
desideri 1,4 0,21 6,1 0,1<br />
diverse -0,95 0,51 2,8 0,9<br />
fare -0,03 -0,01 0 0<br />
livello -0,74 -2,6 1,7 22,3<br />
meglio -0,67 0,17 2,8 0,2<br />
miglioramento -0,25 -0,62 0,3 1,9<br />
nostre 2,32 -0,07 41,8 0<br />
pensieri 1,92 0,37 11,4 0,5<br />
piace -0,22 -0,48 0,2 1,1<br />
porsi 0,38 0,16 0,4 0,1<br />
portare -0,84 -1,04 2,2 3,6<br />
possibilità 0 -0,78 0 2<br />
qualità 0,8 -0,31 3 0,5<br />
radici 1,71 -0,2 9,1 0,1<br />
rispetto -0,83 1,39 2,1 6,4<br />
riuscire -0,58 0,45 1 0,7<br />
180
TABELLA 17: coordinate e contributi assoluti delle forme grafiche<br />
significative per F1 e F2 (domanda 24).<br />
Forme grafiche F1 coord F2 coord F1 CA F2 CA<br />
amicizia -0,5 -0,3 1,1 0,6<br />
apolitica -0,12 -2,7 0,1 35,3<br />
attività -0,76 0,3 6,5 1,4<br />
autenticità 1,75 0,9 20,3 6,3<br />
condivisione 0,13 -0,6 0,3 9<br />
convinzione -1,18 1 6,2 4,9<br />
entusiasmo -1,29 1,1 7,4 6,3<br />
filosofia 1,02 0,1 4,6 0,1<br />
idee -0,09 -1,3 0,1 12,3<br />
obiettivi 0,36 -0,5 0,8 2<br />
persone -1,07 0,7 12,8 5,9<br />
qualità -1,01 0,6 6,7 3,3<br />
semplicità 1,8 1 28,7 9,7<br />
spirito 0,99 0 4,4 0<br />
valori 0,05 -0,7 0 2,9<br />
181
TABELLA 18: coordinate e contributi assoluti delle forme grafiche<br />
significative per F1 e F2 (domanda 25).<br />
Forme grafiche F1 coord F2 coord F1 CA F2 CA<br />
più -0,12 -1,11 0,1 10,5<br />
Comunicazione -0,56 -0,57 4,5 4,8<br />
burocratica -1,07 1,2 13,9 18,3<br />
assistenza -1,08 1,22 16,3 22<br />
carenza -0,32 -1,36 0,4 7,8<br />
conoscere_di_più 1,49 0,53 22,4 3<br />
fare_rete 0 -1 0 4,2<br />
diff_iniz_livello_naz -0,49 -1,02 1,4 6,7<br />
evidenziare 1,66 0,76 16,6 3,7<br />
fondi -0,32 -1,36 0,4 7,8<br />
nuovi 0,99 -0,17 3,9 0,1<br />
professionali -0,23 -1,22 0,2 6,4<br />
progetti 0,73 -0,41 3,2 1,1<br />
successi 1,66 0,76 16,6 3,7<br />
182
183
BIBLIOGRAFIA<br />
- Amaturo E., Messaggio, simbolo, comunicazione, La Nuova Italia Scientifica,<br />
Firenze, 1993.<br />
- Amerio P., Psicologia di comunità, Il Mulino, Bologna, 2000.<br />
- Amovilli L., Bortolotti A., Carrus P., Mancini M., Professione<br />
benessere: la competenza della qualità di vita, Psicologia e Lavoro,<br />
1997, pp. 20-25.<br />
- Arcidiacono C., Gelli B., Putton A., Empowerment sociale. Il futuro<br />
della solidarietà: modelli di psicologia di comunità, Franco Angeli,<br />
Milano, 1996.<br />
- Avallone F., Bonaretti M., Benessere organizzativo, Rubbettino,<br />
Catanzaro, 2003.<br />
- Bandura A., Il senso di autoefficacia, Erickson, Trento, 1996.<br />
- Bassi A., Il terzo settore in Italia. Uno sguardo d’insieme, Autonomie<br />
locali e servizi sociali, 2, 1994, pp.257-273.<br />
- Bassi A., Tra denaro e solidarietà, Rivista del volontariato, 12, 1994,<br />
pp. 7-10.<br />
- Beck W., Van Der Maesen L., Walker A., The Social Quality Of<br />
Europe, Netherlands Universities Institute for Coordination of Research<br />
in Social Science, Temporary Edition, The Hague, 1997.<br />
- Bennis W.G., Benne K.D., Chin R., The planning of change, New<br />
York, Holt, Rinehart and Winston, 1969.<br />
- Benzécri J.P., L’analyse des données, Dunod, Paris, 1973.<br />
- Besson C., Donne, famiglie, reti, Rivista del servizio sociale, 2, 1992.<br />
- Block P., The Empowered Manager: Positive Political Skills At Work,<br />
Jossey-Bass, San Francisco, 1987.<br />
184
- Boccacin L., Marta E., Giovani, adulti e volontariato, Edizioni<br />
Unicopli, Milano, 2003.<br />
- Bolasco S., Cipriani R., Ricerca qualitativa e computer. Teorie, metodi<br />
e applicazioni, Franco Angeli, Milano, 1995.<br />
- Bolasco S., Cipriani R., Meta-data and strategies of textual data<br />
analysis: problems and instruments. Paper presented at the V<br />
internetional conference of IFCS, Kobe, Japan, 1997.<br />
- Bolasco S., Cipriani R., Analisi multidimensionale dei dati, Carocci,<br />
Roma, 1999.<br />
- Bolasco S., Cipriani R., Analisi dei dati testuali, Carocci, Roma, 1999.<br />
- Brodeur C., Rousseau R., L’intervention de réseaux, Edition France<br />
Amèrique, Montréal, 1984.<br />
- Bruscaglioni M., Orizzonte empowerment: panorama sui significati ed<br />
applicazioni dell’empowerment, Risorsa Uomo, 3, 1994, pp. 325-342.<br />
- Bruscaglioni M., La società liberata, Franco Angeli, Milano, 1994.<br />
- Bruscaglioni M., Orizzonte empowerment: l’applicazione nelle<br />
organizzazioni, Risorsa Uomo, 1, 1995, pp. 83-96.<br />
- Bruscaglioni M., Oltre Maslow: nuovi strumenti concettuali per<br />
l’autosviluppo, Rivista FOR, 2003.<br />
- Bruscaglioni M., Gheno S., Il gusto del potere, Franco Angeli , Milano,<br />
2003.<br />
- Bruscaglioni M., La cultura empowerment oriented, Rivista FOR,<br />
2004.<br />
- Burdett J.O., What is empowerment anyway?, Journal of European<br />
Industrial Training, 6, 1991, pp. 23-30.<br />
- Bussini N., Incontro internazionale Ifap, Una ricerca sui circoli di<br />
qualità in Italia, Roma, 1985.<br />
185
- Campbell C., Martinko M., An integrative attributional perspective of<br />
empowerment and learned helpness: a multimethod field study, Journal<br />
of management, 2, 1998, pp.173-200.<br />
- Cemin M., Collini M., Attività didattica integrativa. Manuale di<br />
introduzione allo Spad-T, 1999-2000.<br />
- Cipriani R., Bolasco S., Ricerca qualitativa e computer: teorie, metodi<br />
e applicazioni, Franco Angeli, Milano, 1995.<br />
- Colozzi I., Bassi A., Una solidarietà efficiente, La Nuova Italia<br />
Scientifica, Roma, 1995.<br />
- Converso C., Piccardo C., Il profitto dell’empowerment: formazione e<br />
sviluppo organizzativo nelle imprese non profit, Raffaello Cortina<br />
Editore, Milano, 2003.<br />
- Cornell Empowerment Group, Empowerment and family support,<br />
Networking Bullettin, 1, 1989, pp. 1-23.<br />
- Daly H., Goodland, R., Environmental sustainability: universal and<br />
non-negotiable, Ecological Applications, 6, 1996, pp. 1002-1017.<br />
- De Leonardis O., In un diverso welfare, Feltrinelli, Milano, 1998.<br />
- De Vito Piselli P., La centralità del benessere nelle organizzazioni,<br />
Psicologia e Lavoro, 1994, pp. 8-11.<br />
- Donati P., Sociologia del terzo settore, La Nuova Italia Scientifica,<br />
Roma, 1996.<br />
- Etzioni A., A Comparative Analysis Of Complex Organisations, The<br />
Free Press, New York, 1961.<br />
- Fontanelli G, Tutt’altro che un toccasana però si lavora meglio,<br />
Mondo Economico, 1985.<br />
- Francescato D., Leone L., Traversi M., Oltre la psicoterapia. Percorsi<br />
innovativi di psicologia di comunità, Nis, Roma, 1993.<br />
186
- Francescato D., Burattini M., Empowerment e contesti psicoambientali<br />
di donne e uomini oggi, Aracne, Roma, 1997.<br />
- Galgano A., Circoli della qualità: l’esperienza italiana, Qualeimpresa,<br />
n. 5-6, 1985.<br />
- Hiroto D.S., Seligman M.E.P., Generality of learned helplessness in<br />
man, Journal of Personality and Social Psychology, 31, 1975.<br />
- Hofstede G., Motivazione, leadership, organizzazione: si possono<br />
applicare all’estero le teorie americane?, Sviluppo e Organizzazione,<br />
1980.<br />
- Herzberg F., The motivation to work, Wiley, New York, 1959.<br />
- Inumaru K., Considerazioni sui circoli in Italia e in Giappone, Incontro<br />
internazionale Ifap, Roma, 1985.<br />
- Iscoe I., Community Psychology and the competent community,<br />
American Psychologist, 29, 1974, pp. 607-613.<br />
- Ishikawa K., Guida al controllo di qualità, Franco Angeli, Milano,<br />
1984.<br />
- Juran J. M., Quality Control Handbook, McGraw Hill, New York,<br />
1974.<br />
- Juran J. M., Quality planning and analysis: from product development<br />
through usage, McGraw Hill, New York, 1980.<br />
- JUSE (Union of Japanese Scientists and Engineers), Principes<br />
Généraux des cercles de qualité, ANFOR, 1981.<br />
- JUSE, Come introdurre e seguire le attività dei circoli di qualità,<br />
Franco Angeli, Milano, 1993.<br />
- Karasek R., Theorell T., Healthy work: stress, productivity and the<br />
recostruction of working life, Basic Books, 1990.<br />
187
- Kiefer C., Citizien empowerment: a developmental perspective,<br />
Prevention in Human Service, 3, 1984, pp. 9-36.<br />
- King I.R., Tan K.H., Quality Circles, Omega, vol. 14, n.4, 1986, p.310.<br />
- Laing R., Esterson A., Normalità e follia nella famiglia, Einaudi,<br />
Torino, 1970.<br />
- Lanna M., , Circoli di qualità, Produrre, n.10, 1982.<br />
- Lanzara G., Capacità negativa, Il Mulino, Bologna, 1993.<br />
- Lanzetti C., Elaborazioni di dati qualitativi, Franco Angeli, Milano,<br />
1998.<br />
- Lebart L., Salem A., Statistique textuelle, Dunod, Paris, 1994.<br />
- Lewin K., Field theory in social science: Selected theoretical papers,<br />
New York, Harper, 1951.<br />
- Lewin K., Teoria e sperimentazione in psicologia sociale, Il Mulino,<br />
Bologna, 1972.<br />
- Losito G., L’analisi del contenuto nella ricerca sociale. Franco Angeli,<br />
Milano, 1993.<br />
- May G.D., Kruger M.J., The manager within, Personnel Journal,<br />
February, 1988, pp. 57-65.<br />
- Mannarini T., Comunità e partecipazione, Franco Angeli, Milano,<br />
2004.<br />
- Marcon G., Merlini M., Pianta M., “Introduzione” a Lavori scelti,<br />
Edizioni gruppo Abele, Torino, 1997.<br />
- Martini E., Sequi R., La comunità locale, Nis, Roma, 1995.<br />
- Marzano F., Accountability and Effectiveness Evaluation in non profit<br />
organisation, Studi Economici, 2000.<br />
- Maslow A., Motivation and personality, Harper & Row, 1954.<br />
188
- McGragor D., L’aspetto umano dell’impresa, Franco Angeli, Milano,<br />
1983.<br />
- Monteil B., Ryon P., Alexandre G., Circoli di qualità: gruppi di lavoro<br />
per una nuova competitività dell’impresa, Tecniche nuove, 1980.<br />
- Moranti M., Non profit: produttività e benessere, Franco Angeli,<br />
Milano,1998.<br />
- Napolitano E. M., La qualità nell’impresa sociale: strumenti per il non<br />
profit, Franco Angeli, Milano, 1999.<br />
- Nicoletti B., I circoli di qualità, Franco Angeli, Milano, 1992.<br />
- Nielsen D., Partnering with Employees. A Pratical System for Building<br />
Empowered Relationships, Jossey-Bass, San Francisco, 1993.<br />
- Pearce J.L., Volontariato: motivazioni e comportamenti nelle<br />
organizzazioni di lavoro volontario, Raffaello Cortina Editore, Milano,<br />
1997.<br />
- Pearlstein R.B., Who empowers leaders?, Performance Improvement<br />
Quarterly, 4, 1991, pp. 12-20.<br />
- Peters T., Waterman R., Alla ricerca dell’eccellenza, Tr. It. Spearling<br />
& Kupfer, Milano, 1982.<br />
- Perkins D., Zimmerman M., Empowerment theory, research and<br />
application, American Journal of Community Psychology, 5, 1995, pp.<br />
569-579.<br />
- Piccardo C., Empowerment: strategie di sviluppo organizzativo<br />
centrate sulla persona, Raffaello Cortina Editore, Milano,1995.<br />
- Prezza M., Sgarro, Gli strumenti di valutazione della rete e del<br />
sostegno sociale, Giornale italiano di psicologia, 1992.<br />
- Quaderni di animazione e formazione, L’intervento di rete: concetti e<br />
linee d’azione, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1996.<br />
189
- Randolph A., Blanchard K., Carlos J.P., Le tre chiavi<br />
dell’empowement: come liberare il potere dei collaboratori, Franco<br />
Angeli, Milano, 2002.<br />
- Rappaport J., In praise of paradox. A social Policy of empowerment<br />
over prevention, American Journal of Community Psychology, 1, 1981,<br />
pp. 1-25.<br />
- Rappaport J., Terms of empowerment/exemplars of prevention: toward<br />
a theory for community psychology, American Journal of Community<br />
Psychology, 2, 1987, pp. 121-148.<br />
- Rappaport J., Empowerment meets narrative: listen to stories and<br />
creating settings, American Journal of Community Psychology, 5,<br />
1995, pp. 795-807.<br />
- Rappaport J., Seidma E., Handbook of community psychology, Kluwer<br />
Academic/Plenum Press, 2000, pp. 43-63.<br />
- Ricolfi R., La ricerca qualitativa, La nuova Italia Scientifica, Roma,<br />
1997.<br />
- Riger S., What’s wrong with empowerment, American Journal of<br />
Community Psychology, 3, 1993, pp. 279-292.<br />
- Ripley R.E., Ripley M.J., Empowerment, the cornerstone of quality:<br />
empowering management in innovative organisations in the 1900s,<br />
Management Decision, 4, 1992, pp. 20-43.<br />
- Rothwell S., Team building, involvement and empowerment. Manager<br />
Update, Winter, 1993, pp.19-31.<br />
- Rotter J.B., Generalized expectancies for internal versus external<br />
control of reinforcement, Psychological Monograph, 1966, p. 80.<br />
- Seligman M., Learned Optimism, Knopf, New York, 1990.<br />
190
- Speer P., Intrapersonal and interactional empowerment: implication<br />
for theory, American Journal of Community Psychology, 1, 2000, pp.<br />
51-61.<br />
- Trebbi G., La partecipazione come variabile del benessere<br />
organizzativo, Psicologia e lavoro, 2002.<br />
- Trist E., The evolution of Socio-technical Systems, Occasional Paper, 2,<br />
Quality of Working Life Center, Toronto, 1981.<br />
- Tuzzi A., Analisi del contenuto, Carocci, Roma, 2003.<br />
- Wagner A., Sulla compartecipazione. Prefazione a una teoria<br />
economica del volontariato. In Bramanti D., Politiche sociali e servizi,<br />
Vita e Pensiero, Milano, 1990.<br />
- Zammuner V. L., Tecniche dell’intervista e del questionario, Il Mulino,<br />
Bologna, 1998.<br />
- Zimmerman M., Psychological empowerment: issues and illustration,<br />
American Journal of Community Psychology, 5, 1995, pp. 581-599.<br />
- Zimmerman M., Empowerment e partecipazione nella comunità,<br />
Animazione Sociale, 2, 1999, pp. 10-24.<br />
- Zimmerman M., Empowerment theory. In Rappaport J., Seidman,<br />
Handbook of community psychology, Kluwer Academic/Plenum Press,<br />
New York, 2000.<br />
- Zimmerman M.A., Rappaport J., Citizen participation, perceived<br />
control, and psychological empowerment, American Journal of<br />
Community Psychology, 5, 1988, pp. 725-750.<br />
191