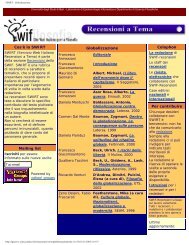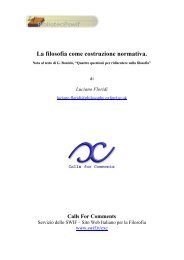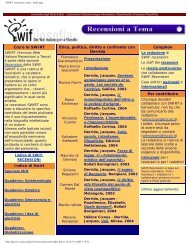Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Ralph Waldo Emerson<br />
a cura di B. Soressi<br />
bensore@lycos.it<br />
Quaderno Filosofi & Classici<br />
SWIF<br />
Sito Web <strong>Italiano</strong> per la Filosofia<br />
www.swif.it
Ralph Waldo Emerson<br />
B. Soressi – Ralph Waldo Emerson<br />
Ralph Waldo Emerson (Boston 1803 - Concord 1882), è il quarto figlio di un pastore<br />
della Chiesa Unitariana, una chiesa protestante “liberale”, per così dire. Rimasto orfano<br />
di padre nel 1811, studia alla Public Latin School e si diploma all’Harvard College nel<br />
1821. Insegna nelle scuole “per giovani donne,” dove resterà fino all’entrata<br />
nell’università di teologia di Harvard, da cui riceve il MA nel ’27. Nel ’29 è ordinato<br />
pastore e sposa Ellen Tucker, che due anni dopo muore di tubercolosi. Ha inizio la<br />
prima importante crisi, che sfocia nelle dimissioni come pastore e in un lungo viaggio in<br />
Europa, Italia inclusa. Stringe amicizia con Carlyle e incontra Wordsworth e Coleridge.<br />
Tornato negli Usa, nel ’34 inizia una lunga carriera come conferenziere. L’anno<br />
seguente si trasferisce in una casa di campagna, a Concord. Sposa Lydia Jackson (1802-<br />
92), da cui avrà cinque figli. Nel ’38 legge pubblicamente un “Appello per i Cherokee,”<br />
che furono allontanati dalla Georgia, e contribuisce alla stessa causa con una severa<br />
lettera a Van Buren, presidente degli Usa. Nel ’40 esce The Dial, la rivista del<br />
Trascendentalismo, che dirigerà nel 1842. Quest’anno H.D. Thoreau si stabilisce in casa<br />
Emerson. Sarà un tuttofare e una figura paterna durante i lunghi tour di conferenze<br />
dell’amico. E. guarda con simpatia distaccata ai tanti esperimenti di vita comunitaria del<br />
suo tempo, come la comunità “neopitagorica” dell’amico A.B. Alcott. Declina l’invito a<br />
prender parte all’altra “comune” Brook Farm. Nel ’43 espone pubblicamente la sua<br />
posizione antischiavista, che lo porta a rischiare l’incolumità durante un discorso del<br />
1861. Nel ’66 riceve il dottorato honoris causa presso l’Harvard College, dove è<br />
convocato l’anno seguente per tenere alcune lezioni. Nel 1873 è nuovamente in Europa<br />
e in Italia.<br />
I Sermoni<br />
Nel 1826 E. pronuncia il primo dei suoi centosettantuno Sermoni, opere in cui, tra<br />
svariate ingenuità, si notano una notevole apertura mentale su questioni teologiche e<br />
acute anticipazioni del suo pensiero futuro. L’ultimo sermone è The Lord’s Supper<br />
(1832): qui presenta le dimissioni come pastore, dopo aver offerto un’interpretazione<br />
simbolistica del dogma della transustanziazione e dopo aver argomentato contro la<br />
tradizionale concezione (fatta propria dagli unitariani) per cui il pane e il vino consacrati<br />
sono il corpo di Cristo. Gesù è visto essenzialmente come modello supremo di<br />
Quaderno Filosofi & Classici<br />
SWIF - Sito Web <strong>Italiano</strong> per la Filosofia - www.swif.it<br />
2
B. Soressi – Ralph Waldo Emerson<br />
educatore, e spogliato di ogni esclusiva veste divina. Emerge un’idea della spiritualità<br />
cristiana come libertà e come invito a vivere nell’amore aprendosi alle possibili forme<br />
rituali e di vita, senza irrigidirsi in forme specifiche o in rigide istituzioni.<br />
Natura (1836)<br />
In questi anni E., che già a Parigi subisce il fascino del Jardin des plantes e del<br />
Musée des sciences, legge con entusiasmo l’astronomo e teorico delle scienze Herschel<br />
e scrive saggi di storia naturale, di letteratura inglese e biografie (come quella di<br />
Michelangelo Buonarroti). Nel 1836 esce, anonimo, Natura, un trattatello sistematico<br />
breve ma centrale nel panorama del Trascendentalismo americano, una corrente<br />
filosofica che nelle versioni di E. e Thoreau può vedersi come un esistenzialismo sui<br />
generis, che ha diramazioni tanto pragmatiche quanto idealistiche e profetiche. Nature<br />
inizia con un’implicita critica degli storicismi post-hegeliani e di ogni sguardo<br />
“retrospettivo,” che egli svilupperà in saggi successivi e si ritroverà poi, quasi invariata,<br />
nella seconda Inattuale di Nietzsche. L’altra critica, rivolta a forme di empirismo<br />
giudicate aride e banalizzanti, come quelle humeane, è sottesa alla volontà di realizzare<br />
un pensiero in grado di ispirare i pensatori dell’avvenire e di invitarli a un<br />
atteggiamento sperimentale e pensante-poetante nei confronti della vita. Ciò è anche una<br />
sorta di trasfigurazione della scommessa di Pascal (i cui Pensieri E. leggeva già a nove<br />
anni). È seguendo attentamente questo filo conduttore, e il continuo riferimento della<br />
vita alla scrittura e viceversa, che si giungerebbe – e senza grossi salti – al pragmatismo<br />
poetico di Nietzsche e Heidegger. Sono tutti tratti caratterizzanti la sua opera<br />
successiva. L’idea principale è quella di preparare il terreno testuale e spirituale per la<br />
venuta di un futuro Pensatore-poeta (altrove chiamato Riformatore, Individuo e, come<br />
qui di seguito, Studioso americano…).<br />
Lo studioso americano (1837) e Divinity School Address (1838)<br />
Questi due saggi sono frutto di fervidi anni di studi pedagogici, di filosofia della<br />
cultura e antropologia filosofica (concentrati in un consistente numero di altri saggi che<br />
forse varrebbe ancora la pena di considerare). Il saggio del ’37 è l’elaborazione di<br />
un’omonima conferenza tenuta a Harvard, definita da O.W. Holmes la “Dichiarazione<br />
d’Indipendenza intellettuale” americana. Lettori e studiosi d’ogni sorta sono invitati a<br />
Quaderno Filosofi & Classici<br />
SWIF - Sito Web <strong>Italiano</strong> per la Filosofia - www.swif.it<br />
3
B. Soressi – Ralph Waldo Emerson<br />
costruire dalle fondamenta una cultura autenticamente americana, e a liberarsi dall’ansia<br />
d’imitare a ogni costo i modelli europei. È inoltre suggerito l’ideale, poi gramsciano, di<br />
un intellettuale organico, totale, in grado di unire pensiero e azione. Lo studioso deve<br />
essere - prima che un lettore di libri - un osservatore del reale, della quotidianità anche<br />
più umile e ordinaria. Il saggio del ’38 disegna a forti tinte un’immagine non certo<br />
nuova ma ancora, nella sua estrema semplicità, “scandalosa” per teologi e conservatori:<br />
quella di un Gesù maestro democratizzatore della divinità, che insegna a tutti e ciascuno<br />
a diventare quegli esseri divini che sono in potenza. È rigettata l’idea per cui solo a<br />
Gesù Cristo o ad altri enti divinizzati - spetterebbero in maniera esclusiva i regali<br />
privilegi della divinità. Questa pretesa di esclusività starebbe alla base della “universale<br />
decadenza e attualmente quasi della morte della fede, nella società”.<br />
Saggi, I serie (1841)<br />
I Saggi rappresentano una delle opere più ricche e mature di E. La fiducia in se<br />
stessi è il cardine del pensiero di E. e non a torto il suo saggio più celebre: è la versione<br />
moderna dell’antico credo socratico e stoico nell’individuo e nelle risorse dell’anima, e<br />
in una mente, o anima, insieme individuale e universale. Ciò comporta la necessità di<br />
esprimere, o almeno di seguire con attenzione, le nostre “convinzioni latenti”, i nostri<br />
pensieri “rigettati”, anche quelli che considereremmo più stupidi e insignificanti. Di qui<br />
l’opzione per il modello di scrittura “errabondo” di Montaigne, il filosofo che E. sente<br />
più congeniale. È una forma intermedia tra l’aforisma e il trattato, vale a dire l’Essay. E.<br />
abbandona così i residui propositi di sistematicità di Nature, e fa sempre più<br />
affidamento sui suoi Journals, i diari, che potrebbero essere considerati il fondamento<br />
della sua opera filosofica, dal momento che contengono molte intuizioni cardinali che<br />
compariranno prima nelle conferenze e infine nelle opere pubblicate. Nei diari sono<br />
riportate intuizioni e annotazioni personali accanto a citazioni e traduzioni, che vanno<br />
da Goethe a Novalis, da Milton a Coleridge, da Platone a Plutarco e Plotino, a<br />
Swedenborg, ai poeti persiani, al pensiero indiano vedico e classico, a quello<br />
confuciano, da trascendentalisti come Sampson Reed a quella sua zia Mary Moody che<br />
fu anche una fondamentale figura parentale per E.<br />
Da Fiducia in se stessi e da Circoli risalta un peculiare modo di pensare, che<br />
Stanley Cavell chiama “aversive thinking,” e che è un pensiero e una teoria<br />
Quaderno Filosofi & Classici<br />
SWIF - Sito Web <strong>Italiano</strong> per la Filosofia - www.swif.it<br />
4
B. Soressi – Ralph Waldo Emerson<br />
dell’individuazione attraverso un’autoeducazione all’abbandono. Ciò implica un’etica<br />
perfezionistica e l’accettazione di forme di incoerenza esteriore cui però, a ben<br />
guardare, soggiace il coerente tragitto di un carattere, di una personalità. Questi due<br />
saggi – rispetto a cui gli altri in questo senso hanno un ruolo ancillare – esprimono<br />
quella che è forse la più radicale tesi di anticonformismo intellettuale mai espressa<br />
prima di Nietzsche. Ma in E. le durezze dal sapore nettamente nicciano si iscrivono in<br />
un atteggiamento chiaramente democratico, che si distingue dunque da quello del<br />
tedesco sia perché meno risentito e meno ossessionato dai suoi obiettivi polemici, sia<br />
perché non si preoccupa mai troppo di porre gerarchie, e mai distingue tra classi di<br />
uomini irraggiungibilmente superiori e altre di soggetti inguaribilmente degeneri. Tutti<br />
sono diversi perché ognuno partecipa a suo modo del patrimonio comune dell’umanità.<br />
Ma tutti sono potenzialmente uguali perché possono partecipare di questo patrimonio, di<br />
questa common-wealth. Anche noi, come fece Dewey, possiamo così scoprire in E. un<br />
“Nietzsche americano” che è anche uno stimolante educatore in una società<br />
democratica. In Storia E. invoca la necessità di unire insieme la vita individuale e la<br />
storia universale. Invita a leggere la storia identificandosi con gli uomini del passato e<br />
ripercorrendo empaticamente, con l’immaginazione, la loro vita, fino a superare tempo e<br />
spazio. La storia è innanzitutto il prodotto di singole vite umane e di ciò che vi è di<br />
universale in esse. Per ciò stesso essa dev’essere per noi un mezzo di scoperta di questo<br />
universale che ci accomuna, e dunque mezzo di scoperta non solo di ciò che è stato, ma<br />
anche di ciò che tutti siamo e potremo essere. Ne risulta un amor fati che fu espresso da<br />
una frase che sarà anche una celebre citazione-omaggio di Nietzsche a E. (frontespizio<br />
alla Gaia Scienza): “Per il poeta, per il filosofo, per il santo, tutte le cose sono amiche e<br />
sacre, tutti gli eventi vantaggiosi, tutti i giorni santi, tutti gli uomini divini”.<br />
Intelletto fa luce su due aspetti pre-heideggeriani della filosofia emersoniana: una<br />
teoria emozionale della conoscenza e una concezione del pensare come “pia ricezione”<br />
(già accennata in La fiducia in se stessi e ne L’oltreanima). Compensazione e Leggi<br />
spirituali illustrano buona parte della concezione dell’etica e della giustizia di E.,<br />
fondata su un supposto onnipresente e inviolabile ordine della natura. In esse è evidente<br />
anche una teoria antropologica compensatoria: l’uomo è un essere che “acquista nuove<br />
arti e perde vecchi istinti”.<br />
Quaderno Filosofi & Classici<br />
SWIF - Sito Web <strong>Italiano</strong> per la Filosofia - www.swif.it<br />
5
Saggi, II serie (1844)<br />
B. Soressi – Ralph Waldo Emerson<br />
Il poeta presenta una profetologia d’impronta democratica che sembra contenere<br />
già tutta la poetica di Whitman (che aveva assistito alla conferenza omonima), e<br />
suggerisce una teoria della trasformazione sociale attraverso la poesia. In una rilettura<br />
del mito platonico della caverna, il Poeta atteso da E. è visto come un “dio liberatore” e<br />
come colui che può realizzare l’ideale di rivoluzione insieme filosofica, scientifica e<br />
poetica che è promosso in Circoli.<br />
Il senso della possibilità di una rivoluzione scientifico-culturale si rende ancor più<br />
forte in chi legge Esperienza, considerato l’apice dello scetticismo emersoniano. Qui è<br />
espressa una teoria epistemologica che livella le aspirazioni delle epistemologie<br />
precedenti e si contrappone alle precedenti concezioni dell’empirismo, che tendono ad<br />
appiattirsi su una forma di esperienza per vari aspetti povera come quella meramente<br />
sensoriale (v. Natura, 1836). L’immagine dell’esperienza umana si complica al punto<br />
che si assiste a una proliferazione dei criteri della conoscenza, i quali non si limitano più<br />
alle categorie di Aristotele o Kant. Analogamente a come avverrà in Heidegger,<br />
entrano in gioco gli umori e altri aspetti della realtà, come la “sorpresa”. Questi<br />
costituiscono criteri di conoscenza del mondo, un modo attraverso cui un mondo può<br />
rivelarsi a noi.<br />
Uomini rappresentativi (1850)<br />
Questa raccolta di saggi mostra inizialmente che senso può avere per noi<br />
conoscere le opere e la vita dei “grandi uomini”: essi valgono per noi non tanto come<br />
esemplari da imitare pedissequamente, quanto come figure stimolanti perché<br />
rappresentative delle potenzialità insite in ciascun essere umano: Platone potrà parlare<br />
al Platone che è in noi, analogamente Shakespeare, e così via. Occorre sapersi mettere<br />
in dialogo con queste voci, ma occorre farne buon uso, evitando di lasciarsi sopraffare<br />
dalla loro autorevole influenza.<br />
La condotta della vita (1860)<br />
Dopo i Saggi, I e II serie, è la raccolta che affronta più direttamente temi<br />
antropologico-filosofici, e, secondo alcuni studi, una di quelle che maggiormente<br />
ispirarono Nietzsche. In essa si presenta una più accentuata istanza pragmatica ed etica,<br />
Quaderno Filosofi & Classici<br />
SWIF - Sito Web <strong>Italiano</strong> per la Filosofia - www.swif.it<br />
6
B. Soressi – Ralph Waldo Emerson<br />
un approccio più realistico che implica anche un più aperto confronto con la civiltà del<br />
proprio tempo. Emerson è qui sempre più orientato alla fondazione di una “filosofia<br />
della condotta di vita” incentrata su una cultura dell’anticonformismo ed elevatissimi<br />
ideali etici (ad esempio il saggio Adorazione, dove si insiste sulla priorità assoluta della<br />
qualità etico-morale dell’esistenza, sembra a tratti una riscrittura in chiave moderna del<br />
Gorgia platonico). In Fato cerca di rilevare i punti di convergenza tra libertà umana e<br />
determinismo e affronta in modo più o meno diretto il problema della schiavitù come<br />
fatto storico. In Potenza sottolinea l’importanza dell’energia vitale e del sentimento di<br />
potenza come criterio di validità, e in Ricchezza estende questi temi a quello della<br />
potenza economica.<br />
Società e solitudine (1870) e Storia naturale dell’intelletto<br />
Il primo volume contiene il saggio omonimo, uno dei migliori saggi dell’ultimo<br />
E., che ritrae un individuo diviso tra una società rincuorante ma “fatale” e una solitudine<br />
liberatrice, ma impraticabile. In Vita domestica abbozza una filosofia della casa e un<br />
pensiero dell’ospitalità. Nel 1870 E. tenne delle lezioni a Harvard (dove tra i corsi<br />
figuravano allora anche quelli di C.S. Peirce, che notò il suo debito nei confronti del<br />
Trascendentalismo – ancorché suo aspro critico), noti col nome di Storia naturale<br />
dell’intelletto, che nelle intenzioni originarie dell’autore intendeva proporre lo studio<br />
“trascendentalista” della mente su basi rigorose dal punto di vista filosofico e scientifico<br />
(uno studio rintracciabile già in Kant e in idealisti tedeschi quali Schelling e Hegel,<br />
approfondito in quel periodo soprattutto attraverso il filtro dell’opera di J.B. Stallo). E.,<br />
con questo progetto, di cui non fu mai del tutto soddisfatto, intendeva rendersi più<br />
“rispettabile” da parte del mondo accademico, restando accessibile anche ai “non addetti<br />
ai lavori”. Ne risulta un raffinato esercizio poetico-psicologico di analisi di diverse<br />
possibili metafore della mente, che vanno dall’idea della pianta, a quella dell’elettricità,<br />
all’immagine psicanalitica del mare, a immagini che anticipano limpidamente lo stream<br />
of consciousness di William James (che fu assai più debitore di E. di quanto non<br />
riconobbe).<br />
Quaderno Filosofi & Classici<br />
SWIF - Sito Web <strong>Italiano</strong> per la Filosofia - www.swif.it<br />
7
Gli ultimi saggi pubblicati<br />
B. Soressi – Ralph Waldo Emerson<br />
Nel 1875 è la volta di Letters and Social Aims, che raccoglie saggi scritti in tempi<br />
diversi, come Poesia e immaginazione (dove intende seguire la concezione provenzale<br />
della poesia come the gai science), Citazione e originalità (dove emerge chiaramente<br />
sia l’idea della genesi sociale della cultura sia la strenua ricerca di liberarsi dalla pura<br />
ripetizione del discorso altrui, ciò che Heidegger chiamerà “chiacchiera”). In<br />
Immortalità E. indaga le possibilità di concepire nuove forme di immortalità<br />
“intramondana”. Nel 1878 esce Miscellanies, una raccolta comprendente numerosi<br />
saggi, tra cui una parte dello sterminato numero di discorsi storici, civili, letterari di<br />
Emerson.<br />
Quaderno Filosofi & Classici<br />
SWIF - Sito Web <strong>Italiano</strong> per la Filosofia - www.swif.it<br />
8
Bibliografia essenziale su Emerson<br />
B. Soressi – Ralph Waldo Emerson<br />
Cavell, S., Emerson Transcendental Etudes, Stanford UP, Stanford 2003. La raccolta di<br />
tutti i saggi su Emerson come filosofo, scritti dal suo più profondo studioso.<br />
Kateb, G., Emerson and Self-Reliance, Sage Press, Thousand Oaks 1995.<br />
L’individualismo democratico di Emerson.<br />
Richardson, R., Emerson: The Mind on Fire, U of California Press, Berkeley 1995. La<br />
biografia più aggiornata e attenta alla genesi testuale del pensiero emersoniano.<br />
Stack, G.J., Nietzsche and Emerson: An Elective Affinity, Ohio UP, Athens 1992.<br />
Soressi, B., Ralph Waldo Emerson. Il pensiero e la solitudine, Armando, Roma 2004.<br />
Urbinati, N., Individualismo democratico. Emerson, Dewey e la cultura politica<br />
americana, Donzelli, Roma 1997.<br />
Whicher, S., Freedom and Fate. An Inner Life of Ralph Waldo Emerson, U of<br />
Pennsylvania P, Philadelphia 1950. Un classico sulla vita e l’opera di Emerson.<br />
Worley, S., Emerson, Thoreau, and the Role of the Cultural Critic, SUNY Press, Albany<br />
2001.<br />
Libro recensito in SWIF.<br />
Quaderno Filosofi & Classici<br />
SWIF - Sito Web <strong>Italiano</strong> per la Filosofia - www.swif.it<br />
9