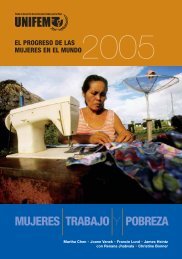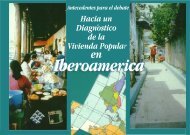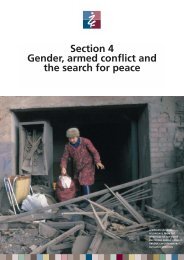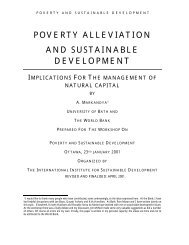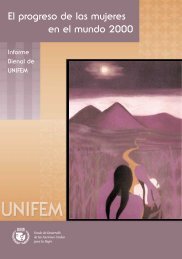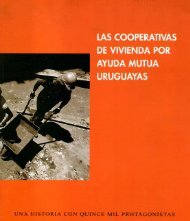Lotta all'esclusione sociale: - HDRNet
Lotta all'esclusione sociale: - HDRNet
Lotta all'esclusione sociale: - HDRNet
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Lotta</strong> all’esclusione <strong>sociale</strong>:<br />
tra sviluppo economico e benessere <strong>sociale</strong><br />
Ota de Laonardis<br />
Università degli Studi Milano-Bicocca<br />
Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale<br />
2000<br />
1
1. INTRODUZIONE<br />
L’esclusione <strong>sociale</strong> è determinata da processi in cui interagiscono e si cumulano problemi<br />
socio-economici, culturali e istituzionali. Proprio per tale carattere complesso e cumulativo<br />
questo problema, che si è diffuso in forme e contesti differenti raggiungendo per estensione e<br />
profondità livelli preoccupanti e inaccettabili, costituisce un termine di riferimento essenziale<br />
per definire gli obiettivi e i criteri di successo dei programmi di Sviluppo Umano che mirano a<br />
coniugare insieme, nei contesti locali concreti in cui essi operano, interventi rivolti allo<br />
sviluppo economico e interventi rivolti ad allargare le possibilità di fruire dei benefici che esso<br />
comporta in termini di benessere (wellbeing).<br />
Soprattutto, l’analisi ravvicinata delle condizioni di esclusione <strong>sociale</strong> di gruppi specifici o<br />
comunità locali ( o di intere popolazioni) mostra la rilevanza che assumono nel produrre queste<br />
condizioni o nel perpetuarle i contesti concreti di vita e la struttura <strong>sociale</strong> di relazioni, poteri e<br />
attori che caratterizzano questi contesti sotto il profilo economico, culturale e istituzionale. E<br />
viceversa l’analisi di programmi rivolti a contrastare l’esclusione <strong>sociale</strong> e delle esperienze<br />
operative in cui si concretizzano mostra come una fondamentale condizione di successo<br />
consista nella capacità di penetrare dentro questi contesti, modificandone appunto la struttura.<br />
Si tratta dunque di interventi che si risolvono in un effettivo aiuto per singoli e gruppi sociali<br />
esclusi in modo soprattutto indiretto, in quanto agiscono prioritariamente su quei contesti di<br />
vita per modificarvi i fattori che generano o mantengono processi di esclusione <strong>sociale</strong>; ma<br />
altrettanto si tratta di interventi che puntano ad attivare e coinvolgere gli esclusi stessi, singoli e<br />
gruppi, come attori centrali, come i veri protagonisti delle strategie e delle pratiche di<br />
cambiamento. La ricostituzione dei diritti e delle capacità di agire sulle condizioni sociali della<br />
propria vita da parte di singoli e gruppo deprivati costituisce infatti il termine di riferimento<br />
essenziale di una effettiva inversione del processo di esclusione <strong>sociale</strong>, a livello sia individuale<br />
che <strong>sociale</strong>.<br />
Infine, i programmi di intervento contro l’esclusione <strong>sociale</strong> con questo duplice obiettivo,<br />
relativo insieme ai soggetti e ai loro contesti di vita, richiedono una particolare attenzione alle<br />
forme organizzative, alle pratiche concrete, alle metodologie di azione in cui si articolano, e alle<br />
conoscenze e competenze necessarie.<br />
2
2. IL QUADRO DEL PROBLEMA E DEGLI INTERVENTI<br />
2.1. Caratteristiche del problema<br />
L’esclusione <strong>sociale</strong> costituisce un problema complesso di deprivazione di risorse e di capacità<br />
di azione e partecipazione alla vita <strong>sociale</strong>. Essa presenta aspetti diversi e compresenti, essendo<br />
prodotta da un insieme di fattori che si cumulano e si rafforzano a vicenda.<br />
a) Fattori economici. L’esclusione, o l’espulsione, dalla vita economica costituisce un<br />
aspetto cruciale del problema. Essa si alimenta su condizioni diffuse di disoccupazione o<br />
di occupazione precaria e marginale; su lavori marginali, mal remunerati e non garantiti; e<br />
sulla conseguente assenza o carenza di fonti di reddito, di risorse materiali di sussistenza. e<br />
di accesso agli scambi economici e sociali. Guardando a questi fattori le matrici<br />
dell’esclusione <strong>sociale</strong> vanno dunque rintracciate nelle dinamiche che sovrintendono<br />
all’economia capitalistica globalizzata e nei costi sociali che esse producono nel mercato del<br />
lavoro e nelle metamorfosi della condizione lavorativa, CON la delocalizzazione dei sistemi<br />
produttivi, nelle polarizzazioni e concentrazioni di potere economico, CON la<br />
deregolazione;<br />
b) Fattori culturali. L’esclusione <strong>sociale</strong> è anche un problema di deprivazione di risorse<br />
culturali e cognitive. Essa si esprime sia nelle disuguaglianze o barriere di accesso<br />
rispetto a queste risorse, e rispetto ai sistemi educativi e ai circuiti di comunicazione e<br />
d’informazione, sia nella discriminazione o emarginazione di gruppi e popolazioni che<br />
portano valori e culture diversi, accompagnate da forme più o meno esplicite di razzismo.<br />
Questi aspetti dell’esclusione <strong>sociale</strong> vanno perciò riferiti all’importanza che assume oggi il<br />
capitale culturale e simbolico, alle disuguaglianze anche radicali che vi si producono, e alle<br />
forme di monopolio dei saperi, delle tecnologie, e dei “sistemi esperti” che in parallelo<br />
tendono a consolidarsi;<br />
c) Fattori politici e istituzionali. L’esclusione avviene comunque anche sul terreno delle<br />
condizioni di partecipazione alla vita civile. Essa si esprime nel mancato accesso formale o<br />
di fatto al sistema dei diritti civili e politici, nonché alle garanzie e ai diritti sociali (salute,<br />
educazione e sicurezza <strong>sociale</strong> anzitutto) che costituisce oggi la dotazione di base del<br />
cittadino; la segregazione in istituzioni totali o il confinamento in luoghi marginali, terre di<br />
nessuno fuori dalla “società civile”, ne costituiscono due espressioni complementari diffuse<br />
ovunque. Là dove il welfare state si era sviluppato in forme più o meno compiute, incidono<br />
3
molto nel determinare queste condizioni i più o meno drastici ridimensionamenti di<br />
quest’ultimo e dei suoi dispositivi di redistribuzione e giustizia <strong>sociale</strong>. Ma incidono<br />
altrettanto nel determinare forme di esclusione da diritti fondamentali situazioni di conflitto<br />
che sospendono o ridefiniscono drammaticamente confini, sovranità e garanzie giuridiche<br />
di base –dove c’è guerra, dove s’instaurano regimi dittatoriali, dove ci sono pulizie etniche o<br />
migrazioni forzate e deportazioni di popolazioni.<br />
L’esclusione <strong>sociale</strong> è dunque un fenomeno complesso: questi fattori e questi aspetti del<br />
problema si presentano per lo più insieme nelle situazioni concrete, combinando in modi<br />
diversi marginalità economica, discriminazione culturale ed esclusione civile, ma addensandosi<br />
comunque attorno a gruppi sociali svantaggiati. Occorre in proposito prendere in considerazione<br />
anche ulteriori aggravanti: le disabilità fisiche e psichiche, l’appartenenza a un genere (le<br />
donne) o a un’età della vita (gli anziani, i bambini), oppure a un’etnia o cultura (le minoranze,<br />
gli immigrati) discriminati, il fatto di vivere in comunità locali tagliate fuori dalla distruzione<br />
creatrice della dinamica economica. Sono questi i tipi di popolazione e di condizione <strong>sociale</strong> che<br />
troviamo dappertutto al centro di situazioni di esclusione <strong>sociale</strong>.<br />
2.2. Panorama degli interventi contro l’esclusione <strong>sociale</strong><br />
Per questa compresenza di più aspetti, e per questa convergenza di più fattori l’esclusione<br />
<strong>sociale</strong> costituisce un parametro di riferimento centrale di programmi e iniziative che in vario<br />
modo esemplificano la prospettiva dello Sviluppo Umano. In quanto questa prospettiva si<br />
caratterizza per l’impegno di creare insieme condizioni di sviluppo economico a livello locale,<br />
condizioni sociali e istituzionali perché esso si traduca in benessere <strong>sociale</strong> delle popolazioni, e<br />
condizioni civili e politiche di integrazione attiva e partecipe nella vita <strong>sociale</strong>, le strategie di<br />
intervento che ad essa si richiamano hanno un terreno cruciale di azione nella capacità di<br />
contrastare e invertire processi che generano e estendono l’ esclusione <strong>sociale</strong>.<br />
I programmi e le iniziative operative che mirano a contrastare l’esclusione <strong>sociale</strong>, con quelle<br />
caratteristiche di complessità più sopra delineate, hanno fisionomie diverse, anche in ragione dei<br />
contesti sociali molto eterogenei in cui operano. I principali elementi su cui programmi e<br />
iniziative si diversificano sono: i campi di azione privilegiati, le condizioni di svantaggio che ne<br />
costituiscono il target principale, i tipi di organizzazione in cui si articolano.<br />
4
I campi di azione più significativi di programmi e iniziative di lotta all’esclusione sono:<br />
- lo sviluppo economico socialmente sostenibile di contesti locali ai margini o esclusi<br />
dalle dinamiche di sviluppo dell’economia capitalistica globalizzata (per esempio<br />
attraverso il sostegno al credito, la promozione di imprese, le politiche attive del lavoro);<br />
- le politiche sociali, nelle loro diverse articolazioni (l’ambito sanitario, educativo e<br />
formativo, di sostegno al reddito, eccetera) in quanto siano rivolte a obiettivi di<br />
promozione <strong>sociale</strong> dei gruppi socialmente svantaggiati;<br />
- i programmi di rigenerazione urbana che intervengono su zone socialmente ed<br />
economicamente deprivate nelle quali si addensano condizioni di esclusione <strong>sociale</strong>.<br />
Ognuno di questi campi di azione non di rado richiede alle iniziative di lotta all’esclusione di<br />
attivare risorse e azioni appartenenti ad altri campi di azione; a volte si intraprende la<br />
costruzione di un campo di azione ai confini tra due diverse aree d’intervento, come per<br />
esempio attraverso la combinazione di misure economiche e di misure di politica <strong>sociale</strong>.<br />
Queste combinazioni, non sempre facili, rivestono un’importanza strategica per contrastare<br />
l’esclusione <strong>sociale</strong>, ma possono a loro volta assumere fisionomie diverse e dar luogo ad esiti<br />
diversi.<br />
Le condizioni di svantaggio <strong>sociale</strong> che ne costituiscono il target principale sono:<br />
- situazioni diffuse di esclusione o marginalità rispetto al mercato del lavoro, nelle<br />
diverse forme di disoccupazione, nelle condizioni lavorative precarie, senza garanzie e<br />
scarsamente remunerate;<br />
- situazioni di disabilità fisiche o mentali che si accompagnano a, e attraggono altri<br />
motivi di svantaggio <strong>sociale</strong>, anzitutto barriere nell’accesso al lavoro;<br />
- aree urbane degradate in cui si concentrano gravi problemi abitativi, assenza di servizi<br />
essenziali, povertà di risorse e di scambi economici;<br />
- condizioni di abbandono legate alla perdita di una rete <strong>sociale</strong> di appartenenza e<br />
processi di disaffiliazione (come nel caso della vita di strada dei bambini);<br />
- condizioni di segregazione in istituzioni totali -come prigioni, manicomi, campi di<br />
concentramento, campi di raccolta- che separano e escludono dalla “società civile”.<br />
Le condizioni di svantaggio su cui intervengono prioritariamente le iniziative possono essere<br />
molto focalizzate e circoscritte; o viceversa si danno iniziative che intervengono<br />
congiuntamente su diverse condizioni di svantaggio. Tra queste due alternative si giocano esiti<br />
molto diversi.<br />
5
Per esempio la focalizzazione su un gruppo specifico e su uno specifico problema di svantaggio<br />
<strong>sociale</strong> può tradursi nell’isolamento delle iniziative in questione, o la chiusura in un setting<br />
specialistico, come tale separato dal contesto <strong>sociale</strong>, o viceversa può fornire, grazie appunto<br />
all’attenzione concentrata su singoli casi e persone concrete, l’energia e il bandolo per<br />
ripercorrere con loro all’inverso il percorso dell’esclusione <strong>sociale</strong> e per agire così sulle<br />
condizioni sociali che hanno costruito questo percorso, dunque su altre condizioni di svantaggio.<br />
I tipi più diffusi di organizzazione cui fanno capo le iniziative sono:<br />
- organismi internazionali con programmi di lotta all’esclusione <strong>sociale</strong>, che possono<br />
avere un carattere pubblico (come l’Onu) o privato (come le fondazioni) e operare<br />
attraverso reti di agenzie locali di diverso tipo e dimensione;<br />
- organizzazioni private non profit (come ONG, cooperative sociali, imprese non prfit,<br />
associazioni) impegnate su uno o più dei diversi fronti dell’esclusione <strong>sociale</strong>;<br />
- amministrazioni pubbliche locali che si dotano di politiche e di sistemi di servizi per la<br />
lotta all’esclusione <strong>sociale</strong> (municipalità, autorità regionali, autorità sanitarie, eccetera);<br />
- mobilitazioni e aggregazioni di cittadini su questioni civili e politiche attorno a cui<br />
vengono costruiti obiettivi e progetti comuni, come ad esempio nel caso di comitati di<br />
quartiere impegnati in programmi partecipati di rigenerazione urbana, o in forme<br />
autogestite di servizi, o nelle diverse forme organizzative della difesa di diritti, compresi<br />
i sindacati e gli advocacy groups.<br />
I programmi operativi sono di solito costituiti da una combinazione di diversi tipi di<br />
organizzazioni: essa può variare molto in rapporto al peso relativo che ciascun tipo ha, al<br />
tipo di organizzazione leader, alle DELle partnership e DELle reti interorganizzative.<br />
2. CRITERI DI ANALISI E D’INTERVENTO<br />
3.<br />
Il problema dell’esclusione <strong>sociale</strong> è un problema complesso in quanto, come abbiamo visto, vi<br />
si addensa una pluralità di fattori, di aspetti e di forme diverse, da riconoscere inoltre nella<br />
specificità delle loro manifestazioni in contesti locali diversi e tra loro non comparabili. Ma si<br />
tratta di un problema complesso anche per ragioni più specifiche. Se si pone l’esclusione <strong>sociale</strong><br />
al centro dell’attenzione, sia per la riflessione scientifica che per la costruzione e la messa in<br />
opera di interventi, diviene necessario affrontare insieme questioni tra loro distanti, mettere in<br />
connessione delle polarità. Si tratta di connettere, a livello sia concettuale che pratico: a) il<br />
6
polo dell’esperienza individuale e soggettiva degli esclusi, la specificità dei singoli casi, con il<br />
polo delle condizioni sociali, collettive e in certo modo strutturali, dell’esclusione <strong>sociale</strong>; b) il<br />
polo dei bisogni di aiuto e assistenza, e di dispositivi di giustizia <strong>sociale</strong>, con il polo del bisogno<br />
di investimenti, finanziari e di energie progettuali, sul terreno economico dello sviluppo, per<br />
incidere sulle condizioni che alimentano quei bisogni; c) il polo delle specificità locali da<br />
riconoscere e valorizzare e il polo dei networks globali con cui quelle specificità sono in<br />
rapporto, di solito, di dipendenza; d) il polo dell’esclusione radicale, quella che si misura sulle<br />
possibilità di sopravvivenza, e il polo dell’esclusione “soft” che si misura su condizioni di<br />
passività e di sudditanza, sull’esclusione dalla cittadinanza attiva.<br />
Sul piano sia concettuale che pratico, la capacità di mettere in connessione, di trattare<br />
congiuntamente queste polarità, costituisce un parametro di riferimento cruciale per la qualità e<br />
l’efficacia di strategie di azione contro l’esclusione <strong>sociale</strong>.<br />
3.1. Tra soggetti e contesti. L’esclusione <strong>sociale</strong> è anzitutto un’ esperienza di deprivazione che<br />
perciò deve essere colta dalla prospettiva dei soggetti che la vivono, che vivono la compresenza<br />
di molteplici motivi di sofferenza e la difficoltà o l’impossibilità di affrontarli tutti insieme, nei<br />
loro effetti cumulativi. Ma d’altra parte questa complessità rimanda immediatamente alle<br />
condizioni sociali in cui i soggetti in questione vivono e all’ organizzazione <strong>sociale</strong> che produce<br />
e perpetua quelle condizioni. L’esclusione <strong>sociale</strong> riguarda cioè vite e persone concrete, ma al<br />
tempo stesso vi illumina le condizioni sociali in cui esse sono immerse: riguarda individui e<br />
gruppi esclusi ma altrettanto la società in cui vivono, o in cui fanno fatica a sopravvivere (v.<br />
Castel, 1995; Mingione, 1991; Sassen, 1999). Se l’attenzione sia analitica che operativa si<br />
concentra soltanto sul primo polo si rischia di isolare le specificità idiosincratiche dei singoli o<br />
gruppi target, creando ad esempio settings specialistici che li astraggono e li separano dai<br />
contesti sociali di appartenenza; se viceversa si risale troppo rapidamente alle cause sociali dei<br />
problemi, si corre il rischio di non mettere a frutto l’apprendimento e il patrimonio di<br />
conoscenze che provengono dall’esperienza dell’esclusione (anzitutto appunto quella dei diretti<br />
interessati) e dal confronto con gli ostacoli e le risorse che si incontrano sul campo ogni giorno.<br />
Nel configurare programmi e interventi che si misurano con l’esclusione <strong>sociale</strong> bisogna perciò<br />
partire dai concreti casi individuali, ma al tempo stesso assumerli come guida per ripercorrere<br />
e trasformare i meccanismi sociali che, nei contesti locali, riproducono la loro condizione di<br />
esclusione: un cambiamento di quest’ultima, dunque della loro esperienza di vita, è altrettanto<br />
un cambiamento di quei meccanismi, un cambiamento <strong>sociale</strong>. Il passaggio può essere chiarito<br />
7
con un esempio. Il target principale può essere costituito dal problema delle basse speranze di<br />
vita alla nascita legate a nascite precoci e sottopeso in condizioni di grave deprivazione<br />
economica: la prima e fondamentale prospettiva di azione è certo quella del sostegno alla<br />
nascita, al neonato e alla madre, nelle varie forme già sperimentate: ma l’obiettivo che ne<br />
emerge come decisivo consiste nel ridurre, a monte, le condizioni di denutrizione e di grave<br />
deprivazione in cui vivono le gestanti, e che sono l’ovvia origine del problema. Si tratta di fare<br />
in modo che le madri siano adeguatamente nutrite e stiano in buona salute, serene e contente.<br />
Altrettanto si può dire di strategie d’intervento che operano a partire da problemi di salute, o<br />
condizioni abitative, o dall’obiettivo dell’integrazione lavorativa di persone disabili. Il target di<br />
partenza costituisce il bandolo di un percorso aperto che conduce gli interventi sulle condizioni<br />
sociali a monte, oltre i confini del campo di azione specifico, e su dispositivi di organizzazione<br />
<strong>sociale</strong> che stanno non ai margini ma nel cuore stesso della struttura <strong>sociale</strong>.<br />
Autorevoli ricerche ed elaborazioni (Castel, 1995) hanno dimostrato come l’esclusione <strong>sociale</strong><br />
costituisca più che una condizione (statica) di singoli e gruppi particolari in una società, un<br />
percorso (dinamico) di progressiva deprivazione, una spirale, in cui s’intrecciano e si cumulano<br />
rafforzandosi a vicenda processi sociali diversi e attinenti a diverse sfere della vita <strong>sociale</strong>. I<br />
processi che conducono a condizioni di esclusione <strong>sociale</strong> attraversano l’intero tessuto della<br />
società alimentandosi sui suoi assetti “normali” e gettando la loro ombra sulla quasi totalità<br />
della popolazione: quando si dà esclusione <strong>sociale</strong> c’è anche, a monte, un problema di<br />
vulnerabilità <strong>sociale</strong> più o meno diffuso, disuguaglianze e discriminazioni, ingiustizia <strong>sociale</strong>, e<br />
reciprocamente privilegi, monopoli di ricchezza e di potere, in forme più o meno polarizzate. I<br />
programmi e gli interventi di lotta contro l’esclusione <strong>sociale</strong> devono perciò misurarsi con<br />
questo carattere dinamico, processuale del problema, configurandosi essi stessi come processi,<br />
come progetti in continua evoluzione, come cantieri aperti, che si misurano non semplicemente<br />
con l’obiettivo della reintegrazione <strong>sociale</strong> dei soggetti esclusi ma con la capacità di contrastare<br />
e invertire i processi sociali che espellono, escludono e confinano nella marginalità. Un esempio<br />
emblematico è costituito dalla storia del processo di deistituzionalizzazione<br />
(deinstitutionalization) dei manicomi in alcuni paesi e in alcuni contesti locali, che poi ha<br />
disseminato chiavi interpretative e metodologie di azione in altri ambiti contigui d’intervento (v.<br />
Basaglia, 1984; Rotelli, 1999; De Leonardis, Mauri, Rotelli, 1986; 1994; De Leonardis, 1993).<br />
L’obiettivo di riportare gli internati dei manicomi alla condizione di cittadini ha costituito il<br />
bandolo di un percorso, compiuto con loro, di trasformazione di alcune condizioni sociali<br />
all’origine di quella loro esperienza di esclusione: agendo su dispositivi istituzionali (con<br />
mutamenti normativi più o meno profondi, fino a riforme che aboliscono l’internamento<br />
8
psichiatrico); innescando cambiamenti nelle organizzazioni, culture e pratiche della salute<br />
primaria, pubblica; attivando nicchie di intrapresa economica che allargassero, anzitutto per gli<br />
interessati, le possibilità di lavoro, di reddito e di scambio economico e <strong>sociale</strong>, e con ciò<br />
mettendo in movimento, indirettamente, dinamiche di sviluppo economico locale.<br />
In generale, questa prospettiva processuale si traduce in concreto nella tendenza a superare<br />
politiche settoriali e focalizzate su target definiti e circoscritti e nella costruzione di politiche<br />
integrate che in vario modo e grado connettono compiti di redistribuzione <strong>sociale</strong>, di<br />
valorizzazione delle risorse economiche, e di allargamento della partecipazione alla vita civile;<br />
ma la polarità qui tematizzata segnala la forza che proviene, per finalizzare questa<br />
intersettorialità alla lotta all’esclusione <strong>sociale</strong>, dall’esperienza diretta del problema, fatta<br />
lavorando con gli esclusi in carne ed ossa e con la loro esperienza primaria dell’esclusione.<br />
3..2. Tra locale e globale. L’esclusione <strong>sociale</strong> si addensa su gruppi, aree e condizioni<br />
specifiche, e perciò richiede di concentrare l’attenzione sia analitica che operativa sulla<br />
dimensione locale. Il radicamento nei contesti locali costituisce un prerequisito essenziale per<br />
alimentare processi più generali di cambiamento delle forme di sviluppo economico, del ruolo<br />
delle istituzioni pubbliche e delle condizioni di partecipazione democratica. Ma è d’altro canto<br />
evidente che queste condizioni locali di esclusione <strong>sociale</strong> si collocano dentro dinamiche macro<br />
di carattere globale (Sassen, 1991; World Bank, 1997) : non possono essere affrontate<br />
indipendentemente dai processi di globalizzazione (comunque definita) che espellono dalla vita<br />
economica aree e gruppi sociali. Riflessioni e programmi devono comunque affrontare la<br />
questione sul piano insieme locale e globale. Questa connessione costituisce un obiettivo<br />
riconosciuto, e difficile da perseguire, in diversi settori sia di ricerca che politici (si pensi<br />
soltanto al dibattito sul declino o le possibili trasformazioni dello stato nazione). Guardando al<br />
problema dalla prospettiva dell’esclusione <strong>sociale</strong> emergono i seguenti ponti da costruire e<br />
potenziare tra locale e globale: a) valorizzare connessioni che seguano la via dei flussi di<br />
comunicazione: per esempio con la messa in rete di buone pratiche contro l’esclusione <strong>sociale</strong>;<br />
b) valorizzare in positivo la mobilità territoriale indotta dalla globalizzazione (nei flussi<br />
migratori, ma anche nelle forme estreme delle deportazioni di massa) per costruire condizioni di<br />
confronto e incontro culturale e legami basati su esperienze in comune; c) valorizzare anche le<br />
connessioni in verticale delle reti con strategie di azione bottom up che risalgano a poteri e<br />
autorità nazionali per influenzarne le politiche, e portino la complessità del problema<br />
dell’esclusione <strong>sociale</strong> nelle agende degli organismi internazionali di mediazione tra locale e<br />
globale (Technical Liaison Officer, 1999).<br />
9
3.3.Tra assistenza e lavoro. Innescare processi di sviluppo economico locale costituisce una<br />
condizione cruciale per contrastare e invertire percorsi di esclusione <strong>sociale</strong>. Ma per affrontare<br />
la complessità di quest’ultima occorre altrettanto dare a questo sviluppo finalità sociali, piegarlo<br />
verso obiettivi di giustizia <strong>sociale</strong> e ancorarlo a strategie di redistribuzione delle opportunità di<br />
partecipazione alla vita economica e delle possibilità di benessere (wellbeing). Politiche e<br />
interventi di carattere economico vanno dunque intrecciati con politiche e interventi di welfare.<br />
Da un lato è necessario un impegno a costruire imprese e sistemi produttivi che allarghino le<br />
opportunità di lavoro, di reddito e di scambio economico (attraverso forme di incubazione<br />
d’impresa, investimenti su piccole imprese, facilitazioni di credito, ecc.). Ma un impegno che<br />
sia esclusivamente concentrato su questo terreno rischia di riprodurre meccanismi di selezione<br />
ed espulsione dai benefici della crescita economica delle fasce più deboli della popolazione,<br />
soprattutto in conseguenza dei vincoli che le forme oggi prevalenti dell’economia impongono<br />
anche a livello locale, con gli imperativi della flessibilità e della precarietà lavorativa e in<br />
genere con la divaricazione tendenziale della forbice tra crescita economica e occupazione. E’<br />
perciò necessario un impegno complementare sul fronte delle politiche sociali, della costruzione<br />
di sistemi di aiuto e assistenza a singoli e gruppi che restano ai margini della vita economica.<br />
Ma anche questo impegno, da solo, rischia a sua volta di perpetuare questa marginalità, di<br />
condannare coloro che si vorrebbero aiutare alla condizione di destinatari passivi, bisognosi e<br />
sempre dipendenti da interventi assistenziali, e di restringere questi ultimi alla sola<br />
distribuzione di risorse prodotte altrove e comunque sempre troppo scarse per incidere davvero<br />
su povertà ed esclusione <strong>sociale</strong>.<br />
Per connettere insieme il terreno economico e il terreno assistenziale è necessario costruire<br />
strategie di investimento sia economico che <strong>sociale</strong>, che accrescano il capitale <strong>sociale</strong>: a) dare<br />
spazio a diverse forme di iniziativa economica, investendo sui patrimoni di conoscenza e di<br />
pratica locali, e valorizzando anche forme di economia diverse da quella monetaria e di<br />
mercato; b) attivare, connettere e mettere in circolazione le risorse nascoste e non convenzionali<br />
dei contesti locali, anzitutto quelle che restano disperse e inutilizzate negli ambienti marginali, e<br />
ancora più precisamente quelle di cui sono portatori gli stessi esclusi; c) intensificare la<br />
socialità, attivando nel tessuto <strong>sociale</strong> spazi e reti di relazioni, incontri e scambi sociali, da cui si<br />
generino progetti comuni, imprese partecipate e scambi economici.<br />
Le esperienze di impresa <strong>sociale</strong>, sviluppatesi in diversi contesti locali per lo più a partire dalla<br />
necessità di aggirare i crescenti vincoli di spesa imposti dal ridimensionamento del welfare,<br />
costituiscono un esempio emblematico di metodologie di azione che coniugano insieme<br />
10
obiettivi e interventi di welfare e obiettivi e interventi economici (De Leonardis, Mauri, Rotelli,<br />
1994; De Leonardis, 1994; 1999). Da un lato i servizi sociali vengono trasformati in laboratori<br />
che intraprendono la costruzione di spazi di scambio <strong>sociale</strong> ed economico attivando e<br />
coinvolgendo in essa, come protagonisti, gli stessi soggetti svantaggiati destinatari del welfare e<br />
i loro contesti di vita (siano essi malati mentali, tossicodipendenti, immigrati, disoccupati<br />
cronici, detenuti, eccetera); dall’altro le imprese economiche che così si coinvolgono o si creano<br />
vengono orientate a valorizzare le competenze e le capacità progettuali di questi soggetti<br />
svantaggiati e a promuoverne la partecipazione attiva alle scelte imprenditoriali e agli scambi<br />
economici: insieme ai prodotti che esse immettono sul mercato esse creano anche le “piazze di<br />
mercato” e gli attori economici che vi s’incontrano, scambiano e partecipano al tessuto locale di<br />
vita economica e <strong>sociale</strong>.<br />
3.4. Tra la sopravvivenza e l’azione politica. Bisogna affrontare l’intero arco del problema<br />
dell’esclusione <strong>sociale</strong>, dalle sue manifestazioni più estreme alle sue manifestazioni<br />
apparentemente più “soft”. Da un lato bisogna misurarsi con casi di deprivazione radicale di<br />
risorse e di violazione dei diritti umani più fondamentali. Possiamo richiamare in proposito tre<br />
esempi diversi di questa deprivazione radicale: a) le condizioni di svantaggio di partenza che si<br />
concretizzano in basse speranze di vita alla nascita, come quelle messe in luce e analizzate da<br />
Sen, a proposito delle donne in diversi paesi del Sud del mondo (Sen, 1999); b) le condizioni di<br />
invalidazione radicale e di destrutturazione del sé prodotte dall’internamento in istituzioni totali,<br />
come nel caso dei manicomi (ma anche dei campi di concentramento); c) le condizioni di<br />
perdita di un mondo cui appartenere che conseguono a situazioni di guerra, di fuga e di<br />
deportazione. Di converso bisogna comprendere nel problema anche le forme più diffuse e<br />
striscianti di esclusione civile, di estraneità e passività rispetto alla partecipazione civile e<br />
politica nei contesti locali di appartenenza: là dove non si dà cittadinanza in quanto essa non può<br />
essere davvero praticata (Bauman, 1999; Beck et al., 1997). Nel configurare programmi e<br />
interventi che si misurano con la complessità dell’esclusione <strong>sociale</strong> occorre considerare<br />
insieme questi due poli, come due facce della stessa medaglia. Il polo della deprivazione<br />
radicale costituisce un fondamentale contrappeso al rischio che gli interventi, privilegiando<br />
terreni sui quali sembra possibile effettivamente influire, riproducano meccanismi selettivi che<br />
anzitutto tornano a escludere, ad abbandonare al loro destino, proprio coloro che vivono<br />
condizioni estreme di bisogno, e che perciò confermano la logica stessa dell’esclusione. Il polo<br />
della deprivazione soft di possibilità di partecipazione alla vita civile costituisce a sua volta un<br />
fondamentale contrappeso al rischio di configurare gli interventi come elargizione di aiuti agli<br />
11
esclusi trattati come destinatari passivi e non come attori, e come tali alla fine condannati a<br />
restare ai margini della vita <strong>sociale</strong> e sempre in condizioni più o meno drammatiche di bisogno.<br />
Guardare al parametro della partecipazione civile e politica, della cittadinanza attiva, richiede<br />
viceversa strategie di azione rivolte a valorizzare gli esclusi come protagonisti in prima persona<br />
dei percorsi di uscita dalla loro condizione di esclusione, e ricostituire il loro diritti e le loro<br />
basic capabilities (capacità fondamentali) di scelta e di azione (Sen, 1992). Si tratta perciò di<br />
configurare programmi e pratiche di azione che rispondano insieme al fabbisogno di risorse –<br />
anzitutto materiali- indispensabili per la sussistenza, per la dignità umana, e per la speranza di<br />
vita, e al fabbisogno di risorse –culturali e politiche- indispensabili per la pratica della<br />
cittadinanza.<br />
Programmi e iniziative contro l’esclusione <strong>sociale</strong> che si misurano con l’obiettivo di mettere in<br />
connessione questi due poli, coniugando insieme i diritti umani più elementari con i diritti di<br />
partecipazione piena alla cittadinanza, trovano un parametro cruciale delle loro metodologie di<br />
azione nella prospettiva della ricostituzione delle capacità fondamentali (basic capabilities) di<br />
coloro che una situazione di deprivazione radicale di risorse ha invalidato. Il percorso di<br />
ricostituzione delle capacità di partecipazione alla cittadinanza di internati in istituzioni totali,<br />
già richiamata, ha costruito un patrimonio di conoscenze e competenze per affrontare altri tipi<br />
estremi di esclusione <strong>sociale</strong>. Il riconoscimento e l’attivazione delle capacità degli interessati vi<br />
è avvenuta insieme con la trasformazione e la ricostruzione di contesti sociali che favorissero<br />
l’impiego di queste capacità; e ha così creato attori partecipi della vita di quei contesti e del suo<br />
miglioramento, attori di scelte relative anche alla vita pubblica, di progetti personali e anche<br />
collettivi, di iniziative e organizzazioni che in vario modo contribuiscono al cambiamento<br />
<strong>sociale</strong> (Basaglia, 1984; Rotelli, 1999).<br />
12
4. RACCOMANDAZIONI<br />
4.1. Un requisito preliminare. Se si assume l’azione contro l’esclusione <strong>sociale</strong> (con le<br />
caratteristiche di complessità ricostruite fin qui) come un obiettivo rilevante per i programmi di<br />
Sviluppo Umano, occorre aderire ad una prima raccomandazione generale: nella messa a punto<br />
e nell’implementazione operativa di programmi d’intervento, la massima attenzione deve essere<br />
dedicata alla loro capacità di connettere le polarità di cui, come abbiamo visto, è costituito il<br />
problema dell’esclusione <strong>sociale</strong>.<br />
Questo requisito, molto generale, richiede ai programmi alcune caratteristiche distintive che<br />
dovrebbero essere come tali oggetto delle attività di diffusione delle conoscenze, di<br />
comunicazione, ricerca e formazione. Esse riguardano:<br />
- le forme organizzative che implementano i programmi, e che non sono inerti rispetto al<br />
rapporto tra obiettivi e risultati;<br />
- le metodologie di azione coerenti con il target dell’esclusione <strong>sociale</strong> da contrastare e<br />
superare, e con quella messa in connessione tra polarità che ne costituisce il criterio di<br />
riferimento generale;<br />
- i tipi di competenze di base necessarie nei diversi ambiti di azione implicati.<br />
4. 2. Forme organizzative<br />
4.2.1. E’ importante che i programmi prestino attenzione alle forme organizzative di cui si<br />
dotano, acquisendo le conoscenze ed esperienze necessarie a riconoscere e mettere a frutto il<br />
potenziale generativo della dimensione organizzativa (Tendler, 1997). Tra i programmi e i loro<br />
esiti è incuneata l’organizzazione che fornisce il suo stampo all’azione nel delineare i contorni<br />
di base di questi esiti: modi diversi di organizzare, come è stato emblematicamente dimostrato a<br />
proposito dei programmi di aiuto allo sviluppo locale, portano ad esiti molto diversi e la<br />
capacità di innescare processi autonomi di sviluppo locale equo e sostenibile dipende da forme<br />
organizzative che facilitano l’organizzazione autonoma dei contesti d’intervento e curano la<br />
qualità di questa organizzazione;<br />
4.2.2. E’ importante perciò che i programmi si dotino di organizzazioni, e di capacità<br />
organizzative, con queste caratteristiche:<br />
13
- learning organizations: organizzazioni costituite di processi aperti, simili a laboratori o<br />
cantieri, che costruiscono man mano, e che man mano a loro volta si trasformano per<br />
rispondere meglio ai cambiamenti prodotti nell’ambiente;<br />
- - organizzazioni ponte: collocate ai confini tra diverse appartenenze sociali (ricchezza e<br />
povertà), culturali (estraneità e conflitti culturali) o istituzionali (autorità separate e<br />
incomunicanti) esse operano per costruire punti di passaggio tra queste: gateways nelle<br />
fratture sociali, terreni di cooperazione su progetti, sinergie tra interessi;<br />
- grounded organizations: organizzazioni costituite anzitutto da attori e interazioni della vita<br />
<strong>sociale</strong> locale, e alimentate dalle risorse di esperienza e conoscenza che vi si esprimono;<br />
- organizzazioni per progetti partecipati: organizzazioni finalizzate alla formulazione e poi<br />
al perseguimento di progetti favoriscono la cura che deve essere rivolta alla qualità dei<br />
processi, oltre che ai risultati: il coinvolgimento dei destinatari, anche nelle scelte<br />
strategiche, le partnership tra attori diversi su obiettivi condivisi, la partecipazione, la<br />
discussione, l’apprendimento e la rettifica in corso d’opera.<br />
4.3. Metodologie di azione<br />
4.3.1. Il radicamento nei contesti concreti di azione costituisce un prerequisito essenziale dei<br />
programmi di lotta all’esclusione <strong>sociale</strong>, perché le spinte e le risorse per uscire da questa<br />
condizione vanno ricercate e suscitate dall’interno. Per questo sono importanti metodologie di<br />
azione che:<br />
- evitano di precostituire la situazione, per esempio dando una definizione preliminare del<br />
problema in base a modelli prefissati;<br />
- sono orientate viceversa all’ascolto, per cercare e suscitare dall’ interno del contesto di<br />
azione il suo specifico patrimonio di culture, esperienze e interpretazioni dei problemi e<br />
delle soluzioni;<br />
4.3.2. Il carattere processuale delle azioni e delle organizzazioni - coerente come abbiamo visto<br />
con l’obiettivo di incidere sui processi di esclusione <strong>sociale</strong> - richiede metodologie di azione<br />
capaci di riflessività (reflexivity): con dispositivi di apprendimento (learning) dall’esperienza<br />
e di autovalutazione che evitino la cristallizzazione in routine e alimentino la capacità di<br />
cambiare in corso d’opera e correggere i modi di agire;<br />
14
4.3.3. Un requisito decisivo è costituito dall’orientamento a valorizzare, che deve esprimersi a<br />
tutti i livelli di un programma, ivi compreso il livello della sua messa in opera pratica e<br />
quotidiana. Esso consiste:<br />
- nell’attenzione rivolta a riconoscere e suscitare le risorse dei contesti, soprattutto quelle<br />
nascoste;<br />
- nel misurare l’azione sulla validazione dei contesti e dei soggetti su cui s’interviene,<br />
riconoscendovi capacità da riattivare e far crescere;<br />
- in un orientamento a investire su questo capitale <strong>sociale</strong>, per valorizzarlo appunto, da un lato<br />
attribuendo credito ( anche nel suo significato di fiducia) e dall’altro assumendo rischi.<br />
Questo orientamento richiede know how diversi, per certi aspetti opposti, rispetto a quelli delle<br />
consuete relazioni di aiuto e di assistenza che trattano i destinatari –singoli o comunità- per ciò<br />
di cui mancano non per le risorse che portano, per le carenze da rimediare non per le capacità da<br />
suscitare; e d’altra parte questo orientamento, se opera per valorizzare il capitale <strong>sociale</strong> dei<br />
contesti e dei soggetti, misura queste metodologie imprenditoriali su parametri diversi da quello<br />
dell’impresa economica di mercato;<br />
4.3.4. L’obiettivo di fondo, su cui misurare il successo nella lotta contro l’esclusione <strong>sociale</strong>,<br />
deve consistere nel raggiungere l’autonomia dei gruppi e delle comunità locali in cui si opera, in<br />
modo da rendere i programmi e gli interventi non più necessari. A questo scopo un principio<br />
metodologico essenziale consiste nell’attribuire alle azioni, anche pratiche, il compito di<br />
generare istituzioni, e di curarne la qualità <strong>sociale</strong> (Beck et al., 1997):<br />
- saper riconoscere e utilizzare i poteri, di cui i programmi e le loro articolazioni organizzative<br />
sono dotati, di formare valori e norme sociali nell’interazione quotidiana con i contesti<br />
concreti in cui operano;<br />
- appoggiarsi sulle mobilitazioni sociali, e sui conflitti, per alimentare la costruzione di<br />
istituzioni che siano istanze di partecipazione democratica, di mediazione e di scelta<br />
collettiva su problemi e su fini comuni;<br />
- curare che per questa via le istituzioni assumano per il proprio agire, soprattutto nelle loro<br />
articolazioni operative come i servizi sociali, standard di qualità <strong>sociale</strong>: questi misurano sia<br />
la qualità della vita privata dei cittadini –anzitutto la dotazione di beni e servizi sociali di<br />
base- sia la qualità della cittadinanza e della vita pubblica –anzitutto condizioni di giustizia<br />
<strong>sociale</strong> che redistribuiscano nella totalità della popolazione le possibilità di partecipazione<br />
<strong>sociale</strong> e politica.<br />
15
4.4. Competenze<br />
4.4.1. E’ importante una riconsiderazione generale delle conoscenze e delle competenze che<br />
sono necessarie nella messa a punto e nell’implementazione di programmi di azione contro<br />
l’esclusione <strong>sociale</strong> con le caratteristiche delineate. Più che sul design di nuove figure<br />
professionali, è opportuno operare sulle competenze presenti, nello staff dei programmi ma<br />
anche e soprattutto nei contesti locali, valorizzandole in modo che acquisiscano, nei diversi<br />
campi specifici di azione, alcuni requisiti di base;<br />
4.4.2. In coerenza con le raccomandazioni di cui al punto 3.2. occorre sviluppare competenze in<br />
materia di organizzazione, la formazione e trasmissione di chiavi di lettura e metodologie di<br />
azione che operano sulla dimensione organizzativa. Le competenze prioritarie in proposito<br />
riguardano da un lato il saper riconoscere in quali aspetti l’organizzazione tende a cristallizzarsi,<br />
a chiudersi in un circuito autoreferenziale in cui la propria presenza diventa un obiettivo in se<br />
stesso; e dall’altro il saper praticare metodologie di azione che favoriscono processi di<br />
apprendimento e di cambiamento dell’organizzazione stessa;<br />
4.4.3. E’ importante costruire figure e competenze di connettori: di agenti dei progetti che a<br />
vari livelli sono orientati a costruire i passaggi, a mettere in relazione gli ambiti di intervento, a<br />
far cooperare forze che appartengono a mondi separati e estranei, poiché l’esclusione <strong>sociale</strong> è<br />
per l’appunto frutto di questa separazione ed estraneità;<br />
4.4.4. E’ importante costruire figure e competenze di facilitatori: per facilitare la partecipazione<br />
delle comunità locali in generale e dei soggetti svantaggiati in particolare occorre saper creare<br />
comunicazione, relazioni, circolazione di esperienze e conoscenze. Ma occorre soprattutto<br />
saper creare spazi di cooperazione su progetti nei quali quelle comunità e quei soggetti<br />
acquisiscano man mano il ruolo di attori protagonisti di quei progetti, e se ne approprino;<br />
4.4.5. E’ importante coltivare e accrescere competenze relative al trattamento dei conflitti:<br />
- la capacità di farli venire alla luce, non soffocarli (poiché spesso l’esclusione <strong>sociale</strong> e frutto<br />
di conflitti soffocati);<br />
- la “gestione creativa dei conflitti”, in particolare quella che li orienta verso una<br />
riformulazione più o meno condivisa dei problemi e delle ragioni di conflitto;<br />
16
- la socializzazione del conflitto e degli apprendimenti e cambiamenti che vi si producono<br />
attivando su questo spazi di discussione e di partecipazione democratica;<br />
4.5. Le metodologie formative<br />
4.5.1. La formazione adeguata a programmi di lotta all’esclusione <strong>sociale</strong> va orientata, prima che<br />
alle competenze individuali e alle relative professionalità, a quelle competenze che sono tali se<br />
condivise e praticate da un collettivo di lavoro nel suo insieme (equipe, gruppo di progetto,<br />
iniziativa comunitaria, singola organizzazione e reti di organizzazioni). Si tratta infatti di acquisire<br />
quelle metodologie di azione già indicate: esse sono trasversali alle singole professionalità e alle<br />
discipline; esse devono essere acquisite sia al livello della formulazione dei programmi, sia al<br />
livello delle pratiche operative, e riguardano i modi in cui è organizzato il lavoro insieme;<br />
4.5.2. Poiché alla base di queste metodologie vi è l’obiettivo di mettere in connessione le polarità<br />
di cui si compongono i processi di esclusione <strong>sociale</strong>, e reciprocamente gli interventi per<br />
contrastarli e invertirli, i contenuti formativi devono prevedere studio ed esperienze su queste<br />
polarità e sulle loro connessioni;<br />
4.5.3. Per apprendere a mettere in connessione polarità occorre una formazione adeguata a<br />
trasmettere capacità di riconoscere i poteri in campo e di agire per orientarli ad interagire,<br />
inducendo in essi cambiamenti e costruendo in questo percorso nuovi poteri, e perciò anche<br />
costruendo nuove basi istituzionali per politiche e programmi di lotta all’esclusione;<br />
4.5.4. Imparare ad imparare: questo obiettivo formativo centrale richiede che le attività<br />
formative, le concrete modalità didattiche e il ruolo dei formatori siano orientati ad accrescere: a) la<br />
capacità di ascoltare, di confrontarsi con posizioni diverse, di autovalutarsi; b) la “negative<br />
capability” che consente di affrontare l’ignoto, costruendo progetti in situazioni di incertezza e di<br />
rischio.<br />
4.5.5. Le metodologie di azione e le competenze qui raccomandate si acquisiscono e crescono con<br />
l’uso: esse si formano soprattutto a contatto diretto con le pratiche. La formazione fondata su<br />
stages operativi va in tutti i modi perseguita e incrementata; e va valorizzato in particolare il<br />
patrimonio disponibile di buone pratiche di lotta all’esclusione <strong>sociale</strong> da cui apprendere: esse<br />
sono del resto all’origine di queste stesse raccomandazioni.<br />
17
BIBLIOGRAFIA<br />
Basaglia, F. (1984) Scritti. 2 voll., Einaudi, Torino<br />
Bauman, Z. (1999) In Search of Politics, Polity Press<br />
Beck, W., van der Maesen, L., Walker, A. (1997) The Social Quality of Europe, Kluwer Law<br />
International, The Hague.<br />
Castel, R. (1995)Métamorphoses de la question <strong>sociale</strong>. Une chronique du salariat, Fayard,<br />
Pari.<br />
De Leonardis, O. (1993) « New Patterns of Collective Action in a ‘Post-Welfare ‘ Society”,<br />
Drover, G., Kerans, P., eds., Welfare Theory, Oxford, Edward Elgar<br />
De Leonardis, O. (1994) « Experiences of Fighting Exclusion through Economic Initiatives »,<br />
Ired Nord, Roma.<br />
De Leonardis, O. (1999) In un diverso welfare. Sogni e incubi, Feltrinelli, Milano (ediz.<br />
pagnola, 2000)<br />
De Leonardis, O., Mauri, D., Rotelli, F. (1986), « Deinstitutionalization : Another Way « ,<br />
Health Promotion, n. 1<br />
De Leonardis, O., Mauri, D., Rotelli, F. (1994) L’impresa <strong>sociale</strong>, Anabasi, Milano (ediz.<br />
Spagnola, Nueva Vision, 1996)<br />
Mingione, E. (1991) Fragmented Societies: a Sociology of Economic Life Beyond the Market<br />
Paradigm, Blackwell, Oxford<br />
Rotelli, F. (1999) Per la normalità, E, Trieste<br />
Sassen, S. (1991) The Global City, Princeton University Press, Princeton<br />
Sassen, S. (1999) Globalization and its Discontents, Oxford University Press, Oxford<br />
Sen, A. (1992) Inequality Reexamined, Clarendon Press, Oxford<br />
Sen, A. (1999) Development as Freedom, Oxford University Press, Oxford<br />
Tendler, J. (1997) Good Government in the Tropics, The John Hopkins University Press,<br />
Baltimore<br />
18