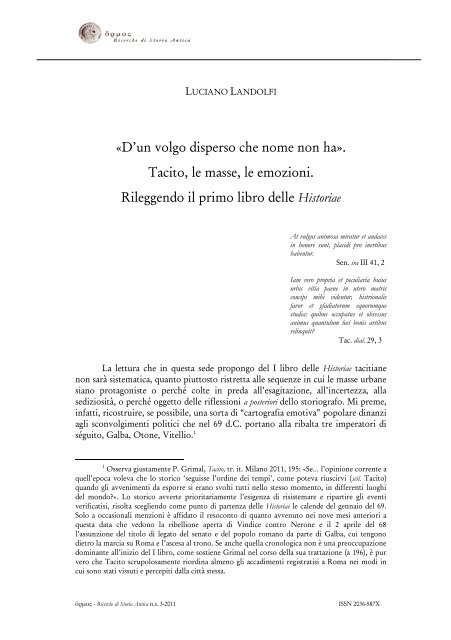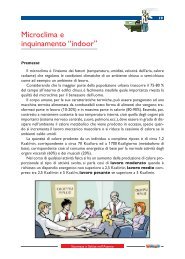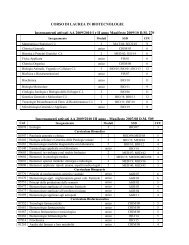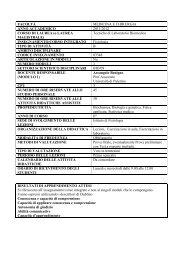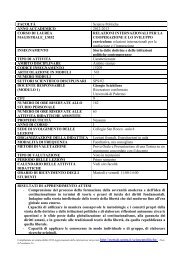«D'un volgo disperso che nome non ha». Tacito, le masse, le ...
«D'un volgo disperso che nome non ha». Tacito, le masse, le ...
«D'un volgo disperso che nome non ha». Tacito, le masse, le ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
LUCIANO LANDOLFI<br />
«D’un <strong>volgo</strong> <strong>disperso</strong> <strong>che</strong> <strong>nome</strong> <strong>non</strong> <strong>ha»</strong>.<br />
<strong>Tacito</strong>, <strong>le</strong> <strong>masse</strong>, <strong>le</strong> emozioni.<br />
Ri<strong>le</strong>ggendo il primo libro del<strong>le</strong> Historiae<br />
At vulgus animosa miratur et audaces<br />
in honore sunt, placidi pro inertibus<br />
habentur.<br />
Sen. ira III 41, 2<br />
Iam vero propria et peculiaria huius<br />
urbis vitia paene in utero matris<br />
concipi mihi videntur, histrionalis<br />
favor et gladiatorum equorumque<br />
studia: quibus occupatus et obsessus<br />
animus quantulum loci bonis artibus<br />
relinquit?<br />
Tac. dial. 29, 3<br />
La <strong>le</strong>ttura <strong>che</strong> in questa sede propongo del I libro del<strong>le</strong> Historiae tacitiane<br />
<strong>non</strong> sarà sistematica, quanto piuttosto ristretta al<strong>le</strong> sequenze in cui <strong>le</strong> <strong>masse</strong> urbane<br />
siano protagoniste o perché colte in preda all’esagitazione, all’incertezza, alla<br />
sediziosità, o perché oggetto del<strong>le</strong> rif<strong>le</strong>ssioni a posteriori dello storiografo. Mi preme,<br />
infatti, ricostruire, se possibi<strong>le</strong>, una sorta di “cartografia emotiva” popolare dinanzi<br />
agli sconvolgimenti politici <strong>che</strong> nel 69 d.C. portano alla ribalta tre imperatori di<br />
séguito, Galba, Otone, Vitellio. 1<br />
1 Osserva giustamente P. Grimal, <strong>Tacito</strong>, tr. it. Milano 2011, 195: «Se… l’opinione corrente a<br />
quell’epoca vo<strong>le</strong>va <strong>che</strong> lo storico ‘seguisse l’ordine dei tempi’, come poteva riuscirvi (scil. <strong>Tacito</strong>)<br />
quando gli avvenimenti da esporre si erano svolti tutti nello stesso momento, in differenti luoghi<br />
del mondo?». Lo storico avverte prioritariamente l’esigenza di risistemare e ripartire gli eventi<br />
verificatisi, risolta scegliendo come punto di partenza del<strong>le</strong> Historiae <strong>le</strong> ca<strong>le</strong>nde del gennaio del 69.<br />
Solo a occasionali menzioni è affidato il resoconto di quanto avvenuto nei nove mesi anteriori a<br />
questa data <strong>che</strong> vedono la ribellione aperta di Vindice contro Nerone e il 2 apri<strong>le</strong> del 68<br />
l’assunzione del titolo di <strong>le</strong>gato del senato e del popolo romano da parte di Galba, cui tengono<br />
dietro la marcia su Roma e l’ascesa al trono. Se an<strong>che</strong> quella cronologica <strong>non</strong> è una preoccupazione<br />
dominante all’inizio del I libro, come sostiene Grimal nel corso della sua trattazione (a 196), è pur<br />
vero <strong>che</strong> <strong>Tacito</strong> scrupolosamente riordina almeno gli accadimenti registratisi a Roma nei modi in<br />
cui sono stati vissuti e percepiti dalla città stessa.<br />
ὅρμος - Ricer<strong>che</strong> di Storia Antica n.s. 3-2011 ISSN 2036-587X
Luciano Landolfi, «D’un <strong>volgo</strong> <strong>disperso</strong> <strong>che</strong> <strong>nome</strong> <strong>non</strong> <strong>ha»</strong>. <strong>Tacito</strong>, <strong>le</strong> <strong>masse</strong>, <strong>le</strong> emozioni |164<br />
Non necessita scorrere una lunga sequela di capitoli per imbattersi in un<br />
ritratto della folla cittadina di taglio psicologico, in quanto, dopo l’ampio<br />
preambolo d’impronta meta<strong>le</strong>tteraria (capp. 1-3), a dominare il fonda<strong>le</strong> della<br />
narrazione sono proprio i singoli ranghi sociali al diffondersi della notizia della<br />
morte di Nerone, in explicit la sordida p<strong>le</strong>bs.<br />
Questo il testo edito per i tipi oxoniensi da Fisher 1977 11 (hist. I 4, 6-16):<br />
Finis Neronis ut laetus primo gaudentium impetu fuerat, ita varios motus animorum <strong>non</strong><br />
modo in urbe apud patres aut populum aut urbanum militem, sed omnis <strong>le</strong>giones ducesque<br />
conciverat, evulgato imperii arcano posse principem alibi quam Romae fieri. Sed patres laeti,<br />
usurpata statim libertate licentius ut erga principem novum et absentem; primores equitum<br />
proximi gaudio patrum; pars populi integra et magnis domibus adnexa, clientes libertique<br />
damnatorum et exulum in spem erecti: p<strong>le</strong>bs sordida et circo ac theatris sueta, simul deterrimi<br />
servorum, aut qui adesis bonis per dedecus Neronis a<strong>le</strong>bantur, maesti et rumorum avidi.<br />
Un consuntivo succinto ma intenso, dove la scomparsa dell’autocrate,<br />
accolta sul<strong>le</strong> prime con un’esplosione di gioia incontrollata, appare poi<br />
diversamente modulata a seconda <strong>che</strong> si tratti di senatori, popolo o milizie urbane, 2<br />
<strong>non</strong>ché di <strong>le</strong>gioni e comandanti. I varii motus animorum conquistano l’attenzione dello<br />
storico il qua<strong>le</strong>, a differenza dell’oratore idea<strong>le</strong> disegnato da Cicerone, <strong>non</strong> si darà<br />
alla conoscenza approfondita dell’animo umano e del<strong>le</strong> sue emozioni per<br />
provocar<strong>le</strong> o sopir<strong>le</strong> all’occorrenza, 3 bensì per studiare gli umori e i sentimenti<br />
del<strong>le</strong> fasce sociali in relazione ad eventi significativi della storia contemporanea o<br />
passata. Non esercitando dunque un controllo sull’uditorio, della qual cosa si<br />
teorizza la necessità nello spazio retorico, né occupandosi della natura e della<br />
tipologia dei motus animorum, prassi usua<strong>le</strong> nel dibattito filosofico, 4 <strong>Tacito</strong> osserva<br />
questi ultimi da un’angolazione psicologica, preoccupato di scoprire i reali <strong>le</strong>gami<br />
intercorsi fra <strong>le</strong> singo<strong>le</strong> fette della società e gli avvicendamenti dinastici. Nel caso<br />
particolare, il suo sguardo si sofferma prima sull’ordine senatorio, esultante per la<br />
libertà ritrovata di colpo, tanto più esplicita in quanto nuovo è il principe e, per di<br />
più, lontano, poi sull’analogo tripudio dei cavalieri più in vista e della parte sana<br />
del popolo, dei clienti, dei liberti dei condannati e degli esuli <strong>che</strong> riprendono a<br />
sperare. In ben altro stato d’animo versa la p<strong>le</strong>baglia, abituata al circo e ai teatri, e<br />
2 «Das ‘republikanis<strong>che</strong>’ Begriffspaar senatus populusque Romanus in den Anna<strong>le</strong>n zu einer<br />
dreigliedrigen Souveränitäts- und Hoheitsformel erzeitert: populus et senatus et mi<strong>le</strong>s»: così M. Vielberg,<br />
Tacitus al Psychologe, «A&A» XLVI (2000), 173-189, a 186, dimentico dell’impiego della triade già in<br />
questo passo del<strong>le</strong> Historiae dove comunque a venir considerate <strong>non</strong> sono <strong>le</strong> milizie indistintamente,<br />
ma solo <strong>le</strong> guarnigioni presenti nell’Urbe.<br />
3 Alludo, naturalmente, a Cic. de orat. I 17, 5 (et omnes animorum motus, quos hominum generi<br />
rerum natura tribuit, penitus pernoscendi, quod omnis vis ratioque dicendi in eorum, qui audiunt, mentibus aut sedandis aut<br />
excitandis expromenda est). Non è questa la sede per discutere sistematicamente della funzione del<br />
controllo del<strong>le</strong> passioni nella retorica latina, di cui il trattato ciceroniano è eloquente testimone.<br />
4 Del <strong>che</strong> una rappresentazione precisa in Cic. de orat. I 51, 220, con la rassegna dei punti di<br />
vista stoico, epicureo e peripatetico sugli animorum motus da integrare con il brano di Tusc. V 84-85. Il<br />
punto nel<strong>le</strong> eccel<strong>le</strong>nti pagine di E. Narducci, Cicerone e l’eloquenza romana. Retorica e progetto cultura<strong>le</strong>,<br />
Roma-Bari 1997, 77-96.<br />
ὅρμος - Ricer<strong>che</strong> di Storia Antica n.s. 3-2011, pp. 163-179
Luciano Landolfi, «D’un <strong>volgo</strong> <strong>disperso</strong> <strong>che</strong> <strong>nome</strong> <strong>non</strong> <strong>ha»</strong>. <strong>Tacito</strong>, <strong>le</strong> <strong>masse</strong>, <strong>le</strong> emozioni |165<br />
con questa la feccia degli schiavi e quanti, dopo aver dissipato i propri averi, si<br />
erano cibati del<strong>le</strong> ignominie di Nerone. 5<br />
Per denotare un ta<strong>le</strong> coacervo <strong>Tacito</strong> ricorre ad una formula <strong>che</strong> ne fissi la<br />
mestizia e l’avidità di chiacchiere (maesti et rumorum avidi) tacendo <strong>le</strong> rispettive<br />
differenze identitarie e giuridi<strong>che</strong>: il <strong>le</strong>ttore si trova pertanto di fronte ad una<br />
massa indistinta <strong>che</strong> versa nella sconsolatezza e brama di informazioni. Calzante la<br />
notazione di La Penna, 6 al cui dire: «La folla, per lo più spregevo<strong>le</strong>, è a volte<br />
grandiosa nella sua forza irraziona<strong>le</strong>, come può esserlo il mare in tempesta; a volte<br />
è mossa an<strong>che</strong> da sentimenti nobili. Sempre però lo storico latino la sente c o m e<br />
f o r z a e m o t i v a , n o n c o m e f o r z a r a z i o n a l e ». <strong>Tacito</strong> <strong>non</strong> costituisce<br />
un’eccezione, in tal senso, posto <strong>che</strong> la storiografia latina <strong>non</strong> si cura <strong>che</strong> molto<br />
raramente di intendere e analizzare <strong>le</strong> motivazioni <strong>che</strong> muovono la folla, <strong>le</strong><br />
particolari condizioni di volta in volta presupposte dal<strong>le</strong> passioni col<strong>le</strong>ttive o dai<br />
sentimenti col<strong>le</strong>ttivi, 7 preferendo viceversa riprodurre a forti tinte gli effetti di<br />
comportamenti incontrollati, frutto di un’emotività instabi<strong>le</strong> e ansiosa.<br />
Ritornando al passo del<strong>le</strong> Historiae qui esaminato, direi <strong>che</strong> maestus, con <strong>le</strong> sue<br />
31 attestazioni, 8 si pone come uno degli epiteti più idonei ad esprimere lo stato di<br />
abbattimento dei nullatenenti, per il qua<strong>le</strong> il <strong>le</strong>ssico tacitiano suo<strong>le</strong> va<strong>le</strong>rsi di<br />
sostantivi rivelatori tanto dell’instabilità politica dominante quanto<br />
dell’inquietudine timorosa <strong>che</strong> li pervade: maestitia, tristitia, timor, metus. Il nesso<br />
rumorum avidi, senza raffronti nel corpo della produzione tacitiana e della<br />
produzione storiografica anteriore (e posteriore), 9 traduce invece l’apprensione<br />
dovuta a incertezza o contraddittorietà di notizie, 10 una condizione di dipendenza<br />
psicologica dal<strong>le</strong> voci <strong>che</strong> si diffondono, caratteristica di diseredati e potenziali<br />
facinorosi. Al termine di questo ritratto orientato socialmente dall’alto verso il<br />
basso, la formula p<strong>le</strong>bs sordida, 11 ritoccata in sordida pars p<strong>le</strong>bis in III 76, 2, 12 la p<strong>le</strong>be<br />
5 La suddivisione della massa in due classi è oggetto di analisi da parte di H.G. Sei<strong>le</strong>r, Die<br />
Masse bei Tacitus, Inaug.-Dissertation Erlangen 1936, 21.<br />
6 Vd. A. La Penna, Storiografia di senatori e storiografia di <strong>le</strong>tterati. Considerazioni generali sulla storiografia<br />
latina di età repubblicana, in Id., Aspetti del pensiero storico latino, Torino 1978, 43-117, 90 (lo spaziato è mio).<br />
7 Seguo qui <strong>le</strong> sottolineature di La Penna, Storiografia di senatori, cit., 90.<br />
8 Cfr. J. Cousin, Rhétorique et psychologie <strong>che</strong>z Tacite, «REL» XXIX (1931), 228-247, 241, n. 1,<br />
con il registro del<strong>le</strong> comp<strong>le</strong>ssive occorrenze dei termini di cui discuto infra.<br />
9 Un quadro esauriente in I. Shatzman, Tacitean Rumours, «Latomus» XXXIII (1974), 549-<br />
578.<br />
10 Vd. C. Heraeus, Cornelii Taciti Historiarum libri qui supersunt. Schulausgabe von dr. C.H., Erster<br />
Band. Buch I und II, Leipzig 1885, 11 ad Hist. I 4, 15: «rumorum avidi ‘erpicht auf schlimme Gerüchte,<br />
Klatsch’. Ähnlich c. 51 fecunda rumoribus; c. 85 rumoribus obiecerat».<br />
11 Osserva in merito W.A. Spooner, Cornelii Taciti Historiarum libri qui supersunt. Introduction,<br />
Notes and Index by the Rev. W.A.Sp., London 1891, 109-110: «The p<strong>le</strong>bs sordida, on the other hand,<br />
was chiefly composed of newly liberated slaves, and even immigrant foreigners, ownig not patronus<br />
but the emperor, to whose liberality they looked for lively hood, and whose staun<strong>che</strong>st upholders<br />
they were. For theme, see Juv. Viii. 118; x. 80; and Meriva<strong>le</strong>, c. iv».<br />
12 Da ultima ricorda il rimpasto del nesso in Hist. III 7, 62, C. Damon, Tacitus Histories Book I,<br />
Cambridge 2003, 103.<br />
ὅρμος - Ricer<strong>che</strong> di Storia Antica n.s. 3-2011, pp. 163-179
Luciano Landolfi, «D’un <strong>volgo</strong> <strong>disperso</strong> <strong>che</strong> <strong>nome</strong> <strong>non</strong> <strong>ha»</strong>. <strong>Tacito</strong>, <strong>le</strong> <strong>masse</strong>, <strong>le</strong> emozioni |166<br />
ignobi<strong>le</strong>, 13 analoga al resoconto <strong>che</strong> di certi schiavi offre Columella in I 8, 2 (circo,<br />
theatris, a<strong>le</strong>ae, popinae, lupanaribus consuetum scil. genus), menzionati in stretta sequenza<br />
dallo storico stesso (deterrimi servorum), 14 il qua<strong>le</strong> <strong>non</strong> tarderà a ripresentare circo e<br />
teatri come fattori <strong>che</strong> snervano i vincitori nel discorso di Antonio Primo contro<br />
Vitellio all’inizio del terzo libro del<strong>le</strong> Historiae (circo quoque ac theatris et amoenitate urbis<br />
emollitos III 2, 7). 15<br />
Ma da chi è costituita la sordida p<strong>le</strong>bs qui descritta? Nel 1965 Zvi Yavetz 16 ha<br />
eliminato qualsiasi dubbio circa la sua composizione attraverso un’analisi serrata<br />
del linguaggio tacitiano, <strong>non</strong> condizionato dal<strong>le</strong> definizioni tecni<strong>che</strong> dei concetti di<br />
p<strong>le</strong>bs e di populus e<strong>che</strong>ggiate da Gell. Noct. Att. X 20, 5 17 o da Gaio Inst. I 3: 18 dovrebbe<br />
trattarsi di quei membri della p<strong>le</strong>bs estranei alla pars integra populi <strong>le</strong>gata al<strong>le</strong> grandi<br />
famiglie, avvezzi a vedere in Nerone una sorta di προστάτης τοῦ δήμου nei cui<br />
rispetti intrattenevano rapporti clientelari (cittadini e <strong>non</strong>, artigiani, osti, schiavi e<br />
affrancati). 19 Tuttavia, in una sorta di anticlimax socia<strong>le</strong> e mora<strong>le</strong> al contempo,<br />
l’obiettivo dello storico decorre dai ceti nobili e abbienti al<strong>le</strong> componenti<br />
moralmente integre del popolo, dei clienti e liberti dei condannati e degli esuli, per<br />
finire con la fascia dei diseredati, dei peggiori fra gli schiavi e degli scialacquatori,<br />
soli a <strong>non</strong> esultare alla fine del principe e bramosi di dicerie. Il connotato<br />
moralistico di cui è impregnato l’epiteto sordida, col<strong>le</strong>gato com’è alla detorsione in<br />
chiave etica di un’area semantica (sordes e derivati) indicante originariamente<br />
“sporcizia” in senso concreto, 20 rimanda alla serie di formu<strong>le</strong> intrise di disprezzo<br />
quali infima p<strong>le</strong>bs (hist. II 38, 8 e 91, 8), 21 vulgus imperitum (dial. de orat. VII 16; ann. II 77,<br />
11), 22 imbel<strong>le</strong> vulgus (ann. XIII 39, 3), flagitans vulgus (ann. XVI 4, 7), vulgus pronum ad<br />
suspiciones (hist. II 21, 7), stolidum vulgus (hist. II 61, 9), vulgus credulum (hist. II 72, 6 e IV 49,<br />
20), vulgus improvidum (hist. III 20, 18), vulgus… immodicum (hist. II 29, 15), vulgus ignavum 23<br />
13 A detta di H. Heubner, P. Cornelius Tacitus. Die Historien Kommentar von H.H., Band I Erstes<br />
Buch, Heidelberg 1963, 30 ad loc.: «die in mehr oder weniger e<strong>le</strong>nden ökonomis<strong>che</strong>n und<br />
moralis<strong>che</strong>n Verhältnissesn <strong>le</strong>bende untere Schicht der Bevölkerung, die, an die unter Nero<br />
übli<strong>che</strong>n Lustbarkeiten gewöhnt, bekümmert und auf Gerüchte, die auf eine neue Umwälzung<br />
deuten könnten, erpicht ist».<br />
14 La Damon, Tacitus Histories Book I, cit., 103, riconduce l’espressione a IV 1, 2: egentissimus<br />
quisque e p<strong>le</strong>be et pessimi servitiorum, sottolineando come il costrutto di per sé enfatizzi «quality (deterrimi)<br />
over rank (servi)» analogamente a 22, 1 intimi libertorum e, più generalmente a 10, 1 (secretum Asiae), 25,<br />
1 (incerta noctis), 79, 2 (lubrico itinerum), 85, 2 (secreta domuum).<br />
15 Brano riportato cursoriamente nel vecchio commento di E. Wolff, Cornelii Taciti<br />
Historiarum libri qui supersunt, erklärt von E.W., Berlin 1866, 30 ad loc.<br />
16 Cfr. Z. Yavetz, Sordida p<strong>le</strong>bs, «Athenaeum» XLIII (1965), 295-311.<br />
17 In populo omnis pars civitatis omnesque eius ordines contineantur.<br />
18 P<strong>le</strong>bs a populo eo distat, quod populi appellatione universi cives significantur, connumeratis patriciis, p<strong>le</strong>bis<br />
autem appellatione sine patriciis ceteri cives significantur.<br />
19 Vd. Yavetz, Sordida p<strong>le</strong>bs, cit., 309.<br />
20 Documentazione in A. Ernout - A. Meil<strong>le</strong>t, Dictionnaire étymologique de la langue latine, Paris<br />
1985 4 , s.v., 637 <strong>non</strong>ché in A. Walde - J.B. Hofmann, Lateinis<strong>che</strong>s etymologis<strong>che</strong>s Wörterbuch II, Heidelberg<br />
1982 5 , s.v., 562.<br />
21 Nesso già presente in Cic. ad Att. IV 1, 5; Curt. Ruf. X 7, 1; vd. poi Suet. Otho VII 1.<br />
22 Variazione ad arte del nesso vulgus imperitorum di Cic. nat. deor. I 101, 2?<br />
23 Formula testimoniata an<strong>che</strong> da Quint. decl. maior. XIII 4.<br />
ὅρμος - Ricer<strong>che</strong> di Storia Antica n.s. 3-2011, pp. 163-179
Luciano Landolfi, «D’un <strong>volgo</strong> <strong>disperso</strong> <strong>che</strong> <strong>nome</strong> <strong>non</strong> <strong>ha»</strong>. <strong>Tacito</strong>, <strong>le</strong> <strong>masse</strong>, <strong>le</strong> emozioni |167<br />
et nihil ultra verbum ausurum (hist. III 58, 5), vulgus mutabi<strong>le</strong> (hist. I 69, 7), insultans vulgus<br />
(hist. IV 2, 15), vulgus… cuiuscumque motus novi cupidum (hist. I 80, 13), 24 vulgus cupiens<br />
voluptatum (ann. XIV 14, 12), vulgus ad deteriora promptum (ann. XV 64), vulgus sine rectore<br />
praeceps pavidum socors (ann. IV 37, 3), vulgus fingendi avidum (hist. II 1, 6), vulgus… vacuum<br />
curis et sine falsi verique discrimine (hist. II 90, 5) 25 dove però, come si può osservare, il<br />
singolo attributo <strong>non</strong> investe con pari viru<strong>le</strong>nza icastica la sfera dei valori morali.<br />
Viceversa, affiora ripetutamente l’interscambiabilità fra p<strong>le</strong>bs e vulgus allorché <strong>Tacito</strong><br />
voglia esprimere il corrispettivo del gr. ὄχλος, cui appone sempre una qualifica di<br />
stampo “etico”, <strong>non</strong> giuridico. 26<br />
In effetti, <strong>le</strong> fasce infime hanno rappresentato il territorio d’e<strong>le</strong>zione sul<br />
qua<strong>le</strong> Nerone ha fondato il proprio consenso e ha costruito il proprio principato<br />
d’impronta assolutistica: distratta dal circo e dai teatri, 27 la marmaglia, insieme alla<br />
p<strong>le</strong>tora degli schiavi peggiori ed ai dissipatori, dopo la fine del princeps si trova priva<br />
di un punto di riferimento e ignora qua<strong>le</strong> atteggiamento adottare. Siamo al<strong>le</strong> soglie<br />
di una definizione coniata più tardi, efficace nel riassumere il punto di vista dello<br />
storico nei confronti della massa allorché abbia perso chi la domini e la indirizzi:<br />
vulgus sine rectore praeceps pavidum socors (hist. IV 37, 3). Irrazionalità, panico, fiac<strong>che</strong>zza<br />
appaiono <strong>le</strong> caratteristi<strong>che</strong> peculiari del comportamento del vulgus, faci<strong>le</strong> preda degli<br />
umori più variabili, della contingenza degli eventi. Significativo, comunque, il<br />
fatto <strong>che</strong> il primo schizzo della massa rinvenibi<strong>le</strong> nel primo libro del<strong>le</strong> Historiae<br />
associ a questa stessa, oltre all’insieme dei peggiori fra gli schiavi, i dilapidatori, di<br />
norma oberati dai debiti e strumentalizzabili da rivoltosi e temerari, come insegna<br />
il paradigma di Catilina in Sall. Cat. 14, 2. La fine di Nerone costituisce quasi un<br />
evento livellatore tra categorie differenti, <strong>che</strong> finiscono per assemblarsi, dalla<br />
visua<strong>le</strong> economica ed etica, proprio per aver rappresentato la base dell’assolutismo<br />
del princeps. 28 Fe<strong>nome</strong>no prevedibi<strong>le</strong>, questo, nei regimi dispotici dove l’intesa fra il<br />
24 Paral<strong>le</strong>lo a populus… novarum rerum cupiens pavidusque di ann. XV 46 su prototipo sallustiano,<br />
cfr. Cat. 37, 2.<br />
25<br />
Che in questo atteggiamento di distacco sprezzante dal vulgus <strong>Tacito</strong> <strong>non</strong> differisca dal<br />
comportamento usualmente tenuto da scrittori e poeti greci e latini sottolinea Sei<strong>le</strong>r, Die Masse bei<br />
Tacitus, cit., 81.<br />
26 Come, dal canto suo, ritiene Yavetz, P<strong>le</strong>bs sordida, cit., 305. Sul tema utili considerazioni<br />
an<strong>che</strong> in A. Borgo, Aspetti della psicologia di massa in Lucano ed in <strong>Tacito</strong>, «Vichiana» n.s. V (1976), 243-257,<br />
specialmente 247-248, e in J. Deininger, Brot und Spie<strong>le</strong>. Tacitus und die Entpolisierung der p<strong>le</strong>bs urbana,<br />
«Gymnasium» LXXXVI (1979), 278-303, in particolare 280-281, secondo il qua<strong>le</strong> populus varrebbe la<br />
massa dei cittadini dal punto di vista eminentemente politico, p<strong>le</strong>bs corrisponderebbe alla massa più<br />
dal punto di vista socia<strong>le</strong>, vulgus più <strong>che</strong> altro esprimerebbe <strong>le</strong> modalità comportamentali della massa<br />
nel suo insieme. Dal <strong>che</strong> un utilizzo meno diffuso della prima designazione, più frequente quello<br />
della seconda, decisamente negativo l’uso della terza, su cui indaga statisticamente Newbold, The<br />
Vulgus, cit., 88.<br />
27 L’importanza <strong>che</strong> la vita teatra<strong>le</strong> assume con la dinastia giulio-claudia nella rete dei<br />
rapporti <strong>che</strong> <strong>le</strong>gano il princeps alla p<strong>le</strong>bs è sottolineata emb<strong>le</strong>maticamente dal fatto <strong>che</strong>, a breve<br />
distanza di tempo dalla morte di Nerone, Vitellio trova faci<strong>le</strong> riscontro presso scurrae, histriones, aurigae<br />
i quali accrescono il suo seguito persona<strong>le</strong> (hist. II 87, 2) e <strong>che</strong>, una volta assurto al potere, omnem<br />
infimae p<strong>le</strong>bis rumorem in theatro ut spectator, in circo ut fautor adfectavit (II 91, 2).<br />
28 Un quadro efficace dei rapporti fra la p<strong>le</strong>be e Nerone in Z. Yavetz, P<strong>le</strong>bs and Princeps,<br />
Oxford 1969, 124 ss.<br />
ὅρμος - Ricer<strong>che</strong> di Storia Antica n.s. 3-2011, pp. 163-179
Luciano Landolfi, «D’un <strong>volgo</strong> <strong>disperso</strong> <strong>che</strong> <strong>nome</strong> <strong>non</strong> <strong>ha»</strong>. <strong>Tacito</strong>, <strong>le</strong> <strong>masse</strong>, <strong>le</strong> emozioni |168<br />
vertice e i ranghi più bassi dura fintantoché resta in vita l’autocrate, per seminare<br />
sconquasso e disorientamento alla sua morte.<br />
Il disegno dell’umoralità popolare, imprevedibi<strong>le</strong> nel<strong>le</strong> sue sortite, emerge<br />
in modo ancora più evidente nel momento in cui la p<strong>le</strong>be chiede vociando la testa<br />
di Otone dopo la scoperta del suo piano eversivo ai danni di Galba (Tac. hist. I 32):<br />
Vniversa iam p<strong>le</strong>bs Palatium imp<strong>le</strong>bat, mixtis servitiis et dissono clamore caedem Othonis et<br />
coniuratorum exitium poscentium ut si in circo aut theatro ludicrum aliquod<br />
postularent: neque illis iudicium aut veritas, quippe eodem die diversa pari certamine<br />
postulaturis, sed tradito more quemcumque principem adulandi licentia adclamationum et<br />
studiis inanibus.<br />
Ancora una volta, la massa si mescola agli schiavi. Nel fare irruzione nel<br />
palazzo imperia<strong>le</strong>, il chiasso disordinato reclama la morte di Otone e l’uccisione<br />
dei congiurati in modo <strong>non</strong> dissimi<strong>le</strong> dalla richiesta di uno spettacolo circense o<br />
teatra<strong>le</strong>, senza una scelta ponderata o schietta, capace com’è la congerie amorfa di<br />
chiedere a gara nello stesso giorno l’esatto contrario. La pagina si snoda su almeno<br />
tre e<strong>le</strong>menti di spicco:<br />
a) il rovesciarsi della folla nella reggia;<br />
b) il clamore discordante;<br />
c) la richiesta dei supplizi a mo’ di ludicrum.<br />
L’arrivo massiccio della p<strong>le</strong>be e degli schiavi trasforma la sede del potere in<br />
un luogo caotico dove predominano gli impulsi, di cui il dissonus clamor è<br />
promanazione diretta, 29 né più né meno <strong>che</strong> in un fonda<strong>le</strong> di pari efficacia iconica,<br />
quantunque di colorito bellico, hist. IV 29, là dove Civi<strong>le</strong> impone ai suoi di<br />
spegnere i fuochi impedendo al<strong>le</strong> <strong>le</strong>gioni romane di colpire gli avversari<br />
distintamente (et restincto igne misceri cuncta tenebris et armis iubet. Tum vero strepitus dissoni,<br />
casus incerti, neque feriendi neque declinandi providentia). L’invasione del palazzo è<br />
espressione di una furia incontrollata in base alla qua<strong>le</strong> la richiesta di esecuzioni,<br />
singola e col<strong>le</strong>ttiva, obbedisce alla “logica” consuetudinaria di un circo o di un<br />
anfiteatro: stigmatizzare la folla inconsulta rievocandone la passione smodata per<br />
gli spettacoli sanguinari permette a <strong>Tacito</strong> di ribadire la condanna di due<br />
caratteristi<strong>che</strong> sconcertanti, irrazionalità e vio<strong>le</strong>nza gratuita, normativizzate<br />
dall’abitudine ai ludicra.<br />
29 Non è affatto improbabi<strong>le</strong> <strong>che</strong> qui operi, più o meno surrettiziamente, il ricordo di Liv.<br />
IV 37, 9 (ab Romanis dissonus (scil. clamor), impar, segnius saepe iteratus [incerto clamore] prodidit pavorem animorum),<br />
del <strong>che</strong> si avvede Heubner, P. Cornelius Tacitus. Die Historien, cit., 70. La clausola dissonus clamor trova<br />
comunque impiego an<strong>che</strong> in Agr. 33, 1. A sua volta, Damon, Tacitus Histories Book I, cit., 164,<br />
commenta: «dissono clamore is formally paral<strong>le</strong>l to mixtis servitiis, but different in content, since servitiis<br />
describes a portion of the crowd, clamore the commotion of the who<strong>le</strong> gathering. Dissono is<br />
distributive, i.e. some were calling for caedes Othonis, others for exitium coniuratorum (cf. A. 1.34-2,<br />
14.51.1 ita dissonae voces respondebant numerum aut aetatem aut sexum ac plurimorum indubiam innocentiam<br />
miserantium). The abstract and therefore more e<strong>le</strong>vated clamor… is commoner in T. than clamores…;<br />
here it is used even… in a situation involving distinct shouts».<br />
ὅρμος - Ricer<strong>che</strong> di Storia Antica n.s. 3-2011, pp. 163-179
Luciano Landolfi, «D’un <strong>volgo</strong> <strong>disperso</strong> <strong>che</strong> <strong>nome</strong> <strong>non</strong> <strong>ha»</strong>. <strong>Tacito</strong>, <strong>le</strong> <strong>masse</strong>, <strong>le</strong> emozioni |169<br />
Il passo predetto <strong>non</strong> può <strong>non</strong> richiamare i toni con i quali i tragediografi<br />
deprecavano la passione popolare per gli spettacoli, come comprova Sen. Herc. fur.<br />
838-839:<br />
Quantus incedit populus per urbes<br />
ad novi ludos avidus theatri<br />
tuttavia, in una scacchiera di riadattamenti, il brano di hist. I 32 prelude molto da<br />
vicino ad uno stralcio dove il tema “sangue e arena” si ripresenta in una scrittura<br />
altrettanto intensa e ripugnante, hist. III 38, passo vertente sullo scontro fra fautori<br />
di Vespasiano e fautori di Vitellio:<br />
Aderat pugnantibus spectator populus, utque in ludicro certamine, hos, rursus<br />
illos clamore et plausu fovebat. quotiens pars altera inclinasset, abditos in tabernis aut si<br />
quam in domum perfugerant, erui iugularique expostulantes parte maiore praedae<br />
potiebantur.<br />
Al di là della tragica conflittualità intestina, l’urto tra <strong>le</strong> fazioni per la<br />
conquista del potere sottostà alla consuetudine della spettacolarità, del ludicrum: da<br />
un lato il popolo <strong>che</strong> assiste come ad un evento circense o teatra<strong>le</strong>, dall’altro i<br />
contendenti fatti oggetto di grida e applausi a seconda dell’adesione ad un indirizzo<br />
politico o ad un altro. Il <strong>le</strong>ssico rispecchia una certa stereotipia se confrontato con<br />
il passo da cui siamo partiti: ludicrum, clamor, expostulo (al posto di posco), in relazione<br />
alla somiglianza fra i contesti, riassunta dalla spettacolarizzazione dell’evento.<br />
Paradossa<strong>le</strong> per quanto possa sembrare, nella visua<strong>le</strong> della massa cittadina la vita<br />
politica assume <strong>le</strong> proporzioni di un entertainment <strong>che</strong> quanto più cruento è tanto più<br />
soddisfa la sua libido cruoris.<br />
Altrove <strong>Tacito</strong> avrebbe <strong>le</strong>vato la propria voce contro la pratica degli<br />
spettacoli, capaci di generare pigrizia e corruzione nel popolo, 30 commentando<br />
l’istituzione da parte di Nerone del quinquenna<strong>le</strong> ludicrum Romae (cfr. ann. XIV 20), 31<br />
viceversa gli influssi diretti dei ludicra sulla psicologia di massa vengono testimoniati<br />
nell’episodio di hist. I 32, dove chiedere la morte di Otone e dei suoi complici <strong>non</strong><br />
si allontana affatto dalla prassi invalsa negli spettacoli. Il sostanzia<strong>le</strong> décalage fra la<br />
richiesta dell’esecuzione di un capoparte politico e seguaci e la richiesta di<br />
30 Né va dimenticato, a proposito dell’indecenza degli spettacoli stessi, l’attacco alla theatralis<br />
populi lascivia di ann. XI 13.<br />
31 Nerone quartum Cornelio Cosso consulibus quinquenna<strong>le</strong> ludicrum Romae institutum est ad morem Graeci<br />
certaminis, varia fama, ut cuncta ferme nova. Quippe erant qui Gn. quoque Pompeium incusatum a senioribus ferrent quod<br />
mansuram theatri sedem posuisset. Nam antea subitariis gradibus et scaena in tempus structa ludos edi solitos, vel si<br />
vetustiora repetas, stantem populum spectavisse, ne, si consideret theatro, dies totos ignavia continuaret.<br />
Spectaculorum quidem antiquitas servaretur, quoties praetores ederent, nulla cuiquam civium necessitate certandi. Ceterum<br />
abolitos paulatim patrios mores funditus everti per accitam lasciviam, ut quod usquam corrumpi et corrumpere queat<br />
in urbe visatur, degeneretque studiis externis iuventus, gymnasia et otia et turpis amores exercendo, principe et senatu<br />
auctoribus, qui <strong>non</strong> modo licentiam vitiis permiserint, sed vim adhibeant proceres Romani specie orationum et<br />
carminum scaena polluantur. Quid superesse nisi ut corpora quoque nudent et caestus adsumant easque pugnas pro militia et<br />
armis meditentur? An iustitiam auctum iri et decurias equitum egregium iudicandi munus exp<strong>le</strong>turos, si fractos sonos et<br />
dulcedinem vocum perite audissent? Noctes quoque dedecori adiectas ne quod tempus pudori relinquatur, sed coetu promisco,<br />
quod perditissimus quisque per diem concupiverit, per tenebras audeat (ed. Fisher 198116 ).<br />
ὅρμος - Ricer<strong>che</strong> di Storia Antica n.s. 3-2011, pp. 163-179
Luciano Landolfi, «D’un <strong>volgo</strong> <strong>disperso</strong> <strong>che</strong> <strong>nome</strong> <strong>non</strong> <strong>ha»</strong>. <strong>Tacito</strong>, <strong>le</strong> <strong>masse</strong>, <strong>le</strong> emozioni |170<br />
esecuzione di un gladiatore qualunque è palmare, eppure <strong>Tacito</strong> sfrutta abilmente<br />
il paradosso per rimarcare l’irrazionalità colpevo<strong>le</strong> della folla dinanzi ad eventi<br />
storici di tutto rilievo, affrontati con la <strong>non</strong>curanza efferata con cui ci si<br />
comporterebbe a teatro o in arena (p<strong>le</strong>bs sordida et circo ac theatris sueta I 4).<br />
“Spettacolarizzare” la vita politica comporta, per così dire, istituzionalizzare via<br />
via certi impulsi incontrollati dinanzi al<strong>le</strong> sue dinami<strong>che</strong>, come, ad es., avviene alla<br />
scoperta di una congiura contro il principe di turno. Turba… / spectatrix sce<strong>le</strong>rum,<br />
avrebbe detto Lucano (III 128-129). Non meraviglia allora <strong>che</strong> i cosiddetti studia<br />
vulgi condizionino la fortuna o la sfortuna di un capoparte, di un’intera fazione, di<br />
un complotto dinastico. Proprio in quest’àmbito la tendenza di <strong>Tacito</strong> allo studio<br />
psicologico del<strong>le</strong> fasce più basse trova terreno ferti<strong>le</strong> e la grana linguistica dei suoi<br />
ritratti svela un altissimo quoziente di elaborazione forma<strong>le</strong> forte della<br />
rimodulazione di <strong>non</strong> pochi lasciti dell’Hochstil. Del <strong>che</strong> si può avere prova<br />
tangibi<strong>le</strong> riesaminando una terza pericope giocata sul<strong>le</strong> reazioni emotive del<br />
popolo e della p<strong>le</strong>be incompetente di questioni politi<strong>che</strong> in hist. I 35. Accantonata<br />
ogni esitazione, Galba sceglie una condotta ad effetto dinanzi alla congiura di<br />
Otone, del qua<strong>le</strong> circola voce <strong>che</strong> sia stato ucciso in castris:<br />
Tum vero <strong>non</strong> populus tantum et imperita p<strong>le</strong>bs in plausus et immodica<br />
studia sed equitum p<strong>le</strong>rique ac senatorum, posito metu incauti, refractis Palatii foribus ruere<br />
intus ac se Galbae ostentare, praereptam sibi ultionem querentes, ignavissimus quisque et, ut<br />
res docuit, in periculo <strong>non</strong> ausurus, nimii verbis, linguae feroces; nemo scire et omnes<br />
adfirmare, donec inopia veri et consensu errantium victus sumpto thorace Galba inruenti<br />
turbae neque aetate neque corpore sistens sella <strong>le</strong>varetur.<br />
La descrizione si svolge in modo inverso rispetto a quanto registrato a<br />
proposito di I 4: prima vengono rievocati il popolo e la marmaglia, 32 poi gran<br />
numero di cavalieri e senatori, questi ultimi uniformati negli applausi e nel<strong>le</strong><br />
manifestazioni di entusiasmo ai primi. Si tratta di una vera e propria schocking scene, 33<br />
come segnala l’attacco avverbia<strong>le</strong> (Tum vero), mutuato dal serbatoio aulico dell’epos,<br />
significativamente attestato <strong>non</strong> solo in Virgilio, il qua<strong>le</strong> ne fa un uso reiterato, 34<br />
bensì an<strong>che</strong> nell’Omero Latino, 35 da Petronio esametrico, 36 Stazio, 37 Silio Italico, 38<br />
32 Nota Heraeus, Cornelii Taciti Historiarum libri qui supersunt, cit., 61: «populus, ist hier der<br />
eigentli<strong>che</strong> Bürgerstand, p<strong>le</strong>bs die niederen Volksklassen, wie c. 4, 11. 13. Vgl. c. 32: universa iam p<strong>le</strong>bs<br />
mixtis servitiis; c. 36 populo ac p<strong>le</strong>be; c. 40 populi aut p<strong>le</strong>bis; c. 76, 17. 82, 10. Anders A. I, 8. XIII, 31».<br />
33 Faccio mia una espressione di Damon, Tacitus Histories Book I, cit., 171, stando alla qua<strong>le</strong> «<br />
tum vero introduces similarly schocking scenes at 81.2, 4.29.2 tum vero strepitus dissoni etc., Agr. 37.2 tum<br />
vero… grande et atrox spectaculum, and A. 1.35.4 tum vero, quasi sce<strong>le</strong>re contaminaretur; it often begins sentence,<br />
line, and revelation in Virgil (e.g. Ecl. 6, 27 tum vero… videres; Aen. 2.105 tum vero ardemus, 2.228 tum<br />
vero… pavor, 2.309 tum vero manifesta, 2.264 tum vero… visum, etc.); cf. Sall. Cat. 61.1 tum vero cerneres, Liv.<br />
28.20.6 tum vero apparuit».<br />
34 Aen. I 485; II 105, 228, 309, 624; III 47; IV 571; V 172, 227, 659, 720; VII 376, 519; IX 73,<br />
424; X 647; XI 633, 832; XII 257, 494, 756, 766 (Nei passi epici riportati qui e nel<strong>le</strong> note seguenti<br />
<strong>non</strong> distinguo Tum vero in posizione incipitaria o mediana del verso).<br />
35 Vv. 306, 441.<br />
36 CXXIII, v. 193.<br />
37 Theb. I 412; VI 518; Ach. I 761.<br />
ὅρμος - Ricer<strong>che</strong> di Storia Antica n.s. 3-2011, pp. 163-179
Luciano Landolfi, «D’un <strong>volgo</strong> <strong>disperso</strong> <strong>che</strong> <strong>nome</strong> <strong>non</strong> <strong>ha»</strong>. <strong>Tacito</strong>, <strong>le</strong> <strong>masse</strong>, <strong>le</strong> emozioni |171<br />
Va<strong>le</strong>rio Flacco. 39 Tuttavia sembra <strong>che</strong> ad aver privi<strong>le</strong>giato una movenza simi<strong>le</strong> sia<br />
stato già Cesare in occasione di abbozzi di massa fortemente “psicologizzati”, basti<br />
ri<strong>le</strong>ggere i brani di Gall. III 26 (tum vero clamore ab ea parte audito nostri redintegratis viribus);<br />
V 37 (tum vero suo more victoriam conclamant atque ululatum tollunt impetuque in nostros facto<br />
ordines perturbant); VII 47 (tum vero ex omnibus urbis partibus orto clamore); civ. II 42 (tum vero<br />
ad summam desperationem nostri perveniunt et partim fugientes ab equitatu interficiuntur, partim<br />
integri procumbunt), per <strong>non</strong> parlare poi di Sallustio, <strong>che</strong> sigla con Cat. 61, 1 il proprio<br />
debito verso ta<strong>le</strong> nesso avverbia<strong>le</strong> con il grandioso ritratto post eventum della battaglia<br />
di Fieso<strong>le</strong> (Sed confecto proelio, tum vero cerneres, quanta audacia quantaque animi vis fuisset in<br />
exercitu Catilinae) o di Livio, <strong>che</strong> offre una campionatura ricchissima in tal senso. 40<br />
Torniamo a <strong>Tacito</strong>.<br />
L’emotività priva di freni varca i limiti sociali e censitari, sicché plausus et<br />
immodica studia cementano tanto i ranghi infimi quanto quelli abbienti travasandosi<br />
dai primi ai secondi. Nello specifico, lo storico punta il dito contro la temerarietà<br />
improvvisa di senatori e cavalieri <strong>che</strong>, deposta la paura, irrompono caoticamente<br />
nel palazzo con una viru<strong>le</strong>nza superiore addirittura a quella del<strong>le</strong> <strong>masse</strong> descritta in<br />
I 32, una viru<strong>le</strong>nza ora riprodotta dall’allitterazione in littera canina (refractis Palatii<br />
foribus ruere), e, sul piano sintattico, dall’impiego dell’infinito storico, dotato di<br />
vividezza iconica, allineato ad ostentare, scire, adfirmare. Gli ordini egemoni assumono<br />
atteggiamenti di solito caratteristici di quelli inferiori in preda all’esasperazione:<br />
tracotanza e arroganza verba<strong>le</strong> (nimii verbis, 41 linguae feroces), 42 unite ad improvvisa<br />
baldanza (ignavissimus quisque… in periculo <strong>non</strong> ausurus). Quella <strong>che</strong> si presenta a Galba è<br />
una inruens turba, nesso, questo, col<strong>le</strong>gato al sintagma precedente ruere intus con cui si<br />
fissava l’orda di senatori e cavalieri rovesciatasi nella reggia. La propensione ad<br />
assimilare all’irrazionalità tipica dei ceti più bassi taluni comportamenti di altre<br />
fette sociali trova una sorta di contrappunto a brevissima distanza di tempo, in<br />
occasione dell’entusiasmo <strong>che</strong> <strong>le</strong> truppe mostrano nei confronti di Otone, issato<br />
fra <strong>le</strong> insegne e cinto dai vessilli, ossia il passo di hist. I 36. Se sullo sfondo si<br />
profilano ancora grida e strepiti, ma an<strong>che</strong> mutui incitamenti, il vocio è<br />
studiatamente scorporato da quello del popolo e della p<strong>le</strong>be, <strong>non</strong> obbedendo a<br />
38<br />
II 378, 592; IV 615, 806; V 279; VI 514; VIII 595; IX 644; X 247; XII 741; XV 146, 764;<br />
XVI 434, 695; XVII 539, 558.<br />
39<br />
II 525, 576; III 576; VI 469; VII 475, 631; VIII 295.<br />
40 Sull’uso di tum vero in àmbito storiografico (e <strong>non</strong>) un quadro attendibi<strong>le</strong> in J.-P.<br />
Chausserie-Laprée, L’expression narrative <strong>che</strong>z <strong>le</strong>s historiens latins. Histoire d’un sty<strong>le</strong>, Paris 1969, 520-531.<br />
41 Chiasmo con variatio nella reggenza, probabilmente modellato, per il primo segmento, su<br />
un nesso sallustiano, hist. 2, 53 (fiducia nimius), se diamo retta ad Heubner, P. Cornelius Tacitus. Die<br />
Historien, cit., 81.<br />
42 A riscontro Wolff, Cornelii Taciti Historiarum libri, cit., 73 riporta i casi di Tac. ann. I 32<br />
(animi ferox), IV 12 (ferox sce<strong>le</strong>rum); Ov. met. VIII 614 (mentis ferox). Dal canto suo, Heraeus, Corneli Taciti<br />
Historiarum libri, cit., 61, segnala come per indicare l’organo in latino ci si serva in genere<br />
dell’ablativo, come, ad es. in 15 Sall. Iug. 44, 1 (lingua promptum); Liv. II 45, 16 (lingua promptum); VII, 4,<br />
5 (lingua impromptus); XXII 12, 11 (lingua inmodicus); XXIII 45, 9 (fortes lingua); Tac. hist. II 23 (procax ore);<br />
III 53 (inmodicus lingua). Richiamerei inoltre il caso sottaciuto di ann. I 16 (procax lingua). Ulteriori<br />
ragguagli sintattici in Heubner, P. Cornelius Tacitus. Die Historien Kommentar, cit, 81.<br />
ὅρμος - Ricer<strong>che</strong> di Storia Antica n.s. 3-2011, pp. 163-179
Luciano Landolfi, «D’un <strong>volgo</strong> <strong>disperso</strong> <strong>che</strong> <strong>nome</strong> <strong>non</strong> <strong>ha»</strong>. <strong>Tacito</strong>, <strong>le</strong> <strong>masse</strong>, <strong>le</strong> emozioni |172<br />
vuota adulazione, bensì al trasporto provato dinanzi ad un nuovo adepto alla causa<br />
di Otone stesso:<br />
Strepere cuncta clamoribus et tumultu et exhortatione mutua, <strong>non</strong> tamquam in populo<br />
ac p<strong>le</strong>be, variis segni adulatione vocibus, sed ut quemque adfluentium militum<br />
aspexerant, prensare manibus, comp<strong>le</strong>cti armis, conlocare iuxta, praeire sacramentum, modo<br />
imperatorem militibus, modo milites imperatori commendare.<br />
Strepere, prensare, comp<strong>le</strong>cti, conlocare, praeire, commendare: sei gli infiniti storici <strong>che</strong><br />
trasmettono l’esultanza dei fautori del futuro princeps, tuttavia il primo è quello <strong>che</strong><br />
più interessa perché, a differenza del dissonus clamor di I 32, 2 ora lo strepito<br />
sottolinea soltanto la reazione emotiva del<strong>le</strong> milizie alla prospettiva di un nuovo<br />
sovrano, senza quella tendenza adulatoria propria della p<strong>le</strong>be <strong>che</strong> proprio in I 32,<br />
5-6 <strong>Tacito</strong> si era affrettato a rimarcare (tradito more quemcumque principem adulandi) e su<br />
cui avrebbe insistito ancora in I 90, 10-11 (vocesque volgi ex more adulandi nimiae et falsae),<br />
commentando l’eccessiva e ipocrita compiacenza del <strong>volgo</strong> nei riguardi di Otone,<br />
pronto a partire da Roma dopo un discorso di conciliazione indirizzato a Vitellio,<br />
ormai destinato a succedergli al potere. Quasi inuti<strong>le</strong>, forse, osservare il ricorso al<br />
nesso in populo ac p<strong>le</strong>be, precorso da <strong>non</strong> populus tantum et imperita p<strong>le</strong>bs di I 35, 1 43 dopo la<br />
segnalazione inizia<strong>le</strong> dello strepito genera<strong>le</strong> memore, a tutti gli effetti, di Liv. XXII<br />
19, 9 (vario tumultu omnia strepunt), ritoccato in XXV 25, 9 (cum omnia terrore ac tumultu<br />
streperent). 44 In sintesi, direi <strong>che</strong> il <strong>le</strong>ttore si trova di fronte ad un’ulteriore<br />
declinazione degli umori politici, stavolta colti nell’alveo del<strong>le</strong> milizie, viste pur<br />
sempre in rapporto al popolo e alla p<strong>le</strong>be, “termometri” emb<strong>le</strong>matici<br />
dell’incostanza e dell’estemporaneità del<strong>le</strong> simpatie nei confronti del principe di<br />
turno, riassumibili nella formula mobilitas vulgi di hist. V 8, 3. D’altronde, <strong>Tacito</strong> <strong>non</strong><br />
si disallinea dalla consueta deprecazione dell’incostanza della massa <strong>che</strong> aveva<br />
trovato in Seneca tinte forti, basti ripercorrere i vv. 169-171 dell’Hercu<strong>le</strong>s furens dove<br />
l’ansia della conquista del potere costringe chi vi ambisce a sottostare<br />
all’inaffidabilità del mobi<strong>le</strong> vulgus: 45<br />
Illum populi favor attonitum<br />
fluctuque magis mobi<strong>le</strong> vulgus<br />
aura tumidum tollit inani<br />
motivo ripreso in un altro brano, stavolta appartenente alla Phaedra, lungo una<br />
nuova serie di Lebensbilder, dove chi si consacra alla caccia e al culto di Diana <strong>non</strong><br />
43 Vd. an<strong>che</strong> hist. I 40, 1: neque populi aut p<strong>le</strong>bis ulla vox; 82, 2: rarus per vias populus, maesta p<strong>le</strong>bs; 89,<br />
1: sed volgus et magnitudine nimia communium curarum expers populus.<br />
44 I passi liviani ricorrono già nel commento di Heraeus, Cornelii Taciti Historiarum libri qui<br />
supersunt, cit, 62 a mo’ di semplici loci simi<strong>le</strong>s.<br />
45 Per una valutazione equilibrata del passo vd. R. Degl’Innocenti Pierini, Tra filosofia e poesia.<br />
Studi su Seneca e dintorni, Bologna 1999, 48-49.<br />
ὅρμος - Ricer<strong>che</strong> di Storia Antica n.s. 3-2011, pp. 163-179
Luciano Landolfi, «D’un <strong>volgo</strong> <strong>disperso</strong> <strong>che</strong> <strong>nome</strong> <strong>non</strong> <strong>ha»</strong>. <strong>Tacito</strong>, <strong>le</strong> <strong>masse</strong>, <strong>le</strong> emozioni |173<br />
sottostà all’incostanza del favore popolare e del <strong>volgo</strong> infido, né alla fragilità del<br />
favore dei potenti (vv. 486-489): 46<br />
<strong>non</strong> illum avarae mentis inflammat furor<br />
qui se dicavit montium insontem iugis,<br />
<strong>non</strong> aura populi 47 et vulgus infidum bonis,<br />
<strong>non</strong> pesti<strong>le</strong>ns invidia, <strong>non</strong> fragilis favor.<br />
Dovremo spingerci sino al passo di hist. I 40 perché sia chiaro fino a <strong>che</strong><br />
punto detentore del potere e aspirante al potere finiscano, nella visua<strong>le</strong> tacitiana,<br />
per essere condizionati dalla massa tanto sul piano fisico quanto su quello emotivo.<br />
Da un lato, Galba è materialmente trascinato dall’ondeggiamento scomposto della<br />
folla incerta, come in Plut. Galba 26, 3, 48 mentre in un’atmosfera spettra<strong>le</strong>, popolo e<br />
p<strong>le</strong>be osservano il si<strong>le</strong>nzio, con lo stordimento dipinto sui volti e <strong>le</strong> orecchie tese a<br />
captare qualunque rumore. Dall’altro, si sparge la notizia <strong>che</strong> la p<strong>le</strong>be si stia<br />
armando, sicché Otone ordina ai suoi di precipitarsi a prevenire il rischio,<br />
uccidendo il vecchio dinasta: 49<br />
Agebatur huc illuc Galba vario turbae fluctuantis impulsu, comp<strong>le</strong>tis undique basilicis ac<br />
templis, lugubri prospectu. Neque populi aut p<strong>le</strong>bis ulla vox, sed attoniti vultus<br />
et conversae ad omnia aures; <strong>non</strong> tumultus, <strong>non</strong> quies, qua<strong>le</strong> magni<br />
metus et magnae irae si<strong>le</strong>ntium est. Othoni tamen armari p<strong>le</strong>bem nuntiabatur;<br />
ire praecipitis et occupare pericula iubet.<br />
Lo scenario delineato da <strong>Tacito</strong> evidenzia l’affollamento del<strong>le</strong> basili<strong>che</strong> e dei<br />
templi, luoghi di riunione politica e di culto, tra il fluttuare della folla <strong>che</strong><br />
risospinge in direzioni opposte il princeps. Per la prima volta domina la mancanza di<br />
clamori: se lugubre è lo spettacolo (lugubri prospectu), pregno di indefinitezza è il<br />
si<strong>le</strong>nzio (<strong>non</strong> tumultus, <strong>non</strong> quies, qua<strong>le</strong> magni metus et magnae irae si<strong>le</strong>ntium est), qualificato<br />
polarmente (<strong>non</strong>… <strong>non</strong>) per imprimere maggior enfasi alla sua evocazione. Il<br />
si<strong>le</strong>nzio del<strong>le</strong> grandi paure e del<strong>le</strong> grandi ire s’impone in un’atmosfera di<br />
sospensione, gravida di interrogativi e di incertezze. Il periodare procede prima per<br />
negazioni (neque… ulla; <strong>non</strong>… <strong>non</strong>), poi per antitesi (sed): balza l’efficacia del<strong>le</strong><br />
strutture sintatti<strong>che</strong>, articolate sulla paratassi <strong>che</strong> traduce la forza del<strong>le</strong> emozioni in<br />
campo. A breve ridiscuterò dell’aspetto architettonico dello stralcio. Intanto vorrei<br />
sottolineare la specificità dei volti intontiti, se a veicolare lo stordimento <strong>che</strong><br />
paralizza è un participio qua<strong>le</strong> attonitus predicato a vultus secondo un uso sporadico,<br />
attestato in precedenza solo da Curt. Ruf. VI 9, 2; Petr. LXXXII 2; Val. Fl. III 532<br />
e VII 191, <strong>che</strong>, a loro volta, sembrano variare la clausola attonita… ora di Epic. Drusi<br />
46 Motivo, questo, <strong>che</strong> trova ancor più compiuta elaborazione, e in pa<strong>le</strong>se riferimento a<br />
Nerone, ai vv. 604-615 dell’Octavia pseudo-senecana. Sul passo della Fedra si veda almeno C. De<br />
Meo, Lucio Anneo Seneca. Phaedra, Bologna 1995, 164.<br />
47 Cfr. inoltre Sen. Thy. 351-352: numquam stabilis favor / vulgi.<br />
48 Τοῦ φορείου, καθάπερ ἐν κλύδωνι, δεῦρο κἀκεῖ διαφερομένου, cfr. G.E.F. Chiever, A<br />
Historical Commentary on Tacitus’ Histories I and II, Oxford 1979, 99.<br />
49 Sul passo cfr. A.J. Pomeroy, Theatricality in Tacitus’s Histories, «Arethusa» XXXI (2006), 171-<br />
191, particolarmente 186 ss.<br />
ὅρμος - Ricer<strong>che</strong> di Storia Antica n.s. 3-2011, pp. 163-179
Luciano Landolfi, «D’un <strong>volgo</strong> <strong>disperso</strong> <strong>che</strong> <strong>nome</strong> <strong>non</strong> <strong>ha»</strong>. <strong>Tacito</strong>, <strong>le</strong> <strong>masse</strong>, <strong>le</strong> emozioni |174<br />
318, rimanendo distanti dal nesso attonitum pectus di Sen. Phoen. 302, 50 dove pectus<br />
subentra all’ “espressione dell’interiorità”, per usare una definizione azzeccata, 51 o,<br />
se si preferisce, alla “faccia semiotica” 52 propriamente detta. L’intero riquadro, se<br />
<strong>non</strong> direttamente a Xen. Ages. II 12, sembra ispirato quantomeno a Liv. I 29, 2, lo<br />
scenario della città di Alba invasa dal<strong>le</strong> truppe romane in un clima di incertezza<br />
agghiacciante. Si tratta di un passo noto ai commentatori, 53 <strong>che</strong> val la pena di citare<br />
per esteso onde saggiare l’attitudine di <strong>Tacito</strong> al riadeguamento iconico e<br />
contestua<strong>le</strong>:<br />
Non quidem fuit tumultus il<strong>le</strong> nec pavor qualis captarum esse urbium<br />
so<strong>le</strong>t, cum effractis portis stratisve ariete muris aut arce vi capta clamor hostilis et cursus per<br />
urbem armatorum omnia ferro flammaque miscet; sed si<strong>le</strong>ntium triste ac tacita<br />
maestitia ita defixit omnium animos.<br />
Scompiglio e panico, e<strong>le</strong>menti-base del resoconto livian, peculiari della<br />
conquista del<strong>le</strong> città, cedono il passo a si<strong>le</strong>nzio e mestizia, quasi <strong>che</strong> <strong>le</strong> reazioni<br />
incontrollate dell’emotività subiscano una sorta di paralisi: specularmente il<br />
si<strong>le</strong>nzio è triste e l’afflizione è si<strong>le</strong>nziosa. Il chiasmo conclusivo (si<strong>le</strong>ntium triste ac<br />
tacita maestitia) con <strong>le</strong> dentali ribattute dopo il sigmatismós (sed si<strong>le</strong>ntium) racchiude<br />
l’immagine dello sconforto genera<strong>le</strong> <strong>che</strong> <strong>non</strong> conosce la rumorosità dell’invasione,<br />
bensì l’inchiodamento degli animi. Da questo quadro intriso di pathos, <strong>Tacito</strong><br />
attinge <strong>le</strong> componenti cenestesi<strong>che</strong> del proprio resoconto: l’assenza tota<strong>le</strong> di suono<br />
articolato, il dominio del si<strong>le</strong>nzio, tipico del<strong>le</strong> grandi paure e del<strong>le</strong> grandi ire. Il<br />
periodare segue da presso l’esempio di Livio: alla variatio avverbia<strong>le</strong> <strong>non</strong>… nec<br />
subentra l’asimmetria avverbia<strong>le</strong>/aggettiva<strong>le</strong> neque… aut ulla, alla coppia sed… ac<br />
subentra l’anafora di <strong>non</strong>, alla comparazione inizia<strong>le</strong> retta da qualis replica la<br />
comparazione fina<strong>le</strong> costruita allo stesso modo. In aggiunta, <strong>le</strong> notazioni psicosomati<strong>che</strong>,<br />
ossia i volti storditi e <strong>le</strong> orecchie tese a percepire qualunque cosa,<br />
irrequiete. Il potenziamento dell’e<strong>le</strong>mento emoziona<strong>le</strong> nella “riscrittura” tacitiana<br />
denunzia una volontà precisa di esasperare i contorni drammatici del racconto:<br />
<strong>non</strong> più un popolo impietrito e ammutolito dinanzi alla conquista romana, bensì<br />
una massa cittadina <strong>che</strong> gremisce i luoghi del potere e dei culti pavida e guardinga,<br />
in attesa <strong>che</strong> si compia da un momento all’altro il cesaricidio.<br />
A breve, un’opportunità imperdibi<strong>le</strong> per ribadire l’inaffidabilità del <strong>volgo</strong> è<br />
costituita dal<strong>le</strong> reazioni di quest’ultimo alla notizia della morte di Galba e<br />
50 Per il cospicuo impiego di attonitus in Seneca, accresciuto dal punto di vista semantico<br />
rispetto alla sua originaria significazione, e volto ad esprimere «lo smarrimento e l’angosciosa<br />
allucinazione della coscienza di fronte all’inesorabilità degli eventi <strong>che</strong> la tra<strong>volgo</strong>no, e la tensione<br />
interiore del<strong>le</strong> anime, costantemente esasperata fino ai limiti del furore e del delirio» va segnalato il<br />
basilare contributo di P. Pasiani, «Attonitus» nel<strong>le</strong> tragedie di Seneca, in A. Traina (a cura di), Seneca. Letture<br />
criti<strong>che</strong>, Milano 20002 (ed. aggiornata a cura di F. Citti), 208-221 (la citazione ricorre a 221).<br />
51 Cfr. M. Bettini, Guardarsi in faccia a Roma. Le paro<strong>le</strong> dell’apparenza fisica nella cultura latina, in Id.,<br />
Le orecchie di Hermes, Torino 2000, 313-356, a 323.<br />
52 Vd. Bettini. Guardarsi in faccia, cit., 327.<br />
53 Mi limito a menzionare Chiever, A Historical Commentary, cit., 99; Damon, Tacitus Histories<br />
Book I, cit., 182.<br />
ὅρμος - Ricer<strong>che</strong> di Storia Antica n.s. 3-2011, pp. 163-179
Luciano Landolfi, «D’un <strong>volgo</strong> <strong>disperso</strong> <strong>che</strong> <strong>nome</strong> <strong>non</strong> <strong>ha»</strong>. <strong>Tacito</strong>, <strong>le</strong> <strong>masse</strong>, <strong>le</strong> emozioni |175<br />
dell’ascesa al potere di Otone (hist. I 45). Non sorprende l’uniformazione<br />
comportamenta<strong>le</strong> fra senato e popolo: ipocrisia e servilismo caratterizzano l’uno e<br />
l’altro, sarcasticamente designati tramite il dimostrativo alius, <strong>che</strong>, com’è noto,<br />
predica “diversità”, 54 onde accentuare, con il rincalzo del potenzia<strong>le</strong> crederes, la<br />
metamorfosi identitaria di entrambi:<br />
Alium crederes senatum, alium populum: ruere cuncti in castra, anteire<br />
proximos, certare cum praecurrentibus, increpare Galbam, laudare militum iudicium,<br />
exosculari Othonis manum; quantoque magis falsa erant quae fiebant, tanto plura facere.<br />
Nec aspernabatur singulos Otho, avidum et minacem militum animum voce vultuque<br />
temperans.<br />
Quello stesso popolo fuggito nel momento in cui l’alfiere della coorte <strong>che</strong><br />
scortava Galba strappa dall’insegna la sua immagine, gettandola per terra (eo signo<br />
manifesta in Othonem omnium militum studia, desertum fuga populi forum I 41, 1-2), ora si<br />
precipita compatto insieme ai membri del senato nel campo pretorio, sorpassando<br />
chi è vicino, gareggiando con chi lo precede, criticando Galba, lodando la scelta<br />
del<strong>le</strong> truppe e baciando <strong>le</strong> mani di Otone. Gli infiniti storici ruere, anteire, certare,<br />
increpare, laudare, exosculari tornano a contraddistinguere la pagina tacitiana secondo<br />
un uso stilistico uniforme nel tessuto del<strong>le</strong> Historiae.<br />
Il quadro scomposto <strong>che</strong> ne sortisce omologa <strong>le</strong> opposte fasce sociali<br />
nell’acclamazione del nuovo principe e <strong>Tacito</strong> indugia a commentare la<br />
rispondenza fra l’ipocrisia dei gesti e la loro moltiplicazione (quantoque magis falsa<br />
erant quae fiebant, tanto plura facere). 55 La relativa convergenza con il ritratto disegnato<br />
da Plut. Galba 28, 1 (εὐθὺς δὲ βουλὴ συνεκαλεῖτο. Καὶ καθάπερ ἄλλοι γεγονότες ἢ<br />
θεῶν ἄλλων γεγονότων συνελθόντες ὤμνυον ὅρκον ὑπὲρ τοῦ Ὄθωνος) è garantita, a<br />
livello linguistico, dall’impiego del dimostrativo (ἄλλοι/alium), tuttavia «die<br />
Anaphora… hebt die Gesinnungslosigkeit von Senat und Volk hervor», 56 e, in<br />
effetti, senato e popolo riappariranno an<strong>che</strong> in hist. II 89, 1, condotti nel corteo<br />
imperia<strong>le</strong> di Vitellio <strong>che</strong> fa il suo ingresso a Roma (senatum et populum ante se agens), a<br />
manifestare la loro sottomissione. 57<br />
L’indistinguibilità fra comportamento senatorio e comportamento<br />
popolare, assente in Plutarco, acquista in <strong>Tacito</strong> ri<strong>le</strong>vanza primaria nel genera<strong>le</strong><br />
collasso fra <strong>le</strong> gerarchie sociali: <strong>non</strong> a caso gli infiniti storici appena ricordati sono<br />
tutti retti dal pro<strong>nome</strong> cuncti 58 <strong>che</strong>, in posizione enfatica, riferisce l’interezza dei<br />
ranghi coinvolti nel plauso smaccato ad Otone, allontanandosi dalla formula cunctus<br />
senatus populusque impiegata da Liv. IX 6, 7, dove si può cogliere ancora l’originario<br />
54 Esemplare, in tal senso, la dimostrazione di Traina, Ambiguità virgiliana: monstrum infelix<br />
(Aen. 2, 245) e alius Achil<strong>le</strong>s (Aen. 6, 89), in Id., Poeti latini (e neolatini), III, Bologna 1989, 141-151.<br />
55 Le adulazioni rivolte a Otone sono riferite an<strong>che</strong> da Suet. Otho 7, 1-2.<br />
56 Osservazione di Heraeus, Cornelii Taciti Historiarum libri qui supersunt, cit., 72.<br />
57 Non ne fa parola Suet. Vitell. 11, <strong>che</strong> parla soltanto di comites e di commilitones.<br />
58 L’etimologia diffusa in antico, pur se controversa, vo<strong>le</strong>va cuncti < da co+iuncti, come<br />
attesta Ernout - Meil<strong>le</strong>t, Dictionnaire étymologique de la langue latine, cit., 157 s.v., ma <strong>non</strong> sarà inuti<strong>le</strong><br />
ricordare come Paul. Fest 50L asserisca: cuncti significat quidem omnes, sed coniuncti et congregati (da ultimo<br />
cfr. R. Maltby, A Lexicon of Ancient Etymologies, Cambridge 2006, 165 s.v.).<br />
ὅρμος - Ricer<strong>che</strong> di Storia Antica n.s. 3-2011, pp. 163-179
Luciano Landolfi, «D’un <strong>volgo</strong> <strong>disperso</strong> <strong>che</strong> <strong>nome</strong> <strong>non</strong> <strong>ha»</strong>. <strong>Tacito</strong>, <strong>le</strong> <strong>masse</strong>, <strong>le</strong> emozioni |176<br />
senso di “rassemblé”, “dans son ensemb<strong>le</strong>” proprio dell’aggettivo/pro<strong>nome</strong> in<br />
questione.<br />
Non sempre però il popolo è gravato dal disprezzo dello storico. Dinanzi<br />
all’immoralità inveterata di Otone e all’abiezione di Vitellio <strong>non</strong> si scuotono solo<br />
gli animi di senatori e cavalieri, bensì, a quanto asserisce <strong>Tacito</strong> stesso in hist. I 50,<br />
1-2:<br />
Tum duos omnium mortalium impudicitia ignavia luxuria deterrimos velut ad perdendum<br />
imperium fataliter e<strong>le</strong>ctos <strong>non</strong> senatus modo et eques, quis aliqua pars et cura rei publicae, sed<br />
vulgus quoque palam maerere.<br />
Chiever 59 <strong>non</strong> ha sottaciuto l’aspetto sorprendente di questo capitolo dove<br />
tutti i ranghi, senza esclusione, deplorano pubblicamente la proclamazione di<br />
Vitellio. La piramide è osservata partendo dal vertice per giungere<br />
progressivamente alla base <strong>che</strong>, pur <strong>non</strong> partecipando alla gestione del<strong>le</strong> cari<strong>che</strong> e<br />
al disbrigo dei munera, è conscia della condotta ignobi<strong>le</strong> dei due personaggi: quasi un<br />
guizzo di consapevo<strong>le</strong>zza etico-politica su cui oggi formulare ipotesi sarebbe<br />
azzardato.<br />
La terna ignavia impudicitia luxuria in asindetica successione ricorda, in qual<strong>che</strong><br />
misura, la ce<strong>le</strong>bre triade sallustiana luxuria atque avaritia cum superbia di Cat. 12, 2 di cui<br />
fa <strong>le</strong> spese la gioventù romana a séguito dell’ascesa al potere di Silla. Ora, inerzia e<br />
dissolutezza, unite alla luxuria, fanno di Otone e Vitellio l’incarnazione dei peggiori<br />
fra tutti gli esseri viventi al punto <strong>che</strong> la consueta pluralità di comportamenti della<br />
massa dinanzi ai detentori del potere è sostituita da un atteggiamento univoco. Il<br />
<strong>le</strong>ttore tacitiano <strong>non</strong> è avvezzo a nulla di simi<strong>le</strong>: persino quando in I 89 lo<br />
storiografo tratterà dei piani di guerra contro Vitellio, si preoccuperà di<br />
evidenziare la gradualità della percezione da parte della p<strong>le</strong>be e del popolo dei mali<br />
derivanti dalla guerra (Sed vulgus et magnitudine nimia communium curarum expers populus<br />
sentire paulatim belli mala), rimanendo pur sempre estranei ai meccanismi troppo<br />
comp<strong>le</strong>ssi della vita politica, <strong>le</strong> communes curae.<br />
In hist. I 50 vediamo maturare invece la coscienza dell’alterità<br />
dell’imminente guerra civi<strong>le</strong> rispetto al<strong>le</strong> esperienze precedenti: Cesare,<br />
combattendo, <strong>non</strong> ha pregiudicato l’impero, così come Augusto stesso; la<br />
repubblica ha resistito sotto Pompeo e Bruto. In atto, pregare per Otone o per<br />
Vitellio suonerebbe parimenti empio, nella certezza <strong>che</strong> inter duos, quorum bello solum<br />
id scires, deteriorem fore qui vicisset (I 50, 3-4). 60 È verisimi<strong>le</strong> <strong>che</strong> <strong>Tacito</strong> stia riadattando ad<br />
un contesto ormai eticamente e politicamente declassato un dibattito di lunga data<br />
riprodotto da Seneca in Ep. XIV 13, là dove a Catone Uticense si obietta l’inutilità<br />
dell’attacco verba<strong>le</strong> a Cesare e a Pompeo, l’inutilità del suo frapporsi tra i due in<br />
armi, oltre alla sua sostanzia<strong>le</strong> estraneità alla guerra intestina, giacché dominus<br />
eligitur: quid tua, uter vincat? potest melior vincere, <strong>non</strong> potest <strong>non</strong> peior esse qui vicerit.<br />
59 Cfr. Chiever, A Historical Commentary, cit., 110.<br />
60 Sul carattere specifico di questa “sententia” rimando a B. Walker, A Study in Incoherence:<br />
Tacitus “Histories” I, «CPh» LXXI (1976), 113-118, a 117. Breve commento an<strong>che</strong> in R. Syme, <strong>Tacito</strong>,<br />
tr. it. Brescia 1967, 244.<br />
ὅρμος - Ricer<strong>che</strong> di Storia Antica n.s. 3-2011, pp. 163-179
Luciano Landolfi, «D’un <strong>volgo</strong> <strong>disperso</strong> <strong>che</strong> <strong>nome</strong> <strong>non</strong> <strong>ha»</strong>. <strong>Tacito</strong>, <strong>le</strong> <strong>masse</strong>, <strong>le</strong> emozioni |177<br />
Nel trapasso da un genere all’altro, 61 da un involucro espressivo ad un altro,<br />
la riserva ideologica <strong>non</strong> varia: di necessità, il vincitore deve essere il peggiore<br />
posto <strong>che</strong> il potere comporta, di necessità, il peggiore suo detentore. In questo<br />
teorema ferreo <strong>non</strong> ba<strong>le</strong>nano vie d’uscita. <strong>Tacito</strong> prelude così all’avvento di<br />
Vitellio, siglato da uno scontro civi<strong>le</strong> memorabi<strong>le</strong>. Intanto, dopo aver spostato il<br />
teatro degli eventi al confine renano, lo storico riprenderà a trattare dei fatti<br />
verificatisi a Roma a partire dal cap. 80 dove un incidente apparentemente<br />
irri<strong>le</strong>vante dà vita a una rivolta <strong>che</strong> per poco <strong>non</strong> fa precipitare la città nel disastro:<br />
il richiamo della diciassettesima coorte da Ostia nell’Urbe, equipaggiata di notte<br />
per mettersi in marcia, desta sospetti di tradimento e getta nello scompiglio <strong>le</strong><br />
truppe <strong>che</strong>, ucciso il tribuno dei pretoriani Vario Crispino, si dirigono a cavallo<br />
verso il Palazzo imperia<strong>le</strong>. Il convito in corso (cap. 81) viene interrotto in un clima<br />
di paura e di sospetto, finché i soldati <strong>non</strong> ottengono di incontrare Otone il qua<strong>le</strong>,<br />
salito contro la dignità del proprio rango su un triclinio, fra preghiere e lacrime<br />
riesce a stento a frenarli e a rinviarli al campo. La descrizione seguente assimila<br />
Roma ad una città conquistata, dall’aspetto spettra<strong>le</strong>, con <strong>le</strong> porte sbarrate, <strong>le</strong><br />
strade quasi deserte, la p<strong>le</strong>be mesta (hist. I 82, 2):<br />
Postera die velut capta urbe clausae domus, rarus per vias populus, maesta p<strong>le</strong>bs.<br />
L’aggettivazione, enfaticamente, precede i tre soggetti dell’intero periodo,<br />
strutturato in altrettante sovraordinate ellitti<strong>che</strong> di copula: clausae, rarus, maesta, <strong>le</strong><br />
tre designazioni participiali/aggettivali, scandiscono i tempi del percorso compiuto<br />
dall’obiettivo dello storico. L’Urbe, nel suo profilo fantomatico, appare una “<strong>non</strong>città”<br />
secondo uno stereotipo caro alla storiografia tragica, abituata a insistere<br />
sull’assenza apparente o rea<strong>le</strong> di forme di vita nel tratteggio del<strong>le</strong> urbes captae. In tal<br />
senso i precedenti abbondano tra Grecia e Roma, tuttavia il confronto più<br />
pertinente rimane quello offerto da Liv. XXIII 25, 1 con il quadro del<strong>le</strong> reazioni<br />
alla notizia della disfatta di Postumio in Gallia (hac nuntiata clade cum per dies multos in<br />
tanto pavore fuisset ciuitas ut tabernis clausis velut nocturna solitudine per urbem acta senatus aedilibus<br />
negotium daret ut urbem circumirent aperirique tabernas et maestitiae publicae speciem urbi demi<br />
iuberent) dove domina l’immagine del deserto cittadino e dell’afflizione pubblica, se<br />
<strong>non</strong> quello reperibi<strong>le</strong> in Iustin. XIX 2, 8-9 (<strong>non</strong> secus ac si urbs capta esset, maesta civitas<br />
fuit… clausae privatae domus).<br />
In pochissime battute, <strong>Tacito</strong> disegna quasi i contorni di una “città<br />
invisibi<strong>le</strong>”, con gli spazi privati sprangati e quelli pubblici animati da sparute<br />
presente. Ai cenni fisici della spettralità si aggiunge il cenno allo stato d’animo in<br />
cui versa la p<strong>le</strong>be, la mestizia. L’essenzialità <strong>non</strong> toglie intensità al quadro, anzi<br />
sembra potenziarne l’iconicità emb<strong>le</strong>matica.<br />
Ciò in controtendenza con l’ultimo ritratto della p<strong>le</strong>be contenuto nel<br />
primo libro del<strong>le</strong> Historiae (I 90, 2-3), dove essa obbedisce nuovamente alla logica<br />
del servilismo e dell’adulazione al Cesare di turno:<br />
61 In materia da più parti si è richiamato a riscontro il brano di Luc. II 60 ss.<br />
ὅρμος - Ricer<strong>che</strong> di Storia Antica n.s. 3-2011, pp. 163-179
Luciano Landolfi, «D’un <strong>volgo</strong> <strong>disperso</strong> <strong>che</strong> <strong>nome</strong> <strong>non</strong> <strong>ha»</strong>. <strong>Tacito</strong>, <strong>le</strong> <strong>masse</strong>, <strong>le</strong> emozioni |178<br />
Clamor vocesque vulgi ex more adulandi nimiae et falsae: quasi dictatorem Caesarem aut<br />
imperatorem Augustum prosequerentur, ita studiis votisque certabant, nec metu aut amore,<br />
sed ex libidine servitii: ut in familiis, privata cuique stimulatio, et vi<strong>le</strong> iam decus publicum.<br />
Ritorna, anularmente, l’accostamento fra <strong>volgo</strong> e schiavi prospettato in hist.<br />
I 32, con una forte sottolineatura della libido servitii <strong>che</strong> affligge i ranghi più bassi<br />
della società. Non sono sentimenti antitetici a muovere il favore o il disfavore della<br />
p<strong>le</strong>baglia, bensì il mos adulandi <strong>che</strong> spinge a salutare Otone come se si trattasse di<br />
Giulio Cesare o di Augusto. Il sarcastico accostamento ai due esponenti di spicco<br />
della gens Iulia rende parossistico l’omaggio al principe da poco salito al trono, ma<br />
proprio l’assimilazione della marmaglia agli schiavi <strong>le</strong>gittima la stoccata fina<strong>le</strong> dello<br />
storico <strong>che</strong> equipara i comportamenti della prima a quelli dei secondi. Come<br />
avviene fra schiavi, spinto dall’interesse persona<strong>le</strong> e incurante del pubblico decoro<br />
il vulgus ossequia Otone facendo a gara nel<strong>le</strong> dimostrazioni di plauso. Non solo<br />
inesperto di affari politici, ma sostanzialmente disinteressato e privo di scrupoli, il<br />
vulgus dà prova della tota<strong>le</strong> assenza di valori etici da cui è afflitto.<br />
Nulla di più lontano dal<strong>le</strong> recriminazioni dell’autore dell’Octavia, il qua<strong>le</strong> ai<br />
vv. 676-682, 62 per bocca del coro, rievoca la condotta del popolo di un tempo,<br />
capace di rintuzzare condottieri funesti, dar <strong>le</strong>ggi alla patria, fasci ai cittadini degni,<br />
di imporre la guerra e la pace, di domare popoli feroci, di catturare e imprigionare<br />
re nemici:<br />
Vbi Romani vis est populi,<br />
fregit diros quae saepe duces,<br />
dedit invictae <strong>le</strong>ges patriae,<br />
fasces dignis civibus olim,<br />
iussit bellum pacemque, feras<br />
gentes domuit,<br />
captos reges carcere clausit?<br />
Di questo popolo coeso e vigoroso per <strong>Tacito</strong> resta solo una pars… integra<br />
(hist. I 4, 12), ben poco rispetto al passato, dal momento <strong>che</strong>, come <strong>non</strong> si è<br />
mancato di osservare, «il popolo s’è mutato in folla», 63 o, per essere meno generici,<br />
la più parte di esso ormai è folla. «Questa p<strong>le</strong>be <strong>non</strong> si preoccupa più degli<br />
avvenimenti se <strong>non</strong> nella misura in cui vengono a rendere più attraenti i suoi<br />
piaceri; <strong>non</strong> partecipa più alla condotta degli affari, gode soltanto dei loro<br />
risultati». Constatazione, questa di Mi<strong>che</strong>l, 64 condivisibi<strong>le</strong> nella sostanza e capace di<br />
spiegare come per lo storico la separazione dai negotia e dalla politica abbia<br />
trasformato una componente basilare del corpo socia<strong>le</strong> in una congerie amorfa,<br />
preoccupata dei bisogni e dei tornaconti personali, aliena dalla preoccupazione<br />
dell’interesse comune, pronta a seguire gli utili estemporanei, i <strong>le</strong>aders<br />
62 Una <strong>le</strong>ttura efficace di questo brano in A. La Penna, Palazzo, coro e popolo nella tragedia antica e<br />
nella tragedia umanistica, in Id. Tersite censurato e altri studi di <strong>le</strong>tteratura fra antico e moderno, Pisa 1991, 37-67, a<br />
40-41.<br />
63 Notazione di A. Mi<strong>che</strong>l, <strong>Tacito</strong> e il destino dell’impero, tr. it. Torino 1973, 207.<br />
64 Vd. Mi<strong>che</strong>l, <strong>Tacito</strong> e il destino dell’impero, cit., 211.<br />
ὅρμος - Ricer<strong>che</strong> di Storia Antica n.s. 3-2011, pp. 163-179
Luciano Landolfi, «D’un <strong>volgo</strong> <strong>disperso</strong> <strong>che</strong> <strong>nome</strong> <strong>non</strong> <strong>ha»</strong>. <strong>Tacito</strong>, <strong>le</strong> <strong>masse</strong>, <strong>le</strong> emozioni |179<br />
estemporanei. In assenza di manifestazioni <strong>che</strong> riasseriscano l’antica dignità e la<br />
pugnacità popolare, la cartografia del<strong>le</strong> emozioni di massa risulta, pur<br />
nell’umoralità <strong>che</strong> la contrassegna, abbastanza ripetitiva. Inquietudine, incertezza,<br />
inclinazione ai facili entusiasmi e ai facili mutamenti di orientamento politico,<br />
servilismo, adulazione: ecco, in sintesi, <strong>le</strong> peculiarità di un ammasso socia<strong>le</strong><br />
ingovernabi<strong>le</strong> <strong>che</strong> scredita l’immagine di Roma, <strong>che</strong> mina al<strong>le</strong> basi la coesione<br />
dell’Impero.<br />
ὅρμος - Ricer<strong>che</strong> di Storia Antica n.s. 3-2011, pp. 163-179<br />
Luciano Landolfi<br />
Università degli Studi di Pa<strong>le</strong>rmo<br />
Facoltà di Lettere e Filosofia<br />
Dipartimento di Scienze<br />
Filologi<strong>che</strong> e Linguisti<strong>che</strong><br />
Via<strong>le</strong> del<strong>le</strong> Scienze - Ed.12<br />
90128 Pa<strong>le</strong>rmo<br />
luciano.landolfi@unipa.it<br />
on line dal 12 novembre 2012