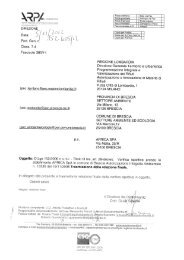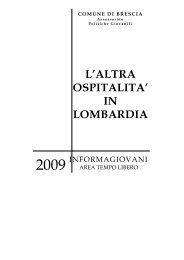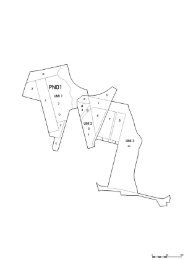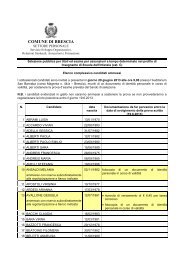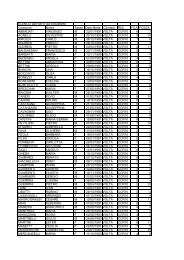scarica il file del libro 30 anni di partecipazione - Comune di Brescia
scarica il file del libro 30 anni di partecipazione - Comune di Brescia
scarica il file del libro 30 anni di partecipazione - Comune di Brescia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
In copertina:<br />
uno scorcio tipico <strong>del</strong> quartiere <strong>di</strong> San Bartolomeo con mulino e roggia<br />
(Archivio Stu<strong>di</strong>o Architetto Lucio Serino)<br />
2
Lisa Cesco Diego Serino<br />
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE<br />
l’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
CIRCOSCRIZIONE NORD<br />
3
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
L’Assessorato alla Partecipazione e Decentramento <strong>del</strong> <strong>Comune</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> ha ritenuto opportuno promuovere una<br />
pubblicazione che ripercorra la storia <strong>del</strong> decentramento<br />
amministrativo nella nostra città, dalle origini fino alla recente<br />
riforma che ne <strong>di</strong>segna una nuova identità formale<br />
e sostanziale, in occasione <strong>del</strong> trentennale <strong>di</strong> fondazione<br />
<strong>del</strong>le Circoscrizioni in forma istituzionale.<br />
I testi presenteranno in forma monografica, snella ed essenziale,<br />
le cinque attuali circoscrizioni <strong>del</strong> sistema decentrato<br />
bresciano, r<strong>il</strong>evando come le stesse abbiamo piano piano preso corpo da una spinta<br />
nata dal basso, dall’esigenza spontanea dei citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> quartiere <strong>di</strong> aggregarsi in Comitati<br />
per con<strong>di</strong>videre un’esperienza <strong>di</strong> <strong>partecipazione</strong> nella vita degli stessi quartieri, nella connotazione<br />
urbanistica e nelle iniziative sociali e aggregative. Il racconto vuole quin<strong>di</strong> anche<br />
ripercorrere l’esperienza dei primi consigli <strong>di</strong> quartiere e <strong>del</strong>le persone che ne sono state<br />
fautrici e protagoniste, riportando la testimonianza dei singoli soggetti che hanno vissuto e<br />
determinato l’esperienza <strong>del</strong>la <strong>partecipazione</strong> attiva e spontanea <strong>di</strong> quegli <strong>anni</strong>.<br />
Il quadro sulle circoscrizioni si completa in un alternarsi fra storia politica dei consigli circoscrizionali,<br />
che comprende anche la menzione dei Presidenti, con un loro prof<strong>il</strong>o biografico<br />
e <strong>il</strong> resoconto <strong>del</strong>la loro esperienza amministrativa, e una breve storia <strong>del</strong> territorio, dei<br />
quartieri e <strong>del</strong>la loro trasformazione urbanistica e sociale, nell’elencazione dei luoghi <strong>di</strong><br />
rappresentanza storica e <strong>di</strong> aggregazione sociale, testimonianza <strong>di</strong> lente trasformazioni e<br />
graduali cambiamenti che ne hanno determinato l’attuale assetto.<br />
La recente riforma, che ha ri<strong>di</strong>segnato i confini circoscrizionali, ha portato come conseguenza<br />
l’avvio <strong>di</strong> un ripensamento complessivo sul significato <strong>del</strong> decentramento, configurandosi<br />
la circoscrizione sempre più come ente territoriale multifunzionale, luogo <strong>di</strong><br />
rappresentanza e consultazione dei quartieri, ma anche luogo <strong>di</strong> erogazione <strong>di</strong> servizi.<br />
Sentiti ringraziamenti vanno a tutti coloro che hanno collaborato all’elaborazione <strong>di</strong> questo<br />
breve trattato storico sulle circoscrizioni, in particolare agli autori che nei mesi scorsi<br />
hanno effettuato un importante lavoro <strong>di</strong> ricerca sulla nascita, la crescita, la trasformazione<br />
e l’evoluzione nel tempo <strong>del</strong> decentramento e <strong>del</strong>la <strong>partecipazione</strong> a <strong>Brescia</strong>.<br />
Il Vicesindaco<br />
Assessore alla Partecipazione e Decentramento<br />
Fabio RolFi<br />
4
I SALUTI<br />
La lunga storia <strong>del</strong>la <strong>partecipazione</strong> sul territorio <strong>del</strong>la<br />
Circoscrizione Nord rappresenta un percorso affascinante<br />
fatto <strong>di</strong> prove, successi, qualche sconfitta e tanto entusiasmo.<br />
Una storia che si snoda dalle prime esperienze nei quartieri,<br />
risalenti agli <strong>anni</strong> Sessanta, alla nascita <strong>del</strong>le Circoscrizioni<br />
Prima e Seconda, destinate ad essere unite<br />
nella Circoscrizione Nord con la riforma comunale <strong>del</strong><br />
decentramento approvata nel 2007.<br />
Il messaggio <strong>di</strong> <strong>partecipazione</strong> custo<strong>di</strong>to in quella storia e raccolto nelle pagine <strong>di</strong> questa<br />
pubblicazione è ancora attuale, perché esprime le ra<strong>di</strong>ci più autentiche <strong>del</strong>la nostra comunità,<br />
<strong>il</strong> volto più vero dei quartieri <strong>di</strong> Sant’Eustacchio, Borgo Trento, San Bartolomeo,<br />
Mompiano, Casazza, V<strong>il</strong>laggio Prealpino e San Rocchino-Costalunga che compongono <strong>il</strong><br />
perimetro <strong>del</strong>la Circoscrizione Nord, e che vengono qui raccontati attraverso la loro storia<br />
nel corso dei secoli, le bellezze artistiche nascoste fra le vie e le piazze, i passaggi amministrativi<br />
più salienti che li hanno interessati e i progressivi sno<strong>di</strong> <strong>del</strong> decentramento.<br />
Ripercorrere queste vicende significa trarne una lezione importante <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>nanza attiva,<br />
<strong>di</strong> prossimità, <strong>di</strong> responsab<strong>il</strong>ità <strong>di</strong> tutti rivolta al bene comune, principi che lungi da<br />
essere qualcosa <strong>di</strong> astratto, ricoprono un ruolo chiave per assicurare la qualità <strong>di</strong> vita<br />
nei nostri quartieri, e vanno pertanto coltivati e <strong>di</strong>vulgati, come ci insegnano i “pionieri”<br />
che raccontano in queste pagine le loro prime esperienze <strong>di</strong> <strong>partecipazione</strong> dal basso,<br />
quando ancora le Circoscrizioni non esistevano.<br />
Il trentennale <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong> <strong>di</strong>venta così occasione per riannodare i f<strong>il</strong>i <strong>del</strong><br />
passato con <strong>il</strong> presente, riflettendo sulla complessa tematica <strong>del</strong> decentramento in una<br />
prospettiva <strong>di</strong> ampio respiro, con <strong>il</strong> contributo <strong>del</strong>le sensib<strong>il</strong>ità e degli approcci maturati<br />
nei singoli quartieri.<br />
5<br />
Il Presidente<br />
<strong>del</strong>la Circoscrizione Nord<br />
MaRco RoSSi
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
Mappa <strong>del</strong>le Circoscrizioni <strong>del</strong>la città <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong><br />
23<br />
5<br />
CIRCOSCRIZIONE OVEST<br />
25<br />
20<br />
7<br />
26<br />
CIRCOSCRIZIONE SUD<br />
9<br />
24<br />
21<br />
3<br />
6<br />
8<br />
28<br />
10<br />
27<br />
4<br />
17<br />
2<br />
6<br />
22<br />
1<br />
<strong>30</strong><br />
12<br />
15<br />
11<br />
CIRCOSCRIZIONE NORD<br />
19<br />
29<br />
14<br />
CIRCOSCRIZIONE CENTRO<br />
CIRCOSCRIZIONE EST<br />
CIRCOSCRIZIONE NORD<br />
2 Borgo Trento - 11 Mompiano - 15 V<strong>il</strong>laggio Prealpino - 17 San Bartolomeo<br />
22 Casazza - 28 Sant’Eustacchio - 29 San Rocchino-Costalunga<br />
CIRCOSCRIZIONE<br />
CENTRO<br />
1 - <strong>Brescia</strong> Antica<br />
3 - Porta M<strong>il</strong>ano<br />
4 - Centro Storico Nord<br />
14 - Porta Venezia<br />
27 - Centro Storico Sud<br />
<strong>30</strong> - Crocifissa <strong>di</strong> Rosa<br />
CIRCOSCRIZIONE<br />
OVEST<br />
5 - Chiusure<br />
7 - Fiumicello<br />
21 - Urago Mella<br />
23 - V<strong>il</strong>laggio Ba<strong>di</strong>a<br />
25 - V<strong>il</strong>laggio Violino<br />
26 - Primo Maggio<br />
CIRCOSCRIZIONE<br />
SUD<br />
6 - Don Bosco<br />
8 - Folzano<br />
9 - Fornaci<br />
10 - Lamarmora<br />
12 - Porta Cremona<br />
20 - Chiesanuova<br />
24 - V<strong>il</strong>laggio Sereno<br />
18<br />
13<br />
16<br />
CIRCOSCRIZIONE<br />
EST<br />
19 - San Polo - Sanpolino<br />
13 - Bettole - Buffalora<br />
18 - Sant’Eufemia<br />
16 - Caionvico
Introduzione<br />
INTRODUZIONE<br />
La ciRcoScRizione noRd è la terza circoscrizione più popolosa <strong>del</strong>la<br />
città, dopo la Sud e la Centro (che presenta una densità abitativa pressoché<br />
analoga alla Nord).<br />
Comprende i quartieri:<br />
• Borgo Trento<br />
• San Bartolomeo<br />
• Casazza<br />
• Sant’Eustacchio<br />
• Mompiano<br />
• V<strong>il</strong>laggio Prealpino<br />
• San Rocchino - Costalunga<br />
E’ abitata da 41.770 residenti, con una leggera prevalenza <strong>del</strong>le donne – che<br />
sono oltre 22 m<strong>il</strong>a – sugli uomini, che ammontano a più <strong>di</strong> 19 m<strong>il</strong>a.<br />
I quartieri più popolosi sono Sant’Eustacchio (8.500 abitanti), Mompiano<br />
(7.700) e Borgo Trento (7.000), <strong>il</strong> meno densamente popolato è Casazza, con<br />
2.900 residenti.<br />
In<strong>di</strong>rizzo Sede Circoscrizione NORD:<br />
Via Monte Grappa, 37 - Succursale Via Colle <strong>di</strong> Ca<strong>di</strong>bona, 5 (aperta solo su appuntamento per ricevimento citta<strong>di</strong>ni)<br />
Orario apertura sede: da lunedì a giovedì dalle 9,<strong>30</strong> alle 12,15 e dalle 14,00 alle 15,45; venerdì dalle 9,<strong>30</strong> alle 12,15<br />
Telefono Sede 0<strong>30</strong>/3384560 - Succursale 0<strong>30</strong>/2099077<br />
Fax Sede 0<strong>30</strong>/3388000 - Succursale 0<strong>30</strong>/2009398<br />
E-ma<strong>il</strong> circoscrizionenord@comune.brescia.it<br />
7
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
Primi inse<strong>di</strong>amenti abitativi nell’area <strong>di</strong> via Veneto 8<br />
Per concessione dei Civici Musei d’Arte e Storia <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>
1. I QUARTIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE NORD<br />
Capitolo 1<br />
I quartieri <strong>del</strong>la Circoscrizione Nord<br />
San baRToloMeo e SanT’eUSTaccHio<br />
San Bartolomeo è oggi un quartiere <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>, non esattamente perimetrato, che<br />
si trova a quattro ch<strong>il</strong>ometri e mezzo dal centro citta<strong>di</strong>no, all’imbocco <strong>del</strong>la Valtrompia,<br />
limitato a nord dai territori <strong>di</strong> Concesio e Bovezzo, a ovest dal fiume<br />
Mella, a est dal torrente Garza ed a sud da via Guglielmo Oberdan.<br />
In realtà questo territorio è stato un comune autonomo sino al 1881 quando<br />
venne annesso, nonostante l’opposizione <strong>di</strong> molti suoi citta<strong>di</strong>ni, al <strong>Comune</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>Brescia</strong> nel quadro <strong>di</strong> aggregazione <strong>di</strong> cinque comuni limitrofi (S. Nazzaro Mella,<br />
S. Alessandro, Fiumicello-Urago, S. Bartolomeo e Mompiano) a quello <strong>del</strong> capoluogo,<br />
ancora limitato dalla cinta muraria.<br />
In passato <strong>il</strong> suo perimetro era molto più esteso <strong>di</strong> quello che attualmente porta <strong>il</strong><br />
suo nome: ossia tutta la zona che va dalla Stocchetta, comprendendone anche la<br />
parte più meri<strong>di</strong>onale e conglobando Borgo Trento, S. Eustacchio e Campo Marte,<br />
fino a Porta P<strong>il</strong>e, la porta nord <strong>del</strong>la città.<br />
La zona era caratterizzata dall’amplia <strong>di</strong>sponib<strong>il</strong>ità <strong>di</strong> acqua, grazie alla presenza<br />
<strong>di</strong> due canali artificiali, <strong>il</strong> Bova ed <strong>il</strong> Grande, ricavati dal Mella, ai quali deve essere<br />
aggiunto <strong>il</strong> Celato, molto più antico, notevolmente spostato più ad est, nella zona<br />
<strong>di</strong> Mompiano, per completare questo importante trio <strong>di</strong> corso artificiali che tanto<br />
caratterizzò la nostra città dal punto <strong>di</strong> vista economico, urbanistico e sociale.<br />
Attualmente, invece, questi fiumi hanno perso <strong>il</strong> loro antico splendore e sono<br />
ridotti a canali sporchi ed inquinati dagli scarichi <strong>del</strong>le fabbriche: la qual cosa fa<br />
specie, soprattutto, se se pensa che fino alla prima metà <strong>del</strong> Novecento i sindaci<br />
dovevano regolare i bagni nel fiume Bova, dove i ragazzi si tuffavano e nel quale<br />
persero la vita due giovani fratelli, figli <strong>del</strong> mugnaio Scanzi, che vi annegarono nel<br />
giugno <strong>del</strong> 1931, come è riportato da un quoti<strong>di</strong>ano <strong>di</strong> quel periodo.<br />
I cambiamenti nel tempo, in realtà, hanno inciso su tutto <strong>il</strong> quartiere, come <strong>di</strong>mostra<br />
la fusione dei segni <strong>del</strong>le varie epoche e, così, in mezzo ad e<strong>di</strong>fici relativamente<br />
moderni, come <strong>il</strong> v<strong>il</strong>laggio Iacp, costruito nel 1957, per gli esuli dalmata,<br />
9
Archivio Serino<br />
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
<strong>il</strong> complesso condominiale le Querce o la nuova chiesa, cercano <strong>di</strong> sopravvivere i<br />
simboli <strong>del</strong> passato che questo ultimo secolo ha provato <strong>di</strong> inghiottire prepotentemente.<br />
Così resistono l’antico chiostro, parte <strong>del</strong> fabbricato <strong>del</strong>l’ex lazzaretto<br />
quattrocentesco, la chiesa <strong>del</strong> Settecento, le varie v<strong>il</strong>le padronali <strong>del</strong> XVIII secolo<br />
ed i vecchi caseggiati con i resti <strong>del</strong>le pale idrauliche in via Ferrini, alle Mole ed<br />
alle Gabbiane.<br />
Dell’antico borgo campagnolo che doveva apparire agli occhi <strong>di</strong> chi vi arrivava<br />
a metà <strong>del</strong> secolo scorso, ormai, è rimasto ben poco, salvo pochi appezzamenti<br />
coltivati ad orti e frutteti, ed <strong>il</strong> paesaggio attuale è quello <strong>di</strong> un anonimo quartiere<br />
citta<strong>di</strong>no.<br />
Nel raccontare la storia <strong>di</strong> San Bartolomeo è possib<strong>il</strong>e, ad<strong>di</strong>rittura, partire dal periodo<br />
romano quando <strong>il</strong> territorio era attraversato da una strada che giungeva<br />
sino alla Valtrompia e, pare, anche da un acquedotto.<br />
L’officina <strong>del</strong> maglio nel museo <strong>del</strong> ferro <strong>di</strong> San Bartolomeo<br />
10
1. I QUARTIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE NORD<br />
La serie <strong>di</strong> ritrovamenti fatta tra l’Ottocento ed <strong>il</strong> Novecento, confermano l’esistenza<br />
<strong>di</strong> un antico vicus romano: nella chiesa <strong>del</strong> Lazzaretto, in quella <strong>di</strong> San<br />
Bartolomeo nella zona nord ed in alcuni terreni agricoli vennero scoperti una serie<br />
<strong>di</strong> reperti funerari risalenti a quell’epoca.<br />
Con la caduta <strong>del</strong>l’impero romano si susseguirono numerose invasioni barbariche<br />
e si dovette aspettare <strong>il</strong> VI secolo, con l’arrivo dei Longobar<strong>di</strong>, perché la nostra<br />
provincia in generale potesse vivere un periodo <strong>di</strong> relativa tranqu<strong>il</strong>lità.<br />
Anche a San Bartolomeo, seppur non permangono segni evidenti come <strong>il</strong> convento<br />
<strong>di</strong> San Salvatore in città, sono rimaste testimonianza <strong>del</strong>la loro presenza,<br />
come le armi, rinvenute nei terreni <strong>del</strong> conte Vallotti, all’inizio <strong>del</strong> Novecento, che<br />
vennero donate ai civici Musei <strong>del</strong> conte Teodoro Lechi.<br />
La tranqu<strong>il</strong>lità <strong>di</strong> questo periodo consentì alla popolazione <strong>di</strong> de<strong>di</strong>carsi al lavoro<br />
agricolo ed alla caccia, prime attività economiche locali.<br />
Successivamente i territori <strong>di</strong> San Bartolomeo passarono sotto la proprietà <strong>del</strong><br />
vescovo <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> <strong>di</strong>venendo, per lo più, zona <strong>di</strong> caccia, come si nota, tra l’atro,<br />
<strong>del</strong>l’etimologia dei nomi <strong>di</strong> alcune vie circostanti come Cazi o Cacciadenno.<br />
Nel IX secolo, grazie ad una donazione <strong>di</strong> questi territori dal vescovo Ramperto<br />
al monastero benedettino <strong>di</strong> San Faustino, alcuni monaci benedettini vi si trasferirono<br />
de<strong>di</strong>candosi alla coltivazione <strong>di</strong> vigne, ortaglie e campi circondati da siepi,<br />
i “cìos” in <strong>di</strong>aletto, da cui proviene <strong>il</strong> nome Chiusure riferito a tutto <strong>il</strong> suburbio e<br />
quello <strong>di</strong> tutta la zona denominata San Bartolomeo in Clausuris.<br />
La presenza dei monaci fu fondamentale per <strong>di</strong>versi secoli, non solo in relazione<br />
alla bonifica dei terreni ma, soprattutto, come punto <strong>di</strong> riferimento essenziale<br />
per l’assistenza religiosa <strong>del</strong>la popolazione. In pochi secoli, infatti, l’incremento<br />
demografico era stato notevole ed alle poche catapecchie sparse qua e là nella<br />
boscaglia, si erano aggiunte v<strong>il</strong>le padronali e, anche, nuove cappelle come quella<br />
<strong>di</strong> S. Donino e quella <strong>di</strong> S. Eustacchio.<br />
Proprio sulla cappella <strong>di</strong> S.Eustacchio, de<strong>di</strong>cata al patrono dei cacciatori, vi sono<br />
riferimenti che segnalano la presenza <strong>di</strong> un monastero a partire almeno dal 1387.<br />
Nel 1466 <strong>il</strong> vescovo Domenico de Dominicis, letterato ed umanista, costruì, proprio<br />
a S.Eustacchio, una v<strong>il</strong>la per ospitarvi amici ed artisti e ricostruì anche la chiesa.<br />
Parlando <strong>di</strong> questa zona si ricorda, anche, un luogo benedetto da San Carlo<br />
Borromeo mentre agli inizi <strong>del</strong> ‘700, un altro vescovo Gian Francesco Barbarigo, vi<br />
costruiva un’altra v<strong>il</strong>la vescov<strong>il</strong>e, con un nuovo pa<strong>di</strong>glione ed un e<strong>di</strong>ficio in grado<br />
11
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
<strong>di</strong> ospitare anche le riunioni <strong>del</strong>l’Accademia Cenomana <strong>del</strong>l’Arca<strong>di</strong>a.<br />
Nel 1751 <strong>il</strong> car<strong>di</strong>nale Angiolo Maria Querini trasformò ed ampliò nuovamente<br />
<strong>il</strong> palazzo destinandolo a sede <strong>del</strong> consiglio ecclesiastico, una sorta <strong>di</strong> università<br />
all’interno <strong>del</strong>la quale insegnarono numerose ed importanti personalità <strong>del</strong><br />
mondo ecclesiastico bresciano, ma nel 1789 <strong>il</strong> palazzo veniva abbattuto dai giacobini<br />
bresciani avversi al vescovo, mentre la chiesa e l’area circostante vennero<br />
confiscati con tutti i beni <strong>del</strong>la mensa vescov<strong>il</strong>e. La chiesetta restò a servizio <strong>del</strong>la<br />
sparuta popolazione <strong>del</strong>la zona <strong>di</strong> S. Eustacchio che, verso la fine <strong>del</strong>l’Ottocento,<br />
<strong>di</strong>venne luogo per la costruzione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici industriali e case popolari.<br />
Significativa, nella storia <strong>di</strong> San Bartolomeo, fu anche la presenza dei canonici<br />
regolari agostiniani, che esercitarono <strong>il</strong> loro priorato sulla chiesetta <strong>di</strong> San Bartolomeo<br />
in Clausuris, <strong>di</strong> cui si ha memoria sin dal 1299.<br />
Gli agostiniani erano, in realtà, una piccola comunità <strong>di</strong> eremiti che viveva isolata<br />
occupandosi <strong>del</strong>la coltivazione <strong>del</strong>le terre, pregando e stu<strong>di</strong>ando. Si ipotizza,<br />
inoltre che tale comunità si de<strong>di</strong>casse, proprio nel me<strong>di</strong>oevo, all’assistenza agli<br />
appestati e che, quin<strong>di</strong>, presso <strong>di</strong> essi esistesse già un ospedale per gli infetti<br />
precursore <strong>del</strong> Lazzaretto che verrà e<strong>di</strong>ficato successivamente.<br />
Anche <strong>il</strong> nome <strong>del</strong> quartiere, San Bartolomeo, santo piagato e scorticato vivo ed<br />
invocato contro malattie <strong>del</strong>la pelle, pest<strong>il</strong>enze ed epidemie, andrebbe a conferma<br />
<strong>di</strong> questa tesi.<br />
Nel 1275 <strong>di</strong>veniva Vescovo e principe <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> Berardo Maggi, personaggio fondamentale<br />
per la storia <strong>del</strong>la nostra città e legato a San Bartolomeo sia dalla<br />
stretta amicizia con <strong>il</strong> suo vicario vescov<strong>il</strong>e Cazzaino de Margotti, sia per gli scavi<br />
voluti fortemente dal Vescovo dei canali Grande e Bova che, influiranno non poco<br />
nell’economia <strong>del</strong>la città ed in quella <strong>di</strong> San Bartolomeo: la popolazione, infatti,<br />
cominciò ad ut<strong>il</strong>izzare i corsi d’acqua per mettere in moto i mulini, i magli, le segherie,<br />
i f<strong>il</strong>atoi per seta, le concerie e le polveriere sfruttando la tecnologia <strong>del</strong>la<br />
ruota idraulica già <strong>di</strong>ffusa, nel XII secolo, in tutta Europa.<br />
La storia <strong>di</strong> San Bartolomeo dei secoli successivi, in particolare dal Quattrocento<br />
al Seicento, è legata alla presenza <strong>del</strong> Lazzaretto, <strong>del</strong>l’esistenza <strong>del</strong> quale si hanno<br />
documentazioni sicure a partire dal XV secolo, quando <strong>il</strong> <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> decise<br />
<strong>di</strong> aprire <strong>il</strong> lazzaretto civico proprio in questa zona, ritenuta più idonea <strong>di</strong> Mompiano<br />
e Costalunga, in quanto già vantava una tra<strong>di</strong>zione in questo senso.<br />
Dal 1428 gli appestati furono inviati con regolarità all’interno <strong>del</strong> Lazzaretto, no-<br />
12
1. I QUARTIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE NORD<br />
nostante questo fosse ancora<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni limitate, in quanto<br />
confinato nel antico priorato<br />
degli agostiniani e costituito<br />
solamente da poche capanne,<br />
baracche e tettoie. Solamente<br />
nel primo <strong>anni</strong> vi morirono almeno<br />
trem<strong>il</strong>a persone colpite<br />
dalle più <strong>di</strong>versificate malattie<br />
infettive, chiamate dalle cronache<br />
<strong>del</strong> tempo tutte alla stessa<br />
maniera: “peste”.<br />
La peste fu <strong>il</strong> male <strong>del</strong>l’epoca e<br />
San Bartolomeo, suo malgrado,<br />
fece da sfondo alla sofferenza<br />
<strong>di</strong> migliaia <strong>di</strong> persone che per<br />
tutto <strong>il</strong> quattrocento vi furono<br />
ospitate con continuità.<br />
Nell’ultimo ventennio <strong>del</strong> secolo<br />
<strong>il</strong> <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> si<br />
preoccupò <strong>di</strong> rinnovare <strong>il</strong> Lazzaretto<br />
sia dal punto <strong>di</strong> vista<br />
strutturale che organizzativo:<br />
Una tipica roggia <strong>di</strong> San Bartolomeo<br />
nel 1482 si <strong>di</strong>ede via ai lavori<br />
con la costruzione <strong>di</strong> un nuovo<br />
e<strong>di</strong>ficio quadr<strong>il</strong>atero a due piani con portici, corsie, logge ed un amplio cort<strong>il</strong>e <strong>di</strong><br />
cui probab<strong>il</strong>mente si occupò l’ingegner Tonino da Lumezzane.<br />
Dal punto <strong>di</strong> vista organizzativo la gestione <strong>del</strong>l’ospedale passò nelle mani dei<br />
frati carmelitani.<br />
Nel 1512 <strong>Brescia</strong> insorse al domino francese che dominava la città dal 1509 e la<br />
reazioni <strong>del</strong>le truppe transalpine guidate da Guglielmo <strong>di</strong> Foix fu terrib<strong>il</strong>e: la città<br />
venne devastata e depredata <strong>di</strong> ogni ricchezza, i suoi citta<strong>di</strong>ni massacrati, torturati<br />
e violentati in tal modo da suscitare sconcerto ed in<strong>di</strong>gnazione nel resto d’Europa.<br />
Lo stesso Lazzaretto venne depredato e le sue suppellett<strong>il</strong>i vendute a M<strong>il</strong>ano.<br />
13<br />
Archivio Serino
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
Il Lazzaretto, comunque, proseguì nella sua attività per tutto <strong>il</strong> cinquecento sino<br />
al 16<strong>30</strong>, quando la terrib<strong>il</strong>e pest<strong>il</strong>enza, quella nota con <strong>il</strong> nome “<strong>del</strong> Manzoni”<br />
proprio perché è in quel periodo che sono ambientati i Promessi Sposi, fu l’ultima<br />
che si registrò in città, se si eccettua <strong>il</strong> colera <strong>del</strong> 1836 per <strong>il</strong> quale, tuttavia, venne<br />
ut<strong>il</strong>izzato <strong>il</strong> Civ<strong>il</strong>e. Con <strong>il</strong> settecento <strong>il</strong> Lazzaretto cadde gradualmente in <strong>di</strong>suso,<br />
affittato ai conta<strong>di</strong>ni e poi progressivamente abbandonato <strong>di</strong>venendo rifugio <strong>di</strong><br />
senzatetto, tanto che, nel 1864, lo stab<strong>il</strong>e venne abbattuto per circa tre quarti<br />
mentre la parte restante sarà protagonista nel 1888 <strong>di</strong> un intervento <strong>di</strong> riut<strong>il</strong>izzo<br />
allo scopo <strong>di</strong> ottenere spazi per le scuole comunale. Nel 1921, infine, <strong>il</strong> sindaco <strong>di</strong><br />
<strong>Brescia</strong> Bruno Boni donò l’e<strong>di</strong>ficio <strong>del</strong>l’ex Lazzaretto alla parrocchia.<br />
Attualmente sopravvivono <strong>il</strong> chiostro, che mantiene tuttora, nonostante la scarsa<br />
manutenzione, <strong>il</strong> suo fascino, e le facciata a sud, decurtata, tuttavia, dai lavori <strong>del</strong><br />
1961-62, per giungere alla chiesa nuova.<br />
La storia <strong>di</strong> San Bartolomeo <strong>di</strong> quei secoli, ovviamente, non è solamente quella <strong>del</strong><br />
Lazzaretto: <strong>Brescia</strong> era ritornata già nel 1517 nelle mani <strong>del</strong>la Repubblica <strong>di</strong> Venezia<br />
che, nel 1529, concludeva la guerra con la Francia firmando la pace <strong>di</strong> Bologna.<br />
Nel frattempo San Bartolomeo si era costituita comune, grazie ad un proprio statuto<br />
riconosciuto dalla stessa città e ad un consiglio detti “giu<strong>di</strong>ci dei chiosi”. Il<br />
comune <strong>di</strong> San Bartolomeo era esclusivamente tenuto ad una ridotta contribuzione<br />
fiscale, secondo gli estimi pubblicati <strong>il</strong> 14 Dicembre <strong>del</strong> 1591 dalla Serenissima,<br />
ed era sottoposto alla città con alcuni priv<strong>il</strong>egi daziari.<br />
San Bartolmeo, oltre all’agricoltura, sv<strong>il</strong>uppava, come già si può notare osservando<br />
la mappa <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> e <strong>di</strong>ntorni <strong>del</strong> XVI secolo, <strong>il</strong> settore artigianale sfruttando i<br />
percorsi d’acqua, inizialmente solo per i mulini e, successivamente, per la lavorazione<br />
<strong>del</strong> ferro, <strong>del</strong> rame e <strong>del</strong>le pelli. A testimonianza <strong>del</strong>la laboriosità <strong>di</strong> questo<br />
borgo ci sono, anche, le denominazioni <strong>del</strong>le sue vie, come <strong>il</strong> rione <strong>del</strong>le Mole o via<br />
Rassiche, che prende <strong>il</strong> nome da “rasseghe”, per ricordare la presenza <strong>di</strong> impianti<br />
per la lavorazione <strong>del</strong> legno.<br />
Un governatore <strong>del</strong> 1660 parlando <strong>di</strong> San Bartolomeo ricordava la velocità <strong>del</strong>le<br />
sue officine nell’aff<strong>il</strong>atura <strong>del</strong>le spade, mentre, nel periodo compreso tra i secoli<br />
XVI-XVIII, la zona era famosa per la lavorazione <strong>di</strong> baionette, canne e componenti<br />
<strong>di</strong> armi da fuoco. Nel 1688 veniva costruita, per or<strong>di</strong>ne <strong>del</strong> capitano veneto Gerolamo<br />
Corraro, un’enorme polveriera che alla fine <strong>del</strong>l’Ottocento <strong>di</strong>venne la sede<br />
<strong>del</strong>la società cooperativa pellettieri, ed appunto la concia <strong>del</strong>le pelli fu la più tra<strong>di</strong>-<br />
14
1. I QUARTIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE NORD<br />
zionale e la più antica <strong>di</strong> tutte le lavorazioni artigianali <strong>del</strong> Borgo, tant’è che alcuni<br />
storici hanno ipotizzato che <strong>il</strong> nome <strong>del</strong>la zona non sia dovuto alla presenza <strong>del</strong><br />
Lazzaretto ma a questo genere <strong>di</strong> attività <strong>di</strong> cui si vuole San Bartolomeo patrono.<br />
La situazione dal punto <strong>di</strong> vista politico e produttivo restò più o meno la stessa<br />
sino al 17 ottobre <strong>del</strong> 1797, quando al termine <strong>del</strong>la vittoriosa campagna in Italia<br />
<strong>di</strong> Napoleone Bonaparte, Francia ed Austria, firmarono <strong>il</strong> trattato noto con <strong>il</strong> nome<br />
<strong>di</strong> pace <strong>di</strong> Campoformio che, sostanzialmente, stab<strong>il</strong>iva la definitiva caduta <strong>del</strong>la<br />
Repubblica <strong>di</strong> Venezia, ed <strong>il</strong> passaggio dei suoi domini nelle mani <strong>del</strong>lo sconfitto<br />
Francesco II d’Austria. La popolazione bresciana, tuttavia, si ribellò, proclamandosi<br />
repubblica e <strong>di</strong>venendo parte <strong>del</strong>la Repubblica Cisalpina e <strong>del</strong> Regno d’Italia, come<br />
capoluogo <strong>del</strong> <strong>di</strong>partimento <strong>del</strong> Mella. All’inizio <strong>del</strong>l’Ottocento cominciò a farsi<br />
strada l’opinione che i comuni limitrofi alla città dovessero essere ad essa annessi:<br />
percorso che tra varie vicessitu<strong>di</strong>ni si concluderà definitivamente nel 1881.<br />
Con l’inizio <strong>del</strong> ‘900 anche San Bartolomeo venne toccata dagli eventi <strong>del</strong> secolo<br />
e dopo l’uccisione <strong>di</strong> re Umberto a Monza <strong>di</strong>versi suoi abitanti vennero arrestati<br />
come socialisti ed anarchici. Durante la I Guerra mon<strong>di</strong>ale questo quartiere sacrificò<br />
<strong>di</strong>eci dei suoi giovani alla causa nazionale, i cui nomi sono ricordati ancora oggi<br />
da una lapide posta sul fianco occidentale <strong>del</strong>la chiesa, ed alla quale verranno<br />
aggiunti i nominativi <strong>del</strong>le vittime <strong>del</strong> secondo conflitto mon<strong>di</strong>ale.<br />
Palazzo INCIS in via Veneto<br />
15<br />
Per concessione dei Civici Musei d’Arte e Storia <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
Dopo le due guerre e l’arrivo degli esuli <strong>del</strong>l’Istria e <strong>del</strong>la Dalmazia che a <strong>Brescia</strong>,<br />
ed a san Bartolomeo, in particolare, troveranno ospitalità, <strong>il</strong> quartiere non venne<br />
più interessato da eventi storici <strong>di</strong> particolare importanza e dalla metà <strong>del</strong> Novecento<br />
in poi muterà <strong>il</strong> suo aspetto omologandosi in modo molto evidente a tutto<br />
<strong>il</strong> resto <strong>del</strong> paesaggio citta<strong>di</strong>no. Dal 1950, in poi, furono e<strong>di</strong>ficati <strong>di</strong>versi complessi<br />
condominiali: sorsero <strong>il</strong> V<strong>il</strong>laggio Bianco (1955), le case per i profughi dalmati<br />
<strong>del</strong>l’istituto case popolari (1957), seguiti, successivamente, dai complessi <strong>del</strong>le<br />
“Querce”, degli “Olmi”, dei “Platani” ecc.<br />
Nel 1962 veniva costruito l’istituto Industriale Benedetto Castelli, nel 1982 un<br />
nuovo e<strong>di</strong>ficio postale, nel 1993 grazie alla collaborazione tra <strong>Comune</strong> e Parrocchia<br />
si e<strong>di</strong>ficò un nuovo centro sportivo e nel 1995 un nuovo centro residenziale<br />
Aler.<br />
Tra queste abitazioni si trovano oggi <strong>di</strong>versi complessi industriali (Ori Martin, Palazzoli,<br />
Idra, Maifrini) ed i resti <strong>del</strong> passato con le varie v<strong>il</strong>le settecentesche.<br />
16
oRgo TRenTo<br />
1. I QUARTIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE NORD<br />
All’interno <strong>di</strong> quello che fu <strong>il</strong> territorio <strong>di</strong> San Bartolomeo era presente anche<br />
Borgo Trento, uno dei quartieri <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> che, per la propria morfologia, è riuscito<br />
a mantenere l’immagine <strong>di</strong> piccolo borgo che lo ha sempre reso affascinante.<br />
Borgo Trento, da prima parte <strong>del</strong> <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> San Bartolomeo, venne annesso alla<br />
parrocchia <strong>di</strong> Borgo P<strong>il</strong>e nel 1886 che comprendeva un vasto territorio.<br />
La zona da sempre era stata caratterizzata da un certo fermento dal punto <strong>di</strong> vista<br />
sociale, religioso ma, anche, <strong>del</strong>le attività produttive e la storia <strong>di</strong> Borgo Trento fu<br />
legata a quella <strong>di</strong> questo territorio e, soprattutto, nel lontano passato a quella <strong>di</strong><br />
San Bartolomeo e <strong>del</strong>le zone a nord <strong>del</strong>la città.<br />
Le vicende <strong>di</strong> Borgo Trento sono, comunque, legate anche a quelle <strong>di</strong> Borgo P<strong>il</strong>e,<br />
nome che contrad<strong>di</strong>stinse <strong>il</strong> Borgo che si formò al <strong>di</strong> là <strong>del</strong>la porta, eretta dal<br />
1237 al 1239, oltre la chiesa <strong>di</strong> San Faustino.<br />
Porta Trento, i nuovi mercati rionali<br />
17<br />
Per concessione dei Civici Musei d’Arte e Storia <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
Il nome P<strong>il</strong>e deriva, secondo Fè D’Ostiani, dall’e<strong>di</strong>ficio <strong>di</strong> p<strong>il</strong>e mosso dalle acque<br />
<strong>del</strong> Celato, anche, se è molto più probab<strong>il</strong>e, che prendesse origine da p<strong>il</strong>astro o<br />
car<strong>di</strong>ne.<br />
Il Borgo nell’arco dei secoli crebbe <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni ma, nel 1517, al termine <strong>del</strong>la<br />
terrib<strong>il</strong>e dominazione francese, si decise, per motivi <strong>di</strong> sicurezza, <strong>di</strong> abbattere tutti<br />
gli e<strong>di</strong>fici intorno alla città per un raggio <strong>di</strong> mezzo miglio.<br />
Borgo P<strong>il</strong>e venne, così, trasferito, più a nord, come racconta, all’inizio <strong>del</strong> seicento<br />
lo stesso Giov<strong>anni</strong> Da Lezze nel suo “Catastico bresciano” che parla <strong>di</strong> “case<br />
costruite alla moderna ed assai belle” e <strong>di</strong> “mercanti <strong>di</strong> biava”, ossia frumento,<br />
segno <strong>del</strong>la caratterizzazione agricola, oltre che pre-industriale <strong>del</strong>la zona, segnalata<br />
dalla presenza <strong>di</strong> mulini attorno al Garza.<br />
Tra porta P<strong>il</strong>e e Borgo Trento si estendeva, ai tempi, un’amplia zona verde, all’interno<br />
<strong>del</strong>la quale si era sv<strong>il</strong>uppato un agglomerato <strong>di</strong> case, denominato Isolabella,<br />
come “All’Isolabella”, si chiamava un ristorante dei fratelli Basché, antica osteria<br />
che si trovava sulla riva destra <strong>del</strong> Garza, dove si giocava anche a bocce.<br />
Di fronte all’Osteria, nel 1911, venne e<strong>di</strong>ficata la Casa Marchesi, che i proprietari<br />
vollero abbellire con affreschi raffiguranti figure allegoriche.<br />
Questo territorio era caratterizzato, anche, dalla presenza <strong>di</strong> lavoratori giornalieri<br />
ed anche <strong>di</strong> miserab<strong>il</strong>i, come racconta <strong>il</strong> notaio Antonio Losi, in un documento <strong>del</strong><br />
6 giugno <strong>del</strong> 1728.<br />
Come spesso in quegli <strong>anni</strong>, accanto ai benestanti, quin<strong>di</strong>, vivevano anche numerose<br />
persone che tiravano a campare: la miseria, tuttavia, fu solo uno dei<br />
problemi che i citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> quei tempi si trovarono ad affrontare. Ci fu l’esperienza<br />
<strong>del</strong>la guerra con le truppe austriache <strong>del</strong> capitano Rakowki e quelle provenienti<br />
dal trentino che si ritrovarono proprio al <strong>di</strong> fuori <strong>del</strong>le mura <strong>del</strong>la città nel 1813,<br />
mentre solo tre <strong>anni</strong> dopo vi fu una carestia tale da richiamare ad<strong>di</strong>rittura i lupi<br />
nelle zone limitrofe alla città, ed anche in quella <strong>del</strong> Borgo.<br />
Chi, invece, racconterà le vicende novecentesche <strong>del</strong> Borgo sarà Lino Monchieri<br />
nel <strong>libro</strong> “Il mio Borgo”, e<strong>di</strong>to nel 1973: un’opera nostalgica sui tempi che furono<br />
e sul fascino <strong>del</strong> “bòrg”, luogo fervente sia dal punto <strong>di</strong> vista dei rapporti sociali<br />
che da quello <strong>del</strong>le attività artigianali.<br />
Monchieri ricorda, così, la morfologia <strong>del</strong> Borgo, la scuola elementare Cesare<br />
Battisti, tutt’ora esistente, <strong>il</strong> ponte sul Garza, <strong>il</strong> ponte alto noto, soprattutto, per<br />
la “Trattoria <strong>del</strong>la Lepre”, la fermata <strong>del</strong> tram che portava a Mompiano ed <strong>il</strong> gioco<br />
18
1. I QUARTIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE NORD<br />
<strong>del</strong>le bocce. C’erano Le Grazzine con la loro chiesa ed un numero significativo<br />
<strong>di</strong> case sparse, cascine e v<strong>il</strong>le rurali, per lo più, tra le quali spicca, la “v<strong>il</strong>la degli<br />
spiriti”, come era chiamata dai ragazzini <strong>del</strong> tempo v<strong>il</strong>la Cottinelli.<br />
Lo stesso autore parla <strong>di</strong> Borgo Trento come una comunità fervente ma chiusa<br />
in sé stessa, e questa se <strong>anni</strong> fa, allo stesso autore poteva sembrare un limite, è<br />
quella che ha mantenuto <strong>il</strong> Borgo inalterato nel tempo, almeno dal punto <strong>di</strong> vista<br />
<strong>del</strong>le costruzioni e <strong>del</strong>la tranqu<strong>il</strong>lità <strong>del</strong> luogo, che ai giorni nostri è considerata<br />
una piacevole zona residenziale.<br />
19
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
MoMPiano e caSazza<br />
Mompiano, anticamente “Monte Plano” con riferimento alla piana circondata da<br />
colle San Giuseppe e Maddalena, nasce come vivace borgo rurale, impreziosito<br />
da fonti d’acqua e abitato da famiglie conta<strong>di</strong>ne, cui si aggiungeranno nel tempo<br />
le case <strong>di</strong> campagna <strong>del</strong>le famiglie bresciane più in vista.<br />
I primi inse<strong>di</strong>amenti risalgono all’epoca romana. Il territorio <strong>di</strong> Mompiano era<br />
abbinato all’idea <strong>di</strong> salubrità anche per la presenza <strong>di</strong> fonti che attraverso un<br />
acquedotto alimentavano tutta la città e le numerose fontane pubbliche fin dai<br />
tempi <strong>di</strong> re Desiderio, l’ultimo sovrano longobardo. A solcare Mompiano è anche<br />
un canale derivato dal Mella, conosciuto come fiume Celato, ora coperto, che<br />
secondo le ipotesi deve <strong>il</strong> suo nome al fatto <strong>di</strong> scorrere “nascosto” dal vecchio<br />
acquedotto romano, o <strong>di</strong> essere “salato”, a causa <strong>del</strong>l’abbondanza <strong>di</strong> sali minerali<br />
<strong>del</strong>le sue acque.<br />
Destinata a lasciare un segno fu la presenza, nel I secolo d.C., dei monaci benedettini<br />
<strong>del</strong> cenobio <strong>di</strong> San Faustino maggiore, che bonificarono alcuni terreni<br />
paludosi <strong>del</strong>la zona, introducendo la coltura <strong>del</strong>la vite e tracciando i collegamenti<br />
Veduta aerea <strong>del</strong> Parco Castelli<br />
20
1. I QUARTIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE NORD<br />
col colle San Giuseppe (chiamato in origine monte <strong>del</strong> Guas, dal termine longobardo<br />
“gaggio”, che significava bosco dove la popolazione poteva far legna).<br />
Nel Me<strong>di</strong>oevo Mompiano è una <strong>del</strong>le “chiusure” <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>, cioè <strong>del</strong>le aree abitate<br />
al <strong>di</strong> fuori <strong>del</strong>le mura, ma sottoposte agli statuti citta<strong>di</strong>ni. Nel XV secolo, con<br />
la nuova ripartizione <strong>del</strong> territorio in “quadre”, <strong>il</strong> borgo, sv<strong>il</strong>uppatosi attorno al<br />
fulcro <strong>del</strong>la vita sociale e religiosa rappresentato dalla chiesa <strong>di</strong> Sant’Antonino,<br />
viene classificato come l’ottava <strong>del</strong>le “quadre” <strong>di</strong> San Faustino.<br />
Sotto la dominazione austriaca, nel 1816 Mompiano <strong>di</strong>venta <strong>Comune</strong> in<strong>di</strong>pendente<br />
da <strong>Brescia</strong>, assorbendo nei suoi confini una vasta area a nord <strong>del</strong>la città,<br />
che andava dal Conicchio alla Maddalena, fino alla Pusterla e a Borgo Trento.<br />
Le cinque contrade che componevano <strong>il</strong> quartiere, la Sant’Antonio, la Fontane,<br />
la Montedenno, la Piazza e l’Ambaraga, furono rette da un’autonoma amministrazione<br />
fino al 1880, quando con regio decreto <strong>il</strong> governo italiano accolse<br />
la richiesta <strong>del</strong> <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> <strong>di</strong> annettere <strong>il</strong> vicino <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Mompiano<br />
insieme agli altri quattro <strong>di</strong> S. Bartolomeo, Fiumicello-Urago, S. Nazzaro-Mella, S.<br />
Alessandro, nonostante le ferme proteste <strong>del</strong>le piccole municipalità, che temevano<br />
la prospettiva <strong>di</strong> essere inglobate.<br />
Nonostante le vicissitu<strong>di</strong>ni storiche, <strong>il</strong> volto più autentico <strong>del</strong> quartiere, che rimarrà<br />
invariato fino ai primi decenni <strong>del</strong> Novecento, è quello <strong>di</strong> una comunità<br />
agreste, impegnata nei campi e nelle vigne, a far legna nei boschi alle pen<strong>di</strong>ci<br />
<strong>del</strong>la Maddalena, o a cavare <strong>il</strong> medolo, la pietra tipica <strong>del</strong>le dorsali locali. Quello<br />
<strong>del</strong> “roncher” e <strong>del</strong> “medoler” sono sempre stati i lavori caratteristici <strong>del</strong> quartiere,<br />
insieme a quello <strong>del</strong>le lavandaie, mestiere tramandato nei secoli, ai bor<strong>di</strong> <strong>del</strong><br />
fiume Celato, fra p<strong>anni</strong> da pulire, spazzole e lisciva.<br />
Con l’annessione a <strong>Brescia</strong> arriveranno anche <strong>il</strong> tram, l’<strong>il</strong>luminazione pubblica<br />
e verranno ampliate le scuole, avviando <strong>il</strong> quartiere verso un lento processo <strong>di</strong><br />
modernizzazione che si compirà nel secondo dopoguerra, con una significativa<br />
trasformazione urbanistica e <strong>il</strong> rapido sv<strong>il</strong>uppo <strong>di</strong> quella che <strong>di</strong>venterà la periferia<br />
nord <strong>del</strong>la città.<br />
Sull’onda <strong>del</strong> boom economico <strong>il</strong> quartiere abbandona <strong>il</strong> suo prof<strong>il</strong>o agreste per<br />
de<strong>di</strong>carsi prevalentemente al settore terziario. Per rispondere al fabbisogno residenziale<br />
e alla popolazione in continua crescita vengono costruiti nuovi alloggi,<br />
fra cui <strong>il</strong> v<strong>il</strong>laggio Valotti negli <strong>anni</strong> Sessanta e <strong>il</strong> quartiere Europa 70 agli inizi<br />
degli <strong>anni</strong> Settanta.<br />
21
Archivio Fototeca storica Spedali Civ<strong>il</strong>i <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong><br />
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
Lo sta<strong>di</strong>o Rigamonti era stato inaugurato nel 1959, mentre all’inizio degli <strong>anni</strong><br />
Settanta prendono <strong>il</strong> via le prime lezioni <strong>di</strong> Ingegneria (nel convitto Gerolamo<br />
Em<strong>il</strong>iani <strong>di</strong> Mompiano) e Me<strong>di</strong>cina (nella sede costruita nelle a<strong>di</strong>acenze <strong>del</strong>l’ospedale<br />
Civ<strong>il</strong>e), con la collaborazione <strong>del</strong> Politecnico <strong>di</strong> M<strong>il</strong>ano e <strong>del</strong>le Università <strong>di</strong><br />
M<strong>il</strong>ano e Parma. Bisognerà aspettare fino al 1982 per la nascita ufficiale <strong>del</strong>l’Università<br />
degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>, che consoliderà proprio a Mompiano <strong>il</strong> polo me<strong>di</strong>co<br />
e ingegneristico.<br />
Nell’area vicino all’innesto con la via Triumplina sorge <strong>il</strong> quartiere <strong>di</strong> Casazza, nel perimetro<br />
dove un tempo esisteva una cascina, chiamata “casaccia”, che ha dato <strong>il</strong> nome<br />
alla via e poi a tutto l’inse<strong>di</strong>amento urbano.<br />
Agli inizi <strong>del</strong> Novecento la via si chiamava “Strada consorziale <strong>del</strong>la Casazza o cascina<br />
larga” e si estendeva oltre via Triumplina verso Mompiano.<br />
Gli inse<strong>di</strong>amenti più significativi per <strong>il</strong> quartiere si sono sv<strong>il</strong>uppati con gli <strong>anni</strong> Settanta<br />
<strong>del</strong> secolo scorso, a partire dalle case costruite dall’Istituto autonomo case popolari.<br />
1942: la zona non ancora urbanizzata attorno all’Ospedale Civ<strong>il</strong>e<br />
22
1. I QUARTIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE NORD<br />
La storia <strong>del</strong>l’ospedale<br />
L’attuale sede <strong>del</strong>l’ospedale<br />
Civ<strong>il</strong>e viene costruita a partire<br />
dal 1938, con un piano finanziario<br />
<strong>di</strong> 21 m<strong>il</strong>ioni <strong>di</strong> lire e un<br />
innovativo progetto architettonico<br />
“a raggiera”, per farne<br />
un ospedale d’avanguar<strong>di</strong>a.<br />
Il primo reparto viene aperto<br />
nel 1951 e nel 1953 si assiste al trasferimento definitivo <strong>del</strong>le degenze<br />
dalla vecchia sede <strong>del</strong>l’ospedale, nell’area <strong>del</strong> convento <strong>di</strong> San Domenico<br />
nei pressi <strong>di</strong> via Moretto. La scelta <strong>del</strong>l’area <strong>di</strong> Mompiano, che negli <strong>anni</strong><br />
Trenta aveva scatenato un ampio <strong>di</strong>battito (molti criticavano la lontananza<br />
<strong>del</strong> nosocomio dal centro e ritenevano sarebbe stato escluso dalle traiettorie<br />
<strong>del</strong>la crescita urbana), si rivelerà invece strategica: <strong>il</strong> Civ<strong>il</strong>e sarebbe<br />
<strong>di</strong>ventato negli <strong>anni</strong> una <strong>del</strong>le strutture più determinanti per lo sv<strong>il</strong>uppo <strong>di</strong><br />
<strong>Brescia</strong> a nord <strong>del</strong> Cidneo, un risultato favorito anche dalla nascita <strong>del</strong>la<br />
confinante Università degli Stu<strong>di</strong>, nel 1982.<br />
I cantieri per la costruzione <strong>del</strong>l’ospedale e l’ingresso nel 1938<br />
23<br />
Archivio Fototeca storica Spedali Civ<strong>il</strong>i <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>
Archivio Solidarietà Viva<br />
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
V<strong>il</strong>laggio PRealPino<br />
Fino al secondo dopoguerra l’area <strong>del</strong> V<strong>il</strong>laggio Prealpino, nel triangolo fra <strong>il</strong> crocevia<br />
per Nave, la chiesa <strong>del</strong>la Stocchetta e <strong>il</strong> Conicchio era un’area <strong>di</strong> aperta<br />
campagna, con vigne e pescheti, punteggiata da qualche cascina.<br />
L’esplosione urbanistica si avrà dal 1958 al 1971, quando le cooperative <strong>del</strong> gruppo<br />
La Famiglia, dall’intuizione <strong>di</strong> padre Ottorino Marcolini, inizieranno a costruire<br />
v<strong>il</strong>lette a schiera, dando vita a un vero e proprio “paese” nella città (<strong>il</strong> V<strong>il</strong>laggio<br />
Prealpino si chiama così dal nome <strong>del</strong>le prime due cooperative che vi hanno costruito),<br />
che verrà gradualmente dotato <strong>di</strong> infrastrutture e servizi.<br />
Inizialmente le strade all’interno <strong>del</strong> V<strong>il</strong>laggio non erano asfaltate, i bus non arrivavano<br />
perché <strong>il</strong> capolinea era alla Stocchetta, elementi che rafforzavano la<br />
<strong>di</strong>mensione raccolta e <strong>di</strong> con<strong>di</strong>visione fra le prime famiglie residenti.<br />
Il primo luogo <strong>di</strong> socializzazione <strong>del</strong> V<strong>il</strong>laggio furono le scuole elementari, che per<br />
i primi cinque <strong>anni</strong> dopo l’avvio degli inse<strong>di</strong>amenti rappresentarono, con l’am-<br />
Fine <strong>anni</strong> ‘50: si inizia a progettare la costruzione <strong>del</strong> Prealpino<br />
24
1. I QUARTIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE NORD<br />
pio seminterrato <strong>di</strong> cui <strong>di</strong>sponevano,<br />
un importante “centro <strong>di</strong> aggregazione”<br />
per la comunità: lì si svolgevano<br />
assemblee pubbliche, si proiettavano<br />
f<strong>il</strong>m per offrire <strong>il</strong> cinema ai più giovani,<br />
venivano messe in scena le comme<strong>di</strong>e<br />
<strong>del</strong>la f<strong>il</strong>odrammatica <strong>di</strong> quartiere.<br />
Nel 1960 viene ultimato l’oratorio,<br />
mentre la chiesa <strong>di</strong> Santa Giulia sarà<br />
terminata nel 1961 (<strong>il</strong> primo parroco<br />
<strong>del</strong> V<strong>il</strong>laggio fu l’in<strong>di</strong>menticato don Nicola Pietragiovanna), cui seguirà, nel 1963,<br />
l’inaugurazione <strong>del</strong>la scuola materna.<br />
Col tempo <strong>il</strong> quartiere è <strong>di</strong>ventato particolarmente vivace, oltre che dal punto<br />
<strong>di</strong> vista associazionistico, anche da quello culturale ed artistico, grazie al Teatro<br />
Santa Giulia, costruito negli <strong>anni</strong> Sessanta con <strong>il</strong> nome <strong>di</strong> Cinema-Teatro Excelsior,<br />
allora tra le sale più gran<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> con 600 posti. Dopo la ristrutturazione, avvenuta<br />
nel 2001, che lo ha reso moderno e funzionale, <strong>il</strong> teatro ha preso <strong>il</strong> nome<br />
<strong>di</strong> Santa Giulia, in onore alla santa <strong>del</strong>la parrocchia, iniziando una intensa attività<br />
<strong>di</strong> proposta cinematografica e teatrale rivolta a tutta la città.<br />
Il primo lotto <strong>del</strong> Prealpino e, in alto, veduta o<strong>di</strong>erna <strong>del</strong> V<strong>il</strong>laggio<br />
25<br />
Archivio Solidarietà Viva
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
coSTalUnga - San RoccHino<br />
Nei primi <strong>anni</strong> <strong>del</strong> secolo scorso, quando non era ancora stato costruito<br />
l’ospedale Civ<strong>il</strong>e, l’area dove oggi sorge <strong>il</strong> quartiere - che va dalle pen<strong>di</strong>ci<br />
<strong>del</strong>la Maddalena verso occidente, confinando con i Ronchi <strong>di</strong>etro San Gottardo<br />
- era scarsamente abitata, ed era piuttosto un luogo <strong>di</strong> svago extraurbano,<br />
meta <strong>di</strong> gite e sito apprezzato dai raccoglitori <strong>di</strong> funghi.<br />
Il nome originario <strong>di</strong> Costalunga pare fosse “Cogolo”, da cogol, che in<br />
<strong>di</strong>aletto significa sasso, probab<strong>il</strong>mente per evocare la presenza <strong>di</strong> cave <strong>di</strong><br />
pietra nella zona. San Rocchino prende invece <strong>il</strong> nome dalla piccola chiesa<br />
costruita nel Seicento nella zona e de<strong>di</strong>cata al santo, che era protettore<br />
degli appestati e che richiamava la presenza nelle vicinanze <strong>del</strong> lazzaretto<br />
che accoglieva i malati.<br />
Nel Seicento l’area faceva parte <strong>del</strong>la seconda “quadra” <strong>di</strong> San Faustino,<br />
secondo l’organizzazione amministrativa data allora alla città. Successivamente,<br />
alle originarie case sparse <strong>di</strong> conta<strong>di</strong>ni nel Settecento si aggiunsero<br />
v<strong>il</strong>le patrizie, poste negli scorci più panoramici ed estese anche al tratto<br />
chiamato Ponte Alto (nell’area occupata oggi da piazzale Golgi) dal ponte<br />
che consentiva <strong>di</strong> attraversare <strong>il</strong> fiume Celato.<br />
Per l’urbanizzazione <strong>del</strong>la zona bisognerà attendere <strong>il</strong> secondo dopoguerra<br />
e gli <strong>anni</strong> Sessanta, che daranno <strong>il</strong> via al boom ed<strong>il</strong>izio, con la costruzione,<br />
fra gli altri, anche <strong>di</strong> un v<strong>il</strong>laggio Marcolini nel 1964.<br />
26
1. I QUARTIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE NORD<br />
27
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
Esterno <strong>del</strong> Museo <strong>del</strong> ferro a San Bartolomeo 28<br />
Archivio Serino
Capitolo 2<br />
A spasso per la Nord<br />
i MUSei<br />
2. A SPASSO PER LA NORD<br />
Il Museo <strong>del</strong> Ferro<br />
Il Museo <strong>del</strong> Ferro – La fucina <strong>di</strong> San Bartolomeo, inaugurato nel 2001, offre un<br />
suggestivo colpo d’occhio su come dovevano essere un tempo <strong>il</strong> lavoro e i trucchi<br />
<strong>del</strong>la sapienza artigiana e industriale. Ambientato nei locali dove nel corso dei<br />
secoli si è sv<strong>il</strong>uppata una fucina da ferro con un laboratorio <strong>di</strong> molatura, in via <strong>del</strong><br />
Manestro 107/111, <strong>il</strong> polo espositivo nasce da un progetto <strong>di</strong> recupero e musealizzazione<br />
pensato per raccontare una parte importante <strong>del</strong>la storia economica e<br />
sociale bresciana attraverso oggetti d’uso comune e attrezzi da lavoro che si sono<br />
conservati nel tempo.<br />
Fulcro <strong>del</strong> percorso espositivo è <strong>il</strong> maglio (conservatosi dagli <strong>anni</strong> Ottanta <strong>del</strong> secolo<br />
scorso), <strong>il</strong> <strong>di</strong>spositivo meccanico per battere i metalli che funzionava come un<br />
grande martello, e con la sua cadenza regolare scan<strong>di</strong>va i tempi <strong>del</strong> lavoro.<br />
Nel percorso viene <strong>il</strong>lustrato anche <strong>il</strong> funzionamento <strong>del</strong>la ruota idraulica che grazie<br />
alla canalizzazione esterna <strong>del</strong>le acque procurava l’energia per la fucina. Tutte<br />
le fasi <strong>di</strong> lavorazione <strong>del</strong> metallo sono documentate nei dettagli, come nell’opificio<br />
<strong>di</strong> molatura che conserva ancora forgia, mole e attrezzi per la realizzazione degli<br />
oggetti in ferro, e nelle <strong>di</strong>verse sezioni <strong>del</strong>la fucina.<br />
Percorsi <strong>di</strong>dattici mirati sono stati sv<strong>il</strong>uppati per ragazzi e scolaresche. Lo spazio<br />
espositivo <strong>di</strong> San Bartolomeo rappresenta <strong>il</strong> polo iniziale <strong>del</strong> futuro Museo <strong>del</strong>l’Industria<br />
e <strong>del</strong> Lavoro “E. Battisti” <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>, ed è stato promosso dalla Fondazione<br />
Civ<strong>il</strong>tà <strong>Brescia</strong>na.<br />
Il Museo civico <strong>di</strong> Scienze naturali<br />
Il museo cura le attività <strong>di</strong> conservazione e ricerca scientifica e propone percorsi<br />
<strong>di</strong>dattici per <strong>di</strong>ffondere attraverso le proprie collezioni la cultura naturalistica.<br />
Nelle sale espositive <strong>del</strong>la sede <strong>di</strong> via Ozanam 4 vengono <strong>il</strong>lustrate le tematiche<br />
relative alle scienze naturali, fra cui botanica, geologia e zoologia. Il servizio gesti-<br />
29
Archivio Serino<br />
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
sce anche la Civica Specola Cidnea, per promuovere la <strong>di</strong>vulgazione <strong>del</strong>l’astronomia,<br />
<strong>del</strong>l’astrofisica e geografia astronomica.<br />
Le attività scientifiche condotte dai ricercatori sono orientate alla conoscenza <strong>del</strong><br />
territorio locale e alla sua valorizzazione, per contribuire alla ricerca, acquisizione e<br />
conservazione <strong>di</strong> reperti e testimonianze <strong>del</strong>l’ambiente naturale. Attorno al museo<br />
gravitano anche le attività promosse dalle associazioni naturalistiche e dai gruppi<br />
scientifici locali.<br />
All’interno <strong>del</strong> museo è aperta una biblioteca specializzata, che fa parte <strong>del</strong> sistema<br />
bibliotecario urbano e raccoglie volumi relativi a <strong>di</strong>scipline <strong>di</strong> carattere scientifico e<br />
naturalistico, in particolare quelle astronomiche, biologiche, geologiche e preistoriche.<br />
Il fondo <strong>del</strong>la biblioteca, costituito da oltre 100 m<strong>il</strong>a documenti, è composto da monografie,<br />
perio<strong>di</strong>ci, estratti, materiali multime<strong>di</strong>ali, carte geografiche e documenti.<br />
Il percorso espositivo all’interno <strong>del</strong> Museo <strong>del</strong> ferro<br />
<strong>30</strong>
le cHieSe<br />
Parrocchia<br />
<strong>di</strong> San Bartolomeo,<br />
ex Parrocchiale<br />
Nell’antica parrocchia è da<br />
vedere <strong>il</strong> <strong>di</strong>pinto murale conservato<br />
presso l’altare laterale<br />
sinistro, che raffigura la<br />
Madonna con Gesù Bambino<br />
in trono ed è risalente al XV<br />
secolo. Di pregiata fattura è<br />
anche l’altare maggiore con<br />
marmi policromi, <strong>del</strong> 1708,<br />
mentre <strong>il</strong> presbiterio vale una<br />
visita per osservare i <strong>di</strong>pinti<br />
murali <strong>di</strong> Pietro Scalvini, risalenti<br />
al 1739.<br />
2. A SPASSO PER LA NORD<br />
San Bartolomeo, <strong>il</strong> campan<strong>il</strong>e <strong>del</strong>la vecchia parrocchiale<br />
Parrocchia <strong>di</strong> Cristo Re<br />
Nel cuore <strong>di</strong> Borgo Trento la chiesa, dalle architetture armoniche, vanta numerose<br />
opere <strong>del</strong> pittore Vittorio Trainini <strong>di</strong> Mompiano, in particolare la Pala <strong>del</strong>l’altare<br />
maggiore con Cristo Re in trono e San Pietro Apostolo (<strong>del</strong> 1927), e la decorazione<br />
<strong>del</strong>la volta, risalente al 1934-36, con <strong>il</strong> Giu<strong>di</strong>zio Universale.<br />
Vale una visita anche <strong>il</strong> presbiterio, dove è conservata un’opera <strong>di</strong> Palma <strong>il</strong> giovane,<br />
<strong>del</strong> secolo XVII, raffigurante Sant’Antonio abate. All’ingresso <strong>il</strong> visitatore<br />
attento riconoscerà sulla parete sinistra la Madonna con Gesù Bambino e Santi <strong>di</strong><br />
Pietro Ricchi (1640-1660).<br />
Per chi apprezza <strong>il</strong> lavoro <strong>di</strong> cesello e le pietre preziose, alla chiesa <strong>di</strong> Santa<br />
Maria <strong>del</strong>le Grazzine si può ammirare l’altare con marmi intarsiati, madreper-<br />
31<br />
Archivio Serino
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
la e lapislazzuli risalente al XVII secolo e conservato nel presbiterio.<br />
Notevole anche <strong>il</strong> <strong>di</strong>pinto murale, che data attorno agli <strong>anni</strong> 1500-1524, e raffigura<br />
la Madonna con Gesù Bambino in trono.<br />
Chiesa <strong>di</strong> Sant’Antonino<br />
<strong>del</strong>la parrocchia <strong>di</strong> San Gaudenzio a Mompiano<br />
L’antica parrocchiale risale alla fine <strong>del</strong> Trecento ed è intitolata a Sant’Antonino,<br />
soldato romano martire e patrono <strong>di</strong> Piacenza. Qui veniva officiato in tempi antichi<br />
<strong>il</strong> culto religioso per i residenti <strong>del</strong> quartiere. Ancora oggi si possono ammirare<br />
notevoli opere realizzate nel corso dei secoli, secondo <strong>il</strong> gusto <strong>del</strong> tempo: l’Altare<br />
dei Santi, <strong>di</strong> Giulio Vannucci, risalente al XVII secolo, con la Pala <strong>di</strong> Sant’Antonio<br />
da Padova con Santi; la Pala <strong>del</strong>l’altare maggiore, <strong>del</strong> XVI secolo, che raffigura la<br />
Madonna con Gesù Bambino e Santi, e l’Altare <strong>del</strong> Rosario, <strong>del</strong> XVII secolo, con i<br />
Misteri <strong>del</strong> Rosario.<br />
Sempre nella “Mompiano vecchia” si trova la chiesa <strong>di</strong> Santa Maria, risalente<br />
al Settecento e costruita su una precedente cappella. Alle pareti resta ancora un<br />
particolare <strong>di</strong>pinto murale, <strong>del</strong> secolo XVII, che raffigura Cristo Deriso. Significativo<br />
anche l’altare maggiore, <strong>di</strong> Francesco Pialorsi, dei secoli XVII-XVIII, con una<br />
notevole soasa lignea.<br />
Suggestiva e ricca <strong>di</strong> storia è la chiesetta <strong>di</strong> San Bernardo in Costalunga,<br />
risalente al XV secolo, poi ricostruita nel 1825. Da osservare, nell’abside, la pala <strong>di</strong><br />
fine Settecento raffigurante San Bernardo e la Madonna addolorata.<br />
A San Rocchino, nella parrocchia <strong>del</strong>la SS. Trinità, fra le particolarità da<br />
vedere si segnalano una pregiata scultura, nella forma <strong>di</strong> bassor<strong>il</strong>ievo, <strong>del</strong> 1600-<br />
1610, che ha per soggetto la Madonna con Gesù Bambino e San Giov<strong>anni</strong>no.<br />
La Pala <strong>del</strong>l’altare maggiore è datab<strong>il</strong>e invece al XVI secolo (1550-1574) e raffigura<br />
la Madonna con Bambino e Santi.<br />
32
i PaRcHi<br />
2. A SPASSO PER LA NORD<br />
A Mompiano <strong>il</strong> parco Castelli, nei pressi <strong>del</strong>l’area collinare rappresenta un<br />
polmone verde <strong>di</strong> richiamo per l’intera città, con i suoi 48.581 metri quadrati <strong>di</strong><br />
superficie, dotati <strong>di</strong> aree gioco per bambini, pergolati, uno spazio de<strong>di</strong>cato all’attività<br />
motoria dei cani e le attrezzature sportive per praticare la pallacanestro o<br />
giocare a bocce. L’arena interna <strong>di</strong>venta d’estate sede <strong>di</strong> spettacoli e proiezioni<br />
cinematografiche.<br />
Più a nord, al v<strong>il</strong>laggio Prealpino si trova <strong>il</strong> parco Belvedere, che si estende per<br />
circa 10 m<strong>il</strong>a metri quadrati impreziositi da essenze arboree stagionali, betulle e<br />
un f<strong>il</strong>are alberato. Il parco è dotato <strong>di</strong> un’area giochi per bambini, una piastra polifunzionale,<br />
un percorso salute e attrezzature per calcetto, pallacanestro e bocce.<br />
I giar<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> via Casazza, dopo <strong>il</strong> ri<strong>di</strong>segno complessivo con rinnovo <strong>di</strong> pavimentazione<br />
e arre<strong>di</strong>, sono oggi un luogo <strong>di</strong> aggregazione <strong>di</strong> riferimento per <strong>il</strong><br />
Il Parco Castelli a Mompiano<br />
33
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
quartiere, con spazi ver<strong>di</strong> per oltre 13 m<strong>il</strong>a metri quadrati, arricchiti da aree gioco<br />
per i più piccoli, pergolati per garantirne la funzionalità in tutte le stagioni e attrezzature<br />
per la pallacanestro.<br />
I giar<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> via <strong>del</strong> Sebino sono <strong>il</strong> simbolo <strong>del</strong> volto nuovo <strong>del</strong> quartiere, che<br />
ha conosciuto una r<strong>il</strong>evante crescita residenziale nelle aree un tempo a vocazione<br />
industriale.<br />
I giar<strong>di</strong>ni, che si estendono su una superficie <strong>di</strong> 9.252 metri quadrati, sono <strong>di</strong>ventati<br />
un luogo <strong>di</strong> ritrovo per i residenti, grazie anche a spazi gioco e all’area per<br />
l’attività motoria dei cani.<br />
Gli spazi ver<strong>di</strong> più recenti <strong>di</strong> cui può <strong>di</strong>sporre <strong>il</strong> territorio <strong>del</strong>la Nord sono <strong>il</strong> parco<br />
<strong>di</strong> Campo Marte, a Sant’Eustacchio, acquisito dal <strong>Comune</strong> nel 2007, con una<br />
superficie <strong>di</strong> quasi 39 m<strong>il</strong>a metri quadrati.<br />
La sistemazione definitiva <strong>del</strong>l’area – già aperta al pubblico – verrà <strong>del</strong>ineata<br />
attraverso un percorso <strong>di</strong> progettazione partecipata con Circoscrizione e realtà<br />
<strong>di</strong> quartiere.<br />
I giar<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> Campo Marte<br />
34
2. A SPASSO PER LA NORD<br />
Nella rete <strong>del</strong> verde comunale è entrata a far parte anche l’ex Polveriera <strong>di</strong><br />
Mompiano (già deposito <strong>di</strong> munizioni <strong>di</strong> Valpersane), che con i suoi 146.510<br />
metri quadrati estesi su una vasta area collinare rappresenta una vera e propria<br />
oasi ecologica, ora in corso <strong>di</strong> recupero e valorizzazione per essere fruita<br />
dall’intera citta<strong>di</strong>nanza.<br />
La Valle <strong>di</strong> Mompiano, <strong>il</strong> colle <strong>di</strong> San Giuseppe, i Ronchi e la Maddalena fanno<br />
parte <strong>del</strong> Parco <strong>del</strong>le Colline, uno spazio naturale costituito da riserve<br />
ambientali <strong>di</strong> grande interesse e rarità dal punto <strong>di</strong> vista geologico e <strong>del</strong>la<br />
vegetazione.<br />
L’area si estende oltre i confini citta<strong>di</strong>ni e, insieme a <strong>Brescia</strong>, coinvolge i Comuni<br />
<strong>di</strong> Bovezzo, Cellatica, Collebeato, Rodengo Saiano. Grazie a interventi <strong>di</strong> recupero<br />
degli accessi e ai sentieri <strong>di</strong>dattici <strong>il</strong> Parco offre l’occasione per sperimentare<br />
un rapporto più stretto fra città e verde, fra uomo e natura.<br />
Ingresso <strong>del</strong>l’ex Polveriera <strong>di</strong> Mompiano<br />
35
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
RealTà <strong>del</strong> TeRRiToRio<br />
La Nikolajewka<br />
Era <strong>il</strong> 1978 quando un gruppo <strong>di</strong> persone generose e volenterose decisero<br />
<strong>di</strong> supplire alla mancanza <strong>di</strong> strutture assistenziali rivolte a giovani spastici e<br />
miodostrofici, dando vita alla scuola <strong>di</strong> mestieri “Nikolajewka”, per cercare <strong>di</strong><br />
fornire ai ragazzi, altrimenti abbandonati a sé stessi ed alle loro famiglie, le<br />
capacità per inserirsi professionalmente e socialmente.<br />
Grazie, quin<strong>di</strong>, all’impegno <strong>di</strong> queste persone e <strong>del</strong> padre f<strong>il</strong>ippino Giacomo<br />
Capretti, che fu l’anima <strong>del</strong> movimento, la scuola trovò sede provvisoria al<br />
centro “Federico Palazzoli”, dove già operava un consorzio sorto due <strong>anni</strong> prima.<br />
L’assorbimento <strong>del</strong> Centro da parte <strong>del</strong>la Ussl 41, a seguito <strong>del</strong>la riforma<br />
sanitaria, portò in breve tempo all’in<strong>di</strong>sponib<strong>il</strong>ità dei locali ut<strong>il</strong>izzati dalla scuola,<br />
alla quale, tuttavia, vennero incontro, con la consueta generosità gli alpini<br />
<strong>di</strong> tutta la provincia <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>, che si rimboccarono le maniche ed in 20.000,<br />
con settantam<strong>il</strong>a ore <strong>di</strong> lavoro, costruirono l’e<strong>di</strong>ficio, in titolando la scuola a<br />
“Nikolajewka”, in imperituro ricordo <strong>del</strong>le migliaia <strong>di</strong> ragazzi che persero la<br />
vita in Russia.<br />
Furono circa <strong>30</strong>0 m<strong>il</strong>ioni quelli che gli alpini riuscirono a raccogliere grazie<br />
ad innumerevoli iniziative, 495 quelli messi in campo dalla Cariplo, 495 quelli<br />
offerti dai bresciani me<strong>di</strong>ante offerte private o partecipando ad una sottoscrizione<br />
<strong>del</strong> Giornale <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>.<br />
Spesso gli Alpini giungevano sul cantiere con i loro attrezzi personali, per lavorare<br />
dalle sei <strong>del</strong> mattino alle nove <strong>del</strong>la sera, sette giorni su sette <strong>di</strong> ogni settimana,<br />
anche per tutta l’estate. L’obiettivo era <strong>di</strong> finire la costruzione <strong>del</strong>l’e<strong>di</strong>ficio<br />
entro la data <strong>del</strong> quarantesimo <strong>anni</strong>versario <strong>del</strong>la battaglia <strong>di</strong> Nikolajewka,<br />
ma nel gennaio <strong>del</strong> 1983 solo una parte <strong>del</strong>l’e<strong>di</strong>ficio sarebbe stata ultimata.<br />
Per l’immensa de<strong>di</strong>zione, gli Alpini bresciani ricevettero, in quel 1982, <strong>il</strong> Premio<br />
Fraternità, istituito in <strong>Brescia</strong> a ricordo <strong>del</strong> giornalista Bruno Marini.<br />
36
Scuola Au<strong>di</strong>ofonetica Mompiano<br />
2. A SPASSO PER LA NORD<br />
Nel primo ventennio <strong>del</strong> secolo scorso, esattamente nel 1919, le suore Canossiane<br />
trasferirono nella loro casa <strong>di</strong> via S. Antonio, a Mompiano, la scuola <strong>di</strong><br />
sordomute già attiva da una sessantina d’<strong>anni</strong> dalla loro casa in città.<br />
L’attività <strong>del</strong>le Figlie <strong>del</strong>la carità in questo campo fu molto producente tanto è<br />
che con <strong>il</strong> tempo si decisero a passare dal sistema mimico ad <strong>il</strong> metodo orale,<br />
meno fac<strong>il</strong>e da ut<strong>il</strong>izzare ma più red<strong>di</strong>tizio dal punto <strong>di</strong> vista dei risultati.<br />
All’interno <strong>del</strong>la scuola, inoltre, venne introdotta la psicomotricità per au<strong>di</strong>olesi<br />
e si aprirono le iscrizioni, anche, per i maschi.<br />
Passo fondamentale, inoltre, fu quello <strong>di</strong> affiancare ai ragazzi svantaggiati quelli<br />
normali come quello <strong>di</strong> destinare parte <strong>del</strong>la scuola alle materne, all’interno<br />
<strong>del</strong>la quale vengono introdotti bambini i<strong>di</strong> età inferiore ai tre <strong>anni</strong>, proprio<br />
perché i risultati maggiori si possono ottenere in giovane età.<br />
37
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
le PaRRoccHie <strong>del</strong>la ciRcoScRizione noRd<br />
San Bartolomeo<br />
Via Gabbiane, 8 - 25128 <strong>Brescia</strong><br />
Parroco: Don Angelo Cretti<br />
tel. 0<strong>30</strong> 2002438 - fax. 0<strong>30</strong> 2002438<br />
Cristo Re<br />
(Borgo Trento)<br />
Via Fabio F<strong>il</strong>zi, 3 - 25128 <strong>Brescia</strong><br />
Parroco: Don Umberto Dell’Aversana<br />
tel. casa 0<strong>30</strong> 3700600<br />
tel. oratorio 0<strong>30</strong> <strong>30</strong>2427<br />
Santa Maria Immacolata<br />
(Pavoniana)<br />
Via Pavoni, 11/a - 25128 <strong>Brescia</strong><br />
Parroco: Don Trainotti Mario<br />
tel. 0<strong>30</strong> <strong>30</strong>0265 - 0<strong>30</strong> 399196<br />
Santa Maria Madre<br />
<strong>del</strong>la Chiesa<br />
(Casazza)<br />
Via Casazza, 42 - 25128 <strong>Brescia</strong><br />
Parroco: Don Evandro Della Dote<br />
tel. 0<strong>30</strong> 2001789 - 0<strong>30</strong> 2001789<br />
San Barnaba Apostolo<br />
Via Valle, 37 - 25128 <strong>Brescia</strong><br />
Parroco: Don Gianluigi Carminati<br />
tel. 0<strong>30</strong> <strong>30</strong>5363 - fax. 0<strong>30</strong> <strong>30</strong>5363<br />
38<br />
S. Giulia<br />
Via Tovini, 2 (V<strong>il</strong>laggio Prealpino)<br />
Parroco Don Luciano Bianchi<br />
tel. 0<strong>30</strong> 2090003<br />
S. Giov<strong>anni</strong> Battista<br />
Via Triumplina n. 268<br />
Parroco: Padre Toffari Mario<br />
tel. 0<strong>30</strong> 2005608 - fax. 0<strong>30</strong> 2097128<br />
S. Gaudenzio<br />
Via Fontane n. 26<br />
Parroco: Don Cesare Verzeletti<br />
tel. 0<strong>30</strong> 2004254<br />
SS. Francesco e Chiara<br />
Via Bligny n. 10/b<br />
Parroco: Don Franco Lanfranchi<br />
tel. 0<strong>30</strong> 2008259<br />
SS. Trinità<br />
P.le Spedali Civ<strong>il</strong>i 51<br />
Parroco: Don Pitozzi Elio<br />
tel. 0<strong>30</strong> <strong>30</strong>3352 - fax. 0<strong>30</strong> 391778<br />
S. Bernardo<br />
Via Costalunga n. 38<br />
Parroco: Don Samuele Bramb<strong>il</strong>lasca<br />
tel. 0<strong>30</strong> 3398222 - fax. 0<strong>30</strong> 398898
Acli Cristo Re<br />
Via Trento 62 - tel. 0<strong>30</strong> <strong>30</strong>3254<br />
Ascomarte<br />
Via Pasubio 2<br />
tel. 0<strong>30</strong> 391161<br />
www.ascomarte.it<br />
Impronta Camuna<br />
Via Pasubio 2<br />
tel. 0<strong>30</strong> 391161 - 335 5943534<br />
www.improntacamuna.it<br />
Camminando Insieme<br />
Via Vittime d’Istria e Dalmazia 10<br />
tel. 0<strong>30</strong> 2010233<br />
Pensionati Casazza<br />
Via Casazza 46<br />
Anziani in allegria<br />
Via Casazza <strong>30</strong><br />
tel. 0<strong>30</strong> 2001502<br />
Gruppo Campo Marte<br />
Via Monte Grappa 10/A<br />
tel. 338 8085235 - 0<strong>30</strong> 396<strong>30</strong>4<br />
gruppocampomarte@libero.it<br />
2. A SPASSO PER LA NORD<br />
le aSSociazioni <strong>del</strong>la ciRcoScRizione noRd<br />
39<br />
Associazione officine mentali<br />
tel. 0<strong>30</strong> 2583449<br />
trainini@iol.it<br />
Libertà e progresso<br />
Via Luzzago 4<br />
tel. 0<strong>30</strong> 8374161<br />
associazione@libertaprogresso.it<br />
Club Azzurri<br />
Via Montesuello 18<br />
tel. 0<strong>30</strong> 2010534<br />
info@clubazzurri.it<br />
Strada Sapori Longobar<strong>di</strong><br />
Via <strong>del</strong> Sarto 34<br />
tel. 0<strong>30</strong> 2312791<br />
www.strada<strong>del</strong>vinocollide<strong>il</strong>ongobar<strong>di</strong>.it<br />
Associazione amore,<br />
pizza e fantasia<br />
Via <strong>del</strong>lo Sta<strong>di</strong>o 15<br />
tel. 333 7809147 - 0<strong>30</strong> 2004077<br />
francescogiordano101@alice.it<br />
Compagnia Lyria<br />
Via Tosoni 19 - tel. 0<strong>30</strong> 3702422<br />
info@compagnialyria.it
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
le aSSociazioni <strong>del</strong>la ciRcoScRizione noRd<br />
Associazione Palcogiovani<br />
Via Trento 85<br />
tel. 335 7797944 - 0<strong>30</strong> 396648<br />
info@palcogiovani.it<br />
Amici <strong>del</strong>la solidarietà<br />
Via Sant’Antonio 16 - tel. 0<strong>30</strong> 2003574<br />
Arpa<br />
Via Brolo 4 - tel. 338 6268532<br />
angelofacchi1804@libero.it<br />
Alpini <strong>del</strong> V<strong>il</strong>laggio Prealpino<br />
Via settima 21<br />
tel. 0<strong>30</strong> 2090674 - 335 1579125<br />
luigi.lorenzini59@libero.it<br />
Alpini <strong>di</strong> Mompiano<br />
Via Rampinelli 7<br />
Bimbo chiama bimbo<br />
Via Fontane 29<br />
Sede Amministrativa: tel. 0<strong>30</strong> 2000408<br />
Segreteria e Servizi: tel. 0<strong>30</strong> 209<strong>30</strong>06<br />
bimbochiamabimbo@bimbochiama.191.it<br />
Gnari de Mompià<br />
Via Prima V<strong>il</strong>laggio Montini<br />
tel. 338 505<strong>30</strong>24<br />
gnarimompiano@virg<strong>il</strong>io.it<br />
40<br />
Teatro inverso<br />
Via Tosoni 13 - tel. 0<strong>30</strong> 3701163<br />
teatroinverso@teatroinverso.it<br />
Partigiani d’Italia (Anpi)<br />
Sez. Verginella<br />
Via Cacciadenno - Coop Lavoratori<br />
tel. 0<strong>30</strong> 390472<br />
Solidarietà Viva<br />
Via <strong>del</strong> Brolo 71 - tel. 0<strong>30</strong> 2005566<br />
Club spastici adulti Aias<br />
tel. 0<strong>30</strong> 2002942 - 0<strong>30</strong> 2<strong>30</strong>5522<br />
Commercianti e artigiani<br />
<strong>di</strong> Mompiano<br />
Piazzale Kossuth 25<br />
tel. 347 8941135 - 339 1468334<br />
floral.stu<strong>di</strong>o@libero.it<br />
Gruppo S. Vincenzo<br />
Stocchetta<br />
Via tre<strong>di</strong>cesima 24 Stocchetta<br />
tel. 0<strong>30</strong> 2090896<br />
<strong>Brescia</strong> golf Country Club<br />
Via Stretta 48 - Tel. 0<strong>30</strong> 2006981<br />
info@clubazzurri.it
Asd Master - Class Fitness Club<br />
Azzurri <strong>Brescia</strong><br />
Via C<strong>il</strong>iegi 1 Gussago - tel. 0<strong>30</strong> 2010534<br />
info@clubazzurri.it<br />
Nuova Impronta<br />
Via Tavelli 35<br />
tel. 0<strong>30</strong> 2090375 - 339 8242919<br />
2. A SPASSO PER LA NORD<br />
le aSSociazioni <strong>del</strong>la ciRcoScRizione noRd<br />
41
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
1959: L’unica via <strong>di</strong> accesso al V<strong>il</strong>laggio Prealpino (attuale via 42Prima)<br />
Archivio Solidarietà Viva
3. ALLE ORIGINI DEL DECENTRAMENTO<br />
Capitolo 3<br />
Alle origini <strong>del</strong> decentramento<br />
dai coMiTaTi SPonTanei ai conSigli <strong>di</strong> qUaRTieRe<br />
La storia <strong>del</strong>la <strong>partecipazione</strong> a <strong>Brescia</strong><br />
Le prime esperienze <strong>di</strong> <strong>partecipazione</strong> nei quartieri risalgono al 1965, in particolare,<br />
per la zona nord <strong>del</strong>la città, a Borgo Trento, San Bartolomeo, Mompiano<br />
e V<strong>il</strong>laggio Prealpino. Si trattava però <strong>di</strong> episo<strong>di</strong> a sé stanti, temporanei e senza<br />
organicità, in cui i residenti facevano gruppo per risolvere qualche specifico problema<br />
<strong>di</strong> quartiere.<br />
L’avvio <strong>del</strong> movimento <strong>di</strong> quartiere vero e proprio viene datato al 1967, quando a<br />
Mompiano, in marzo, si costituisce <strong>il</strong> secondo comitato <strong>di</strong> quartiere <strong>del</strong>la città, che<br />
segue <strong>di</strong> qualche mese quello attivato spontaneamente a San Polo in gennaio.<br />
All’interno dei comitati si <strong>di</strong>scute dei problemi più r<strong>il</strong>evanti <strong>del</strong>la zona, e presto si<br />
fa sentire <strong>il</strong> desiderio <strong>di</strong> trasformarli in consigli <strong>di</strong> quartiere, con l’intento <strong>di</strong> dar vita<br />
a un organismo solido e rappresentativo, capace <strong>di</strong> <strong>di</strong>ventare protagonista <strong>del</strong>le<br />
battaglie più importanti, come quelle per la casa, i trasporti, la scuola e i servizi.<br />
Bisognerà attendere l’inizio degli <strong>anni</strong> Settanta per passare dalla spontaneità iniziale<br />
<strong>del</strong> movimento, ancora troppo frammentato per riuscire a interloquire con<br />
l’amministrazione comunale, ad una fase <strong>di</strong> maturazione: fu in quel periodo che i<br />
comitati <strong>di</strong> quartiere si dotarono <strong>di</strong> statuti che ponevano l’assemblea dei citta<strong>di</strong>ni<br />
al centro <strong>del</strong>le attività decisionali, e che stab<strong>il</strong>ivano le modalità <strong>di</strong> elezione dei<br />
futuri Consigli <strong>di</strong> quartiere, che avrebbero rappresentato l’organismo esecutivo<br />
<strong>del</strong>l’assemblea.<br />
In alcune zone, in particolare a Mompiano e Borgo Trento, si optò per l’elezione<br />
<strong>di</strong>retta in seno all’assemblea dei residenti, mentre in altri quartieri, come la<br />
zona <strong>di</strong> via Chiusure, si procedette a vere e proprie elezioni a suffragio universale.<br />
Alla fine <strong>del</strong> 1970 erano già operanti cinque Consigli <strong>di</strong> quartiere, fra cui Mompiano<br />
e Borgo Trento, mentre si stavano preparando le elezioni al V<strong>il</strong>laggio Preal-<br />
43
Archivio Solidarietà Viva<br />
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
pino, e <strong>il</strong> movimento <strong>di</strong> <strong>partecipazione</strong> si stava ra<strong>di</strong>cando anche a Casazza e San<br />
Bartolomeo.<br />
Nei quartieri stava crescendo l’interesse a partecipare alle scelte <strong>di</strong> amministrazione<br />
citta<strong>di</strong>na, tanto che in una riunione <strong>del</strong> Consiglio <strong>di</strong> Mompiano, nel <strong>di</strong>cembre<br />
<strong>del</strong> 1970, vennero messi a fuoco due punti car<strong>di</strong>nali attorno a cui sarebbe ruotata<br />
la riven<strong>di</strong>cazione dei Consigli: fu avanzata la possib<strong>il</strong>ità <strong>di</strong> analizzare i b<strong>il</strong>anci<br />
<strong>del</strong> <strong>Comune</strong> e si espresse <strong>il</strong> desiderio <strong>di</strong> intervenire sulle scelte urbanistiche che<br />
interessavano la zona.<br />
Nel giugno <strong>del</strong> 1971 nacque anche <strong>il</strong> Comitato <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento fra i quartieri,<br />
ritenuto un passaggio in<strong>di</strong>spensab<strong>il</strong>e per acquisire omogeneità <strong>di</strong> azione e rappresentatività.<br />
Il coor<strong>di</strong>namento chiedeva esplicitamente un riconoscimento ufficiale<br />
dei Consigli <strong>di</strong> quartiere da parte <strong>del</strong> <strong>Comune</strong>, e l’assegnazione <strong>di</strong> mezzi e strumenti<br />
(come le se<strong>di</strong>) perchè potessero espletare al meglio <strong>il</strong> loro ruolo.<br />
L’atteso riconoscimento da parte <strong>del</strong> Consiglio comunale arrivò <strong>il</strong> 28 luglio <strong>del</strong><br />
1972, con la previsione <strong>di</strong> un periodo <strong>di</strong> “sperimentazione” <strong>di</strong> 18 mesi, e la programmazione<br />
nei quartieri <strong>di</strong> elezioni a suffragio universale (con l’estensione <strong>del</strong><br />
<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto ai <strong>di</strong>ciottenni, nonostante la maggiore età fosse allora fissata a<br />
1969: asfaltate le strade, <strong>il</strong> primo autobus <strong>di</strong> linea entra nel v<strong>il</strong>laggio Prealpino<br />
44
3. CENNI STORICI DELLA NORD<br />
ventuno <strong>anni</strong>) con lista unica aperta a tutti i citta<strong>di</strong>ni.<br />
Fra <strong>il</strong> 1973 e <strong>il</strong> ’74 vennero eletti <strong>30</strong> Consigli <strong>di</strong> quartiere. Le zone <strong>del</strong>l’attuale<br />
circoscrizione Nord in cui si inse<strong>di</strong>arono Consigli furono quartieri piccoli come<br />
San Bartolomeo e Casazza, che avevano meno <strong>di</strong> 5 m<strong>il</strong>a abitanti, aree <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a<br />
<strong>di</strong>mensione - come Mompiano, <strong>il</strong> V<strong>il</strong>laggio Prealpino, Costalunga-San Rocchino - e<br />
quartieri più popolosi come Borgo Trento e Sant’Eustacchio, con una popolazione<br />
superiore a 10 m<strong>il</strong>a abitanti.<br />
Una volta terminato <strong>il</strong> periodo <strong>di</strong> “sperimentazione”, <strong>il</strong> coor<strong>di</strong>namento dei quartieri<br />
avviò un confronto con l’amministrazione comunale per <strong>del</strong>ineare un regolamento<br />
con<strong>di</strong>viso, che co<strong>di</strong>ficasse le competenze assegnate ai Consigli <strong>di</strong> quartiere.<br />
Da parte <strong>di</strong> questi ultimi, <strong>di</strong> pari passo con <strong>il</strong> ra<strong>di</strong>camento in città, cresceva l’interesse<br />
a partecipare da protagonisti alle decisioni sui no<strong>di</strong> amministrativi, sociali<br />
e urbanistici.<br />
Una vera svolta per i quartieri sarà l’approvazione in <strong>Comune</strong> <strong>del</strong>l’atteso regolamento<br />
nell’apr<strong>il</strong>e <strong>del</strong> 1975, che recepiva molte <strong>del</strong>le istanze avanzate dal coor<strong>di</strong>namento<br />
dei Consigli, prevedendo la consultazione obbligatoria <strong>di</strong> questi ultimi<br />
su alcuni temi centrali per la vita amministrativa citta<strong>di</strong>na, quali i b<strong>il</strong>anci comunali<br />
<strong>di</strong> previsione, i piani regolatori, le convenzioni urbanistiche, i piani <strong>di</strong> ed<strong>il</strong>izia economica<br />
e popolare, l’informazione obbligatoria sulle richieste <strong>di</strong> licenze ed<strong>il</strong>izie<br />
riguardanti <strong>il</strong> quartiere, la facoltà <strong>di</strong> proposta <strong>di</strong> iniziative idonee per i servizi sociali<br />
<strong>di</strong> zona.<br />
La normativa prendeva atto <strong>del</strong> ruolo riconosciuto <strong>di</strong> fatto ai Consigli <strong>di</strong> quartiere,<br />
che avevano già contribuito alla <strong>di</strong>scussione sulla variante al Piano regolatore approvata<br />
dal <strong>Comune</strong> nel giugno <strong>del</strong> 1973, in cui nel complesso erano state recepite<br />
le istanze proposte dai quartieri: fra queste la necessità <strong>di</strong> salvaguardare l’area <strong>del</strong>le<br />
colline, con l’imposizione <strong>di</strong> un vincolo <strong>di</strong> tutela per Sant’Anna e la Maddalena, e<br />
per la parte <strong>del</strong> colle San Giuseppe ancora libera da convenzioni <strong>di</strong> lottizzazione.<br />
Nel frattempo anche <strong>il</strong> Parlamento stava affrontando la questione <strong>del</strong>la <strong>partecipazione</strong><br />
“dal basso” ai temi amministrativi locali, che si sarebbe tradotta nella legge<br />
nazionale sul decentramento, la n. 278 <strong>del</strong>l’apr<strong>il</strong>e 1976, che prevedeva la possib<strong>il</strong>ità<br />
per i Comuni <strong>di</strong> <strong>di</strong>videre <strong>il</strong> proprio territorio in Circoscrizioni.<br />
Dopo un decennio <strong>di</strong> esperienza partecipativa, anche <strong>Brescia</strong> intraprese <strong>il</strong> cammino<br />
che porterà, nell’apr<strong>il</strong>e <strong>del</strong> 1977, ad approvare <strong>il</strong> regolamento locale attuativo<br />
<strong>del</strong>la legge.<br />
45
Archivio Solidarietà Viva<br />
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
Anni ‘60, scuola materna al Prealpino<br />
46<br />
Con questo passaggio <strong>il</strong> Consiglio<br />
comunale introdusse<br />
la sud<strong>di</strong>visione territoriale in<br />
nove Circoscrizioni al posto<br />
dei trenta quartieri originari,<br />
accorpando Mompiano, V<strong>il</strong>laggio<br />
Prealpino, Costalunga-San<br />
Rocchino e Crocifissa <strong>di</strong> Rosa<br />
nella Seconda Circoscrizione,<br />
mentre Borgo Trento, San<br />
Bartolomeo, Sant’Eustacchio e<br />
Casazza formeranno la Prima<br />
Circoscrizione. Nella primavera<br />
<strong>del</strong> 1978 vennero eletti<br />
dal Consiglio comunale i primi<br />
Consigli <strong>di</strong> Circoscrizione,<br />
che rimasero in carica fino al<br />
1980 quando, in contemporanea<br />
con le elezioni in Loggia, a<br />
suffragio universale i bresciani<br />
votarono <strong>il</strong> rinnovo dei Consigli<br />
<strong>di</strong> Circoscrizione.<br />
La ripartizione <strong>del</strong> territorio urbano in nove Circoscrizioni è rimasta valida fino<br />
alla riforma <strong>del</strong> decentramento comunale votata in Loggia nell’ottobre <strong>del</strong> 2007<br />
- ed entrata formalmente in vigore con le elezioni amministrative <strong>del</strong>la primavera<br />
2008 - che ha ridotto <strong>il</strong> numero <strong>del</strong>le Circoscrizioni da nove a cinque (denominate<br />
Centro, Nord, Est, Ovest, Sud).<br />
Nella Circoscrizione Nord sono state unite le originarie Prima e Seconda Circoscrizione,<br />
con i relativi quartieri, ad eccezione <strong>di</strong> Crocifissa <strong>di</strong> Rosa, che è stato<br />
scorporato per andare a far parte <strong>del</strong>la Circoscrizione Centro.
i PReSidenTi <strong>del</strong>la PRiMa ciRcoScRizione<br />
1978 - 1982 • Italo Cerruti<br />
3. CENNI STORICI DELLA NORD<br />
Nato a Sesto San Giov<strong>anni</strong>, Italo Cerruti è praticamente<br />
bresciano <strong>di</strong> adozione, a <strong>Brescia</strong> ha effettuato gli stu<strong>di</strong><br />
al liceo scientifico, a <strong>Brescia</strong> è ritornato dopo le vicissitu<strong>di</strong>ni<br />
<strong>del</strong>la guerra, qui si è sposato e tutt’ora vive con<br />
la moglie. Laureatosi in ingegneria al termine <strong>del</strong> conflitto<br />
Cerruti lavora per <strong>anni</strong> per <strong>il</strong> Ministero dei Trasporti,<br />
presso la motorizzazione civ<strong>il</strong>e. Dal punto <strong>di</strong> vista politico Cerruti è sempre stato<br />
un libero pensatore e questo si è riflesso in maniera particolare sul suo operato da<br />
presidente <strong>di</strong> circoscrizione, attento alle cose pratiche più che agli interessi <strong>del</strong>la<br />
politica. Tra i protagonisti <strong>del</strong>la nascita dei comitati <strong>di</strong> quartiere Cerruti prende<br />
<strong>il</strong> posto <strong>del</strong>l’ingegner Buizza qualche anno prima che le circoscrizioni vengano<br />
istituzionalizzate e nelle prime votazioni viene eletto come presidente, carica che<br />
occupa con impegno ottenendo importanti risultati. Tra tutti la valorizzazione <strong>di</strong><br />
Borgo Trento e l’assegnazione <strong>del</strong>la sede <strong>del</strong>la circoscrizione <strong>di</strong> via Montegrappa.<br />
1982 - 1986 • Amedea Gianotti (PCI)<br />
Nata nel 1931 a Reggio Em<strong>il</strong>ia, zona particolarmente<br />
sensib<strong>il</strong>e al decentramento, e cresciuta politicamente,<br />
sin da giovane nel Pci, Amedea Gianotti, giunge a <strong>Brescia</strong>,<br />
dopo aver conosciuto <strong>il</strong> marito, A<strong>del</strong>io Terraroli, che<br />
sarà consigliere regionale e parlamentare, all’età <strong>di</strong> 24<br />
<strong>anni</strong>. Particolarmente sensib<strong>il</strong>e all’attività sociale e <strong>di</strong><br />
volontariato la Gianotti lavorerà per la nascita dei comitati <strong>di</strong> quartiere, sino a<br />
<strong>di</strong>venire presidente nel 1982 in prima circoscrizione: ruolo che manterrà sino al<br />
1986. Successivamente impegni famigliari la porteranno a tralasciare la passione<br />
per la politica.<br />
47
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
1986 - 1990 • Rolando Corinaldesi (PRI)<br />
Nato nel ’32, in provincia <strong>di</strong> Ascoli, anche, Rolando Corinaldesi, come la maggioranza<br />
dei primi presidenti <strong>di</strong> circoscrizione, si avvicina alla politica più per<br />
spirito <strong>di</strong> servizio, per essere ut<strong>il</strong>e alla comunità, che per intraprendere la carriera<br />
politica.<br />
Ingegnere, Corinaldesi è un mazziniano convinto e nel ’86 visto <strong>il</strong> suo valore<br />
umano e professionale viene inserito all’interno <strong>del</strong>le liste <strong>del</strong> Pri.<br />
Eletto presidente <strong>di</strong> circoscrizione Corinaldesi vive questa esperienza con impegno<br />
e de<strong>di</strong>zione ma al termine abbandona la politica amareggiato, soprattutto,<br />
dal marcio messo in vetrina da Tangentopoli. Scompare nel 1996.<br />
1990 - 1993 • Bruno Bonera (PSI)<br />
Nato a <strong>Brescia</strong> nel 1942, coniugato con un figlio,<br />
Bruno Bonera lavora come operaio all’Iveco, poi,<br />
conseguito <strong>il</strong> <strong>di</strong>ploma <strong>di</strong> geometra frequentando le<br />
lezioni serali al “Tartaglia”, viene inserito nell’ufficio<br />
progetti <strong>del</strong>la medesima <strong>di</strong>tta.<br />
Dal punto <strong>di</strong> vista politico,Bonera, <strong>di</strong> provenienza socialista,<br />
vive la nascita dei comitati <strong>di</strong> quartiere, poi, l’esperienza dei primi<br />
consigli <strong>di</strong> circoscrizione, sino a <strong>di</strong>venire presidente <strong>del</strong>la prima nel ’90.<br />
Conclusa questa esperienza Bonera continua ancora per qualche anno la<br />
propria attività istituzionale come consigliere <strong>di</strong> circoscrizione. Attualmente<br />
collabora ed appoggia i socialisti rappresentati da Laura Castelletti.<br />
48
3. CENNI STORICI DELLA NORD<br />
1993 - 1994 • Renato Pigoli (Lega Nord)<br />
Artigiano, 2 figli, classe 1955, Renato Pigoli cresce politicamente all’interno<br />
dei movimenti giovan<strong>il</strong>i <strong>di</strong> estrema sinistra ma alla fine degli <strong>anni</strong> ’80, ritrovandosi<br />
nella politica <strong>del</strong>la prima Lega Nord, decide <strong>di</strong> legarsi al partito <strong>di</strong><br />
Umberto Bossi: è <strong>il</strong> settimo bresciano ad aderire al Carroccio.<br />
Nel ’93 <strong>di</strong>viene presidente <strong>del</strong>la prima circoscrizione, un incarico mantenuto per<br />
pochi mesi e vissuto con grande <strong>partecipazione</strong> da Pigoli che, tuttavia, l’anno<br />
successivo, <strong>del</strong>uso dalla politica, abbandona definitivamente quest’esperienza<br />
de<strong>di</strong>candosi a lavoro e famiglia.<br />
1994 - 1997 • Vittorio Gobbi (DS)<br />
Nato nel 1937 a Vobarno Vittorio Gobbi si trasferisce<br />
presto a <strong>Brescia</strong>, lavorando presso la Cinematic, ed avvicinandosi<br />
all’attività politica attraverso la Cg<strong>il</strong>, rapporto<br />
che non interromperà mai. Agli inizi degli <strong>anni</strong> ’70 cominciano<br />
a nascere i primi comitati <strong>di</strong> quartiere, che solo<br />
nel 1978 verranno istituzionalizzati come circoscrizioni e<br />
Gobbi è protagonista anche in questo periodo, impegnandosi particolarmente in<br />
quella che fu la prima circoscrizione.<br />
Dopo <strong>di</strong>eci <strong>anni</strong> <strong>di</strong> esperienza come consigliere circoscrizionale Gobbi <strong>di</strong>viene presidente<br />
<strong>del</strong>la prima nel ’94, rimanendo in carica sino al ’97. Passato <strong>il</strong> testimone<br />
ad Onofri, Gobbi vive ancora due legislature da consigliere, fino alle ultime votazioni<br />
dove non riesce a raggiungere i voti necessari per entrare nel consiglio <strong>del</strong>la<br />
circoscrizione nord.<br />
Attualmente è membro esterno <strong>del</strong>la commissione attività promozionali <strong>del</strong>la<br />
Nord, m<strong>il</strong>itante attivo <strong>del</strong> Pd ma, soprattutto, è impegnato nelle attività sociali e<br />
<strong>di</strong> volontariato all’interno <strong>del</strong>la associazione quartiere Casazza, che rappresentano<br />
la sua priorità.<br />
49
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
1997 - 1999 • Giulio Onofri (PPI)<br />
Scomparso improvvisamente nel 2000, all’età <strong>di</strong> settant’<strong>anni</strong>,<br />
<strong>di</strong> professione avvocato, Giulio Onofri ha de<strong>di</strong>cato<br />
buona parte <strong>del</strong>la sua esistenza nell’impegno al<br />
servizio <strong>del</strong>la comunità.<br />
Formatosi in ambiente cristiano, grazie agli stu<strong>di</strong> all’Arici<br />
e, poi, alla laurea in legge conseguita in Cattolica, Onofri<br />
m<strong>il</strong>itò all’interno <strong>di</strong> Azione Cattolica, durante gli <strong>anni</strong> ’50. Nel 1960 lo ritroviamo<br />
nel consiglio comunale, inizialmente come assessore al personale, successivamente<br />
come assessore ai Lavori pubblici ed agli Affari Generali, a fianco <strong>del</strong> sindaco<br />
Bruno Boni.<br />
Nel 1965 <strong>di</strong>venne segretario provinciale <strong>del</strong>la Dc, incaricò che ricoprì sino al 1969.<br />
Al termine <strong>di</strong> questo periodo Onofri preferisce allontanarsi, per un certo periodo,<br />
dalla vita politica per de<strong>di</strong>carsi alla guida <strong>del</strong>l’Ospedale Civ<strong>il</strong>e, <strong>di</strong> cui resta presidente<br />
per <strong>di</strong>eci <strong>anni</strong>, a partire dal 1978, prendendo <strong>il</strong> posto <strong>di</strong> Italo Nicoletto che<br />
resterà, comunque, al suo fianco come vice.<br />
A metà degli <strong>anni</strong> ’80 si riaffaccia sulla scena politica: per un breve periodo rientra<br />
nella segreteria citta<strong>di</strong>na <strong>del</strong>la Dc, anche se in maniera più def<strong>il</strong>ata: nel ’94 <strong>di</strong>viene<br />
consigliere in prima, poi, presidente.<br />
1999 - 2003 • Fausto Pracek (Forza Italia)<br />
Friulano, classe ’73, entra giovanissimo nel consiglio<br />
<strong>del</strong>la prima circoscrizione, eletto tra le liste <strong>di</strong> Forza Italia<br />
nel ’94, dopo essere stato fra i primissimi a <strong>Brescia</strong> ad<br />
aderire al nuovo movimento fondato da Berlusconi.<br />
Nel ‘96 è nominato coor<strong>di</strong>natore <strong>del</strong>la commissione cultura<br />
e nella successiva tornata elettorale viene rieletto con<br />
<strong>il</strong> maggior numero <strong>di</strong> preferenze e <strong>di</strong>viene presidente <strong>del</strong>la prima: siamo nel ’99.<br />
Per quattro <strong>anni</strong> governa <strong>il</strong> consiglio <strong>del</strong>la circoscrizione attraverso un accordo<br />
istituzionale fra tutti i partiti rappresentati a causa <strong>del</strong>la mancanza <strong>di</strong> una chiara<br />
maggioranza politica.<br />
50
3. CENNI STORICI DELLA NORD<br />
Terminato <strong>il</strong> mandato viene rieletto nel 2003, come consigliere nella medesima<br />
circoscrizione, dal cui ruolo si <strong>di</strong>mette nel 2007 causa pressanti impegni <strong>di</strong><br />
lavoro. Appassionato <strong>di</strong> volo, attualmente è titolare <strong>di</strong> una nota società <strong>di</strong> consulenza<br />
e sv<strong>il</strong>uppo software in città.<br />
2003 - 2008 • Marco Toma (UDC)<br />
Nato a <strong>Brescia</strong> <strong>il</strong> 10 marzo 1971 dove risiede tutt’ora,<br />
coniugato, laureato in giurisprudenza presso l’Università<br />
degli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> M<strong>il</strong>ano, esercita la professione <strong>di</strong><br />
avvocato.<br />
Cresciuto politicamente nella Democrazia Cristiana,<br />
partito in cui ha m<strong>il</strong>itato sin da giovane, Toma partecipa<br />
attivamente al percorso che porterà alla formazione <strong>del</strong> CCD prima, all’interno<br />
<strong>del</strong> quale ha ricoperto <strong>di</strong>versi incarichi soprattutto per quanto riguarda i<br />
movimenti giovan<strong>il</strong>i ed universitari, e <strong>del</strong>l’Udc, poi, <strong>di</strong>venendo membro attivo<br />
<strong>del</strong>la segreteria citta<strong>di</strong>na <strong>del</strong> partito.<br />
Partecipa attivamente alla nascita <strong>del</strong> Pdl bresciano ed è tra i fondatori <strong>del</strong>l’associazione<br />
Popolarismo Europeo. Nel ’94 <strong>di</strong>viene consigliere <strong>di</strong> circoscrizione,<br />
nel 2003 <strong>di</strong>viene, invece, presidente in prima circoscrizione, incarico che ricopre<br />
sino al 2008, anno in cui viene eletto come consigliere comunale all’interno<br />
<strong>del</strong>le liste <strong>del</strong> Popolo <strong>del</strong>le Libertà.<br />
Attualmente è presidente <strong>del</strong>la Commissione Cons<strong>il</strong>iare Urbanistica e Viab<strong>il</strong>ità<br />
e membro <strong>del</strong>la Commissione Cons<strong>il</strong>iare Commercio, Economia, Lavoro e Turismo<br />
<strong>del</strong> <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>.<br />
51
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
i PReSidenTi <strong>del</strong>la Seconda ciRcoScRizione<br />
1978 - 1980 • Scipione Magoni (DC)<br />
Figura impegnata nella Democrazia Cristiana locale,<br />
Magoni proveniva da esperienze <strong>di</strong> attivismo nel sociale<br />
e sul territorio, negli organismi <strong>di</strong> <strong>partecipazione</strong> nelle<br />
scuole, come i consigli dei genitori. A lui spettò <strong>il</strong> compito<br />
<strong>di</strong> avviare la “macchina” <strong>del</strong>la Circoscrizione, e <strong>di</strong> traghettare<br />
l’esperienza dei Consigli <strong>di</strong> quartiere nel nuovo<br />
organismo istituzionale <strong>del</strong> decentramento voluto dalla legge nazionale 278 <strong>del</strong><br />
1976. L’attività prioritaria <strong>del</strong> Consiglio guidato da Magoni fu quella <strong>di</strong> preparazione<br />
e stesura <strong>del</strong>lo statuto <strong>del</strong>la Circoscrizione, che <strong>del</strong>ineava commissioni<br />
<strong>di</strong> lavoro e modalità per promuovere la <strong>partecipazione</strong> popolare alla gestione<br />
amministrativa attraverso assemblee consultive perio<strong>di</strong>che.<br />
1980 - 1985 • Lucio Scalvini (DC)<br />
Nato a Leno nel 1936, è stato funzionario <strong>di</strong> banca. Il<br />
suo impegno civico inizia negli <strong>anni</strong> Settanta, quando<br />
ricopre <strong>il</strong> ruolo <strong>di</strong> presidente <strong>del</strong>l’ospedale <strong>di</strong> Leno e <strong>di</strong><br />
vice presidente <strong>del</strong> Comitato sanitario <strong>di</strong> zona per <strong>Brescia</strong>.<br />
Eletto alla presidenza <strong>del</strong>la Circoscrizione con una<br />
maggioranza composta da Dc, liberali, repubblicani e<br />
Ps<strong>di</strong>, <strong>il</strong> suo mandato è stato caratterizzato da una <strong>partecipazione</strong> pressoché con<strong>di</strong>visa<br />
alle scelte amministrative da parte <strong>di</strong> tutti gli schieramenti politici.<br />
Fra i gran<strong>di</strong> temi affrontati sotto la sua presidenza si ricorda l’impegno <strong>del</strong>la Circoscrizione<br />
per verificare con Asm le garanzie <strong>di</strong> non inquinamento <strong>del</strong>la Centrale<br />
nord <strong>del</strong> teleriscaldamento, e la grande nevicata <strong>del</strong> 1985, in cui alla Circoscrizione<br />
venne data una autonomia finanziaria per contattare e compensare i privati<br />
<strong>di</strong>sponib<strong>il</strong>i a sgombrare le strade dalla neve.<br />
52
1985 - 1990 • Guido Bonar<strong>di</strong> (PSI)<br />
Figura impegnata nel Psi bresciano, attivo nel coor<strong>di</strong>namento<br />
provinciale <strong>del</strong> partito, in Circoscrizione Bonar<strong>di</strong><br />
fu alla guida <strong>di</strong> una coalizione <strong>del</strong>l’allora pentapartito<br />
(Dc, Psi, Ps<strong>di</strong>, liberali, repubblicani).<br />
Sfruttando un’ampia con<strong>di</strong>visione <strong>di</strong> intenti <strong>di</strong>ede <strong>il</strong> via<br />
a due iniziative destinate a lasciare <strong>il</strong> segno sul territorio<br />
<strong>del</strong>la Circoscrizione. Sotto la sua presidenza vennero aperti per la prima volta gli<br />
uffici <strong>del</strong>l’Anagrafe decentrata, che trovarono posto a Mompiano, nella vecchia<br />
sede <strong>del</strong>la Circoscrizione, spostata in via Colle <strong>di</strong> Ca<strong>di</strong>bona.<br />
Nei locali attigui alla nuova sede <strong>del</strong>la Seconda venne inaugurata anche la biblioteca<br />
decentrata, integrata nel Sistema bibliotecario urbano, oltre a un centro <strong>di</strong><br />
aggregazione con sala pubblica per <strong>di</strong>battiti e proiezioni <strong>di</strong> f<strong>il</strong>m, che rappresenterà<br />
nel corso degli <strong>anni</strong> un significativo punto <strong>di</strong> riferimento per la vita sociale dei<br />
quartieri.<br />
1990-1995 • Mario Grottolo<br />
(DC e successivamente PPI)<br />
3. CENNI STORICI DELLA NORD<br />
Nato a <strong>Brescia</strong> nel 1946, <strong>di</strong> professione biologo, è stato<br />
<strong>di</strong>rigente <strong>del</strong>l’ASL <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>.<br />
La sua esperienza politica matura negli organismi <strong>di</strong><br />
base, prima nel Comitato Sanitario <strong>di</strong> Zona <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>,<br />
quale responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong>la Me<strong>di</strong>cina scolastica, poi nel<br />
quartiere <strong>di</strong> Crocifissa <strong>di</strong> Rosa, in cui ha ricoperto la<br />
carica <strong>di</strong> presidente <strong>del</strong> Consiglio <strong>di</strong> quartiere, e successivamente nella Seconda<br />
Circoscrizione, come consigliere fin dalla sua istituzione.<br />
Durante <strong>il</strong> suo mandato <strong>di</strong> presidente <strong>del</strong>la Circoscrizione, dal 1990 al 1995,<br />
ha guidato una coalizione <strong>del</strong>l’allora pentapartito (Dc, Psi, Ps<strong>di</strong>, liberali, repubblicani).<br />
Fra i traguar<strong>di</strong> significativi raggiunti in quel quinquennio si ricorda<br />
la realizzazione definitiva <strong>del</strong> parco Castelli, opera ritenuta prioritaria per la<br />
Circoscrizione.<br />
53
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
1995 - 1999 • Francesco Arenghi (FI)<br />
La carriera politica <strong>di</strong> Francesco Arenghi, nato a Vezza<br />
d’Oglio nel 1961, inizia nel 1994, quando viene eletto<br />
nel primo <strong>di</strong>rettivo <strong>di</strong> Forza Italia all’interno <strong>del</strong> quale<br />
resta sino al 1997. Quasi contemporanea è la sua<br />
elezione a presidente <strong>del</strong>la Seconda Circoscrizione, incarico<br />
che occupa fino al ’98. Questi <strong>anni</strong> lo vedono<br />
particolarmente impegnato nella <strong>partecipazione</strong> a varie commissioni comunali<br />
e provinciali ed in particolare nella commissione provinciale sicurezza per i problemi<br />
relativi al tifo violento. Nel ’99 <strong>di</strong>viene consigliere, sempre in Seconda,<br />
nonché capogruppo <strong>di</strong> Forza Italia nel consiglio <strong>del</strong>la Circoscrizione, oltre ad<br />
essere segretario citta<strong>di</strong>no <strong>del</strong> suo partito, sino al 2001. Attualmente è membro<br />
<strong>del</strong> <strong>di</strong>rettivo provinciale <strong>di</strong> Forza Italia e capogruppo Pdl <strong>del</strong>la Circoscrizione<br />
Nord <strong>del</strong> <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>.<br />
1999 - 2003 • 2003 - 2008<br />
Giambattista Ferrari (DS)<br />
Nato a <strong>Brescia</strong> nel 1961, perito aziendale e corrispondente<br />
in lingue estere, ha lavorato nel settore <strong>del</strong> commercio<br />
alimentare e presso Poste Italiane.<br />
L’incontro con l’impegno civico e politico avviene nel<br />
1989, a Mompiano, con la costituzione <strong>del</strong> Comitato<br />
per la realizzazione <strong>del</strong> Parco Castelli. Nel corso <strong>di</strong><br />
quell’esperienza Ferrari sarà presidente <strong>del</strong>la Cooperativa <strong>del</strong> Parco. Nel 1994<br />
viene eletto consigliere alla Seconda Circoscrizione <strong>di</strong> cui <strong>di</strong>viene presidente nel<br />
1998.<br />
Riconfermato alla guida <strong>del</strong>la Seconda nel 2003, ha lavorato per promuovere<br />
valore e rispetto <strong>del</strong>lo spazio pubblico nel segno <strong>del</strong> rapporto con citta<strong>di</strong>ni e associazioni.<br />
Dal 2005 al 2007 è stato anche segretario citta<strong>di</strong>no dei Democratici<br />
<strong>di</strong> Sinistra. Dal 2008 è consigliere comunale nel gruppo <strong>del</strong> Partito Democratico e<br />
membro <strong>del</strong>la Commissione cons<strong>il</strong>iare Urbanistica e Viab<strong>il</strong>ità.<br />
54
<strong>il</strong> PReSidenTe <strong>del</strong>la ciRcoScRizione noRd<br />
Marco Rossi (FI)<br />
3. CENNI STORICI DELLA NORD<br />
Nato a <strong>Brescia</strong> <strong>il</strong> 26 marzo 1955, laureato in Economia<br />
e Commercio presso l’Università degli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>, è<br />
sposato dal 1990.<br />
Specializzato in Marketing e Gestione <strong>del</strong>la Pubblicità<br />
presso l’Università Cattolica <strong>di</strong> M<strong>il</strong>ano e la Laurea in<br />
Comunicazione Sociale presso la Pontificia Università<br />
Lateranense in Vaticano è giornalista e collabora con testate locali, regionali e<br />
nazionali.<br />
Specializzato in tematiche <strong>di</strong> carattere agricolo, agroalimentare ed enogastronomico,<br />
è impegnato nella valorizzazione <strong>del</strong> territorio bresciano oltre ad essere<br />
docente <strong>di</strong> Marketing presso l’Accademia Santa Giulia <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>.<br />
L’impegno politico, lo vede come vice coor<strong>di</strong>natore citta<strong>di</strong>no <strong>di</strong> Forza Italia, oltre<br />
che attuale presidente <strong>del</strong>la circoscrizione nord, dopo essere stato per due legislature<br />
consigliere presso la seconda circoscrizione come capo gruppo <strong>di</strong> Forza Italia<br />
e componente <strong>del</strong>le Commissioni Attività Promozionali e Servizi Sociali.<br />
55
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
Vista aerea <strong>del</strong>l’imbocco <strong>del</strong>la Valle <strong>di</strong> Mompiano 56<br />
© Archivio Gnàri dè Mompià - Foto Fausto Martini
4. LA CIRCOSCRIZIONE RACCONTATA<br />
Capitolo 4<br />
La Circoscrizione raccontata<br />
La storia <strong>del</strong>le Circoscrizioni è la storia degli uomini che le hanno abitate, e che<br />
con ruoli e modalità <strong>di</strong>verse – molti da semplici citta<strong>di</strong>ni – hanno inteso animare <strong>il</strong><br />
percorso <strong>di</strong> <strong>partecipazione</strong>, ciascuno con <strong>il</strong> proprio personale contributo.<br />
La lunga trama <strong>del</strong> decentramento a <strong>Brescia</strong> è in buona parte racchiusa, quasi cu-<br />
sto<strong>di</strong>ta gelosamente nelle testimonianze dei protagonisti, che a partire dagli <strong>anni</strong><br />
Sessanta hanno vissuto i primi fermenti partecipativi nei quartieri, li hanno seguiti<br />
e accompagnati fino alla nascita <strong>del</strong>le Circoscrizioni.<br />
La narrazione <strong>di</strong> queste esperienze, declinate nel sociale, nel civ<strong>il</strong>e o nella politica,<br />
compone un affresco da cui emerge l’aspetto forse più autentico <strong>di</strong> quegli <strong>anni</strong>,<br />
che lascia un’ere<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> cui fare memoria.<br />
57
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
i laVoRaToRi <strong>del</strong>la caMPagna, cHe aFFollaRono<br />
le FabbRicHe, cHieSeRo PaRTeciPazione e caMbiaRono<br />
la ciTTa’<br />
Angelo Boniotti<br />
Il 28 gennaio 1966, quando in bicicletta andai dal V<strong>il</strong>laggio Prealpino alla<br />
Trattoria Palazzina a Mompiano per incontrare i capi storici <strong>di</strong> alcune <strong>del</strong>le più<br />
importanti associazioni sociali e politiche <strong>di</strong> quel vivace quartiere, anche se mi<br />
sorreggeva l’euforia per la sorprendente vittoria elettorale nella recente competizione<br />
amministrativa, mi sentivo ansioso e in apprensione come <strong>il</strong> primo<br />
giorno <strong>di</strong> scuola, quando ragazzo <strong>di</strong> campagna varcai per la prima volta, senza<br />
conoscere nessuno, <strong>il</strong> portone <strong>del</strong>l’Istituto Magistrale.<br />
Andavo ad un appuntamento semiclandestino come promotore <strong>di</strong> una iniziativa<br />
considerata con sospetto negli ambienti politici, per fare una proposta<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>alogo e <strong>di</strong> collaborazione a chi aveva fama <strong>di</strong> elevata preparazione e <strong>di</strong><br />
lunga esperienza, ma anche <strong>di</strong> frequenti ra<strong>di</strong>cali contrapposizioni: comunisti,<br />
socialisti, democristiani anomali.<br />
In quegli <strong>anni</strong> la presunzione non veniva più considerata una colpa, perchè<br />
stava nascendo un movimento <strong>di</strong> persone che avevano sofferto la sud<strong>di</strong>tanza,<br />
l’esclusione, lo sfruttamento, la strumentalizzazione, la miseria, la fame,<br />
l’ignoranza e andavano scoprendo che i mali erano comuni e che, insieme,<br />
avrebbero potuto contare <strong>di</strong> più e risolvere meglio le proprie <strong>di</strong>fficoltà.<br />
Pedalando quella sera, come tante altre volte, ricordavo i tanti passaggi <strong>del</strong>la<br />
storia che stava accelerando e i tanti volti <strong>di</strong> amici e parenti che consumavano<br />
la vita nella fatica e nella speranza <strong>di</strong> uscire dalla comune miseria. Pochi<br />
<strong>anni</strong> prima avevo lasciato l’ambiente in cui ero cresciuto, un piccolo paese<br />
<strong>del</strong>la Franciacorta, abitato da montanari, mezzadri o emigranti in Svizzera, in<br />
cui era viva la memoria <strong>del</strong> sopruso operato dai fascisti con l’accorpamento<br />
coatto al comune <strong>di</strong> Provaglio, che aveva con<strong>di</strong>viso le povere abitazioni con<br />
gli sfollati durante gli ultimi <strong>anni</strong> <strong>del</strong>la guerra. Ricordavo quei giovani con cui<br />
giocavo infinite partite a calcio i quali, finita la guerra,tornati dalla montagna<br />
che avevano con<strong>di</strong>viso con i partigiani o dai campi <strong>di</strong> prigionia <strong>del</strong>la Germania,<br />
<strong>del</strong>la Polonia, <strong>del</strong>l’Africa, non potendo più trovare possib<strong>il</strong>ità <strong>di</strong> mantenimento<br />
58
4. LA CIRCOSCRIZIONE RACCONTATA<br />
nell’economia dei piccoli poderi<br />
<strong>di</strong> cui era formata l’agricoltura<br />
<strong>di</strong> Provezze, cercarono<br />
lavoro ovunque: nell’ed<strong>il</strong>izia<br />
come muratori, nelle officine<br />
e nelle fabbriche <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> o<br />
<strong>di</strong> M<strong>il</strong>ano. Al mattino, sullo<br />
stradone che collegava Iseo<br />
con <strong>Brescia</strong>, si formavano<br />
lunghe e nutrite f<strong>il</strong>e <strong>di</strong> biciclette<br />
che andavano verso la<br />
città. F<strong>il</strong>e ininterrotte <strong>di</strong> giovani<br />
che pedalavano, sotto<br />
la pioggia, con la neve, con<br />
<strong>il</strong> sole, in gruppi con la foga<br />
<strong>di</strong> chi non può arrivare tar<strong>di</strong>.<br />
Più o meno ci si conosceva<br />
tutti: giovani dei paesi vicini Angelo Boniotti durante l’esperienza partecipativa<br />
che avevamo incontrato nel<br />
campo <strong>di</strong> calcio o con i quali lavoravamo in fabbrica. Io andavo a scuola, non<br />
conoscevo nulla <strong>del</strong>la vita <strong>del</strong>la fabbrica, <strong>del</strong>l’attività sindacale, <strong>del</strong>le correnti<br />
ideologiche o politiche, se non quello che sentivo occasionalmente durante<br />
la mensa dai rappresentanti sindacali che tenevano i loro <strong>di</strong>scorsi mentre gli<br />
operai mangiavano. Non conoscevo nulla dei comuni, se non per le letture<br />
o per i racconti <strong>di</strong> amici impegnati nelle amministrazioni comunali. Ancora<br />
meno conoscevo l’attività <strong>del</strong>l’amministrazione comunale <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>, se non<br />
per i rapporti che questa aveva con <strong>il</strong> V<strong>il</strong>laggio Prealpino, quartiere nato <strong>di</strong><br />
recente e in cui abitavo da poco. Eppure i pochi <strong>anni</strong> <strong>di</strong> impegno nelle Acli<br />
furono un’esperienza culturale e sociale, una scuola <strong>di</strong> vita e <strong>di</strong> riflessione che<br />
mi fece capire con rapi<strong>di</strong>tà gli avvenimenti che ci coinvolgevano. Mi guidava<br />
l’entusiasmo <strong>di</strong> partecipare ad un’avventura che nob<strong>il</strong>itava l’impegno con la<br />
consapevolezza <strong>di</strong> donare tempo ed energie per aiutare la crescita culturale e<br />
contribuire a migliorare le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> vita <strong>di</strong> parenti ed amici.<br />
Anche la storia si era mossa ed ora stava accelerando e mi trascinava in una<br />
59
Archivio Solidarietà Viva<br />
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
avventura affascinante. Le Acli avevano maturato esperienze con le mon<strong>di</strong>ne,<br />
con i conta<strong>di</strong>ni e le case coloniche, con gli appren<strong>di</strong>sti e <strong>il</strong> lavoro minor<strong>il</strong>e, con<br />
i corsi <strong>di</strong> formazione sociale e politica, con gli incontri sociali nei Circoli <strong>di</strong> tutta<br />
la Provincia, con le esperienze amministrative <strong>di</strong> alcuni splen<strong>di</strong><strong>di</strong> <strong>di</strong>rigenti. Le<br />
loro idee erano chiare e feconde, <strong>il</strong> loro impegno conosciuto ed apprezzato dai<br />
lavoratori e dalle persone sensib<strong>il</strong>i e oneste <strong>di</strong> tutti gli schieramenti ideologici.<br />
Pensavano ad un mondo in cui le persone si parlano e si capiscono, in cui le<br />
idee si confrontano, in cui la solidarietà tra i poveri e i deboli è garanzia <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>gnità e <strong>di</strong> libertà, in cui la democrazia non si compra con la ricchezza, non si<br />
lascia con<strong>di</strong>zionare dai notab<strong>il</strong>i, in cui la laicità <strong>del</strong>le istituzioni è garanzia <strong>di</strong><br />
libertà anche per la religione. Pensavano che l’attività amministrativa dovesse<br />
essere orientata al bene comune, cioè al bene <strong>di</strong> tutte e <strong>di</strong> ciascuna <strong>del</strong>le<br />
persone e <strong>del</strong>le famiglie povere e in <strong>di</strong>fficoltà. I <strong>di</strong>rigenti erano contemporaneamente<br />
leader e maestri <strong>di</strong> vita ed in<strong>di</strong>rizzavano l‘impegno dei giovani<br />
con comprensione ed amicizia. Si spendevano generosamente nelle esperien-<br />
La prima sede <strong>del</strong> Comitato <strong>di</strong> Quartiere <strong>del</strong> V<strong>il</strong>laggio Prealpino<br />
60
4. LA CIRCOSCRIZIONE RACCONTATA<br />
ze <strong>del</strong>le ACLI: Don Agazzi, Mario Faini, Mario Picchieri, Franco Sarasini, Rita<br />
Gabelli, Adamo Baresi, Maffeo Chiecca, Alfredo Soggetti, Giov<strong>anni</strong> Botticini,<br />
Angelo Faccio, Giacomo Galeri e tantissimi altri.<br />
Andavo all’incontro <strong>del</strong>la Trattoria Palazzina certo con apprensione, perchè mi<br />
sentivo un neofita, ma sapevo che dove non arrivava la mia esperienza supplivano<br />
gli uomini <strong>del</strong>le Acli, <strong>il</strong> patrimonio <strong>di</strong> conoscenze e <strong>di</strong> idee che avevamo<br />
accumulato.<br />
In particolare quella sera con me ci sarebbero stati: Battista Fenaroli, per <strong>anni</strong><br />
l’addetto alla formazione, che poteva vantare una testimonianza <strong>di</strong> coerenza e<br />
<strong>di</strong> fe<strong>del</strong>tà <strong>di</strong>mostrata nella sua fabbrica e che ne fece per tanti <strong>anni</strong> un sicuro<br />
punto <strong>di</strong> riferimento anche nell’animazione <strong>di</strong> gruppi <strong>di</strong> presenza sindacale;<br />
Mario Dioni, un geometra che aveva collaborato con Padre Marcolini nello<br />
stu<strong>di</strong>o <strong>del</strong>le case per lavoratori con cui le cooperative La Famiglia riempirono<br />
i v<strong>il</strong>laggi; Gi<strong>anni</strong> Baresi, un ragioniere <strong>di</strong> S. Eufemia promotore <strong>di</strong> attività amministrative<br />
ed io. Facevamo parte <strong>del</strong> gruppo <strong>di</strong> amministratori aclisti, eletti<br />
consiglieri comunali a <strong>Brescia</strong> nelle liste <strong>del</strong>la Dc. Avevamo raccolto l’esperienza<br />
amministrativa <strong>di</strong> Mario Picchieri, non amavamo le correnti <strong>del</strong>la Dc, anche<br />
se sentivamo simpatia con i giovani <strong>di</strong> Provincia Democratica.<br />
Quella sera andavamo a verificare la possib<strong>il</strong>ità <strong>di</strong> <strong>di</strong>alogo con socialisti e<br />
comunisti e la <strong>di</strong>sponib<strong>il</strong>ità ad avviare forme <strong>di</strong> <strong>partecipazione</strong> <strong>di</strong> base sempre<br />
più sentite dalle periferie <strong>del</strong>la città. Sapevamo che <strong>il</strong> Partito <strong>di</strong> cui formalmente<br />
facevamo parte, ed in particolare <strong>il</strong> sindaco Boni e gli assessori, non con<strong>di</strong>videvano<br />
l’istituzione <strong>di</strong> organismi <strong>di</strong> <strong>partecipazione</strong> che sapevamo essere attivi<br />
in <strong>di</strong>verse città italiane e che sembravano programmi <strong>del</strong>la sinistra comunista.<br />
In preparazione <strong>del</strong>le elezioni <strong>del</strong> 1965 le Acli fac<strong>il</strong>itate dall’impegno, dalla<br />
capacità e dall’esperienza <strong>di</strong> un gruppo <strong>di</strong> eccezionali amministratori comunali<br />
come Chiecca, Soggetti, Pichieri, Botticini, Faccio, Dalola elaborarono e pubblicarono<br />
Il <strong>Comune</strong> Democratico, un libretto che riassumeva norme, proponeva<br />
obiettivi, iniziative e modalità amministrative chiare e concrete, destinato a<br />
guidare l’impegno dei consiglieri comunali aclisti. Di fatto fu l’occasione per<br />
innumerevoli incontri e convegni che arricchirono la cultura e l’attività <strong>di</strong> molte<br />
amministrazioni. Noi avevamo partecipato a questa straor<strong>di</strong>naria attività e<br />
facevamo tesoro <strong>del</strong>le in<strong>di</strong>cazioni elaborate.<br />
Nonostante la preoccupazione, che non era solo mia, l’incontro <strong>del</strong>la Palazzina<br />
61
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
fu cor<strong>di</strong>ale e promettente: Non ricordo tutti i partecipanti ma sicuramente erano<br />
presenti Battista Sarasini, Franco Saresera, Guido Onar<strong>di</strong>, Giacomo Galeri<br />
e Carlo Carli. Il nostro compito sarebbe stato quello <strong>di</strong> sollecitare <strong>il</strong> Partito<br />
<strong>del</strong>la Democrazia Cristiana ad assumere una iniziativa <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o e <strong>di</strong> proposta<br />
relativa al decentramento amministrativo.<br />
Nei mesi successivi, spinti dalle notizie <strong>del</strong>l’organizzazione <strong>di</strong> riunioni sim<strong>il</strong>i<br />
alla nostra realizzate in altri quartieri <strong>del</strong>la città, <strong>il</strong> consiglio citta<strong>di</strong>no <strong>del</strong>la<br />
Democrazia Cristiana <strong>di</strong> cui facevano parte i giovani <strong>di</strong> Provincia Democratica,<br />
che successivamente espressero come segretario citta<strong>di</strong>no. Giov<strong>anni</strong> Perfumi,<br />
permise la costituzione <strong>di</strong> una commissione <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o sul problema dei consigli<br />
<strong>di</strong> quartiere composta da S<strong>il</strong>vio Formenti, <strong>il</strong> dott. Marchese ed io. Con<br />
la collaborazione <strong>di</strong> Mario Picchieri e <strong>di</strong> Giov<strong>anni</strong> Perfumi, ci vennero inviati,<br />
dai Comuni che avevano <strong>del</strong>iberato o che avevano allo stu<strong>di</strong>o esperienza <strong>di</strong><br />
<strong>partecipazione</strong>, proposte e regolamenti. Fu così che la commissione produsse<br />
un regolamento moderato, mi pare sulla scorta <strong>di</strong> quello elaborato a Modena,<br />
che passò <strong>di</strong> mano in mano ma non venne mai ufficialmente <strong>del</strong>iberato dalla<br />
Democrazia Cristiana.<br />
Nel frattempo le esperienze <strong>di</strong> base, prima a S. Polo, poi a Mompiano, poi<br />
a Urago, a S. Eufemia, <strong>di</strong>edero vita all’esperienza spontanea dei consigli <strong>di</strong><br />
Quartiere, un’esperienza che la città e molti citta<strong>di</strong>ni ricordano con rimpianto<br />
e che, purtroppo, non si è poi trasformata in quella ventata <strong>di</strong> <strong>partecipazione</strong><br />
che avrebbe dovuto cambiare in meglio la città.<br />
62
la naSciTa <strong>del</strong> conSiglio <strong>di</strong> qUaRTieRe al PRealPino<br />
Lucio Bregoli<br />
4. LA CIRCOSCRIZIONE RACCONTATA<br />
“Ho vissuto l’esperienza dei Consigli <strong>di</strong> Quartiere dalla loro nascita, all’interno<br />
<strong>del</strong>l’esperienza che <strong>il</strong> Circolo Acli <strong>del</strong> V<strong>il</strong>l. Prealpino ed i Circoli <strong>del</strong>la città stavano<br />
facendo nei rispettivi quartieri.<br />
Durante gli <strong>anni</strong> sessanta le Acli hanno coinvolto i propri <strong>di</strong>rigenti e i propri iscritti<br />
a con<strong>di</strong>videre <strong>il</strong> desiderio <strong>di</strong> giustizia e <strong>di</strong> emancipazione <strong>del</strong> movimento operaio<br />
e conta<strong>di</strong>no, ra<strong>di</strong>cando le proprie motivazioni nel vangelo e nell’esperienza democratica<br />
che si stava vivendo in quegli <strong>anni</strong> scaturita dalla Resistenza” spiega Lucio<br />
Bregoli che, proprio al Prealpino, fu uno dei protagonisti nella nascita dei consigli<br />
<strong>di</strong> quartiere.<br />
“L’emancipazione dei lavoratori non poteva fermarsi solo ai posti <strong>di</strong> lavoro ma<br />
doveva contaminare anche la società, la vita politica e amministrativa ed è in<br />
questo <strong>il</strong> periodo che l’esperienza amministrativa <strong>di</strong> alcuni sindaci, che sono anche<br />
<strong>di</strong>rigenti provinciali <strong>del</strong>le Acli, porta un nuovo desiderio <strong>di</strong> <strong>di</strong>scutere e partecipare<br />
alla vita politica e amministrativa <strong>del</strong> Paese” prosegue Bregoli nel proprio racconto,<br />
ricordando che le Acli, la cui sede, al Prealpino, venne aperta nel ’64, furono la<br />
cassa <strong>di</strong> risonanza <strong>di</strong> questa volontà <strong>di</strong> <strong>partecipazione</strong> che veniva dalla gente.<br />
Le Acli, infatti, promuoveranno incontri, <strong>di</strong>battiti e corsi per amministratore che le<br />
cui sollecitazioni porteranno alla pubblicazione <strong>di</strong> un <strong>libro</strong> che, in quel periodo,<br />
ottenne un notevole successo proprio tra gli amministratori pubblici: “<strong>Comune</strong><br />
Democratico”.<br />
La nascita dei Comitati <strong>di</strong> Quartiere a <strong>Brescia</strong> e, quin<strong>di</strong>, anche al V<strong>il</strong>l. Prealpino<br />
vengono promossi, tra gli altri, proprio dai <strong>di</strong>rigenti locali dei Circoli Acli, sempre<br />
attenti all’impegno per la promozione e l’educazione sociale <strong>del</strong>la citta<strong>di</strong>nanza.<br />
Dall’inizio degli <strong>anni</strong> sessanta la <strong>partecipazione</strong> dei citta<strong>di</strong>ni alla vita <strong>del</strong> proprio<br />
<strong>Comune</strong> e <strong>del</strong> proprio quartiere <strong>di</strong>venne oggetto <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> molti <strong>di</strong>rigenti <strong>del</strong>le<br />
Acli ma, in particolare, vi furono degli “aclisti”, eletti nel Consiglio Comunale<br />
<strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>, che approfon<strong>di</strong>rono le esperienze <strong>di</strong> <strong>partecipazione</strong> e decentramento<br />
fatte in altre città come Bologna, Modena, Parma, Ferrara, Torino, Bergamo, tanto<br />
per citare quelle più importanti.<br />
“Essi <strong>di</strong>vulgarono tra gli iscritti alle Acli i regolamenti e le ipotesi <strong>di</strong> <strong>partecipazione</strong><br />
63
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
che in queste città si andavano costruendo e, per alcuni <strong>anni</strong>, queste ipotesi <strong>di</strong><br />
<strong>partecipazione</strong> furono oggetto <strong>di</strong> <strong>di</strong>scussioni e riflessioni non solo tra iscritti ma<br />
anche con citta<strong>di</strong>ni sensib<strong>il</strong>i a questa tematica.<br />
Fu così che quando, anche altre realtà politiche <strong>del</strong>la città, sollecitate dalle esperienze<br />
che stavano nascendo in molte città italiane in merito al decentramento,<br />
decisero <strong>di</strong> fare alcune sperimentazioni <strong>di</strong> <strong>partecipazione</strong> sul territorio trovarono<br />
i circoli Acli <strong>di</strong>sponib<strong>il</strong>i alla costruzione <strong>di</strong> questa importante esperienza <strong>di</strong> <strong>partecipazione</strong><br />
dal basso”.<br />
Nel gennaio <strong>del</strong> 1969 <strong>il</strong> Circolo Acli <strong>del</strong> V<strong>il</strong>laggio Prealpino rende pubblico alla<br />
popolazione lo statuto <strong>del</strong> nascente Comitato <strong>di</strong> Quartiere <strong>di</strong> Mompiano.<br />
Con una lettera inviata ai can<strong>di</strong>dati Dc, Psi, Pci e Psiup al Consiglio Comunale<br />
<strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> i Circoli Acli <strong>del</strong>la zona Nord chiedono ai can<strong>di</strong>dati, una volta eletti,<br />
impegni precisi in modo da non rendere vana la voglia <strong>di</strong> <strong>partecipazione</strong> <strong>di</strong> molti<br />
citta<strong>di</strong>ni e <strong>di</strong> limitare <strong>il</strong> loro mandato incontrollato, trasformandolo in uno strumento<br />
<strong>di</strong> vera vita democratica.<br />
Su questo tema <strong>il</strong> Consiglio <strong>del</strong> Circolo ACLI <strong>del</strong> V<strong>il</strong>l. Prealpino in<strong>di</strong>ce un <strong>di</strong>battito<br />
pubblico con i can<strong>di</strong>dati dei maggiori partiti democratici.<br />
Nel <strong>di</strong>cembre 1970, dopo una serie <strong>di</strong> incontri informali promossi dal Circolo ACLI,<br />
persone <strong>di</strong> <strong>di</strong>versa estrazione politica (DC, PSI, PRI, PLI, PCI, ACLI) danno vita al<br />
Comitato <strong>di</strong> Quartiere.<br />
“Sig. Can<strong>di</strong>dato, troppo spesso la campagna elettorale è ed è stata la “fiera <strong>del</strong>la<br />
demagogia”, lo sforzo organizzativo <strong>di</strong> partiti, <strong>di</strong> gruppi e <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui per carpire<br />
con tutti i mezzi l’adesione dei citta<strong>di</strong>ni a singoli e a uomini.<br />
Ma, passato <strong>il</strong> giorno <strong>del</strong>le elezioni, fatta la “conta” dei voti, <strong>il</strong> citta<strong>di</strong>no, tanto<br />
importante prima <strong>del</strong> voto, viene <strong>di</strong>menticato e per cinque <strong>anni</strong> gli amministratori<br />
interpretano, senza mai interpellarlo, le sue esigenze.<br />
E’ possib<strong>il</strong>e fare in modo che <strong>il</strong> citta<strong>di</strong>no, <strong>il</strong> lavoratore conti qualcosa <strong>di</strong> più <strong>di</strong> un<br />
voto? E’ possib<strong>il</strong>e prevedere momenti ed occasioni in cui le comunità <strong>di</strong> quartiere<br />
che vivono all’interno <strong>del</strong>la città possono esprimere <strong>il</strong> loro parere sui problemi<br />
<strong>del</strong>la vita amministrativa prima che le soluzioni <strong>di</strong>ventino formali <strong>del</strong>ibere <strong>del</strong> Consiglio<br />
Comunale?<br />
I Circolo Acli <strong>del</strong>la zona nord <strong>del</strong>la città ritengono che sia possib<strong>il</strong>e e che si tratti<br />
solo <strong>di</strong> volontà politica!”<br />
La lettera, poi, prosegue, <strong>il</strong>lustrando quali devono essere i punti fondamentali per-<br />
64
4. LA CIRCOSCRIZIONE RACCONTATA<br />
ché l’esperienza dei consigli <strong>di</strong><br />
quartiere possa rappresentare,<br />
realmente, un nuovo modo <strong>di</strong><br />
fare politica ed in particolare<br />
si chiede l’impegno ad incontrarsi<br />
in pubblica assemblea<br />
almeno una volta ogni tre<br />
mesi, che <strong>il</strong> progetto <strong>di</strong> b<strong>il</strong>ancio<br />
preventivo e gli interventi<br />
urbanistici, che interessano<br />
<strong>il</strong> quartiere, vengano <strong>di</strong>scussi<br />
con la comunità prima che <strong>il</strong><br />
Consiglio Comunale li ab¬bia<br />
<strong>del</strong>iberati.<br />
“Chiedevamo, inoltre, un impegno<br />
costante nella dotazione<br />
ai Quartieri <strong>di</strong> locali per<br />
riunioni ed attività culturali<br />
Un intervento <strong>di</strong> Lucio Bregoli<br />
e collettive in genere, come<br />
quello <strong>di</strong> <strong>di</strong>scutere con la popolazione <strong>di</strong> tutte le problematiche più <strong>di</strong>ffuse e che<br />
necessitavano <strong>di</strong> un impellente soluzione: le priorità erano rappresentate dalla<br />
situazione scolastica. Le aree ver<strong>di</strong>, <strong>il</strong> servizio <strong>di</strong> trasporto pubblico” continua nel<br />
suo racconto <strong>il</strong> rappresentante <strong>del</strong>le Acli.<br />
Il gruppo Promotore tiene la sua prima assemblea pubblica <strong>il</strong> 18 Dicembre 1970<br />
presso i locali <strong>del</strong> bar Prealpino. Sul volantino <strong>di</strong> invito <strong>di</strong>stribuito alla popolazione<br />
è scritto:<br />
(…)Il “Comitato <strong>di</strong> quartiere” intende sollecitare la soluzione dei problemi che<br />
interessano la collettività agli amministratori provinciali e comunali.<br />
Ha, tuttavia, anche altri scopi:<br />
- fare inchieste, <strong>di</strong>battiti e ricerche sulle con<strong>di</strong>zioni dei servizi pubblici;<br />
- stimolare maggiore attenzione e interesse, e rendere possib<strong>il</strong>e la <strong>di</strong>retta <strong>partecipazione</strong><br />
dei citta<strong>di</strong>ni ai problemi civici e amministrativi <strong>del</strong> quartiere e <strong>del</strong>la città;<br />
- rendere più vivi e intensi i rapporti umani e sociali tra i citta<strong>di</strong>ni <strong>del</strong> quartiere, e<br />
più <strong>di</strong>retti e responsab<strong>il</strong>i quelli democratici con gli amministratori;<br />
65
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
- promuovere iniziative culturali, sportive e ricreative. (…)<br />
Provvisoriamente le riunioni <strong>del</strong> nuovo Consiglio <strong>di</strong> Quartiere vengono effettuate<br />
presso sede <strong>del</strong> Circolo ACLI. Solo nel 1972 <strong>il</strong> Consiglio avrà una sede propria in<br />
via XVI <strong>di</strong> fronte alla scuola me<strong>di</strong>a Piran<strong>del</strong>lo.<br />
Il 12 maggio 1971, proprio presso la nuova sede, si tenne la prima assemblea<br />
pubblica per <strong>di</strong>scutere e approvare lo statuto <strong>di</strong> quartiere preparato dal Comitato<br />
provvisorio.<br />
Mercoledì 9 e giovedì 10 giugno 1971, a<strong>di</strong>acente alla riven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> giornali <strong>di</strong><br />
via Tovini, si tennero le elezioni <strong>del</strong> Consiglio <strong>di</strong> Quartiere precedute da una intensa<br />
propaganda per la presentazione <strong>del</strong>le liste presso l’apposita commissione<br />
elettorale composta da Alberto Andretto, Giov<strong>anni</strong> Belletti, G. Lucio Bregoli, Tina<br />
Don<strong>del</strong>li, Angelo Gustinelli, Giorgio Orlando e Angelo Perazzolo. Vennero ammessi<br />
al voto anche i quattor<strong>di</strong>cenni.<br />
“Ricordo che i primi temi affrontati dal nuovo Consiglio <strong>di</strong> Quartiere furono, in<br />
particolare, quelli urbanistici con pressioni sull’assessore in questione in merito<br />
alle aree da mantenere a verde pubblico, quelle da attrezzare per giochi per bambini<br />
e la necessità <strong>di</strong> un centro sociale, la scuola materna”.<br />
Furono numerosi gli interventi dei consigli <strong>di</strong> quartiere, volti sostanzialmente a<br />
risolvere i problemi pratici e più sentiti dalla gente.<br />
Sollecitato dagli abitanti <strong>del</strong> V<strong>il</strong>laggio Prealpino, a<strong>di</strong>acenti alla Ferriera Stefana<br />
Antonio <strong>di</strong> Conicchio, per l’eccessivo rumore che questa produceva nel ciclo <strong>del</strong>la<br />
lavorazione, <strong>il</strong> Consiglio <strong>di</strong> Quartiere faceva un esposto alle autorità competenti<br />
(sindaco <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>, prefetto e pretore). Il pretore basandosi sull’esposto <strong>del</strong> Consiglio<br />
<strong>di</strong> quartiere or<strong>di</strong>nava dei r<strong>il</strong>ievi fotometrici che riscontravano la fondatezza<br />
<strong>del</strong>l’esposto dando <strong>il</strong> via al proce<strong>di</strong>mento penale verso la <strong>di</strong>tta Stefana Antonio.<br />
Di fronte all’evidenza dei fatti la <strong>di</strong>tta si <strong>di</strong>chiarava <strong>di</strong>sposta a pagare la multa e <strong>di</strong><br />
impegnarsi a ridurre <strong>il</strong> rumore.<br />
Nel PRG esposto al pubblico all’inizio <strong>del</strong> 1973 era evidenziato <strong>il</strong> progetto <strong>di</strong><br />
una superstrada sopraelevata, che doveva collegare la valle Trompia con la valle<br />
Sabbia, questa superstrada avrebbe <strong>di</strong>viso in due. Dopo un’infuocata assemblea<br />
sul tema, <strong>il</strong> consiglio decise <strong>di</strong> inviare una lettera al sindaco, agli assessori e ai<br />
consiglieri comunali perché tale progetto venisse tolto dal PRG in quanto causa <strong>di</strong><br />
notevoli problemi <strong>di</strong> traffico, rumore, inquinamento e <strong>di</strong>minuzione <strong>di</strong> aree ver<strong>di</strong>.<br />
Nell’ottobre <strong>del</strong> 1974 si rinnovò <strong>il</strong> Consiglio <strong>di</strong> Circoscrizione, al quale votarono<br />
66
4. LA CIRCOSCRIZIONE RACCONTATA<br />
i maggiori <strong>di</strong> 18 <strong>anni</strong>. La <strong>partecipazione</strong> fu particolarmente elevata: i can<strong>di</strong>dati<br />
furono 39, 1766 i votanti, pari al 47,87% degli aventi <strong>di</strong>ritto.<br />
Rispetto alla prima, in questa tornata <strong>di</strong> elezioni, cominciano a <strong>di</strong>venire maggiormente<br />
evidenti gli schieramenti. Vengono, infatti, presentate più liste <strong>di</strong> can<strong>di</strong>dati<br />
ed alcune forze politiche pongono <strong>il</strong> veto sul nome <strong>di</strong> chi doveva fare <strong>il</strong> Presidente<br />
<strong>di</strong> Quartiere.<br />
“Un ulteriore motivo <strong>di</strong> frizione furono le elezioni dei rappresentanti nella scuola<br />
previsti dai decreti <strong>del</strong>egati all’interno <strong>del</strong> quale <strong>il</strong> Consiglio <strong>di</strong> Quartiere aveva<br />
preparato una lista unitaria mentre, in contrapposizione, si presentò anche la lista<br />
denominata “Associazione Genitori” legata soprattutto alla realtà <strong>del</strong> mondo<br />
cattolico”.<br />
Il nuovo Consiglio <strong>di</strong> quartiere <strong>di</strong>ede vita a <strong>di</strong>verse commissioni aperte anche ai<br />
non eletti. Alcune <strong>di</strong> queste commissioni erano incalzate anche da associazioni<br />
come le Acli che suggerivano percorsi <strong>di</strong> lavoro che già avevano dato vita come<br />
associazione come la situazione scolastica, la viab<strong>il</strong>ità, i trasporti, la ristrutturazione<br />
<strong>del</strong>la cascina Pederzani, la Conceria Capretti, le osservazioni al PRG, <strong>il</strong> consultorio<br />
fam<strong>il</strong>iare.<br />
La commissione scuola dopo un paio d’<strong>anni</strong> <strong>di</strong> lavoro restituì in un’assemblea<br />
pubblica un elaborato sulla situazione scolastica che fu oggetto <strong>di</strong> un appassionato<br />
<strong>di</strong>battito.<br />
La commissione urbanistica riuscì a far sistemare i giar<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> via nona, salvò dalla<br />
speculazione ed<strong>il</strong>izia l’attuale area mercatale e riuscì a far mettere <strong>il</strong> semaforo <strong>di</strong><br />
via Zola/Conicchio dopo che era stato investito mortalmente un giovane ragazzo<br />
<strong>del</strong> Prealpino presso <strong>del</strong>l’incrocio in questione.<br />
Nel gennaio <strong>del</strong> 1978, infine, <strong>il</strong> Consiglio <strong>di</strong> Quartiere con una lettera recapitata a<br />
tutta la popolazione, invitava a partecipare a un’assemblea nella quale si portava<br />
a conoscenza la <strong>del</strong>ibera <strong>del</strong>l’amministrazione Comunale sulle Circoscrizioni.<br />
Finiva così l’esperienza <strong>del</strong> Consiglio <strong>di</strong> quartiere e la <strong>partecipazione</strong> <strong>di</strong>retta dei<br />
citta<strong>di</strong>ni ai problemi <strong>del</strong>la propria comunità.<br />
67
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
FRa PaSSaPaRola e VolanTini, SPonTaneiTà e<br />
coMPeTenza: la PaRTeciPazione abiTa qUi<br />
Alessandro Marelli<br />
“Stasera ci si trova per…”: semplice ed essenziale, bastava quella frase, stampata<br />
su cartelloni improvvisati o affidata al passaparola, per riempire la sala <strong>del</strong><br />
quartiere. Quasi una formula magica, a quei tempi, capace <strong>di</strong> attirare i vecchi ma<br />
anche i più giovani con la promessa <strong>di</strong> dar voce ai bisogni, trovare insieme risposte<br />
ai problemi.<br />
Alessandro Marelli era uno <strong>di</strong> loro, veniva dal comparto metalmeccanico <strong>del</strong>la<br />
Franchi Armi, aveva fatto <strong>il</strong> sindacalista in fabbrica ma soprattutto era convinto<br />
<strong>del</strong>le potenzialità che la “sua” Mompiano poteva esprimere. Negli <strong>anni</strong> Settanta<br />
partecipò ai primi passi e poi al consolidamento <strong>del</strong> Consiglio <strong>di</strong> quartiere <strong>di</strong><br />
Mompiano, esperienza che insieme a quella <strong>di</strong> altre zone <strong>del</strong>la città si sarebbe<br />
tradotta, nel 1978, nella nascita <strong>del</strong>le Circoscrizioni.<br />
Mompiano fu una <strong>del</strong>le aree più vivaci <strong>di</strong> <strong>partecipazione</strong>, fra i capof<strong>il</strong>a <strong>del</strong> movimento<br />
dei quartieri. «La presenza e <strong>il</strong> lavoro <strong>del</strong>le Acli creò l’humus per la crescita<br />
<strong>di</strong> un movimento <strong>di</strong> <strong>partecipazione</strong>, ma la spinta venne anche dal basso, dai<br />
problemi <strong>di</strong> quartiere vissuti quoti<strong>di</strong>anamente, mentre i Consigli comunali erano<br />
lontani», ricorda Marelli.<br />
I bisogni per cui ci si trovava erano questioni <strong>di</strong> tutti i giorni, la carenza <strong>di</strong> ricettività<br />
nelle scuole materne, gli scarsi collegamenti con i pulmini <strong>del</strong> servizio pubblico<br />
e i problemi <strong>di</strong> viab<strong>il</strong>ità, la poca <strong>di</strong>sponib<strong>il</strong>ità <strong>di</strong> posti nel cimitero <strong>di</strong> quartiere,<br />
l’assistenza sociale, i no<strong>di</strong> urbanistici che creavano problemi nella zona. A fare<br />
da minimo comun denominatore era una forte spinta civ<strong>il</strong>e e ideale, la voglia <strong>di</strong><br />
stare insieme e <strong>di</strong> partecipare, «quella stessa voglia che portò, all’indomani <strong>del</strong>lo<br />
scoppio <strong>del</strong>la bomba in piazza Loggia, nel maggio <strong>del</strong> 1974, a riempire <strong>di</strong> gente<br />
la sala <strong>del</strong>l’oratorio per confrontarsi e ritrovarsi uniti».<br />
Era qualcosa, insomma, che trascendeva gli stessi schieramenti politici. «I gran<strong>di</strong><br />
partiti allora avevano una buona rappresentatività, ma unendo i rispettivi gruppi<br />
non si sarebbe ottenuto un momento partecipativo così numeroso e intenso come<br />
quello dei Consigli <strong>di</strong> quartiere, dove ci si trovava con uno spirito che andava al <strong>di</strong><br />
là dei movimenti politici e degli schieramenti ideologici».<br />
68
4. LA CIRCOSCRIZIONE RACCONTATA<br />
Chi partecipava alle riunioni <strong>di</strong> quartiere vi trovava la più assoluta varietà <strong>di</strong> persone<br />
e storie: c’era gente con un passato politico e istituzionale mescolata a residenti<br />
che portavano in dote nient’altro che la propria spontaneità e la voglia <strong>di</strong><br />
collaborare. Fianco a fianco si ritrovavano <strong>il</strong> giu<strong>di</strong>ce e <strong>il</strong> metalmeccanico, l’artigiano<br />
e <strong>il</strong> professore, «e talvolta ne uscivano assemblee infuocate, confronti aspri,<br />
perché i Consigli <strong>di</strong> quartiere erano anche <strong>il</strong> punto <strong>di</strong> incontro <strong>di</strong> realtà politiche<br />
<strong>di</strong>stanti. Poi però arrivava sempre <strong>il</strong> momento in cui le <strong>di</strong>stanze si accorciavano,<br />
davanti ai grattacapi <strong>di</strong> casa, ai propri figli che dovevano andare a scuola ma<br />
che non trovavano posto, questioni forse or<strong>di</strong>narie, ma profondamente sentite, e<br />
capaci <strong>di</strong> accomunarci».<br />
Il collante erano i problemi <strong>del</strong> quartiere, <strong>del</strong>le sue strutture, <strong>del</strong>le strade e dei servizi,<br />
«percepiti come un bene comune», <strong>di</strong>ce Marelli, nell’evidenziare l’intuizione<br />
<strong>di</strong> fondo alla base dei Consigli <strong>di</strong> allora: «Si era capito, più <strong>di</strong> trent’<strong>anni</strong> fa, l’importanza<br />
<strong>di</strong> responsab<strong>il</strong>izzare i residenti, <strong>di</strong> creare una rete sociale che trovasse in<br />
sé le risorse per affrontare le problematiche <strong>del</strong> territorio, <strong>di</strong> valorizzare <strong>il</strong> mondo<br />
<strong>del</strong>l’associazionismo spontaneo. Che è un po’ la stessa “metodologia” rispolverata<br />
oggi per risanare quartieri problematici, afflitti da degrado e marginalità».<br />
Con le elezioni spontanee dei can<strong>di</strong>dati e l’inquadramento più “istituzionale” dei<br />
Alessandro Marelli<br />
69
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
Consigli <strong>di</strong> quartiere <strong>il</strong> fermento <strong>del</strong>la prima ora, più spontaneo, iniziò a darsi una<br />
regola. «La spontaneità iniziale incominciò ad essere guidata per raggiungere dei<br />
risultati concreti. Come Consigli avevamo un potere propositivo nei confronti <strong>del</strong>la<br />
Loggia, ma bisognava saper sv<strong>il</strong>uppare un’ab<strong>il</strong>ità nel far passare <strong>il</strong> messaggio».<br />
Le regole furono chiare fin dall’inizio: era necessario essere competenti nell’arte<br />
<strong>del</strong> <strong>di</strong>alogo con gli assessori, ma al contempo saper fare leva sulla <strong>partecipazione</strong><br />
popolare, «perchè si era ben consapevoli che l’ascolto da parte <strong>del</strong>le istituzioni<br />
arrivava se c’era movimento, se si riusciva a “far rumore” sulle <strong>di</strong>verse vicende <strong>di</strong><br />
interesse, e in questo senso la storia <strong>del</strong> parco Castelli è emblematica».<br />
Per raggiungere questi risultati una <strong>del</strong>le corde da toccare, <strong>di</strong> cui <strong>il</strong> Consiglio <strong>di</strong><br />
quartiere fu conscio fin dai suoi primi passi, era la capacità <strong>di</strong> comunicare, <strong>di</strong> coinvolgere<br />
la gente, soprattutto <strong>di</strong> farsi capire per creare con<strong>di</strong>visione sui problemi<br />
comuni. Da questa consapevolezza nacque <strong>il</strong> giornalino <strong>di</strong> quartiere, denominato<br />
“Informa-quartiere”, che ragguagliava perio<strong>di</strong>camente i residenti sull’attività <strong>del</strong>le<br />
commissioni interne al Consiglio (cultura, servizi sociali, urbanistica), informava<br />
sulle assemblee previste e in generale si proponeva <strong>di</strong> “fornire i mezzi e le informazioni<br />
necessarie al citta<strong>di</strong>no per aumentare e qualificare la sua inderogab<strong>il</strong>e<br />
<strong>partecipazione</strong> alle decisioni”, come recitava <strong>il</strong> frontespizio <strong>del</strong>l’Informa-quartiere<br />
<strong>del</strong>l’apr<strong>il</strong>e 1974, ammonendo i residenti sulla necessità <strong>di</strong> una loro <strong>partecipazione</strong><br />
viva e concreta, “anche perché – scrivevano i redattori - non vogliamo che <strong>il</strong> Consiglio<br />
<strong>di</strong> quartiere <strong>di</strong>venti una brutta copia <strong>del</strong> Consiglio comunale, priva peraltro<br />
<strong>di</strong> potere decisionale”.<br />
«Quella dei Consigli <strong>di</strong> quartiere era un’esperienza forte ma destinata a concludersi,<br />
con l’esaurirsi, nell’arco degli <strong>anni</strong>, <strong>del</strong> fermento partecipativo iniziale»,<br />
considera Marelli. «Non credo, però, che l’esperienza dei quartieri abbia lasciato<br />
una specifica ere<strong>di</strong>tà, se non nel ruolo <strong>di</strong> “fucina” ricoperto dai Consigli, dove si<br />
formarono figure <strong>del</strong>la futura classe <strong>di</strong>rigente: <strong>il</strong> quartiere in quegli <strong>anni</strong> era una<br />
“scuola <strong>di</strong> politica”, che attraverso incontri e approfon<strong>di</strong>menti favoriva una crescita<br />
<strong>di</strong> consapevolezza <strong>del</strong>la gente».<br />
Altrettanto certo, secondo Marelli, è che un’esperienza trascinante come quella<br />
dei Consigli <strong>di</strong> quartiere fu intimamente legata a quel periodo storico, e non<br />
avrebbe mai potuto nascere se non ci fossero stati un tessuto sociale coeso, una<br />
con<strong>di</strong>visione allargata da parte <strong>del</strong>la gente, e tanti citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong>sponib<strong>il</strong>i a spendersi<br />
per la causa comune.<br />
70
nella lUnga SToRia <strong>del</strong> PaRco caSTelli c’è l’iMPRonTa<br />
<strong>di</strong> Un’inTeRa geneRazione<br />
Gianluigi Fondra<br />
4. LA CIRCOSCRIZIONE RACCONTATA<br />
L’avventura <strong>del</strong>la <strong>partecipazione</strong> dal basso si intreccia con <strong>il</strong> protagonismo giovan<strong>il</strong>e<br />
e i temi <strong>del</strong>l’ambiente nella storia <strong>di</strong> Gigi Fondra, <strong>il</strong> “gnaro de Mompià”.<br />
Lo sfondo è Mompiano, «che insieme a Sant’Eufemia è stato <strong>il</strong> nucleo vero <strong>di</strong><br />
spinta per <strong>il</strong> movimento <strong>del</strong> decentramento, con la sua tra<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> quartiere<br />
“precursore” e una lunga storia <strong>di</strong> m<strong>il</strong>itanza politica e sociale, in cui sono<br />
cresciuti pezzi <strong>del</strong>la classe <strong>di</strong>rigente <strong>del</strong>la città». Figure come Mario Picchieri,<br />
<strong>il</strong> segretario provinciale <strong>del</strong>le Acli, «che per primo, negli <strong>anni</strong> Sessanta, insieme<br />
ad altri impegnati nel sociale ha realizzato una forma <strong>di</strong> cooperazione per la<br />
casa non aff<strong>il</strong>iata ai gran<strong>di</strong> movimenti <strong>di</strong> cooperativa ed<strong>il</strong>izia: una figura cui la<br />
mia generazione – allora eravamo ragazzi – guardava come un padre».<br />
C’era fermento, nell’oratorio <strong>di</strong> San Gaudenzio, nei primi <strong>anni</strong> Settanta. Era<br />
<strong>il</strong> tempo <strong>del</strong>la stagione post-conc<strong>il</strong>iare, Fondra e un’altra decina <strong>di</strong> ragazzi<br />
respiravano l’aria dei primi Consigli <strong>di</strong> quartiere, interpretandone, dall’esterno,<br />
<strong>il</strong> côté più innovativo e critico. «Furono gli <strong>anni</strong> <strong>di</strong> un banchetto contro <strong>il</strong> carovita<br />
che ci attirò le ire dei commercianti, e<br />
<strong>del</strong>la prima iniziativa che organizzammo in<br />
città contro la <strong>di</strong>ffusione <strong>del</strong>l’eroina, problema<br />
che stava emergendo in tutta la sua<br />
drammaticità. Mompiano, <strong>il</strong> nostro quartiere,<br />
è sempre stato fucina <strong>di</strong> esperienze<br />
sociali. E la vicenda <strong>del</strong> parco Castelli ci<br />
sta tutta in questa storia».<br />
L’area <strong>del</strong>l’attuale parco fu negli <strong>anni</strong><br />
Settanta una <strong>del</strong>le prime riven<strong>di</strong>cazioni<br />
<strong>del</strong> Consiglio <strong>di</strong> quartiere, in<strong>di</strong>viduata<br />
come luogo <strong>di</strong> ritrovo pubblico ideale<br />
e allora mancante a Mompiano, dopo<br />
l’espansione <strong>del</strong> nucleo abitato, che ave-<br />
Gigi Fondra<br />
va inevitab<strong>il</strong>mente fatto perdere alla piaz-<br />
71
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
zetta <strong>del</strong>la chiesa <strong>di</strong> Santa Maria <strong>il</strong> suo ruolo <strong>di</strong> centro catalizzatore <strong>del</strong>la<br />
vita aggregata.<br />
«L’area, che era stata acquistata dal <strong>Comune</strong> alla metà degli <strong>anni</strong> Sessanta,<br />
era stata promessa dall’amministrazione come spazio per un parco pubblico,<br />
visto che allora <strong>il</strong> solo parco citta<strong>di</strong>no era <strong>il</strong> Ducos, dall’altra parte <strong>del</strong>la città»,<br />
ricorda Fondra. Il tempo però passava senza che la situazione si sbloccasse,<br />
fino ad arrivare alla fine <strong>del</strong> 1989.<br />
«La scint<strong>il</strong>la che ha fatto scattare <strong>il</strong> movimento per <strong>il</strong> parco, raggruppatosi<br />
sotto <strong>il</strong> nome <strong>di</strong> Comitato per l’ambiente zona nord, fu la notizia che gli assessorati<br />
comunali avevano deciso <strong>di</strong> realizzare sul perimetro <strong>del</strong> parco un grande<br />
parcheggio per le auto, attiguo allo sta<strong>di</strong>o, esteso fino alla via Triumplina e<br />
destinato ai tifosi <strong>del</strong>le partite <strong>di</strong> calcio domenicali».<br />
Tutto questo per <strong>il</strong> Comitato, che aveva in Bobo Archetti l’”anima” <strong>del</strong> gruppo,<br />
era una «mossa inaccettab<strong>il</strong>e, perché avrebbe contrad<strong>di</strong>stinto <strong>il</strong> nostro territorio<br />
con una colata d’asfalto inut<strong>il</strong>e, visto che <strong>il</strong> parcheggio sarebbe stato<br />
ut<strong>il</strong>izzato con la cadenza quin<strong>di</strong>cinale <strong>del</strong>le partite in casa, e soprattutto vista<br />
la posizione <strong>del</strong> terreno, a ridosso <strong>del</strong>la collina e vicino all’abitato», racconta<br />
Fondra. Contro la variante al Piano regolatore che incombeva sull’area,<br />
a Mompiano vennero raccolte seim<strong>il</strong>a firme per suffragare un’osservazione<br />
formale alla variante stessa.<br />
Ma soprattutto, anziché la girandola canonica <strong>di</strong> manifestazioni e volantinaggi,<br />
<strong>il</strong> Comitato nella sua azione <strong>di</strong> protesta scelse una tattica ine<strong>di</strong>ta, che si<br />
rivelerà vincente: «L’idea fu quella <strong>di</strong> costruirlo noi <strong>il</strong> parco». Superate le recinzioni<br />
che proteggevano <strong>il</strong> terreno, <strong>il</strong> gruppo costruì alcune panchine e altalene<br />
artigianali, <strong>di</strong>pinse a mano un’insegna col nome “Parco Castelli”, denominazione<br />
scelta dalla via su cui si affacciava, posizionò un barbecue alla buona.<br />
«Il car<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> tutto, in quella primavera <strong>del</strong> ’90, non fu la provocazione, ma la<br />
<strong>partecipazione</strong>», ricorda Fondra. «Furono le persone più <strong>di</strong>sparate, dalle famiglie<br />
agli anziani, a “fare” <strong>il</strong> parco con la loro presenza». Grazie al passaparola<br />
ogni giorno <strong>il</strong> parco, “occupato” pacificamente, <strong>di</strong>venne la meta <strong>di</strong> svago per<br />
molti residenti, nei week end si raggiungevano le 200-<strong>30</strong>0 persone, vennero<br />
fatte due feste per finanziare la realizzazione <strong>di</strong> giochi per bambini.<br />
«Nel giro <strong>di</strong> due mesi la politica bresciana si accorse <strong>di</strong> avere sbagliato», ricorda<br />
Fondra. Nel 1992 venne fondata la Cooperativa Parco Castelli, <strong>di</strong> cui Fondra<br />
72
4. LA CIRCOSCRIZIONE RACCONTATA<br />
fu <strong>il</strong> primo presidente, e a cui l’amministrazione comunale, con un esperimento<br />
<strong>di</strong> “gestione partecipata”, aggiu<strong>di</strong>cò l’appalto per la manutenzione e la gestione<br />
<strong>del</strong> verde all’interno <strong>del</strong> parco Castelli, con un budget <strong>di</strong> 40 m<strong>il</strong>ioni <strong>di</strong><br />
vecchie lire.<br />
«La Cooperativa venne fatta con lo spirito dei Consigli <strong>di</strong> quartiere, al suo<br />
interno erano rappresentate le più ampie sensib<strong>il</strong>ità, per provare a gestire dal<br />
basso una piccola porzione <strong>di</strong> territorio comune». La scommessa era ancora<br />
più ambiziosa, <strong>di</strong>mostrare che accorciando le <strong>di</strong>stanze con le istituzioni era<br />
più fac<strong>il</strong>e far rispettare le norme, ridurre gli atti <strong>di</strong> vandalismo e l’insicurezza<br />
all’interno <strong>del</strong> parco, «perché a gestirlo, agli occhi dei citta<strong>di</strong>ni, non era un’entità<br />
astratta, ma alcuni <strong>di</strong> loro». Anche in termini <strong>di</strong> costi, l’esperienza è servita<br />
«per mettere in luce <strong>il</strong> ritorno positivo, dal punto <strong>di</strong> vista economico, <strong>del</strong>la <strong>partecipazione</strong>.<br />
In quell’occasione, su più versanti, si sperimentò un lavoro vero e<br />
serio fra istituzioni e citta<strong>di</strong>nanza».<br />
Il periodo <strong>di</strong> “autogestione” <strong>del</strong> parco durò un anno, poi, complici i rivolgimenti<br />
politici e non ultimo lo scoppio <strong>di</strong> Tangentopoli, si tornò all’antico con<br />
la gestione comunale <strong>del</strong> “Castelli” e la fine <strong>del</strong>la Cooperativa. L’onda lunga<br />
<strong>di</strong> quell’esperienza, però, non si è fermata lì. «La vicenda <strong>del</strong> parco Castelli<br />
ha dato <strong>il</strong> via alla stagione dei parchi a <strong>Brescia</strong>, evidenziando la necessità <strong>di</strong><br />
avere verde attrezzato e vivib<strong>il</strong>e, non giar<strong>di</strong>ni da guardare». Fu allora che si<br />
incominciò a comprendere che <strong>il</strong> parco, “luogo d’incontro occasionale certo”,<br />
come ama definirlo Fondra, è uno strumento <strong>di</strong> risposta sociale al bisogno<br />
<strong>di</strong> relazioni, uno spazio fisico e ideale che nella società dei “non-luoghi” ha<br />
sostituito <strong>il</strong> ruolo svolto un tempo dalla piazza.<br />
Partecipazione, socialità, rispetto <strong>del</strong>l’ambiente sono un tutt’uno per chi,<br />
come Fondra e gli altri “gnari”, ha vissuto la sua infanzia nella valle <strong>di</strong> Mompiano,<br />
e ne ha ancora impresso <strong>il</strong> ricordo <strong>di</strong> fonti <strong>di</strong> acqua limpide, maggiolini<br />
e farfalle che danzavano nei prati, in<strong>di</strong>ce <strong>del</strong>la salubrità dei luoghi. Su questi<br />
presupposti nasce, nel 1996, <strong>il</strong> Comitato citta<strong>di</strong>ni per la valle <strong>di</strong> Mompiano,<br />
che si impegna da subito perché l’ex Polveriera, <strong>di</strong>smessa dai vincoli m<strong>il</strong>itari,<br />
venga destinata ad uso pubblico. Seguiranno raccolte <strong>di</strong> firme per crearvi<br />
una “Casa <strong>del</strong>la natura” che alla fine non verrà realizzata nella Polveriera,<br />
ma vedrà comunque la luce nel rifugio nella valle <strong>di</strong> Mompiano, un e<strong>di</strong>ficio<br />
ristrutturato in un’area boschiva e incontaminata <strong>del</strong>la valle, per opera<br />
73
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
<strong>del</strong>l’associazione Gnari de Mompià onlus (associazione <strong>di</strong> volontariato per<br />
la tutela ambientale costituita nel 2002, <strong>di</strong> cui Fondra è stato <strong>il</strong> primo presidente)<br />
d’intesa con la Cooperativa Fraternità agricola <strong>di</strong> Ospitaletto.<br />
Il rifugio è gestito dai Gnari de Mompià per promuovere una frequentazione<br />
responsab<strong>il</strong>e <strong>del</strong> territorio, realizzando escursioni <strong>di</strong>dattiche, soggiorni <strong>di</strong><br />
turismo “dolce”, manutenzione dei sentieri storici, centri estivi sui temi ambientali.<br />
Se Fondra non nasconde qualche riserva sul cammino a volte tortuoso compiuto<br />
in città dalla “<strong>partecipazione</strong>”, percepita come un percorso ancora da<br />
completare in un’ottica <strong>di</strong>versa dalla semplice logica amministrativa - «un<br />
bicchiere mezzo pieno, o mezzo vuoto, a seconda dalla parte in cui lo si guar<strong>di</strong>»<br />
- è certo che i Gnari de Mompià sono la prosecuzione <strong>di</strong> una storia iniziata<br />
molti <strong>anni</strong> prima, con <strong>il</strong> Comitato per l’ambiente zona nord. «L’esperienza<br />
<strong>di</strong> gestione <strong>del</strong> rifugio, che tuttora continua, è un modo per <strong>di</strong>mostrare che,<br />
se viene supportata correttamente dalle scelte politiche, la <strong>partecipazione</strong> è<br />
possib<strong>il</strong>e e necessaria per dare risposta ai <strong>di</strong>versi bisogni sociali. La “chiave”<br />
è unirsi non contro qualcuno ma a favore <strong>di</strong> qualcosa, per mescolare le forze<br />
migliori».<br />
I soci fondatori dei Gnàri dè Mompià davanti al rifugio <strong>del</strong>la valle <strong>di</strong> Mompiano<br />
74<br />
© Archivio Gnàri dè Mompià - Foto Cristian Penocchio
nella Piccola aTene <strong>di</strong> qUaRTieRe, a ScUola <strong>di</strong> deMocRazia<br />
Maur<strong>il</strong>io Lovatti<br />
4. LA CIRCOSCRIZIONE RACCONTATA<br />
Come nell’Atene <strong>di</strong> Pericle. Citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> pari <strong>di</strong>ritto con la possib<strong>il</strong>ità <strong>di</strong> intervenire<br />
nelle assemblee <strong>di</strong> democrazia <strong>di</strong>retta, partecipando personalmente alle decisioni.<br />
E lasciando <strong>il</strong> proprio segno nella vita <strong>del</strong>la polis.<br />
Così si sentivano i ragazzi che nei primi <strong>anni</strong> Settanta, con la barba lunga e <strong>il</strong> fermento<br />
<strong>del</strong>la contestazione ancora nel sangue, si sarebbero buttati nell’avventura<br />
dei Consigli <strong>di</strong> quartiere con una buona dose <strong>di</strong> idealismo, senso <strong>di</strong> responsab<strong>il</strong>ità<br />
quanto basta e una manciata <strong>di</strong> “lieta furia dei vent’<strong>anni</strong>”.<br />
Maur<strong>il</strong>io Lovatti inizia la sua avventura nel quartiere <strong>di</strong> Sant’Eustacchio da giovane<br />
studente universitario <strong>di</strong> F<strong>il</strong>osofia e partecipante <strong>del</strong>la gioventù aclista. Dal<br />
’74 sarà consigliere <strong>di</strong> quartiere, poi con la nascita <strong>del</strong>le Circoscrizioni, nel ’78,<br />
<strong>di</strong>venterà consigliere <strong>del</strong>la Prima fino ai mandati <strong>del</strong> 1980 e ‘85, ricoprendo anche<br />
i ruoli <strong>di</strong> vice presidente e coor<strong>di</strong>natore <strong>del</strong>la commissione urbanistica.<br />
Quella che ricorda con più slancio è la fase che definisce spontanea, quella dei<br />
primi <strong>anni</strong> e dei timi<strong>di</strong> riconoscimenti che arrivavano dall’amministrazione comunale.<br />
«Eravamo consapevoli <strong>di</strong> essere <strong>di</strong> fronte a qualcosa <strong>di</strong> nuovo», <strong>di</strong>ce Lovatti,<br />
ricordando la composizione <strong>del</strong> tutto eterogenea dei primi Consigli, formati da<br />
casalinghe cinquantenni e ragazzi universitari, artigiani e operai, ingegneri e professionisti<br />
che fino ad allora non avevano coltivato nessun interesse specifico per<br />
la politica. Tutti convinti a far sentire la loro voce, persuasi <strong>di</strong> poter cambiare <strong>il</strong><br />
modo <strong>di</strong> amministrare, agendo con un controllo imme<strong>di</strong>ato su ciò che si faceva, e<br />
contribuendo alle decisioni dal basso.<br />
A voler tentare un inquadramento storico, sono almeno tre i contesti che possono<br />
aver influito sulla <strong>partecipazione</strong> <strong>di</strong> quartiere: l’onda lunga <strong>del</strong> movimento studentesco,<br />
l’autunno caldo, la situazione politica in evoluzione. Eppure c’era <strong>del</strong>l’altro<br />
nella testa <strong>di</strong> quella gente che a centinaia affollava <strong>il</strong> teatro <strong>del</strong>la Pavoniana fino<br />
a occuparne tutti i posti <strong>di</strong>sponib<strong>il</strong>i, corridoi e anfratti possib<strong>il</strong>i per ascoltare e <strong>di</strong>re<br />
la propria.<br />
«Il fermento partecipativo può essere stato stimolato dalla situazione storica, ma<br />
c’era anche, non secondario, l’elemento <strong>del</strong> “credere” in un progetto ritenuto<br />
vicino e possib<strong>il</strong>e, che <strong>di</strong>pendeva dall’impegno <strong>di</strong> tutti». Tanto è vero che i partiti,<br />
75
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
seppure non in<strong>di</strong>fferenti al movimento nei quartieri («<strong>il</strong> Pci lo vide come un’occasione<br />
per entrare fra la gente dei quartieri, nella Dc e nel Psi la minoranza più<br />
aperta sfruttò quel momento per riequ<strong>il</strong>ibrare le posizioni <strong>di</strong> forza all’interno <strong>del</strong><br />
partito»), non ne furono i protagonisti, ritagliandosi una posizione ai margini.<br />
«Il numero degli “in<strong>di</strong>pendenti” era più <strong>del</strong>la metà, a riprova che l’organismo <strong>di</strong><br />
quartiere non era un Consiglio comunale in miniatura che riproduceva le stesse<br />
<strong>di</strong>namiche fra maggioranza e opposizione, perché non era emanazione dei partiti.<br />
Non, quin<strong>di</strong>, un duplicato <strong>di</strong> quei rapporti <strong>di</strong> forza, ma un luogo <strong>di</strong> confronto dove<br />
spesso si affermavano posizioni trasversali. Questo spiega la fiducia riposta dai<br />
citta<strong>di</strong>ni».<br />
I traguar<strong>di</strong> raggiunti con <strong>il</strong> Comitato <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento <strong>del</strong> 1971 e con <strong>il</strong> regolamento<br />
approvato dal <strong>Comune</strong> nel 1975, che conferiva ai Consigli <strong>di</strong> quartiere<br />
una importante voce in capitolo sui temi <strong>di</strong> urbanistica, b<strong>il</strong>ancio e politiche sociali<br />
sono, secondo Lovatti, una «conquista sul campo» dei quartieri. «Allora si dava<br />
Maur<strong>il</strong>io Lovatti<br />
76
4. LA CIRCOSCRIZIONE RACCONTATA<br />
molta importanza al consenso, i quartieri erano <strong>di</strong>ventati una massa <strong>di</strong> pressione<br />
talmente forte e ra<strong>di</strong>cata che le istituzioni non potevano ormai trascurare».<br />
La grande alchimia che dava forza alla <strong>partecipazione</strong> era la capacità <strong>di</strong> far convivere<br />
st<strong>il</strong>i <strong>di</strong> vita, età, mentalità e status sociali dei più <strong>di</strong>versi, miscelati da un deciso<br />
coinvolgimento emotivo. «C’erano professionisti in giacca e cravatta - come<br />
l’in<strong>di</strong>menticab<strong>il</strong>e ingegner Giov<strong>anni</strong> Buizza, che da presidente <strong>del</strong> Consiglio <strong>di</strong><br />
quartiere ci ha accompagnato in tante battaglie - e c’eravamo noi giovani, c’erano<br />
alternativi e c’erano conformisti, persone <strong>di</strong> destra e <strong>di</strong> sinistra, e nonostante ciò<br />
ci si riusciva a confrontare, con un accostamento che aveva talvolta <strong>il</strong> sapore <strong>di</strong> un<br />
<strong>di</strong>alogo fra generazioni <strong>di</strong>verse».<br />
Significativa anche la presenza femmin<strong>il</strong>e: a Sant’Eustacchio le donne erano circa<br />
la metà dei componenti <strong>del</strong> Consiglio, e su tre coor<strong>di</strong>natori <strong>di</strong> commissione, due<br />
(per Cultura e Servizi alla persona) erano donne.<br />
«L’atmosfera era contagiosa, anche per quelli inizialmente più scettici. L’impegno<br />
richiesto era molto, come le sere passate a casa <strong>del</strong>l’uno o <strong>del</strong>l’altro per stu<strong>di</strong>are<br />
le carte o le nuove normative, o la <strong>di</strong>stribuzione dei volantini informativi, per cui<br />
ciascuno si sceglieva una zona e li depositava a tappeto nelle buche <strong>del</strong>le lettere.<br />
In questo senso <strong>di</strong>co che a noi giovani <strong>di</strong> allora, convinti ed entusiasti <strong>del</strong>l’esperienza,<br />
sembrava davvero <strong>di</strong> vivere in una “Atene <strong>di</strong> Pericle”, così avvertita era la<br />
possib<strong>il</strong>ità <strong>di</strong> partecipare alla vita <strong>del</strong>la res publica».<br />
Lovatti iniziò a interessarsi <strong>di</strong> temi urbanistici quasi per caso, «erano temi ostici e<br />
noi eravamo un po’ tutti <strong>di</strong>giuni, non c’era nessuno che li seguisse, così mi offrii<br />
io. Creammo un gruppo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> per affrontare un settore completamente nuovo,<br />
ci si trovava la sera per stu<strong>di</strong>are le normative urbanistiche. Alla fine maturammo<br />
una certa competenza».<br />
E in Consiglio le <strong>di</strong>scussioni erano accese, si dava battaglia sui temi urbanistici,<br />
dai sensi unici ai percorsi <strong>del</strong>le linee autobus, fino a questioni più importanti affrontate<br />
in quella metà degli <strong>anni</strong> Settanta, come <strong>il</strong> prolungamento <strong>di</strong> via Veneto<br />
in quella che sarebbe <strong>di</strong>ventata via Salvo d’Acquisto, e che allora non esisteva<br />
ancora, la realizzazione <strong>del</strong> giar<strong>di</strong>no <strong>di</strong> via Reverberi, la pratica per rendere <strong>di</strong><br />
fruib<strong>il</strong>ità pubblica Campo Marte, «che venne avviata proprio allora nel Consiglio<br />
<strong>di</strong> quartiere».<br />
Anche in campo culturale fu una stagione feconda, con la nascita dei primi corsi <strong>di</strong><br />
ginnastica per adulti e anziani, oltre alle lezioni <strong>di</strong> pittura, ceramica e altro. «Oggi<br />
77
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
è <strong>di</strong>ventata una prassi, ma allora era qualcosa <strong>di</strong> assolutamente ine<strong>di</strong>to: quando<br />
chiedevamo <strong>di</strong> poter ut<strong>il</strong>izzare la palestra degli istituti ci guardavano straniti, al<br />
tempo erano solo le scuole e le società sportive ad essere “legittimate” per questo<br />
tipo <strong>di</strong> attività».<br />
La vita dei consigli fu costellata anche <strong>di</strong> battaglie perse, vissute spesso come uno<br />
smacco, come fu <strong>il</strong> caso <strong>del</strong>la vicenda <strong>di</strong> Canton d’Albera, secondo Lovatti la più<br />
emblematica per Sant’Eustacchio.<br />
In quel caso i consiglieri <strong>di</strong> quartiere si spesero perché l’area <strong>di</strong> Canton d’Albera<br />
- nei pressi <strong>di</strong> via Pastrengo e via Leonardo Da Vinci (estesa su 9 m<strong>il</strong>a metri<br />
quadrati, dove attualmente sorge <strong>il</strong> complesso <strong>del</strong>la banca Bipop Unicre<strong>di</strong>t e gli<br />
altri esercizi limitrofi) - venisse vincolata a servizi pubblici, dopo che la normativa<br />
regionale <strong>del</strong> 1975 aveva aumentato i metri quadrati da destinare a servizi<br />
per abitante. «I quartieri volevano che la nuova normativa venisse applicata alla<br />
svelta, traducendosi in una variante <strong>del</strong> Piano regolatore, mentre gli interessi economici<br />
premevano per andare a r<strong>il</strong>ento, e ottenere nel frattempo la possib<strong>il</strong>ità <strong>di</strong><br />
e<strong>di</strong>ficazione privata <strong>del</strong>l’area». Il braccio <strong>di</strong> ferro con la Giunta comunale fu lungo<br />
ed estenuante, e si concluse con la sconfitta dei quartieri, che non riuscirono a<br />
salvaguardare l’area dall’e<strong>di</strong>ficazione privata.<br />
Lovatti ha vissuto anche la stagione <strong>del</strong> lento esaurirsi <strong>del</strong>la spinta partecipativa.<br />
«Se nei primissimi <strong>anni</strong> dopo <strong>il</strong> passaggio alle circoscrizioni c’era ancora un certo<br />
clima, tanto che molti consiglieri provenivano ancora dai quartieri, perché liste con<br />
soli can<strong>di</strong>dati imposti dai partiti avrebbero rischiato <strong>di</strong> perdere, col tempo furono<br />
i quartieri a irrigi<strong>di</strong>rsi, a smarrire l’impulso propositivo, la capacità <strong>di</strong> massa critica<br />
e quin<strong>di</strong> la forza contrattuale. Il clima culturale e politico era cambiato, e i partiti<br />
invasero <strong>il</strong> campo, a incominciare dalla <strong>di</strong>stribuzione dei presidenti».<br />
A fare da spartiacque fu la legge <strong>del</strong> 1976 che istituiva le circoscrizioni, una normativa<br />
che secondo Lovatti offre due chiavi <strong>di</strong> lettura: «dal punto <strong>di</strong> vista <strong>del</strong>la<br />
<strong>partecipazione</strong> fu un passo in<strong>di</strong>etro, perché con circoscrizioni molto estese <strong>di</strong>ventava<br />
più <strong>di</strong>ffic<strong>il</strong>e la rappresentatività rionale, ma sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o <strong>del</strong> decentramento<br />
fu un passo avanti, perché accorpando i quartieri rese possib<strong>il</strong>e realizzare strutture<br />
e centri sociali <strong>di</strong> riferimento per le <strong>di</strong>verse aree <strong>del</strong>la città». Evolversi, alla fine<br />
degli <strong>anni</strong> Settanta, era <strong>di</strong>ventato un salto necessario, tanto più che <strong>il</strong> movimento<br />
dei quartieri, pur referenziato localmente, aveva sempre cercato <strong>di</strong> “pensare globale”,<br />
evitando la tentazione campan<strong>il</strong>istica per contribuire, soprattutto tramite <strong>il</strong><br />
78
4. LA CIRCOSCRIZIONE RACCONTATA<br />
Comitato <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento <strong>di</strong> tutti i Consigli, a temi <strong>di</strong> interesse generale come<br />
b<strong>il</strong>ancio e Piano regolatore.<br />
E’ in questa prospettiva che va decifrata l’ere<strong>di</strong>tà lasciata dalla lunga stagione<br />
<strong>del</strong>la <strong>partecipazione</strong>. «Il ruolo <strong>del</strong>le Commissioni in Circoscrizione, ad esempio,<br />
quella Urbanistica, quella alla Cultura e attività promozionali e quella dei Servizi<br />
alla persona è un retaggio <strong>di</strong> allora, così come la possib<strong>il</strong>ità per i citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> partecipare<br />
alle sedute <strong>del</strong>le Commissioni, che sono “aperte”, e la prassi per cui gli<br />
assessori prima <strong>di</strong> decidere su tematiche <strong>di</strong> quartiere sentono chi è sul territorio».<br />
Certo, «sarebbe potuto rimanere qualcosa <strong>di</strong> più, soprattutto in tema <strong>di</strong> istanze<br />
partecipative. Ma qualcosa è restato. Senza <strong>di</strong>menticare che arrivare all’accorpamento<br />
era nella logica <strong>del</strong>le cose: solo così i quartieri hanno potuto <strong>di</strong>sporre<br />
<strong>di</strong> strutture, palestre e centri <strong>di</strong> aggregazione che una <strong>di</strong>mensione rionale non<br />
avrebbe potuto offrire».<br />
79
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
RiPeRcoRReRe la SToRia <strong>del</strong>le ciRcoScRizioni<br />
Luciano Rubessa<br />
Ripercorrere la storia <strong>del</strong>le circoscrizioni significa, non solo esaminare i processi<br />
che portarono alla loro nascita ed istituzionalizzazione, ma raccontare le<br />
vicende <strong>del</strong>la gente, <strong>del</strong> territorio ed i legami con quelli che sono stati gli eventi<br />
storici più importanti.<br />
San Bartolomeo è una <strong>del</strong>le zone <strong>del</strong>la città strettamente legata ad una <strong>del</strong>le<br />
vicende più tragiche avvenute in coda alla Seconda Guerra Mon<strong>di</strong>ale, non solo<br />
per <strong>il</strong> nome <strong>del</strong>le sue vie che rievocano quei momenti ma perché, nel ’57, venne<br />
in<strong>di</strong>cato come <strong>il</strong> punto <strong>di</strong> chiusura <strong>di</strong> raccolta profughi fuggiti dall’Istria, da<br />
Fiume e dalla Dalmazia e perchè, proprio, qui, risiedono ancora molte <strong>di</strong> quelle<br />
famiglie che, ormai, si sono inserite a <strong>Brescia</strong> grazie all’impegno ed alla volontà<br />
che caratterizza generalmente tutti gli italiani <strong>del</strong> nord Italia, sempre pronti a<br />
rimboccarsi le maniche davanti alle <strong>di</strong>fficoltà.<br />
Luciano Rubessa, presidente <strong>del</strong>l’associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia<br />
<strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>, è l’esempio <strong>di</strong> come, nell’arco degli <strong>anni</strong>, questa gente, giunta<br />
all’ombra <strong>del</strong> Cidneo dopo aver abbandonato la propria casa ed i propri averi,<br />
abbia avuto la capacità da un lato, e la possib<strong>il</strong>ità dall’altra, <strong>di</strong> inserirsi all’interno<br />
<strong>del</strong>la nostra società <strong>di</strong>venendo protagonisti, anche, <strong>del</strong>la storia politico ed<br />
istituzionale <strong>del</strong>la nostra città.<br />
Un percorso non fac<strong>il</strong>e, anzi particolarmente impervio, quello che portò gli esuli<br />
a raggiungere le varie città d’Italia, dopo gli orrori <strong>del</strong>la guerra, i bombardamenti<br />
prima, gli orren<strong>di</strong> massacri <strong>del</strong> generale Tito e dei suoi ed, infine, l’in<strong>di</strong>fferenza<br />
e l’oblio che i libri <strong>di</strong> storia, predominio <strong>di</strong> una certa parte politica e<br />
culturale, riservò a questa gente ed alle loro vicende, per quasi cinquant’<strong>anni</strong>.<br />
Una storia che, quin<strong>di</strong>, ora è giusto raccontare <strong>il</strong> più possib<strong>il</strong>e, per cercare con la<br />
memoria <strong>di</strong> ripercorrere quel percorso che portò migliaia <strong>di</strong> esuli a raggiungere<br />
la nostra città, contribuendo alla sua crescita ed al suo sv<strong>il</strong>uppo.<br />
Rubessa era ancora piccolo all’epoca ma ricorda bene <strong>il</strong> dolore e la paura ed <strong>il</strong><br />
lungo “esodo” che lo portò a <strong>Brescia</strong>.<br />
“Dopo i bombardamenti pensavamo che <strong>il</strong> peggio fosse finito ma con l’arrivo<br />
dei partigiani comunisti <strong>di</strong> Tito le cose avrebbero preso una piega ancora più<br />
80
4. LA CIRCOSCRIZIONE RACCONTATA<br />
dolorosa: ogni famiglia ebbe i suoi lutti e tutti fummo costretti ad abbandonare<br />
tutto: la nostra terra, la nostra casa, i nostri averi e, soprattutto, tanti affetti”<br />
ricorda Rubessa, ripercorrendo <strong>il</strong> viaggio verso la speranza che affrontò con suo<br />
padre, sua madre e due fratelli.<br />
“Io ero piccolo, avevo sei <strong>anni</strong> ma ci sono cose che non si <strong>di</strong>menticano: era<br />
<strong>di</strong>cembre <strong>del</strong> ’48, <strong>il</strong> treno che ci portava in Italia venne fermato proprio al confine,<br />
faceva freddo ma tutti gli adulti vennero fatti scendere dal treno denudati e<br />
perquisiti, volevano assicurarsi che non portassimo al <strong>di</strong> là <strong>del</strong> confine neanche<br />
un soldo” racconta <strong>il</strong> presidente <strong>del</strong>l’associazione che a <strong>Brescia</strong> arrivò all’età <strong>di</strong><br />
sei <strong>anni</strong>, dopo un lungo viaggio che lo portò prima a Trieste, poi a Venezia ed,<br />
infine, alle “baracche rosse” <strong>di</strong> U<strong>di</strong>ne.<br />
La fortuna <strong>del</strong>la sua famiglia, privata praticamente <strong>di</strong> qualsiasi, fu l’amicizia <strong>di</strong><br />
suo padre con un uomo che a <strong>Brescia</strong> era titolare un’impresa <strong>di</strong> ingegneria ed<strong>il</strong>e<br />
e falegnameria. Da allora, Rubessa, pur non <strong>di</strong>menticando le proprie origine e<br />
lottando per quel riconoscimento storico giunto praticamente solo pochi <strong>anni</strong><br />
fa, ha operato con impegno e de<strong>di</strong>zione all’interno <strong>del</strong>la società bresciana.<br />
“Non avevamo più una casa, un lavoro, dei sol<strong>di</strong>: siamo arrivati a <strong>Brescia</strong> come<br />
dei <strong>di</strong>sperati e siamo riusciti a rifarci una vita ed a contribuire allo sv<strong>il</strong>uppo <strong>di</strong><br />
questa città sempre in maniera onesta” ha riba<strong>di</strong>to Rubessa, che a <strong>Brescia</strong> è<br />
stato funzionario Enel, consigliere comunale, assessore alla pubblica istruzione,<br />
consigliere <strong>di</strong> circoscrizione ed ha vissuto, quin<strong>di</strong>, da vicino proprio al percorso<br />
dei comitati <strong>di</strong> quartiere che ha fissato le basi <strong>del</strong> decentramento.<br />
“La fine degli <strong>anni</strong> sessanta, con la nascita dei comitati <strong>di</strong> quartiere, è stato<br />
un bel periodo, ricco <strong>di</strong> spinte che venivano davvero dalle esigenze pratiche<br />
<strong>del</strong>la gente che viva <strong>il</strong> territorio e dalla volontà <strong>di</strong> molti, in quel periodo, a voler<br />
mettersi al servizio <strong>del</strong>la società per concorrere a costruire un qualcosa insieme”<br />
ha spiegato Rubessa cercando <strong>di</strong> far comprendere quale fosse l’aria che si<br />
respirava in quegli <strong>anni</strong>.<br />
“Il concetto <strong>di</strong> decentramento nato a quei tempi era ben <strong>di</strong>verso da risultato<br />
ottenuto ai giorni nostri: la politica c’entrava poco, o solo in parte, e le <strong>di</strong>fferenze<br />
<strong>di</strong> colore erano superate davanti alla necessità <strong>di</strong> risolvere i problemi reali.<br />
Le <strong>di</strong>versità erano appianate da un reale spirito <strong>di</strong> servizio e si <strong>di</strong>scuteva sulle<br />
soluzioni pratiche più che sulle ideologie. Basti pensare che le prime liste non<br />
erano rappresentate da simboli <strong>di</strong> partito” prosegue nel suo racconto Rubessa,<br />
81
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
convinto che l’istituzionalizzazione dei comitati <strong>di</strong> quartiere, sia stata una sorta<br />
<strong>di</strong> boomerang su quello che sarebbe dovuto essere <strong>il</strong> corretto cammino <strong>del</strong><br />
decentramento.<br />
“Nel momento in cui si è passato a consiglieri eletti, spesso scelti dai partiti,<br />
si è andata smarrendo quella territorialità che aveva caratterizzato i quartieri:<br />
non erano più i reali rappresentati <strong>del</strong> territorio, rappresentati magari dal vicino<br />
operoso che si preoccupava <strong>di</strong> risolvere i problemi, ma consiglieri calati<br />
dall’alto”.<br />
Infine un pensiero ancora alla zona San Bartolomeo ed all’influenza positiva<br />
che proprio gli esuli scacciati da Istria, Fiume e Dalmazia, <strong>di</strong>ede nello sv<strong>il</strong>uppo<br />
<strong>del</strong> quartiere.<br />
“L’aumento <strong>del</strong>la popolazione <strong>del</strong>la zona <strong>di</strong> San Bartolomeo generata dall’arrivo<br />
degli esuli contribuì in maniera non in<strong>di</strong>fferente a far sv<strong>il</strong>uppare questo<br />
quartiere, che più popolato necessitava <strong>di</strong> maggiori servizi”.<br />
82
oRgo TRenTo: da SeMPRe Un’iSola Felice<br />
Raul Porteri<br />
4. LA CIRCOSCRIZIONE RACCONTATA<br />
“Il mio Borgo, negli <strong>anni</strong> Trenta, si stendeva dal capolinea <strong>del</strong> tram elettrico n.2,<br />
a ridosso <strong>del</strong> Garza, in prossimità <strong>del</strong>lo sta<strong>di</strong>o <strong>di</strong> calcio “Armando Casalini” alla<br />
mia casa col civico numero 107 <strong>di</strong> via Trento. Entro questo angusto, ma compiuto<br />
spazio, un vero e proprio borgo satellite, <strong>di</strong> periferia, fino ad allora chiamato Borgo<br />
P<strong>il</strong>e, brulicava un angolo <strong>di</strong> mondo vivacissimo e vitale. Fermo nella memoria, affettivamente<br />
presente nel mio animo, fermenta ancora nella sua vitalità e stimola i<br />
miei ricor<strong>di</strong>” era <strong>il</strong> 1973 quando Lino Monchieri, scrittore nato e cresciuto a Borgo<br />
Trento raccontava <strong>del</strong> fascino particolare che da sempre caratterizza questa parte<br />
<strong>di</strong> via Trento e <strong>del</strong>l’affetto che anima coloro che ne “el bòrg” sono cresciuti.<br />
Lo stesso attaccamento al proprio quartiere e la ferma volontà <strong>di</strong> mantenere viva<br />
la memoria <strong>del</strong>le storie e <strong>del</strong>la tra<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> quel pezzo <strong>di</strong> strada lungo appena <strong>30</strong>1<br />
metri è comune ai nativi <strong>del</strong> borgo ed in particolare a quelli che sono ancora li<br />
nonostante l’incedere <strong>del</strong> tempo e la società che cambia.<br />
La famiglia Porteri è una <strong>di</strong> quelle storicamente legate alla borgata sin dal 1875<br />
quando aprì la propria salumeria che da oltre un secolo è specializzata in formaggi<br />
e salumi <strong>di</strong> qualità.<br />
Salumeria Porteri 1912: <strong>il</strong> titolare Giuseppe con <strong>il</strong> figlio Antonio<br />
83
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
Dal 1995, infine, proprio accanto alla vecchia salumeria e sorta la trattoria<br />
“Porteri” che proprio come <strong>il</strong> Borgo che la ospita traspare quel fascino che<br />
viene dal passato e dalla tra<strong>di</strong>zione.<br />
“Borgo Trento è un’isola felice che fa propria la forza dei rapporti umani <strong>di</strong> chi<br />
vi abita: una zona che a saputo adeguarsi ai tempi, come confermano, anche,<br />
gli interventi urbanistici degli ultimi <strong>anni</strong> che, dal mio punto <strong>di</strong> vista, hanno<br />
migliorato la viab<strong>il</strong>ità <strong>del</strong> quartiere rendendolo ancora maggiormente fruib<strong>il</strong>e”<br />
spiega Raoul Porteri, particolarmente sod<strong>di</strong>sfatto per i lavori <strong>di</strong> risistemazione<br />
<strong>del</strong>le piazza <strong>del</strong>la Chiesa <strong>di</strong> Cristo Re, strutturata, proprio, per favorire i momenti<br />
<strong>di</strong> incontro tra i citta<strong>di</strong>ni.<br />
“Il borgo è sempre stato un luogo importante, storica strada <strong>di</strong> passaggio agli<br />
albori <strong>del</strong>la storia, poi, prolifico quartiere ricco <strong>di</strong> attività artigianali ed, infine,<br />
ai giorni nostri storico quartieri che si caratterizza per la suo ospitalità” ha proseguito<br />
Porteri ricordando i tempi quando <strong>il</strong> Borgo era circondato unicamente<br />
da campi e ci si conosceva tutti.<br />
“I tempi cambiano ma Borgo Trento resta legato alle proprie tra<strong>di</strong>zioni ed al<br />
modo <strong>di</strong> essere <strong>del</strong>la gente che vi abita: credo che questa zona abbia davvero<br />
<strong>del</strong>le possib<strong>il</strong>ità straor<strong>di</strong>narie, anche, perché forte <strong>del</strong>la presenza storica <strong>di</strong><br />
alcune famiglie, come i Gelmi o i Meraviglia, che da oltre cento <strong>anni</strong> risiedono<br />
qui”.<br />
“Il borgo, inoltre, ha prodotto personalità importanti sia a livello citta<strong>di</strong>no, penso<br />
per esempio a mio fratello Antonio, che è docente alla facoltà <strong>di</strong> economia<br />
<strong>del</strong>l’Università degli stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>, o ad Ottavio Bianchi, che nacque proprio<br />
qui nel 1943, per poi <strong>di</strong>venire allenatore <strong>di</strong> Diego Armando Maratona e portare<br />
<strong>il</strong> Napoli alla vittoria <strong>del</strong> suo primo storico scudetto”.<br />
84
4. LA CIRCOSCRIZIONE RACCONTATA<br />
85
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza <strong>del</strong>le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
86
In<strong>di</strong>ce<br />
INDICE<br />
La mappa <strong>del</strong>le Circoscrizioni pag. 6<br />
Introduzione - La Circoscrizione Nord pag. 7<br />
Capitolo 1<br />
I quartieri <strong>del</strong>la Circoscrizione Nord<br />
San Bartolomeo e Sant’Eustacchio pag. 9<br />
Borgo Trento pag. 17<br />
Mompiano e Casazza pag. 20<br />
La storia <strong>del</strong>l’ospedale pag. 23<br />
V<strong>il</strong>laggio Prealpino pag. 24<br />
Costalunga - San Rocchino pag. 26<br />
Capitolo 2<br />
A spasso per la Nord<br />
I musei pag. 29<br />
Le chiese pag. 31<br />
I parchi pag. 33<br />
Realtà <strong>del</strong> territorio pag. 36<br />
Le parrocchie pag. 38<br />
Le associazioni pag. 39<br />
Capitolo 3<br />
Alle origini <strong>del</strong> decentramento<br />
La storia <strong>del</strong>la <strong>partecipazione</strong> a <strong>Brescia</strong> pag. 43<br />
I presidenti <strong>del</strong>la Prima Circoscrizione pag. 47<br />
I presidenti <strong>del</strong>la Seconda Circoscrizione pag. 52<br />
Il presidente <strong>del</strong>la Circoscrizione Nord pag. 55<br />
Capitolo 4<br />
La Circoscrizione raccontata<br />
Angelo Boniotti pag. 58<br />
Lucio Bregoli pag. 63<br />
Alessandro Marelli pag. 68<br />
Gianluigi Fondra pag. 71<br />
Maur<strong>il</strong>io Lovatti pag. 75<br />
Luciano Rubessa pag. 80<br />
Raul Porteri pag. 83<br />
87
Progettazione ed impostazione grafica<br />
FZ Graphic & Design - <strong>Brescia</strong><br />
Stampa<br />
Graficasette - Bagnolo Mella (BS)