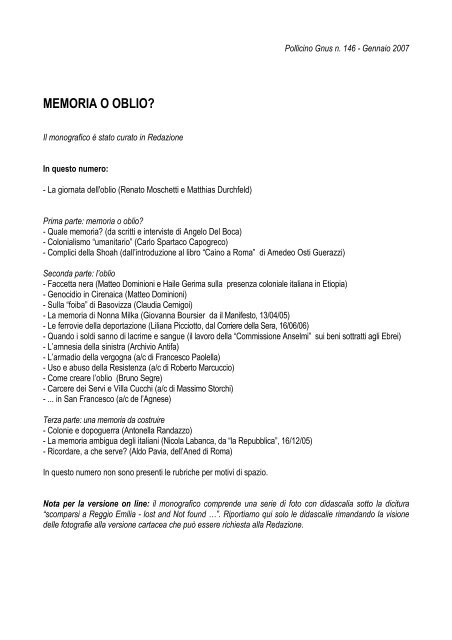Scarica il monografico - Pollicino Gnus
Scarica il monografico - Pollicino Gnus
Scarica il monografico - Pollicino Gnus
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
MEMORIA O OBLIO?<br />
Il <strong>monografico</strong> è stato curato in Redazione<br />
In questo numero:<br />
- La giornata dell'oblio (Renato Moschetti e Matthias Durchfeld)<br />
Prima parte: memoria o oblio?<br />
- Quale memoria? (da scritti e interviste di Angelo Del Boca)<br />
- Colonialismo “umanitario” (Carlo Spartaco Capogreco)<br />
- Complici della Shoah (dall’introduzione al libro “Caino a Roma” di Amedeo Osti Guerazzi)<br />
<strong>Pollicino</strong> <strong>Gnus</strong> n. 146 - Gennaio 2007<br />
Seconda parte: l’oblio<br />
- Faccetta nera (Matteo Dominioni e Ha<strong>il</strong>e Gerima sulla presenza coloniale italiana in Etiopia)<br />
- Genocidio in Cirenaica (Matteo Dominioni)<br />
- Sulla “foiba” di Basovizza (Claudia Cernigoi)<br />
- La memoria di Nonna M<strong>il</strong>ka (Giovanna Boursier da <strong>il</strong> Manifesto, 13/04/05)<br />
- Le ferrovie della deportazione (L<strong>il</strong>iana Picciotto, dal Corriere della Sera, 16/06/06)<br />
- Quando i soldi sanno di lacrime e sangue (<strong>il</strong> lavoro della “Commissione Anselmi” sui beni sottratti agli Ebrei)<br />
- L’amnesia della sinistra (Archivio Antifa)<br />
- L’armadio della vergogna (a/c di Francesco Paolella)<br />
- Uso e abuso della Resistenza (a/c di Roberto Marcuccio)<br />
- Come creare l’oblio (Bruno Segre)<br />
- Carcere dei Servi e V<strong>il</strong>la Cucchi (a/c di Massimo Storchi)<br />
- ... in San Francesco (a/c de l’Agnese)<br />
Terza parte: una memoria da costruire<br />
- Colonie e dopoguerra (Antonella Randazzo)<br />
- La memoria ambigua degli italiani (Nicola Labanca, da “la Repubblica”, 16/12/05)<br />
- Ricordare, a che serve? (Aldo Pavia, dell’Aned di Roma)<br />
In questo numero non sono presenti le rubriche per motivi di spazio.<br />
Nota per la versione on line: <strong>il</strong> <strong>monografico</strong> comprende una serie di foto con didascalia sotto la dicitura<br />
“scomparsi a Reggio Em<strong>il</strong>ia - lost and Not found …”. Riportiamo qui solo le didascalie rimandando la visione<br />
delle fotografie alla versione cartacea che può essere richiesta alla Redazione.
LA GIORNATA DELL'OBLIO<br />
In questo <strong>monografico</strong> abbiamo raccolto alcuni spunti per documentare quella che, secondo noi, è una “Giornata<br />
dell’Oblio” che dura ormai da tanti anni...<br />
Tralasciando i motivi psicologici che possono portare la singola persona alla scelta dell’oblio, vorremmo porre<br />
qui l’attenzione sulle scelte politiche, quelle rivolte alla collettività, alla cittadinanza... quelle scelte che sono<br />
state ut<strong>il</strong>izzate per nascondere verità scomode. Altro che memoria!<br />
Quanto conosciamo realmente del passato storico dell’Italia?<br />
Dov’è una divulgazione storica minimamente obbiettiva, senza scopi partitici, patriottici o scandalisticocommerciali?<br />
Chi vendeva all’esercito fascista italiano <strong>il</strong> gas usato per uccidere in Africa?<br />
Come mai conosciamo la Gestapo, ma non l’U.P.I.?<br />
Dov’è quella v<strong>il</strong>la dove i “ragazzi di Salò” anche a Reggio Em<strong>il</strong>ia torturavano i partigiani?<br />
Chi erano i poliziotti della Questura che arrestavano gli ebrei di Reggio?<br />
Chi guidava i treni della deportazione?<br />
Chi ha nascosto per decenni l’armadio della vergogna? I nazisti? Non sembra!<br />
Una memoria che sia attiva, che non sia riferita solo al passato, infastidisce?<br />
E’ forse l’oblio che ci può regalare una crescita civ<strong>il</strong>e della società in cui viviamo?<br />
L’esclusione, l’ingiustizia, la guerra, <strong>il</strong> razzismo ... tutte questioni di cui è meglio non parlare se non con toni<br />
celebrativi?<br />
Fra <strong>il</strong> Pansa di turno, “Le rose del deserto” o <strong>il</strong> monumento nazionale di Basovizza, <strong>Pollicino</strong> rischia anche lui<br />
di perdere quasi la speranza. Quasi!<br />
Speriamo ancora nella voglia di memoria, nella curiosità, nel rifiuto della superficialità e dei miti. Se non scaviamo<br />
più a fondo nella nostra (!) storia, anche la giornata della memoria del 27 gennaio rischia di diventare<br />
sempre di più l’ennesima celebrazione della favola del “bravo italiano” o vittima o buon samaritano.<br />
Ricordiamoci che ci volle una rete di luoghi e di persone che agirono con efficienza o anche solo con indifferenza<br />
per rendere possib<strong>il</strong>e quello che oggi spesso viene presentato come crimine di pochi.<br />
<strong>Pollicino</strong> continua ad affrontare queste tematiche non solo per passione storiografica ma perché crede che sia<br />
fondamentale per comprendere e agire oggi a favore dei diritti umani.<br />
Il 27 gennaio, anniversario della liberazione dei campi di Auschwitz, è una occasione importante per ricordare,<br />
e per riflettere quanto l’oblio ci impedisca di vivere un presente davvero libero.<br />
Renato Moschetti e Matthias Durchfeld<br />
(Redazione di <strong>Pollicino</strong> <strong>Gnus</strong>)<br />
scomparsi a Reggio Em<strong>il</strong>ia<br />
lost and Not found 1<br />
V<strong>il</strong>la Cucchi, sede dell’UPI (Ufficio Politico Investigativo del GNR, la “gestapo” Italiana) diretto<br />
dal maggiore Att<strong>il</strong>io Tesei dall’ottobre ’44 all’apri le 0’45. Qui venivano svolti gli interrogatori e<br />
qui i prigionieri venivano torturati. Nessun segno è mai stato posto a memoria di quanto è successo<br />
in tale luogo.
QUALE MEMORIA?<br />
PRIMA PARTE: MEMORIA O OBLIO?<br />
Lo storico Angelo Del Boca, ha proposto di istituire una Giornata della Memoria in ricordo dei cinquecentom<strong>il</strong>a<br />
africani uccisi dalla presenza coloniale italiana in Libia, Etiopia e Somalia. La richiesta è anche stata formalizzata<br />
al ministro degli esteri D’Alema e c’è già una proposta di legge in merito presentata dal deputato dei Comunisti<br />
Italiani Oliviero D<strong>il</strong>iberto. Riportiamo qui lo stralcio di un articolo di Del Boca, apparso sulla rivista “Nigrizia” (luglio-agosto<br />
2006) dove viene argomentata la richiesta.<br />
A seguire un pezzo di Emanuele Giordana tratto da “<strong>il</strong> Manifesto” del 17 Novembre 2005 sull’ultimo libro di Del<br />
Boca “Italiani Brava Gente?” (Neri Pozza, 2005).<br />
Del Boca è nato nel 1925 a Novara, per molti anni inviato speciale in Africa e Medio Oriente, ha insegnato Storia<br />
contemporanea alla facoltà di Scienze Politiche dell'università di Torino. Attualmente è presidente dell'Istituto<br />
Storico della Resistenza di Piacenza e direttore della rivista storica “Studi Piacentini”. Tra le sue numerose<br />
opere, ricordiamo i quattro volumi “Gli italiani in Africa orientale (1976-1984)”, i due di “Gli italiani in Libia<br />
(1986-88)”, e “L'Africa nella coscienza degli italiani (1992)”.<br />
Il 22 maggio 2006 <strong>il</strong> quotidiano “la Repubblica” pubblicava, su due intere pagine e con un richiamo in prima, un<br />
articolo di Paolo Rumiz su uno dei peggiori crimini consumati in Etiopia dalle truppe fasciste. L’articolo raccontava,<br />
in sintesi, ciò che lo storico Matteo Dominioni aveva scoperto nei dintorni di Ankober, seguendo<br />
l’itinerario indicato da una mappa dell’Ufficio storico dello Stato maggiore dell’esercito.<br />
Si tratta di un’immensa caverna nella quale alcune migliaia di etiopici, partigiani combattenti ma anche donne<br />
e bambini, si rifugiarono <strong>il</strong> 9 apr<strong>il</strong>e 1939, durante uno dei frequenti rastrellamenti ordinati da Amedeo di Savoia<br />
e dal comandante delle truppe, generale Ugo Cavallero.<br />
Per snidare gli arbegnuoe (i partigiani) dalla caverna, <strong>il</strong> plotone chimico della divisione “Granatieri di Savoia”<br />
ut<strong>il</strong>izzò i lanciafiamme e, quando queste armi si rivelarono inefficaci, impiegò l’artiglieria, con bombe caricate a<br />
iprite e arsine. Tuttavia, occorsero tre giorni di intensi bombardamenti per eliminare “<strong>il</strong> focolaio di rivolta”. Secondo<br />
i documenti m<strong>il</strong>itari italiani, i morti “accertati” furono 800, ma gli etiopici, che Dominioni ha interrogato<br />
nella regione, parlano invece di migliaia di uccisi. Cifra convalidata anche da ciò che di macabro e di terrificante<br />
Dominioni ha rinvenuto nella sua ispezione della caverna.<br />
L’episodio, certamente tra i più gravi accaduti in Etiopia (ma neppure <strong>il</strong> più angoscioso, se confrontato con le<br />
stragi di Addis Abeba del 19-21 febbraio 1937 e con la totale distruzione della popolazione della città conventuale<br />
di Debrà Libanòs), è <strong>il</strong> risultato di una di quelle “operazioni di grande polizia coloniale” che hanno caratterizzato<br />
<strong>il</strong> periodo della presenza italiana in Etiopia. Dopo aver sconfitto in 7 mesi, con una serie di battaglie<br />
campali, gli eserciti dell’imperatore Ha<strong>il</strong>è Selassiè, Mussolini era persuaso di aver concluso le operazioni belliche.<br />
Invece, non era che all’inizio. Per cinque anni avrebbe dovuto contrastare una generale e insidiosa guerriglia,<br />
ricorrendo a una controguerriglia fra le più feroci e cruente. In effetti, gli italiani non riuscirono mai a conquistare<br />
tutto l’impero del Negus.<br />
L’Etiopia è <strong>il</strong> paese che maggiormente ha pagato, in termini di vite umane, le aggressioni dell’imperialismo italiano.<br />
Ma la repressione è stata durissima anche in altre colonie africane, come la Libia e la Somalia. Nel Memorandum<br />
presentato dal governo imperiale etiopico al consiglio dei ministri degli esteri, riunitosi a Londra nel<br />
settembre del 1945, si parlava di 760m<strong>il</strong>a morti, facendo riferimento solo alle perdite subite tra <strong>il</strong> 1935 e <strong>il</strong> 1943<br />
e non a quelle della prima guerra italo-abissina del 1895-96. Alcuni storici libici e lo stesso governo di Gheddafi<br />
indicano, dal canto loro, in mezzo m<strong>il</strong>ione gli uccisi tra <strong>il</strong> 1911 e <strong>il</strong> 1943. Si tratta di due cifre non scientificamente<br />
documentate.<br />
Tuttavia, i morti etiopici accertati non sono meno di 350m<strong>il</strong>a e quelli libici superano certamente i 100m<strong>il</strong>a. Nelle<br />
repressioni ordinate in Somalia dal quadrumviro fascista Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon, tra <strong>il</strong> 1926 e <strong>il</strong><br />
1928, sono stati uccisi almeno 20m<strong>il</strong>a somali. Gli eritrei non hanno subito dure repressioni (se si eccettua quella<br />
del 1894 contro <strong>il</strong> degiac Batha Hagos), ma hanno perso almeno 30m<strong>il</strong>a ascari nelle campagne di conquista<br />
libiche, somale ed etiopiche. Tirando le somme, i governi di Crispi, Giolitti e Mussolini sono responsab<strong>il</strong>i della<br />
morte di 500m<strong>il</strong>a africani.
L’articolo di Paolo Rumiz sulla “foiba abissina” ha suscitato commenti e proposte di notevole r<strong>il</strong>ievo. Il giurista<br />
Antonio Cassese, ad esempio, suggeriva di seguire l’esempio della Germania, che ha reagito al nazismo scavando<br />
a fondo nel proprio passato recente, facendolo conoscere alle giovani generazioni, erigendo monumenti<br />
e musei alla memoria. Egli proponeva, inoltre, di creare una commissione di storici che esaminasse ciò che è<br />
avvenuto in Etiopia (e nelle altre colonie italiane, aggiungiamo noi) e preparasse una documentazione e<br />
un’analisi rigorose.<br />
In seguito alla proposta di Antonio Cassese (apparsa sulla Repubblica del 23 maggio), noi chiedevamo ospitalità<br />
allo stesso giornale per avanzare un ulteriore suggerimento: quello di istituire una Giornata della Memoria<br />
per i 500m<strong>il</strong>a africani che l’Italia crispina, giolittiana e fascista hanno sacrificato nelle loro sciagurate campagne<br />
di conquista. Nello stesso giorno (27 maggio) in cui Nello Ajello esponeva la nostra proposta sul giornale romano,<br />
scrivevamo una lettera al ministro degli affari esteri, Massimo D’Alema, per metterlo al corrente della<br />
nostra iniziativa. (…)<br />
Nella lettera a D’Alema, facevamo osservare che gli attuali rapporti con le nostre ex colonie non sono sereni, a<br />
cominciare da quelli con Tripoli, turbati dal mancato risarcimento dei danni di guerra. Una ricerca a tutto campo,<br />
eseguita con metodi scientifici, sui crimini commessi in Africa, non potrebbe che allontanare dal nostro paese<br />
<strong>il</strong> sospetto che si voglia rimuovere <strong>il</strong> passato e negarne gli aspetti più deteriori, come sta facendo da tempo<br />
<strong>il</strong> Giappone. Ciò potrebbe anche agevolare la soluzione del problema del contenzioso, che si trascina da<br />
anni. (…)<br />
Se questa Giornata venisse fatta propria dal nostro governo, - scrivevamo nella lettera a Massimo D’Alema - si<br />
raggiungerebbe anche l’obiettivo di riconoscere ufficialmente le colpe e gli orrori del nostro passato coloniale<br />
nella maniera più esplicita, nob<strong>il</strong>e e definitiva.<br />
(“Nigrizia”, luglio-agosto 2006)<br />
Benché “Italiani brava gente?”, l’ultimo libro di Angelo Del Boca, osservi la manipolazione storica dell’identità<br />
italiana a partire dall’800, la cronaca recente continua a servirgli spunti. E l’ultimo capitolo gliel’ha offerto qualche<br />
settimana fa <strong>il</strong> presidente del Consiglio, secondo cui l’Italia della brava gente avrebbe sconsigliato la guerra<br />
in Iraq a Bush. Un’affermazione che ha lasciato stupefatto anche lo storico del colonialismo, che abbiamo<br />
raggiunto al telefono mentre è in giro per l’Italia a presentare la sua ultima fatica.<br />
“Le dichiarazioni di Berlusconi sono perfettamente in linea con quello di cui parlo nel libro, che per altro non<br />
dimentica l’avventura irachena del governo. La verità è che c’è una sorta di linea di continuità, che va dall’Italia<br />
liberale ai nostri giorni, passando per <strong>il</strong> fascismo. Continuità nell’ostinarsi a nascondere le verità scomode sulle<br />
quali anzi viene costruito <strong>il</strong> mito del bravo italiano”.<br />
Proprio qui sta <strong>il</strong> tema del libro, che prende le mosse addirittura dalla visita dell’abate benedettino Jean Mab<strong>il</strong>lon<br />
(autore di una memoria che, alla fine del Seicento, disegna la povertà contadina di alcune regioni italiane)<br />
o dalle pagine di Charles-Louis de Secondat, che nel Settecento taccia le repubbliche italiane di “miserab<strong>il</strong>i aristocrazie<br />
in cui i nob<strong>il</strong>i ambiscono a conservare <strong>il</strong> loro ozio e i loro priv<strong>il</strong>egi”. Ma <strong>il</strong> libro si concentra poi<br />
sull’Italia unita che non può più accusare lo Stato pontifico o l’oscurantismo dei Borboni. E’ infatti dalla seconda<br />
metà dell’800 che prende avvio la costruzione di un mito buono per tutte le avventure. “Mi sono concentrato<br />
su una dozzina di episodi - dice lo storico - che dimostrano una capacità distruttiva <strong>il</strong>limitata. Ma l’intento del<br />
libro non è quello di mettere l’Italia al primo posto come campione di violazioni patenti in casa o nelle colonie.<br />
Il mio lavoro intende dimostrare semplicemente che gli italiani sono stati uguali agli altri, se non peggio, nel<br />
corso di una storia che, faticosamente, abbiamo ricostruito squarciando <strong>il</strong> velo su segreti e bugie. Uguali agli<br />
altri, nel bene e nel male, ma con una differenza: si è sempre cercato di dimenticare e nascondere le pagine<br />
buie della nostra storia per esaltare un’italianità della tolleranza, della diversità. Un mito che serviva a cancellare<br />
le tracce delle nostre nefandezze, sia che si trattasse dell’oppressione dei contadini poveri del meridione<br />
per finire con le bombe all’iprite della campagna etiopica. Il mito del buon italiano che costruisce scuole strade<br />
è semplicemente falso. Anche se continua a resistere nel tempo come dimostrano le dichiarazioni di Berlusconi”.
Questo mito della diversità italiana è dunque <strong>il</strong> rimedio autoassolutorio, secondo Del Boca, che impedisce al<br />
nostro paese di fare i conti con la storia, con la memoria, con una coscienza nazionale monca. E’, dice lo storico,<br />
una passione che ha coinvolto le leadership e, da lì, sino all’ultimo protagonista della nostra storia recente.<br />
“Direi che sostanzialmente c’è un’assoluta linea di continuità tra la liberaldemocrazia, <strong>il</strong> fascismo e gli anni<br />
che hanno seguito la dittatura. Il mito resiste al di là dei governi. Certo durante un regime, diventa più fac<strong>il</strong>e<br />
propagandarlo perché non c’è controllo, non c’è opposizione, dibattito, non c’è stampa che possa contestare.<br />
Ma se si pensa all’avventura della Libia si comprende che la differenza non è poi molta. In questo non c’è molto<br />
di diverso tra Giolitti e Mussolini. Certo si potrebbe dire che la dittatura costruì una sorta di industrializzazione<br />
della barbarie <strong>il</strong> cui obiettivo in Africa era l’annientamento più che la conquista…<br />
Mussolini non dormiva la notte, tormentato com’era dallo spettro di Adua. Non voleva un bis. E allora <strong>il</strong> bravo<br />
italiano sganciò le bombe con i gas mortali di cui abbiamo avuto un’ammissione tardiva soltanto qualche anno<br />
fa”. Quella delle bombe all’iprite, su cui del Boca e altri storici avevano lavorato per anni, è diventata verità ufficiale<br />
solo negli anni Novanta. E ancora molti stentavano a credere che fosse potuto accadere.<br />
“Quando ho presentato <strong>il</strong> libro a M<strong>il</strong>ano, al momento degli interventi, un signore che aveva fatto le campagne<br />
d’Africa mi disse che non poteva essere d’accordo perché lui le cose raccontate nel libro non le aveva viste.<br />
Commetteva lo stesso errore di Montanelli con cui ebbi una polemica durata anni, anche se poi Montanelli,<br />
che era una persona intellettualmente onesta, ammise di essersi sbagliato. Il fatto è che per lui la guerra era<br />
durata di fatto quaranta giorni (poi, ferito, era stato trasferito in Italia ndr) e in Africa le bombe non le aveva<br />
davvero viste. Il fatto è che l’iprite venne sganciata solo <strong>il</strong> 21 dicembre quando lui non era più lì. Come Montanelli,<br />
molti soldati non videro quel che faceva l’aviazione che del resto tenne ben nascoste le cose.<br />
Questi italiani in buona fede, al fronte o a casa, sono rimasti vittime di un mito che nasce verso al fine dell’800<br />
e che si dipana per tutto <strong>il</strong> secolo successivo sino ad arrivare alla strage dei nostri soldati in Iraq. Tutti se ne<br />
stupirono: ma come? Noi che andiamo ad aiutare, noi che siamo forze di pace? Com’era possib<strong>il</strong>e che venissimo<br />
colpiti? L’effetto del mito è anche questo. A differenza degli italiani, i britannici, per fare un esempio, si<br />
sono sempre assunti le loro responsab<strong>il</strong>ità Se vanno in guerra vanno in guerra e basta. Considerano insomma<br />
la brutalità un aspetto legittimo di una campagna m<strong>il</strong>itare. Noi invece questa ammissione non la vogliamo mai<br />
fare e allora ci andiamo mascherando le aggressioni con i ponti e le strade. Che alimentano <strong>il</strong> mito”.<br />
Il libro di Del Boca passa in rassegna <strong>il</strong> suo dipanarsi dai giorni di Pechino durante la rivolta dei boxer, alle<br />
campagne in Libia e in Africa orientale, alla guerra in Slovenia, passando per le pagine buie firmate dal generale<br />
Cadorna nella Grande guerra. A salvarsi sono in pochi. E la sinistra italiana? C’è chi l’ha accusata di nascondere<br />
la verità. Nel dopoguerra ad esempio si è detto che ha cercato di occultare le prove di eccidi compiuti<br />
per vendetta o interesse personale approfittando della caduta del fascismo. “Certo ci sono state delle responsab<strong>il</strong>ità<br />
individuali, come negarlo? Ma non si può far confusione e non si possono far lievitare i numeri<br />
come è stato fatto quando si parlò di 300m<strong>il</strong>a morti… b<strong>il</strong>ancio sceso poi a 30-40m<strong>il</strong>a… Io mi rifaccio alle stime<br />
del governo democristiano che parlano di 10m<strong>il</strong>a vittime. Il fatto è che la guerra non terminò <strong>il</strong> 25 apr<strong>il</strong>e ma <strong>il</strong> 3<br />
maggio. In quella settimana eravamo di fatto ancora in guerra. Lo ricordo bene perché comandavo un’unità<br />
partigiana a Piacenza. I cecchini, dopo <strong>il</strong> 25 apr<strong>il</strong>e, ci sparavano dai tetti delle case e noi reagimmo. Quando<br />
capitavano occasioni di giustizia sommaria, intervenivo per evitarli”. (...)<br />
“<strong>il</strong> Manifesto” - 17 Novembre 2005<br />
Testimonianza del Negus sull’uso dei gas<br />
A Quoram, squadriglie di sette o di nove apparecchi sorvolavano <strong>il</strong> nostro quartier generale, le nostre truppe, i<br />
nostri v<strong>il</strong>laggi per intere settimane, dall’alba al tramonto. [...] Il paese sembrava sciogliersi. Il s<strong>il</strong>enzio si faceva<br />
ogni giorno più grande su questi magnifici altipiani dove gli orizzonti sono così vasti e l’aria così pura. Né gli<br />
uomini né le bestie erano più in grado di respirare. Ogni essere vivente che veniva toccato dalla leggera pioggia<br />
caduta dagli aerei, che aveva bevuto l’acqua avvelenata o mangiato cibi contaminati, fuggiva urlando e<br />
andava a rifugiarsi nelle capanne o nel folto dei boschi per morirvi. [...] C’erano cadaveri dappertutto, in ogni
macchia, sotto ogni albero, ovunque ci fosse la parvenza di un rifugio. Ma ce n’erano anche di più all’aperto, in<br />
piena vista, perché la morte veniva in fretta e molti non avevano <strong>il</strong> tempo per cercare un rifugio per morirvi in<br />
pace. Presto un odore insopportab<strong>il</strong>e gravò sull’intera regione. Non si poteva però pensare di seppellire i cadaveri,<br />
perché erano più numerosi dei vivi. Bisognò adattarsi a vivere in questo carnaio. Nel prato vicino al nostro<br />
quartier generale più di cinquecento cadaveri si decomponevano lentamente.<br />
Da: La vérité sur la guerre italo-éthiopienne. Une victoire de la civ<strong>il</strong>isation, par le Négus, supplemento a “Vu”,<br />
Paris, luglio 1936, pp.27-28. vedi: http://www.museodelleintolleranze.it/<br />
L’uso delle armi chimiche e batteriologiche era stato proibito dal trattato internazionale di Ginevra del 17 giugno<br />
1925 sottoscritto dal governo italiano. Mussolini autorizza, in una serie di telegrammi indirizzati ai generale<br />
Graziani e al Maresciallo Badoglio, rispettivamente comandanti del fronte meridionale e comandante superiore<br />
in Africa orientale, <strong>il</strong> ricorso a “qualunque mezzo”, facendo costantemente riferimento alla necessità di operare<br />
con la “massima decisione” ed esplicitamente riferendosi all’ “impiego gas qualunque specie et su qualunque<br />
scala” (Mussolini a Badoglio, <strong>il</strong> 29 marzo 1936)<br />
COLONIALISMO “UMANITARIO”<br />
Di Carlo Spartaco Capogreco, pubblichiamo un brano tratto dal libro “I campi del duce - l’internamento<br />
nell’Italia fascista 1940 - 1943” (Einaudi, 2004). Capogreco (1955), docente presso la Facoltà di Scienze Politiche<br />
dell’Università della Calabria è presidente della Fondazione Ferramonti. Tra i suoi scritti “Ferramonti. La<br />
vita e gli uomini del più grande campo d’internamento fascista 1940-1945” (Giuntina, Firenze 1987) e “Renicci.<br />
Un campo di concentramento in riva al Tevere” (Mursia, M<strong>il</strong>ano, 2003).<br />
(...) Nei territori jugoslavi, occupati o annessi dopo l'invasione nazifascista del 6 apr<strong>il</strong>e 1941, l'Italia ricorse<br />
spesso a metodi repressivi che prevedevano l'incendio dei v<strong>il</strong>laggi, la fuc<strong>il</strong>azione di ostaggi civ<strong>il</strong>i e la deportazione<br />
della popolazione negli speciali campi di concentramento “per slavi”. Allestiti in Italia e negli stessi territori<br />
invasi, e gestiti quasi sempre dal Regio Esercito, quei campi costrinsero i reclusi a un internamento rigoroso<br />
e durissimo che portò alla morte migliaia di persone, tra cui moltissimi bambini. Eppure nel nostro paese si sa<br />
ancora poco, non solo di quelle vicende, ma anche della stessa esistenza di campi di concentramento italiani<br />
durante la Seconda guerra mondiale. “Internamento in condizioni disumane”: ecco <strong>il</strong> capo d'accusa che figurava<br />
nell'elenco - st<strong>il</strong>ato nel dopoguerra dal governo jugoslavo - dei crimini che avrebbero commesso gli occupanti<br />
italiani. Ma la nostra giovane Repubblica “nata dalla Resistenza” evitò di sottoporre a processo anche i<br />
principali fautori e organizzatori di quei campi, i cui nomi, per l'appunto, compaiono tra quelli degli italiani dei<br />
quali la Jugoslavia chiese inut<strong>il</strong>mente l'estradizione.<br />
Sia l'insabbiamento delle indagini sui criminali di guerra italiani che l'epurazione di facciata del personale coinvolto<br />
col fascismo contribuirono al formarsi di una coscienza collettiva della recente storia nazionale largamente<br />
autoassolutoria e rassicurante. Il colonialismo italiano fu definito “umanitario”; l'antisemitismo fu liquidato<br />
quale “prodotto d'importazione”, e i delitti commessi dalle nostre truppe nelle colonie e nei Balcani vennero<br />
coperti da una cortina di s<strong>il</strong>enzio. In tal modo cominciò a sedimentarsi nel senso comune quella visione edulcorata<br />
del comportamento degli italiani in tempo di pace e, ancor più, in tempo di guerra, che li rappresenta<br />
sempre “umani e bendisposti” nei confronti delle popolazioni dei paesi invasi e, in ultima analisi, vittime anch'essi<br />
della dittatura e delle guerre volute da Mussolini.<br />
Al rafforzarsi di questa immagine, nel dopoguerra contribuì anche l'atteggiamento delle forze politiche di sinistra<br />
e dell'antifascismo nel suo insieme, che, in nome della “ragion di Stato”, preferirono sottolineare i meriti<br />
dell'Italia partigiana piuttosto che le colpe di quella fascista. L'argomento della “bontà nazionale” costituì <strong>il</strong> nucleo<br />
centrale del discorso egemonico della nuova classe dirigente, che perseguiva l'obiettivo della riconc<strong>il</strong>iazione<br />
di tutti “i buoni italiani”, facendo ricorso alla “virtuosità” dell'intero popolo per esaltare <strong>il</strong> carattere tirannico
del fascismo, presentato come “regime senza consenso” e quindi come “corpo estraneo” alla storia e al “carattere<br />
nazionale” degli italiani. In tal modo fu possib<strong>il</strong>e offuscare la più semplice verità che la dittatura - come osservò<br />
acutamente Carlo Rosselli - in realtà aveva espresso i vizi, le debolezze e le miserie di tutto <strong>il</strong> nostro popolo.<br />
Lungo questa strada, intrapresa da un paese come <strong>il</strong> nostro non abituato all'autocritica, c'è voluto poco<br />
perché si giungesse alla quasi totale rimozione delle gravissime responsab<strong>il</strong>ità italiane nel ventennio e nella<br />
Seconda guerra mondiale. Gli stessi ebrei italiani, che pure erano stati tra le principali vittime della dittatura, in<br />
un clima non certo favorevole all'accettazione di identità particolari, preferirono, nel dopoguerra, rifugiarsi in<br />
una memoria “di carattere riconc<strong>il</strong>iatorio”.<br />
D'altro canto, era la particolare efferatezza dei crimini nazisti a fornire un alibi assai comodo al diffondersi dell'oblio<br />
nostrano: ci volle ben poco perché <strong>il</strong> confronto fra <strong>il</strong> comportamento dei due alleati portasse a relativizzare<br />
e minimizzare (se non a trascurare del tutto) le specifiche responsab<strong>il</strong>ità fasciste. Pertanto gli italiani, che<br />
sin dagli anni Trenta erano ricorsi proprio ai campi di concentramento per “pacificare” le colonie africane, finirono<br />
con l'adagiarsi sulla comoda presunzione che questo capitolo emblematico della storia del XX secolo li<br />
riguardasse solo come vittime. E quando Giorgio Rochat, nel 1973, Si “permise” di pubblicare uno dei pochi<br />
studi tuttora disponib<strong>il</strong>i sui campi coloniali italiani, venne accusato di “faziosità anti-italiana preconcetta” e coperto<br />
da ingiurie personali. (...)<br />
Nel romanzo La frontiera (1964) di Franco Vegliani, ad esempio, è addirittura a un anziano jugoslavo avviato<br />
nei campi di concentramento fascisti che si fa dichiarare - in ossequio alla “bontà italiana” - che “gli italiani, alla<br />
fine, sono brava gente...”, mentre in anni più recenti, quella stessa “bontà” permeerà <strong>il</strong> pluripremiato f<strong>il</strong>m di<br />
Gabriele Salvatores Mediterraneo. Ancora: quando negli anni Sessanta una delegazione di ex combattenti jugoslavi<br />
giunse nel nostro paese per rendere omaggio alle spoglie mortali dei suoi connazionali deceduti nel<br />
campo di Monigo, né le autorità comunali né le associazioni partigiane seppero indicare <strong>il</strong> luogo della sepoltura.<br />
Addirittura, fu solo grazie a quella visita che moltissimi cittadini di Treviso presero coscienza della passata<br />
esistenza di un campo di concentramento alle porte della loro città. È potuto accadere, d'altra parte (errore<br />
tecnico o volontà italiana di deresponsab<strong>il</strong>izzazione?), che immagini di internati jugoslavi scheletriti dalla fame<br />
nei campi di concentramento di Mussolini venissero presentate come documenti dell'universo concentrazionario<br />
nazista; o che - in un contesto da Italietta festosa e nostalgica - la canzone-simbolo delle guerre coloniali<br />
fasciste, Faccetta nera, venisse riproposta dalla televisione pubblica senza alcun accenno ai lutti e ai disastri<br />
provocati a tanti popoli dal nostro colonialismo. Infine, chiudendo un elenco che potrebbe essere molto lungo,<br />
una doverosa riflessione sulle dichiarazioni fatte nel dicembre 1990 dall'allora presidente della Repubblica<br />
Cossiga, nel corso di una sua visita in Germania (“Noi italiani non abbiamo conosciuto gli orrori dei campi di<br />
concentramento...”); e su quelle r<strong>il</strong>asciate, nel settembre 2003, dal nostro presidente del Consiglio (“Mussolini<br />
non ha mai ammazzato nessuno; Mussolini mandava la gente a fare vacanza al confino”), che riducono la dittatura<br />
fascista pressoché ad una sorta di tour-operator (...).<br />
Memoria e disgusto: una lettera, una proposta<br />
di Daniele Barbieri<br />
Scrive Igiaba Scego, scrittrice somala: “In che Paese viviamo? Forse qualcuno ne era a conoscenza, ma io<br />
casco dalle nuvole... cercavo qualcosa per la mia tesi di dottorato e vo<strong>il</strong>à un pugno allo stomaco. (...). E’ come<br />
fare un museo a Hitler. Era <strong>il</strong> macellaio d'Etiopia. Usò noi somali in modo v<strong>il</strong>e. Scopro: Museo Civico Maresciallo<br />
Rodolfo Graziani … ingresso gratuito: di prossima apertura, via Antonio Arcuati a F<strong>il</strong>ettino (Frosinone).<br />
Mi sembra uno schiaffo alla legalità. Ai diritti umani. Così si uccide la storia. Che già è moribonda, parecchio<br />
tronca direi”.<br />
Condivido <strong>il</strong> disgusto di Igiaba e faccio girare <strong>il</strong> messaggio. Fra gli altri ricevo questa risposta di Hamid Abdu<br />
Barole, poeta eritreo: “Se ti capita di venire a Parma, appena esci dalla stazione sarai accolta dal monumento
di Badoglio. Preso atto che ho m<strong>il</strong>le e un motivo per non fare un commento (per i limiti della democrazia), mi<br />
limito a fornirti l'informazione”.<br />
Risponde Igiaba: “Ma allora quante strade, quanti monumenti sono dedicati a leader fascisti in Italia? E sul periodo<br />
coloniale in particolare? Perché non le elenchiamo e fotografiamo? Chi mi vuole aiutare? Mettetevi in<br />
contatto o mandate segnalazioni. Grazie”.<br />
Propongo a <strong>Pollicino</strong>: aiutiamo Igiaba (igiaba74@alice.it) in questa raccolta e facciamo un piccolo dossierschifo.<br />
Che dite?<br />
COMPLICI DELLA SHOAH<br />
Davanti alla deportazione degli ebrei dal ghetto di Roma c’è stato solo <strong>il</strong> s<strong>il</strong>enzio del Papa? Oppure c’è stata<br />
anche una collaborazione da parte di cittadini comuni e istituzioni romane? Come avrebbero potuto altrimenti, i<br />
nazisti, dopo aver arrestato più di 1.000 persone <strong>il</strong> 16 ottobre 1943, deportare altri 1.000 ebrei nei pochi mesi<br />
che separavano dalla liberazione della città, avvenuta all’inizio del giugno 1944?<br />
Su questo tema, che ovviamente non riguarda solo la città di Roma, riportiamo alcuni stralci dall’introduzione<br />
del libro “Caino a Roma - i complici romani della Shoah”, di Amadeo Osti Guerazzi (Cooper srl, Roma 2005).<br />
(...) Nelle memorie di chi ha vissuto in quel periodo, le leggi razziali, la persecuzione degli ebrei e la deportazione<br />
dall'Italia sembrano essere dei dettagli, degli avvenimenti astratti che non avevano attinenza con là realtà.<br />
È come se fossero avvenuti in un altro paese, in altre città, e non avessero riguardato concittadini, vicini di<br />
casa, compagni di scuola, amici. Soprattutto si è voluto dimenticare che, senza l'attiva collaborazione di alcuni<br />
romani, i tedeschi non avrebbero potuto trovare, arrestare e deportare 2.000 ebrei oltre a migliaia di partigiani<br />
e renitenti alla leva. La rimozione è avvenuta attraverso lo spostamento di ogni responsab<strong>il</strong>ità verso <strong>il</strong> “cattivo<br />
tedesco” oppure verso <strong>il</strong> “fascista”, comunque verso qualcuno che si ritiene altro da sé, ost<strong>il</strong>e e nemico. Rimozione<br />
e spostamento di responsab<strong>il</strong>ità hanno permesso al popolo italiano di evitare qualunque complesso di<br />
colpa ma anche ogni riflessione seria, almeno fino agli anni Novanta, relativamente al ruolo svolto nella Shoah;<br />
ciò non ha soltanto consentito la cancellazione di ogni memoria di partecipazione attiva alle deportazioni,<br />
ma anche ogni conoscenza dei fatti. Migliaia di cittadini inermi di ogni età sono stati prima fatti oggetto di una<br />
odiosa discriminazione sociale, e in seguito sono stati deportati e uccisi in maniera barbara, e questo grazie<br />
anche all'attiva collaborazione di numerosi romani; tuttavia di tutto questo si è parlato pochissimo.<br />
(...) Forse anche per questi motivi fu così fac<strong>il</strong>e, per i delatori, essere assolti non solo dai tribunali. ma anche<br />
dalla società, che li riammise grazie prima di tutto all'amnistia del 1946, poi all'oblio che coprì rapidamente tanti<br />
misfatti. L'amnistia, infatti, aggravò ulteriormente le cose, perché permise la scarcerazione di persone che<br />
erano state oggettivamente e consapevolmente complici della persecuzione degli ebrei, consentendo un generale<br />
clima di sfiducia nella possib<strong>il</strong>ità di perseguire i colpevoli e favorendo un generico senso di “riappacificazione”.<br />
Sull'amnistia voluta dal Segretario del PCI si è scritto moltissimo, e le sue implicazioni e i suoi risultati<br />
sul contesto generale della storia del dopoguerra esulano dagli scopi di questo lavoro. Ma la ricaduta sulla<br />
posizione giudiziale dei vari delatori e collaborazionisti fu sicuramente negativa proprio perché favorì quel processo<br />
di rimozione che, come abbiamo visto, ha impedito una reale presa di coscienza delle responsab<strong>il</strong>ità italiane.<br />
(...) Tale politica veniva poi sostenuta da un fiume di memorialistica agiografica tutt'ora ut<strong>il</strong>izzata dagli storici<br />
come fonte attendib<strong>il</strong>e sulle gesta dei soldati italiani. La politica dei governi che si avvicendarono nel dopoguerra<br />
fu tutta incentrata sul tentativo di presentare <strong>il</strong> popolo italiano vittima prima del fascismo e poi dell'occupazione<br />
tedesca, obliando quindi la fase iniziale della guerra quando, con grande convinzione, gran parte di<br />
quello stesso popolo italiano esultava per le vittorie dell'Asse e sognava un “Nuovo Ordine Europeo” con<br />
l’Italia, assieme alla Germania, in posizione dominante.
(...) Tutti questi fattori, in sintesi, hanno consentito la creazione di questo mito, di questa memoria condivisa, o<br />
meglio “smemoratezza condivisa”, che ha portato fascisti e antifascisti, memorialisti e storici, alla stessa conclusione,<br />
alla creazione del mito del fascismo “buono”, o “meno cattivo” del nazismo, e degli italiani “geneticamente”,<br />
“naturalmente” migliori dei tedeschi. Se un italiano non può che sentirsi compiaciuto nel leggere tali<br />
frasi, tuttavia le acquisizioni storiografiche più recenti dimostrano che, nella legislazione e nella prassi, le leggi<br />
razziali furono tutt'altro che una farsa, che l'apparato statale italiano diede prova di efficienza e determinazione<br />
nel perseguitare i cittadini ebrei, e l'antisemitismo fu un fenomeno piuttosto radicato nella popolazione romana.<br />
Nel 1997 una oramai famosa intervista allo storico tedesco Lutz Klinkhammer, portava l'attenzione degli storici<br />
su quella “percezione sb<strong>il</strong>anciata” della memoria collettiva italiana che portava gli italiani stessi a sentirsi sempre<br />
“vittime” e mai colpevoli, e a dimenticare, ad esempio, la brutale politica di occupazione messa in atto dal<br />
fascismo in vari paesi tra <strong>il</strong> 1935 e <strong>il</strong> 1943. Hanno seguito, anche per merito di questa intervista, una serie di<br />
pubblicazioni di giovani storici che hanno incrinato <strong>il</strong> mito del “bravo italiano”. Ad esempio Davide Rodogno ha<br />
esaminato la politica di occupazione in Francia e nei Balcani, mentre Massim<strong>il</strong>iano Griner ha ricostruito le gesta<br />
criminali della banda Koch. Negli ultimi mesi Costantino Di Sante ha invece pubblicato una serie di documenti<br />
sui crimini di guerra italiani in Jugoslavia. In particolare Klinkhammer e Focardi hanno ricostruito in maniera<br />
convincente la politica dello Stato italiano intesa a soffocare ogni tentativo di far pagare ai criminali di<br />
guerra italiani i loro crimini, anche a costo di far fuggire tanti tedeschi colpevoli di delitti orrendi commessi ai<br />
danni della popolazione italiana.<br />
(...) Bisogna a questo punto fermarsi e tornare alla seconda domanda di questa introduzione: cosa sapevano i<br />
romani della persecuzione degli ebrei? A quale grado di conoscenza erano arrivati o potevano arrivare in base<br />
alle notizie che f<strong>il</strong>travano dall'Est europeo e dagli apparati statali tedeschi? Cosa avevano visto e cosa avevano<br />
capito durante i mesi dell'occupazione tedesca?<br />
È necessario fare un primo elenco di categorie di italiani che, in vario modo, erano arrivati a contatto con la<br />
realtà e avevano saputo brandelli di notizie. Innanzitutto i fascisti e <strong>il</strong> governo fascista, per cominciare dai più<br />
vicini ai tedeschi e quindi alla verità.<br />
Nell'Archivio storico del Ministero degli Affari Esteri è conservata la sintesi di una trasmissione radiofonica trasmessa<br />
da Londra <strong>il</strong> 27 febbraio 1943. Il testo dice:<br />
“L'Ufficio Informazioni Internazionali a Londra ha rivelato <strong>il</strong> numero approssimativo di vittime dei nazisti in Europa:<br />
In Polonia, durante l'ultimo anno, sono periti fuc<strong>il</strong>ati o nei campi di concentramento tedeschi due m<strong>il</strong>ioni e<br />
mezzo di polacchi, dei quali un m<strong>il</strong>ione di ebrei. Il massimo tempo che si possa rimanere in vita in un campo di<br />
concentramento è di 9 mesi. In Cecoslovacchia, 2.463 persone sono state giustiziate senza contare le vittime<br />
a Lidice e di Lidaske. In Francia, 24.000 francesi sono periti, ma i tedeschi non osano pubblicare i nomi, per<br />
via dell'ira pubblica che questo suscita”.<br />
Ciò che stupisce, leggendo questo appunto, è <strong>il</strong> tono che, nella sua freddezza burocratica, espone tutto con<br />
l’indicativo, senza quindi mettere in dubbio la veridicità delle affermazioni della radio nemica. Radio Londra ha<br />
rivelato <strong>il</strong> numero dei morti fatti dai tedeschi, non ha accusato i nazisti di un crimine, ha dato soltanto le cifre di<br />
qualcosa che si dà, evidentemente, per scontato per i funzionari del Ministero degli Esteri italiano.<br />
(...) In ultimo, i cittadini comuni potevano comunque attingere anche da Radio Londra, che dall'autunno del<br />
1943 cominciò a denunciare la persecuzione degli ebrei italiani con le trasmissioni curate da Paolo Treves. E<br />
che Radio Londra fosse ascoltata da tutti i romani, è provato da numerosissime testimonianze.<br />
Anche la stampa clandestina antifascista contribuì a diffondere notizie relative alla persecuzione degli ebrei.<br />
Ad esempio “L'Italia libera”, organo del Partito d'Azione raccontò la deportazione degli ebrei romani del 16 ottobre,<br />
in una maniera che non lasciava assolutamente dubbi sulla volontà nazista di sterminare tutti gli ebrei<br />
donne e bambini compresi. Il 30 ottobre lo stesso periodico clandestino poteva denunciare agli italiani <strong>il</strong> massacro<br />
di Meina, dove i tedeschi trucidarono un gruppo di 14 persone, tra uomini, donne e bambini ebrei. Dopo<br />
l'8 settembre vi era, infine, la stampa del Regno del Sud, che aveva cominciato a pubblicare articoli sugli ebrei.<br />
“Il Messaggero” ad esempio, <strong>il</strong> 9 luglio 1944, pubblicava in prima pagina l'articolo intitolato “Due m<strong>il</strong>ioni di ebrei<br />
massacrati in tre campi polacch”i. Il 24 giugno “LItalia libera” riportava un articolo del “Times” relativo all'impiego<br />
di gas letali nei campi nazisti, a cui ne seguiva un secondo <strong>il</strong> 1 ottobre successivo. (...)<br />
Insomma, i fascisti in primis, ma anche molti cittadini comuni, avevano a loro disposizione tanti piccoli tasselli<br />
di una verità forse troppo enorme per essere creduta, e che tuttavia era sotto gli occhi di tutti. Chi avesse visto<br />
i cinegiornali dell'Istituto Luce, che mostravano gli ebrei polacchi con la stella gialla divisi dalla popolazione “a-
iana”, avesse parlato con un prete o con un m<strong>il</strong>itare reduce dal fronte, avesse ascoltato Radio Londra e, infine,<br />
avesse avuto notizia del rastrellamento del ghetto di Roma, aveva tutti gli elementi per capire almeno una<br />
parte della verità. Non si spiega altrimenti, sempre ut<strong>il</strong>izzando un metodo deduttivo, come mai tanti romani si<br />
siano messi deliberatamente in pericolo per aiutare i numerosi concittadini ebrei. Perché l'avrebbero fatto, se<br />
non sapevano nulla della sorte che aspettava i perseguitati? Insomma, la tesi di questo libro è che numerosi<br />
italiani, e i romani in particolare, potevano sapere che gli ebrei deportati dai tedeschi sarebbero stati “liquidati”.<br />
Come, perché, e in quale modo sicuramente no, ma sul fatto che sapessero che la morte fosse <strong>il</strong> loro destino,<br />
non vi possono essere più molti dubbi. Il problema è dunque un altro: come è stato possib<strong>il</strong>e che delle persone<br />
normali abbiano compiuto degli atti che, come vedremo in seguito, si possono definire abbietti? Come si arriva<br />
a tradire e denunciare intere famiglie di vicini di casa, facendo arrestare donne e bambini inermi? È solo <strong>il</strong> lucro<br />
l'unico movente di tante delazioni? (...)<br />
scomparsi a Reggio Em<strong>il</strong>ia<br />
lost and Not found 2<br />
Cardini del ghetto ebraico<br />
Nel 1669 la duchessa Laura Martinozzi, vedova del duca Alfonso IV e reggente lo stato a nome del<br />
figlio minorenne Francesco II, dispone la istituzione del ghetto e che gli ebrei reggiani fino a quel<br />
momento “dispersos per urbem”, vengano obbligati a risiedere nelle vie oggi denominate San Rocco,<br />
Caggiati, della Volta, dell'Aqu<strong>il</strong>a, Monzermone, in ottemperanza alla disposizione papale (bolla<br />
Cum nimis absurdum di Paolo IV, 1555). Gli ebrei reggiani entrano in ghetto. Si tratta di 162 famiglie<br />
equivalenti a circa 885 persone. Tutte le strade di accesso al ghetto sono munite di portoni<br />
che vengono chiusi al tramonto e riaperti all'alba a cura di guardiani cristiani. Non esiste targa<br />
che ricordi questa incredib<strong>il</strong>e separazione, e, grazie ad un restauro insensib<strong>il</strong>e, sono spariti nel<br />
2006 anche gli ultimi importanti segni tangib<strong>il</strong>i. Ora si notano solo gli smussi che ospitavano cardini<br />
e portoni.<br />
A tal proposito <strong>il</strong> consigliere comunale Sebastiano Zini ha presentato una interpellanza<br />
all’Assessore Spadoni nella quale, oltre a chiedere conto della scomparsa dei cardini, chiede<br />
l’apposizione di una targa a ricordo di quello che fu <strong>il</strong> luogo della segregazione dei cittadini ebrei<br />
reggiani.
FACCETTA NERA<br />
SECONDA PARTE: L’OBLIO<br />
Sulla presenza coloniale italiana in Etiopia, riportiamo due scritti. Il primo è di Paolo Rumiz (“la Repubblica”, 22<br />
Maggio 2006) e ci parla delle prove di una strage compiuta dall’Esercito italiano a 100 km da Addis Abeba, solo<br />
recentemente scoperte dal ricercatore Matteo Dominioni. Il secondo è di Emanuele Giordana (“Il Sole 24 ore”,<br />
17 Settembre 2006) e racconta una pagina della Resistenza etiopica contro l’invasore italiano in un’intervista al<br />
regista etiope Ha<strong>il</strong>e Gerima.<br />
Le prove di un efferato crimine italiano riemergono in Etiopia, 70 anni dopo la proclamazione dell’Impero, gettano<br />
luce sinistra su un conflitto che la nostra memoria ancora rimuove o traveste da scampagnata coloniale. Le ha<br />
trovate in queste settimane Matteo Dominioni, 33 anni, dottore di ricerca dell’università di Torino. Prima le carte,<br />
documenti inoppugnab<strong>il</strong>i. Poi le ossa umane, nella grotta dell’infamia, ancora avvolte da fosche leggende. La<br />
conferma definitiva di quanto avvenne in quelle ore tra <strong>il</strong> 9 e l’11 apr<strong>il</strong>e 1939. Tutto comincia per caso, con un<br />
pacco di telegrammi dimenticati in un faldone dal titolo “Varie” all’ufficio storico dello Stato maggiore dell’Esercito.<br />
Dentro, un manoscritto senza firma, con una mappa della zona di Debra Brehan, 100 km a Nord di Addis Abeba,<br />
nell’alto Scioa. Il contenuto, confermato da altri documenti, è agghiacciante.<br />
Una carovana di “salmerie” dei partigiani di Abebè Aregai, leader del movimento di liberazione, si è rifugiata in<br />
una grotta dopo essere stata individuata dall’aviazione italiana, e non accenna ad arrendersi pur essendo circondata<br />
da un numero soverchiante di uomini. La sproporzione è totale: le “salmerie” della resistenza etiope sono in<br />
prevalenza vecchi, donne e bambini, parenti degli uomini in armi, che garantiscono la cura dei feriti e <strong>il</strong> sostentamento<br />
dei partigiani alla macchia (ad Adua, mezzo secolo prima, dietro ai 100 m<strong>il</strong>a combattenti c’erano 80 m<strong>il</strong>a<br />
persone di supporto).<br />
L’ordine del Duce è perentorio: stroncare la ribellione che perdura sulle montagne a tre anni dall’ingresso di Badoglio<br />
ad Addis Abeba. Ma stavolta stanare i ribelli è impossib<strong>il</strong>e, così <strong>il</strong> 9 apr<strong>il</strong>e la grotta viene attaccata con<br />
bombe a gas d’arsina e con la micidiale iprite che devastò le trincee della Grande Guerra. L’Italia ha firmato <strong>il</strong><br />
bando internazionale di queste armi letali, ma ormai le usa in grande st<strong>il</strong>e su autorizzazione di Mussolini. Nella<br />
grotta <strong>il</strong> “bombardamento speciale” - gli eufemismi sulle bombe intelligenti si inaugurarono allora - è portato a<br />
termine dal “plotone chimico” della divisione Granatieri di Savoia, da sempre ritenuta una delle più “nob<strong>il</strong>i” delle<br />
nostre Forze Armate.<br />
La notte dopo, una quindicina di ribelli armati tenta una sortita e riesce a scappare. Molti cadaveri vengono gettati<br />
fuori dalla grotta. Gli altri muoiono avvelenati o si arrendono all’alba del giorno 11. Ottocento persone, si legge<br />
nel documento, che <strong>il</strong> mattino stesso vengono fuc<strong>il</strong>ate, “d’ordine del Governo Generale”. Come dire del generale<br />
Ugo Cavallero o dello stesso Amedeo di Savoia, pure lui di nob<strong>il</strong>e reputazione. Un massacro, contro ogni norma<br />
della convenzione di Ginevra. Ma non è finita. Dentro c’è chi resiste ancora - uomini, donne e animali - e i nostri<br />
chiedono i lanciafiamme per “bonificare” l’antro, ramificatissimo. I meticolosi telegrammi degli alti comandi sono<br />
istantanee dall’inferno. “Si prevede che fetore cadaveri et carogne impediscano portare at termine esplorazione<br />
caverna che in questo sarà ostruita facendo br<strong>il</strong>lare mine. Accertati finora 800 cadaveri, uccisi altri sei ribelli. Risparmiate<br />
altre 12 donne et 9 bambini. Rinvenuti 16 fuc<strong>il</strong>i, munizioni et varie armi bianche”. La prevalenza di inermi<br />
disarmati tra i ribelli è ormai chiara. In quegli stessi giorni, in un’altra grotta della zona, ne vengono uccisi<br />
62, di cui due donne. Ma vengono “risparmiate 62 donne et 58 bambini”, poi sono “catturati 33 muli, 3 cavalli et<br />
23 asini denutriti dal lungo digiuno”, e successivamente altri “27 uomini, 16 donne e 4 bambini”.<br />
Le prove, schiaccianti, entrano nella tesi di dottorato di Dominioni. Ma mancano ancora i riscontri sul terreno, così<br />
<strong>il</strong> ricercatore organizza un blitz col supporto dell’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in<br />
Italia. Va in Africa dove viene accompagnato dal giovane studioso etiope Johnatan Sahle. Siamo a fine apr<strong>il</strong>e, in<br />
tempo per evitare le grandi piogge equatoriali. La mappa trovata allo Stato maggiore consente di individuare fac<strong>il</strong>mente<br />
la zona, a un giorno di macchina dalla Capitale, in un terreno crivellato di grotte e punteggiato di chiese<br />
copte, attorno alla cittadina di Ankober, 2600 metri di quota, alta sulle valli dei fiumi Uancit e Beressà.<br />
E’ dai preti dei v<strong>il</strong>laggi che arrivano le prime conferme (“non ottocento, ma migliaia di morti”) e l’indicazione delle<br />
strada giusta, fino al paesino di Zemerò, e poi - per altri 30 ch<strong>il</strong>ometri fuori pista - fino al v<strong>il</strong>laggio di Zeret, una
ventina di tukul in pietra e paglia, 180 metri a picco sopra la bocca dell’inferno. Il nome della grotta dice già tutto:<br />
Amezegna Washa, antro dei ribelli. Sotto, <strong>il</strong> fiume Ambagenen, che vuol dire Fiume del Tiranno. All’imboccatura,<br />
lo stesso muretto protettivo descritto nei rapporti dell’esercito italiano. La gente del posto ha già elaborato magicamente<br />
l’evento, racconta che gli scheletri trovati davanti alla grotta sono “caduti dal cielo come monito” e poi<br />
sono stati spostati nella chiesa di Jigem, ora irraggiungib<strong>il</strong>e perché infestata di briganti.<br />
Dentro la caverna non c’è più andato nessuno, da allora. Si dice che sia piena di spiriti, pronti a spegnerti la candela<br />
con un soffio per inghiottirti nel buio. Ma Dominioni ha una dotazione di torce elettriche che nessun Grande<br />
Spirito può toccare, così molti giovani del v<strong>il</strong>laggio si fanno coraggio e decidono di accompagnarlo nella caverna,<br />
in una missione scientifica che per loro diventa esorcismo. Dentro, un labirinto, in parte impercorrib<strong>il</strong>e. Ma bastano<br />
i primi cento metri alla luce incerta delle torce per dare conferme. “Ossa dappertutto - racconta <strong>il</strong> ricercatore -<br />
quattro teschi, di cui uno con addosso la pelle della schiena; proiett<strong>il</strong>i, vestiti abbandonati, ceste per <strong>il</strong> trasporto<br />
delle granaglie”. E poi rocce annerite, forse dai bivacchi (ma era diffic<strong>il</strong>e che i ribelli accendessero fuochi <strong>il</strong> cui<br />
fumo li segnalasse all’aviazione italiana) o forse dai lanciafiamme. Gli italiani, raccontano i figli e i nipoti di chi vide,<br />
calarono verso l’imboccatura della grotta dei pesanti bidoni che poi furono fatti esplodere con i mortai. Era<br />
quasi certamente l’iprite, <strong>il</strong> gas che corrode la pelle e brucia le pup<strong>il</strong>le. E ancora: chi non fu fuc<strong>il</strong>ato, fu buttato nel<br />
burrone sotto la grotta. “Fu colpa degli ascari, le truppe indigene inquadrate nell’esercito italiano” è l’obiezione<br />
ricorrente di fronte ai massacri in Abissinia. “Ma gli ascari - ribatte Dominioni - non si muovevano mai senza<br />
l’ordine di un ufficiale bianco. La ferocia di queste repressioni era anche <strong>il</strong> segno dell’esasperazione dei fascisti di<br />
fronte alla resistenza degli etiopi. La rabbia per un controllo incompleto del territorio”.<br />
No, <strong>il</strong> camerata Kappler non fu peggio di noi. Il governatore della regione di Gondar, Alessandro Pirzio Biroli, di<br />
rinomata famiglia di esploratori, fece buttare i capitribù nelle acque del Lago Tana con un masso legato al collo.<br />
Ach<strong>il</strong>le Starace ammazzava i prigionieri di persona in un sadico tiro al bersaglio, e poiché non soffrivano abbastanza,<br />
prima li feriva con un colpo ai testicoli. Fu quella la nostra “missione civ<strong>il</strong>izzatrice”? L’Africa per noi non fu<br />
solo strade e ferrovie. Fu anche <strong>il</strong> collaudo del razzismo finito poi nei forni di Birkenau. Negli stessi anni, un altro<br />
personaggio con la fama di “buono” - Italo Balbo governatore della Libia - fece frustare in piazza gli ebrei che si<br />
rifiutavano di tenere aperta la bottega di sabato.<br />
Quanti perfidi depistaggi della coscienza. “Ambaradan”, per esempio. Da noi è una parola che fa ridere; vuol dire<br />
“allegra confusione”. Ma quando sai cosa accadde nella battaglia dell’Amba Aradam, montagna fatale<br />
dell’Etiopia, quel termine sembra coniato apposta per coprire l’orrore. Migliaia di tonnellate di iprite per stanare i<br />
nemici arroccati nelle grotte, cioè morte orrenda, inflitta vigliaccamente con sofferenze inaudite. Badoglio fece<br />
agli etiopi ciò che Saddam fece ai Curdi. Solo che Saddam è alla sbarra, e l’Italia non ha risposto dei suoi crimini.<br />
“C’è bisogno di parlarne - spiega Dominioni - <strong>il</strong> vuoto storico e morale da riempire è enorme. (…)”. La cosa, ovviamente,<br />
dà fastidio. Chissà che agli etiopi non venga in mente di chiederci danni di guerra, cosa che finora non<br />
hanno fatto. “Gli etiopi non hanno mai capito perché l’Italia ha voluto quella guerra dopo innumerevoli trattati di<br />
pace, fratellanza e promesse di coesistenza pacifica” va giù duro <strong>il</strong> professor Abebe Brehanu, uno dei massimi<br />
storici di Addis Abeba. “E che sia chiaro - insiste - la vostra non fu una colonizzazione, ma una semplice invasione,<br />
contro tutti i trattati internazionali. Un atto di <strong>il</strong>legalità totale di cui ci chiediamo ancora <strong>il</strong> senso”.<br />
Paolo Rumiz (“la Repubblica”, 22 Maggio 2006)<br />
Ha<strong>il</strong>e Gerima è <strong>il</strong> cineasta etiopico che incontriamo a Roma dove è venuto a cercare materiali e finanziamenti per<br />
un nuovo lungometraggio, “I figli di Adua: 40 anni dopo”, storia della resistenza etiopica negli anni Trenta e proseguimento<br />
ideale di un documentario realizzato nel ’99, “Adua”, in cui raccontava la vittoria dell’Etiopia del 1896.<br />
Come per molti f<strong>il</strong>m che parlano del nostro passato ( “Il leone del deserto” dedicato al guerrigliero libico Omar al-<br />
Mukhtar viene ospitato solo nei cine club), anche “Adua” è in Italia del tutto sconosciuto. Quando Gerima venne<br />
nel nostro paese a cercare finanziamenti, l’Istituto Luce (che invece questa volta ha cambiato atteggiamento) gli<br />
chiuse la porta in faccia. E gli fu diffic<strong>il</strong>e persino lavorare. Difficoltà meschine, come quelle che Gerima incontrò<br />
quando cercò di f<strong>il</strong>mare un grande affresco conservato in museo della capitale e che Menelik aveva ordinato a<br />
un pittore locale per glorificare l’epopea della battaglia (di Adua, ndr).<br />
“Nel mio primo f<strong>il</strong>m raccontavo la grande battaglia attraverso <strong>il</strong> vissuto degli etiopi, i canti popolari, l’iconografia e<br />
le testimonianze di diversi storici, tra cui mio padre”, che era un personaggio noto della resistenza. Scrittore e<br />
storico amava i libri. Ha<strong>il</strong>e ricorda che la sua infanzia “trascorse in una vecchia ambulanza trasformata da papà in
un chiosco”, sorta di libreria popolare parcheggiata a Gondar, la città dei Gerima. La figura del padre anima anche<br />
<strong>il</strong> soggetto di questo proseguimento ideale di Adua. Un progetto per <strong>il</strong> quale <strong>il</strong> regista sta cercando, anche in<br />
Italia, i finanziamenti per coprodurlo. In questo secondo f<strong>il</strong>m Ha<strong>il</strong>e affronta <strong>il</strong> tema della resistenza alla nuova Italia<br />
mussoliniana che torna in Africa per fare dell’impero di Ha<strong>il</strong>e Selassie una parte di quello italiano d’oltremare.<br />
“E’ una storia raccontata attraverso la memoria dei colleghi di mio padre nella resistenza, che sono ancora vivi.<br />
Tutti loro erano cresciuti con la consapevolezza che gli italiani sarebbero tornati per vendicarsi dell’onta di Adua.<br />
E’ dunque un omaggio al lavoro di ricostruzione e r<strong>il</strong>ettura storica a cui già mio padre, che alla fine aveva fatto<br />
vivere anche la mia adolescenza all’ombra della vicenda di Adua, mi aveva educato”.<br />
Il f<strong>il</strong>m di Gerima è dunque una storia riscritta dall’altra parte, in un’ottica africana che forse, gli chiediamo, potrebbe<br />
aiutare anche noi a rimuovere i macigni che pesano su una verità scomoda. “Non so se questo potrà servire<br />
agli italiani e non è questo <strong>il</strong> mio obiettivo. Cerco solo di raccontare ai giovani etiopi quale fu la loro storia, quella<br />
scritta dalla resistenza, in un continente dove si finisce sempre per parlare d’altro: povertà, aids, malattie, che<br />
sono ormai diventati una sorta di industria, tra l’altro sempre diretta dall’Occidente, che finisce per distrarre i giovani<br />
africani da vicende che li riguardano invece molto da vicino. Questa ricostruzione che manca è dunque importante<br />
proprio per affrontare <strong>il</strong> presente. E credo che questo sia <strong>il</strong> ruolo degli artisti: restituire un pezzo di memoria<br />
che è <strong>il</strong> fondamento della nostra storia. Molti giovani non sanno nemmeno che Adua significò la vittoria di<br />
un popolo africano su un esercito europeo moderno… Voglio dire che gli africani, attraverso una r<strong>il</strong>ettura dei fatti,<br />
potrebbero smettere di essere dei semplici spettatori di questa industria della povertà e diventare protagonisti<br />
della propria vita. Esserlo significa anche saper poi combattere la povertà con strumenti propri”. (…)<br />
Emanuele Giordana (“Il Sole 24 ore”, 17 Settembre 2006)<br />
GENOCIDIO IN CIRENAICA<br />
Un articolo di Matteo Dominioni che ricostruisce un episodio particolarmente sanguinoso della conquista italiana<br />
della Libia: <strong>il</strong> massacro, lucidamente perseguito dal regime fascista sotto la direzione di Graziani e Badoglio,<br />
delle popolazioni del Gebel, che rappresentavano una sacca di resistenza alla colonizzazione. Si trattò di<br />
un vero e proprio genocidio, attuato attraverso deportazioni di massa, rastrellamenti ed esecuzioni: non fu certo<br />
“l'unico genocidio della storia delle conquiste coloniali, se ciò può consolare qualcuno, ma è certo uno dei<br />
più radicali, rapidi e meglio travisati dalla propaganda e dalla censura” (1).<br />
La conquista della Libia negli anni si dimostrò ben più diffic<strong>il</strong>e di quanto si era propagandato. Anche durante gli<br />
avvenimenti bellici molte cose non si vennero a sapere, soprattutto in patria, per via di un distacco, cercato ed<br />
ottenuto nei fatti, tra <strong>il</strong> fronte e la patria. Tale distacco emerge prepotentemente nel momento in cui <strong>il</strong> conflitto<br />
si tramutò da nazionale, fatto da un esercito regolare di massa con grossi apparati per la creazione dell'opinione<br />
pubblica, in coloniale, fatto da volontari, coloni e mezzi m<strong>il</strong>itari più evoluti. Agli inizi del 1930 si stava ultimando,<br />
dopo un ventennio di guerra, la conquista della parte occidentale della Libia, la Tripolitania, mentre<br />
ad oriente, in Cirenaica, era in atto uno scontro tra fascisti e patrioti libici che durò più a lungo e fu più intenso<br />
negli scontri. In gennaio <strong>il</strong> generale Graziani, sulla scia della popolarità e degli agganci seguiti alla conquista<br />
della Tripolitania, viene nominato vicegovernatore della Cirenaica e insieme a Badoglio diventa uno dei personaggi<br />
chiave della fase finale, quella risolutiva. Per farci un'idea del loro operato è sufficiente ricordare, per ora,<br />
che <strong>il</strong> primo diede vita ai “tribunali volanti” con diritto di morte per reati quali possesso di arma da fuoco o<br />
pagamento di tributi ai ribelli; <strong>il</strong> secondo propose l'ut<strong>il</strong>izzo di strumenti terroristici, quali le bombe ad aggressivi<br />
chimici per stroncare la resistenza libica.<br />
Il fronte opposto era occupato dalla Senussia, organizzazione statuale dei seminomadi di religione musulmana.<br />
Nata agli inizi dell'ottocento, si basava su di numerose zauie, luoghi periferici del controllo politico, e allo<br />
stesso tempo religioso, che regolavano l'attività dei commerci, del pagamento delle decime e dell'attività am-
ministrativa e giudiziaria in una società di numerosi duar, accampamenti talvolta m<strong>il</strong>itarizzati, sparsi per l'altopiano<br />
del Gebel.<br />
I fascisti compresero che per rompere i legami organizzativi della resistenza dovevano eliminare la Senussia<br />
come fattore di mantenimento dell'ordine feudale. In un territorio come quello del Gebel però non era accettata<br />
l'invasione di stranieri che poteva mettere a repentaglio <strong>il</strong> delicato equ<strong>il</strong>ibrio ecologico, in relazione alla densità<br />
demografica, che si era instaurato. L'altopiano presentava maggiori possib<strong>il</strong>ità di coltivare e allevare bestiame<br />
soprattutto per la presenza di piogge senz'altro maggiori che nella parte occidentale del paese. Tale fert<strong>il</strong>ità<br />
tuttavia veniva messa in discussione dall'arrivo di nuove genti che non avevano minimamente intenzione di<br />
mantenere <strong>il</strong> naturale ordine delle cose della natura ma di colonizzare e portare un altro mondo fondato sul<br />
dominio e non sul rispetto della natura.<br />
L'invasione fu vista come annientamento delle proprie risorse e di conseguenza della propria esistenza. Resistere<br />
significava tentare di sopravvivere, farsi soggiogare era, agli occhi dei libici, come andare incontro a un<br />
suicidio perchè avrebbe rotto <strong>il</strong> naturale rapporto di equ<strong>il</strong>ibrio con la natura e con esso la vita stessa. Chiarendo<br />
tale atteggiamento della maggioranza della popolazione locale, che non deve essere colto solamente nell'omogeneità<br />
delle posizioni data la numerosa eterogeneità delle culture di origine tribale, è possib<strong>il</strong>e comprendere<br />
<strong>il</strong> forte attaccamento per l'indipendenza che portò tutta la popolazione a collaborare coi ribelli ed a<br />
pagare di persona.<br />
Di fronte ai colonizzatori si presentava un problema di non poco conto: la zona più ricca della Libia, la Cirenaica,<br />
era quella che presentava una ribellione diffusa e diffic<strong>il</strong>e da sconfiggere perchè mimetizzata nel territorio e<br />
soprattutto perchè godeva dell'appoggio della popolazione. Non dev'essere trascurato <strong>il</strong> ruolo della dirigenza<br />
della resistenza che, grazie soprattutto all'opera di Omar al-Mukhtar, fu in grado di impiegare un efficiente sistema<br />
informativo e un veloce reclutamento delle forze.<br />
I fascisti decisero un'azione radicale sulla collocazione geografica delle etnie per mezzo di movimenti coatti di<br />
popolazione. A partire dal 25 giugno 1930 si decise per la creazione di campi di concentramento che dovevano<br />
contenere le popolazioni del Gebel che avevano dato maggiore appoggio alla resistenza. Furono immuni<br />
alla detenzione le popolazioni già sottomesse e quelle stanziate al di fuori del Gebel. Lo scopo era quello di<br />
rompere ogni legame tra ribelli e popolazione ma anche di rompere ogni possib<strong>il</strong>ità di autosussistenza delle<br />
comunità.<br />
Lo stesso Badoglio, cosciente di cosa stava andando a fare, dice: “Non mi nascondo la portata e la gravità di<br />
questo provvedimento che vorrà dire la rovina della popolazione cosiddetta sottomessa. Ma ormai la via ci è<br />
stata tracciata e noi dobbiamo perseguirla fino alla fine anche se dovesse perire tutta la popolazione della Pirenaica”.<br />
Quanti furono i deportati dal Gebel ai campi limitrofi alla costa? Giorgio Rochat giunge ad una stima, per approssimazione,<br />
di 100/120.000 persone, praticamente tutta la popolazione del Gebel. Tuttavia, anche operando<br />
in modo così radicale, non si raggiunsero gli obiettivi prefissati cosicchè a fine agosto fu deciso di muovere<br />
nuovamente i campi in zone costiere perchè i legami tra Senussia e popolazione non erano venuti meno. Furono<br />
inasprite le sanzioni verso i detenuti e irrigidite le norme riguardanti la detenzione. All'interno dei campi<br />
vigevano condizioni precarie per la mancanza di cibo e di risorse; ci furono epidemie di tifo a cui diffic<strong>il</strong>mente si<br />
riuscì a porre rimedio per l'assoluta mancanza medici - due per 60.000 detenuti - e di strumenti bas<strong>il</strong>ari, anche<br />
semplici pentole, per ster<strong>il</strong>izzare vesti e vettovagliamenti. Il disinteresse dei fascisti si tramutò in una f<strong>il</strong>antropia<br />
che si concretava nel trasmettere, forzatamente, ai locali una sorta di etica del lavoro. Venivano negati i mezzi<br />
di produzione (terra e bestiame) ma allo stesso tempo si ricercava di inserire (sussumere) i locali in lavori di<br />
natura propriamente capitalistica.<br />
La popolazione del Gebel, una volta rinchiusa, divenne versat<strong>il</strong>e serbatoio di forza lavoro a basso prezzo da<br />
inserire nelle innumerevoli opere pubbliche (soprattutto strade) che andavano di pari passo con l'occupazione.<br />
Ai lavoratori veniva dato un salario tre volte inferiore a quello degli italiani che li metteva su di un piano di subordinazione<br />
ed allo stesso tempo li privava gradatamente degli strumenti e delle conoscenze nei lavori tradizionalmente<br />
sv<strong>il</strong>uppati. Alle donne venivano dati telai e materie prime da impiegare nella fattura di tappeti e<br />
tessuti. Lo scopo era inserire gradatamente la popolazione entro un rapporto sociale legato al salario e alla<br />
produzione per l'accumulazione e non per l'autoconsumo. Tuttavia tali iniziative erano destinate a fallire, perchè<br />
i fascisti volevano ricreare in maniera coatta comunità artificiali di autosussistenza, senza rendersi conto
che la precedente distruzione dell'autosussistenza formatasi attraverso pratiche graduali socialmente e culturalmente<br />
accettate impediva poi di ricreare mondi artificiali funzionanti in tale realtà perchè ad essa estranei.<br />
Fu imposto un vero e proprio modo di produzione altro. Se le popolazioni erano in precedenza occupate nell'allevamento<br />
del bestiame e nell'agricoltura, ora venivano impiegate nella costruzione di opere ed<strong>il</strong>i o nella<br />
pesca. L'imperialismo italiano fu innanzi tutto esportazione di un modo di produzione che andò a destrutturare<br />
i rapporti sociali precedenti.<br />
Un altro modo per spezzare i legami tradizionali della società libica fu l'eliminazione del 90-95% del bestiame<br />
tra gli anni 1930-1931. In una società dedita alla pastorizia, oltre che all'agricoltura e al commercio, venivano<br />
messi in discussione i requisiti minimi di approvvigionamento delle popolazioni del Gebel. Un ultimo provvedimento<br />
fu infine ut<strong>il</strong>izzato per fare terra bruciata attorno ai ribelli di Omar al-Mukhtar: la proibizione del commercio<br />
con l'Egitto, dove circa 20.000 libici che si erano rifugiati erano certamente interessati a dare man forte ai<br />
patrioti. Più tardi, allo scopo di porre fine al contrabbando che avveniva per mezzo di piccole spedizioni su<br />
cammelli, i fascisti decisero di costruire un reticolato lungo 270 km lungo la direttrice Bardia-Giarabub. Dall'apr<strong>il</strong>e<br />
a settembre 1931 fu costruito tale recinto largo qualche metro e impenetrab<strong>il</strong>e perchè controllato per<br />
mezzo di fortini e voli aerei.<br />
Una volta depredato <strong>il</strong> Gebel, per <strong>il</strong> lungo e per <strong>il</strong> largo, agli italiani non restava altro che porre fine alla resistenza<br />
in un ambiente finalmente immune, dove i rastrellamenti risultarono efficaci a tale scopo. I ribelli non<br />
avevano più la possib<strong>il</strong>ità di muoversi in maniera discreta ed era venuta meno la precedente copertura delle<br />
popolazioni. Gli esploratori al servizio degli italiani tallonavano i ribelli passando informazioni tempestive ai<br />
comandi per un pronto intervento. L'accerchiamento dei ribelli veniva fatto in maniera tale da presidiare eventuali<br />
vie di fuga. In caso di fuga intervenivano l'aeronautica e la cavalleria per inseguire in maniera più stringente<br />
<strong>il</strong> nemico. L'arresto di Omar al-Mukhtar avvenne nel settembre del 1931 e l'esecuzione della condanna a<br />
morte, già decisa in sede extragiudiziaria, si tenne, secondo macabro rito colonial-fascista, sulla pubblica piazza.<br />
Il 9 dicembre si riunirono i rimanenti oppositori all'occupazione e decisero per la resa. L'uccisione di Omar<br />
al-Mukhtar apparve come l'episodio definitivo di una serie che aveva portato a un veloce indebolimento della<br />
Senussia. Una volta intaccate, come si è visto, le bas<strong>il</strong>ari strutture della produzione, dei commerci e dell'amministrazione,<br />
la vittoria era totale. Furono distrutti non solo i caratteri propriamente endogeni della società senussita,<br />
ma anche quelli esogeni come <strong>il</strong> rapporto tra densità demografica-popolazione. E totale fu anche <strong>il</strong><br />
dominio, che fu subito da tutta la popolazione nonostante i ribelli in armi fossero tra i 600 e gli 800, con variazioni<br />
a seconda del dor che veniva coinvolto negli scontri.<br />
Risulta enorme la sproporzione nel perseguire i ribelli e i loro fiancheggiatori: i secondi pagarono molto di più,<br />
primo perchè erano marginalmente coinvolti nelle battaglie, secondo perchè perirono in maggior numero. Si<br />
tenga conto del fatto che l'amnistia per i ribelli entrò in vigore prima della chiusura dei campi che andarono in<br />
contro a tale sorte proprio a causa della contraddizione per cui non si potevano perseguire le popolazioni anziché<br />
i diretti responsab<strong>il</strong>i dei fatti.<br />
Secondo fonti italiane i morti tra i ribelli per <strong>il</strong> periodo 1923-1931 sarebbero stati 6.500 ma c'è un vizio di forma<br />
in tali dati, che sono presi da materiale di parte. Altri sono i numeri macabri che emergono tenendo conto dell'esistenza<br />
dei campi, delle malattie, dei trasferimenti e dell'impoverimento arrecato alle popolazioni. Prendendo<br />
in considerazione valutazioni e censimenti della popolazione, effettuati prima e dopo la guerra dalle autorità<br />
coloniali, si ha la conferma di una impressionante diminuzione demografica nella Cirenaica. Da dati del 1928<br />
gli abitanti sarebbero stati 225.000, mentre dal censimento del 1931 risulterebbero essere 142.000 compresi<br />
gli italiani e i nuovi immigrati. Tenendo conto di quanti fuggirono dal Gebel verso l'Egitto (10-15.000 persone) e<br />
del tasso di incremento demografico, <strong>il</strong> genocidio fascista dovuto alla repressione sarebbe di circa 45-50.000<br />
persone che crescono fino a 70.000 se ai dati italiani si sostituiscono quelli dell'antropologo Evans-Pritchard.<br />
“Questo non è l'unico genocidio della storia delle conquiste coloniali, se ciò può consolare qualcuno, ma è certo<br />
uno dei più radicali, rapidi e meglio travisati dalla propaganda e dalla censura” (1) .<br />
Una volta che la ribellione fu vinta le popolazioni non poterono tornare nei luoghi d'origine sul Gebel che erano<br />
destinati, essendo le zone più fert<strong>il</strong>i, agli italiani. I libici subirono così la radicale modifica dei principali aspetti<br />
della vita materiale e non solo: in quanto seminomadi furono rinchiusi in riserve, dove essere sfruttati come<br />
manodopera semplice.<br />
(1) Giorgio Rochat e Giulio Massobrio, “Breve storia dell'esercito italiano dal 1861 al 1943”, Torino, 1978
SULLA “FOIBA” DI BASOVIZZA<br />
Sulle vicende legate all’occupazione fascista dei Balcani, pubblichiamo questo pezzo di Claudia Cernigoi sulla<br />
“foiba” di Basovizza diventata “Monumento Nazionale” alla pari della Risiera di San Sabba. Claudia Cernigoi,<br />
giornalista, ha scritto “Operazione Foibe, Tra storia e mito”, (Kappa Vu Edizioni, 2005) di cui, sul sito internet di<br />
Wu Ming, si dice "Un libro fon-da-men-ta-le, che deve circolare, che va diffuso con ogni mezzo necessario e letto<br />
dal maggior numero di persone possib<strong>il</strong>e. La lettura spalanca <strong>il</strong> mondo davanti agli occhi. Questo saggio è uno<br />
strumento di lotta, è un'ascia di guerra dissepolta ...".<br />
La voragine nota come “foiba” di Basovizza è in realtà <strong>il</strong> pozzo di ispezione per la ricerca di un giacimento di carbone,<br />
commissionato dalla società Škoda tra <strong>il</strong> 1901 ed <strong>il</strong> 1908; gli scavi furono infruttuosi e <strong>il</strong> pozzo fu abbandonato.<br />
Il nome tradizionale del pozzo è Šoht, la profondità è di 256 metri e la sua imboccatura dovrebbe misurare<br />
circa quattro metri per due.<br />
Tra le due guerre mondiali due persone si suicidarono gettandosi nel pozzo e i loro corpi furono immediatamente<br />
recuperati. Vi sono inoltre testimonianze che parlano di prigionieri civ<strong>il</strong>i gettati nel pozzo nell’estate del 1944, ad<br />
opera della Guardia civica di Trieste, un corpo collaborazionista dei nazisti.<br />
Alla fine della seconda guerra mondiale, dopo la battaglia di Basovizza (30 apr<strong>il</strong>e 1945) la gente del posto gettò<br />
nel pozzo corpi di m<strong>il</strong>itari, soprattutto tedeschi, carcasse di cavalli (morti durante i raid effettuati dagli aerei britannici<br />
nel corso della battaglia) ed anche materiale m<strong>il</strong>itare.<br />
Di infoibamenti presumib<strong>il</strong>mente avvenuti a Basovizza dal 2 al 5 maggio 1945 iniziò a parlare <strong>il</strong> CLN triestino (che<br />
aveva una funzione antijugoslava) in una denuncia inviata alle autorità angloamericane e datata 14 giugno 1945<br />
(1) , nella quale leggiamo: “Nelle giornate del 2-3-4 e 5 maggio numerose centinaia di cittadini vennero trasportati<br />
al cosiddetto Pozzo della Miniera, in località prossima a Basovizza e fatti precipitare nell’abisso profondo circa<br />
240 m”. A questa denuncia seguirono, in luglio, alcune notizie stampa, che parlavano di 400 morti, ma furono<br />
presto smentite, come leggiamo su “Risorgimento Liberale” (organo nazionale del partito Liberale) del 29/7/45:<br />
“Smentita alleata sul pozzo di cadaveri a Trieste”. Infatti “Il Comando generale dell’Ottava Armata britannica ha<br />
ufficialmente smentito oggi le notizie pubblicate dalla stampa italiana secondo cui 400 o 600 cadaveri (si pubblica<br />
la smentita, ma si fanno lievitare i morti, n.d.a.) sarebbero stati rinvenuti in una profonda miniera della zona di<br />
Trieste. Alcuni ufficiali dell’Ottava Armata hanno precisato inoltre che non si hanno indicazioni circa i cadaveri<br />
degli italiani ma per quanto riguarda l’asserita presenza di cadaveri di soldati neozelandesi essa viene senz’altro<br />
negata”.<br />
Successivamente a queste notizie, gli angloamericani decisero di effettuare delle ricognizioni a Basovizza ed <strong>il</strong><br />
“Piccolo” di Trieste pubblicò i risultati di esse in alcuni articoli del gennaio 1995. “È del 13 ottobre 1945 <strong>il</strong> rapporto<br />
che elenca sommariamente i risultati delle esumazioni, effettuate ut<strong>il</strong>izzando la benna (...); questo documento (...)<br />
permette di avere la conferma che almeno una decina di corpi umani furono recuperati dagli angloamericani”.<br />
Viene poi citato un rapporto angloamericano: “le scoperte effettuate si riferiscono a parti di cavallo e cadaveri di<br />
tedeschi, e si può dedurre che ulteriori sopralluoghi potrebbero eventualmente r<strong>il</strong>evare cadaveri di italiani” (“Il<br />
Piccolo”, 31/1/45). Nello stesso articolo vengono riportati brani del “rapporto segreto” sopra citato nel quale appare<br />
la reale entità dei recuperi effettuati: otto corpi umani interi, due di questi presumib<strong>il</strong>mente di tedeschi ed uno<br />
forse di sesso femmin<strong>il</strong>e, alcuni resti umani e carcasse di cavalli. Prosegue l’articolo “Ma una decina di corpi<br />
smembrati e irriconoscib<strong>il</strong>i non dovevano sembrare un risultato soddisfacente e alla fine si preferì sospendere i<br />
lavori”. In un documento del 21/10/45, <strong>il</strong> Comando generale delle forze armate statunitensi del Mediterraneo, con<br />
sede a Caserta, scrisse che “<strong>il</strong> materiale finora ottenuto indica che corpi umani (alcuni identificab<strong>il</strong>i come tedeschi)<br />
e carcasse di cavalli sono stati gettati nel pozzo. A parte ciò i risultati sono inconcludenti”. Ed ancora, <strong>il</strong><br />
16/2/46, <strong>il</strong> Comando inviò a Trieste un telegramma nel quale si autorizzava la “cessazione delle investigazioni”.<br />
Ma “per minimizzare qualsiasi effetto sull’opinione pubblica italiana e qualsiasi possib<strong>il</strong>ità che gli Jugoslavi interpretino<br />
la cessazione come un’ammissione che le accuse contro di loro erano infondate, siete autorizzati a r<strong>il</strong>a-
sciare una dichiarazione pubblica che la cessazione delle investigazioni è dovuta a difficoltà fisiche sopravvenute,<br />
e che ciò non implicava che le asserzioni fatte dal CLNAI (sic: ma <strong>il</strong> CLN triestino non aveva aderito al CLNAI,<br />
n.d.a.) siano dimostrate essere senza fondamento”.<br />
Dopo la sospensione dei recuperi, <strong>il</strong> pozzo fu usato come discarica, e fu svuotato quasi completamente nel 1954,<br />
poco prima che gli angloamericani lasciassero Trieste; questi movimenti risultano da diversi documenti, alcuni<br />
conservati presso l’Archivio del Comune di Trieste. Uno di questi è datato 28/4/55 ed è firmato dall’allora questore<br />
di Trieste Marzano.<br />
“Oggetto: pozzo artificiale a Basovizza. Per le ulteriori azioni di competenza, si segnala quanto segue. Nei pressi<br />
di Basovizza, e precisamente a 500 metri circa dall’abitato (…) esiste un pozzo artificiale profondo m. 180 e comunemente<br />
noto come <strong>il</strong> pozzo della miniera o foiba di Basovizza. In occasione di alcuni lavori di recupero eseguiti<br />
tempo addietro da un’impresa privata, l’apertura della cavità, di circa 9 mq. di larghezza, venne recintata,<br />
ma, al termine dei lavori stessi, <strong>il</strong> recinto venne tolto. La zona è completamente sprovvista di segnalazioni ed è in<br />
più ricoperta da una fitta vegetazione, per cui è evidente <strong>il</strong> pericolo che la foiba presenta nelle attuali condizioni;<br />
va anche aggiunto che, data la bella stagione, la località, specie nelle giornate festive, è meta di frequenti gite”.<br />
Questo rapporto è interessante perché conferma gli avvenuti recuperi dalla “foiba”, ma non fa parola di eventuali<br />
ritrovamenti di resti umani.<br />
Dopo <strong>il</strong> 1954 <strong>il</strong> sindaco di Trieste Gianni Bartoli (che aveva costruito la propria immagine pubblica sulla base della<br />
nostalgia per le terre perdute dell’Istria e del ricordo dei martiri delle foibe (comprese le “centinaia di infoibati di<br />
Basovizza”!), autorizzò l’uso del pozzo come discarica di rifiuti e soprattutto di scarti di prodotti della raffineria, e<br />
tale fu l’uso che se ne fece fino al 1959 quando venne coperto dalla lastra di pietra che vediamo a tutt’oggi. Come<br />
<strong>il</strong> cattolico praticante Gianni Bartoli potesse autorizzare la discarica di immondizie sopra resti di corpi umani,<br />
è cosa diffic<strong>il</strong>e da comprendere: si potrebbe ipotizzare che Bartoli, anche alla luce del fatto che un dirigente comunale<br />
era stato presente allo scavo del 1954, avesse saputo che lì sotto non c’erano i resti di coloro che lui, nei<br />
suoi libri, aveva lasciato credere che ci fossero. Forse però non è un caso che <strong>il</strong> “Martirologio delle genti adriatiche”<br />
di Bartoli sia stato pubblicato dopo la copertura del pozzo della miniera; e del resto, dalle note biografiche<br />
dei morti riportate in questo libro come “infoibato nella miniera Salit (evidente errore di trascrizione del corsivo di<br />
Šoht, n.d.a.) di Basovizza” appare un unico nominativo: Mario Fabian, ex tranviere triestino che si arruolò volontario<br />
nell’Ispettorato Speciale di Pubblica Sicurezza diretto dal commissario Collotti ed operò rastrellamenti antipartigiani.<br />
Da atti giudiziari Fabian è l’unica persona che risulta “infoibata” nello Šoht: infatti alcuni ex partigiani<br />
furono arrestati per avere arrestato Fabian ed averlo gettato nel pozzo della miniera; furono processati e condannati<br />
nel 1949. Questo processo fu poi annullato dalla Cassazione, e nel corso del secondo processo la difesa<br />
produsse la copia di una circolare del Distretto M<strong>il</strong>itare per l’Istria datata 27 apr<strong>il</strong>e 1945 dove si leggono i nomi di<br />
Collotti e di sei dei suoi accoliti (tra i quali anche quello di Mario Fabian) e l’esplicito ordine di arrestarli e fuc<strong>il</strong>arli.<br />
Quindi gli imputati furono assolti, in quanto “non punib<strong>il</strong>i avendo eseguito un ordine <strong>il</strong>legittimo quando la legge<br />
non consentiva loro alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine stesso”. “L’Unità” del 28/6/50 fece <strong>il</strong> resoconto del<br />
processo e citò la testimonianza di Daniele Pettirosso che “ha raccontato come l’8 gennaio del 1945 in seguito<br />
ad un rastrellamento effettuato dai nazisti e da agenti della Collotti a S. Antonio Moccò, egli venne arrestato e<br />
condotto all’Ispettorato di via Cologna. Quivi fu interrogato saltuariamente per ben diciassette giorni e fra i suoi<br />
aguzzini <strong>il</strong> Fabian fu quello la cui fisionomia gli restò impressa. Infatti fu proprio <strong>il</strong> Fabian che lo legò alla famosa<br />
sedia elettrica durante l’interrogatorio all’osteria di Moccò”.<br />
Quando si vanno a rendere onori agli “infoibati” a Basovizza, bisognerebbe forse rendersi conto di chi è la persona<br />
che si va ad “onorare”.<br />
In sintesi, stando a risultanze storiche, non esiste alcune prova di massacri di civ<strong>il</strong>i o m<strong>il</strong>itari avvenuti presso <strong>il</strong><br />
pozzo della miniera di Basovizza: l’unica persona che risulterebbe lì uccisa sarebbe appunto Mario Fabian, ucciso<br />
sommariamente da elementi partigiani. Ciononostante, <strong>il</strong> luogo è stato dichiarato monumento nazionale e tutti<br />
coloro che ne scrivono parlano di eccidi, massacri, luogo di ricordo e via di seguito, al punto che nella prevista<br />
“riconc<strong>il</strong>iazione” auspicata dai governanti italiani, <strong>il</strong> sito è fra quelli che dovrebbero vedere le visite congiunte dei<br />
presidenti di Italia, Slovenia e Croazia, accomunato al campo di internamento fascista di Gonars dove trovarono<br />
la morte donne, vecchi e bambini, ed alla Risiera di San Sabba, campo nazista di smistamento per ebrei e di<br />
sterminio per partigiani.<br />
Ma noi vorremmo osservare che una “riconc<strong>il</strong>iazione” che si basa su un falso storico non è un buon punto di partenza<br />
per la convivenza tra i popoli, e che reiterare notizie di massacri mai avvenuti, allo scopo di creare un con-
traltare “jugoslavo” o “comunista” ai crimini commessi dal nazifascismo, non è comportamento che possa aiutare<br />
né a fare chiarezza storica né a distendere i rapporti tra i popoli di queste terre.<br />
(1) Tra <strong>il</strong> 1 maggio ed <strong>il</strong> 12 giugno 1945 Trieste rimase sotto amministrazione jugoslava (periodo cosiddetto dei “quaranta<br />
giorni”); <strong>il</strong> 12 giugno le truppe si ritirarono lasciando l’amministrazione della città agli angloamericani.<br />
Isola di Rab (Arbe), Croazia. Qui, nel luglio del 1942, l’Italia fascista istituì un campo di concentramento<br />
dove, sino al settembre 1943, persero la vita non meno di 1400 deportati, in maggioranza<br />
sloveni.<br />
Nel cimitero in cui sono raccolti i resti dei morti in quel campo c’è una lapide apposta dalla “Fondazione<br />
Ferramonti”.<br />
Nessuna lapide o altro segno da parte dello Stato Italiano ricorda quanto successo.<br />
A questo si preferisce invece un “Monumento Nazionale” per Basovizza.<br />
LA MEMORIA DI NONNA MILKA<br />
Di Giovanna Boursier. Come gli italiani hanno partecipato, Duce comandando, all'eliminazione dei Rom e dei<br />
Sinti. Da “<strong>il</strong> manifesto” del 13 apr<strong>il</strong>e 2005<br />
M<strong>il</strong>ka ha 83 anni, l'espressione fiera e cammina incerta. Fa fatica quando sale sul pulmino, ma la maschera con una<br />
domanda: “dove stiamo andando?”. E' quello che si chiedono molti qui, all'alba, nel campo nomadi di Foro Boario,<br />
quartiere Testaccio di Roma, dove i rom si stanno svegliando. Mentre qualcuno prepara <strong>il</strong> caffè altri guardano stupiti<br />
<strong>il</strong> furgone sul quale c'è scritto “Osservatorio Nomade di Roma”, anche se quasi tutti sanno che si tratta di uno strano<br />
gruppo di artisti e amici che da qualche anno frequenta questo luogo mettendo in relazione storie e persone diverse<br />
che oggi partono insieme. Quelli dell'Osservatorio usano la loro arte per creare spazi di comunicazione e lo fanno<br />
soprattutto nei luoghi di confine, sul mare, lungo i fiumi, nei campi sosta, perché, spiegano, “in un mondo occupato<br />
quasi esclusivamente dalla solitudine mediatica è soprattutto lì che le persone si spostano con le loro vite e culture<br />
da raccontare e mettere a confronto”. Cosa che ormai avviene sempre più nella marginalità in cui si muovono masse<br />
di immigrati e nomadi.<br />
Anche per questo M<strong>il</strong>ka sale sul pulmino dell'Osservatorio che, intanto, si riempie: ci sono Aldo, un altro rom, Osama,<br />
un operatore cinematografico egiziano, Matteo, S<strong>il</strong>via e Lorenzo. E qualcuno risponde subito a M<strong>il</strong>ka: “Stiamo<br />
andando ad Agnone”. Lei sorride, guarda fuori dal finestrino e, con l'aria di chi la sa lunga, dice: “Ma sì, lo sapevo.<br />
Ci andiamo per raccontare. Perché io ci sono stata ad Agnone, tanto tempo fa. Ma allora datemi un po' di soldi”.<br />
Tutti ridono e finalmente si parte.<br />
Sconosciuto a torto, Agnone è un paesino arroccato sulle montagne del Molise, a nord fra Isernia e Campobasso,<br />
non molto conosciuto. Dovrebbe invece esserlo soprattutto per la storia che si trascina dietro da più di mezzo secolo:<br />
perché ad Agnone, durante <strong>il</strong> fascismo, c'era uno dei tanti campi di internamento italiani. Un campo in cui, almeno<br />
da un certo punto in poi, erano imprigionati soltanto “zingari”.<br />
Mentre la storia ufficiale è ancora lenta e ritarda a raccontarlo, lo fa M<strong>il</strong>ka scendendo dal furgone, con i suoi 83 anni<br />
e la sua fatica, davanti all'ex convento di San Bernardino. Fa freddo, è stanca perché nel frattempo ha già parlato<br />
per due ore a un centinaio di studenti attentissimi, ma si incammina, decisa a ritrovare la memoria di quei luoghi e di<br />
quei tempi. E si arrabbia subito perché <strong>il</strong> cancello non è più lo stesso: “Non si entrava di qua, forse da là dietro”, dice
al sindaco e al professor Francesco Paolo Tanzi, che con le sue ricerche e i suoi studenti ha ricostruito tutta la storia<br />
di Agnone in un libro. L'edificio, una specie di cascinale fuori dal paese, a più di 800 metri d'altezza, adesso è un<br />
ricovero per anziane povere, prima e dopo la guerra era dei frati (ma <strong>il</strong> vescovo non ebbe dubbi a cederlo ai fascisti),<br />
dal 1940 al 1943 campo di concentramento. E, sicuramente a partire dalla seconda metà del 1941, c'erano rinchiusi<br />
solo rom e sinti di varie nazionalità: donne, uomini e bambini.<br />
Dai documenti finora ritrovati si capisce che nel luglio del 1942 erano almeno 250 e che nel gennaio successivo era<br />
stata anche allestita una scuola per i bambini rom o, come si legge, per la loro “educazione intellettuale e religiosa”<br />
che doveva “toglierli dalle loro abitudini randagie e amorali”. “Io la scuola non me la ricordo”, dice M<strong>il</strong>ka un po' seccata,<br />
“però avevo già 18 anni quando sono entrata qua dentro. Ero con mio marito e i miei figli. E poi c'era tutta la<br />
famiglia, la mamma, mio padre, che è morto dalla fatica due mesi dopo che siamo usciti, <strong>il</strong> nonno e gli altri, zii e cugini<br />
miei e di mio padre. Due sono morti, li hanno portati all'ospedale di Isernia. Anche <strong>il</strong> nonno è morto e <strong>il</strong> corpo<br />
non lo abbiamo più visto. Insomma c'erano tutti i parenti stretti e poi altri rom. Eravamo più di 100. Noi Goman stavamo<br />
al piano di sotto e i Bogdandi sopra. E quando siamo arrivati molti erano già qui, dal Veneto. C'erano le guardie<br />
intorno e non potevamo mai uscire. La mattina facevano l'appello, come succedeva in Germania. Ma i nostri erano<br />
italiani. Però non chiedetemi che anno era, io gli anni non me li ricordo. Ci sarà ben scritto. So che qui sono<br />
diventata maggiorenne, ho compiuto 21 anni in questo posto, perché allora mi hanno dato <strong>il</strong> sussidio. Prima non me<br />
lo davano, mi davano qualcosa per <strong>il</strong> bambino che avevo al seno, ma morivamo di fame. Mio marito andava in cucina<br />
a rubare le bucce delle patate mentre quelli che avevano <strong>il</strong> sussidio qualche volta uscivano a comprare qualcosa.<br />
Con due carabinieri, uno per parte. Compravano anche dai contadini che venivano con le ceste di frutta. Ma<br />
noi non avevamo soldi. La mattina ci davano <strong>il</strong> caffè che era acqua e poi sempre la minestra con le patate e la bieta.<br />
E con i vermi. Tutti i giorni c'erano i vermi, verdi e grossi che mi viene ancora da vomitare. Ma dovevamo mangiare<br />
per non morire. Ci davano 100 grammi di pane e la gente cascava per terra. Li ho visti entrare come leoni e<br />
diventare scheletri. Un signore si metteva contro <strong>il</strong> muro per non cadere. Era un omone, è diventato come un pezzo<br />
di legno. Così ci avevano ridotto. Per fortuna non ci hanno fuc<strong>il</strong>ato anche se tanti sono morti”.<br />
M<strong>il</strong>ka sa che i rom non erano solo ad Agnone. C'erano altri campi di internamento in Italia e c'erano altri prigionieri<br />
“zingari”: di sicuro, per quanto se ne sa fino a oggi, erano rinchiusi a Ferramonti in Calabria, in Sardegna, alle isole<br />
Tremiti, a Tossicia in Abruzzo, a Boiano e Vinchiaturo, altri due campi del Molise. In base a un ordine fascista del<br />
settembre 1940 i rom venivano rastrellati nei loro accampamenti, portati in carcere e nei vari campi: “A noi ci hanno<br />
preso in un prato vicino a Pisa - continua M<strong>il</strong>ka - mi sembra fosse estate ma non chiedetemi quando perché se non<br />
ricordo bene, io non dico niente. Stavamo in quel prato, molti lavoravano <strong>il</strong> rame, anche mio marito. Eravamo giovani<br />
con i nostri figli, ma sono arrivati i carabinieri, e ci hanno detto di lasciare tutto perché ci portavano in un posto<br />
migliore. Ma ci hanno portato con <strong>il</strong> treno fin qua giù, hanno aperto <strong>il</strong> portone e ci hanno buttato dentro. C'erano i<br />
letti di ferro, materassi vecchi e due coperte a testa. E i pidocchi dappertutto che per me erano la cosa peggiore: li<br />
vedevi anche sul pavimento, grossi, e ci toglievamo i pezzi di carne per grattarci. A me è venuta una malattia che<br />
avevo tutti i buchi sulla faccia. D'inverno faceva molto freddo, non c'era <strong>il</strong> riscaldamento e l'umidità era terrib<strong>il</strong>e. Ti<br />
marcivano le ossa. Ancora adesso cammino male e questo me lo sono guadagnato qua dentro”.<br />
M<strong>il</strong>ka comincia a girare dentro l'edificio, cerca di ricordare e ritrovare la sua stanza. Cammina traballante e con le<br />
mani sempre davanti. Non riesce ad entrare, si aggrappa al braccio di chi le è vicino, guarda restando sulle porte e<br />
dice che ormai tutto è diverso. “Le stanze - ripete - le stanze, le stanze”. Va verso un balcone ed esce: “Qui si veniva<br />
e guardavamo fuori. Stavo qui e guardavo”, sospira. Poi va verso <strong>il</strong> cort<strong>il</strong>e: “Ecco la fontana, questa è rimasta<br />
uguale. Sono arrivata a vederla. Mi tremano le gambe come una foglia”. La fontana è di ferro battuto, al centro del<br />
cort<strong>il</strong>e. M<strong>il</strong>ka si siede per riposare un po'. E piange: “Per mio marito - dice - lui soffriva più di me e dopo la guerra<br />
non è mai stato bene. Il signore se l'è preso 25 anni fa. Ma sai come piangevamo quando siamo usciti di qua? Io ci<br />
sono stata 3 anni ma eravamo tanti, non solo italiani, anche tedeschi, jugoslavi e spagnoli, che la sera qualche volta<br />
suonavano. E' l'unico ricordo bello. Il resto è tutto buio. Un giorno sono arrivati i tedeschi, hanno spalancato <strong>il</strong> portone.<br />
Per fortuna c'erano i Campos, madre e figlio, che parlavano tedesco. Gli hanno raccontato come stavamo male<br />
e loro ci hanno aperto e ci hanno lasciati uscire. Lo so che i tedeschi hanno fatto male al mondo, l'ho visto alla televisione,<br />
eppure a noi ci hanno lasciato andare, senza mitragliarci. Siamo fuggiti subito, come fanno i conigli quando<br />
scappano dalle gabbie. Davvero - sorride - è la santa verità davanti a Dio. Poi abbiamo ricominciato a girare e battere<br />
<strong>il</strong> rame, abbiamo comprato un carrettino, anche un cavallino e siamo arrivati a Roma. Adesso voglio essere pagata<br />
per quello che abbiamo sofferto. Ora che ci sono i documenti, c'è scritto, non si può più dire che non è vero”.
Negli archivi della prefettura, infatti, <strong>il</strong> professor Tanzi ha trovato due elenchi di rom internati e anche altri documenti<br />
che raccontano la storia di Agnone. M<strong>il</strong>ka chiede un risarcimento che le sarebbe dovuto. Come a tutti gli ex internati,<br />
come per qualcuno è stato fatto. Non per i rom, vittime negate prima ancora che dimenticate.<br />
Un po' più tardi, nella sala del consiglio comunale, <strong>il</strong> sindaco di Agnone, Gelsomino De Vita, area centrodestra, le<br />
chiede ufficialmente scusa. Dice: “Io chiedo scusa a M<strong>il</strong>ka, a Tomo Bogdan che era con lei e oggi è rimasto a Roma<br />
perché sta male, al marito di M<strong>il</strong>ka che non c'è più e a tutti gli altri rom internati qui nella nostra città. Ci sono s<strong>il</strong>enzi<br />
che pesano sul popolo di Agnone. Lo abbiamo capito tardi, ma oggi la cittadinanza vuole chiedere scusa. Se accetti,<br />
M<strong>il</strong>ka, io ti chiedo scusa”. E lei: “Ma prego, prego signor sindaco, non mi dica così, non faccia così. Io le sono riconoscente.<br />
Io però vivo in una roulotte che è grande come questo tavolo, con i buchi e non ho niente. Nemmeno la<br />
cittadinanza, solo <strong>il</strong> permesso di soggiorno. Sono ancora straniera, dopo la prigionia e più di 60 anni in questo paese.<br />
E non ho mai staccato uno sp<strong>il</strong>lo da una siepe, anzi ho tolto <strong>il</strong> pane dalla mia bocca per darlo agli altri. Qui ad<br />
Agnone sono stata male e non si guarisce più. Vorrei una sistemazione e forse lei, signor sindaco, può aiutarmi”.<br />
M<strong>il</strong>ka chiede un posto dove vivere, e dice che con lei lo chiedono molti altri rom. Il sindaco risponde che la aiuterà e<br />
le consegna un attestato: oltre alle scuse c'è scritto che è cittadina d'onore. Lei, uscendo, dice che non sa leggere,<br />
ma “mi ha fatto piacere vedere dove ho sofferto”. Nessuno ha parlato di fascismo e di responsab<strong>il</strong>ità politiche, ma<br />
almeno, come voleva l'Osservatorio, qualcosa è stato fatto mettendo insieme persone e luoghi diversi, testimoni e<br />
documenti. Un atto di verità unico e importante per <strong>il</strong> nostro paese: <strong>il</strong> riconoscimento di una persecuzione che diventa<br />
strumento di conoscenza contro l'indifferenza e i revisionismi. E le scuse di una città a una donna rom che, con i<br />
suoi 83 anni, ha fatto un po' meno fatica a risalire sul furgone per tornare a Roma. Almeno per una notte.<br />
A forza di essere vento<br />
Lo sterminio nazista degli Zingari in un Doppio Dvd + libretto<br />
Quanti, non si saprà mai. Diciamo cinquecentom<strong>il</strong>a. Tanti furono, più o meno, i Rom e i Sinti, gli Zingari che<br />
furono sterminati dai Nazisti. Oltre ventim<strong>il</strong>a nel solo Zigeunerlager, <strong>il</strong> campo loro riservato dentro al campo<br />
di sterminio di Auschwitz-Birkenau, tra <strong>il</strong> febbraio 1943 e l’agosto 1944.<br />
Nel primo Dvd ci sono un’intervista con Marcello Pezzetti, del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea<br />
di M<strong>il</strong>ano, sulla storia dello Zigeunerlager, <strong>il</strong> settore zingaro del campo di sterminio di Auschwitz-<br />
Birkenau; un documentario (Porrajmos) sulle persecuzioni contro i Rom e i Sinti subite in Italia e Yugoslavia<br />
da parte di fascisti, ustascia e nazisti; la testimonianza di un Sinto tedesco torturato ad Auschwitz da Joef<br />
Mengele.<br />
Nel secondo Dvd ci sono le videoregistrazioni di due spettacoli tenutisi alla Camera del Lavoro di M<strong>il</strong>ano,<br />
una musicale con Moni Ovadia e i Taraf da Metropulitana (Rom rumeni) che eseguono canzoni zingare e<br />
yiddish, un’altra multimediale con musica, letture e documenti sul Porrajmos (parola romanes analoga a<br />
“Shoa”). C’è poi un’intervista a un Rom veneto sulla sua vicenda, dall’arresto in Friuli, l’internamento ad Auschwitz<br />
e <strong>il</strong> ritorno al suo paese.<br />
Nel libretto (72 pagine), Gloria Arbib si sofferma sull'irriducib<strong>il</strong>ità di Ebrei e Rom all'assim<strong>il</strong>azione; Giovanna<br />
Boursier traccia un quadro sintetico della persecuzione nazista dei Rom e dei Sinti, facendo luce anche sulle<br />
complicità del regime fascista. Un parallelo tra la Shoah e <strong>il</strong> Porrajmos è tracciato da Paolo Finzi. La situazione<br />
degli Zingari nell'Europa odierna è esaminata da Maurizio Pagani e dal rom Giorgio Bezzecchi, dell'Opera<br />
Nomadi. L'obiettivo del fotografo Paolo Poce fissa le immagini dello sgombero di una casa occupata da<br />
Rom rumeni a M<strong>il</strong>ano nel 2004. Il testo della canzone dedicata agli zingari da Fabrizio De André e Ivano<br />
Fossati sig<strong>il</strong>la <strong>il</strong> libretto.<br />
Il 2Dvd costa 30 euro e si può richiedere ai curatori:<br />
Editrice A, cas. post. 17120, 20170 M<strong>il</strong>ano, tel 02.2896627, fax 02.28001271,<br />
e ma<strong>il</strong>: arivista@tin.it - sito web: www.arivista.org
LE FERROVIE DELLA DEPORTAZIONE<br />
Di L<strong>il</strong>iana Picciotto ( “Corriere della Sera”, 16 Giugno 2006). Chi conduceva i treni che dalle varie stazioni italiane<br />
poprtava i deportati ebrei verso i lager tedeschi? Un’altra pagina sempre rimasta nell’oblio.<br />
E’ di qualche giorno la notizia che per la prima volta in Francia lo Stato e le Ferrovie dello Stato (SNCF) sono<br />
stati condannati a Tolosa per la loro corresponsab<strong>il</strong>ità nella deportazione degli ebrei. L’accusa per aver giocato<br />
un ruolo nel trasferimento della sua famiglia nel 1944 verso <strong>il</strong> campo di transito di Drancy, ultima tappa francese<br />
prima della deportazione, era stata mossa dal deputato europeo verde Alain Lipietz.<br />
Nei miei studi sugli arresti e le deportazioni degli ebrei dall'Italia nel periodo 1943-1945, ho sempre riflettuto<br />
sul fatto che le traduzioni da una prigione all'altra, i trasferimenti da un campo di internamento all'altro e le deportazioni<br />
verso i lager di Polonia e Germania erano basati su movimenti ferroviari. Il meccanismo messo in<br />
atto portò un insieme di inermi, tra cui nonni, bebè, giovani madri, perfino invalidi in carrozzella e dementi<br />
strappati dai manicomi (sì, questo è avvenuto anche qui da noi) da un luogo all'altro dell'Italia, sotto lo sguardo<br />
discreto e anche troppo distratto della popolazione civ<strong>il</strong>e.<br />
Furono messi su strada ferrata 42 convogli di ebrei deportati Oltralpe, ma si contano decine di traduzioni ferroviarie<br />
di piccoli gruppi di arrestati, scortati dalle forze dell'ordine in scompartimenti dedicati o in carrozze agganciate<br />
a treni interni (gli uni e le altre perfettamente individuati con le date di partenza e di arrivo, pubblicate<br />
ne “Il libro della Memoria”). Per realizzare ciò, è ovvio, occorse tutta una complessa organizzazione costituita<br />
da decisori politici - sia italiani, sia tedeschi - tecnici, guardie, ferrovieri, manovali e molti altri attori.<br />
Uno studio accurato sul ruolo delle ferrovie nello sterminio degli ebrei d'Europa è stato condotto da Raul H<strong>il</strong>berg,<br />
negli Anni Settanta, nella disattenzione generale. A testimonianza però dell’importanza del tema, io<br />
stessa nel 1997 ero stata sentita dalla Commissione Indipendente di Esperti sulla Svizzera e la Seconda guerra<br />
mondiale, coordinata dal professor Bergier, che indagava anche sull’eventuale passaggio di treni di deportazione<br />
sul suolo svizzero.<br />
Ora la sentenza del tribunale di Tolosa riapre, seppur molto in ritardo, l'intera questione. Sarebbe forse ora di<br />
parlarne, pacatamente e razionalmente, non solo per la Francia, ma per tutta Europa, senza eccezioni.<br />
scomparsi a Reggio Em<strong>il</strong>ia - lost and Not found 3<br />
Il Museo della Resistenza posto all’interno dei Civici Musei e ivi rimasto fino agli anni 80 circa.<br />
Oggi non c’è più.<br />
C’è chi ancora se lo ricorda e ricorda anche gli oggetti che lì erano confluiti, perché donati da ex<br />
partigiani, all’indomani della Liberazione.
QUANDO I SOLDI SANNO DI LACRIME E SANGUE<br />
Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri <strong>il</strong> 1° dicembre 1998 è stata istituita una commissione alla<br />
quale è stato affidato “<strong>il</strong> compito di ricostruire le vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione<br />
dei beni di cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati”. La commissione, presieduta dall’on. Tina<br />
Anselmi, ha concluso i suoi lavori <strong>il</strong> 30 apr<strong>il</strong>e 2001, dopo vent’otto mesi di attività.<br />
Riportiamo in queste pagine una sintesi del “Rapporto generale” st<strong>il</strong>ato da questa Commissione tratto da<br />
“Triangolo Rosso”, la rivista dell’ANED (ottobre 2001). A seguire un amaro commento di Michele Sarfatti che<br />
della Commissione ha fatto parte (Corriere della Sera, 13 novembre 2002).<br />
L’ordine di polizia del ministro dell’Interno del 30 novembre (del 1943, ndr) stab<strong>il</strong>iva, oltre all’arresto e<br />
all’internamento degli ebrei, che “tutti i loro beni, mob<strong>il</strong>i ed immob<strong>il</strong>i, debbono essere sottoposti ad immediato<br />
sequestro, in attesa di essere confiscati nell’interesse della Repubblica sociale italiana la quale li destinerà a<br />
beneficio degli indigenti sinistrati dalle incursioni aeree nemiche”.<br />
La confisca dei beni venne decisa con un decreto legislativo del 4 gennaio 1944. Il decreto riguardava i beni di<br />
tutte le persone fisiche classificate di “razza ebraica”, sia italiane, (...) sia straniere, anche se non residenti nella<br />
Rsi. Esse non potevano possedere nel territorio della Rsi “aziende di qualunque natura… terreni… fabbricati…<br />
titoli, valori, crediti e diritti di compartecipazione di qualsiasi specie… altri beni mob<strong>il</strong>iari di qualsiasi natura.”<br />
I decreti di confisca venivano pubblicati sulla Gazzetta ufficiale d’Italia ed elencavano tutti i beni posseduti<br />
dall’ebreo: aziende, terreni, fabbricati, crediti vari, valori depositati nelle banche, mob<strong>il</strong>i di arredamento, soprammob<strong>il</strong>i,<br />
stoviglie, lenzuola, vestiario, spazzolini da denti, ecc. (...)<br />
Se fino all’8 settembre ’43 la spoliazione dei beni degli ebrei avvenne, pur con i suoi odiosi aspetti persecutori,<br />
quasi esclusivamente ad opera dello Stato sulla base di norme stab<strong>il</strong>ite, dopo tale data subentrò l’arbitrio. Nota<br />
infatti <strong>il</strong> Rapporto come <strong>il</strong> processo di spoliazione venisse “affidato, da un lato , all’iniziativa di istituzioni fortemente<br />
indebolite e quindi sempre più governate dall’arbitrio dei funzionari ad esse preposte e, dall’altro,<br />
all’intervento di soggetti privati, portati ad approfittare di più o di meno della loro vicinanza ai perseguitati in difficoltà,<br />
alle loro famiglie e alle loro cose.” (...)<br />
Per gestire e liquidare i beni ebraici espropriati, nel 1939 venne istituito l’Egeli, sigla che significa “Ente di gestione<br />
e liquidazione immob<strong>il</strong>iare” che, essendo stato incaricato anche di altri compiti dopo lo scoppio della<br />
guerra come la gestione di beni di cittadini di nazionalità straniera, cesserà la sua attività soltanto nel 1997.<br />
L’Ente per la gestione dei beni espropriati si avvalse anche dell’attività di una serie di banche. Secondo <strong>il</strong> rapporto,<br />
sul finire del 1946 i beni ebraici furono quasi tutti restituiti ma allora si pose lo spinoso problema delle<br />
richieste ai cittadini espropriati delle spese di gestione, avanzate dall’Egeli o dalle banche. Si calcolava che a<br />
tutto <strong>il</strong> 1947 i compensi dovuti all’Egeli ammontassero a più di 22 m<strong>il</strong>ioni di lire cui andavano aggiunti 3 m<strong>il</strong>ioni<br />
e 300 m<strong>il</strong>a lire relativi ai beni gestiti extra Egeli.<br />
Le richieste sollevarono forti proteste da parte degli interessati, sostenuti dall’Unione delle comunità israelitiche<br />
italiane, i quali chiedevano l’annullamento da parte dello Stato di quanto preteso argomentando in sostanza:<br />
“Come, ci hanno depredato e dobbiamo anche pagare?!”<br />
In una lettera all’Unione delle comunità israelitiche del ’48, Arrigo Vita scrive: “…vi segnalo che l’Istituto<br />
S.Paolo di Torino mi ha richiesto la somma di L. 18.650 per la gestione del mio alloggio… durante <strong>il</strong> periodo<br />
nazifascista… Ho rifiutato di pagare ritenendo che l’Egeli abbia avuto la funzione di campo di concentramento<br />
per i nostri beni…”. Un’altra lettera, dai toni molto più duri, della quale non viene citato <strong>il</strong> mittente, venne inviata<br />
al San Paolo <strong>il</strong> 23 novembre 1947 e dice: “Con disinvoltura ora …definite <strong>il</strong> governo della Repubblica sociale<br />
‘sedicente governo’ mentre lo avete fedelmente servito interpreti ed esecutori di tutti i soprusi escogitati dai<br />
nazifascisti contro i perseguitati razziali… Ma affinché non vi sembri questa mia uno sfogo polemico per disconoscere<br />
le Vs/benemerenze desidero raccontarVi alcune Vs/responsab<strong>il</strong>ità nei ns/confronti come saggio di ciò<br />
che sarà accaduto a quasi tutti gli altri; gli assassinati senza eredi non hanno più voce e lasciano per ora a voi<br />
<strong>il</strong> godimento dei frutti dei loro beni… Il 5 febbraio 1944 presenti Vs/funzionari e si direbbe col Vs/compiacente<br />
e indifferente consenso, è avvenuto che nazifascisti bene informati saccheggiassero masserizie e arredi<br />
nell’alloggio di mia madre e negli uffici delle mie società… (...) E così andarono perduti tutta la corrispondenza<br />
dei miei cari defunti, manoscritti e poesie inediti di letterati miei amici, libri, documenti notarli ecc. e una colle-
zione di 2000 francobolli antichi... La cosiddetta Vs/gestione si è limitata a cristallizzare gli affitti nella misura di<br />
quelli del 1934… Ed ora dopo oltre 21 mesi ci presentate in forma perentoria un conto globale di oltre <strong>il</strong> doppio<br />
di quanto faticosamente percepito. A parte la questione morale che segnalerò al ministero delle Finanze, sarebbe<br />
inammissib<strong>il</strong>e far pagare alle vittime della persecuzione le spese di una gestione escogitata a loro danno<br />
da aguzzini, per impadronirsi delle proprietà di candidati alle camere a gas. Vi segnaliamo <strong>il</strong> fatto che noi<br />
non vi abbiamo nominati ns/tutori”. (...)<br />
(“Triangolo Rosso”, Ottobre 2001)<br />
Ho fatto parte della “Commissione Anselmi”, la Commissione governativa che per due anni e mezzo ha setacciato<br />
gli archivi pubblici e privati italiani per indagare i meccanismi di spoliazione attuati contro gli ebrei italiani<br />
dal 1938 al 1945. Nell'apr<strong>il</strong>e 2002 abbiamo consegnato alla Presidenza del Consiglio e al Paese un Rapporto<br />
Generale di 540 pagine fitte, ricco di ricostruzioni storiche e di indicazioni su ciò che nel dopoguerra era stato<br />
restituito, su ciò che era stato disperso definitivamente, su ciò che era o poteva essere rimasto in possesso di<br />
enti pubblici o privati.<br />
Nei successivi diciotto mesi si è verificato un solo episodio di restituzione, per meritoria decisione autonoma<br />
della Provincia di Trento. Nient'altro. Nel frattempo i depredati si sono anagraficamente ridotti di numero, le<br />
ricchezze del Paese sono cresciute e diminuite, le manifestazioni di antisemitismo sono calate o aumentate,<br />
viaggi (in Israele) sino a ieri non offerti e non graditi sono diventati possib<strong>il</strong>i. Ma la maggior parte delle Raccomandazioni<br />
conclusive del Rapporto Generale è rimasta inevasa. Una di esse auspicava che “<strong>il</strong> Governo, anche<br />
alla luce delle risultanze emerse dal lavoro della Commissione, e secondo modalità che riterrà più opportune,<br />
renda sollecitamente possib<strong>il</strong>i i risarcimenti individuali alle vittime di sequestri, confische e furti avvenuti<br />
negli anni 1938-1945”. Cara Tina Anselmi, non più ragazzina: quanta sprovvedutezza in quel nostro “sollecitamente”.<br />
A fronte di questa situazione, gli unici elementi di novità sono stati, <strong>il</strong> mese scorso, la pubblicità al libro di Norman<br />
Finkelstein sull'esosità (per non dir di peggio) ebraica “olocaustica” e, ora, i giudizi liquidatori della Commissione<br />
Anselmi scritti da Sergio Romano sul “Corriere della Sera” di giovedì 7 novembre. In questi diciotto<br />
mesi (ci si potrebbero fabbricare due bambini, lavoro non da poco) tutti hanno avuto cose importanti da fare,<br />
più importanti anche della restituzione degli orologi confiscati dalle autorità italiane repubblichine a ebrei arrestati<br />
sul confine svizzero (gli ebrei furono deportati; gli orologi nel dopoguerra vennero venduti dal nostro Stato<br />
democratico a beneficio dell'Erario), o della bandiera d'Italia confiscata nell'abitazione di un rabbino (a quella<br />
data già ucciso ad Auschwitz).<br />
Se l'Italia non deve restituire, non restituisca. Ma, per cortesia, lo si faccia in s<strong>il</strong>enzio. Ci si risparmi l'ironia sui<br />
soldi degli ebrei, sulla potenza degli ebrei, sulla protervia degli ebrei, sull'insopportab<strong>il</strong>ità degli ebrei.<br />
Michele Sarfatti (Corriere della Sera, 13 novembre 2002)<br />
L’AMNESIA DELLA SINISTRA<br />
DALL’AMNISTIA DI TOGLIATTI ALLA RIABILITAZIONE DEI REPUBBLICHINI DI SALÒ<br />
A cura dell’Archivio antifa - Liberamente tratto da “Umanità Nova” del 24 settembre 2006<br />
La partecipazione, peraltro applaudita, di Fausto Bertinotti, presidente della camera dei deputati alla Festa nazionale<br />
di Azione giovani, l’organizzazione giovan<strong>il</strong>e di Allenza Nazionale, appare a tutti gli effetti l’ultimo atto<br />
del processo di legittimazione di un partito “postfascista” come AN che mantiene nel proprio simbolo e nella<br />
sua dirigenza l’eredità di un passato mai passato. Ed oltre alla presenza del leader di Rifondazione comunista,<br />
va segnalata nell’ambito della stessa festa tricolore anche quella del presidente dell’ARCI Paolo Beni e della<br />
ministra Ds Livia Turco.
Ancora una volta la pregiudiziale antifascista della repubblica nata dalla Resistenza è stata così annegata nello<br />
spirito della cosidetta pacificazione nazionale, dopo che questo ha cancellato la memoria di una guerra civ<strong>il</strong>e<br />
e sociale prolungatasi almeno dal 1919 al 1945, accumunando i morti dell’una e dell’altra parte al fine di azzerare<br />
ogni divisione e responsab<strong>il</strong>ità.<br />
Molti sono stati quelli che hanno lavorato più o meno scientemente in questa direzione, dalla fine della seconda<br />
guerra mondiale ad oggi, seppur in diverso modo e a diverso livello ed anche con diversa connotazione ideologica;<br />
basti pensare al “revisionismo storico” all’italiana che in realtà iniziò subito a modificare gli eventi<br />
connessi alla Resistenza affrettandosi a stab<strong>il</strong>irne la data di nascita (8 settembre 1943) e, soprattutto, quella di<br />
morte (25 apr<strong>il</strong>e 1945). Era infatti, per troppi, una pagina da chiudere quanto prima non solo sul passato, ma<br />
anche sul presente e sull’avvenire.<br />
Dall’amnistia di Togliatti alla nascita del MSI<br />
A far tornare inizialmente sulle scene della politica nazionale i fascisti, nel conflittuale dopoguerra italiano, fu<br />
Palmiro Togliatti. Di fatto, proprio <strong>il</strong> segretario del Partito Comunista Italiano che, nella sua veste di ministro<br />
Guardasig<strong>il</strong>li della neonata repubblica, pose la sua firma nel giugno ’46 a quell’amnistia che assicurò l’impunità<br />
e scarcerazione a circa 10m<strong>il</strong>a fascisti della repubblica di Salò, compresi torturatori di partigiani e fuc<strong>il</strong>atori di<br />
civ<strong>il</strong>i inermi.<br />
Le indagini avviate sui tanti eccidi compiuti in Italia dai nazi-fascisti finirono invece sepolte negli “armadi della<br />
vergogna”, da dove soltanto da poco stanno riemergendo.<br />
Non casualmente <strong>il</strong> Movimento Sociale Italiano nacque a pochi mesi dalla generosa amnistia, nel dicembre<br />
dello stesso anno, raccogliendo nel nuovo partito innumerevoli esponenti del passato regime, anche con gravi<br />
responsab<strong>il</strong>ità individuali, e una serie di formazioni minori clandestine.<br />
Giudici più che indulgenti, formati e legati ideologicamente agli imputati, nel frattempo rimettevano in circolazione,<br />
tra <strong>il</strong> ’46 e <strong>il</strong> ’47, <strong>il</strong> grosso dello stato maggiore fascista e repubblichino; d’altra parte risultava evidente la<br />
continuità del ceto che esercitava le funzioni repressive statali incaricate, si fa per dire, di impedire <strong>il</strong> ritorno al<br />
passato: dei 369 prefetti soltanto 2 non avevano fatto parte dell’ingranaggio fascista; dei 135 questori e 139<br />
vicequestori soltanto 5 avevano avuti rapporti con la Resistenza: dei 1642 commissari soltanto 24 avevano<br />
avuto dei contatti con l’antifascismo.<br />
Si trattava dello stesso apparato che continuava a schedare i “sovversivi”; nel casellario del Ministero<br />
dell’Interno su 13.716 sorvegliati per ragioni politiche 12.491 risultavano di sinistra; questi almeno i dati ufficiali,<br />
dato che l’attività di schedatura e controllo era cap<strong>il</strong>lare, sistematica e larghissima.<br />
La comparsa del MSI, fortemente avversata a livello popolare, fu quindi possib<strong>il</strong>e grazie a consistenti assensi<br />
e complicità politiche. Innanzi tutto va sottolineato <strong>il</strong> beneplacito dei Liberatori, ossia delle autorità politicom<strong>il</strong>itari<br />
britanniche e statunitensi già da tempo impegnate nell’arruolamento in chiave anticomunista di innumerevoli<br />
dirigenti del nazismo e del fascismo; quindi non si può tacere la connivenza sia dei vertici della Democrazia<br />
Cristiana, in esecuzione delle volontà della Chiesa di Pio XII apertamente favorevole ad una totale riab<strong>il</strong>itazione<br />
dei fascisti, che quella della dirigenza del PCI, tutti interessati a favorire la creazione di un’estrema<br />
destra politicamente ben individuab<strong>il</strong>e, isolab<strong>il</strong>e e ricattab<strong>il</strong>e, ut<strong>il</strong>izzando a tal fine anche la minaccia di scioglimento<br />
per “ricostruzione del partito fascista”.<br />
L’appoggio, anche finanziario, da parte delle gerarchie cattoliche a favore dei fascisti ebbe come principale<br />
sostenitori la curia romana, l’Azione cattolica, l’organo dei Gesuiti “La Civ<strong>il</strong>tà cattolica” e i Comitati civici di Luigi<br />
Gedda.<br />
Ovviamente anche <strong>il</strong> padronato vide con favore tale riorganizzazione antioperaia e anticomunista; lo stesso<br />
Enrico Mattei, ex-partigiano bianco ed esponente di punta del neocapitalismo italiano, avrebbe paragonato i<br />
fascisti ad un taxi di cui servirsi, pagando, finché potevano risultare ut<strong>il</strong>i per <strong>il</strong> mantenimento del comando delle<br />
fabbriche.<br />
Dagli anni Cinquanta agli anni Settanta furono innumerevoli i servigi del MSI ai governi, sempre guidati dalla<br />
DC, come nel 1957 quando salvarono <strong>il</strong> governo Segni. I missini inoltre offrirono ai servizi segreti americani e<br />
a governi dittatoriali come quello spagnolo o greco la manovalanza squadristica, sempre ispirata da un feroce<br />
anticomunismo, contro gli studenti alla fine degli anni Sessanta e i movimenti di sinistra. Inoltre molti esponenti<br />
della formazione politica della destra italiana furono coinvolti nei vari progetti destab<strong>il</strong>izzanti del sistema politico<br />
italiano e nella strategia della tensione.
Da Craxi a Berlusconi e D’Alema: lo sdoganamento del neofascismo italiano<br />
Nel 1982 <strong>il</strong> leader radicale Marco Pannella presenziava al congresso nazionale missino; quindi nell’83, dopo<br />
l’uccisione di un attivista del Fronte della Gioventù, <strong>il</strong> MSI ricevette una larga solidarietà e nello stesso anno,<br />
Bettino Craxi, al momento delle consultazioni per la formazione dei suo governo, incontrò anche i dirigenti<br />
missini. Fu infatti soprattutto <strong>il</strong> segretario del PSI che, rinnegando origini e identità antifasciste, scelse in quel<br />
periodo di riab<strong>il</strong>itare <strong>il</strong> partito con la fiamma tricolore, definendolo nell’83 “un partito come tutti gli altri”.<br />
Lo sdoganamento missino segnò nell’84 un ulteriore tappa: rappresentanti della DC e del PLI parteciparono al<br />
congresso del MSI.<br />
Nel 1985, mentre correvano i mitici anni del rampantismo, delle tangenti e della proclamata morte delle ideologie,<br />
si giunse così alla completa integrazione del fascismo parlamentare nel panorama istituzionale.<br />
Forte di questo clima, negli anni tra <strong>il</strong> ’91 e <strong>il</strong> ’94 <strong>il</strong> neofascismo italiano viveva quindi una nuova stagione. Nel<br />
’93 S<strong>il</strong>vio Berlusconi apriva una carta di credito a Fini, succeduto ad Almirante alla guida del partito, sostenendone<br />
la candidatura a sindaco di Roma: Forza Italia si alleava al MSI per le politiche nel Meridione, mentre i<br />
giornali scoprivano <strong>il</strong> volto “nuovo” e per bene del neo-segretario, definito “un bravo ragazzo” anche da Francesco<br />
Cossiga.<br />
Nel ’94 <strong>il</strong> MSI andava al governo, con ben 5 ministri, con Forza Italia e la Lega Nord. Nel ’95 a Fiuggi si teneva<br />
<strong>il</strong> Congresso della “svolta” in cui, raccogliendo una manciata di ex-democristiani di destra, <strong>il</strong> MSI si trasformò in<br />
Alleanza Nazionale. All’interno del partito che conservava nella bandiera anche la fiamma tricolore ardente dal<br />
catafalco del duce, non si registrarono grandi cambiamenti sostanziali, ma fu sufficiente per <strong>il</strong> definitivo “sdoganamento”.<br />
Non mancava <strong>il</strong> plauso del monsignor Ruini, fautore dell’alleanza di centrodestra, e <strong>il</strong> f<strong>il</strong>osofo ex-<br />
DC Rocco Buttiglione ebbe a definire ormai i postfascisti come “la destra democratica”. Così cadevano anche<br />
le ultime resistenze. Per la prima volta i partiti di sinistra mandarono i loro rappresentanti al congresso di un<br />
partito erede della Repubblica di Salò; mentre si sprecavano i commenti positivi di personalità non di destra:<br />
Vittorio Foa, Eugenio Scalfari, lo storico liberale Denis Mack-Smith, autore di un ponderoso saggio su Mussolini...<br />
Da parte sua, l’onorevole diessino Luciano Violante fin dal ’94 aveva riab<strong>il</strong>itato in parlamento “i ragazzi di Salò”.<br />
Un suo compagno di partito andava anche oltre: nel ’98 <strong>il</strong> sindaco del PDS di Cattolica annunciava di voler<br />
ricollocare una targa rievocativa della Marcia su Roma inaugurata sotto <strong>il</strong> regime nel ’32.<br />
Nessuno stupore quindi se in questi anni si sia cercato di assicurare la pensione ai repubblichini o togliere ogni<br />
residuo riferimento antifascista nella Costituzione, come a suo tempo proposto da Marcello Pera dall’alto<br />
della sua carica istituzionale. D’altra parte nell’ottobre 2001 è stato lo stesso ex-presidente della Repubblica,<br />
Carlo Azeglio Ciampi, ad equiparare partigiani e fascisti di Salò, rendendo onore al “sentimento che animò<br />
molti dei giovani che allora fecero scelte diverse e che lo fecero, credendo di servire ugualmente l’onore della<br />
propria patria”, per non parlare poi delle ultime esternazioni di D’Alema sulla morte del duce.<br />
Nessuna meraviglia neppure se oggi Alleanza Nazionale, oltre a raccogliere gli ex del MSI, si presenta come<br />
l’ultimo approdo dei reduci di altre formazioni dell’estremismo fascista degli anni Settanta e Ottanta (Ordine<br />
nuovo, Avanguarda nazionale, NAR, Terza posizione...), oppure se un partito che si proclama liberale come<br />
Forza Italia alle ultime elezioni politiche abbia stretto intese elettorali con tutte le fiamme tricolori dell’estrema<br />
destra.<br />
Siamo all’ultimo capitolo di un gioco iniziato già all’indomani della Liberazione. D’altra parte, ald<strong>il</strong>à dei saluti<br />
romani e dei tetri labari littori, <strong>il</strong> nucleo ideologico-culturale di base risulta immutato, come provano in modo<br />
trasparente le recenti dichiarazioni di un dirigente di Azione Giovani, tale Francesco Marascio: “Essere conservatori<br />
significa sposare una visione del mondo tradizionale, cioè immune dalla contaminazione ideologica<br />
iniziata con la rivoluzione francese alla fine del 1700 [...] Volendo trovare uno slogan possiamo tranqu<strong>il</strong>lamente<br />
riproporre <strong>il</strong> celebre Dio, patria e famiglia”.
scomparsi a Reggio Em<strong>il</strong>ia lost and Not found 4<br />
Serbatoio dell’acqua<br />
delle Officine Reggiane<br />
Simbolo della storia operaia della città abbattuto <strong>il</strong> 12 febbraio 2002 per la realizzazione di un<br />
parcheggio.<br />
L’ARMADIO DELLA VERGOGNA<br />
A cura di Francesco Paolella, collaboratore Istoreco di Reggio Em<strong>il</strong>ia.<br />
Franco Giustolisi è un giornalista de “L’espresso”. E’ un giornalista alla vecchia maniera. E’ fac<strong>il</strong>e sentire parlare<br />
del suo libro, L’armadio della vergogna, perché è lui stesso a parlarne, incessantemente, ormai da qualche<br />
anno, in ogni angolo dell’Italia. Parla delle sue ricerche, del suo impegno (quasi una “vocazione”), di una<br />
ostinata passione per la verità, intesa, ancor prima che come conoscenza rigorosa, come divulgazione di una<br />
terrib<strong>il</strong>e ingiustizia. In ciò stanno la forza ed <strong>il</strong> limite della sua opera.<br />
Il suo libro, resoconto di una lotta durata anni contro l’indifferenza burocratica e gli insabbiamenti ministeriali, è<br />
un lungo racconto di centinaia di crimini: omicidi, eccidi, stragi, carneficine (spesso gratuite e crudeli fino<br />
all’inverosim<strong>il</strong>e), compiuti in Italia fra l’autunno del 1943 e la primavera del 1945 dagli uomini dell’occupazione<br />
tedesca. Sia chiaro: dagli occupanti assieme (ed in spirito di perfetta collaborazione) dalle forze solerti della<br />
Repubblica sociale italiana.<br />
In sintesi, Giustolisi ha scritto di una lunga strage di m<strong>il</strong>itari e civ<strong>il</strong>i. Decine di migliaia di vittime, che non hanno<br />
avuto, se non un tardivo, es<strong>il</strong>issimo riconoscimento, né (se non in pochissimi casi) giustizia.<br />
Il libro ricostruisce i meccanismi dell’insabbiamento, le spinte e le coperture governative, i lunghi anni di s<strong>il</strong>enzio,<br />
fino alla scoperta, una decina di anni fa, di un armadio, pieno di fascicoli, i documenti su quegli omicidi<br />
dentro un armadio, in un palazzo romano, alla sede della Procura generale m<strong>il</strong>itare.<br />
Hanno prevalso, negli ambienti istituzionali repubblicani, ragioni di opportunità politica (di politica estera e in<br />
nome di una fantomatica «riconc<strong>il</strong>iazione nazionale»), di conformismo o, peggio, di indifferenza. Fivizzano,<br />
Marzabotto, Sant’Anna di Stazzema, tutti luoghi oggi della memoria, ma senza che una piena giustizia sia ormai<br />
possib<strong>il</strong>e.<br />
I brani che seguono vengono dal volume di F. Giustolisi, L’armadio della vergogna, Nutrimenti, Roma 2004.<br />
Finì la guerra, cominciò la ricostruzione. Ma fu abbattuto quello che è <strong>il</strong> p<strong>il</strong>astro di ogni civ<strong>il</strong>tà: la giustizia. C’è<br />
un palazzo cinquecentesco a Roma, in via degli Acquasparta, sede della Procura generale m<strong>il</strong>itare. Lì affluivano,<br />
dopo la Liberazione, i fascicoli di quegli eccidi. C’erano annotati i nomi delle vittime, i nomi degli assassini,<br />
le località dove erano stati commessi i crimini. Un’istruttoria per ogni fascicolo, un processo per ogni istruttoria.<br />
Se ne sarebbero dovute occupare le Procure m<strong>il</strong>itari distrettuali, destinatarie istituzionali di quelle carte.<br />
Ma tutto rimase in quell’antico palazzo. Arrivò un ordine, un ordine dall’alto. Quando? Non prima del 31 maggio<br />
1947. Subentrò, allora, ai governi del Comitato di liberazione nazionale la prima formazione di centro destra.<br />
Chi si assunse quella drammatica responsab<strong>il</strong>ità non poteva essere stato che un uomo di governo con<br />
l’avallo del presidente del Consiglio. Si trattava di salvare migliaia di criminali, di uccidere una seconda volta<br />
una moltitudine di cittadini. I fascicoli rimasero in quel palazzo. Non ci furono istruttorie, non ci furono processi.<br />
Tutto fu avvolto dal s<strong>il</strong>enzio che <strong>il</strong> potere aveva imposto. La descrizione di quei misfatti, le prove, le testimonianze<br />
vennero scoperte per caso mezzo secolo più tardi. Erano nascoste in quel vecchio armadio, nella sede<br />
della Procura generale m<strong>il</strong>itare. Lo avevano rif<strong>il</strong>ato in un vano recondito, protetto da un cancello con tanto di<br />
lucchetto. L’armadio, l’Armadio della vergogna, aveva le ante, chiuse a chiave, rivolte verso <strong>il</strong> muro. Su un
grande registro, in ben 2274 voci, era annotato tutto quel che conteneva o aveva contenuto. Già, perché negli<br />
anni qualcosa era uscito di là. Come alibi, come scusa, come pretesto, come vergognoso simbolo di un dovere<br />
mai compiuto, alcune carte erano state smistate. Ma si trattava esclusivamente di atti riguardanti delitti ormai<br />
prescritti o di importanza relativa. Comunque non avrebbero mai permesso di risalire ai responsab<strong>il</strong>i. In<br />
quell’armadio rimasero, per cinquant’anni, 695 fascicoli. In 415 erano riportati i nomi dei colpevoli. Al numero 1<br />
l’eccidio delle Ardeatine. In testa Herbert Kappler, seguito da un codazzo di assassini. C’era anche Erich Priebke,<br />
<strong>il</strong> cui nome un cancelliere disattento aveva annotato come Priek. Grazie a quell’armadio lui s’è goduto 50<br />
anni di libertà. E così per i nazifascisti di Stazzema. E così per i nazifascisti di Marzabotto. E così per i nazifascisti<br />
di Fivizzano... Fu la ragion di Stato a imporre l’occultamento, sentenziò un’inchiesta della procura m<strong>il</strong>itare.<br />
Fu formulata anche l’ipotesi della motivazione: quella della guerra fredda. Occidente e Oriente si guardavano<br />
in cagnesco, la nuova Germania doveva far da spalla alla Nato contro l’Unione sovietica. Il fango rinchiuso<br />
in quell’armadio avrebbe impedito ogni sogno di rinascita della Werhmacht... (pp. 28-29).<br />
Adesso l’Armadio della vergogna non è più lì. Forse rimosso, forse distrutto, incolpevole scrigno di così pesanti<br />
segreti. Rimosso o distrutto, forse, per annullare un passato che la memoria degli uomini non può, non deve<br />
annullare. La decisa iniziativa del procuratore Intelisano [Antonino Intelisano, come Procuratore m<strong>il</strong>itare a Roma,<br />
nel 1994 venne a conoscenza dei fascicoli nell’ambito dell’estradizione di Priebke dall’Argentina, N.d.R.]<br />
aveva portato alla sua scoperta. Ma non c’era nessuno che ne ammettesse l’esistenza, nessuno che dicesse<br />
di conoscerne <strong>il</strong> contenuto. Poi la breve intervista a quei giornali veneti che, però, non ebbe alcun seguito.<br />
Qualche mese dopo, siamo all’inizio del 1996, insieme al collega Alessandro De Feo sto occupandomi del caso<br />
Priebke e della strage di Capistrello. All’Espresso ci arriva, in forma anonima, un documento composto di<br />
alcune pagine ingiallite dal tempo e dai bordi consumati. Dall’analisi fatta effettuare sulla carta e sulla scritta a<br />
macchina sembra autentico. Si tratta di un appunto riservato comp<strong>il</strong>ato da un alto giudice m<strong>il</strong>itare, indubbiamente<br />
un capo come si può r<strong>il</strong>evare dall’autoritarismo con cui si esprime. Si riferisce ai criminali nazisti latitanti.<br />
La premessa è una lunga e minuziosa disamina degli atti acquisiti e delle questioni legate alla procedib<strong>il</strong>ità e<br />
alla possib<strong>il</strong>ità di prescrizione e di estradizione. E sembra scritto apposta per rispondere “no” a ogni tentativo<br />
di mettere le mani sui criminali delle Fosse Ardeatine: se ne sanno nomi e cognomi, ma nessuno ne conosce <strong>il</strong><br />
volto, né si sa dove si nascondono, si legge nel documenti: comunque, qualora se ne sapesse qualcosa di più,<br />
si legge ancora, inut<strong>il</strong>e insistere con una richiesta di estradizione finora ignorata dai governi ai quali è stata indirizzata.<br />
E via cav<strong>il</strong>lando.<br />
(A proposito della possib<strong>il</strong>ità di mandare a processo Hans Keller, generale della giustizia m<strong>il</strong>itare tedesca, fra i<br />
comp<strong>il</strong>atori degli elenchi per le Ardeatine, in quel documento si legge:)<br />
“La possib<strong>il</strong>ità di un giudizio in contumacia è stata prospettata sin dall’epoca del processo Kappler, ma la sua<br />
realizzazione è stata esclusa, per direttiva del Procuratore generale m<strong>il</strong>itare, in un primo momento per non ritardare<br />
la celebrazione del processo a carico di Kappler e degli altri m<strong>il</strong>itari consegnati, in un secondo momento,<br />
per ragioni di opportunità, non sembrando conveniente, anche in considerazione delle scarse possib<strong>il</strong>ità di<br />
una pratica realizzazione della pretesa punitiva, turbare ancora una volta l’opinione pubblica, riportando alla<br />
ribalta <strong>il</strong> triste episodio dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, tale direttive del Procuratore generale sono state periodicamente<br />
riconfermate, a richiesta di questa Procura m<strong>il</strong>itare” (pp. 47-49).<br />
Chi decise l’occultamento dei fascicoli sulle stragi nazifasciste? La risposta è semplice: fu <strong>il</strong> procuratore generale<br />
m<strong>il</strong>itare dell’epoca, Umberto Borsari, a far seppellire nell’Armadio della vergogna tutto ciò che riguardava<br />
gli eccidi perpetrati dai nazisti e dai fascisti di Salò. Ma i mandanti? Chi e perché prese la decisione politica? Il<br />
31 maggio 1947 Alcide De Gasperi ottenne la fiducia del Parlamento per <strong>il</strong> suo nuovo governo. Via comunisti,<br />
socialisti e democratici del lavoro. Entrano, al fianco di Dc e liberali, i socialdemocratici (a gennaio c’era stata<br />
la grande scissione nel Psi: Nenni da una parte e Saragat dall’altra) e i repubblicani. La guerra fredda è ormai<br />
alle porte o, più realisticamente, è già entrata: vecchi alleati diventano nuovi nemici, vecchi nemici diventano<br />
nuovi alleati. [...] Probab<strong>il</strong>mente sin da allora, cioè dalla nascita di quel primo quadripartito De Gasperi, che<br />
segna <strong>il</strong> cambio delle alleanze interne e internazionali, ci si deve essere posti <strong>il</strong> problema di come guardare <strong>il</strong><br />
passato. Il nazismo era ed è rimasto un orrore per quel che già si sapeva, ma perché aggiungervi altri sinistri e<br />
vistosissimi tasselli? Nazismo e Germania democratica sono due cose distinte, ma è diffic<strong>il</strong>e ipotizzare un<br />
riarmo tedesco se continuano a venire alla luce e a diventare di dominio pubblico i misfatti dei suoi m<strong>il</strong>itari, SS,
ma non solo. Meglio, allora, <strong>il</strong> s<strong>il</strong>enzio, l’oblio, <strong>il</strong> segreto per fac<strong>il</strong>itare l’inserimento della nuova Germania nel<br />
nuovo sistema di alleanze politico-m<strong>il</strong>itari. Ma c’è anche un’altra tesi, portati avanti dagli storici F<strong>il</strong>ippo Focardi<br />
e Lutz Klinkhammer. E’ questa: anche l’Italia aveva una nutrita schiera di criminali di guerra, poco meno di<br />
1700 secondo l’elenco delle Nazioni Unite. Ce li richiedevano l’Unione sovietica, la Grecia, l’Albania e, particolarmente,<br />
la Jugoslavia. Quelli più richiesti erano circa un centinaio, accusati di reati gravissimi dagli Stati che<br />
<strong>il</strong> fascismo aveva invaso e occupato sino all’8 settembre 1943 (p. 69).<br />
Dal rapporto dei carabinieri di Capistrello, in data 24 apr<strong>il</strong>e 1946, numero di protocollo 17 / 44, avente per oggetto<br />
“Esito informazioni sulle atrocità commesse dai tedeschi in Italia”. E’ scritto in quel rapporto: «Il 20 marzo<br />
1944 verso le ore 21 <strong>il</strong> giovane italiano Masci Pietro, di anni 18, studente, venne prelevato dalla propria abitazione<br />
e condotto al comando tedesco retto dal tenente Haing Negben, Fend-Post 57302-F, residente a Chelin.<br />
Il Masci venne accusato di aver rubato alcune sigarette a un maresciallo abitante nella casa del Masci stesso.<br />
Negben ne ordinò la fuc<strong>il</strong>azione. La teste Bonanni Marta fu Leopoldo riferisce che <strong>il</strong> mattino seguente fu incaricata<br />
per la rimozione del cadavere Masci. Egli, riferisce la teste, aveva <strong>il</strong> corpo crivellato di proiett<strong>il</strong>i ... era<br />
stato oggetto di percosse a sangue tanto che sul viso si notavano i segni di gravi sofferenze ... giungendo al<br />
punto di strappargli i testicoli e <strong>il</strong> pene: sembra che allo scopo fosse stato adoperato del f<strong>il</strong>o di ferro a cappio».<br />
Seguono i nomi e le descrizioni dei componenti del plotone di esecuzione e di un paio di traditori che caldeggiarono<br />
l’azione. Ma l’oblio di Stato impedì la giustizia. A Capistrello vennero massacrati 33 civ<strong>il</strong>i (p. 20).<br />
scomparsi a Reggio Em<strong>il</strong>ia - lost and Not found 5<br />
Lapide a ricordo dei bombardamenti del 7 e 8 gennaio 44 (261 morti e 256 feriti) che colpirono la<br />
stazione, le Reggiane, l’Ospedale Psichiatrico San Lazzaro, l’ospedale Santa Maria Nuova che si<br />
trovava allora nell’odierna via Dante, nel luogo dove oggi sorge la Questura. La targa era stata<br />
posta nel gennaio del 54, a 10 anni dall’evento, nel piazzale della stazione, piazzale Marconi. Oggi<br />
non c’è più.<br />
USO E ABUSO DELLA RESISTENZA<br />
L’attentato di Via Rasella e la conseguente strage alle Fosse Ardeatine fra ricerca storiografica e polemica politica.<br />
Di Roberto Marcuccio, bibliotecario presso la Biblioteca Municipale Paniizzi di Reggio Em<strong>il</strong>ia.<br />
Nel campo della vasta pubblicistica dedicata negli ultimi anni alla Resistenza, spicca ora un volumetto in cui a<br />
prendere la parola è un protagonista: <strong>il</strong> partigiano romano Rosario Bentivegna. Via Rasella. La storia mistificata<br />
è <strong>il</strong> significativo titolo del libro, pubblicato da Manifestolibri all’inizio del 2006, in cui, dopo un’articolata introduzione<br />
dello storico Sergio Luzzatto, Bentivegna puntualizza alcuni non secondari dettagli della sua esperienza<br />
nella Resistenza romana, alla luce delle affermazioni contenute in due degli innumerevoli volumi del<br />
giornalista Bruno Vespa. E proprio al carteggio intercorso fra Bentivegna e Vespa, tra <strong>il</strong> dicembre 2004 e <strong>il</strong><br />
giugno 2005, è dedicata la parte centrale del volume, che si chiude con un’appendice documentaria su La Resistenza<br />
di Roma, “città ribelle”.<br />
Il volume di Bentivegna - autore anche di Achtung Banditen, una più ampia opera dedicata all’argomento - nasce<br />
dunque da una polemica contingente, ma coglie questa occasione per offrire un contributo di valore non<br />
effimero al lungo e a volte ster<strong>il</strong>e dibattito pro o contro la Resistenza italiana o singoli episodi di essa.
Nei due volumi Storia d’Italia da Mussolini a Berlusconi e Vincitori e vinti, Vespa aveva ricordato due fra i più<br />
noti e tragici episodi della Resistenza: l’attentato di Via Rasella a Roma, dove <strong>il</strong> 23 marzo 1944 un commando<br />
di dodici partigiani aveva attaccato una compagnia dello SS Polizei Regiment Bozen, uccidendo trentatré m<strong>il</strong>itari,<br />
e la strage delle Fosse Ardeatine del giorno successivo, in cui, alle porte di Roma, i nazisti agli ordini di<br />
Herbert Kappler trucidarono 335 ostaggi, fra antifascisti e cittadini di origine ebraica.<br />
Le critiche di Vespa a Bentivegna e ai partigiani romani non sono nuove, ma riprese senza alcuna verifica -<br />
come dimostrano Luzzatto e lo stesso Bentivegna - da precedenti polemiche di stampo revisionista. Afferma<br />
Vespa che, dopo l’episodio di Via Rasella, da lui giudicato “un gravissimo errore”, <strong>il</strong> comando tedesco diffuse<br />
appelli agli autori dell’attentato, affinché si consegnassero per evitare rappresaglie. In realtà questa intimazione<br />
non ci fu e la strage delle Fosse Ardeatine si svolse in gran segreto e senza alcun preavviso, come ha dimostrato<br />
Alessandro Portelli nel suo volume, giudicato “splendido” da Bentivegna, dal titolo L’ordine è già stato<br />
eseguito. Altra affermazione di Vespa è <strong>il</strong> giudizio negativo di Alcide De Gasperi e dello stesso CLN (Comitato<br />
di liberazione nazionale) sull’attentato di Via Rasella. Si sa invece che De Gasperi nel 1950 insignì Bentivegna<br />
e Franco Calamandrei, che aveva guidato l’attacco con Carlo Salinari, della medaglia d’argento al valor<br />
m<strong>il</strong>itare e <strong>il</strong> CLN, con <strong>il</strong> comunicato del 28 marzo 1944, aveva definito l’attacco di Via Rasella un “atto di guerra”<br />
di “patrioti italiani”. Il terzo argomento polemico di Vespa verte sull’identità dei m<strong>il</strong>itari tedeschi colpiti in Via<br />
Rasella: non “un reparto scelto e spavaldo”, quindi degno bersaglio di un’azione di guerra, ma soldati italiani,<br />
in quanto di origine altoatesina, fra cui quarantenni e cinquantenni padri di famiglia. Secondo Luzzatto, Vespa<br />
sembra ignorare quanto appurato dalla recente storiografia e cioè che le deportazioni, le torture e le stragi<br />
perpetrate dalle forze m<strong>il</strong>itari tedesche furono eseguite, indistintamente, da giovani e anziani, soldati semplici<br />
e ufficiali, m<strong>il</strong>itari della prima ora e riservisti, membri della Wehrmacht e delle SS, e da uomini delle più diverse<br />
nazionalità: lituani e polacchi, ungheresi e croati, altoatesini e italiani. Tutto questo per chiarire lo svolgimento<br />
di due episodi cruciali della Resistenza italiana e tutelare, come legittimamente chiede Bentivegna, la propria<br />
onorab<strong>il</strong>ità di uomo e di partigiano. In realtà Luzzatto, parlando di “dialogo fra sordi”, bene dimostra come le<br />
risposte di Vespa eludano le richieste di chiarimento di Bentivegna, in quanto <strong>il</strong> partigiano romano, pur protagonista<br />
dell’episodio<br />
di cui si parla, fa uno sforzo di obiettività, mentre <strong>il</strong> giornalista televisivo “cerca di ricacciarlo indietro, vuole rinchiuderlo<br />
nella gabbia del passato con argomenti che pertengono alla memoria, alla politica, alla morale, a tutto<br />
fuorché alla storia” (p. 10).<br />
Il valore di questo libro va però - come già accennato - al di là dei pur importanti episodi da cui prende le mosse.<br />
È un’occasione preziosa per cercare di chiarire questioni di fondo, relative al significato e agli obiettivi della<br />
Resistenza.<br />
Citando Bentivegna, Luzzatto propone, a proposito della dinamica azione/reazione che avrebbe legato Via<br />
Rasella e le Fosse Ardeatine, un’interessante osservazione, che parte dalla critica all’uso stesso del termine<br />
“rappresaglia” per stragi come quelle delle Fosse Ardeatine o di Marzabotto. “Come se davvero - scrive Luzzatto<br />
-, per qualificare tali eventi, non esistessero altre parole che quelle tratte dal vocabolario dei carnefici. E<br />
come se impiegare la terminologia degli aguzzini non rischiasse di legittimarne la logica, suggerendo<br />
l’esistenza di una correlazione diretta fra l’attentato quale causa efficiente e l’eccidio quale risposta necessaria”<br />
(p. 12).<br />
Cediamo ora la parola a Bentivegna, che puntualizza <strong>il</strong> contesto in cui fu progettato ed eseguito l’attacco di Via<br />
Rasella e ritorna anch’egli sul concetto di “rappresaglia”.<br />
“L’azione di Via Rasella - scrive Bentivegna - non fu l’atto isolato di uno o più fanatici comunisti, ma va inquadrata<br />
nella storia della Resistenza a Roma e nell’intero Lazio, del controllo assunto dai partigiani su interi quartieri<br />
come Centocelle, Torpignattara, <strong>il</strong> Quadraro, ecc. e poi in quella fase critica attraversata dopo lo sbarco di<br />
Anzio dai combattenti della libertà, molti dei quali uscirono allo scoperto, vennero arrestati, torturati, uccisi dalle<br />
SS di Herbert Kappler a via Tasso, alle pensioni romane Oltremare e Jaccarino dalla Banda Koch, alla Questura<br />
di Roma dagli scherani di Pietro Caruso, a Palazzo Braschi e nelle sedi delle varie organizzazioni repubblichine<br />
(Legione Muti, Roma o morte, ecc.), a Forte Bravetta, alle Fosse Ardeatine, nelle strade e nelle piazze<br />
della città, alla Storta, nei paesi e sulle montagne del Lazio: dovunque capitava” (p. 31).<br />
Facendo riferimento alle teorizzazioni del feldmaresciallo Albert Kesselring, Bentivegna dimostra come le<br />
“rappresaglie” svolgessero una funzione ben precisa per impedire e indebolire la lotta partigiana. Lo stesso<br />
Giorgio Amendola, comandante delle brigate Garibaldi nell’Italia centrale e membro della giunta m<strong>il</strong>itare del
CLN, aveva affermato, come ricorda lo stesso Vespa, che “accettare <strong>il</strong> ricatto delle rappresaglie voleva dire<br />
rinunciare in partenza alla lotta” (p. 39). La stessa prospettiva dello scambio fra i responsab<strong>il</strong>i delle azioni partigiane<br />
e la vita di prigionieri innocenti era stata presa in esame da Bentivegna in Achtung Banditen e meditatamente<br />
esclusa. “Tante volte, da quei giorni in poi - scrive Bentivegna citando l’ultima edizione di quel volume<br />
-, ci siamo domandati - o ci è stato chiesto - che cosa avremmo fatto se <strong>il</strong> nemico avesse accettato le nostre<br />
vite in cambio di quelle dei nostri compagni che giacevano nelle loro carceri. […]. Oggi noi sappiamo che era<br />
nostro dovere non presentarci a un bando del nemico che ci avesse offerto la vita degli ostaggi in cambio della<br />
nostra; sappiamo anche che avremmo scatenato una battaglia furiosa, a costo di morire tutti, per strappare al<br />
nemico le vittime che già aveva designato. Avremmo certo ottenuto l’appoggio dei romani, e in particolare dei<br />
famigliari e degli amici dei carcerati, le vittime più probab<strong>il</strong>i, cioè, del minacciato massacro” (p. 40).<br />
La “guerra ai civ<strong>il</strong>i”, ricorda Bentivegna, non era una risposta alle azioni partigiane, ma una precisa strategia,<br />
elaborata dal generale tedesco W<strong>il</strong>helm von Keitel nei Balcani e poi messa in atto anche in Grecia e in Italia<br />
per spingere le popolazioni civ<strong>il</strong>i ad opporsi ai partigiani. La stessa strage delle Fosse Ardeatine aveva questo<br />
scopo, ma raggiunse l’effetto opposto di avvicinare ancora di più la popolazione alle formazioni partigiane.<br />
Interessante e originale questo “dialogo fra sordi” tra <strong>il</strong> partigiano ultraottuagenario e <strong>il</strong> sessantenne giornalista<br />
televisivo. Ad un tempo razionale e ancora appassionato <strong>il</strong> primo, teso a comprendere e far comprendere<br />
un’esperienza che, posta sul solo piano della soggettività, risulta probab<strong>il</strong>mente “indicib<strong>il</strong>e”. Freddo e misurato<br />
<strong>il</strong> secondo, attento a non esporsi troppo alle circostanziate contestazioni dell’interlocutore, ma fermo nel ribadire,<br />
oltre alle proprie legittime opinioni, una lettura della Resistenza tutta politica e proiettata sulle polemiche dei<br />
nostri giorni.<br />
La Resistenza, come ogni altra vicenda storica, deve essere libero campo di indagine, interpretazione e lettura,<br />
ma dovrebbe ormai essere appurato che non tutti i combattenti di quella “guerra civ<strong>il</strong>e” furono sullo stesso<br />
piano. Da un lato <strong>il</strong> CLN, le formazioni partigiane di ogni colore politico e i reparti m<strong>il</strong>itari fedeli al governo Badoglio,<br />
legittimo rappresentante di ciò che rimaneva dello Stato italiano, dall’altro la Repubblica sociale italiana,<br />
istituzione <strong>il</strong>legale che appoggiava l’invasore tedesco e quasi gareggiava con esso in efferata crudeltà.<br />
È questo, crediamo, l’accorato appello che si leva dal libro: accettare la logica della “rappresaglia” come atto in<br />
qualche modo conseguente o comprensib<strong>il</strong>e vuole dire, oggi come ieri, accettare la legge dei carnefici, operare<br />
una progressiva e devastante assuefazione al terrore.<br />
Poi errori, deviazioni e delitti non mancarono, purtroppo, nemmeno da parte di partigiani o sedicenti tali ma,<br />
come ricorda Bentivegna citando in chiusura del volume le parole dell’antifascista Vittorio Foa al missino Giorgio<br />
Pisanò: “la differenza di fondo tra noi e voi è che siccome ho vinto io, tu sei legittimamente senatore della<br />
Repubblica, se invece avessi vinto tu, io sarei ancora in galera” (p. 100).<br />
COME CREARE L’OBLIO<br />
Un estratto dal discorso “Pàvidi s<strong>il</strong>enzi e coraggio della verità“ di Bruno Segre, tenuto al convegno “Auschwitz:<br />
<strong>il</strong> s<strong>il</strong>enzio di dio, <strong>il</strong> s<strong>il</strong>enzio dell’uomo“, organizzato dalla rivista “Qol”, al Teatro Comunale di Novellara<br />
<strong>il</strong> 26 novembre 2006. L’intervento prende spunto dal discorso che <strong>il</strong> papa Benedetto XVI pronunziò alla fine del<br />
maggio di quest’anno visitando <strong>il</strong> campo di Auschwitz-Birkenau<br />
(...) Storica visita apostolica, questa, di un pontefice germanico al luogo-simbolo dello sterminio degli ebrei<br />
d’Europa perpetrato da coloro che governarono la Germania dal 1933 al 1945. Un’occasione forse irripetib<strong>il</strong>e che<br />
si offriva a Benedetto XVI per dichiarare in modo inequivoco, nella duplice veste di sovrano pontefice e di un tedesco<br />
cresciuto in Germania ai tempi di Hitler, l’intenzione di fare luce piena su un passato di demonizzazioni e<br />
violenze feroci, e di dare sostanza e anima a un futuro di rapporti rispettosi, riconc<strong>il</strong>iati e creativi tra ebrei e cattolici<br />
e tra ebrei e tedeschi.
In effetti, <strong>il</strong> messaggio che <strong>il</strong> papa diffonde da Auschwitz (...) si presenta come una macchina comunicativa a<br />
raggio molto ampio, ben congegnata, contenente una ricostruzione storica degli orrori estremi del regime nazista<br />
in termini tali da suscitare un sicuro consenso nelle opinioni tedesca e polacca (attraversata negli ultimi tempi,<br />
questa seconda, da una certa ripresa di antisemitismo cattolico), e a ottenere poi, anche, un minimo di gradimento<br />
in ambito ebraico. Un aspetto che balza subito all’occhio è che, anche quando parla di storia, <strong>il</strong> papa non dimentica<br />
mai d’essere un raffinato teologo: talché nel linguaggio che egli ut<strong>il</strong>izza, è diffic<strong>il</strong>e individuare un confine<br />
preciso tra teologia e storiografia. Per competenza, lascio volentieri ad altri <strong>il</strong> còmpito di esprimere un apprezzamento<br />
circa le visioni teologiche di Joseph Ratzinger, mentre preferisco restringere queste mie considerazioni a<br />
una valutazione delle sue analisi storiche.<br />
R<strong>il</strong>evo, in primo luogo, che ad Auschwitz Benedetto XVI parla in qualità di tedesco che ricorda la storia patria<br />
probab<strong>il</strong>mente al modo di altri tedeschi, cattolici e non cattolici, della sua età (non di tutti, però). Significativamente,<br />
là dove tratta dello sterminio degli ebrei assolve <strong>il</strong> proprio popolo da ogni responsab<strong>il</strong>ità, circoscrivendo le colpe<br />
a “un gruppo di criminali” che (sono parole sue) “raggiunse <strong>il</strong> potere mediante promesse bugiarde, in nome di<br />
prospettive di grandezza, di ricupero dell’onore della nazione e della sua r<strong>il</strong>evanza, con previsioni di benessere e<br />
anche con la forza del terrore e dell’intimidazione, cosicché <strong>il</strong> nostro popolo poté essere usato e abusato come<br />
strumento della loro smania di distruzione e di dominio”.<br />
Con <strong>il</strong> dire cose di questo genere, Ratzinger sottopone la vicenda storica del nazionalsocialismo a una palese<br />
forzatura. Non vi è infatti chi non ricordi le modalità dell’accesso di Hitler al potere, formalmente legali, ineccepib<strong>il</strong>i<br />
sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o giuridico, e quanto diffusa e convinta fosse, ancora dopo dodici anni, fino agli ultimi giorni dell’apr<strong>il</strong>e<br />
1945, la devozione delle masse popolari germaniche per <strong>il</strong> Führer. Vi furono, naturalmente, eccezioni in Germania,<br />
che proprio per questo acquistano uno straordinario significato morale, esemplare. Particolarmente degni<br />
d’ammirazione sono appunto quegli eroi tedeschi (socialdemocratici, comunisti, liberali, <strong>il</strong> gruppo cattolico della<br />
Rosa Bianca, persino alcuni schietti conservatori) che non si piegarono, anzi combatterono da isolati e clandestini<br />
la loro battaglia in difesa dell’onore della patria tedesca e della sua libertà, eroi che <strong>il</strong> papa, peraltro, si guarda<br />
bene dal menzionare - le uniche persone cui accenna sono, non a caso, <strong>il</strong> padre francescano polacco Maksym<strong>il</strong>ian<br />
Kolbe ed Edith Stein, la monaca carmelitana d’origine ebraico-tedesca, uccisa con <strong>il</strong> gas ad Auschwitz come<br />
ebrea (la cui santificazione, proclamata da Giovanni Paolo II nel 1998, suscitò, come tutti ricordiamo, polemiche<br />
piuttosto aspre da parte di ambienti ebraici). Ma al di là di ciò, <strong>il</strong> discorso del pontefice confligge con tutta<br />
l’impressionante mole di ricerche storiche degli ultimi anni, che hanno insistito sulla “banalità del male”. È un f<strong>il</strong>one<br />
che, sulle orme di Hannah Arendt, ascrive e risolve l’enormità della Shoah proprio all’interno della ‘normalità’<br />
dei carnefici, fedeli servitori dello Stato nazista e delle sue regole. È ben noto che nella Germania egemonizzata<br />
da Hitler funzionò un sistema di corresponsab<strong>il</strong>ità di tutti i ceti dirigenti che la storiografia ha chiarito al di là d’ogni<br />
dubbio; compresa l’adesione entusiastica e consapevole di gran parte della popolazione al regime e alle sue teorie<br />
razziali, prima fra tutte l’antisemitismo m<strong>il</strong>itante. La pervasività del nazismo e <strong>il</strong> consenso della masse plaudenti<br />
che ne assecondarono i disegni criminali costituisce una pagina dolorosa della memoria collettiva dei tedeschi<br />
di oggi.<br />
(...) Stupisce quindi che <strong>il</strong> papa tedesco non si mostri informato degli esiti cui è pervenuta su questa tematica la<br />
più recente e accreditata ricerca storiografica internazionale, e che non tenga in alcun conto la sensib<strong>il</strong>ità che<br />
oggi caratterizza, sui punti appena ricordati, le generazioni più giovani della sua Germania.<br />
Ancora maggiori perplessità suscita, poi, un’altra affermazione contenuta nell’allocuzione che <strong>il</strong> pontefice pronunzia<br />
ad Auschwitz: quella secondo la quale coloro che (parole sue) “si ritenevano i forti che avevano saputo impadronirsi<br />
del mondo” (ossìa i nazisti), con la Shoah “volevano, in fin dei conti, strappare anche la radice su cui si<br />
basa la fede cristiana, sostituendola definitivamente con la fede fatta da sé, la fede nel dominio dell’uomo, del<br />
forte”. In realtà, nel progetto di omicidio di massa elaborato dagli ideologi paganeggianti del nazionalsocialismo, <strong>il</strong><br />
cristianesimo non costituiva di certo un bersaglio significativo. Nel fondo, la politica hitleriana era segnata da una<br />
nettissima curvatura biologistica, alla luce della quale <strong>il</strong> popolo tedesco veniva visto come una sorta di mirab<strong>il</strong>e<br />
corpo organico, da curare e proteggere anche mediante l’impietosa amputazione delle parti infette, quelle “spiritualmente<br />
già morte”. In questo senso la soppressione del nemico, in particolare degli ebrei, era necessaria per<br />
garantire la sanità, la vita stessa del popolo tedesco, mentre l’attacco al cristianesimo per le sue radici ebraiche<br />
appariva, complessivamente, un obbiettivo del tutto trascurab<strong>il</strong>e.<br />
Come ho già detto, nell’allocuzione tenuta ad Auschwitz, Ratzinger incrocia volentieri <strong>il</strong> piano storiografico con<br />
quello teologico. L’approccio è tale che i due piani ora si separano, ora si collegano e si confondono. Per esem-
pio, l’invocazione che <strong>il</strong> papa eleva già nelle prime battute del suo testo: “Perché, Signore, hai taciuto? Perché<br />
hai potuto tollerare tutto questo?” e, più avanti, la lunga citazione dal Salmo 44 con <strong>il</strong> lamento dell’Israele sofferente<br />
(“Svégliati, perché dormi, Signore? Déstati, non ci respingere per sempre!”) sovrastano fino quasi ad annullarle<br />
la dimensione umana, le responsab<strong>il</strong>ità concrete di uomini in carne e ossa, di quegli uomini che “hanno fatto<br />
la storia”. E con <strong>il</strong> ridurre <strong>il</strong> male a un’offesa alla divinità, in sostanza a una mera astrazione, scarnificano la tragedia<br />
del nazismo e dell’antisemitismo sino a rendere vana ogni interrogazione sul male e le sue radici.<br />
Il nazismo sarà pure stato - come Benedetto XVI preferisce intendere - l’amplificazione, sia pure estrema e degenerata,<br />
della “fede nel dominio dell’uomo”: un eccesso assoluto di orgoglio terreno, di fiducia nelle capacità<br />
degli uomini di “fare da sé”. Ma <strong>il</strong> proporre l’immagine del nazismo come quella di una sorta di peccato teologico,<br />
apre inevitab<strong>il</strong>mente varchi a una tentazione ‘totalizzante’, che alla fin fine diventa assolutoria.<br />
Insomma, <strong>il</strong> pontefice tedesco non può ignorare che l’hitlerismo e lo sterminio degli ebrei d’Europa furono mali<br />
storici, esiti di volontà e di scelte umane; che nell’attuazione della Shoah vi furono carnefici e vi furono vittime,<br />
sempre e tutte umane, m<strong>il</strong>ioni di corpi straziati, torturati, massacrati. In questo discorso papale - che, animato da<br />
una sorta di “eccedenza teologica”, sarà ricordato più per le reticenze e le omissioni che per le cose effettivamente<br />
dette - non compare mai la parola ‘antisemitismo’, così come risultano totalmente dimenticate le vittime omosessuali,<br />
che nei campi di sterminio furono molte, né si fa cenno al m<strong>il</strong>ione e mezzo di bambini e alle migliaia di<br />
portatori di handicap torturati ed eliminati. Si reitera, come abbiamo visto, la domanda su dove fosse Dio - una<br />
domanda ardua, destinata a rimanere senza risposta -, mentre non si formulano mai i quesiti più fac<strong>il</strong>i e ovvii:<br />
Dov’era la Chiesa ad Auschwitz?<br />
Quali motivazioni spinsero <strong>il</strong> lontano predecessore Pacelli a mantenersi generalmente s<strong>il</strong>enzioso assieme a larga<br />
parte della cristianità? E quali furono, se vi furono, le responsab<strong>il</strong>ità della Chiesa cattolica nel sostegno s<strong>il</strong>enzioso<br />
al regime di Hitler e nella persecuzione degli ebrei? (...)<br />
IL CARCERE DEI SERVI E VILLA CUCCHI<br />
Due importanti luoghi della memoria antifascista di Reggio Em<strong>il</strong>ia vittime dell’oblio (da: Giannetto Magnanini,<br />
“Vicolo dei Servi”, Magisbook, 1995).<br />
Il Carcere dei Servi era collocato nella parte meridionale del Convento dei Serviti, più volte ristrutturato. Nel<br />
1797 adibito a caserma, dal 1820 affidato in parte ai Padri Minori osservanti. Dall’autunno 1943 adibito a Carcere<br />
politico (quello Giudiziario era in S. Tommaso, dove è rimasto fino alla costruzione dell’attuale Carcere di<br />
via Settembrini). Dalla primavera 1944 alla Liberazione <strong>il</strong> maresciallo della GNR (Guardia Nazionale Repubblicana)<br />
Giuseppe Sidoli è responsab<strong>il</strong>e delle guardie. Arrestato dopo la Liberazione viene ucciso nell’attiguo<br />
Manicomio Giudiziario alla metà del maggio 1945. Nel carcere dei Servi i prigionieri, ammassati in alcun stanzoni,<br />
superarono anche le 100 unità. In totale furono imprigionati almeno 500 resistenti o sospetti di collaborare<br />
con i partigiani, molti dei quali malmenati e costretti a vivere in condizioni durissime.<br />
“La lunga scala, a muro pieno, ove a ogni<br />
pianerottolo stazionavano uno o due m<strong>il</strong>iziani, costoro con la bandoliera appesantita dai caricatori, mi scaraventarono<br />
sul capo una gragnuola di sventole aprendomi in più punti <strong>il</strong> cuoio capelluto… un vigliacco, alla fine<br />
della scala, mi inflisse sulla schiena una grave botta con <strong>il</strong> moschetto”.<br />
(P. Fornaciari, Testimonianze, Edizioni Em<strong>il</strong>ia Romagna, 1981).<br />
Dopo parecchie ore di interrogatorio al quale si susseguirono diversi interroganti, fui accompagnato alle carceri<br />
dei Servi da due italiani al servizio dei tedeschi. La mia prima impressione di questa prigione fu catastrofica:<br />
nel cort<strong>il</strong>e vi erano, in assetto di guerra, una decina di m<strong>il</strong>iti della guardia nazionale repubblicana fascista. Con
modi che non si possono dire urbani, fui portato al primo piano in un ufficio dove feci conoscenza con <strong>il</strong> comandante<br />
mar. Sidoli ed <strong>il</strong> suo vice Colla. Questi due fascisti avevano nomea di aguzzini, mi trattarono con<br />
spavalderia, ma senza infierire sul mio fisico già sufficientemente provato. Comp<strong>il</strong>arono una scheda con le mie<br />
generalità ed <strong>il</strong> motivo per <strong>il</strong> quale ero stato arrestato. Espletate tutte le formalità fui portato in una cella larga<br />
circa tre metri posta al piano terra del carcere dove rimasi solamente alcune ore. Fui riportato ad altro interrogatorio<br />
dai tedeschi. Al ritorno in prigione fui trasferito dalla cella di isolamento in altra al primo piano dove rimasi<br />
assieme ad altri carcerati i cui nomi, ad eccezione di un certo Gamella non ricordo. Dopo alcuni giorni fui<br />
trasferito nuovamente al piano terreno in un grande ambiente che in passato servì all’esercito italiano come<br />
stalla per cavalli e muli. Questo grande ambiente era attorniato da soppalchi dove i prigionieri, ed erano tanti,<br />
dovevano trascorrere le giornate di prigionia. Il cibo era scarso, pessimo e quasi vomitevole, i servizi igienici<br />
erano inesistenti. Ogni necessità corporale doveva essere soddisfatta in un solo recipiente in legno maleodorante.<br />
I ratti da fogna erano numerosissimi, grossi e aggressivi. Ai prigionieri era data la possib<strong>il</strong>ità di passeggiare<br />
nel cort<strong>il</strong>e trenta minuti al giorno.<br />
Questa mezz’ora era concessa a gruppi di cinque detenuti alla volta i quali non potevano assolutamente parlare<br />
fra di loro. In una di tali passeggiate ebbi l’occasione di intravedere <strong>il</strong> reparto delle detenute che si trovava al<br />
primo piano. Fra tante donne riconobbi la madre di Morini Ubaldo (Caput) e la signora Morelli madre del Solitario,<br />
le quali, seppi poi, erano state arrestate come ostaggi nel tentativo e speranza che i relativi figli si costituissero.<br />
Sia Caput che Solitario erano riusciti a sfuggire all’arresto… Nella grande cella, oltre all’amico Varini,<br />
mio compagno di sventura, ebbi occasione di conoscere l’avv. Matteotti noto agricoltore di S. Valentino di Castellarano.<br />
Tale prigioniero era ritenuto far parte del servizio spionistico inglese operante in Italia…<br />
(testimonianza di Carlo Ferri - Fogli Tricolore)<br />
Gli interrogatori dei prigionieri, ad opera dell’UPI (Ufficio Polizia Investigativa), con al comando prima <strong>il</strong> capitano<br />
Cesare P<strong>il</strong>ati e poi <strong>il</strong> maggiore Att<strong>il</strong>io Tesei, si svolgevano prima presso <strong>il</strong> comando in via Monfenera poi<br />
dall’ottobre 1944 presso V<strong>il</strong>la Cucchi.<br />
Si costituisce un gruppo di addetti agli interrogatori e alla tortura che viene praticata sui prigionieri qui trasferiti<br />
dai Servi. A V<strong>il</strong>la Cucchi viene torturato anche Paolo Davoli che, in un tentativo di fuga, rimane gravemente<br />
ferito. Amputato di una gamba e nuovamente torturato sarà fuc<strong>il</strong>ato <strong>il</strong> 28 febbraio 1945 con altri nove antifascisti.<br />
Sotto le torture a V<strong>il</strong>la Cucchi muoiono i partigiani Aronte Catellani e Athos Piccinini.<br />
Il capitano P<strong>il</strong>ati fu condannato a morte dalla Corte di Assise Straordinaria di Reggio e fuc<strong>il</strong>ato <strong>il</strong> 3 ottobre 1945<br />
insieme a 4 m<strong>il</strong>iti torturatori a V<strong>il</strong>la Cucchi.<br />
Il maggiore Att<strong>il</strong>io Tesei, processato dalla Corte di Assise Straordinaria di Reggio Em<strong>il</strong>ia e condannato a morte<br />
sarà amnistiato e rimesso in libertà agli inizi degli anni cinquanta.<br />
“Fui arrestato <strong>il</strong> 2 dicembre 1944 da una squadra di 4 elementi capitanata da un individuo di robusta costituzione,<br />
dal viso rotondo. Lo riconoscerei se lo vedessi. Fui portato subito a V<strong>il</strong>la Cucchi, mi fu intimato l’arresto<br />
dal magg. Tesei e fui interrogato da Cocconi Giuseppe [recte: F<strong>il</strong>ippo] dell’UPI. L’iterrogatorio durò tutto <strong>il</strong> pomeriggio:<br />
mi si prese tutto quanto avevo in tasca (denari e oggetti). Verso le ore 21 fui consegnato alla “squadra<br />
dei torturatori”: c’era Zanichelli Dino ed altri che non conosco. Non mi pare che ci fosse quello che mi aveva<br />
arrestato. Mi furono ammanettate le mani dietro la schiena e fui disteso su un tavolino basso in modo che<br />
dalle reni in su sporgessi dal tavolino e con una corda legata dietro le spalle mi costrinsero la testa verso terra.<br />
Ciò mi provò la congestione immediata. Fui tenuto così fino alle 2, salvo vari intervalli durante i quali mi slegavano<br />
la testa per farmi parlare.<br />
Durante <strong>il</strong> periodo in cui ero a testa bassa e non potevo vedere chi dei presenti mi torturasse mi si scottarono i<br />
piedi ed altre parti del corpo non so se con un ferro caldo o con carta accesa. Mi fu versato olio bollente<br />
sull’inguine, mi strapparono parte dei peli dell’inguine, mi furono compresse le costole. Dopo le 2 fui slegato e<br />
poi ammanettato con la mano sinistra al ferro di una branda. Al mattino riprese l’interrogatorio che fu continuato<br />
fino alle 4 o 5 del pomeriggio. Verso le ore 19 fui portato a S. Tommaso”.<br />
(Testimonianza di Carlo Calvi al processo Tesei, 1946)
“L’arrestato Berti (di Reggio Em<strong>il</strong>ia) era presente a diversi interrogatori da me subiti alla famosa “V<strong>il</strong>letta” ed<br />
egli stesso si adoperò nell’opera barbara della tortura su di me, imbavagliandomi, percuotendomi dopo avermi<br />
spogliato di ogni veste. Con sfacciataggine inumana mi tormentava sia con atti morali che materiali - diceva lui<br />
per farmi “cantare” - senza rispetto e pudore verso <strong>il</strong> mio sesso. Fu inoltre uno dei più infervorati aguzzini<br />
quando si trattò di sottoporre <strong>il</strong> mio nudo corpo alla passione di un cane (Argo) che <strong>il</strong> capo dei sadisti-magg.<br />
Tesei aveva ammaestrato per così losche e schifose operazioni. Da un numero molto elevato di compagni ebbi<br />
la certezza che costui era fra i più vigliacchi torturatori della “V<strong>il</strong>letta”. Egli confessò in mia presenza che<br />
chiese ai suoi superiori di avere le mie pratiche nelle sue mani poiché -“dato che io non volevo parlare” - mi<br />
avrebbe decisa a parlare con certi metodi scientifici di tortura, che lui stesso aveva escogitato”.<br />
(Testimonianza di Boniburini Clarice Tina al processo Tesei, 1946)<br />
Reggio Em<strong>il</strong>ia, 29 settembre 1943, mattina, ore 9.30. E’ un martedì e c’è mercato, nonostante la guerra, nonostante<br />
i tedeschi, nonostante i fascisti che rialzano la testa a fianco degli alleati uncinati. Un uomo con <strong>il</strong> cappello e un soprabito<br />
bianco attraversa la piazza delle adunate, la piazza d’armi, <strong>il</strong> cuore pulsante di Reggio Em<strong>il</strong>ia. Cammina veloce,<br />
ma non troppo. Disinvolto, ma attento. Guarda in alto… Laudato sii mi signore per tutte le tue creature… Non<br />
tutte, pensa, non tutte. E San Francesco lo accoglie, la canonica lo accoglie, strano perché lui con la chiesa non è<br />
molto in confidenza. In canonica ad attenderlo ce ne sono altri, non è arrivato per primo: Don Lorenzo gli stringe la<br />
mano e lo conduce in una stanza con un tavolo e sulle sedie massicce son seduti Marzi, Franceschini, Reggiani e<br />
Ariosto. E poi lui, Fossa. Un prete, un comunista, un cattolico, un socialista e un azionista che non vuol dire che<br />
c’ha i soldi, vuol dire che appartiene al Partito D’Azione. Lui, Fossa, l’azionista assume la presidenza perché <strong>il</strong> cattolico,<br />
<strong>il</strong> comunista, <strong>il</strong> prete e i socialista glielo chiedono. E quell’uomo che corre svelto ma non troppo, attento ma disinvolto<br />
in mezzo alla gente che va al mercato nonostante la guerra, i tedeschi e i fascisti che non cambiano mai e<br />
stanno sempre con Hitler, lui, Fossa legge un foglio sott<strong>il</strong>e, trasparente e stropicciato su cui è scritto:<br />
1. accantonare provvisoriamente le ideologie dei singoli partiti per coordinare, animare e dirigere unitariamente gli<br />
sforzi di tutti coloro che intendono dare le loro energie per la riconquista della indipendenza dallo straniero e delle<br />
libertà perdute con <strong>il</strong> fascismo;<br />
2. lottare uniti fino alla fine, anche a rischio della vita, col proposito di instaurare un ordinamento democratico ed un<br />
assetto sociale di più alta giustizia;<br />
3. agire col solenne vincolo del segreto e con piena dedizione alla causa comune;<br />
4. prendere contatto con gli analoghi organi che fossero costituiti nelle province vicine e con <strong>il</strong> CLN che la radio annuncia<br />
essersi costituito a Roma.<br />
Il prete approva, <strong>il</strong> cattolico avvocato con la barba da missionario anche, così come <strong>il</strong> comunista che ha ancora negli<br />
occhi le truppe tedesche che marciano su Parigi occupata e poi Stalingrado che è arrivata, e <strong>il</strong> ghiaccio ha iniziato<br />
a sciogliersi sotto gli scarponi chiodati dei nazisti in fuga. Stalingrado non crolla. Il socialista approva anche lui e,<br />
assieme al presidente, si alza nel s<strong>il</strong>enzio. Poi via, alla spicciolata. Via dalla canonica di San Francesco che aveva<br />
dischiuso le braccia, le porte per loro. Chissà se lo sapevano che lì iniziava tutto, chissà se lo sapevano e gli tremavano<br />
le gambe: c’era da combattere adesso. Trovare le armi, fare crescere le forze, formare e informare, creare <strong>il</strong><br />
movimento. La Resistenza.<br />
scomparsi a Reggio Em<strong>il</strong>ia - lost and Not found 6<br />
Il Carcere dei Servi, abbattuto alla metà degli anni ’60 per fare spazio al parcheggio del Palazzotto dello<br />
Sport (1967). I cardini raccontano ancora dov’era l’inresso…
scomparsi a Reggio Em<strong>il</strong>ia - lost and Not found 7<br />
Targa a ricordo della prima riunione del CLN<br />
posta all’interno della Canonica della chiesa di San Francesco, all’esterno della stanza in cui avvenne<br />
l’incontro clandestino. Oggi è stata tolta.<br />
Reggio Em<strong>il</strong>ia, 29 settembre 1943, mattina, ore 9.30. E’ un martedì e c’è mercato, nonostante la guerra,<br />
nonostante i tedeschi, nonostante i fascisti che rialzano la testa a fianco degli alleati uncinati. Un<br />
uomo con <strong>il</strong> cappello e un soprabito bianco attraversa la piazza delle adunate, la piazza d’armi, <strong>il</strong> cuore<br />
pulsante di Reggio Em<strong>il</strong>ia. Cammina veloce, ma non troppo. Disinvolto, ma attento. Guarda in alto…<br />
Laudato sii mi signore per tutte le tue creature… Non tutte, pensa, non tutte. E San Francesco lo<br />
accoglie, la canonica lo accoglie, strano perché lui con la chiesa non è molto in confidenza. In canonica<br />
ad attenderlo ce ne sono altri, non è arrivato per primo: Don Lorenzo gli stringe la mano e lo conduce<br />
in una stanza con un tavolo e sulle sedie massicce son seduti Marzi, Franceschini, Reggiani e Ariosto.<br />
E poi lui, Fossa. Un prete, un comunista, un cattolico, un socialista e un azionista che non vuol<br />
dire che c’ha i soldi, vuol dire che appartiene al Partito D’Azione. Lui, Fossa, l’azionista assume la<br />
presidenza perché <strong>il</strong> cattolico, <strong>il</strong> comunista, <strong>il</strong> prete e i socialista glielo chiedono. E quell’uomo che corre<br />
svelto ma non troppo, attento ma disinvolto in mezzo alla gente che va al mercato nonostante la<br />
guerra, i tedeschi e i fascisti che non cambiano mai e stanno sempre con Hitler, lui, Fossa legge un foglio<br />
sott<strong>il</strong>e, trasparente e stropicciato su cui è scritto:<br />
1. accantonare provvisoriamente le ideologie dei singoli partiti per coordinare, animare e dirigere unitariamente<br />
gli sforzi di tutti coloro che intendono dare le loro energie per la riconquista della indipendenza<br />
dallo straniero e delle libertà perdute con <strong>il</strong> fascismo;<br />
2. lottare uniti fino alla fine, anche a rischio della vita, col proposito di instaurare un ordinamento democratico<br />
ed un assetto sociale di più alta giustizia;<br />
3. agire col solenne vincolo del segreto e con piena dedizione alla causa comune;<br />
4. prendere contatto con gli analoghi organi che fossero costituiti nelle province vicine e con <strong>il</strong> CLN<br />
che la radio annuncia essersi costituito a Roma.<br />
Il prete approva, <strong>il</strong> cattolico avvocato con la barba da missionario anche, così come <strong>il</strong> comunista che<br />
ha ancora negli occhi le truppe tedesche che marciano su Parigi occupata e poi Stalingrado che è arrivata,<br />
e <strong>il</strong> ghiaccio ha iniziato a sciogliersi sotto gli scarponi chiodati dei nazisti in fuga. Stalingrado non<br />
crolla. Il socialista approva anche lui e, assieme al presidente, si alza nel s<strong>il</strong>enzio. Poi via, alla spicciolata.<br />
Via dalla canonica di San Francesco che aveva dischiuso le braccia, le porte per loro. Chissà se lo<br />
sapevano che lì iniziava tutto, chissà se lo sapevano e gli tremavano le gambe: c’era da combattere adesso.<br />
Trovare le armi, fare crescere le forze, formare e informare, creare <strong>il</strong> movimento. La Resistenza.<br />
A ricordo di: Vittorio Pellizzi, Fossa, azionista e primo Prefetto della Liberazione; Cesare Campioli,<br />
Marzi, comunista e primo Sindaco della Liberazione; Don Prospero Simonelli, Reggiani, nel dopoguerra<br />
insegnante al Liceo Ariosto; Pasquale Marconi, Franceschini, cattolico poi democristiano, vice commissario<br />
delle formazioni della montagna, costituente; Alberto Simonini, socialista, nella direzione del<br />
quotidiano La Giustizia e per tre legislature deputato alla Camera per <strong>il</strong> PSLI. A ricordo dei componenti<br />
del CLN, Comitato di Liberazione Nazionale, organo politico della Resistenza reggiana, che si sono<br />
trovati nella canonica di San Francesco, in centro a Reggio Em<strong>il</strong>ia, accolti da un prete che così interpretava<br />
i valori della sua missione cristiana. A ricordo di questa prima riunione clandestina c’era una<br />
targa, posta all’ingresso della stanza in cui si svolse. Oggi quella piccola targa non c’è più, perché<br />
qualche parrocchiano che non si riconosceva nella Resistenza “fatta dai comunisti” la trovava fastidiosa.<br />
E così un prete accondiscendente, che temeva di perdere qualche pecorella, l’ha tolta. Così, un<br />
giorno, perché dava fastidio. E chissà dov’è andata a finire. Laudato sii mi signore con tutte le tue creature…<br />
non proprio tutte, però.<br />
a/c de L’Agnese
Scomparsi a Reggio Em<strong>il</strong>ia - lost and Not found 8<br />
Lapide apposta nei pressi della Caserma Zucchi e dedicata ad Angelo Zanti: comunista, componente<br />
del CLN di Reggio Em<strong>il</strong>ia, ucciso dai fascisti e dai nazisti in quel luogo <strong>il</strong> 13 gennaio del<br />
1945.<br />
Oggi non c’è più ma sembra che sarà di nuovo esposta in occasione dell’anniversario<br />
dell’uccisione nel gennaio 2007.<br />
COLONIE E DOPOGUERRA<br />
TERZA PARTE: UNA MEMORIA DA COSTRUIRE<br />
Dove si racconta la difficoltà italiana a riconoscere i crimini coloniali del passato. Alcune pagine tratte dal libro<br />
di Antonella Randazzo “Roma Predona - Il colonialismo italiano in Africa” (Kaos Edizioni, 2006<br />
A partire dal 1945, con la caduta del fascismo e la fine della Seconda guerra mondiale, l'Italia tornò a essere<br />
un Paese senza colonie come all'inizio della sua storia unitaria. Anzi, in virtù del nuovo corso democratico pretese<br />
- senza molto successo - di assumere un ruolo nel processo di liberazione dei popoli colonizzati. Fin dal<br />
primo dopoguerra, invece di ammettere e condannare i crimini di Roma in Africa, la nuova Italia democratica si<br />
sforzò di alimentare un'idea positiva del passato coloniale italico. Portatrice di una concezione paternalistica<br />
analoga a quella che aveva connotato prima l'imperialismo della età liberale e poi la dittatura fascista, la nuova<br />
Italia da un lato cancellò <strong>il</strong> passato, e dall'altro affermò di voler contribuire al progresso economico delle sue ex<br />
colonie africane, valorizzandone le risorse locali e salvaguardando gli interessi dei connazionali là residenti.<br />
Il primo passo della rimozione collettiva fu quello di impedire una valutazione critica dei fatti coloniali. Il generale<br />
Rodolfo Graziani, primo responsab<strong>il</strong>e e simbolo delle atrocità italiane in Etiopia, non venne mai estradato a<br />
Addis Abeba né condannato in Italia. Il generale Pietro Badoglio, tra i massimi responsab<strong>il</strong>i delle aggressioni<br />
coloniali, arrivò a scrivere nel suo diario:<br />
“Chiunque esamini senza preconcetti gli avvenimenti accaduti in Abissinia dal 1914 in poi deve onestamente<br />
riconoscere che le provocazioni partirono tutte da parte abissina... Oggi è venuto di moda in Italia dire peste<br />
dell'impresa abissina ma se noi non fossimo entrati in questa orrib<strong>il</strong>e guerra ed avessimo lavorato seriamente<br />
a pacificare ed a mettere in valore quei ricchi ed ampi territori chi oserebbe lanciare l'anatema contro quella<br />
conquista?”<br />
Il 6 maggio 1946 un Decreto del governo De Gasperi istituì, presso <strong>il</strong> ministero della Guerra (poi della Difesa),<br />
una Commissione d'inchiesta sui criminali di guerra italiani, attiva fino al 1948. L'impegno principale della<br />
Commissione fu quello di giustificare la mancata consegna dei criminali alla giustizia, accogliendone tutte le<br />
argomentazioni difensive senza eccezioni. Il numero stesso degli inquisiti andò assottigliandosi col passare<br />
del tempo: le richieste internazionali al governo italiano di estradizione dei criminali di guerra arrivarono a 295;<br />
nell'archivio parlamentare Luigi Gsparotto erano indicate 168 persone accusate di crimini di guerra.<br />
Il presidente del Consiglio Alcide De Gasperi aveva reso pubblico un elenco di 40 tra m<strong>il</strong>itari e civ<strong>il</strong>i accusati di<br />
aver violato le leggi del diritto internazionale di guerra compiendo crimini contro l'umanità. Nel corso del 1947
la Commissione governativa li aveva ulteriormente e definitivamente ridotti a 29, ma nemmeno costoro verranno<br />
mai processati in Italia per i crimini commessi in Africa (e in Jugoslavia).<br />
La sostanziale impunità per i criminali di guerra italiani fu garantita anche dalla connivenza degli Alleati, che<br />
intendevano salvaguardare personaggi come Badoglio e Graziani, importanti in funzione anticomunista nell'ambito<br />
della guerra fredda. Nel 1946 Jugoslavia e Etiopia protestarono per la mancata estradizione dei criminali<br />
italiani, ma <strong>il</strong> ministro degli Esteri britannico, lord Halifax, replicò: “L'arresto di alcuni elementi che hanno<br />
occupato alte cariche nel ministero della Guerra italiano provocherebbe un imbarazzo politico. Queste persone<br />
hanno aiutato in maniera esemplare gli Alleati. Arrestarli creerebbe uno shock tale nel governo italiano e nell'opinione<br />
pubblica che ci procurerebbe molti problemi e causerebbe un grande scontento”. Nell'occasione, <strong>il</strong><br />
ministro degli Esteri britannico riferì inoltre <strong>il</strong> parere americano: “Il Dipartimento di Stato considera che la migliore<br />
tattica per entrambi i governi [Londra e Washington, ndr] sia tentare di guadagnare tempo”.<br />
Nella primavera del 1948 si svolse l'ultima seduta della Commissione sui crimini di guerra delle Nazioni Unite.<br />
In totale, la Commissione aveva esaminato solo 10 casi tra le centinaia presentati dagli etiopici, rappresentati<br />
da un delegato svedese. Il primo caso vagliato fu quello del generale Badoglio, accusato di aver ut<strong>il</strong>izzato armi<br />
chimiche, e di aver bombardato ospedali della Croce rossa, durante la campagna d'Etiopia. Malgrado le resistenze<br />
inglesi, gli etiopici (sostenuti anche da Norvegia e Cecoslovacchia) riuscirono a convincere la Commissione<br />
internazionale a inserire Badoglio nella lista dei criminali di guerra col “grado A” (<strong>il</strong> massimo). Anche a<br />
Graziani venne attribuito <strong>il</strong> “grado A”, sulla base di 9 capi di imputazione, mentre altri 7 gerarchi e generali fascisti<br />
furono inclusi nella lista (Em<strong>il</strong>io De Bono, Alessandro Lessona, Alessandro Pirzio Biroli, Carlo Geloso,<br />
Sebastiano Gallina, Ruggero Tracchia, Guido Cortese).<br />
Delusi dai modesti risultati dell'inchiesta internazionale, gli etiopici organizzarono una Commissione nazionale<br />
di indagine sui crimini di guerra. E sulla base delle sue risultanze, Addis Abeba nel 1949 chiese all'Italia l'estradizione<br />
di Graziani e Badoglio, ricevendo in risposta un netto rifiuto. Il 17 settembre 1949 l'ambasciatore<br />
etiopico a Londra sottopose la questione al Foreign Office, e in risposta ottenne <strong>il</strong> consiglio di desistere.<br />
Nessun criminale della guerra italiana in Africa fu estradato. Quando morì, <strong>il</strong> generale Badoglio ottenne gli onori<br />
di un funerale di Stato. Il generale Graziani, invece, fu processato da un tribunale m<strong>il</strong>itare italiano, ma solo<br />
per le sue attività nella Repubblica sociale di Salò: <strong>il</strong> 2 maggio 1950 venne condannato a 19 anni di carcere, di<br />
cui 13 condonati, e quattro mesi dopo la sentenza tornò in libertà. Morì di morte naturale nel 1955, dopo aver<br />
svolto per anni un'intensa attività politica nei ranghi della destra neofascista italiana.<br />
La Commissione etiopica dichiarò gli ex governatori coloniali Carlo Geloso e Alessandro Pirzio Biroli criminali<br />
di guerra per la politica repressiva attuata nelle loro regioni (negli anni 1936-38 Geloso era stato governatore<br />
nella regione Galla Sidama, mentre nel biennio 1936-37 Pirzio Biroli era stato governatore dell'Amhara). Il generale<br />
Sebastiano Gallina per le violenze, i rastrellamenti, le uccisioni di cui furono protagoniste le sue truppe<br />
in Etiopia. Guido Cortese venne incriminato per l'ondata di terrore scatenata a Addis Abeba dopo l'attentato a<br />
Graziani del 19 febbraio 1937. Ruggero Tracchia per aver fatto fuc<strong>il</strong>are i fratelli Cassa (che si erano liberamente<br />
costituiti), dopo aver loro promesso salva la vita.<br />
La rimozione alimentò nuove tendenze imperialiste. Fra <strong>il</strong> 29 e <strong>il</strong> 31 gennaio 1946 si svolse a Firenze un convegno<br />
per riproporre sotto nuove forme <strong>il</strong> progetto neocoloniale. Intanto nelle ex colonie e in Italia nascevano<br />
giornali i quali riproponevano <strong>il</strong> tema coloniale in maniera propagandistica: “Riconquista”, “Difesa africana”,<br />
“Voci d'Africa” e “Vergogna!”. L'Italia coloniale non voleva rinunciare ai suoi possedimenti, così rispolverava<br />
vecchi temi per accampare nuove pretese, presentandosi come vittima di una guerra conclusasi con un sopruso<br />
(...).<br />
L'idea neocoloniale finì per improntare l'azione dei primi governi dell'Italia repubblicana. Il presidente del Consiglio<br />
Alcide De Gasperi avvallò <strong>il</strong> protrarsi della occupazione m<strong>il</strong>itare nei territori ex coloniali, e ingaggiò una<br />
dura battaglia diplomatica per impedire la ratifica dell'art. 17 del trattato di pace con l'Etiopia, articolo che toglieva<br />
a Roma la sovranità sulle colonie. E anche dopo la firma del trattato (10 Febbraio 1947), De Gasperi<br />
tentò di ottenerne una radicale revisione.
LA MEMORIA AMBIGUA DEGLI ITALIANI<br />
Di Nicola Labanca, Docente di Storia contemporanea e Storia dell'espansione europea all'Università di Siena.<br />
Da “la Repubblica” del 16 dicembre 2005<br />
Il protagonista del romanzo di Ennio Flaiano “Tempo di uccidere” (1947), ambientato nell’Africa orientale italiana<br />
al tempo della guerra d’Etiopia (1935-36), ama carnalmente una donna locale ma poi finisce per ucciderla.<br />
La sua memoria rimane indeleb<strong>il</strong>mente segnata da quella doppia esperienza, di fascinazione e repulsione, di<br />
amore e odio. Tornando in patria però solo una parte dell’esperienza viene ricordata: quella dell’amore,<br />
dell’affetto. Flaiano fa dire al suo protagonista: “Il prossimo è troppo occupato coi propri delitti per accorgersi<br />
dei nostri”. “Meglio così”, dissi. “Se nessuno mi ha denunciato, meglio così”. La memoria del delitto rimane in<br />
Africa, in Italia torna solo quella dell’affetto: nasce così <strong>il</strong> mito della “bravagente”.<br />
L’episodio di Flaiano potrebbe essere la chiave per comprendere la memoria nazionale del colonialismo italiano.<br />
Un’esperienza di dominio italiano durata grossomodo sessant’anni, dall’Eritrea (1882) alla Somalia, dalla<br />
Libia all’Etiopia. Una storia per quarant’anni liberale e per vent’anni fascista, bruscamente interrotta perché <strong>il</strong><br />
regime perse in guerra (1941-43) tutte le sue colonie. Di quella storia è rimasta una memoria nazionale fortemente<br />
ambigua, parziale. Solo una parte della storia è stata ricordata.<br />
Come tutti i colonizzatori europei, gli italiani amano ricordarsi e immaginarsi come “bravagente” affascinata<br />
dalle bellezze della natura africana, sinceramente interessata delle popolazioni dominate, prodiga di interventi<br />
in loro favore. È diffic<strong>il</strong>e negare che anche questo furono (ma quanto rispetto ad altri imperi coloniali? già a<br />
questa domanda non si vuole rispondere). Inoltre, un po’ come i francesi in Algeria e i britannici in Rhodesia o<br />
in Sudafrica, laddove poterono, gli italiani affollarono le loro colonie anche di povera gente, di lavoratori manuali,<br />
di petit blancs o poor whites come si diceva a Parigi o a Londra. L’Italia liberale e persino l’Italia fascista<br />
(se si esclude la conquista dell’Etiopia, 1935-41) esportarono nelle colonie molto più manodopera che capitale.<br />
Ma questa è solo una parte della storia.<br />
Chi ricorda <strong>il</strong> “regime delle sciabole” della primissima Eritrea italiana prima di Adua? O le deportazioni indiscriminate<br />
dei libici già nel 1911-12 verso le isole italiane come le Tremiti? O <strong>il</strong> sangue sparso nella “riconquista”<br />
della Libia voluta da Mussolini e condotta con brutalità da Badoglio e Graziani nel 1929-31? In particolare,<br />
chi ricorda i campi di concentramento della Cirenaica fra 1929 e 1933? (...) chi ricorda i massacri del convento<br />
copto di Debra Libanos, in cui Graziani fece sterminare l’elite religiosa etiopica?<br />
Non si tratta del s<strong>il</strong>enzio naturale della memoria di fronte a fatti sgradevoli, né è sufficiente lavarsi le mani dicendo<br />
che di fatti sgradevoli è piena tutta la storia del colonialismo europeo. Il punto è che senza quei fatti <strong>il</strong><br />
debole dominio italiano non ci sarebbe stato, non avrebbe potuto né instaurarsi né sostenersi. Non sono fatti<br />
aggiuntivi, sono sostanziali. Inoltre <strong>il</strong> dominio italiano fu, per vent’anni, fascista. Per capire cosa ciò significhi si<br />
legga <strong>il</strong> programma politico del fascio di Asmara già fra 1919 e 1922, o si ponga mente al fatto che nel 1937 -<br />
un anno prima dell’adozione della legislazione antisemita - <strong>il</strong> fascismo introdusse istituzionalmente nel suo impero<br />
la discriminazione razziale, come al tempo forse nemmeno <strong>il</strong> Sudafrica aveva fatto. Tutto questo, gli italiani<br />
dei decenni della Repubblica hanno preferito non ricordarlo, come <strong>il</strong> genio letterario di Flaiano aveva per<br />
tempo intuito.<br />
Quali le spiegazioni di questa memoria selettiva? È stato chiamato in causa <strong>il</strong> carattere nazionale degli italiani<br />
(sullo specifico coloniale già Benedetto Croce, nel 1927, aveva parlato di “bonomia” degli italiani…). Gli storici<br />
hanno spiegato che non aver vissuto le aspre divisioni che in Francia o in Gran Bretagna hanno accompagnato<br />
la decolonizzazione negli anni Cinquanta-Sessanta ha impedito una presa di coscienza ed un dibattito sul<br />
passato coloniale. C’è chi ha voluto trascinare in giudizio persino la sinistra, accusata prima di ambiguità (in<br />
effetti, per <strong>il</strong> prestigio nazionale, nel 1945-47 anche Pci e Psi volevano la restituzione all’Italia di tutte o parti<br />
delle vecchie colonie) e poi di “debolezza di anticolonialismo”.<br />
Forse, per trovare una risposta dobbiamo invece guardare in basso, in alto e al governo. In basso: perché le<br />
stesse responsab<strong>il</strong>ità storiche di lavoratori e popolani nonpossono essere uguagliate a quelle di un Mussolini o<br />
di un Graziani. In alto: perché le maggiori decisioni, come sempre, furono prese da una ristretta cerchia di governatori<br />
coloniali, funzionari, m<strong>il</strong>itari. Al governo: questo è, per l’Italia repubblicana, <strong>il</strong> capitolo più interessante.<br />
Nelle liste st<strong>il</strong>ate dalle potenze vincitrici della seconda guerra mondiale, non pochi politici e m<strong>il</strong>itari erano
accusati di crimini di guerra perpetrati nelle colonie. E nel 1947 l’Etiopia aveva richiesto alcuni alti gerarchi del<br />
fascismo, fra cui Badoglio e Graziani, per i crimini commessi in colonia. Ma l’Italia repubblicana e ormai democratica<br />
fece di tutto per non consegnarli. Graziani non affrontò mai un processo per i suoi misfatti coloniali, del<br />
1929-33 come del 1936-38. E se i tribunali dell’Italia democratica non processarono i massimi responsab<strong>il</strong>i politici<br />
e m<strong>il</strong>itari, perché i petit blancs dell’imperialismo demografico italiano avrebbero dovuto ritenersi responsab<strong>il</strong>i?<br />
La loro memoria fu aiutata a divenire parziale.<br />
Se nel 1947 non furono fatti i processi, se l’Italia democratica non ricorda pubblicamente i campi di concentramento<br />
in Cirenaica del 1929-33 (ma attenzione: in quelli del 1941 passarono anche gli ebrei libici) e se oggi<br />
l’Italia (…) restituisce l’obelisco di Axum all’Etiopia ma lo fa alla chetichella, perché obbligata, e non imposta un<br />
serio dibattito pubblico sul passato coloniale, se insomma così si fa in alto e al governo, perché in basso i<br />
combattenti della guerra d’Etiopia dovrebbero ricordare tutta la storia del colonialismo e non solo una sua parte?<br />
(...)<br />
RICORDARE, A CHE SERVE?<br />
UN INVITO ALLA RIFLESSIONE E ALL'IMPEGNO<br />
Di Aldo Pavia, presidente Aned Roma (Associazione nazionale Ex Deportati). Da Triangolo Rosso, Periodico<br />
dell'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti e della Fondazione Memoria della Deportazione<br />
(ottobre 2006). L’invito, qui rivolto dall’autore ai soci dell’Aned, crediamo sia a maggior ragione da estendere<br />
a chiunque abbia a cuore <strong>il</strong> rispetto della dignità umana.<br />
Sono sempre più convinto che la memoria sia, oggi più di ieri, uno degli aspetto fondamentali della conoscenza,<br />
senza la quale noi tutti e le nostre società si troverebbero a vivere, e rivivere, drammi e tragedie che la nostra<br />
speranza vorrebbe definitivamente relegate ai ricordi del passato.<br />
La memoria come esercizio di continua verifica del presente e come timone per le scelte del futuro.<br />
Come garanzia costante di quel Mai più, giuramento di ieri e impegno di sempre.<br />
Se così è - e credo che così sia e debba essere - mi pongo allora una domanda, forse retorica. Ma me la pongo.<br />
È sufficiente, può bastare a noi, all'Aned, la meritoria ed indefessa opera di testimonianza?<br />
Può bastare <strong>il</strong> ricordo della deportazione, dell'annientamento e dello sterminio da oltre mezzo secolo portata ai<br />
giovani e ai non più tali, senza che questa sia contestualizzata, senza che sia legata ad un impegno di azione<br />
identificab<strong>il</strong>e in un obiettivo?<br />
Non voglio qui e scorrettamente affermare che ciò non sia mai stato fatto, che l'impegno dell'Aned sia stato carente,<br />
che la nostra Associazione ed i suoi componenti abbiano latitato da impegni culturali, politici e sociali.<br />
Sarebbe affermare <strong>il</strong> falso. Tuttavia, personalmente sento che oggi, e sarebbe umanamente comprensib<strong>il</strong>e,<br />
noi ci si sia un poco adagiati sull'impegno della testimonianza, quasi questa fosse fine a se stessa. Mi piacerebbe<br />
che, soprattutto alle generazioni più giovani che si trovano ad affrontare società molto complesse, strade<br />
irte di difficoltà e ostacoli, percorsi confusi con alti rischi di imprevedib<strong>il</strong>ità e di amare sorprese, noi indicassimo<br />
un tema di impegno sul quale esercitare la memoria che con loro costruiamo giorno per giorno.<br />
Un tema che traduca le nostre parole in atti concreti, in volontà manifesta. Ne voglio qui suggerire uno.<br />
Lo spunto mi viene dato dalla pubblicazione di un libro di Marco Rovelli, dal titolo “Lager Italiani”. Non si tratta<br />
di una nuova pubblicazione che parla di Ferramonti o di Sforzacosta o di Anghiari.<br />
Parla, con estrema lucidità e senza alcuna concessione alla benché minima autoassoluzione, dei Cpt, dei<br />
Centri di Permanenza Temporanea. Letta così questa sigla e queste parole sembrano gent<strong>il</strong>i, tranqu<strong>il</strong>lizzanti,<br />
pienamente accettab<strong>il</strong>i.<br />
Ma, e anche per questo serve la memoria, i nazisti non chiamavano wohnungsbezirk (distretto abitativo, tranqu<strong>il</strong>la<br />
e tranqu<strong>il</strong>lizzante definizione amministrativa ) i ghetti, della cui infamia non si perderà mai <strong>il</strong> ricordo e la<br />
conoscenza?
Ma non era così allora e non è così oggi per i Cpt. Non luoghi tranqu<strong>il</strong>li, non luoghi sereni. Tutt'altro e ben altro!<br />
E che altro siano lo dimostra <strong>il</strong> quasi comune e generale s<strong>il</strong>enzio intorno alle loro realtà, alle inaccettab<strong>il</strong>i<br />
vicende quotidiane. Un s<strong>il</strong>enzio che potremmo definire bipartisan, rotto solo da poche voci coraggiose, da poche<br />
voci che ben altro e maggiore ascolto dovrebbero riscuotere.<br />
Il nostro ascolto ed <strong>il</strong> nostro sostanziale appoggio, ad esempio. Perché i Cpt sono veri e propri Lager. Diversi e<br />
uguali a quelli che abbiamo conosciuto.<br />
Sarebbe in questa sede lungo tracciare le diversità, che pur ci sono. Sono gli aspetti di identità - non pochi -<br />
che colpiscono e ci devono seriamente preoccupare e indignare. Marco Rovelli ci porta la voce, la testimonianza<br />
diretta di quale sia la tragica realtà dei Cpt. A che situazioni ci abbia portato la tanto conclamata legge<br />
Bossi-Fini, vantata come esempio di avanzata democrazia.<br />
Sono parole pesanti, disperate, voci che denunciano un tradimento ma anche una accorata volontà di speranza.<br />
Voci che ci portano tanti anni indietro e alle quali non si può rispondere con l'appellarci alla solita e falsa<br />
definizione di “italiani, brava gente”.<br />
Vorrei proporvi citazioni delle testimonianze e delle storie umane che <strong>il</strong> libro raccoglie e propone. Ritengo tuttavia<br />
che non riuscirebbero a dare che una minima rappresentazione dell'orrore dei Cpt.<br />
Vi invito a leggere <strong>il</strong> libro, invito che estendo ai nostri rappresentanti nazionali con la speranza che, trovandosi<br />
d'accordo con me, indichino come impegno dell'Aned l'aiuto possib<strong>il</strong>e a chi si sta prodigando perché la realtà<br />
dei Cpt venga a modificarsi sostanzialmente, cancellando una profonda vergogna del nostro Paese.<br />
Facendone un impegno primario, caratterizzante. E su questo impegno chiamare quanti ci sono vicini, quanti<br />
hanno fatto dei nostri ricordi la loro memoria.<br />
Per concludere quello che è certamente <strong>il</strong> mio personale appello alla mob<strong>il</strong>itazione, voglio citare un brano della<br />
postfazione di Moni Ovadia: “La Bossi-Fini ha dato <strong>il</strong> la alla fascistizzazione dei Cpt. (...) Dopo Auschwitz, dopo<br />
i Gulag, nessuno può essere assolto per aver girato la faccia al fine di non vedere e di non sapere. Il clandestino<br />
è l'ebreo di oggi. Egli è ridotto a ‘sotto uomo’ prima dalla sinistra cultura retorica ‘sicuritaria’, poi da una<br />
legge fascista che lo dichiara criminale per <strong>il</strong> solo fatto di essere ciò che è, un essere umano che ha fame e<br />
cerca futuro per sé e per i suoi cari e che per questo viene privato di qualsivoglia status, sottoposto alla violenza<br />
della reclusione, sottratto alle tutele minime che spettano a un essere umano per diritto di nascita. Una<br />
volta sepolto in uno spazio di eccezione, <strong>il</strong> clandestino è alla mercé di arbitrii, percosse, torture, privazioni, abusi<br />
sessuali”. Credo che per noi, superstiti dei lager nazisti e per i fam<strong>il</strong>iari degli assassinati, queste siano parole<br />
sufficienti per esprimere <strong>il</strong> nostro deciso, chiaro: NO.