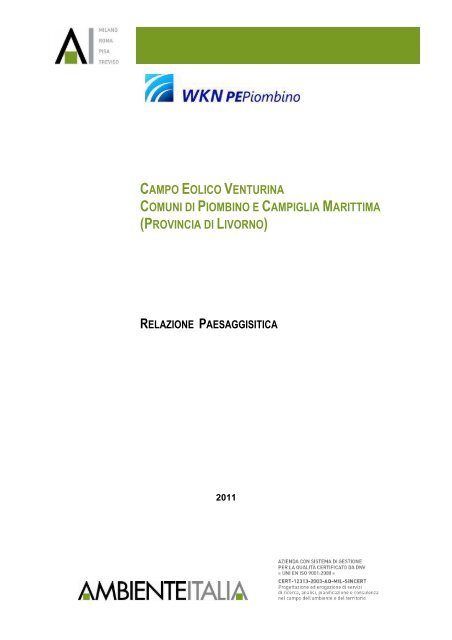Relazione Paesaggistica - Eolico Venturina
Relazione Paesaggistica - Eolico Venturina
Relazione Paesaggistica - Eolico Venturina
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
COMUNI DI PIOMBINO E CAMPIGLIA MARITTIMA<br />
(PROVINCIA DI LIVORNO)<br />
RELAZIONE PAESAGGISITICA<br />
2011
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
SOCIETÀ PROPONENTE:<br />
Stradale Primosole, 38<br />
95121 Catania<br />
SOCIETÀ RESPONSABILE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE PAESAGGISTICA<br />
Il gruppo di lavoro che ha eseguito le analisi e contribuito alla redazione della <strong>Relazione</strong> <strong>Paesaggistica</strong><br />
è così composto:<br />
Approvazione degli elaborati Dott. Mario Zambrini<br />
Responsabile Arch. Mario Miglio<br />
Gruppo di lavoro Dott. Giuseppe Dodaro<br />
Ing. Teresa Freixo Santos<br />
Arch. Mario Miglio<br />
Dott.ssa Valentina Toninelli<br />
Dott. Mario Zambrini<br />
Elaborazioni cartografiche Dott.ssa Valentina Toninelli<br />
Codice di progetto 11V071<br />
Versione documento 01<br />
PAGINA: 2: 98 2011 COD: 11V071
RELAZIONE PAESAGGISTICA<br />
INDICE<br />
1 PREMESSA..................................................................................................................................... 5<br />
1.1 L’IMPIANTO EOLICO IN PROGETTO ED I BENI PAESAGGISTICI INTERESSATI ......................................................... 5<br />
1.2 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO ...................................................................................................... 6<br />
1.2.1 Le norme nazionali sulla relazione paesaggistica ............................................................................ 6<br />
1.2.2 Le Linee Guida nazionali del MIBAC ............................................................................................... 7<br />
1.2.3 Le Linee Guida nazionali del MISE .................................................................................................. 8<br />
1.3 LA STRUTTURA ED I CONTENUTI DELLA PRESENTE RELAZIONE PAESAGGISTICA ................................................. 8<br />
2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO................................................................................................. 10<br />
2.1 UBICAZIONE ED ACCESSIBILITÀ AL SITO DELL’IMPIANTO ................................................................................ 10<br />
2.2 CARATTERISTICHE GENERALI DELL’IMPIANTO ED OPERE CONNESSE .............................................................. 10<br />
2.2.1 Premessa ......................................................................................................................................... 10<br />
2.2.2 Viabilità ........................................................................................................................................... 11<br />
2.2.3 Piazzole ed aree funzionali alle attività di cantiere - Fondazioni ................................................... 12<br />
2.2.4 Cavidotto d’impianto....................................................................................................................... 15<br />
2.2.5 Stazione utente ................................................................................................................................ 19<br />
2.3 ATTIVITÀ DI CANTIERE .............................................................................................................................. 20<br />
2.4 ATTIVITÀ IN FASE DI ESERCIZIO ................................................................................................................. 21<br />
2.5 DISMISSIONE DELL’IMPIANTO EOLICO ......................................................................................................... 21<br />
3 TUTELE OPERANTI NEL CONTESTO PAESAGGISTICO E NELL’AREA D’INTERVENTO ... 22<br />
3.1 PIANO DI INDIRIZZO TERRITORIALE DELLA REGIONE TOSCANA ..................................................................... 22<br />
3.1.1 Riferimenti generali ........................................................................................................................ 22<br />
3.1.2 Relazioni tra PIT ed impianto – Premessa ...................................................................................... 24<br />
3.1.3 Le infrastrutture di interesse unitario regionale ............................................................................. 24<br />
3.1.4 Il paesaggio ..................................................................................................................................... 25<br />
3.2 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE – PROVINCIA DI LIVORNO ........................................ 32<br />
3.2.1 Riferimenti generali ........................................................................................................................ 32<br />
3.2.2 Relazioni tra PTCP ed interventi ricadenti nei beni paesaggistici ................................................. 36<br />
3.3 PIANO STRUTTURALE D’AREA DELLA VAL DI CORNIA .................................................................................. 49<br />
3.3.1 Riferimenti generali ........................................................................................................................ 49<br />
3.3.2 Relazioni tra PS d’Area ed interventi ricadenti nei beni paesaggistici ........................................... 51<br />
3.4 REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA .......................................................... 57<br />
3.4.1 Riferimenti generali ........................................................................................................................ 57<br />
3.4.2 Relazioni tra RU ed interventi ricadenti nei beni paesaggistici ...................................................... 58<br />
3.5 VARIANTE GENERALE DEL PRG DEL COMUNE DI PIOMBINO ......................................................................... 62<br />
3.5.1 Riferimenti generali ........................................................................................................................ 62<br />
3.5.2 <strong>Relazione</strong> tra VG di PRG ed interventi ricadenti nei beni paesaggistici ........................................ 62<br />
3.6 PARCHI E RISERVE NATURALI - RETE NATURA 2000 ................................................................................... 65<br />
3.6.1 Riferimenti generali ........................................................................................................................ 65<br />
3.6.2 Relazioni tra aree protette ed interventi ricadenti nei beni paesaggistici vincolati ........................ 66<br />
3.7 BENI CULTURALI E PAESISTICI VINCOLATI .................................................................................................. 66<br />
3.7.1 Riferimenti generali ........................................................................................................................ 66<br />
3.7.2 Relazioni tra beni culturali e paesaggistici vincolati ed impianto eolico ....................................... 67<br />
4 CARATTERI PAESAGGISTICI DEL CONTESTO E PREVISIONI DEGLI EFFETTI .................. 71<br />
4.1 USO DEL SUOLO E VEGETAZIONE .............................................................................................................. 71<br />
4.1.1 Premessa ......................................................................................................................................... 71<br />
4.1.2 Flora e vegetazione nell’area di ubicazione dell’impianto eolico .................................................. 71<br />
4.1.3 Effetti sulla vegetazione in fase di cantiere e di esercizio ............................................................... 72<br />
4.2 BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI ............................................................................................................. 73<br />
4.2.1 Premessa ......................................................................................................................................... 73<br />
4.2.2 I beni culturali e paesaggistici presenti nell’area d’indagine ......................................................... 74<br />
4.2.3 Effetti sui beni culturali e paesaggistici in fase di cantiere............................................................. 77<br />
4.2.4 Effetti sui beni culturali e paesaggistici in fase di esercizio ........................................................... 77<br />
4.3 PAESAGGIO ............................................................................................................................................ 78<br />
4.3.1 Premessa ......................................................................................................................................... 78<br />
4.3.2 Gli Ambiti di Paesaggio identificati dal PIT ................................................................................... 78<br />
4.3.3 Gli Ambiti di Paesaggio identificati dal PTCP ............................................................................... 83<br />
4.3.4 Gli Ambiti di Paesaggio identificati dal PS d’Area della Val di Cornia ......................................... 88<br />
4.3.5 Elementi che connotano il paesaggio e loro persistenze e trasformazioni ...................................... 90<br />
4.3.6 Gli elementi del paesaggio .............................................................................................................. 96<br />
4.3.7 Effetti sugli elementi del paesaggio in fase di cantiere ................................................................... 96<br />
VERS: 01 2011 PAGINA: 3: 98
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
4.3.8 Effetti sugli elementi del paesaggio in fase di esercizio .................................................................. 97<br />
PAGINA: 4: 98 2011 COD: 11V071
RELAZIONE PAESAGGISTICA<br />
1 PREMESSA<br />
1.1 L’impianto eolico in progetto ed i beni paesaggistici interessati<br />
L’impianto eolico di progetto, composto da 17 aerogeneratori, è ubicato nella zona<br />
pianeggiante a cavallo del Fiume Cornia, nel territorio dei Comuni di Campiglia Marittima e di<br />
Piombino, in Provincia di Livorno. In maggiore dettaglio, gli aerogeneratori si distribuiscono<br />
nell’area centrale della piana, sostanzialmente compresa tra la Vecchia Aurelia, il ramo della<br />
linea ferroviaria per Piombino e la Strada della Base Geodetica, distanziati dalle colline di<br />
Campiglia, dai rilievi del promontorio di Piombino e dalla fascia costiera. Gli interventi di<br />
adeguamento della viabilità esistente e di apertura dei nuovi brevi tratti delle strade funzionali<br />
all’accesso agli aerogeneratori, così come la posa del cavidotto d’impianto, riguardano, allo<br />
stesso modo, tale area agricola pianeggiante ed il territorio di entrambi i citati Comuni. La<br />
stazione elettrica, da realizzare per la consegna dell’energia elettrica prodotta e la<br />
connessione alla Rete, ricade anch’essa nella zona agricola della piana, nella località tra<br />
Caselli di Cornia e Podere La Rinsacca, nel territorio del Comune di Piombino.<br />
Le opere in progetto, considerando anche quelle transitorie riferite alla sola fase di cantiere,<br />
non ricadono in beni culturali monumentali vincolati ai sensi del D.lgs 42/2004 e nemmeno in<br />
beni paesaggistici tutelati a seguito di dichiarazione del loro notevole interesse pubblico, ai<br />
sensi dell’art. 157 del citato decreto legislativo, compresi i cosiddetti “Galassini” emanati con<br />
Decreto Ministeriale.<br />
Un numero limitato di interventi ricade, invece, in beni paesaggistici vincolati ai sensi<br />
dell’articolo 142 del D.lgs 42/2004, in quanto appartenenti alla categoria paesaggistica dei<br />
corsi d’acqua pubblici e relative fasce contermini, per una profondità di 150 m sui due lati<br />
dalla sponda. In dettaglio, in base all’individuazione dei beni paesaggistici vincolati riportate<br />
nel SITAP del MIBAC, negli elaborati integrativi del PIT della Regione Toscana ed anche<br />
nelle tavole degli strumenti di pianificazione territoriale (PTCP) ed urbanistica (PS Val di<br />
Cornia), i corsi d’acqua interessati corrispondono a quelli indicati nel sottostante riquadro,<br />
dove si evidenzia la correlazione con l’opera in progetto che li riguarda.<br />
CORSI D’ACQUA A VINCOLO PAESAGGISTICO – RELAZIONE CON GLI INTERVENTI E MANUFATTI DI PROGETTO<br />
Fossa Calda Allestimento dell’area di cantiere dell’aerogeneratore 82 Comune di Campiglia M.<br />
Fosso Verrocchio Adeguamento di un breve tratto della viabilità esistente.<br />
Posa del cavidotto d’impianto<br />
Fosso Diavolo Posa del cavidotto d’impianto<br />
Fiume Cornia Posa del cavidotto d’impianto Comune di Piombino<br />
Fosso Cosimo Adeguamento puntuale della viabilità esistente<br />
In merito ai beni paesaggistici vincolati coinvolti si evidenzia che non si tratta degli<br />
aerogeneratori e loro piazzole di servizio e nemmeno della stazione elettrica ma di opere<br />
minori che, in quasi tutti i casi, determinano un’occupazione del suolo solo durante la fase di<br />
cantiere, con successiva possibilità di ripristino dei caratteri del luogo, essendo previsto il<br />
recupero delle aree coinvolte. Tale situazione riguarda, in particolare, l’area di cantiere<br />
dell’aerogeneratore n. 82 che, per altro, interessa in misura del tutto marginale la fascia<br />
contermine alla Fossa Calda, attualmente ad uso agricolo, e la posa del cavidotto d’impianto,<br />
in alcuni casi anche per l’attraversamento degli stessi corsi d’acqua, in quest’ultimo caso con<br />
soluzioni in appoggio ai ponti esistenti o, in via generale, in sottopasso dell’alveo, con ricorso<br />
alla tecnica della perforazione orizzontale teleguidata e quindi senza effettuare scavi a cielo<br />
aperto. Gli altri interventi, che determineranno modifiche permanenti durente la fase di<br />
esercizio, sono solo due ed in entrambi i casi si tratta dell’allargamento della sezione di<br />
strade esistenti. Nel successivo riquadro si identificano le citate opere e le fasce contermini<br />
ai corsi d’acqua a vincolo paesaggistico.<br />
VERS: 01 2011 PAGINA: 5: 98
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
CORSI D’ACQUA A VINCOLO PAESAGGISTICO – IDENTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI E MANUFATTI DI PROGETTO<br />
Fossa Calda<br />
Area di cantiere dell’aerogeneratore 82<br />
Fiume Cornia<br />
Cavidotto d’impianto<br />
Fosso Verrocchio<br />
Adeguamento strada esistente<br />
Cavidotto d’impianto<br />
Fosso Cosimo<br />
Adeguamento strada esistente<br />
Fosso Diavolo<br />
Cavidotto d’impianto<br />
In considerazione delle caratteristiche degli interventi che riguardano le fasce contermini ai<br />
corsi d’acqua pubblici vincolati, tutti di tipo puntuale e sostanzialmente connessi alla<br />
realizzazione di infrastrutture, le informazioni e le considerazioni riportate nella presente<br />
<strong>Relazione</strong> si concentrano su queste singole opere. Nella presente <strong>Relazione</strong> non sono<br />
dunque trattati gli aspetti legati alla percezione dell’impianto eolico dai luoghi circostanti,<br />
come derivante dalla vista degli aerogeneratori, in quanto gli stessi non ricadono in aree<br />
sottoposte a vincolo paesaggistico; al tema della visibilità è in ogni caso dedicata una<br />
specifica attenzione nello Studio di Impatto Ambientale relativo al presente progetto, a cui si<br />
rimanda per eventuali approfondimenti, redatto considerando anche le indicazioni, di seguito<br />
riportate, contenute nelle Linee Guida del MIBAc e del MISE.<br />
1.2 Il quadro normativo di riferimento<br />
Per la redazione della <strong>Relazione</strong> <strong>Paesaggistica</strong> si adotta l’impostazione definita, nella<br />
struttura e nei contenuti, dalla normativa nazionale sui beni paesaggistici, ovvero il D.lgs<br />
42/2004 ed il D.P.C.M. 12.12.2005. Inoltre, si tiene conto del contenuto del documento del<br />
MiBAC, “Linee Guida per l’inserimento paesaggistico degli interventi di trasformazione<br />
territoriale - Gli impianti eolici: suggerimenti per la progettazione e la valutazione<br />
paesaggistica”, pubblicato nel 2006, nonché delle Linee Guida nazionali, di cui al D.M.<br />
10.9.2010, del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicate sulla G.U. n. 219 del<br />
18.9.2010.<br />
1.2.1 Le norme nazionali sulla relazione paesaggistica<br />
Il D.P.C.M. 12.12.2005, “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della<br />
compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del<br />
Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”,<br />
nell’Allegato 1, “<strong>Relazione</strong> paesaggistica”, definisce finalità, criteri di redazione e contenuti di<br />
tale elaborato. La <strong>Relazione</strong> paesaggistica, assieme al progetto ed alla relazione di progetto,<br />
costituisce documentazione di corredo dell’istanza di autorizzazione paesaggistica,<br />
necessaria per le valutazioni previste dall’art. 146, comma 5, del Codice dei beni culturali e<br />
del paesaggio, da effettuare a cura dell’amministrazione competente.<br />
PAGINA: 6: 98 2011 COD: 11V071
RELAZIONE PAESAGGISTICA<br />
I contenuti della <strong>Relazione</strong> paesaggistica, con riferimento a quanto indicato nel citato<br />
Allegato, sono individuati nei seguenti:<br />
Documentazione Tecnica<br />
- Elaborati di Analisi dello stato attuale<br />
• Descrizione dei caratteri paesaggistici del contesto e dell’area di<br />
intervento (punto 3.1.A.1)<br />
• Indicazione e analisi dei livelli di tutela operanti nel contesto<br />
paesaggistico e nell’area di intervento, rilevabili da strumenti di<br />
pianificazione e norme o provvedimenti, e indicazione della presenza<br />
di beni culturali tutelati (punto 3.1.A.2)<br />
• Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell’area d’intervento e<br />
del contesto paesaggistico (punto 3.1.A.3)<br />
- Elaborati di progetto<br />
• Inquadramento dell’area e dell’intervento (punto 3.1.B.1)<br />
• Area d’intervento (punto 3.1.B.2)<br />
• Opere di progetto (punto 3.1.B.3)<br />
Elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica<br />
- Simulazione dettagliata dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del<br />
progetto (punto 3.2.1)<br />
- Previsioni degli effetti delle trasformazioni (punto 3.2.2)<br />
- Indicazione delle opere di mitigazione, visive ed ambientali, previste, ed anche messa<br />
in evidenza degli effetti negativi non mitigabili e delle eventuali misure di<br />
compensazione (punto 3.2.3).<br />
Al punto 4 dell’Allegato sono fornite indicazioni sulla documentazione da predisporre in<br />
relazione a tipologie di interventi ed opere di grande impegno territoriale ed in particolare, al<br />
punto 4.2 si precisa che, per quanto riguarda gli impianti eolici, deve essere redatta la carta<br />
dell’influenza visiva e riportata la conoscenza dei caratteri paesaggistici dei luoghi. Sempre<br />
in riferimento agli impianti eolici si precisa che deve essere mostrata la localizzazione<br />
dell’impianto nella cartografia conoscitiva e simulato l’effetto paesaggistico, attraverso la<br />
fotografia e lo strumento del rendering. Per tali impianti, come dalla nota al testo del citato<br />
punto 4.2 dell’Allegato, l’ulteriore documentazione progettuale sarà specificata nelle Linee<br />
Guida che il Ministero dei Beni e Attività Culturali, il Ministero dell’Ambiente ed il Ministero<br />
delle attività produttive elaboreranno, ai sensi del comma 2, art. 2 del D.lgs 387/2004.<br />
In riferimento ai contenuti della presente <strong>Relazione</strong> si evidenzia che, come richiesto, sono<br />
richiamati i caratteri distintivi degli Ambiti di Paesaggio, già individuati e delimitati dal Piani<br />
territoriali, con un approfondimento derivante da una ulteriore lettura degli elementi del<br />
paesaggio presenti nell’area di ubicazione dello stesso impianto e quindi includendo anche i<br />
siti puntuali interessati dai citati interventi riguardanti i corsi d’acqua vincolati. Viceversa,<br />
come si è detto, non si riporatano le analisi e considerazioni relative alla percezione<br />
dell’impianto, dato che gli aerogeneratori non ricadono mai in aree sottoposte a vincolo<br />
paesaggistico.<br />
Si riporta, nel sottostante riquadro, estratto della cartografia di individuazione dei vincoli<br />
paesaggistici correlata alle opere di progetto.<br />
1.2.2 Le Linee Guida nazionali del MIBAC<br />
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha pubblicato, nell’anno 2006, le “Linee Guida per<br />
l’inserimento paesaggistico degli interventi di trasformazione territoriale” con riferimento agli<br />
impianti eolici. Tale Linee Guida, come precisato nello stesso documento, intendono<br />
facilitare l’applicazione del D.P.C.M. 12.12.2005 ed in particolare definiscono meglio i<br />
contenuti della <strong>Relazione</strong> paesaggistica, con riferimento alla progettazione e valutazione<br />
degli impianti eolici; con tale documento, come evidenziato nello stesso, non si intende<br />
VERS: 01 2011 PAGINA: 7: 98
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
dettare regole rigide ma fornire chiavi di lettura del contesto paesaggistico ed indicazioni<br />
finalizzate a migliorare il contenuto degli elaborati.<br />
1.2.3 Le Linee Guida nazionali del MISE<br />
Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con il D.M. 10.9.2010, di concerto con il MIBAC e con<br />
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, ha emanato le Linee Guida<br />
per il procedimento di autorizzazione e costruzione all’esercizio di impianti di produzione di<br />
elettricità da fonti rinnovabili e linee guida tecniche per gli impianti stessi.<br />
Nell’Allegato 4, “Impianti eolici: elementi per il corretto inserimento nel paesaggio e sul<br />
territorio”, sono fornite indicazioni per l’analisi dell’inserimento nel paesaggio, che<br />
contemplano la ricognizione degli elementi caratterizzanti e qualificanti del paesaggio e<br />
l’illustrazione del modo in cui l’impianto viene percepito all’interno del bacino visivo allo<br />
stesso correlato, in quest’ultimo caso tenendo conto degli effetti cumulativi derivanti dalla<br />
compresenza di più impianti. Al contempo si richiede una documentazione fotografica dei<br />
luoghi, come si presentano ante operam e post operam, nel secondo caso con simulazioni<br />
per una reale valutazione degli effetti sul paesaggio prodotti dalle trasformazioni previste.<br />
L’analisi dell’inserimento nel paesaggio dell’impianto, come indicato, deve includere: l’analisi<br />
dei livelli di tutela, fornendo in tale senso l’indicazione della presenza dei beni culturali e<br />
paesaggistici tutelati ai sensi del Codice; l’analisi delle caratteristiche del paesaggio nelle sue<br />
componenti naturali ed antropiche; l’analisi dell’evoluzione storica del territorio; l’analisi<br />
dell’intervisibilità dell’impianto nel paesaggio.<br />
In merito a quanto richiesto dalle Linee Guida, stante il fatto che ricadono in beni<br />
paesaggistici vincolati alcune opere connesse ma non gli aerogeneratori di progetto, nella<br />
presente <strong>Relazione</strong> si riportano, come richiesto, le considerazioni riguardanti i livelli di tutela<br />
operanti (con riferimento alle aree vincolate interessate dalle opere di progetto) e la presenza<br />
dei beni culturali e paesaggistici tutelati (nell’area vasta) ed ancora l’analisi dei caratteri<br />
d’insieme del paesaggio mentre si omette l’analisi relativa alla intervisibilità dello stesso<br />
impianto eolico. In quest’ultimo caso si rimanda, comunque, allo SIA che contiene, come già<br />
evidenziato, sia la restituzione dell’intervisibilità dal territorio, sia la verifica della percezione<br />
da singoli punti di osservazione, con ricorso alle simulazioni in foto panoramiche.<br />
1.3 La struttura ed i contenuti della presente <strong>Relazione</strong> paesaggistica<br />
La <strong>Relazione</strong> si articola nei seguenti punti, gli ultimi due inclusi nello stesso capitolo, per<br />
mantenere una più diretta relazione tra la descrizione dello stato attuale e l’analisi dei<br />
possibili effetti:<br />
- Descrizione del progetto: sono fornite le informazioni principali, inerenti all’impianto<br />
ed opere connesse, comprendenti le caratteristiche degli aerogeneratori ed altri<br />
manufatti, la tipologia degli interventi previsti distinguendo, in tale caso, la fase di<br />
cantiere da quella di esercizio, ed ancora note sullo smantellamento al termine del<br />
ciclo di vita dell’impianto;<br />
- Tutele operanti nel contesto paesaggistico e nell’area d’intervento: sono riportati i<br />
contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica, con riferimento<br />
alla disciplina riguardante gli aspetti paesaggistici, illustrando la relazione tra le<br />
norme e le opere in progetto ricadenti nei beni vincolati;<br />
- Caratteri paesaggistici del contesto e dell’area d’intervento: sono riportati gli elementi<br />
conoscitivi inerenti agli usi del suolo, alla vegetazione, ai beni culturali vincolati o<br />
segnalati per il loro interesse, al paesaggio in generale ed ai beni paesaggistici<br />
vincolati;<br />
- Previsioni degli effetti delle trasformazioni: sono descritte le ricadute sugli usi del<br />
suolo, la vegetazione, i beni culturali ed il paesaggio, nonché gli interventi di ripristino<br />
ambientale previsti.<br />
PAGINA: 8: 98 2011 COD: 11V071
RELAZIONE PAESAGGISTICA<br />
La documentazione cartografica, che comprende le tavole di individuazione degli interventi di<br />
progetto (fase di cantiere e fase di esercizio), gli estratti delle tavole dei Piani territoriali ed<br />
urbanistici e le tavole tematiche relative all’analisi del paesaggio ed alla individuazione dei<br />
beni monumentali e paesaggistici vincolati, è raccolta in apposito Allegato della presente<br />
<strong>Relazione</strong> paesaggistica.<br />
VERS: 01 2011 PAGINA: 9: 98
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO<br />
2.1 Ubicazione ed accessibilità al sito dell’impianto<br />
L’impianto eolico di <strong>Venturina</strong> è ubicato nell’area pianeggiante che si estende a cavallo del<br />
Fiume Cornia, in parte sul territorio del Comune di Campiglia Marittima (10 aerogeneratori)<br />
ed in parte sul territorio di Comune di Piombino (7 aerogeneratori). Nel dettaglio, nel Comune<br />
di Campiglia Marittima, ricadono gli aerogeneratori 3, 47, 49, 50, 51, 53, 57, 58, 82 ed 83,<br />
mentre nel Comune di Piombino gli aerogeneratori 6, 64, 69, 70, 71, 76 e 84. 1<br />
Per accedere all’area di ubicazione degli aerogeneratori dell’impianto, uscendo dalla SS 1<br />
Variante Aurelia, si seguiranno tre distinti percorsi, in relazione alla posizione degli<br />
aerogeneratori, percorrendo sempre la viabilità esistente ed in dettaglio la SS o SR 398<br />
della Val di Cornia, la SP 23bis, la SP 39 Vecchia Aurelia, la strada comunale degli Affitti, la<br />
via delle Lavoriere e la via Campo all’Olmo; in tutti i casi non si rendono necessari interventi<br />
sulla citata viabilità, fatta eccezione per due soli adeguamenti puntuali in corrispondenza<br />
degli incroci principali lungo la strada degli Affitti.<br />
2.2 Caratteristiche generali dell’impianto ed opere connesse<br />
2.2.1 Premessa<br />
L’impianto eolico di progetto è composto da un totale di 17 aerogeneratori da 2 MW e si<br />
prevede di utilizzare il modello Vestas V90 con torre di altezza pari a 105 m; le<br />
caratteristiche principali di tale modello sono riportate nel sottostante riquadro.<br />
Vestas<br />
V90 / 2.0 MW<br />
Potenza del generatore kW 2.000<br />
Velocità di avvio (cut-in) m/s 4<br />
Velocità vento di arresto (cut-off) m/s 25<br />
Velocità di rotazione RPM<br />
(giri/min)<br />
9,0-14,9<br />
Numero di pale n. 3<br />
Altezza mozzo del rotore (H) m 105<br />
Diametro del rotore m 90<br />
Area spazzata dal un rotore m 2 6.362<br />
Colore Bianco<br />
Caratteristiche del modello V90/2MW (dati Vestas 2 )<br />
1 Si rimanda alle tavole di “Inquadramento”, inserite nell’Allegato Cartografico.<br />
2 Vestas: V90-1.8/2.0 MW: General Specification V90 – 1.8/2.0 MW (Item no. 950019 V07, 2008-05-05).<br />
PAGINA: 10: 98 2011 COD: 11V071
RELAZIONE PAESAGGISTICA<br />
Gli interventi previsti per la realizzazione dell’impianto eolico, in dettaglio, comprendono:<br />
- l’adeguamento della viabilità esistente e l’apertura di nuovi brevi tratti di strada<br />
funzionali all’accesso agli aerogeneratori;<br />
- l’allestimento dell’area di cantiere e piazzole di ogni singolo aerogeneratore;<br />
- lo scavo e la successiva posa delle fondazione degli aerogeneratori;<br />
- lo scavo per la posa del cavidotto d’impianto;<br />
- la realizzazione della stazione elettrica di utenza per la consegna/connessione alla<br />
Rete.<br />
Le attività necessarie alla posa in opera delle fondazioni ed al successivo montaggio delle<br />
componenti degli aerogeneratori, richiedono la disponibilità di piazzole (una per ogni<br />
aerogeneratore) di dimensioni e caratteristiche funzionali alle manovre in sicurezza dei mezzi<br />
di cantiere e al posizionamento delle autogrù utilizzate per il montaggio delle componenti<br />
degli aerogeneratori. Per l’installazione degli aerogeneratori si ricorre alla messa in opera di<br />
plinti di fondazione, che saranno quasi interamente interrati e ricoperti da terreno. Le<br />
piazzole devono essere accessibili dai mezzi da cantiere e da trasporto, ed a questo scopo<br />
sono raccordate alla viabilità esistente per mezzo di apposite piste, alcune da realizzare ed<br />
altre invece già coincidenti con strade minori esistenti che saranno adeguate. Per quanto<br />
riguarda l’accesso all’area di ubicazione dell’impianto, come già evidenziato si utilizza la<br />
viabilità esistente e si prevede di intervenire sulla stessa, per i necessari adeguamenti, solo<br />
in due casi e per modifiche di tipo puntuale. Gli aerogeneratori verranno interconnessi tra<br />
loro mediante un unico cavo configurato in entra-esci, in media tensione, fino alla stazione di<br />
utenza; in tale caso è prevista la posa di un cavidotto interrato che si sviluppa a lato della<br />
viabilità esistente. Dalla citata stazione si sviluppa il cavidotto, in alta tensione, per il breve<br />
tratto necessario a raggiungere la già prevista sottostazione elettrica di Terna.<br />
Nei successivi paragrafi si forniscono informazioni generali per inquadrare le diverse opere in<br />
progetto, con l’avvertenza che tra queste, quelle riguardanti i beni paesaggistici vincolati,<br />
comprendono l’adeguamento della viabilitù esistente, in soli due casi, la posa del cavidotto<br />
d’impianto, per alcuni tratti, e l’allestimento dell’area di cantiere della sola piazzola<br />
dell’aerogeneratore 82, in quest’ultimo caso per una limitata parte della stessa che, per altro,<br />
si posiziona con il margine esterno a cavallo della linea dei 150 m dal Fosso Calda.<br />
2.2.2 Viabilità<br />
Gli interventi sulla viabilità di accesso al sito (nonché quelli relativi alla viabilità interna al sito<br />
di progetto) sono finalizzati a rendere percorribile l’itinerario individuato da parte dei mezzi<br />
adibiti al trasporto delle componenti degli aerogeneratori e delle attrezzature da cantiere. In<br />
particolare, occorre garantire spazi adeguati al passaggio ed alla manovra degli automezzi<br />
per trasporti eccezionali necessari alla movimentazione delle pale degli aerogeneratori e<br />
della navicella. Tenuto conto delle caratteristiche dei mezzi che dovranno percorrere la<br />
viabilità di servizio al sito eolico per il trasporto dei componenti, il progetto prevede una<br />
carreggiata con larghezza complessiva pari a 7 m, comprese le cunette laterali.<br />
Il sedime delle strade da realizzare o da allargare sarà così costituito: primo strato di<br />
sottofondo, di circa 15 cm, realizzato con materiale calcareo e con dimensioni da 7 a 20 cm;<br />
secondo strato di 10 cm, con materiale calcareo di dimensioni da 4 a 7 cm e quindi terzo<br />
strato, quello superiore, in misto calcareo stabilizzato di dimensioni da 0,8 a 1,5 cm.<br />
Nel riquadro sottostante si riportano i disegni relativi alla configurazione delle strade di<br />
accesso alle piazzole ed aerogeneratori di progetto, sia quelle di nuova apertura, sia quelle<br />
associate all’adeguamento delle esistenti.<br />
VERS: 01 2011 PAGINA: 11: 98
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
Sezione tipo delle strade di accesso alle piazzole e relativo pacchetto stradale<br />
(Dati di progetto WKN)<br />
Dati di progetto WKN<br />
2.2.3 Piazzole ed aree funzionali alle attività di cantiere - Fondazioni<br />
Le piazzole e annesse aree di cantiere avranno una superficie pari a circa 9.279 m 2 (le<br />
piazzole 49 e 50 hanno delle dimensioni leggermente superiori e pari rispettivamente a<br />
10.057 e 10.942 m 2 ) determinata sulla base delle esigenze connesse al trasporto ed al<br />
montaggio dei componenti di ogni singolo aerogeneratore: in particolare, sulla piazzola e<br />
aree annesse deve essere assemblato il rotore prima di essere montato sull’asse della<br />
PAGINA: 12: 98 2011 COD: 11V071
RELAZIONE PAESAGGISTICA<br />
navicella; devono essere installate le gru necessarie al montaggio della torre<br />
dell’aerogeneratore ed alla successiva posa in opera della navicella e del rotore.<br />
Nel dettaglio in corrispondenza di ciascun aerogeneratore verranno allestite le seguenti aree:<br />
• area b: piazzola di istallazione definitiva;<br />
• area c: area posa elementi turbina;<br />
• area d: area posa pale;<br />
• area e: area di occupazione braccio e sostegni gru;<br />
• area g: area di cantiere per l’installazione, manutenzione straordinaria e ordinaria.<br />
Immediatamente a fianco della piazzola viene posizionata l’area di fondazione delle torri<br />
(area a).<br />
L’area funzionale all’istallazione di ciascun aerogeneratore (esclusa l’area della fondazione)<br />
in fase di cantiere è pari a circa 6.207 m 2 (leggermente inferiori per 49 e 50 che occupano<br />
una superficie pari rispettivamente a 5.745 e 6.198 m 2 ) per complessivi circa 105.048 m 2<br />
considerando il layout composto da n. 17 aerogeneratori (si tenga presente che l’area g) non<br />
è oggetto di alcun intervento). A conclusione della fase di cantiere, ovvero della fase di<br />
collaudo dell’impianto eolico, le aree c) d) e e) saranno oggetto di ripristino riportandole alla<br />
funzionalità ante operam. L’area occupata in fase di esercizio si ridurrà quindi a circa 2.280<br />
m 2 (compresa l’area della fondazione) per complessivi circa 38.760 m 2 .<br />
Di seguito si riporta sia la planimetria tipo relativa alla piazzola in fase di cantiere , sia la<br />
configurazione in fase di esercizio a seguito dell’avvenuto ripristino parziale a<br />
completamento della fase di cantiere. 3<br />
Planimetria tipo della piazzola in fase di cantiere (Dati di progetto WKN)<br />
3 Si rimanda anche alle tavole di “Inquadramento” riferita alle citate due fase, inserite nell’Allegato Cartografico.<br />
VERS: 01 2011 PAGINA: 13: 98
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
Planimetria tipo della piazzola in fase di esercizio (Dati di progetto WKN)<br />
Le fondazioni su cui vengono fissate le torri degli aerogeneratori sono costituite da plinti di<br />
cemento armato a pianta quadrata quasi completamente interrati (emerge solamente la base<br />
della torre) che poggiano, secondo indicazioni di progetto, direttamente sul suolo (fondazioni<br />
dirette). Più in particolare le fondazioni hanno lato di 19,0 m e spessore compreso fra 0,7 m<br />
al bordo e 2,40 m al centro; sulla fondazione è inghisata la virola in acciaio a cui vengono<br />
imbullonati i trami della torre.<br />
PAGINA: 14: 98 2011 COD: 11V071
RELAZIONE PAESAGGISTICA<br />
2.2.4 Cavidotto d’impianto<br />
Tipico della fondazione (Dati di progetto WKN)<br />
Gli aerogeneratori sono interconnessi mediante un unico cavo, configurato in entra-esci, in<br />
media tensione fino alla stazione di utente da realizzare in prossimità degli aerogeneratori 6<br />
e 71, dove verrà effettuata la trasformazione da media ad alta tensione e dalla quale partirà<br />
un cavidotto interrato, in alta tensione, fino alla nuova stazione di smistamento della RTN a<br />
132 kV deonominata Populonia, di proprietà di Terna e localizzata nel Comune di Piombino 4 .<br />
La soluzione tecnica individuata dalla società Terna prevede che i raccordi alla linea 132 kV<br />
della RTN “Piombino TAG-Suvereto” vengano realizzati in singola terna.<br />
Le tre linee elettriche (A e B di MT e linea AT) saranno realizzate mediante utilizzo di cavi<br />
elettrici con conduttori in corda compatta in alluminio, con isolamento in mescola<br />
elastomerica reticolata, provvisti di strati semiconduttivi interni ed esterni all’isolante<br />
primario, con schermo metallico costituito da fili di rame avvolti ad elica e guaina esterna<br />
costituita da una mescola termoplastica in PVC di qualità RZ. Il progetto prevede l’uso delle<br />
seguenti tipologia di cavo: ARE4H1R 20 kV per le linee in MT e ARE4H1H5E 132 kV per la<br />
linea in AT.<br />
I cavi elettrici in media tensione saranno interrati ad una profondità di 1,20 m e la posa sarà<br />
effettuata realizzando una trincea a sezione di circa 0,60 m di larghezza nel caso di posa di<br />
una terna e 0,80 m di larghezza nel caso di posa di due terne, ponendo sul fondo dello<br />
scavo, opportunamente livellato, un letto sabbia fine o di terreno scavato in sito se di buone<br />
caratteristiche geomeccaniche. Il cavo elettrico in alta tensione sarà interrato invece ad una<br />
profondità di 1,60 m.<br />
Nei successivi riquadri si riportano i disegni relativi alle diverse soluzioni tipo di realizzazione<br />
del cavidotto d’impianto ed anche la soluzione relativa alla posa del cavidotto interrato in AT<br />
di collegamento tra la stazione utente e la sottostazione di Terna.<br />
4 La soluzione tecnica per la connessione alla Rete Terna è stata comunicata dalla stessa società elettrica il 29/07/2011.<br />
VERS: 01 2011 PAGINA: 15: 98
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
Sezione tipo cavidotto MT – una / due e tre terne (dati di progetto WKN)<br />
Sezione tipo cavidotto AT (dati di progetto WKN)<br />
Il cavidotto verrà realizzato in affiancamento alla viabilità esistente e/o da realizzare,<br />
lasciando una fascia di 0,8 m tra la sezione stradale e lo scavo, come indicato nel disegno<br />
relativo alla sezione stradale tipo di seguito riportato.<br />
PAGINA: 16: 98 2011 COD: 11V071
RELAZIONE PAESAGGISTICA<br />
Sezione tipo stradale e tipologia di cavi (dati di progetto WKN)<br />
Per quanto riguarda l’’attraversamento di linee ferroviarie e di strade verrà effettuato un<br />
sottopasso mediante il ricorso alla trivellazione orizzontale teleguidata. L’attraversamento dei<br />
corsi d’acqua potrà essere effettuato appoggiandosi all’impalcato del ponte (come nel caso<br />
del Fiume Cornia), ricorrendo alla già citata trivellazione orizzontale con sottopasso<br />
dell’alveo o viceversa con soluzione in sovrappasso esterno ed al di sopra del corso<br />
d’acqua.<br />
Attraversamento di linee ferroviarie e di strade (dati di progetto WKN)<br />
VERS: 01 2011 PAGINA: 17: 98
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
Attraversamento di corsi d’acqua a vincolo paesaggistico<br />
Attraversamento di corsi d’acqua a trivellazione orizzontale (dati di progetto WKN)<br />
Attraversamento del Fiume Cornia (dati di progetto WKN)<br />
PAGINA: 18: 98 2011 COD: 11V071
RELAZIONE PAESAGGISTICA<br />
2.2.5 Stazione utente<br />
La stazione di utente sarà realizzata in prossimità degli aerogeneratori 6 e 71, ovverosia<br />
vicino alla nuova stazione di smistamento della RTN a 132 kV, denominata Populonia, di<br />
proprietà di Terna e localizzata nel Comune di Piombino. La soluzione tecnica individuata<br />
dalla società Terna prevede che i raccordi alla linea 132 kV della RTN “Piombino TAG-<br />
Suvereto” vengano realizzati in singola terna.<br />
La stazione di utente, di cui si riporta la planimetria e la sezione nel sottostante riquadro,<br />
occuperà una superficie pari a 3.486 m 2 (circa 70,7 m x 49,3 m); al suo interno verranno<br />
istallato il trasformatore MT/AT e collocato l’edificio comando e controllo.<br />
L’area interessata dalla realizzazione della stazione utente è attualmente ad uso agricolo e<br />
non soggetta a vincolo paesaggistico.<br />
Stazione di utente (dati di progetto WKN)<br />
VERS: 01 2011 PAGINA: 19: 98
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
2.3 Attività di cantiere<br />
Stazione di utente – cabina di comando (dati di progetto WKN)<br />
La realizzazione dell’impianto eolico si svilupperà secondo il seguente programma<br />
orientativo:<br />
A. interventi di adeguamento della viabilità e di apertura dei nuovi tratti di strada sterrata;<br />
B. scavo in trincea e posa della linea elettrica;<br />
C. allestimento delle piazzole;<br />
D. messa in opera delle fondazioni delle torri di sostegno;<br />
E. assemblaggio delle componenti dell’aerogeneratore ed installazione delle stesse;<br />
F. dismissione del cantiere, collaudo e messa in esercizio dell’impianto.<br />
Tra i citati interventi, quelli che riguardano i corsi d’acqua sottoposti a vincolo paesaggistico,<br />
sono limitati all’adeguamento di due tratti della viabilità esistente, con ampliamento<br />
dell’attuale sezione stradale e per un breve tratto della stessa, ed alla messa in opera del<br />
cavidotto d’impianto che potrà avvenire, come da tipici prima riportati, con posa all’interno<br />
dello scavo in trincea, con passaggio all’interno di tubazione inserita in sottosuolo a seguito<br />
della perforazione orizzontale teleguidata, con ancoraggio ai ponti esistenti od ancora con<br />
passaggio esterno.<br />
Per quanto riguarda la posa del cavidotto interrato si prevede che il materiale inerte risultante<br />
dallo scavo a sezione obbligata venga interamente riutilizzato per il reinterro e quindi<br />
garantendo il ripristino del piano di campagna alle condizioni attuali.<br />
A conclusione della fase di cantiere, ed una volta collaudato l’impianto eolico, si procederà al<br />
ripristino ambientale di circa 2/3 della superficie delle singole piazzole; in tale senso è quindi<br />
previsto anche il recupero dell’area coinvolta per l’allestimento dell’area di cantiere<br />
dell’aerogeneratorie n. 82 che, per una minima parte, riguarda la fascia contermine al Fosso<br />
Calda, assoggettata a vincolo paesaggistico.<br />
PAGINA: 20: 98 2011 COD: 11V071
RELAZIONE PAESAGGISTICA<br />
2.4 Attività in fase di esercizio<br />
Nel periodo di esercizio dell’impianto non si prevedono ulteriori interventi con ricadute sui<br />
caratteri del luogo ed in particolare non saranno interessati i beni paesaggistici vincolati,<br />
considerato che sarà svolta unicamente la manutenzione ordinaria dell’impianto, da parte di<br />
una squadra di servizio e manutenzione che sarà composta da due tecnici. Ad ogni controllo<br />
vengono testati tutti i componenti dell'aerogeneratore. Le verifiche periodiche comprendono<br />
anche una serie di simulazioni in condizioni di avaria, per verificare la sicurezza del sistema.<br />
Per quanto riguarda i beni paesaggistici vincolati, rispetto alla situazione attuale, l’unica<br />
modifica, determinata in fase di cantiere, che permane nel corso del periodo di esercizio, è<br />
da ricondurre all’occupazione di una stretta fascia di suolo da riferire ai due interventi di<br />
adeguamento della viabilità esistente, entrambi configurati come ampliamento della<br />
carreggiata e quindi in aderenza al sedime stradale esistente. Le aree coinvolte, attualmente<br />
agricole, hanno una lunghezza limitata ed in dettaglio si tratta, in un caso, dell’ampliamento<br />
nei pressi dell’incrocio tra la SP 40 e la strada degli Affitti, nell’altro dell’ampliamento della<br />
strada secondaria che ha origine presso il P. Trafossi, che sarà percorsa per raggiungere<br />
l’aerogeneratore n. 47.<br />
2.5 Dismissione dell’impianto eolico<br />
La vita media di un impianto eolico è generalmente pari ad almeno 25 anni, trascorsi i quali è<br />
comunque possibile, dopo un’attenta revisione di tutti i componenti dell’impianto, prolungare<br />
ulteriormente l’attività dell’impianto e conseguentemente la produzione di energia. In ogni<br />
caso, una delle caratteristiche dell’energia eolica che contribuiscono a caratterizzare questa<br />
fonte come effettivamente “sostenibile” è la quasi totale reversibilità degli interventi di<br />
modifica del territorio attuati per realizzare lo stesso impianto. Una volta esaurita la vita utile,<br />
in altri termini, è possibile programmare lo smantellamento dell’intero impianto ed attuare il<br />
recupero delle aree occupate dai manufatti e dalla residua parte delle piazzole degli<br />
aerogeneratori.<br />
Le principali attività connesse con la fase di smantellamento dell’impianto e rimessa in<br />
pristino del territorio coinvolto comprendono la disconnessione del cavidotto elettrico, lo<br />
smontaggio delle pale e del perno centrale di ogni aerogeneratore, la rimozione della<br />
navicella contenente il generatore e il riduttore; il sezionamento della torre. Per quanto<br />
riguarda la porzione di ancoraggio della torre, collocata fino ad una profondità di circa 2 m<br />
rispetto al piano di campagna ed al di sopra di questo per circa 40 cm, si prevede la<br />
completa rimozione della stessa; l’intera area viene quindi ricoperta di terreno vegetale,<br />
ripristinando il profilo originario del terreno e consentendo successivamente di praticare tutte<br />
le normali operazioni agricole (aratura compresa) e quindi di ridenistare l’area alla<br />
coltivazione.<br />
VERS: 01 2011 PAGINA: 21: 98
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
3 TUTELE OPERANTI NEL CONTESTO PAESAGGISTICO E NELL’AREA<br />
D’INTERVENTO<br />
3.1 Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana<br />
3.1.1 Riferimenti generali<br />
La L.R. 3.1.2005, n. 1, “Norme sul governo del territorio”, che disciplina la materia relativa<br />
alla pianificazione territoriale regionale, prevede l’approvazione del Piano di Indirizzo<br />
Territoriale (PIT), di competenza della Regione.<br />
Il Piano di indirizzo territoriale (PIT), come stabilito all’art. 48 della citata legge quadro<br />
regionale, contiene lo Statuto del Territorio che individua e definisce:<br />
- i sistemi territoriali e funzionali;<br />
- le invarianti strutturali che rappresentano oltre che i beni e le regole d’uso del territorio<br />
che si intende tutelare anche i livelli di qualità e le relative prestazioni minime;<br />
- i principi per l’utilizzazione delle risorse essenziali e le prescrizioni inerenti ai relativi<br />
livelli minimi prestazionale e di qualità;<br />
- le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ovvero i beni paesistici come definiti dal<br />
D.lgs 42/2004 che hanno un rilievo sovraprovinciale.<br />
Lo Statuto del Territorio, come precisato all’art. 48, ha anche valore di piano paesaggistico,<br />
ai sensi di quanto previsto dall’articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio<br />
(D.lgs 42/2004) e pertanto individua i beni paesaggistici e la relativa disciplina.<br />
Il PIT delinea la strategia di sviluppo territoriale mediante l’indicazione e definizione: degli<br />
obiettivi del governo del territorio e delle azioni conseguenti; del ruolo dei sistemi<br />
metropolitani e dei sistemi delle città, dei sistemi locali e dei distretti produttivi, delle aree<br />
caratterizzate da intensa mobilità nonché degli ambiti territoriali di rilievo sovraprovinciale;<br />
delle azioni integrate per la tutela e valorizzazione delle risorse essenziali. Il PIT, con<br />
riferimento alla necessità di delineare la strategia, definisce una serie di aspetti tra i quali<br />
sono comprese: le prescrizioni relative all’individuazione dei tipi di intervento e dei relativi<br />
ambiti territoriali che hanno effetti intercomunali e sono oggetto di concertazione tra i diversi<br />
livelli istituzionali; le prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore della Regione;<br />
le prescrizioni relative alla individuazione degli ambiti territoriali per la localizzazione di<br />
interventi sul territorio di competenza regionale; le misure di salvaguardia immediatamente<br />
efficaci.<br />
Gli strumenti della pianificazione territoriale dei Comuni e delle Province si conformano al<br />
PIT.<br />
Per quanto attiene alle invarianti strutturali, come definite all’art. 4, si tratta delle risorse, dei<br />
beni e delle regole relative all’uso, individuati dallo Statuto del Territorio, ed anche dei livelli<br />
di qualità e delle prestazioni minime da sottoporre a tutela al fine di garantire lo sviluppo<br />
sostenibile.<br />
Per quanto riguarda lo Statuto del territorio, come stabilito all’art. 5, questo assume e<br />
ricomprende le invarianti strutturali, definite all’art. 4, quali elementi cardine dell’identità dei<br />
luoghi consentendo l’individuazione, ad ogni livello di pianificazione, delle regole di<br />
insediamento e di trasformazione del territorio interessato la cui tutela garantisce, nei<br />
processi evolutivi sanciti e promossi dallo strumento medesimo, lo sviluppo sostenibile ai<br />
sensi degli articoli 1 e 2 della stessa L.R. 1/2005. Gli strumenti della pianificazione<br />
territoriale, PIT compreso, tenendo conto dello Statuto del territorio definiscono gli obiettivi,<br />
gli indirizzi e le azioni progettuali strategiche.<br />
Il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Regione Toscana, redatto ai sensi della L.R.<br />
1/2005 è stato approvato con D.C.R. n. 72 del 24.7.2007 (pubblicata sul BURT n. 42 del<br />
PAGINA: 22: 98 2011 COD: 11V071
RELAZIONE PAESAGGISTICA<br />
17.10.2007). Tale Piano è stato modificato ed integrato, per l’implementazione della<br />
disciplina paesaggistica, ai sensi dell’art. 143 del D.lgs 42/2004 e dell’art. 33 della L.R.<br />
1/2005, con una serie di elaborati disciplinari, cartografici e ricognitivi, adottati con la D.C.R.<br />
n. 32 del 16.6.2009 (avviso sul BURT 22.7.2009, n. 29).<br />
Il PIT, nella versione integrata come dalla citata adozione degli elaborati d’implementazione<br />
paesaggistica, è costituito dai seguenti elaborati:<br />
a) il Documento di Piano;<br />
b) la Disciplina generale del Piano;<br />
c) la Disciplina specifica dei beni paesaggistici;<br />
d) il Quadro Conoscitivo.<br />
Il Documento di Piano contiene: l’agenda per l’applicazione dello Statuto; i meta obiettivi ed<br />
obiettivi conseguenti; l’agenda strategica; la strumentazione per presidiare l’efficacia delle<br />
opzioni del PIT. La Disciplina è integrata dagli allegati denominati “Schede dei paesaggi e<br />
individuazione degli obiettivi di qualità”, per le parti relative alla Sezione 3 e 4 delle stesse<br />
schede, e dalle cartografie di individuazione degli immobili ed aree dichiarate di notevole<br />
interesse pubblico, delle aree tutelate per legge ed ancora delle aree gravemente<br />
compromesse o degradate (interne alle aree dichiarate di notevole interesse pubblico). Il<br />
Quadro Conoscitivo è formato da diversi elaborati: i quadri analitici di riferimento; in quadro<br />
aggiornato allo stato di fatto della mobilità e logistica; l’atlante ricognitivo dei paesaggi;<br />
l’atlante ricognitivo delle risorse archeologiche; la rappresentazione cartografica dei 38 ambiti<br />
di paesaggio; la Sezione 1 e 2 delle citate Schede.<br />
Il PIT, come definito all’articolo 2 della Disciplina generale, definisce lo Statuto del territorio<br />
toscano e formula direttive, prescrizioni e salvaguardie concernenti le invarianti strutturali che<br />
lo compongono e la realizzazione delle agende di cui lo Statuto si avvale ai fini della sua<br />
efficacia sostantiva. Il PIT costituisce strumento di adempimento della L.R. 1/2005 e del<br />
D.lgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), in quest’ultimo caso assumendo<br />
valenza di piano paesaggistico ai sensi degli articoli 135 e 143 del Codice ed anche<br />
dell’articolo 33 della legge regionale. L’agenda strategica, come precisato all’art. 38 della<br />
Disciplina generale, è costituita dagli obiettivi, dalle connessioni tra pianificazione territoriale<br />
e programmazione regionale generale e settoriale, dalle linee di azione contemplate al<br />
paragrafo 7 (da 7.1 a 7.3) del Documento di Piano; in particolare, la Regione cura la<br />
realizzazione dell’agenda strategica, per lo sviluppo sostenibile del territorio toscano,<br />
nell’ambito dei sistemi funzionali.<br />
Lo Statuto del territorio toscano è definito individuando meta obiettivi ed obiettivi conseguenti<br />
che compongono l’agenda e che costituiscono invarianti strutturali assieme alle invarianti<br />
attinenti alle infrastrutture ed ai beni di interesse unitario regionale. Gli obiettivi dell’agenda<br />
strategica sono definiti ed integrati mediante i sistemi funzionali.<br />
La struttura del territorio toscano, come indicato all’articolo 3 della Disciplina generale, si<br />
configura mediante il sistema territoriale ed i sistemi funzionali, la cui correlazione organica è<br />
prevista ed argomentata nel paragrafo 5 del Documento di Piano.<br />
Le componenti del sistema territoriale sono individuate come “universo urbano della<br />
Toscana” e “universo rurale della Toscana” e le invarianti strutturali correlate a questo<br />
sistema sono:<br />
a) la città policentrica toscana;<br />
b) la presenza industriale;<br />
c) il patrimonio collinare;<br />
d) il patrimonio costiero, insulare e marino;<br />
e) le infrastrutture di interesse unitario regionale;<br />
f) i paesaggi ed i beni paesaggistici.<br />
I sistemi funzionali sono identificati con le capacità funzionali che il Piano concepisce e<br />
adotta quali quadri di riferimento concettuale, analitico e valutatorio e tali capacità sono:<br />
VERS: 01 2011 PAGINA: 23: 98
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
a) la Toscana della nuova qualità e dalla conoscenza:<br />
b) la Toscana delle reti;<br />
c) la Toscana della coesione sociale e territoriale;<br />
d) la Toscana dell’attrattività e dell’accoglienza.<br />
Il PIT, con riferimento allo Statuto del territorio toscano, prevede misure generali di<br />
salvaguardia e modalità di adeguamento della strumentazione provinciale e comunale allo<br />
stesso Piano.<br />
Per quanto riguarda le salvaguardie (art. 36 delle NTA), in particolare si stabilisce che, in<br />
attesa dell’adeguamento dei PTCP, dei PS dei Comuni e dei Piani dei Parchi, gli atti di<br />
governo del territorio di Province, Comuni ed Enti parco regionali, si conformano alla<br />
specifica disciplina dei beni paesaggistici e che gli strumenti di pianificazione ed atti di<br />
governo del territorio, dalla pubblicazione dell’avviso di adozione sul BURT, non devono<br />
prevedere nuove edificazioni, manufatti o trasformazioni morfologiche (salvo le opere<br />
indicate al comma 4 e 5) negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le<br />
due fasce della larghezza di 10 metri dal piede esterno dell’argine o del ciglio di sponda dei<br />
corsi d’acqua principali individuati nel Quadro conoscitivo dello stesso PIT. Allo stesso modo<br />
non sono consentiti, sugli immobili od aree sottoposte a vincolo paesaggistico per<br />
dichiarazione di notevole interesse pubblico od in quanto aree tutelate per legge, interventi in<br />
contrasto con le prescrizioni di tutela previste dalla stessa disciplina (specifica dei beni<br />
paesaggistici).<br />
Per quanto attiene all’adeguamento (art. 36 bis delle NTA), si prevede che le Province, i<br />
Comuni e gli Enti gestori delle aree naturali protette, verificano l’adeguatezza dei contenuti<br />
paesaggistici dei propri strumenti di pianificazione, provvedendo, nel caso, all’adeguamento<br />
entro 2 anni; nei casi di verifica positiva di adeguatezza o di avvenuto adeguamento, a<br />
seguito della specifica istruttoria di verifica della Regione e poi del Ministero, conclusa con<br />
esito positivo, il parere espresso dal Soprintendente nel procedimento autorizzativo<br />
associato al vincolo paesaggistico, assume natura obbligatorio non vincolante.<br />
La disciplina del PIT (art. 36ter) prevede, con appositi provvedimenti della Giunta Regionale,<br />
la periodica revisione delle delimitazioni e rappresentazioni delle aree tutelate e<br />
l’aggiornamento dei contenuti delle Schede (Sezione 1 e 2).<br />
3.1.2 Relazioni tra PIT ed impianto – Premessa<br />
Tra i citati sistemi territoriali, tenendo conto della tipologia del progetto, si richiama nel<br />
successivo paragrafo la disciplina generale inerente alle “infrastrutture di interesse unitario<br />
regionale” ed anche, per una considerazione di ordine generale e tenendo conto che alcuni<br />
interventi (alcuni tratti delle strade esistenti da adeguare e del cavidotto) ricadono in beni<br />
paesaggistici vincolati per legge (fasce contermini ai corsi d’acqua), si richiama anche la<br />
disciplina riguardante il “paesaggio”.<br />
3.1.3 Le infrastrutture di interesse unitario regionale<br />
La categoria delle “Infrastrutture di interesse unitario regionale” è disciplinata dagli articoli 29<br />
e 30 della Disciplina generale del PIT.<br />
L’articolo 29 definisce come risorse di interesse unitario regionale i beni, le funzioni e le<br />
infrastrutture attinenti alla realizzazione ed operatività di un insieme di strutture tra le quali<br />
sono compresi gli impianti per la produzione o distribuzione di energia.<br />
L’art. 30 della Disciplina, riguardante le “direttive correlate alle infrastrutture di interesse<br />
unitario regionale”, invariante strutturale dello Statuto, al comma 3 stabilisce che “la Regione<br />
promuove la massima diffusione delle fonti rinnovabili di energia. Ai fini del conseguimento<br />
della piena efficienza produttiva degli impianti necessari alla produzione di fonti energetiche<br />
rinnovabili e della tutela delle risorse naturali e dei valori paesaggistici del territorio toscano,<br />
la localizzazione e la realizzazione degli impianti stessi avrà luogo ai sensi dell’articolo 10,<br />
PAGINA: 24: 98 2011 COD: 11V071
RELAZIONE PAESAGGISTICA<br />
comma 2, della l.r. 1/2005, sulla base delle determinazioni del Piano di Indirizzo Energetico<br />
Regionale previa specifica valutazione integrata a norma del piano paesaggistico regionale<br />
di cui al presente PIT e dei vincoli previsti dalla normativa nazionale e regionale”. Il comma 4<br />
del medesimo articolo recita inoltre: “A tale fine la programmazione regionale in materia<br />
energetica formula il quadro ricognitivo delle aree disponibili all’accoglimento dei relativi<br />
impianti coerentemente al disposto del comma precedente oltre che nel rispetto della<br />
disciplina del paesaggio”.<br />
La realizzazione dell’impianto eolico è coerente con il contenuto della direttiva di cui al citato<br />
articolo 30, per quanto riguarda la produzione di energia da rinnovabili.<br />
Per quanto riguarda il Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER), approvato dal<br />
Consiglio Regionale della Regione Toscana in data 8 luglio 2008, si evidenzia che lo stesso<br />
identifica l’area di ubicazione dell’impianto eolico come zona con velocità media compresa<br />
tra 4-5 m/s, senza sovrapposizioni con alcuno dei vincoli riportati nella medesima cartografia.<br />
Elaborazioni Ambiente Italia su base PIER<br />
3.1.4 Il paesaggio<br />
Legenda<br />
L’impianto eolico ricade all’interno di aree sottoposte a vincolo paesaggistico, con riferimento<br />
unicamente alle fasce contermini ai corsi d’acqua pubblici, tutelate per legge ai sensi<br />
dell’articolo 142 del Codice, e solo per la realizzazione di alcune opere connesse.<br />
In dettaglio, si tratta dei seguenti interventi puntuali:<br />
- l’adeguamento della viabilità esistente, in due soli casi, riguardanti la fascia associata<br />
al Fosso Verrocchio ed al Fosso Cosimo;<br />
- l’allestimento della piazzola dell’aerogeneratore n. 82, nella configurazione prevista in<br />
fase di cantiere e per una minima porzione della stessa, che si colloca sul limite della<br />
fascia associata al Fosso Calda;<br />
- la posa del cavidotto interrato, che interessa il F. Cornia in due punti (per un tratto in<br />
affiancamento a viabilità esistente e per il sovrappasso in appoggio al ponte presso<br />
Caselli di Cornia), il Fosso Diavolo (scavalcato in due punti, uno in corrispondenza<br />
della Vecchia Strada Aurelia) ed il già citato Fosso Verrocchio (per il transito lungo<br />
strada esistente).<br />
VERS: 01 2011 PAGINA: 25: 98
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
Per quanto riguarda il cavidotto si evidenzia che non si prevedono modifiche permanenti<br />
dell’aspetto attuale dei luoghi, e quindi ricadute sul bene paesaggistico vincolato, stante la<br />
posa interrata a bordo strada ed ancora, nel caso dell’intersezione con il F. Cornia e con il<br />
Fosso Diavolo (in corrispondenza della Vecchia Aurelia), la possibilità, già definita<br />
progettualmente, di ancoraggio al ponte esistente o di sottopasso dell’alveo con perforazione<br />
teleguidata e non con scavo in trincea; viceversa, per quanto riguarda la seconda<br />
intersezione del Fosso Diavolo, ricadente in area agricola coltivata, il progetto, al momento,<br />
indicativamente contempla una soluzione in sovrappasso che potrebbe essere sostituita, al<br />
fine di escludere trasformazioni rispetto allo stato attuale, con un’identica soluzione di<br />
sottopasso con perforazione teleguidata.<br />
I beni paesaggistici sono assoggettati alla disciplina relativa ai “Paesaggio” di cui agli articoli<br />
31, 34 bis e 34 ter della Disciplina generale del PIT.<br />
Nella seguente tabella si espongono le considerazioni inerenti alla relazione tra la disciplina<br />
dettata dal PIT, nei citati articoli, e l’impianto in progetto.<br />
Disciplina del PIT e relazioni con l’impianto in progetto<br />
Art. 34 bis. Comma 3 e 4<br />
I PTC delle Province formulano indirizzi e criteri. Gli strumenti della pianificazione territoriale dei Comuni<br />
applicano le disposizioni del PIT.<br />
Il PTCP della Provincia di Livorno, approvato nel marzo 2009, è redatto in conformità del PIT ma con riferimento<br />
alla versione antecedente alle modifiche apportate a seguito dell’adozione del giugno 2009. Per quanto attiene al<br />
Piano Strutturale d’Area della Val di Cornia si evidenzia che questo è stato approvato, dai tre Comuni, tra aprile e<br />
giugno 2007, poco prima dell’approvazione del PIT (luglio 2007) e quindi non tiene conto di tale strumento. Il RU,<br />
in attuazione del citato PS, è stato approvato, dal Comune di Campiglia, nel giugno 2011; tale strumento<br />
recepisce il PTCP ed anche il PIT/PPR (integrazione paesaggistica).<br />
Art. 34 bis. Comma 6<br />
Criteri relativi all’ubicazione degli impianti eolici (al di fuori di):<br />
- Siti di interesse archeologico.<br />
- Ambiti di tutela dei monumenti e centri antichi.<br />
- Aree dichiarate di notevole interesse pubblico, di cui all’articolo 136 del Codice.<br />
L’impianto in progetto non ricade in siti di interesse archeologico vincolati in quanto beni culturali, ai sensi del<br />
Codice, come constatato da verifiche effettuate sulla base delle informazioni disponibili sul sito della Regione<br />
Toscana – Sistema Informativo Territoriale Beni Culturali e Paesaggistici e sulla lettura delle tavole e degli elenchi<br />
contenuti nel PTC della Provincia di Livorno, nel Piano d’Area della Val di Cornia e nel RU del Comune di<br />
Campiglia Marittima.<br />
In base alle informazioni acquisite, anche attraverso il sito della Regione Toscana, nella sezione relativa al<br />
Sistema Informativo Governo Territorio Ambiente, dove è riportata la ricognizione delle aree tutelate per legge ai<br />
sensi dell’articolo 142 del Codice, non risultano individuate zone archeologiche tutelate in corrispondenza del sito<br />
di ubicazione degli aerogeneratori, della stazione utente e delle diverse opere connesse (viabilità, cavidotto ed<br />
aree di cantiere).<br />
Con riferimento, inoltre, alla definizione di zone di interesse archeologico di cui alla lettera m), dell’articolo 3 della<br />
Disciplina specifica del PIT, in base alle informazioni rese disponibili, in particolare a quelle riportate nel PS<br />
d’Area e nel RU di Campiglia Marittima, non risulta che le aree interessate dagli interventi sono oggetto di<br />
provvedimenti di riconoscimento dell’interesse archeologico.<br />
L’impianto in progetto e le opere connesse non ricadono in ambiti di tutela dei monumenti e centri antichi.<br />
L’impianto in progetto e le opere connesse non ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico a seguito di<br />
specifica dichiarazione del notevole interesse pubblico.<br />
Art. 34ter Comma 2<br />
Itinerari storico culturali riconosciuti ai fini della tutela:<br />
- via Francigena e relative diramazioni;<br />
- tracciati della difesa del territorio (via dei Cavalleggeri);<br />
- strade della transumanza;<br />
- percorsi del lavoro (vie del ferro, del sale, del marmo) e della fede.<br />
L’impianto in progetto e le opere connesse non ricadono in un’area interessata dalla presenza dei citati itinerari; si<br />
precisa che la via dei Cavalleggeri si sviluppa lungo il litorale tra S. Vincenzo ed il Golfo di Baratti, raggiungendo<br />
poi, come da tracciato riportato sulle tavole del PTCP, il centro di Piombino, senza attraversare l’area di<br />
ubicazione dell’impianto ed ovviamente senza essere interessata degli interventi previsti.<br />
PAGINA: 26: 98 2011 COD: 11V071
RELAZIONE PAESAGGISTICA<br />
Per quanto riguarda il rimando (art. 31) al Quadro conoscitivo ed alle Schede dei Paesaggi,<br />
si considera la parte relativa all’individuazione degli obiettivi di qualità e correlate azioni, nel<br />
successivo paragrafo, si riporta quanto contenuto nelle citate schede, verificando le relazioni<br />
con l’impianto di progetto, complessivamente inteso.<br />
3.1.4.1 Le Schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità<br />
Le Schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità, relative ad ogni Ambito di<br />
paesaggio, sono articolate in diverse sezioni: la sezione 1, di riconoscimento dei caratteri<br />
strutturali del paesaggio; la sezione 2, di riconoscimento dei valori; la sezione 3, relativa ai<br />
“funzionamenti, dinamiche, obiettivi di qualità, azioni prioritarie” che contiene appunto<br />
l’individuazione dei valori correlati agli obiettivi ed azioni; la sezione 4, relativa<br />
all’individuazione dei beni paesaggistici soggetti a tutela con specifico provvedimento di<br />
riconoscimento del notevole interesse pubblico. Gli obiettivi di qualità, riportati nella Sezione<br />
3 della Scheda, sono raggruppati con riferimento a tre categorie, quella degli elementi<br />
costitutivi naturali, degli elementi costitutivi antropici e degli insediamenti e infrastrutture, e<br />
secondo l’associazione ai valori di tipo naturalistico, storico-culturale, estetico-percettivo.<br />
Il Comune di Campiglia Marittima ed il Comune di Piombino, assieme a quelli di Follonica,<br />
San Vincenzo, Sassetta e Suvereto, ricadono nell’Ambito di Paesaggio n. 23, denominato<br />
“Val di Cornia”. Nei successivi riquadri si richiamano, in forma sintetica, sia gli obiettivi che le<br />
correlate azioni 5 , come definite per il citato Ambito, stralciando quelle che riguardano valori<br />
evidentemente non relazionati, per collocazione territoriale, con l’area interessata<br />
dall’ubicazione dell’impianto in progetto. Con riferimento agli obiettivi, si verifica se<br />
sussistono relazioni con le opere in progetto ed eventualmente si riportano considerazioni<br />
sulla coerenza mentre, per le azioni, evidenziato che sono formulate come indicazioni rivolte<br />
alla pianificazione provinciale e comunale e che le stesse possono essere state prese in<br />
considerazione solo nel caso del RU del Comune di Campiglia, in quanto di redazione<br />
successiva all’adozione del PIT integrato, si considera se la realizzazione dell’impianto può<br />
costituire pregiudiziale o fattore di ostacolo alla loro attuazione.<br />
Per quanto riguarda gli obiettivi di qualità degli elementi costitutivi naturali si nota che<br />
l’impianto non riguarda ed è ubicato ad una distanza tale dalla fascia costiera che si possono<br />
escludere ricadute dirette sulla stessa; al contempo non sono coinvolte aree caratterizzate<br />
per la presenza della macchia mediterranea e nemmeno zone umide ed inoltre, in entrambi i<br />
casi, i manufatti si collocano in una posizione tale da non interferire nemmeno con le aree<br />
circostanti a tali ambiti (si ritiene ininfluente, sui caratteri della zona di Orti e Palude di<br />
Bottagone, l’intervento di adeguamento dell’incrocio sulla strada della Base Geodetica) e<br />
quindi non si preclude la possibilità di attuare anche gli obiettivi correlati all’incremento degli<br />
elementi di naturalità (Ob4.2). In merito agli ambiti fluviali si osserva che nessuno degli<br />
interventi determina un’alterazione od anche solo una modifica delle caratteristiche attuali dei<br />
corsi d’acqua, tutti regimati, che attraversano la piana, ed allo stesso modo non si prevedono<br />
ricadute sulla vegetazione riparia del reticolo idraulico minore e quindi non si preclude<br />
l’attuazione degli obiettivi paesaggistici (Ob3.3) indicati dal PIT.<br />
5 Per comodità di esposizione si assegna una numerazione progressiva agli obiettivi ed alle azioni, non presente nelle Schede.<br />
VERS: 01 2011 PAGINA: 27: 98
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
Scheda dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità – Ambito 23 “Val di Cornia”<br />
Valori – Macchia mediterranea<br />
Sezione 3 – Obiettivi di qualità e azioni prioritarie - Elementi costitutivi naturali<br />
Obiettivi di qualità<br />
Ob1.1. Tutela del mosaico vegetazionale della macchia mediterranea.<br />
Ob1.2. Incremento del valore naturalistico delle formazioni forestali<br />
Ob1.3. Conservazione dell’estensione e della continuità delle aree boscate e spazi aperti a cespuglieto e prato delle colline di<br />
Riotorto e Montioni.<br />
Azioni prioritarie<br />
Az1.1. La pianificazione comunale per gli ambiti di macchia mediterranea o gariga: dispone il monitoraggio della sua<br />
consistenza e del suo stato di conservazione (..); ne prevede la conservazione (..).<br />
Az1.2. La pianificazione territoriale e di settore della Provincia: individua le aree e i corridoi di connessione che garantiscono la<br />
continuità delle aree boscate e gli elementi vegetazionali tipici, quali siepi e filari alberati (..).<br />
Az1.3. Con riferimento ai SIR “Le Bandite di Follonica” e “Montecalvi di Campiglia”, la Provincia assicura l’applicazione delle<br />
“Principali misure di conservazione” indicate nella DGR 644/2004 (..).<br />
Az1.4. La pianificazione comunale assicura, nella gestione dei procedimenti amministrativi (..) interessanti i SIR “Le Bandite di<br />
Follonica” e “Montecalvi di Campiglia”, l’applicazione delle suddette misure di conservazione. Le politiche di settore promuovono<br />
ed incentivano: azioni di sostegno alle attività agricole (..); adozione di tecniche di ingegneria naturalistica (..).<br />
Valori – Fascia costiera<br />
Obiettivi di qualità<br />
Ob2.1/2.3 (..)<br />
Azioni prioritarie<br />
Az2.1/2.5 (..)<br />
Valori – Ambiti fluviali<br />
Obiettivi di qualità<br />
Ob3.1 Tutela dei corsi d’acqua.<br />
Ob3.2 Conservazione dei caratteri ambientali e degli equilibri ecologici, nell’ambito fluviale del Cornia.<br />
Ob3.3. Tutela della vegetazione riparia del reticolo idraulico minore.<br />
Ob3.4. Combinare politiche tradizionali di protezione del rischio idraulico con quelle di gestione delle risorse naturali.<br />
Azioni prioritarie<br />
Az3.1. La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi e individua negli ambiti fluviali gli elementi di valore<br />
paesaggistico (..) e stabilisce per essi indirizzi per la valorizzazione e conservazione e l’eventuale ripristino; promuove e<br />
incentiva l’adozione di tecniche di ingegneria naturalistica per gli interventi di regimazione delle acque.<br />
Az3.2. La pianificazione comunale promuove per quanto di competenza, la tutela della vegetazione di ripa (..).<br />
Az3.3. Le politiche di settore promuovono e sostengono: la tutela della vegetazione di ripa ed in generale la conservazione e<br />
valorizzazione degli ambiti fluviali (..); l’adozione di interventi tradizionali di protezione del rischio idraulico combinati con<br />
interventi di gestione delle risorse naturali.<br />
Valori – Zone umide<br />
Obiettivi di qualità<br />
Ob4.1. Mantenimento e ampliamento delle zone umide.<br />
Ob4.2. Mantenimento degli ambienti naturali e seminaturali esistenti nelle zone umide e mantenimento/incremento degli<br />
elementi di naturalità presenti nelle aree circostanti.<br />
Ob.4.3. Miglioramento della gestione idraulica nelle aree umide e della qualità delle acque.<br />
Azioni prioritarie<br />
Az4.1. La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi e individua nelle zone umide gli ambiti di permanenza dei<br />
caratteri di naturalità e il loro grado di conservazione, stabilisce per essi indirizzi per la valorizzazione e conservazione e<br />
l’eventuale ripristino.<br />
Az4.2/4.3 (..)<br />
Valori – Fascia costiera tra il golfo di Baratti e il golfo di Salivoli<br />
Obiettivi di qualità<br />
Ob5.1/5.3 (..)<br />
Azioni prioritarie<br />
Az 5.1 (..)<br />
Per quanto attiene agli obiettivi degli elementi costitutivi antropici si considera quello della<br />
conservazione del reticolo idraulico (Ob1.1), associato ai valori degli appoderamenti e corsi<br />
d’acqua, dato che l’impianto si colloca all’interno della vasta area della bonifica del basso<br />
Cornia, caratterizzata dal reticolo delle scoline irrigue e dalla presenza dei fossi rettificati<br />
dalle opere idrauliche di regimazione; con riferimento a tale obiettivo si evidenzia che le<br />
opere previste, in particolare quelle di realizzazione di nuovi tratti di viabilità per l’accesso<br />
alle piazzole, si adattano, in larga misura, al disegno geometrico delle scoline e per tale<br />
motivo non si determinano modifiche strutturali di tale matrice storica di formazione del<br />
PAGINA: 28: 98 2011 COD: 11V071
RELAZIONE PAESAGGISTICA<br />
paesaggio rurale, derivante delle opere di bonifica idraulica. Anche per quanto attiene<br />
all’obiettivo Ob2.1, correlato ai valori del paesaggio agricolo, si osserva che gli interventi non<br />
inficiano il perseguimento del fine di mantenere gli elementi strutturanti il paesaggio rurale,<br />
considerato che non si cancellano i singoli segni e non si destruttura la configurazione<br />
derivante dalla trama della viabilità poderale storica, grazie ad un disegno dei tracciati dei<br />
tratti di strade da realizzare che, nella gran parte dei casi, riprende gli orientamenti dettati<br />
dagli assi viari principali e dalle suddivisioni particellari; si precisa, inoltre, che l’area<br />
occupata dalle piazzole si riduce, al termine della fase di cantiere, grazie agli interventi di<br />
recupero del suolo, e che nella configurazione finale, per quanto possibile, si tiene conto<br />
della trama rurale. Le opere che riguardano le aree a vincolo paesaggistico, per altro,<br />
trattandosi di adeguamenti delle strade e di posa interrata del cavidotto (o in appoggio a<br />
manufatti), non comportano ricadute sulla configurazione attuale del reticolo idraulico.<br />
Scheda dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità – Ambito 23 “Val di Cornia”<br />
Sezione 3 – Obiettivi di qualità e azioni prioritarie - Elementi costitutivi antropici<br />
Valori – Sistema degli appoderamenti – Sistema dei percorsi d’acqua<br />
Obiettivi di qualità<br />
Ob1.1. Conservazione del reticolo idraulico della pianura alluvionale del Cornia (..).<br />
Ob1.2. Tutela e valorizzazione delle fattorie e delle opere d’arte attinenti alle sistemazioni idraulico agrarie della bonifica.<br />
Azioni prioritarie<br />
Az1.1. La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento e individua gli ambiti della trama del sistema della<br />
bonifica e ne definisce gli indirizzi di conservazione e valorizzazione.<br />
Az1.2. Gli strumenti di pianificazione e gli atti di governo del territorio comunali:<br />
- individuano il sistema dei percorsi d’acqua creati per la regimazione delle acque nel contesto delle bonifiche,<br />
interessante tutta la pianura della Val di Cornia;<br />
- perimetrano le aree caratterizzate da vegetazione ripariale delle sponde dei principali corsi d’acqua;<br />
- dispongono la tutela dei manufatti, delle fattorie, dei poderi e degli annessi attinenti al sistema della bonifica (..).<br />
Az1.3. Le politiche di settore promuovono e incentivano: la conservazione e valorizzazione del sistema dei percorsi d’acqua<br />
creati per la regimazione delle acque nel contesto delle bonifiche; gli interventi di rinaturalizzazione o il potenziamento della<br />
vegetazione ripariale delle sponde dei principali corsi d’acqua.<br />
Valori – Paesaggio agricolo<br />
Obiettivi di qualità<br />
Ob2.1. Mantenimento degli elementi strutturanti il paesaggio rurale (sistemazioni idrauliche, equipaggiamento vegetale, trama<br />
viaria agricola, strade, muretti a secco, terrazzamenti e ciglionamenti).<br />
Ob2.2. Conservazione degli assetti rurali del territorio agricolo di pianura.<br />
Ob2.3. Conservazione, del mosaico delle aree boscate e dei coltivi delle colline e tutela delle colture arboree connotanti il<br />
paesaggio, quali gli oliveti<br />
Ob2.4. Tutela dei caratteri di ruralità espressi dalle modalità insediative e dalle tipologie architettoniche.<br />
Azioni prioritarie<br />
Az2.1 La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento e individua gli ambiti di permanenza degli assetti<br />
agrari tipici e i caratteri strutturali degli insediamenti e della viabilità rurale.<br />
Az2.2. La pianificazione comunale:<br />
- individua le sistemazioni agrarie storiche o di valore identitario (..);<br />
- individua gli elementi della struttura profonda di impianto del paesaggio agrario e il loro grado di conservazione (..);<br />
- individua le componenti paesaggistiche (..) e nelle zone collinari i principali elementi persistenti del paesaggio storico<br />
agrario (..).<br />
Az2.3. L’amministrazione comunale (..): assicura (..) l’applicazione di misure di conservazione e comunque favorisce e incentiva<br />
la permanenza del valore così come riconosciuto; dispone misure volte ad evitare che l’introduzione di attività ricettive turisticoalberghiere<br />
vada a sminuire il valore storico ambientale del paesaggio agricolo.<br />
Az2.4. Le politiche di settore provinciali di gestione delle risorse forestali e la pianificazione territoriale comunale (..) agevolano il<br />
recupero colturale delle aree che hanno subito processi di estensione del bosco, precedentemente coltivate ad oliveto<br />
terrazzato o altre colture, alle quali sia riconosciuto valore paesaggistico prevalente rispetto a quello di area forestale.<br />
Az2.5. Le politiche di sviluppo promuovono ed incentivano: la conservazione e la valorizzazione delle sistemazioni agrarie<br />
storiche o di valore identitario; la conservazione e la valorizzazione degli elementi di permanenza della struttura profonda di<br />
impianto del paesaggio agrario (..).<br />
Con riferimento agli obiettivi degli insediamenti e infrastrutture si sottolinea, innanzitutto, che<br />
nessuna delle opere ricade in aree di interesse archeologico riconosciute e tutelate ed in<br />
particolare gli aerogeneratori si posizionano ad una distanza minima di circa 3 km dalla più<br />
vicina zona archeologica vincolata (località Poggio Malassarto), da questa separati per<br />
interposta presenza della linea ferroviaria, della S.P. n. 23 ed anche della zona urbanizzata<br />
all’interno dell’area agricola, in località podere S. Chiara e podere S. Francesco, oggetto di<br />
condono nel 1985 (situazione analoga a quella del più vicino tra gli interventi ricadenti nelle<br />
VERS: 01 2011 PAGINA: 29: 98
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
fasce a vincolo paesaggistico, di attraversamento del F. Cornia da parte del cavidotto<br />
d’impianto); la citata ubicazione consente di escludere ricadute che possono inficiare il<br />
perseguimento dell’obiettivo Ob6.1, di valorizzazione dei tre più importanti siti archeologici<br />
presenti all’interno di tale Ambito di Paesaggio.<br />
Scheda dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità – Ambito 23 “Val di Cornia”<br />
Sezione 3 – Obiettivi di qualità e azioni prioritarie – Insediamenti e infrastrutture<br />
Valori – Dotazione ambientale all’interno delle strutture urbane<br />
Obiettivi di qualità<br />
Ob1.1/1.2 (..)<br />
Azioni prioritarie<br />
Az1.1/1.2 (..)<br />
Valori – Porto commerciale e passeggeri di Piombino<br />
Obiettivi di qualità<br />
Ob2.1/2.2 (..)<br />
Azioni prioritarie<br />
Ob2.1 (..)<br />
Valori – Aggregati e centri minori – Ambito rurale adiacente ai centri storici ed aggregati<br />
Obiettivi di qualità<br />
Ob3.1. Tutela dei centri antichi e degli aggregati nella loro configurazione storica, estesa all’intorno territoriale ad essi adiacente<br />
e salvaguardia della loro integrità storica e culturale e delle visuali panoramiche da essi offerta.<br />
Ob3.2. Riqualificazione ambientale e urbanistica delle aree di contatto tra la città di Piombino e le aree industriali delle<br />
acciaierie.<br />
Azioni prioritarie<br />
Az3.1. La pianificazione provinciale: elabora i quadri conoscitivi di riferimento, individua i centri antichi e degli aggregati storici di<br />
valore storico culturale e detta i relativi indirizzi di tutela dell’integrità dei valori; dispone che per l’installazione di nuove<br />
infrastrutture per il trasporto dell’energia vengano utilizzati corridoi infrastrutturali esistenti appositamente individuati ed ove (..)<br />
non fattibile, valutano comunque le migliori soluzioni, compreso l’interramento, al fine di rendere minima la percezione visiva e<br />
favorire le successive operazioni di manutenzione.<br />
Az3.2. La pianificazione comunale:<br />
- individua l’intorno territoriale di tutela dell’integrità dei valori storico culturali dei centri urbani, degli aggregati e dei<br />
nuclei insediativi di valore storico o comunque identitario;<br />
- (..)<br />
- individua e, per quanto di competenza, sottopone a specifica disciplina di tutela le aree agricole a corona degli<br />
insediamenti e la relazione tra gli usi del suolo e la maglia agraria tradizionale, favorendo l’uso agricolo del suolo;<br />
- (..).<br />
Az3.3. Le politiche di sviluppo promuovono ed incentivano azioni finalizzate a salvaguardare la relazione tra gli usi del suolo e la<br />
maglia agraria tradizionale nelle aree agricole a corona degli insediamenti.<br />
Valori – Sistema difensivo costiero, ville e giardini, case coloniche, complessi religiosi, castelli<br />
Obiettivi di qualità<br />
Ob4.1. Tutela del patrimonio diffuso di architetture storiche (..).<br />
Ob.4.2. Tutela (anche dei rapporti visuali) del sistema delle torri e forti di avvistamento e individuazione di un’area di rispetto e/o<br />
di servizio per la fruizione culturale del bene.<br />
Ob.4.3. Tutela del sistema delle Pievi.<br />
Ob4.4. Riconoscimento e tutela delle alberature aventi valore di testimonianza storica.<br />
Azioni prioritarie<br />
Az4.1. La pianificazione provinciale elabora i quadri conoscitivi di riferimento, individua i sistemi degli edifici civili, militari e<br />
religiosi di valore storico culturale e detta gli indirizzi di tutela della loro integrità e per la loro valorizzazione.<br />
Az4.2. La pianificazione comunale:<br />
- tutela l’integrità delle ville storiche, residenze padronali e giardini, castelli, sistema delle torri e forti di avvistamento,<br />
sistema delle pievi e case coloniche (..), ed estende tale tutela ad adeguati intorni territoriali;<br />
- valorizza il sistema dei castelli e delle ville storiche di pregio architettonico (..).<br />
- (..).<br />
Valori – Viabilità storica, anche di matrice rurale<br />
Obiettivi di qualità<br />
Ob5.1. Tutela e valorizzazione della rete della viabilità storica (vecchia Aurelia e via dei Cavalleggeri) compresi i percorsi storici<br />
di matrice rurale (..).<br />
Azioni prioritarie<br />
Az5.1. La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, individua la viabilità storica, anche di matrice<br />
rurale, e detta i relativi indirizzi di tutela (..).<br />
Az5.2. La pianificazione comunale (..) dispone la manutenzione e la riqualificazione delle sistemazioni e degli arredi delle aree<br />
contigue alla viabilità storica (..).<br />
segue<br />
PAGINA: 30: 98 2011 COD: 11V071
RELAZIONE PAESAGGISTICA<br />
L’impianto eolico in progetto, considerando la posizione degli aerogeneratori, si colloca<br />
all’interno della piana del Cornia in posizione distante rispetto a quella dei principali centri<br />
antichi, Campiglia Marittima (distacco minimo di circa 5,4 km) e Piombino (distacco minimo<br />
di circa 7 km), ed anche dal più significativo degli aggregati minori, Populonia (distacco<br />
minimo circa 4 km); si possono ragionevolmente escludere (anche considerando gli<br />
interventi puntuali ricadenti nelle fasce dei corsi d’acqua a vincolo paesaggistico, per<br />
distanza e soluzioni di progetto) variazioni dei caratteri dell’intorno territoriale di tali<br />
insediamenti storici. L’opera in progetto si ritiene che, nell’insieme e certamente con<br />
riferimento agli interventi in aree vincolate, non si pone in contrasto con l’obiettivo Ob3.1, di<br />
salvaguardia dell’integrità storica culturale del nuclei e delle visuali che si hanno da tali<br />
centri.<br />
Scheda dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità – Ambito 23 “Val di Cornia”<br />
Sezione 3 – Obiettivi di qualità e azioni prioritarie – Insediamenti e infrastrutture<br />
Valori – Aree e insediamenti di valore archeologico<br />
Obiettivi di qualità<br />
Ob6.1.Tutela, restauro e valorizzazione (..) delle aree archeologiche del promontorio di Populonia, Golfo di Baratti e San<br />
Silvestro.<br />
Ob6.2. Tutela del sistema insediativi difensivo di età ellenistica (..).<br />
Azioni prioritarie<br />
Az6.1. La pianificazione comunale (..) definisce specifici ambiti di rispetto e le misure per tutelare le emergenze di valore<br />
archeologico e paleontologico in contesti di pregio paesaggistico e per la valorizzazione dei relativi siti (..)<br />
Valori – Parco Archeo-Minerario di San Silvestro<br />
Obiettivi di qualità<br />
Ob7.1 (..)<br />
Azioni prioritarie<br />
Az7.1/7.2 (..)<br />
Valori – Strade panoramiche<br />
Obiettivi di qualità<br />
Ob8.1. Tutela delle visuali panoramiche percepite dalle strade riconosciute panoramiche (..)<br />
Azioni prioritarie<br />
Az8.1. La pianificazione provinciale fornisce i quadri conoscitivi di riferimento, individua la viabilità storica e le strade<br />
panoramiche e detta i relativi indirizzi di tutela.<br />
Az8.2. La pianificazione comunale dispone misure di riqualificazione delle sistemazioni delle aree contigue alle strade<br />
panoramiche per assicurare la tutela delle visuali da esse godute; assicura analoga qualità estetico percettiva, funzionale ed<br />
ambientale nella realizzazione delle nuove infrastrutture per la mobilità.<br />
Valori – Borghi rurali, versanti collinari fra edificato e fondovalle, fasce al piede delle colline, castelli, sistema delle torri<br />
e forti di avvistamento, sistema delle pievi e altri complessi religiosi, centri capoluogo di comune, ville e giardini, case<br />
coloniche<br />
Obiettivi di qualità<br />
Ob9.1 Tutela dei centri antichi, degli aggregati, degli edifici e dei manufatti ai quali di riconosciuto (..) valore estetico percettivo<br />
(..).<br />
Azioni prioritarie<br />
Az9.1. La pianificazione provinciale elabora i quadri conoscitivi di riferimento, individua i centri urbani, gli aggregati, gli edifici e i<br />
manufatti di valore estetico percettivo o che consentono visuali panoramiche e dispone indirizzi per la riqualificazione delle<br />
sistemazioni delle aree contigue (..).<br />
Az9.2. La pianificazione comunale: individua l’intorno territoriale dei centri urbani e degli aggregati ai fini della definizione di<br />
specifiche norme di tutela della percezione visuale (..); dispone che le nuove addizioni insediative (..) siano adiacenti al<br />
perimetro consolidato dell’insediamento (..); dispone che sia specificatamente controllata la dimensione d’intervento (..).<br />
Valori – Cave dismesse<br />
Obiettivi di qualità<br />
Ob10.1 (..)<br />
Azioni prioritarie<br />
Az10.1/10.4 (..)<br />
Valori – Porti turistici<br />
Obiettivi di qualità<br />
Ob11.1 (..)<br />
Azioni prioritarie<br />
Az11.1 (..)<br />
VERS: 01 2011 PAGINA: 31: 98
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
La prevista posa della linea elettrica per la connessione alla rete in cavidotto interrato è<br />
inoltre coerente con l’indicazione di cui all’azione Az3.1, relativa alle modalità di<br />
realizzazione delle nuove infrastrutture per il trasporto dell’energia; in un contesto territoriale<br />
già segnato dalla presenza di numerosi elettrodotti ed associati tralicci di sostegno, si evita di<br />
aggiungere una nuova linea aerea. In aggiunta, si evidenzia che non si prevede una linea<br />
esterna per il breve tratto tra la stazione utente AT/MT ed il punto di connessione, presso la<br />
prevista sottostazione, associata all’elettrodotto che raggiunge Piombino, situata a nord della<br />
frazione Montegemoli.<br />
Per quanto attiene ai valori associati al sistema difensivo costiero si precisa che gli<br />
aerogeneratori sono ubicati lontani dalle più vicine Torre del Sale (distanza minima di circa 4<br />
km), Torre di Barattti (distanza minima di circa 3 km) e Torre del Castello di Polulonia<br />
(distanza minima di circa 4 km), per cui si possono escludere interferenze con l’area<br />
circostante, che si prevede di tutelare e valorizzare (Ob4.2), ed anche ricadute sotto il profilo<br />
percettivo, considerando i coni visivi associati ai luoghi dai quali è possibile inquadrare, nella<br />
migliore prospettiva, le citate torri del sistema difensivo costiero.<br />
Per quanto riguarda la viabilità storica si precisa che non sono previste opere sulla via dei<br />
Cavalleggeri e che la posa del cavidotto interrato lungo l’antica via Aurelia (per un breve<br />
tratto della stessa) non comporta alcuna modifica dei caratteri di tale strada strada ed in<br />
particolare si mantiene invariato il tracciato e la dotazione dei manufatti o delle essenze<br />
vegetali associate, ponendosi quindi in situazione di coerenza con quanto indicato dal PIT,<br />
con l’obiettivo Ob5.1 di tutela e valorizzazione di tale rete. Allo stesso modo, considerando<br />
l’obiettivo Ob8.1, la posizione degli aerogeneratori è tale da non riguardare le fasce attigue<br />
alle strade panoramiche riconosciute e da non determinare una chiusura delle visuali dalle<br />
stesse, con particolare riferimento sia a quella coincidente con la già citata via dei<br />
Cavalleggeri, che si sviluppa lungo il litorale, a sud di San Vincenzo, passando poi per la<br />
frazione di Fiorentina (S.P. n. 23) fino a raggiungere Piombino, sia alla S.P. n. 23ter, che<br />
dalla variante dell’Aurelia raggiunge il Golfo di Baratti, incrociando la stessa SP n. 23,<br />
entrambe segnalate negli elaborati del PTCP (tavola 2.1). Alle citate strade si aggiunge<br />
quella indicata nella tavola C, la nuova S.S. n. 1, segnalata per le aperture delle visuali, sia<br />
verso la zona agricola della piana del Cornia, sia verso i rilievi collinari.<br />
3.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Provincia di Livorno<br />
3.2.1 Riferimenti generali<br />
La L.R. 3.1.2005. n. 1, “Norme per il governo del territorio”, individua, quale strumento di<br />
pianificazione per il livello provinciale, il Piano territoriale di coordinamento (PTC) provinciale<br />
(art. 9). L’articolo 51 della citata legge regionale, definisce i contenuti del PTC provinciale e<br />
stabilisce che contiene lo Statuto del Territorio, previsto dal precedente articolo 5. Tale<br />
Statuto, in relazione al territorio provinciale, individua e definisce: i sistemi territoriali e<br />
funzionali che determinano la struttura del territorio; le invarianti strutturali; i criteri di<br />
utilizzazione delle risorse essenziali; i livelli minimi prestazionali e di qualità, con riferimento a<br />
ciascuno dei sistemi territoriali e funzionali; i criteri per la riqualificazione e la valorizzazione<br />
dei paesaggi e l’individuazione e descrizione degli ambiti paesaggistici di interesse unitario<br />
provinciale ed i relativi obiettivi di qualità paesaggistica; gli ambiti paesaggistici di rilievo<br />
sovracomunale. In base al citato articolo 5 della L.R. 1/2005, lo Statuto del Territorio, inoltre,<br />
assume e ricomprende le invarianti strutturali, queste ultime definite, all’articolo 4, quali<br />
elementi cardine dell’identità dei luoghi; inoltre, gli strumenti di pianificazione territoriale,<br />
tenendo conto dello Statuto, definiscono gli obiettivi, gli indirizzi e le azioni progettuali<br />
strategiche. Per quanto riguarda le invarianti strutturali, come definite all’articolo 4, si tratta<br />
delle risorse, dei beni e delle regole relative all’uso, individuati dallo Statuto del Territorio, ed<br />
anche dei livelli di qualità e delle prestazioni minime da sottoporre a tutela, al fine di garantire<br />
lo sviluppo sostenibile.<br />
PAGINA: 32: 98 2011 COD: 11V071
RELAZIONE PAESAGGISTICA<br />
Il PTC provinciale, sempre in base all’articolo 51, delinea la strategia di sviluppo territoriale<br />
della Provincia attraverso l’individuazione anche: degli obiettivi e degli indirizzi dello sviluppo<br />
territoriale con le conseguenti azioni, sulla base del Piano di Indirizzo Territoriale; degli<br />
immobili di notevole interesse pubblico di interesse sovracomunale, di cui all’art. 32 (quelli<br />
del D.lgs 42/2004); degli indirizzi sull’articolazione e sulle linee di evoluzione dei sistemi<br />
territoriali individuati nello Statuto; degli indirizzi, criteri e parametri per l’applicazione<br />
coordinata delle norme relative al territorio rurale (art. 39/47); dei criteri e degli indirizzi per le<br />
trasformazioni dei boschi, ai sensi dell’art. 41 della L.R. 39/2000. Il PTC provinciale, inoltre,<br />
stabilisce: le prescrizioni per la finalizzazione ed il coordinamento delle politiche di settore e<br />
strumenti di programmazione provinciali; le prescrizioni per gli ambiti territoriali inerenti alla<br />
localizzazione degli interventi di competenza provinciale; le misure di salvaguardia<br />
immediatamente efficaci.<br />
La Provincia di Livorno ha approvato, con D.C.P. n. 52 del 25.3.2009, pubblicata sul BURT<br />
n. 20 del 20.5.09 – Parte II, il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC).<br />
Il PTC assume le finalità ed i principi generali espressi al Titolo I, Capo I, della L.R. 1/2005<br />
ed è atto di pianificazione del territorio che: definisce lo Statuto del territorio ed i criteri per la<br />
verifica di compatibilità di strumenti di pianificazione ed atti di governo con le regole, vincoli e<br />
prescrizioni dello stesso Statuto; definisce la strategia di sviluppo territoriale; finalizza e<br />
coordina le politiche di settore e gli strumenti di programmazione provinciali, stabilendo<br />
prescrizioni per la localizzazione degli interventi di propria competenza; stabilisce misure di<br />
salvaguardia per i casi previsti dalla legge regionale.<br />
La disciplina di attuazione del PTC, redatta in applicazione del D.lgs 267/2000 e della L.R.<br />
1/2005, nonché in conformità con i contenuti del Piano di Indirizzo territoriale (PIT) della<br />
Regione Toscana, approvato con D.C.C. 72 del 24.7.2007, si articola, come contenuti (art. 3<br />
della stessa Disciplina), in:<br />
- definizioni, identificazione univoca dell’oggetto delle disposizioni e con eventuale<br />
riferimento agli elaborati grafici dello stesso Piano;<br />
- obiettivi, iferimenti sostanziali per la programmazione e per gli atti di governo della<br />
Provincia, nonché per la pianificazione comunale;<br />
- indirizzi, orientamenti finalizzati al conseguimento degli obiettivi;<br />
- criteri e direttive, regole da recepire per la formazione degli strumenti di pianificazione e<br />
degli atti di governo del territorio e per la definizione dei loro contenuti nonché per la loro<br />
valutazione integrata e per il monitoraggio periodico;<br />
- prescrizioni; disposizioni cogenti relative alla finalizzazione ed al coordinamento delle<br />
politiche di settore ed alla individuazione degli ambiti territoriali per la localizzazione di<br />
interventi di competenza provinciale ai quali devono dare attuazione o conformarsi,<br />
rispettivamente, gli strumenti della programmazione, i piani di settore e gli altri atti di<br />
governo del territorio provinciali ed i Piani Strutturali e atti di governo di competenza<br />
comunale.<br />
Il PTC, per quanto riguarda la classificazione delle aree a rischio idraulico, esondate ed<br />
esondabili, rinvia ai PAI del Bacino dell’Arno e del Bacino Regionale Toscana Costa, che la<br />
Provincia ha recepito con atto D.C.P. n. 107 del 13.7.2006. Il PTC, inoltre, recepisce la<br />
disciplina nazionale e regionale sulla tutela dei beni paesaggistici d’interesse unitario<br />
regionale, come definiti all’articolo 31 della disciplina del PIT.<br />
La disciplina del Piano stabilisce che gli strumenti di pianificazione territoriale dei Comuni e<br />
gli atti di governo del territorio di ogni soggetto pubblico si conformano a quanto disposto dal<br />
PTC, per quanto attiene ai criteri stabiliti per la conoscenza dello stato del territorio, la<br />
formazione coordinata degli strumenti ed atti di governo territoriale, la valutazione integrata e<br />
la verifica periodica, ed al contempo dimostrano il rispetto delle invarianti strutturali<br />
individuate dal PTC e la piena coerenza delle scelte statutarie, strategiche ed operative con i<br />
contenuti del PTC. I Comuni, inoltre, danno attuazione al PTC con i Piani Strutturali e gli atti<br />
di governo del territorio, di loro competenza, verificando ed integrando il quadro conoscitivo<br />
VERS: 01 2011 PAGINA: 33: 98
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
del PTC, ed adeguano lo stesso PS; le previsioni vigenti in contrasto con il PTC sono<br />
soggette alle misure di salvaguardia, ai sensi dell’articolo 61 della L.R. 1/2005.<br />
Il PTC è composto dai seguenti documenti:<br />
- Quadro conoscitivo, comprendente una serie di elaborati tra i quali i diversi piani e studi<br />
di settore provinciali e regionali e le elaborazioni dei caratteri del paesaggio del territorio<br />
provinciale (Tavole Analitiche Tematiche, Elaborazioni Dignostiche, Atlante dei paesaggi,<br />
<strong>Relazione</strong>);<br />
- Documento di Piano, che costituisce elemento di indirizzo e riferimento per la disciplina<br />
del PTC;<br />
- Disciplina di attuazione;<br />
- Disciplina dei valori e degli obiettivi di qualità paesaggistica;<br />
- Elaborati di progetto, costituiti da una serie di carte, una relativa ai sistemi territoriali,<br />
nove riguardanti i sistemi funzionali (produttivo,della rete della cultura, della rete dei<br />
servizi, delle infrastrutture, dei nodi, delle aree protette, dei collegamenti extraurbani, del<br />
trasporto dell’energia elettrica, dei rifiuti), una inerente ai valori statutari del paesaggio ed<br />
infine una sulle strategie paesaggistiche di governo del territorio.<br />
Gli obiettivi generali del PTC, come elencati all’articolo 15 della Disciplina, sono i seguenti:<br />
- la tutela, valorizzazione e gestione sostenibile delle risorse territoriali ed ambientali (..);<br />
- lo sviluppo di un sistema di città equilibrato e policentrico (..);<br />
- lo sviluppo della potenzialità dei territori collinari, della fascia costiera e delle aree<br />
agricole nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale ad esse peculiari;<br />
- la crescita di competitività del sistema produttivo provinciale (..);<br />
- la crescita del territorio provinciale come luogo di accoglienza, di coesione e<br />
d’integrazione sociale e di nuove opportunità per le comunità ed i cittadini che vi<br />
risiedono e che la frequentano (..);<br />
- la promozione di un diffuso e stabile livello di qualità della vita urbana e rurale finalizzato<br />
ad assicurare la migliore accessibilità a beni e servizi pubblici e di interesse pubblico (..);<br />
- un adeguato livello di sicurezza delle persone e dei beni rispetto ai fattori di rischio<br />
connessi all’utilizzazione del territorio;<br />
- l’assunzione del paesaggio come valore fondativo, culturale ed attivo, prima ancora che<br />
vincolistico (..);<br />
- una qualità insediativa ed edilizia opportunamente differenziata nei diversi ambiti<br />
territoriali, che garantisca la salvaguardia dell’ambiente naturale, la riduzione dei consumi<br />
energetici, la sanità ed il benessere dei fruitori, l’eliminazione delle barriere<br />
architettoniche, il diritto all’autodeterminazione delle scelte di vita.<br />
Per quanto riguarda lo Statuto del Territorio, come precisato nella Disciplina (artt. 16 e 17),<br />
questo concorre a definire l’impegno delle comunità locali per un uso delle risorse essenziali<br />
del territorio, finalizzata ad affermare e perseguire le esigenze di una migliore qualità della<br />
vita, indicando i processi di sviluppo sostenibile alla scala provinciale.<br />
In dettaglio, il PTC, attraverso tale Statuto:<br />
- individua i Sistemi e Sottosistemi territoriali, i Sistemi funzionali, le invarianti strutturali, le<br />
risorse essenziali del territorio di valenza sovracomunale e quelle per le quali è<br />
necessario formulare indirizzi ed obiettivi per il coordinamento delle politiche territoriali;<br />
- recepisce i vincoli di tutela, le direttive e le prescrizioni statutarie del PIT;<br />
- persegue l’integrazione del paesaggio nelle politiche territoriali;<br />
- concorre a definire interventi di valorizzazione dei paesaggi;<br />
- integra lo statuto del PIT anche al fine di individuare progetti prioritari per la<br />
conservazione, recupero, riqualificazione e gestione del paesaggio;<br />
- ripartisce il territorio in ambiti di paesaggio in conformità con quanto previsto dallo statuto<br />
del PIT, indicando i relativi obiettivi di qualità paesaggistica e definisce da assumere i<br />
criteri per la riqualificazione e la valorizzazione dei paesaggi nella definizione dei PS,<br />
anche ai fini degli artt. 31 e 35 della L.R. 1/2005;<br />
PAGINA: 34: 98 2011 COD: 11V071
RELAZIONE PAESAGGISTICA<br />
- recepisce le previsioni delle infrastrutture ferroviarie e stradali (Piano regionale della<br />
mobilità e della logistica);<br />
- specifica gli elementi da tutelare all’interno degli ambiti sottoposti a tutela e le relative<br />
prescrizioni ad integrazione dello statuto regionale e individua e descrive gli ambiti<br />
paesaggistici di interesse unitario provinciale da sottoporre alla disciplina di<br />
valorizzazione ed i relativi obiettivi di qualità paesaggista.<br />
I Sistemi e Sottosistemi territoriali, definiti in base alle peculiarità fisiche, idro-geomorfologiche,<br />
ambientali ed insediative, individuano la struttura del territorio provinciale<br />
(componenti, risorse essenziali, invarianti strutturali, zone ad esclusiva o prevalente funzione<br />
agricola, ambiti paesaggistici di interesse unitario provinciale); le connotazioni specifiche di<br />
tali sistemi sono riportate nelle schede identificative degli Ambiti di Paesaggio contenute<br />
nell’Atlante dei paesaggi della Provincia di Livorno. I Sistemi, in numero di quattro,<br />
corrispondono a quello della fascia costiera e della pianura, della collina, delle isole, del<br />
mare e linea di costa, mentre i Sottosistemi territoriali sono complessivamente dieci; nella<br />
Tavola 1 sono individuati gli stessi. Tali sistemi devono essere assunti dagli strumenti di<br />
pianificazione territoriale comunale e dagli atti di governo del territorio quali ambiti territoriali<br />
di riferimento per la previsione, programmazione e realizzazione di obiettivi ed interventi di<br />
interesse sovracomunale.<br />
I Sistemi e Sottosistemi funzionali, strumentali all’individuazione della struttura organizzativa<br />
e funzionale del territorio provinciale, di norma sono composti da nodi di funzioni e da reti di<br />
interrelazioni. Il PTC, attraverso la loro definizione, individua una struttura organizzativa<br />
idonea ad assicurare requisiti di attrattività, accoglienza, coesione sociale e territoriale,<br />
dinamicità; individua le linee di evoluzione dei sistemi funzionali e le interconnessioni e<br />
sinergie da attivare fra le diverse componenti; individuare ambiti sovacomunali e<br />
interprovinciali caratterizzati da problematiche comuni e promuovere il coordinamento e<br />
l’integrazione delle politiche di sviluppo sostenibile; stabilire criteri e parametri comuni per<br />
riconoscere le potenzialità presenti, gli elementi di criticità da superare e permettere la<br />
valutazione integrata.<br />
I Sistemi funzionali sono i seguenti:<br />
- degli Insediamenti (tav. 7), articolato nei Sottosistemi “struttura insediativa” e “rete dei<br />
luoghi e spazi della collettività” (tav. 3 e tav. 4) ;<br />
- delle Attività economiche, articolato nei Sottosistemi “produzione di beni e servizi” (tav.<br />
2.1), “agricoltura” (tav. 2.2), “pesca” e “commercio” (tav. 2.1) e “turistico ricettivo” (tav.<br />
2.1);<br />
- delle Reti e dei nodi infrastrutturali, articolato nei Sottosistemi “mobilità e logistica” (tav. 6<br />
e tav. 7), “risorse idriche” (tav. 5), “rifiuti” (tav. 11) e “risorse energetiche” (tav. 10);<br />
- dell’Ambiente o delle Aree protette (tav. 8).<br />
Le invarianti strutturali del territorio sono individuate come le risorse ed i beni riconosciuti<br />
quali elementi cardine dell’identità dei luoghi e, per tale motivo, da sottoporre a tutela al fine<br />
di garantire la sostenibilità dello sviluppo. Le invarianti sono individuate e definite in relazione<br />
ai Sistemi e Sottosistemi territoriali o funzionali; per quelle della risorsa paesaggio,<br />
l’individuazione e la definizione è riportata negli elaborati e nell’apposita disciplina, facente<br />
parte dello stesso PTCP. Alle invarianti strutturali sono associati obiettivi prestazionali che<br />
individuano regole relative al loro uso, livelli di qualità e relative prestazioni minime attese.<br />
Le risorse essenziali del territorio, intese come beni comuni costituenti patrimonio della<br />
collettività, sono associate ad obiettivi, criteri e prestazioni, al fine di promuovere processi di<br />
sviluppo sostenibile alla scala provinciale. Le risorse, individuate ed oggetto di disciplina,<br />
sono le seguenti: l’aria, comprensiva dell’inquinamento acustico, luminoso ed<br />
elettromagnetico; l’acqua; il suolo, comprensivo degli arenili e degli approdi turistici; gli<br />
ecosistemi della flora e della fauna; la città ed il sistema degli insediamenti, comprensivo<br />
della mobilità urbana e del traffico; il paesaggio ed i documenti della cultura.<br />
VERS: 01 2011 PAGINA: 35: 98
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
Per quanto attiene al Paesaggio, oggetto di considerazione specifica, si definiscono sia i<br />
sistemi di paesaggio che le risorse, le ultime distinte con riferimento a valori naturalisticiecosistemici,<br />
storico culturali ed estetico percettivi, e si rimanda, sotto il profilo disciplinare,<br />
ad una serie di elaborati riguardanti la Risorsa Paesaggio che comprendono: le Norme<br />
Tecniche di Attuazione (Statuto del Territorio/Strategia di Piano); la Tavola delle Strategie<br />
Paesaggistiche e le tavole dei valori paesaggistici; il documento sulle Invarianti, facente<br />
sempre parte dello Statuto del Territorio, che contiene l’identificazione cartografica delle<br />
stesse, articolata secondo le nove identità paesaggistiche riconosciute.<br />
Il PTCP definisce le strategie di sviluppo territoriale, con riferimento all’attivazione di processi<br />
su temi ed obiettivi di interesse regionale, elencati dalla stessa disciplina, e promuovendo la<br />
formazione del sistema di relazione delle aree protette, come rete di paesaggi ed ambienti<br />
da salvaguardare e valorizzare. In particolare, sono individuati tre assi strategici<br />
complementari, per i quali si formula una strategia di piano unitaria ed integrata per la<br />
valorizzazione del patrimonio paesaggistico della provincia. Tali assi sono: A – sistema di<br />
relazione dei paesaggi protetti; B – sistema turistico-ricreativo delle green way; C – diversità<br />
paesaggistiche della costa. Il PTC, al contempo, definisce il “Programma strategico per<br />
l’organizzazione della rete dei luoghi e degli spazi della collettività” ed articola le strategie<br />
della competitività territoriale sia per sistemi territoriali, sia facendo riferimento ai sistemi<br />
funzionali. In ultimo il PTC definisce i raccordi con i piani di settore e le strategie per la<br />
governance.<br />
3.2.2 Relazioni tra PTCP ed interventi ricadenti nei beni paesaggistici<br />
Gli interventi che ricadono all’interno dei beni paesaggistici associati ai corsi d’acqua, in base<br />
alla lettura degli elaborati cartografici, riguardano alcune delle categorie identificate,<br />
delimitate e sottoposte a specifica normativa dal Piano. Inoltre, si riconoscono relazioni di<br />
ordine complessivo tra l’impianto di progetto ed alcuni degli aspetti generali oggetto di<br />
disciplina e non declinati anche in identificazioni di elementi territoriali. Nella successiva<br />
tabella si evidenzia la relazione tra le categorie di Piano, interessate dagli interventi<br />
riguardanti le aree vincolate, facenti parte dei sistemi territoriali e dei sistemi funzionali<br />
(invarianti).<br />
PTC Provincia di Livorno - Sistemi territoriali e Sistemi funzionali<br />
Categorie interessate dagli interventi ricadenti nei beni paesaggistici vincolati<br />
Elaborati di Progetto Categoria Interventi<br />
Tavola 1<br />
- Sottosistema urbano di Piombino e della pianura Tutti gli interventi.<br />
Sistemi territoriali<br />
meridionale del Cornia<br />
Tavola 2.1<br />
Sistema funz. produttivo (.., turismo, ..)<br />
(nessuna categoria direttamente interessata) -<br />
Tavola 2.2<br />
Sistema funz. produttivo (agricolo)<br />
- Eccellenze agricole Tutti gli interventi<br />
Tavola 3<br />
Sistema funz. rete della cultura<br />
(nessuna categoria direttamente interessata) -<br />
Tavola 4<br />
Sistema funz. rete dei servizi<br />
(nessuna categoria direttamente interessata) -<br />
Tavola 5<br />
Sistema funz. delle acque<br />
(nessuna categoria direttamente interessata) -<br />
Tavola 6<br />
Sistema funz. delle infrastrutture<br />
(nessuna categoria direttamente interessata) -<br />
Tavola 7<br />
Sistema funz. delle reti e nodi<br />
(nessuna categoria direttamente interessata) -<br />
Tavola 8<br />
Sistema funz. aree protette<br />
(nessuna categoria direttamente interessata) -<br />
Tavola 9<br />
Sistema funz. dei collegamenti extraurbani<br />
(nessuna categoria direttamente interessata) -<br />
Tavola 10<br />
Sistema funz. trasporto energia elettrica<br />
(nessuna categoria direttamente interessata) -<br />
Tavola 11<br />
Sistema funz. rifiuti<br />
(Aree penalizzanti) -<br />
PAGINA: 36: 98 2011 COD: 11V071
RELAZIONE PAESAGGISTICA<br />
Allo stesso modo si considera la sezione del PTC riguardante la Risorsa Paesaggio e quindi<br />
la tavola delle “strategie paesaggistiche di governo del territorio”, le tre tavole dei “valori<br />
statutari” del paesaggio ed il documento inerente all’identificazione delle Invarianti strutturali<br />
del paesaggio, per condurre analoga verifica delle categorie interessate dalle opere in<br />
progetto ricadenti nei beni paesaggistici vincolati; nella successiva tabella si riporta il risultato<br />
dei riscontri effettuati. 6<br />
PTC Provincia di Livorno - Risorsa Paesaggio<br />
Categorie interessate dagli interventi ricadenti nei beni paesaggistici vincolati<br />
Elaborati di Progetto Categoria Interventi<br />
Tavola 11a<br />
- Sistema di Paesaggio della pianura del Tutti gli interventi<br />
Ambiti di Paesaggio<br />
Cornia e delle Colline Metallifere<br />
Tavola Valori Paesaggistici<br />
- Corsi d’acqua Cavidotto<br />
A – Valori naturalistici ed ecosistemici - Area cuscinetto dei biotopi Adeguamento strada esistente<br />
Tavola Valori Paesaggistici<br />
- Reticolo delle scoline irrigue<br />
(incrocio S.P. 40)<br />
Cavidotto<br />
B – Valori storici e culturali<br />
Adeguamento strade esistenti<br />
- Ambito rurale connotato dalla struttura<br />
agraria riconducibile agli interventi di<br />
bonifica con presenza di reticoli irrigui<br />
Tutti gli interventi<br />
- Strade alberate Cavidotto (F. Diavolo - Vecchia<br />
Aurelia)<br />
- Reticolo viario presente alla fine del XIX Cavidotto<br />
secolo<br />
Adeguamenti strade esistenti<br />
Tavola Valori Paesaggistici<br />
- Ambito rurale connotato dalla struttura Tutti gli interventi<br />
C – Valori percettivi<br />
agraria riconducibile agli interventi di<br />
bonifica con presenza di reticoli irrigui<br />
- Strade alberate Cavidotto (F. Diavolo – Vecchia<br />
Aurelia)<br />
Documento Invarianti<br />
- Invariante 4 - “Identità culturale della Tutti gli interventi<br />
Invarianti strutturali del paesaggio tessitura dei paesaggi agrari planiziali di<br />
bonifica”<br />
- Invariante 7 – “Identità tipologica e Cavidotto (F. Diavolo – Vecchia<br />
identità funzionale del reticolo viario storico<br />
e dei relativi caratteri visuali”<br />
Aurelia)<br />
Tavola<br />
- Aree di interesse naturalistico Adeguamento strada esistente<br />
Strategie paesaggistiche e governo del<br />
(incrocio S.P 40)<br />
territorio<br />
- Connessioni tra paesaggi protetti Cavidotto (F. Cornia – Fosso<br />
dell’entroterra<br />
Diavolo)<br />
- Fasce di rispetto fluviale Tutti gli interventi<br />
- Paesaggi agrari planiziali di bonifica Tutti gli interventi<br />
- Strada Parco Vecchia Aurelia Cavidotto (F. Diavolo - Vecchia<br />
Aurelia)<br />
Gli interventi, come da delimitazioni riportate sulla Tavola 1 del PTC, ricadono nel “Sistema<br />
territoriale della fascia costiera e della pianura” e nel “Sottosistema territoriale urbano di<br />
Piombino e della pianura meridionale del Cornia”. Per tale sistema e sottosistema territoriale<br />
sono definiti, rispettivamente, obiettivi generali (art. 19.1) ed obiettivi specifici (art. 22.1), di<br />
cui si riportano, in forma sintetica, nel successivo riquadro, le parti di maggiore interesse.<br />
Art. 19.1<br />
Sistema territoriale<br />
PTCP – Disciplina<br />
“Sistema territoriale della fascia costiera e della pianura del Cornia”<br />
“Sottosistema territoriale urbano di Piombino e della pianura meridionale del Cornia”<br />
Obiettivi generali<br />
- promuovere un equilibrato sviluppo degli insediamenti e delle attività economiche, incentrato sul<br />
consolidamento e recupero dell’edificato esistente, sulla salvaguardia e valorizzazione delle risorse<br />
fondamentali (energia , risorsa idrica, lavoro,…), sulla attivazione di un sistema diffuso di servizi<br />
pubblici e privati efficienti (..);<br />
- individuare limiti alla crescita degli insediamenti per recuperare uno stabile equilibrio tra insediamenti<br />
e territorio aperto (..);<br />
- contrastare ulteriori fenomeni di dispersione insediativa e di insediamenti monotematici (..);<br />
- favorire l’evoluzione di processi organizzativi nei settori produttivi, sostenendo l’attivazione di reti di<br />
collaborazione tra imprese (..);<br />
- concorrere allo sviluppo della piattaforma logistica costiera (..).<br />
6 Si rimanda all’estratto delle tavole A, B, C e Strategie del PTC, inserite nell’Allegato Cartografico.<br />
VERS: 01 2011 PAGINA: 37: 98
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
Art. 22.1<br />
Sottosistema<br />
territoriale<br />
Obiettivi specifici<br />
- non superare i limiti di criticità dei bacini idrici soggetti a bilancio idrico deficitario o soggetti ad<br />
ingressione di acqua marina e condizionare i prelievi dai corpi idrici sotterranei ricadenti in zone<br />
vulnerabili da nitrati.<br />
Tra gli obiettivi generali si osserva che il Piano considera l’energia, come risorsa<br />
fondamentale da salvaguardare e valorizzare, in via funzionale allo sviluppo delle attività<br />
economiche.<br />
L’area di ubicazione dell’impianto in progetto, come da delimitazioni riportate sulla Tavola 2.2<br />
di progetto del PTC, ricade all’interno delle “Eccellenze agricole” ricondotte al Sottosistema<br />
funzionale dell’agricoltura, parte del “Sistema funzionale delle attività economiche”. Per il<br />
citato Sottosistema sono definiti obiettivi prestazionali (art. 37.1) che si riportano, in forma<br />
sintetica, nella successiva tabella.<br />
Art. 37.1<br />
Obiettivi<br />
prestazionali<br />
PTCP – Disciplina<br />
“Sottosistema funzionale dell’agricoltura”<br />
Obiettivi prestazionali<br />
- favorire gli investimenti in produzione di qualità e sopratutto quelle tese al recupero di produzioni<br />
colturali dismesse (..);<br />
- limitare l’introduzione di funzioni in antitesi nel territorio rurale mediante destinazioni d’uso diverse<br />
dalla funzione agraria e favorendo il ruolo multifunzionale dell’imprenditore agricolo professionale con<br />
attività complementari a quella aziendale;<br />
- riconoscere e valorizzare la connessione tra turismo e ruralità (..);<br />
- sostenere la presenza di produzioni di eccellenza (..);<br />
- favorire una gestione multifunzionale del territorio extraurbano;<br />
- garantire la conservazione attiva del patrimonio paesaggistico di tutto il territorio rurale (..);<br />
- ridurre la negatività dei processi di riconversione delle aree rurali verso funzioni sostitutive (..);<br />
- contrastare il processo di frammentazione fondiaria (..);<br />
- salvaguardare le risorse genetiche autoctone;<br />
- favorire il ruolo di presidio ambientale della presenza umana nelle zone più marginali.<br />
Obiettivo primario:<br />
- definizione condivisa di criteri per l’individuazione, a livello comunale (..), delle zone con esclusiva o<br />
prevalente funzione agricola (..), degli specifici valori e peculiarità (..), delle aree rurali connotate da<br />
caratteristiche di residualità (..), della regolamentazione degli usi ricreativi (..);<br />
- redazione dello specifico regolamento avente anche valore di Regolamento Forestale Provinciale.<br />
Con riferimento ai richiamati obiettivi si osserva che la realizzazione dell’impianto eolico, ed a<br />
maggiore ragione gli interventi ricadenti nei beni paesaggistici, per la dimensione puntuale<br />
rispetto all’estensione dell’area agricola della piana del Cornia e per la ridotta incidenza delle<br />
zone sottratte, considerando anche che si prevede il recupero totale (cavidotto) o di buona<br />
parte delle aree impegnate in fase di cantiere (piazzole), non comporta ricadute di rilievo<br />
sull’assetto agricolo, anche sotto forma di limitazioni alla prosecuzione delle attività in<br />
essere, ne la perdita di colture pregiate o di particolare interesse paesaggistico, quali i<br />
vigneti, uliveti e frutteti. Gli impianti eolici, unitamente alle opere connesse, per altro, come<br />
stabilito dalla normativa nazionale, si considerano ammissibili in zone definite agricole dagli<br />
strumenti di pianificazione urbanistica, senza che la loro realizzazione determini una<br />
variazione delle previsioni di destinazione d’uso. Si ricorda, in merito alla posa del cavidotto<br />
in posizione laterale alle strade esistenti o da realizzare, che si prevede l’interramento e<br />
quindi il successivo ripristino delle aree agricole che saranno interessate, quindi, per<br />
l’occupazione transitoria del suolo nella sola fase di cantiere.<br />
Per quanto riguarda le S.P. 23ter, 39 e 40, identificate sulla Tavola 6 di progetto del PTC e<br />
ricondotte al già citato Sottosistema funzionale delle infrastrutture, si evidenzia che gli<br />
interventi che le riguardano, ivi compreso l’adeguamento dell’ultimo tratto della strada che<br />
incrocia la S.P. 40, prima del Ponte Salta La Lepre, sono tutti di tipo puntuale e tali da non<br />
modificare le attuali caratteristiche. Le Norme del PTC, sempre da riferire all’articolo 41, si<br />
limitano a segnalare che sono d’interesse provinciale una serie di infrastrutture,<br />
comprendenti anche le “strade provinciali”, per la cui modifica o sostituzione (e non è il caso<br />
delle opere in progetto), “occorre attivare un processo di concertazione istituzionale”.<br />
PAGINA: 38: 98 2011 COD: 11V071
RELAZIONE PAESAGGISTICA<br />
In considerazione del fatto che si tratta di progetto per la produzione energetica da fonti<br />
rinnovabili, si richiama anche quanto riferito al “Sistema funzionale delle risorse energetiche”<br />
per il quale, il PTC, nelle Disciplina, riporta sia una considerazione di ordine generale (art. 44<br />
– individuazione) sia la definizione di obiettivi (art. 44.1); si richiamano, nel sottostante<br />
riquadro, i passaggi di maggiore interesse.<br />
Art. 44<br />
Individuazione<br />
Art 44.1<br />
Obiettivi<br />
PTCP – Disciplina<br />
“Sistema funzionale delle risorse energetiche”<br />
. (..) .si affacciano proposte di nuovi insediamenti di produzione di energia da fonti alternative rinnovabili e<br />
la locazione di questi impianti crea non pochi problemi di compatibilità con alcuni programmi strategici<br />
territoriali in zona agricola. Aree ad eccellente produzione vitivinicola olivicola, produzione ortaggere ad<br />
alta intensità e i processi che investono alcune aree di riconversione colturale possono essere messe in<br />
discussione dall’innesto di processi di risalita della rendita per la realizzazione di campi fotovoltaici, eolici,<br />
impianti per l’utilizzazione di biomasse, ecc.<br />
- Favorire lo sviluppo di eolico;<br />
- (..).<br />
L’impianto eolico in progetto, che rientra tra quelli che si intendono favorire, come già<br />
sottolineato, non riguarda appezzamenti legati alla presenza di colture legnose agrarie ed in<br />
particolare non risultano interessati vigneti ed uliveti. Allo stesso modo, la trasformazione ed<br />
occupazione del suolo agricolo, per caratteristiche proprie degli impianti eolici e per la<br />
possibilità di attuare interventi di recupero dei terreni impegnati in fase di cantiere dalle<br />
piazzole, si può ritenere contenuta, soprattutto se messa in rapporto con l’estensione dei<br />
coltivi della zona della piana del Cornia ed anche della più ristretta area contermine agli<br />
aerogeneratori. In ragione di quanto evidenziato si ritiene che non si determinano ricadute<br />
negative di rilievo sulla permanenza dell’attività rurale e sulla caratterizzazione delle<br />
conduzioni agricole dei terreni. 7<br />
Per quanto riguarda le Invarianti strutturali del territorio, evidenziato che il PTC rimanda, nel<br />
caso della Risorsa Paesaggio (art. 48), all’apposita disciplina dello stesso Piano, una<br />
correlazione, tra quelle individuate ed il progetto di realizzazione dell’impianto, si nota per la<br />
“risorsa energia”, con riferimento all’articolo 55 della disciplina, dove si precisa che<br />
“costituiscono inoltre invarianti strutturali il sistema di impianti di produzione energetica da<br />
fonti alternative finalizzate alla vendita”. Allo stesso modo si nota una correlazione,<br />
considerando l’area di ubicazione dell’impianto, con una delle Invarianti strutturali dei sistemi<br />
territoriali (art. 58), quella associata al “Sistema urbano di Piombino e della pianura<br />
meridionale del Cornia” e definita come “bonifica planiziale e sistema degli appoderamenti”;<br />
tale invariante è elencata ma non associata ad una norma, con la precisazione, riportata nel<br />
citato articolo, che per indirizzi e prescrizioni di natura paesaggistica si rimanda alla specifica<br />
disciplina.<br />
Lo Statuto delle “Risorse essenziali del territorio” definisce principi, criteri generali e<br />
prescrizioni per la tutela e l’utilizzo delle stesse; tra le risorse individuate si considera il<br />
“suolo” ed il “paesaggio”. Nel successivo riquadro si stralcia la parte della disciplina (art. 73),<br />
relativa al suolo, di maggiore interesse con riferimento all’impianto in progetto.<br />
7 Si osserva, a mero titolo comparativo, che la citata previsione del PTC inerente all’area logistica dello scalo ferroviario di<br />
Campiglia, riguarda un territorio attualmente agricolo di estensione decisamente maggiore e non paragonabile a quello che si<br />
impegnerà a seguito della realizzazione dell’impianto eolico.<br />
VERS: 01 2011 PAGINA: 39: 98
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
Art. 43<br />
Obiettivi, indirizzi e<br />
prestazioni<br />
PTCP – Disciplina<br />
“Lo Statuto per il suolo”<br />
(..)<br />
- incentivare la conservazione ed il mantenimento del reticolo idrografico e dei canali agricoli di deflusso<br />
delle acque attraverso la creazione di una fascia di rispetto da sottrarre alle lavorazioni con mezzi<br />
meccanici. E' vietato interrompere e/o impedire il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree<br />
agricole, sia con opere definitive sia provvisorie, senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le<br />
acque di scorrimento intercettate.<br />
- Tutti i tipi di impianti artificiali previsti dovranno essere realizzati con modalità atte a consentire una<br />
corretta regimazione delle acque superficiali. In particolare i materiali impiegati per le pavimentazioni<br />
dovranno favorire l'infiltrazione nel terreno e comunque la ritenzione temporanea delle acque di<br />
precipitazione.<br />
- Gli impianti artificiali dovranno essere realizzati in modo da non alterare la funzionalità idraulica del<br />
contesto in cui si inseriscono garantendo il mantenimento dell'efficienza della rete di convogliamento e di<br />
recapito delle acque superficiali<br />
(..)<br />
- Tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo dovranno essere volti al mantenimento<br />
dell’efficienza del sistema delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità<br />
laddove questa risulti essere stata manomessa.<br />
Gli interventi previsti, inclusi quelli ricadenti nei beni paesaggistici vincolati in quanto corsi<br />
d’acqua pubblici, sono o possono essere condotti in modo da garantire la conservazione e la<br />
funzionalità del deflusso superficiale delle acque nei fossi presenti in area agricola ed al<br />
contempo, i materiali utilizzati per gli interventi di realizzazione ed adeguamento dei tratti<br />
della viabilità e per l’allestimento delle piazzole, consentono l’infiltrazione delle acque di<br />
pioggia nel terreno, coerentemente a quanto indicato nella disciplina.<br />
Per quanto attiene al Paesaggio, la disciplina del PTC precisa, agli articoli 85 ed 86, che<br />
sono individuati Sistemi di paesaggio ed Ambiti di paesaggio sovracomunali ed ancora che le<br />
norme statutarie identificano le caratteristiche di rilevanza del paesaggio secondo i tre punti<br />
di vista, adottati dalla pianificazione territoriale regionale (PIT), corrispondenti ai valori<br />
naturalistici ed ecosistemici, ai valori storici culturali ed ai valori estetico percettivi. Le norme<br />
da applicare al Paesaggio sono definite in un separato documento riguardante, appunto, la<br />
Risorsa Paesaggio.<br />
L’impianto in progetto, quindi anche gli interventi che interessano i corsi d’acqua vincolati,<br />
ricade nel “Sistema di Paesaggio della pianura del Cornia e delle Colline Metallifere”, per il<br />
quale, il PTCP, con l’articolo 7 delle NTA - Risorsa paesaggio, dello Statuto del Territorio,<br />
demanda ai PS dei Comuni interessati le definizione ed attuazione delle politiche territoriali<br />
idonee a salvaguardare e migliorare le qualità identificate dagli stessi obiettivi specifici<br />
provinciali. In dettaglio, la disciplina individua le salvaguardie e valorizzazioni, richiamate<br />
nella sottostante riquadro.<br />
PTCP – Disciplina Risorsa Paesaggio – Articolo 7 delle NTA<br />
“Sistema di paesaggio della pianura del Cornia e delle Colline Metallifere”<br />
Salvaguardia e valorizzazione dei paesaggi della bonifica della Val di Cornia<br />
- salvaguardia dell’assetto idraulico agrario storico dei paesaggi della bonifica, attraverso il mantenimento dell’efficienza del<br />
reticolo dei canali, la valorizzazione dei manufatti idraulici, il recupero della trama fondiaria minuta della rete della viabilità<br />
interpoderale, il potenziamento dei filari alberati e delle siepi campestri;<br />
- conservazione e potenziamento del Fiume Cornia (..);<br />
- attenzione alle problematiche di approvvigionamento idrico (..);<br />
- mitigazione degli impatti delle reti infrastrutturali e tecnologiche esistenti (..);<br />
- contenimento della dispersione insediativa in area agricola e della polverizzazione dei nuclei fondiari (..);<br />
- valorizzazione del patrimonio edilizio diffuso di interesse paesaggistico e del sistema difensivo delle torri costieri.<br />
Per quanto riguarda gli obiettivi definiti dal PTCP per il citato Sistema di paesaggio si<br />
osserva che l’impianto in progetto non determina alcuna modifica strutturale dell’assetto<br />
idraulico derivante dalla bonifica storica e non comporta variazioni della dotazione di filari e<br />
siepi campestri che, con riferimento ai tratti di viabilità da adeguare, qualora presenti,<br />
possono essere mantenuti o reintegrati con nuovi impianti, ed ancora, relativamente ai nuovi<br />
tratti di viabilità da realizzare, possono essere eventualmente incrementati con interventi di<br />
PAGINA: 40: 98 2011 COD: 11V071
RELAZIONE PAESAGGISTICA<br />
compensazione ambientale, da definire. In merito all’impatto delle reti tecnologiche si<br />
evidenzia che la soluzione di realizzare un cavidotto interrato, per la connessione alla rete,<br />
non comporta l’aggiunta di un nuovo elettrodotto aereo ai numerosi che già attraversano la<br />
piana del Cornia.<br />
I “Corsi d’acqua” individuati, nella tavola A 8 , come uno degli elementi che costituiscono gli<br />
“Ambiti con significativi caratteri di naturalità e biopermeabilità” dei “Valori naturalistici ed<br />
ecosistemici”, sono interessati dal passaggio del cavidotto ed in dettaglio si tratta<br />
dell’attraversamento del Fiume Cornia, del Canale Allacciante Destro e dei Fossi Cosimo,<br />
Verrocchio, Diavolo ed Acquaviva, parte dei quali assoggettati a vincolo paesaggistico. I<br />
corsi d’acqua sono sottoposti alla disciplina di cui all’articolo 12 delle NTA della Risorsa<br />
Paesaggio, che si richiama, per stralci, nel sottostante riquadro.<br />
PTCP – Disciplina Risorsa Paesaggio – Articolo 12 delle NTA<br />
“Valori naturalistici ed ecosistemici – Ambiti con significativi caratteri di naturalità e biopermeabilità”<br />
2. Criteri per la tutela<br />
E’ opportuno che siano emanate anche a livello comunale specifiche disposizioni finalizzate alla salvaguardia degli ecosistemi<br />
degli ambiti con significativi caratteri di naturalità e biopermeabilità in conformità ai seguenti criteri:<br />
- proteggere e migliorare dal punto di vista ecologico e morfologico i corsi d’acqua, attraverso il recupero di spazi agli alvei, il<br />
ripristino di andamenti meandrici, il rallentamento dello scorrimento delle acque e il mantenimento dei livelli di deflusso minimo<br />
vitale, nonché la realizzazione delle opere necessarie mediante tecniche di ingegneria naturalistica;<br />
(..)<br />
- conservare e incrementare qualitativamente e quantitativamente le formazioni vegetali ripariali, al fine di un progressivo<br />
recupero della naturalità dei corsi d’acqua, delle capacità di autoregolazione e protezione, della valenza ecologica svolta dal<br />
corridoio vegetazionale;<br />
(..)<br />
La disciplina si limita ad indicare alcuni criteri di tutela da considerare in sede di definizione<br />
delle disposizioni urbanistiche rispetto ai quali, in ogni caso, si ritiene che non sussista<br />
un’incoerenza per le opere in progetto, dato che le stesse non comportano modifiche degli<br />
alvei e del deflusso e nemmeno incidono, per l’entità delle aree interferite e per le modalità di<br />
realizzazione previste od applicabili, sulle formazioni vegetali riparie (esistenti o ricostituibili)<br />
rispetto alle quali, in ogni caso, possono essere definiti puntuali interventi di compensazione<br />
ambientale, ove praticabili, con messa a dimora di vegetazione erbacea ed arbustiva lungo<br />
le sponde dei fossi scavalcati. Si evidenzia, per quanto riguarda le intersezioni dei corsi<br />
d’acqua da parte del cavidotto, che l’unico vincolato scavalcato non in corrispondenza di<br />
viabilità esistente è il Fosso del Diavolo, nel punto a sud dell’aerogeneratore 57, dove non<br />
risulta la presenza di vegetazione arborea, essendo le fasce contermini al corso d’acqua<br />
agricole e condotte a seminativo. Le soluzioni di progetto già definite contemplano il<br />
passaggio dei corsi d’acqua, da parte del cavidotto, in appoggio ai ponti esistenti (come per il<br />
F. Cornia) od al di sotto dell’alveo, nell’ultimo caso ricorrendo alla tecnica della perforazione<br />
teleguidata, in modo da evitare scavi a cielo aperto e quindi escludendo ogni ricaduta diretta<br />
e permanente sull’alveo e sulla fasce laterali e quindi anche sull’eventuale vegetazione<br />
presente; il progetto, in un caso, contempla anche il sovrappasso del fosso ma si ritiene<br />
comunque possibile, qualora ritenuto necessario, adottare la citata soluzione in sottopasso<br />
dell’alveo.<br />
Le “Aree cuscinetto dei biotopi” sono uno degli elementi che formano le “Emergenze di<br />
interesse geo-morfologico e di interesse floro faunistico”, rientranti tra i “Valori naturalistici ed<br />
ecosistemici”. Tali aree sono disciplinate dall’articolo 13 delle NTA della Risorsa Paesaggio<br />
che definisce criteri per la tutela, riportati nel successivo riquadro. Si evidenzia che all’interno<br />
di tale tipo di Area, associata alla Padule Bottegone, ricade solo l’intervento di adeguamento<br />
della strada degli Affitti che, come già richiamato, insiste all’interno della fascia a vincolo<br />
paesaggistico del Fosso Cosimo.<br />
8 Si rimanda all’estratto della citata Tavola A, inserito nell’Allegato Cartografico.<br />
VERS: 01 2011 PAGINA: 41: 98
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
PTCP – Disciplina Risorsa Paesaggio – Articolo 13 delle NTA<br />
“Valori naturalistici ed ecosistemici – Emergenze di interesse geo-morfologico<br />
e di interesse floro-faunistico”<br />
2. Criteri per la tutela<br />
E’ opportuno che siano emanate anche a livello comunale specifiche disposizioni per la salvaguardia delle peculiarità geo<br />
morfologiche e floro-faunistiche, sia attraverso la definizione di interventi scientifici per il mantenimento di elementi a rischio, sia<br />
disciplinando le azioni di trasformazione dei suoli con particolare attenzione alle aree ecotonali di transizione ad alta fragilità, al<br />
fine di ridurre i fattori di pressione antropica nei confronti delle emergenze naturalistiche (valutazione d’incidenza).<br />
L’intervento, di puntuale adeguamento della viabilità esistente per allargamento del sedime<br />
stradale, in corrispondenza dell’incrocio tra la strada degli Affitti (per La Sdriscia) e la S.P.<br />
40, non determina alcuna ricaduta significativa, con perdita di peculiarità floro-faunistiche o<br />
con aumento di pressione antropica, considerato che non si determina sottrazione di zona<br />
umida e tantomeno interruzioni di continuità; allo stesso modo non viene meno, a seguito<br />
della citata sistemazione viaria, la possibilità di attuare interventi di salvaguardia delle<br />
emergenze naturalistiche.<br />
L’impianto in progetto, considerando l’insieme degli interventi previsti, ricade all’interno della<br />
vasta zona caratterizzata dalla presenza del “Reticolo delle scoline irrigue” ed anche distinta<br />
come “Ambito rurale connotato dalla struttura agraria riconducibile agli interventi di bonifica<br />
con presenza di reticoli irrigui”, entrambi elementi ricondotti a quelli degli “Ambiti del territorio<br />
rurale di valore storico culturale”, associati ai “Valori storico culturali”, di cui alla Tavola B, ed<br />
anche ai “Paesaggi agrari storici di rilevanza estetico percettiva”, associati ai “Valori estetico<br />
percettivi”, di cui alla Tavola C. 9 Il citato Ambito è sottoposto alla disciplina di cui all’articolo<br />
19, delle NTA dello Statuto del Territorio, mentre per il citato “Paesaggio” le disposizioni sono<br />
contenute all’articolo 27; nei successivi riquadri si riportano gli estratti d’interesse della<br />
norma del PTCP relativa alla Risorsa Paesaggio.<br />
PTCP – Disciplina Risorsa Paesaggio – Articolo 19 delle NTA<br />
“Valori storici e culturali - Ambiti del territorio rurale di valore storico culturale”<br />
2. Criteri per la tutela<br />
E’ opportuno che siano emanate anche a livello specifiche disposizioni volte alla salvaguardia degli ambiti rurali di valore<br />
storico-culturale, in conformità ai seguenti criteri:<br />
- salvaguardare le sistemazioni idraulico-agrarie, sia per la funzione di protezione e controllo del dissesto idrogeologico sia per<br />
la valenza paesaggistica, incentivando il recupero dei muri a secco, dei sentieri poderali e dei manufatti, con la rivalorizzazione<br />
di materiali e forme locali, la conservazione delle colture arborate;<br />
- salvaguardare la tessitura del paesaggio agrario della bonifica, con il mantenimento della efficienza idraulica del sistema delle<br />
canalizzazioni, del valore semiologico, oltre che ecosistemico e percettivo, della vegetazione lineare di margine con siepi e<br />
canneti e dei filari alberati, della funzionalità della rete delle strade interpoderali e del sistema insediativo rurale.<br />
PTCP – Disciplina Risorsa Paesaggio – Articolo 27 delle NTA<br />
“Valori estetici e percettivi – Paesaggi agrari storici di rilevanza estetico percettiva”<br />
2. Criteri per la tutela<br />
E’ opportuno che siano emanate anche a livello comunale specifiche disposizioni per l’integrità percettiva di tali aree con<br />
attenzione alle problematiche di dissesto idrogeologico utili alla conservazione del paesaggio agrario storico, disciplinando gli<br />
interventi di trasformazione dei suoli in modo da garantire la permanenza degli elementi colturali ed arborei nelle specifiche<br />
relazioni spaziali, funzionali e visuali con l’intorno. Per tutti gli interventi urbanistici nelle aree dei paesaggi agrari storici di<br />
rilevanza estetico percettiva dovranno essere predisposte specifiche valutazioni paesaggistiche sulle opportunità e modalità<br />
d’intervento di trasformazione dei suoli.<br />
Le opere previste, compresi gli interventi ricadenti nei beni paesaggistici vincolati (corsi<br />
d’acqua), nell’insieme, si ritiene che non comportano modifiche strutturali del disegno o<br />
variazioni della funzionalità delle sistemazioni idrauliche e agrarie e della rete della viabilità<br />
rurale, considerato che, in larga misura, nella definizione dei tracciati delle strade e della<br />
collocazione delle piazzole, si tiene conto delle partizioni e delle geometrie esistenti, e che a<br />
seguito della posa del cavidotto si effettueranno i ripristini dei campi coltivati; allo stesso<br />
tempo non sono direttamente interessati appezzamenti di colture legnose agrarie (vigenti,<br />
9 Si rimanda agli estratti della Tavola B e C inseriti nell’Allegato Cartografico.<br />
PAGINA: 42: 98 2011 COD: 11V071
RELAZIONE PAESAGGISTICA<br />
uliveti, frutteti) e non si prevedono interventi su elementi della vegetazione naturale ed anche<br />
su componenti della vegetazione rurale, con particolare riferimento alle alberate campestri<br />
che, per altro, a titolo compensativo, potrebbero essere rafforzate con impianto di nuovi tratti.<br />
La norma del PTCP rimanda alla successiva declinazione dei criteri da parte degli strumenti<br />
urbanistici; per la ulteriore verifica delle relazioni tra le tutele e gli interventi in progetto si<br />
rimanda ai successivi paragrafi riguardanti il PS d’Area della Val di Cornia ed il RU del<br />
Comune di Campiglia Marittima.<br />
Le “Strade alberate” fanno parte degli “Elementi arborei di valore storico culturale”, riferiti ai<br />
“Valori storico culturali”, e sono anche associate ai “Filari alberati di rilevanza provinciale”,<br />
quali “Valori estetico percettivi”. Le NTA per la Risorsa Paesaggio, stabiliscono alcuni criteri<br />
di tutela, rispettivamente nell’articolo 21 e nell’articolo 28, che si riportano nei successivi<br />
riquadri.<br />
PTCP – Statuto del Territorio – Articolo 21 delle NTA<br />
“Valori storici e culturali – Elementi arborei di valore storico culturale”<br />
2. Criteri per la tutela<br />
E’ opportuno che siano emanate anche a livello comunale misure disciplinari per la conservazione dei beni individuati, non solo<br />
per quanto riguarda l’integrità fisica degli elementi che rivestono valore storico-culturale, ma anche quella relazionale degli<br />
stessi con il contesto paesaggistico, con specifica attenzione alle relazioni funzionali e percettive tra le ville e i giardini e parchi<br />
che ne costituiscono le pertinenze e tra le ville e i filari alberati delle strade di accesso alle stesse; tra il sistema insediativi<br />
aggregato e le colture agrarie terrazzate degli oliveti e i complessi boschivi, all’interno dei quali rivestono particolare importanza<br />
il patrimonio forestale di interesse culturale quale sugherete e castagneti e le emergenze isolate degli alberi monumentali.<br />
PTCP – Statuto del Territorio – Articolo 28 delle NTA<br />
“Valori estetici e percettivi – Filari alberati di rilevanza provinciale”<br />
2. Criteri per la tutela<br />
E’ opportuno che siano emanate anche a livello comunale specifiche disposizioni per la conservazione, l’integrazione ed il<br />
ripristino di filari alberati presenti nel proprio territorio, in modo da garantire la permanenza degli elementi di valore, la loro<br />
relazione col contesto e la presenza di coni visuali privilegiati verso e dai sistemi arborati lineari. In particolare nella<br />
progettazione di nuove infrastrutture dovrà essere previsto, nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada,<br />
l’equipaggiamento delle strade con alberature ai lati e scelta delle specie arboree in relazione alle caratteristiche dimensionali<br />
dell’infrastruttura prevista.<br />
La categoria delle strade alberate, individuate nella tavola B dei Valori storici e culturali e<br />
nella tavola C dei Valori percettivi, coincide, per il territorio in esame, con la Vecchia Aurelia<br />
che è interessata dai previsti interventi di adeguamento o di realizzazione degli imbocchi<br />
delle strade per l’accesso alle piazzole degli aerogeneratori n. 57, 58, 64 e 83 (tutti non<br />
ricadenti in beni paesaggistici) e dal passaggio del cavidotto che, invece, interseca il<br />
vincolato Fosso Diavolo. Quest’ultimo intervento, considerato che si tratta di uno scavo<br />
laterale o lungo la citata strada, ora distinta come S.P. n. 39, e del passaggio del fosso in<br />
appoggio a manufatto esistente od in alternativa in sottopasso all’alveo, si ritiene che non<br />
determinerà alcuna modifica, con riferimento alla permanenza degli elementi arborei oggetto<br />
di previsione di tutela, che formano l’alberata lungo la via Aurelia.<br />
Il “Reticolo stradale presente alla fine XIX secolo”, che rientra tra le “Infrastrutture storiche”<br />
associate ai “Valori storico culturali”, è sottoposto alle previsioni normative di cui all’articolo<br />
23 che si richiama nel successivo riquadro.<br />
PTCP – Statuto del Territorio – Articolo 23 delle NTA<br />
“Valori storici e culturali – Infrastrutture storiche”<br />
2. Criteri per la tutela<br />
E’ opportuno che siano emanate anche a livello comunale specifiche disposizioni volte alla salvaguardia delle infrastrutture<br />
storiche, in conformità ai seguenti criteri:<br />
- conservare le caratteristiche della rete stradale di impianto storico, soprattutto nelle sue relazioni funzionali e percettive con gli<br />
insediamenti urbani, mantenendo ove esiste e potenziando la presenza di filari alberati;<br />
- salvaguardare la viabilità minore di tipo rurale, garantendone possibilmente la utilizzabilità pubblica, e i relativi manufatti di<br />
interesse storico-testimoniale;<br />
- salvaguardare le caratterizzazioni di pregio anche panoramico del sistema delle strade storiche e della sentieristica di<br />
interesse naturalistico, incentivando la fruizione delle risorse paesaggistiche attraverso tale rete.<br />
VERS: 01 2011 PAGINA: 43: 98
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
Per quanto riguarda gli assi viari facenti parte del reticolo storico, come identificati sulla<br />
Tavola B, si sottolinea che parte degli stessi è indirettamente interessata per le opere di posa<br />
del cavidotto interrato, necessario per la connessione alla rete; in merito all’ultimo intervento,<br />
considerando che si effettuerà, al termine della fase di cantiere, il completo ripristino della<br />
fascia laterale alla strada coinvolta durante lo scavo, non si prevedono modifiche delle attuali<br />
caratteristiche planoaltimetriche e di tracciato, delle relazioni percettive, delle funzioni e della<br />
fruizione di tali percorsi e quindi non si profilano situazioni in contrasto con l’applicazione dei<br />
menzionati criteri, da attuare anche tramite disposizioni degli strumenti comunali.<br />
L’impianto in progetto ricade, considerando l’insieme degli interventi e dei manufatti, nella<br />
“Invariante strutturale del paesaggio” n. 4, distinta come “Identità culturale della tessitura dei<br />
paesaggi agrari planiziali della bonifica”, che riguarda anche la piana del Cornia, interessata<br />
dai segni della bonifica idraulica storica. Si riportano, nei successivi riquadri, stralcio<br />
dell’elaborato cartografico e della disciplina riguardanti tale Invariante.<br />
La disciplina contenuta all’articolo 36, delle NTA della Risorsa Paesaggio, oltre alla<br />
definizione, formula criteri di coerenza, distinti in relazione ai Sistemi Paesaggistici; nel<br />
precedente riquadro si riporta un estratto della citata definizione e la parte riguardante il<br />
Sistema 3 (Paesaggio della pianura del Cornia e delle Colline Metallifere) a cui appartiene<br />
l’area dove si prevede di ubicare l’impianto eolico.<br />
PTCP – Disciplina Risorsa Paesaggio<br />
“Invariante strutturale del paesaggio – n. 4”<br />
PAGINA: 44: 98 2011 COD: 11V071
RELAZIONE PAESAGGISTICA<br />
PTCP – Disciplina Risorsa Paesaggio– Articolo 36 delle NTA<br />
“Invariante strutturale del paesaggio”<br />
“Identità culturale della tessitura dei paesaggi agrari planiziali di bonifica”<br />
1. Definizioni<br />
Il PTC individua quale invariante la peculiare relazione morfologica e funzionale tra il reticolo dei canali irrigui e la tessitura del<br />
paesaggio agrario della bonifica, secondo uno schema geometrico che ha ordinato lo sviluppo della rete infrastrutturale locale e<br />
degli insediamenti. Tale sistema costituisce elemento d’identità culturale del paesaggio collinare del territorio livornese, alla<br />
quale concorrono tanto l’attenzione alla salvaguardia della tessitura agraria, frutto delle importanti modificazioni riferite alle<br />
bonifiche e al conseguente prosciugamento dei “paduli”, dove la fitta rete dei drenaggi e delle strade interpoderali segnati da<br />
siepi e canneti definisce la specifica caratterizzazione del sistema degli appoderamenti agricoli, quanto (..).<br />
2. Criteri per la coerenza<br />
Il PTC_definisce la salvaguardia dell’identità culturale del paesaggio planiziale quale requisito essenziale per la sostenibilità<br />
delle politiche e delle azioni di governo territoriale degli strumenti urbanistici comunali e dei piani di settore provinciali.<br />
Il PTC definisce i seguenti criteri per interventi prioritari all’interno degli strumenti e atti di governo del territorio comunali e nei<br />
progetti di paesaggio, distinti per ciascuno dei quattro sistemi territoriali:<br />
(..)<br />
SISTEMA 3:<br />
- conservazione della rete di canali di bonifica e la conseguente geometria della tessitura agraria dei campi, dove la massima<br />
parcellizzazione è frutto delle trasformazioni antropiche della pianura costiera, finalizzate allo sfruttamento agricolo per colture<br />
orticole dei terreni, che ha assunto carattere strutturale del paesaggio della Val di Cornia, circondato dalla corona delle Colline<br />
Metallifere.<br />
- (..) ;<br />
- valorizzazione del patrimonio edilizio diffuso con identificazione e recupero dei caratteri architettonici distintivi locali e la<br />
ricomposizione con i sistemi paesaggistici delle colture orticole e degli spazi aperti di pertinenza, anche attraverso introduzione<br />
di tecniche di bioarchitettura (introduzione di tecnologie fotovoltaiche e solari, recupero delle acque piovane, brise-soleil per<br />
limitare il soleggia mento estivo, etc.).<br />
Gli interventi relativi alla posa del cavidotto, considerando il successivo ripristino e la<br />
collocazione a lato della viabilità, non comportano alcuna ricaduta sulle geometrie definite<br />
dalla trama dei fossi irrigui o di scolo e dalla partizione tra le particelle od appezzamenti<br />
coltivati; si ritiene che la soluzione adottata consente di non alterare la rete dei canali e di<br />
mantenere, o modificare nelle misura minima possibile, la trama rurale, senza alterare il<br />
disegno complessivo che connota storicamente la piana del Cornia. Analoga considerazione<br />
vale per i due interventi di adeguamento della viabilità esistente e per l’allestimento dell’area<br />
di cantiere della piazzola dell’aerogeneratore n. 82, ricadenti in bene paesaggistico vincolato,<br />
quest’ultima oggetto di recupero al termine dei lavori relativi all’installazione della torre. In<br />
generale, considerando l’impianto eolico di progetto, per quasi tutti gli aerogeneratori, sia le<br />
strade di accesso che la collocazione della piazzola, nella sua configurazione definitiva (fase<br />
di esercizio), riprendono il diverso orientamento degli appezzamenti e si inseriscono<br />
all’interno degli stessi, senza comportare rotture di continuità. Allo stesso modo non si<br />
prevedono interventi in corrispondenza dei beni che formano il patrimonio edilizio diffuso e<br />
dei correlati spazi aperti di pertinenza.<br />
L’intervento relativo alla posa del cavidotto nel tratto ricadente all’interno della fascia<br />
vincolata del Fosso Diavolo riguarda, indirettamente, anche la “Invariante strutturale del<br />
paesaggio” n. 7, definita come “Identità tipologica ed integrità funzionale del reticolo viario<br />
storico e dei relativi caratteri visuali”, che nel territorio di ubicazione dell’impianto eolico<br />
coincide con l’asse della Vecchia Aurelia.<br />
Tale invariante è sottoposta alla disciplina dell’articolo 39 delle NTA della Risorsa Paesaggio<br />
che si richiama, nel successivo riquadro, in forma di stralcio, per la parte relativa alla<br />
definizione ed ai criteri per la coerenza da applicare per il Sistema 3 - Paesaggio della<br />
pianura del Cornia e delle Colline Metallifere.<br />
VERS: 01 2011 PAGINA: 45: 98
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
PTCP – Disciplina Risorsa Paesaggio<br />
“Invariante strutturale del paesaggio – n. 7”<br />
PTCP – Disciplina Risorsa Paesaggio– Articolo 39 delle NTA<br />
“Invariante strutturale del paesaggio”<br />
“Identità tipologica e integrità funzionale del reticolo viario storico e dei relativi caratteri visuali”<br />
1. Definizioni<br />
Il PTC individua quale invariante la peculiare relazione funzionale tra rete infrastrutturale e territorio utile a garantire<br />
l’accessibilità e la fruizione delle risorse, attraverso il sistema delle strade di rilievo storico-culturale e di pregio paesaggistico e<br />
panoramico, compresi i collegamenti veloci (Aurelia, autostrada, ferrovia) e la rete minore, e la permanenza dei caratteri di<br />
panoramicità (con la limitazione degli insediamenti lineari ai margini, sia di tipo residenziale che produttivo o turistico).<br />
2. Criteri per la coerenza<br />
Il PTC definisce la salvaguardia dell’identità paesaggistica delle infrastrutture quale requisito essenziale per la sostenibilità delle<br />
politiche e delle azioni di governo territoriale degli strumenti urbanistici comunali e dei piani di settore provinciali.<br />
Il PTC_definisce i seguenti criteri per interventi prioritari all’interno degli strumenti e atti di governo del territorio comunali e nei<br />
progetti di paesaggio, distinti nei quattro sistemi territoriali:<br />
(..)<br />
SISTEMA 3:<br />
- conservazione degli alberi a filare a segnare la viabilità, anche attraverso interventi di sostituzione e potenziamento della rara<br />
vegetazione esistente, per mantenere il carattere semiologico storicizzato del paesaggio della Val di Cornia;<br />
- il controllo di nuove piantagioni (arboricoltura, biomassa, etc.) al fine di evitare l’oscuramento di visuali interessanti, di<br />
suggestione paesaggistica o di osservazione su particolarità di valore naturalistico (osservatori, aree umide);<br />
- valorizzazione del patrimonio edilizio diffuso di interesse paesaggistico (casali colonici, torri, fornaci dismesse ed elementi di<br />
archeologia industriale) e ricomposizione dei sistemi paesaggistici storicizzati degli spazi aperti di pertinenza con particolare<br />
attenzione alla limitazione della frammentazione;<br />
- controllo e limitazione per l’installazione di elementi tecnologici (attrezzature della cantieristica navale, elettrodotti, impianti di<br />
telefonia mobile, impianti eolici, etc.) a rischio di compromissione di contesti di alta valenza paesaggistica nell’apertura visuale<br />
dal mare alla corona delle Colline Matallifere.<br />
In merito al criterio di conservare i filari alberati lungo la strada, vale quanto già evidenziato<br />
con riferimento alla precedente categoria delle “strade alberate”, associate ai Valori<br />
Paesaggistici; la opere di scavo e le modalità di sovrappasso o sottopasso del Fosso<br />
possono essere realizzate senza determinare alcuna ricaduta e garantendo, in ogni caso, la<br />
permanenza di tale segno del paesaggio. In generale, si ricorda che non è prevista la messa<br />
in opera, per la connessione alla rete, di elettrodotti o linee aeree, dato che si adotta,<br />
PAGINA: 46: 98 2011 COD: 11V071
RELAZIONE PAESAGGISTICA<br />
appunto, la soluzione del cavidotto interrato, coerentemente con quanto indicato nel citato<br />
articolo del PTCP.<br />
Per quanto attiene agli elementi delle “Strategie paesaggistiche”, in base a quanto riportato<br />
nella relativa Tavola 10 del PTCP, gli interventi in progetto riguardano le categorie di seguito<br />
richiamate.<br />
Le “Aree di interesse naturalistico”, sono coinvolte per il solo intervento puntuale di<br />
adeguamento della viabilità in corrispondenza dell’incrocio tra la S.P. n. 40, all’altezza del<br />
Ponte Salta La Lepre, e la strada degli Affitti (per La Sdriscia). Le NTA della Risorsa<br />
Paesaggio, all’articolo 45 definiscono gli indirizzi strategici, rivolti al livello comunale, per<br />
l’adozione di disposizioni volte a “rafforzare, nel rispetto delle loro componenti ecosistemiche<br />
e caratterizzazioni strutturali, le relazioni esistenti o potenziali tra diverse aree di interesse<br />
naturalistico e/o tra queste e le aree protette, favorendo azioni per la costituzione di paesaggi<br />
protetti di rango comunale, provinciale o regionale”. Le citate opere, di mero adeguamento<br />
della viabilità, non comportano, come già ricordato, per collocazione, alcuna ricaduta sugli<br />
elementi di interesse naturalistico (Padule Bottegone) e nemmeno una modifica od un<br />
impedimento a costruire delle relazioni tra le diverse aree di interesse ecologico o già<br />
protette.<br />
Le “Connessioni tra paesaggi protetti dell’entroterra”, identificati dal Piano come areali o linee<br />
indicative, che per il territorio della piana agricola riguardano la fascia lungo il Fiume Cornia,<br />
all’interno della quale ricadono gli interventi necessari all’installazione dell’aerogeneratore n.<br />
57 (strade di accesso e piazzola), non ricadenti in area a vincolo paesaggistico, ed alla posa<br />
del cavidotto d’impianto che invece riguarda l’area contermine al Fosso Diavolo ed al Fiume<br />
Cornia. Tale elemento strategico è sottoposto alla disciplina di cui all’articolo 47 che si<br />
riporta, per estratto, nel successivo riquadro.<br />
PTCP – Disciplina Risorsa Paesaggio– Articolo 47 delle NTA<br />
“Strategie paesaggistiche di governo del territorio”<br />
“Connessione tra paesaggi dell’entroterra, della costa e dell’Arcipelago”<br />
2. Indirizzi strategici<br />
E’ opportuno che siano individuati anche a livello comunale gli elementi del territorio rurale con ruolo di connessione<br />
paesaggistica con significative qualità funzionali ecosistemiche (frange di bosco, siepi e vegetazione lineare, elementi arborei,<br />
vegetazione di ripa) ed i varchi non edificati tra gli insediamenti con funzione di collegamento tra sistemi di aree protette e<br />
definiscono progetti per il potenziamento dei caratteri di continuità paesaggistica nel rispetto delle specifiche qualità strutturali e<br />
funzionali locali e della complessiva diversità del paesaggio.<br />
E’ inoltre opportuno che siano definite specifiche norme per la salvaguardia dei caratteri di naturalità in relazione ad interventi di<br />
trasformazione delle coste ad uso turistico (infrastrutture, porti e servizi turistici, parcheggi) attraverso una specifica valutazione<br />
della capacità di carico ambientale e l’individuazione di forme efficaci di compensazione, anche attraverso la certificazione<br />
ambientale.<br />
La disciplina rimanda alla successiva attuazione degli indirizzi in sede di definizione degli<br />
strumenti urbanistici comunali, che devono individuare gli elementi di connessione con<br />
qualità ecosistemiche. Con riferimento alla prevista posa del cavidotto, si sottolinea che la<br />
fascia di territorio interessata dallo scavo, in entrambi i casi, non si caratterizza per la<br />
presenza di vegetazione naturale, dato che si tratta di campi coltivati; ragionevolmente, si<br />
escludono ricadute immediate ed anche in riferimento al previsto rafforzamento delle<br />
connessioni ecologiche, considerando che per la posa interrata non si vanno a precostituire<br />
barriere che interrompono la continuità territoriale e relazionale che si intende rafforzare, si<br />
ritiene che non si prefigurano impedimenti al perseguimento del citato indirizzo.<br />
Le “Fasce di rispetto fluviale”, con riferimento a quelle presenti nell’area di ubicazione<br />
dell’impianto ed alle opere previste che le riguardano, sono da associare alla Fossa Calda<br />
che è interessata, sul limite esterno della stessa fascia, dalle opere previste per installare<br />
l’aerogeneratore n. 82, per una sola parte dell’area di cantiere associata alla messa in opera<br />
dell’aerogeneratore. In aggiunta, in tale categoria ricadono anche gli interventi di<br />
adeguamento della viabilità esistente, quello necessario per raggiungere l’aerogeneratore n.<br />
10 Si rimanda all’estratto della Tavola “Strategie paesaggistiche e governo del territorio”, inserita nell’Allegato Cartografico.<br />
VERS: 01 2011 PAGINA: 47: 98
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
47 e quello di sistemazione del tratto di strada vicino all’incrocio tra la S.P. 40 e la strada<br />
degli Affitti. Ancora, si deve considerare la posa del cavidotto interrato o l’attraversamento,<br />
da parte dello stesso, dei vincolati Fosso Diavolo e Fiume Cornia. A tali fasce si applica<br />
quanto definito all’articolo 48 delle NTA della Risorsa Paesaggio, il cui contenuto si richiama<br />
nel successivo riquadro.<br />
PTCP – Disciplina Risorsa Paesaggio– Articolo 48 delle NTA<br />
“Strategie paesaggistiche di governo del territorio”<br />
“Fasce di rispetto fluviale”<br />
1. Definizioni<br />
Il PTC individua le aree lungo i fiumi, torrenti e corsi d’acqua sottoposte a tutela quali paesaggi preferenziali per la formazione<br />
delle connessioni paesaggistiche, finalizzate anche alla costituzione e valorizzazione all’interno del paesaggio rurale di una rete<br />
ecologica provinciale.<br />
2.Indirizzi strategici<br />
E’ opportuno che siano individuati anche a livello comunale i sistemi di connessione lineare salvaguardando e potenziando la<br />
funzione ecosistemica della vegetazione ripariale e il ruolo degli alvei fluviali al fine del mantenimento e della valorizzazione<br />
della connettività paesaggistica.<br />
La disciplina rinvia al recepimento degli indirizzi in sede di pianificazione comunale e per tale<br />
motivo si rimanda ai successivi paragrafi, relativi al Piano d’Area della Val di Cornia ed al RU<br />
del Comune di Campiglia Marittima. Si evidenzia, con riferimento alle ipotesi di creare<br />
sistemi di connessione lineare, associati ai corsi d’acqua, che per l’installazione<br />
dell’aerogeneratore non si coinvolgono aree con caratteri naturali ma campi coltivati ed in<br />
subordine che la collocazione dello stesso, sul margine esterno della fascia di rispetto, non<br />
impedisce od ostacola l’eventuale attuazione di interventi, riguardanti la formazione di<br />
vegetazione riparia, per il consolidamento di un corridoio. Per la precisione si sottolinea che<br />
l’area a vincolo paesaggistico è interessata solo in fase di cantiere, per l’allestimento<br />
dell’area funzionale allo svolgimento dei lavori, che sarà oggetto di recupero e quindi si<br />
garantisce il ripristino delle condizioni d’uso in essere. In ogni caso è fattibile delineare<br />
eventuali interventi, concordati, di compensazione ambientale, finalizzati a ricostituire fasce<br />
di vegetazione sul bordo del citato fosso, commisurati all’area interferita, in fase di cantiere,<br />
per l’installazione dell’aerogeneratore.<br />
Per quanto riguarda i due citati interventi di adeguamento della viabilità, rilevato che non si<br />
incide su aree con vegetazione ma si ricade in campi a seminativo, allo stesso modo non si<br />
determina una perdita di elementi vegetali ripari e si possono eventualmente definire<br />
interventi compensativi, con messa a dimora di vegetazione erbacea ed arbustiva nella<br />
fascia tra l’asse viario oggetto di adeguamento e la sponda del corso d’acqua. Per quanto<br />
riguarda il cavidotto, ancora una volta si precisa che questo scavalca il Fiume Cornia<br />
appoggiandosi all’esistente ponte, non determinano modifiche dello stato dei luoghi nella<br />
fascia laterale al corso d’acqua. Per quanto riguarda il Fosso Diavolo, nel caso del passaggio<br />
dove non sono presenti infrastrutture viarie (a sud di Podere Affitti Manci, in un’area agricola<br />
coltivata), la soluzione attualmente indicata negli elaborati di progetto è quella del<br />
sovrappasso ma si evidenzia che si ritiene comunque fattibile applicare, anche in tale caso,<br />
un’altra della soluzioni già contemplate dal progetto, quella in sottopasso e con perforazione<br />
orizzontale teleguidata, tale da escludere modifiche dello stato attuale del luogo, in fase di<br />
cantiere ed in fase di esercizio, anche sotto il profilo percettivo.<br />
La “Strada Parco Vecchia Aurelia” coincide con l’asse di tale strada per la quale, con<br />
l’articolo 49, si fornisce una definizione della stessa e si formulano indirizzi strategici; nel<br />
sottostante riquadro si riporta uno stralcio della disciplina.<br />
Il successivo articolo 56, riguardante sempre tale Strada, definisce, allo stesso modo,<br />
indirizzi strategici rivolti al livello comunale che si ritiene deve individuare i “tratti significativi”<br />
e “stabilire accordi ed intese”, con esplicito rimando al precedente articolo 49.<br />
PAGINA: 48: 98 2011 COD: 11V071
RELAZIONE PAESAGGISTICA<br />
PTCP – Disciplina Risorsa Paesaggio– Articolo 48 delle NTA<br />
“Strategie paesaggistiche di governo del territorio”<br />
“Direttrice di connessione longitudinale Strada Parco Vecchia Aurelia”<br />
1. Definizioni<br />
Il PTC individua nella direttrice provinciale a sviluppo longitudinale della strada Vecchia Aurelia una importante struttura in<br />
grado di costituire la spina dorsale Strada-Parco del sistema connettivo provinciale, capace di svolgere la funzione di<br />
collegamento tra i Sistemi ed i Sub-sistemi di paesaggio, anche nelle relazioni intercomunali ed interprovinciali con Pisa e<br />
Grosseto, sia per il suo radicamento nel territorio, con i numerosi agganci alle reti infrastrutturali minori, sia per la valenza<br />
panoramica, supportata da un equipaggiamento vegetale di molti tratti, verso il paesaggio costiero, le pianure bonificate e i<br />
rilievi forestali.<br />
2.Indirizzi strategici<br />
E’ opportuno che siano individuati anche a livello comunale i tratti significativi della Strada-Parco che interessano il proprio<br />
territorio e siano stabiliti accordi ed intese per una gestione coordinata, in collaborazione con le strutture provinciali e con i<br />
Comuni limitrofi, favorendo, nel rispetto delle specifiche competenze territoriali e all’interno di un progetto collettivo e condiviso,<br />
la formazione di specifici progetti per il potenziamento del valore di sistema di collegamento, per il miglioramento della qualità<br />
della percezione visiva, per il rafforzamento dell’equipaggiamento vegetazionale, per la valorizzazione delle relazioni con il<br />
paesaggio.<br />
Tale asse viario, come già evidenziato con riferimento alla categoria delle “strade alberate”, è<br />
interessato perché dallo stesso hanno origine le strade di accesso ad alcuni aerogeneratori,<br />
esistenti nel caso del collegamento al n. 57 e da realizzare nel caso del n. 58, 64 e 83 (non<br />
ricadenti in beni paesaggistici vincolati), e perchè lungo tale strada si posa il cavidotto<br />
d’impianto che attraversa il Fosso Diavolo, corso d’acqua sottoposto a vincolo paesaggistico.<br />
Per quanto riguarda la messa in opera del cavidotto interrato si ritiene che possono essere<br />
evitate, in sede di esecuzione dello scavo, ricadute sulla dotazione vegetale (filari a bordo<br />
strada) e si escludono, considerando le soluzioni progettuali applicabili, effetti sulla<br />
percezione del paesaggio.<br />
I “Paesaggi agrari planiziali di bonifica”, che riguardano l’intera area pianeggiante a cavallo<br />
del Fiume Cornia, sono disciplinati dall’articolo 61 delle NTA dello Statuto del Territorio<br />
relativo alla Risorsa Paesaggio; nel successivo riquadro si riporta, per stralci, il contenuto<br />
della norma.<br />
PTCP – Disciplina Risorsa Paesaggio – Articolo 61<br />
“Paesaggi agrari planiziali di bonifica”<br />
Definizioni<br />
Il PTC individua i paesaggi agrari della bonifica quali elementi di specifica caratterizzazione paesaggistica, sia per la presenza<br />
di un articolato sistema di appoderamenti che ancora conserva caratteri strutturali di rilievo, sia per le specifiche relazioni con gli<br />
insediamenti limitrofi, tanto nei nuclei rurali e borghi minori che nei centri urbani. (..)<br />
Indirizzi strategici<br />
E’ opportuno che siano individuate anche a livello comunale le relazioni tra i sistemi insediativi ed i paesaggi agrari della pianura<br />
bonificata distinguendo gli elementi significativi per il mantenimento dei caratteri strutturali e funzionali, al fine di preservare e<br />
rafforzare quanto rimane di un delicato equilibrio che si relaziona alla presenza di aree umide, alle esigenze colturali, alle<br />
espansioni edilizie residenziali e turistiche, alle nuove richieste infrastrutturali. Particolare attenzione deve essere rivolta alle<br />
problematiche di approvvigionamento idrico, per la manifesta criticità idrica di molte aree, con specifica valutazione del carico<br />
sostenibile per interventi di diverso uso del suolo (agricolo, industriale, residenziale<br />
La norma demanda al livello comunale la precisa identificazione degli elementi significativi<br />
che consentono di mantenere i caratteri strutturali e funzionali che caratterizzano tali<br />
paesaggi; si rimanda, quindi, ai successivi paragrafi inerenti al PS d’Area della Val di Cornia<br />
ed anche a quanto già evidenziato, con riferimento ai singoli valori paesaggistici ed alla<br />
stessa invariante strutturale legata ai paesaggi agrari della bonifica.<br />
3.3 Piano Strutturale d’Area della Val di Cornia<br />
3.3.1 Riferimenti generali<br />
La L.R. 3.1.2005. n. 1, “Norme per il governo del territorio”, individua (art. 9), tra gli strumenti<br />
della pianificazione territoriale, il Piano strutturale comunale (PS), ed all’articolo 52 stabilisce<br />
che tale piano è lo strumento della pianificazione del territorio a cui si affiancano gli atti di<br />
governo del territorio.<br />
VERS: 01 2011 PAGINA: 49: 98
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
Il Piano Strutturale (PS), in quanto strumento della pianificazione territoriale, contiene lo<br />
Statuto del Territorio, come previsto all’art. 5, che nel caso specifico definisce, secondo<br />
quanto stabilito dall’art. 53: le risorse che costituiscono la struttura identitaria del territorio<br />
comunale, definita attraverso l’individuazione dei sistemi e dei sub-sistemi territoriali e<br />
funzionali; le invarianti strutturali; i principi di governo del territorio; i criteri per l’utilizzazione<br />
delle risorse essenziali nonché i relativi livelli minimi prestazionali e di qualità con riferimento<br />
a ciascuno dei sistemi funzionali e territoriali; la disciplina di valorizzazione del paesaggio e<br />
le disposizioni di dettaglio per la tutela dell’ambiente, dei beni paesistici e dei beni culturali, in<br />
attuazione del PIT e del PTCP; le aree e gli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico<br />
(beni culturali e paesistici). Il PS delinea la strategia dello sviluppo territoriale indicando e<br />
definendo, tra i diversi punti elencati all’art. 53, in particolare: gli obiettivi ed indirizzi; le unità<br />
territoriali organiche elementari che assicurano un’equilibrata distribuzione delle dotazioni<br />
necessarie alla qualità dello sviluppo territoriale; le misure di salvaguardia, di durata non<br />
superiore a tre anni, da rispettare sino all’approvazione o all’adeguamento del Regolamento<br />
urbanistico.<br />
I Comuni di Campiglia Marittima, Piombino e Suvereto hanno ratificato, con distinti atti<br />
d’approvazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali, il Piano Strutturale d’Area della Val<br />
di Cornia, già approvato con D.G.E. del Circondario della Val di Cornia n. 17 del 23.3.2007. I<br />
provvedimenti comunali sono, per Campiglia Marittima, la D.C.C n. 37 del 26.3.2007, per<br />
Piombino, la D.C.C. n. 52 del 19.6.2007, ed infine, per Suvereto, la D.C.C. n. 19 del<br />
4.4.2007.<br />
Il Piano Strutturale d’Area, come precisato all’articolo 83 delle Norme dello stesso, trova<br />
attuazione nella disciplina dettata dagli atti di governo del territorio (art. 10, L.R. 1/2005) e<br />
fino all’approvazione degli stessi, vale quanto dettato dai PRG e relativi piani attuativi, per le<br />
parti non in contrasto con le misure di salvaguardia del PS, disposte all’articolo 84, e dalle<br />
Varianti ai PRG formate successivamente alla data di adozione dello stesso PS, conformi<br />
alle disposizioni dello stesso. Le misure di salvaguardia valgono fino all’entrata in vigore del<br />
Regolamento Urbanistico ed in ogni caso non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del<br />
PS. Le Norme del PS, sempre all’articolo 84, precisano che gli articoli 5-6 e 13-14 del Piano<br />
di Bacino (D.C.R.T. 13/2005) trovano applicazione rispettivamente nelle aree di pericolosità<br />
idraulica molto elevata (PIME) ed elevata (PIE) e nelle aree a pericolosità geomorfologia<br />
molto elevata (PFME) ed elevata (PFE), come perimetrale nel Quadro Conoscitivo del Piano<br />
Strutturale d’Area.<br />
Il Piano Strutturale è costituito da: <strong>Relazione</strong> generale; <strong>Relazione</strong> geologica e idrologicoidraulica;<br />
elaborati grafici del quadro conoscitivo (Tavole dalla 1 alla 8); elaborati complessi<br />
facenti parte del quadro conoscitivo (dossier A/D); elaborati grafici corrispondenti alla<br />
strategia di Piano (Tavole 9 e 10); Norme; Valutazione degli effetti ambientali; Specifiche<br />
relazioni di incidenza; documento di cui al comma 6, articolo 1 del vigente PIT regionale.<br />
Il Piano si articola, anche con specifico riferimento alla struttura e contenuto delle Norme, in:<br />
una Parte I di disposizioni generali; una Parte II, inerente allo Statuto del Territorio, che fa<br />
riferimento ad una serie di altri elaborati cartografici (tavole da 4.11 a 4.13, tav. 9.1 e tav.<br />
6.1) e Dossier A (Beni culturali) e Dossier D (Rischio di incidente rilevante); una Parte III<br />
riguardante la Strategia dello sviluppo territoriale, che fa riferimento alle Norme delle UTOE<br />
ed alle Tavole 6.5 e 10.1 ed anche al Dossier C (Aree critiche); una Parte IV di disposizioni<br />
integrative, relative alle modalità di attuazione e misure di salvaguardia. Costituiscono parte<br />
integrante delle Norme le disposizioni riferite alle singole Unità Territoriali Organiche<br />
Elementari. Le disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 20, 21, 29 e 30, come precisato,<br />
sono una riproposizione delle norme del Piano di assetto idrogeologico del bacino regionale<br />
Toscana Costa.<br />
Lo Statuto del Territorio, disciplina gli aspetti inerenti alla pericolosità geomorfologica,<br />
idraulica e idrogeologica, e detta disposizioni relative ad altri aspetti ambientali che in<br />
dettaglio riguardano la tutela dell’aria, la tutela dell’acqua, la tutela del suolo e sottosuolo ed<br />
PAGINA: 50: 98 2011 COD: 11V071
RELAZIONE PAESAGGISTICA<br />
ancora il risparmio energetico, la tutela dall’inquinamento elettromagnetico, la gestione dei<br />
rifiuti, il sistema produttivo. Sempre nella parte dello Statuto sono definite le disposizioni<br />
correlate alle caratteristiche dei sistemi territoriali, con riferimento al territorio rurale ed<br />
aperto, al sistema insediativo ed al sistema infrastrutturale. Per quanto riguarda il territorio<br />
rurale ed aperto, il Piano d’Area detta disposizioni riferite all’articolazione per Subsistemi<br />
(identificati nella Tavola 9.1), definisce la disciplina delle trasformazioni ed utilizzazioni (con<br />
rimando sostanziale al RU), individua i beni territoriali appartenenti al sistema, riconosce gli<br />
elementi insediativi nel sistema. Per quanto attiene al Sistema insediativo si definisce<br />
l’articolazione in subsistemi (identificati nella tavola 9.1) e si individuano i beni territoriali<br />
appartenenti a tale sistema, con rimando al RU ed agli altri atti di governo del territorio. Per<br />
quanto riguarda il Sistema infrastrutturale, si classificano gli elementi della viabilità e si<br />
definiscono direttive e mitigazioni da applicare agli stessi.<br />
La Strategia dello sviluppo territoriale, oltre a definire indirizzi programmatici e disposizioni<br />
riferite ai Sistemi e Subsistemi, individua le UTOE (rimando alla Tavola 10.1) e detta le<br />
relative disposizioni di ordine generale, rimandando, per quelle specifiche, all’appendice,<br />
ovvero alle “Norme relative alle UTOE”, in cui si riportano, per ognuna delle Unità,<br />
l’inquadramento e gli obiettivi generali, l’articolazione interna, la capacità insediativa, i criteri<br />
localizzativi e prestazionali da osservare tramite il RU, gli obiettivi specifici per le singole parti<br />
dell’UTOE riferiti al sistema insediativo, al sistema del territorio rurale ed aperto, al sistema<br />
infrastrutturale.<br />
3.3.2 Relazioni tra PS d’Area ed interventi ricadenti nei beni paesaggistici<br />
Le opere previste per la realizzazione dell’impianto eolico che ricadono nella fascia<br />
contermine ai corsi d’acqua sottoposti a vincolo paesaggistico, in base alla lettura delle<br />
Tavole 9.1 e 10.1 11 , ricadono in alcune delle categorie individuate e sottoposte a specifica<br />
disciplina; nella successiva tabella si distinguono quelle interessate e si precisa quali<br />
interventi o manufatti riguardano le stesse.<br />
PS Area Val di Cornia - Strategia del Piano<br />
Categorie interessate dagli interventi ricadenti nei beni paesaggisitci<br />
Elaborati di Progetto Categoria Interventi<br />
Tavola 9.1<br />
Subsistema del Territorio rurale aperto Adeguamento strade esistenti<br />
Subsistemi ed elementi strutturali<br />
Pianura alluvionale del Fiume Cornia Cavidotto (tutti)<br />
Subsistema del Territorio rurale aperto<br />
Pianura costiera occidentale<br />
Area di cantiere piazzola A82<br />
Beni del Territorio aperto<br />
Adeguamento strada esistente<br />
Viabilità storica<br />
(incrocio S.P 40)<br />
Cavidotto (F. Cornia)<br />
Beni del Territorio aperto<br />
Area di pertinenza fluviale (F. Cornia)<br />
Cavidotto (F. Cornia)<br />
Tavola 10.1<br />
UTOE 3 – Piana di <strong>Venturina</strong> Area di cantiere piazzola A82<br />
UTOE<br />
Adeguamento strada esistente<br />
(per A47)<br />
Cavidotto<br />
Verrocchio)<br />
(F. Diavolo, F.<br />
UTOE 5 – Riotorto e Costa est Adeguamento strada esistente<br />
(incrocio S.P. 40)<br />
Cavidotto (F. Cornia)<br />
UTOE 8 – Riconversione urbana Cavidotto (F. Cornia)<br />
La “Pianura alluvionale del Fiume Cornia”, uno dei sei “Subsistemi del Territorio rurale<br />
aperto” identificati dal PS d’Area, è disciplinato, oltre che dalle norme generali di cui<br />
all’articolo 42, che definiscono anche i compiti del RU, da quelle specifiche contenute<br />
all’articolo 46; nel sottostante riquadro si riportano gli stralci di maggiore interesse dei citati<br />
articoli.<br />
11 Si rimanda agli estratti delle citate tavole inserite nell’Allegato Cartografico.<br />
VERS: 01 2011 PAGINA: 51: 98
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
PS d’Area Val di Cornia – Norme – Articolo 42<br />
“Subsistemi”<br />
(..)<br />
4. Ai fini del rispetto della legislazione regionale il presente piano qualifica quali zone con esclusiva funzione agricola il<br />
subsistema della pianura costiera orientale e il subsistema della pianura alluvionale del Fiume Cornia, mentre gli altri subsistemi<br />
di cui al comma 2 sono qualificati quali zone con prevalente funzione agricola.<br />
(..)<br />
PS d’Area Val di Cornia – Norme – Articolo 46<br />
“Pianura alluvionale del Fiume Cornia”<br />
1. Costituisce invariante strutturale del subsistema della pianura alluvionale del Fiume Cornia l’unitarietà e la continuità dei<br />
territori pianeggianti, e il loro porsi come la matrice connettiva più forte dell’intero territorio oggetto del presente piano, seppure<br />
intaccata da fenomeni di frammentazione e di dispersione infrastrutturali e insediativi. Costituiscono inoltre invariante strutturale<br />
del subsistema della pianura alluvionale del Fiume Cornia il reticolo idraulico identificato nella tavola contrassegnata con 4.9.<br />
2. Il regolamento urbanistico rivolge particolare e prioritaria attenzione alle aree di riordino o riqualificazione ambientale<br />
individuate, e in genere all’ottimizzazione dell’inserimento ambientale degli insediamenti e degli elementi infrastrutturali,<br />
esistenti e previsti.<br />
All’interno del Subsistema ricadono la maggior parte degli interventi previsti per la<br />
realizzazione dell’impianto eolico, sostanzialmente riconducibili alla presenza degli<br />
aerogeneratori, con relativa piazzola (che in fase di esercizio sarà ridimensionata rispetto a<br />
quella prevista in fase di cantiere), ed alla viabilità di accesso agli stessi, a cui si aggiunge<br />
l’allestimento della stazione utenza. Per quanto attiene alle opere che interessano le aree a<br />
vincolo paesaggistico, si tratta dei due adeguamenti delle strade esistenti e di tutti quelli<br />
associati alla posa in opera del cavidotto d’impianto. In termini generali, le occupazioni<br />
puntuali (in rapporto all’estensione dell’area agricola della pianura alluvionale), determinate<br />
dalle modifiche connesse alla viabilità esistente da adeguare nella larghezza (per il cavidotto<br />
interrato si tratta di interfenze momentanee, dati i previsti ripristini), si ritiene che non fanno<br />
venire meno l’unitarietà e continuità del territorio pianeggiante ad uso agricolo, proprio<br />
perché non si mettono in opera manufatti che danno origine a trasformazioni dell’uso<br />
agricolo per superfici estese e tali da determinare interruzioni e separazioni del connettivo<br />
rurale che caratterizza il sottosistema. Allo stesso modo, le opere in progetto si ritiene che<br />
non alterano il reticolo idraulico, identificato sulla tavola 4.9, considerato, in particolare, che<br />
gli intereventi che riguardano direttamente le aste dei corsi d’acqua vincolati, sono quelle<br />
inerenti alla posa del cavidotto, che scavalcherà gli stessi in appoggio ai ponti esistenti, in<br />
sottopasso (mediante perforazione orizzontale teleguidata), od anche in sovrappasso, come<br />
indicato negli elaborati di progetto, soluzioni tali da non determinare modifiche dei caratteri<br />
(tracciato, sezione idraulica, ecc.) di tale invariante strutturale.<br />
La “Pianura costiera occidentale”, comprendente la zona agricola pianeggiante che si<br />
estende ad ovest rispetto a <strong>Venturina</strong>, è interessata solo dalla messa in opera di due<br />
aerogeneratori, il n. 76 ed 82, e dalla relativa viabilità di accesso, in adeguamento e di nuova<br />
realizzazione; nel caso dell’aerogeneratore 82, la relativa area di cantiere riguarda, in minima<br />
parta, la fascia a vincolo paesaggistico associata al Fosso Verrocchio. Tale Subsistema è<br />
sottoposto alla disciplina specifica contenuta nell’articolo 44 delle Norme del PS d’Area che<br />
si riportano nel sottostante riquadro.<br />
PS d’Area Val di Cornia – Norme – Articolo 44<br />
“Pianura costiera occidentale”<br />
1. Costituiscono invariante strutturale del subsistema della pianura costiera occidentale la prevalenza dei suoli antichi asciutti,<br />
detti “sabbie rosse”, nel loro rapporto con limitate presenze di suoli idromorfi delle repressioni retrodunali.<br />
2. Il regolamento urbanistico, nel disciplinare le trasformazioni relative agli edifici e agli altri manufatti edilizi funzionali e<br />
connessi all’esercizio dell’attività agricola ai sensi dalla Sezione II del presente Capo, tiene conto dell’elevata attitudine dei suoli<br />
antichi asciutti, detti “sabbie rosse”, per ordinamenti orticoli intensivi a pieno campo.<br />
La norma stabilisce che il RU deve definire le modalità di trasformazione inerenti ad opere<br />
edilizie, considerando le attenzioni da prestare alle “sabbie rosse”; evidenziato che si occupa<br />
un’area di superficie decisamente limitata rispetto a quella associata a tale caratteristica<br />
pedologica e che è previsto il recupero dell’area di cantiere, al termine dei lavori per<br />
PAGINA: 52: 98 2011 COD: 11V071
RELAZIONE PAESAGGISTICA<br />
l’installazione dell’aerogeneratore 82, si rimanda, per approfondimenti, al contenuto del RU<br />
del Comune di Campiglia M., nel cui territorio ricade l’intervento.<br />
La “Viabilità storica”, inclusa tra i “Beni del territorio aperto”, considerando la dislocazione e<br />
la relazione con le opere in progetto riguardanti i beni paesaggistici (corsi d’acqua),<br />
corrisponde alla strada che da Caselli di Cornia arriva a La Sdriscia, interessata dal<br />
passaggio del cavidotto d’impianto, ed alla strada degli Affitti, in corrispondenza dell’incrocio<br />
con la SP 40. Nel successivo riquadro si riporta il contenuto della norma applicata a tale<br />
bene.<br />
PS d’Area Val di Cornia – Norme – Articolo 44<br />
“Viabilità storica”<br />
1. Per gli elementi della viabilità storica individuati nelle tavole contrassegnate con 9.1 del presente piano, anche con valenza di<br />
invarianti strutturali, il regolamento urbanistico prescrive e disciplina il mantenimento nei relativi aspetti strutturali, quali il<br />
tracciato, la giacitura e le caratteristiche dimensionali, nonché, ove si siano conservati, o siano recuperabili, negli aspetti<br />
costruttivi e formali sia degli elementi di viabilità che dei relativi elementi di supporto e di arredo, quali i muri di recinzione<br />
latistanti e quelli di sostegno e di contenimento, e simili.<br />
2. Qualora gli elementi della viabilità storica non siano stati irreversibilmente trasformati in elementi dell’esistente viabilità<br />
carrabile, e non siano confermati in tale loro configurazione e funzione dal presente piano, in essi sono in ogni caso ammessi gli<br />
interventi volti a rimettere in luce la pavimentazione, e gli altri elementi costitutivi, originari, e a ripristinarne, per quanto<br />
possibile, gli assetti storici.<br />
La disciplina prevede che le prescrizioni funzionali alla conservazione di tale viabilità siano<br />
definite dal RU che, per quanto riguarda il territorio del Comune di Piombino, in cui ricadono<br />
gli assi viari interessati dagli interventi, non è stato ancora adottato. In ogni caso si può<br />
sottolineare che la messa in opera del cavidotto, interrato ed in posizione laterale all’asse<br />
viario ed ancora in sovrappasso del F. Cornia in appoggio all’esistente ponte, non modifica i<br />
caratteri strutturali di tale strada, restando invariato il tracciato e la giacitura. Analoga<br />
considerazione vale per l’adeguamento, di tipo puntuale, della strada degli Affitti, considerato<br />
che si tratta di allargare la carreggiata, per un breve tratto.<br />
Le “Aree di pertinenza fluviale”, in tale caso associate al F. Cornia per il previsto passaggio<br />
del cavidotto, sono disciplinate dall’articolo 57 che rimanda al RU per l’individuazione degli<br />
alvei fluviali ordinari in modellamento attivo, delle aree golenali e delle aree di tutela dei<br />
caratteri ambientali dei corsi d’acqua e la relativa definizione delle trasformazioni ammesse<br />
ed attività ammissibili tra quelle complessivamente ritenute fattibili e riportate in elenco<br />
contenuto nello stesso articolo. Tra i citati interventi è incluso quello di realizzazione di<br />
impianti per il trasporto dell’energia, con la precisazione che ove non completamente interrati<br />
non devono correre parallelamente alle rive dei corsi d’acqua e che si può prevedere<br />
esclusivamente l’attraversamento trasversale. Per quanto riguarda la realizzazione del<br />
cavidotto, si evidenzia che lo stesso si sviluppa in sotterranea, seguendo la viabilità esistente<br />
e scavalcando il corso d’acqua in appoggio ad un ponte esistente, come evidenziato negli<br />
elaborati identificativi delle soluzioni di progetto; le opere in oggetto sono quindi coerenti con<br />
l’indicazione formulata nella citata disciplina del Piano d’Area.<br />
La Unità Territoriale Organica Elementare, come stabilito all’articolo 80 delle Norme, sono<br />
sottoposte alla disciplina definita nell’allegato documento intitolato “Norme relative alle<br />
UTOE” ed anche alle disposizioni comuni di cui all’articolo 81 ed alle disposizioni quantitative<br />
dell’articolo 82. Per quanto riguarda il contenuto dell’articolo 81 si riprendono, nel sottostante<br />
riquadro, le parti di maggiore interesse.<br />
VERS: 01 2011 PAGINA: 53: 98
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
PS d’Area Val di Cornia – Norme – Articolo 81<br />
“UTOE - Disposizioni comuni”<br />
1. Le aree eventualmente necessarie per soddisfare il fabbisogno pregresso di spazi per usi pubblici e collettivi, riferito a ogni<br />
singolo nucleo o centro esistenti, possono essere individuate in aggiunta al sistema insediativo esistente.<br />
2. Il perimetro dell’unità territoriale organica elementare “7. Aree naturali protette” individua il sistema di aree protette esistenti. Il<br />
regolamento urbanistico individua e disciplina le aree contigue, oltre a quelle perimetrate dai piani delle aree protette comunque<br />
denominati, e altre porzioni del territorio che per la loro configurazione fisica e naturale e per la loro localizzazione sono<br />
funzionali al perseguimento degli obiettivi di tutela.<br />
3. Il regolamento urbanistico individua un’adeguata fascia di protezione contigua al perimetro del sistema insediativo, di<br />
ampiezza comunque non inferiore a 100 metri, nella quale non ammettere la nuova edificazione.<br />
La Unità distinta come “UTOE 3 – Piana di <strong>Venturina</strong>”, identificata e delimitata sulla Tavola<br />
10.1, è sottoposta alla disciplina contenuta nella sezione specifica delle Norme che definisce<br />
gli obiettivi generali, l’articolazione interna all’unità, la capacità insediativa, i criteri<br />
localizzativi e prestazionali da osservare in sede di redazione del RU, gli obiettivi specifici<br />
riferiti ai Sistemi insediativo, del territorio rurale aperto, infrastrutturale. In considerazione del<br />
fatto che gli interventi previsti, riguardanti tale UTOE, ricadono nel “Sistema del territorio<br />
rurale aperto” e che una parte di questi coinvolge la Vecchia Aurelia (S.P. 39) si richiamano,<br />
nel successivo riquadro, gli obiettivi specifici riguardanti il Sistema del territorio rurale ed il<br />
Sistema infrastrutturale, per le parti di diretto interesse.<br />
(..)<br />
Sistema del territorio rurale e aperto<br />
PS d’Area Val di Cornia – Norme UTOE<br />
“UTOE 3 – Piana di <strong>Venturina</strong>”<br />
Subsistemi della pianura costiera occidentale, della pianura alluvionale del fiume Cornia, delle colline di Riotorto e Montioni<br />
Il territorio rurale e aperto è composto, nella presente Utoe, dai subsistemi della pianura costiera occidentale e della pianura<br />
alluvionale del fiume Cornia e dal subsistema delle colline di Riotorto e Montioni.<br />
Nei suoi riguardi, il piano strutturale fa propri i temi prioritari individuati nel documento d’avvio:<br />
- conservazione e qualificazione del territorio rurale<br />
- difesa e promozione dello sviluppo delle attività agricole.<br />
Da questi temi discendono gli obiettivi generali da perseguire:<br />
- tutelare le risorse culturali e ambientali con un particolare riguardo a quelle minori, cui è legata la memoria e l’identità delle<br />
popolazioni<br />
- governare il cambiamento del paesaggio agrario in coerenza con la storia e la struttura del territorio, intesa come maglia<br />
territoriale cui agganciare il disegno del nuovo paesaggio<br />
- recuperare le parti compromesse e contrastare i fenomeni di degradazione del territorio e dell’ambiente, considerando ogni<br />
intervento sul territorio come occasione di riqualificazione ambientale<br />
- garantire il soddisfacimento delle necessità delle aziende agricole e delle attività connesse, compatibilmente con le risorse, in<br />
particolar modo quelle paesaggistiche e quelle idriche<br />
- tenere conto delle tendenze in atto, ma orientare le attività agricole alla vocazione del territorio nei suoi aspetti fisiografici,<br />
pedologici, botanici, agronomici, culturali e visuali, in modo che il loro sviluppo sia sostenibile e durevole<br />
- sostenere tutte le attività agricole e agrituristiche presenti nel territorio rurale in funzione della loro valenza di presidio<br />
ambientale<br />
Rispetto alle risorse specifiche del territorio individuato dalla presente Utoe, il regolamento urbanistico deve:<br />
- tutelare gli elementi specifici del paesaggio quali i percorsi storici e i filari, particolarmente e tassativamente ove di cipressi<br />
- disincentivare o limitare le attività idroesigenti nella piana agricola caratterizzata dai noti fenomeni di ingressione del cuneo<br />
salino e di subsidenza<br />
- salvaguardare il reticolo idrografico superficiale e dei fossi minori<br />
- favorire il consolidamento, il mantenimento e l’incentivazione delle aziende agricole presenti<br />
- incentivare la riconversione alberghiera delle strutture ricettive esistenti<br />
- non ammettere l’ampliamento delle attività produttive esistenti e incentivare la loro delocalizzazione all’interno del sistema<br />
insediativi<br />
(..)<br />
Sistema infrastrutturale principale<br />
(..)<br />
il piano strutturale propone l’allargamento della piattaforma stradale conformemente al tipo C2 (9,5 m) per la Sp n. 39 e al tipo<br />
F2 (8,5 m) per la Sp n. 23 ter, la realizzazione di aree per la sosta di emergenza eventualmente attrezzate anche per la sosta<br />
turistica, l’adeguamento degli angoli di visibilità in corrispondenza delle curve e degli innesti di altre strade e la realizzazione, in<br />
aderenza al tracciato, di una pista ciclabile.<br />
(..)<br />
PAGINA: 54: 98 2011 COD: 11V071
RELAZIONE PAESAGGISTICA<br />
Con riferimento agli obiettivi generali del territorio rurale, come già evidenziato, l’inserimento<br />
dell’impianto eolico in progetto, in generale, e l’esecuzione dell’intervento provvisorio di<br />
allestimento dell’area di cantiere della piazzola A82, di adeguamento della strada esistente<br />
per l’aerogeneratore A47 e di posa del cavidotto d’impianto, non comporta modifiche<br />
strutturali della maglia territoriale che connota il paesaggio della pianura agricola. Tale<br />
affermazione si basa sul fatto che gli interventi riguardanti i beni paesaggistici vincolati,<br />
associate a soluzioni di progetto non modificative dello stato attuale (considerando il previsto<br />
recupero dell’area di cantiere, l’interramento del cavidotto ed il mero ampliamento della<br />
sezione di starda esistente) tengono conto della necessità di preservare il disegno<br />
geometrico derivante dalla rete irrigua e dalla suddivisione particellare. Per quanto riguarda<br />
le indicazioni rivolte al RU, rimandando al successivo paragrafo, per quanto riguarda i<br />
contenuti del citato strumento già approvato dal Comune di Campiglia Marittima, si sottolinea<br />
che non si prevedono ricadute sui percorsi storici e sulla dotazione dei filari ed ancora non si<br />
determina alcuna modifica del reticolo idrografico superficiale.<br />
La Unità distinta come “UTOE 4 – Piana di Fiorentina”, è disciplinata secondo l’articolazione<br />
per punti già richiamata con riferimento alla UTOE 3; nel successivo riquadro si riprende la<br />
parte degli obiettivi specifici del Sistema del Territorio rurale aperto, considerato che le opere<br />
in progetto ricadono all’interno del Subsistema alluvionale del Fiume Cornia.<br />
(..)<br />
Sistema del territorio rurale e aperto<br />
PS d’Area Val di Cornia – Norme UTOE<br />
“UTOE 4 – Piana di Fiorentina”<br />
Subsistemi della pianura alluvionale del Fiume Cornia, del promontorio costiero del Monte Massoncello e del Golfo di Baratti e<br />
della pianura costiera occidentale<br />
(..)<br />
Nei suoi riguardi, il piano strutturale fa propri i temi prioritari individuati nel documento d’avvio:<br />
- conservazione e qualificazione del territorio rurale<br />
- difesa e promozione dello sviluppo delle attività agricole e zootecniche<br />
Da questi temi discendono gli obiettivi generali da perseguire:<br />
- tutelare le risorse culturali e ambientali con un particolare riguardo a quelle minori, cui è legata la memoria e l’identità delle<br />
popolazioni<br />
- governare il cambiamento del paesaggio agrario in coerenza con la storia e la struttura del territorio, intesa come maglia<br />
territoriale cui agganciare il disegno del nuovo paesaggio<br />
- recuperare le parti compromesse e contrastare i fenomeni di degradazione del territorio e dell’ambiente, considerando ogni<br />
intervento sul territorio come occasione di riqualificazione ambientale<br />
- garantire il soddisfacimento delle necessità delle aziende agricole e delle attività connesse, compatibilmente con le risorse, in<br />
particolar modo quelle paesaggistiche e quelle idriche<br />
- tenere conto delle tendenze in atto, ma orientare le attività agricole alla vocazione del territorio nei suoi aspetti fisiografici,<br />
pedologici, botanici, agronomici, culturali e visuali, in modo che il loro sviluppo sia sostenibile e durevole<br />
- sostenere tutte le attività agricole e agrituristiche presenti nel territorio rurale in funzione della loro valenza di presidio<br />
ambientale<br />
Rispetto alle risorse specifiche del territorio individuato dalla presente Utoe, il regolamento urbanistico deve:<br />
- conservare il paesaggio rurale di grande pregio paesaggistico che costituisce il connettivo tra le emergenze naturalistiche e<br />
archeologiche dei parchi<br />
- tutelare gli elementi specifici del paesaggio quali i percorsi storici e i filari, particolarmente e tassativamente ove di cipressi<br />
- disincentivare o limitare le attività idroesigenti nella piana agricola caratterizzata dai noti fenomeni di ingressione del cuneo<br />
salino e di subsidenza<br />
- salvaguardare il reticolo idrografico superficiale e dei fossi minori<br />
- studiare l’inserimento paesaggistico delle aree agricole frazionate e intensamente antropizzate<br />
- incentivare la riconversione alberghiera delle strutture ricettive esistenti<br />
- non ammettere l’ampliamento delle attività produttive esistenti e incentivare la loro delocalizzazione all’interno del sistema<br />
insediativi<br />
(..)<br />
Sistema infrastrutturale principale<br />
(..)<br />
Il piano strutturale comprende fra le strade da ristrutturare la strada provinciale n. 23 ter “Caldanelle”. Gli interventi consistono<br />
nell’allargamento della piattaforma stradale conformemente al tipo F2 (8,5 m), nella realizzazione di aree per la sosta di<br />
emergenza eventualmente attrezzate anche per la sosta turistica, nell’adeguamento degli angoli di visibilità in corrispondenza<br />
delle curve e degli innesti di altre strade e nella realizzazione, in aderenza al tracciato, di una pista ciclabile.<br />
(..)<br />
VERS: 01 2011 PAGINA: 55: 98
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
In tale UTOE ricadono cinque aerogeneratori ed in particolare, con riferimento ai beni<br />
paesaggistici vincolati, le opere connesse relative all’adeguamento della strada degli Affitti<br />
ed alla messa in opera del cavidotto nel tratto di passaggio del F. Cornia, entrambe in<br />
territorio del Comune di Piombino.<br />
Gli obiettivi e le indicazioni, contenute nel citato articolo e rivolte al RU, sono<br />
sostanzialmente simili a quelle definite per la UTOE 3 ed in tale senso si rimanda alle<br />
considerazioni prima formulate, con riferimento agli aspetti di conservazione della maglia<br />
territoriale e della rete idraulica, a cui si aggiunge la sottolineatura che la localizzazione delle<br />
opere che riguardano i beni paesaggistici vincolati non interferisce con le emergenze<br />
naturalistiche ed archeologiche dei parchi. Nemmeno si identificano possibili ricadute per il<br />
paesaggio rurale di grande pregio, che svolge un ruolo di connettivo tra le stesse<br />
emergenze, considerato che si trasformano aree di dimensione puntuale (nel caso<br />
dell’adeguamento della strada degli Affitti) ed in via transitoria (nel caso dell’area di cantiere<br />
della piazozla e della posa del cavidotto), in rapporto a quella agricola complessiva<br />
appartenente a tale Unità, e che si tratta sempre di campi condotti a seminativo.<br />
La Unita denominata “UTOE 5- Riotorto e Costa Est”, all’interno della quale ricadono due<br />
aerogeneratori (n. 64 e 84), è interessata, considerando le opere ricadenti nella fascia<br />
contermine ai corsi d’acaua a vincolo paesaggistico, dall’adeguamento della strada degli<br />
Affitti e dalla posa del cavidotto per un tratto lungo strada esistente che si sviluppa<br />
parallelamente all’asta del F. Cornia. La disciplina si articola secondo le stesse modalità<br />
delle precedenti UTOE; si riprendono, nel riquadro, le parti degli obiettivi inerenti al Sistema<br />
del territorio rurale aperto - Subsistema alluvionale del Fiume Cornia.<br />
(..)<br />
Sistema del territorio rurale e aperto<br />
PS d’Area Val di Cornia – Norme UTOE<br />
“UTOE 5 – Riotorto e Costa Est”<br />
Subsistemi delle colline di Riotorto e Montioni, della pianura alluvionale del fiume Cornia e della pianura costiera orientale<br />
Il territorio rurale e aperto è composto dal subsistema delle colline di Riotorto e Montioni, dal subsistema della pianura<br />
alluvionale del fiume Cornia e dal subsistema della pianura costiera orientale.<br />
Nei suoi riguardi, il piano strutturale fa propri i temi prioritari individuati nel documento d’avvio:<br />
- conservazione e qualificazione del territorio rurale<br />
- difesa e promozione dello sviluppo delle attività agricole e zootecniche<br />
Da questi temi discendono gli obiettivi generali da perseguire:<br />
- tutelare le risorse culturali e ambientali con un particolare riguardo a quelle minori, cui è legata la memoria e l’identità delle<br />
popolazioni<br />
- governare il cambiamento del paesaggio agrario attraverso la proposizione di forme coerenti con la storia e la struttura del<br />
territorio, intesa come maglia territoriale cui agganciare il disegno del nuovo paesaggio<br />
- recuperare le parti compromesse e contrastare i fenomeni di degradazione del territorio e dell’ambiente, considerando ogni<br />
intervento sul territorio come occasione di riqualificazione ambientale<br />
- garantire il soddisfacimento delle necessità delle aziende agricole e delle attività connesse, compatibilmente con le risorse, in<br />
particolar modo quelle paesaggistiche e quelle idriche<br />
- tenere conto delle tendenze in atto, ma orientare le attività agricole alla vocazione del territorio nei suoi aspetti fisiografici,<br />
pedologici, botanici, agronomici, culturali e visuali, in modo che il loro sviluppo sia sostenibile e durevole<br />
- sostenere tutte le attività agricole e agrituristiche presenti nel territorio rurale in funzione della loro valenza di presidio<br />
ambientale<br />
Rispetto alle risorse specifiche del territorio individuato dalla presente Utoe, il regolamento urbanistico deve:<br />
- conservare il tipico paesaggio rurale pedecollinare ai margini delle colline di Montioni e le aree agricole di pianura a Sud della<br />
strada della Base Geodetica che rappresentano il tessuto connettivo e il filtro paesaggistico rispetto alle emergenze<br />
naturalistiche del parco della Sterpaia, della riserva naturale Orti-Bottagone e del parco di Montioni<br />
- tutelare gli elementi specifici del paesaggio quali i percorsi storici e i filari, particolarmente e tassativamente ove di cipressi<br />
- disincentivare o limitare le attività idroesigenti nella piana agricola caratterizzata dai noti fenomeni di ingressione del cuneo<br />
salino e di subsidenza<br />
- salvaguardare il reticolo idrografico superficiale e dei fossi minori<br />
- favorire il consolidamento, il mantenimento e l’incentivazione delle aziende agricole presenti<br />
Gli obiettivi e le indicazioni rivolte al RU sono sostanzialmente simili a quelle definite per la<br />
UTOE 3 e 4 ed in tale senso si rimanda alle considerazioni prima formulate, con riferimento<br />
agli aspetti di conservazione della maglia territoriale e della rete idraulica, a cui si aggiunge<br />
PAGINA: 56: 98 2011 COD: 11V071
RELAZIONE PAESAGGISTICA<br />
la sottolineatura che gli interventi, anche quelli relativi all’installazione degli aerogeneratori,<br />
non ricadono e si trovano distanti sia dalle aree pedecollinari e collinari di Montoni, sia dalla<br />
fascia costiera delimitata dalla strada della Base Geodetica; si esclude, pertanto, ogni<br />
possibile ricaduta su tali ambiti territoriali e paesaggistici. Allo stesso modo valgono le<br />
considerazioni già svolte in merito alle previsioni di adeguamento la viabilità, con riferimento<br />
al previsto intervento lungo la strada degli Affitti, in corrispondenza dell’incrocio con la SP 40.<br />
La Unità distinta come “UTOE 8 – Riconversione urbana”, interessata da un breve tratto<br />
della strada esistente da adeguare per l’accesso agli aerogeneratori 70 e 71, è attraversata<br />
anche dal cavidotto d’impianto che, per un breve tratto, ricade nella fascia vincolata<br />
contermine al Fiume Cornia. Tale UTOE è disciplinata secondo l’articolazione per punti già<br />
richiamata con riferimento alle precedenti UTOE e nel successivo riquadro si riprende la<br />
parte degli obiettivi specifici associati al Sistema del Territorio rurale aperto, dato che le<br />
opere in progetto ricadono all’interno del Subsistema alluvionale del Fiume Cornia.<br />
(..)<br />
Sistema del territorio rurale e aperto<br />
Subsistema della pianura alluvionale del fiume Cornia<br />
PS d’Area Val di Cornia – Norme UTOE<br />
“UTOE 8 – Riconversione urbana”<br />
L’Utoe comprende solo limitate porzioni di territorio aperto, spesso frammentate da aree insediative sparse. Le aree aperte<br />
afferiscono interamente al subsistema della pianura alluvionale del fiume Cornia.<br />
Rispetto alle risorse specifiche della presente Utoe, il regolamento urbanistico deve:<br />
- prevedere trasformazioni che non accentuino la frammentazione insediativi presente; a questo fine, le eventuali nuove<br />
addizioni urbane devono essere funzionali alla riqualificazione e al recupero del territorio disordinatamente edificato, ovvero<br />
concentrate in pochi blocchi compatti<br />
- incentivare il mantenimento delle attività agricole con preferenza per indirizzi produttivi ad alto valore ambientale che non<br />
aggravino l’impatto ambientale delle attività produttive ma abbiano un alto potenziale di compensazione<br />
- salvaguardare il reticolo idrografico superficiale e dei fossi minori<br />
- promuovere la riqualificazione e la valorizzazione dell’asta fluviale del Cornia vecchio e delle aree contermini, costituendo un<br />
filtro verde sia rispetto alla nuova viabilità, sia riguardo le aree industriali adiacenti; questo obiettivo costituisce una specifica<br />
prescrizione per il progetto della nuova strada.<br />
(..)<br />
Per quanto riguarda gli obiettivi del Territorio rurale aperto si osserva che la posa in opera<br />
del cavidotto d’impianto, lungo ed a ridosso della viabilità esistente, non determina alcuna<br />
ulteriore frammentazione territoriale, dato che il previsto interramento con successivo<br />
ripristino garantisce il mantenimento del reticolo idrografico e dell’attuale disposizione dei<br />
fossi minori.<br />
3.4 Regolamento Urbanistico del Comune di Campiglia Marittima<br />
3.4.1 Riferimenti generali<br />
La L.R. 3.1.2005. n. 1, “Norme per il governo del territorio”, all’articolo 52 stabilisce che il<br />
Piano d’Area si attua attraverso gli atti di governo del territorio che comprendono il<br />
Regolamento Urbanistico (RU), i Piani complessi di intervento ed i Piani attuativi.<br />
Il Regolamento Urbanistico (RU), che in base all’art. 55 disciplina l’attività urbanistica ed<br />
edilizia per l’intero territorio comunale, si compone di una disciplina per la gestione degli<br />
insediamenti esistenti e di una disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi,<br />
infrastrutturali ed edilizi del territorio. La disciplina per la gestione, individua e definisce, tra i<br />
diversi punti elencati dalla normativa, anche la disciplina del territorio rurale (rimando agli<br />
articoli 39/47) e la valutazione di fattibilità idrogeologica degli interventi anche ai fini del<br />
vincolo idrogeologico di cui alla L.R. 39/2000.<br />
Il Regolamento Urbanistico, per quanto riguarda il Comune di Campiglia Marittima, è stato<br />
approvato con D.C.C. n 54 del 20.6.2011, ai sensi dell’articolo 17 della L.R. 1 /2005.<br />
VERS: 01 2011 PAGINA: 57: 98
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
Tale RU è costituito dai seguenti elaborati: Tavole dalla 1 alla 9, relative agli aspetti Usi e<br />
trasformazioni ammesse, Assimilazione alle zone omogenee, Abbattimento barriere<br />
architettoniche, Vincoli in attuazione del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, Fasce di<br />
rispetto e di tutela, Standard urbanistici esistenti e di previsione, Componente geologico<br />
idraulica, Fattibilità geologico idraulica; Dossier A - Analisi morfo tipologica del sistema<br />
insediativi, Dossier B e C riguardanti il Rilievo del patrimonio edilizio di valore storico e<br />
testimoniale all’interno del sistema insediativi e di valore storico nel territorio rurale e aperto;<br />
Dossier D – Sistemi della mobilità urbana e rete ciclabile extraurbana; Dossier E –<br />
Individuazione di beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi; Dossier F – Schede normativa<br />
e di orientamento progettuale; Norme Tecniche di Attuazione; <strong>Relazione</strong>; Valutazione<br />
integrata; <strong>Relazione</strong> geologica; <strong>Relazione</strong> idraulica.<br />
Il RU, che disciplina l’attività urbanistica ed edilizia, si compone di una parte attinente alla<br />
disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, con una distinzione tra il Sistema<br />
insediativo, il Territorio rurale e aperto e le Infrastrutture e dotazioni territoriali ed urbane, e<br />
di una parte riguardante la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi,<br />
infrastrutturali ed edilizi del territorio. Il RU individua, nelle Tavole 1 e 2, “Usi e trasformazioni<br />
ammesse”, le diverse categorie, di riferimento per l’applicazione delle norme, che sono<br />
assimilate alle zone omogenee definite dalle disposizioni nazionali.<br />
Nella parte delle Norme che definisce le “regole di gestione e trasformazione”, si<br />
considerano anche quelle relative alla “tutela ambientale e paesaggistica”, alla “protezione e<br />
fattibilità geologica, idrogeologica e idraulica” ed alla “tutela ambientale”, le ultime articolate<br />
in quelle riguardanti l’aria e clima acustico, l’acqua, il suolo e sottosuolo, l’elettromagnetismo,<br />
i rifiuti, l’inquinamento luminoso, il risparmio e gli impianti energetici da fonti rinnovabili.<br />
Le “regole di protezione e fattibilità geologica, idrogeologica e idraulica”, oltre a definire<br />
prescrizioni generali, contengono la disciplina associata ai diversi gradi di fattibilità alle<br />
trasformazioni, in parte già riportate sull’elaborato cartografico, quando associate a previsioni<br />
univocamente definite, ed in parte da ricavare sulla base dell’applicazione di una matrice che<br />
consente l’incrocio tra una serie di definite tipologie d’intervento e le classi di pericolosità; per<br />
ogni grado di fattibilità, derivante delle possibili combinazioni, e per ognuno dei tre aspetti<br />
(geomorfologico, idraulico, idrico), si definiscono i criteri applicativi da osservare.<br />
Le “regole di tutela ambientale e paesaggistica”, come precisato all’articolo 39 delle Norme,<br />
danno forma applicativa agli obiettivi di tutela del paesaggio toscano e dei valori che lo<br />
compongono ed alle finalità di valorizzazione espresse dal Piano di Indirizzo Territoriale<br />
avente valore di Piano paesistico regionale, e “danno operatività alle condizioni statutarie del<br />
vigente Piano strutturale di Area, in modo da fornire sostenibilità ambientale e paesistica al<br />
presente R.U.”. Al contempo, tali regole “danno operatività ai vincoli e alle condizioni d’uso<br />
delle risorse statuite dal Piano strutturale e si applicano ai beni paesaggistici definiti dalle<br />
norme nazionali in materia e al paesaggio inteso come risorsa del territorio, come stabilito<br />
dal PIT/PPR ai sensi della parte III, Titolo I del codice dei beni culturali e del paesaggio e del<br />
Titolo IV, capo I, della L.R. 1/2005, nonché come definito al Titolo III dello Statuto/Strategia di<br />
Piano – Risorsa Paesaggio, del PTC della Provincia di Livorno”. Tali regole danno sostanza<br />
anche agli obiettivi e definizioni del paesaggio, contenuti nel PTC della Provincia di Livorno<br />
ed in particolare sono individuati, con definizioni proprie del RU, i beni storici, naturalistici,<br />
culturali e paesaggistici disciplinati dal PIT/PPR e dal Piano strutturale di area.<br />
3.4.2 Relazioni tra RU ed interventi ricadenti nei beni paesaggistici<br />
Le opere previste per la realizzazione dell’impianto eolico, che interessano i beni<br />
paesaggistici vincolati (corsi d’acqua), come riportati anche nella Tavola 5, in base alla<br />
lettura degli elaborati Tavole 1 e 2 riguardanti gli usi e le trasformazioni ammesse per il<br />
Territorio aperto e per il Sistema insediativo e la Tavola 3 di assimilazione alle zone<br />
PAGINA: 58: 98 2011 COD: 11V071
RELAZIONE PAESAGGISTICA<br />
omogenee 12 , riguardano alcune delle categorie individuate e sottoposte a specifica<br />
disciplina. Nella successiva tabella si distinguono le categorie di piano ed i beni interessati e<br />
si precisa quali interventi o manufatti riguardano le stesse.<br />
RU - Comune di Campiglia Marittima<br />
Categorie interessate dagli interventi ricadenti nei beni paesaggisitci<br />
Elaborati di Progetto Categoria Interventi<br />
E1 – Area agricola produttiva (art. 82) Cavidotto (F. Diavolo)<br />
E2/fl – Aree agricole di pertinenza Area di cantiere piazzola 82<br />
fluviale (art. 82)<br />
Adeguamento strade esistenti (per 47)<br />
Cavidotto (F. Verrocchio)<br />
Tavola 2 – Usi e trasformazioni ammesse<br />
Sistema insediativo<br />
(nessuna categoria interessata) -<br />
Tavola 3<br />
Zone E – Aree destinate all’attività Tutti<br />
Assimilazione alle zone omogenee agricola e forestale<br />
Tavola 5<br />
Fascia contermine ai corsi d’acqua Area di cantiere piazzola 82<br />
Vincoli in attuazione del Codice<br />
Adeguamento strada esistente (per 47)<br />
Cavidotto (F. Diavolo e F. Verrocchio)<br />
Per quanto riguarda i beni storici, naturalistici, culturali e paesaggistici, come elencati<br />
all’articolo 39 delle Norme, si considera l’area agricola “E2/fl – Area agricola di pertinenza<br />
fluviale”, sul margine della quale ricade la piazzola dell’aerogeneratore n. 82 (nella<br />
configurazione di cantiere) e la strada da adeguare per consentire l’accesso<br />
all’aerogeneratore 47. Tali elementi fanno entrambi parte dei “Beni del territorio aperto” e,<br />
come precisato dal RU, sono definiti invarianti strutturali ai sensi della L.R. 1/2005. Le Norme<br />
del RU contengono, all’articolo 40, le regole generali da applicare a tali beni, ed agli articoli<br />
41 e 42, rispettivamente, le regole per la tutela dei beni territoriali del sistema insediativo e<br />
del sistema rurale e aperto, il cui contenuto, per le parti riguardanti le categorie di bene<br />
interessate dalle opere in progetto, è richiamato nel successivo riquadro.<br />
Art. 40<br />
Regole generali<br />
RU Comune di Campiglia Marittima – Norme – Articolo 40/42<br />
“Regole di tutela ambientale e paesaggistica”<br />
Sui beni oggetto del presente Capo, sono ammessi i seguenti interventi:<br />
- (..)<br />
- l’apertura di piste fuori strada per mezzi motorizzati necessari alle attività agrosilvo- pastorali o<br />
all’approvvigionamento di rifugi, posti di soccorso, funzioni di vigilanza, spegnimento incendi, prevenzione<br />
incendi, realizzazione di opere pubbliche;<br />
- (..)<br />
- la manutenzione dei tracciati viari esistenti, l’eventuale loro ammodernamento funzionale purché<br />
compatibilmente con le caratteristiche del contesto e del tracciato medesimo, ai fini della sicurezza delle<br />
persone e per realizzare percorsi ciclopedonali;<br />
- (..)<br />
- nuove costruzioni solo per finalità pubbliche, per le quali sia dimostrato che il sito scelto sia utilizzabile a<br />
tal fine e che non vi sono alternative di pari livello per il soddisfacimento di tali finalità, e sempre che non<br />
siano compromesse le caratteristiche ambientali e paesaggistiche;<br />
- (..).<br />
Sui beni oggetto del presente Capo, sono invece sempre vietati i seguenti tipi di intervento:<br />
- nuove infrastrutture, ivi compresi impianti della telefonia mobile (se non in forme, dimensioni, tecnologie<br />
tali da permetterne l’inserimento senza impatti) e impianti per la produzione di energia eolica, fatti salvi i<br />
piccoli generatori eolici ad uso agricolo;<br />
- (..)<br />
- la riduzione o la trasformazione di vegetazione boschiva e assimilata, dunale, di zone umide e degli<br />
acquiferi, di minerali e fossili, di formazioni arboree di argine, ripa e golena, di alberature segnaletiche,<br />
monumentali, di arredo e stradali, di siepi rigenerate e residue, di vegetazione forestale presente nelle<br />
aree di pregio paesaggistico e/o di verde privato individuate dal presente Regolamento urbanistico;<br />
- arredi vegetazionali estranei al contesto ambientale;<br />
- alterazione di elementi tipici delle sistemazioni agrarie;<br />
- la manomissione di viabilità e tracciati storici;<br />
- opere dannose alle emergenze geomorfologiche e florofaunistiche.<br />
12 Si rimanda all’estratto della Tavola 1 del RU, inserita nell’Allegato Cartografico.<br />
VERS: 01 2011 PAGINA: 59: 98
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
Art. 42<br />
Regole<br />
Beni del Sistema<br />
rurale e aperto<br />
Viabilità storica e viabilità vicinale<br />
Per i tracciati della viabilità storica, individuati dal presente R.U. sulla cartografia in conformità alle<br />
individuazioni del vigente Piano strutturale, sono prescritti il mantenimento nei relativi aspetti strutturali,<br />
quali il tracciato, la giacitura e le caratteristiche dimensionali, nonché, ove si siano conservati, o siano<br />
recuperabili, negli aspetti costruttivi e formali sia degli elementi di viabilità che dei relativi elementi di<br />
supporto e di arredo, quali i muri di recinzione latistanti e quelli di sostegno e di contenimento, e simili.<br />
Non sono pertanto ammesse:<br />
- trasformazioni territoriali, fondiarie, edilizie, che comportino la cancellazione di percorsi storici e di<br />
interesse paesaggistico;<br />
- l’asfaltatura della viabilità poderale e vicinale già presente all’impianto del Catasto Terreni;<br />
- la distruzione o la manomissione delle diverse componenti formali e costruttive, dimensionali, di tracciato<br />
della viabilità storica e dei relativi elementi di supporto e di arredo, quali i muri di recinzione latistanti e<br />
quelli di sostegno e di contenimento, e simili;<br />
- l’interruzione a fini privati della fruizione pubblica della viabilità vicinale.<br />
Sono ammesse:<br />
- la ricarica del cassonetto stradale con materiale idoneo tipo terra stabilizzata o conglomerati a matrice<br />
resinosa trasparente;<br />
- l’adeguamento funzionale di strade asfaltate esistenti.<br />
(..)<br />
In merito all’aerogeneratore 82, si precisa che nella zona E2/fl, “Area agricola di pertinenza<br />
fluviale”, per altro in corrispondenza del perimetro che delimita la stessa, ricade una ridotta<br />
parte dell’area occupata, in fase di cantiere, per l’allestimento dell’area di cantiere necessaria<br />
per procedere all’installazione dell’aerogeneratore la cui base, invece, si colloca al di fuori<br />
della citata zona agricola. La disciplina generale, riguardante i beni, non consente di<br />
realizzare impianti eolici sugli stessi, ma, in tale caso, si evidenzia che si tratta di<br />
un’occupazione e trasformazione transitoria del suolo, attualmente agricolo e quindi non<br />
rientrante nella casistica degli “altri beni”, per i quali si fa divieto di riduzione e<br />
trasformazione; al termine della fase di cantiere è per altro fattibile procedere, come previsto,<br />
al completo ripristino della parte ricadente all’interno dell’area agricola di pertinenza del<br />
corso d’acqua. Sempre con riferimento alla zona E2/fl, considerando il breve tratto di strada<br />
esistente che sarà utilizzato per accedere all’aerogeneratore 47, da adeguare nella<br />
larghezza, si evidenzia che le regole generali prevedono la possibilità di attuare sia interventi<br />
di manutenzione dei tracciati viari esistenti, per ammodernamento funzionale, sia l’apertura<br />
di nuove piste, per la realizzazione di opere pubbliche (gli impianti eolici assumono la<br />
valenza di opere di interesse pubblico).<br />
La “Zona E1 - Area agricola produttiva”, all’interno della quale ricadono la gran parte delle<br />
opere in progetto, e la “Zona E2/fl – Area agricola di pertinenza fluviale” sono sottoposte alle<br />
regole generali contenute nell’articolo 78, relative all’uso e valorizzazione delle risorse del<br />
territorio rurale ed aperto, ed alla disciplina specifica definita, rispettivamente, agli articoli 82<br />
e 83, che si richiama, per stralci, nei successivi riquadri.<br />
(..)<br />
RU Comune di Campiglia Marittima – Norme – Articolo 82<br />
“Zona E1 – Area agricola produttiva”<br />
Gli interventi devono esplicitare il rispetto delle invarianti strutturali prescritte dal piano strutturale vigente, che per la sottozona<br />
E1 sono:<br />
- per la porzione coincidente con il subsistema della pianura costiera occidentale la prevalenza dei suoli antichi asciutti, detti<br />
“sabbie rosse”, nel loro rapporto con limitate presenze di suoli idromorfi delle repressioni retrodunali. In particolare, l’elevata<br />
attitudine dei suoli antichi asciutti, detti “sabbie rosse”, deve essere considerata per ordinamenti orticoli intensivi a pieno campo;<br />
- per la porzione coincidente con il subsistema della pianura alluvionale del Fiume Cornia l’unitarietà e la continuità dei territori<br />
pianeggianti, e il loro porsi come la matrice connettiva più forte dell’intero territorio oggetto del presente piano, seppure<br />
intaccata da fenomeni di frammentazione e di dispersione infrastrutturali e insediativi; nonché il reticolo idraulico identificato<br />
nella tavola contrassegnata con 4.9 del Piano strutturale vigente.<br />
PAGINA: 60: 98 2011 COD: 11V071
RELAZIONE PAESAGGISTICA<br />
RU Comune di Campiglia Marittima – Norme – Articolo 83<br />
“Zona E2/fl – Area agricola di pertinenza fluviale”<br />
(..)<br />
In applicazione dell’art. 57 delle Norme del Piano strutturale vigente, nelle sottozone E2/fl sono ammesse:<br />
- (..)<br />
- la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione di impianti a rete e puntuali (..), per il trasporto dell’energia e per le<br />
telecomunicazioni, fermo restando che, nei casi di ristrutturazione e di nuova realizzazione, gli impianti a rete, ove non<br />
completamente interrati, non devono correre parallelamente alle rive dei corsi d’acqua, dei quali, come delle eventuali relative<br />
aree golenali, può prevedersi esclusivamente l’attraversamento trasversale;<br />
- (..)<br />
- la manutenzione, l’adeguamento, la realizzazione, al di fuori dagli alvei fluviali ordinari in modellamento attivo e delle eventuali<br />
relative aree golenali, di strade poderali e interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari, le quali non devono essere<br />
asfaltate, né pavimentate con altri materiali impermeabilizzanti;<br />
- (..)<br />
Il RU, in base a quanto riportato sulla Tavola 3 e definito all’articolo 9, stabilisce la<br />
corrispondenza tra il Subsistema del territorio rurale e aperto”, di cui al PS, distinta in diverse<br />
categorie siglate come En dal RU, e le zone omogenee distinte come “Zone E – Aree<br />
destinate all’attività agricola e forestale” dalla normativa nazionale di cui al D.M. 1444/1968.<br />
Come richiamato al citato articolo, “nel territorio rurale e aperto”, articolato nelle sottozone E,<br />
sono individuati “i beni del territorio aperto, considerati invarianti strutturali dal Piano<br />
strutturale”, che in tale caso coincidono con le sottozone E2/fl area di pertinenza fluviale, E4<br />
area boscata ed E5 area umida fluviale e palustre. Ancora, la disciplina precisa che i restanti<br />
beni del territorio rurale e aperto, sono soggetti a “tutela assoluta per la specificità dei valori<br />
naturalistici, o ambientali o paesaggistici”, e regolati nel Capo II del Titolo II delle stesse<br />
Norme; in tale caso sono individuati, quali beni, le spiagge, le dune, la costa alta del<br />
promontorio, il sito di preminente valore dei Parchi di Populonia e San Silvestro (nessuno è<br />
interessato dalle opere in progetto).<br />
Per quanto riguarda la compatibilità degli interventi previsti si evidenzia che, in base al D.lgs<br />
29.12.2003, n. 387, di recepimento della Direttiva 2001/77/CEE, la realizzazione di impianti<br />
di produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita se ricade in territori definiti come<br />
zone agricole dagli strumenti urbanistici, nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno<br />
nel settore agricolo, della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, della tutela<br />
della biodiversità e del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. 13<br />
In aggiunta, si sottolinea che, come ulteriormente precisato al punto 3.1 delle Linee Guida di<br />
cui al D.M. 10.9.2010, ai fini dell’applicazione del citato articolo 12 del D.lgs 387/2003, tra le<br />
opere connesse sono compresi anche i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla<br />
connessione alla rete elettrica. Al contempo, come specificato al punto 15.3 delle citate<br />
Linee Guida, l’eventuale variante dello strumento urbanistico vigente non è richiesta nel caso<br />
di ubicazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in zone<br />
classificate agricole, con la precisazione che restano ferme le previsioni dei piani<br />
paesaggistici e le prescrizioni d’uso indicate nei provvedimenti di dichiarazione di notevole<br />
interesse pubblico ai sensi del D.lgs 42/2004.<br />
In merito alle regole per la tutela ambientale riferite ai “criteri localizzativi degli impianti<br />
energetici”, di cui all’articolo 57 del RU, si evidenzia che una parte delle stesse ha perso<br />
efficacia a seguito dell’emanazione delle Linee Guida nazionali e regionali in materia e che<br />
per la restante parte si tratta di un richiamo ai contenuti delle Linee Guida nazionali in<br />
attuazione del D.lgs 387/2003 e della precisazione che, in attesa del provvedimento<br />
regionale di indicazione delle aree escluse, in applicazione del punto 1.2 delle Linee Guida<br />
nazionali, “la pianificazione comunale assume carattere programmatorio, nel rispetto dei<br />
criteri di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità”.<br />
13 D.lgs. 387/2003, art. 12, c. 7: ”Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all’articolo 2, lettere b) e c)<br />
possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici”.<br />
VERS: 01 2011 PAGINA: 61: 98
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
3.5 Variante Generale del PRG del Comune di Piombino<br />
3.5.1 Riferimenti generali<br />
Il Comune di Piombino, che con D.C.C. n. 52 del 19.6.2007 ha approvato il Piano Strutturale<br />
d’Area della Val di Cornia, non si è ancora dotato di conseguente RU e pertanto, come<br />
stabilito dall’articolo 83 delle Norme dello stesso PS, è valida la disciplina del PRG e dei<br />
piani attuativi vigenti ed anche quella delle varianti, successivamente redatte, conformi alle<br />
disposizioni del PS, nonché dei piani attuativi, eventualmente previsti da tali varianti. In<br />
merito alle misure di salvaguardia contenute nel PS d’Area, come precisato all’articolo 84<br />
delle Norme, le stesse avevano validità fino all’entrata in vigore del RU e comunque per un<br />
periodo non superiore a 3 anni dall’entrata in vigore del PS; i citati termini temporali sono<br />
stati già superati.<br />
In considerazione del quadro richiamato, che vede solo avviata la procedura di definizione<br />
del RU relativo al territorio del Comune di Piombino, si considera la Variante Generale al<br />
PRG 94, approvata con atto del Consiglio Regionale n. 254 del 16.7.1997 e con atti della<br />
Giunta della Regione Toscana n. 1578 del 21.12.98 e n. 30 del 17.1.2000.<br />
La VG, che interessa l’intero territorio comunale, considera l’assetto delle infrastrutture di<br />
comunicazione, l’assetto e l’uso del territorio, compresa la disciplina paesaggistica ed<br />
ambientale di cui alla ex L.R. 52/1982, D.C.R. 296/1998 e L.R. 4/1990. Tale Variante<br />
individua cinque Sistemi territoriali (dei Monti e Stagno di Piombino, dei Monti di Populonia e<br />
Baratti, costiero orientale o delle Macchie dei Perelli e della Sterpaia, delle Colline di Riotorto<br />
e Montioni, della piana centrale), per i quali stabilisce, mediante le Norme Tecniche<br />
Attuative, disposizioni comuni e disposizioni specifiche per ognuno di questi.<br />
Gli atti costitutivi della VG comprendono gli elaborati di conoscenza e di analisi dell’assetto e<br />
delle risorse del territorio e gli elaborati di progetto, gli ultimi costituiti da una serie di 13<br />
Tavole, dalle Norme Tecniche di Attuazione con i relativi allegati e dalla <strong>Relazione</strong><br />
Illustrativa. Le Tavole, restituite a scale differenti, riguardano i seguenti aspetti: sistemi<br />
territoriali; ambiti prevalentemente edificati o di completamento, patrimonio edilizio sparso ed<br />
interventi unitari; suddivisione del territorio comunale in zone omogenee; relazione sugli studi<br />
geologico tecnici di supporto alla pianificazione urbanistica con la carta della pericolosità e la<br />
carta della fattibilità; la carta delle risorse naturali e storico archeologiche del territorio<br />
prevalentemente inedificato; la carta delle proposte di modifica del perimetro delle aree<br />
protette; la carta di classificazione tipologica delle aree protette.<br />
Nelle NTA, innanzitutto, forniscono le definizioni dei principali termini urbanistici utilizzati ed<br />
in particolare quella relativa ai Sistemi territoriali ed agli Ambiti, distinguendo, nel secondo<br />
caso, quelli prevalentemente edificati o di completamento (le zone A, B, C, D ed F), da quelli<br />
prevalentemente non edificati agricolo ambientali (le zone E ed F). Le Norme precisano la<br />
classificazione delle destinazioni d’uso (dalla A alla G) associate ad ogni area, complesso od<br />
immobile, definendo le relative funzioni ammesse, e dettano disposizioni comuni relative a<br />
differenti aspetti. In particolare, si evidenzia che le norme, al Titolo II, definiscono la disciplina<br />
generale riguardante le modificazioni del suolo (art. 8), le aree riparie (art. 17), i ritrovamenti<br />
archeologici (art. 20), la classificazione degli ambiti, ivi compreso quello agricolo ambientale<br />
o delle Zone omogenee E (art. 60), e le aree con funzione di protezione paesaggistica ed<br />
ambientale (art. 28). Per quanto riguarda i Sistemi Territoriali, secondo la distinzione tra<br />
Ambiti prevalentemente edificati e di completamento ed Ambiti prevalentemente non edificati<br />
agricolo ambientali ed a parco, le NTA definiscono, ai Titoli III e IV, la disciplina di dettaglio.<br />
3.5.2 <strong>Relazione</strong> tra VG di PRG ed interventi ricadenti nei beni paesaggistici<br />
Gli interventi ed i manufatti dell’impianto eolico di progetto ricadono nell’Ambito<br />
prevalentemente non edificato agricolo ambientale ed in dettaglio in quello distinto come<br />
“Ambito agricolo ambientale”, con l’unica eccezione del tratto di cavidotto in sovrappasso del<br />
PAGINA: 62: 98 2011 COD: 11V071
RELAZIONE PAESAGGISTICA<br />
F. Cornia, la cui asta ricade anche nella categoria delle “Aree riparie”. 14 In quest’ultimo caso<br />
si precisa che il passaggio del cavidotto, che riguarda per altro anche la fascia a vincolo<br />
paesaggistico legata al corso d’acqua, è effettuata con una collocazione interrata e laterale<br />
alla viabilità esistente ed ancora in appoggio al ponte già presente, non determinando alcuna<br />
ricaduta, sotto il profilo funzionale ed ambientale, incluso quello idraulico. L’impianto eolico,<br />
con tutte le opere connesse, ricade, inoltre, all’interno del “Sistema territoriale della piana<br />
centrale” che comprende l’estesa porzione di territorio delimitata dal confine comunale, a<br />
nord, dalla strada della Base Geodetica, a sud, dalla linea ferroviaria, ad ovest, ed infine<br />
dalle colline di Riotorto, ad est.<br />
Gli Ambiti agricoli ambientali (Zone omogenee E), sono disciplinati all’articolo 29 delle NTA<br />
della VG che nella premessa precisa che si tratta di “zone con esclusiva prevalente o<br />
residuale funzione agricola (zone omogenee E del D.M. 2.4.1968 n. 1444)”; nel successivo<br />
riquadro si riportano gli stralci relativi alle parti di maggiore interesse dell’articolo 29.<br />
(..)<br />
VG PRG Comune di Piombino – NTA – Articolo 29<br />
“Classificazione degli ambiti agricolo ambientali”<br />
CONSERVAZIONE DEGLI AMBITI AGRICOLO-AMBIENTALI<br />
Ai fini delle conservazione dei valori ambientali e degli assetti idrogeologici delle zone agricole non è ammesso:<br />
- ridurre la consistenza delle formazioni arboree lineari individuate negli elaborati grafici di piano e tutelate dal presente<br />
strumento;<br />
- eliminare qualsiasi manufatto di valore storico e/o culturale;<br />
- eliminare e asfaltare la viabilità poderale esistente;<br />
- diminuire il grado di efficienza idraulica della rete scolante superficiale;<br />
- eseguire opere di sistemazione fondiaria che aggravino le possibilità di ristagni ed impaludamenti;<br />
- procedere con asportazione di materiale arido se non nelle quantità strettamente necessarie per nuovi ordinamenti colturali di<br />
aziende agricole e, comunque, sempre previa presentazione del programma aziendale;<br />
(..)<br />
AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO<br />
Nelle aree di interesse archeologico individuate negli elaborati grafici della Variante Generale, modificabili in ogni tempo senza<br />
che ciò costituisca variante urbanistica, le lavorazioni di profondità superiore a m 1,00 possono essere eseguite solo previa<br />
comunicazione alla competente Soprintendenza Archeologica.<br />
IMPIANTI PUBBLICI E DI PUBBLICO INTERESSE<br />
Nelle zone agricole è ammessa la realizzazione di reti di telecomunicazione, trasporto, distribuzione e trasformazione di energia<br />
elettrica (..) , quando tali opere non siano espressamente vietate o condizionate da specifiche norme per le varie sottozone e<br />
dalle disposizioni comuni per le aree con funzione di protezione paesaggistica ed ambientale di cui all'art. 28. La nuova<br />
costruzione di linee ed impianti per il trasporto, la distribuzione e la trasformazione di energia elettrica sono regolati dalla L.R. n.<br />
51/99 “Disposizioni in materia di linee elettriche ed impianti elettrici”, fatta eccezione per la costruzione di opere edilizie adibite a<br />
stazioni ed a cabine elettriche che restano assoggettate al procedimento della concessione edilizia o altro procedimento<br />
urbanistico.<br />
(..)<br />
Le nuove linee aeree dovranno essere realizzate in maniera tale da evitare o mitigare il contrasto con i valori e con le funzioni<br />
proprie del contesto ambientale e paesaggistico interessato. A tal fine si dovrà, ove possibile, seguire la viabilità esistente e non<br />
operare riduzioni sostanziali della vegetazione esistente, si dovranno prevedere tecniche di mimetizzazione<br />
(..)<br />
In attesa della approvazione delle linee guida previste dal comma 10 dell’art. 12 del DLgs 387/03, del Piano di Indirizzo<br />
Energetico Regionale e della Pianificazione Energetica Provinciale nonché della definizione del Regolamento Urbanistico<br />
Comunale, gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili devono osservare precise regole insediative.<br />
(..)<br />
Gli Ambiti in oggetto si articolano, ai fini gestionali ed attuativi della L.R. n. 64/95, in diverse<br />
tipologie di Unità di Paesaggio Rurale (UPR) ed in Unità di Paesaggio Urbano (UPU),<br />
individuate dal Piano Territoriale di Coordinamento sulla base della omogeneità di uso del<br />
suolo e della geomorfologia, recepite, con limitate modifiche e di fatto coincidenti con i<br />
Sistemi Territoriali identificati dalla VG del PRG. Per quanto riguarda le opere in progetto si<br />
precisa che si ricade all’interno della UPR con prevalente funzione agricolo produttiva<br />
“Cornia 1“ ed in aggiunta, con riferimento alle sottozone in cui si articolano le zone con<br />
esclusiva, prevalente o residuale funzione agricola, si rientra in quella distinta come “E1-<br />
Area agricola produttiva”. Per le citate zone con esclusiva, prevalente o residuale funzione<br />
14 Si rimanda all’estratto della Tavola 3.1 del QC del PS d’Area della Val di Cornia, inserita nell’Allegato Cartografico.<br />
VERS: 01 2011 PAGINA: 63: 98
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
agricola si applicano sia le disposizioni comuni, definite al citato articolo 29, sia quelle<br />
specifiche delle singole sottozone che, nel caso della E1, in aggiunta rispetto a quelle<br />
generali, precisano solo che “è ammessa l'ospitalità agrituristica con mezzi autonomi di<br />
soggiorno negli spazi aperti delle aziende agricole“.<br />
In merito ai contenuti dell’articolo 29 si osserva che le opere in progetto, incluse quelle<br />
ricadenti nei beni paesaggistici vincolati (il cavidotto d’impianto, con riferimento alla fascia<br />
contermine al F. Cornia, e l’adeguamneto della strada degli Affitti, in relazione alla fascia<br />
contermine al Fosso Cosimo) non risulta che interessano formazioni arboree lineari e<br />
tantomeno manufatti di valore storico culturale. Allo stesso modo non è previsto di eliminare<br />
la viabilità poderale esistente e nemmeno di asfaltare la stessa, anche nei casi di interventi di<br />
adeguamento, quando la stessa è in sterrato. In merito alle rete scolante, evidenziato in<br />
generale che la posizione delle piazzole ed il tracciato delle strade si adegua, per quanto<br />
possibile, al disegno interpoderale e della fitta maglia delle scoline, evitando di modificare la<br />
stessa, si precisa che non si prevedono ricadute per la messa in opera del cavidotto interrato<br />
(grazie ai previsti ripristini del suolo) e che del tutto marginale è quella inerente al puntuale<br />
adeguamento della citata strada che per altro non modifica il grado di efficienza idraulica<br />
della rete scolante superficiale.<br />
Per quanto riguarda le aree di interesse archeologico, ovviamente, prima di eseguire gli<br />
scavi necessari per la posa del cavidotto interrato, si invierà opportuna comunicazione alla<br />
competente Soprintendenza.<br />
Per quanto attiene agli impianti di interesse pubblico si osserva che la realizzazione di nuove<br />
linee elettriche, per altro sostanzialmente da riferire a quelle aeree, non è esclusa e si<br />
fornisce l’indicazione di evitare o mitigare le eventuali ricadute sull’ambiente e paesaggio<br />
interessato. La soluzione adottata, con cavidotto interrato che si sviluppa, prevalentemente,<br />
in affiancamento e seguendo la viabilità esistente, assicura il rispetto dei citati criteri ed in<br />
ogni caso si provvederà, al termine della fase di cantiere, al ripristino dello stato dei luoghi,<br />
ovvero a consentire la ripresa dell’uso agricolo. In merito al riferimento agli impianti<br />
energetici da fonti rinnovabili, si ritiene che, a seguito della approvazione delle Linee Guida<br />
nazionali, sono superate le indicazioni contenute nelle NTA della VG e viceversa si deve fare<br />
riferimento al contenuto del D.M. 10.9.2010.<br />
Per quanto riguarda tale Ambito, equiparato alle Zone omogenee agricole E, vale quanto<br />
previsto dal D.M. 1444/1968 e dal D.lgs 29.12.2003, n. 387, in base ai quali la realizzazione<br />
di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è ammessa se in territori identificati,<br />
negli strumenti urbanistici, come zone agricole, senza necessità di effettuare varianti, come<br />
per altro ulteriormente precisato dal D.M. 10.9.2010, al punto 15.3, tenuto conto, per altro,<br />
che non si ricade in aree sottoposte a vincolo a seguito di provvedimenti di dichiarazione di<br />
notevole interesse pubblico, ai sensi del D.lgs 42/2004.<br />
Il Sistema territoriale della piana centrale, con riferimento agli Ambiti prevalentemente non<br />
edificati agricolo ambientali, è disciplinato dall’articolo 58 dove si riportano considerazioni<br />
inerenti all’inquinamento salino ed al risanamento idrologico (obiettivo essenziale) ed alla<br />
necessità di non sottovalutare i valori paesaggistici di tale sottosistema territoriale, in<br />
connessione con gli altri. In aggiunta, si precisa che tale Sistema è sottoposto alla disciplina<br />
delle Aree E1, definita al già citato articolo 29. All’interno di tale Sistema si distingue l’Ambito<br />
del Cornia, sottoposto alla disciplina di cui all’articolo 59.<br />
VG del PRG Comune di Piombino – NTA – Articolo 59<br />
“Ambito del Cornia”<br />
Comprende l'alveo e gli argini del fiume Cornia; oltre le disposizioni comuni di cui all'art.17, valgono le seguenti norme<br />
specifiche: è vietata qualunque forma di escavazione nell'alveo del fiume che non sia motivata da necessità per pubblico<br />
interesse o per la protezione civile (opere di regimazione idraulica). Il materiale solido dovrà essere restituito a valle o utilizzato<br />
per interventi di ripascimento del litorale sabbioso. Le aree laterali, per una profondità di 150 metri, sono classificate E2, di cui<br />
all'art. 29 e sottoposte alle relative norme.<br />
PAGINA: 64: 98 2011 COD: 11V071
RELAZIONE PAESAGGISTICA<br />
Con riferimento alla richiamata disciplina si precisa che per il passaggio del cavidotto non si<br />
prevede di effettuare alcuno scavo all’interno dell’alveo ed inoltre, con riferimento al<br />
contenuto dell’articolo 17, si evidenzia che non si modificano le caratteristiche attuali<br />
dell’alveo e non si interviene sull’eventuale vegetazione presente, essendo previsto, come<br />
da progetto, l’ancoraggio alla fiancata del ponte esistente.<br />
Per quanto riguarda le aree E2, definite come “Aree agricole d’interesse paesaggistico<br />
d’insieme”, le norme specifiche non aggiungono alcun riferimento riguardante la<br />
realizzazione di infrastrutture energetiche per cui valgono le considerazioni riferite alla<br />
disciplina generale degli Ambiti agricoli ambientali, a cui si è già fatto riferimento.<br />
3.6 Parchi e Riserve naturali - Rete Natura 2000<br />
3.6.1 Riferimenti generali<br />
La Legge Quadro La Legge Quadro nazionale sulle Aree Protette (L. 394/91) classifica le<br />
aree naturali protette in: Parchi Nazionali; Parchi naturali regionali e interregionali; Riserve<br />
naturali.<br />
La Regione Toscana, con la L.R. n. 49 dell’11/04/1995 “Norme sui parchi, le riserve naturali<br />
e le aree naturali protette di interesse locale” e smi, da parte sua definisce le disposizioni per<br />
l’istituzione e la gestione di parchi regionali e provinciali, riserve naturali e aree naturali<br />
protette di interesse locale, al fine di garantire la conservazione e riqualificazione<br />
dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-culturale e naturalistico della Regione; la<br />
promozione delle attività economiche compatibili, delle attività ricreative, della ricerca<br />
scientifica, della divulgazione ambientale, nonché della gestione faunistica attraverso il<br />
coordinamento con le normative di settore (in particolare con la LR 12 gennaio 1994, n. 3),<br />
nel rispetto dei criteri e limiti fissati per la gestione del territorio e la regolamentazione della<br />
caccia. Le aree naturali protette, come definite dalla L.R. 49/1995 si distinguono in Parchi,<br />
Riserve Naturali e Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL).<br />
Ogni tre anni il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, approva il Programma della<br />
Aree Protette, che si articola in un piano di indirizzo e in un provvedimento di riparto delle<br />
disponibilità finanziarie. Al Programma è allegato, anche ai sensi dell’art. 5 della L. 394/1991,<br />
l’elenco delle aree protette regionali, recante la classificazione dei parchi provinciali e<br />
regionali, delle riserve naturali e delle aree naturali protette d’interesse locale.<br />
La Rete Natura 2000 costituisce la più importante strategia d’intervento dell’Unione Europea<br />
per la tutela del territorio. Tenuto conto della necessità di attuare una politica più incisiva di<br />
salvaguardia degli habitat e delle specie di flora e fauna, si è voluto dar vita ad una rete<br />
coerente di aree destinate alla conservazione della biodiversità del territorio dell’Unione<br />
Europea. I siti che compongono la Rete (Siti Natura 2000) sono rappresentati dai Siti<br />
d’Importanza Comunitaria (SIC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS), individuati dagli<br />
Stati membri in base alla presenza di habitat e specie vegetali e animali d’interesse europeo.<br />
I siti della Rete Natura 2000 sono regolamentati dalle Direttive Europee 79/409/CEE (e<br />
successive modifiche) concernente la conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE (e<br />
successive modifiche) relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali delle<br />
flora e della fauna selvatiche.<br />
La direttiva 92/43/CEE, la cosiddetta direttiva “Habitat”, è stata recepita dallo stato italiano<br />
con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva<br />
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora<br />
e della fauna selvatiche”. Il decreto stabilisce che le regioni e le province Autonome di Trento<br />
e Bolzano devono individuare i siti (SIC) in cui si trovano le tipologie di habitat elencate<br />
nell'allegato A e gli habitat delle specie di cui all'allegato B, per la costituzione della rete<br />
ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata "Natura 2000".<br />
VERS: 01 2011 PAGINA: 65: 98
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
La direttiva europea 79/409/CEE, la cosiddetta direttiva “Uccelli”, prevede, per le specie<br />
d’avifauna elencate nell’allegato I, misure speciali di conservazione dell’habitat per<br />
garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione. La Legge<br />
157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo<br />
venatorio” (e successive modifiche ed integrazioni), in attuazione di quanto richiesto dalla<br />
Direttiva “Uccelli”, richiede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano<br />
provvedano ad istituire lungo le rotte di migrazione dell’avifauna, segnalate dall’Istituto<br />
Nazionale per la Fauna Selvatica, le zone di protezione (ZPS) finalizzate al mantenimento ed<br />
alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad<br />
esse limitrofe; provvedano al ripristino dei biotopo distrutti ed alla creazione dei biotopi.<br />
In Regione Toscana il recepimento delle sopra citate direttive comunitarie avviene con la LR<br />
del 6 aprile 2000, n. 56 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e<br />
seminaturali, della flora e della fauna selvatiche – Modifiche alla LR 23 gennaio 1998, n. 7 –<br />
Modifiche alla LR 11 aprile 1995, n. 49” con la quale la Regione individua i Siti di Importanza<br />
Regionale (SIR), intesi come aree geograficamente definite che contribuiscono in modo<br />
significativo a mantenere o ripristinare un tipo di habitat naturale o una specie di interesse<br />
regionale.<br />
3.6.2 Relazioni tra aree protette ed interventi ricadenti nei beni paesaggistici vincolati<br />
Nessuno degli interventi che riguardano le fasce contermini ai corsi d’acqua sottoposti a<br />
vincolo paesaggistico e, più in generale, nessuna delle opere di progetto, ricade all’interno di<br />
Aree Protette e di SIC, SIR o ZPS.<br />
Tra i parchi, le riserve e le ANPIL, quelle che si trovano più vicine al sito di ubicazione degli<br />
aerogeneratori ed all’insieme delle opere previste, incluse quelle ricadenti nei beni<br />
paesaggistici vincolati, sono la Riserva Naturale Provinciale “Padule Orti Bottagone” e la<br />
ANPIL “Baratti-Populonia”.<br />
Tra le aree della Rete Natura 2000, le più vicine sono il SIC/ZPS IT5160010 “Padule Orti-<br />
Bottagone” ed il SIC IT5160009 “Promontorio di Piombino e Monte Massoncello”.<br />
3.7 Beni Culturali e Paesistici vincolati<br />
3.7.1 Riferimenti generali<br />
Il D. Lgs del 22.1.2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo<br />
10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”, costituisce il riferimento normativo in materia di beni<br />
culturali e paesaggistici. Tale decreto, in applicazione dell’articolo 9 della Costituzione,<br />
disciplina sia le forme di tutela dei beni culturali (patrimonio storico, artistico, demo-etnoantropologico,<br />
archeologico, archivistico, librario) che quelle dei beni paesaggistici ed<br />
ambientali (bellezze naturali; singolarità geologiche; ville, giardini e parchi; immobili di valore<br />
estetico e tradizionale; bellezze panoramiche e belvederi).<br />
Per quanto riguarda i beni culturali, le disposizioni per la tutela si applicano a seguito di una<br />
dichiarazione di interesse od immediatamente nel caso delle cose immobili o mobili di<br />
interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico. La tutela dei beni<br />
immobili si esercita nella forma del divieto alla demolizione, danneggiamento e utilizzo per<br />
usi incompatibili alla loro conservazione ed in particolare nella preventiva autorizzazione per<br />
una serie di interventi come elencati all’articolo 21. L’autorizzazione deve essere richiesta,<br />
dai proprietari, possessori o detentori dei beni, all’amministrazione competente al rilascio;<br />
tale autorizzazione può essere rilasciata con motivata dichiarazione in sede di conferenza<br />
dei servizi (art. 25) e con atto rilasciato in sede di concerto sulla compatibilità ambientale nel<br />
caso di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (art. 26).<br />
PAGINA: 66: 98 2011 COD: 11V071
RELAZIONE PAESAGGISTICA<br />
Per quanto attiene ai beni paesaggistici l’assoggettamento a tutela avviene a seguito della<br />
dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 137 - 141) o per effetto di disposizioni<br />
legislative, fino all’approvazione del piano paesaggistico, nel caso delle specifiche categorie<br />
di beni elencati nell’articolo 142. La normativa nazionale stabilisce che i beni paesaggistici<br />
sono tutelati e valorizzati sottoponendo a specifica normativa d’uso il territorio mediante Piani<br />
paesaggistici o Piani urbanistico territoriali con specifica considerazione dei valori<br />
paesaggistici, concernenti l’intero territorio regionale (art. 135). Il vincolo di tutela, che<br />
riguarda tutti i beni, si esercita nella forma del divieto (per i proprietari, possessori o<br />
detentori) di distruggere i beni od introdurvi modificazioni e nell’obbligo di sottoporre i progetti<br />
delle opere di qualunque genere (salvo quelle elencate all’art. 149) da eseguire alla<br />
competente amministrazione ai fini di ottenere preventiva autorizzazione.<br />
Il D.P.C.M. 12.12.2005, di individuazione della documentazione necessaria alla verifica della<br />
compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, definisce le finalità, i criteri di redazione<br />
ed i contenuti della <strong>Relazione</strong> <strong>Paesaggistica</strong> che correda, congiuntamente al progetto<br />
dell’intervento ed alla relazione di progetto, l’istanza da presentare per l’autorizzazione<br />
paesaggistica.<br />
3.7.2 Relazioni tra beni culturali e paesaggistici vincolati ed impianto eolico<br />
Il quadro relativo ai beni culturali e paesaggistici vincolati, presenti nel territorio dei Comuni<br />
territorialmente interessati dagli interventi previsti in fase di cantiere e dai manufatti<br />
dell’impianto in progetto, è ricostruito sulla base della consultazione delle informazioni<br />
contenute in diverse banche dati nazionali e regionali e nei documenti ed elaborati<br />
cartografici degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale ed urbanistica comunale.<br />
In dettaglio, si è fatto riferimento alle seguenti fonti o documenti:<br />
- SITAP del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Direzione Generale per i Beni<br />
Architettonici e Paesaggistici, dove sono identificate e delimitate le aree sottoposte a<br />
vincolo paesaggistico a seguito della loro dichiarazione d’interesse pubblico e parte di<br />
quelle corrispondenti alle categorie paesaggistiche tutelate per legge dal Codice;<br />
- Sistema Informativo Territoriale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Regione<br />
Toscana, che contiene schede relative alle aree soggette a vincolo architettonicomonumentale,<br />
alle aree soggette a vincolo archeologico ed alle aree soggette a<br />
vincolo paesaggistico ai sensi della ex L. 1497/1939;<br />
- Sito web della Regione Toscana, dove alla sezione relativa al PIT, mette a<br />
disposizione la cartografia di individuazione, delimitazione e rappresentazione degli<br />
immobili ed aree dichiarate di notevole interesse pubblico ed ancora, per l’intero<br />
territorio regionale, delle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell’articolo<br />
143, lettera c (fiumi, torrenti e corsi d’acqua), lettera d (montagne eccedenti i 1200<br />
m), lettera e (circhi glaciali), lettera g (foreste e boschi), lettera h (usi civici e<br />
università agrarie), lettera m (zone di interesse archeologico);<br />
- PIT della Regione Toscana che, nella Sezione 4 delle Schede degli Ambiti di<br />
Paesaggio, contiene le informazioni inerenti alle aree sottoposte a vincolo<br />
paesaggistico con specifica dichiarazione dell’interesse pubblico;<br />
- PTC della Provincia di Livorno, con riguardo agli elaborati di progetto, Tavola 2.1,<br />
“Sistema funzionale – Produttivo, Turismo, Commercio, Industria”, e Tavola 3<br />
“Sistema funzionale - Rete della cultura”, dove sono individuati i Parchi archeologici<br />
ed i Beni archeologici, ed ancora alla Tav. B, “Valori storici e culturali”, dove di<br />
delimitano le zone archeologiche e si identificano le emergenze architettoniche<br />
soggette a vincolo monumentale;<br />
- PS della Val di Cornia, in relazione al Quadro Conoscitivo, Tavola 1.2 “Unità di<br />
paesaggio rurale e aree con rilevante funzione ambientale”, dove si delimitano le<br />
zone archeologiche vincolate ex L. 1089/1939, Tavola 2.1 “Carta dei vincoli”, dove si<br />
delimitano i beni paesaggistici tutelati a seguito di dichiarazione del loro interesse<br />
pubblico e quelli tutelai per legge (art. 142) in quanto categorie del paesaggio ed<br />
VERS: 01 2011 PAGINA: 67: 98
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
ancora si individuano i beni culturali architettonici e si delimitano le aree dei beni<br />
culturali archeologici, tutelati ai sensi dell’articolo 13 del Codice.<br />
Per quanto attiene ai beni culturali immobili monumentali vincolati, questi non risultano<br />
essere presenti nell’area direttamente interessata dalla realizzazione dell’impianto eolico e<br />
delle opere connesse, considerando quindi anche i previsti interventi previsti di apertura di<br />
nuovi tratti di strade, funzionali a consentire l’accesso alle piazzole degli aerogeneratori, e di<br />
adeguamento della viabilità esistente, nonché quelli relativi alla posa del cavidotto interrato<br />
ed all’installazione della stazione utente, necessaria per la connessione alla rete tramite la<br />
già prevista sottostazione elettrica AT/MT. 15<br />
Nel Comune di Piombino, l’edificio monumentale più vicino agli aerogeneratori dell’impianto<br />
in progetto è la Torre della Vignarca, sottoposta a tutela, unitamente all’associata Fontana,<br />
con D.M. 26.3.1979. Il fabbricato si trova sulla strada provinciale n. 40 (strada della base<br />
geodetica), nei pressi della località Padule Bottagone, ad una distanza di circa 2,6 km<br />
dall’aerogeneratore n. 50 ed a circa 1,7 km dal più vicino intervento, quello di adeguamento<br />
puntuale della strada degli Affitti (ricadente nell’area vincolata del Fosso Cosimo), situazione<br />
che consente di escludere ricadute dirette sul bene derivanti dalle opere in progetto.<br />
Nel Comune di Campiglia Marittima, i beni vincolati situati più vicini agli aerogeneratori sono<br />
il Mausoleo Romano, ubicato all’interno dell’edificato della frazione di <strong>Venturina</strong>, e la Villa di<br />
Magona (D.M. 12.2.1956), collocata in posizione isolata su un poggio, in località Caldana di<br />
Sopra. Il Mausoleo si trova ad una distanza circa 2,6 km dal più vicino aerogeneratore n. 82,<br />
la cui piazzola nella configurazione di cantiere interessa parzialmente la fascia a vincolo<br />
paesaggistico associata alla Fossa Calda, e la Villa ad una di circa 2,8 km dal più vicino<br />
aerogeneratore n. 57, e poco più distante dall’intervento di posa del cavidotto nella fascia a<br />
vincolo paesaggistico del Fosso Diavolo. Tale distacco, unitamente al diverso contesto di<br />
appartenenza dei beni, urbanizzato nel primo caso e collinare nel secondo, rispetto a quello<br />
della piana agricola dove si posizionano gli aerogeneratori e si prevede di attuare i citati<br />
interventi riguardanti i beni paesaggistici, consente di escludere possibili ricadute dirette sugli<br />
edifici monumentali.<br />
Le aree archeologiche vincolate, allo stesso modo, non sono direttamente interessate dagli<br />
interventi previsti per la realizzazione dell’impianto eolico, e si precisa che quelle presenti in<br />
tale contesto territoriale comprendono: le diverse zone attorno a Populonia e Baratti, nel<br />
territorio del Comune di Piombino, tra le quali la più vicina all’impianto è quella di Poggio<br />
Malassarto (D.M. 11.8.1962), distante circa 1,9 km dall’aerogeneratore n. 69 e poco di più<br />
dall’intervento più vicino ricadente in area a vincolo paesaggistico, quello di posa del<br />
cavidotto all’interno della fascia contermine al Fiume Cornia. Le diverse zone in Val Fucinaia<br />
e in località San Silvestro, tra le quali le prime risultano essere le più vicine all’impianto, si<br />
trovano comunque alla significativa distanza minima di circa 8,4 km, considerando il più<br />
vicino aerogeneratore 82.<br />
Per quanto riguarda i beni paesaggistici vincolati con specifico provvedimento di<br />
dichiarazione del loro notevole pubblico interesse, ai sensi dell’articolo 136 del D.lgs<br />
42/2004, inclusi i cosiddetti “Galassini” emanati con specifico Decreto Ministeriale, che<br />
conservano tuttora efficacia ai sensi dell’art. 157 del D.lgs 42/2004, non risultano<br />
direttamente interessati dall’insieme delle opere in progetto, che ricadono tutte all’esterno dei<br />
territori vincolati. 16<br />
I beni d’insieme vincolati più vicini all’impianto eolico di progetto sono i seguenti:<br />
- la fascia costiera compresa tra il Golfo di Baratti ed il Golfo di Salivoli (D.M.<br />
22.9.1957, su G.U. 244/1957), in territorio del Comune di Piombino, il cui perimetro si<br />
trova ad una distanza minima di circa 1,4 km dagli aerogeneratori, considerando il più<br />
vicino, corrispondente al n. 69;<br />
15 Si rimanda alla tavola “2.1 Carta dei vincoli” del PS ed alla tavola “Beni vincolati”, inserite nell’Allegato Cartografico.<br />
16 Si rimanda alla tavola “MIBAC – Aree vincolate D.lgs 42/2004”, alla tavola “Beni vincolati”, inserite nell’Allegato Cartografico.<br />
PAGINA: 68: 98 2011 COD: 11V071
RELAZIONE PAESAGGISTICA<br />
- la zona compresa tra Torre del Sale ed il confine con il Comune di Follonica (D.M.<br />
20.9.1962, su G.U. 250/1962), in territorio del Comune di Piombino, il cui perimetro<br />
dista circa 2,6 km dal più vicino aerogeneratore n. 64;<br />
- la fascia costiera sita nel Comune di San Vincenzo (D.M. 18.12.1953, rettificato con<br />
D.M. 25.1.1967, pubblicati rispettivamente sulla G.U. 7/1954 e 156/1967), il cui<br />
perimetro si trova ad una distanza di circa 2,5 km dal più vicino aerogeneratore n. 76.<br />
Nel caso dei beni paesaggistici vincolati in quanto categorie del paesaggio, ai sensi<br />
dell’articolo 142 del D.lgs 42/2004 (ex L. 431/1985), nella parte di territorio corrispondente<br />
alla pianura del Cornia, si distinguono unicamente i corsi d’acqua pubblici con le relative<br />
fasce contermini, per una profondità di 150 sui due lati dalla sponda od argine.<br />
Alcuni dei corsi d’acqua sottoposti a tutela sono direttamente interessati dalle opere in<br />
progetto ed in dettaglio si tratta dei seguenti casi:<br />
- Fosso Calda, per l’allestimento, in fase di cantiere, della piazzola dell’aerogeneratore<br />
n. 82 che, per una minima parte, ricade a cavallo del perimetro che delimita la fascia<br />
vincolata di tale corso d’acqua, ricadente nel territorio del Comune di Campiglia<br />
Marittima;<br />
- Fosso Verrocchio, per l’adeguamento della viabilità esistente che si prevede di<br />
percorrere per raggiungere l’aerogeneratore n. 47, in un tratto, nei pressi del P.<br />
Trafossi, in territorio del Comune di Campiglia Marittima, che affianca il corso<br />
d’acqua, ricadendo all’interno della fascia contermine allo stesso, ed ancora per il<br />
passaggio del cavidotto d’impianto, interrato e collocato a bordo strada;<br />
- Fiume Cornia, per il passaggio del cavidotto in corrispondenza di strada e ponte<br />
esistenti e per un tratto all’interno di un’area agricola, in località Caselli di Cornia, nel<br />
territorio del Comune di Piombino;<br />
- Fosso Cosimo, per l’adeguamento puntuale delle viabilità esistente, in<br />
corrispondenza dell’incrocio tra la strada della Base Geodetica e la strada per La<br />
Sdriscia, in un tratto che fiancheggia il corso d’acqua, nel territorio del Comune di<br />
Piombino;<br />
- Fosso Diavolo, per l’attraversamento del cavidotto in due punti, uno in coincidenza<br />
del passaggio della strada Vecchia Aurelia, nei pressi di P. Prete Cola, e l’altro<br />
all’interno della zona agricola coltivata, ad est rispetto al podere Affitti Manci,<br />
entrambi ricadenti nel territorio del Comune di Campiglia Marittima.<br />
Con riferimento all’intervento che riguarda il Fosso Calda si evidenzia che la fascia<br />
contermine al corso d’acqua è interessata per un’area di ridotte dimensioni, sul margine del<br />
perimetro che delimita la stessa fascia oggetto di tutela paesaggistica, e nella sola fase di<br />
cantiere, per l’allestimento della piazzola. In tale caso risulta coinvolto un campo coltivato a<br />
seminativi e pertanto non si prevedono effetti significativi sugli elementi del paesaggio, anche<br />
con riferimento all’area circostante, sul lato verso il fosso, che presenta analoghe<br />
caratteristiche di utilizzo del suolo. Al termine dei lavori si prevede di ridimensionare la<br />
piazzola con una configurazione che rende fattibile il recupero dello stato dei luoghi nelle<br />
condizioni antecedenti, per la porzione ricadente all’interno della fascia contermine al corso<br />
d’acqua; pertanto, non si configura alcuna modifica, in via definitiva, dei caratteri del<br />
paesaggio rurale che si presentano, per altro, molto semplificati, proprio in relazione<br />
all’intenso utilizzo agricolo.<br />
L’adeguamento della strada esistente che fiancheggia il Fosso Verrocchio, che consiste<br />
nell’allargare la carreggiata in modo da portarla ad una larghezza di 7 m (incluse le cunette<br />
laterali), riguarda un’area a seminativi del tutto simile a quelle che connotano l’intero ambito<br />
della Piana del Cornia e si configura come occupazione di una fascia in continuità con l’asse<br />
viario esistente, mantenendo quindi invariato il disegno del paesaggio rurale. L’intervento,<br />
che per altro ricade nell’area tutelata per pochi metri, considerando le caratteristiche e<br />
l’ubicazione, non determina modifiche strutturali o perdita di elementi significativi del<br />
paesaggio associati alla presenza del corso d’acqua. Analoga considerazione vale per la<br />
VERS: 01 2011 PAGINA: 69: 98
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
posa del cavidotto, che sarà completamente interrata e quindi non tale da modificare i<br />
caratteri del luogo.<br />
Il Fiume Cornia, come già accennato, è interessato solo per il passaggio del cavidotto; la<br />
soluzione adottata, con posa in sotterranea e tracciato che segue la viabilità esistente, salvo<br />
un breve tratto in attraversamento di campi coltivati, consente di escludere, in ogni caso,<br />
modifiche permanenti e quindi non si prevede, all’interno della fascia vincolata, alcuna<br />
variazione dello stato dei luoghi, tale da potere determinare una modifica della struttura e<br />
percezione del paesaggio. In merito al passaggio sopra al corso d’acqua si evidenzia che la<br />
presenza del ponte ( presso caselli di Cornia) consente di adottare una soluzione che non<br />
richiede alcun intervento sull’alveo e sulle sponde arginate e pertanto si esclude ogni<br />
ricaduta, anche per quanto riguarda la vegetazione presente ai lati del fiume canalizzato.<br />
Anche nel caso della fascia contermine al Fosso Cosimo, interessata per un puntuale<br />
intervento di adeguamento della viabilità principale, non si prefigura una modifica strutturale<br />
del paesaggio od una perdita di elementi qualificanti, considerando che si può intervenire<br />
modificando un’area di superficie ridotta ed attualmente occupata da campi a seminativo,<br />
senza coinvolgere la zona di Orti del Bottagone.<br />
Per quanto riguarda il Fosso del Diavolo, nel caso dell’intersezione del cavidotto interrato in<br />
corrispondenza della Vecchia Aurelia, non si prevede alcuna modifica dei caratteri attuali del<br />
corso d’acqua e della relativa fascia contermine, considerato che il tracciato si sviluppa<br />
seguendo l’asse viario e che può passare in sottopasso dell’alveo, come indicato nelle<br />
soluzioni tipo di progetto. Nel caso dell’altra intersezione si evidenzia che il percorso del<br />
cavidotto interrato ricade in aree agricole coltivate a seminativo, seguendo, sul lato sud, la<br />
viabilità minore e quindi senza determinare modifiche permanenti degli usi del suolo, stante<br />
le possibilità di ripristino al termine dei lavori di scavo e reinterro. Per l’attraversamento del<br />
corso d’acqua, in base agli elaborati di progetto, si indica una soluzione con passaggio<br />
esterno, al di sopra dell’asta del fosso; in alternativa, si ritiene che, anche in tale caso, può<br />
essere adottata la già definita soluzione in sottopasso dell’alveo, con trivellazione orizzontale<br />
teleguidata che consente di evitare scavi a cielo aperto in trincea e quindi garantendo il<br />
permanere dei connotati e della percezione attuale del paesaggio, per altro banalizzato<br />
trattandosi di campi a seminativo.<br />
PAGINA: 70: 98 2011 COD: 11V071
RELAZIONE PAESAGGISTICA<br />
4 CARATTERI PAESAGGISTICI DEL CONTESTO E PREVISIONI DEGLI EFFETTI<br />
4.1 Uso del suolo e vegetazione<br />
4.1.1 Premessa<br />
Il territorio in cui si prevede di realizzare l’impianto ha una connotazione marcatamente<br />
agricola: tutta la piana, percorsa da numerosi fossi e canali, è occupata prevalentemente da<br />
aree a seminativo (asciutto o irrigabile), alternate talvolta a piccoli appezzamenti a frutteto,<br />
vigneto od oliveto. Nell’area non sono presenti nuclei insediativi significativi, ma sono<br />
presenti numerose case sparse. All’interno dell’area sono ormai quasi del tutto scomparsi<br />
elementi di pregio naturalistico, ad eccezione delle due aree umide a sud dell’area di<br />
impianto (Padule Otri-Bottagone e Padule i Perelli), uniche aree umide rimaste a seguito<br />
dell’ultimo intervento di bonifica, effettuato all’inizio del 1900, che ha interessato tutta la<br />
bassa Val di Cornia. A sud delle sopra citate zone umide si trovano due importanti realtà<br />
industriali della Provincia di Livorno: la centrale Enel di Torre del Sale e l’area delle industrie<br />
minerarie in prossimità del Porto di Piombino. Nell’area sono presenti diverse aree adibite ad<br />
attività estrattiva, localizzate principalmente in corrispondenza dei rilievi collinari posti a nord<br />
dell’area di impianto (Cave di Monte Romolo e Monte Calvi), a nord dell’abitato di Campiglia<br />
marittima.<br />
Elementi di maggiore naturalità si possono invece trovare in corrispondenza dei rilievi<br />
collinari, dove, accanto ai vigneti e agli oliveti, si è mantenuta anche una vegetazione<br />
naturale di pregio. In particolare sui rilievi collinari della costa si possono riscontrare elementi<br />
della macchia mediterranea, mentre sulle colline più interne sono presenti boschi misti a<br />
dominanza di querce (Quercus suber, Quercus ilex). Gli ambiti collinari sono anche quelli in<br />
cui si possono ritrovare i borghi storici, mentre lungo le coste, dove si è avuto un notevole<br />
sviluppo di attività industriali e commerciali (industria mineraria e insediamento portuale) e<br />
turistiche, si trovano insediamenti urbani più recenti.<br />
4.1.2 Flora e vegetazione nell’area di ubicazione dell’impianto eolico<br />
L’area di studio si localizza a cavallo di due comuni della Provincia di Livorno: Campiglia<br />
Marittima e Piombino, all’interno di una vasta area pianeggiante contraddistinta dalla<br />
presenza di un mosaico agricolo determinato dall’alternanza di aree a seminativo (colture<br />
cerealicole-foraggere, barbabietola e girasole), colture arborate (vite, olivo, frutta) e<br />
orticole 17 . Il sistema, pertanto, non manifesta una significativa eterogeneità ecosistemica<br />
essendo caratterizzato esclusivamente dalla presenza di aree agricole, se si esclude una<br />
piccola superficie a Pino mediterraneo a nord ovest dell’aerogeneratore n. 82, e le Padule<br />
Otri-Bottagone e Padule i Perelli, localizzate rispettivamente a circa 1,5 e 3,4 km a sud<br />
dall’aerogeneratore n. 49.<br />
Nelle sopracitate zone umide sono presenti 6 habitat di interesse comunitario (ai sensi della<br />
Direttiva 92/43/CEE e della L.R. 56/2000 e succ. modifiche e integrazioni), nessuno dei quali<br />
interessato direttamente dagli interventi di realizzazione dell’impianto eolico. Gli habitat sono<br />
i seguenti:<br />
1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi);<br />
1150 Lagune costiere;<br />
1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi);<br />
1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine;<br />
6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-<br />
Holoschoenion;<br />
17 Si rimanda alle Tavole “PS della Val Cornia - Tav. 5.1 - Carta dell'uso agricolo del suolo” e “Uso del suolo 1993 (fonte dati:<br />
SIT Provincia Livorno)” riportate nell’Allegato Cartografico.<br />
VERS: 01 2011 PAGINA: 71: 98
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
1310 Vegetazione pioniera a Salicornia e altre specie annuali delle zone fangose e<br />
sabbiose.<br />
L’area di sviluppo dell’impianto è caratterizzata inoltre dalla presenza di alcuni corsi d’acqua<br />
ed una fitta rete di fossi e canali, lungo le cui sponde, originariamente, era presente una<br />
vegetazione riparia, che attualmente risulta quasi del tutto scomparsa, fatta eccezione per<br />
alcuni canali ed alcuni tratti del Fiume Cornia, lungo i quali però, accanto a specie tipiche di<br />
questi ambienti (carpino bianco, acero campestre, orniello, salice bianco, pioppo nero) si<br />
ritrovano anche alberi e arbusti nitrofili e ad ampia distribuzione, nonché specie esotiche<br />
(robinia e ailanto).<br />
Dalla consultazione della banca dati RENATO non risulta la presenza di specie, habitat o<br />
fitocenosi protette nelle aree direttamente interessate dalle opere previste per la<br />
realizzazione del progetto.<br />
4.1.3 Effetti sulla vegetazione in fase di cantiere e di esercizio<br />
Nel corso della fase di cantiere e messa in opera del progetto i potenziali impatti sulle<br />
componenti vegetazione e flora sono prevalentemente riconducibili alla produzione di polveri<br />
ad opera dei mezzi di cantiere, alla eradicazione della vegetazione originaria ed alla modifica<br />
degli usi del suolo.<br />
Per quanto attiene al primo è innegabile che la realizzazione degli scavi e il passaggio dei<br />
mezzi determineranno un’emissione di polveri che si depositeranno sulle specie vegetali<br />
localizzate nelle aree prossime a quelle interessate dagli interventi. Tenendo conto però che<br />
l’impianto verrà realizzato all’interno di una vasta area ad uso agricolo intensivo, in cui non<br />
sono quindi presenti specie di particolare interesse conservazionistico, l’interferenza<br />
determinata da questo fattore può essere ritenuta del tutto irrilevante.<br />
La realizzazione dell’impianto determinerà, come detto, la perdita di alcune porzioni di aree<br />
agricole, riconducibili, in particolare, alla realizzazione dei seguenti interventi:<br />
- adeguamento delle strade esistenti;<br />
- realizzazione di nuovi tratti di viabilità (non riguarda beni paesaggistici vincolati);<br />
- predisposizione delle piazzole e delle fondazioni degli aerogeneratori (solo nel caso<br />
del n. 82 è parzialmente coinvolto un bene paesaggistico vincolato);<br />
- predisposizione dell’area ed installazione della stazione AT/MT (non riguarda beni<br />
paesaggistici vincolati);<br />
- scavo per la posa del cavidotto interrato di impianto.<br />
Viabilità di accesso all’impianto – adeguamento delle strade esistenti<br />
Per permettere il passaggio dei mezzi necessari alla realizzazione dell’impianto è necessaria<br />
la presenza di una struttura viaria adeguata, costituita da strade con sezione pari a 7 m<br />
(comprese le cunette laterali). Dei 38.170 m di viabilità già esistente che saranno utilizzati<br />
per raggiungere l’impianto, 33.210 m hanno già le caratteristiche adeguate per il passaggio<br />
dei mezzi, mentre i restanti 4.960 m necessiteranno di un allargamento della sezione<br />
stradale dagli attuali 2,5 m ai 7 m previsti dal progetto; la superficie complessivamente<br />
trasformata è pari a 22.320 m 2 ma di questa una quota irrilevante, da associare<br />
all’adeguamento della strada per l’aerogeneratore 47 ed all’intervento puntuale lungo la<br />
strada degli Affitti, riguarda i beni paesaggistici vincolati in quanto appartenenti ai corsi<br />
d’acqua pubblici. Tutti gli interventi di allargamento interesseranno aree a seminativo; in<br />
particolare, per quanto riguarda il tratto di circa 67 m lungo la strada degli Affitti, che si trova<br />
tra un’area a seminativo ed un’area a vegetazione palustre, è ovviamente fattibile prevedere<br />
di effettuare l’allargamento della strada sul lato rivolto verso l’area agricola, in modo da non<br />
interferire con la vegetazione palustre.<br />
Piazzole e fondazioni<br />
Il progetto prevede la realizzazione di 17 piazzole, 15 delle quali con superficie pari a 6.207<br />
m 2 ciascuna, mentre la n. 49 e la n. 50 con superficie pari rispettivamente a 5.745 m 2 e 6.198<br />
PAGINA: 72: 98 2011 COD: 11V071
RELAZIONE PAESAGGISTICA<br />
m 2 . Le fondazioni invece occuperanno una superficie pari a 6.137 m 2 . La superficie totale<br />
necessaria per la realizzazione delle piazzole e delle fondazioni (pari a 111.185 m 2 ) sarà<br />
sottratta ad aree attualmente a seminativo. In merito all’allestimento delle piazzole in fase di<br />
cantiere si è detto che solo nel caso di quella per l’aerogeneratore 82 si ricade, per una<br />
quota irrilevante, all’interno della fascia sottoposta a vincolo paesaggistico della Fossa<br />
Calda; anche in tale caso si tratta di area agricola che potrà essere recuperata a conclusione<br />
dei lavori.<br />
Cavidotto interrato<br />
Il cavidotto di impianto si sviluppa seguendo il tracciato della viabilità esistente o da<br />
realizzare ex novo, fatta eccezione per alcuni brevi tratti che ricadono, comunque, sempre in<br />
aree a seminativo, e pertanto non si prevedono ricadute per la vegetazione, considerazione<br />
che vale anche per il tratto in attraversamento dell’area vincolata associata al Fosso Diavolo.<br />
Lo scavo necessario per la posa del cavidotto avrà una larghezza compresa tra 0,6 e 1 m e<br />
si prevede, al termine dei lavori, il riempimento ed il ripristino del piano di campagna. Nel<br />
caso del passaggio all’interno dei beni paesaggistici ed in particolare per l’intersezione con i<br />
corsi d’acqua, quando non presenti ponti che consentono l’ancoraggio del cavidotto,<br />
possono essere adottate, come previsto dal progetto, soluzioni in sottopasso, tali da non<br />
comportare alcuna ricaduta, nemmeno transitoria.<br />
In fase d’esercizio non intervengono ulteriori fattori di pressione a danno della componente<br />
vegetale o modificativi dell’uso del suolo. Al contrario si determinerà una riduzione<br />
complessiva degli effetti sull’uso del suolo dal momento che parte della superficie della<br />
piazzola verrà ricoperta con terreno, restituendo così la stessa all’antecedente utilizzo<br />
agricolo; in dettaglio, pur precisando che tale aspetto non riguarda, sostanzialmente, i beni<br />
paesaggistici vincolati, si evidenzia che in fase di esercizio le piazzole avranno una<br />
dimensione pari a circa 2.280 m 2 e conseguentemente si passerà dai complessivi 111.185<br />
m 2 a 38.760 m 2 , con un recupero di ben 72.425 m 2 di aree a seminativo.<br />
Anche lo scavo per la realizzazione del collegamento elettrico verrà interamente ricoperto,<br />
utilizzando terreno vegetale, e quindi restituito all’uso agricolo.<br />
In conclusione in fase di cantiere saranno sottratte 214.002 m 2 di aree a seminativo, che si<br />
ridurranno a 121.588 m 2 in fase di esercizio (grazie al recupero di parte della superficie delle<br />
piazzole e dello scavo del cavidotto descritti precedentemente). Tale superficie, pur essendo<br />
quantitativamente significativa, non comporterà modifiche sostanziali nell’uso del suolo del<br />
territorio nell’area vasta in cui tale tipologia d’uso risulta essere abbondantemente diffusa e<br />
nettamente prevalente rispetto ad altre.<br />
4.2 Beni culturali e paesaggistici<br />
4.2.1 Premessa<br />
L’analisi dei beni culturali e paesaggistici è condotta considerando, quale ambito di<br />
riferimento, quello definito dalle Linee Guida per il procedimento di Autorizzazione Unica, di<br />
cui al D.M. 10.9.2010, che, con l’Allegato 4, fornisce elementi per l’analisi dell’impatto sui<br />
beni; in dettaglio si tiene conto dell’indicazione di effettuare una ricognizione dei beni culturali<br />
e paesaggistici, riconosciuti come tali ai sensi del D.lgs 42/2004, distanti in linea d’aria non<br />
meno di 50 volte l’altezza massima degli aerogeneratori. 18<br />
Per l’identificazione dei beni sottoposti a vincolo, ai sensi del D.lgs 42/2004, e degli elementi<br />
identificati come di interesse storico, si è fatto riferimento alle banche dati ed agli elaborati<br />
già citati nel precedente paragrafo relativo ai beni culturali e paesaggistici vincolati ed in<br />
generale all’insieme della documentazione del PTCP della Provincia di Livorno e del Piano<br />
d’Area della Val di Cornia.<br />
18 In tale caso si tratta di una distanza arrotondata a 7,5 km da ogni aerogeneratore.<br />
VERS: 01 2011 PAGINA: 73: 98
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
4.2.2 I beni culturali e paesaggistici presenti nell’area d’indagine<br />
I beni culturali vincolati non sono interessati da nessuno degli interventi previsti per<br />
realizzare l’impianto eolico e non si trovano nelle vicinanze degli stessi; diversi sono invece<br />
quelli inclusi nell’ambito di analisi di cui alle Linee Guida nazionali e con riferimento a<br />
quest’ultima area si presenta il relativo quadro. 19<br />
Nel territorio del Comune di Piombino i beni monumentali ricadono tutti all’interno dell’area di<br />
indagine e si possono distinguere quelli ubicati nell’area urbana della stessa città di<br />
Piombino, quelli situati presso il borgo di Populonia e Baratti e quelli in posizione isolata nel<br />
territorio della Piana del Cornia o lungo la fascia costiera.<br />
Per quanto riguarda la città di Piombino si tratta di numerosi monumenti, parte dei quali non<br />
inclusi nella schede dell’archivio digitale dei beni della Regione Toscana ma segnalati dai<br />
citati strumenti di pianificazione provinciale ed intercomunale, ed in dettaglio si tratta dei<br />
seguenti: Mura e fortificazioni; Cappella di Cittadella; Cittadella con cisterna marmorea; ex<br />
Convento e Ospedale della SS Trinità o di San Giovanni di Dio (D.M 17.2.2004); Chiesa<br />
della Misericordia; Ex Ospedale Civile, già Chiesa e Convento di Sant’Animo (D.M.<br />
14.11.1998); Fonti dei Canali; Porta di Terra; Palazzo di marmo (D.M. 21.12.1988); Casa<br />
falchi (D.M. 21.4.1913); Palazzo Comunale, Casa delle Bifore (D.M. 13.6.1913 e<br />
11.12.1980); ex Chiesa e Convento di Sant’Animo (D.M. 20.10.2010); Convento di<br />
Sant’Agostino (D.M. 25.11.1982); Castello e Fortezza con bastioni; Chiesina della Madonna<br />
del Desco; Cimitero di Piombino; ex rifugio antiaereo (D.M. 2.12.2009 e 20.10.2010).<br />
Per quanto attiene al borgo di Populonia e Baratti, si tratta della Torre medioevale di Baratti<br />
(D.M. 13.6.1913), del Castello di Populonia (D.M. 29.8.1989) e di un edificio pubblico<br />
all’interno dello stesso castello (D.M. 29.8.1989) ed infine del Cimitero di Populonia (D.M.<br />
3.8.1981).<br />
Gli altri monumenti isolati comprendono la Torre e fontana di Vignarca (D.M. 26.3.1979),<br />
ubicata lungo la strada della Base Geodetica, la Torre Mozza (provvedimento non<br />
archiviato), situata sul lato est del litorale del Golfo di Follonica ed ancora il Cimitero di<br />
Riotorto, situato dove la stessa frazione.<br />
Nel territorio del Comune di Campiglia Marittima i beni vincolati sono in prevalenza ubicati<br />
all’interno dello stesso abitato principale ed in tale caso si tratta dei seguenti: Rocca di<br />
Campiglia (D.M. 1.5.1911); Palazzo Pretorio e Palazzo Comunale; Cimiteri di Campiglia,<br />
incluso quello di San Giovanni (D.M.21.7.1981); Torrione Cassero; Teatro dei Concordi<br />
(D.M. 24.1.1969); Porta urbana; Chiesa di Sant’Antonio. Ai citati beni si aggiungono i<br />
seguenti: la Rocca di San Silvestro (D.M. 28.4.1983), situata nella zona collinare vicino al<br />
Monte Rombolo; la Chiesa Madonna della Fucinaia, santuario ubicato nell’omonima località,<br />
poco a nord di Campiglia; il Mausoleo romano, che si trova nella frazione di <strong>Venturina</strong>; la<br />
Villa o Palazzo di Magona (D.M. 12.2.1956), situata su un poggio il località Caldana di Sopra;<br />
il Castello di Casalappi, ubicato nella zona orientale della piana, vicino al Fosso della<br />
Cornacchia; il Poggio al Frassine, situato sul rilievo a nord rispetto all’abitato di Campiglia.<br />
I beni archeologici vincolati, allo stesso modo, non sono interessati da nessuno degli<br />
interventi e non ricadono nell’area circostante ma, in alcuni casi, rientrano nell’area<br />
d’indagine definita dalle Linee Guida nazionali; si tratta, come già richiamato, delle diverse<br />
aree situate nel territorio del Comune di Piombino, di Campiglia Marittima ed anche di<br />
Castagneto Carducci.<br />
Per quanto riguarda il Comune di Piombino, le aree si concentrano nella zona di Populonia e<br />
del Golfo di Baratti, tutte incluse nel perimetro del Parco Archeologico, ed in dettaglio, con<br />
riferimento ai distinti provvedimenti di tutela, si tratta delle seguenti: Poggio Malassarto (D.M.<br />
11.8.1962); mura di cinta etrusche di Populonia (D.M. 4.2.1963); terreno in località Chiuse<br />
19 Si rimanda alla tavola “Beni vincolati”, inserita nell’Allegato Cartografico.<br />
PAGINA: 74: 98 2011 COD: 11V071
RELAZIONE PAESAGGISTICA<br />
del Casone, ad oriente della Necropoli arcaica di Populonia (D.M. 4.3.1963); area di rispetto<br />
dei Poderi Casone, Cerbone e Porcareccia (D.M. 4.3.1953 e 22.4.1963); Poggio di San<br />
Leonardo (D.M. 4.11.1982); tombe etrusche a camera scavate nel tufo, di età ellenistica, in<br />
località Buca delle Fate (D.M. 26.11.1963); tombe etrusche e cave antiche di Panchina,<br />
unitamente alla tomba del Conchino (D.M. 5.11.1962 e 26.11.1963); mura di cinta<br />
dell’Acrocoro di Populonia 8D.M. 14.2.1963); tratti di antica fogna in Populonia (D.M.<br />
22.8.1962); Costone della Fredda e Sepolcreto etrusco (D.M. 22.8.1962); Pozzo detto di<br />
Santa Caterina (D.M. 5.11.1962); ruderi della villa romana di Populonia (D.M. 21.4.1911 e<br />
4.3.1953); Villa romana di Poggio al Mulino (D.M. 8.11.1980); Necropoli di Poggio delle<br />
Granate (D.M. 22.8.1962, 30.4.1981 e 12.1.1982).<br />
Per quanto attiene al Comune di Campiglia Marittima, oltre ai resti del già richiamato<br />
Mausoleo di epoca imperiale romana (D.M. 20.7.1988), si distinguono tre aree in località Val<br />
Fucinaia, riguardanti resti di forni fusori (D.M. 12.7.1980), ed ancora tre delle cinque aree<br />
ubicate nei pressi del Monte Rombolo, relative ai ritrovamenti di un giacimento antropico di<br />
epoca ellenistica e necropoli ellenizzante, ai resti di un abitato del secolo VI-V a.C. e ad una<br />
necropoli e muro di terrazzamento (D.M. 7.6.1995), che riguarda anche il Comune di San<br />
Vincenzo.<br />
Con riferimento alla porzione di territorio del Comune di San Vincenzo inclusa nell’ambito di<br />
analisi, oltre alla già citata necropoli, all’interno di tale area d’indagine ricadono i resti di un<br />
abitato estrusco, unitamente ad un insediamento di epoca ellenistica (D.M. 7.6.1995),<br />
localizzato sempre nei pressi del Monte Rombolo, poco ad ovest rispetto a tale cima.<br />
I beni paesaggistici vincolati con apposito provvedimento, non sono interessati da nessuno<br />
degli interventi in progetto e nemmeno si trovano nelle aree circostanti agli stessi; nell’ambito<br />
territoriale da prendere in considerazione per la verifica della presenza di tali beni, secondo<br />
quanto indicato nelle Linee Guida nazionali, si distinguono tre aree, di seguito richiamate,<br />
sottoposte a tutela per il loro interesse paesaggistico.<br />
La “fascia costiera compresa tra il Golfo di Baratti e il Golfo di Salivoli”, ricadente nel territorio<br />
del Comune di Piombino è vincolata, con D.M. 22.9.1957 in quanto, come riportato nello<br />
stesso provvedimento ministeriale, tale zona “costituisce, con la pineta a nord e a levante del<br />
golfo di Baratti, con il promontorio di Populonia, ricco di foltissima vegetazione, dominante il<br />
golfo, con la zona archeologica e con il centro urbano di Populonia con il suo castello<br />
medioevale, un quadro naturale di non comune bellezza panoramica e di notevole valore<br />
estetico e tradizionale”.<br />
La “zona sita nel territorio del Comune di Piombino tra la località Torre del Sale ed il confine<br />
con il Comune di Follonica”, vincolata con D.M. 20.9.1962, riguardava, in origine, anche una<br />
porzione di territorio ora ricadente nel Comune di Follonica, quale conseguenza della<br />
successiva ridefinizione dei confini comunali. Le motivazioni dell’imposizione della tutela<br />
paesaggistica, come riportato nel provvedimento ministeriale, sono ricondotte al fatto che<br />
tale zona ha notevole interesse pubblico “perché con le sue pendici dai rilievi collinari di varia<br />
altezza e le sue piccole rade e le spiagge, dovute alle linee di impluvio dei rilievi stessi,<br />
presenta una superficie in declivio completamente ricoperta da vegetazione cedua e di alto<br />
fusto senza soluzione di continuità e di particolare bellezza per la varietà dei toni di verde (..)<br />
costituendo pertanto un quadro naturale ed un panoramico punto di vista accessibile al<br />
pubblico”.<br />
La “fascia costiera sita nel Comune di San Vincenzo”, è vincolata con D.M. 18.12.1953 a cui<br />
ha fatto seguito un provvedimento di svincolo (D.M. 25.1.1967) per una parte del territorio<br />
oggetto di tutela. Le ragioni alla base della dichiarazione del notevole interesse pubblico,<br />
come riportato nel provvedimento ministeriale, risiedono nel fatto che la zona “offre dei<br />
caratteristici e singolari spetti di non comune bellezza naturale godibili da numerosi punti di<br />
vista accessibili al pubblico”.<br />
VERS: 01 2011 PAGINA: 75: 98
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
Sempre con riferimento al vincolo paesaggistico, considerando i beni paesaggistici tutelati<br />
per legge in quanto categorie del paesaggio, si rammenta che gli unici presenti nell’area di<br />
ubicazione dell’impianto eolico sono i corsi d’acqua pubblici, con l’associata fascia laterale<br />
alle sponde; alcuni di tali corsi d’acqua, puntualmente elencati nei precedente paragrafo<br />
relativo ai beni vincolati, sono interessati dagli interventi per la messa in opera del cavidotto,<br />
dalla’deguamento della viabilità esistente (in soli due casi) ed ancora, per altro in misura<br />
marginale, dall’allestimento della piazzola, funzionale allo svolgimento delle attività in fase di<br />
cantiere, dell’aerogeneratore 82.<br />
Ai fini della verifica dei possibili effetti, si considerano anche i beni del territorio aperto, come<br />
individuati nelle Tavola 9.1 del PS della Val di Cornia, ovvero la categoria dei nuclei storici e<br />
degli edifici o manufatti di interesse architettonico, tenendo conto, in entrambi i casi, della<br />
distinzione tra quelli anteriori al 1830 e quelli di epoca successiva. 20<br />
In base al confronto effettuato si evidenzia che nell’area circostante alle opere di progetto<br />
non ricadono nuclei storici e nemmeno edifici d’interesse storico di epoca anteriore al 1830<br />
(Catasto Leopoldino) 21 ed allo stesso modo, fatta eccezione per il solo passaggio del<br />
cavidotto nei pressi di Caselli di Cornia, tutte le opere ricadenti all’interno dei beni<br />
paesaggistici vincolati si trovano distanti dagli edifici, manufatti e nuclei di interesse storico<br />
individuati nella citata tavola.<br />
In maggiore dettaglio, considerando solo gli interventi che riguardano i beni paesaggistici<br />
vincolati, si evidenzia che:<br />
- l’area di cantiere da allestire, in via transitoria, per installare l’aerogeneratore 82 si<br />
trova ad una distanza di circa 600 m dal più vicino edificio rurale della Fattoria<br />
Torretta ed a circa 400 m dal P. Molinaccio, edificio rurale distinto nella tavola C1 del<br />
RU di Campiglia Marittima;<br />
- la fascia di territorio interessata dall’adeguamento della strada esistente utilizzata per<br />
accedere all’aerogeneratore 47 e dalla posa interrata del cavidotto d’impianto, dista<br />
circa 850 m dal più vicino edificio rurale di Magona ed in ogni caso non è coinvolta la<br />
zona di pertinenza del P. Trafossi, edificio rurale distinto nella tavola C1 del RU di<br />
Campiglia Marittima;<br />
- le aree interessate dalla posa del cavidotto d’impianto, nei due tratti che attraversano<br />
il Fosso Diavolo, si trovano rispettivamente ad una distanza di circa 350 m e di circa<br />
700 m dal più vicino edificio rurale di C. Terra di Napoli e Villa Ranacchiaia ed al<br />
contempo non sono coinvolte le zone di pertinenza del P. Prete Cola e C. Affitti,<br />
edificio rurali distinti nella tavola C1 del RU di Campiglia Marittima;<br />
- la fascia laterale alla strada degli Affitti interessata dall’intervento di adeguamento di<br />
tale asse viario si trova ad una distanza di circa 1,3 km dal più vicina C. Vignarca;<br />
- la fascia laterale alla SS 398, interessata dalla posa del cavidotto interrato che per un<br />
tratto ricade nalla fascia contermine al F. Cornia, è distanziata e non riguarda l’area di<br />
pertinenza del fabbricato rurale identificato in località Campo all’Olmo<br />
- la posa del cavidotto d’impianto in attraversamento del F. Cornia, in appoggio al<br />
ponte esistente e con tracciato che si sviluppa lateralmente alla viabilità esistente,<br />
non coinvolge direttamente la zona di pertinenza dei fabbricati di Caselli di Cornia,<br />
passando di lato ed in ogni caso con soluzione interrata non modificativa dei caratteri<br />
attuali del luogo.<br />
Per quanto attiene ai beni paesaggistici d’interesse, segnalati in quanto tali dai citati<br />
strumenti di pianificazione territoriale, si evidenzia, quale elemento strutturale del paesaggio<br />
della bonifica, il sistema dei fossi di regimazione della acque superficiali ovvero il reticolo<br />
delle scoline irrigue, che riguarda l’intera area della Piana del Cornia.<br />
20 Si rimanda alla citata Tav. 9.1 del PS, inserita nell’Allegato Cartografico.<br />
21 Si precisa che i più vicini, corrispondenti alla C. Amatello (con riferimento all’aerogeneratore n. 58), alla C. Affitti (con<br />
riferimento all’aerogeneratore n. 50) ed al complesso rurale di La Sdriscia (in relazione all’aerogeneratore n. 49), si trovano ad<br />
una distanza che varia tra 400 e 550 m circa dagli aerogeneratori di progetto.<br />
PAGINA: 76: 98 2011 COD: 11V071
RELAZIONE PAESAGGISTICA<br />
4.2.3 Effetti sui beni culturali e paesaggistici in fase di cantiere<br />
L’impianto, considerando sia gli aerogeneratori che tutte le opere connesse, come già<br />
evidenziato, non ricade in beni culturali vincolati a seguito di specifico provvedimento e<br />
nemmeno in beni archeologici e si trova ad una distanza tale, da questi, che si possono<br />
ragionevolmente escludere ricadute, associate all’esecuzione delle opere previste per<br />
l’installazione dei diversi manufatti, sui caratteri degli stessi monumenti e dell’area<br />
immediatamente circostante.<br />
Per quanto riguarda gli edifici di interesse storico si sottolinea che le opere in progetto, nel<br />
loro insieme, non determinano alcuna ricaduta diretta su tali beni e sulle loro aree di<br />
pertinenza. In maggiore dettaglio, considerando quelle ricadenti nelle fasce contermini ai<br />
corsi d’acqua a vincolo paesaggistico, si possono escludere effetti diretti ed anche indiretti, in<br />
considerazione della distanza da tali edifici e/o delle modalità realizzative degli interventi, in<br />
particolare per quanto riguarda la posa del cavidotto d’impianto, interrato od in appoggio a<br />
strutture esistenti nel caso del passaggio sopra ai corsi d’acqua.<br />
L’impianto, come sottolineato nei paragrafi precedenti, non ricade all’interno di beni<br />
paesaggistici vincolati a seguito della dichiarazione del loro pubblico interesse e pertanto si<br />
può ragionevolmente affermare che non si determinerà alcuna ricaduta diretta sui distinti<br />
elementi che connotano il paesaggio e che sono all’origine della tutela, in linea generale<br />
riconducibili ad aspetti legati alla morfologia collinare, alla vegetazione di alto fusto, alle<br />
spiagge, alle zone archeologiche e nel caso della fascia costiera di Baratti, anche alla<br />
presenza delle zone archeologiche e del nucleo storico di Populonia.<br />
Per quanto attiene ai beni paesaggistici vincolati in quanto categorie del paesaggio, una<br />
parte degli interventi ricadono all’interno di area sottoposte a tutela in quanto contermini ai<br />
corsi d’acqua pubblici, entro la fascia dei 150 m dalla sponda od argine. Si tratta degli<br />
interventi già richiamati nel precedente paragrafo inerente ai beni vincolati, a cui si rimanda<br />
per le precisazioni. Si rammenta che, nel caso dell’allestimento della piazzola<br />
dell’aerogeneratore 82 e della posa del cavidotto interrato, in particolare nel tratto in<br />
attraversamento del Fosso Diavolo e del Fiume Cornia, stante il successivo ripristino del<br />
suolo agricolo, non si prevedono modifiche permanenti e quindi si escludono ricadute, sotto il<br />
profilo paesaggistico.<br />
In ultimo, per quanto riguarda la presenza delle scoline irrigue ed il relativo disegno, si<br />
escludono ricadute con riferimento agli interventi ricadenti nei beni paesaggistici vincolati,<br />
considerato il previsto recupero dell’area di cantiere dell’aerogeneratore 82, la soluzione<br />
interrata (o in appogio ai ponti) relativa al passaggio del cavidotto d’impianto ed in ultimo<br />
l’ampliamento della viabilità esistente, laterale alla sezione stradale attuale e quindi tale da<br />
non alterare tale maglia.<br />
4.2.4 Effetti sui beni culturali e paesaggistici in fase di esercizio<br />
In fase di esercizio si conferma che non risultano direttamente interessati, dalla presenza dei<br />
manufatti dell’impianto eolico, beni culturali e paesaggistici vincolati con specifico<br />
provvedimento di dichiarazione del loro pubblico interesse.<br />
Per quanto riguarda i beni paesaggistici riferiti alle categoria dei corsi d’acqua e fasce<br />
contermini, le modifiche che li riguardano restano quelle già descritte, con riferimento al solo<br />
adeguamento della viabilità esistente; nel caso del cavidotto si prevede, infatti, il ripristino<br />
delle condizioni antecedenti e quindi non si configura nessuna modifica degli attuali caratteri<br />
del paesaggio. Si precisa che la soluzione di sovrappasso prevista nel caso del Fosso<br />
Diavolo può essere modificata adottando, come per altro già contemplata dal progetto, la<br />
tecnica in sottopasso dell’alveo con perforazione orizzontale e quindi con sviluppo<br />
completamento interrato del cavidotto. Nel caso della piazzola dell’aerogeneratore n. 82,<br />
come già precisato, la riduzione della stessa, al termine della fase di cantiere, unitamente<br />
alla copertura con terra del plinto di fondazione dell’aerogeneratore, consente di<br />
VERS: 01 2011 PAGINA: 77: 98
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
disimpegnare la pur ridotta area ricadente nella fascia contermine al Fosso Calda e quindi di<br />
provvedere al ripristino delle condizioni antecedenti che, per altro, sono da ricondurre<br />
all’utilizzo agricolo del suolo con conduzione a seminativo.<br />
4.3 Paesaggio<br />
4.3.1 Premessa<br />
L’analisi del paesaggio è condotta al fine di riconoscere gli elementi, di tipo naturale ed<br />
antropico, che lo caratterizzano, considerando sia le persistenze, con riferimento ai “segni”<br />
che restano invariati dall’epoca storica, sia le trasformazioni, che determinano la<br />
configurazione attuale e le eventuali nuove identità di paesaggio.<br />
Tale analisi si basa:<br />
- sulla ricostruzione del quadro relativo al riconoscimento degli Ambiti di Paesaggio, da<br />
parte del PIT della Regione Toscana e del PTC della Provincia di Livorno, ed anche<br />
tenendo conto degli elementi descrittivi e conoscitivi relativi agli elementi e<br />
trasformazioni del paesaggio contenuti negli elaborati del Piano Strutturale d’Area<br />
della Val di Cornia, riguardante il territorio dei Comuni di Campiglia Marittima,<br />
Piombino e Suvereto;<br />
- sulla lettura della cartografia di base e tematica, con riferimento, ove possibile, a<br />
diverse soglie storiche, ed alla considerazione di tre aspetti ritenuti fondamentali per<br />
la formazione del paesaggio, ovvero la morfologia e idrografia, la vegetazione e l’uso<br />
agricolo del suolo, il sistema insediativo e delle infrastrutture viarie, con associata<br />
descrizione dei caratteri principali di connotazione del paesaggio e indicazione delle<br />
persistenze o viceversa delle trasformazioni avvenute nel periodo recente od attuale;<br />
- sulla sintesi delle informazioni derivanti dall’analisi di cui ai due punti precedenti, a cui<br />
si aggiungono gli elementi conoscitivi acquisiti a seguito di sopralluogo, con<br />
l’identificazione, per il contesto direttamente interessato dagli interventi e manufatti di<br />
progetto e per l’immediato intorno, degli elementi costitutivi od identificativi del<br />
paesaggio, quelli qualificanti ma anche gli eventuali “detrattori”.<br />
L’identificazione degli elementi di caratterizzazione del paesaggio, di cui alla terza fase<br />
dell’analisi, consente di verificare la relazione che si determinerà con i manufatti in progetto e<br />
quindi di valutare le eventuali ricadute.<br />
Gli ambiti territoriali di analisi sono definiti considerando sia le Linee Guida redatte dal<br />
MiBAC per gli impianti eolici, che forniscono suggerimenti in relazione alle modalità di studio<br />
del paesaggio, sia le Linee Guida per la VIA degli impianti eolici della Regione Toscana, che<br />
stabiliscono criteri per la valutazione dell’impatto sul paesaggio e sul patrimonio storico,<br />
architettonico e archeologico, sia, infine, le Linee Guida per il procedimento di Autorizzazione<br />
Unica, di cui al D.M. 10.9.2010, che con l’Allegato 4 forniscono elementi per l’analisi<br />
dell’impatto visivo e dell’impatto sui beni culturali e sul paesaggio.<br />
4.3.2 Gli Ambiti di Paesaggio identificati dal PIT<br />
Il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Regione Toscana, redatto ai sensi della L.R.<br />
1/2005 ed approvato con D.C.R. n. 72 del 24.7.2007, successivamente integrato, con<br />
l’adozione degli elaborati relativi all’implementazione della disciplina paesaggistica, di cui alla<br />
D.C.R. 16.6.2009, n. 32, definisce una suddivisione dell’intero territorio regionale in Ambiti di<br />
Paesaggio.<br />
La Parte Terza del “Quadro conoscitivo e quadri analitici di riferimento”, denominata “I<br />
Territori e i Paesaggi della Toscana” contiene un documento che descrive la metodologia<br />
seguita per individuare i territori della Toscana, per i quali sono poi stati definiti i caratteri del<br />
paesaggio, col fine di delineare una suddivisione della Regione in aree minori capaci di<br />
rappresentare la ricchezza e la diversità dei paesaggi che ne costituiscono fattore di<br />
eccellenza. In base alle premesse metodologiche delineate, i lavori di redazione del PIT<br />
PAGINA: 78: 98 2011 COD: 11V071
RELAZIONE PAESAGGISTICA<br />
hanno portato alla formazione di un “Atlante dei paesaggi toscani”, documento che si<br />
compone di 38 schede relative ad altrettanti macroambiti di ordine storico-geografico con<br />
valenza strumentale di riferimento territoriale per l’elaborazione degli studi e delle descrizioni.<br />
Nel Quadro si sottolinea che l’elaborazione dell’Atlante ha consentito di definire schede dei<br />
paesaggi, in cui si riportano indicazioni geografiche relative ai sistemi territoriali regionali ed<br />
agli ambiti provinciali e comunali interessati.<br />
Per individuare le identità paesaggistiche locali o comunque sub-regionali sono stati distinti<br />
due ordini di caratteri:<br />
- quelli strutturali identificativi del paesaggio, che comprendono le “configurazioni alle quali<br />
è riferibile la riconoscibilità dei territori di un ambito o di alcuni ambiti della regione”;<br />
- quelli strutturali ordinari del paesaggio, che comprendono, generalmente, le<br />
“configurazioni diffuse nel territorio regionale, non subordinate alle precedenti dal punto<br />
di vista del rilievo strutturale, ma distinte per la loro minore rilevanza quali fattori<br />
dell’identità locale e talvolta configurazioni tipiche dell’ambito trattato, ma come rilevanza<br />
identificativa subordinata”.<br />
La caratterizzazione strutturale del paesaggio è stata condotta attraverso un inquadramento<br />
interpretativo, riferito alla bibliografia specifica ed ai documenti elaborati come quadri<br />
conoscitivi dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali, e ricorrendo all’elaborazione dei<br />
dati di Corine Land Cover, accorpando le categorie di uso del suolo in modo da ottenere solo<br />
quattro tipi principali di sistemi paesistici, ovvero quelli delle formazioni forestali, delle colture<br />
agrarie miste, delle colture agrarie specializzate, degli insediamenti.<br />
La ricognizione dei caratteri paesaggistici strutturali del paesaggio è stata condotta anche<br />
mediante una campagna di sopralluoghi e di rilevamenti fotografici e gli elementi acquisiti<br />
sono stati classificati, in relazione alla descrizione dei caratteri strutturali identificati, nei<br />
seguenti: geomorfologia; idrografia naturale; idrografia antropica; mosaico forestale: mosaico<br />
agrario; insediamento storico; insediamento moderno e contemporaneo; reti e impianti viari e<br />
tecnologici; alterazioni paesistiche puntuali profonde; alterazioni paesistiche ridotte;<br />
emergenze paesistiche.<br />
Le Schede dell’Atlante, nella versione approvata del PIT, sono articolate in tre sezioni. La<br />
prima ha funzione di inquadramento territoriale degli ambiti e di descrizione sintetica delle<br />
caratteristiche di base e dei processi evolutivi del paesaggio. L’illustrazione qualitativa dei<br />
caratteri di distribuzione spaziale e di incidenza proporzionale relativa delle quattro citate<br />
categorie (tipi principali di sistemi di formazioni paesistiche) è rappresentata sinteticamente,<br />
basandosi sui dati del Corine Land Cover, attraverso finestre dove si individua la loro<br />
distribuzione spaziale nel territorio, intesa come indicatore paesaggistico macrostrutturale. In<br />
tale sezione è riportata anche una foto panoramica, utilizzata per evidenziare le relazioni<br />
significative che connotano il paesaggio, ed un profilo ideogrammatico, mediante il quale si<br />
rappresentano le caratteristiche di articolazione fisionomica del paesaggio, a livello di<br />
morfologia di base e di tessitura del mosaico paesistico. In un testo sono sintetizzati i<br />
caratteri strutturali ed i processi evolutivi del paesaggio, con riferimento al quadro<br />
complessivo derivante dalle sezioni successive e dalle rappresentazioni grafiche e<br />
fotografiche. Nella seconda e terza sezione, sono descritti i caratteri strutturali e processi<br />
evolutivi, secondo la distinzione tra i caratteri identificativi ed i caratteri ordinari.<br />
Il Comune di Piombino ed il Comune di Campiglia Marittima ricadono, assieme ai Comuni di<br />
Follonica, San Vincenzo, Sassetta, Scarlino e Suvereto, nell’Ambito di Paesaggio n. 23,<br />
denominato “Val di Cornia”; si osserva che nella versione successiva della Scheda, il<br />
Comune di Scarlino non rientra più tra quelli di tale Ambito. Le informazioni relative<br />
all’Ambito di Paesaggio, contenute nelle prima sezione della scheda dell’Atlante, con<br />
riferimento alla prima versione approvata, sono riportate, in forma sintetica e per stralci, nella<br />
successivo riquadro; si evidenzia che i punti relativi al profilo ideogrammatico restano<br />
invariati anche nella Scheda della seconda versione.<br />
VERS: 01 2011 PAGINA: 79: 98
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
Scheda dell’Atlante dei paesaggi toscani – Ambito 23 “Val di Cornia”<br />
Macchia mediterranea<br />
Borghi storici<br />
Insediamento urbano<br />
Pianura bonificata coltivata a seminativo<br />
Espansioni insediative<br />
Versanti collinari con oliveti, vigneti e borghi storici di<br />
mezzacosta<br />
Profilo ideogrammatico – Caratteristiche fisionomiche<br />
Cave e miniere<br />
Boschi misti di lecci e querce da sughero<br />
Seminativi semplici<br />
Frutteti<br />
Boschi misti a prevalenza di querce anche da sughero<br />
Relazioni significative che connotano il paesaggio<br />
- Rilievi collinari, a cui corrisponde la prevalenza dei boschi, in formazioni sostanzialmente continue, ai margini inferiori dei quali<br />
dominano le colture agrarie miste.<br />
- La pianura coltivata, diffusamente interessata dalle colture a seminativo specializzato, ma connotata dagli insediamenti urbani<br />
costieri di Piombino e Follonica e relative configurazioni produttive industriali.<br />
- Le formazioni forestali più rappresentate, formate da leccete, boschi di sclerofile sempreverdi, anche misti con latifoglie<br />
decidue e boschi a dominanza di latifoglie decidue termofile.<br />
- I rilievi di Campiglia Marittima, segnati dall’intensa attività estrattiva.<br />
- Il Fiume Cornia, che conserva significativi caratteri di naturalità nel corso più alto, mentre nella piana il tracciato è deviato e<br />
rettificato, con una fitta rete di canali di bonifica.<br />
- Paesaggio articolato, con valenze storico culturali e naturalistiche di rilievo, con parchi archeologici minerari, parchi costieri,<br />
riserve forestali ed oasi naturalistiche.<br />
- Il paesaggio agrario che presenta colture erborate e specializzate ad oliveto, con terrazzamenti ed ampi appezzamenti a<br />
vigneto, anche di nuovo impianto.<br />
- In pianura, presenza di antichi frutteti e colture orticole.<br />
- I nuclei storici sono ben conservati (quello di Piombino legato alle attività industriali siderurgiche ed al porto mercantile), anche<br />
se in pianura si registra la diffusione edilizia.<br />
- Nei centri minori si mantiene un equilibrato rapporto col territorio.<br />
Nelle aree interne ed in quelle costiere dei parchi si manifestano forme consapevoli di salvaguardia e conservazione del<br />
patrimonio naturalistico e di quello storico.<br />
Gli impianti industriali, legati alla tradizione storico mineraria, determinano forti impatti ambientali e visuali.<br />
- Il potenziamento delle strutture turistiche, localizzate in aree sensibili limitrofe alle pinete litoranee, sta innescando forme di<br />
disturbo ed alterazione del paesaggio costiero.<br />
Le categorie utilizzate per classificare i caratteri del paesaggio sono state ulteriormente<br />
definite ed aggregate ottenendo una struttura definitiva, utilizzata per articolare le “Schede<br />
dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità”, predisposte già in sede di<br />
approvazione del PIT ed oggetto di modifica nella successiva versione dello stesso Piano.<br />
Gli aspetti considerati nelle citate Schede sono i seguenti:<br />
- elementi costitutivi naturali - che contengono la descrizione dei principali aspetti connessi<br />
alla geomorfologia, idrografia naturale, vegetazione;<br />
- assetti agricoli e forestali – che contengono la descrizione dei principali aspetti connessi<br />
all’idrografia artificiale, paesaggio agrario e forestale storico e moderno;<br />
- insediamenti e infrastrutture – che contengono la descrizione dei principali aspetti<br />
connessi agli insediamenti storici, moderni, contemporanei ed alla viabilità ed<br />
infrastrutture storiche, moderne e contemporanee.<br />
Le Schede, riferite ad ogni Ambito di Paesaggio, sono inoltre articolate in diverse sezioni:<br />
descrizione dei caratteri strutturali del paesaggio; riconoscimento dei valori; interpretazione e<br />
definizione degli obiettivi di qualità; riconoscimento dei paesaggi di eccellenza.<br />
Con l’integrazione paesaggistica del PIT, per ognuno degli Ambiti di paesaggio, sono state<br />
rielaborate le relative Schede che sono adottate, per le Sezioni 1 e 2, relative al<br />
“riconoscimento dei caratteri strutturali” ed al “riconoscimento dei valori”, quali elaborati del<br />
Quadro Conoscitivo. La struttura ed il contenuto delle nuove Schede, nella sostanza, non<br />
varia, in forma significativa, rispetto a quelle precedenti; nei successivi riquadri si richiama, in<br />
forma sintetica, il contenuto dei citati elaborati.<br />
PAGINA: 80: 98 2011 COD: 11V071
RELAZIONE PAESAGGISTICA<br />
Scheda dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità – Ambito 23 “Val di Cornia”<br />
Sezione 1 – Riconoscimento dei caratteri strutturali<br />
Elementi<br />
costitutivi naturali<br />
Caratteri strutturali identificativi Caratteri strutturali ordinari<br />
Geomorfologia - Promontorio del Golfo di Baratti.<br />
- Colline metallifere a nord, rilievi collinari ad est.<br />
- Industria mineraria che ha storicamente<br />
Idrografia naturale<br />
caratterizzato e profondamente segnato le colline<br />
metallifere della Val di Cornia.<br />
(non identificati) - Fiume Cornia, con caratteri di naturalità nel corso<br />
più alto e tracciato deviato e rettificato nella piana,<br />
con fitta rete di canali di bonifica.<br />
Vegetazione - Litorale di Follonica con lunghi tratti di pineta poco - Dune colonizzate dalla vegetazione spontanea nel<br />
profonda.<br />
litorale a nord di Piombino.<br />
- Vegetazione di particolare pregio nel Parco - Formazioni di vegetazione naturale, con specie<br />
interprovinciale di Montioni.<br />
tipiche mediterranee sulle pendici dell’entroterra<br />
follonichese.<br />
Assetti agricoli e<br />
forestali<br />
Caratteri strutturali identificativi Caratteri strutturali ordinari<br />
Idrografia artificiale - Paesaggio agrario prossimo alla costa, solcato dai<br />
canali di bonifica e costellato dai poderi d’epoca e<br />
recenti.<br />
(non riportati)<br />
Paesaggio agrario - Paesaggio agrario di collina, con colture arborate - Boschi prevalenti sui rilievi, in formazioni<br />
e forestale storico e specializzate ad oliveto, con terrazzamenti ed sostanzialmente continue, sui cui margini inferiori<br />
e moderno ampi appezzamenti di vigneto.<br />
dominano le colture agrarie miste.<br />
- Pianura con presenza anche di frutteti e colture - Formazioni forestali più rappresentate, costituite<br />
orticole.<br />
da leccete, sclerofile sempreverdi, anche miste con<br />
- Colture ad olivo caratterizzano i versanti collinari latifoglie decidue e dominanza di latifoglie decidue<br />
lasciando il posto, alle quote più alte, ai boschi di termofile.<br />
sughere e lecci.<br />
- Pianura coltivata interessata dalle colture a<br />
seminativo specializzato, decisamente connotata<br />
dagli insediamenti urbani costieri di Piombino e<br />
Follonica<br />
industriali.<br />
e relative configurazioni produttive<br />
Insediamenti e<br />
infrastrutture<br />
Caratteri strutturali identificativi Caratteri strutturali ordinari<br />
Insediamenti storici - Centro storico di Follonica, caratterizzato - Nuclei storici, nei centri abitati, ben conservati,<br />
dall’insediamento produttivo dell’ex ILVA, con edifici anche se in pianura si registra la diffusione edilizia.<br />
industriali, la chiesa di San Leopoldo e caratteristici - Centri minori mantengono un equilibrato rapporto<br />
arredi urbani in ghisa.<br />
- Rete degli insediamenti produttivi etrusco romani<br />
intorno alla baia di Portiglione ed all’area umida.<br />
col territorio.<br />
Insediamenti - Piombino, nucleo storico assai caratterizzato, Campeggi litoranei in villaggi turistici con utilizzo di<br />
moderni<br />
strettamente legato alle attività industriali unità abitative di tipo seriale di scarsa qualità,<br />
e contemporanei siderurgiche ed al porto mercantile.<br />
elemento di profonda trasformazione dei caratteri<br />
paesaggistici.<br />
Viabilità e<br />
infrastrutture<br />
storiche<br />
- Tracciato della Vecchia Aurelia.<br />
Viabilità e<br />
- Impianti della centrale termoelettrica, che - S.G.C. Aurelia, nel nuovo tracciato.<br />
infrastrutture costituiscono elemento paesaggistico del tratto di<br />
moderne<br />
costa limitrofo alla foce del F. Cornia e promontorio<br />
e contemporanee di Piombino.<br />
Per quanto riguarda i caratteri strutturali identificativi si evidenzia che quelli associabili al sito<br />
di ubicazione dell’impianto ed all’area contermine sono riconducibili al paesaggio agrario<br />
prossimo alla costa solcato dai canali della bonifica, legato alla “idrografia artificiale” degli<br />
“assetti agricoli” ed ancora al tracciato della Vecchia Aurelia, correlato alla “viabilità storica”<br />
degli “insediamenti ed infrastrutture”.<br />
Per quanto attiene ai caratteri strutturali ordinari si nota una relazione con il fiume Cornia,<br />
componente associata alla voce “idrografia naturale” degli “elementi costitutivi naturali”, ed<br />
ancora alla pianura coltivata, citata con riferimento alla voce “paesaggio agrario” inclusa<br />
negli “assetti agricoli” ed infine alla variante dell’Aurelia, citata con riferimento alla voce<br />
“viabilità moderna” degli “insediamenti e infrastrutture”.<br />
VERS: 01 2011 PAGINA: 81: 98
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
Scheda dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità – Ambito 23 “Val di Cornia”<br />
Sezione 2 – Riconoscimento dei valori – Elementi costitutivi naturali<br />
Valori naturalistici<br />
- Macchia alta e bassa, e gariga, di grande interesse naturalistico e percettivo, che connotano decisamente lo scenario<br />
paesaggistico.<br />
- Aree boscate di notevole pregio naturalistico; quella di Montioni si estende tra la Valle del Cornia e del Pecora, nel<br />
sistema collinare tra Massa Marittima e Suvereto, su colline di media altitudine coperte da boschi soprattutto di leccio e<br />
costituisce un paesaggio strettamente legato all’azione dell’uomo, in particolare alla produzione del carbone e al taglio del<br />
bosco.<br />
- SIC Le Bandite di Follonica (SIR B21) e Montecalvi di Campiglia (SIR 54).<br />
- Fascia costiera contraddistinta da elementi naturali di valore estetico percettivo.<br />
- Spiagge e coste alte si alternano in corrispondenza del promontorio di Piombino e del Golfo di Baratti.<br />
- Costa est del promontorio, dalla centrale ENEL a Follonica, interessata dalla presenza del sistema dunale colonizzato<br />
dalla vegetazione spontanea, che ha carattere di particolare naturalità.<br />
- Fascia costiera nel Comune di San Vincenzo costituisce un paesaggio di particolare valore naturalistico ed estetico.<br />
- Promontorio del golfo di Baratti costituisce la visuale meridionale del litorale sabbioso di San Vincenzo, la cui bellezza è<br />
tutelata dal Parco Naturale di Ripigliano (la visuale verso il promontorio ha particolare valore estetico percettivo).<br />
- Elementi di spicco del tratto di fascia costiera: promontorio di Baratti: pinete a nord e ad est del golfo di Baratti;<br />
vegetazione della fascia costiera, ad est del promontorio di Piombino.<br />
- Strada panoramica tra Piombino e il golfo di Salivoli.<br />
- Porzioni residuali della pineta lungo il litorale di Follonica, dal confino di Scarlino a quello di Piombino, presentano un<br />
notevole valore naturalistico.<br />
- Promontorio costiero di Piombino e Monte Massoncello (SIR 55) e del Golfo di Baratti, costituenti complesso mosaico di<br />
spiagge, coste alte, aree boscate.<br />
- Ambiti fluviali che rappresentano un habitat di rilevante valore ambientale per la presenza di biodiversità e quindi per la<br />
loro funzione ecologica.<br />
- Zone umide di valore naturalistico: Padule di Orti Bottegone, area umida salmastra, che è SIR 56.<br />
Valori storico culturali<br />
- Fascia costiera tra il golfo di Baratti ed il golfo di Salivoli, con la pineta a nord e a levante del golfo, il promontorio di<br />
Populonia ricco di foltissima vegetazione, dominante il golfo, la zona archeologica ed il centro urbano di Populonia, il<br />
castello medioevale, che costituiscono un paesaggio di particolare valore storico culturale ed estetico.<br />
Valori estetico percettivi<br />
(i valori estetico percettivi sono identici ai valori naturalistici)<br />
Con riferimento ai valori degli elementi costitutivi naturali si osserva che nessuno di quelli<br />
individuati nella scheda, richiamati nel precedente riquadro, è strettamente riferibile ai siti di<br />
ubicazione degli aerogeneratori e gli elementi del paesaggio che li esprimono non ricadono<br />
nella fascia immediatamente attorno agli stessi aerogeneratori.<br />
Scheda dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità – Ambito 23 “Val di Cornia”<br />
Sezione 2 – Riconoscimento dei valori – Elementi costitutivi antropici<br />
Valori naturalistici<br />
(nessuno identificato)<br />
Valori storico culturali<br />
- Nella pianura è rilevante la presenza del sistema della bonifica, comprendente manufatti ed opere idrauliche.<br />
- Elementi di valore: il sistema degli appoderamenti (Ente Maremma); il sistema dei percorsi d’acqua creati per la<br />
regimazione delle acque nel contesto delle bonifiche, interessante tutta la pianura della Val di Cornia.<br />
- Paesaggio agricolo di collina è caratterizzato dalla rilevanza della coltivazione dell’olivo accompagnato da estesi vigneti.<br />
- Terrazzamenti con muri a secco fittamente arborati ad oliveto costituiscono elemento di eccezionale rilievo in prossimità<br />
dell’abitato di <strong>Venturina</strong>.<br />
- Campagna di Follonica dove si affiancano ai prevalenti seminativi colture intensive a frutteto e vigneto.<br />
- Piana di Scarlino e Follonica con mosaico agrario che presenta caratteri di notevole varietà colturale con filari di alberi e<br />
masse erborate in prossimità dell’abitato.<br />
Valori estetico percettivi<br />
(i valori estetico percettivi sono identici ai valori storico culturali)<br />
In merito ai valori degli elementi costitutivi antropici, sempre assumendo quale riferimento<br />
l’area contermine agli aerogeneratori, si nota una correlazione, d’ordine generale, con i segni<br />
del sistema della bonifica, in tale caso da ricondurre ad ai fossi di regimazione delle acque,<br />
segnalati con riferimento ai valori storico culturali e ribaditi anche come elementi correlati ai<br />
valori estetico percettivi.<br />
Per quanto attiene ai valori degli insediamenti ed infrastrutture, richiamati nel successivo<br />
riquadro, nella porzione di territorio di ubicazione dell’impianto eolico si riscontra la presenza<br />
delle case coloniche, associate sia ai valori storico culturali che a quelli estetico percettivi, ed<br />
PAGINA: 82: 98 2011 COD: 11V071
RELAZIONE PAESAGGISTICA<br />
ancora la rete delle strade storiche, sia quelle di collegamento tra l’entroterra e la costa, sia<br />
la Vecchia Aurelia.<br />
Scheda dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità – Ambito 23 “Val di Cornia”<br />
Sezione 2 – Riconoscimento dei valori – Insediamenti e infrastrutture<br />
Valori naturalistici<br />
- Corsi d’acqua e aree di pertinenza fluviale, dotazioni di verde anche privato degli insediamenti litoranei, nonché aree<br />
collinari limitrofe agli insediamenti urbani, costituiscono dotazione ambientale di eccezionale valore all’interno delle<br />
strutture urbane ai fini della continuità dei sistemi ambientali.<br />
- Coltivi di elevato valore del promontorio di Piombino e delle aree collinari, che hanno funzione di cuscinetto ecologico<br />
rispetto agli aggregati urbani.<br />
Valori storico culturali<br />
- Porto commerciale e passeggeri di Piombino rappresenta una forma significativa del paesaggio costiero contemporaneo.<br />
- Centro storico di Piombino, in parte racchiuso da una splendida cinta muraria, presenta molti monumenti significativi<br />
(nucleo originario del Castello risalente al XIII secolo).<br />
- Paesaggio costiero di Piombino caratterizzato dalla presenza degli stabilimenti metallurgici, il cui impianto risale alla fine<br />
dell’Ottocento, di rilevante valore identitario e culturale per la comunità locale.<br />
- Suvereto, borgo medievale le cui origini risalgono a prima del mille, ricco di testimonianze storiche e artistiche.<br />
- Borgo storico di Sassetta, antico castello medievale, sorge tra boschi e selve di castagni sulla sommità di una collina che<br />
domina il mare.<br />
- Campiglia Marittima, borgo storico di origine antica; nei pressi si trova la Rocca di San Silvestro, villaggio fortificato di<br />
fondazione del X secolo.<br />
- Castello della Magona, in prossimità dell’abitato di <strong>Venturina</strong>, emergenza architettonica.<br />
- Follonica, riveste particolare valore storico culturale l’insediamento della città Leopoldina (poi comprensorio ex ILVA), per<br />
gli edifici e per gli elementi di arredo urbano in ghisa, e la chiesa di San Leopoldo con pronao in ghisa.<br />
- Chiesa-torre della Pievaccia, interna al parco di Montioni, sito fortificato di particolare interesse.<br />
- Elementi di valore: il sistema difensivo costiero (torri e fortilizi) e la viabilità storica con i manufatti ad essa collegati (ponti,<br />
cippi miliari, edicole votive) e le strade che presentano banchine con filari di pini, quali la vecchia Aurelia e la<br />
- via delle Collacchie.<br />
- In generale, costituiscono valori, per quanto riconosciuti come documenti storici e culturali ed elementi di identificazione<br />
per le comunità locali: gli aggregati e i centri storici minori; le ville ed i giardini; le case coloniche; i complessi religiosi; i<br />
castelli.<br />
- Ambito rurale adiacente ai centri storici e agli aggregati, nel quale si stabiliscono relazioni di carattere percettivo,<br />
morfologico e strutturale.<br />
- Aree di Populonia, di Baratti, di San Silvestro e gli insediamenti fortificati ellenistici sulle creste collinari, che hanno<br />
preminente valore archeologico.<br />
- Parco Archeo-Minerario di San Silvestro, nella parte collinare tra Campiglia Marittima e San Vincenzo, con reperti<br />
etruschi, miniere, pozzi, gallerie, cave, ville e palazzi medievali.<br />
- Insediamenti prevalentemente a carattere produttivo, fra la baia di Portiglioni e intorno all’area umida dell’antico lago di<br />
Scarlino, sorti in età protostorica etrusca e romana.<br />
Valori estetico percettivi<br />
- Strade che collegano l’interno alla costa, la vecchia Aurelia e la strada delle Collacchie, a sud di Follonica, si aprono su<br />
visuali panoramiche di rilievo.<br />
- Ambito panoramico di particolare rilievo, legato alla strada tra Piombino ed il golfo di Salivoli.<br />
- In generale, per la percezione di visuali panoramiche o per esserne oggetto: le strade nazionali e provinciali; tutte le<br />
strade riconosciute panoramiche<br />
- dagli strumenti e atti di pianificazione e governo del territorio; la rete della viabilità storica,<br />
- Borghi rurali dominano i colli coltivati a vigneto ed oliveto fino ai fondovalle.<br />
- In generale, per la loro configurazione e per il rapporto morfologico, fra centri e nuclei edificati e territorio rurale: i versanti<br />
collinari fra l’edificato e il fondovalle; le fasce al piede delle colline.<br />
- Per consentire la percezione di visuali panoramiche o per esserne oggetto: i castelli; il sistema delle torri e dei forti di<br />
avvistamento; il sistema delle pievi e altri complessi religiosi; i centri capoluogo di comune e le frazioni; gli aggregati ed i<br />
centri storici minori; le ville ed i giardini; le case coloniche.<br />
- Porti turistici, componenti caratterizzanti il paesaggio costiero percepito dal mare che offrono spazi privilegiati di fruizione<br />
pubblica da cui sono percepite visuali aperte sul mare e verso l’interno.<br />
4.3.3 Gli Ambiti di Paesaggio identificati dal PTCP<br />
Il PTC della Provincia di Livorno suddivide il territorio provinciale in ventisette Ambiti di<br />
Paesaggio, definiti come “unità spaziale in cui si riscontra una determinata associazione di<br />
tipi di paesaggistici, la cui distribuzione spaziale e quantitativa rende l’ambito unico e non<br />
ripetibile”; tali ambiti sono distinti e raggruppati secondo quattro Sistemi di Paesaggio<br />
principali che, a loro volta, derivano dall’articolazione in Ambiti di Paesaggio effettuata dal<br />
PIT. Nella <strong>Relazione</strong> inerente al paesaggio (Quadro Conoscitivo), oltre ad esplicitare la<br />
metodologia adottata per l’analisi, si descrivono i citati Sistemi, i processi di evoluzione e di<br />
degrado del paesaggio ed infine anche i tipi paesaggistici di ogni Ambito. Negli Allegati alla<br />
<strong>Relazione</strong>, oltre alle Tavole analitiche tematiche (elaborazione di dati tematici di base, analisi<br />
strutturale di base, analisi strutturale di sintesi) ed alla cartografie di elaborazione diagnostica<br />
VERS: 01 2011 PAGINA: 83: 98
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
(evoluzione del paesaggio e Ambiti di paesaggio), è incluso l’Atlante del paesaggio che<br />
contiene le schede descrittive di ognuno degli Ambiti provinciali individuati. Tali schede si<br />
articolano in tre sezioni inerenti alla descrizione tematica, ai caratteri strutturali ed alla<br />
connotazione tipologica: la sezione della descrizione tematica è composta da una fotografia,<br />
da una carta in cui si riporta il perimetro dell’Ambito e da note relative ai temi già considerati<br />
nelle Schede dell’Atlante del PIT; la sezione dei caratteri strutturali riporta una serie di<br />
fotografie, associate a commenti, relative ai caratteri ritenuti idonei ad individuare l’identità<br />
paesaggistica di ogni Ambito, definiti come caratteri strutturali, a cui si aggiungono note sul<br />
tema delle Emergenze paesaggistiche, della Linea di costa e dei Principali fattori di rischio; la<br />
sezione della connotazione tipologica riporta un estratto della tavola relativa ai Tipi<br />
paesaggistici, con un grafico relativo all’incidenza percentuale degli stessi nell’Ambito ed una<br />
nota di commento.<br />
La porzione di territorio in cui si colloca l’impianto eolico in progetto ricade all’interno<br />
dell’Ambito n. 18, denominato “Paesaggio di pianura della Val di Cornia a dominante agricola<br />
orticola”, facente parte del “Sistema della Pianura del Cornia e delle Colline Metallifere”.<br />
PTCP - “Ambiti di Paesaggio” – Tavola 11b<br />
PAGINA: 84: 98 2011 COD: 11V071
RELAZIONE PAESAGGISTICA<br />
Nel successivo riquadro si riportano alcuni stralci della descrizione del citato Sistema,<br />
contenuta nella <strong>Relazione</strong> sul paesaggio, riprendendo i passaggi di maggiore interesse con<br />
riferimento agli aspetti strettamente paesaggistici.<br />
“Sistema della Pianura del Cornia e delle Colline Metallifere”<br />
La costa occidentale dall’insediamento di San Vincenzo al Parco Naturale di Rimigliano, apre alla panoramica sul golfo di<br />
Baratti, il promontorio di Populonia ed il Parco Naturale ed Archeologico del Promontorio di Piombino; verso sud il golfo di<br />
Follonica con il porto di Piombino, l’area naturalistica Padule Orti Bottagone e le spiagge turistiche da Torre del Sale a Torre<br />
Mozza, con recenti interventi di sistemazione ad uso turistico (piccolo porto nautico e stabilimenti, parcheggi e posti camper).<br />
Nell’interno la vasta area pianeggiante è delimitata a nord dalle cave di Monte Rombolo e Monte Calvi che sovrastano il borgo<br />
di Campiglia ecostituiscono forte impatto paesaggistico, mentre ad est apre alla valle del Pecora e al Parco Naturale di<br />
Montioni, di grande interesse per il turismo naturalistico all’interno delle aree protette del sistema dei Parchi della Val di Cornia.<br />
Forte espansione del sistema insediativi turistico sia sulla costa che all’interno.<br />
L’intensivo sistema colturale della valle è ancora caratterizzato dalla minuta tessitura territoriale delle colture prevalentemente<br />
orticole, ma la vegetazione di margine di salici e pioppi tende alla scomparsa totale e le case coloniche sparse stanno perdendo<br />
i caratteri dell’architettura rurale.<br />
(..)<br />
Il golfo di Baratti conserva una necropoli monumentale etrusca di grandissima importanza storica, archeologica e culturale<br />
testimonianza dello sfruttamento del ferro. Populonia rappresenta già dal IX secolo a.C. un importante approdo strategico nel<br />
mediterraneo per il commercio sinergico. I ritrovamenti archeologici oltre a rappresentare un’importante testimonianza,<br />
valorizzata dall’interesse culturale dei parchi della Costa degli Etruschi, si inseriscono nel paesaggio costiero e della Val di<br />
Cornia con notevole valore scenico-percettivo. Il Parco archeominerario di San Silvestro ed i suoi percorsi permettono di<br />
comprendere di ripercorrere gli itinerari storici dall’antichità ai giorni nostri dell'attività estrattiva sulle colline che si trovano a<br />
nord di Campiglia Marittima, in un contesto paesaggistico caratterizzato da pregevoli espressioni della flora mediterranea e da<br />
suggestive viste panoramiche. Di grande interesse il sito della Rocca di San Silvestro, antico villaggio (secolo X) fondato per i<br />
minatori.<br />
Il sistema dei Parchi della Val di Cornia costituisce un elemento di raccordo tra le aree protette situate sulla costa e quelle<br />
collinari che permettono di ripercorrere la storia di questa porzione di territorio, dagli etruschi fino ai nostri giorni, all’interno di un<br />
articolato complesso paesaggistico di grande valore. Il sistema comprende infatti il Parco archeologico-minerario di San<br />
Silvestro, il Parco archeologico Baratti e Populonia, il Parco interprovinciale di Montioni, I Parchi della Costa orientale e della<br />
Sterpaia e l’Oasi Orti Bottagone.<br />
(..)<br />
Per quanto riguarda l’analisi dei processi di evoluzione e degrado del paesaggio, sempre<br />
facendo riferimento alla <strong>Relazione</strong> sul paesaggio, si riprendono, nel sottostante riquadro,<br />
alcune considerazioni riferite all’Ambito di Paesaggio n. 18.<br />
Ambito di Paesaggio n. 18 - “Paesaggio di pianura della Val di Cornia a dominante agricola orticola”<br />
Processi di evoluzione e di degrado<br />
Caratteristiche di stato<br />
La dominante dell’ambito è rappresentata dalla diffusa presenza delle aree con stati di frammentazione paesaggistica a piena<br />
reversibilità potenziale per la prevalenza di fattori agrari, che interessano l’80% della superficie, connotando decisamente la<br />
matrice paesaggistica con unità estese e continue.<br />
Le aree con stati di frammentazione paesaggistica a reversibilità irrilevante, quantitativamente minoritarie (5%), assumono<br />
configurazioni spaziali significative dal punto di vista degli stati critici di frammentazione solo nel caso del cordone insediativo<br />
costiero di San Vincenzo.<br />
I soprassuoli biopermeabili, presenti con una quota relativa del 13%, sono diversamente distribuiti nell’ambito, dove a est di San<br />
Vincenzo connotano la matrice paesaggistica per una equa alternanza con i soprassuoli agrari specializzati, mentre a sud della<br />
città e in genere nell’ambito costituiscono formazioni assai più rarefatte e frammentate, con l’eccezione delle altre aree di<br />
maggiore concentrazione intorno alla Pineta di Rimigliano, ancora nel settore nord-occidentale dell’ambito, e lungo tutto il corso<br />
del Cornia, nonché, ancora lungo questo, in modo più significativo, all’estremità centro-orientale dell’ambito.<br />
Caratteristiche di processo<br />
L’ambito è connotato dalla diffusione di formazioni agrarie specializzate (categoria 3) nella misura dominante (80%) e con la<br />
distribuzione spaziale già rilevate fra le caratteristiche di stato.<br />
I processi involutivi sono rappresentati, nella misura complessiva del 13% della superficie, dalle dinamiche di tendenziale<br />
relittualità delle colture agrarie arborate (7%, categoria 4) a causa della loro marginalità produttiva e da quelle di tendenziale<br />
ricolonizzazione forestale conseguenti all’abbandono delle terre (1%, categoria 6). Sebbene tali processi siano presenti in<br />
piccole unità anche nella pianura centrale dell’ambito, la loro evidente concentrazione, ancora in unità frammentate, è<br />
osservabile nelle aree di transizione tra la pianura e le colline che la orlano, sia in sinistra che in destra di Cornia.<br />
Le dinamiche di metastabilità o di resilienza paesaggistica proprie delle formazioni forestali (categoria 8) risultano decisamente<br />
subordinate nella connotazione evolutiva dell’ambito con il 3% di incidenza sulla sua superficie complessiva e la maggiore<br />
concentrazione lungo la costa.<br />
Nella <strong>Relazione</strong> sul paesaggio, come già accennato, nel capitolo relativo ai Tipi di<br />
paesaggio, si precisa che la classificazione tipologica elementare è finalizzata alla<br />
descrizione delle proprietà degli ambiti di paesaggio ed alla conseguente identificazione dei<br />
caratteri strutturali che connotano le qualità essenziali della struttura, funzionamento e<br />
VERS: 01 2011 PAGINA: 85: 98
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
cambiamento. Ancora, si sottolinea che tale descrizione si avvale dell’incrocio dello strato<br />
informativo dei tipi paesaggistici, la Tavola 6 inclusa tra le carte in Allegato alla <strong>Relazione</strong> 22 ,<br />
con l’articolazione spaziale degli ambiti di paesaggio, la Tavola 11 sempre inserita in<br />
Allegato alla <strong>Relazione</strong>. Nel successivo riquadro si riprende la descrizione relativa all’Ambito<br />
di Paesaggio n. 18.<br />
Ambito di Paesaggio n. 18 - “Paesaggio di pianura della Val di Cornia a dominante agricola orticola”<br />
“Tipi di paesaggio”<br />
L’ambito presenta una bassa diversità tipologica relativa del paesaggio (valori minimi relativi del territorio provinciale), con 53<br />
tipi significativi per una rispettiva superficie totale di 16.266 ettari. Esso è connotato da una spiccata dominante tipologica<br />
agraria che presenta anche, limitatamente ai tipi dominanti, omogeneità dei caratteri colturali e morfologici del paesaggio.<br />
I soprassuoli colturali erbacei su suoli scarsamente acclivi su substrati alluvionali (tipo 28: 48%) costituiscono la principale<br />
dominante paesaggistica dell’ambito, distribuita in tutto il settore centrale e meridionale, in misura minore ma continua sulla<br />
destra fluviale e in modo prevalente sulla sinistra (Comune di Suvereto, Comune di Campiglia Marittima, Comune di Piombino).<br />
Con i soprassuoli colturali erbacei su suoli scarsamente acclivi, su substrati sabbiosi o arenacei (tipo 31: 14%) e su substrati<br />
argillosi (tipo 29: 11%), l’incidenza d’insieme dei tipi paesaggistici dominanti raggiunge il 74% della superficie complessiva dei<br />
tipi dell’ambito. I soprassuoli colturali erbacei su suoli scarsamente acclivi, su substrati sabbiosi o arenacei connotano in modo<br />
significativo il primo entroterra dell’ambito dalle aree a sud di San Vincenzo fino al P.re Poggio all’Agnello, vicino al quale si<br />
trova la stazione ferroviaria di Populonia (Comune di San Vincenzo, Comune di Campiglia Marittima, Comune di Piombino). I<br />
soprassuoli della stessa natura formatisi su substrati argillosi sono invece presenti in unità sparse le più significative delle quali<br />
risultano dislocate in corrispondenza di aree di bonifica intorno alla Pineta di Rimigliano, presso P.re Molino Nuovo (Comune di<br />
San Vincenzo e Comune di Piombino) e P.re Fossa Calda (Comune di San Vincenzo, Comune di Campiglia Marittima), in<br />
cinque lenti in sinistra Cornia a cavallo della ferrovia (Comune di Campiglia Marittima e Comune di Piombino) e in unità estese<br />
nelle aree di bonifica intono al Fiume Cornia e al Fosso Allacciante (Comune di Piombino) a ovest, nella pianura di destra, e il<br />
Fosso Cosimo (Comune di Piombino) a est in sinistra idrografica, fino a La Striscia (Comune di Piombino).<br />
Nella gamma dei tipi subdominanti risultano prevalere ancora quelli con soprassuoli colturali, ma in questo caso arborati e<br />
arborei, su suoli scarsamente acclivi e substrati alluvionali (tipo 22: 5%), su suoli scarsamente acclivi e substrati sabbiosi o<br />
arenacei (tipo 23: 4%) e su suoli mediamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei (tipo 20: 2%). Essi interessano nell’insieme<br />
l’11% della superficie complessiva dei tipi dell’ambito, elevando l’incidenza della dominante agraria generale composta dai tipi<br />
dominanti con colture erbacee e da quelli subdominanti con colture arboree e arborate ad un’incidenza complessiva dell’85%.<br />
La subdominante dei soprassuoli insediativi su suoli scarsamente acclivi e substrati alluvionali (tipo 52) ha un’incidenza<br />
prossima al 3%. I soprassuoli colturali arborati e arborei su suoli scarsamente acclivi e substrati alluvionali formano sue sole<br />
unità significative, in destra Cornia, fra il fiume e il Fosso delle Gore, presso C. San Giovanni e C. alla Gera (Comune di<br />
Suvereto) e sulla sinistra fluviale, tra C. San Lorenzo e P.re Marracchiccio (Comune di Suvereto). Quelli su substrati sabbiosi o<br />
arenacei sono per lo più presenti in due areali nord occidentali limitrofi: a sud di San Vincenzo, da P.re Castellaccio (Comune di<br />
San Vincenzo) a P.re San Giuseppe (Comune di San Vincenzo) e, più a sud, tra le località Plamentello (Comune di San<br />
Vincenzo) e Lumiere (Comune di San Vincenzo). Quelli su suoli mediamente acclivi e substrati sabbiosi o arenacei<br />
costituiscono invece un unico areale segnalabile, ma con unità frammentate, tra San Vincenzo e San Carlo (Comune di San<br />
Vincenzo). I soprassuoli insediativi su suoli scarsamente acclivi e substrati alluvionali sono infine presenti, sul litorale, a nord e<br />
sud di San Vincenzo e, nell’entroterra centrale, a <strong>Venturina</strong> (Comune di Campiglia Marittima) e, più a est, a Forni (Comune di<br />
Suvereto).<br />
I restanti 46 tipi paesaggistici significativi riscontrati, rappresentati nell’ambito con un’incidenza unitaria inferiore al 2% e una<br />
incidenza complessiva pari al 12%, interessano complessivamente 2.007 ettari di territorio.<br />
L’esame cartografico della distribuzione spaziale di tali tipi paesaggistici evidenzia che essi costituiscono alcune formazioni<br />
significative a scala di paesaggio, in corrispondenza del corso del fiume Cornia (Comune di Suvereto, Comune di Campiglia<br />
Marittima, Comune di Piombino), dei dolci rilievi collinari dell’immediato entroterra di San Vincenzo, fino a San Carlo (Comune<br />
di San Vincenzo), e del cordone costiero che da San Vincenzo termina al P.re Torre Nuova (Comune di Vincenzo), all’estremità<br />
meridionale dell’ambito. Poco distaccate da quest’ultimo, due unità di minore estensione sono costituite dalle formazioni<br />
forestali del P.re Contessa Beatrice (Comune di San Vincenzo) e dalla Pineta di Ripigliano (Comune di San Vincenzo).<br />
Per quanto attiene alla scheda dell’Ambito di Paesaggio n. 18, in merito alla connotazione<br />
tipologica, si afferma che tale Ambito “presenta una bassa diversità tipologica relativa al<br />
paesaggio” e che lo stesso “è connotato da una spiccata dominante agraria con omogeneità<br />
dei caratteri colturali e morfologici del paesaggio”, con evidenziazione che l’incidenza<br />
d’insieme dei tipi paesaggistici dominanti (tre tipi di soprassuoli colturali erbacei) raggiunge il<br />
74% della superficie complessiva dell’ambito. Nei sottostanti riquadri si riportano, in forma<br />
sintetica, gli elementi distintivi, come individuati nella sezione della descrizione tematica e dei<br />
caratteri strutturali.<br />
22 Si rimanda all’estratto della citata Tavola 6 del QC relativo al Paesaggio, inserito nell’Allegato Cartografico.<br />
PAGINA: 86: 98 2011 COD: 11V071
RELAZIONE PAESAGGISTICA<br />
Ambito di paesaggio n. 18 - “Paesaggio di pianura della Val di Cornia a dominante agricola orticola”<br />
-<br />
Descrizione tematica<br />
Pianura alluvionale attraversata dal F. Cornia, un tempo tipico paesaggio maremmano, oggi<br />
caratterizzato dalle opere di bonifica idraulico agraria.<br />
Geomorfologia - Basso arenile di Rimigliano segnato dalla fascia dunale con zona retrodunale boscata (pineta).<br />
- Stretta fascia litoranea nel Golfo di Follonica con esile fascia dunale ed aree residuali del Palude di<br />
Piombino.<br />
- Interventi di regimazione idraulica iniziati in epoca medicea, estesi ad un progetto di bonifica<br />
sull’intera pianura in epoca napoleonica e attuati dai Lorena nell’800.<br />
Idrografia antropica<br />
- Sistema dei corsi d’acqua connesso, attraverso il Fosso Allacciante, al sistema del Fosso della<br />
Corniaccia.<br />
- Sistema di regimazione dei fossi con tratti di canale di collettamento e connessione; il Fosso Cervia,<br />
parallelo alla costa, drena le acque che sgrondano nella pianura per convogliarle al mare.<br />
- Reticolo idrografico primario (F. Cornia) e secondario (botro Redigaffi, fosso Valdicciola, fosso<br />
Idrografia naturale<br />
-<br />
Acquari, fosso Riomerdancio, fosso Ragnaia, fosso Valle di Ripopolo).<br />
Acquifero carbonatico e importante fenomeno termale ai piedi del rilievo di Campiglia Marittima che<br />
sfocia nelle sorgenti termali di Calidario, de Canneto e della Caldana di <strong>Venturina</strong>.<br />
- Pineta di pino domestico sull’arenile occidentale dalle ultime propaggini urbane di San Vincenzo fino<br />
a La Torraccia e lungo la costa meridionale, tra Torre del Sale e Torre Mozza; all’interno Pineta di<br />
Rimigliano, Pineta di Torrenova e Bosco della Sterpaia, l’ultimo a dominanza di querce e frassini..<br />
Mosaico forestale - Diffusi mosaici di tamariceti e salicornieti.<br />
- Vegetazione ripariale di connessione tra il sistema collinare e la costa; ridotta la presenza di corridoi<br />
vegetazionali tra le colture fittemente arborate.<br />
- Rare le macchie boscate nella pianura più interna.<br />
- Articolata tessitura, con partizioni fortemente frammentate, di seminativi semplici a cereali e<br />
foraggere, nelle aree orientali alternate ad arborati a olivo e frutteti.<br />
Mosaico agrario - Serre a Bocca di Cornia, vicino alla centrale Enel.<br />
- Nell’entroterra seminativo arborato residuo, seminativi semplici e colture ortive in prossimità<br />
dell’edificato.<br />
- Sistema difensivo costituito dalle cinquecentesche torri di guardia: Torraccia e Torre Nuova, a San<br />
Vincenzo; Torre Mozza e Torre del Sale, nel Golfo di Follonica.<br />
Insediamento<br />
storico<br />
-<br />
-<br />
Presenza di ritrovamenti d’interesse archeologico (Sant’Antonio, Casa Franciana, Casa Boldrinim<br />
Masseria Paduletto).<br />
Diffuso patrimonio dell’architettura rurale costituito, prevalentemente, da case coloniche degli<br />
appoderamenti da recuperare.<br />
- Terme di Caldana, presumibilmente nel sito delle antiche Terme di Populonia.<br />
- Stazione balneare ad alta frequentazione, con insediamenti residenziali di tipo turistico ricettivo, aree<br />
Insediamento<br />
servizi, campeggi, parcheggi per camper in prossimità della linea di costa.<br />
moderno e - Polverizzazione dei nuclei fondiari.<br />
contemporaneo - Insediamenti produttivi a <strong>Venturina</strong> di criticità percettiva ed ambientale.<br />
- Presenza di ormeggi nel Golfo di Follonica e costa di san Vincenzo.<br />
- Via Aurelia, Variante Aurelia e linea ferroviaria tirrenica, con inclusione di aree tra i due tracciati, ed<br />
Rete ed impianti ancora via della Principessa, della Base Geodetica di Piombino e della S.S. n. 398.<br />
viari e tecnologici - Presenza ingombrante di reti tecnologiche.<br />
- Faro a San Vincenzo.<br />
- ANPIL della fascia costiera tra Torre del Sale e Torre Mozza.<br />
Aree protette<br />
emergenze<br />
paesaggistiche<br />
ed<br />
-<br />
-<br />
Parco naturalistico costiero della Sterpaia (sistema dunale, arenili, aree umide retrodunali, radure<br />
agricole, aree boscate) e Parco costiero di Ripigliano (cordoni dune mobili, residui delle dune fisse,<br />
pinete e macchia mediterranea).<br />
Fiume Cornia che riveste un particolare interesse naturalistico.<br />
- Valore panoramico e paesaggistico della strada litoranea in prossimità della Torraccia.<br />
Vincoli - Fascia costiera di San Vincenzo per i valori naturalistici e panoramici (D.M. 25.1.1967).<br />
Gli elementi del paesaggio citati nella descrizione tematica dell’Ambito, riguardanti anche<br />
l’area direttamente interessata dalla realizzazione dell’impianto o quella immediatamente<br />
contermine agli aerogeneratori, sono riconducibili alla geomorfologia della pianura<br />
alluvionale ed all’idrografia derivante dalla sistemazione idraulica correlata alla bonifica ed<br />
ancora alla suddivisione fondiaria frammentata e ad un segno dell’insediamento storico<br />
derivante dalla diffusa presenza degli edifici rurali a cui si aggiungono le infrastrutture,<br />
storiche e recenti, della via Aurelia e sua Variante, della linea ferroviaria tirrenica ed ancora<br />
delle reti tecnologiche.<br />
VERS: 01 2011 PAGINA: 87: 98
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
Ambito di paesaggio n. 18 - “Paesaggio di pianura della Val di Cornia a dominante agricola orticola<br />
Geomorfologia<br />
-<br />
-<br />
Caratteri strutturali<br />
Pianura attraversata dal Fiume Cornia, risultato della sedimentazione dei depositi alluvionali.<br />
Bonifiche delle aree paludose che hanno definito la maglia poderale e infrastrutturale.<br />
- Rete dei fossi di regimazione delle acque e caselli idraulici.<br />
Idrografia antropica - Ormeggi per natanti.<br />
- Caselli idraulici.<br />
Idrografia naturale<br />
-<br />
-<br />
Reticolo idrografico d’interesse in relazione al fiume Cornia.<br />
Tratti a volte canalizzati e deviati dalle opere di bonifica, ma con abbondante vegetazione riparia.<br />
- Paesaggio cerealicolo silvo pastorale delle pianure maremmane praticamente scomparso.<br />
Mosaico agrario - Tessitura di seminativi semplici e cereali a foraggere, colture orticole alternate ad arborati ad olivo e<br />
frutteti (aree orientali).<br />
Rete ed impianti - Rete stradale e ferroviaria.<br />
viari e tecnologici - Fasci di elettrodotti di servizio agli impianti industriali.<br />
Emergenze<br />
paesaggistiche<br />
-<br />
-<br />
-<br />
Aree palustri salmastre della Sterpaia e Bosco della Sterpaia.<br />
Pinete sull’arenile occidentale e nel Golfo di Follonica, con relativo sistema dunale.<br />
Sistema delle torri costiere.<br />
- Testimonianza delle tipiche fasce vegetazionali delle coste sabbiose: area dunale con macchia<br />
mediterranea, area palustre retrodunale a bosco mesoigrofilo e pinete.<br />
Linea di costa - Duna mobile quasi scomparsa a causa del fenomeno erosivo e rischio di compromissione della duna<br />
fissa per pressione antropica.<br />
- Ormeggi dei natanti e strutture balneari a ridosso della duna.<br />
- Stazioni balneari, campeggi e villaggi turistici con unità abitative seriali e di scarsa qualità che<br />
trasformano i caratteri paesaggistici.<br />
Fattori di rischio - Polverizzazione dei nuclei fondiari con insediamenti residenziali stagionali.<br />
- Alterazione del Bosco della Sterpaia per effetto della ora demolita lottizzazione di Riva Verde.<br />
- Ingressione salina nella falda freatica e presenza di inquinanti nei pozzi irrigui.<br />
Tra i caratteri strutturali individuati, quelli che riguardano il sito di ubicazione dell’impianto<br />
eolico in progetto, corrispondono agli aspetti già evidenziati con riferimento alla descrizione<br />
generale dell’Ambito. In dettaglio, si tratta: per la morfologia e idrografia, della pianura<br />
alluvionale del Conia, della rete dei fossi di regimazione e dei corsi d’acqua naturali<br />
canalizzati; per il mosaico agrario, della tessitura derivante dai seminativi e foraggere; per le<br />
reti ed impianti, delle strade principali, della ferrovia e degli elettrodotti. Con riferimento alle<br />
emergenze paesaggistiche indicate si osserva, invece, che non sussiste alcuna relazione<br />
diretta, così come non vi è rapporto territoriale con gli elementi della linea di costa e<br />
interazione con i fattori di rischio rilevati.<br />
4.3.4 Gli Ambiti di Paesaggio identificati dal PS d’Area della Val di Cornia<br />
Il Piano Strutturale d’Area della Val di Cornia, al capitolo 7 della <strong>Relazione</strong> Generale,<br />
descrive l’analisi del paesaggio agrario e naturale condotta per i Comuni di Campiglia<br />
Marittima, Piombino e Suvereto allo scopo di conseguire una caratterizzazione preliminare<br />
delle strutture di lunga durata del paesaggio (sistemi ed unità di terre) con le relative<br />
peculiarità fisiografiche, climatiche, podologiche e vegetazionali, ed ancora delle dinamiche<br />
storiche che hanno interessato l’uso dei diversi sistemi di terre, nel periodo 1960-2000.<br />
Per condurre tale analisi, come evidenziato nella citato documento, si è fatto riferimento alla<br />
“Carta dell’uso agricolo del suolo” (Tav. 5.1 del Q.C.) 23 , revisione di quella prodotta dalla<br />
Provincia di Livorno in occasione della redazione del PTC, e sono stati utilizzati o prodotti i<br />
seguenti elaborati: la “Carta delle unità di terre” (Tav. 5.2 del Q.C.), di definizione di ambiti<br />
territoriali omogenei per opportunità e problemi legati all’uso delle risorse; la “Carta storica<br />
dell’uso agricolo e forestale delle terre”, per comparazione della carta dell’uso del suolo<br />
all’anno 1960 prodotta dal TCI e della carta Corine Land Cover 2000; la “Carta delle<br />
dinamiche dell’uso agro forestale delle terre”, per il periodo 1960-2000, ottenuta per incrocio<br />
delle due carte prima citate; la “Carta delle unità ambientali” (Tav. 5.3 del Q.C.), che<br />
individua gli ambiti omogenei per quanto concerne le caratteristiche di lunga durata delle<br />
terre e le forme caratterizzanti legate all’uso agricolo e all’insediamento rurale. In definitiva,<br />
pur non trattandosi di una suddivisione del territorio finalizzata a definire Ambiti di Paesaggio,<br />
23 Si rimanda allo stralcio della citata Tavola 5.1 del QC, inserito nell’Allegato Cartografico.<br />
PAGINA: 88: 98 2011 COD: 11V071
RELAZIONE PAESAGGISTICA<br />
bensì di una distinzione utile ai fini della pianificazione, i risultati ottenuti, che derivano<br />
dall’integrazione delle caratteristiche permanenti dei sistemi di unità di terre con le<br />
trasformazioni degli usi del suolo, sono comunque di interesse ai fini della lettura del<br />
paesaggio.<br />
Tavola 5.3 del QC del Piano Strutturale d’Area della Val di Cornia<br />
“Carta delle unità ambientali”<br />
Per quanto riguarda il risultato di tale procedura d’analisi, conclusa con la restituzione della<br />
citata “Carta delle unità ambientali”, si constata che la porzione pianeggiante del territorio a<br />
cavallo del Fiume Cornia, dove si localizza l’impianto in progetto, è classificata in prevalenza<br />
come “Area della pianura alluvionale a prevalente indirizzo agricolo”, con alcune zone<br />
interne, che si estendono fino a saldarsi con quelle della fascia costiera, definite come “Aree<br />
idromorfe di pianura costiera a prevalente indirizzo agricolo”, ed ancora, nel settore sud-<br />
VERS: 01 2011 PAGINA: 89: 98
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
occidentale, verso il promontorio di Piombino e verso il litorale di San Vincenzo, si<br />
distinguono le “Aree della pianura costiera a prevalente indirizzo agricolo”.<br />
La prima e la terza Area citata sottostanno alle “Unità di pianura a prevalente indirizzo<br />
agricolo” che, come riportato nella <strong>Relazione</strong>, comprendono le aree agricole della pianura<br />
“con la loro varietà di paesaggi, i paesaggi orticoli delle “sabbie rosse”, quelli a seminativi<br />
aperti della pianura alluvionale del Cornia, quelli più complessi delle pianure pedecollinari”,<br />
situazioni per le quali si definisce come “valore da preservare” l’apertura e l’integrità degli<br />
spazi agricoli, “controllando i fenomeni di frammentazione e dispersione infrastrutturale ed<br />
urbana. Al contempo si evidenzia, nella descrizione, che tale Unità rappresenta “la matrice<br />
connettiva a più elevata continuità che tiene insieme l’intero cinrciondario con i suoi valori e<br />
le sue emergenze identitarie”.<br />
La seconda Area è invece l’unica associata alle “Unità idromorfe della pianura costiera ad<br />
indirizzo agricolo, a elevata fragilità ambientale e potenziale rinaturalizzazione”, che<br />
comprende, secondo quanto riportato nella relazione, le aree caratterizzate da elevata<br />
fragilità ambientale (per caratteristiche proprie dei suolo, rischi di subsidenza e<br />
salinizzazione, scarsa capacità protettiva per le falde), da elevata potenzialità per la<br />
ricostruzione di habitat idromorfi e dal valore di cuscinetto ecologico e di habitat<br />
complementare nei confronti delle aree idromorfe a più elevata naturalità.<br />
4.3.5 Elementi che connotano il paesaggio e loro persistenze e trasformazioni<br />
Lo studio del paesaggio, finalizzato a riconoscere gli elementi che lo connotano, è condotto,<br />
per l’area vasta e per l’area di ubicazione dell’impianto, considerando distinti aspetti: la<br />
geomorfologia ed idrografia, la vegetazione e gli usi del suolo, il sistema insediativo ed<br />
infrastrutturale. Tale analisi, ovviamente, tiene conto di quanto già definito nelle distinzioni,<br />
tra ambiti ed unità di paesaggio, di cui ai diversi piani territoriali paesaggistici ed urbanistici<br />
precedentemente richiamati.<br />
L’analisi è effettuata, con riferimento all’area vasta, in modo diacronico, ovvero mettendo a<br />
confronto la situazione “storica” con quella “recente”, al fine di evidenziare le persistenze e/o<br />
le trasformazioni del paesaggio. A tale fine si assume, quale riferimento “storico”, lo stato del<br />
territorio rappresentato sulle Tavole IGM, in scala 1.25.000, relative ai rilievi eseguiti<br />
nell’anno 1939. Tali carte consentono di identificare i principali elementi associati alla<br />
presenza umana (nuclei insediativi, singoli fabbricati, viabilità), alla vegetazione (boschi,<br />
distinti per tipo, ed arbusteti), all’idrografia e geomorfologia, ed anche, in parte, all’uso<br />
agricolo del suolo (vigneti ed uliveti, distinti rispetto ai seminativi e prati). Si restituisce,<br />
quindi, per interpretazione di tale carta IGM, una tavola che evidenzia i principali elementi<br />
che connotano in paesaggio. 24<br />
La situazione “recente” è ricostruita considerando, gli elaborati del PTC relativi all’evoluzione<br />
del paesaggio, ovvero le Tavole 10a, 10b e 10 c, ed ancora gli elaborati del Quadro<br />
Conoscitivo del Piano d’Area distinti come Tavola 6.2 e 6.3, l’elaborato del PS della Val di<br />
Cornia distinto come Tavola 5.1, di restituzione dell’uso agricolo del suolo, ed infine la carta<br />
degli usi del suolo all’anno 1993 reperibile sul SIT della Provincia di Livorno. Alla citata<br />
cartografia si aggiunge l’utilizzo delle foto aeree più recenti reperibili sul sito BING-MAP.<br />
Sulla base delle citate informazioni si restituisce, quindi, per un’area intermedia, una carta in<br />
cui si evidenziano le modifiche intervenute rispetto all’epoca storica, considerando in<br />
particolare le variazioni degli usi del suolo e le modifiche interne allo stesso utilizzo agricolo<br />
dei terreni. 25<br />
24 Si rimanda alle carta “Elementi strutturali storici del Paesaggio”, inserita nell’Allegato Cartografico.<br />
25 Si rimanda alla carta “Elementi del paesaggio – Trasformazioni rispetto all’epoca storica”, inserita nell’Allegato Cartografico.<br />
PAGINA: 90: 98 2011 COD: 11V071
RELAZIONE PAESAGGISTICA<br />
4.3.5.1 Morfologia e idrografia<br />
L’area di ubicazione dell’impianto di progetto ricade in un più vasto territorio caratterizzato,<br />
sotto il profilo geologico, per l’appartenenza alla vasta piana di origine alluvionale che si<br />
estende, dal piede delle “colline metallifere” fino al litorale, del Golfo di Follonica, a sud, e del<br />
Golfo di Baratti , ad ovest.<br />
Tavola 4.2 del QC del Piano Strutturale d’Area della Val di Cornia<br />
“Carta geologica” – stralcio della tavola e della legenda<br />
La morfologia di tale ambito, ovviamente, è di tipo pianeggiante, degradante verso il mare<br />
con debole inclinazione, in parte risultato di storici interventi di bonifica idraulica che hanno<br />
prosciugato le paludi che ricoprivano buona parte della piana del Cornia. Il promontorio di<br />
Piombino, antica isola che si è unita al continente a seguito del depositarsi dei citati apporti<br />
alluvionali, è costituito dai rilievi collinari del Poggio Guardiola, Poggio Tondo, M. Pecorino,<br />
M. Massoncello, M. Gigante, M. S. Maria, M. Pitti, le cui cime formano la linea spartiacque,<br />
sull’asse nord-sud, che separa i versanti occidentali, quelli che scendono verso il mare, con<br />
VERS: 01 2011 PAGINA: 91: 98
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
costa caratterizzata da tratti rocciosi affioranti, nel suo sviluppo dalla Punta delle Pianacce e<br />
Punta Saltacavallo fino alla Cala Moresca, dai versanti orientali. Questi ultimi degradano, in<br />
forme più dolci, verso la pianura e si nota la presenza di una fascia intermedia con colline<br />
isolate e più basse, quelle del Poggio al Finocchio, Poggio al Poro, Poggio Malassarto,<br />
Poggio Giampiero, Poggio La Cagliana, Poggio Caselle ed ancora, immediatamente ad est<br />
del Golfo di Baratti, il Poggio al Lupo, il Poggio Grattalocchio ed il Poggio Piovanello, ed in<br />
posizione più centrale, già all’interno della piana, Montegemoli, Poggio l’Aquilino e Poggio<br />
l’Aquila. Per quanto riguarda la propaggine meridionale delle “colline metallifere” si<br />
distinguono, all’interno dell’ambito territoriale considerato, i poggi più esterni e di minore<br />
altezza, corrispondenti al Colle Merlo, M. Valerio, Poggio Angelica, M. Patoni, M. Solaio e M.<br />
Pitti, separati da strette fasce sub pianeggianti dai retrostanti più elevati rilievi, con la cima<br />
del M. Campiglia che chiude, a sud, il crinale principale che fa capo al M. Calvi.<br />
L’idrografia, nella zona della piana, si connota per la presenza, oltre che del F. Cornia, di<br />
diversi altri corsi d’acqua naturali che scendono dai citati rilievi collinari e quando entrano<br />
nella pianura sono canalizzati formando, assieme alla rete delle scoline, un sistema<br />
complesso derivante dalle opere di regimazione idraulica. Una diversa configurazione hanno<br />
i corsi d’acqua presenti sul versante occidentale del promontorio di Piombino, disposti a<br />
pettine e tutti con breve corso e foce a mare, tra i quali si riconoscono il Fosso S. Quirico, il<br />
Fosso dei Botrafichi, il Fosso Fornacione, il Rio Fanale ed infine il Rio Salivoli che ha un’asta<br />
più lunga e con rami laterali. Per quanto riguarda il lato opposto del citato rilievo si<br />
distinguono il Fosso delle Grotte ed il Fosso di Valgranila, che sfociano nel Golfo di Baratti,<br />
ed il più ramificato Fosso della Cagliana che, per la presenza, a nord, del Poggio Giampiero<br />
e Poggio Lazzaraccio, ed a sud del citato M. S. Maria e Poggio Caselle, si sviluppa verso est<br />
dove viene poi intercettato dal Fosso Allacciante che recapita le acque nel mare, dove ora si<br />
trova il nuovo porticciolo di Piombino (in località Foce Cornia Vecchia), detto delle “Terre<br />
Rosse”.<br />
Dalle colline attorno a Campiglia Marittima scendono i corsi d’acqua minori del V. di S.<br />
Caterina, del V. Pozzatello e del V. Volpaiola, a cui si aggiunge il Fosso Corniaccia che,<br />
dopo avere superato la Vecchia Aurelia, assume un andamento lineare ed attraversa la<br />
piana, con un asse sostanzialmente parallelo a quello del F. Cornia, fino ad incontrare, a sud<br />
rispetto al poggio di Montegemoli, il Fosso Allacciante. La zona pianeggiante di nord-ovest è<br />
attraversata da due principali corsi d’acqua canalizzati, il Fosso Calda ed il Fosso Rocchio,<br />
che confluiscono entrambi nel Fosso Allacciante che taglia il territorio con un andamento<br />
nord-sud fino a sfociare, come già detto, nel tratto più occidentale del Golfo di Follonica<br />
dove, ancora all’inizio del secolo, si trovava anche la foce della Cornia Vecchia. Ad est<br />
rispetto al F. Cornia si distingue, innanzitutto, il Fosso Diavolo che si sviluppa con un<br />
andamento rettilineo prendendo poi il nome di Fosso Cosimo, nell’ultimo tratto dove, in<br />
epoca storica, attraversata la zona acquitrinosa della Padule Bottagone e Padule i Perelli<br />
Bassi raggiungeva lo sbocco a mare presso la Torre del Sale. Ancora, si , nella fascia della<br />
piana tra il Cornia ed il Fosso la Corniaccia, i minori Fosso Acquaiola, Fossetto n. 8, Fosso<br />
Botrangola, la Fossaccia ed il Fossetto, tra loro sostanzialmente paralleli e che raggiungono<br />
la costa incrociando il Fosso Cervia che si sviluppa lungo tutto il litorale, ad est rispetto a<br />
Torre del Sale (nel tratto precedente prende il nome di Fosso Tombolo).<br />
Infine, il F. Cornia, che presenta una evidente variazione dei caratteri, da quelli di tipo<br />
naturale con limitata divagazione dell’alveo, nel tratto della piana prima della Vecchia<br />
Aurelia, dove riceve il Fosso Riomerdancio, a quelli chiaramente derivanti dagli interventi di<br />
rettificazione e regimazione idraulica, con un asse rettilineo che si divide poi un due rami,<br />
quello della Fossa Cornia Vecchia, che prosegue verso sud in direzione di Piombino, e<br />
quello che mantiene il nome di F. Cornia e taglia verso est dando origine, in epoca storica,<br />
dopo la Bocca di Cornia, alla zona paludosa della fascia litoranea.<br />
Per quanto riguarda le trasformazioni intercorse rispetto all’epoca storica considerata, tolte<br />
quelle associate alla presenza delle cave nella zona collinare, per altro da sempre presenti<br />
PAGINA: 92: 98 2011 COD: 11V071
RELAZIONE PAESAGGISTICA<br />
come attività estrattiva fin dalle origini dello sfruttamento minerario dell’epoca etrusca,<br />
seppure con ovvie modifiche nel tempo delle modalità di lavorazione, si distingue quella<br />
relativa alla variazione della foce del Cornia. Tale foce è stata infatti spostata, con un<br />
prolungamento in forma di canale, direttamente sulla linea di costa a seguito e<br />
funzionalmente all’intervento di prosciugamento della gran parte della zona acquitrinosa di<br />
Ischia di Crociano e Padule Perelli, dove si è ricavato lo spazio per l’espansione della zona<br />
industriale di Piombino che ha consentito l’insediamento dello stabilimento siderurgico<br />
Lucchini – Dalmine, ed ancora si è ottenuta l’area dove è stata costruita la Centrale elettrica<br />
dell’Enel di Torre del Sale. Allo stesso modo è stata modificata la foce del Fosso Cornia<br />
Vecchia e del Fosso Allacciante, a seguito della realizzazione del nuovo porticciolo di “Terre<br />
rosse”, con un ridisegno della stessa linea di costa, tra il Porto Vecchio di Piombino ed il<br />
tratto iniziale del litorale dove, precedentemente, si trovava la Cassa di Colmata del Cornia.<br />
Ancora, si nota la modifica dell’ultimo tratto del Fosso Acquaviva e l’interruzione della<br />
continuità del canale di raccolta che si sviluppa lungo il litorale, formato dal Fosso Tombolo e<br />
Fosso Cervia.<br />
Nella zona di ubicazione dell’impianto non si notano variazioni morfologiche o idrografiche e<br />
si confermano i caratteri derivanti dalla giacitura pianeggiante dei terreni alluvionali e dalla<br />
complessa rete dei corsi d’acqua e delle scoline irrigue, i primi rappresentati dal Fosso<br />
Calda, Fosso Rocchio, Fiume Cornia, Fosso Diavolo e Fosso Acquaviva.<br />
4.3.5.2 Vegetazione ed uso agricolo del suolo<br />
L’analisi della vegetazione e dell’utilizzo del suolo, nel vasto ambito territoriale considerato,<br />
comprendente sia l’area della piana del Cornia all’interno della quale si prevede di realizzare<br />
l’impianto eolico, sia quella del promontorio di Piombino e dei rilievi collinari di Campiglia<br />
Marittima, è condotta ricostruendo, innanzitutto, la situazione rilevabile in storica.<br />
Nei primi anni del XX secolo, in base alla rilettura delle tavole IGM, si nota che la<br />
vegetazione, in tutta la zona pianeggiante, è confinata alle piccole macchie boschive a ceduo<br />
localizzate in coincidenza con i poggi isolati (Poggio al Lupo, Montegemoli, Poggio l’Aquilino,<br />
Poggio Giampiero) ed alle zone occupate dalle pinete, quella di Romigliano e quella di<br />
Torrenova, tra loro vicine e situate nella parte più a nord.ovest della piana. Ancora, si<br />
distingue la presenza, in corrispondenza del Golfo di Baratti e lungo tutto il litorale di<br />
Rimigliano, della vegetazione dunale e della pineta litoranea; la fascia costiera e del primo<br />
entroterra del Golfo di Follonica, invece, si caratterizza per la vasta estensione delle zone<br />
acquitrinose comprendenti una piccola ed isolata area ubicata a ridosso dell’ultimo tratto del<br />
F. Cornia e l’estesa porzione di territorio delimitata dall’Argine di Recinto e dalla vecchia<br />
strada della Base Geodetica, comprendente le località Casse di Colma del Cornia, Ischia di<br />
Crociano, Padule Bottagone e Padule i Perelli bassi e alti. Un’altra zona paludosa si trova,<br />
sempre in corrispondenza della fascia costiera, in località La Sterpaia, attorniata<br />
dall’omonima macchia formata anche da vegetazione arborea, porzione residuale del bosco<br />
che occupava parte della zona pianeggiante prima della bonifica idraulica e massa a coltura<br />
dei terreni. La copertura del suolo con formazioni estese a bosco, elemento distintivo del<br />
paesaggio, unitamente alla morfologia, si riscontra in tutta la zona del rilievo del promontorio<br />
di Piombino, come prevalente formazione a ceduo di latifoglie, ed ancora nella porzione del<br />
primo territorio collinare, a sud ed attorno all’abitato di Campiglia Marittima, in quest’ultimo<br />
caso come macchie a ceduo di minore dimensione, sempre associate alla presenza dei<br />
rilievi, tra loro separate per interposta presenza di appezzamenti ad ulivo ed in misura<br />
minore di campi a seminativo od a prato.<br />
Per quanto riguarda l’uso agricolo del suolo, sempre con riferimento al periodo di inizio ‘900,<br />
si distingue chiaramente l’ambito della pianura alluvionale da quello dei rilievi collinari e del<br />
promontorio di Piombino. Nel caso dei rilievi collinari predomina la presenza dell’uliveto, in<br />
combinazione, come già evidenziato, con le macchie a bosco, mentre minore è lo spazio<br />
occupato dalle zone a seminativo e/o prato e dagli appezzamenti a vigneto, gli ultimi di<br />
VERS: 01 2011 PAGINA: 93: 98
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
piccole dimensioni. Il promontorio di Piombino, come già osservato in netta prevalenza<br />
occupato dal bosco, si connota, nella parte meridionale, quella verso l’abitato di Piombino e<br />
la frazione di Poggetto, comprendente anche la conca del Fosso Salivoli, per la presenza<br />
delle aree agricole che si caratterizzano per l’articolazione a mosaico derivante<br />
dall’accostamento di appezzamenti ad uliveto e vigneto, di analoga dimensione, e di campi a<br />
seminativo o prato; si evidenzia la presenza, in corrispondenza del borgo di Populonia, sul<br />
versante che si affaccia verso il Golfo di Baratti, di una piccola area ad uliveto. La piana del<br />
Cornia si caratterizza per la prevalente conduzione a seminativo dei terreni, con una<br />
rilevabile differenza tra la fascia situata a ridosso delle colline e più in generale della zona<br />
che si estende a nord della linea ferroviaria, e la porzione meridionale della stessa pianura<br />
coltivata. Nel primo caso si osserva la maggiore presenza di vigneti, con appezzamenti<br />
spesso contigui e che configurano, in alcuni casi, come quello in corrispondenza<br />
dell’insediamento di <strong>Venturina</strong> e del Podere Casalpiano (tra il Fosso Diavolo ed il Fosso<br />
Acquaviva), aree continue ed estese. Nel secondo caso, viceversa, i vigneti sono presenti in<br />
misura minore, quasi sempre associati ai fabbricati rurali, tra i quali si nota il caso del Podere<br />
Poggio all’Agnello.<br />
Il confronto tra la situazione descritta e quella odierna consente di confermare la richiamata<br />
distinzione tra i diversi ambiti connotati da una prevalenza della copertura boschiva, da una<br />
combinazione di aree seminaturali e di aree agricole a legnose agrarie ed infine dalla quasi<br />
esclusiva messa a coltura a seminativo. Per quanto riguarda la presenza della vegetazione<br />
naturale, la principale trasformazione riguarda la scomparsa o riduzione della zona<br />
acquitrinosa lungo la fascia costiera e del primo entroterra e quindi la perdita di una parte<br />
consistente delle aree connotate dalle associazioni tipiche degli ambienti umidi e paludosi; si<br />
è conservata la zona della Padule Orti, unico saliconeto rimasto a rappresentare i caratteri<br />
del paesaggio antecedenti alle opere di bonifica idraulica, ed alcune aree, non ancora<br />
trasformate, situate all’interno del perimetro della zona di espansione industriale di Piombino.<br />
All’opposto, si nota il recupero del bosco di La Sterpaia, interessato da una lottizzazione<br />
residenziale, e la conservazione della stretta fascia di vegetazione lungo il litorale del Golfo<br />
di Follonica e la costa di Baratti e San Vincenzo dove si riscontra, per altro, la presenza di<br />
una striscia di bosco litoraneo nel tratto a cavallo del Poggio S. Leonardo. Per quanto<br />
riguarda le aree agricole si evidenzia la perdita delle zone a vigneto presenti attorno al<br />
vecchio borgo di <strong>Venturina</strong>, determinata dalla significativa espansione, residenziale e<br />
produttivo commerciale, di tale insediamento, e la drastica riduzione degli appezzamenti a<br />
vigneto in tutta la porzione meridionale della piana del Cornia, accompagnata da una<br />
contrazione della loro presenza anche nella parte a nord della linea ferroviaria, spesso con<br />
trasformazione a seminativo arborato.<br />
Più in dettaglio, considerando la porzione di territorio che include il sito di ubicazione<br />
dell’impianto eolico ed una estesa zona circostante, si coglie la trasformazione dei vigneti a<br />
seminativo, particolarmente significativa nel caso della zona di Podere Casalpiano, e la<br />
secca perdita degli stessi per urbanizzazione, in particolare quella già richiamata riguardante<br />
l’abitato di <strong>Venturina</strong>, non compensata dai nuovi impianti che riguardano la fascia di territorio<br />
più vicina ai rilievi collinari, sia a nord-ovest che a nord-est di tale frazione. Allo stesso modo<br />
si rileva la trasformazione di alcune aree agricole della fascia costiera, a sud della strada<br />
della Base Geodetica, per interventi legati alla realizzazione di insediamenti, residenziali di<br />
seconde case e turistico ricettivi (in forma anche di villaggi), oltre ovviamente al già citato<br />
insediamento produttivo della Dalmine; analoga situazione riguarda l’area a seminativi<br />
coinvolta dall’urbanizzazione del nuovo insediamento di Montegemoli e l’area dei cosiddetti<br />
Orti Urbani, realizzata con materiali precari ed oggetto di condono urbanistico edilizio. Per<br />
quanto riguarda la zona collinare si riscontra una riduzione della macchia boschiva, a favore<br />
dell’uliveto, e si nota la presenza delle cave.<br />
Con riferimento al sito di ubicazione dell’impianto di progetto, le modifiche, rispetto al periodo<br />
storico considerato, riguardano la perdita di alcuni appezzamenti a vigneto, quasi sempre<br />
ubicati in corrispondenza di fabbricati rurali, trasformati in seminativi e viceversa la saltuaria<br />
PAGINA: 94: 98 2011 COD: 11V071
RELAZIONE PAESAGGISTICA<br />
modifica in senso inverso, con nuovo impianto di uliveto o vigneto, relativa a pochi casi e per<br />
estensioni contenute. In generale si constata la persistenza della conduzione agricola dei<br />
terreni, con predominanza del seminativo, e la totale assenza di aree con vegetazione<br />
naturale o seminaturale.<br />
4.3.5.3 Sistema insediativo e viario<br />
Per quanto riguarda il sistema insediativo ed infrastrutturale, con riferimento alla soglia<br />
storica considerata, sono individuabili, ad una scala territoriale estesa, quali centri ordinatori,<br />
l’abitato di Campiglia Marittima, collocato in una posizione, sulle prime colline, favorevole al<br />
controllo della sottostante piana, ed ovviamente il centro di Piombino, sulla costa, con le sue<br />
espansioni verso l’entroterra che includono l’aggregato residenziale di Poggetto. A questi si<br />
aggiungono gli insediamenti minori del borgo di Populonia, sul poggio che domina il Golfo di<br />
Baratti, e della frazione di <strong>Venturina</strong>, posizionata a cavallo della Vecchia Aurelia. Il sistema<br />
viario principale comprende la storica via dei Cavalleggeri, che si sviluppa lungo il litorale di<br />
San Vincenzo e Rimigliano, raggiungendo il borgo di Populonia ed il centro di Piombino, la<br />
Vecchia Aurelia, che taglia in diagonale la piana del Cornia, ed ancora la strada della Val di<br />
Cornia, che si attesta al piede delle colline, e la strada che sale a Campiglia Marittima,<br />
spingendosi poi all’interno delle zona delle colline metallifere; si segnala anche la linea<br />
ferroviaria tirrenica e la deviazione che la collega alla zona portuale di Piombino. Il territorio è<br />
inoltre interessato dalla diffusa presenza di fabbricati rurali, distribuiti in forma sparsa in tutta<br />
la pianura, con situazioni di maggiore aggregazione che danno origine a dei complessi rurali;<br />
in quest’ultimo caso si possono distinguere i casi del Podere Poggio all’Agnello, di La<br />
Sdriscia, di Palmentello, di Lamiere, di Banditelle. Lungo la costa si nota che, tolto Piombino<br />
e le poche case di Baratti, non sono presenti insediamenti ed allo stesso modo i singoli<br />
fabbricati sono limitati a pochi casi che comprendono la Torre del Sale, la Villa Barone De<br />
Stefano e la C. Cavalleggeri.<br />
Le principali trasformazioni del sistema insediativo, rispetto al quadro precedentemente<br />
richiamato, sono da ricondurre alla già citata espansione residenziale e produttiva<br />
commerciale di <strong>Venturina</strong>, che ha interessato la zona della piana, incuneandosi all’interno<br />
dell’area agricola, seguendo sia l’asse della Vecchia Aurelia, sia quello del Fiume Cornia, e<br />
di Piombino, che ha riguardato la fascia costiera, in particolare con l’insediamento produttivo<br />
della Dalmine e la realizzazione del nuovo porto turistico. A queste principali urbanizzazioni<br />
si aggiungono altri episodi, riconducibili alla edificazione della Centrale dell’Enel di Torre del<br />
Sale, alla realizzazione degli insediamenti ricettivi extra alberghieri lungo la costa del Golfo di<br />
Follonica, alle espansioni residenziali di Fiorentina e Montegemoli, all’edificazione sparsa<br />
degli Orti urbani che ha riguardato la fascia a cavallo della SP 23, nel tratto tra la periferia<br />
nord di Piombino e la località dove si trova il Podere S. Albina. In generale si deve anche<br />
considerare l’edificazione di nuovi edifici residenziali singoli ubicati in forma sparsa nel<br />
territorio agricolo. Per quanto riguarda le infrastrutture, le variazioni più significative sono da<br />
ricondurre alla realizzazione della Variante dell’Aurelia ed alla messa in opera dei numerosi<br />
elettrodotti che attraversano la zona della piana del Cornia, in uscita dalla citata Centrale od<br />
in ingresso alla zona residenziale, industriale e portuale commerciale di Piombino. Si<br />
osserva, in ultimo, la chiusura dell’asse viario della Base Geodetica (SP40), conseguente<br />
all’intervento di riduzione della zona paludosa e di insediamento della centrale di Torre del<br />
Sale.<br />
Per quanto riguarda l’area di ubicazione dell’impianto le principali trasformazioni sono<br />
riconducibili alla realizzazione delle infrastrutture, la variante dell’Aurelia e gli elettrodotti,<br />
mentre l’espansione urbana non ha una incidenza diretta, pur rilevando che la zona<br />
meridionale di espansione di <strong>Venturina</strong> si colloca in posizione intermedia ed in parte separa i<br />
due ambiti di ubicazione degli aerogeneratori di progetto. In merito al sistema insediativo non<br />
si riscontrano, quindi, significative differenze e resta confermato il carattere rurale<br />
determinato dalla presenza di fabbricati sparsi, nella gran parte dei casi di origine storica,<br />
alcuni risalenti ad un epoca anteriore al 1830.<br />
VERS: 01 2011 PAGINA: 95: 98
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
4.3.6 Gli elementi del paesaggio<br />
Per quanto riguarda la porzione di territorio circostante alle opere di progetto, sulla base<br />
della precedente analisi degli aspetti morfologici, idrografici, vegetazionali e di uso agricolo<br />
del suolo, insediativi e di infrastrutturazione viaria, e delle persistenze o trasformazioni del<br />
paesaggio, possono essere in sintesi riconosciuti i seguenti elementi strutturali o di<br />
connotazione, positiva o negativa, dello stesso paesaggio.<br />
In primo luogo si evidenzia l’elemento morfologico, da associare alla giacitura orizzontale<br />
della pianura alluvionale del Cornia. A tale aspetto si correla la presenza dei corsi d’acqua<br />
superficiali che sono stati regimati, a seguito dei lavori storici della bonifica idraulica, ed<br />
anche la fitta rete delle scoline irrigue che, con il loro disegno, definiscono la matrice<br />
originaria del paesaggio.<br />
Il dominante utilizzo agricolo dei terreni, con una trasformazione, nell’ultimo periodo, che<br />
segna la riduzione della già scarsa presenza degli appezzamenti a vigneto, a favore della<br />
conversione a seminativi, che rappresentano la conduzione prevalente dei terreni e da cui<br />
deriva la semplificazione del paesaggio rurale, costituisce altro elemento distintivo.<br />
Panoramiche rappresentative dei caratteri del paesaggio della Piana del Cornia<br />
In ultimo, i caratteri del paesaggio, sono riconducibili alla diffusa presenza dei fabbricati rurali<br />
e residenziali, dove a quelli storici si affiancano le costruzioni recenti di analoga tipologia ed<br />
ancora, distinguibili come detrattori del paesaggio, i numerosi elettrodotti che attraversano,<br />
nelle diverse direzioni, l’area della piana.<br />
4.3.7 Effetti sugli elementi del paesaggio in fase di cantiere<br />
Gli impatti in fase di cantiere sono presi in considerazione assumendo quale riferimento la<br />
presenza, nell’area dell’impianto eolico ed in particolare in quella circostante alle opere di<br />
progetto, degli elementi del paesaggio, come individuati al precedente paragrafo.<br />
Per quanto riguarda la morfologia, gli interventi ed i manufatti, inclusi quelli che riguardano<br />
direttamente le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, non determinano alcuna variazione<br />
delle caratteristiche attuali, dato che non si prevedono significative movimentazioni di terra<br />
per l’allestimento delle piazzole e l’adeguamento dei nuovi tratti di strada, essendo le<br />
PAGINA: 96: 98 2011 COD: 11V071
RELAZIONE PAESAGGISTICA<br />
superfici interessate dai lavori già pianeggianti. In merito alla posa del cavidotto d’impianto, si<br />
prevede, ovviamente, il reinterro, al termine dei lavori, e quindi il ripristino del piano di<br />
campagna.<br />
Per quanto attiene al sistema dei corsi d’acqua, come già evidenziato nel precedente<br />
paragrafo riguardante i beni paesaggistici vincolati, non si prevede di intervenire sulle aste<br />
principali, apportando modifiche dei caratteri attuali delle stesse; nella sostanza, gli<br />
interventi, che interessano il Fiume Cornia ed i principali fossi sottoposti a vincolo<br />
paesaggistico, sono riconducibili al passaggio del cavidotto d’impianto. In quest’ultimo caso,<br />
per le soluzioni adottate, in appoggio a strutture già esistenti (ponti) o con una collocazione<br />
interrata ed in sottopasso dell’alveo, non si determina alcuna ricaduta su tali elementi del<br />
paesaggio; tale considerazione vale anche per il Fosso Diavolo, tenendo conto della<br />
possibilità di adottare, anche per questo, la tecnica della perforazione teleguidata al posto<br />
della prospettata soluzione in scavalcamento esterno. In merito al reticolo delle scoline vale<br />
quanto già evidenziato nel precedente paragrafo, relativo ai beni culturali e paesaggistici, nel<br />
senso che gli interventi previsti, per loro collocazione e modalità esecutive, non prefigurano<br />
modifiche strutturali di tale sistema, il cui disegno ordinatore del paesaggio resta<br />
sostanzialmente invariato.<br />
I terreni ad uso agricolo, evidenziato che nessuno degli interventi previsti ricade in<br />
appezzamenti a vigneto od uliveto, in tale fase sono coinvolti per l’occupazione di alcuni<br />
campi a seminativo, all’interno dei quali si allestiranno le piazzole degli aerogeneratori e<br />
saranno posati i plinti di fondazione degli stessi, si effettueranno gli adeguamento della<br />
viabilità esistente o saranno aperti i nuovi tratti della viabilità di accesso alle piazzole ed<br />
infine sarà posato il cavidotto interrato ed installata la stazione di utenza (in area non a<br />
vincolo paesaggistico). Le superfici coinvolte, complessivamente significative, se rapportate<br />
all’estensione dei seminativi presenti nella Piana del Cornia, elemento che connota in<br />
maggiore misura tale ambito di paesaggio, hanno una incidenza irrilevante e tale da non<br />
comportare modifiche strutturali o perdita di tale elemento del paesaggio. Tali interventi,<br />
inoltre, per ubicazione, nella maggior parte dei casi si inseriscono all’interno dei campi senza<br />
determinare significative rotture di continuità o variazioni della matrice del paesaggio<br />
derivante dal disegno particellare e della rete delle scoline; in particolare, la nuova viabilità,<br />
salvo rare eccezioni, segue l’orientamento delle particelle e si attesta sul perimetro esterno<br />
delle stesse. Allo stesso modo, le opere relative allo scavo per la posa del cavidotto interrato,<br />
con tracciato che segue quello della viabilità, tolta l’occupazione temporanea di suolo<br />
attualmente coltivato, non determinano, a seguito del previsto reinterro, una modiifca<br />
strutturale e permanente. In maggiore dettaglio, con riferimento alle fasce contermini ai corsi<br />
d’acqua, a vincolo paesaggistico, tolto il caso dell’occupazione di una stretta fascia di<br />
territorio, per il previsto allargamento di un breve tratto della viabilità esistente (strada degli<br />
Affitti e strada presso il P. Trafossi), non si prevedono occupazioni permanenti delle superfici<br />
agricole.<br />
Per quanto riguarda i fabbricati rurali, sottolineato che nessuno è direttamente coinvolto dalle<br />
opere di progetto e che pertanto non si prevedono modifiche dei caratteri architettonici o dei<br />
valori di testimonianza storica, si rimanda a quanto già osservato nel precedente paragrafo<br />
relativo ai beni culturali.<br />
4.3.8 Effetti sugli elementi del paesaggio in fase di esercizio<br />
Nel periodo di funzionamento dell’impianto eolico le trasformazioni, con riferimento alla<br />
configurazione del paesaggio, sono quelle già descritte per la fase di cantiere non essendo<br />
previsti nuovi interventi od installazione di altri manufatti.<br />
Le ricadute permanenti sono sostanzialmente riconducibili, per quanto riguarda i beni<br />
paesaggistici vincolati, alla modifica relativa all’adeguamento della viabilità esistente, nel<br />
primo tratto della strada secondaria che consente l’accesso all’aerogeneratore 47 ed in un<br />
breve tratto della strada degli Affitti, in corrispondenza dell’incrocio con la SP 40.<br />
VERS: 01 2011 PAGINA: 97: 98
CAMPO EOLICO VENTURINA<br />
Per quanto riguarda il cavidotto d’impianto, la soluzione interrata, da associare ai previstini<br />
ripristini, e quella di appoggio ai manufatti esistenti per l’attraversamento dei corsi d’acqua,<br />
consente di mantenere invariati i caratteri paesaggistici attuali dei luoghi coinvolti. Analoga<br />
considerazione vale per la superficie occupata dalla piazzola di cantiere dell’aerogeneratore<br />
82, stante il previsto recupero del suolo e restituzione all’uso agricolo dei terreni.<br />
PAGINA: 98: 98 2011 COD: 11V071