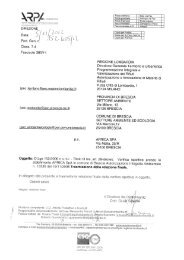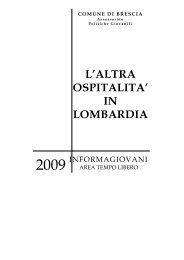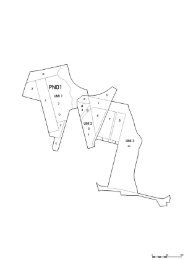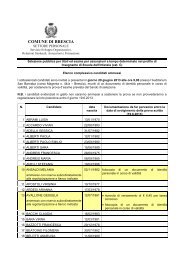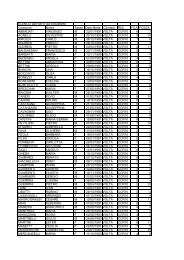VIA MARTINENGO DA BARCO - Comune di Brescia
VIA MARTINENGO DA BARCO - Comune di Brescia
VIA MARTINENGO DA BARCO - Comune di Brescia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>VIA</strong> <strong>MARTINENGO</strong> <strong>DA</strong> <strong>BARCO</strong><br />
1. Pinacoteca Tosio Martinengo<br />
già palazzo Martinengo da Barco, n.1<br />
2. casa <strong>di</strong> sant’Angela già Moro, n.4<br />
Toponomastica e cenni storici<br />
Via Martinengo da Barco è preceduta dalla piazza de<strong>di</strong>cata<br />
al pittore bresciano Alessandro Bonvicino detto il<br />
Moretto. Tale piazza fu aperta nel 1898 con l’inaugurazione<br />
del monumento de<strong>di</strong>cato all’omonimo pittore,<br />
opera <strong>di</strong> Domenico Ghidoni. Fino al 1892 infatti al posto<br />
<strong>di</strong> questo spazio aperto, sorgevano numerose casette<br />
e lungo quella che oggi è la facciata d’ingresso del palazzo<br />
della Pinacoteca, correva il vicolo cieco detto dello<br />
Sguazzo. Giungendovi oggi si viene accolti dalla statua raffigurante Moretto,<br />
in pie<strong>di</strong> su un alto basamento con in mano tavolozza e pennelli, gli strumenti della<br />
sua arte. Sui gradoni del basamento è seduta una figura femminile che simboleggia<br />
la pittura mistica, con un volume aperto sulle ginocchia. Per questa scultura,<br />
nel 1893 Ghidoni aveva presentato all’Ateneo un bozzetto che però venne<br />
rifiutato perché troppo innovativo. Venne allora indetto un concorso nazionale e<br />
lo scultore presentò un nuovo bozzetto. Il 26 agosto 1894 l’Ateneo gli commissionò<br />
l’esecuzione del monumento, che venne inaugurato il 3 settembre 1898.<br />
Dalla piazza prende vita via Martinengo da Barco, che si collega a via Alessandro<br />
Monti, ed è generalmente conosciuta per la presenza <strong>di</strong> palazzo Martinengo<br />
da Barco, attuale sede della civica Pinacoteca Tosio Martinengo. Sul lato est del<br />
tracciato, fino al 1922 scorreva scoperto il canale Molin del Brolo che in questa<br />
zona faceva un notevole salto mettendo in moto una ruota idraulica. L’andamento<br />
curvilineo della via è dato proprio dallo scorrere <strong>di</strong> questo canale. Sul lato opposto<br />
invece trova sede, al civico 2, l’istituto “Figlie del Sacro Cuore <strong>di</strong> Gesù”,<br />
collegio universitario, e al civico 4 la Casa <strong>di</strong> sant’Angela, includendo parte dei<br />
chiostri dell’ex convento <strong>di</strong> sant’Afra, oggi sant’Angela Merici. Fra la casa <strong>di</strong><br />
sant’Angela e il prospiciente palazzo della Pinacoteca esisteva fino al 1870 un cavalcavia<br />
che attraversava la strada mettendo in comunicazione le due <strong>di</strong>more della<br />
famiglia Martinengo.<br />
120
Passeggiando per via Martinengo da Barco<br />
La facciata della Pinacoteca Tosio Martinengo (1) su piazza Moretto è un rifacimento<br />
moderno, ad opera dell’architetto bresciano Antonio Tagliaferri, in uniformità<br />
con il seicentesco prospetto su via Martinengo. Come si è detto, fino al<br />
1892 la piazza non esisteva e la facciata del palazzo su questo lato era un rustico<br />
muro che correva lungo il vicolo chiuso. Il grande palazzo Martinengo da Barco<br />
fu costruito su precedenti e<strong>di</strong>fici trecenteschi ritrovati in alcuni ambienti a piano<br />
terra e ristrutturato nel 1680 circa da un grande mecenate, il conte Francesco Leopardo<br />
che fece eseguire importanti lavori tra cui la facciata meri<strong>di</strong>onale, portando<br />
così a compimento la sua bella <strong>di</strong>mora. Sembra che ad<strong>di</strong>rittura lo stesso conte<br />
Francesco Leopardo avesse dato i <strong>di</strong>segni delle mo<strong>di</strong>fiche da apportare al palazzo<br />
e della nuova facciata,<br />
dando prova del suo buon gusto.<br />
Questa facciata è sud<strong>di</strong>visa in<br />
tre corpi <strong>di</strong>stinti: i due più esterni,<br />
un tempo destinati ad abitazione,<br />
si presentano massicci,<br />
con alte finestre al piano nobile,<br />
coronate da un frontone curvilineo<br />
in cui è inserito un mascherone<br />
dalle bizzarre smorfie. I<br />
due corpi sono uniti fra loro dall’ingresso,<br />
costituito da un alto<br />
muro sormontato da balaustra<br />
interrotto al centro dal portale<br />
coronato dalle statue <strong>di</strong> Marte e<br />
Pallade opere <strong>di</strong> Andrea Paracca.<br />
Numerosi ambienti del pianterreno<br />
e del piano nobile furono<br />
decorati con prospettive architettoniche<br />
o motivi vegetali. Lavori<br />
<strong>di</strong> ampliamento e decorativi<br />
vennero continuati anche durante<br />
il XVIII secolo: interes-<br />
sante è la decorazione del soffitto<br />
dello scalone con l’apoteosi<br />
121<br />
Domenico Ghidoni,<br />
Moretto e la pittura mistica, 1898
della famiglia Martinengo. Nei primi decenni dell’Ottocento vennero interamente<br />
decorate tre sale, con motivi pompeiani ed egizi attribuiti al Teosa.<br />
L’antica abitazione su cui sorge questo palazzo doveva essere <strong>di</strong> proprietà della<br />
famiglia Fisogni, che alla fine del Seicento non avendo ere<strong>di</strong> vendette ai vicini<br />
conti Martinengo da Barco, già proprietari della casa <strong>di</strong> fronte. Le vicende ottocentesche<br />
sono segnate dalla nobile figura <strong>di</strong> Francesco Leopardo. Ultimo erede<br />
della famiglia Martinengo, rivestì importanti cariche politiche: ministro del governo<br />
provvisorio <strong>di</strong> Manin e Tommaseo, presidente del consiglio provinciale a<br />
Venezia, senatore del regno, ma anche grande cultore delle lettere e delle arti,<br />
come la maggior parte dei membri della sua famiglia. Furono infatti i suoi predecessori,<br />
almeno due secoli prima <strong>di</strong> lui, ad iniziare la collezione <strong>di</strong> opere d’arte,<br />
libri, stampe, strumenti scientifici, medaglie e monete <strong>di</strong> ogni genere, che lui stesso<br />
lasciò alla città con l’intero palazzo. Proprio questo palazzo, <strong>di</strong>ventato proprietà<br />
del <strong>Comune</strong>, fu subito a<strong>di</strong>bito a pubblica Pinacoteca. Negli ultimi decenni<br />
dell’800 infatti la quantità <strong>di</strong> opere esposte nella galleria <strong>di</strong> palazzo Tosio era così<br />
cresciuta che mancava lo spazio materiale per la loro esposizione e valorizzazione.<br />
Cresceva la necessità <strong>di</strong> trasferire parte del patrimonio in una nuova sede, più<br />
spaziosa e luminosa. A questo scopo venne scelto il palazzo che proprio in que-<br />
Casa <strong>di</strong> sant’Angela: sala con affreschi settecenteschi a<strong>di</strong>bita a cappella<br />
122
gli stessi anni veniva donato alla città <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> dal nobile Francesco Leopardo<br />
V Martinengo da Barco.<br />
Nel 1888 vennero trasferite le stampe e i primi <strong>di</strong>pinti della collezione Tosio, a<br />
cui si unirono opere provenienti da chiese, alcuni acquisti del municipio e le opere<br />
<strong>di</strong> alcuni nuovi legati: Richiedei (1869-1870), Lorenzetti (1881), Vergine Pernici<br />
(1882), Renica (1883). Così quasi contemporaneamente si apriva in palazzo<br />
Martinengo la Pinacoteca <strong>di</strong> arte antica e in palazzo Tosio la Pinacoteca <strong>di</strong> arte<br />
moderna (cfr. approfon<strong>di</strong>mento, p.).<br />
Al civico 4, proprio <strong>di</strong> fronte al palazzo della Pinacoteca, è la casa <strong>di</strong> sant’Angela<br />
(2), <strong>di</strong>mora che come si <strong>di</strong>ceva era <strong>di</strong> proprietà della famiglia Martinengo da<br />
Barco. Questi ultimi avevano fatto costruire un cavalcavia per renderla accessibile<br />
dal palazzo prospiciente. Quando però il nobile Giulio Moro acquistò la casa<br />
nel 1870, demolì il cavalcavia e fece risistemare la facciata. All’inizio del Novecento<br />
la famiglia Moro si estinse e l’ultima erede lasciò la casa alla Compagnia<br />
<strong>di</strong> sant’Angela. La struttura del piccolo palazzo è secentesca, il modesto portale<br />
è contornato da larghe bugne e il cornicione è decorato in stucco. Una sala, oggi<br />
a<strong>di</strong>bita a cappella, è affrescata in pieno stile settecentesco e presenta le pareti decorate<br />
con finte prospettive, sormontate da balaustra e coronate da finte architetture.<br />
La civica Pinacoteca <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong><br />
Orario <strong>di</strong> apertura<br />
Estate: 10-13; 14-18 - Inverno: 9.30-13; 14.30-17<br />
Chiuso il lunedì; per informazioni consultare il sito www.bresciamusei.com<br />
La doppia intitolazione Tosio e Martinengo non in<strong>di</strong>ca un legame <strong>di</strong> tipo familiare,<br />
ma semplicemente l’omaggio ai due principali collezionisti ottocenteschi<br />
che hanno contribuito all’apertura della Pinacoteca citta<strong>di</strong>na donando le proprie<br />
raccolte al <strong>Comune</strong>: Paolo Tosio e Francesco Leopardo Martinengo da Barco. A<br />
questi due nuclei principali si aggiunsero le raccolte <strong>di</strong> illustri personaggi, che<br />
sulle orme dei predecessori, hanno legato le collezioni alla città e molte opere<br />
provenienti da chiese, conventi e monasteri soppressi.<br />
Le <strong>di</strong>verse donazioni hanno reso la collezione della Pinacoteca particolarmente<br />
ricca ed eterogenea. Sono ben rappresentati <strong>di</strong>versi generi artistici: dall’arte sacra<br />
e devozionale, al paesaggio e la pittura <strong>di</strong> genere. I recenti allestimenti hanno<br />
quasi totalmente sostituito la vecchia modalità <strong>di</strong> esposizione secondo la tra<strong>di</strong>zione<br />
della quadreria, ovvero opere <strong>di</strong>sposte su più livelli dal pavimento al<br />
soffitto, con nuovi criteri <strong>di</strong> esposizione ragionata, che mettono in rilievo, attra-<br />
123
verso filoni tematici, la varietà <strong>di</strong> questo patrimonio e la personalità dei vari collezionisti.<br />
Oggi viene dato spazio alla figura del conte Tosio, facendo emergere,<br />
attraverso l’esposizione <strong>di</strong> alcune opere della sua raccolta, una personalità dal<br />
gusto raffinato. La figura <strong>di</strong> Tosio rispecchia fedelmente quella del buon collezionista,<br />
che riesce ad ottenere al momento giusto le migliori opere, precorrendo<br />
i tempi e commissionando <strong>di</strong>pinti ad artisti non ancora affermati ma che presto<br />
sarebbero <strong>di</strong>ventati gran<strong>di</strong> nomi dell’arte ottocentesca.<br />
Aprono l’esposizione due tra i pezzi più rappresentativi della collezione Tosio:<br />
l’Angelo e il Cristo Redentore, opere del celebre Raffaello Sanzio, cui fanno seguito<br />
altri <strong>di</strong>pinti dai lui acquistati e firmati da gran<strong>di</strong> nomi come Lorenzo Lotto,<br />
Giovanni Battista Moroni, Andrea Solario, Moretto per passare alla sezione<br />
de<strong>di</strong>cata alla pittura bresciana del Cinquecento dal Foppa al Moretto, in cui viene<br />
documentata l’arte bresciana del Rinascimento, percorrendo attraverso il<br />
tema sacro gli esor<strong>di</strong> e la maturità <strong>di</strong> due gran<strong>di</strong> artisti come Moretto e Romanino,<br />
messi a confronto con opere illustri <strong>di</strong> Foppa, Ferramola e Savoldo.<br />
In questa esposizione largo<br />
spazio è stato dato al pittore<br />
milanese <strong>di</strong> nascita e bresciano<br />
d’adozione Giacomo<br />
Ceruti meglio conosciuto<br />
con il soprannome <strong>di</strong> Pitochetto,<br />
pittore settecentesco<br />
particolarmente legato alla<br />
pittura <strong>di</strong> genere e ai temi<br />
pauperistici a sfondo sociale.<br />
Chiude il percorso<br />
un’ampia sezione de<strong>di</strong>cata<br />
all’arte del Seicento nelle<br />
sue varie forme e sfaccettature:<br />
la pittura naturalistica,<br />
il paesaggio, la pittura devozionale,<br />
il ritratto.<br />
Questo tipo <strong>di</strong> esposizione<br />
non esaurisce naturalmente<br />
il grande patrimonio che la<br />
Pinacoteca possiede, ma<br />
consente una lettura approfon<strong>di</strong>ta<br />
<strong>di</strong> alcune opere con<br />
l’auspicio, attraverso nuovi<br />
filoni e nuovi allestimenti,<br />
<strong>di</strong> venire a conoscenza del<br />
suo intero ricco patrimonio.<br />
124<br />
Raffaello, Cristo bene<strong>di</strong>cente,<br />
olio su tavola, 1505 – 1506