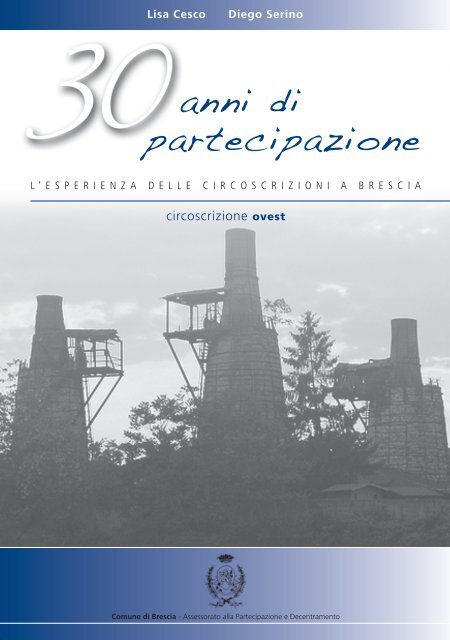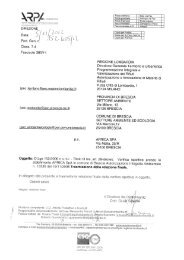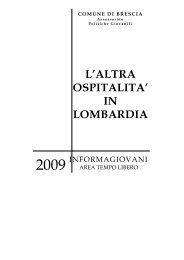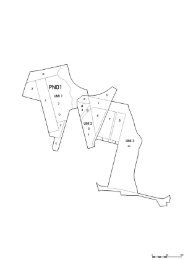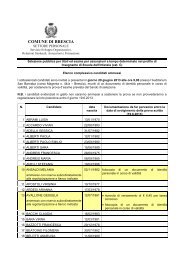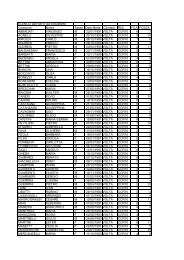30 anni di partecipazione Circoscrizione Ovest - Comune di Brescia
30 anni di partecipazione Circoscrizione Ovest - Comune di Brescia
30 anni di partecipazione Circoscrizione Ovest - Comune di Brescia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Lisa Cesco Diego Serino<br />
<strong>anni</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>partecipazione</strong><br />
L’ESPERIENZA DELLE CIRCOSCRIZIONI A BRESCIA<br />
circoscrizione ovest<br />
<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> - Assessorato alla Partecipazione e Decentramento
Lisa Cesco è autrice della storia dei quartieri Urago Mella, Chiusure e Villaggio Ba<strong>di</strong>a, del capitolo<br />
secondo “A spasso per la <strong>Ovest</strong>”, delle interviste a Maria Cipriano, Valerio Lanzini e Angelo Borboni.<br />
Diego Serino è autore della storia dei quartieri Fiumicello, Primo Maggio e Villaggio Violino, del<br />
capitolo terzo “Alle origini del decentramento”, e delle interviste a Alberto Martinuz, Francesco<br />
Maltempi e Mario Setti<br />
In copertina:<br />
Le fornaci <strong>di</strong> Ponte Crotte
Lisa Cesco Diego Serino<br />
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE<br />
l’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
CIRCOSCRIZIONE OVEST
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
L’Assessorato alla Partecipazione e Decentramento del<br />
<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> ha ritenuto opportuno promuovere una<br />
pubblicazione che ripercorra la storia del decentramento<br />
amministrativo nella nostra città, dalle origini fino alla<br />
recente riforma che ne <strong>di</strong>segna una nuova identità formale<br />
e sostanziale, in occasione del trentennale <strong>di</strong> fondazione<br />
delle Circoscrizioni in forma istituzionale.<br />
I testi presenteranno in forma monografica, snella ed<br />
essenziale, le cinque attuali circoscrizioni del sistema<br />
decentrato bresciano, rilevando come le stesse abbiamo piano piano preso corpo da una<br />
spinta nata dal basso, dall’esigenza spontanea dei citta<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> quartiere <strong>di</strong> aggregarsi in<br />
Comitati per con<strong>di</strong>videre un’esperienza <strong>di</strong> <strong>partecipazione</strong> nella vita degli stessi quartieri,<br />
nella connotazione urbanistica e nelle iniziative sociali e aggregative. Il racconto vuole<br />
quin<strong>di</strong> anche ripercorrere l’esperienza dei primi consigli <strong>di</strong> quartiere e delle persone che<br />
ne sono state fautrici e protagoniste, riportando la testimonianza dei singoli soggetti che<br />
hanno vissuto e determinato l’esperienza della <strong>partecipazione</strong> attiva e spontanea <strong>di</strong> quegli<br />
<strong>anni</strong>.<br />
Il quadro sulle circoscrizioni si completa in un alternarsi fra storia politica dei consigli<br />
circoscrizionali, che comprende anche la menzione dei Presidenti, con un loro profilo<br />
biografico e il resoconto della loro esperienza amministrativa, e una breve storia del<br />
territorio, dei quartieri e della loro trasformazione urbanistica e sociale, nell’elencazione<br />
dei luoghi <strong>di</strong> rappresentanza storica e <strong>di</strong> aggregazione sociale, testimonianza <strong>di</strong> lente<br />
trasformazioni e graduali cambiamenti che ne hanno determinato l’attuale assetto.<br />
La recente riforma, che ha ri<strong>di</strong>segnato i confini circoscrizionali, ha portato come<br />
conseguenza l’avvio <strong>di</strong> un ripensamento complessivo sul significato del decentramento,<br />
configurandosi la circoscrizione sempre più come ente territoriale multifunzionale, luogo<br />
<strong>di</strong> rappresentanza e consultazione dei quartieri, ma anche luogo <strong>di</strong> erogazione <strong>di</strong> servizi.<br />
Sentiti ringraziamenti vanno a tutti coloro che hanno collaborato all’elaborazione <strong>di</strong><br />
questo breve trattato storico sulle circoscrizioni, in particolare agli autori che nei mesi<br />
scorsi hanno effettuato un importante lavoro <strong>di</strong> ricerca sulla nascita, la crescita, la<br />
trasformazione e l’evoluzione nel tempo del decentramento e della <strong>partecipazione</strong> a <strong>Brescia</strong>.<br />
Il Vicesindaco<br />
Assessore alla Partecipazione e Decentramento<br />
Fabio RolFi<br />
4
I SALUTI<br />
Sono lieto <strong>di</strong> presentare agli abitanti della <strong>Circoscrizione</strong><br />
<strong>Ovest</strong> questa particolare pubblicazione che, intervallando<br />
notizie storiche ad interessanti acca<strong>di</strong>menti politicosociali,<br />
ci fa entrare nel vivo <strong>di</strong> quella che dovrebbe essere<br />
la <strong>di</strong>mensione partecipativa <strong>di</strong> una “parte” importante<br />
della nostra Città.<br />
Tanto è accaduto al <strong>di</strong> qua e al <strong>di</strong> là della storica “Via<br />
Milano” che ha visto nascere nelle sue imme<strong>di</strong>ate<br />
a<strong>di</strong>acenze gran<strong>di</strong> quartieri ed estesi villaggi <strong>di</strong> citta<strong>di</strong>ni che hanno contribuito ad<br />
arricchire economicamente e umanamente il patrimonio sociale <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>.<br />
E’ giusto pertanto, a trent’<strong>anni</strong> dalla nascita delle Circoscrizioni, fare per i bresciani il<br />
punto della situazione riguardo gli aspetti del tessuto sociale e nel quale essi hanno<br />
operato e nel quale continueranno ad operare.<br />
Sono certo che questo testo, ricco <strong>di</strong> curiosità nonché <strong>di</strong> utili informazioni sulle realtà<br />
associative operanti sul territorio della <strong>Ovest</strong>, sia da stimolo per un rafforzamento della<br />
forma partecipativa tanto incoraggiata anche dall’attuale Amministrazione comunale.<br />
Un particolare e caloroso saluto a tutti gli abitanti della <strong>Ovest</strong> dal Vostro Presidente.<br />
5<br />
Il Presidente<br />
della circoscrizione <strong>Ovest</strong><br />
Mattia MaRgaRoli
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
23<br />
25<br />
CIRCOSCRIZIONE<br />
NORD<br />
Mappa delle Circoscrizioni della città <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong><br />
5<br />
CIRCOSCRIZIONE OVEST<br />
20<br />
7<br />
26<br />
CIRCOSCRIZIONE SUD<br />
2 - Borgo Trento<br />
11 - Mompiano<br />
15 - Villaggio Prealpino<br />
17 - San Bartolomeo<br />
22 - Casazza<br />
28 - Sant’Eustacchio<br />
29 - San Rocchino-Costalunga<br />
9<br />
24<br />
21<br />
3<br />
6<br />
8<br />
28<br />
10<br />
27<br />
4<br />
17<br />
2<br />
22<br />
6<br />
1<br />
<strong>30</strong><br />
12<br />
15<br />
11<br />
CIRCOSCRIZIONE NORD<br />
19<br />
29<br />
14<br />
CIRCOSCRIZIONE CENTRO<br />
CIRCOSCRIZIONE EST<br />
CIRCOSCRIZIONE OVEST<br />
5 Chiusure - 7 Fiumicello - 21 Urago Mella<br />
23 Villaggio Ba<strong>di</strong>a - 25 Villaggio Violino - 26 Primo Maggio<br />
CIRCOSCRIZIONE<br />
CENTRO<br />
1 - <strong>Brescia</strong> Antica<br />
3 - Porta Milano<br />
4 - Centro Storico Nord<br />
14 - Porta Venezia<br />
27 - Centro Storico Sud<br />
<strong>30</strong> - Crocifissa <strong>di</strong> Rosa<br />
CIRCOSCRIZIONE<br />
EST<br />
19 - San Polo - SanPolino<br />
13 - Bettole- Buffalora<br />
18 - Sant’Eufemia<br />
16 - Caionvico<br />
18<br />
13<br />
16<br />
CIRCOSCRIZIONE<br />
SUD<br />
6 - Don Bosco<br />
8 - Folzano<br />
9 - Fornaci<br />
10 - Lamarmora<br />
12 - Porta Cremona<br />
20 - Chiesanuova<br />
24 - Villaggio Sereno
Introduzione<br />
La CiRCosCRizione oVest è, insieme alla Centro, fra le circoscrizioni<br />
con più alta densità demografica, in base al rapporto fra superficie territoriale<br />
e numero <strong>di</strong> abitanti.<br />
Il territorio della <strong>Ovest</strong> comprende i quartieri:<br />
• Chiusure<br />
• Urago Mella<br />
• Villaggio Ba<strong>di</strong>a<br />
• Villaggio Violino<br />
• Fiumicello<br />
• Primo Maggio<br />
La <strong>Circoscrizione</strong> è abitata da 39.447 residenti, con una prevalenza delle donne<br />
– che sono oltre 20.600 – sugli uomini, che ammontano a 18.800.<br />
I quartieri più popolosi sono quelli <strong>di</strong> Chiusure e <strong>di</strong> Urago Mella (entrambi abitati<br />
da oltre 10 mila residenti), seguiti dal quartiere Fiumicello, che ha oltre 7 mila<br />
abitanti. Il meno popolato è il quartiere Primo Maggio, con 2.753 residenti.<br />
La <strong>Circoscrizione</strong> <strong>Ovest</strong> ha due se<strong>di</strong>:<br />
1. I QUARTIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE OVEST<br />
Sede <strong>di</strong> Via Villa Glori, 13<br />
Telefono 0<strong>30</strong>-3732965<br />
fax 0<strong>30</strong>-3736196<br />
E-mail circoscrizioneovest@comune.brescia.it<br />
Sede <strong>di</strong> Via Farfengo, 69<br />
Telefono 0<strong>30</strong>-318007<br />
Fax 0<strong>30</strong>-2411477<br />
E-mail circoscrizioneovest@comune.brescia.it<br />
Entrambe le se<strong>di</strong> sono aperte al pubblico<br />
dal lunedì al giovedì dalle 9,<strong>30</strong> alle 12,15 e dalle 14,00 alle 15,45; il venerdì dalle ore 9,<strong>30</strong> alle 12,15.<br />
7
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
8<br />
Ponte Crotte negli <strong>anni</strong> ‘80 Archivio Lucini
Capitolo 1<br />
1. I QUARTIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE OVEST<br />
I quartieri della <strong>Circoscrizione</strong> <strong>Ovest</strong><br />
CHiUsURe<br />
La porta <strong>di</strong> ingresso privilegiata verso l’Oltremella e il quartiere Chiusure è<br />
sempre stata rappresentata da ponte Crotte, una denominazione che compare<br />
già in un documento del 1233 come “pontem de li Grottis”. Secondo una<br />
prima interpretazione il nome deriverebbe da pons cryptarum, a sua volta da<br />
cryptae, con riferimento all’esistenza nella zona <strong>di</strong> cantine o ospizi per accogliere<br />
i viandanti; un’altra spiegazione riconduce invece il termine al sassone<br />
“grot”, che in<strong>di</strong>ca un ponte grande.<br />
Quel che è certo è che ponte Crotte era uno dei tre ponti più antichi sul fiume<br />
Mella (insieme a quello <strong>di</strong> via Milano e quello <strong>di</strong> Roncadelle), e coincideva<br />
con un originario tracciato viario <strong>di</strong> periodo romano, come confermano lapi<strong>di</strong><br />
e iscrizioni latine rinvenute nelle mura della struttura.<br />
Il ponte <strong>di</strong>venne tristemente famoso nella seconda metà del Cinquecento,<br />
quando scoppiò la peste <strong>di</strong> San Carlo e nelle sue vicinanze venne realizzato<br />
un cimitero per dare sepoltura a circa 20 mila cadaveri. Un viatico per chi<br />
passava sul Mella per recarsi nella zona <strong>di</strong> Chiusure era la santella posta<br />
sul bordo del ponte fino agli inizi del Novecento, quando la fisionomia della<br />
struttura cambiò per consentire il passaggio dei binari del tram in <strong>di</strong>rezione<br />
Gussago.<br />
Arrivati sulla riva opposta del fiume, all’incrocio fra le o<strong>di</strong>erne via Crotte,<br />
Chiusure e Torricella <strong>di</strong> Sopra, sulla strada per Milano e Iseo esisteva<br />
nell’antichità una statio romana, cioè un ricovero per i pellegrini <strong>di</strong> passaggio<br />
nella zona. Successivamente sull’area, <strong>di</strong>venuta <strong>di</strong> proprietà del monastero<br />
<strong>di</strong> Santa Giulia e poi <strong>di</strong> quello <strong>di</strong> San Faustino, viene fondato un<br />
ospizio o luogo <strong>di</strong> accoglienza per i viandanti, denominato Ospitale Denni,<br />
cioè ospedale del vescovo o “del Signore”, a seconda delle interpretazioni,<br />
<strong>di</strong>ventato in seguito Ospedaletto, un appellativo che lungo i secoli ha dato<br />
il nome alla località.<br />
9
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
Il territorio dell’Oltremella è sempre stato una zona poco urbanizzata, con<br />
campi coltivati, filari <strong>di</strong> viti, cascinali e ville signorili. Bisogna aspettare gli<br />
<strong>anni</strong> Trenta del secolo scorso per vedere l’avvio <strong>di</strong> uno sviluppo e<strong>di</strong>lizio che<br />
trasformerà la zona da aperta campagna a porzione a tutti gli effetti della<br />
periferia citta<strong>di</strong>na.<br />
Nel 1931, lungo la riva del Mella nei pressi <strong>di</strong> ponte Crotte nasce il primo inse<strong>di</strong>amento<br />
abitativo, con una quin<strong>di</strong>cina <strong>di</strong> baracche allineate su quattro file,<br />
per ospitare gli “sfrattati”, rimasti senza tetto a seguito dello sventramento<br />
pianificato <strong>di</strong> piazza Vittoria, in centro storico.<br />
Il quartiere, chiamato “degli sfrattati” o <strong>di</strong> San Vincenzo, arriva ad ospitare<br />
250 famiglie: nel secondo dopoguerra sarà fondamentale e carismatica la<br />
figura <strong>di</strong> don Giacomo Vender, che sceglierà <strong>di</strong> andare fra gli “sfrattati” de<strong>di</strong>candosi<br />
alla formazione dei giovani, alla promozione culturale e spirituale<br />
del quartiere, all’assistenza sociale. Sarà don Vender a sostenere il progetto<br />
<strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficazione <strong>di</strong> case per le famiglie accolte nei capannoni, che verranno<br />
realizzate nelle zone limitrofe negli <strong>anni</strong> Cinquanta, prima della demolizione<br />
delle baracche. La chiesa parrocchiale, de<strong>di</strong>cata al Santo Spirito, verrà invece<br />
consacrata nel 1969.<br />
Nuovi nuclei <strong>di</strong> popolamento nella zona <strong>di</strong> Chiusure sorgono alla fine degli<br />
<strong>anni</strong> Trenta del Novecento, quando l’Istituto fascista autonomo case popolari<br />
vi in<strong>di</strong>vidua spazi che ben si prestano all’espansione urbana, per far fronte<br />
alla necessità <strong>di</strong> abitazioni dovuta al richiamo <strong>di</strong> lavoratori e manodopera<br />
verso la città. Le prime abitazioni costruite sono quelle “dei francesi”, perché<br />
destinate a ospitare gli italiani richiamati dalla Francia. La crescita prosegue<br />
nel secondo dopoguerra, con numerosi progetti <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia popolare attraverso<br />
cui prende forma, lungo l’asse <strong>di</strong> via Chiusure, il reticolo del quartiere, con<br />
i tracciati <strong>di</strong> via Colombo e via Caduti del Lavoro attorno a cui si <strong>di</strong>ramano<br />
fabbricati e servizi.<br />
L’appellativo <strong>di</strong> Chiusure, rimasto alla via e al quartiere, rimanda ai territori<br />
esterni alle mura citta<strong>di</strong>ne a partire dall’epoca me<strong>di</strong>evale, che pur essendo<br />
legati alle quadre urbane erano entità amministrative a sé stanti, con propri<br />
statuti e una autonoma giuris<strong>di</strong>zione (i “giu<strong>di</strong>ci dei chiosi”). La derivazione<br />
del nome è dal latino clausum, per in<strong>di</strong>care campi recintati da siepi o muraglie,<br />
com’era in passato il tipico paesaggio alle porte della città.<br />
10
1. I QUARTIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE OVEST<br />
Ai pie<strong>di</strong> della collina <strong>di</strong> Sant’Anna si stende l’omonimo quartiere, cresciuto<br />
alla fine degli <strong>anni</strong> Cinquanta del secolo scorso, secondo un <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia<br />
con complessi abitativi inframmezzati da spazi ver<strong>di</strong>.<br />
Il colle è <strong>di</strong> origine miocenica (età terziaria) e rappresenta un sito preistorico<br />
significativo, in cui sono stati rinvenuti reperti ceramici e oggetti <strong>di</strong> selce<br />
risalenti all’età del bronzo me<strong>di</strong>o.<br />
Nel Me<strong>di</strong>oevo la collina veniva chiamata Monterotondo – probabilmente per<br />
la sua conformazione – e anche Monte Cleve. Grazie all’opera dei monaci del<br />
monastero <strong>di</strong> San Salvatore, cui il re longobardo Desiderio aveva assegnato<br />
quel territorio, l’area viene valorizzata con coltivazioni e filari <strong>di</strong> viti.<br />
Sul lato occidentale del colle viene fondata nel XII secolo l’abbazia de<strong>di</strong>cata<br />
ai santi Gervasio e Protasio retta dai monaci vallombrosani cui, nel Cinquecento,<br />
subentrano i Cappuccini. Fulcro della vita religiosa e comunitaria per<br />
l’abitato limitrofo <strong>di</strong>venta la cappella de<strong>di</strong>cata a Sant’Anna, costruita dagli<br />
stampatori Rizzar<strong>di</strong> nelle a<strong>di</strong>acenze della loro casa <strong>di</strong> campagna: nei secoli il<br />
nome <strong>di</strong> Sant’Anna <strong>di</strong>viene identificativo <strong>di</strong> tutta la zona.<br />
Oggi il colle, che segna il confine fra l’area urbana e la Franciacorta, è parte<br />
integrante del Parco delle colline.<br />
Quartiere S. Anna, la chiesa<br />
11<br />
Archivio Architetto Serino
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
Le fornaci <strong>di</strong> Ponte Crotte<br />
Nei pressi <strong>di</strong> ponte Crotte sorgono le tre torri delle antiche fornaci<br />
per la produzione della calce, che oggi rappresentano un affascinante<br />
monumento <strong>di</strong> archeologia industriale, come tale vincolato<br />
dai Beni culturali.<br />
Le fornaci appartenevano in origine alla famiglia Giacoletti, che<br />
avviò l’attività della prima torre, più prossima al Mella, nel 1875,<br />
cui seguirono la seconda, sorta nel 1885 e la terza eretta agli inizi<br />
del Novecento.<br />
Nel processo <strong>di</strong> produzione della calce venivano utilizzate anche<br />
le pietre calcaree e i ciottoli raccolti dai renaioli sul greto del Mella,<br />
cui si aggiungeva la materia prima più pregiata proveniente da<br />
una cava <strong>di</strong> Nave: le fornaci funzionavano a fuoco continuo, e raccoglievano<br />
attorno alla loro caratteristica forma conica un vivace<br />
an<strong>di</strong>rivieni <strong>di</strong> carri per il carico e lo scarico dei materiali, oltre a un<br />
gran numero <strong>di</strong> garzoni e lavoranti.<br />
Le fornaci, che vennero in seguito acquistate dai Crescini e infine dai<br />
Rovetta, pur avendo cessato la loro attività sono tuttora un importante<br />
documento tangibile della storia del lavoro e dell’industria bresciana.<br />
Le Calchere <strong>di</strong> Ponte Crotte<br />
12
URago Mella<br />
1. I QUARTIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE OVEST<br />
Situato sulla sponda destra del fiume Mella, Urago è un quartiere dalla storia<br />
millenaria, che deve il suo nome alla ra<strong>di</strong>ce celtica “ur”, che significa acqua,<br />
fiume, cui si è aggiunto il suffisso “ragh”, che vuol <strong>di</strong>re davanti, verso: un villaggio,<br />
quin<strong>di</strong>, che si protende “davanti al fiume”, secondo il senso che gli stu<strong>di</strong>osi<br />
hanno dato al toponimo.<br />
In effetti Urago, fin dalle sue origini, ha sempre goduto <strong>di</strong> una posizione strategica<br />
sul Mella, al crocevia del guado <strong>di</strong> collegamento con la città. Già in epoca preistorica<br />
si ritiene che nella zona, in particolare sulle alture del Picastello, esistesse un<br />
inse<strong>di</strong>amento <strong>di</strong> gruppi de<strong>di</strong>ti alla caccia. Successivamente Urago viene abitato<br />
dai Galli Cenomani, fino a quando passa sotto la dominazione dei romani.<br />
Come villaggio inserito prima nella Gallia cisalpina e poi nella colonia romana, Urago<br />
conosce un significativo sviluppo essendo prossimo al ponte sul Mella su cui passa<br />
la strada per Tellegatae (Telgate) e Me<strong>di</strong>olanum (Milano), con biforcazione per Iseo,<br />
che rappresentava per l’epoca una delle più importanti arterie viarie locali.<br />
La vicinanza con il fiume favorisce anche la crescita delle attività agricole, con<br />
la coltivazione <strong>di</strong> vigne e orti che connota per secoli quella porzione <strong>di</strong> territorio<br />
urbano, cui si aggiunge, secondo alcuni stu<strong>di</strong>, anche l’attività artigianale <strong>di</strong> lavorazione<br />
della lana.<br />
Dopo le invasioni barbariche, il villaggio rifiorisce sotto la dominazione dei Longobar<strong>di</strong>.<br />
Dal 760 il re longobardo Desiderio assegna parte del territorio <strong>di</strong> Urago<br />
alle monache benedettine del monastero <strong>di</strong> Santa Giulia, che avviano lavori <strong>di</strong><br />
bonifica <strong>di</strong> palu<strong>di</strong> e acquitrini formatisi con gli straripamenti del Mella.<br />
La prima chiesa, de<strong>di</strong>cata alla Natività della Beata Vergine Maria, viene eretta intorno<br />
all’anno Mille, svolgendo un ruolo aggregativo oltre che spirituale per la comunità.<br />
Dal punto <strong>di</strong> vista amministrativo, nel XIV secolo gli inse<strong>di</strong>amenti fuori dalle mura<br />
della città incominciano a riunirsi in quadre, come quella <strong>di</strong> Gussago, <strong>di</strong> cui Urago<br />
in quel periodo entra a far parte, per passare agli inizi del Quattrocento sotto la<br />
quadra <strong>di</strong> Lumezzane, e entrare pochi decenni dopo nella quadra <strong>di</strong> Nave.<br />
Nel frattempo, sotto la dominazione veneta iniziata nel 1426, il borgo viene occupato<br />
dall’esercito visconteo del Piccinino nel suo asse<strong>di</strong>o <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> del 1438.<br />
Nei secoli successivi conoscerà il passaggio <strong>di</strong> truppe francesi e spagnole, nel<br />
13
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
Seicento verrà colpito da un’epidemia <strong>di</strong> peste e dovrà far fronte a inaspettate<br />
inondazioni del Mella.<br />
Proprio agli inizi del Seicento si sa dal Catastico <strong>Brescia</strong>no del podestà veneto Giov<strong>anni</strong><br />
da Lezze che il villaggio contava “40 fuochi e 250 anime, de quali utili 60”.<br />
Significativa è la presenza <strong>di</strong> proprietari terrieri, e fra le varie tenute ne spicca una<br />
in particolare, quello del pittore Romanino, che nel Cinquecento possiede appezzamenti<br />
coltivati nella zona, in località Carretto, e che proprio in virtù <strong>di</strong> questo<br />
legame con il borgo lascerà a Urago la splen<strong>di</strong>da pala dell’Annunciazione, opera<br />
della sua scuola, ora conservata nella parrocchiale.<br />
Grazie anche alla sua posizione geografica al <strong>di</strong> là del Mella, Urago come libero<br />
<strong>Comune</strong> conserva per lungo tempo una sua autonomia e in<strong>di</strong>pendenza rispetto<br />
alla città. Dopo l’unità d’Italia, nel 1867 viene aggregato al comune <strong>di</strong> Fiumicello<br />
(Regio Decreto 8 <strong>di</strong>cembre 1867, n. 4114), mentre pochi <strong>anni</strong> più tar<strong>di</strong>, nel 1884,<br />
analogamente alle altre municipalità rurali, il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Fiumicello-Urago viene<br />
annesso a <strong>Brescia</strong>.<br />
Durante la prima guerra mon<strong>di</strong>ale Urago allestisce nella struttura delle scuole<br />
elementari un ospedale militare per prestare assistenza ai feriti. Sul finire della<br />
Grande guerra, nel 1918, la villa Carolina, nell’antica contrada del Mulino, ospita<br />
il generale Armando Diaz, “nei giorni <strong>di</strong> preparazione alla riscossa”, come recita<br />
la targa posta in ricordo <strong>di</strong> quell’episo<strong>di</strong>o.<br />
La connotazione tipicamente conta<strong>di</strong>na del borgo (a fine Ottocento si era costituita<br />
la Società <strong>di</strong> mutuo soccorso) è destinata a mo<strong>di</strong>ficarsi dopo il secondo conflitto<br />
mon<strong>di</strong>ale, quando Urago, che fino ad allora aveva mantenuto le <strong>di</strong>mensioni <strong>di</strong> villaggio<br />
a bassa densità abitativa, punteggiato da ville padronali e piccoli inse<strong>di</strong>amenti<br />
conta<strong>di</strong>ni, conosce improvvisamente un’accelerazione urbanistica ed economica.<br />
Nella zona iniziano a nascere le prime officine e vengono costruite nuove abitazioni,<br />
Urago <strong>di</strong>venta centro <strong>di</strong> attività commerciali e impren<strong>di</strong>toriali, e la popolazione<br />
residente cresce esponenzialmente, allargandosi dal nucleo originario <strong>di</strong><br />
1500 abitanti agli attuali 10 mila. Anche il tessuto sociale e il sistema dei mestieri<br />
si trasforma, passando dalle figure dei braccianti e vignaioli <strong>di</strong> un tempo a una<br />
composizione prevalente <strong>di</strong> operai, artigiani, commercianti e impiegati.<br />
Negli <strong>anni</strong> Sessanta conoscono un particolare sviluppo gli inse<strong>di</strong>amenti abitativi alla<br />
Pendolina, zona che deriva il nome dalla parola “pendol”, cioè salice (secondo un’altra<br />
tesi la denominazione sarebbe invece mutuata dalla pendenza della collina).<br />
14
1. I QUARTIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE OVEST<br />
Il quartiere viene ulteriormente ampliato negli <strong>anni</strong> Ottanta con interventi e<strong>di</strong>lizi<br />
dell’Istituto case popolari.<br />
Anche il quartiere Torricella, il cui toponimo deriva dalla presenza, nel passato,<br />
<strong>di</strong> una torre – la turris Juliae – a <strong>di</strong>fesa del valico per Cellatica, nasce come agglomerato<br />
compiuto negli <strong>anni</strong> Sessanta, con gli interventi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia popolare che<br />
cambiano i connotati secolari dell’area, fino ad allora agricola con bassa densità<br />
abitativa, impreziosita da alcune ville patrizie.<br />
L’impostazione del nuovo quartiere rispetta un preciso <strong>di</strong>segno urbanistico, volto<br />
a conferire una unità d’insieme ai <strong>di</strong>versi e<strong>di</strong>fici, realizzati attorno a spazi <strong>di</strong> vita<br />
in comune, come giar<strong>di</strong>ni e cortili, per salvaguardare il contesto <strong>di</strong> socialità su cui<br />
si sviluppano gli inse<strong>di</strong>amenti.<br />
Il quartiere Cesare Abba sorge invece alla fine degli <strong>anni</strong> Cinquanta a nord <strong>di</strong><br />
via Torricella <strong>di</strong> Sopra, in un’area che il <strong>Comune</strong> aveva acquistato dalle sorelle<br />
Abba Legnazzi, che imposero come clausola l’intitolazione del nuovo quartiere<br />
al loro antenato Giuseppe Cesare Abba, che era stato volontario nelle file dei<br />
Mille <strong>di</strong> Garibal<strong>di</strong>, un’esperienza rievocata nella sua celebre opera “Da Quarto al<br />
Volturno: Noterelle <strong>di</strong> uno dei Mille”.<br />
Il centro <strong>di</strong> Urago con la vecchia Parrocchiale<br />
15<br />
Archivio Lucini
Archivio Centro Stu<strong>di</strong> La Famiglia<br />
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
Villaggio baDia<br />
Nucleo originario dell’abitato era l’abbazia dei Santi Gervasio e Protasio,<br />
fondata dai monaci benedettini vallombrosani agli inizi del XII secolo sulle<br />
pen<strong>di</strong>ci occidentali della collina <strong>di</strong> Sant’Anna. Il nome Ba<strong>di</strong>a deriva infatti da<br />
“abba<strong>di</strong>a”, ovvero abbazia.<br />
Nel Cinquecento subentrarono nel cenobio i Cappuccini, che ben presto però<br />
trasferirono parte del convento con la chiesa all’estremità meri<strong>di</strong>onale della<br />
collina - nelle a<strong>di</strong>acenze dell’area dove sorgerà il villaggio Ba<strong>di</strong>a – in un<br />
luogo panoramico costellato <strong>di</strong> vigne. Con alterne vicende, i frati abitarono<br />
il convento fino alla fine dell’Ottocento.<br />
La denominazione Ba<strong>di</strong>a si è poi estesa al territorio circostante, a vocazione<br />
rurale, dove nel 1955 prendono il via i lavori per costruire il villaggio voluto<br />
da padre Ottorino Marcolini, della Congregazione dei Padri della Pace, e<br />
realizzato per iniziativa della cooperativa “La Famiglia” da lui fondata nel<br />
1953.<br />
Il Villaggio Ba<strong>di</strong>a negli <strong>anni</strong> Sessanta<br />
16
1. I QUARTIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE OVEST<br />
All’insegna del motto “fare e ancora fare”, dopo il primo inse<strong>di</strong>amento realizzato<br />
al Violino, padre Marcolini – mente e personalità poliedrica che poteva<br />
vantare anche una laurea in ingegneria e in matematica - si concentrò<br />
sull’area della Ba<strong>di</strong>a per trovare una soluzione alla crescente richiesta <strong>di</strong><br />
alloggi favorita dalla ripresa industriale ed economica del secondo dopoguerra.<br />
Alla Ba<strong>di</strong>a padre Marcolini realizzò compiutamente e su larga scala la sua<br />
intuizione <strong>di</strong> partenza che si rivelerà vincente, quella della forma cooperativistica<br />
come via privilegiata per dare risposta all’urgenza del problema casa,<br />
soprattutto per i giovani e le categorie più modeste.<br />
Questa soluzione si muoveva parallela e alternativa all’idea <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia economico-popolare<br />
sovvenzionata dallo Stato e assistita da leggi e finanziamenti<br />
pubblici che si stava affermando in quel periodo <strong>di</strong> forte urbanizzazione. Il<br />
criterio seguito dalla cooperativa “La Famiglia” era <strong>di</strong> impostazione antistatalista,<br />
e guardava alla finanza cattolica e al paternalismo industriale come<br />
via <strong>di</strong> conciliazione fra capitale e lavoro (per realizzare la Ba<strong>di</strong>a un significa-<br />
Veduta aerea del Villaggio Ba<strong>di</strong>a<br />
17<br />
Archivio Centro Stu<strong>di</strong> La Famiglia
Archivio Centro Stu<strong>di</strong> La Famiglia<br />
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
tivo aiuto arrivò anche dalla Congrega della carità apostolica e dai mutui che<br />
le principali aziende bresciane accordarono ai propri <strong>di</strong>pendenti).<br />
Il primo mattone fu benedetto nel marzo del 1955 e nell’arco <strong>di</strong> due <strong>anni</strong><br />
erano già ultimati quasi 700 alloggi, che nel 1967 <strong>di</strong>venteranno oltre un<br />
migliaio.<br />
Lo schema seguito dalla cooperativa era quello <strong>di</strong> un villaggio periferico<br />
articolato attorno a un progetto <strong>di</strong> casa economica bifamiliare o a schiera,<br />
corredata da appezzamenti a<strong>di</strong>biti a orto o a giar<strong>di</strong>no. Nel reticolo <strong>di</strong> vie e<br />
traverse, semplicemente in<strong>di</strong>cate con numeri <strong>di</strong>spari e pari, la pianificazione<br />
del villaggio favorì la creazione <strong>di</strong> un senso <strong>di</strong> comune appartenenza fra<br />
i residenti, favorito dal fatto <strong>di</strong> essere tutti proprietari della propria casa,<br />
inserita in un contesto abitativo a misura d’uomo.<br />
Lo schema tipico delle abitazioni al villaggio Ba<strong>di</strong>a<br />
18
Villaggio Violino<br />
1. I QUARTIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE OVEST<br />
Il Villaggio Violino è situato a sud-ovest <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> sulla destra del Fiume Mella.<br />
Dal punto <strong>di</strong> vista storico i territori dove attualmente sorge il Villaggio appartenevano<br />
alla Chiusure <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> fin dal me<strong>di</strong>oevo.<br />
Il suo nome deriva, secondo Paolo Guerrini, dalla famiglia Violini che, nel 1621, acquistò<br />
terreni dall’Ospedale Maggiore. Precedentemente e, fino al 1807, il centro <strong>di</strong><br />
questo territorio era noto con il nome <strong>di</strong> Castelletto, probabilmente per la presenza <strong>di</strong><br />
una casa signorile in parte ad un fabbricato colonico, che insieme davano l’immagine<br />
<strong>di</strong> una fortificazione.<br />
Negli <strong>anni</strong>, intorno ad una breda centrale, che <strong>di</strong>verrà proprietà della famiglia Tagliaferri,<br />
cominceranno a sorgere nuove case e cascine, che animeranno la comunità.<br />
Nell’800 proprio da qui vene fatta passare le neonate linee ferroviarie <strong>Brescia</strong>-Iseo<br />
e <strong>Brescia</strong>-Milano.<br />
Precedentemente all’e<strong>di</strong>ficazione del Villaggio attuale il territorio era <strong>di</strong>viso in tre<br />
<strong>di</strong>fferenti nuclei abitati: Violino <strong>di</strong> Brione, Violino <strong>di</strong> Sotto e Violino <strong>di</strong> Sopra.<br />
Violino 4 luglio 1954: posa della prima pietra con, <strong>di</strong> schiena, padre Marcolini<br />
19
Archivio Centro Stu<strong>di</strong> La Famiglia<br />
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
Il primo era situato praticamente a ridosso del Mella ed era una zona interamente<br />
agricola, oggi parte del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> Roncadelle.<br />
La zona del Violino <strong>di</strong> Sotto era, anch’essa, eminentemente agricola, caratterizzata<br />
dalla presenza <strong>di</strong> un’antica casa e <strong>di</strong> qualche cascinale sparso. Nel 1920 il <strong>Comune</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> cedeva questi terreni per farne una piazza d’armi, in sostituzione <strong>di</strong> Campo<br />
Marte.<br />
Il Violino <strong>di</strong> Sopra, infine, era legato, soprattutto, ad una casa colonica, poi <strong>di</strong> proprietà<br />
Falconi, ed anche i suoi terreni furono utilizzati, soprattutto, a scopi agricoli. Ancora<br />
oggi, in questa via è possibile ammirare un bel cascinale, un tempo noto come casa<br />
Bossini, ennesima conferma <strong>di</strong> una zona interamente destinata al lavoro agricolo.<br />
Con l’aumento degli abitanti e con il passare del tempo le tre frazioni cominciarono<br />
ad essere considerati una zona unica.<br />
Nel 1922, anche il Violino fu segnato dalle vicissitu<strong>di</strong>ni politiche che caratterizzarono<br />
quegli <strong>anni</strong>: a farne le spese fu un certo Eugenio Lamberti, titolare <strong>di</strong> un’osteria,<br />
probabilmente fascista, che qui venne ammazzato.<br />
Nel 1925 gli abitanti del Violino protestarono perché la zona era stata lasciata ancora<br />
priva <strong>di</strong> illuminazione a <strong>di</strong>fferenza delle ville dei Ronchi, che già usufruivano <strong>di</strong><br />
Veduta aerea del nucleo storico del Villaggio Violino<br />
20
1. I QUARTIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE OVEST<br />
questo servizio: proteste, quelle inerenti ai servizi che, in quegli <strong>anni</strong>, erano usuali,<br />
come conferma, anche, la richiesta <strong>di</strong> un acquedotto risalente al 1933.<br />
La storia moderna <strong>di</strong> questo territorio è, comunque, legata doppio filo alla figura <strong>di</strong><br />
Padre Ottorino Marcolini e della sua cooperativa La Famiglia: fu proprio qui, infatti,<br />
che si decise <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficare il primo <strong>di</strong> quei villaggi economico popolari che influenzarono,<br />
non poco, lo sviluppo urbanistico della nostra città.<br />
Su 100mila metri quadri <strong>di</strong> terreo agricolo vennero e<strong>di</strong>ficati i primi 252 alloggi, inaugurati<br />
nel maggio 1955. Da questo momento in poi, il Villaggio Violino, inizialmente<br />
chiamato “La Famiglia“, cominciò a svilupparsi come una vera e propria comunità:<br />
è solo <strong>di</strong> un anno dopo la nascita della scuola materna affidata alle suore dorotee<br />
e de<strong>di</strong>cata a Sandro Bonicelli, <strong>di</strong> poco tempo dopo quella della scuola elementare<br />
“Montale”.<br />
Nel frattempo il Villaggio continuava ad espandersi: nel 1993 arriva il teleriscaldamento<br />
e, un anno dopo, cominciano i lavori per l’e<strong>di</strong>ficazione del Villaggio Violino 2,<br />
altri 134 alloggi su 57 mila metri quadrati, in gran parte destinati a verde pubblico.<br />
Dal 2001, proprio qui, sorge un Centro per la riabilitazione dei ragazzi Down. Nuove<br />
abitazioni vengono progettate, infine, nel 2004 e nel 2005.<br />
Gli orti domestici del Villaggio Violino<br />
21<br />
Archivio Centro Stu<strong>di</strong> La Famiglia
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
FiUMiCello<br />
Fiumicello è un quartiere <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>, una volta frazione, situato ad ovest <strong>di</strong><br />
<strong>Brescia</strong>, che si espande da Ponte Crotte a Ponte San Giacomo. Il suo nome<br />
deriva dal vaso d’acqua detto Fiumicella, unico in tutto il territorio, ed è<br />
risalente al 1022.<br />
Per secoli fece parte delle Chiusure <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> e, precisamente, del Vitexeto,<br />
proprio per le sue terre caratterizzate da estesi vigneti che lo renderanno per<br />
lungo tempo un territorio eminentemente agricolo.<br />
Probabilmente abitato già in epoca preistorica, ipotesi confermata da un ritrovamento<br />
<strong>di</strong> un villaggio sulla collina della Ba<strong>di</strong>a, sicuramente lo fu nel periodo<br />
romano, come accertano alcune lapi<strong>di</strong> e tombe rinvenute in via Crotte,<br />
Chiusure e Torricella nel 18<strong>30</strong>.<br />
Divenuto corte longobarda Fiumicello venne, il 4 ottobre 1460, donato da re<br />
Desiderio al monastero <strong>di</strong> Santa Giulia che cominciò a bonificare la zona.<br />
Il monastero, inoltre, qui creò un proprio cenobio fattoria denominato S. Pietro<br />
<strong>di</strong> Fiumicello che venne annesso al monastero benedettino femminile dei<br />
SS. Cosma e Damiano nel 1343.<br />
Un’altra parte <strong>di</strong> territorio, invece, fu conglobata nelle proprietà del monastero<br />
<strong>di</strong> San Faustino.<br />
Con l’allargamento delle mura, iniziate nel 1239, al <strong>di</strong> fuori <strong>di</strong> queste cominciò<br />
a svilupparsi Borgo San Giov<strong>anni</strong>. Di una chiesa de<strong>di</strong>cata a San Giov<strong>anni</strong><br />
in questa zona già si parlava nel IX secolo, e documentazione risalente a quel<br />
periodo racconta della presenza <strong>di</strong> un antichissimo monastero de<strong>di</strong>cato a S.<br />
Pietro.<br />
Nel XII secolo proprio da Fiumicello prese il nome un’importante famiglia<br />
che darà alla chiesa bresciana anche un vescovo, Giov<strong>anni</strong> da Fiumicello.<br />
Nel 1125 i terreni <strong>di</strong> Fiumicello passavano <strong>di</strong>rettamente alle <strong>di</strong>pendenza del<br />
vescovato.<br />
Fiumicello e Borgo San Giov<strong>anni</strong>, al <strong>di</strong> là dei continui passaggi <strong>di</strong> proprietà da<br />
un monastero all’altro, furono due borghi particolarmente flagellati da numerose<br />
traversie: oltre alle perio<strong>di</strong>che inondazioni del Mella, i loro abitanti furono<br />
costretti a resistere agli asse<strong>di</strong> ed ai numerosi passaggi degli eserciti. Nel<br />
22
1. I QUARTIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE OVEST<br />
1438 furono ad<strong>di</strong>rittura 1600 gli uomini del Piccinino che qui fortificarono e,<br />
poco dopo, scoppiò la peste ed alcune case vennero a<strong>di</strong>bite a Lazzaretto.<br />
Dal punto <strong>di</strong> vista agricolo, intanto, i tra<strong>di</strong>zionali vigneti venivano sostituiti<br />
da campi coltivati a miglio, a panico e sorgo. Con lo spianamento delle mura<br />
deciso dal governo della Repubblica Fiumicello finì con il restare isolato dalla<br />
città e a costituire una propria comunità. Retto dal punto <strong>di</strong> vista civile da<br />
una vicinia, da quello religioso <strong>di</strong>venne parrocchia, che venne fisicamente<br />
eretta nel 1518. Nei secoli XV-XVI secolo esisteva una scuola particolarmente<br />
prestigiosa nella quale insegnò anche il noto Andrea Rabirio.<br />
A fine Quattrocento venivano fondate la scuola <strong>di</strong> Carità de’ poveri e quella<br />
del SS. Sacramento, mentre, nel 1586 nasceva la scuola Confraternità del<br />
Rosario.<br />
Nel XVIII secolo causa un aumento della popolazione venne eretta una nuova<br />
parrocchiale che fu inaugurata nel 1763.<br />
Come numerose zone segnate dal passaggio dei canali che caratterizzavano<br />
il territorio bresciano, anche, Fiumicello vide sorgere varie officine sul fiume<br />
Grande, grazie al quale venivano mosse le ruote ad acqua: in via Carducci, per<br />
esempio, era presente un filatoio che per lungo tempo <strong>di</strong>ede anche la propria<br />
denominazione a via Carducci, nota appunto come via Filatoio o Filatoglio.<br />
Nella prima metà del XIX secolo in questa zona venne costituita la fabbrica<br />
<strong>di</strong> pellami <strong>di</strong> Vincenzo Maria Noy, primo inse<strong>di</strong>amento industriale al quale<br />
seguirono la filanda <strong>di</strong> Antonio Franchi, l’officina per la fabbricazione <strong>di</strong> macchine<br />
agricole Benini e la fabbrica <strong>di</strong> stoviglie Dall’Era.<br />
Nel 1884, nonostante una forte contrarietà dei suoi abitanti, anche la chiusura<br />
<strong>di</strong> Fiumicello-Urago venne aggregata al <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>.<br />
Il vero slancio industriale arrivò con la fondazione, nel 1887, della fonderia<br />
Sant’Eustacchio, alla quale preso si aggiunsero la fabbrica <strong>di</strong> automobili Brixia-Zust,<br />
futura Om, la società elettrochimica Caffaro, la Bontempi Novaglia,<br />
l’Ideal Standard, la Breda armi e molte altre: attività che caratterizzeranno<br />
particolarmente questa zona della città e che, purtroppo, la segneranno anche<br />
dal punto <strong>di</strong> vista ambientale. Negli <strong>anni</strong> Settanta la zona fu protagonista<br />
anche <strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia residenziale.<br />
Agli inizi del 1972, invece, nasceva il comitato <strong>di</strong> quartiere ed il 10 novembre<br />
del 1974 veniva eletto il primo consiglio <strong>di</strong> quartiere.<br />
23
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
QUaRtieRe pRiMo Maggio<br />
Il Primo Maggio è un quartiere che si trova tra via Rose <strong>di</strong> Sotto, via Tempini,<br />
via Divisione Acqui e via Lunga. Via Divisione Acqui <strong>di</strong>vide in due zone il<br />
quartiere, del quale la parte più antica è quella settentrionale che si spegne<br />
a ridosso della ferrovia <strong>Brescia</strong>-Edolo.<br />
La storia <strong>di</strong> questo quartiere è relativamente recente ed i primi inse<strong>di</strong>amenti<br />
abitativi risalgono alla metà degli <strong>anni</strong> ’20, quando l’istituto Autonomo fascista<br />
Case Popolari, nato nel 1926, decise <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficare una cinquantina <strong>di</strong> villette,<br />
tutte quadrilocali, che vennero progettate dall’ingegner Oreste Buffoli.<br />
Prima <strong>di</strong> questi interventi vaste aree <strong>di</strong> questo territorio erano state in<strong>di</strong>cate<br />
come possibile sede <strong>di</strong> un futuro mercato ortofrutticolo, poi del porto del<br />
canale navigabile Bergamo, <strong>Brescia</strong>, Mincio-Po, infine, <strong>di</strong> un aeroporto. In<br />
quegli <strong>anni</strong>, infatti, l’industriale Giulio Togni che, qui, possedeva numerose<br />
industrie, aveva acquistato numerosi terreni proprio in questa zona. Alcuni<br />
terreni, infatti, sembravano destinati ad un’operazione speculativa legata<br />
al progetto per la navigazione <strong>di</strong> un canale navigabile che verrà presentata<br />
ufficialmente nel 1922.<br />
Tutte le <strong>di</strong>fferenti ipotesi restarono, tuttavia, solamente sulla carta e gli entusiasmi<br />
vennero spenti definitivamente proprio per la ven<strong>di</strong>ta, <strong>di</strong> parte <strong>di</strong><br />
terreni, <strong>di</strong> proprietà dell’industriale Giulio Togni, che decise, appunto, nel<br />
1918, <strong>di</strong> cederli all’istituto che ne iniziò l’e<strong>di</strong>ficazione. Qui andranno a vivere<br />
proprio gli operai della società italiana Tubi Togni.<br />
Il quartiere, chiamato impropriamente Togni, venne denominato nel marzo<br />
del 1928 Quartiere XXI aprile, con un chiaro riferimento al fascismo ed ai<br />
legami mitologici che volevano quest’ultimo erede della civiltà e dei fasti<br />
dell’antica Roma. Questo nome resterà sino al luglio del 1945, quando vennero<br />
proposti i nomi <strong>di</strong> quartiere Sardegna, poi quartiere 25 aprile, infine,<br />
nell’agosto del 1946 si arrivò, finalmente, alla denominazione attuale.<br />
Dopo il primo inse<strong>di</strong>amento l’urbanizzazione della zona è proseguita e dall’area<br />
della ferrovia <strong>Brescia</strong>-Edolo e si è allargata a gran parte del territorio circostante.<br />
24
1. I QUARTIERI DELLA CIRCOSCRIZIONE OVEST<br />
Dal punto <strong>di</strong> vista ecclesiastico il quartiere <strong>di</strong>pendeva dalla parrocchia dei<br />
SS. Nazaro e Celso ed era assistita dal curato Don Battista Canesi. Inizialmente<br />
la parrocchia era rappresentata da una baracca che era stata eretta<br />
a <strong>Brescia</strong> dopo essere servita, nel 1945, ad ospitare i reduci dei campi <strong>di</strong><br />
concentramento ed era poi per l’assistenza spirituale alla “Baia del Re” <strong>di</strong><br />
via Chiusure.<br />
Affidata a Don Paolo Arrigo, la baracca <strong>di</strong>venne ben presto il centro <strong>di</strong> un’attiva<br />
parrocchia che venne de<strong>di</strong>cata a S. Benedetto. Nel 1952 iniziarono i<br />
lavori della chiesa, curati dall’ingegner Giacomo Lanfranchi. Un anno dopo<br />
la chiesa veniva benedetta da mons. Tre<strong>di</strong>ci. Accanto alla chiesa venne eretta<br />
una scuola materna e, nel 1959, un oratorio, poi ampliato <strong>di</strong>eci <strong>anni</strong> dopo.<br />
Scorcio storico del Quartiere Primo Maggio<br />
25<br />
Per concessione dei Civici Musei d’Arte e Storia <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
Chiesa <strong>di</strong> San Giacomo al Mella<br />
26
Capitolo 2<br />
2. A SPASSO PER LA OVEST<br />
A spasso per la <strong>Ovest</strong><br />
le CHiese<br />
chiesa della Natività della Beata Vergine<br />
La nuova parrocchiale <strong>di</strong> Urago Mella, progettata da Giov<strong>anni</strong> Tagliaferri, è<br />
stata consacrata nel 1914 da monsignor Giacinto Gaggia, vescovo <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>,<br />
con una cerimonia cui partecipò tutta la popolazione del quartiere. La facciata<br />
è in stile lombardo, con impianto centrale a capanna e un grande rosone sovrastante,<br />
impreziosita dalle varianti cromatiche che alternano linee <strong>di</strong> pietre<br />
chiare a quelle in cotto.<br />
L’interno <strong>di</strong> stile neogotico è a tre navate sostenute da pilastri che terminano<br />
con archi acuti, oltre i quali si aprono piccole finestre.<br />
Nell’abside, <strong>di</strong> forma trapezoidale, è custo<strong>di</strong>ta la pala dell’Annunciazione, che<br />
proviene dalla vecchia parrocchiale <strong>di</strong> Urago ed è stata al centro <strong>di</strong> un vivace<br />
<strong>di</strong>battito storico-artistico per chiarirne l’attribuzione. La tela, infatti, tra<strong>di</strong>zionalmente<br />
attribuita alle opere tarde del Romanino - che proprio nella zona, in<br />
località Carretto, aveva dei terreni <strong>di</strong> proprietà – ha suscitato non poche controversie<br />
fra gli stu<strong>di</strong>osi, alcuni dei quali ne riven<strong>di</strong>cavano l’autenticità, contrapponendosi<br />
a chi considerava la pala frutto <strong>di</strong> collaborazione, se non <strong>di</strong> scuola.<br />
Attualmente l’opera è stata attribuita a Callisto Piazza da Lo<strong>di</strong>, che era allievo<br />
del Romanino. Nonostante il complicato riconoscimento, la tela cinquecentesca<br />
mantiene intatte l’eleganza e la delicatezza del tocco, unite a una descrizione<br />
espressionista delle due figure dell’angelo e della Vergine, in cui non è <strong>di</strong>fficile<br />
ravvisare la poetica del maestro.<br />
Fra le tele preziose all’interno della chiesa è possibile ammirare anche una pala<br />
<strong>di</strong> Francesco Paglia che raffigura la colomba dello Spirito Santo adorata dai<br />
santi, datata alla fine del Seicento, la tela della Deposizione <strong>di</strong> scuola veneta<br />
della fine del XVI secolo, una pala <strong>di</strong> Antonio Gan<strong>di</strong>no con la Madonna in gloria<br />
e i Santi Nicola da Tolentino, Carlo Borromeo e Rocco, e il <strong>di</strong>pinto del Martirio<br />
<strong>di</strong> due Santi che campeggia sulla controfacciata.<br />
Finemente intarsiati i due altari marmorei delle navate minori, provenienti<br />
27
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
dall’antica chiesa, e la mensa seicentesca dell’altare maggiore. Da vedere anche<br />
il crocefisso ligneo <strong>di</strong> grandezza quasi naturale nella prima campata della navata<br />
destra, attribuito a un maestro bresciano o bergamasco del XVII secolo.<br />
La nuova parrocchiale <strong>di</strong> Urago Mella<br />
Chiesa parrocchiale antica <strong>di</strong> Urago<br />
A<strong>di</strong>acente alla nuova parrocchiale sorge l’antica chiesa <strong>di</strong> Urago, anch’essa<br />
intitolata alla Natività della Beata Vergine. La tecnica costruttiva in blocchi<br />
<strong>di</strong> pietra calcarea fa risalire le origini della chiesa al X secolo, mentre il primo<br />
documento che ne attesta la presenza è del 1166.<br />
Della primitiva struttura, che doveva essere costituita da un’unica navata, rimane<br />
oggi parte del campanile romanico (in cui è incorporato un frammento lapideo<br />
romano) e il <strong>di</strong>segno dell’abside trapezoidale. Con successivi interventi nel<br />
Cinquecento e nel Seicento la chiesa venne ampliata con due navate laterali e<br />
rinnovata nella facciata. Dopo la consacrazione dell’attigua nuova parrocchiale,<br />
nel 1914, la chiesa ha subito un lento declino, <strong>di</strong>ventando negli <strong>anni</strong> sede<br />
dell’oratorio, cinema-teatro, magazzino.<br />
28
2. A SPASSO PER LA OVEST<br />
Alla fine degli <strong>anni</strong> Ottanta si procede al restauro della vecchia parrocchiale,<br />
mentre nei primi <strong>anni</strong> Duemila vengono ultimati i lavori <strong>di</strong> recupero dell’intero<br />
“Nucleo antico la pieve”, che comprende anche le aree a<strong>di</strong>acenti alla chiesa,<br />
fra cui un piccolo chiostro ristrutturato.<br />
Oggi l’e<strong>di</strong>ficio antico è <strong>di</strong>ventato sede <strong>di</strong> mostre e conferenze, ma l’osservatore<br />
attento può ancora scorgere al suo interno alcuni retaggi del passato, fra i<br />
quali un brano <strong>di</strong> affresco del Trecento, una parte del pavimento originario<br />
conservatosi fino ai giorni nostri, e alcune lapi<strong>di</strong> che testimoniano la vita della<br />
chiesa nel corso dei secoli.<br />
Chiesa <strong>di</strong> Santa Maria Nascente<br />
Le origini della chiesa <strong>di</strong> Fiumicello risalgono al tempo della dominazione longobarda<br />
quando, nel 780, re Desiderio assegnò quel territorio al monastero <strong>di</strong><br />
San Salvatore. Nell’area dove sorge l’o<strong>di</strong>erna parrocchiale le monache e<strong>di</strong>ficarono<br />
il convento <strong>di</strong> San Pietro, mentre da documenti risalenti al XII secolo si<br />
sa che accanto al monastero esisteva<br />
una cappella “Sanctae Mariae in Pusterula”<br />
che nel Quattrocento fungeva<br />
da lazzaretto.<br />
Dell’antica cappella si conservano<br />
oggi significative tracce <strong>di</strong> affreschi<br />
nel complesso della canonica: le decorazioni,<br />
risalenti al Quattrocento, sono<br />
state recuperate e hanno svelato brani<br />
della preghiera <strong>di</strong> Gesù nell’orto degli<br />
ulivi e dell’arresto, oltre alle raffigurazioni<br />
<strong>di</strong> san Sigismondo e san Genesio,<br />
il santo protettore degli artisti.<br />
All’inizio del Settecento viene decisa<br />
la realizzazione della nuova chiesa,<br />
e<strong>di</strong>ficata in parte sulle fondamenta<br />
del vecchio monastero <strong>di</strong> San Pietro.<br />
Parrocchiale <strong>di</strong> Fiumicello<br />
La struttura che si può ammirare oggi<br />
29
Archivio Architetto Serino<br />
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
è frutto <strong>di</strong> significativi restauri realizzati nel secolo scorso: la sobria facciata<br />
si sviluppa su due or<strong>di</strong>ni, con un finestrone centrale che domina il comparto<br />
superiore. All’interno, sono opera <strong>di</strong> Gaetano Cresseri i quattro medaglioni con<br />
gli Evangelisti nei pennacchi sopra l’altare e i riquadri della volta maggiore<br />
con l’Assunzione e l’Incoronazione <strong>di</strong> Maria. Fra i <strong>di</strong>pinti si segnalano una<br />
Deposizione dalla croce <strong>di</strong> Francesco Sav<strong>anni</strong>, la Crocifissione <strong>di</strong> Cristo sulla<br />
controfacciata, i <strong>di</strong>pinti dei 15 Misteri, le piccole tele della Via Crucis <strong>di</strong> anonimo<br />
locale del XVIII secolo, e il minuscolo <strong>di</strong>pinto votivo detto della Madonna<br />
dei carrettieri, contornato da una fastosa cornice barocca.<br />
Seicentesca è invece la chiesa <strong>di</strong> Sant’Antonio alla Ba<strong>di</strong>a, situata sul declivio<br />
del colle Sant’Anna - in una posizione che domina dall’alto via Ba<strong>di</strong>a - cui<br />
si accede percorrendo un sentiero in salita.<br />
La chiesa faceva parte del complesso<br />
dei Cappuccini, e rappresenta<br />
per l’ubicazione suggestiva<br />
e l’impostazione architettonica<br />
un’importante testimonianza storico-artistica<br />
nell’Oltremella. Al suo<br />
interno si trovavano alcuni <strong>di</strong>pinti<br />
seicenteschi <strong>di</strong> pregio (ora spostati<br />
nella parrocchia della Ba<strong>di</strong>a e<br />
sostituiti con delle riproduzioni).<br />
Adorna la chiesa l’originale <strong>di</strong> una<br />
pala d’altare dell’Assunzione <strong>di</strong><br />
scuola bresciana del Settecento.<br />
Impegnato nel recupero e nella<br />
valorizzazione della chiesa è il<br />
Gruppo Ba<strong>di</strong>a Trenta, che ha realizzato<br />
significativi interventi <strong>di</strong><br />
restauro della struttura (per una<br />
visita è necessario rivolgersi alla<br />
Sant’Antonio alla Ba<strong>di</strong>a<br />
parrocchia della Ba<strong>di</strong>a).<br />
<strong>30</strong>
2. A SPASSO PER LA OVEST<br />
Chiesa della Madonna del Rosario, la parrocchiale della Ba<strong>di</strong>a viene costruita<br />
nel 1958, per accogliere la popolazione del recente villaggio voluto da<br />
padre Marcolini. Al suo interno accoglie il raffinato <strong>di</strong>ttico seicentesco dell’Annunciazione,<br />
proveniente dall’antica chiesa <strong>di</strong> Sant’Antonio, che raffigura l’angelo<br />
e la Vergine ed è attribuita a Palma il Giovane. Le tele si <strong>di</strong>stinguono per<br />
la vivacità della stesura pittorica, la finezza con cui è delineato l’angelo e la<br />
plasticità della posa in cui il pittore ha effigiato la Vergine.<br />
Vicino all’altare della Sacra Famiglia campeggia il <strong>di</strong>pinto cinquecentesco con<br />
i Santi Gervasio e Protasio, cui era de<strong>di</strong>cata l’antica abbazia da cui si è sviluppato<br />
l’inse<strong>di</strong>amento della Ba<strong>di</strong>a.<br />
Notevole la pala-mosaico con la Cena in Emmaus realizzata su <strong>di</strong>segno <strong>di</strong><br />
Oscar Di Prata. Le decorazioni della sommità delle pareti laterali sono <strong>di</strong> Vittorio<br />
Trainini.<br />
In prossimità del ponte su Mella, lungo la <strong>di</strong>rettrice <strong>di</strong> via Milano si trova<br />
l’antica chiesa <strong>di</strong> San Giacomo al Mella, detta anche dei Romei, già ricordata<br />
in un documento risalente alla fine dell’anno Mille. La chiesa sorgeva sul<br />
tracciato percorso dai pellegrini che dalla Francia scendevano a Roma (detti<br />
romei), e faceva parte, con l’attiguo convento, <strong>di</strong> un antico ospizio per accogliere<br />
i viandanti <strong>di</strong> passaggio. Alla fine dell’Ottocento l’e<strong>di</strong>ficio è passato in<br />
proprietà della famiglia Rovetta, cui appartiene tuttora.<br />
L’esterno presenta un profilo a capanna, con la suggestiva abside semicircolare<br />
che si è ben conservata, scan<strong>di</strong>ta da sottili lesene e impreziosita dai chiaroscuri<br />
della muratura. L’interno, che conserva tracce <strong>di</strong> affreschi del Rinascimento,<br />
ha subito <strong>di</strong>versi rimaneggiamenti che ne hanno alterato la visione d’insieme.<br />
La chiesa <strong>di</strong> Sant’Antonio da Padova, parrocchiale <strong>di</strong> Chiusure, origina<br />
dalla presenza <strong>di</strong> una provvisoria cappella baracca intitolata al santo e sistemata<br />
nella zona nel 1947, per far fronte alla crescita demografica del quartiere.<br />
La nuova chiesa, su progetto <strong>di</strong> Vittorio Montini, fu ultimata nel 1950.<br />
L’interno è decorato con due affreschi <strong>di</strong> Oscar Di Prata. Parroco della chiesa<br />
fu per un certo periodo il filippino car<strong>di</strong>nale Giulio Bevilacqua.<br />
31
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
Chiesa <strong>di</strong> Santo Spirito<br />
La storia della parrocchiale è legata alle vicende del villaggio “degli sfrattati”,<br />
sorto sulla sponda occidentale del Mella negli <strong>anni</strong> Trenta, e alla figura <strong>di</strong> don<br />
Giacomo Vender, che si pro<strong>di</strong>gò per la realizzazione <strong>di</strong> case in cui spostare le<br />
famiglie e per la costruzione <strong>di</strong> una chiesa, che venne effettivamente ultimata<br />
nel 1969 nei pressi <strong>di</strong> Ponte Crotte.<br />
L’e<strong>di</strong>ficio, con tetto a capanna, è semplice e moderno, e la facciata è giocata<br />
sul contrasto fra le linee portanti in cemento e i rivestimenti in cotto. All’interno,<br />
impostato su un’unica, ampia navata, si <strong>di</strong>stinguono le formelle con le stazioni<br />
della Via Crucis realizzate da Domenico Lusetti per la vecchia chiesetta<br />
“degli sfrattati” che un tempo sorgeva fra le baracche. Dalla stessa chiesetta<br />
proviene la porzione <strong>di</strong> affresco con l’Annunciazione della seconda metà del<br />
Quattrocento, attribuito a un pittore della cerchia <strong>di</strong> Pietro da Cemmo e donato<br />
da don Vender alla parrocchiale.<br />
32
i paRCHi<br />
2. A SPASSO PER LA OVEST<br />
Rinnovato grazie a un percorso <strong>di</strong> progettazione partecipata, con il coinvolgimento<br />
della <strong>Circoscrizione</strong> e dei residenti del quartiere, il parco delle<br />
Stagioni in via Collebeato, con un’estensione <strong>di</strong> 20 mila metri quadrati, si<br />
sviluppa attorno a un reticolo <strong>di</strong> vialetti per passeggiate inframmezzati da<br />
aree gioco e prati all’inglese. Nel riassetto del parco è stata posta particolare<br />
attenzione alle esigenze degli anziani e alla valorizzazione degli spazi <strong>di</strong> aggregazione<br />
fruibili dalla comunità.<br />
Parco delle Stagioni<br />
Il parco Gui<strong>di</strong> <strong>di</strong> via Panigada si stende su 15 mila metri quadrati ed è il<br />
fulcro <strong>di</strong> un’area residenziale sorta in prossimità della tangenziale: negli <strong>anni</strong><br />
scorsi il parco è stato interessato da un progetto complessivo <strong>di</strong> riqualificazione<br />
del verde e dei viali pedonali, con abbattimento <strong>di</strong> barriere architettoniche<br />
e realizzazione <strong>di</strong> un’area de<strong>di</strong>cata ad ospitare manifestazioni e spettacoli,<br />
che si aggiunge agli spazi gioco per bambini.<br />
33<br />
Settore Manutenzione spazi aperti - <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>
Settore Manutenzione spazi aperti - <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong><br />
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
Parco Gui<strong>di</strong> <strong>di</strong> via Panigada<br />
Di recente rinnovati sono anche i giar<strong>di</strong>ni Franzinetti nella zona <strong>di</strong> Fiumicello,<br />
risistemati con nuovi arre<strong>di</strong>, giochi per bambini, vialetti e aree sosta su<br />
una superficie <strong>di</strong> quasi 4 mila metri quadrati, valorizzata da nuovi impianti<br />
<strong>di</strong> illuminazione.<br />
Nelle a<strong>di</strong>acenze del villaggio Ba<strong>di</strong>a si estende il parco dei Poeti, ideato<br />
secondo una moderna concezione e impreziosito da sculture contemporanee<br />
intorno al suggestivo bacino d’acqua con fontana ornamentale. La progettazione<br />
architettonica del parco, che si sviluppa su una superficie <strong>di</strong> oltre 32<br />
mila metri quadrati, offre scorci insoliti e si arricchisce <strong>di</strong> attrezzature per lo<br />
sport e il <strong>di</strong>vertimento, come giochi per i più piccoli, un’area per la pallavolo<br />
e la pallacanestro e un’arena per spettacoli.<br />
Ampliano la <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> aree ver<strong>di</strong> del quartiere anche i giar<strong>di</strong>ni Ba<strong>di</strong>a<br />
<strong>Ovest</strong> - Traversa VIII e il giar<strong>di</strong>no in via Prima, entrambi estesi su una superficie<br />
<strong>di</strong> oltre 21 mila metri quadrati.<br />
34
2. A SPASSO PER LA OVEST<br />
Parco dei Poeti<br />
Al villaggio Violino un polmone verde è rappresentato dal parco della musica<br />
“John Lennon”, che si estende su un’ampia superficie <strong>di</strong> oltre 34 mila<br />
metri quadrati, costellata da aree gioco per bambini e attrezzata con spazi<br />
de<strong>di</strong>cati alla pallavolo, al calcetto e alla pallacanestro.<br />
Arricchiscono le zone ver<strong>di</strong> del Violino anche il giar<strong>di</strong>no Violino <strong>di</strong> sopra-<br />
Chiesa, con 11 mila metri quadrati <strong>di</strong> superficie, e il parco Nuovo Villaggio<br />
Violino.<br />
La collina <strong>di</strong> Sant’Anna e i monti Ratto e Picastello, invece, fanno parte del<br />
Parco delle Colline, uno spazio naturale costituito da riserve ambientali <strong>di</strong><br />
grande interesse e rarità dal punto <strong>di</strong> vista geologico e della vegetazione. L’area<br />
si estende oltre i confini citta<strong>di</strong>ni e, insieme a <strong>Brescia</strong>, coinvolge i Comuni <strong>di</strong><br />
Bovezzo, Cellatica, Collebeato, Rodengo Saiano. Grazie a interventi <strong>di</strong> recupero<br />
degli accessi e alla realizzazione <strong>di</strong> sentieri <strong>di</strong>dattici il Parco offre l’occasione<br />
per sperimentare un rapporto più stretto fra città e verde, fra uomo e natura.<br />
35<br />
Settore Manutenzione spazi aperti - <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>
Settore Manutenzione spazi aperti - <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong><br />
Settore Manutenzione spazi aperti - <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong><br />
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
Veduta <strong>di</strong> via Carretto, alle pen<strong>di</strong>ci del colle S. Anna<br />
Percorso urbano del fiume Mella<br />
36<br />
La <strong>Circoscrizione</strong> <strong>Ovest</strong> accoglie<br />
anche due gran<strong>di</strong> parchi territoriali, il<br />
Parco delle Colline e quello del Mella.<br />
L’alveo del fiume, infatti, è protetto<br />
da una sequenza <strong>di</strong> fasce ver<strong>di</strong> che<br />
fanno da filtro <strong>di</strong> compensazione fra<br />
l’area a ridosso degli argini, le zone<br />
urbanizzate circostanti e il tracciato<br />
della tangenziale.<br />
Il Parco del Mella si snoda lungo<br />
un percorso verde <strong>di</strong> 12 chilometri<br />
riservato alla fruizione <strong>di</strong> pedoni e<br />
ciclisti, e rappresenta un corridoio<br />
ambientale che connette la zona<br />
collinare con la pianura.
le Realtà Del teRRitoRio<br />
2. A SPASSO PER LA OVEST<br />
La Delegazione <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> della Fondazione ANT Italia Onlus -Associazione nazionale<br />
tumori, con sede in via della Chiesa 75, nel quartiere <strong>di</strong> Urago Mella, è<br />
una realtà attiva nell’assistenza domiciliare gratuita ai malati <strong>di</strong> tumore e nel<br />
sostegno concreto alle famiglie che vivono il dramma della malattia.<br />
L’ANT mantiene un “ospedale domiciliare oncologico” che opera sul territorio<br />
bresciano con le stesse modalità degli altri ospedali domiciliari ANT <strong>di</strong>ffusi in<br />
tutta Italia: grazie alla presenza <strong>di</strong> operatori sanitari (me<strong>di</strong>ci, psicologi, infermieri<br />
professionali, fisioterapisti) che svolgono quoti<strong>di</strong>anamente assistenza domiciliare,<br />
l’ospedale si reca a casa del sofferente, offrendo prestazioni allo stesso livello<br />
<strong>di</strong> quelle <strong>di</strong> un reparto ospedaliero tra<strong>di</strong>zionale. Il principio ispiratore è quello<br />
dell’”eubiosia”, dal greco “buona vita”, nel significato della vita con <strong>di</strong>gnità dal<br />
primo all’ultimo respiro. Gli ospedali domiciliari ANT garantiscono sulle 24 ore,<br />
festivi compresi, una completa assistenza domiciliare e tutte le terapie palliative e<br />
<strong>di</strong> supporto necessarie ad affrontare in piena <strong>di</strong>gnità le ultime fasi della vita.<br />
La Casa-famiglia “Achille Papa” <strong>di</strong> via del Santellone 2 rappresenta un innovativo<br />
modello <strong>di</strong> assistenza agli anziani, inaugurato nel 2004 alla Ba<strong>di</strong>a, nella<br />
sede della vecchia scuola Achille Papa, <strong>di</strong> proprietà comunale.<br />
Sui quattro livelli dell’e<strong>di</strong>ficio sono <strong>di</strong>stribuiti gli spazi de<strong>di</strong>cati all’aggregazione<br />
e agli eventi della <strong>Circoscrizione</strong>, un centro <strong>di</strong>urno integrato gestito dal <strong>Comune</strong>,<br />
dei mini alloggi e una casa famiglia per anziani parzialmente autosufficienti. La<br />
casa è gestita da Anteas, l’Associazione nazionale terza età attiva per la solidarietà,<br />
tramite i propri volontari coa<strong>di</strong>uvati da operatori e infermieri, per offrire<br />
agli anziani un ambiente simile a quello famigliare e un’assistenza quoti<strong>di</strong>ana,<br />
valorizzando i livelli <strong>di</strong> autonomia degli ospiti, coinvolgendoli nella gestione della<br />
casa e responsabilizzandoli nelle azioni quoti<strong>di</strong>ane.<br />
L’organizzazione del servizio è assicurata dalla presenza <strong>di</strong> personale idoneo a<br />
garantire i servizi, l’assistenza e la sorveglianza degli ospiti, in relazione ai loro<br />
bisogni e alle loro con<strong>di</strong>zioni.<br />
L’esperienza, grazie alla vicinanza con il quartiere, punta a rinsaldare i legami <strong>di</strong><br />
solidarietà con il territorio, valorizzare i rapporti umani e sperimentare una nuova<br />
socialità nella terza età.<br />
37
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
le Ville<br />
Villa San Filippo<br />
In origine denominata Villa Martinengo Palatino, fu costruita nei primi <strong>anni</strong><br />
dell’Ottocento. L’impostazione della casa doveva essere <strong>di</strong> assoluto impatto<br />
scenografico, dal momento che alla villa, immersa nella campagna, conduceva<br />
un lungo viale <strong>di</strong>retto che partiva da ponte San Giacomo sul Mella,<br />
attraversando tutto il paesaggio circostante.<br />
Successivamente, negli <strong>anni</strong> Venti del secolo scorso i Padri Filippini dell’Oratorio<br />
della Pace in<strong>di</strong>viduano nella villa la sede ideale <strong>di</strong> esercizi spirituali,<br />
adeguandola alla nuova destinazione e trasformandola in Casa San Filippo,<br />
che oggi ospita ritiri spirituali, corsi <strong>di</strong> formazione, attività scolastiche, convegni<br />
e incontri <strong>di</strong> gruppi ed associazioni. Un ampio porticato chiuso da vetrate<br />
collega i <strong>di</strong>versi ambienti, ed è intatto il bel giar<strong>di</strong>no che fa da cornice alla<br />
casa, attorniata anche da due gran<strong>di</strong> prati e un piccolo campo da calcio per<br />
attività <strong>di</strong> gioco.<br />
Fra gli eventi <strong>di</strong> rilievo ospitati da Casa San Filippo spicca la riunione della<br />
Commissione liturgica preparatoria del Concilio Vaticano II, che si svolse negli<br />
<strong>anni</strong> Sessanta nelle sale della villa bresciana.<br />
Casa dei nobili Sala<br />
In via della Chiesa, all’angolo con via Sant’Emiliano sorge la cinquecentesca<br />
villa fatta costruire dai nobili Sala, antica famiglia patrizia bresciana, oggi<br />
estinta. La villa fu per <strong>di</strong>versi secoli residenza nobiliare del casato, per poi<br />
passare alla Curia vescovile.<br />
La concezione architettonica dell’e<strong>di</strong>ficio è leggibile ancora oggi nell’elegante<br />
portico sostenuto da colonne doriche con inserti a fascia, mentre il primo<br />
piano della casa, scan<strong>di</strong>to da lesene, è ispirato a un’impostazione <strong>di</strong> gusto<br />
semplice e sobrio.<br />
Retaggi significativi dell’originario complesso sono la porta e una colonna<br />
scanalata con capitello a foglie del XV secolo.<br />
38
2. A SPASSO PER LA OVEST<br />
le paRRoCCHie Della CiRCosCRizione oVest<br />
Santa Maria Nascente<br />
Via Manara, 26<br />
Parroco don Osvaldo Resconi<br />
Telefono 0<strong>30</strong>/315103<br />
San Benedetto<br />
Via Divisione Acqui, 99<br />
Parroco don Gualtiero Pasini<br />
telefono e fax 0<strong>30</strong>/3755265<br />
San Giuseppe Lavoratore<br />
Traversa 8^, 4 Villaggio Violino<br />
Parroco don Agostino Bagliani<br />
Telefono 0<strong>30</strong>-312620<br />
Madonna del Rosario<br />
Via 1^, 81 Villaggio Ba<strong>di</strong>a<br />
Parroco don Biagio Fontana<br />
Telefono 0<strong>30</strong>/313492<br />
Sant’Antonio<br />
Via Degli Antegnati, 17<br />
Parroco don Faustino Pari<br />
Telefono 0<strong>30</strong>/311071<br />
Santo Spirito<br />
Via Don Vender, 25<br />
39<br />
Parroco don Camillo Pedretti<br />
(Vicario Zonale)<br />
Telefono 0<strong>30</strong>/310447 – 314054<br />
Natività della Beata Vergine<br />
Via della Chiesa, 126 Urago Mella<br />
Parroco don Francesco (Gigi) Bonfa<strong>di</strong>ni<br />
Telefono e fax 0<strong>30</strong>/<strong>30</strong>1334<br />
Divin Redentore<br />
Via Della Pendolina, 4<br />
Parroco don Mauro Assoni<br />
telefono e fax 0<strong>30</strong>/396284<br />
Sant’Anna<br />
Via B. Bonini, 26<br />
Parroco don Faustino Pari<br />
Telefono 0<strong>30</strong>/311071<br />
San Giacomo<br />
Via Denari, 5<br />
Parroco don Fulvio Ghilar<strong>di</strong><br />
Telefono 0<strong>30</strong>/315504<br />
Santa Giovanna Antida<br />
Via Quinta, 51 Quartiere Abba<br />
Parroco padre Giulio Pase<br />
telefono e fax 0<strong>30</strong>/310908
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
le assoCiazioni Della CiRCosCRizione oVest<br />
A.N.A. Ba<strong>di</strong>a<br />
Trav. XII n. 54 Villaggio Sereno<br />
Telefono 0<strong>30</strong>347570<br />
Amici delle bocce<br />
Via Stampatori 35<br />
Telefono 0<strong>30</strong>3731424<br />
Bocciofila Bocchio<br />
CRS Ba<strong>di</strong>a ASD<br />
Via Stampatori n. 23<br />
Telefono 0<strong>30</strong>3731313<br />
Gruppo alpinisti Ba<strong>di</strong>a<br />
Via XIII, 19 Villaggio Ba<strong>di</strong>a<br />
Telefono 0<strong>30</strong>313<strong>30</strong>3<br />
Associazione Antico Co<strong>di</strong>ce<br />
Via XV, 16 Villaggio Ba<strong>di</strong>a<br />
Telefono 0<strong>30</strong>312614<br />
Protezione civile Oltremella<br />
Traversa IV, 5 Villaggio Ba<strong>di</strong>a<br />
Telefono 3357501270<br />
40<br />
Gruppo ricerca Ba<strong>di</strong>a Trenta<br />
Trav. XX villaggio Ba<strong>di</strong>a, 11<br />
Telefono 0<strong>30</strong>320463<br />
Scuola vita familiare Ba<strong>di</strong>a<br />
Via XIII , 59 Villaggio Ba<strong>di</strong>a<br />
Telefono 0<strong>30</strong>313759<br />
Avis Ba<strong>di</strong>a<br />
Mandolossa<br />
Via XI, 119 - Villaggio Ba<strong>di</strong>a<br />
Telefono 0<strong>30</strong>-310774<br />
La Diade Associazione culturale<br />
Via del Santellone, 120<br />
Telefono 0<strong>30</strong>314222<br />
Agesci Gruppo BS 4<br />
Oratorio S. Spirito<br />
Via Don Vender 40<br />
Telefono 0<strong>30</strong><strong>30</strong>4331<br />
A.I.G.O.<br />
Via Bazoli 10<br />
Telefono 0<strong>30</strong>3737028
2. A SPASSO PER LA OVEST<br />
le assoCiazioni Della CiRCosCRizione oVest<br />
Acli Circolo S. Anna<br />
Piazzale Maestri del Lavoro<br />
Telefono 0<strong>30</strong>312711<br />
Associazione Carlo<br />
Marchini Onlus<br />
Via L. Baitelli, 28<br />
Telefono 0<strong>30</strong>322141<br />
ANPI S. Anna - Chiusure<br />
Via del Franzone 124<br />
Telefono 0<strong>30</strong>313684<br />
Associazione nazionale<br />
mutilati e invali<strong>di</strong><br />
Via Rotonda Montiglio n. 6<br />
Telefono 0<strong>30</strong>396900<br />
Gruppo donne 8 marzo<br />
Via Privata Silva, 12<br />
Telefono 0<strong>30</strong>311164<br />
Caritas parrocchie S. Anna,<br />
S. Antonio, S. Giacomo<br />
Via del Franzone 66<br />
Telefono 0<strong>30</strong>320993<br />
41<br />
Associazione botanica bresciana<br />
Via Canevali, 10<br />
Telefono 334614<strong>30</strong>05<br />
Centro stu<strong>di</strong><br />
G. Rosa<br />
Via Baitelli 40<br />
Telefono 339701669<br />
Centro ascolto Caritas<br />
Via Don Vender 31<br />
Telefono 0<strong>30</strong>314967<br />
Circolo lirico culturale<br />
“L. Dordoni”<br />
Via Canevali 14<br />
Telefono 0<strong>30</strong>318771<br />
Circolo ARCI La Meri<strong>di</strong>ana<br />
Via Risorgimento, 18<br />
Telefono 0<strong>30</strong><strong>30</strong>99066<br />
ACLI Urago Mella<br />
Via Risorgimento, 37<br />
Telefono 0<strong>30</strong><strong>30</strong>5967
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
le assoCiazioni Della CiRCosCRizione oVest<br />
A.N.P.I. Sezione<br />
Urago Mella - OM Iveco<br />
Via Don Vender, 105<br />
Telefono 0<strong>30</strong>390907<br />
Associazione Insieme Terza Età<br />
Via S. Emiliano, 2<br />
Telefono 0<strong>30</strong>382<strong>30</strong>9<br />
Associazione nazionale<br />
carristi d’Italia<br />
Via S. Emiliano, 2<br />
Telefono 0<strong>30</strong>311393<br />
Corpo ban<strong>di</strong>stico<br />
Urago Mella<br />
Via S. Emiliano 2<br />
Telefono 0<strong>30</strong>391394<br />
C.O.D.A.<br />
Via Zuccari, 14<br />
Telefono 0<strong>30</strong>392656<br />
Caritas S. Giovanna Antida<br />
Via Quinta, 51 Q.re Abba<br />
Telefono 0<strong>30</strong>310624<br />
42<br />
Combattenti e reduci<br />
Via 13^, 4 Q.re Abba<br />
Telefono 0<strong>30</strong>392114<br />
Associazione Alcolisti Anonimi<br />
Via del Molino, 37<br />
Telefono 3484928802<br />
C.S.I. “Comitato genitori<br />
Urago Mella”<br />
Via del Molino, 2<br />
Telefono 0<strong>30</strong>394618<br />
Federazione dei Maestri<br />
del Lavoro d’Italia<br />
Via Collebeato, 19<br />
Telefono 0<strong>30</strong>6597709<br />
Gruppo artisti La Pieve<br />
Via Zuccari, 18/b<br />
Telefono 0<strong>30</strong>393954<br />
Gruppo sportivo Urago Mella<br />
Via Ragazzi del ‘99, 26<br />
Telefono 0<strong>30</strong>3389887
2. A SPASSO PER LA OVEST<br />
le assoCiazioni Della CiRCosCRizione oVest<br />
A.S.D. Gruppo Po<strong>di</strong>sti<br />
Urago Mella<br />
Via della Chiesa, 146<br />
Telefono 0<strong>30</strong><strong>30</strong>3424<br />
Polisportiva. Euplo Natali<br />
Via Risorgimento, 18<br />
Telefono 0<strong>30</strong>393937<br />
USO Urago Mella<br />
Traversa II,2 Q.re abba<br />
Telefono 0<strong>30</strong>391861<br />
A.N.M.I. <strong>Brescia</strong><br />
Via I, 19 - Q.re Abba<br />
Telefono 0<strong>30</strong>3750488<br />
A.S.D. Gruppo po<strong>di</strong>stico<br />
Così…..per sport<br />
Via Panigada 18<br />
Telefono 0<strong>30</strong>318038<br />
Associazione <strong>di</strong> promozione<br />
sociale Curiosarte<br />
Via Zuccari, 18/c<br />
Telefono 0<strong>30</strong>21<strong>30</strong>184<br />
43<br />
Associazione “Insieme nella<br />
solidarietà” Parrocchia Pendolina<br />
Via del Molino, 2<br />
Telefono 0<strong>30</strong>396284<br />
Centro <strong>Brescia</strong>no Down<br />
Via della Trisia, 3 Villaggio Violino<br />
Telefono 0<strong>30</strong>3731416<br />
Circolo combattenti<br />
e reduci Violino<br />
Via IV n. 53 Villaggio Violino<br />
Telefono 3395922781<br />
Gruppo fotografico<br />
“O. Marcolini”<br />
Via Re Rotari, 47<br />
Telefono 0<strong>30</strong>3732010<br />
Gruppo raccolta<br />
Violino<br />
Via IX, 11 Villaggio Violino<br />
Telefono 0<strong>30</strong>3739745
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
le assoCiazioni Della CiRCosCRizione oVest<br />
Gruppo riferimento<br />
Quartiere Violino<br />
Via Re Desiderio, 3<br />
Telefono 0<strong>30</strong>3731850<br />
Associazione<br />
“Il Pomerio”<br />
Via della Trisia, <strong>30</strong><br />
Telefono 0<strong>30</strong>3739781<br />
Associazione nazionale<br />
famiglie numerose<br />
Via XXI, 1 - Villaggio Violino<br />
Telefono 0<strong>30</strong>317122<br />
Arciragazzi<br />
Via L. Manara 5/A<br />
Telefono 0<strong>30</strong>3737073<br />
Gruppo volontariato<br />
assistenza sociale Fiumicello<br />
Via L. Manara 26<br />
Telefono 0<strong>30</strong>315103<br />
44<br />
A.V.O. Associazione Volontari<br />
Ospedalieri<br />
Via Cocchetti, 24<br />
Telefono 0<strong>30</strong>3758744<br />
Gruppo Alpini Fiumicello<br />
Via Panigada 17<br />
Telefono 0<strong>30</strong>3753228<br />
WWF <strong>Brescia</strong><br />
Via Cocchetti, 11<br />
Telefono 0<strong>30</strong>/2400818
2. A SPASSO PER LA OVEST<br />
45
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE 2. A SPASSO - L’esperienza PER LA OVEST delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
I primi collegamenti via bus al Villaggio Ba<strong>di</strong>a Archivio Centro Stu<strong>di</strong> La Famiglia<br />
46
3. ALLE ORIGINI DEL DECENTRAMENTO<br />
Capitolo 3<br />
Alle origini del decentramento<br />
Dai CoMitati spontanei ai Consigli Di QUaRtieRe<br />
La lunga storia della <strong>partecipazione</strong> a <strong>Brescia</strong><br />
Le prime esperienze <strong>di</strong> <strong>partecipazione</strong> nei quartieri risalgono al 1965, in particolare<br />
a San Polo oltre che nell’area nord con Borgo Trento, San Bartolomeo,<br />
Mompiano e Villaggio Prealpino. Si trattava però <strong>di</strong> episo<strong>di</strong> a sé stanti, temporanei<br />
e senza organicità, in cui i residenti facevano gruppo per risolvere<br />
qualche specifico problema <strong>di</strong> quartiere.<br />
L’avvio del movimento <strong>di</strong> quartiere vero e proprio viene datato al 1967, quando<br />
proprio a San Polo, nel mese <strong>di</strong> gennaio, si costituisce il primo comitato<br />
<strong>di</strong> quartiere della città, che organizza la sua prima iniziativa in febbraio, una<br />
tavola rotonda sui problemi del borgo abitato, con la <strong>partecipazione</strong> degli<br />
assessori ai Lavori pubblici e all’Urbanistica. A breve <strong>di</strong>stanza, nel mese <strong>di</strong><br />
marzo, si terrà la prima assemblea del secondo comitato, nato a Mompiano.<br />
All’interno dei comitati si <strong>di</strong>scute dei problemi più rilevanti della zona, e<br />
presto si fa sentire il desiderio <strong>di</strong> trasformarli in consigli <strong>di</strong> quartiere, con<br />
l’intento <strong>di</strong> dar vita a un organismo solido e rappresentativo, capace <strong>di</strong> <strong>di</strong>ventare<br />
protagonista delle battaglie più importanti, come quelle per la casa,<br />
i trasporti, la scuola e i servizi. I quartieri capofila del movimento per la<br />
creazione <strong>di</strong> questi nuovi organismi furono quelli della periferia citta<strong>di</strong>na, da<br />
Sant’Eufemia a Urago, da Folzano a Lamarmora, dal quartiere Don Bosco al<br />
Villaggio Prealpino, che erano anche i più penalizzati perché carenti <strong>di</strong> strutture<br />
sociali e servizi.<br />
Bisognerà attendere l’inizio degli <strong>anni</strong> Settanta per passare dalla spontaneità<br />
iniziale del movimento, ancora troppo frammentato per riuscire a interloquire<br />
con l’amministrazione comunale, ad una fase <strong>di</strong> maturazione: fu in quel periodo<br />
che i comitati <strong>di</strong> quartiere si dotarono <strong>di</strong> statuti che ponevano l’assemblea<br />
47
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
dei citta<strong>di</strong>ni al centro delle attività decisionali, e che stabilivano le modalità<br />
<strong>di</strong> elezione dei futuri consigli <strong>di</strong> quartiere, che avrebbero rappresentato<br />
l’organismo esecutivo dell’assemblea.<br />
In molte zone, fra cui Urago Mella, si optò per l’elezione <strong>di</strong>retta in seno<br />
all’assemblea dei residenti, mentre in altri quartieri, come l’area <strong>di</strong> via Chiusure,<br />
si procedette a vere e proprie elezioni a suffragio universale: ai quattro<br />
turni elettorali promossi nei <strong>di</strong>versi rioni <strong>di</strong> Chiusure, da febbraio a maggio<br />
del 1971, parteciparono 1700 citta<strong>di</strong>ni. Alla fine del 1970 erano già operanti<br />
cinque Consigli <strong>di</strong> quartiere, fra cui quello <strong>di</strong> Urago Mella, mentre erano imminenti<br />
le elezioni al villaggio Violino e a Chiusure, e un significativo movimento<br />
<strong>di</strong> <strong>partecipazione</strong> si stava consolidando al villaggio Ba<strong>di</strong>a.<br />
Nei quartieri stava crescendo l’interesse a partecipare alle scelte <strong>di</strong> amministrazione<br />
citta<strong>di</strong>na, tanto che in una riunione del Consiglio <strong>di</strong> Mompiano, nel<br />
<strong>di</strong>cembre del 1970, vennero messi a fuoco due punti car<strong>di</strong>nali attorno a cui<br />
sarebbe ruotata la riven<strong>di</strong>cazione dei Consigli: fu avanzata la possibilità <strong>di</strong><br />
analizzare i bilanci del <strong>Comune</strong> e si espresse il desiderio <strong>di</strong> intervenire sulle<br />
scelte urbanistiche che interessavano la zona.<br />
Nel giugno del 1971 nacque anche il Comitato <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento fra i quartieri,<br />
ritenuto un passaggio in<strong>di</strong>spensabile per acquisire omogeneità <strong>di</strong> azione<br />
e rappresentatività. Il coor<strong>di</strong>namento chiedeva esplicitamente un riconoscimento<br />
ufficiale dei Consigli <strong>di</strong> quartiere da parte del <strong>Comune</strong>, e l’assegnazione<br />
<strong>di</strong> mezzi e strumenti (come le se<strong>di</strong>) per poter espletare al meglio il loro<br />
ruolo.<br />
L’atteso riconoscimento da parte del Consiglio comunale arrivò il 28 luglio del<br />
1972, con la previsione <strong>di</strong> un periodo <strong>di</strong> “sperimentazione” <strong>di</strong> 18 mesi, e la<br />
programmazione nei quartieri <strong>di</strong> elezioni a suffragio universale (con l’estensione<br />
del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto ai <strong>di</strong>ciottenni, nonostante la maggiore età fosse allora<br />
fissata a ventuno <strong>anni</strong>) con lista unica aperta a tutti i citta<strong>di</strong>ni.<br />
Fra il 1973 e il 1974 vennero eletti <strong>30</strong> Consigli <strong>di</strong> quartiere. Le zone dell’attuale<br />
circoscrizione <strong>Ovest</strong> in cui si inse<strong>di</strong>arono Consigli furono quartieri piccoli<br />
come il villaggio Ba<strong>di</strong>a, il villaggio Violino e il quartiere Primo Maggio,<br />
che avevano meno <strong>di</strong> 5 mila abitanti, aree <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a <strong>di</strong>mensione - come il<br />
quartiere <strong>di</strong> Fiumicello - e inse<strong>di</strong>amenti più popolosi come Chiusure e Urago<br />
Mella, che superavano i 10 mila residenti.<br />
48
3. ALLE ORIGINI DEL DECENTRAMENTO<br />
Una volta terminato il periodo <strong>di</strong> “sperimentazione”, il coor<strong>di</strong>namento dei<br />
quartieri avviò un confronto con l’amministrazione comunale per delineare<br />
un regolamento con<strong>di</strong>viso, che co<strong>di</strong>ficasse le competenze assegnate ai Consigli<br />
<strong>di</strong> quartiere. Da parte <strong>di</strong> questi ultimi, <strong>di</strong> pari passo con il ra<strong>di</strong>camento in<br />
città, cresceva l’interesse a partecipare da protagonisti alle decisioni sui no<strong>di</strong><br />
amministrativi, sociali e urbanistici.<br />
Una vera svolta per i quartieri sarà l’approvazione in <strong>Comune</strong> dell’atteso<br />
regolamento nell’aprile del 1975, che recepiva molte delle istanze avanzate<br />
dal coor<strong>di</strong>namento dei Consigli, prevedendo la consultazione obbligatoria <strong>di</strong><br />
questi ultimi su alcuni temi centrali per la vita amministrativa citta<strong>di</strong>na, quali<br />
i bilanci comunali <strong>di</strong> previsione, i piani regolatori, le convenzioni urbanistiche,<br />
i piani <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia economica e popolare, l’informazione obbligatoria sulle<br />
richieste <strong>di</strong> licenze e<strong>di</strong>lizie riguardanti il quartiere, la facoltà <strong>di</strong> proposta <strong>di</strong><br />
iniziative idonee per i servizi sociali <strong>di</strong> zona.<br />
La normativa prendeva atto del ruolo riconosciuto <strong>di</strong> fatto ai Consigli <strong>di</strong> quartiere,<br />
che avevano già contribuito alla <strong>di</strong>scussione sulla variante al Piano<br />
regolatore approvata dal <strong>Comune</strong> nel giugno del 1973, che aveva nel complesso<br />
recepito le istanze proposte dai quartieri: fra queste la necessità <strong>di</strong><br />
salvaguardare l’area delle colline, con l’imposizione <strong>di</strong> un vincolo <strong>di</strong> tutela<br />
per Sant’Anna e la Maddalena, e per la parte del colle San Giuseppe ancora<br />
libera da convenzioni <strong>di</strong> lottizzazione.<br />
Nel frattempo anche il Parlamento stava affrontando la questione della<br />
<strong>partecipazione</strong> “dal basso” ai temi amministrativi locali, che si sarebbe<br />
tradotta nella legge nazionale sul decentramento, la n. 278 dell’aprile 1976,<br />
che prevedeva la possibilità per i Comuni <strong>di</strong> <strong>di</strong>videre il proprio territorio in<br />
Circoscrizioni.<br />
Dopo un decennio <strong>di</strong> esperienza partecipativa, anche <strong>Brescia</strong> intraprese il<br />
cammino che porterà, nell’aprile del 1977, ad approvare il regolamento locale<br />
attuativo della legge.<br />
Con questo passaggio il Consiglio comunale introdusse la sud<strong>di</strong>visione territoriale<br />
in nove Circoscrizioni al posto dei trenta quartieri originari, accorpando<br />
Chiusure, Urago Mella, villaggio Ba<strong>di</strong>a e villaggio Violino nella Terza<br />
<strong>Circoscrizione</strong>, mentre Fiumicello e Primo Maggio (con l’aggiunta <strong>di</strong> Porta<br />
Milano) formeranno la Quarta <strong>Circoscrizione</strong>.<br />
49
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
Nella primavera del 1978 vennero eletti dal Consiglio comunale i primi Consigli<br />
<strong>di</strong> <strong>Circoscrizione</strong>, che rimasero in carica fino al 1980 quando, in contemporanea<br />
con le elezioni in Loggia, a suffragio universale i bresciani votarono<br />
il rinnovo dei Consigli <strong>di</strong> <strong>Circoscrizione</strong>.<br />
La ripartizione del territorio urbano in nove Circoscrizioni è rimasta valida<br />
fino alla riforma del decentramento comunale votata in Loggia nell’ottobre<br />
del 2007 - ed entrata formalmente in vigore con le elezioni amministrative<br />
della primavera 2008 - che ha ridotto il numero delle Circoscrizioni da nove a<br />
cinque (denominate Centro, Nord, Est, <strong>Ovest</strong>, Sud). Nella <strong>Circoscrizione</strong> <strong>Ovest</strong><br />
sono state unite le originarie Terza e Quarta <strong>Circoscrizione</strong> con i relativi quartieri,<br />
ad esclusione <strong>di</strong> Porta Milano, che è stata annessa alla <strong>Circoscrizione</strong><br />
Centro.<br />
50
3. ALLE ORIGINI DEL DECENTRAMENTO<br />
i pResiDenti Della teRza CiRCosCRizione<br />
1979-1980 • Luigi Daffini (Pci)<br />
Nato il 5 aprile del 1949, a <strong>Brescia</strong>, architetto e sposato<br />
con tre figli, è scomparso il 12 luglio del 2005<br />
dopo una lunga malattia, lasciando <strong>di</strong>etro <strong>di</strong> sé un<br />
ricordo particolarmente positivo per la sua voglia <strong>di</strong><br />
impegnarsi all’interno del sociale, come in politica e<br />
nella sua professione.<br />
Originario del Violino Daffini, spinto da un’immancabile voglia <strong>di</strong> fare e <strong>di</strong><br />
mettersi in gioco, fu subito attivo all’interno dei neonati consigli <strong>di</strong> quartiere<br />
<strong>di</strong>venendone presidente. Con l’istituzionalizzazione delle circoscrizioni Daffini<br />
viene incaricato <strong>di</strong> coprire la carica <strong>di</strong> presidente dell’”Oltremella”. Sarà il<br />
primo presidente <strong>di</strong> circoscrizione a celebrare un matrimonio civile.<br />
Il legame con il territorio, in cui viveva, quello del Violino, e la sua vicinanza<br />
con la parte più popolare della società, unite alle sue doti professionali, lo<br />
spingeranno ad abbandonare la sua professione <strong>di</strong> tecnico comunale per avvicinarlo<br />
al mondo delle cooperative, all’interno del quale fu particolarmente<br />
attivo e che contribuì a sviluppare in maniera consistente. Tra i suoi interventi<br />
è da ricordare la scuola elementare <strong>di</strong> Mairano, il piano <strong>di</strong> recupero “della<br />
Cudol” <strong>di</strong> Gussago e, soprattutto, quelli <strong>di</strong> carattere economico popolare, trai<br />
quali spiccano, ovviamente, le villette bifamiliari del suo Violino. Nel 1984<br />
Daffini entra in consiglio comunale nelle file del Pci, operando in particolare<br />
nella commissione urbanistica. Resterà in Loggia sino al 1990 quando, nonostante<br />
l’impegno, verrà “fatto fuori” dalle <strong>di</strong>namiche <strong>di</strong> partito. L’impegno nel<br />
sociale <strong>di</strong> Daffini proseguirà, comunque, anche dopo l’esperienza politica. Tra<br />
le sue numerose iniziative merita <strong>di</strong> essere ricordata l’attività <strong>di</strong> Luigi Daffini<br />
a Capoverde, che fornirà un notevole contributo allo sviluppo del settore<br />
turistico dell’arcipelago africano.<br />
51
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
1980-1985/1985-1990 • Maria Cipriano (Psi)<br />
Classe 1947, originaria <strong>di</strong> Casalnuovo in provincia <strong>di</strong><br />
Foggia, coniugata con Mariano Comini, ex assessore alla<br />
cultura in Loggia, si <strong>di</strong>ploma all’istituto magistrale <strong>di</strong> Lucera<br />
nel 1967.<br />
Vinto il concorso l’anno successivo si trasferisce a <strong>Brescia</strong><br />
ed entra come insegnate elementare <strong>di</strong> ruolo nella scuola<br />
<strong>di</strong> Pie<strong>di</strong>vizzo.<br />
Proveniente dall’ambiente dei sindacati e sensibilmente toccata dalla tragica esperienza<br />
<strong>di</strong> Piazza Loggia decide <strong>di</strong> entrare nel Psi, partito con il quale si can<strong>di</strong>da,<br />
poi, nell’80, al consiglio circoscrizionale della terza, affascinata dall’esperienza della<br />
<strong>partecipazione</strong>. Eletta presidente resta in carica per due mandati. Il suo impegno<br />
fu, soprattutto, destinato a fare comunità ed a migliorare i servizi al citta<strong>di</strong>no. Sua<br />
l’intuizione <strong>di</strong> creare in terza una rete tra le associazioni, come <strong>di</strong> puntare sul Parco<br />
delle Colline per migliorare l’ambiente e la vivibilità della zona.<br />
Dopo “Mani pulite”, e la sostanziale scomparsa del Psi, cerca <strong>di</strong> intraprendere un<br />
nuovo percorso politico che, tuttavia, la lascia insod<strong>di</strong>sfatta. Con la rinascita del Psi<br />
Maria Cipriano ritorna con entusiasmo in prima linea, entrando nel <strong>di</strong>rettivo del suo<br />
partito a livello provinciale.<br />
Vissuto da consigliere, con Martinuz presidente, lo scorso mandato in circoscrizione,<br />
si è presentata con la lista a sostegno <strong>di</strong> Laura Castelletti nelle recenti amministrative,<br />
sia in circoscrizione che in consiglio, senza, tuttavia, riuscire ad essere eletta.<br />
1990-1995 • Francesco Rossi (Dc)<br />
Nato a <strong>Brescia</strong> l’8 giugno del ’42, coniugato con due figli,<br />
Francesco Rossi, attualmente è pensionato, dopo una vita<br />
passata a lavorare come tecnico Telecom, dopo aver vissuto<br />
i vari passaggi e cambiamenti dell’azienda. Interessato<br />
da subito alla <strong>partecipazione</strong> si avvicina ai comitati<br />
<strong>di</strong> quartiere come citta<strong>di</strong>no, benché già interessato alla<br />
politica e tesserato con la Democrazia Cristiana. Proprio per questo, nel momento,<br />
52
3. ALLE ORIGINI DEL DECENTRAMENTO<br />
dell’istituzionalizzazione delle circoscrizioni si presenta per entrare nel consiglio <strong>di</strong><br />
circoscrizione venendo eletto.<br />
Rossi vive il decennio <strong>di</strong> presidenza della <strong>di</strong> Maria Cipriano, come consigliere impegnato<br />
nella commissione urbanistica. Nel frattempo il suo impegno civile e sociale<br />
si muove anche sul fronte dell’istruzione e della scuola: sono gli <strong>anni</strong> dei decreti<br />
delegati ed il futuro presidente <strong>di</strong> circoscrizione occupa, per un certo periodo, anche<br />
la carica <strong>di</strong> presidente <strong>di</strong> circolo.<br />
Nel 1990, forte <strong>di</strong> una particolare esperienza maturata in circoscrizione, Rossi viene<br />
eletto nuovamente in consiglio e nominato presidente. In quegli <strong>anni</strong> sono due le<br />
tematiche che stanno maggiormente a cuore del neo presidente: da un lato lavorare<br />
a favore <strong>di</strong> una <strong>partecipazione</strong> reale, utilizzando la circoscrizione come ricettore delle<br />
esigenze dei suoi abitanti, dall’altro creando spazi aggregativi ed impegnandosi<br />
per il sociale, con una particolare attenzione a giovani, anziani e stranieri. La nascita<br />
della Piastra Pendolina e del centro anziani “Ferrante Aporti”.<br />
Nel ’95 <strong>di</strong>viene consigliere comunale, dopo che il Ppi ha raccolto l’ere<strong>di</strong>tà della Dc,<br />
continuando, comunque, ad interessarsi <strong>di</strong> circoscrizioni anche in questo periodo,<br />
proprio per il suo lavoro all’interno della commissione statuto.<br />
Attualmente è membro esterno della commissione urbanistica in circoscrizione<br />
ovest e volontario dell’associazione per anziani Antares.<br />
1995-1999/1999-2003 • Laura Parenza (ds)<br />
Laura Parenza nasce nel 1957 in via Berardo Maggi, single,<br />
impiegata presso l’Arca Enel, si avvicina giovanissima<br />
alla politica impegnandosi attivamente nella federazione<br />
giovanile comunista all’indomani della strage <strong>di</strong> Piazza<br />
Loggia. Attiva nella sezione dell’Oltremella, zona della città<br />
in cui si trasferisce sin dalla giovane età, del Pci, viene<br />
eletta in consiglio circoscrizionale sotto la presidenza <strong>di</strong> Francesco Rossi, <strong>di</strong>venendo<br />
coor<strong>di</strong>natrice della commissione sevizi alla persona. In quegli <strong>anni</strong> lavora, soprattutto,<br />
per attivare il consultorio <strong>di</strong> via Paganini e per creare un rapporto continuativo<br />
con Asl, in particolare per quanto concerne l’assistenza domiciliare integrata.<br />
Al successivo appuntamento elettorale la Parenza viene confermata all’interno del<br />
53
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
consiglio e, successivamente, eletta presidente della terza circoscrizione. La sua attenzione<br />
sarà de<strong>di</strong>cata alla valorizzazione della <strong>partecipazione</strong> e delle risorse del<br />
territorio, particolarmente propenso all’associazionismo. Importante il contributo<br />
fornito dalla Parenza per quanto riguarda il centro sportivo della Ba<strong>di</strong>a, la piastra<br />
Pendolina ed il centro per anziani ex Ferrante Aporti come, da non <strong>di</strong>menticare, è<br />
l’impegno messo in campo per creare una rete partecipata con le scuole.<br />
Dopo due mandati consecutivi come presidente Laura Parenza sceglie <strong>di</strong> provare<br />
l’esperienza del consiglio comunale ed all’interno <strong>di</strong> questo viene eletta nel 2003.<br />
Sino al 2008 la Parenza resta, così, in Loggia lavorando proprio all’interno della<br />
commissione decentramento, <strong>partecipazione</strong> e sicurezza. Il 7 giugno 2009 viene<br />
eletta consigliere provinciale tra le file del Pd.<br />
2003-2008 • Alberto Martinuz (Margherita)<br />
Nato a <strong>Brescia</strong> il 15 novembre del 1962, coniugato e residente<br />
al Villaggio Violino, Alberto Martinuz è laureato<br />
alla Facoltà <strong>di</strong> Scienze agrarie all’Università degli stu<strong>di</strong><br />
<strong>di</strong> Milano e <strong>di</strong>plomato in Scienze religiose all’Università<br />
Cattolica <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>. Attualmente è consigliere comunale,<br />
eletto nelle liste del Partito Democratico, ed è segretario<br />
della Commissione consiliare “Istruzione, cultura e sport e politiche giovanili” oltre<br />
che membro della Commissione consiliare “Bilancio, programmazione, tributi e rapporti<br />
con le aziende partecipate”. Inscritto all’Azione Cattolica adulti, alla Cisl scuola,<br />
è stato membro del Consiglio Scolastico Provinciale <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>, Consigliere della Terza<br />
<strong>Circoscrizione</strong> e Consigliere Comunale del Partito Popolare Italiano dal 1998 al 2003<br />
dove ha presieduto la Commissione Consiliare “Istruzione, cultura e sport e politiche<br />
giovanili”.<br />
Eletto Presidente della terza circoscrizione tra il 2003 ed il 2008 si è <strong>di</strong>stinto durante<br />
la sua amministrazione per una particolare attenzione ai progetti partecipati,<br />
tra i quali spiccano “Accor<strong>di</strong>amo il Violino” ed il progetto giovanile Volont@riando,<br />
iniziative che <strong>di</strong>mostrano come il suo impegno sia stato destinato ad interventi <strong>di</strong><br />
riqualificazione e valorizzazione delle periferie.<br />
E’ membro costituente a livello regionale del Partito Democratico.<br />
54
3. ALLE ORIGINI DEL DECENTRAMENTO<br />
i pResiDenti Della QUaRta CiRCosCRizione<br />
1979-1985 • Serafino Tregambe (Psi)<br />
Nato a Gussago nel 1941, coniugato con due figli, Serafino<br />
Tregambe, si trasferisce a <strong>Brescia</strong>, a 24 <strong>anni</strong>, vivendo<br />
prima al Prealpino, poi per lunga parte della sua vita a Fiumicello.<br />
Oggi è pensionato dopo <strong>30</strong> <strong>anni</strong> passati come infermiere<br />
<strong>di</strong>rigente a Chiari. Avvicinatosi, nei primi <strong>anni</strong> ’70,<br />
al Psi, in particolare alla sezione citta<strong>di</strong>na <strong>di</strong> Porta Milano,<br />
viene scelto dagli accor<strong>di</strong> tra i partiti come presidente <strong>di</strong> circoscrizione nel momento<br />
della loro istituzionalizzazione. Al primo vero appuntamento elettorale viene rieletto<br />
presidente. Durante la sua presidenza si interessò, soprattutto, <strong>di</strong> problemi sanitari ed<br />
ambientali, in particolare, quelli legate alle realtà produttive della zona ed alle note<br />
problematiche <strong>di</strong> vivibilità ed inquinamento generate, in primis, dalla Caffaro.<br />
1985-1990 • Luigi Beccalossi (Dc)<br />
Nato alla Volta nel 1927, coniugato con quattro figli, a<br />
soli due <strong>anni</strong> si trasferisce nel quartiere Mazzucchelli a<br />
Fiumicello, dove ancora oggi risiede, godendosi la vita da<br />
nonno e da pensionato, dopo quarant’<strong>anni</strong> <strong>di</strong> acciaieria<br />
come responsabile chimico. Dal punto <strong>di</strong> vista politico<br />
Beccalossi si avvicina alla Democrazia cristiana, appena<br />
finita la guerra, a soli <strong>di</strong>ciotto <strong>anni</strong>. Il suo interesse è sempre stato de<strong>di</strong>cato<br />
all’impegno sociale all’interno dei quartieri, per questo, eletto presidente grazie ad<br />
un accordo tra democristiani e comunisti, si occupò, soprattutto, <strong>di</strong> valorizzare le<br />
circoscrizioni come punto <strong>di</strong> riferimento della comunità e come mezzo <strong>di</strong> <strong>partecipazione</strong><br />
reale dei citta<strong>di</strong>ni. Al termine dell’esperienza politica si è de<strong>di</strong>cato alla propria<br />
professione ed alla propria famiglia.<br />
55
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
1990-1991 ) • Luciano Donini (Pci)<br />
Nato nel 1947, geometra, coniugato, oggi è in pensione<br />
dopo aver lavorato come impiegato all’Atb.<br />
Avvicinatosi all’impegno politico nei primi <strong>anni</strong> ’70,<br />
Donini ottiene la tessera sindacale della Cgil e, nello<br />
stesso anno, quella del Pci. Per un certo periodo, per<br />
il partito, sarà segretario della sezione <strong>di</strong> Fiumicello<br />
Romano Gheda. Conosciuta l’esperienza <strong>di</strong> comitati e consigli <strong>di</strong> quartiere<br />
viene eletto all’interno del consiglio della quarta, dove opererà all’interno<br />
delle commissione tempo libero ed urbanistica. Si avvicenderà a Beccalossi<br />
proprio per lo stesso accordo Dc-Pci che aveva portato alla presidenza il suo<br />
predecessore. Nei due <strong>anni</strong> in cui vestirà la carica <strong>di</strong> presidente Donini sarà,<br />
soprattutto, impegnato nel cercare soluzioni alla questione Caffaro, cercando<br />
<strong>di</strong> tutelare il territorio ed i suoi abitanti nella <strong>di</strong>fficile convivenza con le realtà<br />
produttive del quartiere. Resterà in circoscrizione, come consigliere, sia con<br />
Zola che con Margaroli. Attualmente è membro esterno della commissione<br />
urbanistica della circoscrizione nord.<br />
1991-1995 • Costantino Corsini (Dc)<br />
Classe 1952, coniugato con figli, Costantino Corsini<br />
è laureato in me<strong>di</strong>cina ed attualmente è me<strong>di</strong>co dello<br />
sport dopo una lunga esperienza come anestesista<br />
all’Ospedale Civile <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>.<br />
Cresciuto politicamente nelle file della Dc si avvicina<br />
subito al nuovo fenomeno delle circoscrizioni e vive<br />
quest’esperienza come consigliere durante i mandati <strong>di</strong> Beccalossi e Donini.<br />
Nel 1991 è eletto presidente e come i suoi predecessori si troverà ad affrontare<br />
le gravi problematiche ambientali che caratterizzavano e caratterizzano<br />
ancora oggi questa zona della città, per <strong>anni</strong> legata a numerose attività indu-<br />
56
3. ALLE ORIGINI DEL DECENTRAMENTO<br />
striali. Terminato il mandato Corsini prova l’esperienza in consiglio comunale<br />
e riesce ad entrarvi come primo dei non eletti. L’esperienza dura un anno,<br />
tempo <strong>di</strong> finire il mandato. Deluso dall’esperienza politica i Loggia, Corsini si<br />
allontana dal suo partito <strong>di</strong> origine per avvicinarsi a nuove esperienze. Dopo<br />
qualche anno <strong>di</strong> allontanamento dalla scena politica ha aderito all’esperienza<br />
del Fronte sociale nazionale, partito nato nel ’97 e successivamente confluito<br />
nella Destra.<br />
Attualmente Corsini svolge il suo lavoro <strong>di</strong> me<strong>di</strong>co interessandosi alla politica<br />
da esterno.<br />
1995-1999 • Camillo Zola (Fi)<br />
Nato a <strong>Brescia</strong> il 26 ottobre del 1960, coniugato con<br />
tre figli, impren<strong>di</strong>tore, accetta, su pressione <strong>di</strong> un caro<br />
amico impegnato in politica nell’allora formazione <strong>di</strong><br />
Forza Italia, <strong>di</strong> can<strong>di</strong>darsi come consigliere nella quarta<br />
circoscrizione. Viene eletto consigliere e nominato<br />
poi presidente anche con la <strong>partecipazione</strong> <strong>di</strong> alcuni<br />
voti dell’ opposizione. Non avendo come obiettivo un impegno definitivo in<br />
ambito politico, conduce la presidenza secondo un orientamento legato ai risultati,<br />
tra i quali si può ricordare la soluzione dell’annoso problema della sede<br />
circoscrizionale inaugurata alla fine del mandato quinquennale. Pur con<strong>di</strong>videndo<br />
l’impegno e la responsabilità <strong>di</strong> coloro che si impegnano in politica, non<br />
si rican<strong>di</strong>derà più in alcuna elezione amministrativa. Attualmente è presidente<br />
della Compagnia delle Opere <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>.<br />
1999-2003/2003-2008 • Maurizio Margaroli<br />
Nato a <strong>Brescia</strong> il 6 marzo 1958, coniugato e padre <strong>di</strong><br />
due figli, artigiano nel settore della moda,<br />
57
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
inizia l’attività politica nel Partito Socialista al fianco dell’onorevole Gi<strong>anni</strong><br />
Savol<strong>di</strong>.<br />
Nel 1993 entra in Forza Italia e viene eletto per la prima volta, nel 1994,<br />
come consigliere della terza circoscrizione. Tre <strong>anni</strong> dopo si can<strong>di</strong>da alla camera<br />
dei Deputati nel collegio della Valle Sabbia.<br />
Nel 1998 si presenta nella Quarta <strong>Circoscrizione</strong>, viene eletto prima come<br />
consigliere e, poi, successivamente come presidente. Nel 2005 viene eletto<br />
vicecoor<strong>di</strong>natore citta<strong>di</strong>no <strong>di</strong> Forza Italia.<br />
Dal 2003 al 2008 è nuovamente presidente della quarta <strong>Circoscrizione</strong>, ed il<br />
suo lavoro precedente viene premiato in termini <strong>di</strong> voti, è, infatti, il can<strong>di</strong>dato<br />
più preferenziato fra tutti i can<strong>di</strong>dati eletti. Nelle elezioni del 2008, si presenta<br />
in consiglio comunale, tra le file del Popolo della Libertà e, forte <strong>di</strong> un<br />
successo elettorale anche personale, viene nominato assessore alle attività<br />
produttive, artigianato e marketing territoriale.<br />
58
3. ALLE ORIGINI DEL DECENTRAMENTO<br />
il pResiDente Della CiRCosCRizione oVest<br />
Mattia Margaroli (Pdl)<br />
Nato a <strong>Brescia</strong> il 22 marzo 1985, <strong>di</strong>plomato in<br />
ragioneria all’Istituto Piamarta, istituto per il quale ha<br />
ricoperto, anche, il ruolo <strong>di</strong> rappresentante all’interno<br />
della consulta degli studenti, laureando in Scienze<br />
Politiche all’Università <strong>di</strong> Pavia, Mattia Margaroli ha<br />
raccolto l’ere<strong>di</strong>tà del padre Maurizio, conquistando,<br />
nell’ultimo appuntamento elettorale amministrativo, il<br />
ruolo <strong>di</strong> presidente della circoscrizione ovest, nella lista del Pdl.<br />
Nonostante la giovane età, infatti, Mattia Margaroli, aveva già vissuto<br />
l’esperienza circoscrizionale come consigliere, essendo già stato eletto in<br />
circoscrizione nel 2003, ed avendo vissuto cinque <strong>anni</strong> da membro della<br />
Commissione consiliare sicurezza civica, bilancio e <strong>partecipazione</strong> all’interno<br />
della Terza <strong>Circoscrizione</strong>.<br />
59
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
Momenti <strong>di</strong> gioco nei primi <strong>anni</strong> <strong>di</strong> vita del Villaggio Ba<strong>di</strong>a Archivio Centro Stu<strong>di</strong> La Famiglia<br />
60
4. LA CIRCOSCRIZIONE RACCONTATA<br />
Capitolo 4<br />
La <strong>Circoscrizione</strong> raccontata<br />
La storia delle Circoscrizioni è la storia degli uomini che le hanno abitate, e che<br />
con ruoli e modalità <strong>di</strong>verse – molti da semplici citta<strong>di</strong>ni – hanno inteso animare il<br />
percorso <strong>di</strong> <strong>partecipazione</strong>, ciascuno con il proprio personale contributo.<br />
La lunga trama del decentramento a <strong>Brescia</strong> è in buona parte racchiusa, quasi cu-<br />
sto<strong>di</strong>ta gelosamente nelle testimonianze dei protagonisti, che a partire dagli <strong>anni</strong><br />
Sessanta hanno vissuto i primi fermenti partecipativi nei quartieri, li hanno seguiti<br />
e accompagnati fino alla nascita delle Circoscrizioni.<br />
La narrazione <strong>di</strong> queste esperienze, declinate nel sociale, nel civile o nella politica,<br />
compone un affresco da cui emerge l’aspetto forse più autentico <strong>di</strong> quegli <strong>anni</strong>,<br />
che lascia un’ere<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> cui fare memoria.<br />
61
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
stoRia Di Un’eReDità (iMpoRtante),<br />
Di Un MatRiMonio (ineDito)<br />
e Di Un iMpegno CHe FaCeVa DiVentaRe gRanDi<br />
Maria Cipriano<br />
Raccogliere, proseguire e soprattutto non tra<strong>di</strong>re l’ere<strong>di</strong>tà dei Consigli <strong>di</strong> quartiere:<br />
con questo slancio era iniziato, nel 1980, il decennio <strong>di</strong> presidenza in<br />
Terza circoscrizione <strong>di</strong> Maria Cipriano, già consigliere in circoscrizione dal 1978,<br />
sotto la presidenza <strong>di</strong> Luigi Daffini.<br />
Originaria <strong>di</strong> Urago Mella, insegnante <strong>di</strong> scuola elementare, impegnata nell’attività<br />
sindacale e poi attiva in politica con il Psi, Cipriano aveva chiaro un obiettivo,<br />
quello <strong>di</strong> non far morire la spinta <strong>di</strong> <strong>partecipazione</strong> dei quartieri, dopo<br />
il passaggio – non per tutti indolore – dai Consigli alle circoscrizioni, nate a<br />
<strong>Brescia</strong> nel 1978.<br />
«I Consigli avevano avuto una doppia valenza, quella <strong>di</strong> coinvolgere i residenti<br />
su scelte <strong>di</strong> politica amministrativa della città e quella <strong>di</strong> detenere un potere<br />
contrattuale verso la Loggia per tutti i problemi <strong>di</strong> vita delle periferie: questi due<br />
principi continuarono ad essere i pilastri».<br />
In quel delicato periodo <strong>di</strong> transizione che doveva traghettare dalla spontaneità<br />
dei Consigli all’ufficialità delle Circoscrizioni, la preoccupazione più grossa era<br />
quella <strong>di</strong> non chiudersi in un parlamentino e <strong>di</strong>menticare il territorio: i regolamenti,<br />
i co<strong>di</strong>cilli, le scadenze che andavano <strong>di</strong> pari passo con i compiti precisi in<br />
cui era inquadrata la <strong>Circoscrizione</strong> erano percepiti come un vincolo che imbrigliava<br />
naturalezza e genuinità, soprattutto dai molti che, dopo l’esperienza dei<br />
Consigli, erano confluiti come consiglieri nella Terza.<br />
«Per questo cercavamo <strong>di</strong> favorire una estrema libertà <strong>di</strong> accesso alla vita della<br />
<strong>Circoscrizione</strong>, alle commissioni <strong>di</strong> lavoro potevano partecipare quasi liberamente<br />
i citta<strong>di</strong>ni». Il fermento, in quei primi <strong>anni</strong>, c’era ancora, forse perché le<br />
riven<strong>di</strong>cazioni da far valere verso il <strong>Comune</strong> erano ancora molte. «L’obiettivo<br />
era riuscire a portare a casa un risultato: non avevamo un centro socio-sanitario,<br />
che è arrivato in quegli <strong>anni</strong> in via Caduti del Lavoro per svolgere attività<br />
<strong>di</strong> consultorio e <strong>di</strong> assistenza agli anziani, l’anagrafe <strong>di</strong> via Farfengo è stata la<br />
prima ad aprire a livello decentrato, con l’allora Asm trasporti si <strong>di</strong>scuteva per<br />
avere i bus nelle vie non ancora servite».<br />
Quando si faticava a trovare ascolto, come nel caso della scuola materna Mandolossa<br />
che era minacciata <strong>di</strong> chiusura, si passava a vie più concrete, come un<br />
62
4. LA CIRCOSCRIZIONE RACCONTATA<br />
presi<strong>di</strong>o davanti alla Loggia con insegnanti e genitori. «La cosa inconsueta è<br />
che il mio partito allora era <strong>di</strong> maggioranza e faceva parte della giunta, eppure<br />
questi equilibri non ci interessavano, davanti a esigenze concrete da <strong>di</strong>fendere»,<br />
ricorda Cipriano. «Non è che fossimo più liberi allora, è che ci liberavamo<br />
noi, non guardavamo le cose con il paraocchi, se occupavamo quella se<strong>di</strong>a era<br />
per fare l’interesse della citta<strong>di</strong>nanza, con cui l’armonia <strong>di</strong> giunta aveva ben<br />
poco a che fare».<br />
Un altro impegno significativo maturato in Terza in quegli <strong>anni</strong> era la collaborazione<br />
intensa avviata con le scuole, pur nelle <strong>di</strong>verse autonomie, sia sul tempo<br />
pieno che sulle sperimentazioni e le classi aperte: era il periodo in cui nascevano<br />
esperienze importanti nell’Oltremella, soprattutto sul tempo scuola, la società<br />
stava cambiando e un crescente numero <strong>di</strong> donne andava a lavorare. «Come <strong>Circoscrizione</strong><br />
avevamo promosso convegni su questo tema, venivano numerosi genitori,<br />
la <strong>partecipazione</strong> era cosciente, non si trattava <strong>di</strong> “truppe cammellate”».<br />
Ci si guardava attorno, si cercava <strong>di</strong> conoscere le esperienze fatte da altri, le Circoscrizioni<br />
erano ancora giovani e «tutti si inventavano tutto»: una delegazione<br />
della Terza andò a visitare Bologna, dove le Circoscrizioni erano partite prima, e<br />
poi Torino, per prendere spunto su nuove progettualità da attivare.<br />
Maria Cipriano<br />
63
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
Una scelta a parte e assolutamente ine<strong>di</strong>ta fu la determinazione <strong>di</strong> celebrare<br />
matrimoni nella sede circoscrizionale <strong>di</strong> via Farfengo, avviata già nei due <strong>anni</strong><br />
<strong>di</strong> presidenza Daffini. «Credevamo che una struttura decentrata fosse magari<br />
meno prestigiosa per i muri, ma non per il significato: in fondo era sempre la<br />
casa <strong>di</strong> tutti». Come tutti i matrimoni, serviva la delega del sindaco per officiarli,<br />
e Cipriano ricorda ancora la telefonata a casa ricevuta dall’allora sindaco Trebeschi,<br />
che argomentava sull’opportunità reale <strong>di</strong> uno sposalizio così celebrato,<br />
«perché già un matrimonio civile era considerato un po’ inferiore rispetto a<br />
quello in chiesa, se poi veniva celebrato in <strong>Circoscrizione</strong>, era come minimizzarlo<br />
ulteriormente», rievoca Cipriano.<br />
Alla fine però, in quella prima stagione <strong>di</strong> vita della Terza in via Farfengo si<br />
unirono in matrimonio tre coppie, le spose erano due impiegate della <strong>Circoscrizione</strong><br />
e una residente, tutte e tre fermamente convinte a giurarsi amore eterno<br />
con il futuro marito proprio lì.<br />
«Noi abbiamo accettato <strong>di</strong> buon grado queste richieste perché abbiamo sempre<br />
creduto che al <strong>di</strong> là <strong>di</strong> stucchi e soffitti affrescati, un matrimonio celebrato<br />
in circoscrizione potesse avere un forte significato <strong>di</strong> appartenenza per i citta<strong>di</strong>ni:<br />
quelle cerimonie furono una festa per tutti, ricordo ancora il momento<br />
in cui indossai la fascia tricolore, tutti i consiglieri presenti, il bouquet e un<br />
piccolo regalo che come <strong>Circoscrizione</strong> avevamo preparato, per un’esperienza<br />
che era un unicum nel panorama bresciano».<br />
Quelli sono stati gli <strong>anni</strong> che hanno portato all’incubazione del progetto del<br />
Parco delle Colline, all’avvio del Centro sportivo Ba<strong>di</strong>a, a consolidare un rapporto<br />
speciale con le associazioni del territorio, e a “fare sistema” con le altre<br />
Circoscrizioni. «Con Velleda Minelli, presidente della Nona, avevamo inventato<br />
la riunione dei presidenti <strong>di</strong> <strong>Circoscrizione</strong> (un’istituzione nata spontaneamente,<br />
che sarebbe poi stata ufficializzata come conferenza dei presidenti),<br />
perché avevamo intuito che scambiarsi esperienze, confrontarsi su tematiche<br />
importanti per la città e soprattutto essere uniti rendeva più pesante il nostro<br />
potere contrattuale verso la Loggia, visto che le deleghe che avevamo erano <strong>di</strong><br />
consultazione, ma a livello decisionale non ottenevamo l’incisività sperata».<br />
Per Cipriano non si trattava <strong>di</strong> episo<strong>di</strong> estemporanei, «ma <strong>di</strong> qualcosa che ci<br />
faceva crescere a livello politico, sociale, civile». Sullo sfondo giocavano un<br />
ruolo non marginale i partiti, soprattutto a Urago dove batteva il cuore pulsante<br />
della Dc, dove esisteva la storica Casa del popolo del Pci, e dove la sezione<br />
“Rodolfo Moran<strong>di</strong>” del Psi, <strong>di</strong> cui Cipriano faceva parte, negli <strong>anni</strong> Ottanta<br />
contava un’ottantina <strong>di</strong> iscritti. «I Consigli <strong>di</strong> quartiere funzionavano anche<br />
64
4. LA CIRCOSCRIZIONE RACCONTATA<br />
grazie alla presenza delle sezioni dei partiti, che a quei tempi vivacizzavano la<br />
politica perché erano un luogo dove si imparava, si cresceva, ci si confrontava.<br />
Ci si credeva. I partiti erano un vivaio, si faceva la gavetta, si <strong>di</strong>alogava su<br />
ideologie ben precise. E questo modo <strong>di</strong> vivere la politica da parte dei partiti <strong>di</strong><br />
allora favoriva, a cascata, la <strong>partecipazione</strong> <strong>di</strong> tutti alla vita associata».<br />
Sull’oggi lo sguardo <strong>di</strong> Cipriano è piuttosto <strong>di</strong>silluso: «Rispetto ai servizi che<br />
avevamo portato in <strong>Circoscrizione</strong> in quegli <strong>anni</strong> non ne vedo <strong>di</strong> nuovi, le<br />
deleghe sono sempre le stesse e la tanto auspicata “costruzione attiva” del<br />
bilancio comunale non è mai avvenuta». Negli <strong>anni</strong> Ottanta in Terza si parlava<br />
ad<strong>di</strong>rittura, forse in modo futuristico, <strong>di</strong> bilancio circoscrizionale. «Ritenevamo<br />
che se c’era un senso al nostro partecipare alle scelte <strong>di</strong> politica amministrativa,<br />
doveva essere quello <strong>di</strong> concentrarsi sulle priorità. Non abbiamo mai<br />
pensato <strong>di</strong> dover fare battaglie per deleghe su questioni - come marciapie<strong>di</strong> o<br />
aiuole - che risolvono degnamente gli uffici comunali». «Oggi vedo un lento<br />
spegnersi <strong>di</strong> questo fermento. Penso che la <strong>partecipazione</strong> non si misuri sul numero<br />
<strong>di</strong> persone che intervengono a<br />
una serata danzante o a un banchetto:<br />
questo è compito delle associazioni<br />
o delle società sportive, cui la<br />
<strong>Circoscrizione</strong> non si deve sostituire,<br />
svolgendo se mai una funzione <strong>di</strong><br />
sintesi». Il ruolo della <strong>Circoscrizione</strong><br />
deve essere «quello <strong>di</strong> far crescere<br />
le persone dal punto <strong>di</strong> vista politico,<br />
sociale e culturale, coinvolgendo<br />
i citta<strong>di</strong>ni sulle tematiche emergenti<br />
attraverso convegni, incontri, progetti,<br />
proposte. In una parola bisogna<br />
rimettere in moto la <strong>partecipazione</strong><br />
sui problemi. Altrimenti il tutto<br />
si risolve in una delega a una leadership,<br />
con una crescita del <strong>di</strong>vario<br />
fra politica e citta<strong>di</strong>no: se non siamo<br />
più capaci <strong>di</strong> coinvolgere le persone<br />
sui temi politici e amministrativi<br />
abbiamo fatto morire il senso della Cipriano agli esor<strong>di</strong> dell’impegno politico<br />
<strong>partecipazione</strong>».<br />
65
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
C’è Un tesoRo nelle Colline bResCiane,<br />
la sCopeRta inizia nell’oltReMella<br />
Angelo Borboni<br />
Sentire i rombi dei motori e la danza esplosiva delle due ruote che profanava i declivi<br />
millenari delle colline Ratto e Picastello era cosa forte per Angelo Borboni, da sempre<br />
amico dei boschi e appassionato <strong>di</strong> natura. Ma nei primi <strong>anni</strong> Settanta la coscienza<br />
ambientalista era ancora agli albori, e che i colli a corona della città si prestassero<br />
senza con<strong>di</strong>zioni come teatro delle prodezze <strong>di</strong> motocross non scandalizzava nessuno.<br />
Nessuno, tranne appunto Borboni, che vicino a quei colli aveva scelto <strong>di</strong> abitare, e che<br />
ancora oggi ricorda le strette al cuore nel percepire da lontano i fragori e gli sconquassi<br />
delle moto. «Mi veniva da piangere a pensare agli insulti al terreno e all’ecosistema<br />
lasciati da quelle esercitazioni. E quando decisi per la prima volta <strong>di</strong> ispezionare la<br />
collina, l’impatto fu drammatico: sporco dappertutto, rifiuti vecchi <strong>di</strong> decenni, zone<br />
collinari rese irriconoscibili dalle gare dei motociclisti, che lasciavano pesanti solchi nel<br />
bosco e avvallamenti profon<strong>di</strong> <strong>di</strong>fficili da ripianare».<br />
Allora mancavano specifiche normative per il rispetto ambientale, non c’erano particolari<br />
<strong>di</strong>vieti imposti dal <strong>Comune</strong> e non esistevano ancora gli agenti ecologici per controllare<br />
le zone boschive. «Ero convinto che bisognava fare qualcosa, e così, spontaneamente,<br />
formai un primo gruppetto <strong>di</strong> residenti e amici per andare a raccogliere i rifiuti<br />
sulle colline: si lavorava la domenica con gli strumenti che avevamo a <strong>di</strong>sposizione, un<br />
paio <strong>di</strong> guanti, alcuni attrezzi manuali, niente decespugliatori o altri sistemi più sofisticati».<br />
Il gruppo <strong>di</strong> volontari iniziò così a svolgere un servizio <strong>di</strong> pulizia, sistemazione<br />
dei sentieri e riqualificazione dei colli dell’Oltremella, che successivamente si arricchì<br />
della collaborazione dell’Asm, che metteva a <strong>di</strong>sposizione ruspe con contenitori per la<br />
rimozione e il trasporto dei rifiuti.<br />
Le colline del Ratto e del Picastello, fino al confine con i Campiani, sono state per secoli<br />
una risorsa <strong>di</strong> legna da ardere e un’area <strong>di</strong> pascolo, oltre che una zona agricola punteggiata<br />
<strong>di</strong> cascinali, che ha dato da vivere ad intere famiglie fino agli <strong>anni</strong> Cinquanta<br />
del secolo scorso. Da quel momento in poi, con la nascita <strong>di</strong> aziende e acciaierie<br />
nell’Oltremella che hanno incominciato ad assorbire la manodopera del luogo, il territorio<br />
collinare è stato abbandonato e progressivamente lasciato all’incuria. «I sentieri<br />
erano pochi, c’erano solo delle tracce, quelle lasciate dalla gente che andava a caccia<br />
o per funghi: la zona apparteneva a proprietari privati che accarezzavano il sogno <strong>di</strong><br />
rendere i terreni e<strong>di</strong>ficabili, e nel frattempo li tenevano senza curarsene troppo».<br />
Furono Borboni e il suo gruppo a realizzare dal niente la tracciatura dei sentieri, a<br />
66
4. LA CIRCOSCRIZIONE RACCONTATA<br />
curarne l’accessibilità e la manutenzione. Un’attività proseguita in sor<strong>di</strong>na per molti<br />
<strong>anni</strong> fino a che, nel 1978 (lo stesso anno in cui nascono le Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong>), il<br />
gruppo non si costituì ufficialmente nel Coda, Centro Operativo per la Difesa dell’Ambiente,<br />
acquisendo, oltre alla finalità <strong>di</strong> recupero e salvaguar<strong>di</strong>a delle colline dell’Oltremella,<br />
anche quella <strong>di</strong> gruppo antincen<strong>di</strong>o boschivo (dal 2006 è Onlus nel Servizio<br />
protezione civile provinciale ed è iscritto al Dipartimento della protezione civile del<br />
volontariato regionale e nazionale).<br />
«Volevamo il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> transito delle moto, volevamo che i proprietari degli appezzamenti<br />
sui colli si rendessero conto <strong>di</strong> avere una cosa preziosa», <strong>di</strong>ce Borboni, che<br />
successivamente nella duplice veste <strong>di</strong> consigliere in Terza circoscrizione e <strong>di</strong> presidente<br />
Coda ha incominciato un’azione <strong>di</strong> “pressing” sul <strong>Comune</strong> per concretizzare il<br />
progetto <strong>di</strong> una adeguata segnaletica dei <strong>di</strong>versi sentieri.<br />
I volontari del Coda avevano capito prima <strong>di</strong> altri che le colline a corona degli inse<strong>di</strong>amenti<br />
urbani non rappresentavano solo un piacevole ornamento, ma costituivano un<br />
polmone verde per la città, capace, grazie alle migliaia <strong>di</strong> alberi presenti, <strong>di</strong> “filtrare”<br />
l’aria mantenendola <strong>di</strong> una qualità apprezzabile. Accanto a questa consapevolezza<br />
c’era la meraviglia che in ogni stagione riservano le colline, vestite <strong>di</strong> cascate <strong>di</strong> anemoni,<br />
viole, pervinche, primule, rose <strong>di</strong> Natale, impreziosite da pruni e biancospini,<br />
costellate dall’erica e dal ginepro, fino nel cuore più nascosto dei rilievi, dove il terreno,<br />
più fresco e profondo, fa crescere<br />
castagni, ligustri, nespoli e betulle. «La<br />
primavera e l’estate, poi, sono una festa<br />
<strong>di</strong> colori, per i fiori generosi, gli angolini<br />
che ti lasciano stupefatto, le radure per<br />
la sosta che non ti aspetti, un’emozione<br />
vera che andrebbe con<strong>di</strong>visa da un numero<br />
sempre crescente <strong>di</strong> persone».<br />
«La nuova coscienza ecologica che andava<br />
maturando ci portò, come naturale<br />
passaggio successivo, a ipotizzare<br />
la costituzione <strong>di</strong> un parco delle colline<br />
bresciane, per garantirne una maggiore<br />
tutela e riallacciare un legame fra il territorio<br />
boschivo e la città». Ci vollero molti<br />
<strong>anni</strong>, tante manifestazioni e parecchio<br />
impegno perché l’interesse <strong>di</strong>ffuso sul<br />
Angelo Borboni<br />
progetto del parco, che dapprima coin-<br />
67
Archivio Coda<br />
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
volse associazioni e citta<strong>di</strong>ni, “contagiasse” anche le amministrazioni pubbliche «che<br />
fino ad allora non si erano mostrate particolarmente sensibili sulla tutela del patrimonio<br />
collinare, non avvertita come una priorità», <strong>di</strong>ce Borboni. «Eravamo però consapevoli<br />
degli errori da non fare, come <strong>di</strong>mostrano le vicende travagliate del Parco dei colli<br />
<strong>di</strong> Bergamo, in cui eccessivi <strong>di</strong>vieti avevano contribuito a renderlo subito osteggiato<br />
dai cacciatori. Il Parco delle Colline, al contrario, doveva nascere col piede giusto».<br />
La data della svolta fu il 1997, con la firma <strong>di</strong> un accordo <strong>di</strong> programma fra Provincia<br />
<strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> e Comuni <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong>, Bovezzo, Cellatica, Collebeato, Rodengo Saiano, per<br />
realizzare un parco che abbracciasse il monte Maddalena, il Colle San Giuseppe, i<br />
monti Ratto e Picastello, la collina <strong>di</strong> Sant’Anna e le aree collinari dei Comuni limitrofi.<br />
Qualificato come Parco locale <strong>di</strong> interesse sovracomunale, il Parco delle Colline nasce<br />
ufficialmente nel 2002, con un’estensione <strong>di</strong> oltre 35 chilometri quadrati.<br />
Ora che il parco è realtà, il Coda, come promotore della sua nascita, è una delle associazioni<br />
componenti il comitato consultivo del Parco delle Colline. In aggiunta alla<br />
manutenzione dei sentieri dell’Oltremella (oltre ad aver collaborato all’approntamento<br />
<strong>di</strong> sentieri del monte Maddalena, curandone la manutenzione per molti <strong>anni</strong>), Borboni<br />
e gli altri volontari si occupano <strong>di</strong> attività <strong>di</strong>dattiche con le scuole per favorire la conoscenza<br />
naturalistica e storica del territorio collinare. Da qui è scaturito il percorso<br />
natura messo a punto dal Coda sul colle <strong>di</strong> Sant’Anna e rivolto alle classi, ed è nata<br />
l’idea <strong>di</strong> posizionare cartellini sui <strong>di</strong>versi alberi, in modo che i visitatori ne possano<br />
identificare specie e caratteristiche. «Anche questo crea interesse, aiuta a far crescere<br />
la consapevolezza del patrimonio nascosto sulle colline, ciò per cui ci siamo sempre<br />
battuti, da più <strong>di</strong> trent’<strong>anni</strong> a questa parte».<br />
I volontari del Coda al lavoro nel rior<strong>di</strong>no <strong>di</strong> un sentiero<br />
68
paRteCipaRe alle sCelte è Un’aRte<br />
CHe MeDia Utopia e Realtà<br />
Valerio Lanzini<br />
4. LA CIRCOSCRIZIONE RACCONTATA<br />
“La politica non è una scienza, come molti signori professori s’immaginano,<br />
ma un’arte”. Una frase lontana nel tempo e nello spazio, pronunciata dal<br />
cancelliere Bismarck nella Germania <strong>di</strong> fine Ottocento, eppure così vicina a<br />
quei quartieri che, a quasi un secolo <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanza, si stavano muovendo per<br />
riven<strong>di</strong>care un ruolo all’interno della città.<br />
L’Oltremella era una delle zone più attive, agli inizi degli <strong>anni</strong> Settanta, quando<br />
le prime esperienze dei Comitati <strong>di</strong> quartiere si stavano affacciando sulla<br />
scena urbana. Uno dei nuclei <strong>di</strong> <strong>partecipazione</strong> si era formato a San Giacomo,<br />
una manciata <strong>di</strong> case fra via Valcamonica e il confine con via Chiusure, che<br />
conservava l’orgoglio e la compattezza <strong>di</strong> un vecchio borgo.<br />
Valerio Lanzini era uno dei residenti coinvolti nei primi movimenti <strong>di</strong> <strong>partecipazione</strong>,<br />
iniziati in modo improvvisato ma destinati a <strong>di</strong>ventare un percorso<br />
duraturo che sarebbe poi sfociato nelle Circoscrizioni. «Il mio primo approccio<br />
con questa <strong>di</strong>mensione, a me sconosciuta, fu in occasione <strong>di</strong> una riunione<br />
pubblica. Mi <strong>di</strong>ssi “an<strong>di</strong>amo a sentire”, saremo stati in tutto in sette o otto,<br />
ma incominciammo a capire che bisognava darsi da fare per migliorare la<br />
qualità <strong>di</strong> vita e le strutture del territorio», ricorda. «Come tutte le periferie ci<br />
si sentiva <strong>di</strong>menticati, il <strong>Comune</strong> si occupava solo del centro, prestando ben<br />
poca attenzione ai problemi dei quartieri».<br />
E non era un caso che i residenti si sentissero “una minuscola presenza”, come la definisce<br />
Lanzini, davanti all’imponenza e alla <strong>di</strong>stanza siderale misurata con la Loggia.<br />
«La prima cosa che capimmo a San Giacomo era che per contare bisognava<br />
unirsi, in particolare aggregarci con Chiusure, che dal punto <strong>di</strong> vista organizzativo<br />
era più avanti». Dopo il collegamento con Chiusure venne quello con<br />
la Ba<strong>di</strong>a, il Villaggio Violino, Sant’Anna, per dare un coor<strong>di</strong>namento unico a<br />
tutto l’Oltremella. Una figura <strong>di</strong> riferimento per quei primi <strong>anni</strong> fu Vla<strong>di</strong>miro<br />
Ghetti, cui oggi è intestata la biblioteca <strong>di</strong> quartiere, che rappresentò «il perno<br />
<strong>di</strong> tutta l’organizzazione <strong>di</strong> Chiusure e dell’Oltremella, da uomo che credeva<br />
profondamente nei quartieri. Lo ricordo come una persona rara, onesta, pulita,<br />
69
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
senza secon<strong>di</strong> fini. Una figura che in quegli <strong>anni</strong> era <strong>di</strong>ventata la vera anima<br />
del movimento <strong>di</strong> <strong>partecipazione</strong>».<br />
Quando dalla stagione dei Comitati si passa a quella dei Consigli <strong>di</strong> quartiere,<br />
Lanzini <strong>di</strong>venta presidente del Consiglio <strong>di</strong> Chiusure, un organismo che per<br />
scelta venne eletto a suffragio universale (la maggior parte veniva invece<br />
nominata da elezioni autogestite in assemblea). «Ci sembrava giusto far partecipare<br />
tutti, da qui è nata l’idea <strong>di</strong> elezioni aperte, in cui per la prima volta<br />
si consentiva il voto anche ai <strong>di</strong>ciottenni». Alle elezioni <strong>di</strong> Chiusure, svolte in<br />
quat¬tro turni nei <strong>di</strong>versi rioni, da febbraio a maggio del 1971, parteciparono<br />
1700 citta<strong>di</strong>ni, segno <strong>di</strong> una rilevante capacità <strong>di</strong> attrattiva dell’esperienza <strong>di</strong><br />
<strong>partecipazione</strong> che si andava consolidando.<br />
Nelle assemblee pubbliche, precedute dai volantini ciclostilati che avevano il<br />
compito <strong>di</strong> richiamare la popolazione, si raccoglievano i bisogni della gente,<br />
si prendeva nota delle <strong>di</strong>verse esigenze emerse, dei servizi che mancavano,<br />
delle carenze accusate.<br />
Una volta raccolte le doglianze, però, andava affrontato un nodo <strong>di</strong> principio<br />
e programmatico, non altrimenti aggirabile: che veste ricoprire nei confronti<br />
del <strong>Comune</strong>? Quella <strong>di</strong> questuanti alla ricerca <strong>di</strong> qualche benevola intercessione,<br />
o piuttosto quella <strong>di</strong> rappresentanti <strong>di</strong> una comunità, come tali assertivi<br />
e intenzionati a <strong>di</strong>alogare fra pari?<br />
«La faccenda era <strong>di</strong> non poco conto. C’erano certamente questioni pratiche<br />
che ci premevano, dalle strade da asfaltare alle scuole che mancavano, ma<br />
quello che evolvendo abbiamo maturato è che la nostra funzione non voleva<br />
e non doveva essere quella <strong>di</strong> “chiedere”, ma <strong>di</strong> contribuire alla formazione<br />
delle decisioni, allacciando con il <strong>Comune</strong> un rapporto <strong>di</strong> un certo tipo, che<br />
consentisse davvero ai quartieri <strong>di</strong> partecipare alle scelte che riguardavano il<br />
loro territorio o l’intera città».<br />
Una delle prime richieste, non a caso, fu quella <strong>di</strong> collaborare alla formazione<br />
del bilancio comunale, in particolare per gli stanziamenti riguardanti i singoli<br />
quartieri o le voci <strong>di</strong> maggiore rilevanza e <strong>di</strong> interesse comune. «C’era poi<br />
il parere dato dai Consigli su licenze e<strong>di</strong>lizie o piani <strong>di</strong> ampliamento che<br />
interessavano il territorio: per formulare la nostra valutazione ci si preparava<br />
molto prima, si creavano delle piccole commissioni, che potevano essere partecipate<br />
da chiunque. In quella urbanistica si cercava sempre <strong>di</strong> coinvolgere il<br />
70
4. LA CIRCOSCRIZIONE RACCONTATA<br />
geometra o l’ingegnere <strong>di</strong> turno per avere un conforto tecnico».<br />
Da qui anche l’idea della politica non come una scienza esatta, ma come<br />
un’arte da coltivare con creatività e inventiva. «Nel nostro piccolo credevamo<br />
nel ruolo della <strong>partecipazione</strong>, eravamo convinti che servisse a qualcosa,<br />
abbiamo fatto tante battaglie ma abbiamo anche ottenuto risultati che ritenevamo<br />
importanti, come la ristrutturazione della case Eca, dette “dei francesi”,<br />
la costruzione della scuola Rodari, la nascita del Distretto sanitario <strong>di</strong><br />
quartiere, la realizzazione del centro San Filippo, il cui progetto inizialmente<br />
venne avversato dai residenti, salvo poi rivelarsi importante, oltre che come<br />
servizio, per la stessa vivacità dell’Oltremella».<br />
Tanti risultati che erano figli <strong>di</strong> lavoro, confronto, complicità, qualche arrabbiatura:<br />
in una parola la quoti<strong>di</strong>anità che animava le assemblee dove si poteva<br />
andare avanti a <strong>di</strong>scutere per ore, «perché io, come presidente, cercavo<br />
sempre <strong>di</strong> ottenere l’unanimità dei voti, in modo che i progetti fossero il<br />
più possibile con<strong>di</strong>visi», rievoca Lanzini. «Per noi la <strong>partecipazione</strong> era questa,<br />
senza “parlamentini” chiusi<br />
in logiche <strong>di</strong> partito, ma con la<br />
gente».<br />
L’abilità, spesso, era quella <strong>di</strong><br />
riuscire a far capire alla Loggia<br />
che i Consigli <strong>di</strong> quartiere potevano<br />
essere un’importante<br />
sentinella sul territorio, luogo <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>scussione <strong>di</strong> progetti e innovazioni.<br />
«Così accadde con l’avvio<br />
del teleriscaldamento, quando<br />
la gente, che non lo conosceva,<br />
era prevalentemente contraria,<br />
e proprio grazie alle assemblee<br />
pubbliche e agli incontri nei<br />
quartieri, anche con <strong>Comune</strong> e<br />
Asm, riuscimmo a far capire i<br />
notevoli benefici che sarebbero<br />
Valerio Lanzini<br />
derivati da quell’investimento».<br />
71
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
Fra le intuizioni del Consiglio <strong>di</strong> quartiere ce n’è una che, anche se mai realizzata,<br />
illumina sulla capacità <strong>di</strong> precorrere i tempi che la creatività politica <strong>di</strong><br />
rione talvolta alimentava: già nei primi <strong>anni</strong> Settanta il Consiglio <strong>di</strong> Chiusure<br />
accarezzava il sogno <strong>di</strong> trasformare le tre torri <strong>di</strong>smesse <strong>di</strong> Ponte Crotte, le famose<br />
“calchere”, in un museo che ne garantisse il recupero e la conservazione<br />
come elemento <strong>di</strong> archeologia industriale. Un tema <strong>di</strong> cui si <strong>di</strong>batte ancora<br />
oggi, dopo che le torri sono state vincolate dai Beni culturali in riconoscimento<br />
della loro rilevanza storica.<br />
Quanto ai destini della <strong>partecipazione</strong> una volta conclusa l’esperienza dei<br />
Consigli <strong>di</strong> quartiere, Lanzini ha una sua teoria che incrocia il tecnico con il<br />
sociale: «Poi è arrivata la televisione, e la <strong>partecipazione</strong> è finita. Oggi è sempre<br />
più <strong>di</strong>fficile, dal punto <strong>di</strong> vista oggettivo, “tirar fuori” la gente dalle case. E<br />
forse solo allora, proprio perchè c’era ancora tutto da costruire, l’entusiasmo<br />
era così alto. Il lavoro era enorme, non si prendeva una lira, ma si aveva l’illusione<br />
più bella, quella <strong>di</strong> partecipare».<br />
72
4. LA CIRCOSCRIZIONE RACCONTATA<br />
“i Consigli Di QUaRtieRe Della baDia”<br />
Francesco Maltempi<br />
“Quelli sono stati tra gli <strong>anni</strong> più belli, non solo perché erano quelli della mia<br />
giovinezza ma, soprattutto, perché quello era un periodo in cui ci si sentiva<br />
davvero parte <strong>di</strong> una comunità e si voleva contribuire ad essa con entusiasmo<br />
e voglia <strong>di</strong> fare” sono queste le parole con cui Francesco Maltempi, oggi consigliere<br />
provinciale tra le file del Pd, ricorda gli <strong>anni</strong> che precedettero la nascita<br />
delle circoscrizioni, quelli in cui era la voglia <strong>di</strong> fare che veniva dal basso a<br />
risolvere, spesso, i problemi.<br />
Oggi Maltempi ha passato da poco i sessanta, una lunga esperienza lavorativa<br />
come professore prima e come lavoratore in aziende metalmeccaniche poi,<br />
ed alle spalle una carriera politica <strong>di</strong> tutto rispetto, esperienze come consigliere<br />
in comune e provincia, e come membro <strong>di</strong> consigli <strong>di</strong> amministrazione<br />
<strong>di</strong> società dello spessore <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> Trasporti e Autostrade Centro-Padane, ma<br />
guardando al passato non ha dubbi. “Politicamente gli <strong>anni</strong> dei consigli <strong>di</strong><br />
quartiere ed i primi delle circoscrizioni sono quelli che mi hanno più riempito<br />
<strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfazioni: <strong>anni</strong> <strong>di</strong> duro lavoro, <strong>di</strong> voglia <strong>di</strong> fare, <strong>di</strong> amicizie vere e <strong>di</strong><br />
lotte importanti” ricorda nostalgicamente Maltempi che, in primo luogo vuole<br />
ricordare gli amici <strong>di</strong> quegli <strong>anni</strong>, coloro che contribuirono con lui alla nascita<br />
delle circoscrizioni.<br />
“In quegli <strong>anni</strong>, in particolare con i consigli <strong>di</strong> quartiere, dove le questioni politiche<br />
facevano solamente da sfondo ad una voglia <strong>di</strong> lavorare fianco a fianco<br />
per risolvere concretamente i problemi che venivano dal territorio, si cercava<br />
<strong>di</strong> collaborare e le proposte degli uni o degli altri venivano valutate a seconda<br />
della loro funzionalità ed al <strong>di</strong> fuori da preconcetti politici. Ricordo che,<br />
con me, che rappresentavo la Dc, all’interno del coor<strong>di</strong>namento dei consigli <strong>di</strong><br />
quartiere, c’erano Vla<strong>di</strong>miro Ghetti del Pci, l’avvocato Renato Sirna del Psi e mi<br />
sembra, anche, Maurilio Lovatti, in rappresentanza delle Acli” ha proseguito<br />
nel suo ricordo Maltempi che ha voglia <strong>di</strong> rimembrare il successo <strong>di</strong> popolo e <strong>di</strong><br />
democrazia rappresentato dai consigli <strong>di</strong> quartiere e dalla loro elezioni.<br />
“Organizzammo le elezioni dei consigli <strong>di</strong> quartiere secondo una lista unica, non<br />
c’erano i partiti, ma solo i nomi proprio per dare spazio alle persone ed al loro<br />
impegno più che ad altre questioni e scegliemmo <strong>di</strong> far votare i ragazzi sino a 16<br />
<strong>anni</strong>: fu un successo <strong>di</strong> <strong>partecipazione</strong> che ricordo ancora con gioia”.<br />
Ha voglia <strong>di</strong> pensare ai vecchi tempi il consigliere provinciale cresciuto, in gio-<br />
73
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
ventù, nell’Azione Cattolica, <strong>di</strong> ricordare quei fermenti giovanili, quella voglia<br />
<strong>di</strong> partecipare alle decisioni che riguardavano i propri quartieri.<br />
“Ricordo con piacere l’iniziativa che mettemmo in campo con Don Carlo Pacetti<br />
denominata il “<strong>Comune</strong> dei giovani”, rappresentava 1200 ragazzi e funzionava<br />
come un vero e proprio consiglio comunale. Avevamo dato vita anche<br />
ad un giornale dal significativo titolo “Il Rompiglione”: volevamo farci sentire,<br />
proporre e partecipare, perché questa era la strada giusta per migliorare il<br />
nostro quartiere seguendo proprio le istanze della gente”.<br />
In quegli <strong>anni</strong> decentramento e <strong>partecipazione</strong> erano sulla bocca <strong>di</strong> tutti, i partiti<br />
tra<strong>di</strong>zionali guardavano con attenzione ai quartieri ed avevano cominciato<br />
ad aprire delle sezioni nei <strong>di</strong>versi territori ed, anche, l’impegno dei consigli <strong>di</strong><br />
quartiere si faceva più rilevante.<br />
“Le due componenti principali <strong>di</strong> quegli <strong>anni</strong> furono proprio <strong>partecipazione</strong> e<br />
decentramento: due facce <strong>di</strong> una stessa medaglia. Da un lato le periferie volevano<br />
farsi sentire e fornire il proprio contributo alle scelte che le riguardavano,<br />
partecipando alle <strong>di</strong>scussioni riguardanti statuti, piani e<strong>di</strong>lizi e governo del<br />
territorio; dall’altro era necessario che determinati servizi, come uffici anagrafe<br />
e sanità, fossero presenti con<br />
maggior capillarità sul territorio,<br />
proprio per una motivazione pratica”.<br />
Eletto nel consiglio della terza circoscrizione<br />
“Oltremella” con Miro<br />
Ghetti e col presidente Luigi Daffini,<br />
successivamente Maltempi<br />
lascerà le circoscrizioni per vivere<br />
l’esperienza <strong>di</strong> consigliere comunale<br />
ed assessore con Trebeschi,<br />
Padula, Boninsegna, Panella ed,<br />
infine, Corsini.<br />
“Quella dei consigli <strong>di</strong> quartiere<br />
e delle circoscrizioni resta la mia<br />
esperienza politica migliore perché<br />
nasceva dalla concretezza e<br />
dalla vicinanza reale con i pro-<br />
Francesco Maltempi<br />
blemi della gente” ha concluso<br />
Maltempi.<br />
74
4. LA CIRCOSCRIZIONE RACCONTATA<br />
Un pUnto Di RiFeRiMento peR il QUaRtieRe Di FiUMiCello<br />
Mario Setti e Danila Bonati<br />
Un punto <strong>di</strong> riferimento per tutta la comunità <strong>di</strong> Fiumicello, una sorta <strong>di</strong> <strong>di</strong>staccamento<br />
della circoscrizione pronto a captare le istanze del territorio ed i bisogni<br />
della gente.<br />
Non è un ufficio del <strong>Comune</strong> o l’iniziativa <strong>di</strong> qualche associazione ma una semplice<br />
e<strong>di</strong>cola dalla quale Mario Setti e Daniela Bonati, non solo vendono giornali, ma<br />
partecipano attivamente alla vita del quartiere grazie alla loro abilità ad intessere<br />
rapporti umani.<br />
“Siamo arrivati a Fiumicello quando ci siamo sposati, nel ’73, e da allora non ci siamo<br />
più mossi, le nostre due figlie sono nate qui e, nell’80, abbiamo aperto questa e<strong>di</strong>cola.<br />
A gestirla era mia moglie mentre io ero operaio all’Idra e, successivamente, in una<br />
<strong>di</strong>tta <strong>di</strong> arredamenti <strong>di</strong> Cellatica, anche, se in realtà ho sempre dato una bella mano<br />
anche qui” racconta Mario Setti, che una volta pensionato ha cominciato a lavorare<br />
a tempo pieno nell’e<strong>di</strong>cola <strong>di</strong> famiglia.<br />
“Questo è una quartiere chiuso, proprio per la sua conformazione, stretto dalla tangenziale<br />
da un lato e dal Mella dall’altro e, quin<strong>di</strong>, almeno dal punto <strong>di</strong> vista urbanistico,<br />
non ha subito notevoli cambiamenti, in particolare in questi ultimi <strong>anni</strong>. Le<br />
<strong>di</strong>versità, invece, sono sociali: qui sono aumentati in maniera notevole gli extracomunitari<br />
mentre gli italiani sono in <strong>di</strong>minuzione, anche, perché in questa zona gli anziani<br />
sono molti e, quando muoiono, spesso sono sostituiti da stranieri” spiega Mario<br />
che, tra i cambiamenti notati da lui in questi <strong>anni</strong>, c’è anche un indebolito senso <strong>di</strong><br />
comunità ed un maggiore egoismo della gente, anche, se questo, in realtà, non è<br />
solamente un problema <strong>di</strong> Fiumicello.<br />
“Al posto <strong>di</strong> quelle case, che hanno una sessantina <strong>di</strong> <strong>anni</strong>, una volta passava via<br />
Gerle, che era una delle arterie più importanti della città” prosegue nel suo racconto<br />
Mario che, oltre a conoscere la storia del suo quartiere, soprattutto da quando a<br />
rilevato l’e<strong>di</strong>cola, è <strong>di</strong>ventato davvero un punto <strong>di</strong> riferimento fondamentale per gli<br />
abitanti del quartiere ed un ottimo aiuto per la circoscrizione.<br />
“In molti si fermano qui a fare due chiacchiere ma, anche, a chiedere informazioni:<br />
pensa che ultimamente sono venuti a chiedermi anche le lampa<strong>di</strong>ne a basso consumo<br />
energetico ma, ovviamente, per quelle si devono rivolgere ad altri” ha proseguito,<br />
con il sorriso, l’e<strong>di</strong>colante <strong>di</strong> Fiumicello.<br />
75
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
“Mi sono sempre dato da fare per organizzare iniziative sul territorio: con l’Arci, per<br />
esempio abbiamo organizzato mostre e delle bellissime sfilate <strong>di</strong> carri a Carnevale”<br />
ricorda Mario, rmembrando come per lui sia sempre stato importante contribuire alla<br />
creazione <strong>di</strong> quei rapporti umani che sono la vera anima dei quartieri, altrimenti ridotti<br />
solo a dormitori, come, purtroppo, è sempre più frequente nella nostra società.<br />
“Quando sono arrivato a Fiumicello, c’erano ancora i comitati i quartiere, che si adoperavano<br />
a risolvere i problemi più consistenti, come la mancanza <strong>di</strong> servizi: in quegli<br />
<strong>anni</strong> l’illuminazione era ancora sui pali <strong>di</strong> legno e, solamente, più tar<strong>di</strong> vennero<br />
impiantati quelli normali” prosegue nei suoi ricor<strong>di</strong> Mario, spiegando che le prime<br />
case erano veramente poche e che il quartiere si allargò sensibilmente solo nel biennio1975-1977,<br />
quando vennero costruiti i condomini <strong>di</strong> via Panigada.<br />
Un uomo sempre attivo Mario ma che non ha mai cercato <strong>di</strong> fare politica, anche<br />
solamente in circoscrizione.<br />
“In circoscrizione ci sono stato come membro esterno ma non mi sono mai presentato<br />
per il semplice fatto che, già, questa e<strong>di</strong>cola sembra un <strong>di</strong>staccamento della circoscrizione,<br />
se mi avessero dato anche i voti non avrei più pace” ha chiuso scherzosamente<br />
Mario, prima <strong>di</strong> ricominciare, come al solito, a vendere giornali ed a <strong>di</strong>spensare<br />
favori e consigli agli abitanti del suo quartiere come sempre da trent’<strong>anni</strong>.<br />
E<strong>di</strong>cola: un punto <strong>di</strong> riferimento per il quartiere Fiumicello<br />
76
4. LA CIRCOSCRIZIONE RACCONTATA<br />
il Villaggio Violino Dagli <strong>anni</strong> ‘70 aD oggi<br />
Alberto Martinuz<br />
Alberto Martinuz è nato al Violino nel 1962, ad appena <strong>di</strong>eci <strong>anni</strong> dalla nascita del<br />
primo Villaggio creato da Padre Ottorino Marcolini e dalla sua cooperativa La Famiglia.<br />
Qui ha vissuto la sua infanzia, poi l’adolescenza, infine, l’età adulta contrassegnata<br />
da un forte impegno politico e sociale a favore del suo quartiere nativo. Con<br />
lui, anche, il Violino è cresciuto e, nell’arco dei decenni, si è notevolmente allargato<br />
rispetto alle 252 casette e<strong>di</strong>ficate nel 1955.<br />
“Alle sue origini il Villaggio era tipicamente popolare, la maggioranza erano famiglie<br />
<strong>di</strong> operai che lavoravano nei numerosi stabilimenti industriali che caratterizzano la<br />
nostra città e, come tutti i quartieri <strong>di</strong> questo genere, i rapporti umani ed il senso<br />
<strong>di</strong> comunità erano molto sentiti” racconta Martinuz, guardando con piacere ma,<br />
anche, un po’ <strong>di</strong> nostalgia alla sua infanzia.<br />
“Ricordo le lunghe corse con le biciclette che, al Violino, rappresentavano il mezzo<br />
principale, soprattutto per noi ragazzi, i mon<strong>di</strong>ali <strong>di</strong> Formula 1, con le macchinine<br />
appesantite con lo strutto per evitare che andassero fuori pista, ed infine i pomeriggi<br />
e le serate passate a giocare a nascon<strong>di</strong>no. Non sono da <strong>di</strong>menticare, tuttavia, le<br />
interminabili partite con i “cicotti” o quelle a pallone presso il campo dell’Oratorio<br />
” prosegue Martinuz.<br />
Il futuro presidente <strong>di</strong> circoscrizione, ancora giovane, già vedeva quei ragazzi più<br />
gran<strong>di</strong> <strong>di</strong> lui che si impegnavano per la loro comunità galvanizzati dall’entusiasmo<br />
portato dai comitati <strong>di</strong> quartiere e dalla voglia <strong>di</strong> <strong>partecipazione</strong>.<br />
“Ricordo Aldo Rebecchi, Gigi Daffini e Luigi Morgano, personalità che si sono impegnate<br />
per il quartiere per, poi, <strong>di</strong>venire personaggi <strong>di</strong> riferimento <strong>di</strong> tutta la città, ma<br />
anche figure meno note ma fondamentali per la vita del Violino. Penso alla signora<br />
Angelica, dell’Azione Cattolica, sempre tra le prime ad adoperarsi per l’organizzazione<br />
<strong>di</strong> iniziative che animassero il territorio, oppure ad Angelo Greotti, operaio alla<br />
Sant’Eustacchio ed impegnato nella Fiom, celere nel rimettere in strada le biciclette<br />
dei giovani <strong>di</strong> tutto il quartiere” ricorda Martinuz, sottolineando il senso <strong>di</strong> identità<br />
che permeava la vita quoti<strong>di</strong>ana <strong>di</strong> questa zona e che ere decisamente più forte<br />
delle <strong>di</strong>visioni e delle <strong>di</strong>atribe politiche.<br />
“Una esperienza che ha toccato tutti noi ragazzi che vivevamo negli <strong>anni</strong> 70-80<br />
il quartiere è stata la brillante idea <strong>di</strong> realizzare il Campo Amicizia, l’antesignano<br />
dell’attuale grest. Era una vera e propria olimpiade con tutte le <strong>di</strong>scipline sportive,<br />
tranne il nuoto, compreso il ciclismo che si correva per le vie più o meno asfaltate<br />
77
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
del quartiere con qualsiasi tipo <strong>di</strong> mezzo, dalla bici da corsa che possedevano in<br />
pochissimi, quasi nessuno, alla graziella. L’originale idea <strong>di</strong> realizzare in quegli <strong>anni</strong><br />
questa bella esperienza, che tra l’altro iniziava sempre tutte le mattine con un ra<strong>di</strong>ogiornale<br />
tra il serio e il faceto, più faceto che serio, è dovuta al <strong>di</strong>namico e coinvolgente<br />
allora curato Don Gian Mario Chiari, oggi parroco <strong>di</strong> Rovato” prosegue<br />
Martinuz nel suo racconto.<br />
“Essendo il primo quartiere e<strong>di</strong>ficato dalla cooperativa La Famiglia godette subito <strong>di</strong><br />
alcuni privilegi, come l’e<strong>di</strong>ficazione <strong>di</strong> una scuola ed il posizionamento <strong>di</strong> alcuni negozi<br />
ma, il Violino aveva anche dei limiti, come quella <strong>di</strong>visione con il resto del territorio<br />
creata dai tre ponti della ferrovia che ha portato ad un progressivo isolamento del<br />
quartiere, sentito in maniera particolare negli <strong>anni</strong> ’80 e ’90. Il Violino pagava, in<br />
termini <strong>di</strong> sevizi pubblici, il limite geografico della sua posizione, anche, se i successivi<br />
interventi <strong>di</strong> allargamento restituirono al quartiere una maggiore <strong>di</strong>namicità”.<br />
Punto <strong>di</strong> riferimento, come tutti i quartieri citta<strong>di</strong>ni, era, ovviamente, l’oratorio ed è proprio<br />
in questi ambienti che Martinuz<br />
forma la sua cultura cattolica e si avvicina<br />
alla <strong>partecipazione</strong> sociale.<br />
“Come tutti ho frequentato l’oratorio<br />
e, poi, una volta cresciuto, intorno<br />
ai 18-20 <strong>anni</strong>, sono rimasto<br />
al suo interno impegnandomi come<br />
animatore. Ai quei tempi gli oratori<br />
si stavano aprendo maggiormente<br />
al territorio ed ebbi,così, l’occasione,<br />
con l’amico Vittorio Colli <strong>di</strong> impegnarmi<br />
attivamente. Ricordo che<br />
contribuimmo a far nascere una<br />
commissione giovani all’interno<br />
del quartiere, proprio, per portare<br />
avanti le nostre istanze e contribuire<br />
alla crescita del quartiere. Alla<br />
politica, invece, mi sono avvicinato<br />
successivamente grazie ad un altro<br />
carissimo amico prete, che mi spinse<br />
a presentarmi in circoscrizione”.<br />
Alberto Martinuz<br />
L’Oratorio resterà al centro delle<br />
attività del quartiere anche negli<br />
78
4. LA CIRCOSCRIZIONE RACCONTATA<br />
<strong>anni</strong> successivi: “Negli <strong>anni</strong> 90 è nato, invece, grazie alla spinta dell’allora curato<br />
Don Alfredo Scaratti, oggi parroco del Duomo, un gruppo musical che, nell’arco del<br />
tempo, ha ottenuto sempre più successi. Nata, infatti, come esperienza <strong>di</strong> oratorio,<br />
sotto la guida del bravo regista Roberto Gelatti, il gruppo è cresciuto negli <strong>anni</strong> e<br />
quelli che all’inizio erano solo semplici ragazzi <strong>di</strong>lettanti sono <strong>di</strong>ventati praticamente<br />
professionisti. Oggi infatti il gruppo non fa più riferimento all’oratorio del Violino,<br />
anche perché si è sviluppato negli <strong>anni</strong> un forte sodalizio con le Suore operaie <strong>di</strong><br />
Botticino <strong>di</strong> Don Arcangelo Ta<strong>di</strong>ni, che hanno partecipato e dato a questa esperienza<br />
un respiro non solo provinciale ma anche regionale e nazionale. Anche io, due<br />
<strong>anni</strong> fa, ho partecipato ad un loro spettacolo, interpretando Cleofa, padre <strong>di</strong> Maria,<br />
all’interno della rappresentazione “L’ombra del Padre”, tratto dall’omonimo libro <strong>di</strong><br />
Dobraczynski”.<br />
All’interno del Violino sono numerosi i gruppi spontanei che hanno dato una mano a<br />
creare un senso comunitario maggiore. “Un’altra bella esperienza degli ultimi 10 <strong>anni</strong>,<br />
che testimonia la vivacità <strong>di</strong> questo quartiere è “il Gruppo <strong>di</strong> riferimento parrocchiale<br />
del Quartiere”, nato da circa 8 <strong>anni</strong> e seguito e coor<strong>di</strong>nato da un giovane appassionato<br />
al bene comune e all’impegno civile Mirco Biassuti. E’ una esperienza che ricorda i<br />
comitati <strong>di</strong> quartiere degli <strong>anni</strong> settanta. Alcune persone che oggi partecipano vengono<br />
da quella storia e altre ovviamente sono più giovani.<br />
E’ molti <strong>anni</strong> che segue e si adopera per migliorare la vita del quartiere segnalando<br />
problemi alla circoscrizione e al comune con un atteggiamento <strong>di</strong> positiva sollecitazione:<br />
è anche grazie a questo gruppo che il progetto “Accor<strong>di</strong>amo il Violino” ha avuto<br />
grande successo”.<br />
Dal punto <strong>di</strong> vista personale, eletto come consigliere nella terza circoscrizione, Martinuz<br />
l’attività politica non l’ha più abbandonata: alternando esperienze in consiglio<br />
comunale a quelle in circoscrizione, quest’ultima coronata con la presidenza nel<br />
mandato 2003-2008.<br />
“Sono due esperienze <strong>di</strong>verse ma altrettanto gratificanti: il presidente <strong>di</strong> circoscrizione<br />
è più impegnativo ma la gratificazione <strong>di</strong> lavorare vicino alla gente è impagabile.<br />
Penso, infatti, ad iniziative come quello straor<strong>di</strong>nario esempio <strong>di</strong> <strong>partecipazione</strong><br />
che è rappresentato da “Accor<strong>di</strong>amo il Violino”, grazie al quale i citta<strong>di</strong>ni hanno<br />
collaborato a scelte improntati per il loro territorio, o l’impegno profuso con “La<br />
scatola della memoria”, progetto multime<strong>di</strong>ale <strong>di</strong> Oliviero Cherubini, attraverso la<br />
quale abbiamo recuperato la storia del quartiere” ha proseguito Martinuz.<br />
“L’attività in consiglio comunale, invece, mi ha dato la possibilità <strong>di</strong> avere una migliore<br />
visione d’insieme della città e <strong>di</strong> fornire il mio contributo per migliorarla” ha<br />
concluso il consigliere comunale.<br />
79
<strong>30</strong> ANNI DI PARTECIPAZIONE - L’esperienza delle Circoscrizioni a <strong>Brescia</strong><br />
80
In<strong>di</strong>ce<br />
La mappa delle Circoscrizioni pag. 6<br />
Introduzione - La <strong>Circoscrizione</strong> <strong>Ovest</strong> pag. 7<br />
Capitolo 1<br />
I quartieri della <strong>Circoscrizione</strong> <strong>Ovest</strong><br />
Chiusure pag. 9<br />
Urago Mella pag. 13<br />
Ba<strong>di</strong>a pag. 16<br />
Villaggio Violino pag. 19<br />
Fiumicello pag. 22<br />
Il Quartiere Primo Maggio pag. 24<br />
Capitolo 2<br />
A spasso per la <strong>Ovest</strong><br />
Le chiese pag. 27<br />
I parchi pag. 33<br />
Realtà del territorio pag. 37<br />
Le ville pag. 38<br />
Le parrocchie della circoscrizione <strong>Ovest</strong> pag. 39<br />
Le associazioni della circoscrizione <strong>Ovest</strong> pag. 40<br />
Capitolo 3<br />
Alle origini del decentramento<br />
La lunga storia della <strong>partecipazione</strong> a <strong>Brescia</strong> pag. 47<br />
I presidenti della Terza <strong>Circoscrizione</strong> pag. 51<br />
I presidenti della Quarta <strong>Circoscrizione</strong> pag. 55<br />
Capitolo 4<br />
INDICE<br />
La <strong>Circoscrizione</strong> raccontata<br />
Maria Cipriano pag. 62<br />
Angelo Borboni pag. 66<br />
Valerio Lanzini pag. 69<br />
Francesco Maltempi pag. 73<br />
Mario Setti e Danila Bonetti pag. 75<br />
Alberto Martinuz pag. 77<br />
81
Progettazione ed impostazione grafica<br />
FZ Graphic & Design - <strong>Brescia</strong><br />
Stampa<br />
Graficasette - Bagnolo Mella (BS)
circoscrizione ovest<br />
Stampato con il contributo <strong>di</strong><br />
<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong> - Assessorato alla Partecipazione e Decentramento