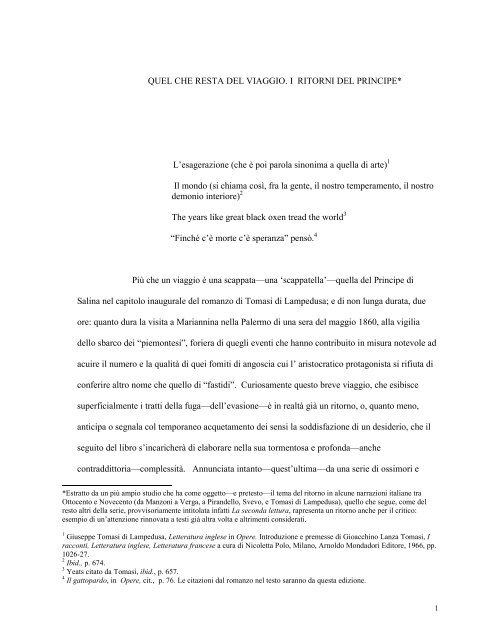QUEL CHE RESTA DEL VIAGGIO. I RITORNI DEL ... - Jonathan Joly
QUEL CHE RESTA DEL VIAGGIO. I RITORNI DEL ... - Jonathan Joly
QUEL CHE RESTA DEL VIAGGIO. I RITORNI DEL ... - Jonathan Joly
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>QUEL</strong> <strong>CHE</strong> <strong>RESTA</strong> <strong>DEL</strong> <strong>VIAGGIO</strong>. I <strong>RITORNI</strong> <strong>DEL</strong> PRINCIPE*<br />
L’esagerazione (che è poi parola sinonima a quella di arte) 1<br />
Il mondo (si chiama così, fra la gente, il nostro temperamento, il nostro<br />
demonio interiore) 2<br />
The years like great black oxen tread the world 3<br />
“Finché c’è morte c’è speranza” pensò. 4<br />
Più che un viaggio è una scappata—una ‘scappatella’—quella del Principe di<br />
Salina nel capitolo inaugurale del romanzo di Tomasi di Lampedusa; e di non lunga durata, due<br />
ore: quanto dura la visita a Mariannina nella Palermo di una sera del maggio 1860, alla vigilia<br />
dello sbarco dei “piemontesi”, foriera di quegli eventi che hanno contribuito in misura notevole ad<br />
acuire il numero e la qualità di quei fomiti di angoscia cui l’ aristocratico protagonista si rifiuta di<br />
conferire altro nome che quello di “fastidi”. Curiosamente questo breve viaggio, che esibisce<br />
superficialmente i tratti della fuga—dell’evasione—è in realtà già un ritorno, o, quanto meno,<br />
anticipa o segnala col temporaneo acquetamento dei sensi la soddisfazione di un desiderio, che il<br />
seguito del libro s’incaricherà di elaborare nella sua tormentosa e profonda—anche<br />
contraddittoria—complessità. Annunciata intanto—quest’ultima—da una serie di ossimori e<br />
*Estratto da un più ampio studio che ha come oggetto—e pretesto—il tema del ritorno in alcune narrazioni italiane tra<br />
Ottocento e Novecento (da Manzoni a Verga, a Pirandello, Svevo, e Tomasi di Lampedusa), quello che segue, come del<br />
resto altri della serie, provvisoriamente intitolata infatti La seconda lettura, rapresenta un ritorno anche per il critico:<br />
esempio di un’attenzione rinnovata a testi già altra volta e altrimenti considerati.<br />
1<br />
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Letteratura inglese in Opere. Introduzione e premesse di Gioacchino Lanza Tomasi, I<br />
racconti, Letteratura inglese, Letteratura francese a cura di Nicoletta Polo, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1966, pp.<br />
1026-27.<br />
2<br />
Ibid., p. 674.<br />
3<br />
Yeats citato da Tomasi, ibid., p. 657.<br />
4<br />
Il gattopardo, in Opere, cit., p. 76. Le citazioni dal romanzo nel testo saranno da questa edizione.<br />
1
paradossi, disseminata nei diversi strati del testo e culminante nella “disperata euforia” (p. 37)<br />
nella quale, “cullato dal trotto dei bai” che lo riportano a casa, il “Principone” si addormenta.<br />
È nella parte terza del romanzo, nell’occasione di un altro viaggio—ch’è<br />
anch’esso un ritorno—all’amata Donnafugata che il narratore ci intrattiene diffusamente e con<br />
notevole esplicitezza sul numero e la qualità dei fastidi del suo personaggio. Il passo è un po’<br />
lungo ma è opportuno averlo sott’occhio.<br />
Don Fabrizio ne aveva avuto parecchi di fastidî in questi due ultimi mesi: erano<br />
sbucati da tutte le parti come formiche all’arrembaggio di una lucertola morta. Alcuni<br />
erano spuntati fuori dai crepacci della situazione politica; altri gli erano stati buttati<br />
addosso dalle passioni altrui; altri ancora (ed erano i più mordaci) erano germogliati dal<br />
suo proprio interno, cioè dalle irrazionali reazioni sue alla politica ed ai capricci del<br />
prossimo (capricci chiamava, quando era irritato, ciò che da calmo designava come<br />
passioni); e questi fastidî se li passava in rivista ogni giorno, li faceva manovrare,<br />
comporsi in colonna o spiegarsi in fila sulla piazza d’armi della propria coscienza<br />
sperando di scorgere nelle loro evoluzioni un qualsiasi senso di finalità che potesse<br />
rassicurarlo; e non ci riusciva. Gli anni scorsi le seccature erano in numero minore e ad<br />
ogni modo il soggiorno a Donnafugata costituiva un periodo di riposo: i crucci<br />
lasciavano cadere il fucile, si disperdevano fra le anfrattuosità delle valli e stavano tanto<br />
tranquilli, intenti a mangiare pane e formaggio, che si dimenticava la bellicosità delle<br />
loro uniformi e potevano esser presi per bifolchi inoffensivi. Quest’anno invece, come<br />
truppe ammutinate che vociassero brandendo le armi, erano rimasti adunati e, a casa<br />
sua, gli suscitavano lo sgomento di un colonnello che abbia detto: «Fate rompere le<br />
righe!» e che dopo vede il reggimento più serrato e minaccioso che mai.<br />
( pp. 94-95 )<br />
Fastidi, seccature, crucci : l’assedio cui essi sottopongono la coscienza del<br />
personaggio—la statura del quale è stata esagerata ad arte nell’iperbole del colosso--viene<br />
offerto al lettore in una sorta di discorso indiretto libero, nel linguaggio e nelle immagini di don<br />
Fabrizio. Esso è dichiarato non recente e riguardante il pubblico e il privato. Di lunga data (si<br />
vedrà poi quanto lunga, anni certamente), da metaforico esercito di formiche si è venuto via<br />
via trasformando in un sempre più letterale e minaccioso reggimento di soldati ammutinati<br />
“che vociassero brandendo le armi”. La difesa opposta dal riposo di Donnafugata, che riusciva<br />
2
a tramutare le truppe in inoffensivi bifolchi “intenti a mangiare pane e formaggio”, cede ora<br />
all’incapacità del Principe di saper “scorgere nelle loro evoluzioni un qualsiasi senso di<br />
finalità”.<br />
In effetti, anche prima che arrivassero i piemontesi, che la crisi si manifestasse con<br />
evidenza inoppugnabile, siamo informati che il personaggio contrastato—risultato di<br />
contrastanti forze genetiche e ambientali: l’ “orgoglio” e l’“intellettualismo materno”, la<br />
“sensualità e faciloneria del padre” (p. 22) “nell’habitat molliccio della società palermitana”<br />
(p. 21)—“viveva in perpetuo scontento” (malcontento, come un personaggio di Svevo) “pur<br />
sotto il cipiglio zeusiano e stava a contemplare la rovina del proprio ceto e del proprio<br />
patrimonio senza avere nessuna attività ed ancora minor voglia di porvi riparo” (p. 22).<br />
Viveva dunque una lunga crisi: una decadenza, o per dir forse meglio una “senilità”, che<br />
attende solo di essere dimostrata per più espliciti esempi. Il privilegio, di cui la statura fisica e<br />
morale è il segno cerimoniale, parlante—si tratti dell’orgoglio del casato ovvero della cultura,<br />
intelletto e buone maniere—è servito a ripararlo finora efficacemente dalle “slings and arrows<br />
of outrageous fortune” (Hamlet, III, 58): per parlare come quell’Amleto, non<br />
sorprendentemente carissimo a Lampedusa, con il quale il suo personaggio condivide non<br />
pochi tratti. Più specificamente, i periodici ritorni estivi a Donnafugata, con l’amore per “la<br />
casa, la gente, il senso di possesso feudale che in essa era sopravvissuto” (p. 60) erano riusciti<br />
in passato ad acquetare--tacitare o ingannare—le malinconie di un soggetto cui<br />
fondamentalmente “manca la facoltà d’ingannare sé stesso” ( p. 173): dello “scettico” che il<br />
testo ci avverte celarsi “sotto l’aspetto leonino” (p. 121). Quest’anno però, nonostante il forte<br />
desiderio di credere che “grazie a Dio, [...] tutto sia come al solito” (p. 65), “Donnafugata [...]<br />
con il suo palazzo, con le sue acque zampillanti, con i ricordi dei suoi antenati santi, con<br />
l’impressione ch’essa dava di perennità dell’infanzia” (p. 64), non sarà in grado di difenderlo<br />
dall’angoscia che sconvolge la sua anima.<br />
3
Verbo e sostantivo sono nel testo, appartenenti, quasi certamente entrambi, allo stesso<br />
discorso del personaggio, 5 il quale del resto, già durante l’orrendo viaggio di tre giorni da<br />
Palermo, era stato indotto dai disagi dello stesso, soprattutto dalle “faune repellenti” nei letti,<br />
dalle “mosche dentro il bicchiere della granita”, e dal risveglio “ai primissimi albori, immerso<br />
nel sudore e nel fetore”, a “paragonare questo viaggio schifoso alla propria vita, che si era<br />
svolta dapprima per pianure ridenti, si era inerpicata poi per scoscese montagne, aveva<br />
sgusciato attraverso gole minacciose per sfociare poi in interminabili ondulazioni di un solo<br />
colore, deserte come la disperazione” (p. 64). Nonostante l’attenuazione che segue (“queste<br />
fantasie del primo mattino erano quanto di peggio potesse capitare a un uomo di mezza età”), e<br />
l’ulteriore limitazione (“e benché don Fabrizio sapesse che erano destinate a svanire con<br />
l’attività del giorno”), è difficile per il lettore resistere alla tentazione di generalizzare, tanto<br />
più che il periodo prosegue così: “ne soffriva acutamente perché era ormai abbastanza esperto<br />
per sapere che esse lasciavano in fondo all’anima un sedimento di lutto che, accumulandosi<br />
ogni giorno avrebbe finito con l’essere la vera causa della morte” (p. 64).<br />
L’accumulo di questi sedimenti, di questi detriti è in qualche modo parallelo o<br />
simmetrico alla perdita ipotizzata nella parte settima (ma poi anche all’accumulo delle reliquie<br />
della parte ottava: quelle di Caterina e Carolina, e le altre, le quattro casse verdi col corredo<br />
disfatto di Concetta e il mucchietto di pelliccia tarlata ch’è divenuto l’alano Bendicò):<br />
all’uscita del fluido vitale , “come i granellini che si affollano e sfilano ad uno ad uno, senza<br />
fretta e senza sosta, dinanzi all’orifizio di un orologio a sabbia” (p. 223), il “continuo,<br />
minutissimo sgretolamento” (ibid.), seguito poi dal “fragore della cascata” (p. 226),<br />
“l’erompere via delle cateratte” (p. 234), “il fragore del mare” (p. 235) che finalmente si<br />
5 “La giornata era stata cattiva; lo avvertiva adesso non soltanto dalla pressione alla bocca dello stomaco, glielo dicevano<br />
anche le stelle; invece di vederle atteggiarsi nei loro usati disegni, ogni volta che alzava gli occhi scorgeva lassù un unico<br />
diagramma: due stelle sopra, gli occhi; una sotto, la punta del mento; lo schema beffardo di un volto triangolare che la sua<br />
anima proiettava nelle costellazioni quando era sconvolta” (p. 87). “Vedi, tu Bendicò, sei un po’ come loro, come le stelle:<br />
felicemente incomprensibile, incapace di produrre angoscia” (p. 88).<br />
4
placa. 6<br />
Quest’angoscia, questa nausea e disperazione, questo senso immanente di lutto che<br />
accompagna malinconicamente l’esistenza del personaggio, la sua “pigrizia”—la stessa<br />
attribuita alla Sicilia e ai siciliani— “attesa del nulla” (p. 176) ovvero “desiderio di immobilità<br />
voluttuosa, cioè ancora di morte” (p. 171) nel colloquio con Chevalley (parte quarta), come—<br />
e forse più di tutto—la solitudine, l’isolamento del personaggio rispetto alla sua stessa classe e<br />
addirittura alla famiglia, 7 si aggiungono alle ragioni prevalentemente formali, messe in rilievo<br />
con molta opportunità da Francesco Orlando, 8 per rendere “un simile protagonista [...]<br />
impensabile in un romanzo dell’Ottocento” (p. 62). La modernità del personaggio, d’altra<br />
parte, rende problematica una definizione di genere quale sarebbe quella di “romanzo<br />
6 Nunzio Zago (in “Modernità del Gattopardo”, Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Cento anni dalla nascita, quaranta dal<br />
Gattopardo, a cura di F. Orlando, Palermo1999, p. 199) ha opportunamente richiamato l’attenzione su quello che<br />
giustamente si può considerare “una sorta di ‘ipotesto’” “nei confronti […] della penultima parte del Gattopardo” : la<br />
pagina, dalla lezione dedicata a Virginia Woolf (in Opere, cit., p. 1257), in cui si legge : “La nostra epoca attuale è<br />
divenuta sensibilissima al Tempo che continuamente udiamo rombare come il frastuono della cascata che ci inghiottirà e<br />
verso la quale, senza scampo, fluiamo”. Approfitto dell’occasione per notare le molte convergenze tra le posizioni di<br />
questo critico e le mie sia sulla problematicità dell’etichetta di romanzo storico applicata all’opera di Tomasi (come,<br />
d’altra parte, sul significato della sua struttura a sbalzi, cfr. p. 196 e 198), sia sull’insistenza su quella che Zago definisce<br />
“il sentimento angoscioso del tempo, della storia” (p. 200), collegato oggettivamente alla “linea nietzschiano-heideggeriana<br />
del cosiddetto ‘pensiero della crisi’”. Che Lampedusa appartenga “a una generazione che subì in pieno l’urto traumatico<br />
del primo conflitto mondiale e delle convulsioni del dopoguerra, cui diede il significato di svolta epocale, di tramonto della<br />
civiltà occidentale, di perdita dei valori e dei fondamenti stessi della vita” (ibid.), era anche a me sembrato evidente, e<br />
indicato non equivocamente in un mio scritto precedente (p.160, citato nella nota seguente) col richiamo a una importante<br />
dichiarazione dello scrittore già nel 1927 in occasione della recensione al Caesar di Friedrich Gundolf (Opere, cit., p.<br />
486), quando parla di “una età come questa nella quale la coscienza del «divenire» di ogni cosa ha assunto un’acuità senza<br />
precedenti, nella quale la rapidità stessa dell’evoluzione conferisce alla vita un senso di disagiata precarietà”: donde il<br />
desiderio--e ristoro--della contemplazione di una vita “completa e chiusa”, una “figura che non sia argilla cedevole ma<br />
bronzo perenne, della quale possiamo compiere il giro e che, mostro o divinità, possiamo pesare e valutare” (le<br />
sottolineature sono mie, in funzione ovviamente del futuro romanzo).<br />
Infine, d’accordo sulla sostanziale allegoricità dei testi di Lampedusa, mi sia consentito di negare l’intenzione che<br />
Zago mi attribuisce (“in omaggio all’ultima moda decostruzionista”, con cui veramente ho poco o nulla da spartire), di<br />
voler “cancellare ogni implicazione storico-politica del Gattopardo” (p. 202). Naturalmente si tratta di intendersi sulla<br />
nozione di storia, essenziale per me come lo era per Lampedusa: assimilabile per me con quella di tempo. Quanto poi alla<br />
“politicità trascendentale”, il rispetto e l’affetto di vecchio allievo di Luigi Russo non mi impediscono di confessare il mio<br />
disagio con una nozione probabilmente efficace retoricamente ma assai vaga e approssimativa concettualmente.<br />
7 Che fa pensare, da un lato (come già accennavo in un precedente scritto, “Nobiltà e letteratura” in Le buone e le cattive<br />
maniere. Letteratura e galateo nel Cinquecento, Bologna, Il mulino, 1992, p. 158) al soggetto dell’ironia romantica<br />
secondo la definizione di P. Szondi (Poetica dell’idealismo tedesco, Torino, Einaudi, 1974, p. 24) : “l’uomo isolato,<br />
divenuto oggetto della sua riflessione, al quale la coscienza ha tolto la facoltà di agire”; dall’altro alla precisazione del<br />
romanziere relativa al suo personaggio: “ch’è sempre stato solo benché avesse moglie e sette figli” (cfr. la lettera ,<br />
testamentaria, del 30 maggio 1957 diretta al barone Enrico Merlo di Tagliavia. La si può leggere sia nella Premessa di<br />
Gioacchino Lanza Tomasi alla nuova edizione riveduta del Gattopardo per le sue cure, Milano, Le Comete Feltrinelli,<br />
2002, pp. 21-22, sia nel volume dello stesso Lanza Tomasi, I luoghi del Gattopardo, Palermo, Sellerio, 2001, pp. 62-64. In<br />
quest’ultimo volume le tavole 169-170-172 e 174 propongono la riproduzione fotografica dell’intero documento.)<br />
8 Specialmente alle pp. 62-63 del suo eccellente ed esaustivo commento, L’intimità e la storia. Lettura del «Gattopardo»,<br />
Torino, Einaudi, 1998.<br />
5
storico”, per sostenere la quale s’è dovuto anche dai critici più solerti e intelligenti far ricorso<br />
a inevitabili e non sempre persuasivi distinguo. La negazione dello stesso romanziere in una<br />
lettera a Guido Lajolo 9 (“Non vorrei che tu credessi che è un romanzo storico! [...]<br />
L’ambiente solo è del 1860.”) a me sembra che tagli la testa al toro. Si tratterà allora di<br />
un’allegoria, per cui la storia del risorgimento sta per un’altra, più recente storia.<br />
Ma importa poi molto? L’interpretazione del testo non cambia, credo, per questo:<br />
sempre, ovviamente, che si prescinda da quello che si è convenuto chiamare il “pregiudizio<br />
immobilistico”. 10 L’attrezzatura retorica messa in opera in esso consiste certamente dell’uso<br />
consistente soprattutto di figure quali lo spostamento, l’iperbole, l’ossimoro, l’ironia , e, come<br />
dicevo, l’allegoria. Ho accennato allo spostamento maggiore: dal presente di Tomasi di<br />
Lampedusa al 1860 del bisnonno astronomo e bigotto, 11 tanto diverso da don Fabrizio Salina;<br />
come pure all’esagerazione, all’iperbole dell’aspetto fisico, specificamente della statura del<br />
personaggio. D’altra parte l’ironia, come le buone maniere, fanno parte del bagaglio<br />
difensivo—anche offensivo, ma soprattutto difensivo—del principe, come—sappiamo--<br />
dell’autore, stando alle molte testimonianze ricavabili dalle pagine delle sue lezioni come pure<br />
dall’aneddotica nei ricordi che lo riguardano. Ad essa fino a un certo punto si può riferire<br />
9 Si può leggere nella biografia di Andrea Vitello, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Sellerio, Palermo, 1987, pp. 229-30.<br />
Ad essa si possono utilmente accostare due affermazioni contenute nell’altra lettera, citata alla nota 67, al Merlo: quella in<br />
cui si dice che il libro “mostra un nobile siciliano in un momento di crisi (che non è detto sia soltanto quella del 1860)”, e<br />
l’altra: “La Sicilia è quella che è; del 1860, di prima e di sempre”.<br />
10 Su questo si vedano i cenni assai precisi di Orlando (L’intimità e la storia, cit., p. 156-77, nota 54). Non ho alcun<br />
dubbio che il romanzo mostri, al contrario, la vittoria della storia—del tempo: inesorabile, contro cui ogni lotta sembra<br />
destinata a fallire, restare desiderio generoso ma futile. D’altra parte mi è impossibile concedere che “in punto di morte,<br />
nel momento del bilancio esistenziale della propria vita, […] la verità si fa strada nel Principe”—come pensa Romano<br />
Luperini (in un saggio che contiene molto di criticamente persuasivo: “Il «gran signore» e il dominio della temporalità”,<br />
Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Cento anni dalla nascita, etc., cit. , p. 209)—per la ragione che a me pare di nuovo non<br />
dubitabile che il personaggio mai s’illude, ma solamente esprime il desiderio: di ciò che manca. Come cercherò di<br />
mostrare nel testo, la differenza tra personaggio e narratore consiste in altro: nella consolazione, che il primo contempla,<br />
della fine della transitorietà e frammentazione ch’è l’esistenza, di contro alla cautela tanto più scettica, ovvero agnostica,<br />
del narratore: che si ferma al di qua, al fatto di quelle.<br />
11 “Giulio Fabrizio Tomasi e Wochinger, bisnonno dello scrittore ed astronomo, era un uomo di qualche originalità, valga<br />
ciò per la sua passione scientifica e l’abilità di prestidigitatore con cui intratteneva familiari ed amici, per il resto<br />
abbastanza pacifico e bigotto, a suo modo un buon pater familias. […] La sua villa ai Colli è aperta soprattutto ad un via<br />
vai di ecclesiastici, e non vi si svolge alcuna vita mondana.” (Gioacchino Lanza Tomasi, I luoghi del Gattopardo, cit., p.<br />
16). Nella lettera ad Enrico Merlo, già anch’essa citata, lo scrittore a sua volta, dopo aver sostenuto la corrispondenza del<br />
suo personaggio (e di quella di padre Pirrone, “autentico anche nel nome”) alla realtà del bisnonno e del gesuita di casa,<br />
aggiunge significativamente: “Credo di aver fatto tutti e due più intelligenti di quel che veramente fossero” (p. 22).<br />
6
anche l’attenzione che la coscienza del personaggio—e del narratore—prestano alle situazioni<br />
e alle espressioni che possono definirsi ossimoriche: tali, per limitarci a qualche esempio dalla<br />
sola parte sesta del romanzo, le giustapposizioni—spaziali—del fasto elegante del ballo a<br />
palazzo Ponteleone con l’adiacente “cameretta trascurata, a livello della loggia dell’orchestra”,<br />
dove “era disposta in bell’ordine una ventina di vasti pitali, a quell’ora quasi tutti colmi, alcuni<br />
sciabordanti per terra” (p. 221); ovvero dei carri “con cumuli d’immondizia alti quattro volte<br />
l’asinello grigio che li trascinava” o del “lungo barroccio scoperto [che] portava accatastati i<br />
buoi uccisi poco prima al macello, già fatti a quarti e che esibivano i loro meccanismi più<br />
intimi con l’impudicizia della morte” con la stella Venere, intravista nella “parte orientale del<br />
cielo, al disopra del mare, [...] avvolta nel suo turbante di vapori autunnali,” dalla quale<br />
l’aristocratico mortale sospira “un appuntamento meno effimero, lontano dai torsoli e dal<br />
sangue, nella propria regione di perenne certezza” (p. 222). O, per un esempio di<br />
giustapposizione temporale, quella degli Dei nel soffitto della sala da ballo, “reclini su scanni<br />
dorati, [che] guardavano in giù sorridenti e inesorabili come il cielo d’estate,” confidenti nella<br />
loro eternità; una fiducia smentita dalla coscienza del narratore: “una bomba fabbricata a<br />
Pittsburgh, Penn. doveva nel 1943 provar loro il contrario” (p. 210).<br />
Sono evidentemente tutte manifestazioni del tempo, più ancora che dei tempi, che<br />
angustiano il nostro personaggio: al quale non basta, come sembra, praticare una strategia<br />
della rimozione (il testo evoca infatti la “naturale tendenza che egli possedeva a rimuovere<br />
ogni minaccia alla propria calma”, p. 75), che potrebbe ben condividere con le abitudini e<br />
l’educazione della sua classe. Più profondo, veramente radicale, appare il suo bisogno di<br />
evasione, il suo desiderio di fuga. Gli esempi sono numerosi. Ecco il rifugio cercato dal<br />
principe nella torretta dell’osservatorio della villa di S. Lorenzo, dove le matematiche che<br />
regolano le traiettorie esatte degli astri possono concedere l’illusione del “trionfo della ragione<br />
umana che si proiettava e prendeva parte alla sublime normalità dei cieli” (p. 51), e i “momenti<br />
7
di astrazione,” conquistati “all’altezza di questo osservatorio,” permettono di ignorare o<br />
dimenticare le ‘fanfaronate’ “qui giù” del cane Bendicò come “la sanguinarietà” del cuoco ,<br />
che tritura col suo coltellaccio “la carne di innocenti bestiole”: fuse anch’esse “in una<br />
tranquilla armonia” (ibid.). O si prenda il “diletto dei giorni di caccia” (p. 93) “nello sgusciare<br />
attraverso la porticina impedita dall’edera”, “nel fuggire, insomma” (p. 94): “si svoltava su per<br />
un pendio e ci si trovava nell’immemoriale silenzio della Sicilia pastorale. Si era subito lontani<br />
da tutto, nello spazio e ancor più nel tempo” (ibid.). Anzi, come il bellissimo seguito precisa,<br />
questa uscita—questa fuga—è veramente fuori del tempo. L’”immutabilità di queste contrade<br />
fuori di mano” trasferisce Donnafugata “con il suo palazzo e i suoi nuovi ricchi”—la storia,<br />
insomma—al di là dello stesso ricordo: già “sbiadita [...], come quei paesaggi che talvolta<br />
s’intravedono allo sbocco lontano di una galleria ferroviaria”, in una dimensione utopica, un<br />
futuro vagheggiato “da un Platone rustico”, un “sognato avvenire [...] che per un qualsiasi<br />
minimo accidente avrebbe anche potuto conformarsi in foggie del tutto diverse o addirittura<br />
non essere; sprovviste così anche di quel tanto di carica energetica che ogni cosa passata<br />
continua a possedere” (p. 94). La storia, il tempo con “le sue pene e il suo lusso”, così “non<br />
potevano più recar fastidio” : apparivano infatti “ancor più insignificanti che se fossero<br />
appartenuti al passato” (ibid.).<br />
Queste fughe, questi distacchi dal tempo—dal presente come dal passato, ma in un<br />
certo senso anche dal futuro—direttamente proporzionali alla malinconia, al “cattivo umore”<br />
che sempre più frequentemente assalgono il personaggio, 12 sono dichiarati per quello che sono<br />
esplicitamente nella parte sesta, quando il principe, cedendo all’irritazione e alla stanchezza,<br />
trova rifugio dalla confusione del ballo nella piccola biblioteca, “silenziosa, illuminata e<br />
vuota”, di palazzo Ponteleone; e lì è sorpreso, dinanzi a “una buona copia della ‘Morte del<br />
Giusto’ di Greuze,” dal nipote Tancredi, che, come sempre ironico, lo interpella: «Zione, sei<br />
12 Cfr. p. 206: “ma sentiva che il cattivo umore lo invadeva lentamente”; p. 208: “la malinconia si era mutata in umor nero<br />
autentico”.<br />
8
una bellezza stasera. La marsina ti sta alla perfezione. Ma cosa stai guardando? Corteggi la<br />
morte?» (p. 213). E in effetti le parole del nipote dicono la verità sull’attività e sul desiderio del<br />
principe: sulla sua “uscita di sicurezza” (ibid.), che non esclude, oltre il ‘disgusto’, la<br />
‘compassione’ per gli “effimeri esseri” contemplati in precedenza: “che cercavano di godere<br />
dell’esiguo raggio di luce accordato loro fra le due tenebre prima della culla, dopo gli strattoni.<br />
Come era possibile infierire contro chi, se ne è sicuri, dovrà morire? [...] Miserevoli, insalvabili<br />
e cari come il bestiame che la notte mugola per le vie della città, condotto al macello” . Di qui<br />
la conclusione dei suoi pensieri: “Non era lecito odiare altro che l’eternità” (p. 211).<br />
Odiare l’eternità. Ma non è la nostalgia di questa, il suo desiderio, la sua mancanza,<br />
che tutto il libro, non che deprecare, lamenta? Di che genere è il conforto, il “po’ di conforto”<br />
che, uscito nella notte da palazzo Ponteleone, l’angosciato personaggio “voleva attingere [...]<br />
guardando le stelle”? o il sospiro di don Fabrizio, che chiude il capitolo: “Quando si sarebbe<br />
decisa a dargli un appuntamento meno effimero, lontano dai torsoli e dal sangue, nella propria<br />
regione di perenne certezza?” (p. 222) In verità ogni fuga dal reale, ogni corteggiamento<br />
della morte in quest’opera, come d’altra parte nel racconto La sirena, non ha nulla a che vedere<br />
con un cupio dissolvi: è semmai protesta o rivolta, non importa quanto assurda, contro la<br />
caduta, la perdita originale (non a caso nella parte settima, è del principe morente il pensiero:<br />
“ma era tutta la vita ad essere colpevole, non questo o quel singolo fatto; vi è un solo peccato<br />
vero, quello originale”, p. 231). La morte, questa morte—le “beatitudini mortuarie” di cui si<br />
parla sempre nella parte settima, p. 232—sono tutt’altro che un annichilimento, piuttosto una<br />
vita superiore, divina, o se si vuole adamitica, anteriore alla caduta. In questo senso dunque un<br />
ritorno: com’è un ritorno all’immortale Lighea, alla Grazia che gli era stata una volta concessa<br />
(p. 427) 13 , la sparizione del vecchio professore Rosario La Ciura nelle acque del Mediterraneo :<br />
“nel cieco muto palazzo di acque informi, eterne, senza bagliori, senza sussurri” (p. 426)<br />
13 Anche le citazioni dal racconto La sirena si riferiscono al volume delle Opere nei Meridiani.<br />
9
promesso dalla sirena.<br />
Il corteggiamento della morte da parte del principe, la sua vocazione di morte—quella<br />
che gli suggerisce la battuta : “Finché c’è morte c’è speranza”—può essere in effetti un<br />
esercizio paradossalmente produttivo di vita: una vita superiore, frutto di un innesto<br />
apparentemente mostruoso, sublimazione e purificazione dalle sostanze più gravi o estranee a<br />
quelle più nobili ed essenziali. Tra le “elargizioni anticipate delle beatitudini mortuarie” il<br />
principe morente ricorda le “molte ore in osservatorio assorte nell’astrazione dei calcoli e<br />
nell’inseguimento dell’irraggiungibile” (p. 232) –quelle stesse che nella parte prima gli<br />
avevano ispirato la considerazione : “Il problema vero, l’unico, è di poter continuare a vivere<br />
questa vita dello spirito nei suoi momenti più astratti, più simili alla morte”, p. 51—e altrove,<br />
nella parte terza, l’immersione nella campagna senza tempo, nella Sicilia “identica a quella dei<br />
giorni in cui per la caccia s’invocava Artemide”, aveva indotto il personaggio a pensare che<br />
“ridotta a questi elementi essenziali, col volto lavato dal belletto delle preoccupazioni, la vita<br />
appariva sotto un aspetto tollerabile” (p. 103). Se non una sublimazione 14 , certamente ancora<br />
una sorta di fuga, di allontanamento ed ascesi--di riduzione agli elementi essenziali,<br />
all’essenza-- aveva operato secondo il principe quell’altro corteggiatore della morte, il figlio<br />
Giovanni, “il solo che gli rassomigliasse” (p. 229), quello che “un bel giorno era scomparso da<br />
casa” (p. 30), aveva lasciato la Sicilia per Londra: “con l’abbandono di tutto aveva organizzato<br />
per sé quel tanto di morte che è possibile metter su continuando a vivere” (p. 230).<br />
Il viaggio, la fuga di Giovanni non contempla ritorni. Chi ritorna invece, nella parte<br />
settima, è il protagonista del libro: malato, per il suo ultimo viaggio. Ma significativamente non<br />
è un ritorno a casa: non alla villa di S. Lorenzo, non al palazzo incantato di Donnafugata, e<br />
neppure al palazzo di Palermo: la “nostra casa di mare”, “più vicina”. Invece all’albergo<br />
Trinacria, dove, nonostante l’assicurazione di Tancredi (“Avrai tutte le comodità”, p. 227), la<br />
14 Sulla sublimazione, le sue implicazioni e la sua trafila, mi sia concesso rinviare anche alle osservazioni che mi occorse<br />
di fare nel mio precedente saggio su Lampedusa , nel citato Le buone e le cattive maniere, soprattutto alle pagine 162-166.<br />
10
descrizione impietosa della camera assegnata al morente (come al solito nella prospettiva<br />
sensoriale e mentale del personaggio) non può non rievocare, in concentrazione sincronica,<br />
quella diacronica del viaggio verso Donnafugata della parte seconda: che a sua volta—come si<br />
vide—aveva indotto il personaggio alla trasposizione metaforica (“non aveva potuto fare a<br />
meno di paragonare questo viaggio schifoso alla propria vita,” p. 64).<br />
Nella stanza bassa si soffocava: il caldo faceva lievitare gli odori, esaltava il<br />
tanfo delle peluches mal spolverate; le ombre delle decine di scarafaggi che vi erano stati<br />
calpestati apparivano nel loro odore medicamentoso; fuori dal tavolino di notte i ricordi<br />
tenaci delle orine vecchie e diverse incupivano la camera. Fece aprire le persiane:<br />
l’albergo era in ombra ma la luce riflessa del mare metallico era accecante; meglio<br />
questo però che quel fetore di prigione.<br />
(p. 228)<br />
“Quel fetore di prigione”. La formola riassume efficacemente la percezione della realtà<br />
da cui il personaggio vuole evadere: da cui finalmente gli è concesso di evadere. Non si tratterà<br />
nel suo caso della ripetizione della scena ritratta nella Morte del Giusto di Greuze, ma, come<br />
nell’equivalente fine del personaggio del racconto La sirena (evocata del resto oggettivamente<br />
nel testo dal “fragore del mare”, che compare nell’ultima frase della parte settima, e<br />
tematicamente dall’altra equivalenza degli abissi marini del racconto con la sublimità degli<br />
“spazi stellari” del romanzo), di una conclusione tuttavia consolante. La morte che attende il<br />
principe di Salina presenta i tratti suggestivi dell’auspicato incontro amoroso,<br />
dell’appuntamento non effimero finalmente concesso dalla divinità discesa a prenderlo, per<br />
trasferirlo “nella propria regione di perenne certezza” (p. 222).<br />
Era lei, la creatura bramata da sempre che veniva a prenderlo: strano che<br />
così giovane com ’era si fosse arresa a lui; l’ora della partenza del treno doveva<br />
essere vicina. Giunta a faccia a faccia con lui sollevò il velo e così, pudica ma<br />
pronta ad essere posseduta, gli apparve più bella di come mai l’avesse intravista<br />
negli spazi stellari.<br />
(p. 235)<br />
Conclusione consolante, dicevo. Anche troppo, ovviamente. Del resto la consolazione,<br />
11
l’ottimismo perfino, era implicito nella stessa sensazione “per nulla sgradevole” (p. 223)<br />
infatti, di cui leggevamo all’inizio della parte settima: “di un continuo, minutissimo<br />
sgretolamento della personalità congiunto però al presagio vago del riedificarsi altrove di una<br />
individualità (grazie a Dio) meno cosciente ma più larga: quei granellini di sabbia non<br />
andavano perduti, scomparivano sì ma si accumulavano chissà dove per cementare una mole<br />
più duratura” (p. 224). O piuttosto, secondo la correzione significativa (e coerente con la già<br />
osservata tematica della sublimazione) immediatamente suggerita, come “particelle di vapore<br />
acqueo che esalassero da uno stagno costretto, per andar su nel cielo a formare le grandi nubi<br />
leggere e libere” (ibid.).<br />
Era necessario a questo punto abbandonare la prospettiva incombente, e in certo modo<br />
tirannica, del protagonista, e affermare decisamente quella del narratore. È quanto viene<br />
assicurato, sia nel romanzo che nel racconto La sirena, dalle appendici costituite<br />
rispettivamente dalla parte ottava (separata anche fisicamente dal resto del libro, e poi,<br />
rispetto agli eventi che la precedono, sia per la notevole distanza temporale che per l’assenza<br />
ovviamente del protagonista) e dal conclusivo rendiconto, da parte del narratore, del destino<br />
dei legati del senatore La Ciura. In tutti e due i casi in evidenza sono dei ritorni, quasi una<br />
rivisitazione--con una riflessione e una correzione—del passato. E in tutti e due i casi si tratta<br />
di resti, o per meglio dire di reliquie, che sono dissacrate o distrutte: ridotte letteralmente in<br />
pezzi, polvere, nulla. È questa—ci è detto—la fine che faranno non solo i libri dell’autore di<br />
Uomini e dei -- ereditati dall’Università di Catania, depositati nel sottosuolo della stessa,<br />
“poiché mancano i fondi per le scaffalature essi vanno imputridendo lentamente” (p. 428)—ma<br />
lo stesso “cratere greco con le figure delle Sirene” e la “grande fotografia della ‘Corè’<br />
dell’Acropoli”, del quale il narratore Corbera era stato il legatario: coinvolti nella distruzione<br />
della sua casa di Palermo, bombardata dai “Liberators”.<br />
Se possibile ancora più disperante e, per i risvolti più drammatici e patetici accordati<br />
12
dallo svolgimento ampio della materia nel romanzo, di tonalità decisamente tragica risulta la<br />
conclusione del grande testo: la quale non per nulla nell’indice analitico provveduto dall’autore<br />
recava l’etichetta Fine di tutto. Qui non sono solo le reliquie religiose di Caterina e Carolina<br />
Salina ad essere dichiarate false e consegnate dal solerte ed efficiente don Pacchiotti, dopo<br />
l’ispezione “lunga e accurata” (p. 255), al cestino di vimini: “roba scartata” di cui disporre.<br />
Anche Concetta, l’erede autentica del Gattopardo, che nella sua “camera solitaria” custodisce<br />
“un inferno di memorie mummificate”, con le quattro casse del suo corredo “confezionato<br />
cinquanta anni “ prima (che “sotto l’ubiquitaria umidità palermitana [...] si disfaceva, inutile<br />
per sempre e per chiunque,” p. 244), i ritratti e le fotografie di “morti non più amati”, gli<br />
acquerelli “di case e luoghi in maggior parte venduti”, e soprattutto il “mucchietto di pelliccia<br />
tarlata “ a cui è ridotto il cane Bendicò--“da quarantacinque anni morto, da quarantacinque anni<br />
imbalsamato, nido di ragnatele e di tarme”, ma anche il “solo ricordo del suo passato che non<br />
le destasse sensazioni penose” (p. 245)--dovrà finalmente arrendersi all’ultima disillusione. La<br />
quale non è neppure la rivelazione della cosiddetta verità, apportatale fortuitamente dal<br />
senatore Tassoni, l’antico compagno d’armi del cugino Tancredi: che “dal fondo intemporale<br />
dell’essere” sale “a macchiarla tutta” con un “dolore nero”. Altro importa: “La sua precarietà<br />
era stata sostituita dall’irrefutabilità della pena” (p. 352).<br />
Di qui l’ultimo passo ( “Concetta si ritirò nella sua stanza; non provava assolutamente<br />
alcuna sensazione: [...] Il ritratto del padre non era che alcuni centimetri quadrati di tela, le<br />
casse verdi alcuni metri cubi di legno,” p. 256), l’entrata vera nella morte: nel nulla, assenza di<br />
sensazioni e di senso, dunque anche di memorie. La disposizione dell’ultima reliquia succede<br />
al completamento del “vuoto interiore” in Concetta. L’annullamento di “quel che rimaneva di<br />
Bendicò” (p. 257) è certamente la “fine di tutto”. La ricomposizione, “durante il volo giù dalla<br />
finestra”, della sua forma in quella del gattopardo mostra chiaramente l’inversione del<br />
movimento verso l’alto, dell’animale emblematico rampante, nel precipitare del cane: nell’<br />
13
“angolo del cortile che l’immondezzaio visitava ogni giorno”. Le immagini conclusive della<br />
parte ottava correggono significativamente quelle con cui si chiudeva la settima. Ma, anche se<br />
manca in quest’ultima l’imprecazione che per un istante nell’ottava sembra suggerire l’arto<br />
anteriore destro alzato del quadrupede, al placarsi “del tutto” del “fragore del mare”, che<br />
concludeva la sezione precedente, corrisponde ancora nell’altra la “pace” che tutto infine trova<br />
“in un mucchietto di polvere livida” .<br />
14