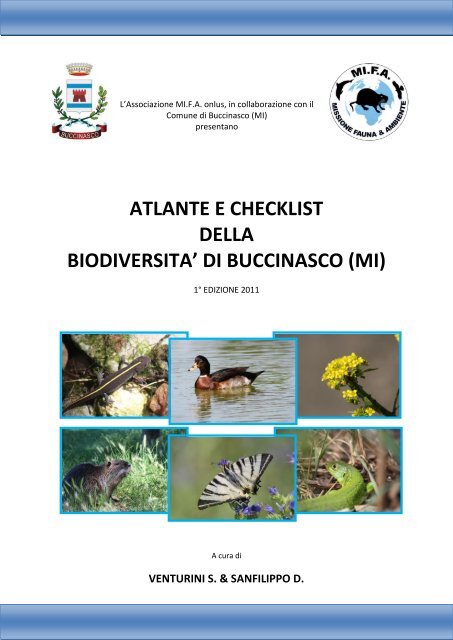atlante e checklist della biodiversita' di ... - Tursiops-biology
atlante e checklist della biodiversita' di ... - Tursiops-biology
atlante e checklist della biodiversita' di ... - Tursiops-biology
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
L’Associazione MI.F.A. onlus, in collaborazione con il<br />
Comune <strong>di</strong> Buccinasco (MI)<br />
presentano<br />
ATLANTE E CHECKLIST<br />
DELLA<br />
BIODIVERSITA’ DI BUCCINASCO (MI)<br />
1° EDIZIONE 2011<br />
A cura <strong>di</strong><br />
VENTURINI S. & SANFILIPPO D.
Venturini Samuele: biologo e presidente dell’Associazione MI.F.A. onlus. mifaonlus@gmail.com<br />
Sanfilippo Daniela: naturalista e membro del Comitato Scientifico dell’Associazione MI.F.A. onlus.<br />
naturalia_d@libero.it<br />
Ringraziamenti<br />
Si desidera ringraziare per il compimento <strong>di</strong> questa opera l’Amministrazione del Comune <strong>di</strong> Buccinasco<br />
(MI), l’Ufficio Ecologia del Comune <strong>di</strong> Buccinasco (MI). Tutti coloro che ci hanno sostenuto e le fonti <strong>di</strong>gitali<br />
e cartacee da cui abbiamo prelevato le informazioni ed alcuni <strong>di</strong>segni.<br />
Tutte le fotografie sono <strong>di</strong> Samuele Venturini.<br />
AVVERTENZA<br />
In caso si osservassero errori, refusi o si volessero dare consigli, potete contattarci e scrivere al seguente<br />
in<strong>di</strong>rizzo <strong>di</strong> posta elettronica: mifaonlus@gmail.com<br />
2
INDICE<br />
Prefazione pag. 4<br />
Introduzione pag. 5<br />
Bio<strong>di</strong>versita’: ricchezza <strong>di</strong> Buccinasco pag. 6<br />
Il territorio pag. 8<br />
Flora e fauna pag. 10<br />
I fontanili <strong>di</strong> Buccinasco pag. 12<br />
FAUNA pag. 15<br />
RETTILI pag. 17<br />
ANFIBI pag. 31<br />
MAMMIFERI pag. 40<br />
UCCELLI pag. 57<br />
INVERTEBRATI pag. 195<br />
Insetti pag. 197<br />
ODONATI pag. 207<br />
LEPIDOTTERI pag. 220<br />
FLORA pag. 228<br />
CHECKLIST pag. 250<br />
SCHEDA DI AVVISTAMENTO FAUNISTICO pag. 257<br />
Elenco alfabetico delle specie pag. 258<br />
Bibliografia pag. 263<br />
3
PREFAZIONE<br />
Fin da quando ero bambino, mio papà mi portava in bicicletta lungo le strade <strong>di</strong> campagna e così , con gli<br />
anni, ho avuto modo <strong>di</strong> imparare a conoscere il territorio. Dapprima come semplice “turista” e<br />
successivamente come stu<strong>di</strong>oso. Buccinasco offre un tesoro davvero ricco per gli appassionati <strong>di</strong> natura, <strong>di</strong><br />
biowatching, <strong>di</strong> birdwatching o per coloro che desiderano solo rilassarsi dopo una settimana lavorativa<br />
nella grande metropoli a pochissimi chilometri da qui.<br />
Diversi sono i paesaggi che contrad<strong>di</strong>stinguono il nostro Comune: dai fontanili alle cave, dai parchi urbani al<br />
parco agricolo sud Milano, dalle fasce boscate alle marcite e ai campi coltivati.<br />
Regolarmente, armato <strong>di</strong> bicicletta, fotocamera, binocolo e – cosa più importante – un profondo amore e<br />
rispetto per la natura, mi de<strong>di</strong>co allo stu<strong>di</strong>o e all’osservazione dell’inestimabile valore naturalistico che<br />
Buccinasco ci offre. Grazie all’associazione MI.F.A. onlus, e insieme al Comune <strong>di</strong> Buccinasco, è nato questo<br />
timido ma ambizioso progetto.<br />
Perché quin<strong>di</strong> un <strong>atlante</strong>? Perché è molto importante conoscere la fauna e la flora dei nostri ambienti e il<br />
loro monitoraggio è fondamentale per conservare lo stato <strong>di</strong> salute del nostro territorio.<br />
Avere un <strong>atlante</strong> in mano con questi dati consente <strong>di</strong> operare delle scelte gestionali a livello <strong>di</strong> territorio e<br />
faunistico atte a tutelare la bio<strong>di</strong>versità.<br />
Grazie alla conoscenza che viene <strong>di</strong>vulgata con quest’opera, ciascuno <strong>di</strong> noi può sentire suo il territorio in<br />
cui vive.<br />
Noi abbiamo una forte responsabilità verso le generazioni future sia nostre ma soprattutto dell’ambiente<br />
che ci ospita.<br />
4<br />
Samuele Venturini<br />
Presidente MI.F.A. onlus
INTRODUZIONE<br />
Il primo <strong>atlante</strong> e <strong>checklist</strong> <strong>della</strong> bio<strong>di</strong>versità <strong>di</strong> Buccinasco, nasce con lo scopo <strong>di</strong> elencare e registrare in<br />
questo particolare progetto lo status naturalistico del nostro territorio. L’importanza <strong>di</strong> questa opera si<br />
rivela nella sua funzione <strong>di</strong> in<strong>di</strong>catore <strong>della</strong> salute ambientale e quin<strong>di</strong> <strong>della</strong> qualità del nostro stile <strong>di</strong> vita.<br />
Nel nostro Comune vivono moltissime altre forme <strong>di</strong> vita e tutte fondamentali per il corretto<br />
funzionamento degli ecosistemi in cui viviamo. Conoscere la fauna e la flora e monitorarle nel tempo è<br />
molto utile per tutelare e valorizzare il nostro ambiente, perché ciò ha una valenza oltre che naturalistica /<br />
ecologica anche culturale, storica, politica, economica e spirituale. La conoscenza <strong>della</strong> biologia dei nostri<br />
luoghi permette una più corretta gestione ecologica con meto<strong>di</strong> biocompatibili i quali si rivelano essere<br />
quelli migliori sia da un punto <strong>di</strong> vista etico che strategico.<br />
Questo volume rappresenta la prima e<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> un progetto più ampio e sempre in costante<br />
aggiornamento. L’osservazione il confronto dei dati raccolti negli anni ci permetterà <strong>di</strong> verificare<br />
l’andamento <strong>della</strong> qualità ambientale e <strong>di</strong> intraprendere <strong>di</strong> conseguenza le azioni migliori per una più<br />
efficiente gestione del territorio. Il dott. Samuele Venturini (biologo e presidente dell’associazione MI.F.A.<br />
onlus) e la dott.ssa Daniela Sanfilippo (naturalista e componente del comitato scientifico dell’associazione<br />
MI.F.A. onlus) hanno iniziato una prima assidua opera <strong>di</strong> censimento <strong>della</strong> fauna e <strong>della</strong> flora del nostro<br />
territorio. Muniti <strong>di</strong> strumentazione adeguata e tramite tecniche <strong>di</strong> fotografia naturalistica, biowatching e<br />
birdwatching, sono riusciti in questa loro prima missione nello stilare l’opera, certamente non completa,<br />
che state leggendo.<br />
Buccinasco permette queste attività naturalistiche, sia come passione che come professione, e conserva un<br />
tesoro naturalistico importante grazie proprio alla sua particolare conformazione e alla fortuna (unita<br />
all’attenzione) <strong>di</strong> aver preservato alcuni luoghi e averne valorizzati altri.<br />
PROGETTI FUTURI: questa è la prima e<strong>di</strong>zione dell’<strong>atlante</strong> e <strong>checklist</strong> <strong>della</strong> bio<strong>di</strong>versità <strong>di</strong> Buccinasco e ne<br />
seguiranno altre, aggiornate. Oltre a queste verranno approfon<strong>di</strong>ti dei temi trattati in particolari<br />
monografie come per esempio “gli Uccelli <strong>di</strong> Buccinasco” e “i Mammiferi <strong>di</strong> Buccinasco”. L’idea quin<strong>di</strong> è<br />
quella <strong>di</strong> ampliare in dettaglio le varie classi <strong>di</strong> fauna, ma anche <strong>di</strong> flora, presenti sul nostro territorio,<br />
corredate da informazioni generali utili alla classificazione ma anche nozioni specifiche sia biologiche che <strong>di</strong><br />
curiosità.<br />
5
BIODIVERSITA’: RICCHEZZA DI BUCCINASCO<br />
Buccinasco è un Comune dell’hinterland milanese in cui una buona parte del suo territorio è costituito dal<br />
PASM (Parco Agricolo Sud Milano). E’ un vero polmone verde, unico nel suo genere ed ha un valore<br />
inestimabile per tutti noi. All’interno del PASM sono presenti vari “paesaggi” che vanno dai campi agricoli<br />
coltivati ai parchi urbani, dalle rogge ai fontanili, dai laghetti ai piccoli boschi etc. In ognuno <strong>di</strong> questi areali<br />
trovano il loro habitat un elevato numero <strong>di</strong> specie animali e vegetali. Dalle mie osservazioni personali ho<br />
potuto constatare la presenza <strong>di</strong> un elevato numero <strong>di</strong> specie <strong>di</strong>verse e vorrei in questa sede esporne<br />
alcune che si possono avvistare e riconoscere.<br />
La Bio<strong>di</strong>versità è la varietà <strong>di</strong> tutti gli esseri viventi che popolano il pianeta Terra, legati l’un l’altro da<br />
<strong>di</strong>verse interazioni e tutti in<strong>di</strong>spensabili. Tale bio<strong>di</strong>versità viene misurata in termini <strong>di</strong> geni, <strong>di</strong> specie, <strong>di</strong><br />
popolazioni e <strong>di</strong> ecosistemi. Grazie alla bio<strong>di</strong>versità la natura è in grado <strong>di</strong> offrirci risorse importantissime<br />
come cibo, acqua ed energia ma anche valori estetici, ricreativi e spirituali. E’ grazie ad essa che la vita può<br />
continuare ad esistere sul nostro pianeta.<br />
Buccinasco presenta molte zone ricche <strong>di</strong> bio<strong>di</strong>versità e quin<strong>di</strong> in grado <strong>di</strong> ospitare moltissime varietà <strong>di</strong><br />
fauna e flora. Una delle caratteristiche che permette al nostro Comune <strong>di</strong> possedere questo valore<br />
inestimabile è la presenza <strong>di</strong> molti corpi idrici come cave, rogge e soprattutto fontanili, ma anche <strong>di</strong> fasce<br />
boscate. Queste aree risultano essere <strong>di</strong> grande importanza per la sosta e lo stanziamento <strong>di</strong> molti animali e<br />
piante.<br />
In particolare, le fasce boscate ricoprono <strong>di</strong>verse e importanti funzioni tra cui quelle <strong>di</strong> tipo produttivo atte<br />
alla produzione <strong>di</strong> materiale come legname, piante officinali, frutti e funghi. Funzioni ecologiche che<br />
consentono un miglioramento qualitativo dell’acqua e <strong>di</strong> conseguenza permettono l’arricchimento <strong>della</strong><br />
zoocenosi che svolge un ruolo anche nella <strong>di</strong>fesa biologica delle colture agricole. Altri vantaggi <strong>di</strong> tipo<br />
ecologico <strong>di</strong> queste fasce boscate riguardano la funzione che l’apparato ra<strong>di</strong>cale <strong>della</strong> vegetazione riparia<br />
svolge nei confronti degli argini proteggendoli dalle erosioni e <strong>di</strong> conseguenza i costi <strong>di</strong> manutenzione dei<br />
corsi d’acqua <strong>di</strong>minuiscono.<br />
Proprio nel nostro Comune vi è la presenza <strong>di</strong> corridoi ecologici utilizzati da una vasta gamma <strong>di</strong> specie<br />
animali e vegetali.<br />
Alcuni esempi <strong>di</strong> fauna che è possibile incontrare passeggiando per il PASM <strong>di</strong> Buccinasco sono: UCCELLI –<br />
cicogne, aironi bianchi, aironi cenerini, nitticore, germani reali, merli, usignoli, cornacchie, poiane,<br />
pettirossi, cinciallegre, ballerine bianche, martin pescatore, cardellini, ron<strong>di</strong>ni, oche cignoi<strong>di</strong>, gallinelle<br />
d’acqua, folaghe, svassi, gabbiani, passeri europei, piccioni, tortore, fagiani, averle piccole e molti altri.<br />
Presso i corpi idrici è più facile avvistare ciconiformi intenti a pescare, mentre tra i rami degli alberi si<br />
nascondono moltissimi esemplari <strong>di</strong> passeriformi.<br />
L’avifauna è molto presente presso il nostro territorio e svolge <strong>di</strong>versi ruoli nella conservazione e<br />
nell’equilibrio degli ecosistemi planiziali.<br />
RETTILI – lucertole muraiole, che ci osservano dai muri e dai tronchi degli alberi, ramarri, bisce, testuggini.<br />
ANFIBI – rane, raganelle, rospi, tritoni. Questi ultimi sono molto importanti anche come in<strong>di</strong>catori biologici.<br />
MAMMIFERI: gatti, bovini, conigli selvatici, musteli<strong>di</strong>, castorini, talpe, arvicole e altri ro<strong>di</strong>tori.<br />
INSETTI: <strong>di</strong>verse specie <strong>di</strong> farfalle, lumache, chiocciole, libellule, ragni e tantissimi altri or<strong>di</strong>ni che<br />
costituiscono il così detto microcosmo.<br />
Tra i VEGETALI oltre alle specie ad uso agricolo si annoverano <strong>di</strong>versi esemplari <strong>di</strong> conifere e latifoglie come<br />
cipressi, pini, farnie, querce, aceri, betulle, biancospini, pioppi e tanti altri.<br />
Tutti gli esemplari <strong>di</strong> fauna e flora sono fondamentali per la vita sulla Terra in quanto ognuno <strong>di</strong> loro è<br />
inter<strong>di</strong>pendente dagli altri e ciascuno riveste un preciso ruolo nella sopravvivenza <strong>di</strong> ogni ecosistema.<br />
Esistono molte ragioni per salvaguardare la bio<strong>di</strong>versità in quanto la per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> specie o varietà è causa <strong>di</strong><br />
danni ecologici, culturali ed economici.<br />
Nel 1992 a Nairobi, in Kenya, è stata adottata la Convenzione sulla Diversità Biologica atta proprio alla<br />
tutela <strong>della</strong> Bio<strong>di</strong>versità.<br />
6
Buccinasco, come accennato precedentemente, è un Comune che ha la fortuna e la responsabilità <strong>di</strong> essere<br />
il custode <strong>di</strong> un piccolo ma grande tesoro naturalistico. Questa ricchezza è composta per buona parte dal<br />
Parco Agricolo Sud Milano ma ad esso si aggiungono i numerosi parchi e soprattutto fontanili.<br />
Proprio queste zone sono quelle più sensibili ai cambiamenti ambientali ma soprattutto alle interazioni<br />
antropiche (attività umane). Questa sensibilità è un in<strong>di</strong>catore assai importante per valutare lo stato <strong>di</strong><br />
salute del territorio e <strong>di</strong> conseguenza anche <strong>della</strong> nostra salute. Se le aree ver<strong>di</strong> <strong>di</strong> un paese sono in buono<br />
stato, tutti ne beneficiano, sia la natura stessa che le persone ivi presenti. Non va <strong>di</strong>menticato infatti che<br />
noi ci nutriamo dei frutti che la Terra ci dona, ma qualunque frutto nasce, cresce e si sviluppa sulla base<br />
delle con<strong>di</strong>zioni ambientali che trova per cui è <strong>di</strong> fondamentale importanza che le risorse quali il suolo e<br />
soprattutto le acque siano pulite e salubri.<br />
Nelle zone ver<strong>di</strong> del nostro Comune, ma soprattutto nel contesto agricolo, ho avuto la possibilità <strong>di</strong><br />
osservare e registrare le spettacolari manifestazioni <strong>della</strong> natura in molte delle sue infinite forme. In questo<br />
modo ho potuto così constatare che il nostro ecosistema – l’ecosistema Buccinasco appunto – è vivo e in<br />
buona salute.<br />
Alcune caratteristiche che lo rendono tale sono da ricercare attentamente e comportano un certo tempo <strong>di</strong><br />
osservazioni, tanta costanza, pazienza, volontà, conoscenza delle scienze biologiche e naturali ma<br />
soprattutto passione e amore per la natura.<br />
La presenza <strong>di</strong> predatori è un fattore molto importante che in<strong>di</strong>ca un ambiente sano. L’esistenza <strong>di</strong> questi<br />
animali può essere sostenuta solo dalla presenza <strong>di</strong> prede. Le prede a loro volta in<strong>di</strong>cano che l’ambiente in<br />
cui vivono è abbastanza salubre. Ogni anno vi sono moltissimi insetti e da loro <strong>di</strong>pende la sopravvivenza <strong>di</strong><br />
molti anfibi e pesci. Gli anfibi a loro volta sono buoni in<strong>di</strong>catori biologici così come determinate specie <strong>di</strong><br />
insetti. Lo stesso <strong>di</strong>casi per i rettili, che si cibano <strong>di</strong> anfibi mantenendone il numero costante. Grazie alla<br />
forte presenza <strong>di</strong> questi animali (invertebrati, pesci, anfibi, rettili), anche i mammiferi e gli uccelli ne<br />
traggono giovamento. A Buccinasco ad esempio vivono – chi in modo stanziale, chi solo per una parte<br />
dell’anno – almeno quaranta specie <strong>di</strong>verse <strong>di</strong> uccelli. Si tratta però <strong>di</strong> una sottostima.<br />
Animali che si cibano <strong>di</strong> vegetali e animali che predano altri animali, il tutto in un perfetto equilibrio in<br />
grado <strong>di</strong> autoregolarsi e che ci delizia con questo suo arcobaleno <strong>di</strong> forme, comportamenti, suoni e colori.<br />
La visione macroscopica <strong>di</strong> questi in<strong>di</strong>catori biologici ci conferisce quin<strong>di</strong> il risultato <strong>di</strong> un ambiente solido<br />
ma soprattutto vivo. E’ possibile anche valutare a livelli microscopici la salute dei nostri ambienti grazie allo<br />
stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> altri in<strong>di</strong>catori biologici, più piccoli che vivono nelle acque e nei terreni del nostro Comune. La<br />
presenza <strong>di</strong> questi piccoli organismi però è in<strong>di</strong>rettamente valutabile proprio dal fatto che le zone umide <strong>di</strong><br />
Buccinasco sono vive e ricche <strong>di</strong> fauna e flora. Tali organismi infatti costituiscono la base alimentare, e non<br />
solo, <strong>di</strong> una grande varietà <strong>di</strong> uccelli, pesci e anfibi e svolgono ruoli fondamentali deputati soprattutto al<br />
mantenimento delle giuste con<strong>di</strong>zioni ambientali. Si tratta infatti per lo più <strong>di</strong> organismi così detti “spazzini”<br />
e che degradano le sostanze organiche rendendole più facilmente assimilabili sia dalle piante che dagli<br />
animali.<br />
Nell’ecosistema Buccinasco infine hanno trovato casa non pochi animali predatori e soprattutto uccelli, per<br />
lo più acquatici, che fino a pochi anni fa era rarissimo osservare.<br />
E’ importante, proprio nell’anno internazionale <strong>della</strong> bio<strong>di</strong>versità, tutelare e valorizzare questo autentico<br />
patrimonio naturalistico. Noi ne siamo i custo<strong>di</strong> e abbiamo il compito <strong>di</strong> portare avanti e proteggere anche<br />
il lato naturalistico del nostro Comune.<br />
7
IL TERRITORIO<br />
Il territorio del Comune <strong>di</strong> Buccinasco fa parte dell‘ambito territoriale definito dal PTCP —me<strong>di</strong>a pianura<br />
irrigua e dei fontanili“. Caratterizzano questa unità paesistico territoriale la presenza <strong>di</strong> numerose teste ed<br />
aste <strong>di</strong> fontanile ed il fitto reticolo <strong>di</strong> canali che costituisce la rete irrigua. Il caratteristico ed eccezionale<br />
sistema irriguo, realizzato artificialmente a partire dal sistema naturale delle risorgive, si è via via<br />
enormemente ri<strong>di</strong>mensionato a causa dell‘urbanizzazione e le tracce che <strong>di</strong> esso sono rimaste sono presso<br />
che esistenti solo negli ambiti tutelati dal Parco Sud.<br />
I fontanili sono emergenze <strong>di</strong> acqua che affiora dove la falda trova strati argillosi impermeabili che le<br />
permettono una risalita in superficie. L'acqua sbocca formando una polla, ovvero una fonte dalla quale si<br />
origina la cosiddetta testa del fontanile. Ai margini <strong>della</strong> testa del fontanile si sviluppa una vegetazione ricca<br />
e rigogliosa che va a creare una piccola oasi <strong>di</strong> natura in mezzo alla campagna. La me<strong>di</strong>a pianura irrigua era<br />
fino a qualche decennio fa il paesaggio storico <strong>della</strong> marcita , ormai quasi del tutto scomparsa ma che nel<br />
territorio <strong>di</strong> Buccinasco sopravvive ancora in qualche esempio.<br />
Il territorio posto a sud <strong>della</strong> tangenziale ovest, quasi interamente ricadente nel perimetro del Parco Sud<br />
Milano, rappresenta ancora oggi una testimonianza storica <strong>di</strong> inestimabile valore dell‘antico paesaggio<br />
agricolo milanese: la presenza degli antichi nuclei agricoli, il sistema delle marcite, i fontanili e il reticolo<br />
idrico, il sistema <strong>di</strong> filari a delimitazione dei campi coltivati si uniscono al risultato <strong>di</strong> antropizzazione che in<br />
molti casi ha lasciato anche segni positivi sul territorio, come ad esempio gli specchi d‘acqua derivati<br />
dall‘attività <strong>di</strong> cava, la cui presenza è notevole anche nel territorio urbanizzato.<br />
Il Parco Agricolo Sud in<strong>di</strong>vidua alcune zone <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a specifica delle risorse naturali più pregiate. Vi<br />
sono poi zone <strong>di</strong> tutela e valorizzazione paesistica nella quale agricoltura e natura s'integrano per formare il<br />
caratteristico paesaggio <strong>di</strong> pianura. Un paesaggio nel quale è centrale il ruolo <strong>di</strong> siepi ed alberature, delle<br />
colture tra<strong>di</strong>zionali (il riso, le marcite, i prati) del set-aside (pratica <strong>di</strong> non lavorazione dei campi istituita e<br />
sovvenzionata dall'Unione Europea per limitare l'eccesso <strong>di</strong> produzione agricola e favorire, tra l'altro, la<br />
formazione <strong>di</strong> aree <strong>di</strong> rifugio <strong>della</strong> fauna selvatica).<br />
Nelle altre zone <strong>di</strong> interesse naturalistico sono incentivati interventi <strong>di</strong> naturalizzazione del territorio per la<br />
presenza <strong>di</strong> boschi e zone umide. Inoltre è sostenuto l'utilizzo <strong>di</strong> tecniche agricole più compatibili con la<br />
ricchezza e la bio<strong>di</strong>versità dell'ecosistema, quali quelle dell'agricoltura biologica, e <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong><br />
naturalizzazione delle fasce parallele <strong>di</strong> vegetazione che accompagnano i corsi dei fiumi (anche attraverso<br />
interventi <strong>di</strong> ingegneria naturalistica).<br />
Le colture non hanno più la varietà <strong>di</strong> un tempo pur tuttavia non è dominante la monocoltura. Il mais da<br />
foraggio (trinciato o granella) ha una presenza rilevante. E‘ la coltura più conveniente costituendo<br />
l‘alimentazione dei bovini da latte. Si semina a primavera, si miete a settembre.<br />
Il loietto è un‘erba da foraggio, viene seminato in autunno e falciato in primavera. Al suo posto si può<br />
subito seminare il mais.<br />
Il riso, che non veniva più coltivato da un ventennio, è riapparso e copre una limitata superficie sulla parte<br />
ovest al confine con Zibido e Gudo Gambaredo.<br />
Le ex marcite sono quelle che, pur mantenendo l‘impianto, non vengono più allagate e vengono tenute<br />
come prato stabile a falciatura trimestrale. Tuttavia qualche caso <strong>di</strong> marcita esiste ancora. Un buon<br />
esempio è in territorio Buccinasco Castello fra il cavo Lisone e la Speziana e sulla strada per Gudo davanti al<br />
laghetto S. Maria. La ragione per cui la marcita è andata scomparendo è che richiede molto lavoro manuale<br />
per mantenere in perfetta pendenza i piani onde si <strong>di</strong>stribuisca in modo uniforme il velo d‘acqua.<br />
Viene dato un contributo per il mantenimento delle marcite ma sulla congruità i pareri sono <strong>di</strong>scor<strong>di</strong> con il<br />
risultato che un esempio storico <strong>di</strong> alta ingegneria idraulica e ottimizzazione agricola sta per <strong>di</strong>ventare un<br />
ricordo. Il grano non si coltiva più tranne su appezzamenti marginali. Si produce una piccola quantità <strong>di</strong> orzo<br />
alla Cascinazza.<br />
Anche nel territorio urbanizzato infatti, sono presenti notevoli elementi <strong>di</strong> qualità del paesaggio,<br />
appartenenti ad una cultura urbana <strong>di</strong> recente espressione che non possono però essere sottovalutati. Va<br />
8
infatti evidenziato come dal punto <strong>di</strong> vista paesaggistico ci troviamo <strong>di</strong> fronte comunque ad un territorio<br />
fortemente antropizzato e lo stesso territorio agricolo è frutto innegabilmente <strong>di</strong> un continuo e secolare<br />
lavoro dell‘uomo. Questo infatti pur costituendo un habitat <strong>di</strong> elevata compatibilità naturalistica è il<br />
prodotto artificiale <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficazioni secolari volte allo sfruttamento agricolo.<br />
Allo stesso modo, nell‘ambito urbanizzato, la presenza <strong>di</strong> un sistema del verde articolato, privato e<br />
pubblico, la sopravvivenza <strong>di</strong> elementi ambientali e la stessa e<strong>di</strong>ficazione in gran parte caratterizzata da<br />
basse densità, hanno dato a Buccinasco un volto caratteristico e <strong>di</strong> valore<br />
9
FLORA E FAUNA<br />
Il Parco Agricolo Sud nel territorio <strong>di</strong> Buccinasco presenta <strong>di</strong>verse tipologie <strong>di</strong> ambienti che sviluppano una<br />
flora e una fauna caratteristica.<br />
Le rogge e fontanili<br />
Lungo i canali si è sviluppata una fascia <strong>di</strong> vegetazione dominata principalmente da specie arboree: l‘ontano<br />
nero (Alnus glutinosa), il pioppo nero (Populus nigra) e il salice bianco (Salix Alba) che trovano in questi<br />
ambienti ripariali umi<strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni ottimali per la loro crescita. Lungo i corsi d‘acqua principali come il Cavo<br />
Belgioioso vi sono anche significativi esemplari <strong>di</strong> Farnia (Quercus robur), <strong>di</strong> Pioppo bianco (Populus alba)e<br />
<strong>di</strong> Tiglio (Tilia x vulgaris).<br />
Tra le piante erbacee legate alle ripe umide sul bordo dei canali segnaliamo Symphytum officinale o<br />
Consolida maggiore, dall‘infiorescenza bianca e vistosa che è possibile vedere fino a tarda estate, Lamium<br />
purpureum o Falsa ortica purpurea e Lamium album, Falsa ortica bianca.<br />
Gli ontaneti, cioè i boschi con dominanza <strong>di</strong> ontano nero (Alnus glutinosa), sono relativamente frequenti<br />
lungo i corsi d‘acqua <strong>di</strong> pianura. E‘ un tipo <strong>di</strong> bosco piuttosto semplice in cui si riconoscono due strati<br />
principali: quello arboreo costituito da ontano nero, olmo, pioppo nero e quello erbaceo che forma il<br />
sottobosco.<br />
Le chiome dell‘ontano nero sono molto dense per cui il sottobosco è piuttosto ombreggiato e ciò impe<strong>di</strong>sce<br />
lo sviluppo <strong>di</strong> uno strato arbustivo se non nelle zone <strong>di</strong> margine o nelle zone più chiare. Tra i rari arbusti vi<br />
sono quelli nemorali come Prunus serotina e Frangula anlus e quelli che amano i terreni molto umi<strong>di</strong> e<br />
ricchi <strong>di</strong> acqua, ma che non sopportano le posizioni in ombra per cui si trovano più facilmente verso il<br />
margine del bosco.<br />
Tra questi ultimi: alcuni salici (Salix alba, Salix fragilis e Salix eleagnos), il sanguinello (Cornus sanguinea) e il<br />
sambuco (Sambucus nigra).<br />
Lo strato erbaceo è invece complesso e molto ricco <strong>di</strong> specie. Se ne riconoscono due tipi fondamentali: uno<br />
formato da alte erbe palustri, dove il terreno è più paludoso e il suolo più profondo, e uno meno rigoglioso,<br />
più rado, costituito da specie meno idrofile e con sviluppo verticale ridotto<br />
I laghetti<br />
Nel territorio <strong>di</strong> Buccinasco sono presenti <strong>di</strong>versi laghetti, non naturali ma cave <strong>di</strong>smesse scavate negli<br />
scorsi decenni.<br />
Il più grande ed importante in territorio Parco Sud è quello denominato S. Maria, scavato nel 1966 per<br />
procurare ghiaia e sabbia per la costruzione <strong>della</strong> tangenziale ovest. Oggi sta <strong>di</strong>ventando punto <strong>di</strong> sosta per<br />
uccelli migratori.<br />
Questi specchi d‘acqua stagnante sono ricchi <strong>di</strong> vegetazione acquatica, questo tipo <strong>di</strong> piante presentano<br />
<strong>di</strong>verse strategie <strong>di</strong> sopravvivenza: possono essere galleggianti senza alcun tipo <strong>di</strong> ancoraggio con il terreno<br />
oppure possono utilizzare come substrato il se<strong>di</strong>mento presente sul fondo dello stagno<br />
Il prato asciutto<br />
Nel Parco Agricolo vi sono anche piccole aree <strong>di</strong> prato asciutto, questa definizione in<strong>di</strong>ca che si tratta <strong>di</strong> una<br />
zona ben drenata, dove cioè non si verificano ristagni d'acqua, ma anzi l'acqua che vi affluisce viene<br />
rapidamente assorbita dal terreno. Le piante in grado <strong>di</strong> crescere su un terreno <strong>di</strong> questo tipo sono dunque<br />
piante adattate a con<strong>di</strong>zioni asciutte, con moderata <strong>di</strong>sponibilità idrica.<br />
Questa con<strong>di</strong>zione può essere verificata <strong>di</strong>rettamente dall'osservazione del terreno cioè dalla valutazione<br />
<strong>della</strong> granulometria del suolo: terreni sabbiosi lasciano fluire l'acqua fino a gran<strong>di</strong> profon<strong>di</strong>tà, terreni<br />
argillosi risultano invece impermeabile e causano ristagni d'acqua nel suolo; ma utili in<strong>di</strong>cazioni ci vengono<br />
fornite anche dalla vegetazione inse<strong>di</strong>atasi, costituita da piante con poche esigenze idriche.<br />
10
IL CANNETO o FRAGMITETO<br />
I canneti in senso lato sono formazioni erbacee palustri composte da monocotiledoni <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni elevate<br />
(fino a 1,5-2 m <strong>di</strong> altezza) che crescono molto compatte anche per estensioni assai ampie, formando<br />
popolamenti puri, cioè costituiti da una sola specie, il fragmiteto, o canneto a Phragmites australis, è un<br />
esempio <strong>di</strong> questa vegetazione piuttosto frequente in pianura. Nel territorio <strong>di</strong> Buccinasco esiste un area<br />
vicino a Buccinasco Castello, vicino all‘incrocio tra il Cavo Lisone e la Roggia <strong>di</strong> Buccinasco, che può essere<br />
definita zona umida in cui è riscontrabile la presenza <strong>di</strong> un piccolo canneto composto esclusivamente dalla<br />
cannuccia <strong>di</strong> palude (Phragmites australis) specie <strong>di</strong>ffusissima negli ambienti umi<strong>di</strong> <strong>di</strong> pianura.<br />
Generalmente esse si instaurano su terreni costantemente allagati o almeno durante le stagioni <strong>di</strong><br />
maggiore piovosità. Nei nostro caso il fragmiteto è cresciuto in una zona precedentemente a<strong>di</strong>ta a prato<br />
marcitorio.<br />
11
I FONTANILI DI BUCCINASCO<br />
Buccinasco è uno dei Comuni <strong>della</strong> Provincia <strong>di</strong> Milano con la più alta presenza <strong>di</strong> fontanili attivi.<br />
E’ opportuno in questa sede fornire una panoramica storica e naturalistica sulle origini dei fontanili e sulle<br />
loro peculiarità.<br />
La Pianura Padana si <strong>di</strong>vide in due fasce principali: l’Alta pianura e la Bassa pianura. Queste <strong>di</strong>fferiscono<br />
l’una dall’altra per le caratteristiche geologiche dei propri suoli. Difatti, il terreno che costituisce l’Alta<br />
pianura è molto permeabile risultando <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficile irrigazione; quello <strong>della</strong> Bassa pianura invece assume una<br />
composizione prevalentemente argillosa, più fine, compatta e quin<strong>di</strong> più impermeabile. L’irrigazione risulta<br />
essere così più abbondante. Il confine tra l’Alta e la Bassa pianura è caratterizzato dalla fascia delle<br />
risorgive. L’acqua piovana che cade sulle colline dell’Alta pianura penetra in profon<strong>di</strong>tà fino ad incontrare<br />
uno strato <strong>di</strong> argille (impermeabile) tipico <strong>della</strong> Bassa pianura. Qui l’acqua affiora dolcemente ad una<br />
temperatura che si mantiene costante nell’arco <strong>di</strong> tutto l’anno. Mentre la risorgiva è un fenomeno naturale,<br />
il fontanile rappresenta, in alcuni luoghi, il prodotto dell’intervento umano che ha mo<strong>di</strong>ficato una risorgiva<br />
o ne ha “creata” una tramite opere <strong>di</strong> scavo per scopi irrigui, sfruttando le acque <strong>di</strong> prima falda. I primi<br />
interventi <strong>di</strong> questo genere risalgono ai secoli XI – XII.<br />
Un fontanile è tipicamente formato da una testa, ovvero il “laghetto” dove si trovano le sorgenti, e da<br />
un’asta che consiste nell’alveo in cui viene incanalata l’acqua estratta.<br />
I fontanili costituiscono un habitat molto particolare caratterizzato dalla contemporanea presenza <strong>di</strong> un<br />
ambiente acquatico e agroforestale. Essendo una zona umida risulta essere ricca <strong>di</strong> cospicue varietà<br />
vegetazionali e animali.<br />
La flora presente nei fontanili e nei loro paraggi <strong>di</strong>pende dalle <strong>di</strong>mensioni e profon<strong>di</strong>tà degli stessi, dai<br />
se<strong>di</strong>menti del fondo e dalla motilità dell’acqua. Ultimamente, in molti casi, possiamo assistere ad una<br />
colonizzazione <strong>di</strong> questi ambienti da parte <strong>di</strong> specie (sia animali che vegetali) alloctone giunte qui per lo più<br />
per cause antropiche. Un esempio su tutti è la presenza in molti fontanili nostrani <strong>della</strong> Robinia e<br />
dell’Ailanto a scapito delle nostre specie autoctone come Querce e Pioppi.<br />
La fauna tipica <strong>di</strong> questi luoghi è composta da numerosissime specie <strong>di</strong> gasteropo<strong>di</strong>, artropo<strong>di</strong>, crostacei,<br />
organismi bentonici (meiofauna e macroinvertebrati), pesci, anfibi, rettili, uccelli e mammiferi.<br />
Purtroppo la mo<strong>di</strong>fica chimica e fisica delle acque e <strong>della</strong> struttura <strong>di</strong> questi corpi idrici è causa<br />
dell’alterazione e dell’impoverimento delle comunità acquatiche, le quali <strong>di</strong>ventano più monotone<br />
comportando un calo drastico <strong>della</strong> bio<strong>di</strong>versità. Questo è un forte in<strong>di</strong>catore dello stato <strong>di</strong> “salute” dei<br />
fontanili.<br />
Sul territorio <strong>di</strong> Buccinasco sono <strong>di</strong>stribuiti <strong>di</strong>versi fontanili che, fortunatamente, sono per buona parte<br />
ancora attivi.<br />
Ne cito solo alcuni, a mio avviso, tra i più conosciuti e importanti.<br />
Il fontanile Battiloca: assomiglia ad un piccolo bosco ove, camminandoci all’interno durante la bella<br />
stagione, è possibile respirare un’atmosfera quasi magica in grado <strong>di</strong> farci <strong>di</strong>menticare che a pochi<br />
chilometri da noi vi è la grande metropoli “Milano”. Qui si trovano <strong>di</strong>verse specie <strong>di</strong> avifauna e<br />
micromammiferi.<br />
Il fontanile Mortisia: caratterizzato dalla presenza <strong>di</strong> un piccolo ma importante “isolotto” nel bel mezzo<br />
<strong>della</strong> testa del fontanile. Durante la primavera e l’estate questo si trasforma in una riserva <strong>di</strong> ni<strong>di</strong> per<br />
<strong>di</strong>verse specie <strong>di</strong> uccelli. Oltre all’avifauna qui vivono castorini, ricci, tartarughe, pesci, etc.<br />
Il fontanile Brianzona: protetto da una fascia boscata caratterizzata da non poche specie arboree<br />
autoctone, è un vero e proprio rifugio naturale <strong>di</strong> molti passeriformi e piciformi (picchi).<br />
Il fontanile Bazzanella: sito in Buccinasco Castello, è stato ristrutturato e recuperato recentemente e si<br />
trova in pieno contesto agricolo. In questo fontanile sono stati osservati esemplari <strong>di</strong> tritone e risulta essere<br />
un buon punto <strong>di</strong> riferimento per alcuni ardei<strong>di</strong> (ciconiformi).<br />
All’interno del Parco Agricolo Sud Milano, tra Buccinasco Castello e Gudo Gambaredo, sono presenti molti<br />
altri fontanili ognuno con la propria origine e le proprie caratteristiche idriche e bio-ecologiche.<br />
12
I fontanili rappresentano quin<strong>di</strong> un luogo <strong>di</strong> incontro tra storia, cultura e natura, all’interno <strong>di</strong> un contesto<br />
sempre più urbanizzato e le loro peculiarità fanno <strong>di</strong> questi habitat umi<strong>di</strong> delle vere e proprie oasi con flora<br />
e fauna spesso uniche. E’ molto importante recuperare e conservare questi ambienti perché rappresentano<br />
una risorsa inestimabile sia da un punto <strong>di</strong> vista culturale che naturalistico.<br />
13
CARTINA IDROGRAFIA BUCCINASCO<br />
14
FAUNA<br />
FAUNA<br />
15
All'interno del Parco Agricolo Sud Milano la fauna è presente in numero considerevole nelle aree <strong>di</strong> maggior<br />
pregio naturalistico (boschi, zone umide, fontanili) e in misura minore nelle zone coltivate. Sono state<br />
rilevate alcune specie fra cui il ghiro, il tasso, la faina, la volpe, il coniglio selvatico, la donnola, la lepre ed<br />
altri. Molteplici gli uccelli presenti nella campagna: l'airone cinerino, il picchio, la garzetta, il cuculo, la<br />
cinciallegra, il migliarino <strong>di</strong> palude e tantissimi altri.<br />
L’ambiente agricolo è un mosaico <strong>di</strong> microambienti che ospitano varie specie animali e vegetali. Spesso la<br />
nostra attenzione è attratta da specie visibili come gli uccelli, ma la presenza <strong>di</strong> questi è garantita<br />
dall’esistenza <strong>di</strong> molte specie come insetti, anfibi, micromammiferi e rettili, che sono in<strong>di</strong>spensabili per il<br />
funzionamento e l’equilibrio <strong>della</strong> rete alimentare e dell’ecosistema agricolo. Inoltre molte <strong>di</strong> queste specie<br />
sono anche utili all’uomo, regolando in maniera naturale altri animali che possono entrare in conflitto con<br />
l’agricoltura come insetti nocivi e ro<strong>di</strong>tori.<br />
16
RETTILI<br />
REPTILIA<br />
17
NOME COMUNE<br />
Lucertola campestre<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Podarcis sicula<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Le <strong>di</strong>mensioni variano dai 15 ai 25 cm, compresa la coda.<br />
Ha una colorazione molto variabile a seconda <strong>della</strong> sottospecie e delle popolazioni locali: il dorso è verde,<br />
verde-oliva o verde-brunastro, variamente macchiettato e/o striato. Il ventre è biancastro o verdastro. Le<br />
popolazioni che vivono nelle isole piccole sono molto variabili e presentano gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>versità nel <strong>di</strong>segno<br />
caratteristico del dorso. Quasi sempre sono presenti 2 macchie cerulee alla base delle zampe anteriori. Il<br />
bordo delle squame ventrali può essere azzurro. Il corpo è agile e snello e le zampe muscolose, la coda può<br />
raggiungere il doppio <strong>della</strong> lunghezza del corpo. Le <strong>di</strong>ta, 5 per zampa, sono sottili e terminano con un<br />
artiglio che permette all'animale <strong>di</strong> arrampicarsi agilmente su ogni superficie ruvida. I maschi adulti<br />
generalmente sono più grossi e possenti e hanno collo e testa più gran<strong>di</strong> e robusti delle femmine. È un<br />
sauro spiccatamente <strong>di</strong>urno e si può osservare, nel suo habitat, quasi sempre in presenza del sole. Nella<br />
parte meri<strong>di</strong>onale dell' areale si può vedere anche in pieno inverno, durante le giornate tiepide e<br />
soleggiate. Alla vista <strong>di</strong> un pericolo scappano velocemente tra la vegetazione fitta o nelle crepe dei muri.<br />
Nelle zone frequentate dagli uomini <strong>di</strong>ventano confidenti e si lasciano avvicinare anche a pochi metri.<br />
DOVE – Zone agricole, urbane, suburbane, parchi e giar<strong>di</strong>ni.<br />
ALIMENTAZIONE – Si nutrono principalmente <strong>di</strong> artropo<strong>di</strong> e occasionalmente anche <strong>di</strong> frutta matura ed<br />
esemplari piccoli <strong>della</strong> stessa specie. I maschi adulti sono territoriali e si scontrane tra <strong>di</strong> loro.<br />
RIPRODUZIONE – La maturità sessuale viene raggiunta dai maschi ad un anno <strong>di</strong> vita e dalle femmine a due<br />
anni. Gli accoppiamenti iniziano in primavera dopo il letargo invernale.<br />
I maschi inseguono le femmine e le bloccano con un morso sul tronco prima delle zampe posteriori. Poi<br />
piegandosi su se stessi uniscono la loro cloaca a quella <strong>della</strong> femmina. A volte le femmine mature<br />
presentano i segni dei morsi dei maschi sul ventre, riconoscibili per la forma a "V".<br />
Le femmine depongono dalle 2 alle 12 uova nella vegetazione fitta, in buche nel terreno o sotto i massi.<br />
Tra luglio ed agosto nascono i piccoli.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
LUCERTOLA CAMPESTRE<br />
18<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Reptilia<br />
ORDINE<br />
Squamata<br />
FAMIGLIA<br />
Lacertidae<br />
GENERE<br />
Podarcis<br />
SPECIE<br />
P. sicula
NOME COMUNE<br />
Lucertola muraiola<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Podarcis muralis<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – È la più comune delle lucertole italiane, è lunga circa 15 cm (compresa la coda) ma può<br />
arrivare a 20-25 cm. Trova la tana in buchi nei muri o sotto terra e appena uscita, si riposa al sole per<br />
scaldarsi.<br />
DOVE – Zone agricole, urbane, suburbane, parchi e giar<strong>di</strong>ni.<br />
ALIMENTAZIONE – La <strong>di</strong>eta comprende essenzialmente insetti e aracni<strong>di</strong>.<br />
RIPRODUZIONE – È una specie ovipara: la femmina depone, solitamente due volte all'anno, da 2 a 10 uova<br />
che si schiudono tra luglio e settembre<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
LUCERTOLA MURAIOLA<br />
20<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Reptilia<br />
ORDINE<br />
Squamata<br />
FAMIGLIA<br />
Lacertidae<br />
GENERE<br />
Podarcis<br />
SPECIE<br />
P. muralis
NOME COMUNE<br />
natrice<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Natrix natrix<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – La natrice dal collare è un colubride europeo sprovvisto <strong>di</strong> zanne e del tutto inoffensivo.<br />
Misura circa un metro <strong>di</strong> lunghezza; le femmine sono molto più grosse dei maschi. La biscia dal collare è<br />
tipicamente verde scura o marrone con un collare giallo caratteristico <strong>di</strong>etro alla testa a cui deve il nome<br />
caratteristico <strong>di</strong> biscia dal collare. Poiché non sono velenose, le loro uniche <strong>di</strong>fese sono la produzione <strong>di</strong> un<br />
fluido dall'odore aspro dalle ghiandole anali o la finzione <strong>della</strong> morte.<br />
DOVE – Fontanili, cave rogge<br />
ALIMENTAZIONE – E' un serpente particolarmente vorace e, per la sua bocca estensibile, può inghiottire<br />
prede relativamente grosse. Agli anfibi, che rappresentano la parte essenziale <strong>della</strong> sua <strong>di</strong>eta, talvolta<br />
aggiunge lucertole, giovani uccelli, piccoli mammiferi e pesciolini.<br />
RIPRODUZIONE – L'accoppiamento avviene ad aprile o maggio. Le uova vengono deposte in gruppi <strong>di</strong> 8 - 40<br />
in giugno e luglio e si schiudono dopo circa 10 settimane. Poiché le uova richiedono una temperatura <strong>di</strong><br />
almeno 21 gra<strong>di</strong> per schiudersi, sono postazioni preferite la vegetazione in putrefazione, incluso i cumuli <strong>di</strong><br />
compost. Con un apposito dente sviluppato, il piccolo pratica 2 o 3 incisioni lungo il guscio e fa uscire la<br />
testa; può rimanere in questa posizione, ossia con il resto del corpo ancora immerso nell'uovo, per alcune<br />
ore prima <strong>di</strong> uscire completamente.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
NATRICE<br />
22<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Reptilia<br />
ORDINE<br />
Squamata<br />
FAMIGLIA<br />
Colubridae<br />
GENERE<br />
Natrix<br />
SPECIE<br />
N. natrix
NOME COMUNE<br />
Ramarro<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
L. viri<strong>di</strong>s<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Il ramarro è un sauro <strong>della</strong> famiglia dei Lacerti<strong>di</strong>, <strong>di</strong> colore verde brillante, rapi<strong>di</strong>ssimo nei<br />
movimenti, la lunghezza può raggiungere i 45 cm (coda compresa). Nei maschi, il dorso è verde brillante;<br />
nelle femmine è più scuro. I maschi si <strong>di</strong>stinguono inoltre dalle femmine per le <strong>di</strong>mensioni <strong>della</strong> testa (più<br />
grossa) e per una maggiore larghezza <strong>della</strong> base <strong>della</strong> coda. Il ramarro passa inattivo il periodo invernale in<br />
anfratti del terreno.<br />
DOVE – Zone agricole, urbane, suburbane, parchi e giar<strong>di</strong>ni.<br />
ALIMENTAZIONE – I ramarri si nutrono <strong>di</strong> insetti e altri piccoli artropo<strong>di</strong>, ma anche <strong>di</strong> piccoli vertebrati<br />
(serpenti, altri rettili ecc.) e <strong>di</strong> uova <strong>di</strong> uccelli. La loro alimentazione è integrata da bacche e altri prodotti<br />
vegetali<br />
RIPRODUZIONE – I ramarri depongono da 5 a circa 20 uova dal guscio non rigido. Le uova vengono<br />
collocate in buche scavate nel terreno, al riparo <strong>della</strong> vegetazione, e si schiudono dopo 2-3 mesi circa. Nella<br />
stagione riproduttiva, i maschi lottano tra loro sollevando la parte anteriore del corpo. Una volta<br />
conquistata la femmina, durante l'accoppiamento, queste vengono trattenute dai maschi tramite un morso<br />
sul fianco: in primavera è quin<strong>di</strong> possibile riscontrare sul loro corpo evidenti cicatrici a forma <strong>di</strong> "V".<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
RAMARRO<br />
24<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Reptilia<br />
ORDINE<br />
Squamata<br />
FAMIGLIA<br />
Lacertidae<br />
GENERE<br />
Lacerta<br />
SPECIE<br />
L. viri<strong>di</strong>s
TARTARUGA DALLE ORECCHIE GIALLE<br />
NOME COMUNE<br />
Tartaruga orecchie gialle<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Trachemys scripta scripta<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – I maschi sono più piccoli e si aggirano sui 13 cm, mentre le femmine possono raggiungere<br />
anche i 28 cm. Presenta delle macchie gialle sulle orecchie e in fondo ad esse presenta macchie molto<br />
chiare sul rossastro. Il carapace cambia colore a seconda dell'età: quando l'in<strong>di</strong>viduo è più giovane il colore<br />
è verde chiaro, poi con il passare del tempo si scurisce fino ad arrivare perfino al nero. I maschi hanno<br />
unghie molto lunghe (possono arrivare fino a 3 cm), che servono per facilitare la danza <strong>di</strong> accoppiamento, e<br />
una coda molto lunga con estremità molto larga e apertura <strong>della</strong> cloaca posta alla sua estremità, in<br />
prossimità <strong>della</strong> punta; le femmine invece hanno una coda sottile con la cloaca posta alla base <strong>della</strong> coda<br />
per aiutarle durante la deposizione delle uova. Il letargo <strong>di</strong> questo animale varia a seconda del luogo,<br />
solitamente dura il periodo invernale, ovvero da fine novembre a inizio marzo. È una tartaruga pacifica che<br />
vive in gruppi che <strong>di</strong>fficilmente superano la decina <strong>di</strong> esemplari.<br />
DOVE – Zone umide (fontanili, cave rogge)<br />
ALIMENTAZIONE – Onnivora. La tartaruga dalle orecchie gialle preferisce cibarsi al mattino, dato che la<br />
temperatura è più bassa, poi rimane al sole per favorire la <strong>di</strong>gestione.<br />
RIPRODUZIONE – Le uova vengono tenute in grembo per un periodo che varia dai 30 ai 60 giorni, e dopo<br />
esser state deposte in un terriccio umido e caldo bisogna aspettare dai 2 ai 4 mesi prima <strong>di</strong> vederle<br />
schiudersi. Una tartaruga può deporre dalle 5 alle 20 uova in ogni covata e ogni anno fa circa tre covate.<br />
Come in altre specie <strong>di</strong> rettili, il sesso <strong>di</strong>pende dalla temperatura, ovvero se le uova vengono deposte in un<br />
luogo con meno <strong>di</strong> 27 gra<strong>di</strong> nascerà una tartaruga <strong>di</strong> sesso maschile, mentre se vengono deposte in un<br />
luogo con temperatura <strong>di</strong> 30 gra<strong>di</strong> o superiore, nascerà una tartaruga <strong>di</strong> sesso femminile. Le covate che<br />
nascono a una temperatura compresa tra i 27 e i 30 gra<strong>di</strong> generano esemplari <strong>di</strong> <strong>di</strong>verso sesso, a seconda <strong>di</strong><br />
quali uova restano più al caldo.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
26<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Reptilia<br />
ORDINE<br />
Testu<strong>di</strong>nes<br />
FAMIGLIA<br />
Emy<strong>di</strong>dae<br />
GENERE<br />
Trachemys<br />
SPECIE<br />
T. scripta scripta
NOME COMUNE<br />
Tartaruga orecchie rosse<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
T. Scripta elegans<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
TARTARUGA ORECCHIE ROSSE<br />
DESCRIZIONE – Le <strong>di</strong>mensioni degli adulti variano da 12,5 a 28 cm (le femmine raggiungono le taglie<br />
maggiori). Il colore del carapace è verde nei giovani, e <strong>di</strong>venta progressivamente più scuro mano a mano<br />
l’animale invecchia, fino a <strong>di</strong>ventare in certi soggetti marrone scuro o quasi nero. Il piastrone è giallo con<br />
macchie o <strong>di</strong>segni neri. La cute è per lo più verde con strisce gialle, ma <strong>di</strong>etro il timpano è presente una<br />
caratteristica macchia rossa, che rende questa sottospecie inconfon<strong>di</strong>bile, ma che può ridursi o scomparire<br />
negli adulti. Sebbene sia un’abilissima nuotatrice Trachemys s. elegans trascorre molto tempo ad esporsi al<br />
sole che ha la funzione principale <strong>di</strong> permettere la termoregolazione, ossia il raggiungimento <strong>di</strong> una<br />
temperatura corporea ottimale. Inoltre ha lo scopo <strong>di</strong> premettere la sintesi <strong>di</strong> vitamina D3 e <strong>di</strong> far asciugare<br />
la cute, il che ostacola la crescita <strong>di</strong> alghe dannose e allontana i parassiti. Raramente si avventura sulla<br />
terraferma, se non per deporre le uova o per cercare un nuovo corso d’acqua, in caso <strong>di</strong> necessità. Le<br />
Trachemys s. elegans sono attive ad una temperatura compresa tra 10° e 37°C; 41°C rappresentano la<br />
temperatura critica superiore. Quando la temperatura scende sotto i 10°C non possono più alimentarsi e<br />
vanno in letargo. In genere passano il letargo sott’acqua.<br />
DOVE – Zone umide (fontanili, cave rogge).<br />
ALIMENTAZIONE – Le Trachemys sono onnivore e in natura si alimentano <strong>di</strong> pesci, rane, girini, vermi,<br />
lumache, insetti, larve, animali morti e piante acquatiche. Un altro tipo <strong>di</strong> strategia alimentare delle<br />
tartarughe dalle orecchie rosse consiste nella neustofagia, un processo <strong>di</strong> filtrazione simile a quello<br />
impiegato dalle balene. Le tartarughe nuotano sul pelo dell’acqua con la bocca aperta, in modo da ingerire<br />
con l’acqua delle particelle alimentari. In seguito chiudono la bocca ed espellono l’acqua attraverso le<br />
narici, e ingoiano il cibo rimasto nella bocca.<br />
RIPRODUZIONE – Allo stato naturale i maschi raggiungono la maturità sessuale a 2-5 anni <strong>di</strong> età, a una<br />
lunghezza del piastrone <strong>di</strong> 9-10 cm. Le femmine <strong>di</strong>ventano sessualmente mature quando raggiungono una<br />
lunghezza <strong>di</strong> 15-19,5 cm (spesso nei rettili l’insorgenza <strong>della</strong> maturità sessuale <strong>di</strong>pende dalla taglia<br />
raggiunta, più che dall’età). La stagione riproduttiva generalmente va da marzo a luglio. Il maschio corteggia<br />
28<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Reptilia<br />
ORDINE<br />
Testu<strong>di</strong>nes<br />
FAMIGLIA<br />
Emy<strong>di</strong>dae<br />
GENERE<br />
Trachemys<br />
SPECIE<br />
T. Scripta elegans
la femmina mettendosi davanti a lei e carezzandone la testa e il collo con le lunghe unghie degli arti<br />
anteriori; la copula vera e propria dura circa 15 minuti. Quando è pronta a deporre le uova, dopo circa 4-6<br />
settimane, la femmina cerca una zona adatta per scavare un nido, in genere un’area <strong>di</strong> terreno umido<br />
vicino all’acqua. Le uova vengono emesse a intervalli <strong>di</strong> 40 secon<strong>di</strong>. Al termine la femmina ricopre il nido<br />
con terriccio e detriti. In un anno vengono deposte fino a tre covate. Il numero <strong>di</strong> uova deposto per covata<br />
va da 4 a 23, a seconda delle <strong>di</strong>mensioni <strong>della</strong> femmina. Le uova impiegano 2-3 mesi per schiudere, e a<br />
volte la schiusa avviene dopo l’inverno. Nei soggetti adulti il riconoscimento del sesso non presenta<br />
<strong>di</strong>fficoltà. Le femmine raggiungono una taglia maggiore dei maschi, i quali presentano una coda più lunga e<br />
le unghie degli arti anteriori molto lunghe Nei soggetti giovani il riconoscimento del sesso è molto <strong>di</strong>fficile.<br />
La determinazione del sesso è legata alla temperatura <strong>di</strong> incubazione. Se le uova vengono incubate al <strong>di</strong><br />
sotto dei 27°C nascono solo maschi (tempo <strong>di</strong> incubazione 100-120 giorni), invece sopra i 30°C nascono<br />
femmine (tempo <strong>di</strong> incubazione 60-70 giorni). A temperature interme<strong>di</strong>e nascono maschi e femmine in<br />
proporzione variabile.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare. T. s. elegans attualmente è in Allegato B del<br />
Regolamento CE n° 338/97 del 09.12.1996. In pratica significa che è vietata la sua importazione nei paesi<br />
dell'Unione Europea, ma i soggetti importati prima dell’entrata in vigore <strong>della</strong> legge sono <strong>di</strong> libera<br />
detenzione. Ciò non perchè sia in pericolo <strong>di</strong> estinzione, ma perché gli innumerevoli soggetti che da anni<br />
vengono in modo incosciente "liberati" nei fiumi e nei laghi costituiscono una vera minaccia per la flora e la<br />
fauna locale, in particolare per gli anfibi e per la tartaruga palustre europea, Emys orbicularis.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
29
ANFIBI<br />
AMPHIBIA<br />
31
NOME COMUNE<br />
Raganella<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Hyla arborea<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Appartenente all'or<strong>di</strong>ne degli Anuri e alla famiglia degli Ili<strong>di</strong>, la raganella può essere<br />
facilmente riconosciuta per il corpo globoso <strong>di</strong> circa 5 cm <strong>di</strong> lunghezza massima, per la colorazione<br />
solitamente verde brillante e per la presenza <strong>di</strong> due fasce brune che, partendo dalle narici e attraversando<br />
l'occhio, scendono lungo i fianchi delimitando cosi un'area ventrale <strong>di</strong> colore grigio fumo o bruno-giallastro<br />
che nel maschio si presenta sempre più scuro che nella femmina.<br />
Un altro carattere molto utile per la <strong>di</strong>stinzione <strong>di</strong> quest'animale è la presenza dei <strong>di</strong>schi adesivi alle<br />
estremità delle <strong>di</strong>ta che le permettono <strong>di</strong> arrampicarsi agevolmente su alberi e cespugli; questo comunque<br />
è un comportamento riscontrabile solo negli esemplari adulti, infatti i giovani preferiscono trascorrere il<br />
tempo in prossimità del terreno.<br />
Una interessante particolarità delle raganelle è la capacità <strong>di</strong> mutare colore al mutare delle variazioni<br />
climatiche e del proprio stato <strong>di</strong> eccitazione, passando così dal verde al grigio, al bruno o ad<strong>di</strong>rittura ad una<br />
colorazione chiazzata.<br />
DOVE – Rogge, fontanili, cave<br />
ALIMENTAZIONE – Le raganelle sono insettivore, si nutrono <strong>di</strong> artropo<strong>di</strong> e altri invertebrati acquatici e<br />
terricoli. Sono prevalentemente arboricole, ma si trovano anche in mezzo alle erbe palustri, nei campi in<br />
prossimità <strong>di</strong> fossi e risaie.<br />
RIPRODUZIONE – Sono legate all'acqua per la riproduzione. Dall'uovo esce il girino che compie il proprio<br />
ciclo vitale in tempi variabili tra 1,5 e 3 mesi. Alla fine <strong>della</strong> metamorfosi il girino avrà sviluppato zampe atte<br />
a saltare, polmoni per respirare fuori dall'acqua, avrà perso la coda e avrà cambiato regime alimentare<br />
passando da detritivoro a carnivoro.<br />
Gli adulti inoltre al <strong>di</strong> fuori del periodo riproduttivo, che va da aprile a maggio e durante il quale le femmine<br />
depongono sino a mille uova riunite in degli ammassi regolari delle <strong>di</strong>mensioni <strong>di</strong> una noce, possono<br />
allontanarsi sensibilmente dall'acqua; nel periodo che invece va dall'autunno alla primavera sono solite<br />
svernare in nascon<strong>di</strong>gli sotterranei sia da sole che in piccoli gruppetti.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare<br />
RISCHIO MINIMO<br />
RAGANELLA<br />
32<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Anfibi<br />
ORDINE<br />
Anura<br />
FAMIGLIA<br />
Hylidae<br />
GENERE<br />
Hyla<br />
SPECIE<br />
H. arborea
NOME COMUNE<br />
Rana verde<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Pelophylax esculentus<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Pelophylax esculentus è una rana acquatica <strong>di</strong> 12 cm <strong>di</strong> lunghezza, dal muso appuntito. Gli<br />
occhi sono composti da una pupilla rotonda leggermente orizzontale con iride giallastra; la lingua è corta<br />
ma estroflettibile, anche se, quando mangiano, si lanciano con tutto il corpo sulla preda. Le zampe<br />
posteriori sono potentissime e palmate ; la vista è acutissima, riuscendo a vedere prede a una notevole<br />
<strong>di</strong>stanza o ad<strong>di</strong>rittura che si muovono sott’acqua, per non parlare dei salti che vengono fatti con estrema<br />
precisione e con un margine <strong>di</strong> errore pressoché nullo. Il dorso, è <strong>di</strong> colore verde smagliante o bruno oliva,<br />
talvolta cosparso <strong>di</strong> macchie nere, è ornato, ad ogni lato. L'ibernazione ha luogo nella melma dello stagno in<br />
cui vive.<br />
DOVE – Fontanili, cave rogge<br />
ALIMENTAZIONE – Si nutrono <strong>di</strong> lombrichi, lumache, insetti acquatici (che mangiano anche sott’acqua),<br />
cavallette, farfalline, falene, bruchi, ragni, pesciolini.<br />
RIPRODUZIONE – il <strong>di</strong>morfismo sessuale è accentuato: i maschi, infatti, presentano due sacchi vocali<br />
laterali, che possono essere estroflessi tramite un'apertura orizzontale posta subito <strong>di</strong>etro l'apertura<br />
boccale. Le femmine sono anche in grado <strong>di</strong> emettere suoni, ma sono molto meno lunghi e forti <strong>di</strong> quelli dei<br />
maschi, e provengono dalla gola, data la mancanza <strong>di</strong> sacchi vocali in questo sesso.<br />
Gli accoppiamenti si svolgono fra Aprile e Giugno; le deposizioni possono contare da poche centinaia ad<br />
alcune migliaia <strong>di</strong> uova; <strong>di</strong> solito le uova vengono deposte a gruppi (2-3); l ’amplesso è ascellare; i girini<br />
schiudono in 7-8 giorni (<strong>di</strong>pende da temperatura e con<strong>di</strong>zioni dell’ acqua), e metamorfosano in circa 2-3<br />
mesi. Quando metamorfosano sono piuttosto gran<strong>di</strong>, potendo raggiungere i 2,5 cm; infine la maturità<br />
sessuale viene raggiunta molto presto: intorno ai 12 mesi <strong>di</strong> vita<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
RANA VERDE<br />
33<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Amphibia<br />
ORDINE<br />
Anura<br />
FAMIGLIA<br />
Ranidae<br />
GENERE<br />
Pelophylax<br />
SPECIE<br />
P. esculentus
NOME COMUNE<br />
Rospo comune<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Bufo Bufo<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – È l'anfibio più grande d'Europa, e raggiunge ad<strong>di</strong>rittura i 20 cm (zampe escluse). La sua<br />
colorazione è marrone, che può tendere al rossiccio, il ventre tende ad essere biancastro. La pelle presenta<br />
numerose verruche, che secernono sostanze allucinogene. Le pupille del rospo comune sono orizzontali;<br />
l'occhio è <strong>di</strong> color oro scuro o rame, e nel suo collo vi sono due ghiandole paroti<strong>di</strong> ovali. Prevalentemente<br />
notturno, <strong>di</strong> giorno tende a nascondersi in buche o anfratti, sotto le pietre o comunque in luoghi riparati<br />
dalla luce, se minacciato assume una caratteristica posa intimidatoria con la testa abbassata e le parti<br />
posteriori sollevate.<br />
DOVE – Rogge, fontanili, cave.<br />
ALIMENTAZIONE – Si nutre praticamente <strong>di</strong> qualsiasi cosa riesca ad entrare nella sua bocca: insetti in<br />
primis, lumache, lombrichi, piccoli vertebrati come ad esempio piccoli topi.<br />
RIPRODUZIONE – Dopo il letargo invernale, in concomitanza con la primavera inizia la stagione degli<br />
accoppiamenti: i rospi si recano vicino ai luoghi <strong>di</strong> riproduzione (solitamente vicino a corsi d'acqua, pozze o<br />
stagni) verso l'inizio <strong>di</strong> marzo e lì i maschi si aggrappano alle ascelle delle femmine, che sono visibilmente<br />
più gran<strong>di</strong>. La femmina depone in acqua circa 10.000 uova in un cordone gelatinoso, contemporaneamente<br />
le uova vengono fecondate dal maschio. Queste uova poi si schiuderanno, facendo uscire dei minuscoli<br />
esserini neri acquatici: i girini. Questi, nutrendosi soprattutto <strong>di</strong> alghe e altri minuscoli materiali organici,<br />
crescono. La temperatura dell'acqua nella zona dove si trovano deciderà la velocità <strong>della</strong> loro metamorfosi:<br />
più è calda l'acqua, più veloce sarà la metamorfosi. Questo perché l'alta temperatura dell'acqua è sintomo<br />
che la loro pozza si sta prosciugando.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare<br />
RISCHIO MINIMO<br />
ROSPO COMUNE<br />
35<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Anfibi<br />
ORDINE<br />
Anura<br />
FAMIGLIA<br />
Bufonidae<br />
GENERE<br />
Bufo<br />
SPECIE<br />
B. bufo
NOME COMUNE<br />
Tritone<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Triturus cristatus<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Lunghezza: 14-16 cm, le femmine arrivano a misurare fino a 18 cm. Il maschio ha una forma<br />
piuttosto slanciata e il muso più sottile rispetto alla femmina, che appare più tozza e grande, con una testa<br />
più larga e massiccia; in ambo i sessi, la pelle si presenta lievemente ruvida al tatto. La regione dorsale è<br />
sempre <strong>di</strong> colore scuro, e varia dal verde al bruno quasi nero; spesso sono visibili delle macchie più o meno<br />
circolari <strong>di</strong> colore nero o verde scuro che sono più appariscenti nel maschio. I fianchi, le zampe e la gola<br />
sono generalmente punteggiati <strong>di</strong> bianco, soprattutto nel periodo riproduttivo. Il colore del ventre è<br />
piuttosto variabile, ma sempre molto acceso, con toni cal<strong>di</strong> che vanno dal giallo all'arancione rossastro e<br />
che contrastano molto con il dorso; sono presenti anche nella regione ventrale delle macchie scure, <strong>di</strong><br />
solito <strong>di</strong> colore nero brillante. Nel periodo degli amori, è ben visibile sulla schiena del maschio la cresta<br />
frastagliata, alta fino a 1,2 cm, che conferisce il nome alla specie e che, intaccata dalla base <strong>della</strong> coda, si<br />
sviluppa sino all'altezza degli occhi; inoltre i lati <strong>della</strong> coda dei maschi in questo periodo si tingono <strong>di</strong> una<br />
fascia madreperlacea con riflessi blu che talora interessa parzialmente anche la cresta bordandone l'orlo<br />
superiore. Nella femmina non si sviluppa alcuna cresta, ma compare una striscia dorsale <strong>di</strong> color giallo<br />
chiaro, che talvolta permane anche al <strong>di</strong> fuori del periodo riproduttivo, e, come nel maschio, compaiono le<br />
carene caudali. In entrambi i sessi, la cloaca appare ingrossata. Esistono, seppur rari, esemplari totalmente<br />
neri. Il tritone crestato, come molti anfibi, trascorre in acqua solo il periodo dell'accoppiamento,<br />
DOVE – Rogge, fontanili, cave.<br />
ALIMENTAZIONE – Nella sua vita terricola, il tritone si ciba essenzialmente <strong>di</strong> vermi, insetti e lumache, ma,<br />
nell'ambiente acquatico, acquista rapi<strong>di</strong>tà e cattura anche girini, piccoli pesci e anche altri tritoni.<br />
RIPRODUZIONE – All'inizio <strong>di</strong> Marzo, quando ha fine il letargo invernale, che trascorrono immersi nel fango<br />
o sotto terra, i primi esemplari <strong>della</strong> specie si riversano nei fossati o negli stagni, i luoghi <strong>della</strong> riproduzione<br />
e i maschi una volta nutritisi a sufficienza, iniziano la ricerca <strong>di</strong> una compagna. Una volta raggiunto lo scopo<br />
si assiste ad una bizzarra danza da parte del maschio, che, piegata la coda a forma <strong>di</strong> "U", ne fa vibrare<br />
l'estremità davanti al muso <strong>della</strong> compagna. Dopo l’accoppiamento, la femmina depone una ad una<br />
trecento uova, avvolgendole con cura nelle foglie delle piante sommerse.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
TRITONE CRESTATO<br />
36<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Anfibi<br />
ORDINE<br />
Caudata<br />
FAMIGLIA<br />
Salamandridae<br />
GENERE<br />
Triturus<br />
SPECIE<br />
T. cristatus
NOME COMUNE<br />
tritone puntinato<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Lissotriton vulgaris<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – La caratteristica punteggiatura, molto evidente nel maschio, gli ha valso il nome. Il maschio<br />
si <strong>di</strong>stingue dalla femmina per una colorazione generalmente più accesa, per una striatura molto marcata ai<br />
lati <strong>della</strong> testa, per la cresta caudale e per la cloaca ingrossata nel periodo riproduttivo. Le sue esigenze<br />
ecologiche lo rendono strettamente legato alle pozze d'acqua, fossi e stagni in cui vengono deposte le uova<br />
(ogni femmina depone circa 300 uova fissandole una per una con le zampe posteriori su cortecce e foglie a<br />
cui dà la caratteristica forma ad U) e dove si svolge la fase acquatica larvale. Le larve hanno caratteristiche<br />
branchie esterne piumate che si mantengono negli in<strong>di</strong>vidui neotenici. Questi ultimi sono pressoché assenti<br />
nelle piscine temporanee dove la scomparsa dell'acqua in estate determina una metamorfosi forzata. Dopo<br />
la metamorfosi i giovani trascorrono due anni a terra nel sottobosco per poi ritornare in acqua una volta<br />
raggiunta la maturità sessuale.<br />
DOVE – Fontanili, rogge, cave<br />
ALIMENTAZIONE – Si nutrono <strong>di</strong> larve <strong>di</strong> zanzare e altri piccoli insetti che cadono nell'acqua.<br />
RIPRODUZIONE – Il periodo riproduttivo comincia all'inizio <strong>della</strong> primavera, anche se le popolazioni del<br />
litorale tirrenico anticipano la deposizione anche all'autunno e alla fine dell'inverno in stagioni<br />
particolarmente calde. I tritoni svolgono una complicata danza nuziale ritualizzata senza il compimento<br />
<strong>della</strong> quale il maschio non emette la spermatofora, un sacchetto contenente gli spermatozoi, che la<br />
femmina raccoglie dal fondo <strong>della</strong> pozza. Terminato il periodo riproduttivo (<strong>di</strong> solito alla fine <strong>di</strong> giugno) i<br />
tritoni migrano dagli stagni e si <strong>di</strong>rigono nelle zone circostanti dove condurranno vita terrestre fino alla<br />
successiva stagione riproduttiva.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
TRITONE PUNTINATO<br />
38<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Anfibi<br />
ORDINE<br />
Caudata<br />
FAMIGLIA<br />
Salamandridae<br />
GENERE<br />
Lissotriton<br />
SPECIE<br />
L. vulgaris
MAMMIFERI<br />
MAMMALIA<br />
40
NOME COMUNE<br />
Arvicola<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Arvicola amphibius<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – L’arvicola è originaria dell’Europa ed è <strong>di</strong>ffusa in quasi tutta Italia. Attualmente la<br />
classificazione è controversa e si possono <strong>di</strong>stinguere <strong>di</strong>verse specie <strong>di</strong> questo ro<strong>di</strong>tore. Testa robusta e<br />
appuntita con occhi piccoli ma <strong>di</strong> buona vista, nonostante siano adatti anche alla vita ipogea. La lunghezza è<br />
<strong>di</strong> circa 20 cm e il loro peso <strong>di</strong> circa 200 grammi. Il colore del mantello è brunastro.<br />
DOVE – frequenta zone umide, campagne, coltivi.<br />
ALIMENTAZIONE – La <strong>di</strong>eta dell’Arvicola è costituita da ra<strong>di</strong>ci, erbe, semi, cereali, insetti e pesci.<br />
RIPRODUZIONE – Animale prolifico, l’Arvicola può partorire 4 volte all’anno da 2 a 7 cuccioli. La gestazione<br />
dura 3 settimane e lo svezzamento avviene già dopo 15 giorni <strong>di</strong> vita.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
ARVICOLA<br />
41<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Mammalia<br />
ORDINE<br />
Rodentia<br />
FAMIGLIA<br />
Cricetidae<br />
GENERE<br />
Arvicola<br />
SPECIE<br />
A. amphibius
NOME COMUNE<br />
Coniglio selvatico<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Oryctolagus scuniculus<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Misura fino a 45 cm <strong>di</strong> lunghezza, per un peso che raggiunge i 2,5 kg: i maschi sono<br />
generalmente più grossi e robusti delle femmine. Ha lunghe orecchie e gran<strong>di</strong> occhi neri situati sui lati <strong>della</strong><br />
testa. Le zampe posteriori sono robuste e più lunghe <strong>di</strong> quelle anteriori e mettono il coniglio in con<strong>di</strong>zione<br />
<strong>di</strong> correre rapidamente. Invece <strong>di</strong> avere dei cuscinetti a protezione <strong>della</strong> pianta dei pie<strong>di</strong>, il coniglio ha una<br />
fitta copertura <strong>di</strong> peli che gli permette <strong>di</strong> non scivolare sia sulla roccia che sulla neve. Le zampe sono inoltre<br />
palmate per impe<strong>di</strong>re alle <strong>di</strong>ta <strong>di</strong> separarsi mentre l'animale salta. La coda è molto corta e rivolta all'insù:<br />
DOVE – Zone umide agricole, urbane, suburbane, parchi e giar<strong>di</strong>ni.<br />
ALIMENTAZIONE – Si tratta <strong>di</strong> animali erbivori, che si nutrono <strong>di</strong> una vasta gamma <strong>di</strong> materiali <strong>di</strong> origine<br />
vegetale, dall'erba alle foglie alle ra<strong>di</strong>ci. Per ricavare il massimo quantitativo <strong>di</strong> nutrimento <strong>di</strong>sponibile dal<br />
cibo, i conigli sono soliti reingerire parte delle proprie feci per rielaborarne il contenuto (nel frattempo<br />
degradato dalla flora batterica) ed ottenere alcuni nutrienti essenziali.<br />
RIPRODUZIONE – La gestazione dura un mese, al termine del quale vengono dati alla luce dai 3 ai 14<br />
cuccioli: prima <strong>di</strong> partorire la femmina tende a scavarsi un cunicolo a fondo cieco nella tana, che ricopre col<br />
proprio pelo e con erbe secche, oppure se è il suo primo parto scava un cunicolo nel terreno ex novo, che<br />
poi verrà ampliato negli anni successivi. I cuccioli nascono nu<strong>di</strong> e ciechi, e la femmina li visita per una<br />
manciata <strong>di</strong> minuti al giorno per la poppata: sono tuttavia estremamente precoci e già a tre settimane<br />
possono essere svezzati.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
CONIGLIO SELVATICO<br />
42<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Mammiferi<br />
ORDINE<br />
Lagomorfi<br />
FAMIGLIA<br />
Lepori<strong>di</strong><br />
GENERE<br />
Oryctolagus<br />
SPECIE<br />
O. scuniculus
NOME COMUNE<br />
Lepre<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Lepus europaeus<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
PRESENZA IN ITALIA<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Simile ai conigli ma presenta, rispetto a questi, orecchie più lunghe, occhi più gran<strong>di</strong>,<br />
maggiori <strong>di</strong>mensioni, punta delle orecchie più scura. Misura circa 50 – 70 cm e pesa tra i 3 e 6 Kg. I cuccioli<br />
<strong>di</strong> lepre nascono già con pelliccia ed occhi aperti a <strong>di</strong>fferenza dei conigli. Le lepri sono solitarie, non<br />
costruiscono tane ma si ricavano un giaciglio tra la bassa vegetazione e sono soggette alla frammentazione<br />
degli habitat. E’ molto veloce nella corsa e può raggiungere i 70 Km/h.<br />
DOVE – Campagne, prati, coltivi.<br />
ALIMENTAZIONE – Il cibo è costituito da erbe, ra<strong>di</strong>ci e vegetali vari.<br />
RIPRODUZIONE – Ogni femmina partorisce 3 – 4 volte all’anno me<strong>di</strong>amente 3 – 4 piccoli per parto. La<br />
gestazione dura circa 1 mese. Dopo solo 1 settimana i leprotti <strong>di</strong>ventano in<strong>di</strong>pendenti e la maturazione<br />
sessuale è raggiunta ad 1 anno <strong>di</strong> età.<br />
STATUS GIURIDICO – Nulla da segnalare. La degradazione degli habitat, l’inquinamento e l’uso <strong>di</strong> pestici<strong>di</strong><br />
ha ridotto notevolmente il numero <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui delle varie popolazioni. I ripopolamenti per attività venatoria<br />
hanno contribuito alla <strong>di</strong>minuzione delle lepri a causa <strong>di</strong> inquinamenti genetici e trasmissioni <strong>di</strong> patologie.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
LEPRE<br />
44<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Mammalia<br />
ORDINE<br />
Lagomorpha<br />
FAMIGLIA<br />
Leporidae<br />
GENERE<br />
Lepus<br />
SPECIE<br />
L. europaeus
NOME COMUNE<br />
Nutria, Coypu, Castorino<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Myocastor coypus<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – La Nutria è un mammifero ro<strong>di</strong>tore dalle <strong>di</strong>mensioni modeste. Gli esemplari adulti possono<br />
raggiungere me<strong>di</strong>amente i 60 cm <strong>di</strong> lunghezza, coda esclusa, e un peso <strong>di</strong> circa 10 chili. Il colore del<br />
mantello è generalmente bruno scuro ma non è raro osservare esemplari grigi o con varie tonalità <strong>di</strong><br />
marrone. Possiede orecchie piccole, lunghi e numerosi baffi bianchi o argentei. La dentatura consiste <strong>di</strong> 8<br />
molari e 2 incisivi per arcata. Questi ultimi in particolare sono molto forti e rivestiti da uno smalto dal tipico<br />
colore arancione. Le zampe sono pentadattili e quelle posteriori sono palmate, con il quinto <strong>di</strong>to libero, in<br />
quanto la Nutria è un animale fortemente semiacquatico. A riprova <strong>di</strong> ciò infatti le femmine presentano le<br />
mammelle in posizione latero-dorsale e questo è dato dal fatto che la prole viene allevata in acqua.<br />
DOVE – Frequenta zone umide.<br />
ALIMENTAZIONE – La <strong>di</strong>eta <strong>della</strong> Nutria è prettamente vegetariana e si basa su piante acquatiche, varie<br />
erbe, ra<strong>di</strong>ci, tuberi e frutti. Generalmente tendono a nutrirsi <strong>della</strong> vegetazione presente in prossimità degli<br />
argini dei corsi d’acqua.<br />
RIPRODUZIONE – Le femmine sono fertili durante tutto l’anno e possono avere 2.7 gravidanze l’anno in<br />
quanto la gestazione ha una durata <strong>di</strong> circa 130 giorni e i cuccioli vengono svezzati a 3-4 settimane dalla<br />
nascita. Il numero <strong>di</strong> cuccioli per gravidanza varia me<strong>di</strong>amente da 2 a 6. Le Nutrie sono in grado <strong>di</strong><br />
autoregolarsi infatti se le risorse territoriali o alimentari sono scarse, le cucciolate <strong>di</strong>minuiscono<br />
drasticamente <strong>di</strong> numero.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – La Nutria è fauna selvatica italiana in quanto specie naturalizzata. E’ pertanto<br />
tutela dalla legge nazionale 157/92 la quale <strong>di</strong>sciplina anche il suo controllo numerico in caso <strong>di</strong> situazioni<br />
particolari, delegando alle Province la scelta del metodo da adottare, pre<strong>di</strong>ligendo prima <strong>di</strong> tutto i meto<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
tipo ecologico.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
NUTRIA<br />
46<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Mammalia<br />
ORDINE<br />
Rodentia<br />
FAMIGLIA<br />
Myocastoridae<br />
GENERE<br />
Myocastor<br />
SPECIE<br />
M. coypus
NOME COMUNE<br />
Pipistrello<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Sono mammiferi antichissimi: allattano i loro piccoli e la loro cute è ricoperta <strong>di</strong> pelo;<br />
volano, grazie a una speciale mo<strong>di</strong>ficazione <strong>di</strong> mano e braccio trasformati in ala. Hanno occhi piccoli e vista<br />
limitata, il loro u<strong>di</strong>to invece è molto sviluppato. Mentre volano emettono degli ultrasuoni che, rimbalzando<br />
contro gli oggetti che incontrano, provocano un'eco permettendo loro così <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare gli ostacoli. L'ala<br />
del pipistrello è costituita da una sottile membrana, il patagio, che è composto da un sottile strato <strong>di</strong><br />
tessuto connettivo lasso vascolarizzato e compreso tra due strati <strong>di</strong> cute. Esso è sotteso sulle ossa <strong>della</strong><br />
mano e delle <strong>di</strong>ta. In inverno i pipistrelli vanno in letargo in gruppo, rallentano tutte le attività corporee,<br />
incluse la frequenza respiratoria e il battito car<strong>di</strong>aco, consumando così poca energia e sopravvivendo grazie<br />
alle riserve <strong>di</strong> grasso corporeo<br />
DOVE - Zone umide (fontanili, cave rogge), agricole, urbane, suburbane, parchi e giar<strong>di</strong>ni.<br />
ALIMENTAZIONE – Predano insetti, eliminando, così, tanti insetti nocivi all'uomo. Un singolo pipistrello, ad<br />
esempio, può in una sola notte mangiare fino a 3000 zanzare.<br />
RIPRODUZIONE – Con l'arrivo <strong>della</strong> primavera, cessa la fase <strong>di</strong> letargo: le femmine, dopo un certo tempo, si<br />
radunano in rifugi ove, tra giugno e luglio, danno alla luce i piccoli (in genere uno solo), dopo poche<br />
settimane, i piccoli sanno già volare e vanno subito a caccia d'insetti.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Minacciato da inquinamento e frammentazione degli habitat.<br />
MINACCIATO<br />
PIPISTRELLO<br />
48<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Mammalia<br />
ORDINE<br />
Chirotteri<br />
FAMIGLIA<br />
Spp.<br />
GENERE<br />
Spp.<br />
SPECIE<br />
Spp. (specie <strong>di</strong>verse)
NOME COMUNE<br />
Ratto<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Rattus spp.<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Lunghezza testa-corpo: 16-24 cm ; Lunghezza coda: 18-26 cm; Peso: 150-250 grammi.<br />
Corpo cilindrico-allungato, con pelo liscio, più lungo sul dorso. Mantello superiore quasi nero. Testa con<br />
muso appuntito, orecchi me<strong>di</strong>o-gran<strong>di</strong>, occhi scuri, gran<strong>di</strong> e sporgenti. Zampe rosa o biancastre; coda più<br />
lunga del corpo, nuda. Il maschio è più grosso <strong>della</strong> femmina. Presenta u<strong>di</strong>to e olfatto eccellenti. Ha<br />
abitu<strong>di</strong>ni soprattutto crepuscolari-notturne. L’Attività è rallentata nei perio<strong>di</strong> fred<strong>di</strong>, anche se non va in<br />
letargo.<br />
DOVE – Zone umide agricole, urbane, suburbane.<br />
ALIMENTAZIONE – Alimentazione: onnivora (soprattutto vegetali).<br />
RIPRODUZIONE – Raggiunge la maturità sessuale a 3-4 mesi. Gli Accoppiamenti sono possibili tutto l'anno.<br />
Durata <strong>della</strong> gestazione circa 3 settimane. Normalmente 2-3 e più parti all'anno con 4-10 piccoli inetti.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
RATTO<br />
49<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Mammalia<br />
ORDINE<br />
Rodentia<br />
FAMIGLIA<br />
Muridae<br />
GENERE<br />
Rattus<br />
SPECIE<br />
Rattus spp.
NOME COMUNE<br />
Riccio<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Erinaceus europaeus<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Lunghezza testa-corpo: 26-35 cm ; Lunghezza coda: 2-4 cm; Peso: 450-1200 grammi. Tutto<br />
il riccio eccetto il muso, le zampe e le parti inferiori, è ricoperto da aculei lunghi circa 2 cm, grigi con la<br />
punta bianca. Il tronco è tozzo, le zampe sono munite <strong>di</strong> forti unghie, il muso è appuntito e la coda è corta e<br />
spessa. Il riccio va in letargo tra ottobre e aprile.<br />
DOVE – Boschi, giar<strong>di</strong>ni, orti, parchi urbani e suburbani, siepi.<br />
ALIMENTAZIONE – onnivoro, si ciba <strong>di</strong> invertebrati, uccelli, rettili, anfibi e piccoli mammiferi. In caso <strong>di</strong><br />
necessità si ciba <strong>di</strong> bacche, ghiande, frutta e altro materiale vegetale. Non è in grado <strong>di</strong> <strong>di</strong>gerire il latte che<br />
risulta essere un veleno per il riccio.<br />
RIPRODUZIONE – Raggiunge la maturità sessuale a circa 12 mesi. Gli accoppiamenti avvengono tra aprile e<br />
agosto. Durata <strong>della</strong> gestazione circa 6 settimane. Partorisce, tra aprile e settembre, 4-5 cuccioli e a<br />
seconda delle <strong>di</strong>sponibilità alimentari può partorire anche 2 volte in un anno. I piccoli vengono svezzati a<br />
circa 6 settimane <strong>di</strong> vita.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
RICCIO<br />
51<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Mammalia<br />
ORDINE<br />
Erinaceomorpha<br />
FAMIGLIA<br />
Erinaceidae<br />
GENERE<br />
Erinaceus<br />
SPECIE<br />
E. europaeus
NOME COMUNE<br />
Silvilago o Minilepre<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Sylvilagus floridanus<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
PRESENZA IN ITALIA<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Questo leporide ha una lunghezza <strong>di</strong> 35-45 cm circa ed un peso <strong>di</strong> 1-1,2 Kg. Ha un aspetto<br />
simile al coniglio selvatico ma presenta orecchie e coda più brevi, zampe anteriori più sottili e zampe<br />
posteriori più allungate. Il colore del mantello in entrambi i sessi è grigio con tonalità ocra e rossa e peli<br />
neri. È attivo <strong>di</strong> notte e non va in ibernazione d’inverno. I silvilaghi mostrano una maggior resistenza alla<br />
mixomatosi.<br />
DOVE – Prati, aree arbustive e agricole.<br />
ALIMENTAZIONE – Il cibo è costituito vegetali ver<strong>di</strong>, cortecce, germogli, ramoscelli.<br />
RIPRODUZIONE – L’accoppiamento avviene tra febbraio e settembre, Le femmine partoriscono<br />
me<strong>di</strong>amente 2-4 ni<strong>di</strong>ate all’anno ed ogni ni<strong>di</strong>ata è composta da 3-5 cuccioli. La gravidanza dura circa 1<br />
mese. I piccoli rimangono nel nido per circa 2 settimane e vengono allattati per 3 settimane. La maturità<br />
sessuale viene raggiunta a 4-5 mesi <strong>di</strong> età.<br />
STATUS GIURIDICO – Nulla da segnalare. Specie originaria del Nord America introdotta per scopi venatori.<br />
Conosciuto anche con il nome <strong>di</strong> minilepre.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
SILVILAGO O MINILEPRE<br />
52<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Mammalia<br />
ORDINE<br />
Lagomorpha<br />
FAMIGLIA<br />
Leporidae<br />
GENERE<br />
Sylvilagus<br />
SPECIE<br />
S. floridanus
NOME COMUNE<br />
Talpa<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Talpa europaea<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Lunghezza testa-corpo: 120-165 cm ; Lunghezza coda: 23-34 cm; Peso: 65-120 grammi.<br />
Presenta una forma tozza <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensione me<strong>di</strong>o – piccole, il corpo è cilindrico con il capo poco <strong>di</strong>stinto dal<br />
tronco. Gli arti sono brevi, sporgono dal corpo e sono provvisti <strong>di</strong> unghie lunghe. Gli occhi sono piccoli e<br />
nascosti nella pelliccia, la coda è breve e carnosa e le vibrisse risultano ben sviluppate. Il corpo è ricoperto<br />
da una folta e vellutata pelliccia nera con riflessi bruni o grigi.<br />
DOVE – Dalla pianura fino a circa 2000 metri. Frequenta zone coltivate, prati, terreni freschi e porosi dove<br />
può scavare le proprie gallerie.<br />
ALIMENTAZIONE – Si nutre <strong>di</strong> invertebrati del sottosuolo.<br />
RIPRODUZIONE – Il periodo degli accoppiamenti è compreso tra marzo e maggio. Partorisce una volta<br />
all’anno in maggio – giugno 3-5 piccoli nu<strong>di</strong> e ciechi. La gestazione dura 1 mese e lo svezzamento avviene a<br />
4 settimane.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
TALPA<br />
54<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Mammalia<br />
ORDINE<br />
Soricomorpha<br />
FAMIGLIA<br />
Talpidae<br />
GENERE<br />
Talpa<br />
SPECIE<br />
T. europaea
NOME COMUNE<br />
topolino delle risaie<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Micromys minutus<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – E’ uno dei più piccoli mammiferi eurasiatici con lunghezza testa-corpo: 50-78 mm ,<br />
lunghezza <strong>della</strong> coda <strong>di</strong>: 45-75 mm, peso: 4-13 grammi. Possiede una colorazione bruno-aranciata sul dorso<br />
e biancastra su ventre e gola: il muso ricoperto <strong>di</strong> vibrisse, le zampine, le piccole orecchie arrotondate e la<br />
lunga coda prensile sono glabri e <strong>di</strong> colore rosato. La femmina è normalmente più grande dl maschio.<br />
Questi animali sono assai timi<strong>di</strong> e schivi e tendono ad avere abitu<strong>di</strong>ni crepuscolari e notturne: si muovono<br />
velocemente nel folto dei canneti e fra i sottili gambi dei cereali, aiutati dalla coda prensile, che viene<br />
utilizzata egregiamente come arto aggiuntivo. Il topolino delle risaie è attivo durante tutto l'arco dell'anno.<br />
DOVE – Zone agricole, suburbane<br />
ALIMENTAZIONE – Si nutre principalmente <strong>di</strong> semi, non <strong>di</strong>sdegnando però occasionalmente frutta e, più<br />
raramente, piccoli insetti.<br />
RIPRODUZIONE –Questo ro<strong>di</strong>tore forma delle coppie monogame che durano per tutto il periodo <strong>della</strong><br />
riproduzione, che può avvenire anche più volte nel corso dell'anno, nel caso <strong>di</strong> annate favorevoli; la<br />
gestazione dura tre settimane, al termine delle quali la femmina dà alla luce da 4 a 7 piccoli. I cuccioli<br />
vengono svezzati nel giro <strong>di</strong> 18 giorni e raggiungono la maturità sessuale in circa un mese. Proprio fra i<br />
canneti, i topolini delle risaie costruiscono dei caratteristici ni<strong>di</strong> sferici intrecciando paglia e sterpaglie, ad<br />
un'altezza <strong>di</strong> circa 50 centimetri dal terreno. Spesso i ni<strong>di</strong> vengono occupati da <strong>di</strong>verse generazioni <strong>di</strong> questi<br />
animali, che provvedono man mano ad effettuare eventuali lavori <strong>di</strong> ristrutturazione e rinforzo.<br />
STATUS CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
TOPOLINO DELLE RISAIE<br />
55<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Mammalia<br />
ORDINE<br />
Ro<strong>di</strong>tori<br />
FAMIGLIA<br />
Muri<strong>di</strong><br />
GENERE<br />
Micromys<br />
SPECIE<br />
M. minutus
NOME COMUNE<br />
Volpe<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Vulpes vulpes<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – La Volpe è specie originaria dell’emisfero settentrionale ed è <strong>di</strong>ffusa in tutta Italia. Presenta<br />
un corpo snello e slanciato che poggia su arti brevi ma robusti. Il muso è lungo e appuntito con orecchie<br />
piuttosto sviluppate. La coda è ricoperta da un pelo folto con una colorazione che varia dal rosso<br />
all’arancione. Può raggiungere la lunghezza <strong>di</strong> 1.30 metri <strong>di</strong> cui 35-40 cm <strong>di</strong> coda e il suo peso oscilla dai 4 ai<br />
15 kg.<br />
DOVE – Boschi, campagne.<br />
ALIMENTAZIONE – La <strong>di</strong>eta <strong>della</strong> Volpe è varia, onnivora, ma composta prevalentemente da piccoli ro<strong>di</strong>tori,<br />
uccelli, conigli, lepri, rettili, pesci, invertebrati ma anche sostanze vegetali <strong>di</strong> vario tipo (bacche, frutti, ecc.).<br />
RIPRODUZIONE – La Volpe rossa si accoppia nel mese <strong>di</strong> gennaio. La gravidanza dura circa 2 mesi e può<br />
partorire dai 3 ai 5 cuccioli per volta. Lo svezzamento avviene dopo 1 mese <strong>di</strong> vita.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
VOLPE<br />
56<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Mammalia<br />
ORDINE<br />
Carnivora<br />
FAMIGLIA<br />
Canidae<br />
GENERE<br />
Vulpes<br />
SPECIE<br />
V. vulpes
UCCELLI<br />
AVES<br />
57
NOME COMUNE<br />
Airone bianco maggiore<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Casmero<strong>di</strong>us albus<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello (airone) <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni ed è il più grande tra gli Ardeideae in Europa. Ha una<br />
lunghezza pari a 85-115 cm ed un’apertura alare <strong>di</strong> 140-180 cm. Maschi e femmine identici con piumaggio<br />
bianco e becco giallo. Le zampe sono nerastre ma nel periodo riproduttivo presentano una colorazione<br />
sfumata giallo-arancione.<br />
DOVE – Frequenta zone umide, rive <strong>di</strong> laghi e fiumi e risaie.<br />
ALIMENTAZIONE – Si nutre <strong>di</strong> pesci, anfibi, rettili, insetti, piccoli mammiferi e occasionalmente ni<strong>di</strong>acei.<br />
RIPRODUZIONE – Depone circa 2-5 uova che vengono covate per 25 giorni e dopo circa 1 mese i giovani<br />
sono in grado <strong>di</strong> allontanarsi dal nido.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare. E’ specie protetta dalla legge nazionale 157/92.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
AIRONE BIANCO MAGGIORE<br />
58<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Ciconiiformes<br />
FAMIGLIA<br />
Ardeidae<br />
GENERE<br />
Casmero<strong>di</strong>us<br />
SPECIE<br />
C. albus
NOME COMUNE<br />
Airone cenerino<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Ardea cinerea<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello (airone) <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni, con una statura <strong>di</strong> 90-98 cm, un peso <strong>di</strong> 1-2Kg ed<br />
un’apertura alare <strong>di</strong> circa 1,70 m. Maschio e femmina hanno una colorazione uguale, prevalentemente<br />
grigia con ampie zone bianche e nere.<br />
DOVE – Frequenta zone umide, aperte e ambienti sub-urbani.<br />
ALIMENTAZIONE – Si nutrie <strong>di</strong> invertebrati e piccoli vertebrati come pesci, anfibi, rettili e piccoli<br />
mammiferi.<br />
RIPRODUZIONE – Ni<strong>di</strong>fica in colonie su alberi oppure nei canneti. Depone circa 4-5 uova a metà marzo che<br />
vengono covate per circa 25 giorni. I pulcini vengono nutriti nel nido per circa 2 mesi.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Minacciato dall’inquinamento delle acque, è una specie protetta dalla legge<br />
nazionale 157/92.<br />
MINACCIATO<br />
AIRONE CENERINO<br />
60<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Ciconiiformes<br />
FAMIGLIA<br />
Ardeidae<br />
GENERE<br />
Ardea<br />
SPECIE<br />
A. cinerea
NOME COMUNE<br />
Airone guardabuoi<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Bubulcus ibis<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello <strong>di</strong> me<strong>di</strong>e <strong>di</strong>mensioni con lunghezza <strong>di</strong> 45-55 cm ed un’apertura alare <strong>di</strong> 90-95 cm. Il<br />
piumaggio è generalmente bianco mentre in abito nuziale <strong>di</strong>viene sfumato <strong>di</strong> giallo e anche le zampe<br />
assumono una colorazione gialla. In inverno le zampe sono nere e il becco giallo.<br />
DOVE – Frequenta zone umi<strong>di</strong> e coltivi con pochi alberi.<br />
ALIMENTAZIONE – Si nutre <strong>di</strong> pesci, anfibi, invertebrati e parassiti presenti sul dorso <strong>di</strong> animali domestici o<br />
selvatici.<br />
RIPRODUZIONE – La femmina depone a fine aprile 3-4 uova che cova per circa 3 settimane. I piccoli sono in<br />
grado <strong>di</strong> volare dopo poco più <strong>di</strong> un mese.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Specie minacciata dal bracconaggio e dalla <strong>di</strong>minuzione degli habitat. E’<br />
protetta dalla legge nazionale 157/92.<br />
MINACCIATO<br />
AIRONE GUARDABUOI<br />
62<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Ciconiiformes<br />
FAMIGLIA<br />
Ardeidae<br />
GENERE<br />
Bubulcus<br />
SPECIE<br />
B. ibis
NOME COMUNE<br />
Airone rosso<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Ardea purpurea<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni con una lunghezza <strong>di</strong> 85-110 cm, un’apertura alare <strong>di</strong> 120-150<br />
cm ed un peso <strong>di</strong> circa 1,4 kg. La colorazione è marrone-rossiccia con alcune zone grige, bianche e nere.<br />
Durante il periodo riproduttivo presenta un ciuffo nero sul capo. Le zampe sono gialle-arancioni e il becco è<br />
arancione con la parte superiore grigio scuro<br />
DOVE – Frequenta zone umide e corsi d’acqua.<br />
ALIMENTAZIONE – Si nutrie <strong>di</strong> pesci, anfibi, rettili, invertebrati, crostacei, molluschi e occasionalmente <strong>di</strong><br />
piccoli mammiferi.<br />
RIPRODUZIONE – Ni<strong>di</strong>fica tra aprile e maggio. Depone 4-5 uova che cova per 1 mese circa. Entro 2 mesi i<br />
piccoli iniziano a volare.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Minacciato dal bracconaggio e dalla <strong>di</strong>struzione degli habitat, è specie<br />
protetta dalla legge nazionale 157/92.<br />
MINACCIATO<br />
AIRONE ROSSO<br />
64<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Ciconiiformes<br />
FAMIGLIA<br />
Ardeidae<br />
GENERE<br />
Ardea<br />
SPECIE<br />
A. purpurea
NOME COMUNE<br />
Allodola<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Alauda arvensis<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – L'allodola è lunga circa 16-19,5 cm, ha un'apertura alare che può raggiungere i 32-37 cm e<br />
pesa circa 33-48 g, coda 6,5-7,5 cm. È caratterizzata da un piumaggio <strong>di</strong> colore marrone leggermente striato<br />
<strong>di</strong> nero nella parte superiore, più chiaro in quella inferiore, nonché da un piccolo ciuffo erettile che mostra<br />
solo se allarmata.. I sessi sono simili. È caratteristico il suo canto <strong>di</strong> tono acuto e musicale, sostenuto a<br />
lungo nel volo volteggiante. E' una specie solitaria durante il periodo riproduttivo e gregaria d'inverno.<br />
Terragnola, cammina e saltella agilmente tenendo il corpo in posizione orizzontale. Si posa su sassi, muretti<br />
e sulla bassa vegetazione, mai sugli alberi.<br />
DOVE – Zone boschive, campagna<br />
ALIMENTAZIONE – Si nutre prevalentemente <strong>di</strong> semi, vegetali (semi, germogli, foglie), arricchendo la <strong>di</strong>eta<br />
con insetti durante il periodo riproduttivo. Occasionalmente si nutre anche <strong>di</strong> piccoli animali.<br />
RIPRODUZIONE – Ni<strong>di</strong>fica sul terreno costruendo un nido in una depressione naturale con steli, erbe e<br />
materiali vari. Tra marzo e agosto la femmina depone 3-6 uova grigio-biancastre picchiettate <strong>di</strong> marronever<strong>di</strong>no<br />
e macchiettate <strong>di</strong> bruno che cova per 11-12 giorni. I piccoli, nutriti anche dal maschio, sono capaci<br />
<strong>di</strong> volare dopo circa 3 settimane dalla nascita. Effettua 2-3 covate all'anno<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
ALLODOLA<br />
65<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Passeriformes<br />
FAMIGLIA<br />
Alau<strong>di</strong>dae<br />
GENERE<br />
Alauda<br />
SPECIE<br />
A. arvensis
NOME COMUNE<br />
Alzavola<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Anas crecca<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Anatra piccola. Raggiunge una lunghezza <strong>di</strong> 33 – 36 cm circa, presenta un’apertura alare <strong>di</strong><br />
70 cm circa e pesa circa 270 – 390 g. Il maschio nella stagione degli amori presenta il capo castano con una<br />
macchia verde scuro che attraversa l’occhio e una macchia gialla sotto la coda. Il corpo è colorato <strong>di</strong> grigio e<br />
presenta sulla ali una banda (specchio) verde – nera. La femmina presenta un piumaggio omogeneo<br />
brunastro.<br />
DOVE – Zone umide, acque interne e aperte con presenza <strong>di</strong> canneti.<br />
ALIMENTAZIONE – Si nutre <strong>di</strong> piccoli insetti, molluschi, semi.<br />
RIPRODUZIONE – La femmina tra aprile e maggio depone 7 – 12 uova che cova per circa 3 settimane.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
ALZAVOLA<br />
66<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Anseriformes<br />
FAMIGLIA<br />
Anatidae<br />
GENERE<br />
Anas<br />
SPECIE<br />
A. crecca
NOME COMUNE<br />
Anatra carolina<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Aix sponsa<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Originaria del Nord America. Raggiunge una lunghezza <strong>di</strong> 43 – 51 cm circa ed un’apertura<br />
alare <strong>di</strong> 70 cm circa. Il maschio ha il capo verde blu con strisce bianche. Il becco è rosso – arancione. Il<br />
sottogola è bianco e il petto bruno. Il ventre e i fianchi sono gialli mentre il dorso e le ali sono verde – blu.<br />
Le zampe sono gialle. La femmina presenta un piumaggio omogeneo bruno scuro. Gli occhi hanno una<br />
cerchiatura bianca. Il becco e le zampe sono grigio – giallo.<br />
DOVE – Zone umide (fontanili, cave rogge), agricole, urbane, suburbane, parchi e giar<strong>di</strong>ni.<br />
ALIMENTAZIONE – Generalmente onnivora. Si nutre <strong>di</strong> vegetali, piccoli pesci, invertebrati e rettili.<br />
RIPRODUZIONE – La femmina depone 9 – 14 uova che cova per circa 1 mese.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare<br />
RISCHIO MINIMO<br />
ANATRA CAROLINA<br />
68<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Anseriformes<br />
FAMIGLIA<br />
Anatidae<br />
GENERE<br />
Aix<br />
SPECIE<br />
A. sponsa
NOME COMUNE<br />
Averla piccola<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Lanius collurio<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioni, lunghezza 16-20 cm, apertura alare 28-30 cm e un peso <strong>di</strong> 22-<br />
45 g. il maschio presenta vertice e nuca grigi, il dorso e la parte superiore delle ali marrone. Becco, zampe e<br />
mascherina sono neri. La femmina è simile al maschio ma i colori sono più tenui e la mascherina è marrone.<br />
DOVE – Frequenta incolti, zone umide e siepi.<br />
ALIMENTAZIONE – Carnivoro, si nutre <strong>di</strong> piccoli insetti, invertebrati ma anche piccoli vertebrati come<br />
ni<strong>di</strong>acei, piccoli mammiferi, rettili e anfibi. Infilza le prede sulle spine dei rovi.<br />
RIPRODUZIONE – La femmina depone 4-5 uova che vengono covate per circa 2 settimane. I piccoli sono in<br />
grado <strong>di</strong> volare dopo 2 settimane e <strong>di</strong>vengono completamente in<strong>di</strong>pendenti dopo 1 mese.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare. Protetto in Italia.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
AVERLA PICCOLA<br />
70<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Passeriformes<br />
FAMIGLIA<br />
Laniidae<br />
GENERE<br />
Lanius<br />
SPECIE<br />
L. collurio
NOME COMUNE<br />
Balestruccio<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Delichon urbica<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioni, con una lunghezza <strong>di</strong> 13-14 cm, un’apertura alare <strong>di</strong> 28-30 cm<br />
ed un peso <strong>di</strong> 15-25 grammi. La livrea è bianca e nera e le parti superiori possono presentare riflessi blu.<br />
Non vi è <strong>di</strong>morfismo sessuale. I giovani hanno colorazioni più tenue e possono essere confusi con il topino.<br />
DOVE – Frequenta aree urbane, suburbane e rurali.<br />
ALIMENTAZIONE – Si nutrie <strong>di</strong> insetti che cattura in volo.<br />
RIPRODUZIONE – Ni<strong>di</strong>fica in primavera, depone 3-5 uova che cova per 2 settimane. La deposizione delle<br />
uova può avvenire 2 o 3 volte durante la bella stagione. I piccoli sono allevati per circa 1 mese.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
BALESTRUCCIO<br />
72<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Hirun<strong>di</strong>nidae<br />
FAMIGLIA<br />
Passeriformes<br />
GENERE<br />
Delichon<br />
SPECIE<br />
D. urbica
NOME COMUNE<br />
Balia nera<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Ficedula hypoleuca<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioni <strong>della</strong> lunghezza <strong>di</strong> 15 cm, apertura alare <strong>di</strong> 22-24 cm. Il<br />
maschio ha una colorazione nera con una banda bianca mentre la femmina ha una colorazione marrone<br />
con la medesima barra bianca. Le parti inferiori sono bianche mentre becco e zampe sono neri.<br />
DOVE – Frequenta zone suburbane e coltivi alberati.<br />
ALIMENTAZIONE – Insettivoro ma integra la <strong>di</strong>eta, soprattutto in autunno, con le bacche.<br />
RIPRODUZIONE – La femmina depone 5-6 uova che cova per 2 settimane. I piccoli si involano dopo 15-16<br />
giorni <strong>di</strong> vita.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare. Protetto in Italia.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
BALIA NERA<br />
73<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Passeriformes<br />
FAMIGLIA<br />
Muscicapidae<br />
GENERE<br />
Ficedula<br />
SPECIE<br />
F. hypoleuca
NOME COMUNE<br />
Ballerina bianca<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Motacilla alba<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello <strong>di</strong> forma slanciata ed elegante, raggiunge una lunghezza <strong>di</strong> 20 cm, un peso <strong>di</strong> 18-27<br />
grammi ed un’apertura alare <strong>di</strong> circa 30 cm. Il dorso è grigio mentre la nuca e il petto sono neri. Ali nere con<br />
doppia banda chiara, ventre, fronte, lati del capo bianchi. La coda è lunga con penne bianche e nere.<br />
DOVE – Frequenta zone umide, coltivi, campi arati, campagne, ambienti urbani e suburbani.<br />
ALIMENTAZIONE – Si ciba <strong>di</strong> piccoli insetti che preda in vari luoghi.<br />
RIPRODUZIONE – La femmina depone 5-6 uova in primavera che cova per 2 settimane. I piccoli vengono<br />
accu<strong>di</strong>ti per circa 14 giorni.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
BALLERINA BIANCA<br />
75<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Passeriformes<br />
FAMIGLIA<br />
Motacillidae<br />
GENERE<br />
Motacilla<br />
SPECIE<br />
M. alba
NOME COMUNE<br />
Ballerina gialla<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Motacilla cinerea<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello <strong>di</strong> forma slanciata ed elegante, raggiunge una lunghezza <strong>di</strong> 18 cm, un peso <strong>di</strong> 20<br />
grammi ed un’apertura alare <strong>di</strong> circa 27 cm. Capo e dorso grigio, ventre e sottocoda giallo. Ali nere con<br />
barra bianca. Il maschio presenta una chiazza nera sotto la gola che <strong>di</strong>viene chiara in inverno.<br />
DOVE – Frequenta zone umide, coltivi, campi arati, campagne, ambienti urbani e suburbani.<br />
ALIMENTAZIONE – Si ciba <strong>di</strong> piccoli insetti e invertebrati.<br />
RIPRODUZIONE – Si riproduce da marzo a maggio, la femmina depone 4-5 uova che cova per 2 settimane. I<br />
piccoli vengono accu<strong>di</strong>ti per circa 14 giorni.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
BALLERINA GIALLA<br />
76<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Passeriformes<br />
FAMIGLIA<br />
Motacillidae<br />
GENERE<br />
Motacilla<br />
SPECIE<br />
M. cinerea
NOME COMUNE<br />
Capinera<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Sylvia atricapilla<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioni <strong>della</strong> lunghezza <strong>di</strong> circa 15 cm e apertura alare <strong>di</strong> 20-25 cm ed<br />
un peso <strong>di</strong> 20 g. Il maschio a <strong>di</strong>fferenza <strong>della</strong> femmina presenta la colorazione del capo nera. Quella <strong>della</strong><br />
femmina invece è fulva. Il restante piumaggio è grigio.<br />
DOVE – Frequenta zone suburbane, campagne, coltivi con presenza <strong>di</strong> alberi e siepi.<br />
ALIMENTAZIONE – Si nutre <strong>di</strong> insetti e piccoli invertebrati ma integra la sua <strong>di</strong>eta con bacche e frutti.<br />
RIPRODUZIONE – La femmina depone 1 o 2 volte all’anno 5 uova che cova per 2 settimane. I piccoli<br />
abbandonano il nido dopo 10-14 giorni.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
CAPINERA<br />
77<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Passeriformes<br />
FAMIGLIA<br />
Sylvidae<br />
GENERE<br />
Sylvia<br />
SPECIE<br />
S. atricapilla
NOME COMUNE<br />
Cardellino<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Carduelis carduelis<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioni, lunghezza <strong>di</strong> 12-15 cm, apertura alare <strong>di</strong> 23-25 cm. Maschio e<br />
femmina sono simili ma il maschio presenta una maggior colorazione rossa <strong>della</strong> faccia e la barra alare<br />
gialla. Il restante piumaggio è colorato <strong>di</strong> bianco, nero e marrone.<br />
DOVE – Frequenta incolti, zone suburbane e coltivi con presenza <strong>di</strong> alberi.<br />
ALIMENTAZIONE – Granivoro, si nutrie prevalentemente <strong>di</strong> semi.<br />
RIPRODUZIONE – 3 covate all’anno. La femmina depone a fine aprile 3-6 uova che cova per circa 2<br />
settimane. Dopo 2 settimane dalla nascita i piccoli sono in grado <strong>di</strong> lasciare il nido.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
CARDELLINO<br />
79<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Ciconiiformes<br />
FAMIGLIA<br />
Ardeidae<br />
GENERE<br />
Ardea7<br />
SPECIE<br />
C. carduelis
NOME COMUNE<br />
Cicogna biaca<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Ciconia ciconia<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
PRESENZA IN ITALIA<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – In Europa ed in Italia sono presenti due sole specie <strong>di</strong> questa famiglia: la cicogna bianca<br />
appunto e la cicogna nera. La cicogna bianca presenta un piumaggio generalmente bianco eccetto la punta<br />
delle ali e la coda che sono nere. Becco e zampe rosse. Ha un’apertura alare <strong>di</strong> circa 155 – 180 cm, un peso<br />
<strong>di</strong> 3,5 – 4,5 Kg. La migrazione verso l’Europa per la ni<strong>di</strong>ficazione avviene tra marzo e maggio mentre la<br />
migrazione verso l’Africa per lo svernamento avviene tra agosto e settembre. Esistono tuttavia colonie <strong>di</strong><br />
cicogne bianche stanziali.<br />
DOVE – Frequenta aree rurali, zone umide.<br />
ALIMENTAZIONE – L’alimentazione <strong>della</strong> cicogna bianca è pressoché carnivora e si basa su anfibi, rettili,<br />
piccoli mammiferi, crostacei, invertebrati e preda anche qualche uccello. Il suo habitat ideale è costituito da<br />
ambienti <strong>di</strong> pianura con presenza d’acqua e siepi alberate. Si adatta bene anche in contesti relativamente<br />
antropizzati.<br />
RIPRODUZIONE – La maturità sessuale è raggiunta a circa 3 – 4 anni. Tra marzo e aprile gli adulti preparano<br />
il nido. Depone in me<strong>di</strong>a 3 – 4 uova che cova per circa un mese. I pulcini imparano a volare dopo circa 2<br />
mesi dalla nascita.<br />
STATUS GIURIDICO – La Cicogna bianca (Ciconia ciconia) è una specie inclusa nell'Allegato II <strong>della</strong><br />
Convenzione relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica, adottata a<br />
Bonn il 23 giugno 1979, e nell'Allegato II del relativo African-Eurasian Waterbird Agreement (AEWA), siglato<br />
in Olanda il 16 giugno 1995, entrato in vigore nel novembre 1999.<br />
MINACCIATO<br />
CICOGNA BIANCA<br />
81<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Ciconiiformes<br />
FAMIGLIA<br />
Cinoniidae<br />
GENERE<br />
Ciconia<br />
SPECIE<br />
C. ciconia
NOME COMUNE<br />
Cinciallegra<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Parus major<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioni con lunghezza <strong>di</strong> 13-15 cm, apertura alare <strong>di</strong> 20-25 cm ed un<br />
peso <strong>di</strong> 16-21 g. Il maschio presenta parti superiori verdastre con una barra alare bianca. La testa è nera<br />
con guance bianche e dalla gola, nera, si <strong>di</strong>parte una striscia che giunge fino all’ addome. La femmina ha un<br />
piumaggio simile al maschio ma la stria nera che parte dalla gola si assottiglia verso l’addome.<br />
DOVE – Frequenta zone suburbane e campagna con presenza <strong>di</strong> alberi. La si trova facilmente anche sugli<br />
alberi dei viali urbani.<br />
ALIMENTAZIONE – Si nutre <strong>di</strong> insetti ma integra la sua <strong>di</strong>eta anche con semi, frutta, bacche.<br />
RIPRODUZIONE – La femmina depone 8-15 uova tra aprile e maggio che cova per 2 settimane. I piccoli<br />
lasciano il nido dopo circa 1 mese <strong>di</strong> vita.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare. Protetto in Italia.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
CINCIALLEGRA<br />
83<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Passeriformes<br />
FAMIGLIA<br />
Paridae<br />
GENERE<br />
Parus<br />
SPECIE<br />
P. major
NOME COMUNE<br />
Cinciarella<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Parus caeruleus<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioni, lunghezza <strong>di</strong> 11-13 cm, apertura alare <strong>di</strong> 19-22 cm ed un peso<br />
<strong>di</strong> 12 g. Maschi e femmine sono simili ma queste ultime presentano colorazioni più tenui. Il dorso è<br />
verdastro con le parti superiori <strong>di</strong> ali e coda azzurro-grigio. Il capo è bianco con vertice azzurro ed un<br />
bavaglino nero che dalla gola si unisce ad una banda sottile sulla nuca.<br />
DOVE – Frequenta zone suburbane e coltici con presenza <strong>di</strong> alberi.<br />
ALIMENTAZIONE – Insettivoro ma integra nella stagione fredda la sua <strong>di</strong>eta con bacche, semi, frutta.<br />
RIPRODUZIONE – La femmina tra aprile e maggio depone 7-10 uova che cova per 2 settimane. I piccoli<br />
possono lasciare il nido dopo circa 15-20 giorni.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare. Protetto in Italia.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
CINCIARELLA<br />
85<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Passeriformes<br />
FAMIGLIA<br />
Paridae<br />
GENERE<br />
Parus<br />
SPECIE<br />
P. caeruleus
NOME COMUNE<br />
Co<strong>di</strong>bugnolo<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Aegithalos caudatus<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioni. Lunghezza 13-16 cm, apertura alare <strong>di</strong> 17-20 cm ed un peso<br />
<strong>di</strong> 6-9 g. Maschio e femmina sono simili. Il piumaggio è bianco, nero e fulvo. La coda è molto lunga con<br />
colorazione bianca e nera.<br />
DOVE – Frequenta zone suburbane, parchi e coltivi alberati.<br />
ALIMENTAZIONE – Si nutre <strong>di</strong> insetti ma integra la sua <strong>di</strong>eta con semi e frutta.<br />
RIPRODUZIONE – La femmina depone tra marzo e maggio 9-12 uova che cova per circa 2 settimane. I<br />
piccoli lasciano il nido dopo circa 3 settimane.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare. Protetto in Italia.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
CODIBUGNOLO<br />
87<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Passeriformes<br />
FAMIGLIA<br />
Aegithalidae<br />
GENERE<br />
Aegithalos<br />
SPECIE<br />
A. caudatus
NOME COMUNE<br />
Co<strong>di</strong>rosso<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Phoenicurus phoenicurus<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensione, lunghezza pari a 14 cm circa, apertura alare 20-24 cm. Il<br />
maschio in primavera presenta il dorso color grigio ardesia e le parti inferiori arancioni. La testa è nera con<br />
la fronte bianca. Le zampe sono nere. Le femmine presentano una colorazione più tenue, con dorso<br />
marrone, petto fulvo e groppone rossiccio.<br />
DOVE – Frequenta zone suburbane e urbane con presenza <strong>di</strong> alberi.<br />
ALIMENTAZIONE – Si nutre <strong>di</strong> invertebrati, bacche e piccoli frutti.<br />
RIPRODUZIONE – Intorno a maggio la femmina depone 5-6 uova che cova per 2 settimane. Nelle successive<br />
2 settimane sia il maschio che la femmina nutrono i piccoli.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE - Nulla da segnalare. Protetto in Italia.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
CODIROSSO<br />
89<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Passeriformes<br />
FAMIGLIA<br />
Tur<strong>di</strong>dae<br />
GENERE<br />
Phoenicurus<br />
SPECIE<br />
P. phoenicurus
NOME COMUNE<br />
Co<strong>di</strong>rosso spazzacamino<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Phoenicurus ochruros<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensione, lunghezza pari a 15 cm circa, apertura alare 25-27 cm. I<br />
maschi hanno una colorazione delle parti superiori grigio scuro ed una banda alare bianca. La parte<br />
superiore <strong>della</strong> coda è rossa e le penne remiganti centrali nere. Guance, gola, petto, becco e zampe neri. Le<br />
femmine sono simili ai maschi senza le parti nere e la banda alare bianca.<br />
DOVE – Frequenta zone suburbane e urbane.<br />
ALIMENTAZIONE – Si nutre <strong>di</strong> invertebrati, bacche e piccoli frutti.<br />
RIPRODUZIONE – La femmina depone 4-6 uova che cova per 2 settimane. Dopo 1 mese dalla nascita i<br />
piccoli abbandonano il nido.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare. Protetto in Italia.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
CODIROSSO SPAZZACAMINO<br />
91<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Passeriformes<br />
FAMIGLIA<br />
Tur<strong>di</strong>dae<br />
GENERE<br />
Phoenicurus<br />
SPECIE<br />
P. ochruros
NOME COMUNE<br />
Colombaccio<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Columba palumbus<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello <strong>di</strong> me<strong>di</strong>e <strong>di</strong>mensioni, lunghezza <strong>di</strong> 40-45 cm e apertura alare <strong>di</strong> 70-80 cm e un peso<br />
<strong>di</strong> 460-570 g. Il piumaggio è simile in entrambi i sessi ed è costituito da una livrea grigia, con sfumature rosa<br />
nella parte inferiore e presenza <strong>di</strong> macchie bianche ai lati del collo.<br />
DOVE – Frequenta zone umide, alberate e lo si ritrova anche in ambito urbano.<br />
ALIMENTAZIONE – Si nutre <strong>di</strong> vegetali (frutti, bacche, ra<strong>di</strong>ci, semi) e <strong>di</strong> piccoli invertebrati.<br />
RIPRODUZIONE – La femmina depone 1 o 2 uova tra marzo e novembre che cova per circa 3 settimane.<br />
Dopo un mese i pulcini sono in grado <strong>di</strong> abbandonare il nido. Il colombaccio può deporre 1 o 2 volte<br />
all’anno.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
COLOMBACCIO<br />
92<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Columbiformes<br />
FAMIGLIA<br />
Columbidae<br />
GENERE<br />
Columba<br />
SPECIE<br />
C. palumbus
NOME COMUNE<br />
Colombo <strong>di</strong> città<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Columba livia<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello <strong>di</strong> me<strong>di</strong>e <strong>di</strong>mensioni, con una lunghezza <strong>di</strong> 32-34 cm, ed un’apertura alare <strong>di</strong> 60-65<br />
cm. Il piumaggio è simile tra maschi e femmine. Presenta due bande nere sulle ali mentre gola, collo e petto<br />
presentano riflessi metallici. Il piccione (o colombo <strong>di</strong> città), a <strong>di</strong>fferenza del colombaccio, presenta una<br />
grande varietà <strong>di</strong> colorazioni.<br />
DOVE – Frequenta zone urbane, suburbane e coltivi.<br />
ALIMENTAZIONE – Dieta prevalentemente vegetariana (semi, germogli, ecc.).<br />
RIPRODUZIONE – La femmina depone 2 uova tra marzo e ottobre che vengono covate da entrambi i<br />
genitori per circa 3 settimane. Durante i primi giorni dopo la nascita, i pulcini vengono alimentati con un<br />
particolare tipo <strong>di</strong> latte prodotto dal gozzo dei genitori. I piccoli abbandonano il nido dopo 1 mese.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
COLOMBO DI CITTA’<br />
94<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Columbiformes<br />
FAMIGLIA<br />
Columbidae<br />
GENERE<br />
Columba<br />
SPECIE<br />
C. livia
NOME COMUNE<br />
Cormorano<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Phalacrocorax carbo<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni con una lunghezza <strong>di</strong> 80-100 cm ed un’apertura alare <strong>di</strong> 120-<br />
150 cm. Il peso si aggira me<strong>di</strong>amente tra i 2 e 3 kg. Il piumaggio è nero con un becco robusto, ad uncino con<br />
una sacca gulare giallastra. Il mento ed i lati del muso sono bianca. Le ali non sono impermeabili e ciò<br />
consente al cormorano una buona capacità <strong>di</strong> nuoto in immersione. E’ costretto però ad asciugare spesso le<br />
ali al sole nella tipica posa.<br />
DOVE – Frequenta zone umide, cave, laghi e ambienti sub-urbani.<br />
ALIMENTAZIONE – Si nutre <strong>di</strong> pesce sia <strong>di</strong> acqua dolce che salta e <strong>di</strong> crostacei.<br />
RIPRODUZIONE – Si riproduce vicino alle zone costiere dove ni<strong>di</strong>fica. Depone circa 3-4 uova tra marzo e<br />
aprile. La cova dura circa 1 mese. Dopo circa 2 mesi i pulcini <strong>di</strong>vengono in<strong>di</strong>pendenti.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
CORMORANO<br />
96<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Pelecaniformes<br />
FAMIGLIA<br />
Phalacrocoracidae<br />
GENERE<br />
Phalacrocorax<br />
SPECIE<br />
P. carbo
NOME COMUNE<br />
Cornacchia grigia<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Corvus corone cornix<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello <strong>di</strong> me<strong>di</strong>e <strong>di</strong>mensioni, lunghezza <strong>di</strong> 45-50 cm e apertura alare <strong>di</strong> 90-100 cm. Maschi e<br />
femmine hanno colorazione uguale con dorso e ventre grigi e le altre parti nere.<br />
DOVE – Frequenta zone urbane, suburbane e coltivi con presenza <strong>di</strong> alberi.<br />
ALIMENTAZIONE – Onnivora, si cibano <strong>di</strong> frutti, ni<strong>di</strong>acei, carcasse, uova, semi.<br />
RIPRODUZIONE – La femmina depone da marzo a maggio 4-6 uova che cova per circa 3 settimane. I piccoli<br />
si involano dopo circa 1 mese <strong>di</strong> vita.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
CORNACCHIA GRIGIA<br />
98<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Passeriformes<br />
FAMIGLIA<br />
Corvidae<br />
GENERE<br />
Corvus<br />
SPECIE<br />
C. corone cornix
NOME COMUNE<br />
Cuculo<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Cuculus canorus<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Ha Lunghezza <strong>di</strong> 32-36,5 cm e apertura alare 55-70 cm. Il maschio adulto ha le parti<br />
superiori, il petto e il capo grigi. L'addome è bianco barrato <strong>di</strong> nero e sfuma con una barratura meno fitta<br />
verso ventre e sottocoda. Il becco è nerastro, l'occhio e le zampe gialli E' una specie solitaria facile<br />
soprattutto da sentire quando emette il suo tipico canto "cu-cu... cu-cu...". Quando è invece silenziosa è<br />
<strong>di</strong>fficile da scorgere soprattutto quando sta posata tra il fogliame degli alberi. In volo è più facile da vedere<br />
e ad una prima impressione assomiglia abbastanza come siluette ad un gheppio con la colorazione da<br />
sparviere. La specie sfrutta infatti in<strong>di</strong>rettamente il fatto <strong>di</strong> assomigliare a quest'ultimo rapace per<br />
spaventare i passeriformi facendoli allontanare dal nido e approfittandone per deporre l'uovo nel nido da<br />
parassitare.<br />
DOVE –Frequenta zone rurali con presenza <strong>di</strong> boschi.<br />
ALIMENTAZIONE – Il cuculo mangia insetti vari, bruchi (come la processionaria), molluschi e ragni.<br />
RIPRODUZIONE – Non costruisce il nido ma depone un uovo in un nido <strong>di</strong> un'altra specie, generalmente<br />
passeriforme. La femmina depone un solo uovo in ogni nido da aprile in poi per un totale <strong>di</strong> circa 15-20. Le<br />
uova somigliano molto a quelle <strong>della</strong> specie "ospite". Alla schiusa (che <strong>di</strong> norma avviene dopo circa 12<br />
giorni), il piccolo del cuculo, con l'aiuto del dorso, si sbarazza delle altre uova presenti nel nido e non ancora<br />
schiuse, presentandosi quin<strong>di</strong> nel nido come l'unico ospite. I genitori adottivi vengono ingannati da questo<br />
comportamento e nutrono il cuculo come se fosse un proprio ni<strong>di</strong>aceo per 2-3 settimane. Recentemente si<br />
è scoperto che i cuculi, dato che non devono occuparsi dei piccoli, migrano nei quartieri <strong>di</strong> svernamento<br />
subito dopo aver deposto le uova.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
CUCULO<br />
100<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Cuculiformes<br />
FAMIGLIA<br />
Cuculidae<br />
GENERE<br />
Cuculus<br />
SPECIE<br />
C. canorus
NOME COMUNE<br />
Fagiano<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Phasianus colchicus<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni me<strong>di</strong>o-gran<strong>di</strong>. Lunghezza 55-90 cm, apertura alare 70-90 cm. Il<br />
maschio presenta capo e collo verde, collare bianco e le parti superiori color bruno-rossiccio. La coda è<br />
lunga e appiattita. Presenta inoltre barbigli e mascherina rossa detta “caruncola” e degli speroni nella parte<br />
posteriore delle zampe. La femmina ha la coda più corta ed una colorazione più omogenea brunastra.<br />
DOVE – Frequenta incolti e coltivi con pochi alberi.<br />
ALIMENTAZIONE – Si nutre <strong>di</strong> vari vegetali ma anche <strong>di</strong> invertebrati, anfibi, rettili.<br />
RIPRODUZIONE – La femmina in primavera depone da 6 a 12 uova che cova per 1 mese circa. I piccoli dopo<br />
poche ore possono abbandonare il nido e dopo circa 2 settimane possono fare i primi voli.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
FAGIANO<br />
101<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Galliformes<br />
FAMIGLIA<br />
Phasianidae<br />
GENERE<br />
Phasianus<br />
SPECIE<br />
P. colchicus
102
NOME COMUNE<br />
Folaga<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Fulica atra<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello acquatico <strong>di</strong> me<strong>di</strong>e <strong>di</strong>mensioni. Raggiunge una lunghezza <strong>di</strong> 36-45 cm ed<br />
un’apertura alare <strong>di</strong> 68-80 cm. Il piumaggio del corpo è nero, il becco è bianco con una placca frontale del<br />
medesimo colore. Le zampe sono verdastre e lobate.<br />
DOVE – Frequenta zone umide, stagni, cave, corsi d’acqua.<br />
ALIMENTAZIONE – Generalmente onnivora. Si nutre <strong>di</strong> sostanze vegetali, piccoli pesci, anfibi, larve,<br />
molluschi, insetti.<br />
RIPRODUZIONE – Depone circa 5-10 uova da marzo a maggio che vengono covate per 3 settimane circa.<br />
Entrambi i genitori si occupano delle cure parentali. Dopo pochi giorni i pulcini possono lasciare il nido e<br />
sono in grado <strong>di</strong> volare a circa 2 mesi <strong>di</strong> vita.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare<br />
RISCHIO MINMO<br />
FOLAGA<br />
103<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Gruiformes<br />
FAMIGLIA<br />
Rallidae<br />
GENERE<br />
Fulica<br />
SPECIE<br />
F. atra
104
NOME COMUNE<br />
Fringuello<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Fringilla coelebs<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensione <strong>della</strong> lunghezza <strong>di</strong> 15-18 cm, apertura alare <strong>di</strong> 25-30 cm ed un<br />
peso <strong>di</strong> 19-23 g. Il maschio in abito nuziale presenta le parti superiori marroni-verdastre, ali scure con<br />
strisce bianche, parte superiore del capo e collo grigi, guancia, petto e addome rossi. Becco bluastro e<br />
zampe marroni. La femmina ha la colorazione del dorso simile al maschio, marrone, e il resto del piumaggio<br />
è più omogeneo.<br />
DOVE – Frequenta zone suburbane e coltivi alberati.<br />
ALIMENTAZIONE – Granivoro (semi) ma si ciba anche <strong>di</strong> piccoli invertebrati.<br />
RIPRODUZIONE – La femmina depone in primavera 4-5 uova che cova per 2 settimane circa. I piccoli<br />
lasciano il nido dopo circa 20 giorni <strong>di</strong> vita.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare. Protetto in Italia.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
FRINGUELLO<br />
105<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Passeriformes<br />
FAMIGLIA<br />
Fringillidae<br />
GENERE<br />
Fringilla<br />
SPECIE<br />
F. coelebs
106
NOME COMUNE<br />
Frullino<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Lymnocryptes minimus<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Lunghezza circa 20 cm, peso ca. 50-90 gr. Dimensioni inferiori a quelle del beccaccino,<br />
becco più breve e carnicino con apice scuro, <strong>di</strong>verso <strong>di</strong>segno del vertice, coda non a ventaglio. Sessi simili.<br />
Piumaggio brunastro con riflessi verdastri nelle parti superiori, striato nelle inferiori e con ventre<br />
biancastro. Non emette nessun verso quando si alza in volo e si mostra riluttante ad alzarsi<br />
DOVE – L'habitat naturale del frullino è rappresentato da acquitrini, praterie allagate, risaie, laghi, stagni e<br />
fiumi.<br />
ALIMENTAZIONE – Si nutre principalmente <strong>di</strong> insetti e delle loro larve.<br />
Abitu<strong>di</strong>ni terragnole, si allontana dalla fitta vegetazione soltanto al crepuscolo per cercare cibo.<br />
RIPRODUZIONE – Conduce vita solitaria ed è monogamo. La femmina depone 3-4 uova che vengono<br />
incubate per 17-24 gg.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare<br />
RISCHIO MINIMO<br />
FRULLINO<br />
107<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Charadriiformes<br />
FAMIGLIA<br />
Scolopacidae<br />
GENERE<br />
Lymnocryptes<br />
SPECIE<br />
L. minimus
NOME COMUNE<br />
Gabbiano comune<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Larus ri<strong>di</strong>bundus<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello <strong>di</strong> me<strong>di</strong>e <strong>di</strong>mensioni con una lunghezza <strong>di</strong> 35-40 cm ed un’apertura alare <strong>di</strong> 85-100<br />
cm. Il piumaggio è bianco, grigio e nero. Il becco e le zampe sono rosse. Durante la stagione riproduttiva il<br />
capo è colorato <strong>di</strong> marrone scuro.<br />
DOVE – Frequenta zone umide e coltivi come risaie e zone suburbane.<br />
ALIMENTAZIONE – Generalmente onnivoro. Si nutrie <strong>di</strong> piccoli invertebrati.<br />
RIPRODUZIONE – Le femmina depone circa 3 uova in primavera che sono covate per 3 settimane. I pulcini<br />
<strong>di</strong>ventano in<strong>di</strong>pendenti dopo circa 5-6 settimane.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
GABBIANO COMUNE<br />
108<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Charadriiformes<br />
FAMIGLIA<br />
Laridae<br />
GENERE<br />
Chroicocephalus<br />
SPECIE<br />
L. ri<strong>di</strong>bundus
109
NOME COMUNE<br />
Gallinella d’acqua<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Gallinula chloropus<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello lungo 31-35 cm con una apertura alare <strong>di</strong> 50-60 cm. La colorazione <strong>della</strong> livrea è<br />
marrone, grigio, nera e molto simile tra i due sessi. Risalta all’occhio il bianco <strong>della</strong> coda e la striscia<br />
spezzata bianca sui fianchi. Il becco è giallo con una placca rossa. Le zampe sono giallo-ver<strong>di</strong> con la base alta<br />
rossa. I pie<strong>di</strong> presentano lunghe <strong>di</strong>ta che permettono alla gallinella d’acqua <strong>di</strong> camminare nei luoghi che<br />
frequenta. I giovani hanno una colorazione più chiara rispetto agli adulti, e il becco color marrone.<br />
DOVE – Frequenta zone umide, stagni, rogge, fontanili ed è in grado <strong>di</strong> camminare anche sulla vegetazione<br />
acquatica.<br />
ALIMENTAZIONE – Si ciba <strong>di</strong> sostanze vegetali ma anche <strong>di</strong> insetti, molluschi, girini.<br />
RIPRODUZIONE – La stagione riproduttiva inizia a fine febbraio, sia il maschio che la femmina collaborano<br />
insieme alla cova e all’accu<strong>di</strong>mento dei pulcini. Vengono deposte 5-10 uova da 2 a 3 volte all’anno. La cova<br />
dura circa 3 settimane e i pulcini <strong>di</strong>vengono in<strong>di</strong>pendenti dopo 2-3 settimane.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
GALLINELLA D’ACQUA<br />
110<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Gruiformes<br />
FAMIGLIA<br />
Rallidae<br />
GENERE<br />
Gallinula<br />
SPECIE<br />
G. chloropus
111
NOME COMUNE<br />
Garzetta<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Egretta garzetta<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello <strong>di</strong> me<strong>di</strong>e <strong>di</strong>mensioni con una lunghezza <strong>di</strong> 55-65 cm, un peso che varia da 300 a 600<br />
g circa ed un’apertura alare <strong>di</strong> circa 90-100 cm. Maschio e femmina presentano colorazione identica con<br />
piumaggio del tutto bianco, becco e zampe neri mentre i pie<strong>di</strong> sono gialli. Nel periodo riproduttivo il<br />
maschio presenta due penne bianche molto lunghe.<br />
DOVE – Frequenta le zone umide, laghi stagli, rive <strong>di</strong> fiumi ed è facile trovarlo in ambiente agricolo<br />
soprattutto nelle risaie.<br />
ALIMENTAZIONE – Si nutre <strong>di</strong> piccoli invertebrati (crostacei, molluschi, insetti) e piccoli vertebrati (pesci,<br />
anfibi, rettili).<br />
RIPRODUZIONE – Ni<strong>di</strong>fica in colonie, in ambienti umi<strong>di</strong>. Il nido viene costruito su pioppi, salici ed alberi ad<br />
alto fusto ma anche tra gli arguti. Ad aprile vengono deposte 3-5 uova covate per circa 3 settimane. Dopo<br />
circa 1 mese dalla schiusa, i piccoli sono in grado <strong>di</strong> volare fuori dal nido.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – La Garzetta è protetta a livello internazionale dalla Direttiva 79/409/CEE (All I<br />
) e dalla Convenzione <strong>di</strong> Berna (All. II ); a livello nazionale dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
GARZETTA<br />
112<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Ciconiiformes<br />
FAMIGLIA<br />
Ardeidae<br />
GENERE<br />
Egretta<br />
SPECIE<br />
E. garzetta
113
NOME COMUNE<br />
Gazza<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Pica pica<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello <strong>di</strong> me<strong>di</strong>e <strong>di</strong>mensioni, lunghezza 40-45 cm, apertura alare 48-55 cm e un peso <strong>di</strong><br />
200-250 g. Maschio e femmina sono uguali con piumaggio nero, fianchi bianchi, ali e coda scuri con riflessi<br />
blu e ver<strong>di</strong> metallici. La coda è molto allungata.<br />
DOVE – Frequenta zone urbane, suburbane, zone umide e coltivi.<br />
ALIMENTAZIONE – Onnivora, si nutrono <strong>di</strong> invertebrati, uova, frutti, ni<strong>di</strong>acei e carcasse.<br />
RIPRODUZIONE – Tra marzo e giugno la femmina depone 4-8 uova covate per circa 20 giorni. I piccoli<br />
vengono allevati per circa 3 settimane e poi <strong>di</strong>vengono autonomi.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
GAZZA<br />
114<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Passeriformes<br />
FAMIGLIA<br />
Corvidae<br />
GENERE<br />
Pica<br />
SPECIE<br />
P. pica
115
NOME COMUNE<br />
Germano reale<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Anas platyrhynchos<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Il Germano reale è l’anatra più <strong>di</strong>ffusa e comune delle nostre zone. Raggiunge una<br />
lunghezza <strong>di</strong> 50 – 60 cm circa ed un’apertura alare <strong>di</strong> 81 – 98 cm circa. La femmina presenta una<br />
colorazione marrone adatta a mimetizzarsi tra la vegetazione durante la cova. Il maschio spicca per la sua<br />
livrea color verde e le piume <strong>della</strong> coda sono ripiegate a ricciolo.<br />
DOVE – Zone umide (fontanili, cave rogge), agricole, urbane, suburbane, parchi e giar<strong>di</strong>ni.<br />
ALIMENTAZIONE – Generalmente onnivora. Si nutre <strong>di</strong> vegetali che setaccia sui fondali delle zone umide<br />
come cave, fontanili, rogge, laghi.<br />
RIPRODUZIONE – Ni<strong>di</strong>fica tra la bassa vegetazione, molto vicino all’acqua. Le coppie si formano nel tardo<br />
autunno e si riproducono nella primavera successiva. La femmina depone da 9 a 15 uova circa e la cova<br />
dura in me<strong>di</strong>a 26 – 28 giorni. I pulcini sono in grado <strong>di</strong> volare a circa 2 mesi dalla nascita e me<strong>di</strong>amente la<br />
maturità sessuale viene raggiunta ad 1 anno <strong>di</strong> vita.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare<br />
RISCHIO MINIMO<br />
GERMANO REALE<br />
116<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Anseriformes<br />
FAMIGLIA<br />
Anatidae<br />
GENERE<br />
Anas<br />
SPECIE<br />
A. platyrhynchos
117
NOME COMUNE<br />
Gheppio<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Falco tinnunculus<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Il gheppio è un uccello <strong>di</strong> me<strong>di</strong>e <strong>di</strong>mensioni appartenente all'or<strong>di</strong>ne dei Falconiformi.<br />
Raggiunge una lunghezza <strong>di</strong> 31-37 cm e un’ apertura alare 70-80 cm. I gheppi mostrano un acceso<br />
<strong>di</strong>morfismo sessuale: i maschi hanno la testa <strong>di</strong> colore grigio chiaro, le femmine invece sono<br />
uniformemente <strong>di</strong> colore rosso mattone. Il gheppio è caratterizzato da un volo particolare, il cosiddetto il<br />
"Spirito Santo", durante il quale si mantiene totalmente fermo in aria, con piccoli battiti delle ali e tenendo<br />
la coda aperta a ventaglio, sfruttando il vento per mantenersi stabile e osservare il suolo in cerca <strong>di</strong> prede<br />
DOVE – Zone boschive, campagna città e tetti <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici.<br />
ALIMENTAZIONE – I gheppi si cibano <strong>di</strong> topi e altri ro<strong>di</strong>tori, <strong>di</strong> piccoli uccelli, insetti (coleotteri, falene,<br />
cavallette) e lombrichi.<br />
RIPRODUZIONE – Il corteggiamento, avviene a fine marzo o ai primi d'aprile. I gheppi depongono le uova in<br />
ni<strong>di</strong> abbandonati <strong>di</strong> da corvi<strong>di</strong>, in particolare cornacchia grigia e gazza mentre in ambiente urbano possono<br />
utilizzare anfratti e cavità <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici e manufatti. Depongono dalle 4-6 uova <strong>di</strong> colore bianco macchiato <strong>di</strong><br />
rosso-bruno<br />
I giovani sono in grado <strong>di</strong> volare dopo circa quattro settimane<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
GHEPPIO<br />
118<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Accipitriformi<br />
FAMIGLIA<br />
falconidae<br />
GENERE<br />
Falco<br />
SPECIE<br />
Falco tinnunculus
119
NOME COMUNE<br />
Gufo Comune<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Asio otus<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Il Gufo Comune è una specie localmente sedentaria. Presenta corpo slanciato, con<br />
piumaggio superiormente fulvo, marrone e grigiastro, striato <strong>di</strong> scuro, inferiormente bruno-giallastro con<br />
striature brune; Ha una taglia <strong>di</strong> 33-40,5 cm e un apertura alare <strong>di</strong> circa 88-100 cm.<br />
La testa è relativamente grande, con due ciuffi <strong>di</strong> piume che non hanno nulla a che vedere col vero e<br />
proprio apparato u<strong>di</strong>tivo, peraltro finissimo. Gli occhi sono gran<strong>di</strong>, posti anteriormente, con iride gialloarancio.<br />
Il gufo non può muovere gli occhi, in compenso però riesce a ruotare la testa <strong>di</strong> ben 360°.<br />
DOVE – Aree boscose ed alberate.<br />
ALIMENTAZIONE – Prevalentemente carnivora, caccia una grande varietà <strong>di</strong> piccoli animali, topi, toporagni,<br />
talpe ,scoiattoli, pipistrelli, ratti, uccelli e insetti<br />
RIPRODUZIONE – Ni<strong>di</strong>fica tra marzo e maggio,. La femmina depone 3-10 uova, Se non trova ni<strong>di</strong> <strong>di</strong> questo<br />
genere depone le uova sul suolo, sotto un albero o un arbusto. Cova le uova per 26-28 giorni, I piccoli<br />
lasciano il nido dopo 3-4 settimane.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
GUFO COMUNE<br />
120<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Strigiformes<br />
FAMIGLIA<br />
Strigidae<br />
GENERE<br />
Asio<br />
SPECIE<br />
A. Otosu
NOME COMUNE<br />
Lodolaio<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Falco subbuteo<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Lungo circa trenta centimetri, ha la coda <strong>di</strong> quin<strong>di</strong>ci, le singole ali <strong>di</strong> ventitré e l'apertura<br />
alare che supera i settanta. La femmina è alquanto più grande. Quanto al colorito, le parti superiori sono<br />
nere azzurrognole, con la testa grigiastra, la nuca segnata da macchie bianche e le ali orlate <strong>di</strong> giallo<br />
ruggine; le parti inferiori sono striate <strong>di</strong> nero sul fondo bianco o gialliccio; nella coda le timoniere sono<br />
azzurre superiormente e volgono al grigio nella parte inferiore, sempre marcate da macchie trasversali<br />
rosso-ruggine. Compie regolari migrazioni che lo portano a trascorrere l'inverno in Africa sub-sahariana. Il<br />
suo volo basso e veloce richiama quello del rondone, poiché, come questo, tiene le ali <strong>di</strong>sposte a falce, le<br />
muove <strong>di</strong> frequente e compie con grande sveltezza le più <strong>di</strong>fficili evoluzioni. Si posa <strong>di</strong> solito sugli alberi e<br />
molto <strong>di</strong> rado sul terreno.<br />
DOVE – Boschi e aree aperte.<br />
ALIMENTAZIONE – Predano soprattutto uccelli <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioni; in particolare, la <strong>di</strong>eta comprende<br />
ron<strong>di</strong>ni, rondoni e passeri. Oltre che <strong>di</strong> questi e <strong>di</strong> altri uccelli, al <strong>di</strong> fuori del periodo <strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione, il<br />
lodolaio eurasiatico si nutre <strong>di</strong> insetti volanti, specialmente locuste, libellule e formiche alate.<br />
RIPRODUZIONE – Maschi e femmine giungono assieme nei luoghi <strong>di</strong> ni<strong>di</strong>ficazione e si <strong>di</strong>vidono le cure<br />
parentali, sebbene sia la femmina a svolgere la parte preponderante <strong>della</strong> cova delle uova, alimentata in<br />
parte dal maschio. Per ni<strong>di</strong>ficare utilizza ni<strong>di</strong> abbandonati da altri uccelli posti sugli alberi elevati.<br />
Frequentemente si serve dei ni<strong>di</strong> delle cornacchie, dopo che i proprietari hanno terminato la ni<strong>di</strong>ficazione;<br />
ni<strong>di</strong>ficazione che nel lodolaio avviene con un certo ritardo rispetto alla maggior parte delle altre specie <strong>di</strong><br />
uccelli europei. Infatti, la deposizione inizia <strong>di</strong> solito intorno alla metà <strong>di</strong> giugno e l'involo dei giovani si<br />
verifica verso la metà <strong>di</strong> agosto. La covata è costituita <strong>di</strong> 3-5 uova <strong>di</strong> forma allungata,<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
LODOLAIO<br />
121<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Ave<br />
ORDINE<br />
Falconiformes<br />
FAMIGLIA<br />
Falconidae<br />
GENERE<br />
Falco<br />
SPECIE<br />
F. subbuteo
122
NOME COMUNE<br />
Lucherino<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Carduelis Spinus<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Il Lucherino eurasiatico è un colorato fringillide che si trova nelle regioni europee ed<br />
asiatiche. Generalmente è lungo circa 10-12 cm e pesa 14 grammi. Il maschio presenta la fronte, la calotta<br />
ed il pizzetto <strong>di</strong> colore nero, assenti nella femmina. Altro segno <strong>di</strong>stintivo è il colore giallo maggiormente<br />
<strong>di</strong>ffuso nella livrea degli in<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong> sesso maschile.<br />
DOVE – Boschi <strong>di</strong> conifere (larici e abeti rossi), ontano betulla, composite, zone suburbane, parchi e<br />
giar<strong>di</strong>ni.<br />
ALIMENTAZIONE – Granivora. Si nutre <strong>di</strong> semi con particolare preferenza per i semi oleosi, mentre i piccoli<br />
sono alimentati da entrambi i genitori a base <strong>di</strong> cibi vegetali e piccoli insetti<br />
RIPRODUZIONE – La riproduzione inizia in Aprile ed il lucherino generalmente ni<strong>di</strong>fica in boschi <strong>di</strong> conifera.<br />
La cova è fatta dalla sola femmina che generalmente depone da un minimo <strong>di</strong> tre ad un massimo <strong>di</strong> cinque<br />
uova,.I piccoli vengono alimentati da entrambe i genitori e raggiungono lo svezzamento intorno al<br />
venticinquesimo giorno <strong>di</strong> vita.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
LUCHERINO<br />
123<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Passeriformes<br />
FAMIGLIA<br />
Fringillidae<br />
GENERE<br />
Carduelis<br />
SPECIE<br />
C.Spinus
124
NOME COMUNE<br />
Luì verde<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Phylloscopus collybita<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni piccole. Lunghezza <strong>di</strong> 12 cm, apertura alare <strong>di</strong> 16-18 cm ed un peso <strong>di</strong><br />
10 g. Maschi e femmine sono simili con un piumaggio marrone - verde sulle parti dorsali e bianco sul<br />
ventre. Il sopracciglio è piuttosto evidente ma più tenue rispetto al Luì verde. I giovani sono simili agli<br />
adulti.<br />
DOVE – Frequenta cave e zone umide, piccoli boschi e canneti, parchi, giar<strong>di</strong>ni e aree suburbane.<br />
ALIMENTAZIONE – Si nutre <strong>di</strong> insetti, crisali<strong>di</strong>, ragni e larve.<br />
RIPRODUZIONE – Da aprile a giugno, 2 covate in un anno. Ni<strong>di</strong>fica al suolo. La femmina depone 5-6 uova<br />
che cova per circa 2 settimane.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
LUI’ PICCOLO<br />
125<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Passeriformes<br />
FAMIGLIA<br />
Sylviidae<br />
GENERE<br />
Phylloscopus<br />
SPECIE<br />
P. collybita
NOME COMUNE<br />
Luì verde<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Phylloscopus sibilatrix<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni piccole. Lunghezza <strong>di</strong> 12 cm, ed un peso <strong>di</strong> 10 g. Maschi e femmine<br />
sono simili con un piumaggio verde oliva su ali, gola e dorso. Presenta alcune penne nere, il petto è chiaro e<br />
il sottogola giallo. Ha una striscia gialla che parte dal becco e attraversa l’occhio terminando poco oltre<br />
quest’ultimo.<br />
DOVE – Frequenta boschi e foreste ma anche aree suburbane e zone alberate con latifoglie ad alto fusto.<br />
ALIMENTAZIONE – Si nutre <strong>di</strong> insetti ma può integrare la sua <strong>di</strong>eta con sostanze vegetali.<br />
RIPRODUZIONE – 1-2 covate in un anno. Ni<strong>di</strong>fica al suolo. La femmina depone 5-7 uova che cova per circa 2<br />
settimane.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
LUI’ VERDE<br />
126<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Passeriformes<br />
FAMIGLIA<br />
Sylviidae<br />
GENERE<br />
Phylloscopus<br />
SPECIE<br />
P. sibilatrix
NOME COMUNE<br />
Martin pescatore<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Alcedo atthis<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioni <strong>della</strong> lunghezza <strong>di</strong> 16-20 cm e apertura alare <strong>di</strong> 25-30 cm. Il<br />
peso è <strong>di</strong> 40-44 g. Maschio e femmina sono simili e il piumaggio è molto colorato. Il maschio presenta un<br />
becco scuro, la femmina presenta la parte inferiore del becco arancione. La livrea è azzurra e il ventre<br />
arancione.<br />
DOVE – Frequenta zone umide, cave, fontanili, lagune.<br />
ALIMENTAZIONE – Prevalentemente pesce ma anche piccoli invertebrati acquatici.<br />
RIPRODUZIONE – La femmina depone 5-8 uova tra marzo e agosto che cova per circa 3 settimane.<br />
Entrambi i genitori partecipano alla cova. I piccoli si involano dopo circa 1 mese.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
MARTIN PESCATORE<br />
127<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Coraciiformes<br />
FAMIGLIA<br />
Alce<strong>di</strong>nidae<br />
GENERE<br />
Alcedo<br />
SPECIE<br />
A. atthis
128
NOME COMUNE<br />
Merlo<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Turdus merula<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni me<strong>di</strong>o-piccole, lunghezza <strong>di</strong> 25-30 cm, apertura alare <strong>di</strong> 35-40 cm. Il<br />
maschio presenta un piumaggio nero con becco e anello oculare giallo. La femmina presenta un piumaggio<br />
marrone.<br />
DOVE – Frequenta aree urbane, suburbane e coltivi.<br />
ALIMENTAZIONE – Onnivoro, Si ciba <strong>di</strong> frutti, bacche, piccoli invertebrati.<br />
RIPRODUZIONE – La femmina depone da 4 a 6 uova 3 volte all’anno tra marzo e maggio che cova per circa<br />
2 settimane. I piccoli possono uscire dal nido dopo circa 2 settimane e anche se non sono ancora in grado <strong>di</strong><br />
volare, la mamma costruisce loro un nido tra i cespugli come riparo.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
MERLO<br />
129<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Passeriformes<br />
FAMIGLIA<br />
Tur<strong>di</strong>dae<br />
GENERE<br />
Turdus<br />
SPECIE<br />
T. merula
130
NOME COMUNE<br />
nibbio bruno<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Milvus migrans<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Il nibbio bruno è grande 55 - 65 cm e ha una larghezza alare <strong>di</strong> 140 - 150 cm. Il suo peso<br />
corporeo ammonta a circa 600 - 1.000 grammi. Il nibbio bruno può arrivare all'età <strong>di</strong> 20 anni. Ha una coda<br />
biforcuta che viene usata come timone. Il piumaggio è molto scuro e le punte delle ali sono <strong>di</strong> colore nero.<br />
Dimorfismo sessuale non evidente: le femmine sono normalmente più grosse del maschio.<br />
DOVE – Zone boschive, campagna città.<br />
ALIMENTAZIONE – Si nutre <strong>di</strong> pesci morti, piccoli uccelli, piccoli mammiferi, anfibi, rettili, insetti, carogne e<br />
rifiuti.<br />
RIPRODUZIONE – Il tempo <strong>di</strong> covata è da aprile a giugno. Il nido viene costruito su vecchi alberi in un<br />
ambiente alto con rami secchi. Ha un <strong>di</strong>ametro <strong>di</strong> 50 - 100 cm. Il mucchio per la covata viene ovattato con<br />
erba, fogliame, pelliccia e pelo. La femmina depone dalle due alle tre uova. Le uova vengono tenute in<br />
caldo soprattutto dalle femmine per 30 - 35 giorni. I giovani uccelli volano dopo 40 - 45 giorni<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
NIBBIO BRUNO<br />
131<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Accipitriformi<br />
FAMIGLIA<br />
Accipitridae<br />
GENERE<br />
Milvus<br />
SPECIE<br />
M. migrans
NOME COMUNE<br />
Nitticora<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Nycticorax nycticorax<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello <strong>di</strong> me<strong>di</strong>e <strong>di</strong>mensioni. La sua lunghezza è <strong>di</strong> 50-65 cm, pesa 700-1000 g ed ha<br />
un’apertura alare <strong>di</strong> 90-110 cm. Il piumaggio è grigio con le ali più chiare rispetto al dorso. Gli occhi sono<br />
rossi, il becco nero, le zampe, corte, sono gialle. Gli in<strong>di</strong>vidui adulti presentano delle piume bianche lunghe<br />
sul capo. Il suo nome significa “corvo <strong>della</strong> notte” perché è un uccello prevalentemente notturno e il suo<br />
verso ricorda quello <strong>di</strong> un corvo.<br />
DOVE – Frequenta zone umide, corsi d’acqua, cave.<br />
ALIMENTAZIONE – Si nutre <strong>di</strong> pesci, anfibi, rettili, invertebrati e piccoli mammiferi.<br />
RIPRODUZIONE – Da maggio a luglio la femmina depone 3-5 uova che vengono covate per circa 1 mese. I<br />
piccoli vengono accu<strong>di</strong>ti da entrambi i genitori per circa 2 settimane.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
NITTICORA<br />
132<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Ciconiiformes<br />
FAMIGLIA<br />
Ardeidae<br />
GENERE<br />
Nycticorax<br />
SPECIE<br />
N. nycticorax
133
NOME COMUNE<br />
Oca cignoide<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Cygnopsis cygnoides<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Specie selvatica, spesso allevata a scopo prevalentemente ornamentale. Deve il nome al<br />
suo portamento regale e fiero che la fa assomigliare ad un cigno. Il maschio pesa me<strong>di</strong>amente 5-6 kg, la<br />
femmina 4-5 kg. Assenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>morfismo sessuale. Il piumaggio è grigio-selvatico con delle barrature <strong>di</strong><br />
bianco, spesso, compatto, con il ventre bianco macchiato <strong>di</strong> nero. Il collo è <strong>di</strong> color nocciola, sfumando al<br />
crema risalendo verso il becco, lungo e piatto interamente nero cinto alla sua base da un anello <strong>di</strong> piume<br />
bianche. Si <strong>di</strong>fferenzia dall'oca domestica per la sua forma slanciata ed elegante ma soprattutto per la<br />
presenza <strong>di</strong> una grossa protuberanza <strong>di</strong> colore quasi nero nella parte superiore del becco.<br />
DOVE – Zone umide (fontanili, cave rogge)<br />
ALIMENTAZIONE – In cattività varia a seconda <strong>della</strong> stagione: nei perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> abbondante verdura questa<br />
svolge una parte importante <strong>della</strong> <strong>di</strong>eta. In carenza <strong>di</strong> erbe ver<strong>di</strong>, l'alimentazione è prevalentemente<br />
costituita da mangimi e cereali sfarinati.<br />
RIPRODUZIONE – In cattività (allevamento).<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
OCA CIGNOIDE<br />
134<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Anseriformes<br />
FAMIGLIA<br />
Anatidae<br />
GENERE<br />
Cygnopsis<br />
SPECIE<br />
C. cygnoides
135
NOME COMUNE<br />
Passera d’Italia<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Passer italiae<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioni, lunghezza <strong>di</strong> circa 15 cm, apertura alare circa 25 cm. Il<br />
piumaggio presenta varie tonalità <strong>di</strong> marrone, grigio e bianco. Il maschio presenta una vistosa macchia nera<br />
sul petto, sotto il becco, e la colorazione del dorso e delle ali è marrone vivace con sfumature <strong>di</strong> nero. La<br />
femmina invece presenta un piumaggio marrone più chiaro e uniforme.<br />
DOVE – Frequenta aree suburbane, urbane e <strong>di</strong> campagna.<br />
ALIMENTAZIONE – Onnivoro, si ciba <strong>di</strong> semi, frutta, insetti.<br />
RIPRODUZIONE – La femmina depone 3-6 uova tra aprile e settembre che cova per circa 2 settimane. Può<br />
effettuare 3-4 covate in un anno.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
PASSERA D’ITALIA<br />
136<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Passeriformes<br />
FAMIGLIA<br />
Passeridae<br />
GENERE<br />
Passer<br />
SPECIE<br />
P. domesticus<br />
italiae
137
NOME COMUNE<br />
Passera mattugia<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Passer montanus<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioni, lunghezza 13-15 cm, apertura alare 22-24 cm. Maschi e<br />
femmine simili con piumaggio marrone, bruno, rossiccio, guance bianche e macchia nera su <strong>di</strong> esse.<br />
Mascherina e gola nere. Parti ventrali bianco grigiastre.<br />
DOVE – Frequenta aree suburbane e coltivi.<br />
ALIMENTAZIONE – Onnivoro, si ciba <strong>di</strong> semi, frutti, insetti.<br />
RIPRODUZIONE – La femmina depone 3-7 uova tra aprile e settembre che cova alternandosi con il maschio<br />
per circa 2 settimane. I piccoli lasciano il nido dopo 2 settimane ma vengono ancora nutriti dai genitori per<br />
altri 10 giorni.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
PASSERA MATTUGIA<br />
138<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Passeriformes<br />
FAMIGLIA<br />
Passeridae<br />
GENERE<br />
Passer<br />
SPECIE<br />
P. montanus
139
NOME COMUNE<br />
Pavoncella<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Vanellus Vanellus<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – La pavoncella ha <strong>di</strong>mensioni me<strong>di</strong>e (lunghezza 30-32 cm, peso 200/220g). Presenta becco<br />
nero, corto e <strong>di</strong>ritto, ali molto larghe arrotondate <strong>di</strong> colore nero-verde come il resto del corpo e sono<br />
attraversate da una linea bianca che da metà ala converge fino alle parti inferiori. Presenta un caratteristico<br />
e <strong>di</strong>stintivo ciuffo nucale molto evidente <strong>di</strong> color nero; Nel maschio è molto più lungo rispetto alla femmina<br />
e negli immaturi è più corto. Il <strong>di</strong>morfismo sessuali non si <strong>di</strong>stingue solamente dal ciuffo ma anche dalla<br />
larghezza delle ali che nel maschio sono più gran<strong>di</strong>; molto probabilmente questo è dovuto ai voli acrobatici<br />
che questo compie durante la riproduzione. La femmina, inoltre possiede vertice meno scuro, zone chiare<br />
del capo più estese e gola macchiata <strong>di</strong> bianco.<br />
In Italia è <strong>di</strong> passo da metà ottobre a novembre e da marzo a metà aprile (ripasso), non ni<strong>di</strong>fica sulla nostra<br />
penisola se non qualche caso eccezionale in pianura padana. E' una specie terragnola e gregaria; durante le<br />
soste in pastura molte sentinelle vigilano ai bor<strong>di</strong> per assicurare lo stormo e avvisarlo in caso <strong>di</strong> pericolo. Ha<br />
volo ondulato con lenti battiti d'ala..<br />
DOVE – Vive lungo le rive dei fiumi o estuari, acquitrini, palu<strong>di</strong>, brughiere e campagne coltivate<br />
ALIMENTAZIONE – Si nutre prevalentemente <strong>di</strong> insetti e le loro larve, in minor quantità <strong>di</strong> sostanze vegetali<br />
RIPRODUZIONE – Specie monogama, depone 3/5 uova una volta l'anno che vengono incubate da entrambi<br />
i sessi per 25-30 giorni. I piccoli, precoci, vengono accu<strong>di</strong>ti principalmente dalla femmina, mentre il maschio<br />
sorveglia la zona. I piccoli raggiungono l'in<strong>di</strong>pendenza in circa 30 giorni.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
PAVONCELLA<br />
140<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Ave<br />
ORDINE<br />
Charadriiformes<br />
FAMIGLIA<br />
Charadriidae<br />
GENERE<br />
Vanellus<br />
SPECIE<br />
V. vanellus
NOME COMUNE<br />
Pettirosso<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Erithacus rubecula<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensione <strong>della</strong> lunghezza <strong>di</strong> 13-15 cm ed un’apertura alare <strong>di</strong> 22-25 cm.<br />
Il peso varia da 11 a 22 g. Maschio e femmina sono simili con livrea marrone e faccia e petto color rosso<br />
arancione.<br />
DOVE – Frequenta zone suburbane e <strong>di</strong> campagna.<br />
ALIMENTAZIONE – Si nutre <strong>di</strong> invertebrati, bacche e piccoli frutti.<br />
RIPRODUZIONE – Ni<strong>di</strong>fica tra aprile e agosto, 1 o 2 volte l’anno. La femmina depone 5 o 6 uova che cova<br />
per 2 settimane circa. I pulcini prendono il volo dopo circa 2 settimane <strong>di</strong> vita.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
PETTIROSSO<br />
141<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Passeriformes<br />
FAMIGLIA<br />
Muscicapidae<br />
GENERE<br />
Erithacus<br />
SPECIE<br />
E. rubecola
142
NOME COMUNE<br />
Picchio rosso maggiore<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Dendrocopos major<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni me<strong>di</strong>o-piccole. Lunghezza <strong>di</strong> 20-25 cm, apertura alare <strong>di</strong> 43 cm circa.<br />
Maschi e femmine sono simili con piumaggio bianco e nero e sottocoda rosso. Il maschio presenta una<br />
macchia rossa sulla nuca e i giovani hanno tutta la sommità dl capo rossa.<br />
DOVE – Frequenta campagne con presenza <strong>di</strong> alberi e boschetti ma anche zone suburbane, parchi e<br />
giar<strong>di</strong>ni.<br />
ALIMENTAZIONE – Insettivoro, si nutre <strong>di</strong> insetti xilofagi (che vivono all’interno delle piante) ma anche <strong>di</strong><br />
semi, frutti e bacche.<br />
RIPRODUZIONE – La femmina depone in primavera 4-5 uova che vengono covate per 2 settimane circa. I<br />
piccoli lasciano il nido dopo 20 giorni.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare. Protetto in Italia.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
PICCHIO ROSSO MAGGIORE<br />
143<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Piciformes<br />
FAMIGLIA<br />
Picidae<br />
GENERE<br />
Dendrocopos<br />
SPECIE<br />
D. major
144
NOME COMUNE<br />
Picchio verde<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Picus viri<strong>di</strong>s<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni me<strong>di</strong>o-piccole. Lunghezza <strong>di</strong> 30-35 cm, apertura alare <strong>di</strong> 48-53 cm<br />
circa. Maschi e femmine sono simili con piumaggio verde sul dorso, con sfumature <strong>di</strong> grigio. Il vertice del<br />
capo è rosso mentre i lati sono neri.<br />
DOVE – Frequenta zone umide, campagne con presenza <strong>di</strong> alberi e boschetti ma anche zone suburbani,<br />
parchi e giar<strong>di</strong>ni.<br />
ALIMENTAZIONE – Insettivoro, si nutre <strong>di</strong> insetti xilofagi (che vivono all’interno delle piante).<br />
RIPRODUZIONE – La femmina depone tra marzo e giugno 5-7 uova che vengono covate per 2 settimane<br />
circa soprattutto dal maschio. I piccoli lasciano il nido dopo 25 giorni.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare. Protetto in Italia.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
PICCHIO VERDE<br />
145<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Piciformes<br />
FAMIGLIA<br />
Picidae<br />
GENERE<br />
Picus<br />
SPECIE<br />
P. viri<strong>di</strong>s
NOME COMUNE<br />
Pigliamosche<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Muscicapa striata<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensione, <strong>della</strong> lunghezza <strong>di</strong> 14-16 cm, apertura alare <strong>di</strong> 23-27 cm e un<br />
peso <strong>di</strong> 16 g. Maschi e femmine presentano colorazioni simili con un piumaggio marrone e più chiaro nelle<br />
parti inferiori. Becco e zampe sono nerastri.<br />
DOVE – Frequenta zone suburbane e coltivi alberati.<br />
ALIMENTAZIONE – Si nutre <strong>di</strong> insetti soprattutto mosche, moscerini, farfalle e libellule. Non <strong>di</strong>sdegna però<br />
in caso <strong>di</strong> perio<strong>di</strong> <strong>di</strong>fficili le bacche.<br />
RIPRODUZIONE – La femmina depone tra maggio e luglio 4-5 uova che cova per 2 settimane.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare. Protetto in Italia.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
PIGLIAMOSCHE<br />
146<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Passeriformes<br />
FAMIGLIA<br />
Muscicapidae<br />
GENERE<br />
Muscicapa<br />
SPECIE<br />
M. striata
147
NOME COMUNE<br />
Piro piro piccolo<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Actitis hypoleucos<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello limicolo <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensione <strong>di</strong> lunghezza pari a circa 19-22 cm ed un’apertura<br />
alare <strong>di</strong> 35-40 cm. Il piumaggio è marrone scuro nelle parti superiori e bianco nelle parti inferiori. Il becco è<br />
marrone e le zampe sono verdastre.<br />
DOVE – Frequenta zone umide, cave, canneti e ambienti coltivi come risaie.<br />
ALIMENTAZIONE – Si nutrie <strong>di</strong> invertebrati (insetti, molluschi, anelli<strong>di</strong>, crostacei).<br />
RIPRODUZIONE – Ni<strong>di</strong>fica una volta all’anno in primavera. La femmina depone circa 4 uova che cova per 3<br />
settimane.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
PIRO PIRO PICCOLO<br />
148<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Charadriiformes<br />
FAMIGLIA<br />
Scolopacidae<br />
GENERE<br />
Actitis<br />
SPECIE<br />
A. hypoleucos
149
NOME COMUNE<br />
Poiana<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Buteo Buteo<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni me<strong>di</strong>o-gran<strong>di</strong> appartenente all'or<strong>di</strong>ne dei Falconiformi Ha una<br />
lunghezza tipica tra i 51 e i 57 cm con una apertura alare dai 110 ai 130 cm. La femmina ha <strong>di</strong>mensioni<br />
maggiori. Il piumaggio è invece in<strong>di</strong>stinguibile nei due sessi e caratterizzato da notevole variabilità, con<br />
in<strong>di</strong>vidui quasi completamente bruno scuro. Possiede zampe con unghie ricurve e appuntite. la coda,<br />
piuttosto corta e arrotondata, è fittamente barrata e presenta una fascia scura terminale. Tipico delle<br />
poiane è il volo lento e con ampi e lunghi volteggi planari.<br />
DOVE – Zone urbane, suburbane.<br />
ALIMENTAZIONE – Si ciba prevalentemente <strong>di</strong> piccoli mammiferi, talvolta <strong>di</strong> uccelli, anfibi, rettili, insetti e<br />
carogne.<br />
RIPRODUZIONE – Sembra formare coppie unite per la vita. Il nido viene ricostruito ogni anno, raramente<br />
viene rioccupato quello dell’anno precedente. Viene costruito principalmente sugli alberi, sulle pareti<br />
rocciose e sul terreno scosceso. La femmina depone solitamente 2 o 3 (più raramente 1 o 4 ) uova nel nido<br />
tra marzo e maggio. La cova dura solitamente 34 giorni. I piccoli restano nel nido per i successivi 40-50<br />
giorni e vengono alimentati da entrambi i genitori<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
POIANA<br />
150<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Accipitriformes<br />
FAMIGLIA<br />
Accipitridae<br />
GENERE<br />
Buteo<br />
SPECIE<br />
B.buteo
151
NOME COMUNE<br />
Ron<strong>di</strong>ne<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Hirundo rustica<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensione, con una lunghezza <strong>di</strong> 18-20 cm ed un’apertura alare <strong>di</strong> 33-35<br />
cm. Maschi e femmine presentano colorazioni simili con piumaggio nero <strong>di</strong> riflessi blu, fronte e gola rossi e<br />
il ventre bianco. La coda è biforcuta.<br />
DOVE – Frequenta zone suburbane, coltivi, zone umide.<br />
ALIMENTAZIONE – Si nutre <strong>di</strong> insetti (mosche, zanzare, libellule e altri invertebrati).<br />
RIPRODUZIONE – La femmina ni<strong>di</strong>fica 2 volte all’anno, tra maggio e agosto, depone 4-5 uova che cova per<br />
circa 2 settimane.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
RONDINE<br />
152<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Passeriformes<br />
FAMIGLIA<br />
Hirun<strong>di</strong>nidae<br />
GENERE<br />
Hirundo<br />
SPECIE<br />
H. rustica
153
NOME COMUNE<br />
Rondone comune<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Apus apus<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioni, <strong>di</strong> lunghezza 15-20 cm, apertura alare pari a 35-45 cm ed un<br />
peso <strong>di</strong> 40-50 g. Maschio e femmina presentano colorazione simile con livrea marrone scuro e la gola<br />
biancastra. Zampe e becco corti. Ali falciformi. I rondoni dormono in volo.<br />
DOVE – Frequenta zone urbane e suburbane ma anche altri siti per la ricerca <strong>di</strong> cibo.<br />
ALIMENTAZIONE – Si nutre <strong>di</strong> insetti, una coppia con ni<strong>di</strong>acei ne può consumare circa 20.000 in un giorno.<br />
RIPRODUZIONE – La femmina depone 2-3 uova a fine primavera (maggio, giugno) che cova per circa 3<br />
settimane. I piccoli possono abbandonare il nido dopo circa 40 giorni. Le coppie sono stabili fino alla morte<br />
<strong>di</strong> uno dei partner.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
RONDONE COMUNE<br />
154<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Apo<strong>di</strong>formes<br />
FAMIGLIA<br />
Apo<strong>di</strong>dae<br />
GENERE<br />
Apus<br />
SPECIE<br />
A. apus
NOME COMUNE<br />
Scricciolo<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Troglodytes troglodytes<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccelli <strong>di</strong> piccolissime <strong>di</strong>mensioni, lunghezza <strong>di</strong> circa 10 cm, apertura alare <strong>di</strong> 14-17 cm.<br />
Maschi e femmine presentano colorazione marrone con macchie scure mentre l’addome è chiaro. Tiene<br />
spesso la coda rivolta verso l’alto.<br />
DOVE – Frequenta zone suburbane e coltivi con alberi.<br />
ALIMENTAZIONE – Insettivoro ma integra la sua <strong>di</strong>eta con bacche nel periodo invernale.<br />
RIPRODUZIONE – A fine aprile la femmina depone 5-10 uova che cova per 2 settimane. I piccoli restano a<br />
lungo nel nido, anche dopo aver raggiunto l’autosufficienza.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare. Protetto in Italia.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
SCRICCIOLO<br />
155<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Passeriformes<br />
FAMIGLIA<br />
Troglodytidae<br />
GENERE<br />
Troglodytes<br />
SPECIE<br />
T. troglodytes
NOME COMUNE<br />
Sgarza ciuffetto<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Ardeola ralloides<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello <strong>di</strong> me<strong>di</strong>e <strong>di</strong>mensioni <strong>della</strong> lunghezza <strong>di</strong> 45-50 cm, un peso <strong>di</strong> 180 – 400 g ed<br />
un’apertura alare <strong>di</strong> 70-90 cm. Il piumaggio è color fulvo, arancione e bianco. Il becco è azzurro con la punta<br />
nerastra. Le zampe sono gialle. Gli in<strong>di</strong>vidui giovani e immaturi hanno una colorazione più chiara.<br />
DOVE – Frequenta zone umide come laghi, cave e ambienti coltivi come le risaie.<br />
ALIMENTAZIONE – Si nutre <strong>di</strong> pesci, anfibi e altri invertebrati.<br />
RIPRODUZIONE – Ni<strong>di</strong>fica una sola volta all’anno. La femmina depone a maggio 4-6 uova covate da<br />
entrambi i genitori per circa 3 settimane.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
SGARZA CIUFFETTO<br />
156<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Ciconiiformes<br />
FAMIGLIA<br />
Ardeidae<br />
GENERE<br />
Ardea7<br />
SPECIE<br />
A. ralloides
NOME COMUNE<br />
Sparviere<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Accipiter nisus<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello <strong>di</strong> me<strong>di</strong>e <strong>di</strong>mensione. Raggiunge una lunghezza <strong>di</strong> 30-40 cm, un’apertura alare <strong>di</strong><br />
55-70 cm ed un peso pari a circa 150-380 grammi. La femmina è più grande del maschio ed ha una<br />
colorazione grigiastra nella parte superiore, mentre le parti inferiori, gola inclusa, sono bianche fittamente<br />
barrate <strong>di</strong> marrone scuro. Una evidente striatura bianca screziata <strong>di</strong> scuro parte dal becco, attraversa gli<br />
occhi e si congiunge <strong>di</strong>etro sulla nuca. Il maschio presenta una livrea simile alla femmina ma la parte<br />
ventrale sfuma dal bianco all’arancione. Occhi e zampe gialli. Becco grigio con parte terminare nera.<br />
DOVE – Frequenta coltivi con presenza <strong>di</strong> piccoli boschi, alberi e siepi, zone umide e aree suburbane.<br />
ALIMENTAZIONE – Si nutrie <strong>di</strong> uccelli e piccoli mammiferi.<br />
RIPRODUZIONE – Si riproduce da maggio ad agosto e depone 2-7 uova che cova per circa 1 mese. I piccoli<br />
sono in grado <strong>di</strong> volare dopo circa 30 giorni.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
SPARVIERE<br />
157<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Falconiformes<br />
FAMIGLIA<br />
Accipitridae<br />
GENERE<br />
Accipiter<br />
SPECIE<br />
A. nisus
NOME COMUNE<br />
Stiaccino<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Saxicola rubetra<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioni <strong>della</strong> lunghezza <strong>di</strong> 12-14 cm, apertura alare <strong>di</strong> 23-26 cm e un<br />
peso <strong>di</strong> 18 grammi. Maschi e femmine presentano colorazione simile ma queste ultime con colori più tenui.<br />
Parti superiori marrone, sopracciglio bianco, la gola e la parte alta del petto sono arancione. La coda è nera<br />
con due bande laterali bianche. Zampe e becco neri.<br />
DOVE – Frequenta incolti e coltivi con pochi alberi e cespugli.<br />
ALIMENTAZIONE – Insettivoro.<br />
RIPRODUZIONE – La femmina tra maggio e luglio depone 6 uova che cova per 2 settimane. I piccoli si<br />
involano dopo circa 2 settimane <strong>di</strong> vita.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare. Protetto in Italia.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
STIACCINO<br />
158<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Passeriformes<br />
FAMIGLIA<br />
Muscicapidae<br />
GENERE<br />
Saxicola<br />
SPECIE<br />
S. rubetra
159
NOME COMUNE<br />
Storno<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Sturnus vulgaris<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni me<strong>di</strong>o-piccole. Lunghezza <strong>di</strong> 20-25 cm, apertura alare <strong>di</strong> 35-40 cm ed<br />
un peso <strong>di</strong> 70-90 g. Maschi e femmine sono simili con un piumaggio variabile. In estate gli storni sono neri<br />
con riflessi violacei e verdastri mentre il becco è giallognolo e l zampe rossastre. In inverno i riflessi si<br />
attenuano, il becco <strong>di</strong>venta bruno.<br />
DOVE – Frequenta aree suburbane e coltivi alberati.<br />
ALIMENTAZIONE – Si nutre <strong>di</strong> insetti, frutta, semi, piccoli vertebrati.<br />
RIPRODUZIONE – Circa 3 covate in un anno. La femmina depone tra aprile e giungo 4-9 uova che cova<br />
insieme al compagno per circa 2 settimane. Dopo circa 3 settimane dalla schiusa, i piccoli possono<br />
abbandonare il nido.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
STORNO<br />
160<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Passeriformes<br />
FAMIGLIA<br />
Sturnidae<br />
GENERE<br />
Sturnus<br />
SPECIE<br />
S. vulgaris
161
NOME COMUNE<br />
Svasso maggiore<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Po<strong>di</strong>ceps cristatus<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello acquatico <strong>di</strong> me<strong>di</strong>e <strong>di</strong>mensioni. Lunghezza <strong>di</strong> 50-56 cm, apertura alare <strong>di</strong> 76-86 cm<br />
ed un peso pari a circa 600-1300 grammi. Assenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>morfismo sessuale. Il piumaggio nuziale si presenta<br />
bruno dorsalmente con petto, parte anteriore del collo e faccia bianchi. Ciuffo e collare bruni. I pulli sono<br />
bianchi con striature nere. Becco lungo, appuntito e rossastro. Coda breve, ali brune e strette, zampe ver<strong>di</strong>gialle<br />
con pie<strong>di</strong> lobati. Il cerimoniale <strong>di</strong> accoppiamento è articolato e molto bello da osservare.<br />
DOVE – Frequenta zone umide, stagni, laghi, cave.<br />
ALIMENTAZIONE – Si nutrie <strong>di</strong> anfibi, piccoli pesci, insetti e crostacei.<br />
RIPRODUZIONE – Si riproduce tra aprile e agosto e depone 2-6 uova che cova per circa 1 mese. I piccoli<br />
sono in grado <strong>di</strong> volare dopo circa 30 giorni.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
SVASSO MAGGIORE<br />
162<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Po<strong>di</strong>cipe<strong>di</strong>formes<br />
FAMIGLIA<br />
Po<strong>di</strong>cipe<strong>di</strong>dae<br />
GENERE<br />
Po<strong>di</strong>ceps<br />
SPECIE<br />
P. cristatus
163
NOME COMUNE<br />
Topino<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Riparia riparia<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Presenta lunghezza <strong>di</strong> 12,5-13 cm e apertura alare 26-29 cm. Gli adulti (in<strong>di</strong>stinguibili in<br />
natura tra <strong>di</strong> loro il maschio e la femmina) hanno le parti superiori completamente marroni. Le parti<br />
inferiori sono biancastre con un evidente collare marrone che separa petto e gola. Il becco è nero e le<br />
zampe, molto corte, anch'esse sono nere. Ha una coda leggermente biforcuta E' una specie gregaria<br />
durante la permanenza nelle nostra provincia e durante le migrazioni si può osservare talvolta in<br />
raggruppamenti anche <strong>di</strong> varie decine <strong>di</strong> in<strong>di</strong>vidui. Si osserva facilmente soprattutto durante le migrazioni<br />
quando è in volo a caccia <strong>di</strong> insetti in ambienti umi<strong>di</strong> spesso in compagnia delle ron<strong>di</strong>ni alle quali si associa<br />
anche quando si posa per riposarsi.<br />
DOVE – Zone boschive, campagna , zone umide (fontanili, cave rogge).<br />
ALIMENTAZIONE – Il topino vola a raso dell'acqua e va alla ricerca <strong>di</strong> insetti. Raggiunge in queste<br />
circostanze una velocità <strong>di</strong> 50 km/h.<br />
RIPRODUZIONE – Entrambi i partner scavano i tunnel per la covata con il becco e gli artigli in profon<strong>di</strong>tà in<br />
pareti ripide e sabbiose. I buchi in salita nel terreno stabile vengono allargati e ovattati nella parte finale<br />
con penne e fili d'erba. Cova una o due volte all'anno una covata <strong>di</strong> 5 - 6 uova <strong>di</strong> entrambi i genitori per 14 -<br />
16 giorni. I piccoli vengono nutriti allo stesso tempo da entrambi i genitori e lasciano i tunnel <strong>di</strong> covata dopo<br />
18 - 23 giorni. I piccoli costruiscono dopo aver lasciato gli uccelli anziani gran<strong>di</strong> spazi per dormire,<br />
specialmente nei canneti o nei pascoli.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
TOPINO<br />
164<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Passeriformes<br />
FAMIGLIA<br />
Hirun<strong>di</strong>nidae<br />
GENERE<br />
Riparia<br />
SPECIE<br />
R. riparia
NOME COMUNE<br />
Torcicollo<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Jynx torquilla<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioni <strong>di</strong> lunghezza 17-19 cm, apertura alare <strong>di</strong> 25-30 cm e un peso<br />
<strong>di</strong> circa 35 g. Maschi e femmine sono simili e il piumaggio è marrone-grigio. L’occhio è attraversato da una<br />
striscia marrone scuro che giunge fino alla spalla. Zampe e becco sono marroni-grigi.<br />
DOVE – Frequenta coltivi alberati con siepi e zone suburbane.<br />
ALIMENTAZIONE – Insettivoro, si nutre prevalentemente <strong>di</strong> formiche.<br />
RIPRODUZIONE – La femmina in primavera depone 7-11 uova che cova per 2 settimane. Dopo 3 settimane i<br />
piccoli sono in grado <strong>di</strong> lasciare il nido.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE: nulla da segnalare. Protetto in Italia.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
TORCICOLLO<br />
165<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Piciformes<br />
FAMIGLIA<br />
Picidae<br />
GENERE<br />
Jynx<br />
SPECIE<br />
J. torquilla
166
NOME COMUNE<br />
Tortora dal collare<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Streptopelia decaocto<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello <strong>di</strong> me<strong>di</strong>e <strong>di</strong>mensioni, lunghezza <strong>di</strong> 30-35 cm, apertura alare <strong>di</strong> 45-55 cm ed un peso<br />
<strong>di</strong> circa 165 g. Maschi e femmine <strong>di</strong> colorazione simile con piumaggio beige ed un caratteristico collare<br />
nero. Estremità delle ali e <strong>della</strong> coda scure.<br />
DOVE – Frequenta zone urbane, suburbane e coltivi.<br />
ALIMENTAZIONE – Si nutre <strong>di</strong> semi, frutta, erbe, piccoli invertebrati.<br />
RIPRODUZIONE – La femmina depone 1 o 2 uova tra marzo e settembre che cova per circa 2 settimane.<br />
Può fare più <strong>di</strong> una ni<strong>di</strong>ata all’anno. I piccoli si involano dopo circa 3 settimane <strong>di</strong> vita.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
TORTORA DAL COLLARE<br />
167<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Columbiformes<br />
FAMIGLIA<br />
Columbidae<br />
GENERE<br />
Streptopelia<br />
SPECIE<br />
S. decaocto
168
NOME COMUNE<br />
Tuffetto<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Tachybaptus ruficollis<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello <strong>di</strong> piccole-me<strong>di</strong>a <strong>di</strong>mensioni. E’ il più piccolo svasso italiano. Ha una lunghezza <strong>di</strong><br />
25-30 cm ed un’apertura alare <strong>di</strong> 40-45 cm. La colorazione del piumaggio è generalmente scusa, marrone,<br />
con gola e coda biancastre. Il becco è scuro. La livrea nuziale è caratterizzata dal collo e gola colorati <strong>di</strong><br />
rosso.<br />
DOVE – Frequenta zone umide, cave, corsi d’acqua.<br />
ALIMENTAZIONE – Si nutre <strong>di</strong> piccoli pesci, girini, invertebrati.<br />
RIPRODUZIONE – La femmina depone in me<strong>di</strong>a 5 uova 2 o 3 volte all’anno dalla fine <strong>di</strong> marzo alla fine <strong>di</strong><br />
agosto. La cova dura circa 3 settimane.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Protetto a livello nazionale (legge 157/92).<br />
RISCHIO MINIMO<br />
TUFFETTO<br />
169<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Po<strong>di</strong>cipe<strong>di</strong>formes<br />
FAMIGLIA<br />
Po<strong>di</strong>cipe<strong>di</strong>dae<br />
GENERE<br />
Tachybaptus<br />
SPECIE<br />
T. ruficollis
NOME COMUNE<br />
Upupa<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Upupa epops<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – L'upupa è lunga 25–29 cm, con apertura alare <strong>di</strong> 44 – 48 cm. Il piumaggio è inconfon<strong>di</strong>bile,<br />
marrone molto chiaro nella parte superiore e a strisce orizzontali bianco-nere nella parte inferiore. Il capo è<br />
provvisto <strong>di</strong> un ciuffo erettile <strong>di</strong> penne, il becco è piuttosto lungo e sottile e leggermente ricurvo verso il<br />
basso. I sessi sono simili. Migra verso i tropici in inverno.<br />
DOVE – Zone boschive, campagna, città.<br />
ALIMENTAZIONE – Si nutre <strong>di</strong> larve <strong>di</strong> invertebrati, grossi insetti quali grilli, grossi bruchi e larve, lombrichi,<br />
molluschi, ragni, millepie<strong>di</strong>, chiocciole.<br />
RIPRODUZIONE – Il nido viene collocato in cavità presenti nei vecchi alberi o in nicchie lungo pareti rocciose<br />
ma anche in costruzioni rurali o ruderi. Le uova vengono deposte una due volte all'anno (da 5 a 8), e<br />
vengono covate per 17 giorni. I piccoli si trattengono nel nido per più <strong>di</strong> 3 settimane, accu<strong>di</strong>ti da entrambi i<br />
genitori. Per proteggersi da eventuali predatori, i ni<strong>di</strong>acei posseggono una singolare forma <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa:<br />
investono il visitatore indesiderato con i loro escrementi puzzolenti<br />
Il canto, un monotono "houp-oup-oup", viene ripetuto incessantemente all'inizio del periodo riproduttivo.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
UPUPA<br />
170<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Coraciiformes<br />
FAMIGLIA<br />
Upupidae<br />
GENERE<br />
Upupa<br />
SPECIE<br />
U. epops
171
NOME COMUNE<br />
Usignolo <strong>di</strong> fiume<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Cettia cetti<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioni, lunghezza pari a 15 cm circa, apertura alare <strong>di</strong> 15-18 cm.<br />
Maschi e femmine sono uguali, il piumaggio è marrone nella parte superiore e marrone-grigiastro in quella<br />
inferiore. Presenza <strong>di</strong> sopracciglio bianco sopra gli occhi. Zampe e becco superiore marroni mentre la parte<br />
inferiore del becco è più chiara.<br />
DOVE – Frequenta cave, zone umide e siepi.<br />
ALIMENTAZIONE – Si ciba <strong>di</strong> insetti, larve, piccoli invertebrati ma integra la sua <strong>di</strong>eta con bacche e frutti.<br />
RIPRODUZIONE – La femmina depone 4-5 uova in primavera.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
USIGNOLO DI FIUME<br />
172<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Passeriformes<br />
FAMIGLIA<br />
Sylviidae<br />
GENERE<br />
Cettia<br />
SPECIE<br />
C. cetti
NOME COMUNE<br />
Verdone<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Carduelis chloris<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioni <strong>di</strong> lunghezza pari a 14 cm circa, un’apertura alare <strong>di</strong> 25-30 cm<br />
ed un peso <strong>di</strong> 23-30 g. Il maschio d’estate ha piumaggio verde (da cui deriva il nome) con sfumature nere.<br />
Testa e collo invece hanno sfumature grigie. Zampe e becco marroni. La femmina ha colori simili al maschio<br />
ma più tenui.<br />
DOVE – Frequenta zone suburbane e coltivi alberati.<br />
ALIMENTAZIONE – Granivoro, si nutre <strong>di</strong> semi ma anche <strong>di</strong> piccoli invertebrati.<br />
RIPRODUZIONE – La femmina depone 4-8 uova tra aprile e giugno che cova per 2 settimane. I piccoli<br />
abbandonano il nido dopo circa 20 giorni.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare. Protetto in Italia.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
VERDONE<br />
173<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Passeriformes<br />
FAMIGLIA<br />
Fringillidae<br />
GENERE<br />
Carduelis<br />
SPECIE<br />
C. chloris
174
NOME COMUNE<br />
Verzellino<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Serinus serinus<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Uccello <strong>di</strong> piccole <strong>di</strong>mensioni, lunghezza <strong>di</strong> 11-12 cm, apertura alare <strong>di</strong> 20-22 cm e peso <strong>di</strong><br />
12 g. Il maschio presenta un piumaggio colorato con testa e petto gialli con sfumature ver<strong>di</strong> e marroni.<br />
L’addome dal giallo passa al bianco. Becco piccolo e zampe color rosato. Le femmine presentano piumaggio<br />
simile al maschi ma con colorazione meno marcata.<br />
DOVE – Frequenta zone urbane e suburbane.<br />
ALIMENTAZIONE – Granivoro, si nutre <strong>di</strong> semi ma anche <strong>di</strong> piccoli invertebrati.<br />
RIPRODUZIONE – Due covate all’anno. La femmina depone dalla fine <strong>di</strong> aprile 4-5 uova che cova per 10-12<br />
giorni. I piccoli lasciano il nido dopo 2 settimane <strong>di</strong> vita.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare. Protetto in Italia.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
VERZELLINO<br />
175<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Aves<br />
ORDINE<br />
Passeriformes<br />
FAMIGLIA<br />
Fringillidae<br />
GENERE<br />
Serinus<br />
SPECIE<br />
S. serinus
176
PESCI<br />
PISCES<br />
177
NOME COMUNE<br />
Alborella<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Alburnus alburnus<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – L’alborella è un piccolo pesce dalla forma allungata e compressa ai fianchi , testa e occhi<br />
gran<strong>di</strong>, bocca leggermente rivolta verso l'alto. La livrea è grigio-azzurra con riflessi metallici e una linea<br />
gialla orizzontale che corre dalla testa alla coda. La lunghezza massima raggiunge i 15 cm, mentre il peso<br />
arriva sino a 50 gr. E’ presente <strong>di</strong>morfismo sessuale: il maschio ha colori leggermente più accentuati,<br />
mentre la femmina risulta leggermente più gonfia. Specie gregaria.<br />
DOVE - Fontanili, cave rogge. Nel periodo invernale tende a frequentare acque più profonde, ma se non è<br />
possibile si <strong>di</strong>stribuisce lungo tutte le profon<strong>di</strong>tà.<br />
ALIMENTAZIONE – Ha <strong>di</strong>eta onnivora, si ciba <strong>di</strong> insetti e larve ma anche <strong>di</strong> zooplancton e vegetali.<br />
RIPRODUZIONE – La riproduzione avviene fra giugno ed agosto; la femmina depone in più riprese 1500-<br />
2000 uova in acque basse, lungo le rive; le uova, piccole, leggermente adesive si schiudono nel giro <strong>di</strong> una<br />
settimana; la maturità sessuale viene raggiunta intorno al terzo-quarto anno <strong>di</strong> età.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare<br />
RISCHIO MINIMO<br />
ALBORELLA<br />
178<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Actinopterygii<br />
ORDINE<br />
Cyprimiformes<br />
FAMIGLIA<br />
Cyprinidae<br />
GENERE<br />
Alburnus<br />
SPECIE<br />
A. Alburnus
NOME COMUNE<br />
Carassio<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Carassius carassius<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – In con<strong>di</strong>zioni eccezionali raggiunge la lunghezza <strong>di</strong> 50 cm ed il peso <strong>di</strong> 3 Kg. I profili ventrale<br />
e dorsale sono molto arcuati. La livrea è <strong>di</strong> colore bruno verdastra sul dorso e gialla con riflessi metallici sui<br />
fianchi.<br />
DOVE – Zone umide fontanili, cave rogge.<br />
ALIMENTAZIONE – Si nutre preferenzialmente <strong>di</strong> invertebrati, più raramente <strong>di</strong> organismi vegetali.<br />
RIPRODUZIONE – La riproduzione avviene tra maggio e giugno in acque a bassa profon<strong>di</strong>tà e in presenza <strong>di</strong><br />
vegetazione abbondante e substrato <strong>di</strong> sabbia e fango.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare. Specie esotica.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
CARASSIO<br />
179<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Actinopterygii<br />
ORDINE<br />
Cypriniformes<br />
FAMIGLIA<br />
Cyprinidae<br />
GENERE<br />
Carassius<br />
SPECIE<br />
C. carassius
NOME COMUNE<br />
Carpa<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Cyprinus carpio<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – La carpa è un pesce d'acqua dolce <strong>di</strong> lunghezza variabile tra i 30 e i 60 centimetri e peso<br />
solitamente compreso tra i 3 e i 35 chili. La bocca è protrattile ed è munita <strong>di</strong> 4 barbigli corti e carnosi. La<br />
coda è forcuta. La livrea è bruno-verdastra con riflessi bronzei su dorso e fianchi. È un pesce estremamente<br />
longevo e si stima possa arrivare a 100 anni <strong>di</strong> età.<br />
DOVE – Fontanili, cave rogge.<br />
ALIMENTAZIONE – Onnivora, si ciba sia <strong>di</strong> organismi animali come insetti e lombrichi che <strong>di</strong> sostanze<br />
vegetali che trova sul fondo,e <strong>di</strong> qualsiasi tipo <strong>di</strong> detrito organico utilizzando i barbigli che hanno funzione<br />
tattile.<br />
RIPRODUZIONE – La carpa è attiva a partire dalla primavera inoltrata sino ai primi fred<strong>di</strong> dell'autunno;<br />
quando la temperatura scende al <strong>di</strong> sotto dei 10°C la carpa si infossa nella melma in uno stato <strong>di</strong> latenza<br />
che dura per tutta la stagione fredda. Si riproduce in tarda primavera ed inizio estate deponendo circa 2-<br />
300.000 uova che schiudono nel giro <strong>di</strong> una settimana.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
CARPA<br />
180<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Actinopterygii<br />
ORDINE<br />
Cypriniformes<br />
FAMIGLIA<br />
Cyprinidae<br />
GENERE<br />
Cyprinus<br />
SPECIE<br />
C. carpio
NOME COMUNE<br />
Cavedano<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Squalius cephalus<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – È caratterizzato dalla bocca grande e terminale, e dal corpo affusolato. La livrea è uniforme,<br />
grigio-verdastra (più chiara sul ventre), con scaglie bordate delicatamente <strong>di</strong> scuro. Le pinne sono brunogiallastre.<br />
I giovani formano piccoli gruppi, gli adulti hanno abitu<strong>di</strong>ni più solitarie.<br />
DOVE – Fontanili, cave rogge<br />
ALIMENTAZIONE – Gli esemplari giovanili hanno una <strong>di</strong>eta onnivora, così come gli adulti, che però si cibano<br />
anche <strong>di</strong> pesci<br />
RIPRODUZIONE – La riproduzione avviene in tarda primavera (maggio-giugno) vicino a riva su fon<strong>di</strong><br />
ghiaiosi: le uova, gialle e molto piccole (0,7 mm) sono deposte su massi e tronchi sommersi, oppure sul<br />
fondo ghiaioso, e si schiudono entro una settimana.<br />
Lo sviluppo è me<strong>di</strong>amente lento: la maturità sessuale giunge a 3-4 anni nei maschi e a 4-5 anni nelle<br />
femmine.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
CAVEDANO<br />
181<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Actinopterygii<br />
ORDINE<br />
Cypriniformes<br />
FAMIGLIA<br />
Cyprinidae<br />
GENERE<br />
Squalius<br />
SPECIE<br />
S. cephalus
NOME COMUNE<br />
Cobite comune<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Cobitis taenia<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – E' una specie <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensione ridotta (massimo 12 cm). Il corpo è allungato e compresso sui<br />
lati soprattutto nella porzione posteriore. La livrea, molto variabile, è caratterizzata dalla presenza, sullo<br />
sfondo <strong>di</strong> colore bruno-giallo, <strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> file parallele <strong>di</strong> macchie più scure. Sul capo, rivolto verso il<br />
basso per le abitu<strong>di</strong>ni bentoniche <strong>della</strong> specie, sono presenti barbigli appuntiti.<br />
DOVE – Zone umide fontanili, cave rogge.<br />
ALIMENTAZIONE – Si nutre <strong>di</strong> invertebrati che recupera sui fondali e sulla vegetazione.<br />
RIPRODUZIONE – La riproduzione avviene in tarda primavera, tra aprile e maggio. Caratteristici sono i<br />
rigonfiamenti laterali, in prossimità <strong>della</strong> pinna dorsale, che i maschi presentano in coincidenza del periodo<br />
riproduttivo.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
COBITE COMUNE<br />
182<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Actinopterygii<br />
ORDINE<br />
Cypriniformes<br />
FAMIGLIA<br />
Cobitidae<br />
GENERE<br />
Cobitis<br />
SPECIE<br />
C. taenia
NOME COMUNE<br />
Cobite mascherato<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Sabanejewia larvata<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Questa specie, rara nel nostro territorio, raggiunge la lunghezza totale massima <strong>di</strong> 10 cm. Il<br />
corpo è allungato, compresso lateralmente e avente colorazione grigia e bruna. Il capo è maggiormente<br />
compresso in senso laterale. La bocca è provvista <strong>di</strong> barbigli.<br />
DOVE – Zone umide fontanili, cave rogge.<br />
ALIMENTAZIONE – Si nutre <strong>di</strong> macroinvertebrati prevalentemente bentonici.<br />
RIPRODUZIONE – La riproduzione avviene tra maggio e giugno.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
COBITE MASCHERATO<br />
183<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Actinopterygii<br />
ORDINE<br />
Cypriniformes<br />
FAMIGLIA<br />
Cobitidae<br />
GENERE<br />
Sabanejewia<br />
SPECIE<br />
S. larvata
NOME COMUNE<br />
Gambusia<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Gambusia affinis<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – La gambusia è un piccolo pesce che presenta uno spiccato <strong>di</strong>morfismo sessuale. Le<br />
femmine sono <strong>di</strong> maggiori <strong>di</strong>mensioni e possono raggiungere la lunghezza massima <strong>di</strong> 6 cm. Il corpo delle<br />
femmine è piuttosto tozzo; quello dei maschi si presenta leggermente affusolato. La colorazione del corpo<br />
è bruna e grigia, lievemente argentea sul ventre. La bocca è rivolta verso l'alto e mostra la man<strong>di</strong>bola<br />
sporgente. Nella femmina è visibile una macchia nera nei pressi <strong>della</strong> pinna anale che appare più evidente<br />
durante la gravidanza.<br />
DOVE – Zone umide fontanili, cave rogge.<br />
ALIMENTAZIONE – Oltre che <strong>di</strong> larve <strong>di</strong> zanzara si nutre <strong>di</strong> altri invertebrati che cattura sulla superficie<br />
dell'acqua.<br />
RIPRODUZIONE – La gambusia è l'unico pesce delle acque interne italiane ad avere fecondazione interna.<br />
Nel maschio la pinna anale è trasformata in organo copulatore (gonopo<strong>di</strong>o). Questa specie ovovipara può<br />
partorire fino a 100 avannotti per volta. Il periodo riproduttivo inizia in tarda primavera e termina alla fine<br />
dell'estate.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare. Specie esotica, originaria dell’area Sud Orientale degli<br />
Stati Uniti.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
GAMBUSIA<br />
184<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Actinopterygii<br />
ORDINE<br />
Cyprinidontiformes<br />
FAMIGLIA<br />
Poeciliidae<br />
GENERE<br />
Gambusia<br />
SPECIE<br />
G. affinis
NOME COMUNE<br />
Ghiozzo Padano<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Padogobius bonelli<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Il ghiozzo comune è un piccolo pesce bentonico con un colore <strong>di</strong> fondo bruno o<br />
brunoverde; lunghezza massima fino a 10 cm; peso fino 12-15 gr. Caratteristica è inoltre una macchia nera<br />
ben evidente posta all’apice superiore delle pinne pettorali. È una specie spiccatamente territoriale ed ogni<br />
in<strong>di</strong>viduo <strong>di</strong>fende strenuamente il proprio territorio non permettendo l’ingresso dei propri simili; l’unica<br />
eccezione a questa abitu<strong>di</strong>ne si nota soltanto nel periodo riproduttivo. Ha abitu<strong>di</strong>ni essenzialmente<br />
notturne e sedentarie, non si sposta molto, in genere, dal suo territorio. Vive in piccoli branchi che si<br />
spostano assieme alla ricerca <strong>di</strong> cibo.<br />
DOVE – Zone umide fontanili, cave rogge<br />
ALIMENTAZIONE – Si nutre <strong>di</strong> invertebrati bentonici, soprattutto <strong>di</strong> larve<br />
RIPRODUZIONE – Avviene tra maggio e luglio, sotto le pietre dei sottoriva, nei ni<strong>di</strong> pre<strong>di</strong>sposti dai maschi<br />
Ogni maschio accoglie nella sua tana una o più femmine, che depongono le uova in modo da farle aderire<br />
alla volta superiore dei nido, dove rimangono, custo<strong>di</strong>te e ossigenate dal maschio, fino alla schiusa<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
GHIOZZO PADANO<br />
185<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Actinopterygii<br />
ORDINE<br />
Perciformes<br />
FAMIGLIA<br />
Gobiidae<br />
GENERE<br />
Padogobius<br />
SPECIE<br />
P.bonelli
NOME COMUNE<br />
Gobione<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Gobio gobio<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Si tratta <strong>di</strong> un piccolo pesce che raramente supera i 15 cm <strong>di</strong> lunghezza. Il corpo, allungato e<br />
fusiforme, ha colorazione prevalentemente grigia con macchie <strong>di</strong> grandezza variabile <strong>di</strong>sposte in una serie<br />
longitu<strong>di</strong>nale spesso in corrispondenza <strong>della</strong> linea laterale. La bocca, piccola e in posizione infero-me<strong>di</strong>ana,<br />
è provvista <strong>di</strong> un paio <strong>di</strong> barbigli.<br />
DOVE – Zone umide fontanili, cave rogge.<br />
ALIMENTAZIONE – Si nutre <strong>di</strong> macro-invertebtrati e piccoli pesci.<br />
RIPRODUZIONE – La deposizione delle uova avviene tra aprile e giugno in acque limpide, sulla ghiaia<br />
grossolana in prossimità <strong>della</strong> riva.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
GOBIONE<br />
186<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Actinopterygii<br />
ORDINE<br />
Cypriniformes<br />
FAMIGLIA<br />
Cyprinidae<br />
GENERE<br />
Gobio<br />
SPECIE<br />
G. gobio
NOME COMUNE<br />
Luccio<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Esox lucius<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Il luccio è un pesce dal caratteristico muso, appiattito dorso-ventralmente, che ricorda il<br />
becco <strong>di</strong> un'anatra, dotato <strong>di</strong> una bocca molto ampia, fornita <strong>di</strong> robusti denti presenti, oltre che nelle<br />
mascelle, anche sul palato, sulla lingua e sui margini delle branchie. La colorazioni del corpo è molto<br />
variabile e <strong>di</strong>pende dall'ambiente in cui il luccio vive. Può raggiungere 1,30 m <strong>di</strong> lunghezza e superare i 20<br />
kg <strong>di</strong> peso. Gli esemplari <strong>di</strong> maggiori <strong>di</strong>mensioni sono generalmente femmine.<br />
DOVE – Fontanili, cave rogge<br />
ALIMENTAZIONE – È un predatore <strong>di</strong> altri pesci, in assenza <strong>di</strong> prede consone non <strong>di</strong>sdegna rane, piccoli<br />
mammiferi, giovani uccelli acquatici e il cannibalismo. Il luccio svolge inoltre un importante ruolo <strong>di</strong><br />
selezione e controllo nei confronti <strong>di</strong> varie specie ittiche ed è stato ingiustamente considerato per anni<br />
come un pesce dannoso per la sua presunta voracità.<br />
RIPRODUZIONE – La riproduzione ha luogo, a seconda <strong>della</strong> temperatura, da Febbraio ad Aprile; i lucci si<br />
spostano dai luoghi frequentati abitualmente alla ricerca <strong>di</strong> acque poco profonde, calme con abbondante<br />
vegetazione dove la femmina depone (in più riprese) le uova che possono venire fecondate anche da<br />
maschi <strong>di</strong>versi.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
LUCCIO<br />
187<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Actinopterygii<br />
ORDINE<br />
Esociformes<br />
FAMIGLIA<br />
Esocidae<br />
GENERE<br />
Esox<br />
SPECIE<br />
E. lucius
NOME COMUNE<br />
Persico reale<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Perca fluviatilis<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Specie avente lunghezza <strong>di</strong> norma non superiore a 50 cm. Il corpo è <strong>di</strong> forma ovale e<br />
leggermente compresso sui lati. La larghezza tende a <strong>di</strong>minuire in <strong>di</strong>rezione <strong>della</strong> pinna caudale. Il capo,<br />
piuttosto grande, è munito <strong>di</strong> una bocca sviluppata provvista <strong>di</strong> una robusta dentatura. Il dorso e i fianchi<br />
sono verdastri e percorsi da bande <strong>di</strong> colore più scuro perpen<strong>di</strong>colari alla linea laterale.<br />
DOVE – Zone umide fontanili, cave rogge.<br />
ALIMENTAZIONE – Si alimenta <strong>di</strong> invertebrati e piccoli pesci che cattura con grande abilità.<br />
RIPRODUZIONE – La stagione riproduttiva inizia a marzo e si conclude in estate inoltrata. I nastri gelatinosi<br />
che contengono le uova vengono adesi agli ostacoli naturali, rappresentati da vegetazione, pietre, ramaglie<br />
ecc., nelle acque poco profonde delle rive dolcemente degradanti.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
PERSICO REALE<br />
188<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Actinopterygii<br />
ORDINE<br />
Perciformes<br />
FAMIGLIA<br />
Percidae<br />
GENERE<br />
Perca<br />
SPECIE<br />
P. fluviatilis
NOME COMUNE<br />
Persico sole<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Lepomis gibbosus<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Gli in<strong>di</strong>vidui adulti sono lunghi al massimo 20 cm. Il corpo, schiacciato sui lati, ha forma<br />
tondeggiante. La testa e grande e la bocca provvista <strong>di</strong> una dentatura robusta ed efficiente. Il corpo è <strong>di</strong><br />
colore olivastro con macchie irregolari gialle e rosse sui fianchi e striature azzurre ai lati <strong>della</strong> testa e sugli<br />
opercoli. L'opercolo presenta una caratteristica macchia rosso scuro.<br />
DOVE – Zone umide fontanili, cave rogge.<br />
ALIMENTAZIONE – E' un animale molto vorace che si nutre <strong>di</strong> invertebrati, vegetazione e piccoli pesci.<br />
Costituisce una minaccia per molte specie autoctone con le quali entra in competizione alimentare.<br />
RIPRODUZIONE – Le uova, deposte dalla femmina in primavera inoltrata, vengono custo<strong>di</strong>te dal maschio<br />
fino al momento <strong>della</strong> schiusa.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare. Specie esotica, originaria del Nord America.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
PERSICO SOLE<br />
189<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Actinopterygii<br />
ORDINE<br />
Perciformes<br />
FAMIGLIA<br />
Centrarchidae<br />
GENERE<br />
Lepomis<br />
SPECIE<br />
L. gibbosus
NOME COMUNE<br />
Pseudorasbora<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Pseudorasbora parva<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Piccolo pesce <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni non superiori a 10 cm. Il corpo è affusolato e la testa termina a<br />
punta. E' <strong>di</strong> colore grigio sul dorso, con riflessi più metallici sui fianchi; il ventre è generalmente bianco.<br />
DOVE – Zone umide fontanili, cave rogge.<br />
ALIMENTAZIONE – Si nutre <strong>di</strong> larve d'insetto, piccoli pesci e uova <strong>di</strong> pesce.<br />
RIPRODUZIONE – Il periodo riproduttivo <strong>di</strong> questa specie sembra legato alla primavera. I maschi<br />
presentano dei tubercoli nuziali visibili nei pressi degli occhi durante il momento <strong>della</strong> riproduzione.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare. Specie esotica, originaria dell’Asia Orientale. Questa<br />
specie è stata solo recentemente introdotta nelle nostre acque come conseguenza <strong>di</strong> errate pratiche <strong>di</strong><br />
ripopolamento con materiale non sufficientemente controllato.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
PSEUDORASBORA<br />
190<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Actinopterygii<br />
ORDINE<br />
Cypriniformes<br />
FAMIGLIA<br />
Cyprinidae<br />
GENERE<br />
Pseudorasbora<br />
SPECIE<br />
P. parva
NOME COMUNE<br />
Rodeo amaro<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Rhodeus sericeus<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Piccolo pesce <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni non superiori a 10 cm. Il corpo è largo e schiacciato in senso<br />
laterale. E' <strong>di</strong> colore grigio-verde sul dorso, più chiaro sui fianchi; il ventre è generalmente bianco.<br />
DOVE – Zone umide fontanili, cave rogge.<br />
ALIMENTAZIONE – Si nutre <strong>di</strong> invertebrati acquatici.<br />
RIPRODUZIONE – Le uova vengono deposte in primavera. La deposizione sembra essere legata alla<br />
presenza del bivalve del genere che il rodeo amaro utilizzerebbe come nido.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare. Specie esotica, originaria dell’Asia Orientale. Questa<br />
specie è stata solo recentemente introdotta nelle nostre acque come conseguenza <strong>di</strong> errate pratiche <strong>di</strong><br />
ripopolamento con materiale non sufficientemente controllato.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
RODEO AMARO<br />
191<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Actinopterygii<br />
ORDINE<br />
Cypriniformes<br />
FAMIGLIA<br />
Cyprinidae<br />
GENERE<br />
Rhodeus<br />
SPECIE<br />
R. sericeus
NOME COMUNE<br />
Rutilo o Gardon<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Rutilus rutilus<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Il corpo è moderatamente allungato e compresso e tende a svilupparsi in altezza con la<br />
crescita. La morfologia generale è simile a quella del triotto. La colorazione è grigio-argentea e bianca sul<br />
ventre. L’occhio è rossiccio così come pure le pinne ventrali, pettorali e anale. Si tratta <strong>di</strong> una specie <strong>di</strong><br />
taglia me<strong>di</strong>a, il cui accrescimento è assai variabile in funzione delle <strong>di</strong>sponibilità ambientali. Lunghezza<br />
me<strong>di</strong>a <strong>di</strong> circa 40 cm.<br />
DOVE – Zone umide fontanili, cave rogge.<br />
ALIMENTAZIONE – I giovani si cibano prevalentemente <strong>di</strong> crostacei planctonici e materiale vegetale per poi,<br />
con l’avanzare dell’età, integrare la <strong>di</strong>eta con invertebrati <strong>di</strong> fondo, piante acquatiche e insetti volanti.<br />
RIPRODUZIONE – La specie <strong>di</strong>viene sessualmente matura intorno al terzo anno <strong>di</strong> vita. Tra aprile e giugno,<br />
lungo le rive, in acque basse a fondo sassoso, le femmine depongono sino a 500.000 uova ciascuna, che<br />
vengono prontamente fecondate da gruppi <strong>di</strong> maschi, dopo vistosi giochi nuziali.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare. Specie esotica, originaria dell’Europa Centrale e<br />
Settentrionale e dell’Asia.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
RUTILO O GARDON<br />
192<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Actinopterygii<br />
ORDINE<br />
Cypriniformes<br />
FAMIGLIA<br />
Cyprinidae<br />
GENERE<br />
Rutilus<br />
SPECIE<br />
R. rutilus
NOME COMUNE<br />
Scardola<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Scar<strong>di</strong>nius erythrophthalmus<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Questa specie raggiunge la <strong>di</strong>mensione massima <strong>di</strong> 45 cm. Il corpo è ovale e compresso in<br />
senso laterale. La livrea è bruna verdastra, leggermente più scura sul dorso; lateralmente prevalgono i<br />
riflessi argentati. Le pinne sono <strong>di</strong> colore rossastro. Il capo è piuttosto piccolo ma con un grande occhio<br />
dorato; la bocca è in posizione supero-me<strong>di</strong>ana.<br />
DOVE – Zone umide fontanili, cave rogge.<br />
ALIMENTAZIONE – Si nutre <strong>di</strong> vegetazione e <strong>di</strong> invertebrati.<br />
RIPRODUZIONE – Si riproduce a partire da aprile ed occasionalmente fino alla tarda estate.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
SCARDOLA<br />
193<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Actinopterygii<br />
ORDINE<br />
Cypriniformes<br />
FAMIGLIA<br />
Cyprinidae<br />
GENERE<br />
Scar<strong>di</strong>nius<br />
SPECIE<br />
S. erythrophthalmus
NOME COMUNE<br />
Triotto<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Rutilus aula<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Normalmente questa specie raggiunge la lunghezza <strong>di</strong> 15 cm. Il corpo è allungato con i<br />
profili dorso-ventrali piuttosto arcuati. La livrea è <strong>di</strong> colore grigio-verdastro sul dorso e bianca sul ventre. La<br />
testa è piccola e la bocca è situata in posizione me<strong>di</strong>ana.<br />
DOVE – Zone umide fontanili, cave rogge.<br />
ALIMENTAZIONE – Si nutre <strong>di</strong> vegetazione acquatica, <strong>di</strong> invertebrati e <strong>di</strong> piccoli pesci.<br />
RIPRODUZIONE – La deposizione delle uova avviene tra aprile e giugno, raramente si protrae fino a luglio.<br />
Le uova vengono deposte <strong>di</strong> norma in acque basse in presenza <strong>di</strong> vegetazione.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
TRIOTTO<br />
194<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Actinopterygii<br />
ORDINE<br />
Cypriniformes<br />
FAMIGLIA<br />
Cyprinidae<br />
GENERE<br />
Rutilus<br />
SPECIE<br />
R. aula
INVERTEBRATI<br />
INVERTEBRATA<br />
195
INVERTEBRATI<br />
Gli invertebrati rappresentano circa il 95% delle specie animali conosciute. Essi non possiedono una<br />
struttura interna organizzata come quella dei vertebrati (pesci, anfibi, rettili, mammiferi e uccelli) e nello<br />
specifico il termine “invertebrato” in<strong>di</strong>ca la mancanza <strong>di</strong> una colonna vertebrale.<br />
Gli invertebrati più conosciuti sono:<br />
- Poriferi (spugne)<br />
- Cnidari (meduse, polipi, idre, coralli)<br />
- Platelminti (vermi piatti)<br />
- Nemato<strong>di</strong> (vermi cilindrici)<br />
- Anelli<strong>di</strong> (sanguisughe, lombrichi)<br />
- Molluschi (lumache, limacce, chiocciole, gasteropo<strong>di</strong>, bivalvi, cefalopo<strong>di</strong>)<br />
- Artropo<strong>di</strong> (crostacei, gamberi, insetti, ragni, miriapo<strong>di</strong>)<br />
- Echinodermi (ricci <strong>di</strong> mare, stelle marine)<br />
INVERTEBRATI A BUCCINASCO<br />
Qui a Buccinasco, nei <strong>di</strong>versi ambienti che costituiscono il territorio in esame, gli invertebrati rappresentano<br />
appunto il più alto numero <strong>di</strong> specie animali presenti. Data la vastità dell’argomento, i <strong>di</strong>versi “phyla”<br />
saranno trattati nelle e<strong>di</strong>zioni successive. Questa prima e<strong>di</strong>zione vuole essere l’inizio da cui partire per le<br />
ricerche naturalistiche future.<br />
I principali invertebrati che si possono osservare sul nostro Comune sono costituiti da insetti, ragni,<br />
molluschi <strong>di</strong> terra (lumache, chiocciole, limacce) e <strong>di</strong> acqua (gastreopo<strong>di</strong>), crostacei (gamberi).<br />
196
Il capo<br />
Insetto significa <strong>di</strong>viso in sezioni, infatti il corpo degli insetti è formato da tre regioni chiamate anche<br />
metameri: la regione del capo, quella toracica, e quella addominale. Il capo porta due occhi grossi<br />
composti, formati da migliaia <strong>di</strong> unità visive detti ommati<strong>di</strong>. Tra i due occhi composti, in prossimità <strong>della</strong><br />
sommità del capo generalmente sono presenti due ocelli o stimmati che non sono altro che due occhi<br />
semplici. L'apparato boccale è costituito da appen<strong>di</strong>ci mo<strong>di</strong>ficate a seconda <strong>della</strong> loro funzione; l'apparato<br />
boccale è costituito dalle seguenti parti: labbro superiore, man<strong>di</strong>bole, mascelle provviste <strong>di</strong> palpi mascellari<br />
e il labbro inferiore dotato <strong>di</strong> palpi labiali. L'apparato boccale può essere masticatore, lambente,<br />
succhiante, pungente-succhiante, a seconda delle abitu<strong>di</strong>ni alimentari dell'insetto. Un'altra importantissima<br />
funzione è svolta dalle antenne che sono delle appen<strong>di</strong>ci cefaliche le quali assolvono funzioni sensoriali.<br />
Torace<br />
INSETTI<br />
197
Il torace è formato da pro-meso e meta-torace, ognuno <strong>di</strong> questi segmenti porta un paio <strong>di</strong> zampe. Le ali;<br />
quando presenti (due o quattro) sono situate nel secondo e terzo segmento toracico, sono delle strutture<br />
membranose sostenute da venature più o meno rigide e fitte, attraversate per l'intera lunghezza in<br />
prossimità delle venature da vasi linfatici. Le ali a seconda <strong>della</strong> specie possono rimanere <strong>di</strong>stese oppure<br />
piegarsi in riposo. Le ali possono subire svariate mo<strong>di</strong>fiche nei vari or<strong>di</strong>ni; nei Coleotteri sono due elitre che<br />
svolgono essenzialmente funzioni protettive, mentre nei <strong>di</strong>tteri il secondo paio è trasformato in piccole<br />
appen<strong>di</strong>ci chiamate bilancieri che offrono maggiore stabilità nel volo.<br />
Addome<br />
L'addome è sud<strong>di</strong>viso generalmente in un<strong>di</strong>ci segmenti e le appen<strong>di</strong>ci che porta sono spesso connesse con<br />
l'apparato riproduttore, talvolta l'addome porta vere e proprie armi da <strong>di</strong>fesa e offesa; come il pungiglione<br />
degli imenotteri aculeati. Nella parte terminale dell'addome possono essere presenti anche appen<strong>di</strong>ci <strong>di</strong><br />
varia forma e funzione detti cerci, oppure particolari strutture che assolvono la funzione <strong>di</strong> deposizione<br />
delle uova all'interno <strong>di</strong> svariati substrati vivi o morti; tali strutture prendono il nome <strong>di</strong> ovopositore<br />
Apparato <strong>di</strong>gerente<br />
La grande variabilità dei regimi alimentari degli insetti ha determinato un notevole adattamento alle<br />
<strong>di</strong>verse situazioni trofiche e pertanto molte sono le <strong>di</strong>fferenze che si riscontrano nei vari apparati tra Or<strong>di</strong>ni<br />
<strong>di</strong>versi: negli Efemerotteri (insetti la cui vita da adulto è limitata a poche ore)l'intestino ha perso la funzione<br />
<strong>di</strong>gerente per assumere quella <strong>di</strong> organo aereostatico per ampliare le prestazioni <strong>di</strong> volo. I Fillosseri<strong>di</strong><br />
hanno l'ultimo tratto dell'intestino atrofizzato, nei Rincoti Diaspini l'intestino è interrotto e dall'ano esce<br />
solo urina prodotta dai tubi malpighiani che serve anche per la costruzione dello scudetto protettivo. Nei<br />
Cercopi<strong>di</strong> e negli Afrofori<strong>di</strong> gli escrementi vengono gonfiati con aria per proteggere gli sta<strong>di</strong> preimmaginali.<br />
Le termiti usano i loro escrementi come materiale cementante e come cibo. Il canale alimentare è<br />
costituito da tre parti morfologiche ben <strong>di</strong>stinte: stomodeo, mesentero, proctodeo. Lo stomodeo a sua<br />
volta è sud<strong>di</strong>viso in quattro parti: - Faringe: è il primo tratto dell'apparato <strong>di</strong>gerente, è formata<br />
specialmente negli Insetti con apparato succhiante da una muscolatura molto sviluppata che svolge l'azione<br />
<strong>di</strong> pompa aspirante. - Esofago: è un semplice canale che mette in comunicazione la faringe con l'intestino.<br />
Alcune specie <strong>di</strong> Insetti presentano delle <strong>di</strong>latazioni a livello dell'esofago, sono chiamate ingluvie e non<br />
sono altro che delle zone <strong>di</strong> deposito temporaneo del cibo, talvolta nell'ingluvie possono avvenire delle<br />
pre<strong>di</strong>gestione ad opera <strong>di</strong> enzimi salivari. Nelle api è chiamata borsa melaria perché al suo interno viene<br />
prodotto il miele. Nelle formiche assume invece il significato <strong>di</strong> stomaco sociale. - Ventriglio: è l'ultima<br />
sezione dello stomodeo e assume la funzione <strong>di</strong> triturare il cibo, l'azione meccanica viene compiuta grazie<br />
ad una possente muscolatura ed a pliche poste nella parete interna del ventriglio che svolgono un'azione <strong>di</strong><br />
198
macinatura del cibo azionata d continue contrazioni muscolari. Il mesentero svolge nella prima parte<br />
un'azione <strong>di</strong>gestiva, e nell'ultima un'azione assorbente, in certe specie l'azione assorbente è<br />
particolarmente sviluppata grazie ad una serie <strong>di</strong> <strong>di</strong>verticoli che ampliano notevolmente la superficie <strong>di</strong><br />
assorbimento intestinale. Il proctodeo svolge ancora delle piccole azioni <strong>di</strong>gestive e ospita organismi<br />
simbionti che facilitano la <strong>di</strong>gestione, è costituito nelle seguenti parti: - Ileo: rappresenta la prima parte del<br />
proctodeo. - Colon: spesso si trova <strong>di</strong>latato a formare una tasca nella quale avvengono azioni <strong>di</strong>gestive. -<br />
Retto: è la parte terminale del tubo <strong>di</strong>gerente e termina con un'apertura anale, nella quale si trovano delle<br />
papille rettali che hanno la funzione <strong>di</strong> riassorbire l'acqua e sali minerali da feci e urine. Bocca Regimi<br />
<strong>di</strong>etetici degli Insetti Gli Insetti presentano una grande varietà <strong>di</strong> regimi alimentari; fondamentalmente<br />
possono essere <strong>di</strong>stinti in eterofagi, fitofagi e zoofagi. Gli eterofagi si nutrono <strong>di</strong> sostanze sia <strong>di</strong> origine<br />
animale che vegetale, i fitofagi si nutrono <strong>di</strong> sostanze vegetali, pertanto molti <strong>di</strong> essi sono responsabili <strong>di</strong><br />
danni ai raccolti. I fitofagi si <strong>di</strong>vidono in; antofagi, i quali si nutrono <strong>di</strong> fiori, carpofagi: si nutrono <strong>di</strong> frutti,<br />
fillofagi: si nutrono <strong>di</strong> foglie, rizofagi: si nutrono <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>ci, xilofagi: si nutrono <strong>di</strong> legno, glicifagi: si nutrono <strong>di</strong><br />
sostanze zuccherine prodotte dalle piante. Gli zoofagi si nutrono <strong>di</strong> altri animali, alcuni come i necrofagi si<br />
nutrono <strong>di</strong> cadaveri, gli ematofagi si nutrono <strong>di</strong> sangue, gli altri invece si nutrono <strong>di</strong> animali vivi. Per<br />
allotrofia viene inteso il cambio <strong>di</strong> regime <strong>di</strong>etetico durante la vita dell'in<strong>di</strong>viduo.<br />
Digestione<br />
La <strong>di</strong>gestione avviene normalmente all'interno del tubo <strong>di</strong>gerente, dove le cellule dell'epitelio producono<br />
enzimi <strong>di</strong>gestivi, alcune volte però gli enzimi prodotti per la <strong>di</strong>gestione non sono sufficienti per <strong>di</strong>gerire cibi<br />
particolari; è il caso degli xilofagi che per <strong>di</strong>gerire la lignina ricorrono a simbiosi con protozoi e funghi. In<br />
altri casi invece la <strong>di</strong>gestione può avvenire all'esterno, è il caso <strong>di</strong> certi Afi<strong>di</strong>, Ditteri e Culici<strong>di</strong>, i quali<br />
generalmente dotati <strong>di</strong> apparato boccale pungente - succhiante, emettono all'esterno liqui<strong>di</strong> contenenti<br />
enzimi <strong>di</strong>gestivi.<br />
specie <strong>di</strong> Insetti presentano delle <strong>di</strong>latazioni a livello dell'esofago, sono chiamate ingluvie e non sono altro<br />
che delle zone <strong>di</strong> deposito temporaneo del cibo, talvolta nell'ingluvie possono avvenire delle pre<strong>di</strong>gestione<br />
ad opera <strong>di</strong> enzimi salivari. Nelle api è chiamata borsa melaria perché al suo interno viene prodotto il miele.<br />
Nelle formiche assume invece il significato <strong>di</strong> stomaco sociale. - Ventriglio: è l'ultima sezione dello<br />
stomodeo e assume la funzione <strong>di</strong> triturare il cibo, l'azione meccanica viene compiuta grazie ad una<br />
possente muscolatura ed a pliche poste nella parete interna del ventriglio che svolgono un'azione <strong>di</strong><br />
macinatura del cibo azionata d continue contrazioni muscolari. Il mesentero svolge nella prima parte<br />
un'azione <strong>di</strong>gestiva, e nell'ultima un'azione assorbente, in certe specie l'azione assorbente è<br />
particolarmente sviluppata grazie ad una serie <strong>di</strong> <strong>di</strong>verticoli che ampliano notevolmente la superficie <strong>di</strong><br />
assorbimento intestinale. Il proctodeo svolge ancora delle piccole azioni <strong>di</strong>gestive e ospita organismi<br />
simbionti che facilitano la <strong>di</strong>gestione, è costituito nelle seguenti parti: - Ileo: rappresenta la prima parte del<br />
proctodeo. - Colon: spesso si trova <strong>di</strong>latato a formare una tasca nella quale avvengono azioni <strong>di</strong>gestive. -<br />
Retto: è la parte terminale del tubo <strong>di</strong>gerente e termina con un'apertura anale, nella quale si trovano delle<br />
papille rettali che hanno la funzione <strong>di</strong> riassorbire l'acqua e sali minerali da feci e urine. Bocca Regimi<br />
<strong>di</strong>etetici degli Insetti Gli Insetti presentano una grande varietà <strong>di</strong> regimi alimentari; fondamentalmente<br />
possono essere <strong>di</strong>stinti in eterofagi, fitofagi e zoofagi. Gli eterofagi si nutrono <strong>di</strong> sostanze sia <strong>di</strong> origine<br />
animale che vegetale, i fitofagi si nutrono <strong>di</strong> sostanze vegetali, pertanto molti <strong>di</strong> essi sono responsabili <strong>di</strong><br />
danni ai raccolti. I fitofagi si <strong>di</strong>vidono in; antofagi, i quali si nutrono <strong>di</strong> fiori, carpofagi: si nutrono <strong>di</strong> frutti,<br />
fillofagi: si nutrono <strong>di</strong> foglie, rizofagi: si nutrono <strong>di</strong> ra<strong>di</strong>ci, xilofagi: si nutrono <strong>di</strong> legno, glicifagi: si nutrono <strong>di</strong><br />
sostanze zuccherine prodotte dalle piante. Gli zoofagi si nutrono <strong>di</strong> altri animali, alcuni come i necrofagi si<br />
nutrono <strong>di</strong> cadaveri, gli ematofagi si nutrono <strong>di</strong> sangue, gli altri invece si nutrono <strong>di</strong> animali vivi. Per<br />
allotrofia viene inteso il cambio <strong>di</strong> regime <strong>di</strong>etetico durante la vita dell'in<strong>di</strong>viduo.<br />
Apparato circolatorio<br />
199
L'apparato circolatorio degli Insetti è costituito dall'insieme <strong>di</strong> vasi sanguigni e da cavità dette emocele<br />
entro le quali scorre emolinfa. L'apparato vascolare non deve trasportare ossigeno dato che la funzione<br />
respiratoria è totalmente svolta dall'apparato tracheale.L'apparato vascolare è costituito dal vaso dorsale e<br />
da vasi pulsanti accessori, le cui pareti sono formate da tuniche muscolari. Il vaso dorsale è un tubo che<br />
percorre longitu<strong>di</strong>nalmente tutto il corpo dell'Insetto, è chiuso posteriormente, mentre è aperto nel capo. Il<br />
vaso dorsale è costituito da: - Cuore: rappresenta la parte pulsante <strong>di</strong> maggiori <strong>di</strong>mensioni, è costituito da<br />
ventricoliti formati da invaginazioni <strong>della</strong> parete, ogni ventricolite possiede due ostioli che permettono la<br />
fuoriuscita del sangue - Aorta: situata nella regione toracica e nel capo, è poco pulsante e spesso <strong>di</strong>visa in<br />
due rami. - Vasi pulsanti accessori: sono a forma <strong>di</strong> ampolla, posti all'interno o alla base delle appen<strong>di</strong>ci del<br />
corpo: ali, zampe, antenne, la loro funzione è quella <strong>di</strong> coa<strong>di</strong>uvare il movimento dell'emolinfa dentro le<br />
appen<strong>di</strong>ci. Il sistema lacunare è costituito dall'emocele in cui viene riversata l'emolinfa e nel quale sono<br />
immersi tutti gli organi. L'emolinfa possiede le seguenti funzioni: Funzione trofica; contiene sostanze<br />
nutritive per i vari organi, Funzione <strong>di</strong> veicolo per gli ormoni: le sostanze ormonali prodotte dalle varie<br />
ghiandole endocrine vengono trasportate nell'emolinfa. Funzione <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa: contiene gli emociti in grado <strong>di</strong><br />
fagocitare eventuali parassiti. Funzione meccanica: durante la metamorfosi l'azione meccanica<br />
dell'emolinfa viene usata per provocare il ce<strong>di</strong>mento del tegumento.<br />
Apparato respiratorio<br />
200
L'apparato respiratorio è costituito da un insieme <strong>di</strong> tubuli chiamati trachee e tracheole che trasportano<br />
l'ossigeno all'interno del corpo e permettono la <strong>di</strong>ffusione dei gas negli interstizi cellulari. Gli scambi gassosi<br />
avvengono senza trasportatori chimici avviene semplicemente una <strong>di</strong>ffusione per capillarità. L'apparato<br />
respiratorio è formato da una rete( apparato tracheale) <strong>di</strong> tubuli che raggiunge ogni organo e tessuto.<br />
L'apparato tracheale è composto da: stigmi, trachee, tracheole, sacchi aerei. Gli stigmi sono delle aperture<br />
nel tegumento dell'insetto, in certe specie si ha l'assenza <strong>di</strong> stigmi dato che gli scambi gassosi avvengono<br />
per via osmotica attraverso il tegumento.<br />
Al <strong>di</strong> sotto dello stigma si trova un apparato filtrante che ha la funzione <strong>di</strong> trattenere i corpi estranei,<br />
successivamente si trova un apparato <strong>di</strong> chiusura che serve in caso <strong>di</strong> necessità ad isolare completamente<br />
l'insetto dall'ambiente atmosferico, talvolta possono rimanere chiusi anche per giorni, l'ossigeno necessario<br />
viene preso dai sacchi aerei che hanno appunto la funzione <strong>di</strong> riserva gassosa. La respirazione non è<br />
regolata da ritmi respiratori, quando l'insetto è a riposo basta la sola <strong>di</strong>ffusione, un Insetto in attività invece<br />
sfrutta la contrazione muscolare all'interno delle cavità per creare una sorta <strong>di</strong> respirazione passiva<br />
prodotta da continue depressioni provocate dall'azione dei muscoli.<br />
Organi respiratori degli Insetti che vivono in ambienti acquatici: Gli Insetti acquatici sono forniti <strong>di</strong> organi<br />
capaci <strong>di</strong> utilizzare l'ossigeno <strong>di</strong>sciolto nell'acqua, sono organi chiamate branchie formate da estroflessioni<br />
del tegumento. - Branchie tracheali: note come tracheobranchie o pseudobranchie, sono costituite da<br />
tessuti molto sottili che formano lamine dove lo scambio <strong>di</strong> ossigeno tra acqua e trachee avviene in modo<br />
<strong>di</strong>retto. - Branchie sanguigne: sono delle formazioni tubulari che non contengono trachee ma emolinfa. -<br />
Branchie cuticolari: sono invaginazioni derivate dagli stigmi in <strong>di</strong>retta comunicazione con le trachee. -<br />
Branchie fisiche: non sono strutture branchiali ma formazioni <strong>di</strong> peli idrofughi che mantengono un sottile<br />
velo <strong>di</strong> aria tra il corpo dell'Insetto e l'acqua, gli Insetti in questo caso devono fare scorte <strong>di</strong> ossigeno prima<br />
<strong>di</strong> immergersi.<br />
Sistema nervoso<br />
201
Il sistema nervoso centrale ha il compito <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>nare e produrre una risposta a tutti gli stimoli che<br />
provengono all'insetto dall'esterno, è formato da gangli costituiti da ammassi <strong>di</strong> cellule nervose, da ogni<br />
ganglio prendono origine i nervi che vanno ad innervare gli organi interni e le appen<strong>di</strong>ci. Il sistema nervoso<br />
centrale è costituito da: il cervello, il gnatocerebro e la catena ganglionare ventrale. Cerebro Gnatoencefalo<br />
Catena gangliolare ventrale<br />
Il cervello è formato dalla fusione dei primi tre coppie <strong>di</strong> gangli, posto in zona craniale i suoi nervi vanno ad<br />
innervare le antenne, gli occhi e ed il labbro superiore. il cervello si <strong>di</strong>vide in tre parti: protocerebro che è la<br />
parte più voluminosa ed innerva gli organi visivi e talvolta produce ormoni.<br />
Il deutocerebro è la sede dei centri olfattivi e innerva le antenne. Il tritocerebro che possiede il controllo<br />
degli apparati boccali. Il gnatocerebro: è la sede dell'innervamento boccale, è costituito da tre gangli e si<br />
trova ventralmente al cervello. La catena gangliolare ventrale: è formata dalla fusione <strong>di</strong> tre coppie <strong>di</strong> gangli<br />
toracici e dalla fusione delle coppie <strong>di</strong> gangli addominali, posta ventralmente al canale alimentare controlla<br />
il movimento delle zampe, delle ali e dell'apparato genitale. l sistema nervoso sensoriale è formato da tutte<br />
quelle strutture che sono in grado <strong>di</strong> ricevere stimoli dall'ambiente e <strong>di</strong> trasmettere coman<strong>di</strong> ai muscoli. Il<br />
centro <strong>di</strong> ricezione dello stimolo è chiamato sensillo e si <strong>di</strong>fferenzia a secondo del segnale che percepisce:<br />
meccanorecettori, chemiorecettori, fotorecettori, igrorecettori, termorecettori.<br />
I meccanorecettori sono in grado <strong>di</strong> percepire stimoli come tatto, onde sonore, pressione atmosferica e<br />
movimento dell'aria. I chemiorecettori sono in grado <strong>di</strong> ricevere stimoli gustativi e olfattivi, sono<br />
particolarmente abbondanti nelle antenne, nei palpi labiali e mascellari. (la mosca domestica possiede dei<br />
chemiorecettori nel pretarso delle zampe, in questo modo assaggia <strong>di</strong> continuo i materiali sulla quale si è<br />
posata.)<br />
I sensilli igrorecettori sono in grado <strong>di</strong> valutare la concentrazione dell'umi<strong>di</strong>tà atmosferica, generalmente si<br />
trovano nelle antenne. I termorecettori sono ij grado <strong>di</strong> percepire le variazioni <strong>di</strong> temperatura. Sensilli<br />
fotorecettori sono posti negli occelli e negli occhi, reagiscono a ra<strong>di</strong>azioni luminose.<br />
Apparato riproduttivo<br />
La riproduzione avviene attraverso la coniugazione dei due sessi, ma esistono anche casi <strong>di</strong> partenogenesi,<br />
in cui la femmina procrea senza bisogno <strong>della</strong> fecondazione maschile, ma ciò avviene in particolari casi in<br />
cui si ha una spiccata mancanza maschile. gli insetti salvo rare eccezioni sono ovipari.<br />
L'apparato sessuale femminile consta <strong>di</strong> due ovari comunicanti con la vagina attraverso gli ovidotti: il canale<br />
che costituisce la vagina sbocca all'esterno nella vulva. la vagina è spesso munita <strong>di</strong> una tasca copulatrice<br />
dove si raccoglie lo sperma e <strong>di</strong> una spermateca dove si possono conservare anche per molto tempo gli<br />
spermatozoi. Questa proprietà permette a molte femmine <strong>di</strong> molte specie <strong>di</strong> insetti <strong>di</strong> fecondare le proprie<br />
202
uova anche a grande <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> tempo dall'ultimo accoppiamento. L'apparato maschile consta <strong>di</strong> un<br />
organo chitinoso estroflessibile detto pene, nel quale sbocca il canale deferente.<br />
Le uova possono essere deposte separatamente, in gruppi o cementate assieme e ricoperte da sostanze<br />
protettive, o racchiuse in appositi involucri detti ooteche. l'insetto che nasce dalla schiusa dell'uovo è<br />
sprovvisto <strong>di</strong> organi sessuali, ma possiede un efficiente apparato <strong>di</strong>gerente. Esteriormente può assomigliare<br />
più o meno all'adulto o essere completamente <strong>di</strong>verso.<br />
Nel primo caso si <strong>di</strong>ce che c'è una metamorfosi incompleta si chiamano quin<strong>di</strong> insetti eterometaboli, la<br />
metamorfosi incompleta può essere <strong>di</strong> svariate caratteristiche: esistono infatti forme giovanili, che pur<br />
essendo somiglianti all'adulto conducono vita <strong>di</strong>versa in altri ambienti e sono dotati <strong>di</strong> organi speciali.<br />
Abbiamo così l'emimetabolia, le cui larve si <strong>di</strong>cono neani<strong>di</strong>. Se le forme giovanili somigliano in tutto alla<br />
forma adulta, ricalcandone anche i costumi, si <strong>di</strong>ce che sono paurometabili.La metamorfosi è invece<br />
completa quando la larva è assolutamente <strong>di</strong>versa dall'adulto, e una volta raggiunto il suo massimo<br />
sviluppo perde la facoltà <strong>di</strong> nutrirsi e <strong>di</strong> muoversi trasformandosi in ninfa.<br />
L'adulto chiamato anche insetto perfetto sfarfallerà dalla ninfa dopo un certo tempo <strong>di</strong> quiescenza detto<br />
ninfosi, mentre in una metamorfosi incompleta esso sguscerà <strong>di</strong>rettamente dalla larva senza passare<br />
attraverso la forma ninfale immobile. Esiste anche l'ipermetabolia, in cui si assiste al susseguirsi <strong>di</strong> forme<br />
larvali <strong>di</strong>verse tra loro sia per aspetto che per biologia. In tutti i casi la larva uscita dall'uovo subisce delle<br />
mute che le permettono <strong>di</strong> accrescere le proprie <strong>di</strong>mensioni liberandosi dal dermascheletro inestensibile.<br />
Le mute possono variare da 2 sino a 10.<br />
203
NOME COMUNE<br />
Gambero <strong>di</strong> fiume<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
A. pallipes<br />
pallipes<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Particolarmente tozzo e dal carapace robusto, può raggiungere gli 11-12 cm <strong>di</strong> lunghezza e i<br />
90 g <strong>di</strong> peso. La colorazione del corpo è bruno-verdastra sul dorso e sui fianchi. Ventre e arti sono invece<br />
biancastri, caratteristica, questa, che è valsa a questa specie il nome <strong>di</strong> "gambero dai pie<strong>di</strong> bianchi"<br />
I maschi si <strong>di</strong>stinguono dalle femmine per il fatto <strong>di</strong> avere le prime due appen<strong>di</strong>ci dell'addome (dette<br />
pleopo<strong>di</strong>) mo<strong>di</strong>ficate in organi sessuali che, all'atto dell'accoppiamento, si uniscono a formare un unico<br />
organo copulatore. Nella femmina le appen<strong>di</strong>ci dell'addome sono invece tutte uguali. Generalmente inoltre<br />
i maschi sono più gran<strong>di</strong> delle femmine e, a parità <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni corporee, hanno le chele più sviluppate e<br />
l'addome più stretto. Vive nei torrenti e nei rii particolarmente ossigenati. Preferisce i letti ghiaiosi o<br />
sabbiosi ma dotati <strong>di</strong> rive in cui siano presenti anfratti e luoghi sicuri, per potersi nascondere e riposare.<br />
Essendo un organismo stenotermo freddo, pre<strong>di</strong>lige le acque fresche con un optimum vicino ai 15 °C e un<br />
range che si <strong>di</strong>scosti <strong>di</strong> pochi gra<strong>di</strong>, sopportando al massimo la temperatura <strong>di</strong> 23 °C.<br />
È un animale tipicamente notturno.<br />
DOVE – Zone umide (fontanili, cave rogge)<br />
ALIMENTAZIONE – La sua <strong>di</strong>eta è onnivora, comprendendo insetti, lombrichi, molluschi, larve, piccoli pesci,<br />
animali morti, ra<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> piante acquatiche e anche detriti vegetali e animali <strong>di</strong> vario genere.<br />
Esso è particolarmente attivo <strong>di</strong> notte, quando va a caccia delle sue prede camminando sul fondo dei letti<br />
dei torrenti con le chele protese in avanti,<br />
RIPRODUZIONE – L'accoppiamento avviene soprattutto in autunno. La femmina porta sull'addome per 5-6<br />
mesi le uova fecondate (circa un centinaio), prendendosene cura, ventilandole e pulendole continuamente.<br />
In Primavera esse schiudono ma le piccole larve rimangono ancora per qualche tempo aggrappate al corpo<br />
materno. Si <strong>di</strong>mostra particolarmente aggressivo nella <strong>di</strong>fesa del suo territorio e nelle lotte sessuali, come<br />
<strong>di</strong>mostrano le catture <strong>di</strong> esemplari con arti o chele parzialmente o totalmente mutilate.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – In <strong>di</strong>minuzione a causa <strong>di</strong> inquinamento, frammentazione degli habitat e<br />
invasioni biologiche.<br />
MINACCIATO<br />
GAMBERO DI FIUME<br />
204<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Malacostraca<br />
ORDINE<br />
Decapoda<br />
FAMIGLIA<br />
Astacidae<br />
GENERE<br />
Austropotamobius<br />
SPECIE<br />
A. pallipes
NOME COMUNE<br />
Gambero rosso<br />
<strong>della</strong>luisiana<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Procambarus clarkii<br />
MIGRATORIA<br />
STANZIALE<br />
QUANDO<br />
GAMBERO ROSSO DELLA LUISIANA<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
DESCRIZIONE – Si tratta <strong>di</strong> una specie originaria delle palu<strong>di</strong> <strong>della</strong> Louisiana, tra le più allevate al mondo ai<br />
fini alimentari. Il gambero rosso è dotato <strong>di</strong> robuste e sviluppate chele dal bordo interno tagliente e<br />
seghettato, con le quali attacca e produce vistose ferite nei pesci. Le chele vengono anche utilizzate per<br />
scavare profonde tane nel substrato. La livrea è variabile, ma tende comunque al rosso scuro, da cui il<br />
nome <strong>di</strong> gambero rosso. Il <strong>di</strong>morfismo sessuale è evidenziato per il fatto che i maschi hanno i primi due paia<br />
<strong>di</strong> arti addominali mo<strong>di</strong>ficati in organi copulatori. Anche le chele sono più robuste e sviluppate nei maschi.<br />
Si tratta <strong>di</strong> una specie infestante, caratterizzata da una intensa attività fossoria. Scava infatti profonde<br />
gallerie negli argini, nei quali causa ce<strong>di</strong>menti, e sul fondo dei canali asciutti, all’interno delle quali sverna<br />
resistendo a temperature inferiori anche a 0° C. Per contro tollera temperature assai elevate e bassissime<br />
concentrazioni <strong>di</strong> ossigeno <strong>di</strong>sciolto (˂ 2 mg/l). Inoltre sopravvive al prosciugamento dei canali, interrandosi<br />
o trasferendosi altrove, essendo in grado <strong>di</strong> sopravvivere fuor d’acqua per <strong>di</strong>verse ore. Infine attacca la<br />
fauna ittica, pinzando i pesci con le sue robuste chele soprattutto durante il periodo riproduttivo, ed è<br />
portatore sano dell’Afanomicosi o “peste del gambero”, malattia alla quale sono recettivi tutti gli Astaci<strong>di</strong><br />
autoctoni, compreso il gambero <strong>di</strong> fiume (Austopotamobius pallipes).<br />
DOVE – Fontanili, cave rogge<br />
ALIMENTAZIONE – L’alimentazione <strong>di</strong> Procambarus clarkii è onnivora, con prevalenza vegetariana negli<br />
adulti.<br />
RIPRODUZIONE – La riproduzione avviene almeno un paio <strong>di</strong> volte alle nostre latitu<strong>di</strong>ni, con la produzione<br />
<strong>di</strong> un basso numero <strong>di</strong> uova (500 circa), ma con un notevole successo demografico.<br />
STATUS E CONSERVAZIONE – Nulla da segnalare.<br />
RISCHIO MINIMO<br />
205<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
malacostraca<br />
ORDINE<br />
Decapoda<br />
FAMIGLIA<br />
Cambaridae<br />
GENERE<br />
Procambarus<br />
SPECIE<br />
P. clarkii
206
ODONATI<br />
Gli odonati sono insetti la cui lunghezza varia da 20 a 80 mm e con un’apertura alare che può raggiungere<br />
anche i 110 mm. Sono caratterizzati da un addome lungo e sottile e da due occhi gran<strong>di</strong> e composti.<br />
L’or<strong>di</strong>ne degli Odonati si <strong>di</strong>vide in tre sottor<strong>di</strong>ni:<br />
- Anisotteri, le cui ali anteriori e posteriori hanno forme <strong>di</strong>verse<br />
- Zigotteri, con ali anteriori e posteriori simili nella forma<br />
- Anisozigotteri, che presentano ali anteriori e posteriori uguali nella forma (come gli Zigotteri) ma il<br />
cui aspetto ricorda quello degli Anisotteri<br />
Agli Odonati appartengono le libellule e le damigelle. Questi insetti vivono lungo le zone umide come laghi,<br />
stagni, corsi d’acqua, cave, ecc.<br />
Generalmente si spostano molto velocemente e all’estremità dell’addome sono presenti un paio <strong>di</strong> cerci.<br />
Sono insetti predatori e presentano un forte apparato masticatore.<br />
- Pag. 208 – in alto: Orthetrum cancellatum; in basso: Sympetrum pedemontanum<br />
- Pag. 209 – in alto: Sympetrum pedemontanum; in basso: Sympetrum pedemontanum<br />
- Pag. 210 – in alto: Anax imperator; in basso: Sympetrum striolatum<br />
- Pag. 211 – in alto: Crocothemis erythraea; in basso: Orthetrum albistylum<br />
- Pag. 212 – in alto: Crocothemis erythraea; in basso: Onychogomphus forcipatus<br />
- Pag. 213 – in alto: Orthetrum albistylum; in basso: Onychogomphus forcipatus<br />
- Pag. 214 – in alto: Sympetrum striolatum; in basso: Sympetrum striolatum<br />
- Pag. 215 – in alto: Onychogomphus forcipatus; in basso: Orthetrum albistylum<br />
- Pag. 216 – in alto: Calopteryx splendens caprai; in basso: Calopteryx splendens caprai<br />
- Pag. 217 – in alto: Platycnemis pennipes; in basso: Platycnemis pennipes<br />
- Pag. 218 – in alto: Ischnura elegans; in basso: Calopteryx virgo padana<br />
- Pag. 219 – in alto: Calopteryx virgo padana; in basso: Calopteryx splendens caprai<br />
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
LEPIDOTTERI<br />
I lepidotteri costituiscono un vastissimo or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> insetti conosciuti col nome <strong>di</strong> farfalle e falene.<br />
Il termine lepidotteri significa “ali con scaglie”. Il loro ciclo vitale è costituito da 4 fasi, a cui fa parte anche il<br />
processo <strong>della</strong> metamorfosi, <strong>di</strong>stinte in uovo, larva (bruco), pupa (crisalide), adulto (immagine). Le larve<br />
sono fitofaghe e si nutrono prevalentemente <strong>di</strong> foglie e altre parti <strong>di</strong> pianta. Gli adulti, alcuni grazie al loro<br />
apparato boccale a spiritromba, si nutrono soprattutto <strong>di</strong> nettare e liqui<strong>di</strong> zuccherini, ma anche <strong>di</strong> polline,<br />
frutta, urine, escrementi e carcasse in decomposizione.<br />
I lepidotteri si trovano in qualunque habitat sia presente <strong>della</strong> vegetazione.<br />
- Pag. 223 – in alto: Inachis io; in basso: Inachis io<br />
- Pag. 224 – in alto: Iphiclides podalirius; in basso: Iphiclides podalirius<br />
- Pag. 225 – in alto: Iphiclides podalirius; in basso: Lycaena <strong>di</strong>spar<br />
- Pag. 226 – in alto: Lycaena <strong>di</strong>spar; in basso: Polygonia egea<br />
- Pag. 227 – in alto: Pieris brassicae; in basso: Celastrina argiolus<br />
- Pag. 228 – in alto: Satyrium spini; in basso: Lycaena alciphron<br />
- Pag. 229 – in alto: Vanessa atalanta; in basso: Vanessa atalanta<br />
220
221
222
223
224
225
226
227
FLORA<br />
FLORA<br />
228
NOME COMUNE<br />
Acero campestre<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Acer campestre<br />
AUTOCTONA<br />
ALLOCTONA<br />
FIORITURA<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
ACERO CAMPESTRE<br />
DESCRIZIONE: albero o alberello con fogliame deciduo alto fino a 20 m, con chioma globosa, densa, <strong>di</strong><br />
colore verde carico.<br />
TRONCO: eretto, sinuoso, presto ramificato con corteccia brunastra, suberosa, fessurata in placche.<br />
FOGLIE: con lamina spessa, palmata, lobata, con 3 – 5 lobi profon<strong>di</strong>, ottusi non dentati o con un dente per<br />
lobo. Pagina superiore lucida verde scuro, pagina inferiore più chiara.<br />
FIORI: giallo – verdastri in infiorescenze corimbose erette.<br />
FRUTTI: <strong>di</strong>samare dapprima rossastre, poi giallo-brunastre con ali opposte.<br />
NOTE: impiegata come pianta ornamentale e un tempo il suo legno era utilizzato per la costruzione <strong>di</strong><br />
attrezzi.<br />
229<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Magnoliophyta<br />
ORDINE<br />
Sapindales<br />
FAMIGLIA<br />
Aceraceae<br />
GENERE<br />
Acer<br />
SPECIE<br />
Acer<br />
campestre
NOME COMUNE<br />
Ailanto<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Ailanthus altissima<br />
AUTOCTONA<br />
ALLOCTONA<br />
FIORITURA<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
AILANTO<br />
DESCRIZIONE: albero con fogliame deciduo alto fino a 20 – 25 m, con chioma globosa, irregolare, <strong>di</strong> colore<br />
verde chiaro.<br />
TRONCO: eretto, ramificato, pollonifero, con corteccia grigio – brunastra intera ma ruvida.<br />
FOGLIE: imparipennate, formate da foglie secondarie lanceolate con base asimmetrica e margine<br />
grossolanamente seghettato.<br />
FIORI: giallo – verdastri, in pannocchie erette e apicali.<br />
FRUTTI: samare lanceolate, brunastre, in densi grappoli penduli, con seme centrale e ala ritorta, presenti<br />
anche in inverno.<br />
NOTE: nel XIX secolo, a causa <strong>di</strong> una epidemia che colpì il baco da seta, l’ailanto fu introdotto e <strong>di</strong>ffuso per<br />
ricavare la seta da un’altra specie <strong>di</strong> baco (Philosamia cynthia) che si nutre delle sue foglie. I risultati però<br />
furono deludenti perché l’insetto non riuscì ad adattarsi al clima europeo.<br />
230<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Magnoliophyta<br />
ORDINE<br />
Sapindales<br />
FAMIGLIA<br />
Simaroubaceae<br />
GENERE<br />
Ailanthus<br />
SPECIE<br />
Ailanthus<br />
altissima
NOME COMUNE<br />
Betulla<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Betula pendula<br />
AUTOCTONA<br />
ALLOCTONA<br />
FIORITURA<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
BETULLA BIANCA<br />
DESCRIZIONE: albero con fogliame deciduo, alto fino a 30 m, con chioma allungata verde, gialla in autunno.<br />
TRONCO: eretto, slanciato con rami molto lunghi, sottili e ramuli penduli, glabri. Corteccia bianca che si<br />
sfoglia in liste orizzontali e con fen<strong>di</strong>ture nerastre verso la base.<br />
FOGLIE: da triangolari a romboidali con apice acuminato, ver<strong>di</strong> su entrambe le facce con margine<br />
grossolanamente dentato, a sua volta seghettato.<br />
FIORI: infiorescenze unisessuali, le maschili in amenti penduli, <strong>di</strong> colore giallo, quelle femminili ver<strong>di</strong>, sulla<br />
stessa pianta.<br />
FRUTTI: infruttescenze cilindriche, prima erette, poi pendule che a maturazione liberano semi alati.<br />
NOTE: pianta ornamentale, utilizzata per il legname e impiegata anche per consolidare versanti instabili.<br />
231<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Magnoliophyta<br />
ORDINE<br />
Fagales<br />
FAMIGLIA<br />
Betulaceae<br />
GENERE<br />
Betula<br />
SPECIE<br />
Betula<br />
pendula
NOME COMUNE<br />
Biancospino comune<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Crataegus monogyna<br />
AUTOCTONA<br />
ALLOCTONA<br />
FIORITURA<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
BIANCOSPINO COMUNE<br />
DESCRIZIONE: albero o arbusto a fogliame deciduo alto fino a 10 m, con chioma globosa o allungata,<br />
irregolare <strong>di</strong> colore verde intenso.<br />
TRONCO: sinuoso, spesso ramoso dalla base, corteccia compatta <strong>di</strong> colore arancio – brunastro e rami scuri<br />
con spine acute.<br />
FOGLIE: con base più o meno tronca e lamina a contorno ovale, lobi con bor<strong>di</strong> paralleli e 2 – 4 denti<br />
dall’apice con nervature <strong>di</strong>vergenti. Pagina superiore <strong>di</strong> colore verde intenso, pagina inferiore più chiara.<br />
FIORI: in densi corimbi eretti formati da 15 – 20 fiori bianchi con 5 petali e un solo stilo.<br />
FRUTTI: pomi <strong>di</strong> colore rosso intenso, con un solo seme, in densi grappoli.<br />
NOTE: coltivato come pianta ornamentale e conosciuto da lungo tempo per le sue proprietà me<strong>di</strong>cinali.<br />
232<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Magnoliophyta<br />
ORDINE<br />
Rosales<br />
FAMIGLIA<br />
Rosaceae<br />
GENERE<br />
Crataegus<br />
SPECIE<br />
Crataegus<br />
monogyna
NOME COMUNE<br />
Cannuccia <strong>di</strong> palude<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Phragmites australis<br />
AUTOCTONA<br />
ALLOCTONA<br />
FIORITURA<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
CANNUCCIA DI PALUDE<br />
DESCRIZIONE: pianta erbacea perenne, rizomatosa, può raggiungere un’altezza <strong>di</strong> 4 m.<br />
FUSTO: epigeo, culmo, eretto e robusto.<br />
FOGLIE: opposte, ampie e laminari, glabre, <strong>di</strong> colore verde, lineari con presenza <strong>di</strong> peli.<br />
FIORI: infiorescenze (pannocchie) con <strong>di</strong>verse spighette, violacee con peli.<br />
FRUTTI: cariosside dotata <strong>di</strong> gluemette e setole.<br />
NOTE: i culmi sono da sempre stati utilizzati per coprire i tetti.<br />
233<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Liliopsida<br />
ORDINE<br />
Poales<br />
FAMIGLIA<br />
Poaceae<br />
GENERE<br />
Phragmites<br />
SPECIE<br />
Phragmites<br />
australis
NOME COMUNE<br />
Carpino bianco<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Carpinus betulus<br />
AUTOCTONA<br />
ALLOCTONA<br />
FIORITURA<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
CARPINO BIANCO<br />
DESCRIZIONE: albero, qualche volta arbusto, a fogliame deciduo, alto fino a 20 m, con chioma globosa<br />
espansa <strong>di</strong> colore verde lucente.<br />
TRONCO: dritto con rami ascendenti e corteccia grigio – brunastra, liscia, con strisce più chiare che formano<br />
un <strong>di</strong>segno a rete.<br />
FOGLIE: lamina ellittica con base simmetrica ed apice acuto, allargata verso l’apice con nervature<br />
pronunciate ma senza nervature secondarie, margine con doppia dentellatura.<br />
FIORI: infiorescenze maschili in amenti penduli gialli, le femminili più piccole e verdastre; sono portate<br />
separate sulla stessa pianta.<br />
FRUTTI: infruttescenze giallo – verdastre, poi brunastre, pendule, formate da brattee membranose,<br />
trilobate, portanti ognuna una piccola noce.<br />
NOTE: il Carpino bianco è utilizzato come specie <strong>di</strong> interesse forestale ma anche come pianta ornamentale.<br />
Le foglie venivano utilizzate in passato come foraggio.<br />
234<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Magnoliophyta<br />
ORDINE<br />
Fagales<br />
FAMIGLIA<br />
Betulaceae<br />
GENERE<br />
Carpinus<br />
SPECIE<br />
Carpinus<br />
betulus
NOME COMUNE<br />
Carpino nero<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Ostrya carpinifolia<br />
AUTOCTONA<br />
ALLOCTONA<br />
FIORITURA<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
CARPINO NERO<br />
DESCRIZIONE: albero, ma spesso arbusto, con foglie decidue alto fino a 10 m, chioma conica, ovale e spesso<br />
irregolare <strong>di</strong> colore verde vivo.<br />
TRONCO: dritto con corteccia grigio – scura, liscia, tar<strong>di</strong>vamente screpolata<br />
FOGLIE: ovali <strong>di</strong> colore verde chiaro con apice acuminato e margine con doppia dentatura, nervature<br />
evidenti.<br />
FIORI: infiorescenze maschili in amenti gialli penduli in gruppi <strong>di</strong> 2 – 3, quelle femminili in amenti portati<br />
<strong>di</strong>visi sulla stessa pianta.<br />
FRUTTI: infruttescenze ovoidali pendule formate da acheni chiusi in brattee biancastre.<br />
NOTE: pianta resistente anche all’inquinamento, viene utilizzata come ornamentale.<br />
235<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Magnoliophyta<br />
ORDINE<br />
Fagales<br />
FAMIGLIA<br />
Corylaceae<br />
GENERE<br />
Ostrya<br />
SPECIE<br />
Ostrya<br />
carpinifolia
NOME COMUNE<br />
Ciliegio selvatico<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Prunus avium<br />
AUTOCTONA<br />
ALLOCTONA<br />
FIORITURA<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
CILIEGIO SELVATICO<br />
DESCRIZIONE: albero con fogliame deciduo alto fino a 20 m, con chioma ovata, piramidale <strong>di</strong> colore verde<br />
vivo.<br />
TRONCO: eretto, sinuoso, ramificato con corteccia grigio – brunastra.<br />
FOGLIE:generalmente pendule con lamina oblanceolata con margine dentellato. Pagina superiore <strong>di</strong> colore<br />
verde scuro, pagina inferiore più chiara.<br />
FIORI: in ombrelle formate da 6 – 10 fiori bianchi.<br />
FRUTTI: drupe (ciliegie) con lungo picciolo <strong>di</strong> colore variabile dal rosa al rosso al rosso – nerastro.<br />
NOTE: il legno viene impiegato nella costruzione <strong>di</strong> mobili mentre i frutti sono utilizzati in ambito<br />
alimentare.<br />
236<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Magnoliophyta<br />
ORDINE<br />
Rosales<br />
FAMIGLIA<br />
Rosaceae<br />
GENERE<br />
Prunus<br />
SPECIE<br />
Prunus<br />
avium
NOME COMUNE<br />
Farnia<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Quercus robur<br />
AUTOCTONA<br />
ALLOCTONA<br />
FIORITURA<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
FARNIA<br />
DESCRIZIONE: albero con fogliame deciduo alto fino a 30 m con chioma da ovale a globosa spesso<br />
irregolare, molto ampia, <strong>di</strong> colore verde scuro.<br />
TRONCO: dritto, robusto, presto ramoso con ramuli glabri, corteccia grigio – brunastra pallida, fessurata in<br />
piccole placche.<br />
FOGLIE: sub sessili con piccolo picciolo, lamina obovata con apice arrotondato con due orecchiette alla base<br />
e <strong>di</strong>visa in 4 – 6 lobi arrotondati su ciascun lato; pagina superiore <strong>di</strong> colore verde scuro, quella inferiore con<br />
riflesso bluastro.<br />
FIORI: i fiori maschili sono degli amenti giallastri, penduli, i femminili insignificanti, all’ascella delle foglie,<br />
portati sulla stessa pianta.<br />
FRUTTI: ghiande sessili, ovali con cupole che le ricoprono per circa ¼ .<br />
NOTE: tra le essenze forestali più pregiate. Il legno è duro e resistente.<br />
237<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Magnoliophyta<br />
ORDINE<br />
Fagales<br />
FAMIGLIA<br />
Fagaceae<br />
GENERE<br />
Quercus<br />
SPECIE<br />
Quercus<br />
robur
NOME COMUNE<br />
Frassino maggiore<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Fraxinus excelsior<br />
AUTOCTONA<br />
ALLOCTONA<br />
FIORITURA<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
FRASSINO MAGGIORE<br />
DESCRIZIONE: albero con fogliame deciduo alto fino a 20 – 40 m, chioma globosa allungata <strong>di</strong> colore verde<br />
pallido.<br />
TRONCO: eretto, lungo, ramificato in alto, corteccia grigia, liscia e fessurata, spesso ricoperta <strong>di</strong> licheni.<br />
FOGLIE: imparipennate composte da 9 – 13 foglioline lanceolate. Pagina superiore verde scuro, pagina<br />
inferiore grigiastra.<br />
FIORI: unisessuali poco evidenti, senza corolla, con lunghe antere purpuree, presenti sia sulla stessa pianta<br />
che su piante <strong>di</strong>fferenti.<br />
FRUTTI: samare lanceolate in densi grappoli penduli.<br />
NOTE: trova impiego come pianta ornamentale mentre il legno viene utilizzato in falegnameria.<br />
238<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Magnoliophyta<br />
ORDINE<br />
Scrophulariales<br />
FAMIGLIA<br />
Oleaceae<br />
GENERE<br />
Fraxinus<br />
SPECIE<br />
Fraxinus<br />
excelsior
NOME COMUNE<br />
Nocciolo<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Corylus avellana<br />
AUTOCTONA<br />
ALLOCTONA<br />
FIORITURA<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
NOCCIOLO<br />
DESCRIZIONE: alberello spesso arbustivo con fogliame deciduo, alto fino a 6 – 7 m, chioma globosa espansa<br />
<strong>di</strong> colore verde vivo.<br />
TRONCO: eretto, ramificato fin dalla base con corteccia grigio brunastra lucida, solo tar<strong>di</strong>vamente con<br />
solchi longitu<strong>di</strong>nali.<br />
FOGLIE: con lamina da ellittica a rotondeggiante, <strong>di</strong> colore verde chiaro opaco, con base cuoriforme e apice<br />
appuntito; margine con dentellatura doppia.<br />
FIORI: infiorescenze maschili in amenti penduli lunghi <strong>di</strong> colore dapprima rosato, poi giallo che si formano in<br />
autunno; i fiori femminili sono simili a piccole gemme.<br />
FRUTTI: piccole noci, generalmente riunite in ciuffi, avvolte quasi completamente da due brattee fogliari<br />
sfrangiate.<br />
NOTE: coltivato per i frutti. Micorizzazione con tartufo bianco e nero.<br />
239<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Magnoliophyta<br />
ORDINE<br />
Fagales<br />
FAMIGLIA<br />
Betulaceae<br />
GENERE<br />
Corylus<br />
SPECIE<br />
Corylus<br />
avellana
NOME COMUNE<br />
Omo campestre<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Ulmus campestris<br />
AUTOCTONA<br />
ALLOCTONA<br />
FIORITURA<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
OLMO CAMPESTRE<br />
DESCRIZIONE: albero con fogliame deciduo, alto fino a 30 m, con chioma allungata <strong>di</strong> colore verde vivo.<br />
TRONCO: eretto, ramificato, corteccia grigio – brunastra, screpolata.<br />
FOGLIE: lamina con forma da ellittica a obovata, apice acuminato e margine doppiamente dentato, base<br />
asimmetrica con lobo che ricopre il picciolo. Pagina superiore glabra, lucente, pagina inferiore con qualche<br />
ciuffo <strong>di</strong> peli.<br />
FIORI: in piccole ombrelle ascellari sessili, rosse.<br />
FRUTTI: samare ellittiche con margine glabro e seme posto nella metà apicale.<br />
NOTE: piante utilizzate spesso come ornamento e sopportano bene l’inquinamento e la potatura. Il legno<br />
viene utilizzato per la costruzione <strong>di</strong> mobili e compensato.<br />
240<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Magnoliophyta<br />
ORDINE<br />
Rosales<br />
FAMIGLIA<br />
Ulmaceae<br />
GENERE<br />
Ulmus<br />
SPECIE<br />
Ulmus<br />
campestris
NOME COMUNE<br />
ontano bianco<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Alnus incana<br />
AUTOCTONA<br />
ALLOCTONA<br />
FIORITURA<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
ONTANO BIANCO<br />
DESCRIZIONE: albero, ma spesso arbusto, con fogliame deciduo, alto fino a 20 m, con chioma ovale o<br />
piramidale <strong>di</strong> colore verde – grigio.<br />
TRONCO: eretto, presto ramificato e spesso spollonante, con corteccia liscia, grigio chiara – grigio scura.<br />
FOGLIE: ovate, con apice appuntito, <strong>di</strong> colore verde chiaro sulla pagina superiore e grigio argento su quella<br />
inferiore; margine con doppia dentellatura.<br />
FIORI: infiorescenze maschili in amenti penduli, <strong>di</strong> colore giallo – brunastro, quelle femminili in piccoli coni<br />
rossastri, sulla stessa pianta.<br />
FRUTTI: strobili con squame legnose che a maturità liberano semi alati.<br />
NOTE: legno resistente all’acqua. Pianta miglioratrice del terreno in quanto le ra<strong>di</strong>ci sono ricche <strong>di</strong> tubercoli<br />
che ospitano batteri azotofissatori. Le ra<strong>di</strong>ci consolidano le sponde.<br />
241<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Magnoliophyta<br />
ORDINE<br />
Fagales<br />
FAMIGLIA<br />
Betulaceae<br />
GENERE<br />
Alnus<br />
SPECIE<br />
Alnus<br />
incana
NOME COMUNE<br />
Ontano nero<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Alnus glutinosa<br />
AUTOCTONA<br />
ALLOCTONA<br />
FIORITURA<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
ONTANO NERO<br />
DESCRIZIONE: albero con fogliame deciduo alto fino a 20 m, con chioma ovata, piramidale <strong>di</strong> colore prima<br />
verde vivo ma presto verde cupo, con riflesso brunastro.<br />
TRONCO: eretto, spesso ramificato dalla base e corteccia grigio – brunastra, fessurata; rami giovani<br />
vischiosi.<br />
FOGLIE: obovate o rotondeggianti con base cuneata, apice spesso inciso e margine con grossolana<br />
dentatura, verde scuro sulla pagina superiore, dello stesso colore su quella inferiore, vischiose da giovani.<br />
FIORI: infiorescenze maschili in amenti lunghi, giallo – brunastri, le femminili ovali sullo stesso peduncolo<br />
portati sulla stessa pianta.<br />
FRUTTI: strobili ovali legnosi marroni che a maturazione liberano semi alati.<br />
NOTE: legno resistente all’acqua. Pianta miglioratrice del terreno in quanto le ra<strong>di</strong>ci sono ricche <strong>di</strong> tubercoli<br />
che ospitano batteri azotofissatori. Le ra<strong>di</strong>ci consolidano le sponde.<br />
242<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Magnoliophyta<br />
ORDINE<br />
Fagales<br />
FAMIGLIA<br />
Betulaceae<br />
GENERE<br />
Alnus<br />
SPECIE<br />
Alnus<br />
glutinosa
NOME COMUNE<br />
Pioppo bianco<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Populus alba<br />
AUTOCTONA<br />
ALLOCTONA<br />
FIORITURA<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
PIOPPO BIANCO<br />
DESCRIZIONE: albero con fogliame deciduo alto fino a 30 m, chioma globosa espansa <strong>di</strong> colore grigio chiaro<br />
– grigio brillante.<br />
TRONCO: eretto, <strong>di</strong>viso in grosse branche fin dal basso, con corteccia grigio chiaro, biancastra poi nerastra<br />
verso la base; ramuli ricoperti da lanugine biancastra.<br />
FOGLIE: con lamina da lobata a quasi rotonda; pagina superiore <strong>di</strong> colore verde scuro e pagina inferiore<br />
ricoperta da una fitta peluria bianca.<br />
FIORI: pianta <strong>di</strong>oica con amenti maschili pelosi <strong>di</strong> colore grigio – rosato, e amenti femminili più piccoli,<br />
ver<strong>di</strong>, portati su piante separate.<br />
FRUTTI: infruttescenze in amenti lunghi, formati da numerose capsule verdastre che a maturazione liberano<br />
semi cotonosi.<br />
NOTE: impiegato nella cartiera e anche come pianta ornamentale e per alberature stradali.<br />
243<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Magnoliophyta<br />
ORDINE<br />
Salicales<br />
FAMIGLIA<br />
Salicaceae<br />
GENERE<br />
Populus<br />
SPECIE<br />
Populus<br />
alba
NOME COMUNE<br />
Pioppo nero<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Populus nigra<br />
AUTOCTONA<br />
ALLOCTONA<br />
FIORITURA<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
PIOPPO NERO<br />
DESCRIZIONE: albero con fogliame deciduo alto fino a 30 m, con rami ascendenti che formano una chioma<br />
ovale espansa, spesso irregolare, <strong>di</strong> colore verde vivo.<br />
TRONCO: eretto, frequentemente con numerose protuberanze, molto ramificato e <strong>di</strong>viso fin dalla base, con<br />
corteccia grigio – brunastra spessa e solcata.<br />
FOGLIE: da triangolari a romboidali, con apice affusolato e margine seghettato, con lungo picciolo, spesso<br />
ricurvo, <strong>di</strong> colore verde intenso, lucido sulla pagine superiore e più chiaro su quella inferiore.<br />
FIORI: infiorescenze in amenti penduli lunghi <strong>di</strong> colore rosso cupo vivo i maschili, giallo – verdastri i<br />
femminili, portati su piante <strong>di</strong>fferenti.<br />
FRUTTI: infruttescenze in lunghi amenti formati da una collana <strong>di</strong> capsule ovali verdastre che a maturità<br />
liberano semi piumosi.<br />
NOTE: impiegato nella cartiera e anche come pianta ornamentale e per alberature stradali.<br />
244<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Magnoliophyta<br />
ORDINE<br />
Salicales<br />
FAMIGLIA<br />
Salicaceae<br />
GENERE<br />
Populus<br />
SPECIE<br />
Populus<br />
nigra
NOME COMUNE<br />
Robinia pseudoacacia<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Robinia pseudoacacia<br />
AUTOCTONA<br />
ALLOCTONA<br />
FIORITURA<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
ROBINIA PSEUDOACACIA<br />
DESCRIZIONE: albero con fogliame deciduo alto fino a 25 m con chioma globosa <strong>di</strong> colore verde pallido.<br />
TRONCO: eretto, largamente ramificato con rami sinuosi e ramuli fortemente spinosi; corteccia grigio –<br />
brunastra, grossolanamente solcata.<br />
FOGLIE: imparipennate composte da foglioline ovate; stipole trasformate in spine robuste; pagina superiore<br />
lucida <strong>di</strong> colore verde – bluastro, pagina inferiore verde – grigiastra.<br />
FIORI: papilionacei bianchi, in densi racemi penduli con odore e sapore dolciastri.<br />
FRUTTI: bacelli lisci, brunastri che rimangono sulla pianta fino all’inverno.<br />
NOTE: impiegato nel consolidamento dei versanti e fornisce ottimo legno.<br />
245<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Magnoliophyta<br />
ORDINE<br />
Fabales<br />
FAMIGLIA<br />
Fabaceae<br />
GENERE<br />
Robinia<br />
SPECIE<br />
Robinia<br />
pseudoacacia
NOME COMUNE<br />
Rovo comune<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Rubus ulmifolius<br />
AUTOCTONA<br />
ALLOCTONA<br />
FIORITURA<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
ROVO COMUNE<br />
DESCRIZIONE: pianta arbustiva perenne, semicaducifoglia. Può raggiungere un’altezza <strong>di</strong> 3 m.<br />
FUSTO: legnoso, <strong>di</strong> colore rossastro e dotato <strong>di</strong> aculei.<br />
FOGLIE: imparipennate, costituite da 3 – 5 foglie con margine seghettato <strong>di</strong> colore verde scuro, acuminate.<br />
La pagina superiore è glabra mentre quella inferiore presenta peli bianchi.<br />
FIORI: bianchi o rosa, composti da 5 petali e 5 sepali. Sono raggruppati in racemi a formare infiorescenze <strong>di</strong><br />
forma oblunga o piramidale.<br />
FRUTTI: composti da piccole drupe, all’inizio ver<strong>di</strong>, poi rosse e nere a maturità (more). Il frutto è maturo tra<br />
luglio e settembre.<br />
NOTE: utilizzato per delimitare proprietà e terreni, per ricavarne miele, come corridoi ecologici per la fauna,<br />
i frutti sono impiegati in ambito alimentare.<br />
246<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Magnoliophyta<br />
ORDINE<br />
Rosales<br />
FAMIGLIA<br />
Rosaceae<br />
GENERE<br />
Rubus<br />
SPECIE<br />
Rubus<br />
ulmifolius
NOME COMUNE<br />
Salice bianco<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Salix alba<br />
AUTOCTONA<br />
ALLOCTONA<br />
FIORITURA<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
SALICE BIANCO<br />
DESCRIZIONE: albero con fogliame deciduo, alto fino a 20 m con chioma globosa.<br />
TRONCO: dritto, ramificato con rami <strong>di</strong>retti verso l’alto. La corteccia è grigio – brunastra, solcata.<br />
FOGLIE: strettamente lanceolate, affusolate alla base e acuminate all’apice con margine seghettato. Pagina<br />
superiore <strong>di</strong> colore verde con peli argentati e pagina inferiore con fitta peluria bianca.<br />
FIORI: pianta <strong>di</strong>oica con infiorescenze in amenti. Quelli maschili sono gialli, quelli femminili ver<strong>di</strong>, portati su<br />
piante <strong>di</strong>verse.<br />
NOTE: <strong>di</strong>ffusamente coltivato lungo le zone umide. Pianta molto resistente e il legno viene utilizzato per<br />
ricavarne vimini.<br />
247<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Magnoliophyta<br />
ORDINE<br />
Malpighiales<br />
FAMIGLIA<br />
Salicaceae<br />
GENERE<br />
Salix<br />
SPECIE<br />
Salix<br />
alba
NOME COMUNE<br />
Tiglio<br />
NOME SCIENTIFICO<br />
Tilia cordata<br />
AUTOCTONA<br />
ALLOCTONA<br />
FIORITURA<br />
G F M A M G<br />
L A S O N D<br />
TIGLIO<br />
DESCRIZIONE: albero con fogliame deciduo. Raggiunge un’altezza <strong>di</strong> 20 – 30 m.<br />
TRONCO: robusto, ramificato con rami ascendenti, corteccia grigio scuro.<br />
FOGLIE: picciolo glabro, base cordata, asimmetrica, apice acuminato e margine seghettato. Pagina<br />
superiore verde, lucida, quella inferiore glauca.<br />
FIORI: infiorescenze in corimbi non penduli formati da fiori bianchi.<br />
FRUTTI: ovali con pericarpo leggero e fragile.<br />
NOTE: il legno viene utilizzato per le sculture mentre i fiori, ricchi <strong>di</strong> oli essenziali, sono impiegati per<br />
preparare infusi.<br />
248<br />
CLASSIFICAZIONE<br />
CLASSE<br />
Magnoliophyta<br />
ORDINE<br />
Malvales<br />
FAMIGLIA<br />
Tiliaceae<br />
GENERE<br />
Tilia<br />
SPECIE<br />
Tilia<br />
cordata
CHECKLIST<br />
Qui <strong>di</strong> seguito viene riportata una lista in cui sono elencate le specie (per alcuni organismi invece solo gli<br />
or<strong>di</strong>ni) censite fino ad oggi.<br />
CLASSE UCCELLI ANFIBI RETTILI MAMMIFERI PESCI ARTROPODI MOLLUSCHI MALACOSTRACA PIANTE<br />
Numero<br />
<strong>di</strong> specie<br />
70 5 9 14 17 49 2 2 86<br />
Totale <strong>di</strong> specie osservate e identificate negli anni 2010/2011: 254<br />
249
NOME COMUNE NOME SCIENTIFICO Classe<br />
ANIMALI (FAUNA)<br />
ANFIBI<br />
raganella Hyla arborea Amphibia<br />
rana verde comune Rana esculenta Amphibia<br />
rospo comune Bufo bufo Amphibia<br />
tritone crestato Triturus cristatus Amphibia<br />
tritone puntinato Lissotriton vulgaris Amphibia<br />
INVERTEBRATI<br />
tisanuri Insecta<br />
efemerotteri Insecta<br />
odonati Crocothemis erythraea Insecta<br />
odonati Orthetrum albistylum Insecta<br />
odonati Orthetrum coerulescens Insecta<br />
odonati Calopteryx splendens caprai Insecta<br />
odonati Calopteryx virgo padana Insecta<br />
odonati Platycnemis pennipes Insecta<br />
odonati Onychogomphus forcipatus Insecta<br />
odonati Sympetrum pedemontanum Insecta<br />
odonati Sympetrum striolatum Insecta<br />
odonati Orthetrum cancellatum Insecta<br />
odonati Ischnura elegans Insecta<br />
odonati Anax imperator Insecta<br />
blattoidei Insecta<br />
mantoidei Insecta<br />
isotteri Insecta<br />
zoratteri Insecta<br />
plecotteri Insecta<br />
embiotteri Insecta<br />
grilloblattoidei Insecta<br />
dermatteri Insecta<br />
fasmi<strong>di</strong> Insecta<br />
ortotteri Insecta<br />
psocotteri Insecta<br />
mallofagi Insecta<br />
anopluri Insecta<br />
tisanotteri Insecta<br />
rincoti Insecta<br />
neurotteri Insecta<br />
mecotteri Insecta<br />
tricotteri Insecta<br />
lepidotteri Inachis io Insecta<br />
lepidotteri Iphiclides podalirius Insecta<br />
lepidotteri Vanessa atalanta Insecta<br />
lepidotteri Bombice del salice Leucoma salicis Insecta<br />
lepidotteri Cavolaia Pieris brassicae Insecta<br />
lepidotteri Sfinge del galio Macroglossum stellatarum Insecta<br />
lepidotteri Vanessa del cardo Vanessa cardui Insecta<br />
250
<strong>di</strong>tteri Insecta<br />
sifonatteri Insecta<br />
coleotteri Insecta<br />
strepsitteri Insecta<br />
imenotteri Insecta<br />
Molluschi Mollusca Gasteropoda<br />
Molluschi Mollusca Bivalvia<br />
gambero <strong>di</strong> fiume Austropotamobius pallipes Malacostraca<br />
gambero rosso <strong>della</strong> Louisiana Procambarus clarkii Malacostraca<br />
MAMMIFERI<br />
nutria Myocastor coypus Mammalia<br />
arvicola terrestre Arvicola terrestris Mammalia<br />
coniglio selvatico Oryctolagus cuniculus Mammalia<br />
faina Martes foina Mammalia<br />
lepre Lepus europaeus Mammalia<br />
moscar<strong>di</strong>no Muscar<strong>di</strong>nus avellanarius Mammalia<br />
pipistrello Chiroptera Mammalia<br />
ratto Rattus norvegicus Mammalia<br />
riccio Erinaceus europaeus Mammalia<br />
silvilago Sylvilagus floridanus Mammalia<br />
talpa Talpa europaea Mammalia<br />
tasso Meles meles Mammalia<br />
topolino delle risaie Micromys minutus Mammalia<br />
volpe Vulpes vulpes Mammalia<br />
PESCI<br />
alborella Alburnus alburnus Actinopterygii<br />
carassio Carassius carassius Actinopterygii<br />
carpa Cyprinus carpio Actinopterygii<br />
cavedano Leuciscus cephalus Actinopterygii<br />
cobite comune Cobitis taenia Actinopterygii<br />
cobite mascherato Sabanejewia larvata Actinopterygii<br />
gambusia Gambusia affinis Actinopterygii<br />
ghiozzo padano Padogobius bonelli Actinopterygii<br />
gobione Gobio gobio Actinopterygii<br />
luccio Esox lucius Actinopterygii<br />
persico reale Perca fluviatilis Actinopterygii<br />
persico sole Lepomis gibbosus Actinopterygii<br />
pseudorasbora Pseudorasbora parva Actinopterygii<br />
rodeo amaro Rhodeus sericeus Actinopterygii<br />
rutilo o gardon Rutilus rutilus<br />
Scar<strong>di</strong>nius<br />
Actinopterygii<br />
scardola<br />
erythrophthalmus Actinopterygii<br />
triotto Rutilus aula Actinopterygii<br />
RETTILI<br />
biacco Hierophis viri<strong>di</strong>flavus Reptilia<br />
colubro europeo Coronella austriaca Reptilia<br />
251
lucertola <strong>di</strong> campagna Podarcis sicula Reptilia<br />
lucertola muraiola Podarcis muralis Reptilia<br />
natrice Natrix natrix Reptilia<br />
orbettino Anguis fragilis Reptilia<br />
ramarro Lacerta viri<strong>di</strong>s Reptilia<br />
Tartaruga dalle orecchie gialle Trachemys scripta elegans Reptilia<br />
Tartaruga dalle orecchie rosse Trachemys scripta scripta Reptilia<br />
UCCELLI<br />
airone bianco maggiore Casmero<strong>di</strong>us albus Aves<br />
airone cenerino Ardea cinerea Aves<br />
airone guardabuoi Bubulcus ibis Aves<br />
airone rosso Ardea purpurea Aves<br />
allodola Alauda arvensis Aves<br />
alzavola Anas crecca Aves<br />
anatra carolina Aix sponsa Aves<br />
averla piccola Lanius collurio Aves<br />
balestruccio Delichon urbica Aves<br />
balia nera Ficedula hypoleuca Aves<br />
ballerina bianca Motacilla alba Aves<br />
ballerina gialla Motacilla cinerea Aves<br />
capinera Sylvia atricapilla Aves<br />
cardellino Carduelis carduelis Aves<br />
cicogna biancha Ciconia ciconia Aves<br />
cinciallegra Parus maior Aves<br />
cinciarella Parus caeruleus Aves<br />
co<strong>di</strong>bugnolo Aegithalos caudatus Aves<br />
co<strong>di</strong>rosso Phoenicurus phoenicurus Aves<br />
co<strong>di</strong>rosso spazzacamino Phoenicurus ochruros Aves<br />
colombaccio Columba palumbus Aves<br />
cormorano Phalacrocorax carbo Aves<br />
cornacchia grigia Corvus corone cornix Aves<br />
cuculo Cuculus canorus Aves<br />
fagiano comune Phasianus colchicus Aves<br />
folaga Fulica atra Aves<br />
fringuello Fringilla coelebs Aves<br />
frullino Lymnocryptes minimus Aves<br />
gabbiano comune Larus ri<strong>di</strong>bundus Aves<br />
gallinella d'acqua Gallinula chloropus Aves<br />
garzetta Egretta garzetta Aves<br />
gazza Pica pica Aves<br />
germano reale Anas platyrhynchos Aves<br />
gheppio Falco tinnunculus Aves<br />
gufo comune Asio otus Aves<br />
lodolaio Falco subbuteo Aves<br />
lucherino Carduelis spinus Aves<br />
luì piccolo Phylloscopus collybita Aves<br />
luì verde Phylloscopus sibilatrix Aves<br />
martin pescatore Alcedo atthis Aves<br />
merlo Turdus merula Aves<br />
nibbio bruno Milvus migrans Aves<br />
252
nitticora Nycticorax nycticorax Aves<br />
oca cignoide Anser cygnoides Aves<br />
passera d'Italia Passer italiae Aves<br />
passera mattugia Passer montanus Aves<br />
pavoncella Vanellus vanellus Aves<br />
pettirosso Erithacus rubecula Aves<br />
picchio rosso maggiore Dendrocopos major Aves<br />
picchio verde Picus viri<strong>di</strong>s Aves<br />
piccione selvatico Columba livia Aves<br />
pigliamosche Muscicapa striata Aves<br />
piro piro piccolo Actitis hypoleucos Aves<br />
poiana Buteo buteo Aves<br />
ron<strong>di</strong>ne Hirundo rustica Aves<br />
rondone Apus apus Aves<br />
scricciolo Troglodytes troglodytes Aves<br />
sgarza ciuffetto Ardeola ralloides Aves<br />
sparviere Accipiter nisus Aves<br />
stiaccino Saxicola rubetra Aves<br />
storno Sturnus vulgaris Aves<br />
svasso maggiore Po<strong>di</strong>ceps cristatus Aves<br />
topino Riparia riparia Aves<br />
torcicollo Jynx torquilla Aves<br />
tortora dal collare Streptopelia decaocto Aves<br />
tuffetto Tachybaptus ruficollis Aves<br />
upupa Upupa epops Aves<br />
usignolo <strong>di</strong> fiume Cettia cetti Aves<br />
verdone Carduelis chloris Aves<br />
verzellino Serinus serinus Aves<br />
VEGETAZIONE (FLORA)<br />
abete Abies alba Pinopsida<br />
acero campestre Acer campestre Magnoliopsida<br />
acetosa Rumex acetosa Magnoliopsida<br />
acetosa minore Rumex acetosella Magnoliopsida<br />
agrimonia comune Agrimonia eupatoria Magnoliopsida<br />
ailanto Ailanthus altissima Magnoliopsida<br />
alliaria Alliaria petiolata Magnoliopsida<br />
aristolochia clematide Aristolochia clematitis Magnoliopsida<br />
aspraggine comune Picris hieradoides Magnoliopsida<br />
assenzio selvatico Artemisia vulgaris Magnoliopsida<br />
bardana maggiore Arctium lappa Magnoliopsida<br />
biancospino comune Crataegus monogyna Magnoliopsida<br />
brugo Calluna vulgaris Magnoliopsida<br />
camomilla bastarda Anthemis arvensis Magnoliopsida<br />
cannuccia <strong>di</strong> palude Phragmites australis Liliopsida<br />
cardo lanoso Cirsium eriophorum Magnoliopsida<br />
cardo rosso Carduus nutans Magnoliopsida<br />
carice spon<strong>di</strong>cola Carex elata Liliopsida<br />
carota selvatica Daucus carota Magnoliopsida<br />
carpino bianco Carpinus betulus Magnoliopsida<br />
carpino nero Ostrya carpinifolia Magnoliopsida<br />
253
centochio dei campi Anagallis arvensis Magnoliopsida<br />
cerretta comune Serratula tinctoria Magnoliopsida<br />
ciliegio selvatico Prunus avium Magnoliopsida<br />
cipollaccio col fiocco Leopol<strong>di</strong>a comosa Liliopsida<br />
consolida maggiore Symphytum officinale Magnoliopsida<br />
cremesina Phytolacca americana Magnoliopsida<br />
crescione Veronica beccabunga Magnoliopsida<br />
crespino Berberis vulgaris Magnoliopsida<br />
dente <strong>di</strong> leone comune Leontodon hispidus Magnoliopsida<br />
enula baccherina Inula conyzae Magnoliopsida<br />
erba cimicina Geranium robertianum Magnoliopsida<br />
falsa ortica bianca Lamium album Magnoliopsida<br />
falsa ortica purpurea Lamium purpureum Magnoliopsida<br />
farnia Quercus robur Magnoliopsida<br />
forasacco rosso Bromus sterilis Liliopsida<br />
frangola Frangula alnus Magnoliopsida<br />
frassino maggiore Fraxinus excelsior Magnoliopsida<br />
issopo Hyssopus officinalis Magnoliopsida<br />
lenticchia d'acqua Lemna minor Liliopsida<br />
linaiola Thesium linophyllon Magnoliopsida<br />
malva selvatica Malva sylvestris Magnoliopsida<br />
mercorella Mercurialis annua Magnoliopsida<br />
millefoglio d'acqua ascellare Myriophyllum verticillatum Magnoliopsida<br />
muschini Muscari botryoides Liliopsida<br />
nocciolo Corylus avellana Magnoliopsida<br />
nontiscordar<strong>di</strong>mè delle palu<strong>di</strong> Myosotis scorpioides Magnoliopsida<br />
olmo campestre Ulmus campestris Magnoliopsida<br />
ontano nero Alnus glutinosa Magnoliopsida<br />
orniello Fraxinus ornus Magnoliopsida<br />
ortica comune Urtica <strong>di</strong>oica Magnoliopsida<br />
papavero Papaver rhoeas Magnoliopsida<br />
pepe d'acqua Polygonum hydropiper Magnoliopsida<br />
pervinca minore Vinca minor Magnoliopsida<br />
pioppo bianco Populus alba Magnoliopsida<br />
pioppo nero Populus nigra Magnoliopsida<br />
poligono minore Polygonum minus Magnoliopsida<br />
poligono mite Polygonum mite Magnoliopsida<br />
poligono persicaria Polygonum lapathifolium Magnoliopsida<br />
primula Primula vulgaris Magnoliopsida<br />
prugnolo Prunus spinosa Magnoliopsida<br />
prugnolo tar<strong>di</strong>vo Prunus serotina Magnoliopsida<br />
quercia Quercus spp. Magnoliopsida<br />
ranuncolo comune Ranunculus acris Magnoliopsida<br />
robinia Robinia pseudoacacia Magnoliopsida<br />
rosa canina Rosa canina Magnoliopsida<br />
rovo bluastro Rubus caesius Magnoliopsida<br />
rovo comune Rubus ulmifolius Magnoliopsida<br />
salcerella Lythrum salicaria Magnoliopsida<br />
salice bianco Salix alba Magnoliopsida<br />
salice fragile Salix fragilis Magnoliopsida<br />
salice ripariolo Salix eleagnos Magnoliopsida<br />
254
sambuco Sambucus nigra Magnoliopsida<br />
sanguinello Cornus sanguinea Magnoliopsida<br />
saponaria Saponaria officinalis Magnoliopsida<br />
silene bianca Silene alba Magnoliopsida<br />
tarassaco Taraxacum officinale Magnoliopsida<br />
tiglio Tilia cordata Magnoliopsida<br />
trifoglio rosso Trifolium incarnatum Magnoliopsida<br />
veccia montanina Vicia cracca Magnoliopsida<br />
verbasco nero Verbascum nigrum Magnoliopsida<br />
verga d'oro maggiore Solidago gigantea Magnoliopsida<br />
veronica comune Veronica chamaedrys Magnoliopsida<br />
viola del pensiero Viola tricolor Magnoliopsida<br />
viola mammola Viola odorata Magnoliopsida<br />
viperina azzurra Echium vulgare Magnoliopsida<br />
255
GENERALITA’<br />
Nome e Cognome:<br />
CONTATTI<br />
Tel./cell.:<br />
E-mail:<br />
Altro:<br />
DOVE E QUANDO<br />
SCHEDA DI AVVISTAMENTO FAUNISTICO<br />
Luogo dell’avvistamento (Comune e Provincia):<br />
Tipologia <strong>della</strong> zona (rurale, bosco, parco, giar<strong>di</strong>no, siepi, coltivato, incolto, zona umida, ecc.):<br />
Data (gg/mm/aaaa): Ora:<br />
Fase <strong>della</strong> giornata: mattino pomeriggio sera notte<br />
OSSERVAZIONE<br />
Tipo <strong>di</strong> animale: invertebrato vertebrato<br />
Classificazione: molluschi insetti pesci anfibi rettili mammiferi uccelli<br />
Descrizione/caratteristiche:<br />
NOTE:<br />
256
Elenco alfabetico delle specie<br />
abete Pinopsida<br />
acero campestre Magnoliopsida<br />
acetosa Magnoliopsida<br />
acetosa minore Magnoliopsida<br />
agrimonia comune Magnoliopsida<br />
ailanto Magnoliopsida<br />
airone bianco maggiore Aves<br />
airone cenerino Aves<br />
airone guardabuoi Aves<br />
airone rosso Aves<br />
alborella Actinopterygii<br />
alliaria Magnoliopsida<br />
allodola Aves<br />
alzavola Aves<br />
anatra carolina Aves<br />
anopluri Insecta<br />
aristolochia clematide Magnoliopsida<br />
arvicola terrestre Mammalia<br />
aspraggine comune Magnoliopsida<br />
assenzio selvatico Magnoliopsida<br />
averla piccola Aves<br />
balestruccio Aves<br />
balia nera Aves<br />
ballerina bianca Aves<br />
ballerina gialla Aves<br />
bardana maggiore Magnoliopsida<br />
biacco Reptilia<br />
biancospino comune Magnoliopsida<br />
blattoidei Insecta<br />
Bombice del salice Insecta<br />
brugo Magnoliopsida<br />
camomilla bastarda Magnoliopsida<br />
cannuccia <strong>di</strong> palude Liliopsida<br />
capinera Aves<br />
carassio Actinopterygii<br />
cardellino Aves<br />
cardo lanoso Magnoliopsida<br />
cardo rosso Magnoliopsida<br />
carice spon<strong>di</strong>cola Liliopsida<br />
carota selvatica Magnoliopsida<br />
carpa Actinopterygii<br />
carpino bianco Magnoliopsida<br />
carpino nero Magnoliopsida<br />
cavedano Actinopterygii<br />
Cavolaia Insecta<br />
centochio dei campi Magnoliopsida<br />
cerretta comune Magnoliopsida<br />
cicogna biancha Aves<br />
257
ciliegio selvatico Magnoliopsida<br />
cinciallegra Aves<br />
cinciarella Aves<br />
cipollaccio col fiocco Liliopsida<br />
cobite comune Actinopterygii<br />
cobite mascherato Actinopterygii<br />
co<strong>di</strong>bugnolo Aves<br />
co<strong>di</strong>rosso Aves<br />
co<strong>di</strong>rosso spazzacamino Aves<br />
coleotteri Insecta<br />
colombaccio Aves<br />
colubro europeo Reptilia<br />
coniglio selvatico Mammalia<br />
consolida maggiore Magnoliopsida<br />
cormorano Aves<br />
cornacchia grigia Aves<br />
cremesina Magnoliopsida<br />
crescione Magnoliopsida<br />
crespino Magnoliopsida<br />
cuculo Aves<br />
dente <strong>di</strong> leone comune Magnoliopsida<br />
dermatteri Insecta<br />
<strong>di</strong>tteri Insecta<br />
efemerotteri Insecta<br />
embiotteri Insecta<br />
enula baccherina Magnoliopsida<br />
erba cimicina Magnoliopsida<br />
fagiano comune Aves<br />
faina Mammalia<br />
falsa ortica bianca Magnoliopsida<br />
falsa ortica purpurea Magnoliopsida<br />
farnia Magnoliopsida<br />
fasmi<strong>di</strong> Insecta<br />
folaga Aves<br />
forasacco rosso Liliopsida<br />
frangola Magnoliopsida<br />
frassino maggiore Magnoliopsida<br />
fringuello Aves<br />
frullino Aves<br />
gabbiano comune Aves<br />
gallinella d'acqua Aves<br />
gambero <strong>di</strong> fiume Malacostraca<br />
gambero rosso <strong>della</strong> Louisiana Malacostraca<br />
gambusia Actinopterygii<br />
garzetta Aves<br />
gazza Aves<br />
germano reale Aves<br />
gheppio Aves<br />
ghiozzo padano Actinopterygii<br />
gobione Actinopterygii<br />
258
grillo Insecta<br />
gufo comune Aves<br />
imenotteri Insecta<br />
isotteri Insecta<br />
issopo Magnoliopsida<br />
lenticchia d'acqua Liliopsida<br />
lepidotteri Insecta<br />
lepre Mammalia<br />
linaiola Magnoliopsida<br />
lodolaio Aves<br />
luccio Actinopterygii<br />
lucertola <strong>di</strong> campagna Reptilia<br />
lucertola muraiola Reptilia<br />
lucherino Aves<br />
luì piccolo Aves<br />
luì verde Aves<br />
mallofagi Insecta<br />
malva selvatica Magnoliopsida<br />
mantoidei Insecta<br />
martin pescatore Aves<br />
mecotteri Insecta<br />
mercorella Magnoliopsida<br />
merlo Aves<br />
millefoglio d'acqua ascellare Magnoliopsida<br />
Molluschi Gasteropoda<br />
Molluschi Bivalvia<br />
moscar<strong>di</strong>no Mammalia<br />
muschini Liliopsida<br />
natrice Reptilia<br />
neurotteri Insecta<br />
nibbio bruno Aves<br />
nitticora Aves<br />
nocciolo Magnoliopsida<br />
nontiscordar<strong>di</strong>mè delle palu<strong>di</strong> Magnoliopsida<br />
nutria Mammalia<br />
oca cignoide Aves<br />
odonati Insecta<br />
olmo campestre Magnoliopsida<br />
ontano nero Magnoliopsida<br />
orbettino Reptilia<br />
orniello Magnoliopsida<br />
ortica comune Magnoliopsida<br />
ortotteri Insecta<br />
papavero Magnoliopsida<br />
passera d'Italia Aves<br />
passera mattugia Aves<br />
pavoncella Aves<br />
pepe d'acqua Magnoliopsida<br />
persico reale Actinopterygii<br />
persico sole Actinopterygii<br />
259
pervinca minore Magnoliopsida<br />
pettirosso Aves<br />
picchio rosso maggiore Aves<br />
picchio verde Aves<br />
piccione selvatico Aves<br />
pigliamosche Aves<br />
pioppo bianco Magnoliopsida<br />
pioppo nero Magnoliopsida<br />
pipistrello Mammalia<br />
piro piro piccolo Aves<br />
plecotteri Insecta<br />
poiana Aves<br />
poligono minore Magnoliopsida<br />
poligono mite Magnoliopsida<br />
poligono persicaria Magnoliopsida<br />
primula Magnoliopsida<br />
prugnolo Magnoliopsida<br />
prugnolo tar<strong>di</strong>vo Magnoliopsida<br />
pseudorasbora Actinopterygii<br />
psocotteri Insecta<br />
quercia Magnoliopsida<br />
raganella Amphibia<br />
ramarro Reptilia<br />
rana verde comune Amphibia<br />
ranuncolo comune Magnoliopsida<br />
ratto Mammalia<br />
riccio Mammalia<br />
rincoti Insecta<br />
robinia Magnoliopsida<br />
rodeo amaro Actinopterygii<br />
ron<strong>di</strong>ne Aves<br />
rondone Aves<br />
rosa canina Magnoliopsida<br />
rospo comune Amphibia<br />
rovo bluastro Magnoliopsida<br />
rovo comune Magnoliopsida<br />
rutilo o gardon Actinopterygii<br />
salcerella Magnoliopsida<br />
salice bianco Magnoliopsida<br />
salice fragile Magnoliopsida<br />
salice ripariolo Magnoliopsida<br />
sambuco Magnoliopsida<br />
sanguinello Magnoliopsida<br />
saponaria Magnoliopsida<br />
scardola Actinopterygii<br />
scricciolo Aves<br />
Sfinge del galio Insecta<br />
sgarza ciuffetto Aves<br />
sifonatteri Insecta<br />
silene bianca Magnoliopsida<br />
260
silvilago Mammalia<br />
sparviere Aves<br />
stiaccino Aves<br />
storno Aves<br />
strepsitteri Insecta<br />
svasso maggiore Aves<br />
talpa Mammalia<br />
tarassaco Magnoliopsida<br />
Tartaruga dalle orecchie gialle Reptilia<br />
Tartaruga dalle orecchie rosse Reptilia<br />
tasso Mammalia<br />
tiglio Magnoliopsida<br />
tisanotteri Insecta<br />
tisanuri Insecta<br />
topino Aves<br />
topolino delle risaie Mammalia<br />
torcicollo Aves<br />
tortora dal collare Aves<br />
tricotteri Insecta<br />
trifoglio rosso Magnoliopsida<br />
triotto Actinopterygii<br />
tritone crestato Amphibia<br />
tritone puntinato Amphibia<br />
tuffetto Aves<br />
upupa Aves<br />
usignolo <strong>di</strong> fiume Aves<br />
Vanessa del cardo Insecta<br />
veccia montanina Magnoliopsida<br />
verbasco nero Magnoliopsida<br />
verdone Aves<br />
verga d'oro maggiore Magnoliopsida<br />
veronica comune Magnoliopsida<br />
verzellino Aves<br />
viola del pensiero Magnoliopsida<br />
viola mammola Magnoliopsida<br />
viperina azzurra Magnoliopsida<br />
volpe Mammalia<br />
zoratteri Insecta<br />
261
Bibliografia<br />
http://www.ornitologiaveneziana.eu<br />
http://www.isprambiente.gov.it<br />
http://www.minambiente.it<br />
http://www.agraria.org<br />
http://www.insetti.org<br />
http://www.odonata.it<br />
http://www.leps.it<br />
http://www.biolib.de<br />
http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/birds/reglat.htm<br />
http://www.provincia.mi.it/parcosud/<br />
http://www.ermesambiente.it<br />
ERSAF – La pozza del sottopasso <strong>di</strong> Buccinasco Castello – breve indagine ambientale sulla pozza del<br />
sottopasso in località Buccinasco Castello e relative in<strong>di</strong>cazioni gestionali<br />
ERSAF – Monitoraggio e conservazione <strong>della</strong> qualità faunistica in fontanili oggetto <strong>di</strong> riqualificazione<br />
ambientale<br />
Fornasari L., Vigorita V. (a cura <strong>di</strong>), 2004 – Scopri la fauna <strong>della</strong> Lombar<strong>di</strong>a. Regione Lombar<strong>di</strong>a, Agricoltura.<br />
Peter Hayman & Rob Hume – La nuova guida del Birdwatcher. Muzzio Pocket Guide<br />
Spagnesi M., A. M. De Marinis (a cuda <strong>di</strong>), 2002 – Mammiferi d’Italia. Quad. Cons. Natura, 14 Min.<br />
Ambiente – Ist. Naz. Fauna Selvatica<br />
Spagensi M., L. Serra (a cura <strong>di</strong>), 2003 – Uccelli d’Italia. Quad. Cons. Natura, 16, Min. Ambiente – Ist. Naz.<br />
Fauna Slevatica<br />
Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante <strong>della</strong> Migrazione degli Uccelli in Italia. 1. non-Passeriformi. Ministero<br />
dell’Ambiente e <strong>della</strong> Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca<br />
Ambientale (ISPRA)<br />
Spina F. & Volponi S., 2008 - Atlante <strong>della</strong> Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero<br />
dell’Ambiente e <strong>della</strong> Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca<br />
Ambientale (ISPRA)<br />
262
Il primo <strong>atlante</strong> e <strong>checklist</strong> <strong>della</strong> bio<strong>di</strong>versità <strong>di</strong> Buccinasco, nasce con lo scopo <strong>di</strong> elencare e registrare in<br />
questo particolare progetto lo status naturalistico del nostro territorio. L’importanza <strong>di</strong> questa opera si<br />
rivela nella sua funzione <strong>di</strong> in<strong>di</strong>catore <strong>della</strong> salute ambientale e quin<strong>di</strong> <strong>della</strong> qualità del nostro stile <strong>di</strong> vita.<br />
Nel nostro Comune vivono moltissime altre forme <strong>di</strong> vita e tutte fondamentali per il corretto<br />
funzionamento degli ecosistemi in cui viviamo. Conoscere la fauna e la flora e monitorarle nel tempo è<br />
molto utile per tutelare e valorizzare il nostro ambiente, perché ciò ha una valenza oltre che naturalistica<br />
/ ecologica anche culturale, storica, politica, economica e spirituale. La conoscenza <strong>della</strong> biologia dei<br />
nostri luoghi permette una più corretta gestione ecologica con meto<strong>di</strong> biocompatibili i quali si rivelano<br />
essere quelli migliori sia da un punto <strong>di</strong> vista etico che strategico.<br />
263<br />
http://mifaonlus.com