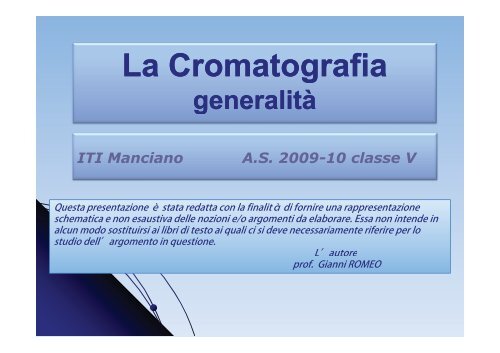Fase mobile - Scuoletoscane.it
Fase mobile - Scuoletoscane.it
Fase mobile - Scuoletoscane.it
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
La cromatografia è il metodo più diffuso per effettuare<br />
separazioni anal<strong>it</strong>iche anal<strong>it</strong>iche.<br />
Fu inventata e così denominata da un<br />
botanico russo, Mikhail Tswett, nel 1906.<br />
Separò pigmenti vegetali come clorofille<br />
e xantofille, fll ffacendo d passare etere ddi<br />
petrolio attraverso una colonna riemp<strong>it</strong>a<br />
con carbonato di calcio. I vari pigmenti pg<br />
davano luogo alla formazione di strati di<br />
diverso colore.
Etere di petrolio<br />
CaCO 3<br />
Esperimento di Tswett<br />
Miscela di pigmenti<br />
pigmenti<br />
separati
Principi generali<br />
La cromatografia è un metodo di separazione che sfrutta la diversa<br />
affin<strong>it</strong>à delle molecole e degli ioni nei confronti di due fasi differenti.<br />
<strong>Fase</strong> stazionaria: è fissa (solido o liquido supportato). Rappresenta la<br />
resistenza alla migrazione di un soluto.<br />
F<strong>Fase</strong> <strong>mobile</strong> bil ( (o eluente): l t ): li liquido id ogass che h sscorre ssulla ll ffase s fiss fissa; ; provoca lla<br />
migrazione di un soluto nella direzione del suo scorrimento.<br />
La migrazione differenziale:
Esperimento fondamentale<br />
a. Caricamento in colonna di una miscela di<br />
fase stazionaria è saturata dall’eluente<br />
dall eluente.<br />
tre sostanze (A, B, C); la<br />
b. Via via che viene aggiunto l’eluente, i diversi componenti si separano<br />
e formano delle bande (ben ( visibili nel caso di sostanze colorate). )<br />
c,d. Raccolta di frazioni di volume noto in usc<strong>it</strong>a dalla colonna.
Dinamica della separazione p<br />
Durante l’eluizione si realizza una sorta di competizione tra fase<br />
stazionaria e fase <strong>mobile</strong> nei confronti delle sostanze elu<strong>it</strong>e elu<strong>it</strong>e.<br />
Ogni componente della miscela tende a distribuirsi tra le due fasi<br />
passando passan o (in (ncon condizioni z on ideali) a ) attraverso attra rso una serie s r infin<strong>it</strong>a nf n ta di stati stat<br />
di equilibrio che si realizzano in ogni strato di spessore infin<strong>it</strong>esimo<br />
della colonna.
Dinamica della separazione<br />
I componenti maggiormente<br />
ttrattenuti tt ti ddalla ll ffase<br />
stazionaria si muovono più<br />
lentamente con il flusso di fase<br />
<strong>mobile</strong>.<br />
I componenti più debolmente<br />
trattenuti dalla fase<br />
stazionaria z<br />
rapidamente.<br />
si muovono mu più pù<br />
Per la differente mobil<strong>it</strong>à, i componenti del campione si<br />
separano in bande discrete (analisi qual<strong>it</strong>ativa e<br />
quant<strong>it</strong>ativa).<br />
t<strong>it</strong> ti )
Classificazione delle tecniche<br />
cromatografiche g f<br />
Le tecniche<br />
cromatografiche possono<br />
essere suddivise in base a:<br />
- tipo di fase <strong>mobile</strong>;<br />
- meccanismo di<br />
separazione;<br />
- tecnica di eluizione eluizione.
Classificazione f in base al tipo p di fase f<br />
<strong>mobile</strong>
Classificazione f in base al tipo p<br />
di eluizione
Classificazione f in base al meccanismo di<br />
separazione
Adsorbimento<br />
A<br />
<strong>Fase</strong> stazionaria: solido in polvere; sulla superficie dei granuli si trovano dei<br />
s<strong>it</strong>i attivi in grado di stabilire legami deboli con le molecole della miscela da<br />
separare.<br />
<strong>Fase</strong> <strong>mobile</strong>: se é un liquido si parla di cromatografia liquido-solido (LSC); se é<br />
un gas, s di cr cromatografia m t r fi gas-solido s s lid (GSC) (GSC).<br />
Durante l’eluizione l eluizione, le molecole si<br />
ciascuna sostanza si ripartiscono<br />
tra le due fasi, in misura variabile<br />
secondo l’ent<strong>it</strong>à lent<strong>it</strong>àdell’adsorbimento dell adsorbimento.
Adsorbimento<br />
la quant<strong>it</strong>à di adsorbato dipende dalla<br />
superfice di contatto tra il gas ed il solido.<br />
ma dipende anche dalla<br />
pressione del gas e dalla<br />
temperatura<br />
Ri ld d il <strong>it</strong><br />
Riscaldando il sistema<br />
le molecole di gas<br />
tendono a staccarsi dalla<br />
fase fissa
Adsorbimento<br />
Equazione di Freundlich<br />
L’ L’adsorbimento d bi t è ill illustrato t t d da d detta tt equazione i<br />
Cf = a P 1/n in cui : :Cf = conc conc. . nella fase fissa<br />
C f<br />
saturazione<br />
pressione pressione<br />
P = pressione del gas, a ed n<br />
dipendono p dalla natura delle<br />
sostanze e dalla temperatura<br />
In genere genere si scelgono le<br />
condizioni operative<br />
lontane dalla saturazione<br />
ddove ve ll’andament andamento è quasi<br />
rettilineo
Ripartizione p<br />
L1 inn questa rappresentazione rappresentaz one i puntini punt n<br />
indicano le molecole di sostanza S ;<br />
L2<br />
le freccette invece indicano il movimento<br />
di queste tra le due fasi sino al<br />
raggiungimento dell’equilibrio
Ripartizione – Equaz. di Nernst<br />
La sostanza S si scioglie ripartendosi tra le due fasi<br />
L1 e L2 secondo l’equazione l equazione di di Nernst C CL1 L1/C /C L2 = K<br />
(costante)<br />
C CL1 L1= L1 = Conc<br />
C L2 =<br />
Conc di d S in n L1 L ;<br />
= Conc di S in L2<br />
K = dipende dalle sostanze presenti e dalla temperatura.<br />
C L1<br />
C L2
Ripartizione p<br />
<strong>Fase</strong> stazionaria: é un liquido, che impregna un solido granulare<br />
inerte inerte, in cui le sostanze da separare si solubilizzano solubilizzano. Esse si<br />
ripartiscono fra le due fasi (immiscibili tra loro), secondo la diversa<br />
solubil<strong>it</strong>à in ciascuna di esse.<br />
K = Cs/Cm<br />
K = coefficiente di ripartizione.<br />
Cs = concentrazione della sostanza nella<br />
fase stazionaria.<br />
Cm = concentrazione della sostanza nella<br />
fase <strong>mobile</strong> <strong>mobile</strong>.<br />
F<strong>Fase</strong> <strong>mobile</strong>: bil seèè un gas sii parla l di cromatografia fi gas-liquido li id (GLC) (GLC),<br />
se invece é un liquido, di cromatografia liquido-liquido (LLC).
Nelle colonne<br />
cromatografiche la<br />
la<br />
ripartizione si realizza<br />
impregnando con una<br />
sostanza oleosa i<br />
microgranuli che<br />
riempiono la colonna<br />
Ripartizione<br />
Rp<br />
s<strong>it</strong>o di ripartizione<br />
molecole di gas<br />
s<strong>it</strong>o di<br />
adsorbimento
Ripartizione Rp /A /Adsorbimento<br />
Si deduce che sia il diagramma g dell’adsorbimento che<br />
quello della ripartizione hanno lo stesso andamento.<br />
andamento<br />
A<br />
Per descrivere la separazione si<br />
preferisce quindi parlare di:<br />
concentrazione in fase fissa<br />
B concentrazione concentrazione in in fase fase <strong>mobile</strong> <strong>mobile</strong><br />
C <strong>mobile</strong>
Scambio ionico<br />
<strong>Fase</strong> stazionaria: polimeri con gruppi ionici o ionizzabili, acidi o<br />
basici (resine a scambio ionico), in grado di scambiare gli ioni mobili<br />
ddella ll resina i con quelli lli presentii nella ll soluzione l i a contatto con essa.<br />
Si instaura una competizione fra i controioni della fase stazionaria<br />
e quella della miscela in analisi nei confronti dei s<strong>it</strong>i attivi presenti<br />
sulla fase stazionaria.
Esclusione<br />
F<strong>Fase</strong> stazionaria: t i i gellcon porii lle cuiidi dimensioni i i variano i iin bbase<br />
alla composizione chimica e al modo in cui viene preparato.<br />
Le molecole di anal<strong>it</strong>a disciolte nella fase <strong>mobile</strong> penetrano nel<br />
Le molecole di anal<strong>it</strong>a, disciolte nella fase <strong>mobile</strong>, penetrano nel<br />
gel e vi permangono per un certo tempo. Quelle grandi sono<br />
escluse daiporiedesconodallacolonnaintempimoltobrevi.
Affin<strong>it</strong>à<br />
a. Le molecole da separare si legano a gruppi funzionali<br />
specifici f ddella ll ffase stazionaria mediante d una reazione reversibile. bl<br />
b. e c. Eluendo con una fase opportuna, si rompono i legami con<br />
la fase stazionaria e si recuperano le molecole molecole.
Il cromatogramma<br />
Fatta eccezione per la TLC e la PC, tutte le<br />
separazioni cromatografiche si concludono<br />
con un tracciato i edd ognii sostanza elu<strong>it</strong>a l i è<br />
detto picco cromatografico.<br />
Il tracciato descrive l’andamento del<br />
rivelatore in funzione del tempo o del<br />
volume di eluente eluente, a t t =0 =0.<br />
tM: tempo morto = tempo di r<strong>it</strong>enzione di una<br />
sostanza non trattenuta dalla fase stazionaria<br />
tR: tempo di r<strong>it</strong>enzione = tempo impiegato da<br />
ciascuna sostanza per scorrere attraverso la<br />
colonna, l ddal l tt=0 0 fi fino all momento t iin cuiinon sii hha il<br />
massimo del picco.<br />
h: altezza del picco p = distanza tra il massimo e la linea di base.<br />
w b: larghezza alla base del picco = lunghezza del segmento interpolato<br />
all’intersezione fra le tangenti ai flessi della gaussiana e la linea di base.
Selettiv<strong>it</strong>à l i i à<br />
La selettiv<strong>it</strong>à indica la capac<strong>it</strong>à p di un<br />
sistema cromatografico di eluire specie<br />
chimiche diverse a veloc<strong>it</strong>à il più possibile<br />
diverse diverse, in modo tale che siano ben separate<br />
l’una dall’altra all’usc<strong>it</strong>a della colonna.
Efficienza<br />
Indica la capac<strong>it</strong>à di un sistema cromatografico<br />
di eluire tutte le particelle di una data specie<br />
chimica con la stessa veloc<strong>it</strong>à, in modo da<br />
fornire bande e picchi molto stretti.<br />
Si può esprimere facendo riferimento alla<br />
larghezza del picco (ad es. wb ), che è diversa<br />
per ogni specie chimica. Essa, però, dipende dal<br />
tempo p di r<strong>it</strong>enzione.<br />
Bassa efficienza<br />
Buona efficienza
Risoluzione<br />
Indica il grado di separazione dei picchi ottenuti al rivelatore di un<br />
sist sistema m ccromatografico; m t fic ; bbande nd bben n sseparate p t lun lungo lla ccolonna l nn generano n n<br />
picchi distinti e sufficientemente stretti da non sovrapporsi. In tal<br />
caso si dice che i picchi sono “ben risolti”.<br />
Effetto della selettiv<strong>it</strong>à, dell’efficienza e del fattore di r<strong>it</strong>enzione<br />
sulla risoluzione.<br />
Selettiv<strong>it</strong>à ed efficienza insufficienti: i<br />
picchi i hi ddei i componenti ti A e B sii<br />
sovrappongono.
Se si migliora la selettiv<strong>it</strong>à (ad es.<br />
cambiando la fase stazionaria) si ottiene<br />
una buona risoluzione: i tempi di r<strong>it</strong>enzione<br />
cambiano e i picchi sono separati.<br />
Se si migliora g l’efficienza, , la risoluzione<br />
diventa accettabile: le basi dei picchi si<br />
restringono e i picchi risultano nettamente<br />
separati separati.<br />
La colonna ha una buona efficienza, ma la<br />
risoluzione i l i è iinsoddisfacente ddi f t (b (basso ffattore tt<br />
di r<strong>it</strong>enzione). La risoluzione può migliorare<br />
iniettando una minore quant<strong>it</strong>à di miscela.