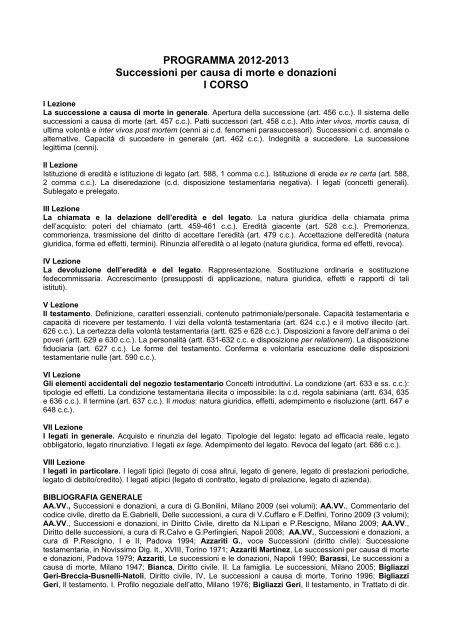Programma successioni - Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di ...
Programma successioni - Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di ...
Programma successioni - Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
PROGRAMMA 2012-2013<br />
Successioni per causa <strong>di</strong> morte e donazioni<br />
I CORSO<br />
I Lezione<br />
La successione a causa <strong>di</strong> morte in generale. Apertura della successione (art. 456 c.c.). Il sistema delle<br />
<strong>successioni</strong> a causa <strong>di</strong> morte (art. 457 c.c.). Patti successori (art. 458 c.c.). Atto inter vivos, mortis causa, <strong>di</strong><br />
ultima volontà e inter vivos post mortem (cenni ai c.d. fenomeni parasuccessori). Successioni c.d. anomale o<br />
alternative. Capacità <strong>di</strong> succedere in generale (art. 462 c.c.). Indegnità a succedere. La successione<br />
legittima (cenni).<br />
II Lezione<br />
Istituzione <strong>di</strong> ere<strong>di</strong>tà e istituzione <strong>di</strong> legato (art. 588, 1 comma c.c.). Istituzione <strong>di</strong> erede ex re certa (art. 588,<br />
2 comma c.c.). La <strong>di</strong>seredazione (c.d. <strong>di</strong>sposizione testamentaria negativa). I legati (concetti generali).<br />
Sublegato e prelegato.<br />
III Lezione<br />
La chiamata e la delazione dell’ere<strong>di</strong>tà e del legato. La natura giuri<strong>di</strong>ca della chiamata prima<br />
dell’acquisto: poteri del chiamato (artt. 459-461 c.c.). Ere<strong>di</strong>tà giacente (art. 528 c.c.). Premorienza,<br />
commorienza, trasmissione del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accettare l’ere<strong>di</strong>tà (art. 479 c.c.). Accettazione dell'ere<strong>di</strong>tà (natura<br />
giuri<strong>di</strong>ca, forma ed effetti, termini). Rinunzia all'ere<strong>di</strong>tà o al legato (natura giuri<strong>di</strong>ca, forma ed effetti, revoca).<br />
IV Lezione<br />
La devoluzione dell’ere<strong>di</strong>tà e del legato. Rappresentazione. Sostituzione or<strong>di</strong>naria e sostituzione<br />
fedecommissaria. Accrescimento (presupposti <strong>di</strong> applicazione, natura giuri<strong>di</strong>ca, effetti e rapporti <strong>di</strong> tali<br />
istituti).<br />
V Lezione<br />
Il testamento. Definizione, caratteri essenziali, contenuto patrimoniale/personale. Capacità testamentaria e<br />
capacità <strong>di</strong> ricevere per testamento. I vizi della volontà testamentaria (art. 624 c.c.) e il motivo illecito (art.<br />
626 c.c.). La certezza della volontà testamentaria (artt. 625 e 628 c.c.). Disposizioni a favore dell’anima o <strong>dei</strong><br />
poveri (artt. 629 e 630 c.c.). La personalità (artt. 631-632 c.c. e <strong>di</strong>sposizione per relationem). La <strong>di</strong>sposizione<br />
fiduciaria (art. 627 c.c.). Le forme del testamento. Conferma e volontaria esecuzione delle <strong>di</strong>sposizioni<br />
testamentarie nulle (art. 590 c.c.).<br />
VI Lezione<br />
Gli elementi accidentali del negozio testamentario Concetti introduttivi. La con<strong>di</strong>zione (art. 633 e ss. c.c.):<br />
tipologie ed effetti. La con<strong>di</strong>zione testamentaria illecita o impossibile: la c.d. regola sabiniana (artt. 634, 635<br />
e 636 c.c.). Il termine (art. 637 c.c.). Il modus: natura giuri<strong>di</strong>ca, effetti, adempimento e risoluzione (artt. 647 e<br />
648 c.c.).<br />
VII Lezione<br />
I legati in generale. Acquisto e rinunzia del legato. Tipologie del legato: legato ad efficacia reale, legato<br />
obbligatorio, legato rinunziativo. I legati ex lege. Adempimento del legato. Revoca del legato (art. 686 c.c.).<br />
VIII Lezione<br />
I legati in particolare. I legati tipici (legato <strong>di</strong> cosa altrui, legato <strong>di</strong> genere, legato <strong>di</strong> prestazioni perio<strong>di</strong>che,<br />
legato <strong>di</strong> debito/cre<strong>di</strong>to). I legati atipici (legato <strong>di</strong> contratto, legato <strong>di</strong> prelazione, legato <strong>di</strong> azienda).<br />
BIBLIOGRAFIA GENERALE<br />
AA.VV., Successioni e donazioni, a cura <strong>di</strong> G.Bonilini, Milano 2009 (sei volumi); AA.VV., Commentario del<br />
co<strong>di</strong>ce civile, <strong>di</strong>retto da E.Gabrielli, Delle <strong>successioni</strong>, a cura <strong>di</strong> V.Cuffaro e F.Delfini, Torino 2009 (3 volumi);<br />
AA.VV., Successioni e donazioni, in Diritto Civile, <strong>di</strong>retto da N.Lipari e P.Rescigno, Milano 2009; AA.VV.,<br />
Diritto delle <strong>successioni</strong>, a cura <strong>di</strong> R.Calvo e G.Perlingieri, Napoli 2008; AA.VV., Successioni e donazioni, a<br />
cura <strong>di</strong> P.Rescigno, I e II, Padova 1994; Azzariti G., voce Successioni (<strong>di</strong>ritto civile): Successione<br />
testamentaria, in Novissimo Dig. It., XVIII, Torino 1971; Azzariti Martinez, Le <strong>successioni</strong> per causa <strong>di</strong> morte<br />
e donazioni, Padova 1979; Azzariti, Le <strong>successioni</strong> e le donazioni, Napoli 1990; Barassi, Le <strong>successioni</strong> a<br />
causa <strong>di</strong> morte, Milano 1947; Bianca, Diritto civile. II. La famiglia. Le <strong>successioni</strong>, Milano 2005; Bigliazzi<br />
Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Diritto civile, IV, Le <strong>successioni</strong> a causa <strong>di</strong> morte, Torino 1996; Bigliazzi<br />
Geri, Il testamento. I. Profilo negoziale dell’atto, Milano 1976; Bigliazzi Geri, Il testamento, in Trattato <strong>di</strong> <strong>di</strong>r.
priv. <strong>di</strong>retto da P. Rescigno, VI, Torino 1982; Bigliazzi Geri, Successioni testamentarie (artt. 587-600 c.c.),<br />
in Comm. cod. civ. a cura <strong>di</strong> Scialoja e Branca, Bologna-Roma 1993; Bion<strong>di</strong>, Successione testamentaria e<br />
donazioni, Milano 1955; Bonilini, Nozioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto ere<strong>di</strong>tario, Torino 1989; Bonilini, Il testamento.<br />
Lineamenti, Padova 1995; Bonilini, Manuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto ere<strong>di</strong>tario e delle donazioni, Torino 2006; Bonvicini, Il<br />
testamento. Lineamenti, Padova 1995; Borghese, Il testamento e le <strong>successioni</strong>, Milano 1986; Burdese,<br />
voce Successione a causa <strong>di</strong> morte, in Enc. giur. Treccani, XXX, Roma 1993; Capozzi, Successioni e<br />
donazioni, I e II, Napoli 2009; Caramazza, Delle <strong>successioni</strong> testamentarie, in Comm. teorico-pratico al cod.<br />
civ. <strong>di</strong>retto da V.De Martino, Novara 1982; Cariota Ferrara, Le <strong>successioni</strong> per causa <strong>di</strong> morte, Napoli 1977;<br />
Cicu, Il testamento, Milano 1951; Cicu, Successioni per causa <strong>di</strong> morte. Parte generale, in Trattato <strong>di</strong> <strong>di</strong>r.<br />
civ. e comm. <strong>di</strong>retto da A.Cicu e F.Messineo, XLII, Milano 1961; Gardani Contursi Lisi, Le <strong>successioni</strong>.<br />
Disposizioni generali, in Giur. sist. <strong>di</strong>r. civ. e comm. <strong>di</strong>retta da W. Bigiavi, Torino 1981; Criscuoli, Le<br />
obbligazioni testamentarie, Milano 1980; Criscuoli, Il testamento, norme e casi, Padova 1991; Criscuoli,<br />
voce Testamento, in Enc. giur. Treccani, XXXI, Roma 1994; De Cupis, voce Successione testamentaria, in<br />
Enc. del <strong>di</strong>r., XLIII, Milano 1990, p. 1378 ss.; Delle Monache, Testamento (artt. 587-590 c.c.), in Il co<strong>di</strong>ce<br />
civile comm., fondato da P.Schlesinger e continuato da F.D.Busnelli, Milano 2005; Dogliotti, voce<br />
Successioni testamentarie, in Dig. <strong>di</strong>sc. priv., sez. civ., XIX, Torino 1999, p. 190 ss.; Ferri, Disposizioni<br />
generali sulle <strong>successioni</strong> (artt. 456-511 c.c.), in Comm. cod. civ. a cura <strong>di</strong> Scialoja e Branca, Bologna-Roma<br />
1980; Gangi, La successione testamentaria nel vigente <strong>di</strong>ritto italiano, Milano 1964; Gardani Contursi Lisi,<br />
Dell’istituzione <strong>di</strong> erede e <strong>dei</strong> legati (artt. 624-632 c.c.), in Comm. cod. civ. a cura <strong>di</strong> Scialoja e Branca,<br />
Bologna-Roma 1983; Giannattasio, Delle <strong>successioni</strong> testamentarie (artt. 587-712 c.c.), in Comm. cod. civ.,<br />
Torino 1978; Grosso Burdese, Le <strong>successioni</strong>. Parte generale, in Trattato <strong>di</strong> <strong>di</strong>r. civ. it. <strong>di</strong>retto da F.Vassalli,<br />
Torino 1977; Loi, Le <strong>successioni</strong> testamentarie, in Giur. sist. <strong>di</strong>r. civ. e comm. <strong>di</strong>retta da W.Bigiavi, Torino<br />
1992; Palazzo, Le <strong>successioni</strong>, in Trattato <strong>di</strong> <strong>di</strong>r. priv. a cura <strong>di</strong> G.Iu<strong>di</strong>ca e P.Zatti, I e II, 2° ed., Milano 2000;<br />
Palazzo, Introduzione al <strong>di</strong>ritto successorio, istituti comuni alle categorie successorie, successione legale,<br />
Milano 1996; Palazzo, voce Successioni (parte generale), in Dig. <strong>di</strong>sc. priv., sez. civ., XIX, Torino 1999, p.<br />
122 ss.; Rossi, Il testamento, Milano 1988; Schlesinger, voce Successioni (<strong>di</strong>ritto civile). Parte generale, in<br />
Novissimo Dig. It., XVIII, Torino 1971, p. 748 ss.; Tamburrino, voce Testamento (<strong>di</strong>ritto privato), in Enc. del<br />
<strong>di</strong>r., XLIV, Milano 1992, p. 486 ss.; Tatarano M.C., Il testamento, in Trattato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto civile del CNN, <strong>di</strong>retto<br />
da P.Perlingieri, Napoli 2003; Triola, Il testamento, Milano 1998; Vascellari, Commento agli artt. 456-809<br />
c.c., in Comm. breve al c.c. <strong>di</strong>retto da G.Cian e A.Trabucchi, Padova ult. ed.<br />
**Nelle schede delle lezioni sarà in<strong>di</strong>cata ulteriore bibliografia, specifica sui singoli temi trattati.
SCHEMI E PARTI PRATICHE<br />
I LEZIONE (20.11.2012)<br />
La successione a causa <strong>di</strong> morte in generale. Apertura della successione (art. 456 c.c.). Il sistema delle<br />
<strong>successioni</strong> a causa <strong>di</strong> morte (art. 457 c.c.). Patti successori (art. 458 c.c.). Atto inter vivos, mortis causa, <strong>di</strong><br />
ultima volontà e inter vivos post mortem (cenni ai c.d. fenomeni parasuccessori). Successioni c.d. anomale o<br />
alternative. Capacità <strong>di</strong> succedere in generale (art. 462 c.c.). Indegnità a succedere. La successione<br />
legittima (cenni).<br />
PARTE TEORICA<br />
LA SUCCESSIONE A CAUSA DI MORTE<br />
La successione a causa <strong>di</strong> morte definisce “la vicenda - o le complesse vicende - traslative <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> una<br />
persona a seguito della sua morte” (Bianca). Più precisamente, per successione a causa <strong>di</strong> morte s’intende il<br />
fenomeno del subentrare, al verificarsi della morte naturale (o della <strong>di</strong>chiarazione giu<strong>di</strong>ziale <strong>di</strong> morte<br />
presunta) <strong>di</strong> una persona fisica, <strong>di</strong> un altro soggetto o più soggetti (persone fisiche o giuri<strong>di</strong>che) nella<br />
situazione giuri<strong>di</strong>co-patrimoniale che il defunto aveva in vita.<br />
La successione a causa <strong>di</strong> morte si apre in conseguenza della morte fisica o della morte presunta, <strong>di</strong>chiarata<br />
con sentenza del Tribunale. Nozioni sulla scomparsa, assenza e <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> morte presunta e sulle loro<br />
conseguenze in materia <strong>di</strong> <strong>successioni</strong> a causa <strong>di</strong> morte (artt. 58 ss. c.c.; artt. 726 ss. c.p.c.).<br />
APERTURA DELLA SUCCESSIONE: TEMPO E LUOGO (art. 456 c.c.)<br />
La successione si apre nel giorno della morte del de cuius (morte fisica e certa) (o, in caso <strong>di</strong> presunta<br />
morte, nel giorno cui risale l'ultima notizia dello scomparso: art. 58 c.c.: Trib. Chieti 22.9.1987). Questo è il<br />
tempo al quale, in virtù della retroattività ex tunc (dall'accettazione <strong>di</strong> ere<strong>di</strong>tà agli effetti della <strong>di</strong>visione),<br />
risalgono tutti gli effetti della successione a causa <strong>di</strong> morte. Apertura della successione e delazione si<br />
verificano nello stesso momento anche quando la delazione abbia luogo in un momento successivo. Il luogo<br />
in cui si apre la successione, in<strong>di</strong>pendentemente dalla località in cui avviene il decesso, è quello dell'ultimo<br />
domicilio del defunto (art. 43 c.c.; Trib. Roma 7.11.1991).<br />
La legge sulla successione a causa <strong>di</strong> morte che si applica è quella nazionale del defunto al momento della<br />
morte (art. 46 l. 218/1995). La morte deve essere certa e incontestabile, perciò deve essere provata (artt.<br />
449 e 452 c.c. - art. 2697 c.c.).<br />
IL SISTEMA DELLE SUCCESSIONI A CAUSA DI MORTE (art. 457 c.c.)<br />
Con l'apertura della successione si verifica la delazione dell'ere<strong>di</strong>tà. Fonti <strong>di</strong> delazione ere<strong>di</strong>taria sono<br />
esclusivamente il testamento e la legge. Il testamento è la fonte prevalente, manifestando la volontà del de<br />
cuius <strong>di</strong> programmare la propria successione. Si fa luogo alla successione legittima se manca in tutto o in<br />
parte il testamento o quando questo è stato revocato o risulta invalido (e non è stato confermato, ex art. 590<br />
c.c.). La successione legittima si apre anche quando all’erede legittimo, con il testamento, sia stato attribuito<br />
solo un legato (Cass. 15.6.1999 n. 5918). La successione legittima, infine, si apre anche quando la <strong>di</strong>visione<br />
fatta dal testatore (art. 734 c.c.) non sia completa (ad esempio, per sopravvenienza <strong>di</strong> beni nel patrimonio<br />
del testatore: Cass. 7.6.1993 n. 6358). La previsione della tutela <strong>dei</strong> legittimari, per la maggior parte della<br />
dottrina, non costituisce una terza forma <strong>di</strong> delazione ere<strong>di</strong>taria (c.d. necessaria, avente fonte nella legge:<br />
Rescigno), ma un limite (<strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne soggettivo ed oggettivo) sia alla successione legittima (donazioni), sia alla<br />
successione testamentaria (<strong>di</strong>sposizioni testamentarie e donazioni). Si parla altresì <strong>di</strong> “successione legittima<br />
potenziata”. Il sistema delle <strong>successioni</strong> ere<strong>di</strong>tarie è un sistema completo, perché non manca mai un<br />
successore (erede). In mancanza del testamento e <strong>di</strong> una famiglia (art. 77 c.c.), successore necessario è lo<br />
Stato (tale successione, peraltro, rientra nella successione legittima).<br />
PATTI SUCCESSORI (art. 458 c.c.) Il testamento e la legge sono gli unici titoli <strong>di</strong> vocazione ere<strong>di</strong>taria. La<br />
nullità <strong>di</strong> ogni convenzione “ere<strong>di</strong>taria” <strong>di</strong>scende dalla illiceità per contrarietà a norma imperativa (art. 458<br />
c.c.) (e non all’or<strong>di</strong>ne pubblico, ammettendo, <strong>di</strong> conseguenza, la sanatoria <strong>di</strong> cui all’art. 590 c.c.: ma la<br />
contrarietà all’or<strong>di</strong>ne pubblico, per il principio della libertà testamentaria, è ampiamente affermata: De Giorgi,<br />
Ferri, De Cupis). In particolare, si afferma l’illiceità della causa per i patti successori istitutivi (De Giorgi), e<br />
l’illiceità dell’oggetto per i patti successori <strong>di</strong>spositivi e rinunciativi (Bianca; Cass. 14.7.1983 n. 4827).<br />
Caratteristiche comuni ad ogni tipo <strong>di</strong> patto successorio: a) la convenzione deve essere stipulata prima<br />
dell’apertura della successione; b) il bene oggetto della convenzione fa parte della futura ere<strong>di</strong>tà; c)<br />
l’acquisto avverrà <strong>successioni</strong>s causa e non ad altro titolo (Cass. 22.7.1972 n. 2404; Cass. 16.2.1995 n.<br />
1683). Si definisce patto successorio ogni convenzione che abbia ad oggetto la costituzione, mo<strong>di</strong>ficazione,<br />
trasmissione o estinzione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti relativi ad una successione non ancora aperta (Cass. 6232/1980). Ratio<br />
del <strong>di</strong>vieto: la spiegazione è tecnico-giuri<strong>di</strong>ca per tutti i tipi <strong>di</strong> patto, ossia l’aver ad oggetto un’ere<strong>di</strong>tà futura<br />
(correlativo all’art. 458 c.c. è art. 771 c.c.: entrambi sono eccezioni all’art. 1348 c.c.) Da intendersi, il bene<br />
futuro, non solo come inesistente in rerum natura, ma come <strong>di</strong>ritto inesistente nel patrimonio <strong>di</strong> chi <strong>di</strong>spone:
(Carnevali). La regolamentazione del patrimonio post mortem deve provenire esclusivamente dal de cuius<br />
(Caccavale e Magliulo). Più che la libertà testamentaria, più recentemente, si guarda alla “centralità” del<br />
volere del de cuius: la <strong>di</strong>rezione <strong>dei</strong> beni post mortem deve essere in<strong>di</strong>cata solo da testatore. Per il patto<br />
successorio istitutivo la ratio è rinvenuta nella tipizzazione della delazione (art. 457 c.c.), nonché nel principio<br />
della libertà testamentaria; per gli altri patti successori la ratio è riferita al pericolo votum corvinum o votum<br />
captandae mortis (ma è ormai questa una spiegazione anacronistica: altri istituti, come la ren<strong>di</strong>ta vitalizia,<br />
l'usufrutto o l’assicurazione sulla vita, non pongono la stessa questione, né subiscono lo stesso trattamento).<br />
Sono patti successori anche le <strong>di</strong>sposizioni sui beni dell’assente, fino alla <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> morte presunta<br />
(solo in tale momento vi è un’immissione definitiva nel possesso <strong>dei</strong> beni dell’assente e si apre la vera e<br />
propria successione).<br />
PATTO ISTITUTIVO (confermativo o istituzione ere<strong>di</strong>taria contrattuale) La morte è causa <strong>di</strong> acquisto, non un<br />
termine o una con<strong>di</strong>zione. Tale patto intercorre fra <strong>di</strong>sponente e i futuri ere<strong>di</strong>/legatari. Struttura: E’ un atto<br />
mortis causa. L’atto mortis causa contrattuale non produce effetti reali imme<strong>di</strong>ati, ma effetti comunque<br />
imme<strong>di</strong>atamente obbligatori fra le parti (bilateralità=irrevocabilità). Solo questo patto costituisce vera<br />
alternativa al testamento (dunque, il confronto tra art. 458 c.c. e fenomeni parasuccessori si pone solo per<br />
questa figura); il <strong>di</strong>vieto si riferisce a contratti a titolo gratuito e oneroso (Capozzi). Ratio: tutela della<br />
revocabilità e della libertà testamentaria (così Cass. 9.10.1972 n. 2958; Cass. 21.4.1979 n. 2228; Cass.<br />
14.7.1983 n. 4827: artt. 587 e 679 - 589 e 635 c.c.: per il combinato artt. 589/458 c.c.: Cass. 27.4.1982 n.<br />
2623). Centralità della volontà del <strong>di</strong>sponente e inesistenza della tutela dell’affidamento <strong>dei</strong> terzi interessati<br />
alla vicenda successoria (Caccavale). Sottospecie: a) patto successorio obbligatorio: può intercorrere fra de<br />
cuius e futuri ere<strong>di</strong> o legatari, ma può essere anche a favore <strong>di</strong> un terzo estraneo alla convenzione (Cass.<br />
10.4.1964 n. 835); è un atto inter vivos (presuppone la vita del <strong>di</strong>sponente che dovrà successivamente fare<br />
testamento nel modo in cui si è obbligato: il negozio dunque costituirà esecuzione dell’accordo pregresso).<br />
Anche tale patto è nullo, ai sensi dell’art. 458 c.c. (Cass. 29.5.1972 n. 1702; Cass. 3.11.1979 n. 5693; Cass.<br />
6.1.1981 n. 63); b) promessa <strong>di</strong> istituzione <strong>di</strong> erede o legatario: è un atto inter vivos. La promessa è valida,<br />
ex art. 458 c.c., in quanto non vincolante, ma comunque inefficace ex art. 1987 c.c. (tipicità delle promesse:<br />
Cass. 29.5.1972 n. 1702). Frequente nella pratica la promessa <strong>di</strong> istituzione <strong>di</strong> erede o legatario, inteso<br />
come compenso/retribuzione <strong>di</strong> attività <strong>di</strong> assistenza/lavorative (Cass. 10.4.1964 n. 835; Cass. 18.7.1969 n.<br />
2680; Cass. 6.1.1981 n. 63; Cass. 8.3.1985 n. 1896: sono considerate comunque in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> onerosità del<br />
contratto <strong>di</strong> lavoro, che non è nullo per illiceità della causa o dell’oggetto, dunque <strong>di</strong>ritto alla retribuzione o al<br />
più all’arricchimento senza causa; per un caso <strong>di</strong> obbligo <strong>di</strong> istituzione come corrispettivo <strong>di</strong> rapporto <strong>di</strong><br />
lavoro: Cass. 8.3.1985 n. 1896); c) ogni altro atto anche unilaterale: se nell’art. 458 c.c. si parla <strong>di</strong> atti<br />
bilaterali, nel correlativo art. 679 c.c. si ricomprendono anche gli atti unilaterali. Ammissibilità <strong>di</strong> conferma <strong>di</strong><br />
cui all’art. 590 c.c.: ammessa per il testamento esecutivo del patto successorio obbligatorio (Toti: cfr. la<br />
<strong>di</strong>stinzione delle varie figure <strong>di</strong> illiceità: Cass. 19.2.1970 n. 389); inammissibile, invece, per il contratto<br />
ere<strong>di</strong>tario vero e proprio e per i patti <strong>di</strong>spositivi e rinunciativi (nessuno <strong>dei</strong> tre è un testamento per quanto<br />
nullo o annullabile: De Giorgi). Ammissibilità della conversione ex art. 1424 c.c. del contratto ere<strong>di</strong>tario in<br />
testamento valido (favorevoli Cass. 14.7.1983 n. 4827; Vignale, Lepri). Tuttavia, vi contrasterebbe l’illiceità<br />
dello scopo e dello strumento; inoltre, non sarebbe configurabile la conversione <strong>di</strong> atto bilaterale in atto<br />
unilaterale (così Cass. 11.10.1980 n. 5451; De Giorgi, Marella).<br />
PATTO DISPOSITIVO Intercorre tra soggetti <strong>dei</strong> quali uno sarà interessato ad una futura ere<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> cui<br />
l’oggetto alienato farà parte. Può comprendere singoli beni della futura ere<strong>di</strong>tà o una quota <strong>di</strong> essa. Si<br />
<strong>di</strong>stingue dal negozio su beni futuri <strong>di</strong> cui all’art. 1472 c.c. (ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> tipo aleatorio, valida ex art. 1348 c.c.)<br />
e soprattutto dalla ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> cosa altrui (art. 1478 c.c., in cui il ven<strong>di</strong>tore si obbliga a procurare l’acquisto al<br />
compratore), in quanto qui dell’oggetto <strong>di</strong> cui si <strong>di</strong>spone ne è previsto l’acquisto a titolo successorio a favore<br />
del <strong>di</strong>sponente (sulla <strong>di</strong>stinzione Cass. 18.4.1968 n. 1164; Cass. 22.2.1974 n. 527; Cass. 9.7.1976 n. 2619;<br />
Cass. 3.6.1977 n. 2261; Cass. 24.10.1978 n. 4801: carattere <strong>di</strong>stintivo è il dato soggettivo, ossia che<br />
entrambi i contraenti considerino il bene alienato come entità <strong>di</strong> una futura successione, ossia comune<br />
intenzione delle parti che il bene oggetto del contratto sia considerato proprio in quanto facente parte <strong>di</strong><br />
futura ere<strong>di</strong>tà (necessità <strong>di</strong> valutazione caso per caso); come criterio oggettivo, in particolare, si esclude l’art.<br />
458 c.c. se la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> cosa altrui produce l’imme<strong>di</strong>ato obbligo a carico dell’alienante <strong>di</strong> far acquistare il<br />
bene alla controparte; se, invece, l’esecuzione della ven<strong>di</strong>ta è rinviata alla morte del proprietario o a tempo<br />
indefinito si ricade nell’art. 458. c.c. Sottospecie: a) patto <strong>di</strong>spositivo obbligatorio (è nullo): in particolare, il<br />
<strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> cui all’art. 458 c.c. colpisce non solo i contratti <strong>di</strong> alienazione definitivi, ma anche i contratti<br />
preliminari (Cass. 9.7.1976 n. 2619); b) patto <strong>di</strong>spositivo a titolo gratuito: è anch’esso nullo ai sensi dell’art.<br />
771 c.c. (<strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> donazione <strong>di</strong> beni futuri). Struttura: è un atto tra vivi (si <strong>di</strong>spone non della propria<br />
successione, ma <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti che possono pervenire per successione <strong>di</strong> una persona ancora vivente<br />
(Giampiccolo). Ratio: tutela del futuro erede/del <strong>di</strong>sponente, oggetto ere<strong>di</strong>tà futura.<br />
PATTO RINUNCIATIVO Intercorre tra soggetti interessati alla futura ere<strong>di</strong>tà e vi può partecipare anche il de<br />
cuius (in tal caso è un atto complesso, ossia patto <strong>di</strong>spositivo + patto istitutivo: Cass. 5.12.1968 n. 3883).<br />
Frequente loro ricorrenza in occasione <strong>di</strong> donazioni. E’ un atto <strong>di</strong>spositivo, ma non <strong>di</strong>rettamente attributivo<br />
(<strong>di</strong>smissione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti futuri). Si correla all’art. 557, 2 comma c.c. (tutela <strong>dei</strong> legittimari). Struttura: è un atto tra
vivi (Giampiccolo). Sottospecie: a) rinuncia verso corrispettivo, rinuncia reciproca o assunzione dell’obbligo<br />
<strong>di</strong> rinuncia: sono tutte figure comprese nell’art. 458 c.c., dunque affette da nullità; b) promessa <strong>di</strong> rinuncia : è<br />
reputata nulla (Schlesinger, Liserre); c) rinuncia unilaterale alla futura ere<strong>di</strong>tà (che sarebbe poi la vera e<br />
propria forma della rinuncia <strong>di</strong>smissiva): anch’essa è nulla (Cariota Ferrara, Ferri). Ratio: rischio <strong>di</strong><br />
pro<strong>di</strong>galità; in linea generale, non si ammette la rinuncia a <strong>di</strong>ritti futuri (Moscarini, Bozzi). La rinuncia non si<br />
presume mai, dunque per avere rilevanza (seppure ai fini <strong>di</strong> una sua nullità) occorre un atto scritto.<br />
DISTINZIONE DEGLI ATTI IN RIFERIMENTO ALLA MORTE<br />
ATTO INTER VIVOS Caratteri fondamentali: a) la produzione imme<strong>di</strong>ata degli effetti che la legge ricollega al<br />
tipo cui esso appartiene, stante la volontà <strong>dei</strong> soggetti <strong>di</strong> vincolarsi attualmente ed irrevocabilmente dal<br />
giorno in cui esso è concluso; b) considerazione del bene oggetto del negozio come entità da commisurarsi<br />
nel momento della perfezione dell’atto e comunque ante mortem (Betti).<br />
ATTO MORTIS CAUSA Ogni atto che risulta <strong>di</strong>retto a <strong>di</strong>sciplinare rapporti o situazioni - patrimoniali e non -<br />
che vengono a formarsi, in via originaria, con la morte del soggetto o che dalla sua morte traggono<br />
comunque una loro autonoma qualificazione, ma dal quale nessun effetto prodromico o preliminare<br />
scaturisce prima della morte del medesimo, implicando la con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> sopravvivenza del beneficiario<br />
all’attribuente (la morte, perciò, è causa <strong>di</strong> attribuzione: Giampiccolo). Rientra in questa categoria la donatio<br />
mortis causa, ma non la donazione cum moriar, si moriar, si praemoriar (Torrente; Cass. 11.11.1988 n.<br />
6083): per essere “a causa <strong>di</strong> morte” l’attribuzione deve essere destinata ad operare soltanto dopo la morte<br />
del <strong>di</strong>sponente (il rapporto non è preesistente, ma trova origine solo con la morte <strong>di</strong> una persona). L’atto<br />
mortis causa può avere ad oggetto l’intero patrimonio del <strong>di</strong>sponente o un singolo bene o più beni<br />
determinati (Giampiccolo, De Giorgi). Requisiti: 1) l’oggetto deve essere un quod superest al momento della<br />
morte (in tutti i suoi aspetti: esistenza, consistenza, modo <strong>di</strong> essere); 2) il beneficiario deve sopravvivere al<br />
<strong>di</strong>sponente. Non è atto mortis causa quando l’attribuzione, se pure sottoposta alla con<strong>di</strong>zione sospensiva o<br />
al termine iniziale della morte dell’attribuente, è tuttavia attuale e non de residuo ed il bene è sottratto, sin dal<br />
tempo della conclusione, al potere <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizione del soggetto (Giampiccolo). Concettualmente l’atto a<br />
causa <strong>di</strong> morte può essere sia bilaterale (contratto ere<strong>di</strong>tario), sia unilaterale (testamento). Nel nostro<br />
or<strong>di</strong>namento sono vietati tutti gli atti a causa <strong>di</strong> morte bilaterali (artt. 457 e 458 c.c.) per il principio della<br />
libertà testamentaria. L’unico atto a causa <strong>di</strong> morte riconosciuto è altresì unilaterale e revocabile - il<br />
testamento - ossia un atto a causa <strong>di</strong> morte <strong>di</strong> ultima volontà (genus/species). Tipici atti a causa <strong>di</strong> morte<br />
sono il patto successorio istitutivo in senso stretto e la donazione a causa <strong>di</strong> morte.<br />
ATTO MORTIS CAUSA DI ULTIMA VOLONTA’ Species dell’atto a causa <strong>di</strong> morte, è un negozio<br />
necessariamente a struttura unilaterale, in cui la morte segna il doppio fenomeno rilevanza giuri<strong>di</strong>ca/efficacia<br />
del negozio, è essenzialmente revocabile e non recettizio, ossia rileva nei confronti <strong>dei</strong> terzi solo dopo la<br />
morte dell’autore, non produce effetti verso i terzi fino a tale evento, né origina aspettative giuri<strong>di</strong>camente<br />
protette (Giampiccolo).<br />
Oltre all’atto mortis causa vi sono degli atti “connessi alla morte”:<br />
ATTO TRANS MORTEM E’ l’atto compiuto sotto modalità <strong>di</strong> morte, in cui cioè l’evento morte rileva come<br />
modalità del negozio (sono le alternative in senso stretto al testamento): requisiti <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà: 1) il bene esce<br />
dal patrimonio del <strong>di</strong>sponente prima della sua morte; 2) l’attribuzione <strong>di</strong>viene definitiva solo dopo la morte del<br />
<strong>di</strong>sponente, cosicché egli possa ancora <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> quel bene e vanificare l'attribuzione medesima; 3) il<br />
<strong>di</strong>sponente, infatti, può ad libitum mo<strong>di</strong>ficare l’assetto patrimoniale pre<strong>di</strong>sposto (dunque, revoca dell’atto: ad<br />
esempio, contratto a favore <strong>di</strong> terzo con effetto post mortem: art. 1411 c.c.; ren<strong>di</strong>ta vitalizia: art. 1872 c.c.;<br />
vitalizio alimentare, come alternativa al legato alimentare, ex art. 660 c.c.; mandato post mortem).<br />
ATTO INTER VIVOS POST MORTEM E’ l’atto tra vivi nel quale l’evento della morte si inserisce come<br />
termine <strong>di</strong> efficacia o come con<strong>di</strong>zione, perciò regola una situazione preesistente alla morte del soggetto pur<br />
subor<strong>di</strong>nandone gli effetti a tale evento (Palazzo, De Giorgi, Nicolò)(sono alternative in senso lato al<br />
testamento): i requisiti <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà sono gli stessi dell’atto trans mortem, ma l’atto non è revocabile (ad<br />
esempio, la donazione modale con adempimento dell’onere post mortem, la donazione cum moriar o si<br />
praemoriar). Per la vali<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> questo atto si deve <strong>di</strong>mostrare che la morte incide sulla produzione dell’effetto,<br />
ma non è fattore causale (Formichelli).<br />
CAPACITA' DI SUCCEDERE IN GENERE (art. 462 c.c.)<br />
PERSONE FISICHE Per l'art. 462 c.c. (regola) sono capaci <strong>di</strong> succedere tutti coloro che sono nati (vivi) o già<br />
concepiti al tempo dell'apertura della successione. Prova del concepimento al tempo dell'apertura della<br />
successione (per la prova in tal senso cfr. il collegamento degli artt. 462, 2 comma e 232 c.c.). La chiamata<br />
del concepito si considera come fattispecie <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zione sospensiva legale (evento della nascita, il bambino<br />
deve nascere vivo). L'amministrazione <strong>dei</strong> beni ere<strong>di</strong>tari del concepito spetta ai genitori esercenti la potestà<br />
genitoria (art. 643 c.c.: tesi della rappresentanza in incertam personam) (<strong>di</strong>stinzione dalla fattispecie <strong>di</strong><br />
ere<strong>di</strong>tà giacente). Non sussisterebbe delazione a favore della persona <strong>di</strong> cui s’ignora l’esistenza (art. 70 c.c.)<br />
(contra Cicu, per il quale non occorrerebbe neppure la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> assenza; per Ferri e Coviello si<br />
porrebbe invece il problema, sul piano probatorio e non sostanziale, dell’impossibilità <strong>di</strong> fornire la prova della<br />
sopravvivenza della persona al de cuius, ex art. 69 c.c.).
PERSONE GIURIDICHE Prima dell’abrogazione dell’art. 17 c.c. (attuata con l. 15.5.1997 n. 127), erano<br />
capaci <strong>di</strong> succedere - previa autorizzazione (con<strong>di</strong>cio iuris <strong>di</strong> efficacia dell’acquisto, con effetti ex tunc) e con<br />
l’obbligo <strong>di</strong> accettare con beneficio <strong>di</strong> inventario (art. 473 c.c., escluse le società commerciali) - le persone<br />
giuri<strong>di</strong>che sia pubbliche sia private (compresi gli enti ecclesiastici: l. 222/85). E’ dubbia la capacità<br />
successoria delle persone giuri<strong>di</strong>che in stato <strong>di</strong> liquidazione (Trib. Napoli 24.3.1980); è esclusa la capacità<br />
successoria della persona giuri<strong>di</strong>ca estinta.<br />
ENTI NON RICONOSCIUTI Necessità <strong>di</strong> accettazione con beneficio <strong>di</strong> inventario; natura perentoria <strong>dei</strong><br />
termini per richiedere il riconoscimento (art. 600 c.c.; art. 3 <strong>di</strong>sp. att. c.c.; art. 786 c.c.). Sono compresi gli enti<br />
non esistenti, neppure <strong>di</strong> fatto, o che sono istituiti nello stesso testamento (Cass. 27.2.1997 n. 1806; Trib.<br />
Voghera 28.1.1998). La l. 22.6.2000 n. 192 ha abrogato le <strong>di</strong>sposizioni che prevedevano il riconoscimento o<br />
le autorizzazioni per accettare lasciti e donazioni. Così, sono stati abrogati (oltre l’art. 17 c.c.) l’art. 600, il<br />
quarto comma dell’art. 782 e l’art. 786 c.c. (nonché le altre <strong>di</strong>sposizioni che prescrivono autorizzazioni per<br />
l’acquisto <strong>di</strong> immobili o per accettazione <strong>di</strong> donazioni, ere<strong>di</strong>tà e legati da parte <strong>di</strong> persone giuri<strong>di</strong>che, ovvero il<br />
riconoscimento o autorizzazioni per l’acquisto <strong>di</strong> immobili o per accettazione <strong>di</strong> donazioni, ere<strong>di</strong>tà e legati da<br />
parte delle associazioni, fondazioni e <strong>di</strong> ogni altro ente non riconosciuto). Inoltre, è stato novellato l’art. 473<br />
c.c. (Ere<strong>di</strong>tà devolute a persone giuri<strong>di</strong>che o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti):<br />
“L’accettazione delle ere<strong>di</strong>tà devolute alle persone giuri<strong>di</strong>che o ad associazioni, fondazioni ed enti non<br />
riconosciuti non può farsi che col beneficio <strong>di</strong> inventario. Il presente articolo non si applica alle società”.<br />
INDEGNITA’ A SUCCEDERE L’indegnità a succedere non è una sanzione penale perché in molti casi si<br />
prescinde dalla condanna e sopravvive all'estinzione del reato. Presupposto fondamentale è l’imputabilità del<br />
soggetto. Può definirsi perciò una sanzione privata con fondamento pubblicistico (App. Brescia 20.7.1951;<br />
Trib. Roma 27.6.1962; Cass. 26.8.1986 n. 5209; Cass. 21.6.1993 n. 6859; Trib. Cagliari 22.8.1994). Teorie<br />
sulla natura giuri<strong>di</strong>ca dell’indegnità: a) tesi minoritaria (incapacità a succedere ipso iure al verificarsi delle<br />
cause previste dall'art. 463 c.c.: azione imprescrittibile, sentenza <strong>di</strong>chiarativa); b) tesi maggioritaria (causa <strong>di</strong><br />
rimozione ex post dall'ere<strong>di</strong>tà o dal legato: azione prescrittibile in <strong>di</strong>eci anni, sentenza <strong>di</strong> tipo costitutivo); c)<br />
tesi interme<strong>di</strong>a (si tratterebbe <strong>di</strong> esclusione ipso iure, ma vi sarebbe comunque la necessità <strong>di</strong> un<br />
accertamento giu<strong>di</strong>ziale). Cause <strong>di</strong> indegnità: sono tassativamente previste all’art. 463 c.c. (non si può<br />
ricorrere all’analogia): a) fatti contro la persona fisica o morale del de cuius (o <strong>dei</strong> suoi stretti congiunti); b)<br />
fatti contro il testamento o la libertà testamentaria (Cass. 11.12.2000 n. 15375). Con la legge 137/2005 è<br />
indegno altresì il genitore decaduto dalla potestà genitoria nei confronti della persona della cui successione<br />
si tratta, a norma dell’art. 330 c.c., non reintegrato nella potestà stessa alla data <strong>di</strong> apertura della<br />
successione. Azione <strong>di</strong> indegnità: ha natura <strong>di</strong> accertamento costitutivo; legittimazione ad agire (interesse<br />
patrimoniale e morale); effetti retroattivi della sentenza (caducazione ex tunc della delazione legittima o<br />
testamentaria a favore dell'indegno); prescrizione or<strong>di</strong>naria (<strong>di</strong>eci anni); rinunciabilità. Conseguenze della<br />
retroattività ex tunc della sentenza: restituzione <strong>dei</strong> frutti (l’indegno si reputa un possessore in malafede); è<br />
presupposto della rappresentazione; caducazione degli atti <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizione compiuti dall’indegno (salva la<br />
<strong>di</strong>sciplina sull’erede apparente <strong>di</strong> cui all’art. 534 c.c.); usufrutto legale, ex art. 465 c.c. Riabilitazione<br />
dell'indegno: l’atto ha natura negoziale (fa parte del contenuto atipico del testamento); è un atto personale<br />
(non è ammessa la rappresentanza); necessità <strong>di</strong> forma (atto pubblico o testamento); la capacità richiesta è<br />
quella <strong>di</strong> fare testamento; irrevocabilità della riabilitazione (atto <strong>di</strong> perdono); possibilità <strong>di</strong> riabilitazione totale<br />
o parziale (art. 466, 2 comma c.c.).<br />
SUCCESSIONE LEGITTIMA (artt. 565 e ss. c.c.) Ai sensi dell’art. 457, 2 comma c.c., la successione<br />
legittima (per legge o ab intestato) interviene per sostituire o integrare (totalmente o parzialmente) il<br />
testamento (mancante, invalido, parziale, revocato, inefficace)(Tamburrino). Fondamento: tutela (oggettiva)<br />
della famiglia legittima e naturale, quale istituto <strong>di</strong> rilevanza sociale. La successione legittima si fonda sulla<br />
solidarietà familiare; l’ambito della famiglia legittima è nei termini dell’art. 77 c.c., mentre l’ambito <strong>di</strong><br />
riconoscimento della famiglia naturale è assai più limitato, soprattutto per quanto concerne la linea<br />
collaterale (per l’interpretazione restrittiva dell’art. 258 c.c.). Superati i limiti dell’art. 77 c.c., si apre<br />
necessariamente la successione dello Stato. Soggetti (successori legittimi): coniuge (è escluso dalla<br />
successione il coniuge <strong>di</strong>vorziato - Cass. 25.2.2004 n. 3747 - o separato con addebito dal de cuius e<br />
valgono regole particolari per il coniuge putativo; è escluso il convivente more uxorio: Corte cost. 26.5.1989<br />
n. 310); figli legittimi, legittimati, adottivi o naturali (cioè, riconosciuti volontariamente o <strong>di</strong>chiarati<br />
giu<strong>di</strong>zialmente, anche dopo la morte del de cuius; gli effetti del riconoscimento o della sentenza sono<br />
retroattivi e dunque il figlio naturale viene reimmesso nella successione del genitore, ma altresì irretroattivi<br />
perché solo dalla data del giu<strong>di</strong>cato decorre il termine per accettare o rinunziare l’ere<strong>di</strong>tà, ai sensi dell’art.<br />
480 c.c.: Cass. 21.3.1990 n. 2326; Cass. 7.4.1990 n. 2923); i fratelli naturali (illegittimità costituzionale<br />
dell’art. 565 c.c.: Corte cost. 4.7.1979 n. 55; Corte cost. 12.4.1990 n. 184, sulla base non della parentela, ma<br />
della c.d. consanguineità) (anche <strong>di</strong> recente, è stata esclusa la successione fra cugini naturali: Corte cost.<br />
27.7.2000 n. 532); vale la regola “il prossimo esclude il remoto”, salva l’applicazione della <strong>di</strong>sciplina sulla<br />
rappresentazione; l’attribuzione delle quote avviene per stirpi (o categorie).<br />
BIBLIOGRAFIA
Albanese, Il tempo e il luogo dell’apertura della successione, in Vita not., 2008, p. 379 ss.; Albanese, L’indegnità a succedere dopo la l.<br />
8 luglio 2005, n. 137, in Contratto e impresa, 2006, p. 854 ss.; Antonini, Il <strong>di</strong>vieto <strong>dei</strong> patti successori, in Stu<strong>di</strong>um iuris, 1996, I, p. 601;<br />
Azzariti, Dichiarazione <strong>di</strong> morte presunta e apertura della successione, in Giur. mer., 1988, I, p. 257 ss.; Bonilini, La riabilitazione<br />
dell’indegno, in Stu<strong>di</strong>um iuris, 1997, II, p. 1141 ss.; Brunese, Indegnità a succedere, in Nuova giur. civ. comm., 1987, I, p. 220 ss.;<br />
Caccavale, Patti successori: il sottile confine tra nullità e vali<strong>di</strong>tà, in Notariato, 1995, I, 1, p. 554; Caccavale, Il <strong>di</strong>vieto <strong>dei</strong> patti<br />
successori, in Successioni e donazioni a cura <strong>di</strong> P.Rescigno, I, Padova 1994, p. 25; Carbone, Il problema della sopravvivenza dell’art.<br />
473 c.c. dopo l’abrogazione dell’art. 17 c.c., in Dir. e giur., 1999, p. 248 ss.; Carnevali, L’abrogazione degli artt. 600, 782 ultimo comma<br />
e 786 del co<strong>di</strong>ce civile, in Contratti, 2000, p. 761; Castronovo, Istituzione <strong>di</strong> ente estinto e successione dell'ente subentrato, in Vita not.,<br />
1991, p. 823 ss.; De Giorgi, I patti sulle <strong>successioni</strong> future, Napoli 1976; De Giorgi, voce Patto successorio, in Enc. del <strong>di</strong>r., XXXII,<br />
Milano 1982, p. 533; De Nova, voce Successioni anomale legittime, in Dig. <strong>di</strong>sc. priv., sez. civ., XIX, Torino 1999, p. 182 ss.;<br />
Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento, Milano 1954; Giampiccolo, voce Atto mortis causa, in Enc. del <strong>di</strong>r., I, Milano 1959, p.<br />
232 ss.; Guerinoni, La Corte costituzionale ancora sulla successione legittima <strong>dei</strong> parenti naturali, in Corr. giur., 2001, p. 1935 ss.;<br />
Iaccone, Le <strong>successioni</strong> legittime anomale, fra <strong>di</strong>ritto privato e interesse pubblico economico, in Vita not., 1998, II, p. 551 ss.; Ieva, I<br />
fenomeni parasuccessori, in Successioni e donazioni a cura <strong>di</strong> P. Rescigno, I, Padova 1994, p. 53 ss.; Ieva-Rastello, Le <strong>successioni</strong><br />
anomale legali, in Riv. not., 1991, II, p. 1187 ss.; Moscati, L’indegnità, in Trattato <strong>di</strong> <strong>di</strong>r. priv. <strong>di</strong>retto da P. Rescigno, 5, III, Torino 1982,<br />
p. 73 ss.; Moscati, Questioni vecchie e nuove in tema <strong>di</strong> capacità <strong>di</strong> succedere e <strong>di</strong> indegnità, in Familia, 2006, p. 39 ss.; Pagliantini,<br />
L’istituzione <strong>di</strong> ente estinto, in Riv. <strong>di</strong>r. civ. 2000, p. 123 ss.; Palazzo, Autonomia contrattuale e <strong>successioni</strong> anomale, Napoli 1983;<br />
Palazzo, Attribuzioni patrimoniali tra vivi e assetti successori per la trasmissione della ricchezza familiare, in Vita not., 1993, II, p. 1228<br />
ss.; Palazzo, Negozi trans mortem e donazioni in<strong>di</strong>rette nella dottrina civilistica del secondo dopoguerra, in Scritti in onore <strong>di</strong> A.Falzea,<br />
2, Diritto Privato, Milano 1991; Ruperto, voce Indegnità a succedere, in Enc. giur. Treccani, XVI, Roma 1989; Tamburrino, voce<br />
Successione legittima (<strong>di</strong>r. priv.), in Enc. del <strong>di</strong>r., XLIII, Milano 1990, p. 1323 ss.<br />
A) Esercitazione in classe<br />
PARTE PRATICA<br />
Tizio, coniugato con Sempronia, intende <strong>di</strong>sporre con testamento pubblico del suo patrimonio il cui valore<br />
complessivo ammonta ad euro 120.000, come segue:<br />
1. Al figlio Caio intende lasciare il solo fondo Tiberino del valore <strong>di</strong> euro 20.000 gravato da un debito<br />
ipotecario per euro 10.000; il testatore precisa che desidera che il debito ipotecario gravi sulla quota<br />
<strong>di</strong>sponibile;<br />
2. Al figlio Cornelio, <strong>di</strong>chiarato indegno nei suoi confronti per avere tentato <strong>di</strong> ucciderlo, intende lasciare<br />
esclusivamente la casa sita in Roma, a<strong>di</strong>bita a residenza familiare, il cui valore - comprensivo<br />
dell'arredamento - è <strong>di</strong> euro 29.000;<br />
3. Al figlio irriconoscibile Valerio intende lasciare i <strong>di</strong>ritti spettanti per legge;<br />
4. Alla moglie Sempronia, in base ad un previo accordo stipulato verbalmente con la stessa, intende lasciare<br />
la villetta <strong>di</strong> Tivoli del valore <strong>di</strong> euro 16.000, con facoltà <strong>di</strong> richiedere eventualmente quanto ulteriormente<br />
necessario ad integrare la quota <strong>di</strong> legittima a lei spettante;<br />
6. Intende inoltre rinunciare ai <strong>di</strong>ritti a lui spettanti sull’ere<strong>di</strong>tà del defunto padre in favore del solo coerede<br />
Filano, nonché trasferire i <strong>di</strong>ritti a lui eventualmente spettanti sull’ere<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> Primo, ancora in vita ma in<br />
precarie con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> salute, a Secondo, che, presente anch’egli <strong>di</strong>nanzi al notaio, si <strong>di</strong>chiara d’accordo;<br />
7. Niente intende <strong>di</strong>sporre relativamente al figlio naturale riconosciuto Filano, desiderando che, in or<strong>di</strong>ne al<br />
restante suo patrimonio, si apra la successione legittima.<br />
Il testatore <strong>di</strong>chiara inoltre che è sua ferma volontà che la propria salma venga cremata e non inumata e<br />
desidera nominare esecutore testamentario Catullo.<br />
Desidera inoltre raccomandare a Licinio <strong>di</strong> smettere <strong>di</strong> fumare.<br />
Nel presupposto che il testatore intenda adeguare le proprie volontà alle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge, il can<strong>di</strong>dato -<br />
assunto il nome del notaio Romolo Romani <strong>di</strong> Roma, con stu<strong>di</strong>o in via Girolamo Induno n. 1 - re<strong>di</strong>ga il<br />
testamento e tratti <strong>dei</strong> principi che regolano la successione del coniuge e del figlio naturale, nonché del<br />
legato in sostituzione <strong>di</strong> legittima.<br />
- - Legato in sostituzione <strong>di</strong> legittima (nozione <strong>di</strong> legittima; <strong>di</strong>stinzione rispetto al legato in conto <strong>di</strong> legittima;<br />
ammissibilità con riferimento ai <strong>di</strong>ritti attribuiti ex lege al coniuge non separato, al coniuge separato con<br />
addebito, al coniuge <strong>di</strong>vorziato, al figlio naturale non riconoscibile).<br />
- - Indegnità: nozione, natura, presupposti, effetti; riabilitazione; indegnità e <strong>di</strong>seredazione.<br />
- - Successioni anomale.<br />
- - Patti successori istitutivi, <strong>di</strong>spositivi, rinunziativi; brevi cenni al patto <strong>di</strong> famiglia, <strong>di</strong>sposizioni testamentarie<br />
esecutive <strong>di</strong> patti successori.<br />
- - Rinunzia all’ere<strong>di</strong>tà in favore <strong>di</strong> tutti gli altri chiamati, in favore <strong>di</strong> alcuni soltanto <strong>di</strong> essi e rinunzia verso<br />
corrispettivo.<br />
- - Concorso della successione legittima e della successione testamentaria: unicità della delazione.<br />
- - Contenuto atipico del testamento.<br />
B) Casi in classe
1) Scomparsa, assenza, morte presunta<br />
Quintilio, celibe e senza figli, ha quattro fratelli: Primo, Secondo, Terzo e Quarto;<br />
con testamento pubblico in data 10 luglio 1998 <strong>di</strong>spone dell’usufrutto sul fondo Tusculano a favore <strong>di</strong><br />
Secondo;<br />
poco dopo Secondo scompare, e nell’autunno del 2000 viene <strong>di</strong>chiarato assente;<br />
il 7 luglio 2001 Quintilio muore;<br />
il 30 gennaio 2002 Primo, Terzo e Quarto vendono a Caio il fondo Tusculano in piena proprietà;<br />
dopo qualche tempo Secondo ricompare;<br />
si recano oggi dal notaio RR, Caio, Secondo e Sempronio, per perfezionare la ven<strong>di</strong>ta del fondo Tusculano a<br />
favore <strong>di</strong> Sempronio; chi risulta legittimato alla ven<strong>di</strong>ta?<br />
2) Scomparsa, assenza, morte presunta<br />
Mevio, celibe e senza figli, scompare durante una gara velica il giorno 2 agosto 1990; il 15 settembre 2004<br />
viene <strong>di</strong>chiarata la sua morte presunta; la sentenza determina la data al 2 agosto 1990;<br />
Mevio ha lasciato un fratello, Caio, e due cugini Sempronio e Sempronia;<br />
questi ultimi due, con atto del notaio Fiorenzo Fiorentini del 1^ aprile 1995, hanno accettato l’ere<strong>di</strong>tà <strong>di</strong><br />
Mevio;<br />
Caio, a sua volta, ha accettato l’ere<strong>di</strong>tà, ma solo nel 2005;<br />
si recano oggi dal notaio RR, Caio, Sempronio e Sempronia, unitamente a Tizio, per perfezionare la ven<strong>di</strong>ta<br />
dell’appartamento in Roma, via Merulana, facente parte del patrimonio <strong>di</strong> Mevio;<br />
chi è legittimato alla ven<strong>di</strong>ta?<br />
3) Scomparsa, assenza, morte presunta<br />
Ulpiano, vedovo, scompare il 10 settembre 1995, lasciando due soli figli: Caio e Caia;<br />
questi provvedono con atto del 3 marzo 2000, a <strong>di</strong>vidersi il patrimonio <strong>di</strong> Ulpiano; a Caia viene assegnato,<br />
tra gli altri beni, un appartamento a Ostia;<br />
nell’anno 2007 viene <strong>di</strong>chiarata la morte presunta <strong>di</strong> Ulpiano, a far data dalla scomparsa;<br />
si recano oggi dal notaio RR, Caia e Sempronio, per perfezionare la ven<strong>di</strong>ta dell’appartamento <strong>di</strong> Ostia; è<br />
presente anche Caio, <strong>di</strong>sponibile, se il notaio lo richiederà, a rinnovare la <strong>di</strong>visione del 2000, prima della<br />
ven<strong>di</strong>ta.<br />
4) Patti successori<br />
Tizio <strong>di</strong>chiara al notaio RR, <strong>di</strong> essersi obbligato con il fratello Sempronio, ad istituirlo erede universale;<br />
in corrispettivo, da circa due anni, sta riscuotendo un assegno mensile dal fratello.<br />
Egli tuttavia rimette al notaio il giu<strong>di</strong>zio sulla vali<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> tale accordo aggiungendo che in subor<strong>di</strong>ne sarebbe<br />
sua intenzione istituire erede una associazione <strong>di</strong> volontariato <strong>di</strong> carattere religioso.<br />
5) Patti successori<br />
Tizio e Caio vendono, in data 15 marzo 2005, a Sempronio, l’appartamento <strong>di</strong> Roma, via Flaminia 160,<br />
appartenente alla zia Catulla, che versa in gravi con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> salute e della quale sono i presumibili unici<br />
successori;<br />
Catulla muore pochi giorni dopo, lasciando effettivamente unici ere<strong>di</strong> Tizio e Caio;<br />
si recano oggi dal notaio RR Sempronio e Mevio, per perfezionare la ven<strong>di</strong>ta dell’appartamento in questione;<br />
sono presenti anche Tizio e Caio, per prestare il loro consenso alla ven<strong>di</strong>ta se ciò sarà ritenuto necessario<br />
dal notaio.<br />
6) Patti successori (e contratto <strong>di</strong> mantenimento)<br />
Tizio si reca dal notaio insieme con Sempronio e chiede al notaio <strong>di</strong> re<strong>di</strong>gere un contratto con cui Sempronio<br />
si obblighi a prestare a Tizio vita natural durante, vitto, alloggio, vestiario, cure me<strong>di</strong>che e trasporto, nonché<br />
ospitarlo nella sua casa <strong>di</strong> campagna, attribuendogli altresì la facoltà <strong>di</strong> ospitare occasionalmente parenti e<br />
amici.<br />
In corrispettivo <strong>di</strong> quanto sopra, Tizio intende trasferire a Sempronio la proprietà della sua casa sita Roma<br />
con effetto a partire dalla propria morte; intende però riservarsi la facoltà <strong>di</strong> vendere il bene in caso <strong>di</strong> suo<br />
assoluto bisogno;<br />
in tal caso però a Sempronio spetterebbe un adeguato compenso per le prestazioni eseguite.<br />
7) Contratto a favore <strong>di</strong> terzo, designazione con testamento<br />
Tizio celibe senza figli, ha, quali ere<strong>di</strong> legittimi, soltanto due fratelli, anch'essi celibi, Primo e Secondo.<br />
In data 12 maggio 1998 stipula con Filano l’acquisto da quest'ultimo <strong>di</strong> un appartamento in Forte <strong>dei</strong> Marmi,<br />
con il patto che esso venga trasferito, alla morte <strong>di</strong> Tizio, <strong>di</strong>rettamente da Filano a quello <strong>dei</strong> due fratelli che,<br />
durante i suoi ultimi anni <strong>di</strong> vita, lo avrà assistito e che verrà designato dallo stesso Tizio con successivo<br />
testamento;
Tizio designa con testamento del 31 ottobre 2007, quale beneficiario Primo;<br />
il 15 novembre 2007 Primo e Tizio muoiono insieme in un incidente stradale;<br />
si recano oggi dal notaio RR, Secondo e Tizietto, unico erede <strong>di</strong> Tizio (Recte: Primo), per vendere a Cornelia<br />
l’appartamento; chi è legittimato alla ven<strong>di</strong>ta?<br />
8) Donazione cum moriar<br />
Tizio intende donare a Caio l'usufrutto del fondo Tuscolano con decorrenza dalla propria morte.<br />
9) Contenuto atipico del testamento, mandato post mortem<br />
Tizio desidera che nel testamento sia espressa la sua volontà <strong>di</strong> consentire l'espianto degli organi ed<br />
escludere che le sue spoglie mortali siano cremate, dovendo le stesse essere sepolte in una cappella<br />
funeraria da costruirsi su suolo cimiteriale.<br />
10) Ere<strong>di</strong>tà devoluta ai figli nascituri<br />
Tizio, con testamento pubblico del 15 <strong>di</strong>cembre 1998, nominava erede universale il figlio primogenito<br />
nascituro non concepito, del suo nipote ex fratre Caio.<br />
Tizio moriva il 15 <strong>di</strong>cembre 2000.<br />
Il 15 gennaio 2001 Caio, tuttora celibe, si reca dal notaio al fine <strong>di</strong> accettare espressamente, in nome e per<br />
conto del figlio nascituro, l'ere<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> Tizio e, successivamente vendere il fondo Tuscolano compreso<br />
nell'ere<strong>di</strong>tà stessa.<br />
Espone al notaio che Tizio ha lasciato come ere<strong>di</strong> legittimi lui (Caio) e suo fratello Sempronio. Il fondo<br />
Tuscolano deve essere venduto per riparare, con il ricavato della ven<strong>di</strong>ta, un e<strong>di</strong>ficio ere<strong>di</strong>tario.<br />
Sempronio, se necessario, è <strong>di</strong>sposto ad intervenire nell'atto per manifestare il suo consenso.<br />
11) Ere<strong>di</strong>tà devoluta ai figli nascituri<br />
Tizio vuole nominare erede universale il figlio Tizietto, intende altresì legare la somma <strong>di</strong> euro 100.000 ai<br />
primi due figli nascituri del nipote ex frate Filano e la somma <strong>di</strong> euro 150.000 alla prima figlia femmina della<br />
giovane sorella Caia.<br />
12) Diseredazione e contenuto necessario del testamento<br />
Tizio si reca dal notaio RR e gli espone <strong>di</strong> essere celibe, senza genitori viventi né <strong>di</strong>scendenti <strong>di</strong> sorta; ha<br />
quattro fratelli (Primo, Secondo, Terzo, e Quarto), con i quali ha avuto spesso qualche <strong>di</strong>scussione; in<br />
particolare intende <strong>di</strong>seredare espressamente Secondo e tutta la sua stirpe, senza però nominare<br />
espressamente ere<strong>di</strong> gli altri fratelli, affidandosi a quanto la legge vigente al momento della sua morte<br />
prevederà.<br />
C) Schema testamento pubblico<br />
D) Esercitazione a casa<br />
Tizio, celibe, sentendosi vicino alla morte, chiama il notaio Romolo Romani <strong>di</strong> Roma, e gli manifesta la<br />
volontà <strong>di</strong> fare testamento;<br />
intende lasciare il proprio patrimonio a Filano, che lo ha amorevolmente assistito negli ultimi anni <strong>di</strong> vita;<br />
vuole riconoscerlo come figlio naturale, se avranno esito positivo gli accertamenti me<strong>di</strong>ci già iniziati;<br />
vuole lasciare la villa sul lago <strong>di</strong> Bracciano alla associazione amici del Lago, che i suoi amici con i quali va a<br />
pesca da tempo, dovranno costituire alla sua morte;<br />
intende essere cremato ed a tale scopo <strong>di</strong>chiara al notaio <strong>di</strong> avere affidato fiduciariamente all’amico Polibio<br />
la somma <strong>di</strong> euro 50.000, con l’incarico <strong>di</strong> provvedervi e <strong>di</strong> consegnare quanto residuerà al comune amico<br />
Sofocle;<br />
vuole che Filano provveda alla migliore sistemazione delle salme <strong>dei</strong> propri familiari che si trovano nella<br />
cappella del Verano, dando corso alla concessione cimiteriale, da lui già richiesta, per una nuova cappella<br />
nel cimitero <strong>di</strong> Tuscolo;<br />
ha contratto un'assicurazione sulla vita in<strong>di</strong>cando come beneficiaria l'amica Sempronia, con la quale ha<br />
litigato; intende quin<strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare la designazione in favore dell'attuale compagna Cornelia;<br />
intende incaricare l'amico Terzilio <strong>di</strong> provvedere al pagamento <strong>di</strong> tutti i suoi debiti compresi quelli da lui<br />
stesso vantati, non fidandosi altro che <strong>di</strong> lui, e vuole che abbia a <strong>di</strong>sposizione i mezzi necessari;<br />
intende inoltre confermare all'amico avvocato Quarto l'incarico a proseguire, anche dopo la sua morte, la<br />
causa in essere nei confronti del Comune <strong>di</strong> Ostia.<br />
Tizio è molto debole e spira subito dopo avere sottoscritto l'atto, prima della sottoscrizione <strong>dei</strong> testimoni.<br />
Il can<strong>di</strong>dato, adeguate le volontà del testatore alle inderogabili <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge, re<strong>di</strong>ga il testamento <strong>di</strong><br />
Tizio e tratti in parte teorica, dopo aver motivato le soluzioni adottate, della capacità a succedere in generale,<br />
della capacità <strong>di</strong> testare e del contenuto atipico del testamento.
II LEZIONE (11.12.2012)<br />
Istituzione <strong>di</strong> ere<strong>di</strong>tà e istituzione <strong>di</strong> legato (art. 588, 1 comma c.c.). Istituzione ex re certa (art. 588, 2<br />
comma c.c.). La <strong>di</strong>seredazione (c.d. <strong>di</strong>sposizione testamentaria negativa). I legati (concetti generali).<br />
Sublegato e prelegato.<br />
PARTE TEORICA<br />
ISTITUZIONE A TITOLO UNIVERSALE (art. 588, 1 comma c.c.) L’art. 588, 1 comma c.c. offre la<br />
definizione ed i criteri <strong>di</strong> determinazione del titolo <strong>dei</strong> chiamati alla successione, a prescindere dalla<br />
terminologia utilizzata dal testatore: l'attribuzione formale, cioè, avrebbe solo un valore confermativo<br />
dell'indagine oggettiva, ma non avrebbe rilevanza, invece, se non conforme all'intrinseca natura della<br />
<strong>di</strong>sposizione: in ciò l'essenziale oggettività/patrimonialità dell'istituzione (Cass. 18.11.1981 n. 6110). La<br />
<strong>di</strong>sposizione in<strong>di</strong>ca un criterio essenzialmente oggettivo o matematico/quantitativo e si tratta <strong>di</strong><br />
in<strong>di</strong>viduazione ex lege perché si prescinde dalla volontà del testatore (Cass. 6.5.1968 n. 143). E’ erede chi<br />
succede nell’universalità del patrimonio quale complesso unitario delle attività/passività patrimoniali del de<br />
cuius, ovvero chi succede in una quota del medesimo: quota come consistenza proporzionale, frazione<br />
aritmetica, numericamente espressa, dell'universum ius defuncti (Cass. 17.12.1980 n. 6525; Trib. Salerno<br />
9.6.2000). Se più ere<strong>di</strong> sono istituiti con uno stesso testamento, ma senza determinazione <strong>di</strong> quote, si<br />
presume l'uguaglianza delle medesime (Cass. 20.6.1967 n. 1458). La ricostruzione della volontà del<br />
testatore, ai fini dell’art. 588, 1 e 2 comma c.c., deve avvenire ex ipso testamento e non aliunde (Cass.<br />
26.6.1976 n. 2417; Cass. 10.11.1977 n. 4865; Cass. 26.5.1989 n. 2556: contra Cass. 7.2.1987 n. 1266).<br />
L'istituzione ere<strong>di</strong>taria risponde ad una funzione <strong>di</strong>spositiva del testamento, non necessariamente attributiva<br />
(passività/legati/oneri). La successione legittima è a titolo ere<strong>di</strong>tario (salvo i legati ex lege come, ad esempio,<br />
i <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> cui agli artt. 580 o 594 c.c.).<br />
E’ possibile che il testamento contenga solo legati, pur <strong>di</strong>sponendo <strong>di</strong> tutto l'asse ere<strong>di</strong>tario (Cass. 20.3.1953<br />
n. 712; Trib. Pavia 21.5.1992): in tal caso si apre la successione legittima (art. 457 c.c.) per in<strong>di</strong>viduare<br />
l’erede.<br />
E’ valida la <strong>di</strong>sposizione testamentaria che non in<strong>di</strong>ca i soggetti nominativamente, ma per relationem<br />
(formale e non sostanziale), attraverso il richiamo alla successione legittima (Cass. 20.6.1967 n. 1458; Cass.<br />
18.3.1978 n. 1359; contra Cass. 7.3.1967 n. 1405).<br />
Usufrutto generale o pro quota: la <strong>di</strong>sposizione è considerata un legato, per la natura del <strong>di</strong>ritto (Cariota<br />
Ferrara, Giannattasio, Barbero, Bigliazzi Geri; Cass. 15.2.1979 n. 986; Cass. 23.5.2002 n. 7541): anche<br />
l’usufrutto uxorio (prima della riforma del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> famiglia del 1975) era reputato un legato, talchè il coniuge<br />
non entrava nella comunione ere<strong>di</strong>taria. Tuttavia si veda Cass. 12.9.2002 n. 13310.<br />
ISTITUZIONE EX RE CERTA (art. 588, 2 comma c.c.) Nell’art. 588, 2 comma c.c. si prevede l’attribuzione<br />
<strong>di</strong> beni determinati (res certa, complesso <strong>di</strong> beni o classi <strong>di</strong> beni: ad esempio, collezioni, tutti i beni immobili o<br />
tutti i beni mobili, ecc.) in funzione della quota proporzionale del patrimonio (la quota non è determinata, ma<br />
determinabile). Il patrimonio, cui rapportare la quota, è quello avuto presente dal testatore al tempo<br />
dell'attribuzione e non della morte (valutazione ex post); secondo alcuni, invece, la valutazione sarebbe da<br />
riportare al tempo dell'apertura della successione (Ama<strong>di</strong>o; Azzariti; Pugliatti). La norma è una novità del c.c.<br />
del 1942: prima tali istituzioni erano considerate sempre <strong>dei</strong> legati; nel <strong>di</strong>ritto romano tali <strong>di</strong>sposizioni erano<br />
inconcepibili perché contrastanti con la vis espansiva dell’ere<strong>di</strong>tà.<br />
Nell’art. 588, 2 comma c.c. la determinazione della quota si deduce da elementi sia oggettivi (rapporto<br />
proporzionale tra il valore <strong>dei</strong> beni determinati ed il valore dell'intero asse: Cass. 12.5.1972 n. 1368; Cass.<br />
26.10.1972 n. 3282), sia soggettivi relativi all’intenzione del testatore (sulla duplice interpretazione<br />
oggettiva/soggettiva: Cass. 20.12.1973 n. 3452; Cass. 21.1.1978 n. 72; Cass. 18.12.1981 n. 6110; App.<br />
Torino 26.5.1983; Cass. 28.11.1984 n. 6190; Cass. 16.11.1985 n. 5625; Cass. 6.11.1986 n. 6516; Cass.<br />
5.11.1987 n. 8123). Tuttavia, in dottrina, il criterio soggettivo per alcuni resterebbe escluso (Ruggiero;<br />
Pran<strong>di</strong>); per altri sarebbe solo suppletivo (Capozzi; Coviello) o confermativo (Bigliazzi Geri; Caramazza)<br />
rispetto a quello oggettivo in<strong>di</strong>cato dall’art. 588, 1 comma c.c. Per alcuni, per l'interpretazione della volontà<br />
del de cuius, si applicherebbero anche gli artt. 1362 ss. c.c. (Bigliazzi Geri; contra Pran<strong>di</strong>; Ruggiero; Cass.<br />
15.7.1980 n. 4582; Cass. 28.11.1986 n. 783; Cass. 7.2.1987 n. 1266; contra App. Torino 26.5.1983). Altri<br />
(Ama<strong>di</strong>o) reputano l’art. 588, 2 comma c.c. una norma d’interpretazione speciale, cioè a scopo prefissato rispetto<br />
alla libertà <strong>di</strong> cui all'art. 1362, 1 comma c.c.<br />
Tra i criteri adottati: a) il valore del lascito, anche se non rilevante (Capozzi; Cass. 7.4.1971 n. 1029); b) la<br />
consapevolezza del testatore delle <strong>di</strong>verse conseguenze fra erede e legatario; c) esaurimento dell'asse con<br />
l'istituzione ex re certa (Cass. 21.1.1978 n. 269); d) consistenza uniforme ed omogenea (Cass. 20.12.1973<br />
n. 3452); e) i rapporti <strong>di</strong> parentela tra de cuius e istituito; f) rapporto con l'intero (criterio dominante); g) per<br />
alcuni (Ama<strong>di</strong>o) anche la sopportazione <strong>dei</strong> debiti e pesi ere<strong>di</strong>tari, nonché la virtù espansiva della quota
attribuita (se escluse dal testatore l’istituzione sarebbe a titolo particolare). La giurisprudenza, poi, tende ad<br />
una tipizzazione (compen<strong>di</strong>o omogeneo, nuda proprietà, gruppi <strong>di</strong> beni - ere<strong>di</strong>tà - mentre l'usufrutto generale<br />
o altri <strong>di</strong>ritti reali minori sarebbero un legato).<br />
Per l'istituzione ex re certa non vale l'art. 651 c.c. perché i beni devono appartenere al testatore (Mengoni;<br />
Trib. Napoli 6.5.2002), perciò la <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> un bene altrui è un legato (salvo una legittimazione<br />
successiva o il possesso al tempo della morte). Alcuni ammettono l’applicazione analogica dell’art. 686 c.c.<br />
(Talamanca; contra Barbero; Azzariti Martinez; Scalisi): vi osterebbero la vis espansiva della quota ere<strong>di</strong>taria<br />
e la possibilità <strong>di</strong> una damnosa here<strong>di</strong>tas.<br />
Differenze<br />
Istituzione ex re certa e legato Il legato non può mai avere ad oggetto una quota astratta (pars quota) del<br />
patrimonio perché essa, per definizione della legge, in<strong>di</strong>ca l'istituzione <strong>di</strong> erede (criterio<br />
oggettivo/quantitativo: rapporto proporzionale tra il valore <strong>dei</strong> beni assegnati e quello del patrimonio). Perciò,<br />
si avrà legato se la specifica in<strong>di</strong>viduazione del bene attribuito è stato in sé considerato, senza alcuna<br />
relazione con l'intero e globale patrimonio (Cass. 6.11.1986 n. 6516).<br />
Istituzione ex re certa e beni omessi a) il testatore <strong>di</strong>spone <strong>di</strong> tutte le sostanze con istituzioni ex re certa<br />
(sono tutte ere<strong>di</strong>tà); b) il testatore <strong>di</strong>spone <strong>di</strong> una o più istituzioni ex re certa, ma non esaurisce il patrimonio:<br />
per questo caso sono state prospettate due soluzioni: 1b) il caso si risolverebbe con la vis espansiva della<br />
quota ere<strong>di</strong>taria (Coviello; Torrente; Cicu); 2b) Il caso si risolverebbe con il ricorso alla successione legittima<br />
(Mengoni; Bigliazzi Geri).<br />
Istituzione ex re certa e <strong>di</strong>visione del testatore (art. 734 c.c.) Rinvio<br />
ISTITUZIONE A TITOLO PARTICOLARE (art. 588, 1 comma c.c.)<br />
Il legato è una <strong>di</strong>sposizione a titolo particolare (singoli beni o <strong>di</strong>ritti determinati): l’art. 588, 1 comma c.c. ne<br />
dà una definizione legale in negativo; una definizione positiva del medesimo è offerta dalla dottrina (Masi;<br />
Giordano Mondello; Bion<strong>di</strong>): il legato costituirebbe una “attribuzione mortis causa imme<strong>di</strong>atamente operativa<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to o reali la cui portata rimane esclusivamente limitata ai singoli <strong>di</strong>ritti considerati”. Dunque, è<br />
legatario chi succede in uno o più <strong>di</strong>ritti reali (beni determinati o un complesso <strong>di</strong> beni determinati) o in uno o<br />
più rapporti specifici (criterio perciò solo oggettivo: Messineo). Il legato resta sempre un'attribuzione mortis<br />
causa (anche se costituisce un rapporto contrattuale a favore del legatario (<strong>di</strong>stinzione fra causa del<br />
contratto e causa del <strong>di</strong>ritto del legatario).<br />
Il legato avrebbe natura attributiva/attiva e non solo <strong>di</strong>spositiva: ma ciò è smentito dal sublegato o dalla<br />
possibile apposizione <strong>di</strong> un onere tali da assorbire l'intera <strong>di</strong>sposizione (art. 671 c.c.). In tali ipotesi il legato<br />
sarebbe uno strumento finalizzato ad un’effettiva attribuzione patrimoniale, tuttavia rivolta ad altri (sublegato)<br />
o al raggiungimento <strong>di</strong> ulteriori scopi avuti <strong>di</strong> mira dal testatore (modus).<br />
Inespansibilità del legato oltre quanto <strong>di</strong>sposto. Il legatario si trova sempre in posizione <strong>di</strong> inferiorità rispetto<br />
ai cre<strong>di</strong>tori ere<strong>di</strong>tari (artt. 495, 499 e 513 c.c.). Il legatario non è tenuto alla collazione e non succede nel<br />
possesso <strong>dei</strong> beni (art. 1146, 2 comma c.c.), né partecipa alla comunione ere<strong>di</strong>taria.<br />
Distinzioni<br />
Ere<strong>di</strong>tà e legato (supra)<br />
Legato e onere (rinvio)<br />
Legato <strong>di</strong> usufrutto con facoltà <strong>di</strong> vendere in caso <strong>di</strong> bisogno Per tale fattispecie sono state prospettate più<br />
soluzioni:<br />
a) nullità della clausola (con applicazione dell’art. 634 c.c.: valido il solo legato <strong>di</strong> usufrutto) perché<br />
incompatibile con l’essenza dell’usufrutto (limitato al go<strong>di</strong>mento e non comprensivo del potere <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre<br />
della piena proprietà); inoltre, perché spetterebbe all’onorato (usufruttuario) la determinazione<br />
dell’ammontare del lascito a favore del nudo proprietario (Talamanca; Cass. 23.10.1958 n. 3426);<br />
b) semplice istituzione <strong>di</strong> erede, considerando l’in<strong>di</strong>cazione dello stato <strong>di</strong> bisogno come raccomandazione,<br />
ovvero se il suo accertamento sia rimesso all’arbitrio incontrollato del successore (Cass. 18.5.1957 n. 7793;<br />
Cass. 19.2.1970 n. 389; Cass. 26.1.1976 n. 251; Cass. 26.7.1977 n. 3342);<br />
c) tesi preferibile del doppio legato e cioè il legato non è invalido (perché l’oggetto non è rimesso al mero<br />
arbitrio dell’onorato o <strong>di</strong> un terzo e perché lo stato <strong>di</strong> bisogno è oggettivamente sindacabile), ma vi sarebbero<br />
due legati: uno incon<strong>di</strong>zionato (usufrutto), l’altro con<strong>di</strong>zionato sospensivamente allo stato <strong>di</strong> bisogno<br />
(Capozzi; Cass. 9.12.1980 n. 6365: proprietà del denaro realizzato con la ven<strong>di</strong>ta della proprietà del bene;<br />
per Cass. 21.1.1985 n. 207 e Cass. 20.2.1993 n. 2088, invece, l’oggetto del secondo legato sarebbe la nuda<br />
proprietà, peraltro con l’obbligo <strong>di</strong> alienare la piena proprietà).<br />
PRELEGATO (art. 661 c.c.) Il prelegato è la <strong>di</strong>sposizione a favore <strong>di</strong> uno o più coere<strong>di</strong> (testamentari o<br />
legittimi) posta a carico <strong>di</strong> tutta l'ere<strong>di</strong>tà. Tale <strong>di</strong>ritto è sod<strong>di</strong>sfatto prima della <strong>di</strong>visione (art. 713 c.c.),<br />
riducendo l'ammontare <strong>dei</strong> beni da <strong>di</strong>videre (prelievo anticipato). Il prelegatario, poi, risponde <strong>dei</strong> debiti<br />
ere<strong>di</strong>tari solo per la parte che gli spetta come coerede. Anche il prelegato può essere gravato da un onere. Il<br />
prelegato è soggetto a riduzione in caso <strong>di</strong> lesione della legittima (Cass. 30.7.1999 n. 8284). E' ammesso il<br />
prelegato a favore dell'unico erede (Trib. Vallo <strong>di</strong> Lucania 17.4.2002); il legato resta valido anche se è nulla
l'istituzione <strong>di</strong> ere<strong>di</strong>tà (Giordano Mondello, Bianca, Capozzi; Cass. 26.6.1973 n. 1834; Cass. 23.3.1992 n.<br />
3593). Prelegato anomalo: prelegato a carico solo <strong>di</strong> alcuni <strong>dei</strong> coere<strong>di</strong> (Messineo).<br />
SUBLEGATO (artt. 662 e 671 c.c.) Il sublegato è la <strong>di</strong>sposizione a favore dell'onorato/legatario che grava<br />
su altro legatario. Trattasi <strong>di</strong> due <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong>stinte: perciò, il sublegatario non è avente causa del<br />
legatario, ma del de cuius. Infatti, il sublegato è un'autonoma e <strong>di</strong>retta attribuzione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti patrimoniali<br />
(Capozzi). L'autonomia del sublegato si evidenzia in caso <strong>di</strong> nullità (se la causa <strong>di</strong> nullità non vale per<br />
entrambi) o <strong>di</strong> rinunzia del legatario/onerato: infatti, il sublegato sarà a carico degli altri collegatari (per<br />
accrescimento) o, in loro mancanza, a carico degli ere<strong>di</strong> (art. 677 c.c. e, in tal caso, non varrà il limite <strong>di</strong> cui<br />
all’art. 671 c.c.); in caso <strong>di</strong> rinunzia dell'onorato, il sublegato si risolve a favore dell'onerato (salvo<br />
devoluzione).<br />
DISEREDAZIONE (o c.d. <strong>di</strong>sposizione testamentaria negativa) Nel nostro or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co, data la<br />
tutela <strong>dei</strong> legittimari, è stabilito implicitamente il <strong>di</strong>vieto della <strong>di</strong>seredazione per determinate categorie <strong>di</strong><br />
soggetti: coniuge, figli (per rappresentazione anche i <strong>di</strong>scendenti), ascendenti legittimi (per un caso <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>seredazione occulta <strong>dei</strong> legittimari: Cass. 19.3.1993 n. 10333). Si pone il problema se il testatore,<br />
nell’ambito della propria autonomia, possa manifestare una volontà <strong>di</strong>retta non solo ad istituire, ma anche ad<br />
escludere dalla successione uno o più successibili ex lege (esclusi, ovviamente, i legittimari: art. 457 c.c.). In<br />
dottrina prevale la tesi positiva (Bin, Trabucchi, Bigliazzi Geri, Lipari, contra Capozzi, Mengoni). La<br />
giurisprudenza, dopo una fase <strong>di</strong> assoluta inammissibilità della clausola, ha accolto una soluzione <strong>di</strong><br />
compromesso: la <strong>di</strong>seredazione è ammessa quando vi siano altresì delle <strong>di</strong>sposizioni positivamente<br />
attributive/<strong>di</strong>spositive: queste ultime, tuttavia, possono dedursi anche implicitamente dal contenuto del<br />
testamento (Cass. 20.6.1967 n. 1458; Cass. 23.11.1982 n. 6339; Cass. 18.6.1994 n. 5895; App. Cagliari<br />
12.1.1996; App. Catania 28.5.2003). Per altro orientamento, sulla base dell’autonomia negoziale del de<br />
cuius, si ammette che la <strong>di</strong>sposizione negativa possa validamente costituire l’intero contenuto del<br />
testamento (Trib. Catania 28.3.2000; App. Genova 16.6.2000). Se si ammette ciò, si aprirà, in virtù dell’art.<br />
457, 2 comma c.c., la successione legittima a favore <strong>dei</strong> successori legittimi non <strong>di</strong>seredati; se si ritiene<br />
valida la <strong>di</strong>sposizione testamentaria istitutiva implicita, invece, in favore <strong>dei</strong> non <strong>di</strong>seredati si dovrebbe<br />
ritenere aperta la sola successione testamentaria.<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
Bin, La <strong>di</strong>seredazione. Contributo allo stu<strong>di</strong>o del contenuto del testamento, Torino 1966; Bonilini, voce Legato, in Dig. <strong>di</strong>sc. priv., sez.<br />
civ., X, Torino 1993, p. 509; Bonilini, I legati, in Comm. c.c. Schlesinger, Milano 2001, p. 305; Bonilini, Institutio ex re certa e acquisto,<br />
per virtù espansiva, <strong>dei</strong> beni non contemplati nel testamento, in Fam. pers. succ., 2008, p. 530 ss.; Bonilini, Il lascito <strong>di</strong> usufrutto<br />
generale, in Fam. pers. succ., 2010, p. 245 ss.; Burdese, Istituzione ex re certa e <strong>di</strong>visione testamentaria, in Riv. <strong>di</strong>r. civ., 1986, II, p.<br />
465; Calapso, Alcune riflessioni sull'indagine della volontà del testatore nei casi <strong>di</strong> institutio ex re certa, in Vita not., 1982, p. 1371;<br />
Corona, La c.d. <strong>di</strong>seredazione: riflessioni sulla <strong>di</strong>sposizione testamentaria <strong>di</strong> esclusione, in Riv. not., 1992, I, p. 505 ss.; Cuffaro, voce<br />
Erede ed ere<strong>di</strong>tà, in Enc. giur. Treccani, XII, Roma 1989; Gardani Contursi Lisi, Istituzione <strong>di</strong> erede e legati, in Comm. al cod. civ. a<br />
cura <strong>di</strong> Scialoja e Branca (artt. 624-632 c.c.), Bologna-Roma 1983; Gerbo, L’institutio ex re certa e la volontà del testatore, in Riv. not.,<br />
2003, p. 220 ss.; Gerbo, Prelegato e funzione del contenuto testamentario nel fenomeno successorio, Roma 1995; Giordano<br />
Mondello, voce Legato, in Enc. del <strong>di</strong>r., XXXIII, Milano 1973, p. 719; Giorgianni, Legato modale (o sublegato) e azioni <strong>di</strong> riduzione, in<br />
Dir. e giur., 1959, p. 149 ss.; Masi, Dei legati, in Comm. al cod. civ. a cura <strong>di</strong> Scialoja e Branca, (artt. 649-673 c.c.), Bologna-Roma<br />
1979; Masi, voce Legato, in Enc. giur. Treccani, XVIII, Roma 1990; Napoli, Il legato, in Giur. sist. cod. civ. e comm. <strong>di</strong>retta da W.Bigiavi;<br />
Pastore, Il prelegato, in Riv. not., 2003, p. 393 ss.; Pastore, Il legato a carico <strong>di</strong> uno o più legatari (c.d. sublegato), in Riv. <strong>di</strong>r. civ., 2003,<br />
p. 223 ss.; Perego, I legati, in Trattato <strong>di</strong> <strong>di</strong>r. priv. a cura <strong>di</strong> P. Rescigno, VI, Successioni, 2, Torino 1982, p. 195; Ruggiero,<br />
Interpretazione delle <strong>di</strong>sposizioni testamentarie: natura del criterio previsto dal 2° comma dell’art. 588 c.c., in Giust. civ., 1973, IV, p.<br />
223; Russo, La <strong>di</strong>seredazione, Torino 1998; Trabucchi, voce Legato, in Novissimo Dig. It., IX, Torino 1963, p. 608.<br />
A) Esercitazione in classe<br />
PARTE PRATICA<br />
Tizio, che non può leggere né scrivere, titolare <strong>di</strong> un cospicuo patrimonio immobiliare, è coniugato con Tizia<br />
ed ha due figli <strong>di</strong> nome Caio e Sempronio; il figlio Sempronio a sua volta ha tre figli.<br />
Tizio, che per una lunga permanenza in Germania, parla stentatamente l'italiano, ma lo comprende, si reca<br />
dal notaio Romolo Romani <strong>di</strong> Roma, manifestandogli l'intenzione <strong>di</strong> far testamento in forma segreta e gli<br />
comunica <strong>di</strong> voler nominare ere<strong>di</strong> in parti uguali fra <strong>di</strong> loro i figli Caio e Sempronio, <strong>di</strong> voler <strong>di</strong>seredare la<br />
moglie, rea <strong>di</strong> averlo tra<strong>di</strong>to con Calpurnio e <strong>di</strong> voler pretermettere il figlio naturale Idomeneo.<br />
Intende, inoltre, legare la sua villetta ad Ostia per metà a quello <strong>dei</strong> figli <strong>di</strong> Sempronio che sarà in<strong>di</strong>cato da<br />
Caio e per l'altra metà a chiunque sarà parimenti in<strong>di</strong>cato da Caio, ed altresì legare l'intero fondo Tuscolano,<br />
<strong>di</strong> cui è comproprietario per una sola metà, al nipote ex fratre Filano, ponendo quest'ultimo legato a carico<br />
dell'erede Caio.<br />
Vuole attribuire a Crasso la villa <strong>di</strong> Formentera, precisando che è sua intenzione che costui sopporti, in<br />
proporzione, i debiti dell’ere<strong>di</strong>tà anche, se possibile, oltre il valore dell’attribuzione stessa.<br />
Vuole conferire a Filano l’usufrutto imme<strong>di</strong>ato sulla casa con vigneto in Provenza, mentre a Tito vuole<br />
attribuire l’usufrutto sul fondo Tuscolano, del quale è nudo proprietario.
Intende, inoltre, attribuire la piena proprietà dell’appartamento che possiede in Roma a Martino, con<br />
costituzione, su detto appartamento, <strong>di</strong> un usufrutto a favore <strong>di</strong> Antonio per l’epoca in cui Martino avrà<br />
cessato <strong>di</strong> vivere.<br />
Intende attribuire alla domestica Licinia un immobile, compreso nell’asse ere<strong>di</strong>tario, da scegliersi da parte <strong>di</strong><br />
Mario, amico del testatore, tenendo conto delle necessità <strong>di</strong> vita della domestica.<br />
Vuole legare a carico <strong>di</strong> Filano e a favore <strong>di</strong> Livio venti casse <strong>di</strong> vino prodotto dal proprio vigneto.<br />
Vuole, infine, attribuire a Pilato, affiliato alla malavita organizzata, la propria quota <strong>di</strong> proprietà<br />
sull’appartamento <strong>di</strong> Brin<strong>di</strong>si, confessando al notaio <strong>di</strong> essere spinto ad effettuare tale <strong>di</strong>sposizione dal solo<br />
motivo <strong>di</strong> indurre Pilato a perpetrare l’omici<strong>di</strong>o del proprio mortale nemico Caronte.<br />
Il can<strong>di</strong>dato, assumendo il nome del notaio Romolo Romani <strong>di</strong> Roma con stu<strong>di</strong>o alla via Induno n. 1, spieghi<br />
a Tizio se impe<strong>di</strong>menti legali si frappongano a che le sue intenzioni trovino pieno accoglimento e re<strong>di</strong>ga nel<br />
suo stu<strong>di</strong>o un testamento valido nella forma e nella sostanza.<br />
Il can<strong>di</strong>dato, altresì, esponga i principi dottrinali attinenti agli istituti giuri<strong>di</strong>ci relativi al testamento redatto.<br />
- Profili formali: legge notarile e testamento segreto;<br />
- Pretermissione <strong>di</strong> legittimari e <strong>di</strong>seredazione; <strong>di</strong>visione fatta dal testatore e posizione del legittimario<br />
nella <strong>di</strong>sciplina prevista dall’articolo 735 c.c.;<br />
- Disposizioni rimesse all’arbitrio del terzo e limiti <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà; determinazione <strong>di</strong> legato per arbitrio altrui;<br />
- Legato <strong>di</strong> cosa altrui e legato <strong>di</strong> cosa parzialmente altrui;<br />
- Institutio ex re certa;<br />
- Legato <strong>di</strong> usufrutto; sublegato; sublegato <strong>di</strong> usufrutto a termine iniziale coincidente con la morte del<br />
primo istituito;<br />
- Con<strong>di</strong>zione e motivo illeciti.<br />
B) Casi in classe<br />
1) Legati in sostituzione <strong>di</strong> legittima<br />
Tizio si reca dal notaio RR e gli espone <strong>di</strong> avere una moglie, Tizia, e due figli: Tizietto e Tizietta;<br />
il suo patrimonio consiste in tre palazzine assolutamente identiche e circa 1.200.000 euro in depositi bancari;<br />
vuole attribuire il tutto in parti uguali, senza far luogo a comunione; vuole però qualificare come legati le sue<br />
<strong>di</strong>sposizioni.<br />
2) Institutio ex re certa<br />
Tizio si reca dal notaio RR e gli espone <strong>di</strong> voler lasciare tutti i suoi beni immobili a Caio e tutti i suoi beni<br />
mobili a Sempronio.<br />
3) Divisione del testatore senza predeterminazione <strong>di</strong> quote, alienazione dell’unico bene attribuito ad<br />
uno <strong>dei</strong> coere<strong>di</strong> istituiti<br />
Tizio così <strong>di</strong>sponeva per testamento, nel 2002:<br />
“lascio a titolo <strong>di</strong> ere<strong>di</strong>tà la mia casa <strong>di</strong> Velletri a Caio e la mia casa <strong>di</strong> Anzio a Sempronio; non possiedo altro<br />
<strong>di</strong> rilevante”;<br />
nel 2008, poco prima <strong>di</strong> morire, per saldare un debito, vendeva a Quintilio la casa <strong>di</strong> Velletri;<br />
si recano oggi dal notaio RR Caio e Sempronio per vendere a Sestilio la casa <strong>di</strong> Anzio; costituire i soggetti<br />
legittimati alla ven<strong>di</strong>ta.<br />
C) Esercitazione a casa<br />
Tizio si reca dal notaio Romolo Romani <strong>di</strong> Roma e, premesso <strong>di</strong> essere coniugato con Tizia e <strong>di</strong> avere due<br />
figli Tizietto e Tizietta, gli manifesta l'intenzione <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre con testamento pubblico come segue:<br />
il suo patrimonio consiste in:<br />
un appartamento in Roma, del valore <strong>di</strong> 200.000 euro, un fondo in Lavinio, del valore <strong>di</strong> 200.000 euro e una<br />
palazzina in Velletri, del valore <strong>di</strong> 400.000 euro;<br />
intende attribuire definitivamente tali beni ai suoi familiari, e precisamente:<br />
- l'appartamento <strong>di</strong> Roma, a Tizia;<br />
- il fondo <strong>di</strong> Lavinio, a Tizietta;<br />
- la palazzina <strong>di</strong> Velletri, a Tizietto;<br />
spiega al notaio che intende con ciò avvantaggiare Tizietto, in quanto Tizietta è coniugata con Sempronio,<br />
facoltoso industriale;
<strong>di</strong>chiara al notaio che la sua residenza è in Ostia, e che non possiede altri beni <strong>di</strong> rilevante valore, e<br />
comunque desidera che il resto del suo patrimonio venga attribuito ai suoi familiari per un quarto a Tizia, per<br />
un quarto a Tizietta e per due quarti a Tizietto.<br />
Il can<strong>di</strong>dato, assunte le vesti del notaio Romolo Romani, re<strong>di</strong>ga il testamento pubblico <strong>di</strong> Tizio, adeguandone<br />
le volontà alle inderogabili <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge e tratti in parte teorica della <strong>di</strong>visione del testatore, e delle<br />
sue <strong>di</strong>fferenze con gli istituti previsti dall'art. 588 2^ comma e dall'art. 733.<br />
D) Schema testamento segreto
III LEZIONE (8.1.2013)<br />
La chiamata e la delazione dell’ere<strong>di</strong>tà e del legato. La natura giuri<strong>di</strong>ca della chiamata prima<br />
dell’acquisto: poteri del chiamato (artt. 459-461 c.c.). Ere<strong>di</strong>tà giacente (art. 528 c.c.). Premorienza,<br />
commorienza, trasmissione del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accettare l’ere<strong>di</strong>tà (art. 479 c.c.). Accettazione dell'ere<strong>di</strong>tà (natura<br />
giuri<strong>di</strong>ca, forma ed effetti, termini). Rinunzia all'ere<strong>di</strong>tà o al legato (natura giuri<strong>di</strong>ca, forma ed effetti, revoca).<br />
PARTE TEORICA<br />
NOZIONI GENERALI Prima dell'apertura della successione non si può accettare o rinunciare all'ere<strong>di</strong>tà (art.<br />
458 c.c.), così come non si può rinunciare alle azioni a tutela del legittimario (art. 557 c.c.). Presupposto<br />
della delazione è l'esistenza (concepito) e la sopravvivenza (premorienza-commorienza) del chiamato. La<br />
semplice scomparsa del chiamato non fa venire meno i suoi <strong>di</strong>ritti successori (artt. 48, 70 c.c.). La delazione<br />
è sempre unica, anche se i titoli sono due (legge e testamento): dunque, il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accettare (o rinunciare)<br />
all’ere<strong>di</strong>tà è sempre unico (Cass. 18.10.1988 n. 5666; contra Gangi; Cicu; Coviello; Mengoni). L'acquisto<br />
dell'ere<strong>di</strong>tà non avviene ipso iure: unica eccezione è la successione dello Stato (art. 586 c.c.). Il chiamato<br />
all’ere<strong>di</strong>tà non è un possessore, anche se legittimato agli atti <strong>di</strong> cui all’art. 460 c.c. (Cass. 30.11.1992 n.<br />
11831; Bigliazzi Geri). Accettazione e rinuncia sono retroattive (ex tunc, dall’apertura della successione), ma<br />
sono salvi gli atti compiuti dal chiamato, in quanto tale (art. 460 c.c.). Accettazione e rinuncia sono atti<br />
unilaterali non recettizi (è esclusa la simulazione).<br />
CHIAMATO ALL'EREDITA' (art. 460 c.c.) Termini per accettare l’ere<strong>di</strong>tà (trattasi <strong>di</strong> termini <strong>di</strong> prescrizione e<br />
non <strong>di</strong> decadenza anche se si esclude l'interruzione perché l'atto sarebbe un’accettazione tacita): A)<br />
Chiamato non nel possesso <strong>dei</strong> beni ere<strong>di</strong>tari (art. 480 c.c.) Il termine <strong>di</strong> prescrizione per accettare è <strong>di</strong> 10<br />
anni dall’apertura della successione ed entro tale termine può fare la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> accettare con beneficio<br />
d’inventario. Art. 487 c.c.: se il chiamato ha fatto la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> accettare con beneficio d’inventario, ha<br />
tre mesi per compilare l'inventario (salva proroga <strong>di</strong> altri tre mesi), altrimenti sarà erede puro e semplice; se<br />
ha fatto l'inventario non preceduto dalla <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> accettare, tale <strong>di</strong>chiarazione deve essere emessa<br />
entro 40 gg. successivi al compimento dell’inventario: in mancanza, si avrà l’estinzione del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />
accettare. Art. 481 c.c.: si prevede la c.d. actio interrogatoria in cui la prescrizione si trasforma in decadenza<br />
(per<strong>di</strong>ta del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accettare in mancanza <strong>di</strong> risposta; la risposta tempestiva senza l'inventario comporta<br />
l'acquisto puro e semplice; B) Chiamato nel possesso <strong>dei</strong> beni ere<strong>di</strong>tari (art. 485 c.c.) Il possesso è qui<br />
inteso in senso ampio e atecnico (è compresa la detenzione). Si presuppone: conoscenza apertura<br />
successione, appartenenza <strong>dei</strong> beni al compen<strong>di</strong>o ere<strong>di</strong>tario, delazione a proprio favore E’ stabilito un<br />
termine breve, ossia tre mesi (più tre mesi <strong>di</strong> proroga) per fare l’inventario; 1) se, in tali termini, non provvede<br />
a fare l’inventario, il chiamato è considerato erede puro e semplice (Pretura Cagliari 8.3.2000); 2) se ha<br />
provveduto nei termini all’inventario, deve fare la <strong>di</strong>chiarazione, ai sensi dell’art. 484 c.c., ai fini del beneficio<br />
<strong>di</strong> inventario, entro 40 gg. dal compimento dell’inventario; se non fa la <strong>di</strong>chiarazione è reputato erede puro e<br />
semplice. Il testatore non può stabilire un termine <strong>di</strong>verso dai 10 anni (maggiore o minore), anche attraverso<br />
l'art. 633 c.c., per l'in<strong>di</strong>sponibilità della delazione e del regime legale <strong>di</strong> prescrizione (art. 2968 c.c.: Ferri;<br />
Grosso-Burdese).<br />
Decorrenza <strong>dei</strong> termini (art. 480, 2 comma c.c.) Il termine <strong>di</strong> prescrizione decorre dal giorno dell’apertura<br />
della successione o, in caso <strong>di</strong> istituzione con<strong>di</strong>zionale (sospensiva), dal giorno in cui si verifica la<br />
con<strong>di</strong>zione. Il termine non decorre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte <strong>di</strong> precedenti<br />
chiamati (indegnità, con<strong>di</strong>zione risolutiva) e successivamente il loro acquisto è venuto meno. Tuttavia -<br />
reputando che la delazione sia attuale e non sospesa - il chiamato ulteriore (anche con<strong>di</strong>zione sospensiva)<br />
può accettare l’ere<strong>di</strong>tà anche se la delazione in suo favore non è attuale (Ferri; Giannattasio; Cass.<br />
28.2.1969 n. 669; Cass. 10.7.1975 n. 2737; Cass. 16.8.1993 n. 8737; contra Barassi; Capozzi; Burdese). La<br />
prescrizione, a <strong>di</strong>fferenza della decadenza, corre anche per gli incapaci (Cass. 30.3.2001 n. 4704; eventuale<br />
azione <strong>di</strong> responsabilità per danni: Capozzi; Natoli). Stabilendo l'art. 459 c.c. che l'ere<strong>di</strong>tà (possesso e<br />
proprietà) si acquista con l'accettazione, l'art. 460 c.c. risponde all'esigenza <strong>di</strong> tutelare i beni del defunto nel<br />
periodo interme<strong>di</strong>o fra l'apertura della successione e l'accettazione: se non è stato nominato un curatore<br />
dell'ere<strong>di</strong>tà (art. 528 c.c.), il chiamato (persona fisica o persona giuri<strong>di</strong>ca: Trib. Roma 11.4.1980) potrà<br />
compiere azioni possessorie (spoglio, manutenzione, azioni nunciazione - secondo gli artt. 1171 e 1172 c.c.<br />
- anche senza la materiale apprensione: non occorre considerare il chiamato fittiziamente possessore: Cass.<br />
30.10.1992 n. 11831), atti conservativi, <strong>di</strong> vigilanza, temporanea amministrazione, ven<strong>di</strong>ta previa<br />
autorizzazione. Il chiamato (possessore o meno <strong>dei</strong> beni ere<strong>di</strong>tari) sarebbe un curatore <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto dell'ere<strong>di</strong>tà<br />
(Natoli; Azzariti Martinez; contra Ferri; Cicu). Se vi è un chiamato nel possesso <strong>dei</strong> beni ere<strong>di</strong>tari (art. 485<br />
c.c.) solo costui è legittimato all'esercizio <strong>dei</strong> poteri <strong>di</strong> cui all'art. 460 c.c. (ex art. 486 c.c.), spettandogli in più<br />
la legittimazione processuale passiva, che non spetta, invece, al chiamato non possessore (App. Cagliari<br />
13.6.1989; Capozzi) e dunque non occorre la nomina <strong>di</strong> un curatore (art. 528 c.c.), né il chiamato non
possessore potrà agire ex art. 460 c.c. (Pret. Verona 26.7.1989). Solo in mancanza <strong>di</strong> chiamato in possesso<br />
<strong>dei</strong> beni, infatti, l'art. 528 c.c. prevede, attraverso la nomina <strong>di</strong> un curatore giu<strong>di</strong>ziale, la conservazione (ma<br />
anche valorizzazione, cioè oltre la previsione <strong>di</strong> cui all’art. 460 c.c.) del patrimonio ere<strong>di</strong>tario (Cass.<br />
22.2.2001 n. 2611). Gli atti compiuti dal chiamato oltre i limiti dell'art. 460 c.c. comportano accettazione tacita<br />
dell'ere<strong>di</strong>tà (art. 476 c.c.).<br />
PREMORIENZA Il chiamato, per legge o per testamento, “non può accettare” in quanto premorto al de<br />
cuius: in tal caso, soccorrono gli istituti della rappresentazione (artt. 467 e ss. c.c.), della sostituzione<br />
or<strong>di</strong>naria (art. 688 e ss. c.c.), dell’accrescimento (art. 674 e ss. c.c.) e, infine, le regole della successione<br />
legittima.<br />
COMMORIENZA (art. 4 c.c.) Commorienza intesa come "non sopravvivenza" <strong>di</strong> una persona ad un'altra,<br />
quando la sopravvivenza rileva per l'acquisto <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto (ad esempio, il <strong>di</strong>ritto successorio) o la produzione<br />
<strong>di</strong> altro effetto giuri<strong>di</strong>co. Secondo alcuni (Santoro Passarelli) nel caso <strong>di</strong> domanda non si tratterebbe <strong>di</strong> una<br />
deroga al principio dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), mentre nel caso <strong>di</strong> eccezione si tratterebbe <strong>di</strong> una<br />
presunzione legale che deroga a quel principio (inversione dell'onere della prova: Cass. 18.2.1986 n. 963).<br />
La prova della sopravvivenza può essere data da chiunque ne abbia interesse e con ogni mezzo (vale anche<br />
per la data dell'ultima notizia dell'assente) e sono ammesse le c.d. praesumptiones hominis (resistenza<br />
fisica, età, sesso, ecc.: Cass. 3.4.1962 n. 683).<br />
DECESSO DEL CHIAMATO PRIMA DELL'ACCETTAZIONE (art. 479 c.c.) Si <strong>di</strong>sciplina la trasmissione<br />
(non della delazione ma) del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accettare l'ere<strong>di</strong>tà (nonché i poteri <strong>di</strong> cui all'art. 460 c.c.) agli ere<strong>di</strong> del<br />
chiamato (anche se la delazione è sospensivamente o risolutivamente con<strong>di</strong>zionata). Ciò vale per<br />
l'istituzione ere<strong>di</strong>taria, ma non per il legato (art. 477 c.c.). Capacità e indegnità si valutano con riferimento al<br />
trasmittente e non all'originario de cuius; per alcuni (Bianca) siccome i trasmissari <strong>di</strong>ventano ere<strong>di</strong> <strong>di</strong>retti del<br />
primo de cuius, se sono indegni rispetto a questi, non potranno accettare (nella rappresentazione<br />
l'argomento è regolato dall'art. 468 c.c.). La posizione del trasmissario prevale sul sostituito, sul<br />
rappresentante e sul coerede in accrescimento. Secondo alcuni (Cicu) il termine <strong>di</strong> prescrizione (art. 480<br />
c.c.) decorre dall'apertura della successione del primo de cuius. La rinuncia all'ere<strong>di</strong>tà propria del<br />
trasmittente importa la rinuncia all'ere<strong>di</strong>tà che al medesimo è devoluta: accettata l'ere<strong>di</strong>tà del trasmittente,<br />
agli ere<strong>di</strong> è data facoltà <strong>di</strong> accettare o rinunciare all'ere<strong>di</strong>tà dell'originario de cuius. Il trasmissario è erede del<br />
trasmittente, non dell'originario de cuius (si verificherebbe una doppia delazione). Non si applica l'art. 479<br />
c.c. al chiamato nascituro concepito se nasce morto.<br />
ACCETTAZIONE DI EREDITA' (artt. 470 e ss. c.c.)<br />
A) PURA E SEMPLICE Natura giuri<strong>di</strong>ca: il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accettare è un <strong>di</strong>ritto potestativo; l'accettazione è<br />
comunemente ritenuta un negozio giuri<strong>di</strong>co (Cicu; Branca; Ferri; contra Romano S., che sostiene la tesi<br />
dell'atto esecutivo; Vocino vi in<strong>di</strong>vidua molti effetti determinati dalla legge; Capozzi la reputa un negozio <strong>di</strong><br />
adesione). In particolare, sarebbe un negozio unilaterale, autonomo, ma funzionale rispetto al testamento,<br />
non recettizio, retroattivo ex art. 459 c.c., irrevocabile, insuscettibile <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zione o termine (art. 475 c.c.), è<br />
ammessa la rappresentanza (procura speciale perché è atto <strong>di</strong> straor<strong>di</strong>naria amministrazione: Trib. Firenze<br />
21.4.1988). E' esclusa la negotiorum gestio (Azzariti Martinez; a favore la giurisprudenza: Cass. 1974/3958;<br />
è ammessa la ratifica come modo <strong>di</strong> accettazione tacita: Cass. 1977/1398). L'accettazione tacita, per alcuni,<br />
non sarebbe un negozio, ma un mero atto giuri<strong>di</strong>co (Cicu; Capozzi; Giannattasio); per altri sarebbe un<br />
negozio <strong>di</strong> attuazione (Ferri; Messineo); per altri ancora un negozio che si conclude attraverso il<br />
comportamento concludente (Giampiccolo). Effetti: confusione <strong>dei</strong> patrimoni, responsabilità ultra vires<br />
dell'erede (debiti, legati e oneri: Cass. 29.4.1993 n. 5067). Forma (art. 474 c.c.): <strong>di</strong>chiarazione espressa (art.<br />
475 c.c.) - cioè l’atto pubblico o la scrittura privata (ma può essere contenuta anche in un atto <strong>di</strong> contenuto<br />
<strong>di</strong>verso, come una compraven<strong>di</strong>ta) - o tacita (art. 476 c.c.), ossia un comportamento concludente qualificato,<br />
un atto che presuppone la volontà <strong>di</strong> accettare e che non si potrebbe fare se non nella qualità <strong>di</strong> erede (ad<br />
esempio, la domanda <strong>di</strong> <strong>di</strong>visione dell'ere<strong>di</strong>tà, l’alienazione <strong>di</strong> un bene ere<strong>di</strong>tario; sono esclusi la<br />
pubblicazione del testamento: Trib. Venezia 4.1.1982; il pagamento <strong>di</strong> debito ere<strong>di</strong>tario con denaro proprio:<br />
Cass. 26.3.1965 n. 497; la denuncia <strong>di</strong> successione: Cass. 24.11.1995 n. 12154). Atti che importano<br />
accettazione A) casi <strong>di</strong> presunzione (relativa) <strong>di</strong> accettazione: 1) art. 477 c.c.: donazione, ven<strong>di</strong>ta o cessione<br />
<strong>dei</strong> <strong>di</strong>ritti successori (tutti o alcuni beni) (definitivi e preliminari, ex art. 2932 c.c.); 2) art. 478 c.c. (rinuncia<br />
traslativa a titolo gratuito): rinuncia verso corrispettivo nei confronti <strong>di</strong> tutti i chiamati (rinuncia traslativa a<br />
titolo oneroso) o a favore <strong>di</strong> alcuni soltanto <strong>dei</strong> chiamati. La rinuncia gratuita a favore <strong>di</strong> tutti (art. 519 c.c.) è<br />
un atto unilaterale <strong>di</strong> ab<strong>di</strong>cazione; B) acquisto forzoso dell'ere<strong>di</strong>tà (a prescindere dalla volontà - erede puro e<br />
semplice): 1) art. 527 c.c. (la sottrazione o l’occultamento intenzionale <strong>di</strong> beni comportano la decadenza<br />
dalla facoltà <strong>di</strong> rinunciare (qualificata sanzione privata: Azzariti Martinez; Giannattasio; Cass. 6.12.1984 n.<br />
6412: anche dopo la rinuncia); 2) art. 485 c.c. (chiamato nel possesso: mancato inventario o mancata<br />
<strong>di</strong>chiarazione; sono esclusi gli incapaci); 3) art. 586 c.c. successione dello Stato (non occorre accettazione:<br />
Capozzi). Invali<strong>di</strong>tà (art. 475 c.c.) Nullità totale dell'accettazione parziale (un parte <strong>di</strong> beni o un tipo <strong>di</strong><br />
delazione: Cass. 18.10.1988 n. 5666; contra Cicu): né si presume l'accettazione totale, né si presume la<br />
rinuncia. Pronunziata la nullità si può validamente sia accettare (in qualsiasi forma), sia rinunciare - (altri casi<br />
<strong>di</strong> nullità: accettazione orale, violenza fisica, con<strong>di</strong>zione o termine; annullabile per violenza e dolo, ex artt.
482, 428 c.c., per interdetto e minore mancanza <strong>di</strong> autorizzazioni, ai sensi degli artt. 322, 377, 396 c.c.).<br />
L'impugnazione per errore (<strong>di</strong>ritto o fatto) (sul titolo o sul contenuto della delazione) è esclusa (art. 483 c.c.):<br />
si tratterebbe <strong>di</strong> un errore sulla consistenza patrimoniale o sull'entità <strong>dei</strong> debiti (unica tutela: beneficio <strong>di</strong><br />
inventario). Art. 483, 2 comma c.c. (presupposti): a) mancata accettazione con beneficio d’inventario; b) nel<br />
testamento successivo il soggetto deve mantenere la qualifica <strong>di</strong> erede; c) i legati nel testamento postumo<br />
devono superare l'attivo. Dalla norma si deduce anche l’irreversibilità e unicità dell'accettazione <strong>di</strong> ere<strong>di</strong>tà<br />
(Cass. 25.1.1983 n. 697; Cass. 18.10.1988 n. 5666). Per alcuni (Ferri; Messineo) vale anche l'errore ostativo<br />
(nullità).<br />
B) CON BENEFICIO DI INVENTARIO L'inventario è un’operazione materiale, la <strong>di</strong>chiarazione è la vera<br />
manifestazione essenziale. Trattasi <strong>di</strong> una fattispecie complessa: operazione materiale più <strong>di</strong>chiarazione<br />
unilaterale, con la risultante <strong>di</strong> un negozio unitario e inscin<strong>di</strong>bile. Il negozio si perfeziona con la <strong>di</strong>chiarazione.<br />
Effetti: responsabilità patrimoniale dell'erede intra vires here<strong>di</strong>tatis (art. 490 c.c.) per i debiti, gli oneri e i<br />
legati; l'erede conserva debiti e cre<strong>di</strong>ti nei confronti del de cuius (tranne quelli personali, come gli alimenti);<br />
separazione <strong>dei</strong> patrimoni (de cuius ed erede) e dunque i cre<strong>di</strong>tori del de cuius hanno una prelazione sul<br />
patrimonio ere<strong>di</strong>tario, rispetto ai cre<strong>di</strong>tori dell'erede (istituto correlativo a favore <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori del de cuius:<br />
separazione <strong>dei</strong> beni, ai sensi dell’art. 512 ss. c.c.). Forma Per l’art. 484 c.c. può essere solo espressa (atto<br />
pubblico: notaio o cancelliere della pretura del mandamento dove si è aperta la successione (se fatta ad un<br />
organo incompetente, vale come accettazione pura e semplice: Cass. 27.7.1988 n. 4780).<br />
Iscrizione/trascrizione: è prescritta l’iscrizione nel Registro delle <strong>successioni</strong> (tale iscrizione si reputa<br />
<strong>di</strong>chiarativa e non costitutiva: Cicu; Ferri; Natoli); per la trascrizione cfr. art. 2648 c.c. Regola: libertà <strong>di</strong><br />
avvalersi del beneficio <strong>di</strong> inventario (il testatore non può imporlo o vietarlo, neanche in forma con<strong>di</strong>zionale, ai<br />
sensi dell’art. 470 c.c.: Cass. 21.12.1966 n. 1966); secondo gli artt. 471, 472, 473 c.c., invece, è obbligatorio<br />
(ma per gli incapaci il beneficio d’inventario non funziona ipso iure), previa autorizzazione del giu<strong>di</strong>ce<br />
tutelare: a) per minori (genitori, ex art. 320 c.c.; curatore speciale, ex art. 321 c.c.; tutore, ex art. 374 c.c.); b)<br />
per gli interdetti (tutore); c) per emancipato e inabilitato (con l'assistenza del curatore): nullità<br />
dell'accettazione tacita in questi casi: Cass. 27.2.1986 n. 1267, secondo cui il minore resta un chiamato e<br />
quin<strong>di</strong> il <strong>di</strong>ritto si può prescrivere in 10 anni, restando a sua tutela solo il risarcimento del danno); d) persona<br />
giuri<strong>di</strong>ca (eccezione società commerciali, ex art. 473 c.c.) previa autorizzazione governativa, ex art. 17 c.c.<br />
(oggi abrogato): la conseguenza è l’inefficacia (App. Roma 10.12.1986). Inoltre, per il legittimario ve<strong>di</strong> l’art.<br />
564 c.c., secondo cui, per agire in riduzione contro donazioni e legati a favore <strong>di</strong> terzi non coere<strong>di</strong>, deve<br />
accettare con beneficio <strong>di</strong> inventario. Diversa funzione del beneficio <strong>di</strong> inventario per capaci e incapaci (per<br />
questi ultimi non si prevede la decadenza); in tal modo, si garantisce l’incapace dal rischio <strong>di</strong> una<br />
responsabilità illimitata: le cause <strong>di</strong> decadenza per gli incapaci funzionano solo al compimento <strong>di</strong> un anno dal<br />
raggiungimento della maggiore età o dalla cessazione dello stato <strong>di</strong> incapacità (art. 489 c.c.). Tuttavia, anche<br />
per gli incapaci funziona la prescrizione (per inerzia del rappresentante legale o per la nullità<br />
dell’accettazione tacita: Cass. 24.7.2000 n. 9648). Natura giuri<strong>di</strong>ca del beneficio <strong>di</strong> inventario: la questione<br />
attiene al concepire o meno il patrimonio comprensivo anche <strong>dei</strong> debiti (vecchia tesi) o solo attivo. A) Tesi<br />
dell’ere<strong>di</strong>tà beneficiata quale personalità giuri<strong>di</strong>ca (abbandonata); B) Tesi della intrasmissibilità <strong>dei</strong> debiti<br />
ere<strong>di</strong>tari: l'erede non succederebbe negli obblighi, ma risponderebbe <strong>dei</strong> debiti per il fatto che i beni<br />
acquistati sono gravati (Ferri; Vocino). All’accettazione con beneficio <strong>di</strong> inventario seguirebbe un vincolo<br />
reale sui beni ere<strong>di</strong>tari, analogo al pegno e all'ipoteca, a favore <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori e legatari del de cuius; C) Tesi<br />
<strong>dei</strong> patrimoni separati (preferibile): l'ere<strong>di</strong>tà, pur appartenendo all'erede, sarebbe un patrimonio separato con<br />
destinazione la sod<strong>di</strong>sfazione <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori ere<strong>di</strong>tari e insensibile alle vicende del patrimonio dell'erede (art.<br />
490 c.c.). L’erede succede anche nelle passività (si ammette la successione nei debiti ere<strong>di</strong>tari) e dunque<br />
assume la qualità <strong>di</strong> soggetto passivo <strong>dei</strong> rapporti obbligatori facenti capo al de cuius e <strong>di</strong>venta debitore<br />
personalmente obbligato: il beneficio <strong>di</strong> inventario rientrerebbe, così, nei limiti della responsabilità<br />
patrimoniale del debitore <strong>di</strong> cui all’art. 2740, 2 comma c.c. (Messineo; Grosso-Burdese; Capozzi; Azzariti<br />
Martinez; Natoli; Bigliazzi Geri; Pino); D) Tesi della responsabilità senza debito (Cicu), ormai superata.<br />
Formalità per conseguire il beneficio Inventario (artt. 769 e ss. c.p.c.): gestione <strong>dei</strong> beni ere<strong>di</strong>tari (colpa<br />
grave) e liquidazione del passivo ere<strong>di</strong>tario (semplice o concorsuale, cessione <strong>dei</strong> beni, ex artt. 507 e 1977<br />
c.c.). Decadenza dal beneficio <strong>di</strong> inventario: 1) art. 485 c.c.: 2) art. 493 c.c. (Trib. Bergamo 2.11.1999); 3) art.<br />
494 c.c.; 4) art. 505 c.c. irregolarità nella liquidazione (nei casi 1, 2, 3, la decadenza è retroattiva). La<br />
decadenza è personale e dunque opera solo contro l'autore del fatto; è retroattiva; la decadenza è fatta<br />
valere dai cre<strong>di</strong>tori del de cuius o dai legatari. Il beneficio <strong>di</strong> inventario viene meno anche per rinuncia<br />
volontaria (secondo Natoli, in tal caso, sarebbe retroattiva; ma non può essere preventiva per l’art. 458 c.c. e<br />
per la libera iniziativa del chiamato). Estensione: il beneficio <strong>di</strong> inventario fatto da uno solo giova a tutti gli<br />
altri se non hanno ancora accettato (salva rinuncia o decadenza), altrimenti coesistenza <strong>di</strong> ere<strong>di</strong> beneficiati<br />
con ere<strong>di</strong> or<strong>di</strong>nari (art. 510 c.c.).<br />
RINUNCIA ALL'EREDITA' (artt. 519-527 c.c.) Nozione: Si tratta <strong>di</strong> un negozio unilaterale non recettizio<br />
(non è smentito, ciò, dall'art. 519, 2 comma c.c.) <strong>di</strong> <strong>di</strong>smissione (o ab<strong>di</strong>cazione, per Ferri si tratta <strong>di</strong> rifiuto<br />
perché non ci si spoglia <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto che è entrato nel patrimonio, ma ve<strong>di</strong> l’art. 479 c.c.) del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />
accettare l'ere<strong>di</strong>tà. Chi ha già accettato non può più rinunciare (semel heres semper heres). La rinuncia è
totale, gratuita e non va fatta a favore <strong>di</strong> destinatari determinati. E' retroattiva (Cass. 9.3.1987 n. 2434) e<br />
dunque comporta problemi sul conteggio delle quote <strong>di</strong> legittima e <strong>di</strong> successione legittima; insuscettibilità <strong>di</strong><br />
con<strong>di</strong>zione o termine; ammessa la rappresentanza; per gli incapaci occorre l’autorizzazione del giu<strong>di</strong>ce<br />
tutelare. Per la capacità valgono le stesse regole dell'accettazione (ma per Messineo; Cariota Ferrara, per le<br />
persone giuri<strong>di</strong>che, non occorrerebbero autorizzazioni per la rinuncia). Termini: or<strong>di</strong>nari (salvo decadenza<br />
dalla facoltà <strong>di</strong> rinuncia: artt. 485, 2 e 3 comma c.c.; 527 c.c.; o termini ridotti: artt. 481, 485 e 487 c.c.).<br />
Forma della rinuncia (art. 519 c.c.) Soltanto espressa (atto solenne: atto notarile o <strong>di</strong>chiarazione al<br />
cancelliere della pretura del luogo <strong>di</strong> apertura della successione); è escluso il comportamento concludente<br />
(c.d. rinuncia tacita, né la rinuncia si presume, per regola). Per avere effetti nei confronti <strong>dei</strong> terzi deve<br />
essere inserita nel Registro delle <strong>successioni</strong> (art. 519 c.c.). Il patto rinunciativo successivo all'apertura della<br />
successione è ammesso (ex art. 458 c.c.), ma non si applicherebbe l'art. 2932 c.c. in quanto atto unilaterale<br />
(Ferri). Rinuncia contrattuale: è stata configurata dalla giurisprudenza (ma la dottrina è contraria) a proposito<br />
dell'art. 519, 2 comma c.c. (rinuncia gratuita a favore <strong>di</strong> tutti coloro ai quali sarebbe devoluta la quota del<br />
rinunziante: non ha effetto se non adempiute le formalità previste). La rinuncia potrebbe essere contenuta in<br />
un contratto, ma avrebbe solo efficacia obbligatoria fra le parti (Cass. 22.10.1975 n. 3500). Mentre nell’art.<br />
477 c.c. c'è una donazione (<strong>di</strong>retta), nell’art. 519 c.c. si ha comunque la rinuncia ab<strong>di</strong>cativa (qualunque sia il<br />
motivo, anche quello <strong>di</strong> beneficiare sarebbe solo in<strong>di</strong>retto e dunque irrilevante), dunque sarebbe un negozio<br />
unilaterale a causa neutra (e non gratuita: Torrente; Barbero; Ferrero-Podetti). Ciò non toglie che possa<br />
parlarsi, a volte, <strong>di</strong> donazione in<strong>di</strong>retta: Grosso-Burdese; Ferri; Losanna; Carnevali; Cass. 29.5.1974 n.<br />
1545, quando - fra rinuncia e arricchimento del beneficiario - vi sia un nesso <strong>di</strong> causalità <strong>di</strong>retta. Rinuncia<br />
parziale: relativa ad una quota, un singolo bene o un titolo (successione legittima o successione<br />
testamentaria: Cicu). La sanzione è la nullità: art. 520 c.c. Rinuncia traslativa (presuppone l'accettazione)<br />
Nell’art. 478 c.c. sono previsti due casi: 1) <strong>di</strong>etro corrispettivo; 2) a favore <strong>di</strong> alcuni soltanto <strong>dei</strong> chiamati a<br />
titolo gratuito (negozio in<strong>di</strong>retto: Cass. 13.7.1974 n. 2119). Impugnazione (art. 526 c.c.) E’ ammessa per dolo<br />
e violenza, è escluso l'errore. Revoca della (valida) rinuncia (art. 525 c.c.) (per l'ere<strong>di</strong>tà, perché la rinuncia al<br />
legato è irrevocabile; si giustifica con la permanenza della delazione dopo la rinuncia: Azzariti Martinez;<br />
Messineo; Cariota Ferrara affermano anche che si trasmette agli ere<strong>di</strong> del rinunziante la facoltà <strong>di</strong> accettare<br />
l'ere<strong>di</strong>tà, nei limiti dell'art. 525 c.c., e in applicazione dell'art. 479 c.c.) limiti <strong>di</strong> prescrizione e comunque fino a<br />
quando l'ere<strong>di</strong>tà non sia acquistata dai chiamati ulteriori (sostituzione, rappresentazione, accrescimento -<br />
attenzione, effetti automatici dell'accrescimento a favore <strong>di</strong> un coerede che ha già accettato rendono<br />
irrevocabile la rinuncia - successione legittima: <strong>di</strong>venta irrevocabile anche se ricorresse il consenso <strong>di</strong> questi<br />
alla revoca della rinuncia: Cass. 19.10.1966 n. 2549, la delazione è in<strong>di</strong>sponibile). La forma è<br />
esclusivamente l'accettazione <strong>di</strong> ere<strong>di</strong>tà: infatti, la revoca è l'effetto della sopravvenuta accettazione<br />
(espressa o tacita: Cass. 6.12.1984 n. 6412) da parte del rinunciante (Cass. 14.5.1977 n. 1938; Cass.<br />
8.6.1984 n. 3457) (vale come accettazione tacita la pro herede gestio, cioè la permanenza nel possesso in<br />
senso tecnico a titolo <strong>di</strong> erede dopo la rinuncia: Cass. 21.4.1958 n. 1319: ma Bigliazzi Geri rileva che<br />
potrebbe trattarsi <strong>di</strong> gestione <strong>di</strong> affari altrui - erede assente - o un acquisto per usucapione). Sono salvi i<br />
<strong>di</strong>ritti acquistati dai terzi sui beni ere<strong>di</strong>tari (artt. 525/534 c.c.). Effetti della rinuncia Sono retroattivi (art. 521<br />
c.c.). Conservazione delle donazioni e <strong>dei</strong> legati (infatti, la rinuncia è solo per l'ere<strong>di</strong>tà): questa <strong>di</strong>sposizione<br />
avrebbe il significato <strong>di</strong> evitare la collazione per il rinunziante. Azione surrogatoria a favore <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori del<br />
rinunziante (art. 524 c.c.) (inefficacia relativa della rinuncia): tutela conservativa con elementi misti<br />
(revocatoria, ma manca il consilium frau<strong>di</strong>s; azione surrogatoria, ma manca l'inerzia). Trascrizione della<br />
rinuncia: si reputa che non sia necessaria, anche se ci sono beni immobili, in quanto non sarebbe un atto <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>smissione <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto reale immobiliare (art. 2643 c.c.: Ferri, Grosso-Burdese).<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
Albanese, L’amministrazione del coerede come gestione <strong>di</strong> affari altrui, in Fam. pers. succ., 2006, p. 802 ss.; Astuni, Accettazione<br />
dell’ere<strong>di</strong>tà con beneficio <strong>di</strong> inventario in nome e per conto del minore e rinuncia, da parte <strong>di</strong> questo, <strong>di</strong>venuto maggiorenne, in Fam. e<br />
<strong>di</strong>r., 2001, p. 405; Azzariti, Ambito normativo dell'art. 460 c.c. sui poteri del chiamato all’ere<strong>di</strong>tà prima dell’accettazione, in Giur mer.,<br />
1990, I, 1; Azzariti, L’accettazione dell’ere<strong>di</strong>tà, in Trattato <strong>di</strong> <strong>di</strong>r. priv. <strong>di</strong>retto da P.Rescigno, V, 1, Torino 1982, p. 137; Belfiore,<br />
Accettazione <strong>di</strong> ere<strong>di</strong>tà giacente e cessazione delle funzioni <strong>di</strong> curatore, in Giur. mer., 1995, p. 941 ss.; Callisti, Rinuncia del chiamato<br />
alle <strong>di</strong>sposizioni testamentarie e successione legittima, in Riv. not., 2003, I, p. 230 ss.; Carbone, Atti conservativi e accettazione <strong>di</strong><br />
ere<strong>di</strong>tà, in Dir. e giur., 1996, I, p. 148; Chelo, Sull’accettazione tacita dell’ere<strong>di</strong>tà me<strong>di</strong>ante l’esercizio del possesso, in Riv. giur. sarda,<br />
2000, p. 139; Coen, Commorienza e onere della prova, in Foro pad., 1987, I, p. 354; Cuffaro, Rinuncia e accettazione dell’ere<strong>di</strong>tà:<br />
considerazioni sul <strong>di</strong>sposto dell’art. 527 c.c., in Giur. It., 1986, I, 1, p. 289; Di Mauro, In tema <strong>di</strong> accettazione tacita dell’ere<strong>di</strong>tà, in Giust.<br />
civ., 1997, I, p. 523; Di Paola, Su alcuni poteri del chiamato all'ere<strong>di</strong>tà prima dell’accettazione: <strong>di</strong>spute vecchie e nuove, in<br />
Quadrimestre, 1992, II, p. 86 ss.; Ferrero Podetti, La rinuncia all'ere<strong>di</strong>tà, in Successioni e donazioni a cura <strong>di</strong> P.Rescigno, Padova<br />
1994, I, p. 377; Gabrielli, L’accettazione <strong>di</strong> ere<strong>di</strong>tà da parte <strong>dei</strong> corpi morali, in Riv. <strong>di</strong>r. civ., 2003, p. 225 ss.; Garofalo, Tutela<br />
possessoria <strong>dei</strong> beni ere<strong>di</strong>tari tra chiamati alla successione, in Giur. It., 1990, I, 2, p. 743; Garofalo, Sulla responsabilità dell’erede<br />
beneficiato per l’adempimento dell’onere testamentario, in Giur. It., 1995, I, 1, p. 536 ss.; Mirando, La giacenza dell’ere<strong>di</strong>tà: la ratio<br />
dell’ammissibilità, in Familia, 2002, II, p. 211; Moscarini, voce Beneficio <strong>di</strong> inventario, in Enc. del <strong>di</strong>r., V, Milano 1959, p. 124; Natoli,<br />
L'amministrazione <strong>dei</strong> beni ere<strong>di</strong>tari, Milano 1968; Par<strong>di</strong>ni, Impugnazione della rinuncia e autorizzazione ad accettare l’ere<strong>di</strong>tà in nome<br />
e in luogo del rinunciante, in Riv. not., 1992, II, p. 748; Pastore, La successione nella delazione ere<strong>di</strong>taria, in Riv. not., 1995, II, p. 891;<br />
Pastore, Incapaci e decadenza dal beneficio <strong>di</strong> inventario, in Riv. not., 1998, II, p. 1209; Perlingieri, Dichiarazione giu<strong>di</strong>ziale <strong>di</strong><br />
paternità e prescrizione del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accettare l’ere<strong>di</strong>tà, in Rass. <strong>di</strong>r. civ., 1996, II, p. 309; Pino, Patrimonio separato, Padova 1950;<br />
Ravazzoni, voce Beneficio <strong>di</strong> inventario, in Enc. giur. Treccani, Roma 1988; Regine, Chiamati ulteriori ed accettazione <strong>di</strong> ere<strong>di</strong>tà, in
Nuova giur. civ. comm., 1994, I, p. 458; Sammartano, L’ere<strong>di</strong>tà giacente, in Vita not., 1998, CXXXI; Santoro Passarelli, voce<br />
Commorienza, in Enc. del <strong>di</strong>r., VII, Milano 1960, p. 978; Santarsiere, Della rinunzia all’ere<strong>di</strong>ta e sua revoca, in Arch. civ., 1999, p. 184;<br />
Trimarchi, L’ere<strong>di</strong>tà giacente, Milano 1954; Vitucci, Prescrizione e <strong>di</strong>ritto successorio, in Riv. not., 1990, I, p. 69; Vocino, Contributo<br />
alla dottrina del beneficio <strong>di</strong> inventario, Milano 1942; Vocino, voce Inventario (beneficio <strong>di</strong>), in Novissimo Dig. It., IX, Torino 1963, p. 14;<br />
Zaccaria, Rapporti obbligatori e beneficio <strong>di</strong> inventario. Tipologie e <strong>di</strong>sciplina dell’attuazione, Torino 1994; Zaccaria, La trasmissione<br />
del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accettare l’ere<strong>di</strong>tà, qualora il chiamato muoia prima <strong>di</strong> aver accettato, si verifica anche lì dove il testatore abbia previsto una<br />
sostituzione?, in Stu<strong>di</strong>um iuris, 2003, p. 442 ss.<br />
A) Esercitazione in classe<br />
PARTE PRATICA<br />
Tizio, celibe e senza figli e ascendenti, si presenta dal notaio Romolo Romani <strong>di</strong> Roma e gli richiede <strong>di</strong><br />
ricevere il suo testamento, <strong>di</strong>chiarandogli <strong>di</strong> essere pressoché paralizzato agli arti superiori, in quanto ogni<br />
movimento <strong>dei</strong> medesimi gli procura fortissimi dolori;<br />
egli ha due fratelli, Primo e Secondo, che vuole nominare ere<strong>di</strong> nella quota <strong>di</strong> 1/3 e 2/3 rispettivamente, con<br />
reciproco <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accrescimento; intende fissare un termine <strong>di</strong> sei mesi dall’apertura della successione per<br />
l’accettazione.<br />
A sua volta Primo ha un figlio, Primetto, mentre Secondo ha una figlia, Secon<strong>di</strong>na; nell’ipotesi che Primo e<br />
Secondo, entrambi, non vengano all’ere<strong>di</strong>tà per un qualche motivo, non vuole che l’ere<strong>di</strong>tà venga attribuita<br />
automaticamente ai loro figli, in quanto vorrebbe beneficiare solo Secon<strong>di</strong>na e nulla vuole che vada a<br />
Primetto;<br />
nelle more dell’accettazione, vorrebbe che l’amministrazione <strong>dei</strong> suoi beni spettasse ad un suo fidato amico,<br />
l’avvocato Sempronio, e che non si aprisse l’ere<strong>di</strong>tà giacente;<br />
Tizio intende beneficiare Secondo rinunziando all’ere<strong>di</strong>tà del comune zio Tizione, deceduto da pochi giorni,<br />
emigrato in America, e del quale unici chiamati sono appunto Tizio e Secondo. Vuole, se possibile, che<br />
l’ere<strong>di</strong>tà vada <strong>di</strong>rettamente a Secondo per non gravare costui <strong>di</strong> doppie imposte <strong>di</strong> successione. Vuole<br />
lasciare alla domestica Cornelia la somma <strong>di</strong> 100.000 euro, ma solo se lo vorrà; Cornelia, inoltre, avrà<br />
facoltà <strong>di</strong> chiedere a Secondo l’uso gratuito per <strong>di</strong>eci anni, e comunque a con<strong>di</strong>zione che non si sposi, <strong>di</strong> un<br />
appartamento in Firenze, facente parte dell’ere<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> Tizione.<br />
Vuole <strong>di</strong>sporre della somma <strong>di</strong> euro 200.000 a favore del figlio <strong>di</strong> Sempronio, attualmente quin<strong>di</strong>cenne, quale<br />
regalo per il ventunesimo compleanno, e vuole revocare la rinuncia al legato <strong>di</strong>sposto in suo favore dal<br />
defunto amico Clau<strong>di</strong>o, avente ad oggetto un prezioso monile.<br />
Tizio sottoscrive il testamento e spira prima che i testimoni abbiano a loro volta sottoscritto.<br />
- Profili formali: grave <strong>di</strong>fficoltà del testatore nell’apporre la propria sottoscrizione: art. 603, comma 3,<br />
c.c.; funzione <strong>dei</strong> testimoni, legge notarile;<br />
- Accrescimento volontario;<br />
- Il termine e la con<strong>di</strong>zione nell’istituzione <strong>di</strong> erede e nel legato; con<strong>di</strong>zioni sospensive meramente<br />
potestative nei legati;<br />
- Rappresentazione e sostituzione;<br />
- Esecutore testamentario e curatore dell’ere<strong>di</strong>tà giacente;<br />
- Rinuncia all’ere<strong>di</strong>tà in favore <strong>di</strong> tutti o alcuni <strong>dei</strong> chiamati ulteriori, a titolo gratuito o oneroso, sua<br />
compatibilità con atti <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizione su beni del compen<strong>di</strong>o ere<strong>di</strong>tario; revoca della rinuncia al legato,<br />
<strong>di</strong>fferenze rispetto alla revoca della rinuncia all’ere<strong>di</strong>tà;<br />
- Con<strong>di</strong>zioni volte a coartare il beneficiario, con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> non contrarre matrimonio;<br />
B) Casi in classe<br />
1) Curatore dell’ere<strong>di</strong>tà giacente e trasmissione della delazione<br />
Il 10 gennaio 2008 decedeva Tizio; si pubblica il testamento, con il quale Tizio nomina erede universale<br />
Sempronio, un cugino archeologo irreperibile per essere occupato con scavi nel deserto del Gobi,<br />
sostituendogli Caio;<br />
il Tribunale <strong>di</strong> Firenze nominava curatore dell’ere<strong>di</strong>tà giacente l’avvocato Mevio, con decreto del 31 marzo<br />
2008;<br />
nell’ere<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> Tizio vi è anche il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accettare l’ere<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> Quintilio, deceduto otto anni prima;<br />
Mevio si reca dal notaio RR per accettare, nell’interesse <strong>di</strong> Sempronio, sia l’ere<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> Tizio che quella <strong>di</strong><br />
Quintilio.<br />
2) Confermabilità del testamento olografo privo <strong>di</strong> sottoscrizione e <strong>di</strong>sposizioni incompatibili<br />
Primo e Secondo si recano dal notaio RR per esporgli quanto segue:
pochi giorni prima è deceduto lo zio Tizio, senza legittimari, del quale peraltro sono gli unici congiunti, che,<br />
poco prima <strong>di</strong> morire, aveva <strong>di</strong>sposto in loro favore con due testamenti separati consegnati personalmente a<br />
ciascuno <strong>di</strong> loro:<br />
nel testamento consegnato a Primo, Tizio lo nomina erede per un mezzo e gli assegna, in conto ere<strong>di</strong>tà, la<br />
casa dove abita;<br />
così pure fa con l’altro testamento, nominando erede Secondo per un mezzo, assegnandogli in conto ere<strong>di</strong>tà<br />
la casa dove abita;<br />
i due testamenti sono interamente scritti <strong>di</strong> pugno da Tizio, e regolarmente datati, ma solo quello <strong>di</strong> Primo<br />
reca la sottoscrizione;<br />
è intenzione <strong>di</strong> Primo <strong>di</strong> non recare danno a Secondo e quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> accettare la quota <strong>di</strong> ere<strong>di</strong>tà devoluta per<br />
testamento, rinunziando alla chiamata <strong>di</strong> legge;<br />
il notaio RR <strong>di</strong>a a Primo e Secondo i consigli del caso.<br />
3) Il sistema della quota mobile e la rinunzia all’ere<strong>di</strong>tà<br />
Tizio, vedovo e senza ascendenti, morendo, così <strong>di</strong>spone per testamento:<br />
lascio la quota <strong>di</strong> legittima ai miei figli Primo e Secondo; la <strong>di</strong>sponibile andrà al mio amico Caio;<br />
si recano dal notaio Primo, Secondo e Caio, manifestandogli l’intenzione:<br />
Primo (senza figli) <strong>di</strong> rinunziare all’ere<strong>di</strong>tà, e Caio e Secondo <strong>di</strong> vendere l’unico cespite ere<strong>di</strong>tario, un<br />
appartamento in Velletri, a Quintilio;<br />
in<strong>di</strong>chi il notaio per che quote spetta il ricavato della ven<strong>di</strong>ta a Caio e Secondo.<br />
4) Irretrattabilità della rinunzia al legato<br />
Tizio, senza legittimari, muore il 15 maggio 2008, dopo aver nominato erede il cugino Caio;<br />
l’ere<strong>di</strong>tà consisteva in una palazzina in Latina, in cattivo stato; due degli appartamenti <strong>di</strong> Latina venivano<br />
legati a Sempronio;<br />
Caio e Sempronio, non volendo preoccupazioni, rinunziano a quanto lasciato da Tizio con atto RR del 10<br />
giugno 2008;<br />
successivamente però, il 20 luglio 2008, si recano insieme all’impren<strong>di</strong>tore Mevio dal notaio RR, per<br />
trasferire al medesimo, congiuntamente, la palazzina in Latina, precisando Caio che intende che anche<br />
Sempronio benefici del ricavato della ven<strong>di</strong>ta, se possibile.<br />
C) Esercitazione a casa<br />
Mevio, titolare <strong>di</strong> un considerevole patrimonio, che comprende solo la lingua tedesca, si reca, unitamente<br />
all'amico Franz, dal notaio Fiorenzo Fiorentini <strong>di</strong> Firenze, nel suo stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> via Renai 23, e gli illustra quanto<br />
segue:<br />
è sposato con Mevia, dalla quale ha avuto tre figli chiamati Primo, Secondo e Terza;<br />
inoltre ha avuto, da una relazione extraconiugale con Tizia, due figli <strong>di</strong> nome Quarta e Quinta;<br />
a Mevia intende attribuire a sod<strong>di</strong>sfazione <strong>dei</strong> suoi <strong>di</strong>ritti, l'usufrutto <strong>dei</strong> suoi beni immobili in Firenze, tra i<br />
quali la casa coniugale;<br />
a Primo, interdetto, intende lasciare la legittima con l'obbligo <strong>di</strong> conservare e restituire i beni lasciati a chi lo<br />
assisterà;<br />
alla figlia Terza, oltre a quanto le spetta, intende lasciare l'usufrutto della tenuta agricola in agro <strong>di</strong> Velletri <strong>di</strong><br />
cui lui medesimo è nudo proprietario;<br />
al figlio Secondo, noto scultore, vuole lasciare soltanto tutto il denaro contante, i titoli e le azioni;<br />
inoltre desidera fondare un museo <strong>di</strong> arte moderna, dotandolo inizialmente <strong>di</strong> almeno <strong>di</strong>eci sculture <strong>di</strong><br />
Secondo (delle quali una raffigurante lui medesimo) e <strong>di</strong> altre venti sculture <strong>di</strong> giovani artisti italiani, nonchè<br />
<strong>di</strong> uno <strong>dei</strong> suoi palazzi in Milano, ove avrà sede, e <strong>di</strong> un capitale sufficiente per il suo mantenimento; tutti i<br />
costi relativi faranno carico all'ere<strong>di</strong>tà;<br />
intende beneficiare Quarta e Quinta, tuttora minorenni, con due ren<strong>di</strong>te vitalizie sufficienti per farle vivere<br />
decorosamente, e con la propria tenuta agricola in Maremma; desidera evitare che la madre <strong>di</strong> Quarta e<br />
Quinta, pessima amministratrice, possa gestire la tenuta, che dovrà invece essere amministrata dall'attuale<br />
amministratore Caio, uomo <strong>di</strong> provata esperienza e <strong>di</strong> sua completa fiducia.<br />
il can<strong>di</strong>dato, adeguando la volontà del testatore a norme <strong>di</strong> legge, re<strong>di</strong>ga il testamento pubblico <strong>di</strong> Mevio,<br />
tenendo presente che il notaio non conosce la lingua tedesca, e che il testatore gra<strong>di</strong>rebbe che Franz,<br />
bilingue citta<strong>di</strong>no tedesco, fungesse da interprete;<br />
tratti in parte teorica delle norme e degli istituti che interessano i minori e gli incapaci nell'ambito della<br />
materia successoria.<br />
D) Correzione 1° esercitazione a casa<br />
E) Schema verbale deposito testamento olografo
IV LEZIONE (22.1.2013)<br />
La devoluzione dell’ere<strong>di</strong>tà e del legato. Rappresentazione. Sostituzione or<strong>di</strong>naria e sostituzione<br />
fedecommissaria. Accrescimento (presupposti <strong>di</strong> applicazione, natura giuri<strong>di</strong>ca, effetti e rapporti <strong>di</strong> tali<br />
istituti).<br />
PARTE TEORICA<br />
RAPPRESENTAZIONE (artt. 467-469 c.c.) La rappresentazione funziona per legge e si applica nella<br />
successione sia testamentaria, sia legittima (il rappresentante è comunque un successore legittimo),<br />
nell'istituzione universale o particolare. Vi sono varie tesi sulla sua natura giuri<strong>di</strong>ca (finzione legislativa:<br />
Santoro Passarelli; conversione legale della mancata vocazione del rappresentato in quella nuova del<br />
rappresentante: Nicolò; vocazione in<strong>di</strong>retta per sostituzione legale: Coviello; surrogazione legale del<br />
rappresentante: Bianca; vocazione per relationem: Cariota Ferrara, Grosso-Burdese; vocazione <strong>di</strong>retta e<br />
delazione in<strong>di</strong>retta: Capozzi; Cicu; Cass. 11.4.1975 n. 1366).<br />
A) Presupposti oggettivi (art. 467 c.c.) Premorienza (in questo caso la delazione è <strong>di</strong>retta ed imme<strong>di</strong>ata),<br />
morte presunta, commorienza, incapacità (artt. 596-599 c.c.), decadenza (artt. 481 e 487 c.c.), prescrizione,<br />
rinuncia, <strong>di</strong>seredazione, indegnità e assenza del primo chiamato.<br />
B) Presupposti soggettivi (art. 468 c.c.) Sul punto hanno interferito la riforma del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> famiglia del 1975 e<br />
numerose pronunce della Corte Costituzionale; la parificazione della filiazione naturale a quella legittima; il<br />
riconoscimento della parentela fra naturali. 1a) de cuius; 2a) rappresentato (linea retta e linea collaterale):<br />
figlio del de cuius (legittimo, legittimato, naturale, questi già dalla Corte Cost. 1969/79, nonché per l’art. 258<br />
c.c., o adottivo) o collaterale del de cuius: fratello o sorella germani/unilaterali. Questioni: 1) solo legittimi<br />
(Perego; Cicu) o anche naturali (Carraro; Bianca; Corte cost. n. 55/1979 e n. 184/1990; Corte cost.<br />
7.11.1994 n. 377): il rapporto <strong>di</strong> parentela deve esistere fra de cuius e rappresentato e fra rappresentato e<br />
rappresentante (cfr. art. 258 c.c. ed effetti del riconoscimento); 2) secondo alcuni (Azzariti; Giannattasio;<br />
Piras; De Marchi; Capozzi; Cass. 6.10.1976 n. 3300; Trib. Messina 5.10.1993) solo entro il 2° grado, cioè<br />
fratelli e sorelle; secondo altri (Bianca; Burdese; Ferri; Talamanca; Gangi; Moscati; App. Milano 24.11.1992)<br />
anche oltre quel grado, comprendendovi pure i loro <strong>di</strong>scendenti; 3a) rappresentante (<strong>di</strong>scendenti legittimi,<br />
adottivi, naturali del rappresentato nati o concepiti: art. 462 c.c.; Trib. Bari 21.10. 1980), si guarda il momento<br />
dell'apertura della successione; è escluso il non concepito (Trib. Bari 21.10.1960); è escluso il non<br />
riconosciuto. Si succede per stirpi e non per capi. Secondo la giurisprudenza il <strong>di</strong>scendente del <strong>di</strong>seredato<br />
può succedere per rappresentazione (Cass. 14.10.1975 n. 3138; Cass. 23.11. 1982 n. 6339; contra<br />
Trabucchi; Grosso-Burdese). Regole <strong>di</strong>verse per i vari tipi <strong>di</strong> adozione; sono esclusi dai rappresentati i figli<br />
irriconoscibili; la <strong>di</strong>chiarazione giu<strong>di</strong>ziale <strong>di</strong> paternità o maternità ha effetti retroattivi (Cass. 7.4.1990 n.<br />
2923). La rappresentazione ha luogo all'infinito (art. 469 c.c.: Ferri; Ivrea; Terzi). L'art. 468 c.c. è tassativo<br />
(Corte cost. 1976/83). La rappresentazione non opera: a) a favore <strong>dei</strong> figli <strong>di</strong> altri collaterali (cugini del de<br />
cuius: Cass. 6.10.1976 n. 3300; Corte cost. 14.4.1976 n. 83); b) per il coniuge (Cass. 30.5.1990 n. 5077); c)<br />
per figlio <strong>di</strong> primo letto del coniuge premorto (Cass. 29.3.1994 n. 3051); c) sono esclusi i <strong>di</strong>scendenti del<br />
nipote ex filio (cass. 28.10.2009 n. 22840).<br />
Effetti (art. 467 c.c.) 1) il rappresentante subentra "nel luogo e nel grado" del rappresentato, per cui si attua<br />
la successione <strong>di</strong>retta dal rappresentante al de cuius iure proprio (i rappresentanti potrebbero anche aver<br />
rinunciato alla successione del rappresentato o essere stati, nei suoi confronti, indegni o incapaci <strong>di</strong><br />
succedere: art. 468, 2 comma c.c.; il <strong>di</strong>ritto tributario si <strong>di</strong>scosta dalla legge civile: Cass. 26.7.1994 n. 6955);<br />
2) le regole, per la capacità <strong>dei</strong> subentrati, si valutano nei confronti del de cuius e non del rappresentato; 3)<br />
ai sensi dell'art. 740 c.c., il rappresentante deve conferire, ai fini della collazione, le donazioni fatte dal<br />
defunto al suo ascendente, ma non quelle ricevute <strong>di</strong>rettamente (Ferri; Grosso-Burdese; Cass. 9.11.1971 n.<br />
3163; contra Cariota Ferrara); 4) la rappresentazione vale anche in caso <strong>di</strong> unicità <strong>di</strong> stirpe; 5) la <strong>di</strong>visione si<br />
fa per stirpi (doppia <strong>di</strong>visione: Cass. 29.10.1992 n. 11762; ammessa deroga con il consenso <strong>di</strong> tutti i<br />
con<strong>di</strong>videnti: Cass. 7.9.1977 n. 3894).<br />
Ambito <strong>di</strong> applicazione Come detto, la rappresentazione si applica sia alla successione legittima, sia a quella<br />
testamentaria, ma in quest'ultima: a) può essere stata prevista la sostituzione (art. 688 c.c.); b) se il<br />
chiamato, che non può o non vuole accettare, è un legittimario, sulla sostituzione prevale la<br />
rappresentazione a favore <strong>dei</strong> “<strong>di</strong>scendenti <strong>dei</strong> figli legittimi e naturali o adottivi” (art. 536, 3 comma c.c.:<br />
rappresentazione c.d. impropria: cfr. sul punto Mengoni); c) art. 467, 2 comma c.c.: non si applica se trattasi<br />
<strong>di</strong> legato <strong>di</strong> usufrutto o altro <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> natura personale <strong>di</strong>sposto dal testatore a favore del rappresentato (art.<br />
467 c.c.: si presume che il testatore abbia voluto beneficiare esclusivamente il rappresentato e non altri),<br />
oppure <strong>di</strong> un legato ex lege (art. 580 c.c.: assegno vitalizio figli irriconoscibili; o perio<strong>di</strong>co: assegno a carico<br />
dell'ere<strong>di</strong>tà per il coniuge <strong>di</strong>vorziato in stato <strong>di</strong> bisogno); d) non si applica se il testatore ha espressamente<br />
escluso l'operatività della rappresentazione, anche senza ricorrere alla sostituzione (Ferri). La <strong>di</strong>sposizione,
quin<strong>di</strong>, avrebbe carattere personale (attenzione: equivale a <strong>di</strong>seredazione se concerne un determinato<br />
rappresentato).<br />
Rapporti con figure affini 1) la rappresentazione non prevale sull'art. 479 c.c. (Ferri, fa salvo il limite della<br />
legittima riservata per rappresentazione ai <strong>di</strong>scendenti del defunto, ex art. 536 c.c.; contra Bianca); sono<br />
<strong>di</strong>versi i presupposti; capacità e indegnità si valutano rispetto al trasmittente, non al de cuius; 2)<br />
accrescimento: la rappresentazione prevale sull'accrescimento, non sulla sostituzione (se questa non<br />
pregiu<strong>di</strong>ca i <strong>di</strong>ritti che i <strong>di</strong>scendenti del figlio hanno sulla quota <strong>di</strong> legittima spettante al loro ascendente (art.<br />
566, 4 comma c.c.).<br />
ACCRESCIMENTO (artt. 674-678 c.c.) Fondamento dell'accrescimento in materia successoria: a) tesi<br />
soggettiva (Gazzara; Robbe; Azzariti Martinez) l'accrescimento si giustifica sulla presumibile volontà del<br />
testatore (che infatti lo può escludere) - secondo questa tesi il testatore può prevedere l'accrescimento (c.d.<br />
volontario) anche oltre i limiti legali (per quote <strong>di</strong>seguali: l'art. 674 c.c. sarebbe una norma <strong>di</strong>spositiva o<br />
integrativa: Gazzara; Robbe; Gangi); b) tesi oggettiva (Patti, Bigliazzi Geri, Barbero, Giannattasio) è un<br />
effetto ex lege (espansione della quota) scelto dal legislatore (secondo l’art. 647 c.c. l’accrescimento “ha<br />
luogo <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto”: la conseguenza <strong>di</strong> questa automaticità fa sì che la rinuncia <strong>di</strong>venti irrevocabile) e fondato<br />
sulla chiamata solidale (opera <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto e cede alla rappresentazione): la legge, cioè, privilegia i successori<br />
testamentari, rispetto agli ere<strong>di</strong> legittimi, e i collegatari rispetto agli ere<strong>di</strong>. Secondo questa tesi (e la<br />
giurisprudenza: Cass. 24.2.1976 n. 604) il testatore non può andare oltre i limiti legali (si nega<br />
l'accrescimento volontario per quote <strong>di</strong>seguali, mancando la chiamata solidale: si tratterebbe <strong>di</strong> una<br />
sostituzione reciproca e gli effetti sarebbero ben <strong>di</strong>versi). Presupposti: a) coniuctio re et verbis (più ere<strong>di</strong><br />
istituiti con uno stesso testamento nello stesso oggetto: Azzariti Martinez; Gangi, Palazzo e Caramazza; i<br />
testamenti potrebbero essere anche due, purchè non incompatibili - se più chiamati in quote uguali con<br />
testamenti <strong>di</strong>versi non si verifica l’accrescimento, perché si presume volontà contraria del de cuius: Gangi)<br />
nell'universalità <strong>dei</strong> beni senza determinazione <strong>di</strong> parti o in parti uguali, anche se determinate) b) mancato<br />
acquisto da parte <strong>di</strong> un coerede: nell'accrescimento si va oltre l'indegnità, la premorienza e la rinuncia,<br />
comprendendosi ogni causa impe<strong>di</strong>tiva dell'accettazione (Gazzara); c) inoperatività dell'art. 479 c. c., della<br />
rappresentazione o della sostituzione. L’accrescimento, in astratto, può riguardare sia una quota non ancora<br />
acquistata (accrescimento proprio), sia una quota già acquistata (accrescimento improprio: vis espansiva<br />
della proprietà). Ambito <strong>di</strong> applicazione A) Successione testamentaria: ai sensi dell’art. 523 c.c.<br />
l'accrescimento fra coere<strong>di</strong> richiede la chiamata congiuntiva (stesso testamento, nell'universalità <strong>dei</strong> beni, o<br />
nella stessa quota senza determinazioni <strong>di</strong> parti o in parti uguali); per i legati l'accrescimento ha luogo<br />
quando il bene sia legato a più collegatari senza determinazione <strong>di</strong> parti o in parti uguali (anche con<br />
testamenti <strong>di</strong>versi); B) Successione legittima: l’art. 522 c.c. (salva la rappresentazione) fa riferimento alla<br />
sola rinuncia (l’art. 522 c.c. è un’eccezione all'art. 521 c.c. che stabilisce la retroattività della rinuncia con la<br />
conseguenza che il rinunciante si considera come mai chiamato): all’apertura della successione,<br />
escludendosi la premorienza, l'accrescimento ha luogo fra chiamati <strong>di</strong> pari grado (gli altri chiamati e il<br />
rinunciante devono essere nello stesso grado (membri dello stesso gruppo, ad esempio figli o fratelli), come<br />
ad esempio nell’art. 581 c.c.: non si ha accrescimento, invece, della quota del coniuge rinunciante a favore<br />
<strong>dei</strong> figli, concorrenti sì, ma in quote <strong>di</strong>verse (App. Perugia 22.6.1987: la quota uxoria, in caso <strong>di</strong> rinuncia,<br />
aumenta la quota <strong>di</strong>sponibile che va devoluta all'erede universale). Nella successione legittima, infatti,<br />
l’accrescimento si spiega come applicazione del principio dell'or<strong>di</strong>ne delle categorie <strong>dei</strong> successibili, per cui<br />
una categoria prevale sull'altra: alcuni lo ammettono (Bianca; Messineo; Robbe; Gangi; Ferrari), per altri non<br />
si tratterebbe <strong>di</strong> accrescimento in senso tecnico, ma <strong>di</strong> mero incremento della quota (Gazzara; Mengoni;<br />
Carraro; Scognamiglio: tesi soggettiva dell'accrescimento fondata sulla presunta volontà del de cuius che<br />
nella successione legittima non c'è). La rinuncia all'ere<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> un coerede opera imme<strong>di</strong>atamente<br />
l'accrescimento (se gli altri hanno già accettato), con conseguente irrevocabilità della rinuncia, ex art. 525<br />
c.c. C) Successione necessaria: la maggioranza della dottrina la esclude: con la rinuncia all'azione <strong>di</strong><br />
riduzione (se legittimario preterito) o all'ere<strong>di</strong>tà (se legittimario leso) il legittimario perde questa qualificazione<br />
ex tunc e dunque non c'è quota vacante (Palazzo; Mengoni; Capozzi), né la quota che spetta ai soggetti<br />
legittimari non rinunciatari si accresce della quota del rinunziante. Quin<strong>di</strong>, il legittimario rinunziante non è<br />
computato nel calcolo della legittima: Cass. 9.3.1987 n. 2434. In tal caso, l’art. 521 c.c. funziona pienamente,<br />
ossia la rinuncia elimina retroattivamente il chiamato (come se non fosse mai esistito).<br />
Regole: 1) non deve risultare prevista dal testatore una sostituzione (art. 688 c.c.); 2) non deve essere<br />
applicabile la rappresentazione (art. 674 c.c.); 3) non deve risultare una volontà (espressa, non si presume)<br />
del testatore contraria all'accrescimento, anche a prescindere dalla sostituzione (l’art. 674 c.c. non è<br />
inderogabile: Terzi, Gangi; in tal modo, la vocazione da solidale <strong>di</strong>venterebbe parziaria: Cicu); 4) se risulta la<br />
volontà del testatore <strong>di</strong> attribuire la quota vacante ai coere<strong>di</strong> (al <strong>di</strong> là <strong>dei</strong> requisiti legali dell'accrescimento) ha<br />
valore <strong>di</strong> una sostituzione reciproca.<br />
Effetti L'accrescimento opera <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto (art. 676 c.c.: effetto della chiamata in universum ius: Cicu):<br />
maggiorazione proporzionale nel quantum spettante agli altri aventi <strong>di</strong>ritto (coere<strong>di</strong> che hanno già accettato)<br />
e ciò avviene a) art. 676 c.c.: acquisto <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto (automatico, senza bisogno <strong>di</strong> ulteriore accettazione); b)<br />
retroattivamente all'apertura della successione; c) irrinunciabilità: la parte accresciuta è tutt'uno con l'ere<strong>di</strong>tà
già conseguita alla quale si può rinunciare solo in toto e non pro parte (Bianca; Patti; Bigliazzi Geri); d)<br />
passaggio <strong>di</strong> oneri <strong>di</strong> natura non personale (anche ultra vires, se non c'è beneficio <strong>di</strong> inventario), ma la<br />
norma è derogabile.<br />
Ven<strong>di</strong>ta della coere<strong>di</strong>tà Se il coerede o il collegatario hanno alienato a terzi la quota <strong>di</strong> ere<strong>di</strong>tà o il bene<br />
oggetto del legato, una successiva attivazione dell'accrescimento, data la sua automaticità, opera a favore<br />
dell'acquirente, salva <strong>di</strong>versa volontà delle parti (che intendono limitare la cessione al <strong>di</strong>ritto esistente nel<br />
momento della cessione, escludendo l'accrescimento: Patti; Pugliatti; Azzariti Martinez; contra Palazzo,<br />
Scognamiglio; Terzi). Accrescimento fra collegatari (art. 675 c.c.) E’ ammesso, salvo contraria volontà del<br />
testatore o funzionamento della rappresentazione (sull’argomento: Pugliatti; Barassi; Scognamiglio; Gangi;<br />
Caramazza; App. Napoli 30.6.1978; Cass. 20.4.1994 n. 3746). Accrescimento nel legato <strong>di</strong> usufrutto<br />
congiuntivo L’art. 678 c.c. è una norma eccezionale, perché l’accrescimento opera anche quando la<br />
mancanza <strong>di</strong> un legatario avvenga “dopo” aver conseguito il possesso (acquisto) della cosa oggetto <strong>di</strong><br />
usufrutto: non si ammette la sua estensione per analogia. Inoperatività dell’accrescimento (art. 677 c.c.): la<br />
quota vacante si devolve agli ere<strong>di</strong> legittimi, la porzione del legatario, invece, in mancanza <strong>di</strong> accrescimento,<br />
sostituzione o rappresentazione, si estingue a profitto dell'onerato (art. 662 c.c.).<br />
Sostituzione or<strong>di</strong>naria (artt. 688-691 c.c.) Il suo ambito <strong>di</strong> applicazione è successione testamentaria ed<br />
evita la successione legittima. Si ammette (Bianca; Eula) che il testatore <strong>di</strong>sponga una sostituzione anche<br />
nei confronti <strong>di</strong> un chiamato ex lege che non possa o non voglia accettare l'ere<strong>di</strong>tà (contra Gangi; Messineo,<br />
secondo cui la sostituzione si fonda esclusivamente sulla primaria istituzione testamentaria; nel caso <strong>di</strong><br />
erede ex lege non si tratterebbe <strong>di</strong> sostituzione, ma <strong>di</strong> chiamata sottoposta a con<strong>di</strong>zione sospensiva che il<br />
chiamato ex lege non succeda). Nozione e natura giuri<strong>di</strong>ca: doppia vocazione, ma unicità dell'istituzione,<br />
vocazione ere<strong>di</strong>taria <strong>di</strong> secondo grado subor<strong>di</strong>nata alla mancata accettazione del primo chiamato: teoria <strong>di</strong><br />
maggioranza (Luminoso; Gangi; Ferrari; Talamanca; Caramazza) della vocazione sospensivamente<br />
con<strong>di</strong>zionata (tesi minoritaria della vocazione in<strong>di</strong>retta - Cicu - come nella rappresentazione o<br />
nell'accrescimento: ma qui la vocazione è <strong>di</strong>retta; Criscuoli la definisce <strong>di</strong>sposizione ad alternatività<br />
soggettiva or<strong>di</strong>nata; altre tesi: istituzione soggetta a con<strong>di</strong>cio iuris: Coviello; Cariota Ferrara; Barbero;<br />
vocazione imme<strong>di</strong>ata con delazione successiva: Cariota Ferrara).<br />
E’ possibile per l'ere<strong>di</strong>tà o per il legato (art. 691 c.c.), nonché per il modus. Sostituzioni c.d. consecutive (ma<br />
la vocazione resta unica); ammissibilità <strong>di</strong> sostituzione semplice o plurima (ad A si sostituisce una pluralità:<br />
B,C,D - il lascito si <strong>di</strong>viderà in parti uguali salva <strong>di</strong>versa volontà del de cuius; se la chiamata è parziaria le<br />
quote <strong>dei</strong> sostituiti rinuncianti si devolvono per legge, perché non può operare l'accrescimento - oppure a più<br />
chiamati si sostituisce un solo chiamato - ma ci sarà sostituzione solo se tutti i primi chiamati non succedono<br />
perché, altrimenti, data l'istituzione congiuntiva, prevale l'accrescimento; se è parziaria la sostituzione<br />
funziona anche con la vacanza <strong>di</strong> una sola quota e il sostituito concorrerà con gli altri istituiti) unilaterale o<br />
reciproca (ossia fra più designati in via primaria: art. 689 c.c.); ammessa, nonostante la non identità<br />
dell'oggetto, la sostituzione parziale (una quota dell'intera ere<strong>di</strong>tà; per la restante quota vacante si aprirà la<br />
successione legittima, rappresentazione o accrescimento: Talamanca; Criscuoli); mentre non è ammessa la<br />
sostituzione mutativa o accrescitiva (mutamento <strong>di</strong> oggetto o accrescimento del medesimo rispetto alla<br />
chiamata originaria; invece può essere inferiore).<br />
Presupposti Impossibilità <strong>di</strong> accettare o mancanza della volontà <strong>di</strong> accettare (premorienza, assenza,<br />
indegnità, invali<strong>di</strong>tà della prima istituzione, rinuncia, decadenza, ecc.). Art. 688 c.c.: se il testatore ha<br />
previsto espressamente una causa, ad esempio la premorienza, si presume iuris tantum che debba<br />
ricomprendersi anche la causa impe<strong>di</strong>tiva non espressa. La sostituzione opera anche in caso <strong>di</strong> risoluzione<br />
per inadempimento dell'onere apposto alla <strong>di</strong>sposizione a favore del primo istituito (Cass. 10.11.1976 n.<br />
4145; Cass. 19.11.1993 n. 11430).<br />
Effetti Si evita l'accrescimento e la rappresentazione (salvo che il chiamato sia un legittimario, ex art. 467, 2<br />
comma c.c. e art. 536, 3 comma c.c.: si afferma che la sostituzione ha valore nei soli limiti della <strong>di</strong>sponibile:<br />
Ferri e Ferrari); art. 690 c.c., salva la natura strettamente personale o la <strong>di</strong>versa volontà del de cuius,<br />
ricadono sul sostituito obblighi, legati e modus posti a carico del primo istituito, ma non la con<strong>di</strong>zione perché<br />
non è un obbligo in senso tecnico (Gangi; Talamanca; contra Azzariti). I termini <strong>di</strong> prescrizione decorrono<br />
dall'apertura della successione (ma sui termini <strong>di</strong> accettazione per i chiamati ulteriori: Cass. 16.8.1993 n.<br />
8737, a proposito dell’art. 480, 3 comma c.c.); inoltre, possibile applicazione dell’art. 481 c.c.<br />
Sostituzione nel legato (art. 691 c.c.) Stessa <strong>di</strong>sciplina dell'erede; se la prima chiamata prevedeva un<br />
prelegato - e nulla <strong>di</strong>spone la sostituzione - si presume che questo debba risolversi.<br />
Rapporti con figure affini 1) art. 479 c.c.: per la dottrina dominante questa norma prevale sulla sostituzione<br />
(per Gangi prevarrebbe la sostituzione, perché si fonda sulla volontà testamentaria); si fa salva la volontà del<br />
testatore che desidera l'accettazione personale del chiamato combinata alla sostituzione, evitando l’art. 479<br />
c.c. (Talamanca); 2) la sostituzione prevale sull'accrescimento, che va <strong>di</strong>stinto dalla sostituzione reciproca;<br />
3) prevalenza della sostituzione sulla rappresentazione (senz'altro se rappresentato è un fratello, ma se è un<br />
figlio prevale solo se non pregiu<strong>di</strong>ca i <strong>di</strong>ritti che i <strong>di</strong>scendenti del figlio/rappresentato hanno sulla quota <strong>di</strong><br />
legittima spettante al loro ascendente (art. 536, 4 comma c.c.) e la sostituzione opererà solo sulla<br />
<strong>di</strong>sponibile.
Sostituzione fedecommissaria (artt. 692-697 c.c.) Caratteristiche a) doppia vocazione - una successiva<br />
all'altra - per il medesimo oggetto o parte <strong>di</strong> esso (<strong>di</strong>stinzione della sostituzione fedecommissaria dalla<br />
fiducia testamentaria - art. 627 c.c. - in cui risulta un unico destinatario); b) la seconda chiamata ha effetto<br />
con la morte del primo chiamato; c) conseguente obbligo per il primo chiamato <strong>di</strong> conservare e restituire al<br />
secondo istituito: in tal modo, si lede la libertà <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizione del primo chiamato, sia inter vivos che mortis<br />
causa (principio <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico); il sostituito succede mortis causa al testatore (art. 696 c.c.). La doppia<br />
chiamata successiva può avere anche titolo <strong>di</strong>verso (l'uno erede e l'altro legato: Talamanca, Capozzi;<br />
Azzariti; per Gangi l'una è istituzione ere<strong>di</strong>taria e l'altra legato a termine iniziale coincidente con la morte<br />
dell'istituito), non si avrebbe, ad esempio, nell’ipotesi <strong>di</strong> lasciti <strong>di</strong> usufrutto e nuda proprietà dello stesso bene<br />
(Cass. 7.10.1974 n. 2632). In realtà, conservazione e restituzione non sono obblighi, ma risultati dell'efficacia<br />
retroattiva del lascito alla morte del primo istituito (Talamanca). Il secondo istituito subentra automaticamente<br />
alla morte del primo e dunque è avente causa del de cuius (se c'è l'obbligo <strong>di</strong> dare i beni ad un terzo, prima<br />
della morte dell'istituito, è un termine efficace per il legato, ma invalido per l'ere<strong>di</strong>tà). Il fondamento, oltre che<br />
la libera <strong>di</strong>sponibilità <strong>dei</strong> beni e la libertà testamentaria, risulterebbe altresì la libera circolazione <strong>dei</strong> beni.<br />
Casi esclusi dalla sostituzione fedecommissaria: a) <strong>di</strong>vieti relativi <strong>di</strong> alienazione (non opponibile a terzi: art.<br />
1379 c.c.); b) usufrutto e proprietà: sono attribuiti ai chiamati in modo simultaneo e non successivo <strong>di</strong>ritti<br />
<strong>di</strong>versi (Azzariti; Cass. 21.1.1985 n. 207; Trib. Viterbo 4.6.1985): la consolidazione dell'usufrutto alla nuda<br />
proprietà non è un effetto della successione, ma della vis espansiva della proprietà (Capozzi); c) clausola si<br />
sine liberis decesserit: valutazione caso per caso della volontà del testatore (Cass. 19.1.1985 n. 190; Cass.<br />
27.11. 1990 n. 11428); d) con<strong>di</strong>zione risolutiva.<br />
Fedecommesso assistenziale (art. 692 c.c.) Avrebbe una ratio assistenziale; l'istituito sarebbe titolare <strong>di</strong><br />
una proprietà temporaneamente in<strong>di</strong>sponibile (non ne può liberamente <strong>di</strong>sporre: Piras; Messineo; Gangi); <strong>di</strong><br />
una proprietà risolubile (Pelosi; Amato-Marinaro, ma oltre al tempo occorre la sopravvivenza del sostituto<br />
all'istituito); o un titolare fiduciario dell'ere<strong>di</strong>tà (Ambrosini, ma l'ere<strong>di</strong>tà si devolve automaticamente, quin<strong>di</strong><br />
non si può accostare all’art. 627 c.c.); simile all'usufruttuario (Butera); istituzione sottoposta alla con<strong>di</strong>zione<br />
risolutiva con la precisazione che essa non ha effetto retroattivo (Talamanca). Istituiti (coniuge e figli, esclusi<br />
i fratelli), sostituiti (per relationem dalla legge - tesi restrittiva - o anche dalla volontà del testatore - tesi<br />
estensiva; persone - anche il tutore - o enti pubblici e privati), incapace (interdetto, minore che sarà<br />
interdetto alla maggiore età, revoca dell'inter<strong>di</strong>zione), cura (in senso materiale ed oggettivo).<br />
Legati (art. 697 c.c.) Stesse regole (da ricordare che per i legati valgono i termini iniziale e finale: ma non è<br />
consentito un termine iniziale coincidente con la morte del primo chiamato, erede o legatario, perché<br />
equivale a sostituzione fedecommissaria: ci sarebbe frode alla legge, invece, quando il termine coincide con<br />
la morte “presumibile” del primo chiamato). Se il legatario deve restituire al sostituito il tantundem <strong>di</strong> un<br />
lascito, avente ad oggetto beni fungibili o il valore del bene ricevuto, non si tratta <strong>di</strong> sostituzione<br />
fedecommissaria, perché manca l'obbligo <strong>di</strong> conservare e il bene non è il medesimo (Talamanca); è una<br />
sostituzione fedecommissaria, invece, se A è istituito a titolo <strong>di</strong> erede e deve conservare per restituire a B a<br />
titolo <strong>di</strong> legato.<br />
Fedecommesso de residuo Si restituisce al sostituito solo ciò che resta alla morte del primo istituito: manca<br />
l'obbligo <strong>di</strong> conservare; l'istituito può godere e <strong>di</strong>sporre inter vivos <strong>dei</strong> beni ricevuti, ma gli è vietato <strong>di</strong>sporne<br />
per testamento. Sono figure eterogenee: a volte si prevede anche per ciò <strong>di</strong> cui è proprietario personalmente<br />
il primo chiamato (caso <strong>di</strong> coniugi senza figli), affinché il patrimonio segua solo una <strong>di</strong>rezione familiare. Sotto<br />
il cod. civ. 1865 la figura si reputava valida. Oggi la sua nullità, oltre che per estensione della nullità della<br />
sostituzione fedecommissaria in ogni caso (art. 692 c.c.; Benedetti, Giannattasio), <strong>di</strong>scenderebbe anche<br />
dall'art. 632, 1 comma c.c. (libero arbitrio dell'onerato la determinazione dell'oggetto o quantità del legato:<br />
ammesso che sia un legato, come rileva Talamanca), nonché dall’art. 458 c.c. (obbligo assunto dall'istituito<br />
verso il testatore <strong>di</strong> restituire il residuo: Bernar<strong>di</strong>; Cass. 22.2.1980 n. 1285). Non è ammessa la sanatoria del<br />
fedecommesso de residuo, perché contrario all’or<strong>di</strong>ne pubblico (Cass. 5.12.1974 n. 4005).<br />
Usufrutto successivo (art. 698 c.c.: usufrutto, ren<strong>di</strong>ta o annualità a più persone successivamente) il legato ha<br />
valore solo per coloro che, alla morte del testatore, si trovano primi chiamati a goderne (non potrebbero<br />
comunque essere trasferiti al secondo) (l'usufrutto congiuntivo con <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> reciproco accrescimento, invece,<br />
è valido, ex art. 678 c.c.); vali<strong>di</strong>tà nei casi previsti dall’art. 699 c.c. La fattispecie è <strong>di</strong>versa dalla sostituzione<br />
fedecommissaria perché manca l'obbligo <strong>di</strong> conservare e restituire (il <strong>di</strong>ritto è legato alla vita del suo titolare),<br />
ma il fondamento è lo stesso (libera <strong>di</strong>sponibilità del bene): l’usufrutto successivo è <strong>di</strong>sposto alla morte <strong>dei</strong><br />
singoli chiamati; invece, in caso <strong>di</strong> legato, è possibile l'usufrutto a termine (iniziale e finale, ma che non<br />
coincida con la morte) per più persone (Talamanca; Ricca; Capozzi). Il <strong>di</strong>vieto è <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne pubblico (Cass.<br />
14.5.1962 n. 1024; Cass. 21.1.1985 n. 207), ma d’interpretazione restrittiva: è ammesso l’usufrutto<br />
congiuntivo con <strong>di</strong>ritto reciproco <strong>di</strong> accrescimento (Trib. Oristano 8.2.1999).<br />
Ammissibilità della conversione della sostituzione fedecommissaria in sostituzione or<strong>di</strong>naria sulla base della<br />
presunta volontà del testatore (art. 1424 c.c.; Trib. Vigevano 9.2.1982; Trib. Messina 5.10.1993): in caso <strong>di</strong><br />
premorienza, si salva la volontà del de cuius talchè, invece della successione legittima, si attua la<br />
successione del sostituito, guardando alla situazione nel momento dell'apertura della successione.
BIBLIOGRAFIA<br />
Achenza, Riflessioni sul fondamento e sui limiti della successione per rappresentazione, in Riv. giur. sarda, 1993, p. 241; Amato<br />
Marinaro, La nuova sostituzione fedecommissaria, Napoli 1979; Azzariti, In tema <strong>di</strong> successione per “rappresentazione”, in Giust. civ.,<br />
1995, IV, p. 209; Bernar<strong>di</strong>ni, La sostituzione fedecommissaria, Napoli 1988; Bernar<strong>di</strong>ni, Sostituzione or<strong>di</strong>naria, in Riv. not., 1992, II, p.<br />
1029; Bernar<strong>di</strong>ni, Sostituzione fedecommissaria, in Riv. not., 1993, II, p. 1081; Calapso, Brevi note sull'accrescimento nell’ambito della<br />
successione legittima. Opinioni <strong>di</strong>verse nel caso <strong>di</strong> concorso del coniuge con i figli del de cuius, in Vita not., 1986, I, p. 446; Caparrelli,<br />
La sostituzione fedecommissaria, in Giur. sist. cod. civ. e comm., Le <strong>successioni</strong> testamentarie a cura <strong>di</strong> C.M. Bianca, Torino 1983;<br />
Cartoni Moscatelli, La sostituzione or<strong>di</strong>naria, in Giur. sist. civ. e comm., Le <strong>successioni</strong> a causa <strong>di</strong> morte a cura <strong>di</strong> C.M. Bianca, Torino<br />
1983; D’Agostino, L’usufrutto successivo, in Via not., 2003, LXXXVI; Durante, voce Fedecommesso, in Enc. giur. Treccani, XIV, Roma<br />
1989; Ferrari, L'accrescimento, in Trattato <strong>di</strong> <strong>di</strong>r. priv. <strong>di</strong>retto da P. Rescigno, VI, Successioni, 2, Torino 1982, p. 248; Ferrari, La<br />
sostituzione or<strong>di</strong>naria, in Trattato <strong>di</strong> <strong>di</strong>r. priv. <strong>di</strong>retto da P. Rescigno, VI, Successioni, 2, Torino 1982, p. 247; Gazzara, Contributo ad una<br />
teoria generale dell'accrescimento, Milano 1956; Meloni, voce Rappresentazione, in Enc. giur. Treccani, XXV, Roma 1991; Moscati, I<br />
limiti della successione per rappresentazione nella linea collaterale (profili storici e costituzionali), in Riv. <strong>di</strong>r. civ., 1977, I, p. 518;<br />
Moretti, La sostituzione fedecommissaria, in Rass. <strong>di</strong>r. civ., 1981, I, p. 443; Moscati, voce Rappresentazione (<strong>di</strong>r. priv.), in Enc. del <strong>di</strong>r.,<br />
XXXVIII, Milano 1987, p. 646; Palazzo, voce Accrescimento, in Dig. <strong>di</strong>sc. priv., sez. civ., Torino 1987, I, p. 46; Perego, La<br />
rappresentazione, in Trattato <strong>di</strong> <strong>di</strong>r. priv. <strong>di</strong>retto da P. Rescigno, V, Successioni, I, Torino 1982, p. 97; Ricca, voce Fedecommesso, in<br />
Enc. del <strong>di</strong>r., XVII, Milano 1968, p. 135; Robbe, voce Accrescimento (<strong>di</strong>ritto civile), in Novissimo Dig. It., I, Torino 1957, p. 164;<br />
Tatarano, voce Accrescimento, in Enc. giur. Treccani, I, Roma 1988; Terzi, Sostituzione semplice e sostituzione fedecommissaria, in<br />
Successioni e donazioni a cura <strong>di</strong> P. Rescigno, I, Padova 1994, p. 1153; Terzi, Accrescimento, in Successioni a causa <strong>di</strong> morte e<br />
donazioni a cura <strong>di</strong> P. Rescigno, I, Padova 1994, p. 1177; Terzi, La rappresentazione, in Successioni e donazioni a cura <strong>di</strong> P. Rescigno,<br />
I, Padova 1994, p. 161; Vettori, La rappresentazione, Napoli 1993.<br />
A) Esercitazione in classe<br />
PARTE PRATICA<br />
Tizio <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> essere sposato, separato e in attesa <strong>di</strong> <strong>di</strong>vorzio e <strong>di</strong> avere un solo figlio naturale, Primo, ed<br />
una figlia adottiva, Seconda, la quale è premorta lasciando una sola figlia, Terza, interdetta.<br />
Vuole lasciare alla moglie Tizia una ren<strong>di</strong>ta annua rivalutabile in sostituzione <strong>di</strong> ogni altro <strong>di</strong>ritto successorio,<br />
in particolare del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> abitazione sulla casa a<strong>di</strong>bita a residenza familiare.<br />
A Terza ed a Primo vuole che vadano i suoi restanti beni, senza il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accrescimento, ed escludendo la<br />
facoltà <strong>di</strong> Terza <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfare in beni immobili od in denaro la porzione spettante a Primo.<br />
Desidera affidare Terza all'istituto Alfa, al quale andranno i beni che spettano a quest’ultima, una volta che<br />
questa sarà morta;<br />
le quote degli ere<strong>di</strong>, che non vogliano o non possano accettare l'ere<strong>di</strong>tà, saranno devolute alla fondazione<br />
culturale Beta.<br />
Vuole lasciare all'Istituto Gamma la somma <strong>di</strong> euro 100.000, con l'onere <strong>di</strong> corrispondere, una generazione<br />
dopo l'altra, la ren<strong>di</strong>ta mensile <strong>di</strong> euro 2.000 ai suoi <strong>di</strong>scendenti, a cominciare dai nipoti. Il testatore desidera<br />
inoltre <strong>di</strong>sporre in or<strong>di</strong>ne alla eventuale sopravvenienza <strong>di</strong> figli, intendendosi riservare la facoltà <strong>di</strong> decidere<br />
se revocare o meno il testamento in tale circostanza.<br />
Il can<strong>di</strong>dato, assunte le vesti del Notaio Romolo Romani con stu<strong>di</strong>o in Roma, re<strong>di</strong>ga un testamento conforme<br />
a legge.<br />
- Legato in sostituzione <strong>di</strong> legittima e <strong>di</strong>ritti spettanti al coniuge superstite ai sensi dell’art. 540, comma<br />
2, c.c.; ren<strong>di</strong>ta costituita me<strong>di</strong>ante legato;<br />
- Esclusione volontaria del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accrescimento;<br />
- Facoltà <strong>di</strong> commutazione e sua esclusione da parte del testatore;<br />
- Sostituzione or<strong>di</strong>naria e sostituzione fedecommissaria, fedecommesso assistenziale, sostituzione<br />
fedecommissaria de residuo;<br />
- Ren<strong>di</strong>ta perpetua semplice e <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> costituzione <strong>di</strong> ipoteca per testamento;<br />
- Revoca del testamento per sopravvenienza <strong>dei</strong> figli: suoi presupposti, tesi interpretative.<br />
B) Casi in classe<br />
1) Rappresentazione e sostituzione<br />
Con testamento olografo del 20 gennaio 2000 Tizio nominava erede universale il proprio figlio Primo,<br />
sostituendogli l’estraneo Caio;<br />
un mese dopo muore Primo, senza testamento, lasciando unico erede il figlio Primetto;<br />
dopo un altro mese muore Tizio;<br />
si recano dal notaio Caio e Primetto per vendere a Quintilio un bene facente parte dell’ere<strong>di</strong>tà: costituire i<br />
soggetti legittimati nell’atto <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta.<br />
2) Accrescimento e sostituzione<br />
Tizio, morendo, istituisce ere<strong>di</strong>: ”i miei cugini Primo e Secondo; qualora non possano o vogliano accettare,<br />
sostituisco loro Terzo”.
Primo rinunzia all’ere<strong>di</strong>tà; si recano dal notaio RR Secondo e Terzo per vendere un bene facente parte<br />
dell’ere<strong>di</strong>tà; costituire nell’atto i soggetti legittimati.<br />
3) Sostituzione fedecommissaria e <strong>di</strong>ritti del sostituito<br />
Tizio, morendo, <strong>di</strong>spone una chiamata a titolo <strong>di</strong> erede universale nei confronti dell’unico figlio Caio,<br />
interdetto, sostituendogli il proprio fratello Sempronio, che ne avrà cura;<br />
Sempronio, in non floride con<strong>di</strong>zioni economiche, si reca dal notaio RR insieme a Mevio, per vendere a<br />
quest’ultimo o un appartamento in Latina, facente parte dell’ere<strong>di</strong>tà, ovvero anche tutta l’ere<strong>di</strong>tà, se<br />
possibile, in vista del momento in cui gli perverrà.<br />
4) Sulla rappresentazione<br />
Tizio, senza <strong>di</strong>scendenti ed ascendenti, <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> voler istituire ere<strong>di</strong> il fratello Sempronio ed i nipoti Caietto<br />
e Caietta, figli della defunta sorella Caia.<br />
Desidera, tuttavia, che, nel caso in cui Sempronio non voglia o non possa accettare la sua ere<strong>di</strong>tà, la sua<br />
quota non si trasmetta ai suoi <strong>di</strong>scendenti per <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> rappresentazione.<br />
5) Attribuzione <strong>di</strong> nuda proprietà e usufrutto<br />
Tizio vuole lasciare tutti i suoi beni alla madre, e alla morte <strong>di</strong> lei vuole che vadano in proprietà alla società<br />
Alfa.<br />
6) Sostituzione fedecommissaria “de residuo”<br />
Tizio nomina erede Caio il quale potrà <strong>di</strong>sporre come vuole <strong>dei</strong> beni ere<strong>di</strong>tari, con il solo obbligo <strong>di</strong> restituire<br />
a Sempronio quanto resterà <strong>di</strong> essi al momento della sua morte.<br />
7) Sostituzione fedecommissaria assistenziale “de residuo”<br />
Tizio nomina erede universale l'unico figlio interdetto Caio con l'obbligo <strong>di</strong> restituire quei beni ere<strong>di</strong>tari <strong>di</strong> cui<br />
non avrà <strong>di</strong>sposto in vita, a quel determinato istituto religioso che avrà avuto cura <strong>di</strong> lui.<br />
C) Esercitazione a casa<br />
Tizio, proprietario <strong>di</strong> un considerevole patrimonio, si reca nello stu<strong>di</strong>o del notaio Romolo Romani <strong>di</strong> Roma, e<br />
gli chiede <strong>di</strong> ricevere il suo testamento in forma pubblica, dopo avergli esposto che è vedovo, sordomuto, e<br />
che ha tre soli figli: Primo e Seconda, figli legittimi e Terzo, figlio naturale;<br />
è sua volontà <strong>di</strong> beneficiare, per quanto possibile, Seconda, in quanto Primo è affermato artista, molto<br />
abbiente, mentre è in lite con Terzo;<br />
intenderebbe:<br />
a) lasciare a Primo e Terzo solo il minimo <strong>di</strong> legge, nonchè la somma <strong>di</strong> Euro 100.000 in contanti;<br />
b) lasciare a Seconda tutto il resto;<br />
desidera però che Seconda si faccia carico dell'assistenza della zia Cornelia, anziana e molto malata; in<br />
particolare dovrebbe assisterla personalmente, tenendola presso <strong>di</strong> sè e non affidandola a case <strong>di</strong> cura o <strong>di</strong><br />
riposo;<br />
c) essere cremato;<br />
d) che con il ricavato della ven<strong>di</strong>ta <strong>dei</strong> suoi appartamenti in La<strong>di</strong>spoli vengano dette messe in suo suffragio,<br />
e venga pagato il nuovo altare della cattedrale del suo paese natale, opera da eseguirsi da parte del suo<br />
caro amico scultore, Quintiliano;<br />
e) che ove uno <strong>dei</strong> suoi figli intenda cedere od alienare in tutto o in parte alcuni degli immobili compresi nella<br />
successione, sia tenuto a preferire gli altri due; vuole inoltre che Terzo conceda a Primo prelazione in caso<br />
<strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta della casa donatagli dalla madre Caia;<br />
f) lasciare a Primo i <strong>di</strong>ritti a lui eventualmente spettanti sull'ere<strong>di</strong>tà del padre naturale Catullo, deceduto nel<br />
1980 senza averlo riconosciuto nè beneficiato in alcun modo, e del quale solo recentemente è stato<br />
<strong>di</strong>chiarato giu<strong>di</strong>zialmente figlio naturale.<br />
Assunte le vesti del notaio Romolo Romani, il can<strong>di</strong>dato adegui la volontà del testatore alle inderogabili<br />
norme <strong>di</strong> legge ed in parte teorica tratti <strong>dei</strong> <strong>di</strong>ritti <strong>dei</strong> legittimari, del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> cui all'art. 549 c.c. e della<br />
prelazione costituita per testamento.<br />
D) Correzione 2° esercitazione a casa
V LEZIONE (5.2.2013)<br />
Il testamento. Definizione, caratteri essenziali, contenuto patrimoniale/personale. Capacità testamentaria e<br />
capacità <strong>di</strong> ricevere per testamento. I vizi della volontà testamentaria (art. 624 c.c.) e il motivo illecito (art.<br />
626 c.c.). La certezza della volontà testamentaria (artt. 625 e 628 c.c.). Disposizioni a favore dell’anima o <strong>dei</strong><br />
poveri (artt. 629 e 630 c.c.). La personalità (artt. 631-632 c.c. e <strong>di</strong>sposizione per relationem). La <strong>di</strong>sposizione<br />
fiduciaria (art. 627 c.c.). Le forme del testamento. Conferma e volontaria esecuzione delle <strong>di</strong>sposizioni<br />
testamentarie nulle (art. 590 c.c.).<br />
PARTE TEORICA<br />
Il testamento è il negozio con cui un soggetto <strong>di</strong>spone <strong>dei</strong> propri beni per i tempo in cui avrà cessato <strong>di</strong><br />
vivere, con cui cioè si regola post mortem la trasmissione ad altri soggetti del proprio patrimonio (Bigliazzi<br />
Geri, Criscuoli). Mentre nel primo comma dell'art. 587 c.c. si definisce il testamento in senso sostanziale, nel<br />
secondo comma si definisce il medesimo in senso formale (<strong>di</strong>sposizioni atipiche o personali) (Giampiccolo).<br />
Dall'art. 587, 1 comma c.c. si deducono i tre caratteri fondamentali del testamento: revocabilità, unilateralità<br />
e patrimonialità. Inoltre, dagli artt. 589 e 631 c.c. si deduce l’unipersonalità; dagli artt. 458 e 679 c.c. la<br />
spontaneità del volere; dagli artt. 601 e ss. c.c. la solennità della forma.<br />
ATTO MORTIS CAUSA Tipico ed unico (artt. 457 e 458 c.c.). Presupposto <strong>di</strong> efficacia è la morte del suo<br />
autore; la causa, intesa come funzione economico-sociale dell'atto, è quella <strong>di</strong> regolare post mortem degli<br />
interessi patrimoniali del testatore. Più specificatamente, il testamento è un atto a causa <strong>di</strong> morte <strong>di</strong> ultima<br />
volontà: l'atto è perfetto al momento della redazione, ma <strong>di</strong>venta efficace solo con la morte del suo autore e<br />
rappresenta l'ultima volontà del de cuius (in quanto non revocato). Non sarebbero atti <strong>di</strong> ultima volontà, pur<br />
essendo a causa <strong>di</strong> morte, il mero atto giuri<strong>di</strong>co a causa <strong>di</strong> morte (ad esempio, gli artt. 285 e 286 c.c.), il<br />
negozio mortis causa liberale (patto successorio istitutivo: Giampiccolo). ATTO UNILATERALE Si perfeziona<br />
con la sola volontà del suo autore: artt. 587 e 458 c.c. ATTO UNIPERSONALE (deve contenere solo la<br />
volontà del testatore: artt. 458, 589, 635 c.c.). ATTO PATRIMONIALE, ma non <strong>di</strong> liberalità o a titolo gratuito,<br />
come tra<strong>di</strong>zionalmente si è inteso (manca la corrispettività e non sempre si risolve in un vantaggio per<br />
l'erede). ATTO NON RECETTIZIO (non ci sono destinatari, né è <strong>di</strong>retto alla conoscenza <strong>di</strong> altri); negli artt.<br />
603 e 609 c.c. il notaio o i testimoni non sono destinatari della <strong>di</strong>chiarazione, ma meri strumenti <strong>di</strong> una<br />
documentazione che concorrono a formare (Giampiccolo). ATTO REVOCABILE (ambulatoria est voluntas<br />
defuncti usque ad supremum exitum). ATTO PERSONALISSIMO (non è ammessa rappresentanza, né può<br />
essere stabilito il suo contenuto oggettivo/soggettivo da altri: artt. 631 e 632 c.c.). ATTO FORMALE E<br />
SOLENNE (non è ammesso il testamento orale, le forme testamentarie sono tutte scritte e tipiche).<br />
CONTENUTO TIPICO o patrimoniale (funzione “<strong>di</strong>spositiva”) (art. 587, 1 comma c.c.): secondo l'opinione<br />
dominante il contenuto patrimoniale si esaurirebbe nell’istituzione <strong>di</strong> uno o più ere<strong>di</strong> e <strong>di</strong> uno o più legatari<br />
(oppure soltanto legati). Disposizioni accessorie o complementari ad esse (Giampiccolo) tra le quali la<br />
nomina dell'esecutore testamentario (art. 700 c.c.), del curatore speciale per l'amministrazione <strong>dei</strong> beni<br />
lasciati al minore (art. 356 c.c.), del terzo arbitratore per la scelta del legatario o dell'oggetto o quantità del<br />
legato (artt. 631 e 632 c.c.), del terzo incaricato <strong>di</strong> formare il progetto <strong>di</strong> <strong>di</strong>visione fra coere<strong>di</strong> (art. 733 c.c.); la<br />
<strong>di</strong>sposizione con cui si impe<strong>di</strong>sce l'accrescimento fra coere<strong>di</strong> o collegatari (artt. 674 e 675 c.c.), la <strong>di</strong>spensa<br />
da collazione (art. 737 c.c.), la <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> preferenza ex art. 558 c.c., gli artt. 733 e 734 c.c., il riparto <strong>dei</strong><br />
debiti fra coere<strong>di</strong> (art. 752 c.c.). Secondo altri nel contenuto patrimoniale vi sarebbero comprese altre<br />
<strong>di</strong>sposizioni (fermo il requisito della forma, sarebbe vero testamento quello che le contiene anche senza<br />
l'istituzione <strong>di</strong> erede o legatario), quali: a) il modus, autonoma <strong>di</strong>sposizione testamentaria (e non elemento<br />
accessorio) che potrebbe esaurire l'intero contenuto del testamento (Giorgianni, Criscuoli, Bin, contra<br />
Marini); b) la <strong>di</strong>seredazione (Bigliazzi Geri, Trabucchi, contra Mengoni); c) la riabilitazione dell'indegno (Bin,<br />
Bigliazzi Geri); d) la costituzione <strong>di</strong> fondazione (Galgano).<br />
CONTENUTO ATIPICO o non patrimoniale (art. 587, 2 comma c.c.). Si ammette che tali <strong>di</strong>sposizioni siano<br />
contenute in un atto avente forma testamentaria, anche se mancano <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> carattere patrimoniale: il<br />
riconoscimento del figlio naturale, l'atto costitutivo della fondazione (art. 14 c.c.), la designazione del tutore e<br />
del protutore del minore (artt. 348 e 355 c.c.), del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato (art. 424<br />
c.c.), la riabilitazione dell'indegno (art. 466 c.c.), la revoca del testamento e la revocazione della stessa (artt.<br />
680 e 681 c.c.), la confessione (art. 2735 c.c.), la revoca del beneficio nel contratto a favore <strong>di</strong> terzo (art.<br />
1412 c.c.), la designazione del beneficiario nell'assicurazione sulla vita a favore del terzo (art. 1920 c.c.) e la<br />
revoca (art. 1912 c.c.), le <strong>di</strong>sposizioni sui funerali e sulla destinazione del cadavere, l'autorizzazione al<br />
prelievo <strong>di</strong> organi a scopo <strong>di</strong> trapianto terapeutico, l'autorizzazione alla pubblicazione postuma delle opere <strong>di</strong><br />
ingegno e degli scritti confidenziali del defunto (l. 22/4/1941 n. 633).<br />
INCAPACITA' DI FARE TESTAMENTO (art. 591 c.c.): A) MINORI (l'emancipato non può fare testamento; il<br />
testamento fatto dal se<strong>di</strong>cenne per riconoscere il proprio figlio naturale, ex art. 250 c.c., è invece reputato<br />
valido: contenuto non patrimoniale del testamento: forma/sostanza del testamento); B) INTERDETTI
Decorrenza dell'incapacità dal giorno della pubblicazione della sentenza <strong>di</strong> inter<strong>di</strong>zione (art. 421 c.c. e art.<br />
416 c.c. per stati <strong>di</strong> incapacità sovrapposti alla minore età). Questione <strong>di</strong> cui all’art. 427 c.c. La revoca della<br />
sentenza fa riacquistare la capacità <strong>di</strong> testare dal giorno del passaggio in giu<strong>di</strong>cato della sentenza <strong>di</strong> revoca<br />
(art. 431 c.c.). L'inabilitato, invece, può fare testamento, salvo <strong>di</strong>mostrare, al momento della redazione del<br />
testamento, la sua incapacità <strong>di</strong> intendere e volere, ai sensi dell’art. 591 n. 3 c.c. (Cass. 2.8.1966 n. 2152);<br />
C) INCAPACI DI INTENDERE E VOLERE Coloro che, sebbene non interdetti, si <strong>di</strong>mostri essere stati, al<br />
momento (non al tempo) della redazione del testamento, incapaci <strong>di</strong> intendere e <strong>di</strong> volere (art. 428 c.c.). Lo<br />
stato psico-fisico del testatore deve essere stato tale da sopprimere l'attitu<strong>di</strong>ne a determinarsi liberamente e<br />
coscientemente (Cass. 22.5.1995 n. 5620). Nozioni <strong>di</strong> “gravità” e “permanenza” dello stato <strong>di</strong> incapacità. La<br />
prova dell'incapacità è data con ogni mezzo (testimoni, presunzioni, scritti, contenuto del testamento,<br />
attestazioni me<strong>di</strong>che, attestazione notarile). La <strong>di</strong>chiarazione del notaio, circa la capacità del testatore, a<br />
volte è stata reputata una clausola <strong>di</strong> stile senza valore probatorio (Cass. 18.8.1981 n. 4939); ma si è<br />
affermato che possa avere anche il valore <strong>di</strong> un virtuale controllo (Cass. 23.1.1991 n. 652).<br />
CAPACITA' DI RICEVERE PER TESTAMENTO A) NON CONCEPITO Può succedere per testamento<br />
anche il non concepito, purchè figlio <strong>di</strong> persona determinata e vivente al momento dell'apertura della<br />
successione (art. 462 c.c.): si tratta <strong>di</strong> fattispecie con<strong>di</strong>zionale legale sospensiva (evento della nascita)<br />
impropria; B) ENTI NON RICONOSCIUTI Sono compresi, in tale nozione, gli enti non esistenti al tempo del<br />
testamento o che sono istituiti nel testamento stesso; mentre sono esclusi gli enti che, pur esistenti, sono<br />
stati soppressi (Cass. 10.1.1995 n. 243; Cass. 27.2.1997 n. 1806). Dopo la l. 22.6.2000 n. 192, è stato<br />
abrogato l’art. 600 c.c.; ai sensi dell’art. 473 c.c., per le ere<strong>di</strong>tà devolute a persone giuri<strong>di</strong>che o ad<br />
associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti, l’accettazione deve farsi con il beneficio <strong>di</strong> inventario<br />
(escluse le società). Incapacità giuri<strong>di</strong>ca relativa: artt. 596, 597, 598, 599 c.c.; gli artt. 592 e 593 c.c. sono<br />
stati abrogati o caducati. L'art. 594 c.c., oggi, non ha più ragione <strong>di</strong> essere contenuto nella <strong>di</strong>sciplina sulla<br />
capacità <strong>di</strong> ricevere per testamento; estensione dell’incapacità a ricevere per testamento<br />
nell’amministrazione <strong>di</strong> sostegno (l. 9.1.2004 n. 6).<br />
VIZI DELLA VOLONTA' TESTAMENTARIA (art. 624 c.c.): a) Violenza (analogia con la <strong>di</strong>sciplina del<br />
contratto, ma maggiore considerazione dell'età, sesso, stato <strong>di</strong> salute, ecc. del de cuius); b) Dolo e<br />
captazione (quest’ultima non consiste nel raggiro, ma nell'attività suggestiva; dottrina e giurisprudenza<br />
propendono per la coincidenza <strong>dei</strong> due vizi, ma cfr. Azzariti Martinez e Barassi); c) Errore. I vizi della volontà<br />
sono causa <strong>di</strong> annullabilità assoluta. ART. 626 c.c. Il motivo illecito - unico, determinante e risultante<br />
dall’atto - comporta la nullità della <strong>di</strong>sposizione testamentaria. Non è un vizio della volontà, né presuppone la<br />
conoscenza, da parte del testatore, dell’illiceità del motivo (ragione determinante) della <strong>di</strong>sposizione<br />
testamentaria.<br />
LA FORMA TESTAMENTARIA Il testamento è un atto essenzialmente formale e solenne perché deve (in<br />
deroga alla regola della libertà delle forme) rivestire una delle forme (scritte) tassativamente stabilite dalla<br />
legge a pena <strong>di</strong> nullità.<br />
TESTAMENTO PUBBLICO E’ il testamento redatto dal notaio (art. 603 c.c. e l. not. 16.2.1913 n. 89).<br />
Species del genus atto pubblico (art. 2699 c.c.), fa piena prova fino a querela <strong>di</strong> falso (art. 2700 c.c.), perciò<br />
la vali<strong>di</strong>tà formale non inficia l'impugnazione (per infermità, mancanza <strong>di</strong> piena libertà e coscienza dell'atto,<br />
volontà viziata). La redazione del testamento pubblico è legata al rispetto <strong>di</strong> una sequenza proce<strong>di</strong>mentale:<br />
a) <strong>di</strong>chiarazione della volontà testamentaria fatta dal testatore al notaio alla presenza <strong>di</strong> due testimoni; b) la<br />
riduzione in iscritto della volontà testamentaria a cura del notaio; c) la lettura del medesimo esclusivamente<br />
da parte del notaio alla presenza <strong>di</strong> due testimoni; d) la menzione nel testamento delle suddette formalità; e)<br />
la menzione del luogo, della data <strong>di</strong> ricevimento e dell'ora della sottoscrizione; f) la sottoscrizione del<br />
testatore, <strong>dei</strong> testimoni e del notaio. La sottoscrizione è un elemento essenziale dell’atto (art. 606 c.c.): della<br />
causa che rende impossibile e/o estremamente <strong>di</strong>fficoltosa la sottoscrizione, da parte del testatore, deve<br />
essere data menzione dettagliata circa le circostanze specifiche e contingenti, la natura ed intensità del fatto<br />
impe<strong>di</strong>tivo. L'impossibilità deve essere effettiva (Cass. 23.10.1978 n. 4781; Cass. 6.11.1996 n. 9674). Il<br />
testatore deve <strong>di</strong>chiarare la causa impe<strong>di</strong>tiva della sottoscrizione e il notaio, prima della lettura dell'atto, deve<br />
menzionare questa <strong>di</strong>chiarazione (nullità del testamento letto prima dell'in<strong>di</strong>cazione della causa): se la causa<br />
d’impossibilità non è effettiva, la menzione della <strong>di</strong>chiarazione non impe<strong>di</strong>sce la nullità dell'atto perché<br />
equivale a rifiuto del testatore <strong>di</strong> sottoscrivere il testamento (Trib. Lucca 11.4.1990; Cass. 6.11.1996 n.<br />
9674). L'inosservanza del complesso delle forme determina la nullità nelle ipotesi in cui manchi la redazione<br />
per iscritto da parte del pubblico ufficiale delle <strong>di</strong>chiarazioni del testatore, ovvero manchi la sottoscrizione<br />
dell'uno o dell'altro. La mancanza delle altre formalità determina l'annullabilità; l'azione può essere proposta<br />
da chiunque vi abbia interesse (annullabilità assoluta). L'attività notarile tipica è la “ricezione in presenza <strong>dei</strong><br />
testimoni” (Triola). Testamento del sordo, del muto o del sordomuto (art. 603, ultimo comma c.c.) -<br />
Testamento del cieco (art. 4 legge 3.2.1975 n. 18).<br />
TESTAMENTO OLOGRAFO E’ il testamento scritto interamente <strong>di</strong> proprio pugno dal testatore (requisiti<br />
essenziali: scrittura autografa del testatore, data e sottoscrizione pure autografe). Il testamento olografo ha<br />
la natura <strong>di</strong> una scrittura privata (artt. 2702 c.c. e 214 c.p.c.: Trib. S. Maria Capua Vetere 5.5.1990). E' valida<br />
la forma epistolare (purchè sia compiuta: App. Trento 19.12.1998). L'autografia risponde ad un’esigenza <strong>di</strong>
autenticità, la data offre certezza temporale, la sottoscrizione in<strong>di</strong>ca la paternità dell'atto, la sua definitività ed<br />
equivale a ricognizione e conferma del contenuto dell'atto. La mancanza <strong>di</strong> autografia (scrittura cosciente,<br />
metodo abituale <strong>di</strong> scrivere) comporta la nullità, così come l'uso <strong>di</strong> macchina da scrivere o computer, metodo<br />
braille. Ammesso lo stampatello (App. Torino 19.12.2000), dubbia la stenografia (impronta personale).<br />
Metodo abituale <strong>di</strong> scrittura. Sulla guida della mano ve<strong>di</strong> Cass. 10.7.1991 n. 7636; Cass. 7.1.1992 n. 32. La<br />
data (giorno, mese, anno) risponde in via presuntiva a risolvere le questioni sulla capacità e sulla revoca (<strong>di</strong><br />
per sé la veri<strong>di</strong>cità della data non è rilevante: art. 602, 2 comma c.c.). Della data si richiede: l'esistenza, la<br />
verità e l'olografia. E' valida la datazione perifrasica (Natale, compleanno, ecc.). La data deve risultare dal<br />
testamento, non aliunde (non vale la data scritta sulla busta: Cass. 24.6.1965 n. 1323; Cass. 6682/1988). Il<br />
testamento privo <strong>di</strong> data non ha efficacia revocatoria <strong>dei</strong> precedenti testamenti (art. 682 c.c.). La mancanza<br />
(totale o parziale) della data comporta annullabilità (Cass. 9.12.1988 n. 6682). Firma autografa del testatore<br />
apposta alla fine della <strong>di</strong>sposizione: nome e cognome, solo cognome e solo nome o altro equipollente<br />
purchè atto a riconoscere il testatore, pseudonimo o rapporto <strong>di</strong> parentela (Cass. 12.10.1992 n. 11504);<br />
ammesso anche il solo nome e l’iniziale del cognome (App. Cagliari 15.1.1993). La mancanza <strong>di</strong><br />
sottoscrizione comporta la nullità dell'atto (art. 601 c.c.; Cass. 1.12.2000 n. 15379). Dopo la morte del<br />
testatore, il testamento olografo, per essere eseguibile, deve essere pubblicato (art. 620 c.c.). Può essere<br />
depositato presso un notaio (implicitamente ammesso dagli artt. 608 e 620 c.c.).<br />
TESTAMENTO SEGRETO Duplicità formale: scheda sottoscritta (atto privato) dal testatore e consegnata in<br />
involucro chiuso al notaio con la <strong>di</strong>chiarazione (atto pubblico) (alla presenza <strong>di</strong> due testimoni) che in esso è<br />
contenuto il suo testamento (<strong>di</strong>fferenza dal semplice deposito del testamento olografo). Tutela della<br />
segretezza del contenuto e maggior garanzia <strong>di</strong> conservazione. Autenticità della data. Per la giurisprudenza<br />
la <strong>di</strong>chiarazione resa al notaio - che nel piego è contenuto il proprio testamento - è assistita da una<br />
presunzione <strong>di</strong> autenticità perché genera una presunzione <strong>di</strong> conformità del contenuto della scheda alla<br />
reale volontà testamentaria del <strong>di</strong>sponente integrando quella <strong>di</strong>chiarazione, da parte dell'autore dell'atto <strong>di</strong><br />
un atto <strong>di</strong> riconoscimento della propria scrittura come documento destinato a tramandare le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong><br />
ultima volontà (Cass. 18.1.1962 n. 83).<br />
TESTAMENTI SPECIALI (artt. 609 ss. c.c.) Non si deroga dalla scrittura, né dalla necessità della<br />
sottoscrizione del testatore e <strong>di</strong> chi lo riceve, ma sono <strong>di</strong>versi i soggetti legittimati a ricevere il testamento e vi<br />
sono delle particolarità anche per quanto riguarda i testi (numero e qualità). Tale testamento ha carattere<br />
provvisorio perché decade per legge (caducazione ex lege; ammissibilità <strong>di</strong> sanatoria ex art. 590 c.c.)<br />
decorsi tre mesi dalla cessazione della circostanza <strong>di</strong> emergenza (Trib. Viterbo 14.4.1987).<br />
E) TESTAMENTO INTERNAZIONALE Si veda la l. 29.11.1990 n. 387, quale legge uniforme per la forma del<br />
testamento internazionale (citta<strong>di</strong>no italiano o straniero): per alcuni è equiparabile al testamento segreto.<br />
La volontà testamentaria La certezza della volontà testamentaria (artt. 625 e 628 c.c.). Disposizioni a<br />
favore dell’anima o <strong>dei</strong> poveri (artt. 629 e 630 c.c.). La personalità (artt. 631-632 c.c. e <strong>di</strong>sposizione per<br />
relationem). La <strong>di</strong>sposizione fiduciaria (art. 627 c.c.). Revoca del testamento.<br />
LA VOLONTA' TESTAMENTARIA deve essere spontanea (libertà testamentaria: artt. 458, 679, 589, 692<br />
c.c.); seria (testamento fatto per scherzo, a scopo d’insegnamento, per finzione scenica: inesistenza e non<br />
nullità: art. 590 c.c.); definitiva (deve contenere una compiuta volontà relativa alla destinazione del<br />
patrimonio post mortem: nullità del progetto o minuta <strong>di</strong> testamento, perché implica una maturazione volitiva<br />
in progresso; il progetto <strong>di</strong> testamento può costituire un elemento estrinseco per interpretare la scheda<br />
testamentaria: Cass. 13.1.1981 n. 275); certa (deve risultare in modo inequivocabile beneficiario/oggetto:<br />
artt. 625 e 628 c.c.); espressa (ovvero scritta); personale (<strong>di</strong>vieto della rappresentanza, volontaria o legale;<br />
non è ammesso il nuncius; la volontà deve provenire “<strong>di</strong>rettamente e personalmente” dal testatore: artt. 602,<br />
605, 603 c.c.; soltanto il testatore può in<strong>di</strong>care il beneficiario della <strong>di</strong>sposizione e l'oggetto della medesima:<br />
artt. 589 e 631 c.c.).<br />
LA CERTEZZA dell'onorato (artt. 625 e 628 c.c.) I soggetti della <strong>di</strong>sposizione devono essere determinati, se<br />
in<strong>di</strong>cati anche solo genericamente devono essere determinabili (dal contesto del testamento o altrimenti).<br />
ART. 625 c.c. Si tratta <strong>di</strong> errore, ma non è un’ipotesi <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizione in incertam personam: segna il limite <strong>di</strong><br />
rilevanza dell’errore ostativo (si ricade, infatti, in caso <strong>di</strong> mancata chiarificazione, nell’annullabilità <strong>di</strong> cui<br />
all'art. 624 c.c.). Non vi rientra l’errore d’identità della persona o <strong>di</strong> una cosa. Nell’art. 625 c.c. si fa<br />
applicazione del principio della prevalenza della volontà sulla <strong>di</strong>chiarazione (art. 1362 c.c.): per escludere la<br />
nullità della <strong>di</strong>sposizione testamentaria per indeterminatezza del beneficiario è sufficiente che questi sia<br />
stato in<strong>di</strong>cato, anche se non per nome, con riferimento ad univoci dati obiettivi (Cass. 2.5.1979 n. 1681).<br />
ART. 628 c.c. Se la persona è sconosciuta o incerta, l'art. 628 c.c. stabilisce la nullità della <strong>di</strong>sposizione<br />
(<strong>di</strong>sposizione in incertam personam: Cass. 30.7.2004 n. 14548).<br />
Disposizioni a favore dell'anima (art. 629 c.c.) (atti del culto secondo la religione del de cuius): sono valide,<br />
se sono determinati i beni o le somme da impiegarsi: si reputa un onere per l'erede o il legatario (art. 648<br />
c.c.). Disposizioni a favore <strong>dei</strong> poveri (art. 630 c.c.) (per estensione “soggetti bisognosi”): se non in<strong>di</strong>cato<br />
l'uso o il pubblico istituto o non vi sia un ente con scopo identico, s’intendono i poveri del luogo in cui il<br />
testatore aveva il domicilio al tempo della morte e i beni sono devoluti al comune (Cass. 6.8.2003 n. 11844;<br />
Cass. 21.2.2007 n. 4022).
LA PERSONALITA’ (artt. 631 e 632 c.c.) La regola è la nullità delle <strong>di</strong>sposizioni testamentarie che fanno<br />
<strong>di</strong>pendere dall'arbitrio (arbitrium merum o arbitrium boni viri) <strong>di</strong> un terzo l'in<strong>di</strong>cazione dell'erede o del<br />
legatario, la determinazione della quota d’ere<strong>di</strong>tà (art. 631, 1 comma c.c.) o la determinazione oggettivaquantitativa<br />
<strong>di</strong> un legato per arbitrio altrui (arbitrium merum) (art. 632 c.c.). Tali nullità riguardano anche le<br />
forme con<strong>di</strong>zionali (si voluerit) (ipotesi <strong>di</strong>versa dalla con<strong>di</strong>zione potestativa, in cui si fa riferimento al fatto del<br />
terzo, mentre l’art. 631 c.c. concerne la volontà del terzo: Cass. 13.3.1993 n. 3082). Le eccezioni - limitate al<br />
legato - riguardano l'in<strong>di</strong>viduazione <strong>dei</strong> soggetti (art. 631, 2 e 3 comma c.c.) e dell’oggetto (artt. 632, 653 665<br />
c.c.). L'art. 631, 2 comma c.c. avrebbe la natura <strong>di</strong> relatio sostanziale Anche la <strong>di</strong>sposizione rivolta all’erede<br />
<strong>di</strong> “dare qualcosa a Tizio a titolo <strong>di</strong> ricordo” è nulla (arbitrium merum: Gangi, Marinaro).<br />
LA DISPOSIZIONE FIDUCIARIA (art. 627 c.c.) La ratio s’in<strong>di</strong>vidua nel formalismo testamentario, nonché nel<br />
<strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> cui all’art. 458 c.c. Secondo alcuni (Azzariti Martinez ed altri), l’art. 627 c.c. s’inquadrerebbe tra<br />
queste <strong>di</strong>sposizioni perché: a) la determinazione della volontà testamentaria si attua al <strong>di</strong> fuori del<br />
testamento; b) ex art. 631 c.c., sarebbe il fiduciario che istituirebbe l’erede o il legatario. Nell’art. 627 c.c. vi<br />
sarebbe un vero negozio fiduciario - anzi, secondo alcuni sarebbe il para<strong>di</strong>gma del negozio fiduciario;<br />
l'assenza dell'obbligo - rectius, della coercibilità dello stesso - deriverebbe solo dal fatto che <strong>di</strong>fetta la forma<br />
(scritta) necessaria; l'incarico <strong>di</strong> trasferire ad altri può essere dato nel testamento, in altro atto o verbalmente.<br />
Differenza con la simulazione (qui è un’interposizione reale) e con l'attribuzione gravata <strong>di</strong> un legato o <strong>di</strong> un<br />
modo. Il fiduciario è il titolare della vicenda successoria (non può rinunciare prima della morte del de cuius,<br />
ex art. 458 c.c.); limitata efficacia alla soluti retentio in caso <strong>di</strong> esecuzione spontanea (obbligazione naturale:<br />
art. 2034 c.c.); la ripetizione è invece ammessa quando il fiduciario sia un incapace o sussista un’incapacità<br />
testamentaria passiva a carico del terzo beneficiario (art. 599 c.c.); secondo alcuni sarebbe estensibile<br />
anche all’incapacità <strong>di</strong> ricevere per testamento (art. 462 c.c.).<br />
DISPOSIZIONE per relationem Relatio sostanziale: E’ vietato - per stabilire i soggetti o l'oggetto della<br />
<strong>di</strong>sposizione - il rinvio al contenuto <strong>di</strong> altri testamenti, atti o documenti del testatore o <strong>di</strong> altri (art. 631, 1<br />
comma c.c.). Sono casi eccezionalmente ammessi: il legato determinato dal terzo con criteri dettati per<br />
l'oggetto e per il beneficiario (art. 631 c.c.); il legato remuneratorio (art. 632, 2 comma c.c.), il legato generico<br />
(art. 653 c.c.) e alternativo (art. 665 c.c.). Relatio formale: è ammessa, perché l'in<strong>di</strong>cazione dell'oggetto o del<br />
beneficiario è completamente stabilita dal testatore; sarebbero valide le <strong>di</strong>sposizioni i cui beneficiari sono<br />
in<strong>di</strong>cati e determinati per relationem con semplice, ma espresso richiamo alle norme sulla successione<br />
legittima (Cass. 18.3.79 n. 1359; contra Cass. 7.3.67 n. 1405).<br />
PATOLOGIE DEL TESTAMENTO Inesistenza: assoluta mancanza della volontà (testamento fatto sulle<br />
scene, per scherzo, ecc.). L'inesistenza non è sanabile in alcun modo; Inefficacia: temporanea (con<strong>di</strong>zione<br />
sospensiva, nascituri, ente non riconosciuto); successiva (con<strong>di</strong>zione risolutiva e termine finale nel legato,<br />
decorso del tempo per i testamenti speciali, art. 687 c.c.); Nullità e annullabilità: <strong>di</strong>fferenze e analogie<br />
nell'ambito del testamento. 1) termine <strong>di</strong> prescrizione: imprescrittibile l'una, l'altra prescrittibile in 5 anni: a)<br />
dal giorno <strong>di</strong> esecuzione del testamento per i vizi <strong>di</strong> forma e l'incapacità; b) dal giorno della notizia del vizio<br />
per vizi della volontà ed errore ostativo; 2) legittimazione: chiunque vi abbia interesse (nullità-annullabilità<br />
assoluta), d'ufficio (nullità); 3) art. 590 c.c. (sanatoria): vale per entrambe; 4) casi nullità: mancanza-serietà<br />
della volontà, simulazione assoluta, vizi <strong>di</strong> forma, artt. 458, 589, 625, 635, 626, 634, 596-599, 631-632, 628-<br />
630, 651, 656, 647, 692 c.c. (ed altri); 5) casi <strong>di</strong> annullabilità: vizi <strong>di</strong> forma, vizi della volontà, incapacità (art.<br />
591 c.c.), ed altri.<br />
CONFERMA O VOLONTARIA ESECUZIONE (art. 590 c.c.)<br />
L’art. 590 c.c. si pone come eccezione all'art. 1423 c.c. (per la donazione: art. 799 c.c.). Per la convalida<br />
s’intende la <strong>di</strong>sponibilità dell'interesse all'impugnazione, per la conferma s’in<strong>di</strong>ca il rispetto della volontà del<br />
testatore (da qui i limiti <strong>di</strong> cui sotto). Emerge in ogni modo la contrad<strong>di</strong>zione della produzione <strong>di</strong> effetti<br />
giuri<strong>di</strong>ci da un negozio giuri<strong>di</strong>co nullo.<br />
Configurazione dell’atto nullo confermato: a) per la giurisprudenza e molta parte della dottrina (Trib.<br />
Napoli 24.1.1976; Azzariti Martinez, Messineo, Galgano, Gangi, Giannattasio, Barassi) si tratterebbe <strong>di</strong> una<br />
rinuncia all'azione <strong>di</strong> nullità da parte del legittimato all'impugnazione; b) obbligazione naturale (Gangi, Oppo);<br />
c) conferma come fattispecie negoziale integrativa (Santoro Passarelli che l'ammette solo per il negozio<br />
“incompleto” non per quello illecito), secondo lo schema: atto nullo + conferma: d) conferma come atto<br />
negoziale inter vivos unilaterale autonomo e gratuito <strong>di</strong>retto a realizzare la volontà testamentaria (Gazzoni);<br />
e) doppio trasferimento (conferma e testamento) (Pasetti).<br />
Ampiezza dell'art. 590 c.c. La norma sembra comprendere non solo la nullità, ma altresì l’annullabilità,<br />
l’inefficacia (confermabili secondo i casi); l’illiceità (secondo i casi); mentre l’inesistenza risulta sempre<br />
inconfermabile.<br />
Casi inclusi: nullità formali; testamento orale (App. Napoli 3.5.1989); testamento speciale caducato;<br />
testamento falso formalmente (falsità della sottoscrizione: Cass. 13.10.1961 n. 2137; Gabrielli, Caprioli,<br />
Bigliazzi Geri); testamento caducato ai sensi dell’art. 687 c.c. (Cass. 19.4.1956; Caprioli); i casi <strong>di</strong><br />
annullabilità (così dottrina e giurisprudenza <strong>di</strong> maggioranza; contra Caprioli, Gazzoni); le <strong>di</strong>sposizioni a<br />
favore dell'indegno (così solo Gabrielli, che estende a tutti i soggetti “incapaci <strong>di</strong> ricevere”; contra Cass.<br />
23.11.1962 n. 3171); la <strong>di</strong>sposizione meramente negativa (Gabrielli, Trabucchi).
Casi esclusi: violenza fisica; riserva mentale; simulazione assoluta; mancanza - non serietà - non definitività<br />
del volere (progetto e minuta <strong>di</strong> testamento: Cass. 5.10.1976 n. 3254); testamento falso (ideologicamente:<br />
Cass. 9.10.1972 n. 2958); testamento revocato (Cass. 9.10.1972 n. 2958; Cicu, Pasetti, Gabrielli, Gazzoni);<br />
casi <strong>di</strong> cui agli artt. 628 e 625 c.c. (per la tutela della volontà testamentaria: App. Napoli 3.5.1989); inefficacia<br />
per mancato avveramento della con<strong>di</strong>zione sospensiva (alterazione della volontà testamentaria:<br />
Caramazza); le incapacità del testatore <strong>di</strong> cui all’art. 591 c.c.; errore ostativo e vizi della volontà (solo per la<br />
dottrina); motivo illecito, <strong>di</strong> cui all’art. 626 c.c.<br />
Casi controversi: Per quanto concerne le <strong>di</strong>sposizioni illecite: a) tesi tra<strong>di</strong>zionale (Giannattasio)<br />
inconfermabili, per la tutela <strong>di</strong> un interesse pubblico, le <strong>di</strong>sposizioni contrastanti l'or<strong>di</strong>ne pubblico e il buon<br />
costume; confermabili quelle illegali perché questa illiceità tutela un interesse privato; b) tesi più recente<br />
(Gabrielli, Pasetti, Caprioli) per l'or<strong>di</strong>ne pubblico si deve <strong>di</strong>stinguere se l'illiceità colpisce solo il mezzo tecnico<br />
utilizzato (ammesso l’art. 590 c.c. - come, ad esempio, nel caso <strong>di</strong> usufrutto successivo, la cui costituzione<br />
sarebbe ammessa per atto fra vivi - esclusa la donazione - quale appunto sarebbe la conferma: Cass.<br />
14.5.1962 n. 1024), ovvero anche il risultato (non ammesso l’art. 590 c.c., come nell’esempio delle<br />
sostituzioni fedecommissarie: così Cass. 19.2.1970 n. 389; Cass. 5.11.1973 n. 2874; Cass. 5.12.1974 n.<br />
4005).<br />
Casi estranei all’art. 590 c.c.: <strong>di</strong>sposizioni lesive della legittima (perché non sono nulle, ma solo riducibili:<br />
Cass. 25.6.1969 n. 2273; Cass. 8.10.1971 n. 2771; Bianca, Giannattasio, Bigliazzi Geri, contra Gabrielli). Se<br />
la conferma proviene dal legittimario leso, equivale a rinuncia all'azione <strong>di</strong> riduzione.<br />
Forma e contenuto: atto espresso (rinvio all'art. 1444 c.c.) o comportamento concludente (univoco e<br />
inequivocabile: esclusa la pubblicazione del testamento e la presentazione della denuncia <strong>di</strong> successione:<br />
Triola): volontà <strong>di</strong> attribuire efficacia all'atto invalido e conoscenza della causa d’invali<strong>di</strong>tà (menzione nell'atto<br />
<strong>di</strong> conferma: Cass. 12.9.1970 n. 1403; Cass. 8.7.1971 n. 2185; Cass. 29.5.1974 n. 1545).<br />
Legittimazione: Sono legittimati alla conferma i chiamati e coloro che potrebbero vantare un <strong>di</strong>ritto<br />
successorio in caso d’invali<strong>di</strong>tà del testamento. La conferma equivale per il chiamato ad accettazione<br />
d’ere<strong>di</strong>tà (così Pasetti; Trib. Napoli 2.4.1955). Invece, l’erede che ha accettato l’ere<strong>di</strong>tà non può<br />
successivamente confermare il testamento nullo che comporti l’istituzione <strong>di</strong> erede incompatibile con la sua<br />
posizione (Triola).<br />
Effetti: La conferma vale soltanto per chi la effettua. Da ciò, per alcuni (Pasetti, Gabrielli, Caprioli)<br />
<strong>di</strong>scenderebbe la possibilità <strong>di</strong> una conferma o esecuzione c.d. parziali (in senso soggettivo), ma per altra<br />
dottrina (Galgano, Caramazza, Loi, Puccini) e soprattutto per la giurisprudenza (Trib. Napoli 24.1.1976; App.<br />
Napoli 30.9.1977; Cass. 11.8.1980 n. 4923) il recupero totale del testamento si ha soltanto se tutti i<br />
legittimati all'impugnazione hanno provveduto a confermare l'atto. Perciò, per l'inscin<strong>di</strong>bilità dell'atto<br />
testamentario (che sarà interamente travolto con effetto retroattivo dalla declaratoria d’invali<strong>di</strong>tà), non può<br />
ammettersi una conferma soggettivamente parziale (Trib. Napoli 24.1.1976; Trib. Napoli 29.4.1986; Cass.<br />
11.7.1996 n. 6313).<br />
CONVERSIONE (art. 1424 c.c.) - NULLITA’ PARZIALE (art. 1419 c.c.) - SIMULAZIONE<br />
TESTAMENTARIA<br />
Nel testamento si ammette solo la conversione formale (ad esempio, art. 607 c.c.); l'inammissibilità della<br />
conversione sostanziale, ex art. 1424 c.c., <strong>di</strong>pende dalla negazione <strong>di</strong> strumenti giuri<strong>di</strong>ci atipici e alternativi al<br />
testamento che possano assolverne la stessa funzione (Lipari e Bigliazzi Geri l’ammettono, ma in relazione<br />
al solo contenuto dell’atto - e non al tipo - del negozio, ossia delle singole <strong>di</strong>sposizioni testamentarie nulle in<br />
altre <strong>di</strong>verse). Accolta ormai comunemente l’autonomia delle singole <strong>di</strong>sposizioni testamentarie, si reputa<br />
ammissibile l’applicazione dell’art. 1419 c.c.: perciò, ove la <strong>di</strong>sposizione testamentaria invalida si rilevi,<br />
nell’intenzione del testatore, inscin<strong>di</strong>bile dall’intero testamento, questo sarà totalmente nullo (Bigliazzi Geri,<br />
Criscuoli). La simulazione comunemente si reputa, invece, un fenomeno estraneo al testamento (contra<br />
Bigliazzi Geri): l’accordo simulatorio, poi, integrerebbe un patto successorio (art. 458 c.c.). La simulazione<br />
relativa, posto che l’atto c.d. <strong>di</strong>ssimulato debba necessariamente essere un altro testamento, si risolve<br />
essenzialmente in un problema <strong>di</strong> revoca testamentaria (testamenti successivi e incompatibili).<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
Ambanelli, Aggiunte apocrife successive e manomissioni <strong>di</strong> terzo al testamento olografo, in Fam. pers. succ., 2009, p. 612 ss.; Auletta,<br />
Disposizioni a favore <strong>di</strong> persona incerta, dell'anima, <strong>dei</strong> poveri, in Giur. sist. <strong>di</strong>r. civ. e comm. <strong>di</strong>retta da W. Bigiavi, Torino 1983, p. 47<br />
ss.; Baralis, Il testamento per relationem, in Successioni e donazioni a cura <strong>di</strong> P. Rescigno, I, Padova 1994, p. 967 ss.; Bernar<strong>di</strong>, La<br />
<strong>di</strong>sposizione testamentaria rimessa all'arbitrio altrui, in Giur. sist. <strong>di</strong>r. civ. e comm. <strong>di</strong>retta da W. Bigiavi, Torino 1983; Bonilini, La<br />
capacità <strong>di</strong> testare e <strong>di</strong> donare del beneficiario dell’amministrazione <strong>di</strong> sostegno, in Fam. pers. succ., 2005, p. 14 ss.; Branca, Dei<br />
testamenti or<strong>di</strong>nari, in Comm. cod. civ. Scialoja e Branca, Bologna-Roma 1986; Branca, Dei testamenti speciali. Della pubblicazione <strong>dei</strong><br />
testamenti olografi e <strong>dei</strong> testamenti segreti, in Comm. cod. civ. Scialoja e Branca, Bologna-Roma 1988; Cecchetti, voce Negozio<br />
giuri<strong>di</strong>co per relationem, in Enc. giur. Treccani, Roma 1990; Ferro, Capacità si succedere degli enti <strong>di</strong> fatto: questioni vecchie e nuove<br />
all’indomani dell’abrogazione dell’art. 17 c.c., in Vita not., 1999, I, p. 55 ss.; Ferro, La clausola <strong>di</strong> “relatio” e il negozio solenne, ovvero:<br />
teoria <strong>di</strong> una incompatibilità, nell’ultima giurisprudenza, solo supposta, in Vita not., 1998, I, p. 1462 ss.; Gazzara, voce Fiducia<br />
testamentaria, in Enc. del <strong>di</strong>r., XVII, Milano 1968; Gerbo, Contenuto atipico ed evoluzione del contenuto del testamento, in Notaro,<br />
1993; Giampiccolo, Il contenuto atipico del testamento, Milano 1954; Irti, Disposizione testamentaria rimessa all'arbitrio altrui, Torino<br />
1967; Marmocchi, Forma <strong>dei</strong> testamenti, in Successioni e donazioni a cura <strong>di</strong> P.Rescigno, I, Padova 1994, p. 757; Marmocchi, Il<br />
testamento olografo tra segretezza e sicurezza, in Riv. <strong>di</strong>r. civ. 1998, p. 115; Musolino, Le <strong>di</strong>sposizioni testamentarie a favore <strong>di</strong>
persona incerta, in Riv. not., 2005, p. 835 ss.; Musolino, Il dolo nel testamento. Disciplina generale e specificità della captazione, in<br />
Nuova giur. civ. comm., 2010, II, p. 19 ss.; Pagliantini, Violenza morale e captazione del testamento (note sull’art. 624 c.c.), in Familia,<br />
2008, p. 37 ss.; Pagliantini, La pluralità <strong>di</strong> regimi normativi del testamento annullabile, in Riv. <strong>di</strong>r. not., 2008, p. 795 ss.; Pagliantini, Il<br />
potere del testatore sull’olografo: per una rivisitazione dell’art. 684 c.c., in Rass. <strong>di</strong>r. civ., 2007, p. 1007 ss.; Par<strong>di</strong>ni, L'equipollente della<br />
sottoscrizione nel testamento pubblico, in Riv. not., 1990, I, p. 539; Privitera, Le <strong>di</strong>sposizioni fiduciarie, in Successioni e donazioni a<br />
cura <strong>di</strong> P. Rescigno, I, Padova 1994, p. 881 ss.; Toti, Disposizione fiduciaria e simulazione testamentaria, in Riv. not., 2010; Uccella,<br />
voce Poveri (<strong>di</strong>sposizioni a favore <strong>dei</strong>), in Dig. <strong>di</strong>sc. priv., sez. civ., XIV, Torino 1996, p. 130 ss.; Zaccaria, Testamenti simultanei (o<br />
corrispettivi), in Stu<strong>di</strong>um iuris, 2002, p. 33 ss.<br />
BIBLIOGRAFIA su simulazione e art. 590 .c.<br />
Bigliazzi Geri, Successioni testamentarie, in Comm. cod. civ. Scialoja e Branca, (artt. 587-600 c.c.), Bologna-Roma 1993; Bigliazzi<br />
Geri, Appunti in tema <strong>di</strong> simulazione del testamento, in Riv. trim. <strong>di</strong>r. e proc. civ., 1962, p. 1274; Caprioli, Conferma ex art. 590 c.c.,<br />
testamento annullabile e pluralità <strong>di</strong> interessati, in Dir. e giur., 1976, I, p. 60; Caprioli, I profili effettuali dell'atto nullo confermato ex artt.<br />
590 e 799 c.c., in Dir. e giur., 1983, II, p. 521; Caprioli, La conferma delle <strong>di</strong>sposizioni testamentarie e delle donazioni nulle, Napoli<br />
1984; De Simone, Se il testamento nuncupativo sia confermabile ex art. 590 c.c., in Dir. giur., 1956, p. 319; Di Staso, Inapplicabilità<br />
degli artt. 590 e 799 alla lesione <strong>di</strong> legittima, in Foro It., 1957, I, p. 520; G.B. Ferri, Convalida, conferma e sanatoria del negozio<br />
giuri<strong>di</strong>co, in Dig. <strong>di</strong>sc. priv., sez. civ., IV, Torino 1989, p.336; Gabrielli, L'oggetto della conferma ex art. 590 c.c., in Riv. trim. <strong>di</strong>r. e proc.<br />
civ., 1964, p. 1366; Gazzoni, L'attribuzione patrimoniale me<strong>di</strong>ante conferma, Milano 1974; Loi, Le <strong>successioni</strong> testamentarie, in Giur.<br />
sist. cod. civ. e comm. <strong>di</strong>retta da W.Bigiavi, Torino 1992; Negri, Il recupero dell’atto nullo me<strong>di</strong>ante esecuzione, Napoli 1983; Niutta, Il<br />
testamento olografo non sottoscritto e l'art. 590 c.c., in Vita not., 1971, p.210; Pasetti, La sanatoria per conferma del testamento e della<br />
donazione, Padova 1953; Perego, Principio <strong>di</strong> conservazione e favor testamenti, in Giur. It., 1970, I, 1, p. 1251; Puccini, Note in tema<br />
<strong>di</strong> legittimazione congiuntiva alla conferma <strong>di</strong> testamento affetto da nullità assoluta, nel quadro degli atti <strong>di</strong> accertamento privato, in<br />
Giust. civ., 1983, II, p. 224; Scalia, La nullità e l'inefficacia delle <strong>di</strong>sposizioni testamentarie, in Successioni e donazioni a cura <strong>di</strong><br />
P.Rescigno, I, Padova 1994, p.1193; Scalia, Confermabilità del testamento orale: prova della volontà del de cuius, certezza <strong>dei</strong> rapporti<br />
e funzione notarile. Alcune riflessioni sul tema, in Riv. not., 1997, II, p. 166; Stolfi, Appunti sull'art. 590 c.c., in Giur. It., 1977, I, 1, p. 357;<br />
Toti, La rilevanza delle cause <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà nell'applicazione dell'art. 590 c.c., in Riv. <strong>di</strong>r. civ., 1995, p. 215 ss. (I parte) e p. 435 ss. (II<br />
parte); Triola, Conferma ed esecuzione volontaria <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizioni testamentarie nulle, in Vita not., 1977, II, p. 888; Ven<strong>di</strong>tti,<br />
Disposizione testamentaria orale e conferma ex art. 590 c.c., in Dir e giur., 1988, p. 151; Ven<strong>di</strong>tti, Un caso controverso <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizione<br />
testamentaria orale eseguita volontariamente ai sensi dell’art. 590 c.c., in Dir. e giur., 1989, p. 407.<br />
A) Esercitazione in classe<br />
PARTE PRATICA<br />
Il facoltoso Tizio, senza legittimari, ottuagenario, si reca dal notaio Romolo Romani con la sua giovane<br />
compagna, Lulù, e la fattucchiera Amalia; richiede al notaio che esse rimangano presenti volendosi<br />
consultare in particolare con Amalia su come <strong>di</strong>sporre per testamento;<br />
Egli vuole:<br />
- nominare erede universale Lulù, nel presupposto che gli rimanga vicino per tutta la vita;<br />
- lasciare 200.000 euro a Amalia, <strong>dei</strong> quali 50.000 unicamente perché scateni un maleficio su Caio,<br />
concorrente in affari <strong>di</strong> Tizio;<br />
- lasciare 500.000 euro a Filano, dopo che avrà completato gli stu<strong>di</strong> intrapresi, ma solo se Amalia lo<br />
consentirà, dopo avere consultato gli astri;<br />
- revocare la designazione della ex moglie Tizia quale destinataria dell’assicurazione sulla vita, e<br />
nominare in sua vece l’amico Quinto;<br />
- <strong>di</strong>sporre che i suoi scritti possano essere pubblicati solo con il consenso <strong>di</strong> Amalia, finchè questa sia<br />
vivente;<br />
- riconoscere <strong>di</strong> avere testimoniato il falso nel giu<strong>di</strong>zio penale contro Sempronio;<br />
- al maggiordomo Filano, che lo ha sempre assistito percependo inadeguati compensi, intende<br />
assicurare una pensione per la vecchiaia;<br />
- lasciare al suo adorato cagnolino Fuffi la somma <strong>di</strong> euro 100.000.<br />
Tizio desidera, inoltre, lasciare al più povero <strong>dei</strong> <strong>di</strong>pendenti della società dell'amico Filano la somma <strong>di</strong> euro<br />
35.000;<br />
vuole lasciare la somma <strong>di</strong> euro 35.000, ad un giovane impren<strong>di</strong>tore <strong>di</strong> Firenze (che abbia una età non<br />
superiore ai trent'anni), che il fratello Sempronio dovrà scegliere tra i più capaci e i più brillanti a suo<br />
insindacabile giu<strong>di</strong>zio;<br />
vuole lasciare la somma <strong>di</strong> euro 30.000 ad un altro citta<strong>di</strong>no <strong>di</strong> Firenze che si sia <strong>di</strong>stinto per particolari meriti<br />
sempre ad insindacabile giu<strong>di</strong>zio del fratello Sempronio;<br />
alla sorella Sempronia vuole lasciare la parte del terreno Tuscolano che sia eventualmente riconosciuto<br />
e<strong>di</strong>ficabile dagli strumenti urbanistici in vigore al momento dell'apertura della successione.<br />
Il can<strong>di</strong>dato, assunte le vesti del Notaio Romolo Romani, re<strong>di</strong>ga un testamento conforme a legge.<br />
- Caratteri della volontà testamentaria;<br />
- La con<strong>di</strong>zione apposta all’istituzione <strong>di</strong> erede e al legato, la con<strong>di</strong>zione coartativa, la con<strong>di</strong>zione<br />
potestativa e meramente potestativa, la con<strong>di</strong>zione illecita; motivo illecito nel testamento e sua rilevanza;
- Nomina e revoca per testamento del beneficiario del contratto <strong>di</strong> assicurazione sulla vita;<br />
- Diritto personale <strong>di</strong> autore; contenuto atipico del testamento;<br />
- Premi <strong>di</strong> nuzialità, opere <strong>di</strong> assistenza e simili;<br />
- Capacità <strong>di</strong> ricevere per testamento;<br />
- Relatio, <strong>di</strong>sposizioni rimesse all’arbitrio del terzo e determinazione del legato per arbitrio altrui.<br />
B) Casi in classe<br />
1) Relatio sostanziale e <strong>di</strong>visione fatta dall’esecutore testamentario<br />
Tizio, morendo, <strong>di</strong>sponeva in favore <strong>dei</strong> figli Primo, Secondo e Terzo, lasciando all’amico Quintilio il compito<br />
<strong>di</strong> determinare in concreto le quote <strong>di</strong> ere<strong>di</strong>tà;<br />
Quintilio, ritenendo <strong>di</strong> poterlo fare, notificava ai tre la sua decisione, attribuendo a Primo e Secondo solo la<br />
legittima e a Terzo, molto più in<strong>di</strong>gente <strong>dei</strong> primi due, la legittima e la <strong>di</strong>sponibile;<br />
si recano tutti dal notaio per vendere a Caio un cespite dell’ere<strong>di</strong>tà.<br />
2) Disposizioni a favore dell’anima<br />
Tizio vorrebbe destinare la somma <strong>di</strong> euro 60.000 alla celebrazione <strong>di</strong> messe in suffragio della sua anima<br />
presso la chiesa <strong>di</strong> Santa Trinità <strong>dei</strong> Monti a Roma.<br />
3) Disposizioni a favore <strong>dei</strong> poveri<br />
Tizio vorrebbe lasciare a favore <strong>dei</strong> poveri del comune <strong>di</strong> nascita della moglie la somma <strong>di</strong> euro 40.000, e la<br />
somma <strong>di</strong> euro 40.000 ai poveri che in<strong>di</strong>viduerà il figlio Tizietto.<br />
C) Esercitazione a casa<br />
Tizio, settantenne, interamente privo dell'u<strong>di</strong>to, intende <strong>di</strong>videre il proprio patrimonio nella maniera seguente,<br />
ed espone al notaio R.Romani, quanto segue:<br />
è coniugato con Enotria, dalla quale ha avuto Caio e Giustiniana; intende trattare la moglie ed i figli alla<br />
stessa maniera, ma, poichè non regna armonia fra <strong>di</strong> essi, vuole evitare che possano sorgere contestazioni<br />
alla sua morte e quin<strong>di</strong> intende assegnare:<br />
a) alla moglie Enotria, la villa in Frascati ed i beni mobili che la arredano (la villa è la attuale residenza<br />
coniugale), nonchè l'usufrutto della villa <strong>di</strong> Fregene;<br />
b) al figlio Caio la palazzina in Civitavecchia, interamente affittata; Caio dovrà però garantire a tutti gli<br />
inquilini, per un certo periodo dall'apertura della successione, le stesse con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> locazione, nonchè la<br />
nuda proprietà della villa <strong>di</strong> Fregene assegnata in usufrutto a Enotria;<br />
c) alla figlia Giustiniana i gioielli <strong>di</strong> famiglia, tutte le quote della società Alfa, della quale è unico titolare,<br />
nonché l'intera liquidazione che gli spetta quale ex funzionario della Beta Spa, ovvero i beni in cui essa sarà<br />
reinvestita.<br />
Intende <strong>di</strong>spensare da collazione i suoi familiari, e <strong>di</strong>chiara al notaio che:<br />
-- alla moglie ha comprato un appartamento a Cortina;<br />
-- al figlio ha fornito i mezzi per iniziare la sua attività <strong>di</strong> pellicciaio e ha comprato un monolocale a Ischia;<br />
-- alla figlia ha pagato tutti i debiti onde evitare il fallimento della società in nome collettivo <strong>di</strong> cui era socia e<br />
ha comprato la casa ove vive;<br />
desidera però che la <strong>di</strong>spensa valga solo se non vi siano, alla sua morte, sostanziali <strong>di</strong>fferenze <strong>di</strong> valore tra<br />
quanto dato a ciascuno <strong>di</strong> essi, a giu<strong>di</strong>zio del rag.Filini, amico <strong>di</strong> famiglia, del quale ha piena stima.<br />
ll testatore fa presente al notaio che ha fatto <strong>dei</strong> testamenti in passato, <strong>dei</strong> quali non ricorda esattamente il<br />
contenuto, e che non ha altri beni <strong>di</strong> rilevante valore.<br />
Il notaio Romolo Romani riceva il testamento <strong>di</strong> Tizio, adeguando la volontà del testatore alle inderogabili<br />
norme <strong>di</strong> legge.<br />
In parte teorica si tratti degli istituti inerenti al caso proposto ed in particolare della <strong>di</strong>visione del testatore e<br />
della collazione.<br />
D) Correzione 3° esercitazione a casa
VI LEZIONE (12.2.2013)<br />
Gli elementi accidentali del negozio testamentario Concetti introduttivi. La con<strong>di</strong>zione (art. 633 e ss. c.c.):<br />
tipologie ed effetti. La con<strong>di</strong>zione testamentaria illecita o impossibile: la c.d. regola sabiniana (artt. 634, 635<br />
e 636 c.c.). Il termine (art. 637 c.c.). Il modus: natura giuri<strong>di</strong>ca, effetti, adempimento e risoluzione (artt. 647 e<br />
648 c.c.).<br />
PARTE TEORICA<br />
La (singola) <strong>di</strong>sposizione testamentaria è suscettibile <strong>di</strong> essere sottoposta agli elementi accidentali del<br />
negozio: con<strong>di</strong>zione, termine e onere. La <strong>di</strong>sposizione testamentaria a titolo universale, però, non sopporta il<br />
termine, per il principio romanistico semel heres semper heres. Una volta apposti, gli elementi accidentali<br />
fanno parte del contenuto essenziale del negozio. Per i legittimari la con<strong>di</strong>zione può riguardare solo la<br />
<strong>di</strong>sponibile (art. 549 c.c.; Cass. 21.2.1992 n. 2122).<br />
CONDIZIONE Ai sensi dell'art. 633 c.c., la <strong>di</strong>sposizione testamentaria, a titolo universale o particolare, è<br />
suscettibile <strong>di</strong> essere sottoposta a con<strong>di</strong>zione sospensiva o risolutiva. Sull’enunciazione della con<strong>di</strong>zione nel<br />
testamento: Cass. 29.8.1992 n. 10008. La con<strong>di</strong>zione può essere casuale (evento estraneo alla volontà<br />
dell'istituito, compreso il fatto del terzo: se riferita alla mera volontà del terzo nullità, ex art. 631 c.c.),<br />
potestativa (comportamento dell'istituito) o mista. E' assai controversa la configurabilità nel testamento della<br />
con<strong>di</strong>zione meramente potestativa (sul punto Gangi, Caramazza, Andrini, Azzariti Martinez). Distinzione fra<br />
con<strong>di</strong>zione e mera raccomandazione. Esigenza <strong>di</strong> certezza temporale: le con<strong>di</strong>zioni potestative semplici<br />
negativa e positiva: artt. 638 (conversione ex lege in con<strong>di</strong>zione risolutiva positiva, salva <strong>di</strong>versa volontà del<br />
de cuius) e 645 c.c. Il tempo cui valutare tali caratteri è la redazione del testamento (Cicu, Gangi,<br />
Giannattasio, Criscuoli, contra Bigliazzi Geri), quello per valutare l'impossibilità e l'illiceità l'apertura della<br />
successione. Sulle c.d. con<strong>di</strong>zioni improprie: Cass. 16.3.1960 n. 531; Cass. 16.11.1981 n. 6061; Cass.<br />
22.4.2002 n. 5871. Retroattività degli effetti della con<strong>di</strong>zione (sospensiva o risolutiva) al tempo dell'apertura<br />
della successione: art. 646 c.c. (art. 1360 c.c.). Liceità e possibilità: l’illiceità può essere oggettiva<br />
(evento/comportamento oggettivamente illecito) o soggettiva (evento/comportamento lecito, ma illecito risulta<br />
l’intento del de cuius <strong>di</strong> comprimere una libertà personale del chiamato erede o legatario in un settore della<br />
sua vita privata, ad esempio, matrimonio, professione, impugnative del testamento: Cass. 11.1.1986 n. 102;<br />
Cass. 18.3.1993 n. 3196). La c.d. regola sabiniana <strong>di</strong> cui all'art. 634 c.c. (art. 1354 c.c.) e la sua ratio:<br />
principio dell’inscin<strong>di</strong>bilità della volontà con<strong>di</strong>zionata (tesi tra<strong>di</strong>zionale del favor testamenti - tesi opposta<br />
della sanzione privata).<br />
Fattispecie particolari <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zioni illecite 1. Previste dalla legge: art. 635 c.c. (con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> reciprocità:<br />
nullità della <strong>di</strong>sposizione intera; art. 636 c.c. (<strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> nuove o ulteriori nozze; <strong>di</strong>stinzioni fra <strong>di</strong>vieti assoluti o<br />
relativi; l’art. 636, 2 comma c.c. concerne legati <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti intrasmissibili, tempo/caso, efficacia ex nunc). 2.<br />
Elaborate dalla giurisprudenza o dalla dottrina relative a professione e/o stu<strong>di</strong>o (Cass. 18.3.1993 n. 3);<br />
libertà religiosa o <strong>di</strong> pensiero (artt. 19 e 21 Cost.); <strong>di</strong>vieti testamentari <strong>di</strong> alienazione inter vivos o<br />
<strong>di</strong>sposizione in senso lato (artt. 692 e 1379 c.c.: Trib. Genova 18.4.1952; prelazione testamentaria;<br />
costituzione <strong>di</strong> ipoteca); clausole sanzionatorie (poenae nomine; Cass. 9.5.1966 n. 1180; Trib. Reggio<br />
Calabria 30.5.1977; Cass. 18.11. 1991 n. 12340; Can<strong>di</strong>an, Bonilini, Marini); <strong>di</strong>vieti <strong>di</strong> impugnazione del<br />
testamento (c.d. clausole <strong>di</strong> decadenza); clausole <strong>di</strong> assistenza-convivenza; clausola si sine liberis<br />
decesserit (Cass. 27.11. 1990 n. 11428; Cass. 28.12.1993 n. 1268; Ricca, Talamanca, Bianca, Bigliazzi<br />
Geri).<br />
Pendenza della con<strong>di</strong>zione (artt. 639-644 c.c.) A) Con<strong>di</strong>zione risolutiva: l'erede o il legatario acquistano da<br />
subito (con l'accettazione) i loro <strong>di</strong>ritti, all'avveramento della con<strong>di</strong>zione l'acquisto si risolve con effetto ex<br />
tunc (art. 646 c.c.). Non configurabilità dell'erede apparente (l'istituito sotto con<strong>di</strong>zione risolutiva è erede<br />
reale: i terzi acquirenti non possono eccepire l'usucapione <strong>dei</strong> beni ere<strong>di</strong>tari - così App. Genova 9.5.1953 -<br />
solo dopo l'avveramento della con<strong>di</strong>zione risolutiva l'istituito potrebbe essere considerato un erede<br />
apparente, applicandosi l'art. 534 c.c. a favore del terzo acquirente). Cadono nel nulla gli atti <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizione<br />
compiuti me<strong>di</strong>o tempore (tranne gli acquisti in buona fede <strong>di</strong> beni mobili, ex art. 1153 c.c.; per i beni immobili<br />
la buona fede <strong>dei</strong> terzi è esclusa dal regime della pubblicità) e l'istituito assume la veste <strong>di</strong> semplice<br />
amministratore (restando vali<strong>di</strong> gli atti da lui compiuti come tale). B) Con<strong>di</strong>zione sospensiva: si pone il<br />
problema se il chiamato sotto con<strong>di</strong>zione sospensiva possa o meno accettare l'ere<strong>di</strong>tà in pendenza della<br />
con<strong>di</strong>zione (sul punto Cass. 28.2.1969 n. 663; Cass. 28.1.1983 n. 808; Cass. 13.7.2000 n. 9286; Cicu,<br />
Caramazza, Natoli, Azzariti Martinez, Andrini, Bigliazzi Geri).<br />
TERMINE Il termine è un evento futuro, ma certo (certezza del quando): non si produce una situazione <strong>di</strong><br />
pendenza del <strong>di</strong>ritto, né <strong>di</strong> retroattività degli effetti. Ai sensi dell'art. 637 c.c., l'istituzione a titolo <strong>di</strong> erede non<br />
sopporta il termine iniziale, né il termine finale (per il principio della perpetuità della qualità ere<strong>di</strong>taria: semel<br />
heres semper heres - Barassi; o più precisamente per i principi della retroattività dell'accettazione e della<br />
continuità - quanto al termine iniziale - dell’irrevocabilità della medesima - quanto al termine finale; Degni,
Bonilini, Bianca, Caramazza, Azzariti Martinez spiegano il <strong>di</strong>vieto con la figura della sostituzione<br />
fedecommissaria). Tuttavia, l’apposizione del termine vitiatur sed non vitiat e perciò la <strong>di</strong>sposizione resta<br />
pura e semplice, salvo che il termine non abbia costituito il motivo unico e determinante (art. 626 c.c.:<br />
Bigliazzi Geri). Nei legati è ammesso il termine iniziale (semplice <strong>di</strong>lazione concessa all'erede per la<br />
prestazione della cosa legata) e il termine finale (art. 640 c.c.: l'oggetto del legato deve essere restituito alla<br />
stessa persona obbligata a prestare il legato, non ad un terzo).<br />
ONERE L'onere (modo) si definisce una <strong>di</strong>sposizione accessoria a carico dell'erede (ultra vires, salvo<br />
accettazione <strong>di</strong> ere<strong>di</strong>tà con beneficio <strong>di</strong> inventario: Cass. 29.4.1993 n. 5067) o del legatario (non è tenuto<br />
oltre i limiti del valore della cosa legata: art. 671 c.c.) - non <strong>di</strong> un terzo - che obbliga (fare, non fare o dare)<br />
l'onerato a devolvere, in tutto o in parte, i beni ricevuti per la finalità in<strong>di</strong>cata dal testatore (interesse del<br />
testatore, dell'onerato stesso o <strong>di</strong> terzi determinati o indeterminati). Natura giuri<strong>di</strong>ca a) tesi tra<strong>di</strong>zionale:<br />
elemento accidentale ed accessorio (all'istituzione <strong>di</strong> erede o <strong>di</strong> legato: Bianca, Giannattasio, Marini, Gangi,<br />
Cicu, Azzariti Martinez, Giampiccolo, Trabucchi); b) tesi del negozio autonomo (tertium genus, può<br />
prescindere dalla <strong>di</strong>sposizione a titolo <strong>di</strong> erede o legato: Giorgianni, Bigliazzi Geri, Criscuoli, Gazzoni,<br />
Costanzo, Capozzi, Cataudella, Liserre, Lupo; Trib. Terni 28.11.1993; Cass. 21.2.2007 n. 4022): la tesi si<br />
fonda sull'ambulatorietà del modo in caso <strong>di</strong> risoluzione della <strong>di</strong>sposizione (artt. 676 e 677 c.c.), sull'art. 629<br />
c.c., nonché sulla funzione <strong>di</strong>spositiva del testamento; la principale conseguenza <strong>di</strong> tale tesi è l'ammissibilità<br />
del modus imposto all'erede legittimo. Contro la tesi dell'autonomia: 1) art. 588 c.c. (non si parla <strong>di</strong> modo, ma<br />
solo <strong>di</strong> ere<strong>di</strong>tà e legato); 2) il modo non si salva in caso <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà dell'istituzione <strong>di</strong> erede o legatario<br />
(mentre è vero il contrario, ex art. 647 c.c.), per cui segue le stesse sorti della <strong>di</strong>sposizione principale.<br />
Onere e con<strong>di</strong>zione potestativa: nella con<strong>di</strong>zione si crea un vincolo inscin<strong>di</strong>bile fra la volontà negoziale e<br />
realizzazione dell'evento posto in con<strong>di</strong>zione; nel modo l'effetto della <strong>di</strong>sposizione non è collegato al suo<br />
adempimento. Nella con<strong>di</strong>zione potestativa il chiamato è libero <strong>di</strong> tenere o meno il comportamento previsto<br />
in con<strong>di</strong>zione (la con<strong>di</strong>zione sospende, ma non costringe); il modus costringe ad un determinato<br />
comportamento, ma non sospende gli effetti del negozio. Se la <strong>di</strong>sposizione si risolve per inadempimento,<br />
l'onere passa ai chiamati successivi, mentre in caso <strong>di</strong> non avveramento della con<strong>di</strong>zione i chiamati<br />
successivi subentrano in modo incon<strong>di</strong>zionato.<br />
Onere e legato obbligatorio Il problema si pone nell'onere a favore <strong>di</strong> terzi, soprattutto se si ammette che il<br />
modo sia un’autonoma <strong>di</strong>sposizione testamentaria. Tesi: a) tra<strong>di</strong>zionale (Azzariti Martinez, Bianca,<br />
Giannattasio, Marini, Gangi, Cicu) il legato è una <strong>di</strong>sposizione autonoma (art. 588 c.c.), il modo è accessorio<br />
ad una <strong>di</strong>sposizione principale (ere<strong>di</strong>tà o legato: art. 647 c.c.); b) il legato è un’attribuzione <strong>di</strong>retta (il legatario<br />
è avente causa del de cuius), l'onorato ha un vantaggio in<strong>di</strong>retto (è avente causa dell'onerato); c) il legato ha<br />
contenuto necessariamente patrimoniale, il modus non sempre (Gangi; Cass. 25.2.1981 n. 1154); d) il legato<br />
è sempre <strong>di</strong>retto a favore <strong>di</strong> persone determinate (o determinabili, ex art. 631 c.c.), mentre il modo è <strong>di</strong>retto a<br />
sod<strong>di</strong>sfare interessi dell’onerato, del testatore o <strong>di</strong> persone genericamente determinate ovvero categorie <strong>di</strong><br />
persone (artt. 629 e 630 c.c.). Sul punto: Cass. 19.11.1979 n. 3754; Cass. 25.2.1981 n. 1154; Cass.<br />
29.4.1992 n. 5067.<br />
Onere impossibile ed illecito (art. 647 c.c.).<br />
Adempimento dell'onere (art. 648 c.c.) Occorre chiarire chi è l'interessato ad agire per l'adempimento: a)<br />
onere a favore <strong>di</strong> un gruppo <strong>di</strong> persone non esattamente identificato (tenendo presente l'interesse perseguito<br />
dal testatore, si attribuisce all'ente esponenziale il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> agire per tutto il gruppo: art. 630 c.c.; Trib. Terni<br />
28.11.1993; Cass. 14.12.1999 n. 14029); b) onere a favore del testatore (titolari dell'interesse anche morale<br />
ad agire per l'adempimento sono i prossimi congiunti anche se non ere<strong>di</strong>: Cass. 13.8.1980 n. 4936); c) onere<br />
a favore dello stesso onerato (secondo Giorgianni, se eccezionalmente s’in<strong>di</strong>viduano altri interessati, si<br />
tratterebbe <strong>di</strong> un onere, altrimenti <strong>di</strong> una con<strong>di</strong>zione potestativa o <strong>di</strong> una semplice raccomandazione senza<br />
valore giuri<strong>di</strong>co).<br />
Risoluzione per inadempimento (art. 648 c.c.): se è stata prevista dal testatore, ovvero quando<br />
l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante della <strong>di</strong>sposizione. Legittimati ad agire: a)<br />
tesi estensiva (anche i legittimati ad agire per l'adempimento: Giorgianni, Marini, Costanzo); b) tesi restrittiva<br />
(soltanto coloro che subentrano nella successione in luogo dell'onerato inadempiente: Bigliazzi Geri,<br />
Giannattasio, Cass. 11.6.1975 n. 2306). La risoluzione della <strong>di</strong>sposizione testamentaria è espressamente<br />
qualificata come risoluzione per inadempimento (applicazione delle norme generali: in particolare,<br />
inadempimento per dolo o colpa grave; l'inadempimento deve rivestire il requisito dell'importanza, avuto<br />
riguardo all'interesse perseguito; la risoluzione ha effetti retroattivi, ma non pregiu<strong>di</strong>ca i <strong>di</strong>ritti acquistati dai<br />
terzi). La retroattività della risoluzione non è reale come nella con<strong>di</strong>zione risolutiva (artt. 1458/2652 c.c.); non<br />
travolge gli acquisti trascritti dai terzi prima della trascrizione della domanda <strong>di</strong> risoluzione (per i beni mobili:<br />
art. 1153 c.c.).<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
Andrini, La con<strong>di</strong>zione nel testamento, in Riv. not., 1983, I, p. 326; Aquaro, Onere testamentario e legato tra accessorietà e<br />
autonomia, in Rass. <strong>di</strong>r. civ., 2003, p. 541 ss.; Barbero, Con<strong>di</strong>zione, in Novissimo Dig. It., III, Torino 1959, p. 1097; Bonilini, La<br />
prelazione testamentaria, in Riv. <strong>di</strong>r. civ., 1984, I p. 223 ss.; Can<strong>di</strong>an, Disposizioni testamentarie e funzione sanzionatoria, in Nuova<br />
giur. civ. comm., 1993, I, p. 484; Carnevali, voce Modo, in Enc. del <strong>di</strong>r., XXVI, Milano 1976, p. 686; Cirillo, Disposizioni con<strong>di</strong>zionali e
modali, in Successioni e donazioni a cura <strong>di</strong> P. Rescigno, Padova 1994, I, p. 1059; Costanza, L'onere nelle <strong>di</strong>sposizioni testamentarie,<br />
in Giur. sist. <strong>di</strong>r. civ. e comm., in Le <strong>successioni</strong> testamentarie a cura <strong>di</strong> C.M.Bianca, Torino 1983, p. 153; Costanzo, Problemi<br />
dell'onere testamentario, in Riv. <strong>di</strong>r. civ., 1978, II, p. 294; Criscuoli, Le obbligazioni testamentarie, Milano 1965; Di Mauro, Con<strong>di</strong>zioni<br />
illecite e testamento, Napoli 1995; Di Mauro, Considerazioni sulle con<strong>di</strong>zioni testamentarie illecite, in Rass. <strong>di</strong>r. civ., 1994, I, p. 1;<br />
Falzea, voce Con<strong>di</strong>zione, in Enc. giur. Treccani, VI, Roma 1989, p. 1; Farace, Sull’efficacia <strong>dei</strong> <strong>di</strong>vieti <strong>di</strong> alienazione <strong>di</strong>sposti per<br />
testamento, in Riv. <strong>di</strong>r. civ., 2006, p. 363 ss.; Gardani Contursi Lisi, Con<strong>di</strong>zione termine e modus, in Comm. cod. civ. Scialoja e<br />
Branca, (artt. 633-648 c.c.), Bologna - Roma 1983; Garutti, Il modus testamentario, Napoli 1990; Gentile Di Marco, Il termine nelle<br />
<strong>di</strong>sposizioni testamentarie, in Giur. sist. <strong>di</strong>r. civ. e comm., Le <strong>successioni</strong> testamentarie a cura <strong>di</strong> C.M. Bianca, Torino 1983, p. 147;<br />
Giorgianni, Il modus testamentario, in Riv. trim. <strong>di</strong>r. e proc. civ., 1957, II, p. 899; Lupo, Il modus testamentario, in Riv. <strong>di</strong>r. civ., 1977, II,<br />
p. 394; Maiorca, voce Con<strong>di</strong>zione, in Dig. <strong>di</strong>sc. priv., sez. civ., III, Milano 1988, p. 273; Marini, Il modus come elemento accidentale del<br />
negozio giuri<strong>di</strong>co, Milano 1976; Masucci, Gli incerti confini tra clausola si sine liberis decesserit e fedecommesso (con<strong>di</strong>zionale) de<br />
residuo, in Giur. It., 1994, I, 1, p. 1767; Morello, La con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> non impugnare il testamento, in Riv. not., 1965, p. 981; Morello,<br />
Considerazioni in tema <strong>di</strong> legato fiduciario e legato modale, in Riv. not., 1979, p. 1579; Rescigno, voce Con<strong>di</strong>zione (<strong>di</strong>ritto vigente), in<br />
Enc. del <strong>di</strong>r., VIII, Milano 1961, p. 762; Rocca, Il <strong>di</strong>vieto testamentario <strong>di</strong> alienare, in Riv. trim. <strong>di</strong>r. e proc. civ., 1982, p. 409;<br />
Santarsiere, Il due volti della con<strong>di</strong>zione si sine liberis decesserit, in Arch. civ., 1988, II, p. 1023; Toti, Con<strong>di</strong>zione testamentaria e<br />
libertà personale, Milano 2004; Zanni, Considerazioni in tema <strong>di</strong> natura giuri<strong>di</strong>ca dell’onere testamentario e <strong>di</strong> determinazione <strong>dei</strong><br />
soggetti legittimati al suo adempimento, in Riv. not., 2000, 1008.<br />
A) Esercitazione in classe I°<br />
PARTE PRATICA<br />
Tizio, citta<strong>di</strong>no canadese residente in Italia, celibe e senza figli, vuole istituire erede universale la convivente<br />
Caia, attribuendole l'intero patrimonio a con<strong>di</strong>zione che accetti l’ere<strong>di</strong>tà entro un anno dall'apertura della<br />
successione.<br />
Vuole lasciare al nipote ex fratre Quarto e alla sua fidanzata Quarta la villetta <strong>di</strong> Ostia, sotto la con<strong>di</strong>zione<br />
che si sposino entro due anni dalla sua morte; in mancanza <strong>di</strong> ciò la villetta deve andare al solo Quarto.<br />
Intende, inoltre, lasciare all’amico Filano i gioielli che si trovano nella sua cassaforte e l’auto d’epoca nel suo<br />
garage a con<strong>di</strong>zione che vi si trovi al momento dell’apertura della successione.<br />
Intende lasciare all’amico Calpurnio la somma <strong>di</strong> euro centomila in denaro contante, destinandone l’impiego<br />
al sod<strong>di</strong>sfacimento <strong>dei</strong> fabbisogni primari <strong>di</strong> vita e all’assistenza <strong>di</strong> Nerone, affetto da grave <strong>di</strong>sabilità;<br />
intende lasciare a Clau<strong>di</strong>o la villa <strong>di</strong> Trieste, apponendovi un vincolo <strong>di</strong> destinazione al solo scopo <strong>di</strong> sottrarre<br />
la stessa alle pretese <strong>di</strong> eventuali cre<strong>di</strong>tori <strong>di</strong> quest’ultimo;<br />
intende, infine, lasciare allo stimato impren<strong>di</strong>tore Sempronio l’opificio in Prato, al fine <strong>di</strong> sfruttarne appieno le<br />
potenzialità produttive a beneficio dell’erede istituita.<br />
Per il caso <strong>di</strong> sopravvenienza <strong>di</strong> figli, il testatore manifesta inoltre la volontà che le <strong>di</strong>sposizioni testamentarie<br />
restino ferme, se possibile.<br />
Il testatore intende sottoporre la propria successione alla legge italiana, ai sensi dell’art. 46, comma 2, legge<br />
n. 218/1995 e, a tal fine, si reca dal notaio Fiorenzo Fiorentini affinché riceva il proprio testamento nelle<br />
forme del testamento internazionale.<br />
- Profili formali: il testamento internazionale;<br />
- Istituzione <strong>di</strong> erede sottoposta a termine e a con<strong>di</strong>zione;<br />
- Con<strong>di</strong>zioni coartative;<br />
- Sostituzione;<br />
- Legato <strong>di</strong> cosa da prendersi da certo luogo e legato sottoposto a con<strong>di</strong>zione che il bene vi si trovi<br />
all’apertura della successione: <strong>di</strong>fferenze concettuali e <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplina;<br />
- Vincolo <strong>di</strong> destinazione ex art. 2645-ter: limiti <strong>di</strong> attuabilità, natura giuri<strong>di</strong>ca e struttura; sua <strong>di</strong>scussa<br />
collocazione nella sistematica del co<strong>di</strong>ce civile; cenni all’istituto del trust interno;<br />
- Revoca del testamento per sopravvenienza <strong>di</strong> figli e sua derogabilità.<br />
A) Esercitazione in classe II°<br />
Tizio, titolare <strong>di</strong> un ingente patrimonio, in fin <strong>di</strong> vita in seguito ad una malattia rarissima appena contratta,<br />
vuole nominare ere<strong>di</strong> in parti uguali la moglie e i due figli; chiede al notaio se esiste un modo per obbligare il<br />
figlio maschio a completare gli stu<strong>di</strong> ed impe<strong>di</strong>re alla moglie <strong>di</strong> risposarsi.<br />
Vuole che la moglie faccia in modo, eventualmente sopportandone i costi, che venga costruito un<br />
monumento funebre in suo onore nella piazza del paese nel quale è nato, e faccia pubblicare, sempre a sue<br />
spese, i suoi manoscritti giovanili, con i tipi della casa e<strong>di</strong>trice Alfa S.p.A.<br />
Desidera obbligare la figlia femmina a fondare un movimento politico in<strong>di</strong>rizzato alla valorizzazione del<br />
buddhismo ("Vita bud<strong>di</strong>sta nuova") utilizzando il programma al quale negli ultimi anni ha lavorato insieme alla<br />
figlia; per questo scopo e per sollecitare le adesioni al partito, la figlia potrà <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> 300.000 euro in<br />
aggiunta a quanto le spetta.
Vuole attribuire alla nipote ex fratre Tertulliana la villa <strong>di</strong> Fiesole ma vuole che si allontani dalle sue attuali<br />
cattive compagnie, o comunque che segua principi <strong>di</strong> retta moralità.<br />
Intende lasciare alla badante Caia la villa in Casentino con l'obbligo <strong>di</strong> accu<strong>di</strong>re anche la moglie fino alla<br />
morte.<br />
Vuole lasciare all'amico Filano tutti i cre<strong>di</strong>ti da lui vantati nei confronti della società Costruzioni e<strong>di</strong>li S.p.A.<br />
con l'obbligo <strong>di</strong> recarsi una volta all'anno in un tempio tibetano e trascorrervi un periodo <strong>di</strong> almeno una<br />
settimana <strong>di</strong> me<strong>di</strong>tazione.<br />
In quanto unico socio della “Gamma S.r.l.”, Tizio desidera che, ove possibile, le quote <strong>di</strong> detta società non<br />
siano alienate a terzi estranei alla compagine familiare, tuttavia non intende giungere a gravare le stesse <strong>di</strong><br />
un vincolo <strong>di</strong> intrasferibilità assoluta. Desidera inoltre che, alla sua morte, la “Gamma S.r.l.” venga<br />
trasformata in S.p.a.<br />
Intende, inoltre, se possibile, confermare il testamento nuncupativo del proprio padre Tizione.<br />
Vuole lasciare all’amica Licina la somma <strong>di</strong> euro un milione, ma intende obbligare la stessa a costituire una<br />
fondazione “Amici della Musica” e chiede lumi al notaio su quale sia l’istituto giuri<strong>di</strong>co più adatto ed efficace<br />
a tal fine.<br />
Intende lasciare a Calpurnia la somma <strong>di</strong> euro mille, purché non riprenda a fumare.<br />
Il can<strong>di</strong>dato, assunte le vesti del Notaio Romolo Romani con stu<strong>di</strong>o in Roma, re<strong>di</strong>ga un testamento conforme<br />
a legge.<br />
- Con<strong>di</strong>zione coartativa;<br />
- Mandato post mortem; contenuto atipico del testamento;<br />
- Divieto <strong>di</strong> pesi o con<strong>di</strong>zioni sulla quota <strong>dei</strong> legittimari;<br />
- Con<strong>di</strong>zione ed onere; adempimento dell’onere; risoluzione della <strong>di</strong>sposizione per inadempimento<br />
dell’onere testamentario.<br />
- Legato <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to, <strong>di</strong> debito, <strong>di</strong> liberazione da debito;<br />
- S.r.l. unipersonale <strong>di</strong> cui unico socio sia il testatore: inserimento (tramite previsione <strong>di</strong> un onere a<br />
carico degli ere<strong>di</strong>) <strong>di</strong> clausole statutarie <strong>di</strong> prelazione, gra<strong>di</strong>mento, trasformazione in altro tipo sociale che<br />
consenta <strong>di</strong> mantenere le predette clausole (s.p.a.);<br />
- Confermabilità del testamento nuncupativo;<br />
- Onere e risoluzione della <strong>di</strong>sposizione testamentaria per il caso <strong>di</strong> suo inadempimento;<br />
- Costituzione <strong>di</strong> fondazione per testamento;<br />
Con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> non fare o <strong>di</strong> non dare.<br />
B) Casi in classe<br />
1. Sulla trasmissibilità della con<strong>di</strong>zione<br />
Con testamento olografo del 20 settembre 1995 Tizio, vedovo, così <strong>di</strong>sponeva <strong>dei</strong> suoi beni: "Lascio a mio<br />
figlio Caio l'appartamento al primo piano della villa Tuscolana e a mio figlio Mevio l'appartamento sito al<br />
piano terreno della stessa villa.<br />
Dispongo che restino in comune tra loro il portone, il viale d'ingresso e il cortile.<br />
Allo scopo <strong>di</strong> conservare il decoro e la signorilità della villa, <strong>di</strong>spongo che nel caso in cui uno <strong>dei</strong> condomini<br />
dovesse soppalcare l'appartamento <strong>di</strong> sua proprietà, la comunione del portone, del viale d'ingresso e del<br />
cortile, cesserà a favore dell'altro condomino che ne <strong>di</strong>venterà pieno proprietario".<br />
Un anno dopo Tizio muore ed i due figli accettano l'ere<strong>di</strong>tà paterna.<br />
Il primo ottobre 1998 muore anche il figlio Caio e gli succede l'unico figlio Sempronio.<br />
Il primo ottobre 2000 Sempronio si reca dal notaio per alienare a Catullo l'appartamento al primo piano della<br />
villa Tuscolana. Catullo è <strong>di</strong>sposto all'acquisto ma chiede una consistente <strong>di</strong>minuzione del prezzo se non<br />
potrà soppalcare l'appartamento.<br />
2. L’onere testamentario; <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> pesi o con<strong>di</strong>zioni sulla quota <strong>dei</strong> legittimari<br />
Tizio, vedovo fiorentino, vorrebbe nominare ere<strong>di</strong> universali i due figli in parti uguali con l'obbligo per il<br />
primogenito <strong>di</strong> offrire un pranzo ai poveri del quartiere <strong>di</strong> Campo <strong>di</strong> Marte ad ogni vigilia <strong>di</strong> Natale e con<br />
l'obbligo per il secondogenito <strong>di</strong> premiare ogni anno gli studenti più meritevoli del liceo classico Dante.<br />
Vuole inoltre lasciare all'amico Sempronio l'intero palazzo in Pistoia con l'obbligo <strong>di</strong> destinare un piano del<br />
palazzo, a sua scelta, ad ospitare i pittori ultrasettantenni residenti in Pistoia.<br />
3. L’onere testamentario
Tizio, noto impren<strong>di</strong>tore pratese, nonché scapolone impenitente senza figli, vuole nominare erede universale<br />
la sorella Tizia e vuole lasciare la sua fiorente società Alfa s.n.c., al fratello minore Tizietto, con l'obbligo <strong>di</strong><br />
costituire a favore dell'amico Filano un usufrutto vitalizio su metà del capitale della società in questione.<br />
Vuole inoltre lasciare la somma <strong>di</strong> euro 150.000 al caro amico d'infanzia Sempronio, con l'obbligo <strong>di</strong><br />
investirla in azioni della promettente società cinese " Zao S.p.A.".<br />
Vuole infine lasciare all'amico d'infanzia Tertulliano la somma <strong>di</strong> euro 1.000.000 e la villa al mare con<br />
l'obbligo <strong>di</strong> provvedere al mantenimento della signora Caia.<br />
4. Onere e sublegato<br />
Tizio, celibe e senza figli:<br />
- vorrebbe lasciare le azioni <strong>di</strong> cui è titolare nella società GAMMA S.p.A., che si occupa <strong>di</strong> restauri <strong>di</strong> mobili<br />
d'antiquariato, all'amico Filano, facendo sì che lo stesso, noto artigiano fiorentino, si impegni a prestare<br />
comunque ed in ogni caso la sua consulenza in materia <strong>di</strong> delicate operazioni <strong>di</strong> restauro fino al 2017<br />
- desidererebbe lasciare le azioni <strong>di</strong> cui è titolare nella BETA S.p.A. alla stessa società, nel pieno rispetto <strong>di</strong><br />
quanto stabilito dalla vigente normativa, e prevedendo che, qualora la detta società si trasformi in S.r.l., le<br />
quote assegnate in luogo delle azioni, siano attribuite in usufrutto alla "DELTA S.r.l.", la quale, in caso <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>fficoltà economiche, potrà venderle liberamente<br />
- vorrebbe lasciare a favore <strong>di</strong> Caio e Sempronio, rispettivamente, i due cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> euro 200.000 ciascuno, che<br />
vanta nei confronti dell'associazione <strong>di</strong> Pistoia ALFA, facendo sì che gli stessi costituiscano una società per<br />
azioni denominata "PROTECTOR S.p.A." nella quale ciascuno conferisca il cre<strong>di</strong>to attribuito, appostandone<br />
metà a riserva e prevedendo che a Caio siano, se possibile, assegnate il doppio delle azioni assegnate a<br />
Sempronio<br />
- lasciare alla fondazione romana "Testaccio" l'immobile in Roma alla via Condotti n.105, con obbligo a<br />
carico della stessa <strong>di</strong> concederlo in locazione a favore dell'associazione <strong>dei</strong> commercianti "Via Condotti" per<br />
la durata prevista dalla legge vigente alla sua morte e per un canone <strong>di</strong> euro 10.000 mensili, con previsione<br />
espressa che il futuro conduttore possa acquistarne la proprietà al termine della locazione e<br />
subor<strong>di</strong>natamente all'avvenuto integrale pagamento <strong>dei</strong> canoni pattuiti ed al pagamento <strong>di</strong> una somma da<br />
determinarsi ad opera del Presidente del Tribunale <strong>di</strong> Roma<br />
5. Onere e sublegato<br />
Tizio, vedovo, è titolare <strong>di</strong> un ingente patrimonio, si reca dal notaio per re<strong>di</strong>gere testamento: vuole nominare<br />
ere<strong>di</strong> i due figli e vuole lasciare all'amico Filano la villa al mare con l'obbligo <strong>di</strong> ultimare i lavori <strong>di</strong> restauro e<br />
<strong>di</strong> lasciarla alla loro amica in comune Caia, almeno <strong>di</strong>eci giorni nel mese <strong>di</strong> luglio, per tutta la vita <strong>di</strong> questa.<br />
Tizio vuole sostituire a Filano la stessa Caia per il caso in cui non possa o non voglia accettare, in tal caso<br />
vuole però che l'obbligo <strong>di</strong> ultimare i lavori ricada sui figli<br />
6. Natura giuri<strong>di</strong>ca dell’onere testamentario<br />
Tizio si reca dal notaio e <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> voler re<strong>di</strong>gere un testamento contenente la sola cosa che gli sta a cuore,<br />
ovvero l'obbligo a carico dell'unico figlio <strong>di</strong> andare a depositare almeno una volta alla settimana sulla sua<br />
tomba <strong>dei</strong> gigli gialli.<br />
C) Esercitazione a casa<br />
Tizia, nubile, vuole <strong>di</strong>sporre delle proprie sostanze per testamento olografo, per la cui redazione intende<br />
avvalersi <strong>dei</strong> consigli del notaio Fiorenzo Fiorentini <strong>di</strong> Firenze, con stu<strong>di</strong>o in via <strong>dei</strong> Renai 23, presso il quale<br />
vuole depositare ritualmente la scheda;<br />
espone al notaio che possiede tre appartamenti, oltre a ingenti <strong>di</strong>sponibilità liquide;<br />
vuole lasciare:<br />
- alla madre Tiziona, l'usufrutto dell'appartamento in Comune <strong>di</strong> Firenze;<br />
- alla sorella Cornelia, l'appartamento in Viareggio, nonchè la liquidazione che le spetta quale <strong>di</strong>rigente della<br />
società Alfa;<br />
- vuole infine lasciare ai suoi tre amici Agenore, Bartolomeo e Cirillo, con i quali coltiva la passione della<br />
montagna, il suo mini appartamento <strong>di</strong> Cortina; vorrebbe però che ne potessero <strong>di</strong>sporre a rotazione, in<br />
modo che ogni anno il periodo migliore spetti ad un soggetto <strong>di</strong>verso;<br />
- a Mevio, suo convivente, quanto altro;<br />
espone altresì al notaio che desidera:<br />
- che nel caso in cui Mevio muoia entro un anno dalla sua morte, quanto a lui attribuito vada a Cornelia;
- che nel caso <strong>di</strong> premorienza <strong>di</strong> Cornelia, tutto quanto a lei assegnato vada alla sua figlia minore;<br />
- che Tiziona sia accu<strong>di</strong>ta sia da Mevio che da Cornelia, in modo assolutamente vincolante per questi, ed è<br />
<strong>di</strong>sposta sul punto a seguire quanto il notaio le vorrà consigliare;<br />
- intende invogliare l'amico avvocato Catullo ad abbandonare una recente relazione extraconiugale con la<br />
segretaria, <strong>di</strong>sponendo in suo favore per tale ipotesi della sua autovettura Ferrari;<br />
- vuole <strong>di</strong>sporre a favore del nipote Cornelietto, ex tossico<strong>di</strong>pendente, se l'amico me<strong>di</strong>co Publio che l'ha<br />
avuto in cura lo riterrà meritevole, <strong>di</strong> una somma <strong>di</strong> denaro sufficiente ad acquistare un fondo ed ivi iniziare<br />
un'attività artigianale <strong>di</strong> sua scelta.<br />
il can<strong>di</strong>dato, assunte le vesti del notaio Fiorenzo Fiorentini, re<strong>di</strong>ga la scheda testamentaria ed il verbale <strong>di</strong><br />
deposito dell'olografo e tratti in parte teorica della sostituzione, rappresentazione e accrescimento nel<br />
negozio testamentario.<br />
D) Correzione 4° esercitazione a casa
VII LEZIONE (26.2.2013)<br />
I legati in generale Acquisto e rinunzia del legato. Sublegato e prelegato. Tipologie del legato: legato ad<br />
efficacia reale, legato obbligatorio, legato rinunziativo. I legati ex lege. Adempimento del legato. Revoca del<br />
legato (art. 686 c.c.).<br />
PARTE TEORICA<br />
Soggetti A) <strong>di</strong>sponente (testatore, ammesso anche un terzo ex art. 631, 2 comma c.c.); B) onerato (erede<br />
testamentario o legittimo); se unico, solo lui è tenuto al legato; se a carico <strong>di</strong> tutti i coere<strong>di</strong> l’adempimento<br />
avviene senza vicolo <strong>di</strong> solidarietà, ma in proporzione alle quote (art. 663 c.c.); l'insolvenza <strong>di</strong> uno non va a<br />
danno degli altri (se posto alternativamente a più soggetti, il legatario sceglie e l'adempiente non ha<br />
regresso); altro legatario/i = sublegato (art. 662 c.c.), tenuto/i entro i limiti <strong>di</strong> valore del legato (art. 671 c.c.).<br />
Questa norma si riferisce al legato e “ad ogni altro onere”: riduzione <strong>dei</strong> vari pesi eccedenti il valore del<br />
legato, mentre la spontanea esecuzione dell'eccedenza equivarrebbe ad un’obbligazione naturale irripetibile<br />
(erede e legatario sono gli unici che possono subire il legato: Cass. 30.5.1967 n. 1181); C) legatario/onorato<br />
(art. 631, 2 comma c.c.; anche un erede = prelegato).<br />
Oggetto E’ tanto ampio da potersi affermare che può formare oggetto <strong>di</strong> legato tutto ciò che può essere<br />
oggetto <strong>di</strong> obbligazione ((Azzariti Martinez, Masi, Giordano Mondello, Trabucchi: necessita il requisito della<br />
patrimonialità: artt. 1174 e 587 c.c.; inoltre, stessi requisiti possibilità/liceità/determinato o determinabile,<br />
anche ex art. 632, 1 e 2 comma c.c.).<br />
A) Acquisto Termini or<strong>di</strong>nari (art. 2946 c.c.) o actio interrogatoria (decorso il termine si perde la facoltà <strong>di</strong><br />
rinunciare, ex art. 650 c.c., <strong>di</strong>verso dall’art. 481 c.c.). Più precisamente, l’acquisto avviene ipso iure<br />
(delazione=acquisto), salvo rinuncia, ex art. 649 c.c. Effetti <strong>di</strong> un’eventuale accettazione (irrilevante per<br />
Gangi; consolidare l'acquisto per Ferri; rinuncia alla facoltà <strong>di</strong> rinunciare per Bigliazzi Geri, Bianca).<br />
B) Rinuncia Da tenere presente che: 1) non è <strong>di</strong>smissiva <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto, ma impe<strong>di</strong>sce il prodursi dell'acquisto<br />
(Trabucchi, contra Pugliatti, Bigliazzi Geri; per Giordano Mondello funziona da con<strong>di</strong>zione risolutiva<br />
dell'acquisto); 2) il <strong>di</strong>ritto ritorna alla massa ere<strong>di</strong>taria - se si tratta <strong>di</strong> proprietà o cre<strong>di</strong>to già appartenente al<br />
de cuius - oppure si estingue, se trattasi <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto reale minore o cre<strong>di</strong>to derivante da legato obbligatorio; 3)<br />
negozio unilaterale non recettizio, puro, totale, soggetto a revocatoria; per quanto riguarda la forma, a<br />
<strong>di</strong>fferenza dell’art. 519 c.c., per la rinuncia all'ere<strong>di</strong>tà non sono previste forme particolari: ma se concerne<br />
beni immobili occorre la forma scritta ad substantiam (art. 1350 c.c.; Cass. 26.1.1990 n. 459) e trascrizione<br />
(se trascritto l'acquisto del legato in conformità ad un estratto del testamento); 4) irrevocabile, perché ha<br />
effetto imme<strong>di</strong>ato per l'onerato (Masi, Bianca). Stesse regole per capacità e rappresentazione (salva la<br />
natura personale); inoltre, possibile applicazione degli artt. 625 e 628 c.c.<br />
PRELEGATO (art. 661 c.c.) Il prelegato è la <strong>di</strong>sposizione a favore <strong>di</strong> uno o più coere<strong>di</strong> (testamentari o<br />
legittimi) posta a carico <strong>di</strong> tutta l'ere<strong>di</strong>tà. Tale <strong>di</strong>ritto è sod<strong>di</strong>sfatto prima della <strong>di</strong>visione (art. 713 c.c.),<br />
riducendo l'ammontare <strong>dei</strong> beni da <strong>di</strong>videre (prelievo anticipato). Il prelegatario, poi, risponde <strong>dei</strong> debiti<br />
ere<strong>di</strong>tari solo per la parte che gli spetta come coerede. Anche il prelegato può essere gravato da un onere. Il<br />
prelegato è soggetto a riduzione in caso <strong>di</strong> lesione della legittima (Cass. 30.7.1999 n. 8284). E' ammesso il<br />
prelegato a favore dell'unico erede (Trib. Vallo <strong>di</strong> Lucania 17.4.2002); il legato resta valido anche se è nulla<br />
l'istituzione <strong>di</strong> ere<strong>di</strong>tà (Giordano Mondello, Bianca, Capozzi; Cass. 26.6.1973 n. 1834; Cass. 23.3.1992 n.<br />
3593). Prelegato anomalo: prelegato a carico solo <strong>di</strong> alcuni <strong>dei</strong> coere<strong>di</strong> (Messineo).<br />
SUBLEGATO (artt. 662 e 671 c.c.) Il sublegato è la <strong>di</strong>sposizione a favore dell'onorato/legatario che grava<br />
su altro legatario. Trattasi <strong>di</strong> due <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong>stinte: perciò, il sublegatario non è avente causa del<br />
legatario, ma del de cuius. Infatti, il sublegato è un'autonoma e <strong>di</strong>retta attribuzione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti patrimoniali<br />
(Capozzi). L'autonomia del sublegato si evidenzia in caso <strong>di</strong> nullità (se la causa <strong>di</strong> nullità non vale per<br />
entrambi) o <strong>di</strong> rinunzia del legatario/onerato: infatti, il sublegato sarà a carico degli altri collegatari (per<br />
accrescimento) o, in loro mancanza, a carico degli ere<strong>di</strong> (art. 677 c.c. e, in tal caso, non varrà il limite <strong>di</strong> cui<br />
all’art. 671 c.c.); in caso <strong>di</strong> rinunzia dell'onorato, il sublegato si risolve a favore dell'onerato (salvo<br />
devoluzione).<br />
A) LEGATO AD EFFICACIA REALE<br />
1) Legati <strong>di</strong> specie: trasferimento/costituzione automatica proprietà o altro <strong>di</strong>ritto reale <strong>di</strong> go<strong>di</strong>mento su cose<br />
specifiche dell'asse, ma nei limiti della compatibilità con la natura del <strong>di</strong>ritto (è ammessa la costituzione <strong>di</strong><br />
usufrutto, uso e abitazione, non il loro trasferimento a causa <strong>di</strong> morte: Trib. Prato 27.6.1989; Cass.<br />
28.1.1995 n. 1048; Cass. 21.2.1995 n. 1909); è esclusa la costituzione per testamento dell'ipoteca (art. 2821<br />
c.c.), ma è ammesso il legato <strong>di</strong> ipoteca a favore del debitore ipotecario perché <strong>di</strong>retto ad estinguere la<br />
garanzia reale (Masi); ammesso il pegno, se la cosa è già detenuta dal legatario, altrimenti obbligo<br />
dell'onerato <strong>di</strong> costituire il pegno; esclusa la trasmissione della servitù separata dal fondo dominante, perciò<br />
solo legato <strong>di</strong> servitù a favore <strong>di</strong> proprietario del fondo servente (Masi). Il legatario consegue<br />
imme<strong>di</strong>atamente la proprietà o il <strong>di</strong>ritto reale sul bene (art. 649 c.c.) o effettuata la scelta (artt. 664 e 665<br />
c.c.), ma non consegue automaticamente il possesso che passa, invece, all'erede (art. 1146 c.c.): perciò, il
legatario deve chiedere all'onerato il possesso del bene, anche se espressamente <strong>di</strong>spensato dal testatore<br />
(art. 649 c.c.). Il bene può appartenere ad altri (purchè il de cuius ne sia consapevole: art. 651, 1 comma<br />
c.c.: rientra nell’art. 651 c.c. - e non nell’art. 649 c.c. - il legato avente ad oggetto una cosa acquistata dal<br />
testatore con residuo obbligo <strong>di</strong> pagamento del prezzo e con riserva <strong>di</strong> proprietà).<br />
Anche i legati ad efficacia reale o <strong>di</strong>retta hanno un’efficacia obbligatoria, ma solo strumentale: per il legato <strong>di</strong><br />
proprietà c’è un obbligo <strong>di</strong> trasferire il possesso (accessioni, pertinenze e frutti, ex art. 649, 2 e 3 comma c.c.,<br />
prodotti dopo la morte del de cuius) e <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>re la cosa dalla morte del medesimo fino alla consegna; per il<br />
legato <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to c’è un obbligo <strong>di</strong> consegnare i titoli del cre<strong>di</strong>to in possesso del testatore (Trib. Roma<br />
13.6.2000).<br />
2) Legati <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to Trattasi <strong>di</strong> un cre<strong>di</strong>to del de cuius verso terzi (art. 658 c.c.): trasmissione automatica<br />
senza necessità della notifica dell'acquisto al debitore (analogia art. 1263 c.c.).<br />
B) LEGATO OBBLIGATORIO Comporta un <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to (prestazione, ovvero manca il trasferimento<br />
<strong>di</strong>retto dell'oggetto verso l'onerato. Tale tipo <strong>di</strong> legato costituisce una categoria aperta (c.d. atipicità): sono<br />
tipici i legati previsti agli artt. 651, 652, 653, 654, 665, 1872, 660 c.c.; sono atipici, invece il legato <strong>di</strong> contratto<br />
(compraven<strong>di</strong>ta, lavoro, locazione); la prelazione testamentaria; il legato <strong>di</strong> non concorrenza, Il legato atipico<br />
è espressione <strong>di</strong> autonomia testamentaria (Giordano Mondello, Bonilini).<br />
C) LEGATO RINUNCIATIVO <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto ere<strong>di</strong>tario a favore del legatario; non c'è trasmissione, ma un effetto<br />
estintivo imme<strong>di</strong>ato (legato <strong>di</strong> liberazione o <strong>di</strong> remissione del debito), senza comunicazione al debitore (art.<br />
658 c.c.); ammissibilità della rinuncia all'effetto estintivo del debito da parte del legatario; secondo Azzariti la<br />
remissione del debito, sotto forma <strong>di</strong> legato <strong>di</strong> liberazione, configurerebbe un atto inter vivos con efficacia<br />
post mortem.<br />
D) LEGATI EX LEGE Alcune figure: a) <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> abitazione della casa familiare ed uso <strong>dei</strong> mobili a favore del<br />
coniuge superstite non legalmente separato (art. 540 c.c.); b) assegno vitalizio a favore del coniuge<br />
legalmente separato con addebito (art. 548 c.c.) o <strong>di</strong>vorziato che versi in stato <strong>di</strong> bisogno (art. 9 bis legge sul<br />
<strong>di</strong>vorzio); c) assegno vitalizio a favore del figlio naturale non riconoscibile (art. 580 c.c.): più che <strong>di</strong> legati si<br />
parla <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti ex lege a carico dell'ere<strong>di</strong>tà in funzione alimentare (Bigliazzi Geri, Trabucchi, Masi).<br />
ADEMPIMENTO DEL LEGATO Il momento dell’adempimento della prestazione coincide con l’apertura della<br />
successione (art. 667 c.c.), in<strong>di</strong>pendentemente dal tipo <strong>di</strong> efficacia (obbligatoria o reale): a) se legato ad<br />
efficacia <strong>di</strong>retta, il legatario ha un cre<strong>di</strong>to alla consegna del bene o del titolo che lo legittima ad esercitare il<br />
<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to (l'esigibilità decorre dall'apertura della successione); b) per i frutti ve<strong>di</strong> l’art. 669 c.c.; c) limiti<br />
<strong>di</strong> responsabilità (debiti e pesi ere<strong>di</strong>tari, ma i cre<strong>di</strong>tori del defunto possono sod<strong>di</strong>sfarsi anche sui legati <strong>di</strong><br />
specie); d) spese a carico dell'onerato (art. 672 c.c.),; e) secondo l’art. 667 c.c. il bene deve essere<br />
consegnato nello stato <strong>di</strong> fatto e <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto al tempo dell'apertura della successione, con tutte le sue<br />
pertinenze (art. 819 c.c.), accessioni (art. 934 c.c.: per gli immobili limite dell’art. 686 c.c.), miglioramenti o<br />
detrimenti, accrescimenti del fondo; f) oneri (art. 668 c.c.): per quelli intrinseci (ad esempio, servitù o oneri<br />
reali) ve<strong>di</strong> 1 comma (sono a carico del legatario: limite valore della cosa); per quelli estrinseci ve<strong>di</strong> 2 comma,<br />
sono a carico dell'erede (rientrano tra i debiti ere<strong>di</strong>tari); g) il legato obbligatorio non produce effetti se, dopo<br />
la morte del testatore, la prestazione (infungibile o <strong>di</strong> specie) a carico dell'onerato è <strong>di</strong>venuta impossibile per<br />
causa a lui non imputabile (artt. 673, 2 comma e 1218 c.c.; ad esempio, per perimento della cosa,<br />
smarrimento o furto). In caso <strong>di</strong> perimento integrale si verifica una impossibilità sopravvenuta assoluta e<br />
definitiva, altrimenti il legato è ridotto a ciò che avanza; ex art. 673, 1 comma c.c.; h) il legatario deve<br />
rimborsare le spese per la conservazione e manutenzione (spese per la <strong>di</strong>visione, spese per il rilascio, ecc.).<br />
Revoca del legato (art. 686 c.c.).<br />
BIBLIOGRAFIA (VII e VIII lezione; inoltre bibliografia in<strong>di</strong>cata nella II lezione)<br />
Argiroffi, Legati obbligatori, in Riv. <strong>di</strong>r. civ., 1983, p. 2; Azzariti, Alienazione e trasformazione della cosa legata e revoca del legato, in<br />
Riv. trim. <strong>di</strong>r. e proc. civ., 1976, p. 1620; Bartolozzi, Legato pecuniario come legato <strong>di</strong> genere, in Notariato, 1996, I, p. 131; Bion<strong>di</strong>,<br />
voce Legato, in Novissimo Dig. It., IX, Torino 1963, p. 597 ss.; Bonilini, Autonomia testamentaria e legato. I così detti legati atipici,<br />
Milano 1990; Bonilini, La prelazione testamentaria, in Riv. <strong>di</strong>r. civ., I, p. 223; Bonilini, I legati, in Comm. c.c. Schlesinger, Milano 2001,<br />
p. 305; Bonilini, Le obbligazioni <strong>di</strong> fonte successoria, in Stu<strong>di</strong>um iuris, 2002, p. 1447 ss. (I parte); in Stu<strong>di</strong>um iuris, 2003, p. 41 ss. (II<br />
parte); Bucelli-Galli, Acquisto dal legatario apparente, in Familia 2004, p. 737 ss.; Danova, Il legato <strong>di</strong> quota lite, in Giust. civ., 1985, I,<br />
p. 3183; De Rupertis, La trascrizione dell’acquisto del legato e il notaio, in Vita not., 1996, I, p. 1557 ss.; Di Mauro, Legato <strong>di</strong><br />
coabitazione e accrescimento, in Riv. not., 1991, p. 232; Di Mauro, Legato <strong>di</strong> debito e datio in solutum, in Riv. not., 1990, p. 824; Di<br />
Mauro, Legato <strong>di</strong> cosa da prendersi da certo luogo e legato <strong>di</strong> somma <strong>di</strong> danaro da prendersi in un libretto <strong>di</strong> deposito bancario, in<br />
Giust. civ., 1992, p. 134; Di Mauro, Legato <strong>di</strong> coabitazione e accrescimento, in Riv. not., 1991, p. 232; Di Mauro, Prelegato d’azienda a<br />
favore <strong>di</strong> unico erede, in Fam. pers. succ., 2006, p. 602 ss.; Ferri, Legato <strong>di</strong> cosa da prendersi in un certo luogo, in Riv. trim. <strong>di</strong>r. e proc.<br />
civ., 1956, p. 326; Gardani Contursi Lisi, Istituzione <strong>di</strong> erede e legati, in Comm. al cod. civ. a cura <strong>di</strong> Scialoja e Branca (artt. 624-632<br />
c.c.), Bologna-Roma 1983; Gardani Contursi Lisi, Il legato modale (lineamenti), in Riv. <strong>di</strong>r. civ., 1956, I, p. 957; Gerbo, Prelegato e<br />
funzione del contenuto testamentario nel fenomeno successorio, Roma 1995; Giordano Mondello, voce Legato, in Enc. del <strong>di</strong>r.,<br />
XXXIII, Milano 1973, p. 719; Gradassi, Clausole testamentarie in tema <strong>di</strong> legato <strong>di</strong> posizione contrattuale, in Notariato, 1999, I, p. 43;<br />
Giorgianni, Legato modale (o sublegato) e azioni <strong>di</strong> riduzione, in Dir. giur., 1959, p. 149 ss.; Masi, Dei legati, in Comm. al cod. civ. a<br />
cura <strong>di</strong> Scialoja e Branca, (artt. 649-673 c.c.), Bologna-Roma 1979; Masi, voce Legato, in Enc. giur. Treccani, XVIII, Roma 1990; Masi,<br />
voce Prelegato, in Enc. del Dir., 1985, p. 1017 ss.; Napoli, Il legato <strong>di</strong> contratto, in Rass. <strong>di</strong>r. civ., 1983, p. 738; Pastore, Il legato <strong>di</strong><br />
cosa generica, in Riv. not., 1996, I, p. 644; Pastore, Il legato a carico <strong>di</strong> uno o più legatari (c.d. sublegato), in Riv. <strong>di</strong>r. civ., 2003, p. 223<br />
ss.; Rizzi, Acquisto e rinunzia al legato: forma, trascrizione e <strong>di</strong>sciplina fiscale, in Notariato, 1995, I, p. 566 ss.; Ruperto, Sul legato <strong>di</strong><br />
debito, in Riv. trim. <strong>di</strong>r. e proc. civ., 1991, I, p. 277; Tra<strong>di</strong>ti, Legato <strong>di</strong> azienda, in Notariato, 1999, I, p. 259.
A) Esercitazione in classe<br />
PARTE PRATICA<br />
Tizio, non vedente, ma letterato ed in grado <strong>di</strong> sottoscrivere, sconosciuto al notaio ma amico della segretaria<br />
Tertulliana e dell’avvocato Venanzio, presenti in stu<strong>di</strong>o, si reca dal notaio Romolo Romani in Roma, con<br />
stu<strong>di</strong>o in via Arenula, n. 1, desiderando fare testamento pubblico.<br />
Egli <strong>di</strong>chiara al notaio <strong>di</strong> essere coniugato, in regime <strong>di</strong> separazione <strong>dei</strong> beni, con Tizia.<br />
Aggiunge poi <strong>di</strong> avere tre figli legittimi, Primo, Seconda e Terzo, tutti maggiorenni.<br />
Tizio è titolare <strong>di</strong> un appartamento, sito in Velletri, del valore attuale <strong>di</strong> euro 200.000 e <strong>di</strong> un'azienda <strong>di</strong><br />
ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> prodotti alimentari, in Roma, via Nomentana, che gestisce con i due figli maschi, Primo e Terzo, in<br />
forma <strong>di</strong> impresa familiare, il cui valore patrimoniale attuale, al netto delle passività, è <strong>di</strong> euro 1.800.000.<br />
Egli possiede anche titoli a lui intestati, depositati presso la Filiale <strong>di</strong> Roma della Banca Alfa S.p.a., per un<br />
valore complessivo pari ad euro 2.800.000.<br />
Tizio, nell'esporre le sue volontà al notaio, <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> voler lasciare ai due figli maschi, Primo e Terzo, in<br />
sostituzione <strong>dei</strong> <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> legittima, l'azienda <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> alimentari, ma non la <strong>di</strong>tta, che vuole attribuire a<br />
Calpurnio.<br />
Tizio intende inoltre istituire erede la moglie Tizia nella sola quota <strong>di</strong> riserva a lei spettante, lasciandole la<br />
parte <strong>dei</strong> titoli mobiliari che sia sufficiente a sod<strong>di</strong>sfare le sue ragioni <strong>di</strong> legittima.<br />
Dichiara infine <strong>di</strong> voler istituire erede Seconda, purché quanto sopra non intacchi la sua legittima e purché<br />
non debba rispondere <strong>dei</strong> debiti dell’azienda, che dovrebbero andare a carico <strong>dei</strong> figli.<br />
Vuole lasciare al cre<strong>di</strong>tore Clau<strong>di</strong>o, in luogo dell’adempimento del debito per euro centomila verso il<br />
medesimo, l’imbarcazione da <strong>di</strong>porto Cranchi <strong>di</strong> sua proprietà.<br />
Intende novare l’obbligazione pecuniaria contratta con il cre<strong>di</strong>tore Giulio, avente ad oggetto la somma <strong>di</strong> un<br />
milione <strong>di</strong> euro, sostituendola con l’obbligo <strong>di</strong> trasferire la proprietà del suo vigneto in Agrigento.<br />
Vuole lasciare a Valeria, appassionata <strong>di</strong> equitazione e letteratura, il cavallo Mescal, <strong>di</strong> proprietà comune<br />
sua e <strong>di</strong> Labeone, o, alternativamente, la copia autografata <strong>dei</strong> versi <strong>di</strong> Pablo Neruda.<br />
Avendo, inoltre, scoperto che il suo prozio Mevio intratteneva una relazione extraconiugale, intende<br />
fermamente rinunciare al legato <strong>di</strong>sposto in proprio favore e già accettato, avente ad oggetto la proprietà<br />
dell’autovettura Aston Martin.<br />
A causa <strong>di</strong> un impegno imprevisto, l’avvocato Venanzio e la segretaria Tertulliana si devono assolutamente<br />
allontanare dallo stu<strong>di</strong>o del notaio prima che costui abbia ricevuto le volontà del testatore, subito dopo la<br />
costituzione in atto dello stesso.<br />
Il can<strong>di</strong>dato, assunte le vesti del notaio Romolo Romani, re<strong>di</strong>ga il testamento dopo aver motivato<br />
adeguatamente le soluzioni adottate; tratti, in parte teorica del legato <strong>di</strong> azienda.<br />
- Legge sui ciechi, sua compatibilità con il testamento pubblico;<br />
- Ruolo <strong>dei</strong> fidefacienti;<br />
- Legato in sostituzione <strong>di</strong> legittima e legato in conto <strong>di</strong> legittima;<br />
- Legato <strong>di</strong> azienda, sua <strong>di</strong>sciplina;<br />
- Divisione oggettivamente parziale e <strong>di</strong>visione soggettivamente parziale del testatore; rapporti con<br />
istituti affini;<br />
- Legato <strong>di</strong> contratto: datio in solutum e novazione (con<strong>di</strong>zione sospensiva dell’accettazione da parte<br />
del legatario);<br />
- Legato alternativo e legato <strong>di</strong> cosa parzialmente altrui;<br />
- Rinuncia al legato.<br />
B) Correzione 5° esercitazione a casa
VIII LEZIONE (12.3.2013)<br />
I legati in particolare. I legati tipici (legato <strong>di</strong> cosa altrui, legato <strong>di</strong> genere, legato <strong>di</strong> prestazioni perio<strong>di</strong>che,<br />
legato <strong>di</strong> debito/cre<strong>di</strong>to). I legati atipici (legato <strong>di</strong> contratto, legato <strong>di</strong> prelazione, legato <strong>di</strong> azienda).<br />
PARTE TEORICA<br />
LEGATI TIPICI<br />
1. LEGATI DI COSE ALTRUI Regola La cosa legata deve trovarsi nel patrimonio ere<strong>di</strong>tario, anche se vi è<br />
pervenuta in un momento successivo alla redazione del testamento (artt. 651, 652, 654, 655, 656, 657 c.c.) -<br />
o vi è tornata al tempo della morte (art. 651, ultimo comma c.c.). Il legato <strong>di</strong> cosa altrui o <strong>di</strong> cosa che non si<br />
trova nel patrimonio del de cuius è nullo (artt. 651, 652, 656 c.c.) o senza effetto (artt. 654, 655, 657 c.c.).<br />
Eccezioni Tutti i casi in cui il testatore conosceva l'altruità della cosa e voleva obbligare l'onerato a procurare<br />
la cosa al legatario (cfr. artt. 651, 1 e 2 comma, 652, 656, 657 c.c.): la consapevolezza va accertata<br />
attraverso il testamento o altre risultanze equipollenti anteriori, coeve o posteriori (contra Masi) al testamento<br />
(App. Napoli 7.7.1976; Cass. 21.1.1980 n. 484); anche non sottoscritte dal testatore, come un semplice<br />
appunto (Cass. 9.5.1962 n. 918, Masi, Perego). Non è rilevante l'errore del testatore in or<strong>di</strong>ne alla<br />
determinazione della persona cui la cosa appartiene o circa il mutamento della titolarità del bene verificatosi<br />
fra la redazione e l'apertura della successione (Masi, Gangi).<br />
1a) legato <strong>di</strong> cosa altrui (dell'onerato, <strong>di</strong> un terzo o dello stesso legatario): se la cosa legata, pur<br />
appartenendo al tempo del testamento a terzi, è tornata nel patrimonio del de cuius alla sua morte, il legato<br />
è valido e ha efficacia reale. Ipotesi specifiche: a) legato <strong>di</strong> cosa del legatario (art. 656 c.c.); b) legato <strong>di</strong><br />
cosa acquistata dal legatario (art. 657 c.c.): c) il legato <strong>di</strong> cosa dell'onerato o <strong>di</strong> un terzo.<br />
1b) legato <strong>di</strong> cosa solo in parte del testatore (art. 652 c.c.) il legato è valido, ma limitato alla parte (intesa<br />
come quota ideale e non parte materiale: Masi, Lops) o al <strong>di</strong>ritto minore (ipotesi limitate all'enfiteusi, nuda<br />
proprietà, superficie) che spettano al testatore (legato ad efficacia reale), salvo ritornare all’art. 651 c.c.<br />
(legato ad efficacia sia reale che obbligatoria) quando il testatore intendeva legare l'intero ed era<br />
consapevole della sua <strong>di</strong>sponibilità solo in parte del bene (Cass. 9.5.1965 n. 619).<br />
2. LEGATO DI GENERE<br />
2a) legato <strong>di</strong> cosa determinata solo nel genere (art. 653 c.c.) è valido anche se la cosa non è nel patrimonio<br />
al tempo della redazione o al tempo della morte: si tratta <strong>di</strong> un legato obbligatorio e l'onerato è tenuto alla<br />
scelta della cosa da attribuire al legatario, se non è stata affidata dal testatore al legatario (può scegliere la<br />
migliore) o ad un terzo (che funziona da arbitratore) (artt. 664/666 c.c.). Qualità non inferiore alla me<strong>di</strong>a (art.<br />
1178 c.c.), ma se nel patrimonio vi è solo una cosa del genere in<strong>di</strong>cato dal de cuius non si ha facoltà <strong>di</strong><br />
scelta e il legato si trasforma in legato <strong>di</strong> specie Applicabilità dell'art. 1346 c.c. sui requisiti dell'oggetto (Cass.<br />
2708/1992).<br />
2b) legato <strong>di</strong> cosa da prendersi in un certo luogo (art. 655 c.c.) La fattispecie concerne la quantità o la<br />
qualità. Trattasi <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizione testamentaria per relationem (formale). La posizione spaziale è essenziale<br />
per l’in<strong>di</strong>viduazione: il legato ha effetto solo se le cose vi si trovano (esistenza) e per la parte (quantità) che<br />
vi si trova (Cass. 6317/1991) La norma, riferita al momento della morte e non della redazione, presuppone<br />
l'in<strong>di</strong>viduazione delle cose sulla base del rapporto <strong>di</strong> relazione con il luogo in<strong>di</strong>cato dal testatore: quin<strong>di</strong>, il<br />
luogo funziona come mezzo <strong>di</strong> riferimento per l'in<strong>di</strong>viduazione dell'oggetto del legato. Di solito è in<strong>di</strong>cato il<br />
genere, ma non la quantità e dunque si configura un legato a contenuto variabile (ad esempio, “lascio ad X<br />
tutto ciò che si trova nella mia abitazione”, in cui il luogo vale per il genere, la qualità e la natura/tipo del<br />
bene; si richiama l’art. 655 c.c.: incertezza oggettiva nel momento della redazione del testamento); altre volte<br />
il riferimento è sotto la forma con<strong>di</strong>zionale, ossia che la cosa permanga in quel luogo.<br />
2c) legato alternativo (artt. 665/1285-1286 c.c.) La scelta - spetta all'onerato, salvo che il testatore <strong>di</strong>sponga<br />
che la scelta spetti al terzo o al legatario - fra due o più prestazioni determinate e <strong>di</strong>verse: la <strong>di</strong>sposizione ha<br />
per oggetto l'attribuzione <strong>di</strong> due o più cose tra le quali vi è un nesso <strong>di</strong> alternatività, una volta operata la<br />
scelta il legatario avrà <strong>di</strong>ritto ad una sola <strong>di</strong> esse.<br />
3. LEGATI DI PRESTAZIONI PERIODICHE (obbligazioni <strong>di</strong> durata)<br />
3a) legato <strong>di</strong> prestazioni perio<strong>di</strong>che (art. 670 c.c.) Il legato resta unico anche se le somministrazioni sono<br />
plurime (Capozzi). Diverso è il legato <strong>di</strong> somma <strong>di</strong> denaro da rateizzarsi (vale la prescrizione decennale e i<br />
ratei ancora non pagati si trasmettono agli ere<strong>di</strong> del legatario deceduto). Nel legato <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>ta vitalizia<br />
(costituita mortis causa, a <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> quella inter vivos) è valida la clausola d’in<strong>di</strong>cizzazione monetaria<br />
(Cass. 3.6.1991 n. 62459).<br />
3b) legato <strong>di</strong> alimenti (art. 660 c.c.) Nel legato <strong>di</strong> alimenti senza precisazione del quantum, l’art. 660 c.c.<br />
richiama l’art. 438 c.c. (se ne deducono tutti i presupposti: stato <strong>di</strong> bisogno del legatario; misura<br />
proporzionale al bisogno del legatario-coniuge e figli a carico; con<strong>di</strong>zioni economiche dell'onerato; limite del<br />
necessario per la vita; se al momento dell'apertura della successione il legatario non è in stato <strong>di</strong> bisogno il<br />
legato resta quiescente: Capozzi, Cass. 4.4.1957 n. 1156; Cass. 1326/1959). Il soggetto può essere
chiunque (anche oltre quelli previsti agli art. 433 e ss. c.c.). Legato <strong>di</strong> mantenimento c.d. atipico (molto più<br />
ampio e con caratteri <strong>di</strong>versi da quelli della ren<strong>di</strong>ta vitalizia: cfr. Cass. 5.8.1987 n. 6727).<br />
4. LEGATO DI DEBITO/CREDITO<br />
4a) legato <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to o <strong>di</strong> liberazione da debito (art. 658 c.c.) Si riferisce ad un cre<strong>di</strong>to del testatore nei<br />
confronti del legatario (art. 1236 c.c.: può riguardare una parte, i soli interessi, una clausola penale, la<br />
solidarietà con altri debitori, ecc.), o ad un cre<strong>di</strong>to nei riguar<strong>di</strong> <strong>di</strong> un terzo (art. 1260 c.c., anche dell'onerato o<br />
<strong>di</strong> un terzo): il cre<strong>di</strong>to deve sussistere al tempo della morte (se fosse estinto non avrebbe efficacia; se fosse<br />
una remissione il legatario non avrebbe <strong>di</strong>ritto alla ripetizione) e vale solo per la parte del debito/cre<strong>di</strong>to che<br />
sussiste a questo tempo: l'erede deve consegnare i titoli del cre<strong>di</strong>to legato, ma non è tenuto a garantire<br />
l'esistenza o l'esigibilità del medesimo (Gangi, Trabucchi, Masi).<br />
4b) legato <strong>di</strong> debito/legato a favore del cre<strong>di</strong>tore (art. 659 c.c.) Si prevedono due fattispecie: a) pagamento<br />
del debito tramite legato; b) vera e propria liberalità: l'elemento <strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione è la menzione del debito.<br />
La norma si fonda sulla presunzione che un legato, a favore <strong>di</strong> persona che vanta un cre<strong>di</strong>to verso il<br />
testatore, non ha funzione satisfattiva (art. 2727 c.c.). La mancata menzione del debito verso il legatario fa<br />
presumere iuris tantum che il legato non assolva una funzione solutoria, ma sia <strong>di</strong>sposto a titolo <strong>di</strong> liberalità<br />
(cfr. Cass. 2306/1985; Cass. 4238/1988; Cass. 2.2.1990 n. 706).<br />
LEGATI ATIPICI<br />
Il fondamento <strong>dei</strong> legati atipici è l'autonomia testamentaria (il legato ne è un potente strumento, data la<br />
duttilità del suo contenuto: Bonilini, Giordano Mondello). Limiti: possibilità/liceità e rilevanza sociale, ex art.<br />
1322 c.c. I legati atipici attribuiscono ad un soggetto beneficiario un facere in via in<strong>di</strong>retta, ponendo in capo<br />
ad un terzo soggetto (onerato) l’obbligo <strong>di</strong> realizzarlo (Bonilini): questo facere può essere una mera attività<br />
materiale (legati del fatto del terzo) o un’attività negoziale (legati <strong>di</strong> contratto).<br />
Legato <strong>di</strong> contratto E’ un legato obbligatorio: il legatario vanta il cre<strong>di</strong>to alla stipulazione <strong>di</strong> un<br />
contratto/attività negoziale <strong>di</strong> cui onerati risultano l'erede o altro legatario. La dottrina oggi riconosce, ad<br />
eccezione delle prestazioni incoercibili, l'esecuzione coattiva a spese dell'obbligato e comunque il<br />
risarcimento del danno (art. 2932 c.c.). La fase genetica <strong>di</strong> questa fattispecie è regolata dal <strong>di</strong>ritto<br />
successorio (esistenza, effetti, rinuncia del beneficiario o dell’onerato); la fase funzionale è regolata dalla<br />
materia contrattuale (regole dell’esecuzione del rapporto contrattuale; l’onerato potrà rinunciare alla<br />
controprestazione; possibilità per il legatario <strong>di</strong> trasmettere i suoi <strong>di</strong>ritti sia inter vivos che mortis causa;<br />
termini or<strong>di</strong>nari <strong>di</strong> prescrizione; ammissibilità della risoluzione per eccessiva onerosità; rescissione per<br />
lesione ultra <strong>di</strong>mi<strong>di</strong>um; regime dell’invali<strong>di</strong>tà; sanatoria ex art. 590 c.c., inapplicabilità degli artt. 1444 e 2034<br />
c.c.: su tali aspetti Napoli).<br />
Legato <strong>di</strong> prelazione E’ un legato obbligatorio: l’onorato acquista il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to ad essere preferito, nel<br />
caso in cui l'onerato <strong>di</strong>a vita al negozio contemplato nella scheda (compraven<strong>di</strong>ta, locazione):<br />
l'inadempimento <strong>di</strong> questo legato genera solo il risarcimento del danno (Bonilini). Peraltro, sono escluse le<br />
prestazioni attinenti alle qualità del contraente e alla sua personalità concreta (è da escludere il rapporto<br />
obbligatorio tra onerato e onorato, se si impone <strong>di</strong> avvalersi del secondo come me<strong>di</strong>co, artigiano, ecc.). Limiti<br />
d’ammissibilità comparabili a quelli stabiliti per il <strong>di</strong>vieto d’alienazione (art. 1379 c.c.).<br />
Legato <strong>di</strong> costituzione d’ipoteca (legato obbligatorio) Il problema è la sua conciliazione con l'art. 2821, 2<br />
comma c.c. (l'ipoteca non può essere concessa per testamento, giustificando il <strong>di</strong>vieto nel tentativo <strong>di</strong><br />
salvaguardare la par con<strong>di</strong>cio cre<strong>di</strong>torum che il testatore potrebbe in tal modo alterare): secondo Rubino<br />
anche il legato <strong>di</strong> contratto d’ipoteca (in<strong>di</strong>retta) rientra nel <strong>di</strong>vieto, secondo Gorla, invece, l'ipoteca costituita<br />
dall'erede o dal legatario non raggiunge lo stesso risultato dell’art. 2821 c.c., perché la par con<strong>di</strong>cio esiste<br />
pur sempre all'apertura della successione in quanto l'ipoteca (che potrà gravare solo sulla <strong>di</strong>sponibile) viene<br />
iscritta in base ad un titolo <strong>di</strong>verso (Capozzi).<br />
Legato <strong>di</strong> azienda Si applica la <strong>di</strong>sciplina dell'alienazione inter vivos. Non occorre l'in<strong>di</strong>viduazione specifica<br />
<strong>dei</strong> beni che compongono l'azienda, essendo sufficiente la determinazione per relationem (vis espansiva).<br />
Questione sulla responsabilità del legatario per i debiti aziendali (relativa ai rapporti interni erede/legatario e<br />
non ai rapporti esterni con i cre<strong>di</strong>tori aziendali, nei cui confronti si ha sempre responsabilità solidale): da un<br />
lato, attribuendo all’azienda natura <strong>di</strong> universitas iuris, si reputa che si trasferiscano al legatario anche le<br />
passività (derogandosi alle regole successorie, anche in<strong>di</strong>pendentemente dalla volontà testamentaria); la<br />
maggior parte della dottrina, invece, considerando l’azienda una universitas facti, reputa i debiti non facenti<br />
parte dell’azienda e dunque a carico degli ere<strong>di</strong> in proporzione delle quote ere<strong>di</strong>tarie (salvo <strong>di</strong>versa volontà<br />
del testatore, ex artt. 752 e 756 c.c.). La problematica sembra trovare soluzione nella volontà del testatore<br />
(art. 1371 c.c.): in mancanza <strong>di</strong> volontà <strong>di</strong>versa dal testatore, dunque, i debiti saranno a carico del legatario<br />
(art. 668 c.c.). Il testatore può <strong>di</strong>sporre il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> concorrenza, nei limiti dell’art. 2557 c.c.
A) Esercitazione in classe<br />
PARTE PRATICA<br />
Tizio, separato dalla moglie Tizia con addebito a carico <strong>di</strong> quest’ultima, si reca dal notaio Romolo Romani <strong>di</strong><br />
Roma, con stu<strong>di</strong>o alla via Arenula, n. 1, per <strong>di</strong>sporre delle proprie sostanze.<br />
Egli vuole legare in conto <strong>di</strong> legittima ai figli legittimi Primo, Secondo ed al figlio naturale Terzo i beni che<br />
costoro vorranno o, in alternativa, rispettivamente la villa a Capri, la casa a Roma e lo chalet a Cortina.<br />
Tizio intende inoltre attribuire, in sostituzione <strong>dei</strong> <strong>di</strong>ritti spettanti per legge, al figlio non riconoscibile Quarto il<br />
monolocale in centro a Milano, <strong>di</strong> proprietà <strong>di</strong> Calpurnio ma rispetto al quale ha già stipulato un contratto<br />
preliminare <strong>di</strong> acquisto.<br />
Vuole, inoltre, attribuire alla moglie Tizia, in sostituzione <strong>di</strong> quanto eventualmente dovutole per legge, il<br />
piccolo appezzamento <strong>di</strong> terreno in Comune <strong>di</strong> Velletri.<br />
Tizio vuole lasciare a Corinna il terreno in provincia <strong>di</strong> Sassari percorso dal fuoco sette anni fa.<br />
Il testatore vuole, inoltre, lasciare all’amica Filana, per abbellire ulteriormente il suo splen<strong>di</strong>do giar<strong>di</strong>no<br />
pensile, <strong>di</strong>eci alberi da frutto attualmente non presenti nel suo patrimonio.<br />
Intende, inoltre, lasciare alla stessa le obbligazioni convertibili emesse dalla “Alfa s.p.a.” <strong>di</strong> cui è attualmente<br />
titolare.<br />
Vuole, inoltre, beneficiare il proprio debitore Giulio escludendo la solidarietà nei confronti degli altri<br />
condebitori solidali, Cesare ed Augusto.<br />
Intende, ancora, attribuire all'amico Sempronio il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> prelazione a lui spettante sull'appartamento sito in<br />
via Posillipo a Napoli, nonché attribuire all’amica Caia le somme liquide depositate sul conto corrente<br />
bancario acceso presso la Banca “Beta S.p.a.” e cointestato a Tizio e Primo.<br />
Tizio vuole inoltre legare all'amico Caio il <strong>di</strong>ritto a pretendere dai suoi ere<strong>di</strong> la stipulazione <strong>di</strong> un contratto <strong>di</strong><br />
mutuo gratuito, avente ad oggetto la somma <strong>di</strong> 100.000 euro.<br />
Infine, Tizio vuole legare a Mevio il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> pegno sulla collezione <strong>di</strong> quadri che si trova nella sua villa <strong>di</strong><br />
Ostia, a garanzia del cre<strong>di</strong>to <strong>di</strong> euro 200.000 che Mevio vanta nei suoi confronti.<br />
Il can<strong>di</strong>dato assunte le vesti del notaio, re<strong>di</strong>ga il testamento dopo aver motivato adeguatamente le soluzioni<br />
adottate.<br />
Tratti, in parte teorica del legato del contratto <strong>di</strong> mutuo e del legato <strong>di</strong> pegno.<br />
- Legato in conto <strong>di</strong> legittima;<br />
- Legato <strong>di</strong> cosa altrui;<br />
- Legato <strong>di</strong> cosa non esistente nell’asse;<br />
- Disposizioni testamentarie mo<strong>di</strong>ficative del rapporto obbligatorio;<br />
- Legato <strong>di</strong> somma <strong>di</strong> danaro;<br />
- Legato <strong>di</strong> contratto;<br />
- Legato <strong>di</strong> pegno.<br />
B) Correzione 6° esercitazione a casa