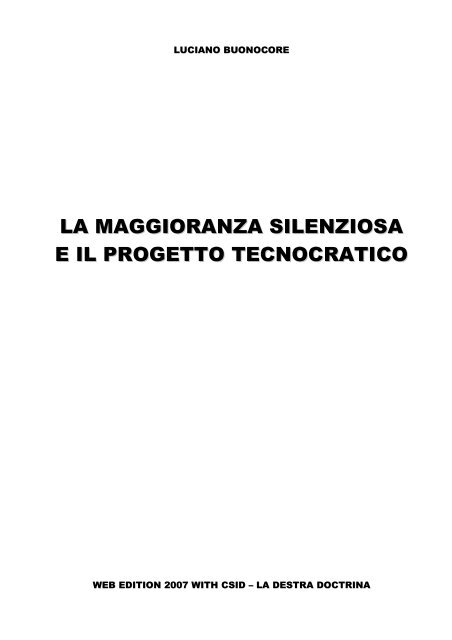LA MAGGIORANZA SILENZIOSA E IL ... - Destra Libertaria
LA MAGGIORANZA SILENZIOSA E IL ... - Destra Libertaria
LA MAGGIORANZA SILENZIOSA E IL ... - Destra Libertaria
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
LUCIANO BUONOCORE<br />
<strong>LA</strong> <strong>MAGGIORANZA</strong> <strong>S<strong>IL</strong>ENZIOSA</strong><br />
E <strong>IL</strong> PROGETTO TECNOCRATICO<br />
WEB EDITION 2007 WITH CSID – <strong>LA</strong> DESTRA DOCTRINA
<strong>LA</strong> <strong>MAGGIORANZA</strong> <strong>S<strong>IL</strong>ENZIOSA</strong> E <strong>IL</strong> PROGETTO TECNOCRATICO<br />
di Luciano Buonocore<br />
PREFAZIONE di Maurizio Blondet<br />
<strong>LA</strong> PRIMA RIUNIONE: 1 Febbraio 1971<br />
INDICE<br />
NASCE <strong>IL</strong> COMITATO CITTADINO ANTICOMUNISTA<br />
<strong>LA</strong> PRIMA MANIFESTAZIONE: 13 Marzo 1971<br />
LE ACCUSE DE “<strong>IL</strong> MONDO”<br />
UN SOCIALISTA CHIEDE DI ADERIRE AL C.C.A.<br />
PROVOCAZIONE E DISORDINI: 17 Aprile 1971<br />
UNA DELEGAZIONE IN PAR<strong>LA</strong>MENTO<br />
<strong>LA</strong> TERZA MANIFESTAZIONE: 29 Maggio 1971<br />
EDGARDO SOGNO E <strong>LA</strong> <strong>MAGGIORANZA</strong> <strong>S<strong>IL</strong>ENZIOSA</strong><br />
LO SCIOPERO CONTRO <strong>IL</strong> “CORRIERE DEL<strong>LA</strong> SERA”<br />
DODICI ANNI DOPO<br />
LE PERSECUZIONI CONTRO I DUE PROTAGONISTI<br />
Il racconto di Luciano Buonocore<br />
Il racconto di Adamo Degli Occhi<br />
APPENDICE<br />
Alcune considerazioni sulla tesi di laurea della Dott.ssa E. Cattini<br />
Dalla TESI: Una esperienza originale della destra italiana: La Maggioranza Silenziosa (1971-1974)<br />
Neofascismo e destra radicale nella storiografia<br />
a) Un bilancio critico<br />
b) L’approccio al tema della “Maggioranza Silenziosa”<br />
Dal “fascismo storico” al “neofascismo”: quale continuità?<br />
a) Delimitazione e definizione della “destra radicale”<br />
b) I nuovi destinatari<br />
Per un intervento attivo<br />
a) Il programma di rinnovamento<br />
b)L’attacco al “Corriere della Sera”<br />
La battaglia giornalistica di “LOTTA EUROPEA”<br />
a) La politica interna<br />
b) Il concetto di “Unità europea<br />
c) Spiritualismo, antiegualitarismo e antimarxismo<br />
d) Il ruolo della cultura di destra<br />
e) La scuola e la contestazione<br />
f) La religione<br />
g) Le scienze<br />
NOTE<br />
Luciano Buonocore – La Maggioranza Silenziosa e il Progetto Tecnocratico 1
PREFAZIONE<br />
In tempi di riflusso, nulla sembra più lontano e passato che la vicenda della Maggioranza Silenziosa, consumatasi in<br />
anni di alta tensione ideologica. Gli autori di questa rievocazione (uno dei quali fu anche tra i protagonisti di quelle<br />
vicende), ritengono invece che quel passato abbia qualcosa da insegnare proprio ai giorni presenti. Questi nostri giorni<br />
degli ultimi anni ’80, segnati dalla vittoria dell’economia sulla politica (e della finanza sull’economia reale), su sogni<br />
privati di arricchimento e di successo (da cui l’emergere della figura, infinitamente stupida, del “bocconiano” come nuovo<br />
ideale giovanile), dell’effimero e dai vaneggiamenti sub-ideologici di ecologisti e verdi, dagli affarismi partitici e<br />
lottizzatori, da arroganze supercapitalistiche sopportate senza reazione, insomma dal rincretinimento illimitato di masse<br />
e di élites, vedono tuttavia in atto un conflitto surrettizio: un conflitto che - come prima approssimazione - possiamo<br />
indicare tra “l’ideologia piemontese”, tecnocratica e supercapitalistica, laicista, illuminata e, nel fondo, antiitaliana, e<br />
un’ideologia nazionale (non nel senso di nazionalista, ma di radicata nel terreno della nazione) e popolare (progressista,<br />
senza essere rivoluzionaria; rispettosa elle varietà e delle diversità delle “anime” realmente presenti in Italia), che tuttavia<br />
stenta a trovare piena coscienza di sé. Proprio nello sfilacciamento culturale e nella degradazione civile di questi anni, nel<br />
loro clima di apparente conciliazione (che tuttavia non potrà essere eterno: nel mondo giovanile e nel lavoro si stanno<br />
accumulando tensioni che finiranno per giungere alla soglia di rottura), il conflitto in atto rischia di passare inosservato,<br />
con i suoi pericoli e le sue possibilità.<br />
Ma andiamo per ordine. Che cosa fu la Maggioranza Silenziosa? Fu essenzialmente il chiamare a raccolta la gente –<br />
gente comune, si badi – che era consapevole dell’avanzata del “compromesso storico” tra DC e PC, e voleva opporsi al<br />
disegno gramsciano di economia comunista sulla società italiana, conquistata ipocritamente attraverso la maschera<br />
legalitaria fornita al progetto della Democrazia Cristiana. La gente che si mobilitò sotto i tricolori della maggioranza<br />
silenziosa accorse da diversi partiti (ci furono i missini, ma anche liberali, repubblicani, socialdemocratici, cattolici)<br />
mostrando che il discrimine attraversava orizzontalmente tutto il sistema partitocratico – che così si manifestava<br />
parzialmente artificiale. Fu promosso da giovani (per lo più militanti di vari partiti), ma ad esso aderirono generazioni<br />
più anziane; nacque a Milano, città della borghesia più fattiva e delle pluri-culture economiche, la città della grande<br />
immigrazione e del Movimento Studentesco, la città da cui storicamente sono partiti movimenti che hanno cambiato e<br />
possono davvero cambiare il corso della storia nazionale, la città-propulsore, il che esclude che i movimenti che in essa<br />
nascono, buoni o cattivi, siano fenomeni marginali o di pura reazione.<br />
Va inoltre detto che la Maggioranza Silenziosa si oppose al compromesso storico non, come altri preferirono fare, con<br />
trame, società segrete, strategie della tensione: fece appello all’opinione pubblica, riempì le piazze (non corridoi del<br />
Palazzo), mobilitò forme di disobbedienza civile: un esempio per tutti, il successo dello “sciopero del Corriere”, quando i<br />
milanesi rifiutarono di acquistare il Corriere della Sera, su invito dei promotori del movimento, giudicandolo troppo filocomunista.<br />
Se oggi, passati gli anni, nella mitologia corrente la Maggioranza Silenziosa continua ad essere catalogata<br />
come un fenomeno “neofascista”, ciò si deve alla macchina propagandistica che fu messa in atto dai partiti maggiori per<br />
criminalizzare e squalificare il movimento. Per il PCI, ma soprattutto per la DC, era troppo evidente il pericolo mortale<br />
rappresentato da un movimento civile, persino “di massa”, che incrinava orizzontalmente la coesione degli apparati<br />
politico-burocratici della partitocrazia artificiale, radunava gente prima divisa sotto bandiere diverse, e lo faceva su<br />
parole d’ordine non previste dalle truffaldine “regole del gioco” preparate dai vertici per loro tornaconto.<br />
Ma il braccio armato della reazione anti-Maggioranza fu fornito dal PSI (allora accodato agli interessi del PCI), e anche<br />
dall’estremismo extra parlamentare. Quest’ultimo fu lanciato a sloggiare con la violenza la borghesia fattiva e civile di<br />
Milano, che alla Maggioranza Silenziosa guardava con simpatia, dai suoi “luoghi deputati” (La Scala, il Corriere, il Circolo<br />
della Stampa) dove, spesso fin dal Risorgimento, essa si aggregava, si frequentava e si formava l’opinione. Il PSI (a<br />
Milano rappresentato allora da Aldo Animasi) si accollò il compito della persecuzione politica, ovviamente in nome della<br />
“Resistenza” e dell’”antifascismo”, che era collante della collusione verso il compromesso storico e la foglia di fico al<br />
riparo della quale esso poteva essere compiuto. Una magistratura serva compì l’opera con la persecuzione legale dei<br />
promotori del movimento, accusati di tutta una serie di atroci delitti “di marca fascista” da cui poi, parecchi anni dopo,<br />
furono riconosciuti innocenti. Era una coalizione di poteri formidabile, quella che si levò contro il movimento: una<br />
coalizione che aveva al suo servizio la magistratura e la stampa, la polizia e il sindaco, gli “intellettuali” e gli apparati dei<br />
partiti. E tutto, per schiacciare qualcosa che era stato suscitato, in fondo, da pochi giovani inesperti.<br />
Ma tuttavia, qualcosa resta di quell’esperienza sconfitta. Resta la dimostrazione del fatto che fu possibile, in Italia,<br />
raccogliere la gente in forma di popolo – ossia al di là delle militanze ideologiche di ciascuno, lacerando orizzontalmente<br />
le solidarietà di partito, superando la divisione “in gruppi minimi fra loro separati e ostili” a cui si è ridotta la convivenza<br />
civile in Italia – per scongiurare un pericolo estremo, chiaramente avvertito e descritto. Perché quell’esperienza è da<br />
ricordare oggi, alla fine degli anni ottanta? Perché proprio oggi cresce occultamente, favorita dalla comune nausea per la<br />
lotta politica (di cui porta gravissima responsabilità l’estrema sinistra violenta e terroristica), dai trionfi dell’economia,<br />
dal rincretinimento culturale e dal vuoto di potere permanente creato dall’esterna rissa dei partiti di governo, un nuovo<br />
tipo di disegno antidemocratico. Stavolta i protagonisti non sono DC e PCI tramanti un “compromesso storico”: è invece<br />
la Grande Industria – più chiaramente: l’enorme complesso di potere economico-finanziario che fa capo al gruppo<br />
Agnelli – a tendere le sue mani sulla società italiana. E’ un sogno annoso, che risale almeno ai Sessanta, a quel progetto<br />
Valletta che intese “ integrare cultura con i bisogni dell’amministrazione industriale”, e a quel saggio finanziato dalla<br />
Fondazione Il Mulino, sul “bipartitismo imperfetto”, che si proponeva di deideologizzare i due partiti maggiori, la “chiesa<br />
laica” comunista e la “chiesa” democristiana, per renderli – al modo anglosassone – maschere intercambiabili di una<br />
dirigenza reale e occulta costituita dal potere economico tecnocratico. La Fiat infatti è più che una grande impresa: è<br />
un’ideologia del dominio, un progetto di aziendalizzazione del Paese. Scuola, Università, stampa, cultura, ciascun<br />
cittadino, come lavoratore e come consumatore, e come lavoratore-consumatore, deve diventare appendice della<br />
Fabbrica Totale, l’Italia deve diventare radicalmente dipendente dalla Fiat. Tale ideologia ha radici antiche: è l’ultima<br />
Luciano Buonocore – La Maggioranza Silenziosa e il Progetto Tecnocratico 2
propaggine di quella che Marcello Veneziani ha chiamato l’”ideologia piemontese”, facendola iniziare da Cavour e dalla<br />
sua politica di “piemontesizzazione d’Italia”, e continuare in Giolitti “che spegne gli ultimi afflati risorgimentali nella<br />
pratica amministrativa”, fino a Valletta che vide il Sud come una colonia e un serbatoio di manodopera per la Fabbrica.<br />
Quest’ideologia piemontese ha una sinistra organica: che, attraverso Olivetti e la sua utopia tecnocratica totalizzante<br />
(l’azienda come unico vero centro di vera cultura e politica) si unisce a Gobetti “padre dell’antifascismo torinese e autore<br />
della Rivoluzione liberale”, e di lì a Gramsci, che a Torino “bagna il bolscevismo nella cultura laico-illuminista francese”,<br />
fino a Vittoriani “che coniuga marxismo e americanismo nella cosiddetta cultura industriale”. Rappresentata idealmente<br />
dalla parabola che va da “Einaudi padre, fondatore del liberalismo, a Einaudi figlio banditore del radicalismo<br />
progressista”, la filiazione-collaborazione fra “destra” e “sinistra” tecnocratica culminò nella scuola del Partito d’Azione e<br />
nell’antifascismo laico”, in cui lavorarono a fianco a fianco comunisti in doppiopetto come Amendola e Spinelli, e<br />
finanzieri e maggiordomi del supercapitalismo come Cuccia, La Malfa, Mattioli, Merzagora, Malagodi. Su questo<br />
“antifascismo” bisogna intendersi. Esso vedeva nel fascismo null’altro che il concentrato dell’Italia popolare, e per essi<br />
barbara, “della retorica e della religione secolare e ultraterrena”, l’Italia passatista e parolaia che è anche – piaccia o meno<br />
– la vera Italia, di cui i vizi sono anche la parte oscura e ineliminabile delle sue virtù, della sua prodigiosa vitalità e<br />
inventiva, della sua spontaneità e pazienza, della sua capacità di risorgere dalle sciagure. A quest’Italia vera, i tecnocrati<br />
vogliono da sempre sostituire un’Italia immaginaria “laica e liberale, moderna e civile”.<br />
E, beninteso, asservita agli interessi del profitto economico: l’Azienda Italia, secondo la metafora burocratica e pecorina<br />
di Giovanni Spadolini. Oggi, inverno del 1987, quel disegno sembra vicinissimo a compiersi. Con arroganza assoluta, la<br />
Grande Industria sta conquistando tutti gli spazi del potere. Possiede la stampa. Accentra attività economico-finanziarie<br />
in un impero di un’estensione mai vista in Italia. Umilia le figure di imprenditori non omogenee al progetto, sorte nei<br />
brevi ani della deregulation economica. Rafforza il suo potere di filtro all’entrata nell’attività dell’imprenditore,<br />
controllando i mezzi finanziari (come da sempre ha fatto attraverso Mediobanca), e umilia i lavoratori abbandonati dallo<br />
smarrimento del sindacato. Non le resta che creare un governo politico da manovrare in vista dei suoi interessi: e in<br />
questa prospettiva ha già potenti alleati. Può contare sull’area laicizzata e acattolica della DC, ideale macchina vuota del<br />
potere da riempire di ideologia tecnocratica, che può passare per “moderata” e “neutrale”; e ancor più, può contare<br />
sull’ala perbenista del PCI che, da Amendola a Napolitano, giunge fino ad Occhetto. Orfani del “compromesso storico”,<br />
questi comunisti rappresentano l’anello debole della resistenza a tale strategia. Il successo dell’economia capitalista li ha<br />
resi dubbiosi sulle speranze di palingenesi rivoluzionaria; resta loro il leninismo, inteso come tecnologia per la presa e<br />
conservazione del potere, un’esperienza di controllo e di agitazione delle masse lavoratrici; oltrechè, ovviamente, una<br />
voglia di potere tanto più sconfinata in quanto più cinica, ossia più legittimata ideologicamente. A costoro, oltretutto<br />
succubi dell’”illuminismo” gramsciano e del suo culto della “modernità”, la Grande Fabbrica offre un ruolo: quello di<br />
compartecipare al potere e al disegno “razionalizzatore” come “controparte”, in realtà come servizio d’ordine, secondini e<br />
poliziotto della forza-lavoro. Le possibilità di accordo permanente tra la Fiat e questa corrente elitaria e ormai<br />
antipopolare del PCI, collaudato da decenni di rapporti sindacali privilegiati, è del resto agevolato da una consonanza<br />
ideologica che ai più sfugge. Nella ideologia Fiat la sola “realtà”, la sola che conti, è la dinamica economica d’impresa;<br />
tutto il resto – le convinzioni morali, le solidarietà familiari, naturali e di classe, i valori religiosi, le altre ideologie – non<br />
sono che “nodi” che inceppano il buon funzionamento dell’impresa, che impediscono alla società italiana di essere ridotta<br />
a puro aggregato di forza di lavoro e di mercato di consumo; il lavoratore che risparmia per far studiare i figli, per<br />
costruire una casa alla sua famiglia, o perché i suoi valori gli vietano di sprecare in consumi frivoli il denaro sudato, non<br />
cambia l’automobile con le frequenza che pare necessaria alla Fabbrica. Egli, secondo l’ideologia Fiat, è vittima di<br />
“sovrastrutture” ideali che gli impediscono di servire bene la “struttura”, l’unica verità, che è il Consumo-Produttivo-di-<br />
Profitto. E’ appena il caso di notare che questo aspetto dell’ideologia Fiat ne fa un materialismo dialettico, amputato<br />
tuttavia della speranza “religiosa” (nell’avvento di una società di eguali) che vi aveva innestato Marx. Ma anche il PCI ha<br />
da tempo rinunciato a credere a quello sbocco: e Del Noce ha ben notato che, senza quelle speranze palingenetiche, il<br />
marxismo diventa “spirito borghese allo stato puro”. In questa forma purificata di spirito borghese l’incontro di PCI e<br />
Grande Industria diventa inevitabile.<br />
A meno che…A meno che qualcosa non sappia contrastare un simile sbocco verso un capitalismo totalitario, verso il<br />
controllo assoluto del potere economico sull’intera società. Intendiamo una chiara consapevolezza politica, che abbia i<br />
mezzi, e sappia adoperarli, per fare quello che i promotori della Maggioranza Silenziosa tentarono con minor fortuna:<br />
l’appello al popolo contro il progetto totalizzante. Mobilitare le forze reali, spontanee e tradizionali, che nella società<br />
italiana non sono omogenee all’ideologia piemontese. Quest’Italia delle legittime diversità, l’Italia molteplice e variegata<br />
che viene minacciata di omologazione e di falsificazione dal Progetto, esiste: ma non ha rappresentanza politica. E’<br />
un’Italia che in qualche modo si fida ingenuamente (ma con sempre maggior disperazione) dei partiti tradizionali. E’<br />
dunque un’Italia guidata in ordine sparso verso miopi vittoriette e ridicole sconfitte, troppo disunita e inconsapevole per<br />
essere una forza storica. Sono i cattolici popolari insoddisfatti della DC modernizzante, sono i lavoratori che si<br />
riconoscono nel partito comunista,e che i dirigenti del partito svendono, è la gente “di destra”, in certo senso “nostalgica”<br />
del fascismo in quanto destra popolare, il cui peso politico è stato obliterato da un partito “neofascista” che si è appagato<br />
ed ha appagato i suoi militanti di simboli saluti romani, tenendoli così lontani dal “pericolo” (pericolo per gli altri,<br />
beninteso) rappresentato dalla nascita di una forza nazionale e popolare progressiva, moderata come fu moderato – cioè<br />
adeguato alla situazione storica – il fascismo ai suoi tempi. Sono, anche, gli imprenditori che giustamente temono di<br />
doversi fare sudditi del Padrone Totale, anche se apparentemente è uno d loro. Sono i nuovi socialisti di Craxi. In breve,<br />
sono realtà che si trovano in ogni partito e in ogni schieramento: perché queste realtà si fondano, occorre che i gusci dei<br />
partiti e degli schieramenti vengano spezzati.<br />
Ma, si capisce, oggi il compito può meno che mai riuscire a giovani inesperti. E’ il compito ambiziosissimo e rischioso a<br />
cui dovrebbe sentirsi pari un leader politico di un’organizzazione in qualche modo già esistente, il leader di un partito di<br />
media forza che senta il bisogno di rompere gli schieramenti tradizionali per diventare più grande, di attrarre a sé altre<br />
forze e altre persone, di convincerle a fare assieme qualcosa, nel rispetto delle diversità, contro il pericolo comune. Questa<br />
Luciano Buonocore – La Maggioranza Silenziosa e il Progetto Tecnocratico 3
prova fu già tentata, con ventennale successo, da Mussolini: la cui azione può anche essere vista come una fortunata<br />
battaglia dell’Italia nazional-popolare contro l’illuminismo laicista, e in definitiva come una riaffermazione d’egemonia<br />
della Politica (con la P maiuscola, in questo caso) sulla Finanza, dell’Italia sull’Anti-Italia. Ovviamente, per questo l’idea<br />
stessa del fascismo è stata demonizzata, e questo rende le cose più difficili. Ma il compito che abbiamo indicato<br />
sommariamente ha natura storica: ciò significa che ad esso, in qualche modo, non si può sfuggire impunemente. Il partito<br />
e il leader che ad esso siano chiamati, se vi si rifiutano, si condannano all’eterna rissa miseranda, nel quadro di una<br />
sovranità limitata compensata da furtarelli tollerati e da posti retribuiti nell’apparato pubblico; insomma, al solito piccolo<br />
brigantaggio, sul quale può essere fatto pesare a piacere il richiamo alle “regole del gioco”, il ricatto dei processi<br />
manipolati per malversazione e corruzione da parte dell’unico potere dell’autodefinizione “incorruttibile”: quello<br />
dell’Efficienza negli Affari. Di partiti che, in quanto non sradicati dalle radici nazional-popolari, i fatti candidano a questo<br />
compito, in Italia ce ne sono almeno due: in parte hanno già sprecato occasioni. Ma cresce anche la consapevolezza<br />
politica del pericolo e del nemico, e questo dà speranza.<br />
<strong>LA</strong> <strong>MAGGIORANZA</strong> <strong>S<strong>IL</strong>ENZIOSA</strong> (1971-1974)<br />
Maurizio Blondet<br />
<strong>LA</strong> PRIMA RIUNIONE: 1 Febbraio 1971 La sera del 1° febbraio 1971 – una fredda sera di sabato – a Milano, nella sede<br />
del Partito democratico di Unità Monarchica in corso Genova 26, ha luogo una insolita riunione. Gli invitati – o i<br />
convocati – sono una dozzina di giovani, rappresentanti di gruppi giovanili o di organizzazioni giovanili di partiti politici.<br />
Luciano Buonocore, 25 anni ancora da compiere, è il dirigente nazionale del missino “Fronte della Gioventù”, Gabriele<br />
Pagliuzzi, presidente provinciale giovanile del partito Liberale, è stato mandato lì dal suo “collega” nel partito, Massimo<br />
De Leonardis. Ha l’incarico di “vedere quel che succede e riferire”; in ogni caso , si presenta a titolo personale. “A titolo<br />
personale” è presente anche Pasqualino di Marineo, democristiano con simpatie monarchiche; A rappresentare i “giovani<br />
monarchici” sono Giampaolo Landi e Cristiano Fiore. Elena Manzoni è lì come rappresentante del circolo “Jan Palach”;<br />
Franco Nodali e Franco Formenti rappresentano i “Bocconiani indipendenti”, un gruppo studentesco che riunisce giovani<br />
di idee liberali; e c’è anche Priori, di “Nuova Gioventù Liberale”. Bruno Sebastiani interviene per il gruppo tradizionalista<br />
“Alleanza Cattolica”; Giorgio Muggiani, per il “Comitato Tricolore”. Il più anziano è Nava, del “Nucleo Genitori<br />
Anticomunisti”. Sono tutti giovani di destra o di centro-destra, il che non esclude che fra loro ci siano differenze e<br />
diffidenze puntigliose. Non tutti si conoscono l’un l’altro, ma hanno qualcosa n comune: i sentimenti anticomunisti,<br />
l’inesperienza politica e la volontà, magari confusa, di “far politica”. A questo proposito anche indubbie qualità: i mesi che<br />
seguiranno consentiranno loro di esplicare le loro capacità. Una cosa è certa: dietro questi giovani non c’è nessun “grande<br />
vecchio” che si dia la pena di manovrarli. L’iniziativa di riunirli è partita da uno di loro, Giampaolo Landi, di Chiavenna –<br />
del PDIUM – che ha mandato a ciascuno una lettera di invito. Il testo della lettera, che non era destinato a passare alla<br />
storia, è perduto. Chi l’ha ricevuta ricorda però, vagamente, che essa agitava l’idea di riunire i rappresentanti di<br />
movimenti giovanili, che avessero come denominatore comune l’anticomunismo, per “lottare insieme contro la violenza”.<br />
Il clima di quei giorni dava alle lettere di Landi un significato d’urgenza, almeno per i giovani a cui s rivolgeva. Da mesi<br />
essi subivano in prima persona quella vastissima, concertata, non contrastata opera di violenza con cui comunisti e<br />
militanti di estrema sinistra andavano prendendo letteralmente possesso di Milano, esercitando una presenza minacciosa<br />
nelle fabbriche, nelle scuole e nelle piazze, volta a intimidire e a paralizzare chiunque non la pensasse come loro. Vi sono<br />
fabbriche a Milano, i cui nomi fra poco diventeranno tristemente famosi come luoghi di sanguinose imprese delle Brigate<br />
Rosse, dove già si è solidamente instaurato un clima di terrore. Alla Sit-Siemens, il 27 novembre 1970, “Lotta Continua”<br />
ha distribuito un volantino di minacce contro lavoratori non comunisti, di cui fa nomi e cognomi, e a cui promette “lotta<br />
dura”. Il 2 dicembre, entrano nella fabbrica elementi estranei che picchiano, inguriano e trascinano fuori l’ingegner<br />
Danilo Briani. All’Alfa Romeo già nel novembre ’69 un operaio, Angelo Peati, che rifiutava di partecipare a uno sciopero,<br />
è stato selvaggiamente pestato e ridotto in fin di vita. Nello stabilimento dell’Alfa le percosse, le minacce, i disordini e gli<br />
arresti del lavoro sono all’ordine del giorno, orchestrati da gruppi tracotanti di estremisti, tra cui spicca Andrea Banfi,<br />
figlio del senatore Arialdo Banfi del PSI, un laureato in filosofia che è riuscito a farsi assumere come operaio. Il 23<br />
novembre 1970 dirigenti dell’Alfa sono sequestrati. 26 novembre: alla Borletti, impiegati vengono aggrediti ed espulsi<br />
dalla mensa aziendale. 27 novembre: alla Loro Parigini viene pestato un sindacalista non comunista, Francesco Ongetta.<br />
7 dicembre: uno stampato del consiglio di fabbrica della Breda dà ordine di vietare con ogni mezzo a lavoratori “borghesi”<br />
e “fascisti” di prestare la loro opera nell’azienda. 9 dicembre: alla Snia-Viscosa viene ingiuriata e malmenata una<br />
sindacalista, Angela Currò. 24 marzo 1971: un altro lavoratore, Leo Lenzo, è picchiato da attivisti comunisti alla “Ponteggi<br />
Dalmine”. Incendi dolosi vengono provocati alla Pirelli e all’aeroporto di Linate. La situazione è minacciosa anche nelle<br />
scuole e nelle strade di Milano. Non passa un sabato senza che il centro della città venga invaso da minifestanti di<br />
sinistra, militanti del Movimento Studentesco, di Lotta Continua, di Avanguardia Operaia e via dicendo, che sfilano in<br />
cortei armati con caschi, spranghe, tascapani pieni di pietre. Questi cortei provocano spesso danni alle cose e alle<br />
persone, e passano alla violenza franca e diretta, ingaggiando scontri con la polizia. Nel novembre del 1969, durante una<br />
di queste manifestazioni inscenate dal Movimento Studentesco, resta ucciso l’agente di P.S. Antonio Annarumma. Il 12<br />
dicembre, in uno scontro simile, perde la vita uno studente, Saverio Saltarelli. Il 22 dicembre 1970 il prefetto Libero<br />
Mazza ha scritto al Ministro degli Interni, Restivo, un rapporto in cui valuta in ventimila il numero degli estremisti<br />
inquadrati nei gruppuscoli di sinistra, forniti di “equipaggiamento e armamento che può definirsi paramilitare: servizio<br />
medico, collegamento radio fra i vari gruppi, sevizio di intercettazione radio della polizia, elmetti, barre di ferro, fionde,<br />
bottiglie Molotov….” I cortei e le manifestazioni messe in atto da queste squadre “sono spesso l’occasione per turbare<br />
profondamente la vita della città. Compiere atti vandalici con gravi danni alle proprietà pubbliche e private, limitare la<br />
libertà dei cittadini e dileggiare i pubblici poteri”.<br />
E’ una descrizione di una realtà che ogni cittadino di Milano ha sotto gli occhi: ma il rapporto Mazza dorme sul tavolo<br />
del Ministro (sarà rivelato da un giornale quattro mesi più tardi), socialisti e comunisti prendono apertamente le difese<br />
Luciano Buonocore – La Maggioranza Silenziosa e il Progetto Tecnocratico 4
degli estremisti rossi e della loro violenza. L’Unità del 25 febbraio1971 nega che il servizio d’ordine armato del Movimento<br />
Studentesco sia “un corpo paramilitare”. “I caschi” calzati dal servizio d’ordine del M.S. sarebbero “un modesto mezzo di<br />
protezione” contro le aggressioni dei “fascisti”. Bisogna respingere l’attacco che si delinea contro il Movimento<br />
Studentesco “per la linea responsabile, unitaria, di collegamento con le masse popolari che esso va sostenendo”.<br />
Dall’orrenda strage di piazza Fontana, dicembre 1969, la sinistra giustificava così ogni eccesso ed ogni intemperanza:<br />
come la necessità imposta dalla “vigilanza antifascista”, “strage fascista”, era stato definito l’eccidio, fin dal primo giorno.<br />
Ma, al contrario, non c’era moderato che non fosse sicuro che quella strage portava un’etichetta di sinistra. Il fatto che i<br />
“progressisti” e gli “antifascisti” di ogni specie gridassero invece alla “strage fascista”, senza prove, senza l’ombra di un<br />
indizio, appariva ai cittadini di sentimenti moderati come una volontà provocatoria di sollevare polvere, per coprire i veri<br />
colpevoli. Non era stato arrestato Valpreda, riconosciuto dal tassista – il comunista Rolandi – come l’uomo che si fece<br />
portare alla Banca dell’Agricoltura di piazza Fontana mezz’ora prima della strage? Non avevano scritto i giornali che<br />
l’editore di sinistra Giangiacomo Feltrinelli s’era dato alla clandestinità 3 giorni prima della tragica bomba? E poche ore<br />
prima della strage un suo cognato, Carlo Melega, non aveva forse annunciato in un bar che l’indomani “si sarebbero lette<br />
sui giornali notizie tremende”? Pochissimi in Italia, anche fra quelli che gridavano alla strage “fascista”, avrebbero potuto<br />
spiegare con chiarezza la trama, a tutt’oggi in parte oscura, chetava dietro ai fatti. Tutti però sentivano che ai vertici, tra le<br />
stesse forze di governo, era in atto uno scontro sotterraneo senza esclusione di colpi. Grosso modo, si potevano descrivere<br />
le cose così: fino alla strage di piazza Fontana s’erano manifestate, e per un momento erano sembrate prevalere, certe<br />
forze che pareva mirassero a interrompere l’esperienza del centro-sinistra, che aveva portato al Paese difficoltà<br />
economiche, crisi politiche e un clima di scontro sociale, per tornare a forme di governo più moderate: queste forze<br />
facevano in qualche modo capo al Capo dello Stato, il socialista e poi socialdemocratico Giuseppe Saragat. Al suo partito e<br />
a certe correnti democristiane (il Ministro degl’Interni Restivo e l’Andreotti di allora). Ma dopo la strage questa parte era<br />
in difficoltà; prevaleva invece una tendenza, riconducibile nella DC a Moro e alla sinistra DC (Donat Cattin, Galloni), che<br />
puntava su “equilibri più avanzati”, a forme di governo o di collaborazione assai vasta con le forze di sinistra, non esclusi i<br />
comunisti. Una potente coalizione, rappresentata nei partiti, in certe forze economiche, nei giornali, collaborava a questo<br />
progetto mai chiaramente espresso: il denominatore comune che queste forze avevano scelto era quello<br />
dell’”antifascismo” e della “vigilanza” ed “unità” antifascista. Era il vecchio spirito del CLN e del Partito d’Azione che<br />
veniva artificialmente resuscitato, con il suo armamentario retorico e propagandistico.<br />
Nell’”Unità antifascista”, ben inteso, ogni forza trovava il suo tornaconto. Il massimalismo dei socialisti, dominati allora<br />
dalla sinistra, vi trovava le sue gratificazioni. Certe correnti democristiane vi trovavano una sorta di alibi per la loro<br />
corruzione e incapacità, una sorta di legittimazione del loro lungo governo, una specie di attenuazione dell’opposizione<br />
dei comunisti, che in qualche modo, in nome dell’antifascismo, venivano resi complici. Ma soprattutto era il PCI che, in<br />
nome dell’unità antifascista, poteva sperare di essere introdotto, grazie alle sue indubbie benemerenze “storiche”,<br />
nell’area del potere. In questo clima, i gruppi dell’ultrasinistra – Lotta Continua, Potere Operaio, Avanguardia Operaia e<br />
altri – si prestavano a farsi braccio armato della “vigilanza antifascista”, creando nelle città un’atmosfera di scontro civile.<br />
La gente, a Milano, assisteva a questa manifestazioni muta, con sentimenti indecifrabili. Era diffusa la sensazione che<br />
aggressioni e violenze, non debitamente represse, fossero gradite se non addirittura volute dai centri del potere; a Milano<br />
come a Roma una certa ricca borghesia, detta radical-chic, che si pretendeva progressista e il cui esponente simbolico era<br />
Giulia Maria Crespi proprietaria del Corriere della Sera, simpatizzava apertamente con l’estremismo rosso. Ma se questa<br />
parte rappresentasse “tutta” la borghesia attiva e concreta, era tuttavia dubbio.<br />
Comunque chi si opponeva in questi anni, anche fisicamente, alla prepotenza del fronte della sinistra erano i giovani del<br />
Fronte della Gioventù. Questi avevano la loro sede al primo piano di uno stabile di corso Monforte, in pieno centro di<br />
Milano. Non vi era sabato pomeriggio che la loro sede non venisse assalita con lanci di bottiglie Molotov e pietre dai<br />
gruppuscoli della sinistra extraparlamentare. Segretario giovanile del Fronte era Luciano Buonocore. Questa era, la sera<br />
in cui nella sede monarchica si riunivano i giovani militanti moderati e di destra, la situazione generale. A soffrirne di più<br />
erano i missini, la cui gente subiva emarginazioni e percosse; per questo motivo, essi erano anche i più consapevoli che<br />
dietro il ritornato atteggiamento “ciellinistico”, di cui essi erano le prime vittime, era sotteso un disegno politico che li<br />
allarmava. Per questo, quel 1° febbraio 1971 fu Luciano Buonocore, il dirigente nazionale del Fronte della Gioventù<br />
presente alla riunione, a porre, come condizione preliminare per poter partecipare ad ulteriori discussioni, che i presenti<br />
rinunciassero a quella che lui chiamava “la pregiudiziale antifascista”. L’equazione “anticomunismo uguale fascismo” che<br />
si cercava di accreditare nella psicologia collettiva, spiegò brevemente, era un trucco buono per far entrare il PCI, che è<br />
senza dubbio il partito più “antifascista” di tutti, nell’area del potere. I presenti alla riunione volevano lottare contro<br />
questa ipotesi? Allora, era giocoforza che non solo ripudiassero, ma anche denunciassero il trucco dell’antifascismo.<br />
Dovevano accettare di agire accanto a giovani e missini militanti, senza timore di contrarre “impurità” psicologiche o<br />
politiche: del resto, questi giovani missini avrebbero partecipato a future azioni di “lotta anticomunista” a titolo<br />
personale, senza l’etichetta del partito. Le future azioni infatti, quali che fossero, avrebbero dovuto attraversare i confini<br />
dei partiti; avrebbero avuto il senso di un incontro tra libere persone, al di là delle muraglie ideologiche, per una difesa di<br />
principi e valori comuni.<br />
Su questi punti, la discussione fu lunga e talvolta aspra. “Ma fu anche molto aperta – dice adesso Buonocore – Eravamo<br />
tutti giovani senza pregiudizi ideologici e aperti a nuovi pensieri politici, non c’era fra noi nessuno che avesse vissuto la<br />
guerra civile: ci accorgemmo che fra noi, tra la nostra generazione, lo scontro “antifascista” non avesse senso”. Il primo ad<br />
aderire alla proposta di Buonocore fu Gabriele Pagliuzzi, liberale; uno dopo l’altro, tutti fecero lo stesso. I partecipanti<br />
furono d’accordo, anche sul fatto che ciascuno di loro era lì a titolo personale non implicava la responsabilità del partito<br />
di provenienza. Tutti, infine, convennero che “l’anticomunismo, la lotta alla violenza stalinista, dovevano essere il<br />
denominatore comune per l’azione politica da svolgere insieme”. Anche su quale dovesse essere la prima “azione<br />
comune” ci fu un accordo di massima: si trattava di organizzare una manifestazione anticomunista, che facesse da<br />
contraltare alle minacciose manifestazioni di piazza “antifasciste”. Ciò avrebbe permesso di contare e di far pesare quella<br />
parte della popolazione, che i convenuti avevano motivo di credere maggioritaria, che guardava con allarme e ostilità al<br />
progetto di “unità antifascista”, preludio al Compromesso Storico. Il gruppo rimandò ad una prossima riunione il<br />
Luciano Buonocore – La Maggioranza Silenziosa e il Progetto Tecnocratico 5
compito di delineare concretamente l’organizzazione della manifestazione, la preparazione dei documenti e la<br />
piattaforma politica. Poi tutti si salutarono ed uscirono nel freddo della notte, alzandosi il bavero dei cappotti. Il seme di<br />
quella che sarebbe stata chiamata la “Maggioranza Silenziosa” era stato gettato. Nemmeno coloro che l’avevano gettato<br />
sapevano quanto sarebbe presto cresciuto e, quanta violenza si sarebbe scatenata contro di loro, e per alcuni la<br />
repressione e l’arresto.<br />
NASCE <strong>IL</strong> COMITATO CITTADINO ANTICOMUNISTA<br />
Dopo quella prima ci furono, nel febbraio 1971, altre tre riunioni. Duole dire che non furono stesi veri e propri verbali;<br />
di quegli incontri abbiamo solo un sommario riassunto.<br />
Seconda riunione – nei locali del PDIUM di corso Genova 26 – 5 febbraio 1971. “Si sono riunite le seguenti persone:<br />
Buonocore – Pagliuzzi – Muggiani – Pasqualino – Manzoni – Fiore – Landi – Sebastiani – Nodali. E’ stato deciso di<br />
affidare a Gabriele Pagliuzzi la rielaborazione e la correzione di una bozza di manifesto, presentata dal Comitato Tricolore<br />
(Muggiani)”. In tale documento si sarebbe dovuto esprimere la linea politica di un nuovo gruppo, che nell’occasione<br />
assumeva la denominazione unanimemente concordata di “Comitato Cittadino Anticomunista per la Difesa della<br />
Libertà”. “Tale linea politica si concretizzava, specificamente, nel certificare alla cittadinanza la falsità dell’interpretazione<br />
che comunemente si dà alla teoria dell’”unità antifascista”, formula propagandisticamente patrocinata dall’estrema<br />
sinistra, la quale di fatto facilita le manovre di potere del PCI impedendo ogni legale e democratica reazione di tutti<br />
coloro che rifiutano la resa al comunismo”.<br />
Era nato così il “comitato Cittadino Anticomunista” che nei mesi seguenti avrebbe firmato decine di altri manifesti,<br />
avrebbe organizzato e diretto le manifestazioni della futura “Maggioranza Silenziosa”, e di essa sarebbe stata la “voce”<br />
politica. In quella stessa riunione Elena Manzoni, responsabile del centro “Jan Palach”, appartenente ad una nobile<br />
famiglia milanese, si assunse anche un compito preciso: si sarebbe messa in contatto con uomini politici e personalità del<br />
mondo economico di Milano, poi in ogni caso con figure “pubbliche” della città, per costruire un comitato di garanti che<br />
si assumesse la responsabilità di chiedere al Questore il permesso per la prima manifestazione. Vedremo fra poco quale<br />
fu il risultato di questa azione.<br />
Per il momento, occorre dare notizia della terza riunione, che si tenne il 22 febbraio seguente. Il laconico “riassunto<br />
verbale” in nostro possesso indica soltanto i nomi dei partecipanti (sono gli stessi dell’incontro precedente) e, sotto, reca<br />
la frase: “essi hanno approvato in linea generale il testo del manifesto e del volantino per la manifestazione ed hanno<br />
fissato nel 13 marzo la data stessa”. Il volantino in questione infatti, con il titolo “Manifestazione unitaria anticomunista”,<br />
reca la data del raduno di piazza: sabato 13 marzo, ore 16.30. Il testo dice:<br />
“Cittadini! Rifiutiamo il comunismo per la nostra libertà! Il disordine e la violenza alimentati<br />
dall’estrema sinistra hanno conquistato le nostre scuole ed i nostri luoghi di lavoro, distruggendo<br />
la pace sociale e la libertà della nostra vita civile.<br />
A questa situazione corrisponde la debolezza dei partiti governativi e l’inerzia dei pubblici poteri<br />
troppo spesso incapaci di garantire i diritti costituzionali di tutti i cittadini.<br />
Noi chiamiamo a manifestare compatte quelle persone che non accettano l’attuale clima di<br />
rassegnazione e di viltà politica.<br />
Oggi più che mai è necessario opporsi al pericolo comunista!<br />
Con questa manifestazione Milano deve dire il suo NO:<br />
1) all’inserimento del PCI nell’area governativa sotto le mentite spoglie di “partito d’ordine”;<br />
2) alle dilaganti violenze fisiche e morali che i satelliti del PCI compiono quotidianamente nelle<br />
scuole e nelle fabbriche protetti dalla faziosità di certa stampa filogovernativa e dei grandi organi<br />
pubblici d’informazione.<br />
Quella parte della città che non rinuncia alla lotta al comunismo, deve responsabilmente assumersi<br />
il fermo impegno di difendere la nostra libertà così gravemente minacciata”.<br />
Questa la bozza del volantino, che sarà definitivamente adottata e distribuita poi alla vigilia della prima manifestazione.<br />
Il suo tono dà un’idea dell’ottimismo combattivo che si respirava nel piccolo gruppo, piccolo quartier generale il cui<br />
seguito era tutto da verificare che si era battezzato “Comitato Cittadino Anticomunista”.<br />
Ma questa atmosfera rischiò di mutarsi di lì a due giorni, il 24 febbraio, quando Elena Manzoni, all’apertura della<br />
quarta riunione, riferì degli incontri avuti nel mondo politico cittadino. La Manzoni aveva avvicinato, chiedendo loro<br />
un’adesione formale alla manifestazione che il Comitato stava organizzando, il capogruppo democristiano a Palazzo<br />
Marino, Massimo De Carolis; il capogruppo del PDI Vittorio D’Ajello e il socialdemocratico Paolo Pilitteri; il consigliere<br />
comunale democristiano Giuseppino Bossi; l’avvocato Ludovico Isolabella. Tutti, pur condividendo l’iniziativa, si erano<br />
tirati indietro forse per timore di esporsi pubblicamente per un’azione politica sul cui successo dubitavano; e le ragioni<br />
del loro rifiuto dovevano avere in parte convinto persino Elena Manzoni la quale, a quel punto, proponeva che la<br />
manifestazione non si tenesse più. Su questo nacque una animata discussione. Buonocore era deciso a fare in ogni caso la<br />
manifestazione. “Tutt’al più – disse - si potrà allestire un Comitato “di garanti” non più formato da politici o da persone<br />
note, ma da gente rispettabile, sia pur senza grande significazione politica”. Franco Nodali era del parere opposto perché,<br />
visto il rifiuto delle persone con cui Elena Manzoni aveva parlato, “l’azione del Comitato era priva dei necessari supporti”;<br />
la Manzoni mantenne il suo atteggiamento di dubbio e di scetticismo. Quando a Landi e a Pagliuzzi, si schieravano dalla<br />
parte di Buonocore. Era questo il primo contrasto, dice Buonocore: “tra quelli che pensavano da una parte che lo “scontro<br />
anticomunista” dovesse svolgersi a livello di “vertice” e quelli che invece, come me Pagliuzzi e Landi, ritenevano<br />
necessario un coinvolgimento popolare nella lotta anticomunista”.<br />
Luciano Buonocore – La Maggioranza Silenziosa e il Progetto Tecnocratico 6
La riunione del 24 febbraio si concluse senza una decisione: fu stabilito di attendere, anche perché un’iniziativa simile a<br />
quella del Comitato era stata annunciata a Torino. Un’organizzazione che si era nominata “dei cittadini<br />
indipendenti”(OCI) aveva indetto una manifestazione anticomunista in piazza San Carlo, nel capoluogo piemontese, per<br />
il 7 marzo. Si decise che Pagliuzzi e Nodali si recassero a Torino per prendere contatti con gli organizzatori dell’OCI (in<br />
cui le personalità più in vista erano quella del liberale Vitaliano Peduzzi e del giornalista del “Borghese” Piero Capello), ed<br />
esaminare da vicino l’organizzazione e la riuscita della manifestazione. Il 7 marzo, a Torino, i due rappresentanti del<br />
Comitato milanese erano in piazza San Carlo ad assistere al più sconfortante dei comizi. L’Organizzazione Cittadini<br />
Indipendenti non era riuscita a richiamare in piazza più di 100 persone, la cui eterogeneità saltò all’occhio pochi minuti<br />
più tardi: i 100 raccogliticci finirono addirittura per prendersi a botte. Ad un certo punto, crollò perfino il palco alzato per<br />
gli oratori, dal quale il giornalista Piero Capello cercava invano di calmare gli animi, invitando alla concordia (3). Era una<br />
manifestazione da cui si potevano trarre solo cattivi auspici, e la sera stessa Pagliuzzi e Nodali ne riferirono al Comitato<br />
milanese, riunito nella sua sesta assemblea. Ma a Milano, nonostante i persistenti dubbi di alcuni, il Comitato era ormai<br />
entrato nella febbrile fase organizzativa: alla serata erano presenti un certo avvocato Jovine, l’avvocato Grezzi Perego,<br />
l’avvocato Piero Bianchi, il segretario del PDIUM, rag. Bertoni, il rag. Piero Cattaneo dei Centri Studio, persone che<br />
Buonocore aveva invitato, e che si impegnarono a chiedere alla Questura l’autorizzazione per la manifestazione da tenersi<br />
il 13 marzo. Era il “Comitato di garanti di non grande significazione politica” che Buonocore stesso aveva proposto nella<br />
riunione precedente. Erano pronti anche il manifesto e i volantini, ed era stato già delineato il percorso che il corteo<br />
avrebbe seguito: da piazza Oberdan, lungo corso Venezia, piazza San Babila e corso Vittorio Emanuele, fino a piazza del<br />
Duomo.<br />
Il resoconto dei fatti di Torino non raffreddò gli entusiasmi. “L’esempio di Torino non faceva testo – dice Luciano<br />
Buonocore – Là, il gruppo promotore aveva idee politicamente confuse, mancava di capacità organizzativa e, in più, era<br />
fatto di anziani che avevano vissuto la guerra civile, da una parte e dall’altra, del 1944 e ne portavano i segni. Noi eravamo<br />
giovani, e il nostro programma politico era chiaro: opporre all’unità “antifascista”, nata da accordi e complicità annodate<br />
ai vertici dei partiti, allo scopo di inserire il PCI nell’area del potere, una “unità anticomunista” fatta da cittadini di<br />
diverse idee politiche, che tagliasse orizzontalmente i partiti. Eravamo sicuri di esprimere così la volontà di molta gente,<br />
una volontà cui nessun partito dava voce e forza”. Doveva essere proprio così, perché v’erano a Milano ambienti influenti,<br />
cui non era sfuggita la nascita del Comitato, e che guardavano a quello con una curiosità pronta a trasformarsi in<br />
simpatia. “Una sera, dopo la settimanale riunione del Comitato – racconta Gabriele Pagliuzzi – io e Buonocore fummo<br />
invitati in via Ruffini a casa del padre di Franco Nodari, Corrado, un industriale milanese, e che aveva sposato una<br />
Gallarati Scotti. Con nostra sorpresa, ci trovammo in mezzo ad una quantità di persone importanti, a figure milanesi con<br />
nomi legati al risorgimento, le quali erano ansiose di porci delle domande, di studiarci da vicino per vedere fino a che<br />
punto eravamo disposti a fare sul serio, per capire meglio le nostre idee”. Tra in “nomi risorgimentali” spiccava il conte<br />
Filippo Jacini, che oltretutto era stato un membro del CNL Alta Italia ai tempi della liberazione; ma c’era anche Attila Du<br />
Chene de Vere, medaglia d’oro della Resistenza. C’erano il senatore liberale Bergamasco, e il senatore Noè della DC; c’era<br />
un certo Porta, che era stato un capo-partigiano, e molti altri che i protagonisti di questa storia non ricordano.<br />
La curiosità di questi personaggi, ed anche la loro diffidenza, si rivolgeva soprattutto a Luciano Buonocore, il giovane<br />
missino che – a quanto sapevano – era il promotore più attivo del Comitato. Furono serviti dolci e liquori. “Ma subito,<br />
quelle persone entrarono in argomento – dice Buonocore –. In sostanza il loro discorso fu assai chiaro: loro erano pronti<br />
ad aderire alla nostra azione, rinunciando alla pregiudiziale antifascista; ma a loro volta chiedevano, come condizione per<br />
la loro adesione, che noi vigilassimo perché la futura manifestazione non si trasformasse in una manifestazione missina.<br />
Niente saluti romani, niente parole d’ordine fasciste; solo tricolori”. Luciano Buonocore parlò con calore, dando le più<br />
ampie garanzie su quel che quelli chiedevano. “Mentre parlavo – ricorda Buonocore – nasceva in me un senso di<br />
esultanza. Il fatto stesso che fossero lì a sentirmi esponenti democristiani ed ex capi della Resistenza, pronti a mettersi<br />
dalla nostra parte, indicava che avevamo visto giusto: il nostro programma esprimeva un’esigenza molto sentita anche in<br />
ambienti estranei all’MSI; inoltre, la presenza lì di quelle persone era già prova che il “fronte antifascista” che vigeva nel<br />
Paese e che aveva resuscitato lo “spirito del CNL”, si poteva rompere. Anzi: era già rotto”. Non mancarono, naturalmente,<br />
le note stonate. Il senatore Noè offrì a Buonocore e Pagliuzzi l’iscrizione alla Democrazia Cristiana. I due giovani<br />
rifiutarono decisamente: “La nostra preoccupazione fondamentale era che la manifestazione partisse, e apparisse partire,<br />
non dall’interno di partiti politici, ma dalla cittadinanza. Doveva essere una manifestazione spontanea, in cui fosse<br />
esclusa l’egemonia di qualsiasi partito politico”. La serata si concluse in un clima di entusiasmo patriottico, quale da<br />
molto tempo non si vedeva a Milano. I signori aderirono al Comitato Anticomunista: le signore presenti si offrirono di<br />
tagliare e cucire bandiere e coccarde tricolori.<br />
Nei giorni, e soprattutto nelle notti seguenti, si videro i giovani dell’alta borghesia milanese, spesso titolari di cognomi<br />
storici, di personaggi che avevano “fatto” le Cinque Giornate, girare per la città, con colla e spazzola per attaccare i<br />
manifesti che invitavano la cittadinanza alla manifestazione. C’erano Franco e Maria Elena Nodali, Marco Dubini,<br />
rampollo di una nota famiglia di banchieri, il giovane Federico Falck, Riccardo Cairati Crivelli, Cristiano Fiore, Andrea<br />
Didier, Angelo Ruffo di Calabria e naturalmente molti altri, a decine. Quanto a Luciano Buonocore e a Gabriele Pagliuzzi,<br />
chiesero un appuntamento a Nino Nutrizio, direttore del quotidiano La Notte, e gli spiegarono il loro programma:<br />
Nutrizio garantì calorosamente il suo appoggio. Alla vigilia della manifestazione, furono distribuiti fra la gente i volantini<br />
il cui testo era stato approvato il 22 febbraio. Migliaia di manifesti furono affissi sui muri della città. Eccone il testo.<br />
“Cittadini, rifiutiamo il comunismo per la nostra libertà. Il disordine e la violenza alimentati dall’estrema sinistra hanno<br />
conquistato le nostre scuole e i nostri luoghi di lavoro, distruggendo la pace sociale e la libertà della nostra vita civile. A<br />
questa situazione corrisponde la debolezza ei partiti governativi e l’inerzia ei pubblici poteri, troppo spesso incapaci di<br />
garantire i diritti costituzionali dei cittadini. Noi chiamiamo a manifestare quelle persone che non accettano l’attuale<br />
clima di rassegnazione e di vita politica. Oggi più che mai è necessario opporsi al pericolo comunista”.<br />
Non mancarono le reazioni delle sinistre, e dei gruppuscoli rossi. Alcuni giovani che distribuivano il volantino del<br />
Comitato furono picchiati da estremisti di sinistra; il sindacato unitario CG<strong>IL</strong>-CISL-U<strong>IL</strong> emise un comunicato in cui<br />
Luciano Buonocore – La Maggioranza Silenziosa e il Progetto Tecnocratico 7
gridava: “Con giudizi tipicamente reazionari e filofascisti, gli organizzatori della manifestazione (anticomunista)<br />
intendono provocare apertamente la coscienza democratica dei lavoratori milanesi”. Il comunicato chiudeva con un<br />
appello alla “vigilanza” contro le “manovre” che “la destra economica e politica va tentando da mesi in tutto il Paese”. In<br />
quella vigilia, nessuno può dirsi certo che la manifestazione anticomunista sarà un successo: ci sono anzi segni (come il<br />
miserevole comizio dell’OCI a Torino) che lascerebbero pensare il contrario. Tuttavia il PCI, attentissimo osservatore,<br />
non sottovaluta il sintomo. Il fatto stesso che una manifestazione del genere possa essere indetta a Milano è già un<br />
ostacolo possibile per la sua manovra di avvicinamento al potere; quella manovra si basa sull’”unità antifascista”, e la<br />
manifestazione di Milano mira apertamente a rompere quell’”unità”. C’è solo un modo di correr ai ripari: isolare<br />
quell’iniziativa, definendola in anticipo “fascista”. E infatti “L’Unità” del 12 marzo, il giorno prima del corteo, pubblica un<br />
trafiletto dal titolo: “Una iniziativa fascista malamente mascherata. E’ stata annunciata per domani (e subito il Corriere<br />
della Sera si è affrettato a darne notizia) una manifestazione anticomunista – esordisce L’unità – Certamente non ci turba<br />
che ci siano gruppi politici che si dichiarano anticomunisti e intendono combattere contro di noi (. . . ). Ma c’è qualcosa<br />
d’altro che deve essere sottolineato, ed è il carattere provocatorio che viene ad assumere questa manifestazione, data la<br />
situazione politica che stiamo attraversando. A Milano e in ogni parte d’Italia si sono svolte imponenti manifestazioni<br />
popolari antifasciste, intorno alle quali si è realizzata una politica d’unità molto vasta; di fronte alle gravissime<br />
provocazioni dello squadrismo fascista, tutte le forze democratiche hanno sentito il dovere di ribadire il proprio impegno<br />
democratico (. . .). E’ dunque del tutto evidente che la manifestazione indetta per domani da un fantomatico “Comitato<br />
Anticomunista” non è altro che un atto di copertura e di appoggio nei confronti delle imprese di marca fascista, ed ha un<br />
chiaro significato di contrapposizione allo schieramento delle forze democratiche e popolari. Chiunque si nasconda dietro<br />
questa sigla (. . .) non possiamo avere dunque alcuna incertezza nel giudicare la manifestazione di domani come un atto<br />
di provocazione nei confronti della Milano democratica, come una iniziativa fascista malamente mascherata”. L’Unità<br />
continuava invocando la repressione della polizia contro il nuovo avversario, che si era così inopinatamente manifestato.<br />
“Fra l’altro si ha notizia che ben individuati figuri dello squadrismo milanese sarebbero incaricati di alcuni aspetti<br />
“organizzativi” della manifestazione e di ciò certamente sono a conoscenza le pubbliche autorità, che devono pertanto<br />
assumersi in tutte le loro responsabilità. Ancora una volta (. . .) affermiamo con forza la necessità che gli organi dello<br />
Stato sappiano prevenire e impedire con la massima fermezza ogni sorta di provocazione, ogni attentato alla legalità<br />
democratica”. L’articolo si concludeva con un appello alle forze politiche già radunate sotto la parola d’ordine della “unità<br />
antifascista”, a non rompere quell’unità” (con il PCI), contro cui la manifestazione della Maggioranza Silenziosa era<br />
evidentemente diretta. “Mai è apparso come in questo momento che la bandiera dell’anticomunismo è l’insegna sotto la<br />
quale si raccolgono le forze più oscure della reazione, le quali vogliono colpire non solo il nostro Partito, ma tutto il<br />
movimento popolare organizzato e le stesse istituzioni democratiche. Di fronte a questo tentativo di provocazione, il<br />
nostro Partito non soltanto fa appello ai propri militanti perché compiano un’opera attenta e responsabile di vigilanza,<br />
ma anche si rivolge a tutto lo schieramento antifascista, a tutti i comitati unitari che sono sorti nei quartieri, nelle<br />
fabbriche, nei comuni, perché l’iniziativa unitaria prosegua con un nuovo slancio e con una grande partecipazione di<br />
massa, così da isolare i gruppi reazionari e sventare ogni tentativo autoritario”.<br />
L’Avanti! Ripeteva gli stessi motivi, naturalmente con maggior rozzezza. Si lasciava andare a fare nomi e cognomi di<br />
“fascisti” che avrebbero partecipato alla manifestazione; lanciava un attacco personale contro il direttore del quotidiano<br />
La Notte, Nino Nutrizio, colpevole di appoggiare apertamente la Maggioranza Silenziosa. Nutrizio rispose con un articolo<br />
che apparve il 13 marzo, con il titolo “Alle 17 di oggi senza provocazione”. Vale la pena di riportarlo, perché esso esprime<br />
molto bene i sentimenti di coloro che si preparavano a partecipare al corteo anticomunista. “Ce ne stavamo belli e<br />
tranquilli per i fatti nostri – esordiva Nutrizio – quand’ecco che “L’Avanti!”, anziché dedicare spazio ai “sinistri” tipo<br />
Storti e Gamaglio, che non pagano le tasse, se la prende con noi e scrive: “Siamo curiosi di vedere se, a fianco del direttore<br />
del “La Notte”, ci sarà qualche squallido rottame del passato”. Il riferimento è legato alla manifestazione di oggi alle 17.<br />
Poiché di questa iniziativa hanno parlato, quasi più di noi, “L’Unità” e “L’Avanti!”, discutiamone pure in piena libertà, se<br />
lor signori consentono ancora, in questa Italia democratica, che chi la pensa in modo diverso da comunisti e socialisti<br />
massimalisti abbia diritto alla parola. I comunisti, i socialisti, i maoisti, gli studenti, gli operai, gli scioperanti: tutti si<br />
erano riuniti innumerevoli volte, hanno sfilato per le città, hanno sventolato bandiere rosse, hanno inneggiato, hanno<br />
inveito, hanno insultato, hanno anche provocato disordini. E nessuno ha fiatato (. . . ) Chi disapprovava, si teneva la sua<br />
disapprovazione per sé. Adesso la cosiddetta Maggioranza Silenziosa invita ad una manifestazione assolutamente<br />
pacifica, ordinata, civile, e subito salta fuori la qualifica a bollarla: provocazione. Perché provocazione? Il chiedere ordine,<br />
pace sociale e libertà per tutti è forse provocazione? Veder passare per le strade di Milano, dopo migliaia di bandiere<br />
rosse, qualche decina di tricolori è provocazione, è fascismo, è rigurgito di moti reazionari? Citavamo ieri i casi della<br />
Polonia e della Svezia. Oggi è la volta della Turchia che stanca del caos e dell’anarchia, chiede spazio – tramite i militari –<br />
un nuovo governo al di sopra dei partiti. Vogliamo arrivare a questo? Non è più giusto, più logico, più democratico che il<br />
buon senso prevalga prima che sia troppo tardi? Se una parte del popolo italiano – per il caso specifico della cittadinanza<br />
milanese – dichiara apertamente e lealmente che non è comunista, che non vuole il comunismo, che non crede nei<br />
benefici del comunismo tipo Ungheria, tipo Cecoslovacchia, tipo Polonia, questo significa provocazione o fascismo? E’<br />
comprensibile che partiti e uomini politici – che vogliono a tutti i costi conservare il potere e le prebende (senza pagare le<br />
tasse) – tengano mano i comunisti, stiano attenti a non irritarli, a non ritardare la loro scalata al potere favorita dal PSI e<br />
da certi ambienti cattolici. Ma i cittadini democratici, che vogliono lavorare ed essere liberi, che hanno sempre votato a<br />
favore di coloro che promettevano dighe e bastioni contro il comunismo, perché dovrebbero ora dichiararsi d’un tratto<br />
sostenitori di un partito e di una dottrina che hanno sempre avversato? Sono dieci anni e più che sosteniamo questi<br />
principi: i compagni comunisti stessi ce ne daranno atto. Abbiamo mai chiesto la violenza contro i comunisti? Abbiamo<br />
mai invocato leggi forcaiole nei loro confronti? Mai. Abbiamo sempre detto: se il popolo italiano un giorno voterà in<br />
maggioranza per il comunismo, lo accetteremo disciplinatamente e democraticamente (. . . ). Ma prima sia consentito a<br />
tutti di lottare con le armi democratiche del ragionamento, della logica, dell’informazione: non con la minaccia, con la<br />
violenza, con il sopruso, la provocazione. Non crediamo che quella di oggi sia una manifestazione fascista: non lo deve<br />
essere. Se accennasse anche per un solo momento a diventarlo, noi l’abbandoneremmo. E’ e deve restare una<br />
testimonianza che la Maggioranza Silenziosa esiste, che non è un fantasma. Se – probabilmente per paura – alle 17 di<br />
oggi, sui Bastioni di Porta Venezia, vi saranno solo quattro gatti, saremo noi i primi a scrivere che la Maggioranza<br />
Luciano Buonocore – La Maggioranza Silenziosa e il Progetto Tecnocratico 8
Silenziosa non esiste più, che la democrazia in Italia non ha avuto nemmeno il coraggio di seguire il suo funerale. Se<br />
viceversa i gatti saranno otto – perché altri ottomila o ottocentomila avranno avuto le commissioni da fare, il film da<br />
vedere, la gita in campagna da compiere: tutti atti più importanti della libertà – allora ci sarà ancora da sperare nel buon<br />
senso, nel ravvedimento, nella tenuta degli italiani. Ma non si parli – per favore e per lealtà – di provocazione e<br />
di”attentati alla legalità democratica”. Nessuno ha in animo di provocare e di attentare. E’ vivissimo invece in tutti il<br />
desiderio ed il bisogno di vivere in pace, in un Paese tranquillo e ordinato (. . .). Stia tranquillo “L’Avanti!” che non<br />
avremo al fianco alcuno “squallido rottame del passato”. Quelli del passato che stimavamo sono morti e morti bene;<br />
quelli che stimavamo hanno fatto carriera politica in tutti i partiti, e non ci sono amici. “L’Avanti!” si deve mettere in testa<br />
che, se fossimo stati rosi dal demone del potere e dell’ambizione, avremmo trovato il modo e la strada per manifestarlo e<br />
per conseguire i nostri traguardi. Un’imponente sfilata di “arrivati” è lì a testimoniarlo e a confermarlo (. . .) Adesso che il<br />
cammino volge al termine lo scopo non è di provocare o di attentare alla legalità democratica: ma di fare un piccolo<br />
contributo perché l’Italia, ancora una volta, non rinunci, incautamente, alla libertà. Piangere dopo lacrime di sangue non<br />
servirebbe a nulla”.<br />
Gli extraparlamentari, dal canto loro, si affrettarono a raccogliere l’appello del quotidiano comunista alla “vigilanza”.<br />
L’Avanguardia Operai indisse per lo stesso giorno in cui si sarebbe svolto il corteo della Maggioranza Silenziosa, una<br />
manifestazione “contro l’imperialismo per la vittoria della rivoluzione mondiale”, che si sarebbe dovuta tenere quasi nelle<br />
stesse ore e negli stessi luoghi (in Largo Cairoli). Vi aderirono Lotta Comunista, i Comitati Leninisti, Lotta Continua,<br />
Potere Operaio, il Movimento Studentesco. L’intento intimidatorio non poteva essere più chiaro. La manifestazione si<br />
preparava dunque in questo clima di tensione. In quegli stessi giorni la polizia faceva irruzione in Via Castelfidardo 2,<br />
nella casa di un tal Enrico Castellani: vi sequestrava proiettili, esplosivi, micce, bersagli da poligono di tiro; nonché<br />
schede ed elenchi di dirigenti industriali, soprattutto della Pirelli, indicati con nome, cognome, indirizzo, tipo e targa<br />
dell’automobile. V’erano anche dei volantini con una sigla: Brigate Rosse. (3) Nei seguenti mesi, parecchi rappresentanti<br />
dell’OCI andranno a costituire il “Comitato di Resistenza Democratica”, patrocinato dall’eroe partigiano Edgardo Sogno,<br />
Medaglia d’Oro della Resistenza ed esponente di rilievo del Partito Liberale. Il “Comitato” accoglierà via via molte<br />
adesioni, che comprenderanno un arco assai vasto, dagli autonomisti socialisti (Craxi), alla destra DC (De Carolis).<br />
<strong>LA</strong> PRIMA MANIFESTAZIONE 13 marzo 1971<br />
Dal Corriere della Sera, pagine della cronaca milanese, di domenica 14 marzo : “Un imponente corteo formato da<br />
migliaia di persone d’ogni età e disseminato di bandiere tricolori,si è snodato ieri da porta Venezia a piazza Duomo, fra le<br />
17 e le 18.20. Una breve allocuzione, alla base del monumento a Vittorio Emanuele, ha concluso la manifestazione, che<br />
era stata organizzata dal “Comitato Cittadino Anticomunista” in segno di protesta – come si leggeva sui volantini diffusi<br />
tra i partecipanti – contro l’attuale clima di violenza e disordine, la cui origine è da ricercarsi nelle manovre di potere del<br />
PCI e in difesa della libertà della nostra vita civile”. Nessun incidente ha turbato la sfilata, che si è svolta compostamente.<br />
“Il raduno era stato fissato, appunto a porta Venezia, e da qui alle 17 ha preso le mosse il corteo, preceduto da reparti di<br />
agenti e carabinieri muniti di caschi di plastica. Subito dietro avanzavano lentamente sei automobili, che sventolavano<br />
dai finestrini altrettanti tricolori; dagli altoparlanti collocati sul tetto di un’altra auto si diffondevano le note dell’Inno di<br />
Mameli, inframmezzato da inviti, rivolti alla folla, di unirsi a quello che veniva definito “un corteo di italiani”. Veniva poi<br />
avanti un bimbetto, che reggeva una bandiera italiana più grande di lui; e alle sue spalle un altro tricolore era tenuto per i<br />
lembi da un quadrato di nove ragazze. Il primo striscione della sfilata recava la scritta: “Milano dice basta alla violenza<br />
rossa”. Altri, svettanti dalla marea di folla, proclamavano: “fuori la teppa rossa dalle scuole”, “No alla schiavitù marxista”,<br />
“La libertà nelle scuole contro la violenza comunista”, “Italiani, Una sola bandiera contro il comunismo”. Una marcia<br />
lentissima. Il corteo si è sviluppato lungo il corso Venezia, fino a raggiungere San Babila. Dagli altoparlanti uscivano<br />
esortazioni ad applaudire la bandiera italiana e, in effetti, gli applausi scrosciavano frequenti dai marciapiedi, dalle<br />
finestre, dai portoni. La presenza di gruppi neofascisti tra le file dei manifestanti si imponeva all’attenzione soprattutto<br />
per qualche slogan di più spiccata intonazione polemica. I motti ufficiali, riportati sui volantini del Comitato<br />
organizzatore (“formato da cittadini di ogni estrazione sociale, che rappresentano la cosiddetta Maggioranza Silenziosa”)<br />
e scanditi a gran voce lungo il percorso, erano: “Giustizia, ordine, libertà!”, “No al comunismo”, “Milano unita contro il<br />
comunismo”, “Il comunismo non passerà”. La testa del corteo si è affacciata in Piazza Duomo alle 17.45, mentre gli<br />
altoparlanti diffondevano la canzone del Piave. Poco dopo, passando davanti alle forze dell’ordine schierate all’imbocco<br />
della Galleria, una voce al megafono ha invitato la folla a “rendere omaggio alla polizia ed ai carabinieri, che si battono<br />
valorosamente nelle piazze”. I presenti hanno risposto con salve di applausi. E’ trascorsa più di mezz’ora, prima che tutti i<br />
partecipanti alla manifestazione prendessero posto sul sagrato. Un esponente del Comitato Cittadini Anticomunista<br />
(Gabriele Pagliuzzi, n.d.r.) si è portato allora alla base del monumento a Vittorio Emanuele – ha detto fra l’altro – le<br />
nostre scuole ed i nostri luoghi di lavoro soggiacciono alla violenta aggressione dell’estremismo di sinistra, che non<br />
nasconde più il proprio obiettivo di distruggere la pace sociale e la libertà della nostra vita civile. . . Alle manovre<br />
bugiarde del PCI, che vuole presentarsi come partito d’ordine e di governo, si risponda con l’unità di tutti gli<br />
anticomunisti. La manifestazione si è conclusa, come s’è detto, senza incidenti. In serata, il Comitato Cittadino<br />
Anticomunista ha diffuso un comunicato stampa in cui il successo della manifestazione viene offerta a tutti i gruppi<br />
politici che vogliono condurre avanti con unità di intenti la battaglia contro il comunismo, per la difesa delle libere<br />
istituzioni. Lo stesso Comitato ha inviato telegrammi al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio e al<br />
Presidente della Rai-TV, protestando perché radio e televisione non avevano annunciato convenientemente la<br />
manifestazione”.<br />
La cronaca del “Corriere” è sostanzialmente esatta, anche secondo i ricordi dei promotori della manifestazione.<br />
Giampaolo Landi: “All’ora indicata per l’inizio della manifestazione, ai Bastioni di porta Venezia c’erano numerose<br />
persone sparse, che si davano l’aria di essere lì per caso, e stavano a vedere. C’era, bisogna dirlo, molta paura di esporsi,<br />
di partecipare. La gente lì radunata (ma il verbo “radunare” è eccessivo), per lo più buoni borghesi, non era mai scesa in<br />
piazza in vita sua. Per di più, si temevano le aggressioni degli ultrà di sinistra. C’era un silenzio strano, ma poi,<br />
Luciano Buonocore – La Maggioranza Silenziosa e il Progetto Tecnocratico 9
all’improvviso, da viale Majno, si sentì il grido cadenzato di molte voci: ”il comunismo non passerà”. Erano i ragazzi del<br />
Fronte della Gioventù, che capeggiati da Buonocore, si dirigevano già in corteo verso il luogo della manifestazione,<br />
agitando bandiere tricolori. Avevano anche uno striscione, saranno stati qualche migliaio. La gente che stava lì indecisa,<br />
di colpo, si sentì rincuorata. Ci fu un applauso, poi quelli che fino ad un istante prima avevano fatto da spettatori si<br />
radunarono attorno al gruppo dei giovani missini. Il corteo cominciò ad avanzare lungo corso Venezia”. Luciano<br />
Buonocore: “Secondo me, saremmo stati più di tremila. Ricordo benissimo che, quando la testa del corteo era già a piazza<br />
Duomo, la coda era ancora a porta Venezia; c’era una grande folla anche sui marciapiedi, che applaudiva al nostro<br />
passaggio. Uno dei fatti più imprevisti e commoventi fu questo: al nostro passaggio, le finestre si aprivano, venivano<br />
esposti tricolori. La gente che stava a guardare a poco a poco entrava nel corteo e marciava con noi, sicchè le nostre file<br />
s’ingrossavano via via. Ricordo anche un’altra cosa: quando arrivammo in piazza Duomo, ed io gridai dall’altoparlante<br />
“Omaggio alle forze d’ordine”, ci fu un applauso caldissimo. Vidi un anziano maresciallo dei carabinieri, che era lì<br />
schierato davanti alla Galleria, con il viso rigato di lacrime”. Gabriele Pagliuzzi: “Un fatto curioso avvenne dentro la sede<br />
del Partito Liberale, in corso Venezia. Mentre sotto le finestre sfilava il corteo, nel Partito ci fu un vero e proprio scontro<br />
fisico tra chi voleva esporre la bandiera tricolore, e chi si opponeva. Infine la bandiera fu esposta; dal basso, la folla<br />
applaudì”.<br />
Luciano Buonocore: “L’adesione alla manifestazione da parte del MSI di Milano seguiva la linea politica espressa dal<br />
congresso dell’EUR del 1970. In quell’occasione fu lanciata da Almirante l’idea di un fronte Anticomunista. Un Fronte che<br />
doveva comprendere indipendenti, democristiani, liberali, ex partigiani. La federazione dell’MSI che in quegli anni era<br />
diretta dall’On. Franco Servello si adoperò moltissimo per far confluire quanti più missini possibile alla manifestazione.<br />
Bisogna aggiungere che, nel frattempo, avevano aderito alla manifestazione, con dichiarazioni rilasciate ai giornali,<br />
alcune di quelle stesse personalità che, poche settimane prima, avevano rifiutato ogni appoggio: fra queste, il<br />
democristiano Massimo De Carolis e il socialdemocratico Vittorio D’Ajello; e, inoltre, due repubblicani: Del Pennino e<br />
Bucalossi. Inutile dire che il successo della manifestazione, e le importanti adesioni ad essa, avevano allarmato in<br />
variegato fronte “antifascista”. Il primo tentativo fu quello di sminuire l’evidenza del fatto: la televisione di Stato, per<br />
esempio, tacque completamente l’avvenimento. “Il Giorno”, il quotidiano dell’ENI diretto da Italo Pietro, l’ex partigiano<br />
che allora incarnava con molta convinzione quello che abbiamo definito “Lo spirito del CLN” descriveva il corteo così:<br />
“File rade per dare la sensazione di una grande folla, e quella folla era composta di persone non più giovani, anzi uomini<br />
anziani, signore in pelliccia”. “L’Avanti!”, dal canto suo dedicava invece una cronaca all’altra manifestazione, quella di<br />
Avanguardia Operaia, rallegrandosi che si fosse svolta “senza incidenti”. Al corteo della Maggioranza Silenziosa dedicava<br />
invece un commento in cui traspariva il dispetto: ricordava “lo sventolio quanto mai fuori posto delle bandiere tricolori,<br />
la partecipazione al corteo dei picchiatori della Giovane Italia, e concludeva rivolgendosi, a quei cittadini in buona fede i<br />
quali hanno partecipato ad una manifestazione che, sotto l’etichetta della “Maggioranza Silenziosa”, è riuscita in parte a<br />
intorbidire le acque coinvolgendo anche chi, pur essendo un conservatore, non ha certo intenzione di dare una mano ai<br />
provocatori neofascisti”.<br />
L’analisi dell’ “Unità” era non meno dura, ma più seria. Riconosceva per esempio che la manifestazione di Milano “Ha<br />
rappresentato un fatto nuovo che merita un’attenta riflessione: nel senso, che essa aveva effettivamente provocato una<br />
crepa nel fronte della “unità antifascista”. Proprio a quell’articolo rispose Nino Nutrizio. Il suo editoriale del 15 marzo<br />
1971 portava il titolo: “Il fatto nuovo”. “Di solito, il lunedì, da quando abbiamo smesso di occuparci di sport, non<br />
scriviamo. Ci scosteremo, una volta tanto, dalla regola per via di quella manifestazione di sabato, sulla quale qualche cosa<br />
bisogna pur dire. A noi ha fatto tanto piacere. Ad altri è rimasta pesantemente nel gozzo. Vediamo, prima, che cosa ne<br />
hanno scritto gli altri. “L’Unità – l’ha definita – un fatto nuovo, che merita una attenta riflessione”. Esattissimo. Quando<br />
“L’Unità” scrive delle cose sensate, come si fa a non darle ragione? E’ quando ragiona con i piedi che è difficile dichiararsi<br />
d’accordo. La manifestazione della “Maggioranza Silenziosa” è effettivamente un grosso fatto nuovo. Pur organizzata alla<br />
meglio e affrettatamente, senza nessuna pratica e tecnica di adunate di massa (“Il Giorno” dice che i partecipanti erano<br />
distanziati gli uni dagli altri, per apparire più numerosi; in realtà si camminava ammassati gli uni agli altri. Qualche<br />
giovane gridò, è vero di stare più larghi. Ma chi gli dava retta?) essa deve considerarsi pienamente riuscita. Ha dimostrato<br />
che anche in una giornata non propizia, come il sabato, si possono adunare molte migliaia di persone. Ha smentito quel<br />
carattere di provocazione che si era tentato di attribuire e si è svolta nel massimo ordine, senza provocare nessuno. Ha<br />
confermato ove ce ne fosse bisogno, che tralasciando le sfumature, le diversificazioni, le preferenze politiche, esiste una<br />
base comune che si è costituita dall’avversione al comunismo, dall’amore per la libertà, dal rispetto e dall’attaccamento<br />
alla democrazia. Il grido che più frequentemente si alzava dal corteo, anche perché breve, facile e da tanti anni trascurato<br />
era: “Italia, Italia”. Il quotidiano socialista “L’Avanti!” ha parlato di “sventolio quanto mai fuori posto delle bandiere<br />
tricolori”. Ci scuserà l’organo del vice presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica italiana, On. Prof. Francesco<br />
De Martino, che freme di impazienza per portare i comunisti al governo, se non siamo del suo avviso. Noi crediamo di<br />
interpretare i pensieri e i sentimenti delle molte persone che c’erano e di quelle, assai più numerose, che non c’erano,<br />
dicendo che lo sventolio delle bandiere tricolori era opportuno, ci voleva, faceva bene al cuore. Soltanto erano poche,<br />
erano piccole, erano sbiadite. Sulla facciata del palazzone del Carminati, ad una finestra dei piani alti, in mezzo ai cento<br />
tabelloni della pubblicità luminosa, c’era una bandiera tricolore. E’ stata notata e applaudita. Pensate a qual punto siamo<br />
ridotti: in una Milano, una piccola bandiera tricolore in piazza del Duomo, fa notizia, richiama l’attenzione, suscita<br />
sentimenti da troppi anni sopiti, dimenticati o repressi. Diranno i duri: basta con questa insopportabile retorica delle<br />
bandiere. D’accordo. E le bandiere rosse allora? Rappresentano un’idea, una aspirazione, una rivolta? Benissimo. La<br />
rappresentano “loro”. Le seguano, le sventolino, le moltiplichino in piena libertà; come consente la democrazia. Ma non<br />
pretendano che anche per “noi”, quelle bandiere siano belle e giuste e valide. Se è retorica quella della bandiere, via tutte<br />
le bandiere. Ma non via soltanto la nostra, la bandiera d’Italia che dovrebbe unirci e che troppi hanno interesse a tenere<br />
divisa, nemica, tormentata, debole. Dove si vuole andare a parare? Si domanda “L’Unità”. Da nessuna parte. Un breve<br />
comunicato emesso dal fantomatico “Comitato Cittadino Anticomunista per la difesa della libertà” offre – diciamo offre,<br />
quindi dà in regalo, senza contropartita – “questo patrimonio di entusiasmo e di civile presa di coscienza”. A chi lo offre?<br />
Ai rottamatt, a chi provoca, a che alimenta la reazione? Nossignori: lo offre “a tutti i gruppi politici che vogliano condurre<br />
avanti, con unità di intenti, la battaglia contro il comunismo per la difesa delle libere istituzioni”. Quindi lo offre, primi<br />
Luciano Buonocore – La Maggioranza Silenziosa e il Progetto Tecnocratico 10
fra tutti, alla Democrazia Cristiana, ai socialdemocratici e ai repubblicani – partiti di governo – purchè si oppongano ai<br />
comunisti, lottino con i comunisti, impongano ai comunisti le regole democratiche del gioco politico e non accettino più<br />
quelle della violenza, della intimidazione, del disordine, degli scioperi continui per motivi non attinenti al lavoro. Ma se si<br />
continuerà a carpire i voti alla Maggioranza Silenziosa promettendo dighe contro il comunismo e poi avremo ministri<br />
come il Donatt Cattin o esponenti di partito come il Galloni, la Maggioranza Silenziosa si ribellerà. E se il Presidente della<br />
Repubblica dovrà essere eletto con i voti determinanti dei comunisti – che non “offrono” certo il loro appoggio senza una<br />
contropartita – allora è inutile ingannare e menare per il naso la maggioranza silenziosa che non capisce – perché non li<br />
vuole capire – i complicati giochi della politica sporca. Ultimo appuntamento di cronaca. Fra i partecipanti all’adunata di<br />
sabato, “L’Unità” cita quattro nomi: quello di una certo Gianluigi Radice, che non conosciamo, denunciato – dice – per<br />
attentati contro le sedi democratiche; il consigliere comunale missino Marchesi, che non c’era, perchè è da molto tempo<br />
seriamente ammalato; un tale Spadoni, vice comandante della Muti, che non c’era, perché operato di recente ad un<br />
occhio; ed il sottoscritto che c’era ed è definito “vecchio rottame del fascismo”, dopo aver notoriamente condotto l’ultima<br />
campagna elettorale a favore della socialdemocrazia e molte precedenti a favore dei liberali. Su quattro nomi due non<br />
c’erano ed uno viene citato con palese e grossolana falsificazione dei dati di fatto. Il “vecchio rottame del fascismo”, in<br />
quegli anni ha fatto il giornalista sportivo al “Popolo d’Italia”, parlando dell’Inter, del Milan, di Bartali, di Coppi e molti se<br />
lo ricordano ancora. Poi è andato in guerra ed è sopravvissuto a Capo Matapan, quando avrebbe potuto benissimo evitare<br />
quel bagno. In prigionia non ha tradito il suo Paese e non l’ha fatto neanche dopo essendo sinceramente democratico.<br />
Veda “l’Unità” se nelle file comuniste taluni autentici “rottami del fascismo” che vi hanno cercato comodo rifugio, hanno<br />
tutti le carte morali e materiali in regola, come il sottoscritto”.<br />
Ma le più violente reazioni si ebbero il giorno dopo in Consiglio Comunale. Il successo della manifestazione<br />
impensieriva tutti i partiti in qualche modo impegnati nella strategia della “solidarietà antifascista”; ancor più allarmava<br />
l’adesione, sia pure a “titolo personale”, di alcuni membri dello stesso Consiglio Comunale, che militavano in partiti<br />
ufficialmente “antifascisti”. Il Sindaco socialista Aldo Animasi aprì la seduta ricordando tutta una serie di episodi di<br />
violenza che erano avvenuti nei giorni precedenti a Trieste, a Foggia e a Montepulciano. Collegò poi quegli avvenimenti<br />
con “gli atti di intolleranza che si sono verificati a Milano sabato sera, dopo lo scioglimento della manifestazione di una<br />
cosiddetta “Maggioranza Silenziosa”. Non possiamo illuderci – proseguì Aniasi – che coloro i quali traggono motivo di<br />
speranza da questi fatti per intaccare il valore delle istituzioni democratiche abbiano a rinunciare presto a questi<br />
degradanti mezzi. D’altra parte noi continueremo a compiere per intero il nostro dovere di denuncia e di opposizione a<br />
metodi che turbano la nostra coscienza di democratici. (. . .)” Poi fu la volta del socialista Paride Accetti. Fu lui ad aprire<br />
la questione che stava a cuore a tutti: deprecò esplicitamente che “personaggi appartenenti al Consiglio Comunale<br />
avessero partecipato ad una manifestazione di chiara marca neofascista”. Un altro socialista, Lionello Beltramini, invitò i<br />
gruppi democristiano e socialdemocratico a “scindere la loro responsabilità da quella manifestazione”. Il comunista<br />
Riccardo Terzi pretese un “chiarimento” da DC e PSDI; il demoproletario Domenico Contestabile ripetè gli stessi concetti,<br />
ma ovviamente con toni più minacciosi. Si alzò Massimo De Carolis. Il capogruppo democristiano, che aveva partecipato<br />
alla manifestazione, era stato chiamato in causa direttamente. Esordì ribadendo che la sua adesione al corteo era stata<br />
fatta “a titolo personale”; negò che le azioni provocatorie inscenate dai neofascisti a manifestazione terminata fossero<br />
state volute dagli organizzatori della “Maggioranza Silenziosa”. “La manifestazione è stata di cittadini per lo più apolitici<br />
– concluse De Carolis – e si è svolta ordinatamente nei limiti in cui nel nostro Paese è lecito manifestare. Sono<br />
profondamente convinto che la nostra democrazia subirebbe un colpo gravissimo se si accettasse l’equazione che chi è<br />
anticomunista è sempre fascista”. Vittorio D’Ajello, socialdemocratico, difese negli stessi termini la sua adesione al<br />
corteo. Si disse convinto che i “promotori, che sono cittadini non iscritti ad alcun partito, credono nei valori della libertà e<br />
della democrazia. Ne condivido ovviamente – aggiunse – lo scopo di protesta contro il crescente disordine dissolvitore<br />
delle nostre istituzioni”. Il liberale Armando Frumento, come nel suo stile, fece un discorso dai toni più sfumati ma fermo<br />
nell’attestazione dei principi di libertà; assolutamente esplicito fu invece il repubblicano Pietro Bucalossi, che difese con<br />
vigore la “Maggioranza Silenziosa”. Poi parlò il vice sindaco Andrea Borruso, democristiano, vicino a “Comunione e<br />
Liberazione”. Ricordo che la DC “vanta il suo passato antifascista e la sua origine popolare. Precisò che l’anticomunismo<br />
della DC non si esprime in forma viscerale e preconcetta ma sul piano del confronto con le forze che intendono migliorare<br />
la società italiana”. Era naturalmente sottointeso che fra “le forze che intendono migliorare” andavano annoverati, per<br />
lui, i comunisti. Il suo discorso era un’implicita condanna ed un richiamo all’ordine di quanti, nella stessa DC, potevano<br />
guardare alla “Maggioranza Silenziosa” come un movimento a cui dare voce e forza. Più esplicito era stato il “richiamo<br />
alla disciplina” in un comunicato emesso quella stessa mattina dalla segreteria provinciale della DC: “la partecipazione di<br />
esponenti democristiani ad iniziative come quella della “marcia silenziosa” rappresenta un’obbiettività inaccettabile<br />
differenziazione dalla linea politica in proposito adottata dalla DC: anche le cosiddette partecipazioni a titolo personale<br />
favoriscono infatti, come l’esperienza insegna, strumentalizzazioni a fini politici diversi e contrastanti con quelli<br />
perseguiti dal partito”. Insomma, la DC veniva a trovarsi in perfetto accordo, nel giudizio sulla manifestazione, non<br />
soltanto con i socialisti, ma con gli stessi comunisti che avevano ottenuto il “chiarimento” reclamato (“un certo<br />
anticomunismo è soprattutto opposizione al movimento operaio e quindi deve essere respinto”, disse il socialista<br />
Umberto Dragone). Non a caso il sindaco Animasi ripetè quasi negli stessi termini il senso del comunicato democristiano,<br />
nel chiudere la seduta: “Anche una marcia “silenziosa” – disse – può entrare in un certo disegno eversivo e antipopolare”.<br />
Lo schieramento di forze di partito contro il movimento spontaneo del Comitato Anticomunista non poteva essere più<br />
netto e chiaro.<br />
LE ACCUSE DEL MONDO<br />
Una sorta di lieto stupore dominava frattanto fra quella parte della cittadinanza che aveva partecipato al corteo<br />
anticomunista o aveva simpatizzato con esso. Questo stupore è espresso in modo sincero – insieme ai motivi autentici<br />
che avevano mosso i cittadini della Maggioranza Silenziosa – da una lettera – articolo apparsa su “La Notte” del 14<br />
marzo, intitolata “Contributo per Milano pulita”. La lettera è di Vitaliano Peduzzi, ex partigiano, liberale, che era stato fra<br />
i promotori dell’analoga manifestazione di Torino, fallata miserabilmente alcuni giorni prima. “Devo confessare – a mia<br />
mortificazione di uomo di poca fede – che non credevo che la manifestazione avrebbe avuto successo – esordiva Peduzzi<br />
Luciano Buonocore – La Maggioranza Silenziosa e il Progetto Tecnocratico 11
– Invece Milano, stupenda inimitabile città, ha risposto gagliardamente all’appello per la difesa della libertà contro ogni<br />
violenza, contro ogni sopraffazione (. . .). Mentre mi avvio al punto di riunione incontro un amico, brav’uomo ma certo<br />
più tiepido che caldo. Mi dice senza preamboli: “Sai, ero molto in dubbio se venire o no. Ma stamattina ho letto il<br />
comunicato di alcune organizzazioni che condannano come reazionaria e filofascista la manifestazione, squallida<br />
provocazione della coscienza democratica dei lavoratori, ecc. ecc.: la solita manfrina. Ho detto: se quelli che si danno<br />
tanto da fare per sconquassare questo povero Paese, allo scopo di sostituire la nostra incerta democrazia occidentale con<br />
una cortissima dittatura orientale si allarmano tanto, vuol dire che la manifestazione è una cosa buona. E così sono<br />
venuto”. Peduzzi descrive l’applauso alle forze d’ordine e la commozione degli agenti: “Erano applausi di cittadini in<br />
borghese ad altri cittadini in uniforme che facevano il loro dovere. Cittadini in uniforme al servizio di uno Stato di<br />
cittadini e non, come ha detto più volte, con tanta vigliaccheria qualche ministro, “figli del popolo”, quasi a discriminarli,<br />
a giustificarli, a scusarli. In un mondo libero, figli del popolo siamo tutti, perché il popolo non è una classe né una<br />
categoria: lo siamo tutti, ognuno al suo lavoro, tranne alcuni che sono figli d’altra roba, ma tanto hanno l’impunità”. E<br />
proseguiva: “Ho visto ragazzi di 16/18 anni insieme con amici della Resistenza – un po’ grigi di capelli, con qualche chilo<br />
in più (. . .) -che non vedevo da quando, nella primavera del 1945, abbiamo ingenuamente e colpevolmente creduto che il<br />
nostro compito di combattere un regime totalitario fosse finito e che cominciasse un’epoca di libertà e di democrazia.<br />
Abbiamo sbagliato a lasciare lo sfruttamento metodico e spudorato di una pagina della nostra storia nazionale ai<br />
comunisti e ai loro subalterni. Ed eccoci a constatare che, a 25 anni da quella che doveva essere la liberazione, il bene più<br />
in pericolo è la libertà. Per questo ci siamo ritrovati per contrastare il passo ad una nuova e più pesante dittatura. La<br />
manifestazione è stata bollata dalla sinistra come “provocatoria”. Così quella del 7 marzo a Torino, così quella del 14<br />
marzo a Roma di solidarietà con le Forze Armate. Chi non si adegua, chi la pensa diversamente, chi non si fa suddito, è<br />
provocatore. La sinistra ha la vocazione dittatoriale e si impenna quando non le si lascia mano libera nelle sue manovre<br />
per impadronirsi del potere. . .” La manifestazione aveva dimostrato che esistevano ancora “tesori civili e morali”<br />
custoditi dai cittadini; concludeva Peduzzi: “I partiti politici democratici hanno ora un grosso compito, una grossa<br />
responsabilità: invece di scannarsi fra loro per spigolare tutti nello stesso campo (. . . ) devono tradurre questi tesori<br />
spirituali, morali, civili e civici in forza politica. Se no, li perderanno. E perderanno sé stessi”.<br />
In quegli stessi giorni, oltre a “La Notte”, anche i giornali e i periodici avversi alla “Maggioranza Silenziosa” e a ciò che<br />
essa rappresentava, ricevevano centinaia di lettere a commento della manifestazione di Milano: segno che essa aveva<br />
scosso anche l’opinione pubblica “progressista”, aveva seminato anche là dubbi, o dispetto, o timore. Un certo Vitaliano<br />
Brocchi di Varese scriveva al “Mondo”: “Nello scorso febbraio i Milanesi assistettero alla sfilata di forse trentamila<br />
studenti con striscioni e bandiere rosse; un mese dopo altrettanti cittadini hanno percorso quasi le stesse strade della<br />
metropoli portando però striscioni e bandiere tricolori. Nel primo caso la sfilata si svolse nell’indifferenza generale;<br />
invece le migliaia del 13 marzo sono state applaudite. I cittadini sono stanchi di vedere il centro della loro città invaso da<br />
una bandiera estranea al loro modo di sentire. Tutto questo può piacere o no, ma è chiaro che il Paese si sta svegliando, e<br />
questa volta no in nome di principi generici, come voi avete detto (. . . ). Perché non analizzate quanto è successo a<br />
Milano?”. Allo stesso giornale, Carla Padovani di Bergamo scriveva: “E’ innegabile che questa massa (la maggioranza<br />
silenziosa n.d.r.) non “tace” più e quindi fa politica: resta da vedere in quale senso. Non vorrei sbagliarmi, ma chi ne avrà<br />
tutti i vantaggi è la Democrazia Cristiana, che ha nel suo seno uomini come Donat Cattin amico dei comunisti e come<br />
l’On. Lucifredi amico dei fascisti”.<br />
A lettere come questa il direttore del “Mondo” Arrigo Benedetti rispose a più riprese. “E’ equivoco lo stesso concetto di<br />
“Maggioranza Silenziosa” – scriveva in uno sprezzante commento sul numero del 21 marzo – il silenzio è sempre<br />
indifferenza. Non è disinteressandosi di politica che si può contrastare, ad esempio, l’attuale spinta a sinistra. Chi ne ha<br />
paura deve rendersi conto che la sinistra sembra tanto forte non per merito di capi, ma perché semmai essi interpretano<br />
gli assilli, le scontentezze e i pregiudizi di ceti sociali molto politicizzati. Vantarsi del proprio silenzio,cioè della propria<br />
estraneità alla vita politica, significa – rendendosene conto o no – disprezzo per la democrazia, con il proposito di<br />
affidare la gestione del potere a chicchessia, pur di avere la comodità di badare ai propri interessi, ai propri egoismi”.<br />
Qualche giorno dopo, Bendetti ritornava sull’argomento: “Migliaia di cittadini socialmente molto ben identificati credono<br />
che si possa fare politica senza i partiti. Non è mai successo e mai succederà”. E ancora, in risposta ad una terza lettera:<br />
“Quelli del Comitato Cittadino Anticomunista cercano il De Gaulle italiano. Ma in Italia non si deve alcun personaggio<br />
che possa pretendere d’interpretare i sentimenti della “Maggioranza Silenziosa”.<br />
Allora nemmeno i più attivi promotori del Comitato Cittadino Anticomunista ebbero né il tempo, né i mezzi, né le sedi<br />
per rispondere. Adesso essi però, rileggendo i commenti del direttore del “Mondo”, ritengono che una replica non sia<br />
inutile, sia pure a distanza di tanto tempo. Essi vedono le idee di Benedetti “una concezione aberrante di “democrazia”,<br />
che è stata causa non ultima dei disordini e del sangue che hanno macchiato l’Italia in quegli anni, attraverso<br />
l’assemblearismo sovversivo da una parte (e di lì fino al terrorismo), e, dall’altra, attraverso le manovre occulte e<br />
golpiste”. La malizia del ragionamento di Benedetti sta nell’identificare il “silenzio” della “Maggioranza Silenziosa” come<br />
una “estraneità alla vita pubblica”, e per di più “vantata” e “disprezzo della democrazia”. In realtà, i cittadini “silenziosi” a<br />
cui faceva appello il Comitato Anticomunista di Milano erano semplicemente quella vasta parte della società che<br />
partecipa alla vita politica “silenziosamente”, cioè – in tempi normali – in cui non siamo in pericolo i fondamenti stessi<br />
del vivere democratico – deponendo il suo voto nell’urna elettorale. Non è affatto “disprezzo della democrazia”, ma al<br />
contrario partecipazione alla democrazia nei termini e nei limiti del metodo democratico. Perché, ecco il fatto che<br />
Benedetti non capiva o fingeva di non capire, non è affatto normale che tutti i cittadini si occupino continuamente di<br />
politica: la maggior parte della gente è giusto che si dedichi in prevalenza ai suoi legittimi interessi, allo svolgimento dei<br />
suoi quotidiani doveri; il suo “silenzio” politico, lungi dall’esprimere “disprezzo”, implica un silenzioso assenso alle<br />
istituzioni. Credere il contrario, come fa Benedetti – all’obbligatorietà della “partecipazione”e della “politicizzazione”,<br />
significa sostituire surrettiziamente al concetto (formale) di democrazia pluralistica e occidentale, quello della<br />
“democrazia di massa”, di “democrazia popolare”, in una parola di “democrazia assembleare”.<br />
Luciano Buonocore – La Maggioranza Silenziosa e il Progetto Tecnocratico 12
Ma la democrazia d’assemblea è una contraffazione maligna della democrazia pluralistica: e lo sa bene chi, proprio in<br />
quegli anni, nelle scuole, nelle fabbriche, negli ospedali persino, assisteva alla manipolazione e alla distorsione dei regimi<br />
assembleari. Le assemblee vengono monopolizzate da professionisti dell’agitazione con metodi assai semplici: la<br />
maggioranza dei partecipanti, tendenzialmente moderata, è dapprima intimidita da urli, da spinte, da violenze; poi<br />
stancata con concioni interminabili e inconcludenti. A poco a poco, le persone serie, quelli che devono lavorare, che<br />
hanno interessi da seguire, e doveri da compiere, abbandonano l’assemblea. E quando questa prende le decisioni cruciali<br />
(per lo più a tarda notte), è ridotta ormai ai militanti, agli estremisti e ai professionisti dell’agitazione il cui “lavoro” e il<br />
cui “interesse” consiste appunto nella manipolazione dell’assemblea, nell’interesse del Partito e della “rivoluzione”. Era a<br />
metodi come questi che nel ’71 si doveva nella “spinta a sinistra” che il direttore del “Mondo” attribuiva al merito di “ceti<br />
molto politicizzati”. Benedetti fingeva di ignorare cosa significasse, cosa mettesse in gioco e quali pericoli celasse quella<br />
“spinta a sinistra”: era il risultato della tecnica leninista di presa del potere, applicata alla situazione italiana. “Tutta la<br />
storia del bolscevismo – diceva Lenin – è piena di compromessi con altri partiti borghesi: c’è la necessità incondizionata,<br />
assoluta per il partito comunista, di stringere compromessi con i diversi gruppi di proletari, con i diversi partiti di operai<br />
e di piccoli padroni”. In Italia, questo “compromesso” passava per la formazione di un “fronte unitario” (per l’occasione,<br />
in nome dell’antifascismo) con partiti come la DC, il PSI, e i partiti “proletari” a sinistra del PCI. Il Partito Comunista,<br />
egemonizzando questo “blocco”, o “fronte unitario”, stava già in Italia modificando le stesse regole del gioco democratico<br />
o, come dice ancora Lenin, “introduceva in tutti i campi di attività, non solo in quello parlamentare, ciò che vi è di nuovo<br />
(. . .) dal punto di vista dei principi”.<br />
Proprio contro questo pericolo mortale per le istituzioni, chiarissimo ai promotori del Comitato Anticomunista di<br />
Milano, nasce l’appello alla “Maggioranza Silenziosa”. I cittadini che in tempi normali partecipano votando,<br />
“silenziosamente”, alla politica nel quadro delle istituzioni, vengono chiamati ad un impegno politico più diretto, per così<br />
dire straordinario, perché le istituzioni cui essi consentono minacciano di crollare sotto uno straordinario attacco. “Ciò<br />
che muoveva la Maggioranza Silenziosa non era affatto la speranza o l’illusione – come dice Benedetti – di far politica<br />
senza i partiti, spiega Luciano Buonocore: “Al contrario, si era mossa proprio perché i partiti che tradizionalmente la<br />
rappresentavano l’avevano tradita, aderendo al “fronte unitario” ad egemonia comunista che, come la storia insegna,<br />
preludeva ad un mutamento “sovversivo” delle istituzioni. Credo che l’ultimo manifestante, partecipando al corteo di<br />
Milano, fosse cosciente che quella sua azione intendeva portare nei partiti democratici lo stimolo, il coraggio di opporsi al<br />
disegno comunista di presa del potere; intendeva svegliare i partiti, perché formassero anche nelle sedi istituzionali<br />
quella linea di resistenza, avversa al comunismo, perché esprimessero anche nel Parlamento quella volontà<br />
anticomunista che s’era così clamorosamente rivelata nella piazza, nelle città e nella società”.<br />
Come vedremo, nessun partito volle o seppe interpretare questa volontà. Non che il vasto disegno che prevedeva<br />
l’associazione al potere del PCI, gli “equilibri più avanzati” di cui parlava Aldo Moro, non trovasse, nei vertici e nelle<br />
stanze del Palazzo, avversari anche autorevoli. Proprio in quel tempo alcuni uomini politici d’alto livello avevano preso<br />
atto del fallimento del centro-sinistra e della sua pericolosa evoluzione in chiave sovversiva; anche nelle sedi del potere<br />
dava segni di vita, dunque, una linea politica che puntava alla rottura dei partiti moderati con il PSI massimalista, per<br />
una sorta di restaurazione in chiave centrista. Questa linea apparteneva a forze diverse e variegate, che miravano a<br />
raggiungere lo scopo con mezzi differenti: mezzi che, come forse avremo modo di vedere in seguito, non escludevano<br />
quelle manovre che noi chiamiamo, con obbligata genericità, “golpiste”. Ma una cosa è certa: nessuno di questi mezzi<br />
prevedeva tuttavia, che venisse raccolto l’appello della “Maggioranza Silenziosa”, cioè di un movimento nato<br />
spontaneamente, al di fuori degli accordi e delle manovre dei vertici. Agì forse, in questo rifiuto, un oscuro timore storico<br />
che accomuna tutta la classe politica della Repubblica, fosse o non favorevole al “compromesso”: il timore che un<br />
movimento popolare su base anticomunista avrebbe finito per reclamare, e forse imporre, non solo la fine delle alleanze e<br />
degli accordi sottobanco con il PCI, ma magari persino un rinnovamento e un ricambio di tutto il ceto politico-partitico,<br />
immutabile e inamovibile, che si perpetuava dalla fine della Resistenza. Molto astutamente Benedetti aveva insinuato che<br />
la “Maggioranza Silenziosa cercava un De Gaulle italiano”: con ciò, aveva toccato la corda della paura “centrale” che agita<br />
la classe dirigente politica del dopoguerra. La paura che il popolo o gli eventi finiscano per imporre, com’è già accaduto<br />
più volte in Francia, la fine della “vecchia” Repubblica e la nascita di una seconda Repubblica, con una classe politica<br />
diversa.<br />
UN SOCIALISTA CHIEDE DI ADERIRE AL C.C.A.<br />
Il successo della manifestazione del 13 marzo suscitò per contagio un fervore di iniziative spontanee in tutta Italia. Il<br />
Comitato Anticomunista milanese decise a tambur battente di indire una seconda manifestazione per il 17 aprile; in quel<br />
mese di intervalli, fu subissato di telefonate, lettere, adesioni che venivano da ogni parte. “Comitati Cittadini” sul modello<br />
di quello di Milano venivano creati spontaneamente in diverse città nel Nord Italia; i loro promotori telefonavano al<br />
Comitato milanese la loro intenzione di mandare i propri simpatizzanti a partecipare al prossimo corteo nel capoluogo<br />
lombardo. Il gruppo partigiano “Volontari della Libertà”, attraverso i suoi dirigenti lombardi, Donato e Marra, assicurò la<br />
partecipazione dei propri associati. I giovani promotori della “Maggioranza Silenziosa” accoglievano queste adesioni con<br />
ovvio entusiasmo, ma anche con qualche preoccupazione. I membri del Comitato Cittadino Anticomunista, in quanto<br />
dirigenti giovanili di partiti, avevano creato all’interno del Comitato un equilibrio preciso e volontario, in base al quale<br />
nessuna componente politica (né quella missina, né quella liberale, né quella monarchica) dovesse prendere il<br />
sopravvento sulle altre. Essi stessi mantenevano un rigoroso anonimato: sui giornali di quelle settimane, non una volta<br />
appare il nome di Buonocore o di Pagliuzzi, di Landi o della Manzoni. Nessuna “egemonia sul movimento”, nessun “culto<br />
della personalità” era permesso. Ora, le adesioni e le aperte solidarietà di personaggi politici noti, almeno in sede<br />
cittadina (da De Carolis a D’Ajello, da Bucalossi a Frumento), rischiavano di mettere in pericolo la correttezza di quella<br />
“linea”. La partecipazione di questi personaggi avrebbe potuto tradursi in una strumentalizzazione del movimento;<br />
d’altra parte era dubbia la stessa “fermezza” che quei personaggi, legati alla disciplina dei rispettivi partiti, avrebbero<br />
potuto dimostrare di fronte alla controffensiva politico-propagandistica del “Fronte Antifascista”, che già si profilava.<br />
Luciano Buonocore – La Maggioranza Silenziosa e il Progetto Tecnocratico 13
Perciò il Comitato Cittadino non si aprì alla partecipazione diretta di quelle personalità; i promotori della “Maggioranza<br />
Silenziosa” restarono quelli del primo giorno, senza ulteriori cooptazioni. Persino alcune adesioni insperate furono<br />
lasciate cadere. Luciano Buonocore ricorda che una sera, durante una riunione dei promotori a casa dell’ing. Nodali,<br />
questi gli fece il nome di “un giovane socialista autonomista”che avrebbe voluto dare la sua adesione alla manifestazione<br />
annunciata: il nome era quello di Bettino Craxi. Buonocore non volle saperne di più: quel nome allora non gli diceva<br />
assolutamente niente. “La mia sola preoccupazione era questa – ricorda – che la presenza di un socialista alla<br />
manifestazione che stavamo preparando avrebbe inevitabilmente provocato la defezione della “nostra” base di<br />
manifestanti, sicuramente di quella missina, ma non solo di quella. I socialisti di Milano, capeggiati allora dal sindaco, il<br />
massimalista Aldo Aniasi, erano la “bestia nera” dell’opinione pubblica moderata. Uno degli slogans più gridati della<br />
prima manifestazione era stato: “Aniasi vattene!”. Era impossibile far capire a questa gente che c’erano socialisti di<br />
tutt’altro genere, disposti a marciare con loro”.<br />
Il PSI, con il partito comunista e i vari gruppi extraparlamentari, proprio in quei giorni si mobilitava per prevenire le<br />
cosiddette “provocazioni” anticomuniste. Una prova generale dell’efficacia di questa mobilitazione si ebbe a Bergamo,<br />
dove già attorno al 29 marzo si era costituito un “Comitato Cittadino Anticomunista” simile, ma del tutto indipendente da<br />
quello di Milano. Questo Comitato bergamasco aveva indetto per il 2 aprile una manifestazione della “Maggioranza<br />
Silenziosa” da tenersi a Bergamo. La Questura aveva concesso l’autorizzazione. Ma pochi giorni prima dell’annunciato<br />
corteo, un “Comitato Antifascista” bergamasco, presentava al Prefetto una protesta, firmata da un ex parlamentare del<br />
PCI, tale Brighenti, in cui si esprimeva “la preoccupazione dell’opinione pubblica democratica per l’annunciata<br />
manifestazione anticomunista”. Non ci fu bisogno d’altro: la questura revocò immediatamente il permesso già accordato<br />
alla “Maggioranza Silenziosa”. La motivazione: “Nell’attuale momento politico la manifestazione potrebbe provocare<br />
turbamenti dell’ordine pubblico”. Tali temuti “turbamenti” non ci furono. Il Comitato Anticomunista di Bergamo si limitò<br />
ad emettere un comunicato di protesta, e la manifestazione non si tenne. Quanto al “momento politico”, c’era chi si<br />
adoperava per farlo diventare rovente. Il 7 aprile si svolse a Milano uno sciopero generale “per le riforme”, con<br />
un‘imponente sfilata in centro di scioperanti, di attivisti e militanti, a cui si unirono tutti i gruppi della sinistra<br />
extraparlamentare. La dizione “per le riforme” può risultare poco comprensibile, a tanti anni di distanza: “riforma” infatti<br />
è una parola ideologica; di quelle, per dirla con Elemire Zolla, per la loro “latitudine semantica”, si prestano a diventare<br />
“motti in cui la massa può proiettare ogni sorta di desideri confusi, illudendosi ciascuno di perseguire il proprio scopo”.<br />
Per “fare le riforme”era sorto il centro sinistra in Italia: ma già allora, la parola aveva significati diversi per i partiti che<br />
partecipavano all’esperienza. Coloro che erano gli eredi del vecchio Partito d’Azione aderivano all’idea di “riforme” quale<br />
veniva formulando in quegli anni il segretario carismatico del Partito Repubblicano Italiano, Ugo La Malfa: ossia una<br />
serie di modifiche istituzionali e sociali che portassero alla eliminazione di rendite “improduttive”, di monopoli<br />
capitalistici privati, e al decentramento amministrativo; in una parola, le “riforme” dovevano servire a fare dell’Italia una<br />
democrazia avanzata, e nello stesso tempo a “razionalizzare” il sistema, trasformandolo in un neocapitalismo che<br />
controllava tutto assieme al sindacato. Ma già i socialisti, che aderirono al centro-sinistra, alla irrinunciabile condizione<br />
che le “riforme” fossero finalmente fatte, attribuivano al concetto un tutt’altro significato: per loro, le “riforme” dovevano<br />
essere l’occasione per smantellare centri di potere privatistico, “borghese” cioè, e avviare un processo di stabilizzazione<br />
dell’economia, che segnasse il primato del “politico” sul potere tecnico degli imprenditori. A causa di questo equivoco di<br />
fondo, nacquero – in modo oscuro – la “riforma dell’energia elettrica” (cioè la nazionalizzazione delle industrie private<br />
produttrici di energia), e più tardi la riforma regionale, con la divisione dello Stato in territori (le Regioni) governati da<br />
parlamentini e governetti che riproducevano tutti i vizi del governo e del parlamento centrale, e in alcune delle quali le<br />
sinistre si trovarono ad avere la maggioranza assoluta; una nuova realtà insomma che diede alla classe politica<br />
“professionale” un quasi insperato aumento di potere, di occasioni di sottogoverno, clientelismo, malversazione, che in<br />
più poteva essere presentato come una “avanzata delle forze popolari”.<br />
Tuttavia, queste prime “riforme” portarono al fatto, inevitabile e previsto dall’opposizione, che gli istituti così<br />
“riformati” presero a funzionare peggio di prima. Questo semplice fatto fu interpretato a sinistra come il segno che le<br />
“riforme” erano state “tradite”, che esse non erano state abbastanza “avanzate”. L’impegno “per le riforme” doveva<br />
dunque essere più forte che mai. Nei mesi in cui si svolge la storia che narriamo, il PCI aveva adottato il linguaggio<br />
riformista, ma naturalmente dava al termine “riforma” un significato ancora diverso: esso reclamava “riforme incisive”,<br />
tali cioè da “cambiare i rapporti di forza nel Paese”: frase, quest’ultima, che significava che il PCI doveva andare al<br />
governo. La “lotta per le riforme” era, allora, uno dei motivi costituivi della stessa “unità antifascista” con cui il PCI si<br />
apriva la strada verso il potere: chi “era contro le riforme” era infatti per definizione “reazionario” o fascista, mentre il<br />
variegato “fronte antifascista unitario” era compattamente per le “riforme”. Con tutto ciò, la parola “riforma” non era<br />
diventata affatto più chiara e concreta: la sinistra DC, per esempio, vedeva nelle “riforme” nient’altro che una occasione<br />
di sottogoverno clientelare. L’estrema sinistra gruppuscolare, dal canto suo, dava alla parola un senso più chiaramente<br />
rivoluzionario. Non a caso, alcuni anni dopo, due leaders dell’Autonomia Operaia, Lando Franco Pace e Paolo Virno,<br />
teorizzarono che “un riformismo moderno può farsi le ossa soltanto accettando senza reticenze di convivere con il<br />
fenomeno terroristico, perché il terrorismo altro non è che, un’azione militare attuata per raggiungere obiettivi concreti<br />
accettabili in linea al principio da larga parte dello schieramento democratico”. Insomma, la sinistra parlamentare e la<br />
sinistra terroristica, unite “per le riforme”, moltiplicano “le occasioni di lotta in cui convivano violenza e non violenza,<br />
rottura e trattativa, autodeterminazione e uso proletario delle istituzioni”, secondo il modello leninista di presa del<br />
potere. Possiamo presumere che questo fosse già l’animo con cui, quel 7 aprile 1971, tutto il vasto schieramento<br />
extraparlamentare partecipasse con gli altri “democratici” allo sciopero e alla manifestazione “per le riforme”. Certo è che<br />
esso vi partecipò esibendo tutti i suoi muscoli: “servizi d’ordine” mascherati e armati di spranghe, parole d’ordine<br />
minacciose, atteggiamento di provocazione. Chi scrive vide e ricorda quella manifestazione con la sua carica di mal<br />
trattenuta violenza. Ricorda anche il silenzio della gente che, con volti impenetrabili, osservava la sfilata in piazza San<br />
Babila.<br />
Il 15 aprile un giornale romano pubblicò il testo segreto di un rapporto del Prefetto di Milano, Libero Mazza, diretto al<br />
Ministro degli Interni Restivo. In esso, il Prefetto, descriveva una mappa delle forze dell’estrema sinistra cosiddetta<br />
“extraparlamentare” nel capoluogo lombardo. Mazza valutava a 20.000 gli aderenti ai gruppuscoli, “riuniti in formazioni<br />
Luciano Buonocore – La Maggioranza Silenziosa e il Progetto Tecnocratico 14
paramilitari”, con disponibilità “di servizio medico e collegamenti radio per intercettare le trasmissioni della polizia,<br />
pronti, equipaggiati e armati per atti di “guerriglia urbana”. Questi gruppi armati s’erano resi colpevoli di innumerevoli<br />
disordini, intimidazioni, blocchi stradali, atti di violenza nelle università, nelle fabbriche, nelle scuole”. Il Prefetto<br />
segnalava: “Occorrerebbe quanto meno vietare che i reparti organizzati intervengano alle dimostrazioni in assetto di<br />
guerriglia cittadina, non esitando ad assicurare il rispetto del divieto con la coazione diretta”. Ma poiché d’altra parte “gli<br />
elementi facinorosi vengano incoraggiati e resi più audaci dalla certezza dell’impunità, in quanto ogni “fermezza anche<br />
prudente” nei loro riguardi viene qualificata “come repressione e provocazione poliziesca, attentato alle libertà<br />
costituzionali, fascismo” – Il Prefetto rilevava che ogni ulteriore “fermezza” verso i gruppuscoli era condizionata a “una<br />
scelta di politica generale”. Il rapporto prefettizio era stato stilato il 20 dicembre 1970, era dunque vecchio di oltre 4 mesi<br />
e dipingeva una situazione di cui tutti i milanesi erano perfettamente al corrente, perché gruppuscoli armati sfilavano per<br />
il centro cittadino, si può dire, ogni sabato. Tuttavia l’Avanti, in un articolo furibondo, lamentava che quel documento<br />
“riservato”, e lasciato a dormire per tanto tempo, fosse stato “rivelato in coincidenza con una manifestazione<br />
antiestremistica” annunciata con gran clamore a Milano per due giorno dopo. L’Avanti insinuava insomma la tesi di un<br />
“complotto” reazionario, di cui il rapporto del Prefetto e la manifestazione della “Maggioranza Silenziosa” non sarebbero<br />
stati che due momenti. Quanto all’Unità, lo proclamava a chiare lettere, in un attacco durissimo contro il Prefetto, che<br />
sarà ripreso nei giorni seguenti: “La pubblicazione di questo rapporto costituisce un nuovo grave atto di quella centrale<br />
della provocazione esistente a Milano e che ha portato a un susseguirsi di gravissimi attacchi alla democrazia”. L’Unità<br />
ovviamente negava l’evidenza, asserendo che le “affermazioni contenute in questo rapporto (. . .) danno dei gruppi della<br />
sinistra extraparlamentare una visione del tutto falsa, deformata ed arbitraria: basta dire che le manifestazioni ad<br />
esempio del Movimento Studentesco si sono svolte a Milano nel massimo ordine, quando la polizia non è intervenuta a<br />
proibirle”(sic). Per L’Unità, il rapporto è “farneticante” e le organizzazioni paramilitari di sinistra “fantomatiche”: la<br />
stessa aggettivazione che per anni, poi, il giornale comunista si ostinerà ad applicare alle Brigate Rosse.<br />
L’ostilità operante del PCI verso il figlio legittimo della violenza gruppuscolare, il terrorismo, verrà molto, molto dopo:<br />
nel 1971 maoisti e ultrà, il Movimento Studentesco che spadroneggia all’Università Statale e Lotta Continua e<br />
Avanguardia Operaia sono, tutti, elementi utili di quel “fronte unitario” che, sulla destra, comprende perfino certi<br />
personaggi della DC, e che il partito comunista egemonizza. Ancora una volta, è l’insegnamento di Lenin che viene<br />
applicato. Il partito, per giungere al potere, deve “spingere coloro che sono insoddisfatti, ogni protesta va sostenuta; tutte<br />
le forze che possono essere utilizzate per il movimento rivoluzionario vanno utilizzate tenendo conto che esse sono in<br />
grandissimo numero; per giungere allo scopo, bisogna unire “lavoro illegale e legale”; ricorrere anche a ogni genere di<br />
astuzie, di metodi illegali, di reticenze, di occultamento della verità, perché la lotta è cruenta e incruenta, violenta e<br />
pacifica, militare ed economica. . .”. Nella situazione che stiamo esaminando, è dunque logico che “L’Unità” accusi il<br />
Prefetto Mazza “di andare in cerca di farfalle invece di colpire e perseguire i fascisti” (articolo del 17 aprile dal titolo “E’<br />
ora che se ne vada”).<br />
In un clima avvelenato da queste polemiche, Milano si avvia alla data della manifestazione della “Maggioranza<br />
Silenziosa”. La tensione si traduce in atti di violenza: il mattino del 16 aprile, uno studente di 21 anni, Mario Cardinale<br />
Bosio, viene picchiato selvaggiamente all’Università Statale da “Katanghesi” (i picchiatori del Movimento Studentesco)<br />
che lo accusano di essere “un fascista della Maggioranza Silenziosa”. La notte seguente due giovani che affiggono<br />
manifesti del Comitato Cittadino Anticomunista annuncianti la manifestazione dell’indomani, vengono aggrediti da 30<br />
estremisti con caschi e sbarre di ferro: uno dei due, Giuseppe Di Stefano (è il figlio del noto tenore) è ricoverato con<br />
prognosi di 20 giorni; l’altro, Cesare Re, con prognosi riservata: nel selvaggio attacco ha riportato lo sfondamento del<br />
cranio. Nelle stesse ore della stessa notte, ebbero luogo due attentati di opposto colore, anche se di natura ambigua. Una<br />
bomba-carta esplose fragorosamente davanti alla sede del Partito Comunista di Affori, senza far danni; e un pacco di<br />
tritolo scoppiò davanti alla Federazione del PSI in viale Lunigiana, devastando l’atrio del fabbricato. Questa volta,<br />
l’attentato era “firmato”: sul marciapiede davanti alla sede socialista, furono trovate stampigliature con la scritta “SAM”<br />
(interpretata come “Squadra d’Azione Mussolini”) e, nientemeno, il simbolo del fascio littorio. I “fascisti” che secondo<br />
L’Unità, il Prefetto Mazza trascurava di perseguire, avevano dunque attestato chiaramente la loro pericolosa presenza.<br />
Forse un po’ troppo chiaramente: la sigla “SAM”, già apparsa in passato a firma di strani attentati, era considerata negli<br />
ambienti di destra come “inesistente” e “provocatoria”; e a destra si ricordò allora che l’estrema sinistra era già ricorsa in<br />
passato a quella che potremmo chiamare la tecnica dell’auto-attentato. Mesi prima, in provincia di Forlì, la polizia aveva<br />
scoperto che una sede del PCI era stata incendiata dai suoi stessi frequentatori, i quali poi ne avevano attribuito la<br />
responsabilità ai missini. Fatto sta che i due attentati “fascisti”, autentici o no, scatenarono come a un segnale le proteste<br />
di tutto lo schieramento di sinistra: proteste che si appuntavano tutte, curiosamente, sull’imminente manifestazione della<br />
“Maggioranza Silenziosa”. “Compagni, per la seconda volta a Milano la teppaglia fascista, nascondendosi dietro la<br />
maschera del democristiano, tenta di provocare la coscienza democratica e antifascista delle masse popolari”, gridava un<br />
volantino ciclostilato e distribuito dal Movimento Studentesco. “Chi appoggia queste squallide provocazioni? I partiti<br />
governativi, la DC in testa, che autorizzano la manifestazione di sabato 17 aprile. . .” Il volantino concludeva proclamando<br />
una “assemblea popolare” che si sarebbe tenuta all’Università Statale di Milano per quello stesso 17 aprile, un’ora prima<br />
della manifestazione anticomunista: in pratica, un concentramento di antifascisti a scopo intimidatorio. Un analogo<br />
volantino firmato “la Federazione Milanese del PCI” proclamava nientemeno che “lo stato di allarme antifascista”. Causa<br />
dell’allarme, le “manifestazioni reazionarie di sabato”, con la partecipazione di elementi del MSI, della destra DC ed<br />
esponenti della socialdemocrazia (. . .). Appare anche più grave (. . .) la partecipazione di associazioni combattentistiche e<br />
di destra. Ciò conferma la nostra denuncia sull’esistenza di organizzazioni fasciste e paramilitari, che godono di<br />
protezioni e finanziamenti. Avanziamo ancora una volta la richiesta di andare a fondo sull’accertamento di tutte le<br />
responsabilità, di applicare la legge, di arrestare e processare i criminali, affermare l’autorità dello Stato repubblicano<br />
nato dalla Resistenza. Di fronte a questi avvenimenti bisogna confermare l’appello all’unità delle forze antifasciste e alla<br />
vigilanza per stroncare ogni conato reazionario”.<br />
Il tono è insieme parossistico e indeterminato; si denuncia un pericolo che appare incombente e, nello stesso tempo<br />
vago. Quali sono le “responsabilità ad accertare”, chi sono i “criminali di cui si chiede l’arresto ed il processo?” Gli ignoti<br />
attentatori delle SAM o i promotori della “Maggioranza Silenziosa?”. In ogni caso, il volantino comunista indica una via,<br />
Luciano Buonocore – La Maggioranza Silenziosa e il Progetto Tecnocratico 15
che sarà puntualmente calcata. Su questa linea, il 16 aprile venerdì, un giorno prima dell’annunciata manifestazione, il<br />
segretario del PSI Giacomo Mancini, fa un discorso in Parlamento, in cui praticamente minaccia la crisi di governo se il<br />
corteo anticomunista di Milano si terrà; nello stesso tempo, lo stesso Mancini eserciterà pressioni sulla Questura<br />
milanese perché la manifestazione sia vietata. La manifestazione, tuttavia, è stata autorizzata con largo anticipo. La<br />
Notte, nell’edizione del 17 aprile (che “chiude” attorno alle 11 del mattino) ne dà ancora per certo lo svolgimento, con un<br />
titolo su quattro colonne: “la Maggioranza Silenziosa sfila per le vie di Milano in difesa della libertà”. Dice l’occhiello:<br />
“Ore 17: nuovo appuntamento a porta Venezia”.<br />
PROVOCAZIONI E DISORDINI: 17 aprile 1971<br />
“Il 17 aprile, a mezzogiorno passato, mi trovavo con Pagliuzzi al Bar Donini di piazza San Babila – racconta Luciano<br />
Buonocore – eravamo 3 o 4 dirigenti del Comitato Cittadino, e stilavamo gli ultimi comunicati per la manifestazione che<br />
si sarebbe tenuta di lì a quattro ore. In quelle, arrivò trafelato uno dei nostri ragazzi: veniva dalla Questura, per<br />
comunicarci che l’autorità di polizia aveva revocato l’autorizzazione al corteo, che era perciò vietato. Naturalmente, “per<br />
motivi d’ordine pubblico”. Fra qualche ora migliaia di persone ignare si sarebbero concentrate a porta Venezia e lungo il<br />
luogo del passaggio della manifestazione; non c’era più modo di avvisare quella gente che il corteo non si sarebbe più<br />
tenuto. La prima cosa che feci fu di dire ai giovani del nostro servizio d’ordine di recarsi a porta Venezia, e di convincere<br />
la gente, che certo avrebbe cominciato ad affluire, a tornare a casa; io poi andai a spedire due telegrammi di protesta, uno<br />
al Prefetto ed uno al Questore: in essi dicevo sostanzialmente che loro stessi dovevano essere ritenuti responsabili di<br />
eventuali incidenti che avrebbero potuto verificarsi a causa dell’intempestiva revoca della manifestazione”.<br />
Le ore passarono nei febbrili tentativi di impedire il concentramento di folla. Furono fatte telefonate anche ad altre<br />
città, da dove avrebbero dovuto affluire altri manifestanti; molti furono rintracciati e fermati in tempo, altri no. Verso le<br />
ore 16, sui Bastioni di porta Venezia cominciò ad arrivare la gente. Secondo le valutazioni della polizia, si trattava di<br />
“circa 4000 persone”, cui dovevano aggiungersi “50 missini” già presenti: era il servizio d’ordine organizzato da<br />
Buonocore, formato in gran parte da ragazzi del Fronte della Gioventù. Questa gente trovò ad attenderli un nutrito<br />
schieramento di poliziotti in tenuta da guerriglia urbana: caschi, scudi, fucili con bombe lacrimogene. “Molti dei<br />
partecipanti al corteo ignoravano che la manifestazione era stata vietata – scriveva il Corriere il giorno dopo – fin<br />
dall’inizio comunque era evidente che non tutti avrebbero rinunciato facilmente alla prevista sfilata”. La gente osservava i<br />
poliziotti, incerta sul da farsi. A più riprese un commissario di PS di nome Vittoria, con l’altoparlante, annunciò che la<br />
manifestazione era stata vietata, impartendo ai presenti l’ordine di “circolare”: la folla – fra cui erano presenti molti di<br />
media età, signori borghesi in doppiopetto, signori eleganti – non obbedì. Era la stessa gente che due settimane prima, in<br />
analoga occasione, aveva fraternizzato con polizia e carabinieri; ora, non riusciva nemmeno a pensare che quella schiera<br />
di forze dell’ordine in assetto di guerra fosse lì per lanciarsi contro di lei. Ma alle 16.45 circa, furono squillati i tre<br />
regolamentari squilli di tromba; subito dopo, la polizia caricò, cercando di disperdere la folla candelotti lacrimogeni. Di<br />
qui, i disordini.<br />
Sulla natura di questi disordini, e sul modo in cui si svolsero, esistono due versioni contrastanti. La prima – diciamolo<br />
subito: falsa – è quella accreditata nei titoli dei quotidiani il giorno dopo, che descrivevano gli avvenimenti come “duri<br />
scontri fra polizia e fascisti” (La Stampa) e “scontri a Milano fra polizia ed estrema destra” (Il Giorno). Anzi, Il Giorno<br />
dirà: “Milano ha potuto constatare ieri pomeriggio cosa c’è dietro la cosiddetta “Maggioranza Silenziosa” o, per lo meno,<br />
quali elementi vi si mescolano e vogliono farsene portabandiera. Squadre fasciste, prendendo a pretesto il divieto del<br />
corteo, tentano di tenere la piazza brandendo il tricolore, e attaccano gli agenti (. . .). Purtroppo non basta la bandiera a<br />
nobilitare gli atti di teppismo. La brava gente che ingenuamente si considera parte della “Maggioranza Silenziosa”<br />
dovrebbe capirlo”. E ancora: “Dopo aver saputo che la manifestazione della “Maggioranza Silenziosa” era stata sospesa, i<br />
moderati sono rimasti a casa. Altri, non informati, si sono radunati a porta Venezia, ma hanno aderito all’invito di<br />
sciogliersi rivolto loro dalla polizia. Non così i fascisti, che hanno tentato di formare un corteo; puntando verso piazza San<br />
Babila”. Questa versione dei fatti non è veritiera ma rivela la speranza e i propositi di chi aveva vietato la manifestazione<br />
con tanto ritardo. Il proposito era quello di “far assaggiare” lo scontro di piazza al grosso dei simpatizzanti per la<br />
“Maggioranza Silenziosa”, considerati come un gregge pusillanime e poco politicizzato, inquadrato da un “nucleo duro” di<br />
militanti di destra; al primo accenno di violenza, i “moderati” ei “borghesi” si sarebbero volatilizzati, lasciando allo<br />
scoperto i “duri”, e “neri”, che invece, per vocazione e formazione avrebbero accettato lo scontro e la sfida; in questo<br />
modo si sarebbe potuto separare la massa, considerata passiva, dei benpensanti, dalla sua, diciamo così, “avanguardia”.<br />
Le cose andarono ben diversamente, come può attestare chi scrive, che fu testimone oculare dei fatti, e come<br />
sostengono i promotori del Comitato Cittadino Anticomunista. Durante gli scontri – che si svolsero su un’area assai<br />
vasta, da corso Buenos Aires a piazza Duomo e durarono più di 4 ore – i giovani missini svolsero infatti una parte attiva,<br />
lanciando sassi contro la polizia, percorrendo di corsa le strade con le bandiere alzate, disperdendosi e raggruppandosi<br />
velocemente. Ma la gente comune, i “borghesi e i “moderati” non si volatilizzarono affatto. Il compito della polizia,<br />
impegnata contro i missini, fu reso difficilissimo dalla presenza sul campo d’azione di almeno 4000 persone che, lungi<br />
dallo sciogliersi impaurite, tentavano continuamente di formare un corteo, continuamente disperse dai lacrimogeni e<br />
dalle cariche. Signori in abito scuro e signore in pelliccia camminavano sui marciapiedi nell’aria irrespirabile delle<br />
bombe, per riunirsi al centro della strada tutte le volte che fosse possibile; gruppetti distinti, mentre polizia e missini si<br />
scontravano poco lontano, sfilavano disordinatamente dietro un tricolore, in direzione piazza Duomo. Il Corriere,<br />
relativamente più obiettivo degli altri quotidiani, descriverà parecchi episodi del genere: “il fermo di una ragazza,<br />
avvenuto alle 17 dopo una ennesima carica sui bastioni ha scatenato tra gli astanti – quasi tutti affluiti sul posto per la<br />
manifestazione – un impulso di ribellione che è stato domato con una nuova carica. . .” E ancora: “sul lato della Galleria,<br />
è iniziata una sorta di manifestazione “a singhiozzo”. Piccoli cortei si formavano all’incrocio con corso Vittorio Emanuele,<br />
marciavano sventolando tricolori (non mancavano applausi da parte di cittadini presenti) arrivavano all’altezza della<br />
Galleria e qui erano respinti da un “muro” di agenti e carabinieri. In via Manzoni (. . .) circa 300 giovani si erano fermati<br />
Luciano Buonocore – La Maggioranza Silenziosa e il Progetto Tecnocratico 16
davanti al cinema (Manzoni, n.d.r.) e avevano steso a terra le loro bandiere tricolori. Al primo accenno di carica, però, si<br />
sono ritirati. I carabinieri hanno sequestrato vari vessilli, e c’è stata una vivace protesta da parte di cittadini. I giovani<br />
hanno allora consegnato spontaneamente le aste delle bandiere, tenendo i drappi”. Come si vede, i “cittadini” non solo<br />
non si dissociavano dai giovani di estrema destra, ma addirittura intervenivano in loro difesa. L’episodio di via Manzoni<br />
dice qualcosa di più: lì i carabinieri, evidentemente accedendo alle richieste dei cittadini, hanno usato maniere meno<br />
brutali ma più persuasive: i giovani hanno consegnato spontaneamente le aste delle bandiere (possibili “armi<br />
improprie”).La loro “violenza” non era dunque affatto premeditata, come tentarono di dire poi gli avversari: era la ovvia<br />
reazione ad aggressioni ingiustificate.<br />
Altrove la polizia agì con mano più pesante. Essa “esplodeva candelotti anche all’interno della stazione del metrò (di<br />
piazza Oberdan, n.d.r.)”, come dice il Corriere, coinvolgendo così nella mischia non solo i dimostranti ma anche gli ignari<br />
passanti e passeggeri; del resto era impossibile stabilire chi, nella folla che si muoveva tra gli scoppi, l’urlo delle sirene e<br />
gli inni cantati dai dimostranti, era lì per manifestare e chi era lì, invece, per fare un giro in centro, tipica abitudine<br />
milanese del sabato. In questo modo fra l’altro fu ferita (tre costole incrinate”, dice il Corriere) una giovane di 29 anni,<br />
Maria Grazia Ventura, che stava appunto uscendo dalla metropolitana, e che era completamente estranea ai disordini. La<br />
polizia arrestò un ex partigiano: Ubaldo Ranzi, presidente regionale dell’Associazione “Volontari della libertà”: il Ranzi<br />
stesso era intervenutoi presso un gruppo di poliziotti che stavano arrestando un giovane manifestante, che sventolava un<br />
tricolore e gridava “Viva l’Italia”. Alle dimostranze del Ranzi, gli agenti presero anche lui e lo caricarono su una<br />
camionetta portandolo in Questura. “Oggi in Italia gridare “Viva l’Italia!” può configurarsi come un reato”, protestò<br />
l’Associazione Partigiana cui il Ranzi apparteneva, in un suo comunicato. Ma l’episodio che colpì i presenti fu un altro,<br />
che s’impresse nella mente di molti come un fatto simbolico. Fu la visione di un noto avvocato milanese, Adamo Degli<br />
Occhi, che era venuto per partecipare al corteo, e dopo i disordini e le cariche, si avvolse una bandiera tricolore<br />
sull’elegante completo grigio, e avanzò solennemente lungo corso Vittorio Emanuele, verso piazza Duomo. Molta gente si<br />
accodò spontaneamente a quell’uomo, moltissimi applaudirono vedendolo passare. La polizia non lo fermò se non<br />
davanti a Palazzo Marino, sede del Comune, dove l’avvocato chiede di parlare con il sindaco. “Non avendolo trovato, ha<br />
lasciato nel suo ufficio una lettera di fiera protesta”, gli fa dire Il Giorno. Adamo Degli Occhi, anch’egli ex partigiano, sarà<br />
uno dei protagonisti delle prossime vicende della “Maggioranza Silenziosa”, e uno dei più sfortunati. Su di lui si accanirà<br />
una vera e propria persecuzione. Gli scontri ebbero termine soltanto verso le 20.30. Il bilancio: ventidue fra feriti e<br />
contusi, 87 i “fermati” e denunciati, 8 arrestati (saranno poi processati “per direttissima”).<br />
UNA DELEGAZIONE IN PAR<strong>LA</strong>MENTO<br />
Il divieto alla manifestazione della “Maggioranza Silenziosa” e i successivi incidenti scossero profondamente le<br />
coscienze, non solo dei milanesi. Moltissime lettere di solidarietà pervennero da tutta Italia al Comitato Cittadino<br />
Anticomunista, e tutte incitavano a non lasciarsi piegare dall’arroganza delle forze marxiste e filomarxiste. “In quelle<br />
lettere – dice Buonocore – la protesta di migliaia di cittadini contrari al comunismo assumeva sempre più un tono di<br />
POLITICITA’ che andava oltre il semplice sdegno. Sempre più chiaramente si esprimeva il dubbio che le forze di governo<br />
volessero e potessero garantire le libertà costituzionali”. Di qui la decisione del Comitato di farsi interprete di questo stato<br />
d’animo, portando la protesta della “Maggioranza Silenziosa” in Parlamento. Si recò a Roma una delegazione così<br />
formata: Gabriele Pagliuzzi per il PLI, Luciano Buonocore per l’MSI, Piero Cattaneo per la DC e il Centro Sturzo, Franco<br />
Nodali per i Bocconiani Indipendenti, Piero Mosini per il PSDI. Fu ricevuta dai capigruppo parlamentari della<br />
Democrazia Cristiana, del Movimento Sociale, del Partito Socialdemocratico e di quello Liberale, poi anche dal<br />
sottosegretario agli Interni, Rodolfo Sarti, e dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. “In questi incontri – ricorda<br />
Pagliuzzi – esprimemmo tutta la nostra indignazione per i gravi incidenti a Milano e chiedemmo con fermezza che<br />
venissero rispettate le libertà costituzionali, soprattutto la libertà di esprimere l’opposizione alla strategia, già dichiarata,<br />
del compromesso storico. Comunicammo ai parlamentari la volontà del Comitato di indire una nuova manifestazione per<br />
il mese di maggio. Ma l’On. Sarti ci garantì che il Governo non si sarebbe opposto”.<br />
Al ritorno a Milano, il Comitato si fece ricevere dal Prefetto Libero Mazza, con il quale concordò la data per la prossima<br />
manifestazione, fissata per il 29 maggio. Sul “rapporto Mazza” infuriavano proprio in quei giorni le polemiche. Il 30<br />
aprile, il ministro degli Interni Restivo rispondeva in Parlamento alle interrogazioni presentate da ogni parte politica in<br />
seguito alla divulgazione del “rapporto”. L’intervento del ministro è lungo e cauto, secondo la consolidata consuetudine<br />
del governo, di non fare discorsi che possano indispettire i socialisti e i comunisti. Tuttavia, pur tra cautele e<br />
minimizzazioni, Restivo conferma il “rapporto”: “Questi estremisti (di sinistra, n.d.r.) – dice il ministro – dispongono di<br />
organizzazione, equipaggiamento e armamento che può qualificarsi paramilitare: servizio medico, collegamento radio fra<br />
i vari gruppi, servizio intercettazione radio della polizia, elmetti, sbarre di ferro, fionde per il lancio delle biglie di acciaio,<br />
trapani per bottiglie molotov, selci, bastoni, ecc.”. In quella occasione comunisti e socialisti attaccarono violentemente,<br />
chiedendo la destituzione immediata del Prefetto Mazza. Da parte della maggioranza, in difesa del Prefetto, intervennero<br />
Carenini (DC), Bucalossi (PRI) e il capogruppo parlamentare del PSDI, Flavio Orlando; questi nel suo intervento attaccò<br />
l’editore Giangiacomo Feltrinelli, “Il miliardario rosso”, ricordando che egli, sulla rivista TRICONTINENTAL, faceva<br />
appello alla violenza di classe e illustrava nei particolari i modi per costruire ordini esplosivi. A difendere Mazza<br />
intervengono anche il liberale Giomo, il missino Servello e il monarchico Covelli. Dalla parte contraria, i più decisi sono il<br />
socialista Riccardo Lombardi ed Eugenio Scalfari. Su Scalfari bisogna aprire una parentesi. Direttore de “L’Espresso”, era<br />
stato eletto nelle liste socialiste, e non aveva ancora abbandonato la direzione del settimanale: lo farà nel giugno, su<br />
pressione, sembra, della redazione. Sulla violenza “studentesca” di sinistra, le posizioni di Scalfari erano vistosamente<br />
cambiate nel giro di poche settimane. Il 30 luglio 1967 le aveva stigmatizzate così: chi è appena un po’ più anziano, fiuta<br />
un ritorno di mode, di atteggiamenti, di culture, che forse sembrano nuove ai più giovani, che nascondono un’orribile<br />
decrepitezza e ricordano vigilie conclusesi in catastrofi spaventose”. Ancora il 3 marzo ’68, sempre su L’Espresso<br />
biasimava i “comunisti e socialisti di varia osservanza che hanno assolto tutti gli eccessi, tutti gli errori e le ingenuità dei<br />
comitati d’agitazione studenteschi”. Ma già il 21 aprile commentava il recente assalto di ultrà con spranghe e bastoni al<br />
Luciano Buonocore – La Maggioranza Silenziosa e il Progetto Tecnocratico 17
Corriere della Sera in tutt’altro modo: “L’assedio delle tipografie per bloccare l’uscita del giornali è un mezzo nuovo di<br />
lotta, molto più sofisticato ed efficace delle barricate ottocentesche e degli scioperi generali. L’assalto al Corriere può<br />
essere un ammonimento per tutte quelle grandi catene di giornali abituate ormai da lunghissimo tempo a nascondere le<br />
informazioni ed a manipolare l’opinione pubblica (. . .). Chi ama la libertà e piena non può che rallegrarsene e trarne felici<br />
presagi per l’avvenire”. Da quel momento, Scalfari si accrediterà come interlocutore del Movimento Studentesco,<br />
cercando in qualche modo di suggerire ad esso atteggiamenti e posizioni: “La rivoluzione non si compie mai nei giorni<br />
dorati del vino e delle rose, ma attraverso un lungo cammino per anni oscuri, confusi, fangosi e talora sanguinosi. . .”<br />
scriveva nell’AUTUNNO DEL<strong>LA</strong> REPUBBLICA, 1969, un libro a cui aveva apposto questa dedica:”Questo libro è dedicato<br />
a due persone. Una mi ha insegnato a non farmi corrompere dal potere, l’altra a non disperare nella rivoluzione”. La tesi<br />
di fondo di Scalfari era che la “sinistra riformatrice e la sinistra rivoluzionaria erano indispensabili l’una all’altra”. Una<br />
tesi ambigua, se si sa che, per Scalfari, la “sinistra riformatrice” si identifica da sempre nell’ideologia della grande<br />
industria “laica”, illuminista, tecnocratica, degli Agnelli, degli Olivetti, dei Pirelli. Nei mesi stessi in cui si dichiarava<br />
pronto a precedere gli studenti “rivoluzionari” nella loro marcia verso l’avvenire, infatti, Scalfari deplorava le richieste<br />
sindacali di aumenti salariali (vedasi ad esempio L’Espresso del 29 luglio 1969).<br />
Il 3 agosto ’69 firma sul giornale due articoli affiancati, in cui la sua tattica equilibrista non potrebbe essere più evidente.<br />
Nel primo (L’arma segreta dei padroni) dipinge l’industriale Leopoldo Pirelli come il cavaliere dell’ala progressista del<br />
capitalismo italiano, capace di proposte rivoluzionarie che superano le stesse richieste sindacali, e favorevole ad un<br />
rafforzamento nelle fabbriche del sindacato unitario; nell’altro (Una corrida per l’autunno), da conto di un colloquio<br />
avuto con Oreste Scalzone (il futuro “omogeneo” dei terroristi delle Brigate Rosse), che in quel periodo aveva cominciato<br />
a concentrare un’attiva azione di propaganda estremista nelle fabbriche, nel tentativo, poi riuscito, di suscitare fra gli<br />
operai gli stessi fermenti massimalisti che agivano nel Movimento Studentesco. “Mi auguro che questi giovani –<br />
concludeva Scalfari – e in pochi o molti operai che sono con loro, non dimentichino che per quanto piccolo, avranno<br />
anch’essi un ruolo nei prossimi mesi. Fare ad essi il discorso della responsabilità sarebbe non soltanto ingiusto, sarebbe<br />
sciocco. Ad essi bisogna fare soltanto il discorso dell’efficienza. Come a tutti quelli che vogliono molto, gli si può<br />
perdonare ogni cosa, salvo che di essere sconfitti”. Sappiamo come poi l’invito alla “efficienza” sarà accolto, nei mesi e<br />
negli anni a venire, dal terrorismo di sinistra. Va detto però che Scalfari non fu solo in quest’opera di “suggerimento” (e di<br />
strumentalizzazione) della violenza giovanile. Quella violenza, nei giorni di cui scriviamo, venne apertamente indirizzata<br />
contro la “Maggioranza Silenziosa” da personaggi che rivestivano responsabilità politiche. Il Corriere della Sera, il 6<br />
maggio 1971, dà notizie di una delegazione “antifascista” ricevuta dal ministro Restivo e dall’On. De Martino. “Il<br />
consigliere Andreini (uno dei componenti della delegazione, n.d.r.) ha duramente criticato il rapporto Mazza sull’attività<br />
dei gruppi parlamentari di estrema sinistra, chiedendo l’intervento dei pubblici poteri contro i fascisti. Ha affermato<br />
inoltre che i partiti della sinistra non potrebbero non ritenere provocatorie nuove manifestazioni anticomuniste. E’ chiaro<br />
il riferimento – commenta il Corriere – alla manifestazione della “Maggioranza Silenziosa” indetta per il 24 maggio<br />
prossimo”.<br />
L’appello implicito in questa protesta viene subito accolto. Il 24 aprile uno studente, Marco Gnochi, viene aggredito<br />
all’interno della facoltà di Chimica, dove studia, e ferito al capo. Il 7 maggio ultrà bloccano e sequestrano nell’Istituto di<br />
Matematica quattro professori, Casotti, Porcu, Locatelli, Peretti. Il giorno seguente viene occupata la Facoltà di<br />
Architettura e messo fuori uso il calcolatore elettronico del Trifoglio; la polizia, intervenuta per sgombrare la Facoltà, è<br />
duramente attaccata. Il 9 maggio un consigliere di zona del MSI, Remo Casagrande di 30 anni, è sprangato a sangue da<br />
una ventina di estremisti che gridano “morte al fascista”. Il 10 maggio all’Università Statale, un altro giovane accusato di<br />
essere “fascista” Valentino Redaelli – si tratta in realtà di un apolitico, iscritto al quinto anno di Medicina – è<br />
selvaggiamente picchiato. Nella stessa giornata altri estremisti di sinistra aggrediscono al liceo “Parini” studenti della<br />
“Nuova gioventù liberale” e della “Confederazione Studentesca”. Il 18 maggio, il fatto più grave: un giovane operaio<br />
missino viene ridotto in fin di vita. Ecco come il Corriere riporta i fatti: “Alcuni studenti di opposte tendenze politiche (. .<br />
.) hanno riconosciuto lo Spanò e l’hanno circondato gridando : “E’ un fascista!”. Il missino si è dato allora alla fuga,<br />
dirigendosi verso una vicina autorimessa. Il fuggiasco, inseguito da una torma di giovani scatenati, ha infilato di corsa<br />
una rampa che conduce all’officina. “E gli altri dietro – ha riferito un testimone – in venti e più. . .Urlavano come<br />
indiani”. Lo Spanò, una volta entrato nell’officina, è rimasto in trappola. Gli inseguitori lo hanno circondato, assalito,<br />
picchiato a sangue. Ai pannelli lungo le pareti erano appesi chiavi inglesi, tubi, catene: gli aggressori se ne sono<br />
impadroniti ed hanno usato questi arnesi come armi per sfogare il loro rabbioso istinto di violenza sul giovane missino. I<br />
medici gli hanno riscontrato una contusione toracico-addominale, una sospetta lesione dell’emi-percardio, una ferita<br />
lacero-contusa al cuoio capelluto e un’altra alla gamba destra. La prognosi è riservata”.<br />
Il 19 maggio il Movimento Studentesco occupa la Statale. Interviene la polizia, che è attaccata dal “servizio d’ordine”<br />
degli estremisti, in tenuta da guerriglia, con bastoni, mazze fionde; un funzionario di polizia, dottor Lombardi, è picchiato<br />
a sangue: ricoverato all’ospedale San Carlo, gli vengono riscontrare “ferite multiple al capo, contusione cranica, abrasione<br />
e un vasto ematoma all’addome”. Dopo le violenze, scatta quella che i componenti del Comitato Cittadino Anticomunista<br />
definiscono la “provocazione”: le bombe attribuite o attribuibili ai “fascisti”. Ricompare la fantomatica sigla “SAM”, che<br />
firma attentati esplosivi (senza feriti) contro il quotidiano “Il Giorno”, contro una sede dell’ANPI e contro una sezione del<br />
PCI a Sesto S. Giovanni. “Alla ricerca dei “fascisti” colpevoli degli attentati – ricorda Buonocore – cominciarono allora le<br />
persecuzioni giudiziarie contro giovani di destra, per opera dei primi magistrati politicizzati che teorizzavano e<br />
applicavano la “teoria del diritto evolutivo”. Il nostro parere era allora, e tale rimane adesso, che questi atti di violenza<br />
“fascista” fossero creati ad arte per controbilanciare, e in qualche modo giustificare a posteriori, la violenza di sinistra: gli<br />
stessi ambienti politici e giornalistici infatti che senza esitare attribuivano quegli attentati a non identificati “fascisti”<br />
erano poi quelli che offrivano una copertura giustificazionista alle violenze rosse. Voglio aggiungere che in questa opera<br />
di copertura-provocazione si misero particolarmente in luce quotidiani come il Giorno e Il Messaggero, settimanali come<br />
Panorama, L’Espresso, Il Mondo; da parte politica, oltre al PSI e PCI, si illustrava la sinistra democristiana la quale<br />
invece di reclamare che fossero fatte rispettare le leggi dello Stato, si univa a socialisti e comunisti nell’aizzamento della<br />
violenza di piazza delle sinistre extraparlamentari. Tutto ciò dava preciso agli ultrà il senso della loro impunità”.<br />
Luciano Buonocore – La Maggioranza Silenziosa e il Progetto Tecnocratico 18
Aggiunge Gabriele Pagliuzzi: “ci fu in questo una fatale cecità della classe politica: la stolta convinzione di poter<br />
strumentalizzare ai propri fini la violenza politica rossa, senza capire che questa impunità garantita ai violenti avrebbe<br />
portato a tragedie, come poi le Brigate Rosse dovevano dimostrare. A mio parere, l’unità delle forze anticomuniste, che<br />
erano maggioritarie nel Parlamento e nel Paese, avrebbero potuto evitare queste tragedie”.<br />
<strong>LA</strong> TERZA MANIFESTAZIONE: 29 maggio 1971<br />
Questo clima in cui il Comitato Cittadino Anticomunista preparava la manifestazione indetta per il 29 maggio. Il<br />
percorso, concordato con la Questura, era il seguente: concentramento in via Palestro, con passaggio per via<br />
Fatebenefratelli e via Pontaccio e conclusione in piazza Castello; come si noterà non era il classico “circuito centrale” delle<br />
manifestazioni milanesi San Babila - Vittorio Emanuele - Piazza Duomo. Le sinistre esercitarono tutto il loro peso politico<br />
per fare in modo che la manifestazione venisse vietata. Nell’Università del 26 maggio si legge: “Nel pomeriggio di ieri una<br />
delegazione del Comitato permanente Antifascista di cui fanno parte i segretari di partito, i dirigenti sindacali, e delle<br />
organizzazioni aderenti si è recato dal Prefetto Mazza per esporgli le decisioni del Comitato con la richiesta del divieto<br />
della manifestazione fascista di sabato, ricordando che, nel caso in cui l’autorità non vietasse la marcia, il Comitato<br />
chiamerà i lavoratori e i cittadini ad una grande manifestazione antifascista in piazza del Duomo, nella stessa giornata di<br />
sabato”. Il Prefetto Mazza rifiuta di vietare la manifestazione. Perciò, il 27 maggio l’Unità scrive che il PCI ha convocato<br />
per lo stesso giorno “riunioni ed assemblee del comitato federale, della commissione federale di controllo, dei segretari<br />
delle sezioni delle città e dei segretari e attivisti delle organizzazioni di fabbrica, per una assemblea straordinaria delle<br />
sezioni della città e della provincia”. Nello stesso numero l’Unità attacca pesantemente il Prefetto accusandolo di aver<br />
concesso il permesso per il “raduno sedizioso della “Maggioranza Silenziosa”, nonostante le petizioni, gli ordini, le<br />
delegazioni che nei giorni scorsi avevano chiesto e che tuttora chiedono al governo – tramite il Prefetto o direttamente –<br />
di impedire la vergogna per la democrazia italiana di una nuova sortita legalizzata della peggior feccia del teppismo<br />
fascista, sotto l’egida politica della destra comunque collocata, dai missini, monarchici, liberali a certi democristiani, a<br />
certi socialdemocratici”.<br />
Sempre nello stesso giorno il Comitato Antifascista convoca i milanesi in piazza Duomo per il 29 maggio, in<br />
concomitanza con la manifestazione della “Maggioranza Silenziosa”. Dal canto suo, il Movimento Studentesco convoca<br />
per il 29 una propria manifestazione con corteo in partenza dalla Statale. Lotta Continua, Potere Operaio e il Manifesto<br />
indicono un raduno in piazza Cadorna, cioè ad un centinaio di metri da piazza Castello, dove si sarebbe conclusa la<br />
manifestazione anticomunista. A questa avevano già dato la loro adesione moltissimi: liberali, missini, ex partigiani,<br />
socialdemocratici, democristiani, associazioni combattentistiche, associazioni studentesche e di genitori. La pressione<br />
politica “antifascista” provocò tuttavia le prime manifestazioni. Il segreto giovanile del PSDI aveva avuto fin dall’inizio<br />
parte attiva nell’organizzazione del Comitato Anticomunista: ma in quell’occasione ritirò la sua adesione divulgando alla<br />
stampa un comunicato in cui si dissociava dalla “Maggioranza Silenziosa”. Questo comunicato, ricorda Gianpaolo Landi,<br />
“suscitò l’indignazione di moltissimi socialdemocratici, che ci espressero la loro solidarietà”. Anche nella DC le minacce<br />
comuniste ebbero il loro effetto. “Massimo De Carolis – dice ancora Landi – pur incitandoci a non mollare, non ebbe il<br />
coraggio di schierarsi apertamente con noi. Non solo. La DC aderì ufficialmente alla manifestazione indetta dal Comitato<br />
Antifascista”.<br />
Luciano Buonocore: “Trovammo invece al nostro fianco i partigiani democristiani “Volontari della Libertà”, tutto il<br />
MSI, il centro Alcide De Gasperi, i centri Sturzo, le organizzazioni studentesche indipendenti, i giovani liberali, centinaia<br />
di singoli democristiani. Fu dalla nostra Nino Nutrizio, direttore de “La Notte” che scrisse nel giorno della manifestazione<br />
un bellissimo articolo dal titolo “Dobbiamo contarci”: “Dobbiamo contarci, perché la democrazia è anzitutto e soprattutto<br />
numero. Dobbiamo contarci: ma non oggi, in piazza. In un avvenire, il più prossimo possibile, alle urne, con tutta la<br />
serietà e le garanzie che la gravità del momento richiedono. Ne ha diritto il popolo sovrano, quel popolo che – come ha<br />
detto ieri Saragat – con l’avvento della Repubblica “ha conquistato l’esercizio della propria sovranità”. Questa sovranità<br />
del popolo non deve essere un gargarismo con il quale ci si sciacqua bocca e gola: né una lustra, con la quale si fa credere<br />
ciò che non è. Se esiste una sovranità del popolo, esso ha il sacrosanto diritto di esercitarla: alle scadenze previste, se<br />
tutto è normale; nei momenti di svolte storiche, ove esse si presentino. Saragat ha detto ancora “I cittadini avevano avuto<br />
modo (allora, nel 1946!) di esprimere direttamente la propria voce, allorché nel medesimo tempo che eleggevano i<br />
componenti dell’Assemblea si pronunziavano per la soluzione repubblicana nella votazione per il referendum. Unico<br />
esempio, questo, di rovesciamento di un regime monarchico con mezzi democratici e per ciò stesso primo titolo di merito,<br />
prima prova di civiltà da parte della rinata democrazia”. Perfetto. Non poteva essere detto meglio. E non vi era giornata<br />
più opportuna di quella di ieri per rievocarlo tanto autorevolmente. Oggi non sono in gioco la monarchia o la repubblica:<br />
ma qualche cosa di molto più importante: la libertà. Allora, nel 1946, “scongiura ogni possibilità di ritorni autoritari<br />
oppressivi e vessatori “fu assicurato “l’illimitato sviluppo e il progressivo arricchimento dei contenuti effettivi della<br />
libertà. Quel compito fu portato a compimento, malgrado il momento non fosse facile per il Paese”. “Con la libertà – e<br />
così concluderemo con le citazioni di Saragat – ogni avanzamento è possibile e così ogni riforma e ogni soluzione di<br />
problemi tuttora aperti; mentre senza libertà tutto questo sarebbe possibile; o quand’anche possibile, vano”. Orbene. Per<br />
mille segni e indizi e manifestazioni e minacce, la libertà oggi in Italia corre gravi pericoli. Non si vive più tranquilli e<br />
sereni nelle strade, nelle fabbriche, nei posti di lavoro, nelle scuole. Minoranze o maggioranze che siano, si combattono,<br />
tentano di sopraffarsi con mezzi violenti, abbandonando il solco della democrazia e quindi della libertà. I regimi<br />
autoritari, oppressivi, vessatori possono essere sostanzialmente due, assai simili fra loro: uno di destra, nazionalista,<br />
legato a individui particolari o a piccoli gruppi (Mussolini, Hitler, Franco, colonnelli) che chiameremo per comodità e per<br />
convenzione “fascismo”; e uno internazionale, imperialista, superautoritario, negatore dell’individuo e della libertà, che è<br />
il “comunismo”. Oggi a Milano si svolgono nel pomeriggio quattro manifestazioni contemporanee: una anticomunista e<br />
tra antifasciste. Tutte e quattro hanno la pretesa d’essere inscenate, sostenute, alimentate da individui assolutamente<br />
democratici. Ma tali si considerano loro stessi, come quel tale che “si considerava” idoneo alla promozione e metteva in<br />
calce al giudizio la propria firma. Non siamo noi, ovviamente, a poterci giudicare. Sono gli altri che danno un giudizio su<br />
Luciano Buonocore – La Maggioranza Silenziosa e il Progetto Tecnocratico 19
di noi: e noi lo diamo sugli altri. Se ci sono in ballo equivoci o malafede, questi si perpetuano all’infinito, ove non si agisca<br />
in modo chiaro e risoluto per eliminarli e ristabilire la verità. Gli uni dicono: noi siamo democratici e ci battiamo contro il<br />
comunismo, che democratico non è (a Praga non hanno voluto sentire nemmeno la voce dei comunisti; proprio una bella<br />
libertà!); gli altri rispondono, alzando la voce: noi siamo democratici e ci battiamo contro il fascismo (che esista o meno<br />
oggi, un autentico fascismo in Italia è problema ancora da chiarire e dimostrare). Gli uni e gli altri pretendono di avere<br />
ragione. Milano oggi darà una prova di civiltà, di democrazia e di politica, con le sue quattro manifestazioni<br />
contemporanee, anche perché il centro cittadino sarà presidiato dalle forze dell’ordine, come forse mai lo fu in questi<br />
anni; e perché il Questore Ferruccio Attilio Bonanno – diamogli atto questa volta di essere stato liberale e imparziale – ha<br />
fatto in modo che tutti si adunino, ma che nessuno si veda o si senta o si incontri. La città sarà divisa in settori, da<br />
sbarramenti rigidi di forze dell’ordine. In questo modo l’ordine sarà garantito per oggi. Ma domani e dopo, purtroppo,<br />
tutto tornerà come prima. E la violenza riprenderà quota e la libertà sarà sempre più derisa, avvilita, conculcata. Nel<br />
1946, la situazione era molto meno grave di oggi, perché l’Italia era distrutta e non faceva gola a nessuno; la Russia si<br />
curava le sue ferite; il fascismo era appena morto; il comunismo era ancora una forza in divenire; l’America era sola ad<br />
essere armatissima e potentissima. Oggi, dopo 25 anni, l’Italia riconosciuta fa gola a chi ha in mente di estendere il suo<br />
impero verso i mari caldi e l’Africa, attraversando l’ultimo lembo di Europa (non a caso ieri Saragat ha parlato di alleanza<br />
atlantica e di “tutela della nostra indipendenza”; chi potrebbe minacciarci? La Svizzera, la Spagna, la Francia o la Russia,<br />
passando dalla Jugoslavia?). L’America non è più la sola ad essere armata e potente. La Russia osa guardarla da pari a<br />
pari; e in Europa è certamente più forte. Il comunismo è talmente potente, e affermato da condizionare tutta la vita<br />
politica ed economica italiana (vedi legge della casa e azione dei sindacati). Il fascismo non è rinato, ma potrebbe trovare<br />
un terreno fertile per la sua affermazione. Che cosa occorre a questa Italia tormentata e in crisi? Le occorre conoscersi<br />
meglio e contarsi. Dobbiamo contarci nelle urne. E i temi devono essere semplici e ridotti all’osso, come lo furono in quel<br />
2 giugno 1946, quando nacque la Repubblica. Il popolo italiano – ma anche quello svizzero, più evoluto e democratico del<br />
nostro – capisce i referendum. Non si tratta di chiedergli se vuole la pace o la guerra; se vuole la monarchia o la<br />
repubblica; se vuole la Russia o l’America. Si tratta di stabilire, una volta per tutte, se l’Italia gradisce, accetta, approva<br />
oppure rifiuta un governo con l’appoggio o la benevolenza o la partecipazione dei comunisti. Se l’Italia risponde si, che lo<br />
vuole, finisco tutte le grane e le violenze; se l’Italia risponde no, che non vuole i comunisti, allora il governo e le autorità<br />
costituite dovranno darsi da fare per rispettare quella famosa sovranità del popolo, di cui tanto si parla. Se non si arriva a<br />
questo, a una chiara consultazione democratica, perderemo la democrazia e la libertà. E’ inutile illudersi: ieri persino il<br />
“Corriere” si è accorto che, con l’inizio del semestre bianco, possono cominciare dei gravissimi guai. Ed ha concluso<br />
dicendo per quelli che dovevano capire: “Il semestre bianco non è cominciato”. Poi si è subito messo a riposo, per<br />
l’enorme fatica fatta. Una specie d’ernia da sforzo politico”. Questo l’articolo di Nino Nutrizio.<br />
Ma torniamo al C.C.A. Restava parimenti compatto il nucleo dirigente originario del Comitato Cittadino Anticomunista<br />
(Buonocore. Pagliuzzi, Landi, Fiore, Nodali, Pasquino di Marineo, Formenti, Dubini, Predolin, Manzoni). Un suo<br />
comunicato, diramato alla stampa in quei giorni, mentre invita i cittadini a partecipare alla manifestazione del 29 senza<br />
portare simboli dei partiti e associazioni, afferma:<br />
“In un momento in cui tutto il fronte della sinistra è mobilitato in una odiosa gara che ha come<br />
obiettivo quello di far comprendere agli italiani che non è più possibile manifestare idee, sentimenti e<br />
intenzioni che siano in contrasto con quelle approvate e sottoscritte dal partito comunista, la coscienza<br />
libera e democratica di tutti i cittadini deve impegnarsi affinché ognuno assuma con coraggio la propria<br />
responsabilità di partecipare a questa pacifica battaglia per la legalità democratica contro l’unico<br />
totalitarismo attuale, che è quello che si riscontra nell’attività violenta e liberticida della sinistra”.<br />
Si organizzano gruppi per affiggere e distribuire manifesti: attività in quei momenti molto pericolosa, perché squadre di<br />
attivisti comunisti si aggiravano di notte per la città armati di sbarre di ferro, per aggredire i membri del Comitato<br />
impegnati nell’opera di attacchinaggio. Tuttavia a quest’opera si prestarono giovani e meno giovani. “Ricordo fra gli altri<br />
– dice Buonocore – un frate ex partigiano ed iscritto alla DC, fratel Beltrando, che alla bella età di 68 anni veniva con noi<br />
ad attaccare i manifesti. Un contributo ci venne anche dal gruppo che faceva capo all’ingegner Nodali: Jacini, Porta,<br />
Bergamasco, Soda, Isolabella, e Duchene de Vère. Le organizzazioni lombarde del Fronte della Gioventù di cui io ero il<br />
responsabile, svolsero ovviamente una parte di primo piano”. I giovani liberali, che facevano capo a Pagliuzzi, con i<br />
monarchici di Landi e Fiore si occuparono soprattutto della distribuzione dei volantini e della propaganda a mezzo posta.<br />
Nel giro di qualche giorno, nonostante i pattugliamenti degli attivisti comunisti, tutta Milano e provincia erano<br />
tappezzate di manifesti che annunciavano la manifestazione. “Per quest’azione avevo la disponibilità di un finanziamento<br />
– dice Gianpaolo Landi – un milione. Un assegno che avevo ottenuto in ambienti confindustriali milanesi. Mi era stato<br />
consegnato con straordinarie precauzioni: tre o quattro girate fasulle, perché fosse impossibile risalire a chi lo aveva<br />
intestato. Lo scopo del finanziamento. Era la promozione di un’azione genericamente anticomunista”.<br />
Il pomeriggio del 29 maggio, il centro di Milano apparve deserto, presidiato da diecimila poliziotti con scudo e casco.<br />
L’atmosfera di paura era palpabile; pochissimi i passanti. Che camminavano guardandosi attorno con sospetto. “Ricordo<br />
benissimo – dice Buonocore – che alle 17 in corso Venezia non c’era anima viva, poliziotti a parte. Poi, a poco a poco,<br />
prima decine, poi centinaia di milanesi cominciarono a raccogliersi in via Palestro, per lo più sbucando dalle uscite della<br />
metrò. Nel giro di mezz’ora erano già qualche migliaio. Qualcuno intonò l’inno di Mameli, e subito altre voci si unirono al<br />
canto. Spuntarono dalla folla, dovunque, centinaia di bandiere tricolori”. Ma vediamo come il Corriere della Sera, il<br />
giorno dopo, descriveva la manifestazione. “Il corteo organizzato dal Comitato Cittadino Anticomunista ha riunito<br />
migliaia di persone che sventolando bandiere tricolori ritmando slogans contro il comunismo. I dimostranti hanno<br />
cominciato a radunarsi all’incrocio di via Palestro con corso Venezia prima delle ore 17: lentamente si è formata la testa<br />
del corteo, che si è mossa alle 17.45 al grido di “Il comunismo non passerà”. In quel momento la folla poteva essere<br />
valutata in quattromila persone. Ma la colonna si è ingrossata via via lungo il tragitto. Faceva strada al corteo un<br />
massiccio contingente di polizia e carabinieri in assetto da campagna. Veniva poi, davanti al primo cordone di<br />
manifestanti, un’auto munita di altoparlanti, che diffondevano le note dell’inno di Mameli alternate a sonori inviti rivolti<br />
Luciano Buonocore – La Maggioranza Silenziosa e il Progetto Tecnocratico 20
al pubblico: “Cittadini, unitevi a questi italiani! Non abbiate paura di manifestare contro il comunismo”. L’invito è stato<br />
raccolto da molti, cosicché alla fine il corteo è risultato piuttosto eterogeneo: accanto ad un nucleo di fede neofascista<br />
sfilavano monarchici, democristiani, liberali, socialdemocratici, e persone di ogni età che si proclamavano semplicemente<br />
anticomunisti senza una precisa etichetta politica. Gli striscioni inalberati dai dimostranti, fra una selva di bandiere<br />
tricolori di ogni forma e dimensione (c’erano vessilli sabaudi, una vecchia bandiera usata per coprire la bara di un caduto<br />
e persino un ombrellino bianco, rosso e verde), dicevano: “Italiani, una sola bandiera contro il comunismo”; “No al<br />
comunismo”; “Fuori i teppisti dall’Università”; “Milano dice basta alla violenza rossa”; “No alla TV rossa”; “Operai liberi,<br />
unitevi!” Una grande scritta si distingueva dalle altre: “No a tutte le violenze!”. Sotto una pioggia di manifestini (“Libertà<br />
si, comunismo no”,”La Maggioranza Silenziosa contro la dittatura”), il corteo ha raggiunto piazza Cavour imboccando via<br />
Fatebenefratelli. I dimostranti scandivano slogans come: “Giustizia, ordine, libertà”;”Roma si, Mosca no”;”Fuori i rossi<br />
dall’Università”. Risuonava con insistenza anche una domanda polemica rivolta al sindaco: “Aniasi dove sei?”. Subito<br />
dopo l’incrocio con via San Marco, la manifestazione è entrata nella fase più calda, che fortunatamente si è risolta senza<br />
conseguenze gravi. Da alcune finestre del vecchio isolato all’angolo fra via Brera e via Pontaccio un gruppo di giovani<br />
barbuti si è prodotta in gesti di scherno e versacci all’indirizzo del corteo. L’auto “ammiraglia” si è fermata, arrestando la<br />
marcia dei manifestanti, e alcuni organizzatori hanno inviato funzionari di polizia a far cessare la provocazione a scanso<br />
di guai. Dalle file dei manifestanti intanto si levavano grida minacciose: “Via i cinesi dalle finestre! Comunisti assassini!”.<br />
La tensione si è allentata grazie al servizio d’ordine dello stesso Comitato Anticomunista che ha diffuso esortazioni a “non<br />
raccogliere le provocazioni”. Scintille si sono accese pochi metri più avanti, all’incrocio di via Solferino, per un deridente<br />
balletto intrecciato sulla strada da due giovani, che mostravano cartelli così concepiti: “Minoranza Misteriosa?<br />
Misericordia!”. I due danzatori sono stati inseguiti da alcuni dimostranti; i cartelli, subito stracciati, sono stati<br />
abbandonati in terra. La manifestazione ha raccolto applausi subito dopo quando i primi dimostranti sono giunti in via<br />
Lanza, assiepata di persone pronte ad immettersi nel corteo. E l’atmosfera è andata sempre più riscaldandosi, man mano<br />
che la testa del corteo si avvicinava al Castello Sforzesco. In quegli stessi momenti, naturalmente, per il tronco del corteo<br />
al quale toccava percorre la strettoia di via Pontaccio si rinnovava la tensione precedente. Alle 19 il corteo ha cominciato a<br />
sfociare in piazza Castello. “Milano anticomunista – scandiva l’altoparlante – è scesa in piazza a manifestare contro la<br />
violenza (. . .) Mentre in piazza Duomo si inneggia al frontismo comunista, noi manifestiamo per la pace e la libertà”. I<br />
partecipanti al corteo hanno continuato ad affluire per oltre trenta minuti, sventolando bandiere al grido di “Italia,<br />
Italia!” (. . .). Ha parlato per primo un ex partigiano, il reverendo fratel Beltrando del Centro Don Sturzo. E’ stata poi la<br />
svolta di un esponente del Centro Culturale “Adelaide Ristori”; poi di Massimo De Leonardis, segretario provinciale della<br />
Gioventù Liberale Italiana. Questi ha dovuto subire un’intensa bordata di fischi; ma poi si è accattivato l’auditorio,<br />
spiegando che la Gioventù Liberale aveva aderito alla manifestazione anticomunista, contrariamente a quanto era stato<br />
annunciato da un telegramma “sospetto”. Sono esplose, alla fine, salve di applausi. Ha preso la parola anche un polacco<br />
del Movimento politico di Oltrecortina, per condannare ogni regime comunista. Ha parlato un rappresentante del<br />
Movimento democristiano giovanile di Trieste (salutato al grido ritmato “Trieste, Trieste!”). Poi due studenti, a nome di<br />
due associazioni Studentesche. Un giovane appartenente al Comitato Cittadino Anticomunista ha letto infine un<br />
documento politico in cui si affermava fra l’altro: “La civile protesta de milanesi non è espressione di sentimenti retrivi: è<br />
la presa di coscienza di quanti credono ancora negli ideali di libertà e di giustizia che costituiscono il fondamento di una<br />
società civile”.<br />
A poche centinaia di metri ed alla stessa ora si svolgevano le tre manifestazioni “antifasciste”. Quella del Comitato<br />
Antifascista era la più numerosa (era riuscito a raccogliere 20 mila persone) e anche la più importante per le personalità<br />
che presiedevano sul palco: c’erano Piero Bassetti, Camillo Ferrari, segretario provinciale della DC, Demetrio Costantino,<br />
segretario provinciale del PSDI, gli onorevoli democristiani Vittorino Colombo e Luigi Granelli, tutti i parlamentari<br />
comunisti di Milano e, naturalmente, il sindaco Aldo Aniasi. Costoro, forse dubitando che la loro presenza bastasse ad<br />
attirare la folla, avevano invitato la cantante Milva (che intrattenne i manifestanti cantando “Bella ciao”) e il cantautore<br />
siciliano, del PCI, Ciccio Busacco. A questo comizio aderì il repubblicano Aldo Maria Maggio; inoltre fu inviato un falso<br />
comunicato d’adesione firmato “Gioventù Liberale”. Questi fatti provocarono polemiche all’interno dei rispettivi partiti. Il<br />
parlamentare repubblicano Piero Bucalossi scrisse una lettera aperta a Maggio sul Corriere della Sera: “Caro Maggio, la<br />
tua partecipazione alla manifestazione di piazza Duomo è stata interpretata, data la tua posizione nel partito, come<br />
adesione ufficiale del PRI. Sappiamo bene che essa non c’è stata. Il passato del PRI è tale da testimoniare, senza la<br />
necessità di periodici richiami, la sua essenza nell’ideologia, come nella pratica politica, ad un tempo antifascista e<br />
democratica. In un momento nel quale il Paese è inquieto e allarmato è necessario preoccuparsi di evitare manifestazioni<br />
di parte che, sotto un’etichetta nobile, possono aumentare le tensioni esistenti a favore di chi mira alla sovversione delle<br />
nostre istituzioni: la loro difesa, infatti, si fa solo isolando la violenza e sostenendo tutti, e per tutti, il rispetto dei principi<br />
di libertà e democrazia sanciti dalla nostra Costituzione repubblicana e antifascista”. Sempre sul Corriere, nello stesso<br />
giorno, il capogruppo liberale Guido Capelli chiariva la posizione del suo partito: “Ho partecipato al corteo anticomunista<br />
della “Maggioranza Silenziosa”. E’ stata una manifestazione imponente e pacifica, composta nella stragrande<br />
maggioranza di cittadini di ogni ceto sociale, non organizzati politicamente, che vogliono ordine democratico, progresso e<br />
libertà. Le forze democratiche realizzino questa giuste aspirazioni e respingano la pressione comunista tendente a<br />
qualificare come fascista chiunque voglia opporsi al comunismo”.<br />
Il successo della manifestazione alzò di parecchi gradi il morale dei membri del C.C.A. “Toccavamo con mano, da ciò<br />
che ci diceva la gente che era con noi, che si era creata una prima frattura, profondissima, tra l’elettorato anticomunista<br />
ed i vertici dei partiti non comunisti, prima di tutto la DC. Il fatto che parlamentari democristiani avessero scelto la<br />
manifestazione di piazza Duomo, accanto a comunisti e socialisti, era sentito come tradimento da una parte, che ritengo<br />
assai larga, dell’elettorato DC”. Così Luciano Buonocore. E Giampaolo Landi: “Il fatto di avere smascherato i falsi<br />
anticomunisti all’interno della DC fu da noi considerato una vittoria”. Contribuì ad aumentare la sensazione di vittoria il<br />
fatto che, di lì a poco, le contraddizioni all’interno della Democrazia Cristiana scoppiarono addirittura in Parlamento,<br />
gettando le basi per la caduta del centro-sinistra e la creazione di un governo centrista. Si avvicinavano ormai le vacanze<br />
estive, ed i giovani del Comitato si preparavano tutti a lasciare Milano, felici e tranquilli, con la convinzione di avere<br />
arrestato in qualche modo l’attacco alle istituzioni, e la lunga marcia del PCI al potere. Quella marcia, come si vede poi,<br />
Luciano Buonocore – La Maggioranza Silenziosa e il Progetto Tecnocratico 21
sarebbe ricominciata meno di un anno dopo; e sarebbero venuti, per alcuni dei membri del Comitato, anni di<br />
persecuzione giudiziaria e poliziesca, e per tutti gli italiani gli anni di piombo delle stragi, degli assassini. Ma niente, in<br />
quei giorni d’estate, faceva ancora presagire quel futuro. All’interno del C.C.A. proprio allora si cominciarono a delineare<br />
qualcosa come tre schieramenti, tre tendenze distinte.<br />
Il primo (ne facevano parte Buonocore, Pagliuzzi, Landi, Fiore, Predolin. Dubini, Formenti e Sorga) era del parere che<br />
l’azione della “Maggioranza Silenziosa” dovesse continuare anche in autunno, rinsaldando le file, e mantenendo al<br />
movimento il suo carattere originale di adesione popolare, autonoma dai partiti. Un secondo gruppo (Manzoni,<br />
Muggiani, Marineo) ritenevano che la direzione dovesse passare dalle mani, in fondo inesperte, dei giovani che lo<br />
componevano, a quelle del senatore missino Mario Tedeschi che, come direttore del Borghese, aveva dato un forte<br />
appoggio alle manifestazioni. In pratica, questo gruppo tendeva a identificare la “Maggioranza Silenziosa” con il MSI.<br />
“Una prospettiva che non potevamo accettare – dice Buonocore (che pure era allora responsabile giovanile missino)-<br />
perché avrebbe impedito in seguito una più ampia strategia politica nella quale far configurare e organizzare il dissenso<br />
anticomunista, allora largamente maggioritario nel Paese”. Un terzo gruppo infine, composto da Nodali, Jacini, Porta,<br />
Bergamasco, riteneva che gli obiettivi della “Maggioranza Silenziosa”erano ormai stati raggiunti, e che quindi bisognava<br />
smobilitare il Comitato.<br />
“Quest’ultima frazione – dice Buonocore – era la più pericolosa, come i fatti dimostreranno. Era pericolosa perché quel<br />
gruppo già meditava di aderire ad una iniziativa annunciata dall’ex medaglia d’oro della resistenza, Edgardo Sogno, che<br />
di lì a poco avrebbe fatto parlare di sé: i Comitati di Resistenza Democratica. Questa iniziativa aveva una sua strategia,<br />
che personalmente non condividevo affatto: era una strategia che io chiamo “di vertice”, che tendeva a contrastare il PCI<br />
facendo affidamento su una rete di esponenti di partito – nella DC, nel PLI, nel PRI, nel PSI – che, in accordo tra loro,<br />
operassero all’interno delle istituzioni per controllarle ed usarle in senso sia anticomunista sia antifascista. Questa<br />
strategia implicava fin dal principio modi d’azione occulti, elitari; era fondata, in fondo, sulla sfiducia nella gente,<br />
nell’opinione pubblica anticomunista; o meglio, quell’opinione pubblica tendeva ad escluderla da una partecipazione<br />
attiva. La nostra posizione, al contrario, prevedeva la partecipazione popolare ad un processo di rinnovamento e di<br />
restaurazione dei principi delle libertà occidentali nella nostra società; il successo della “Maggioranza Silenziosa” provava<br />
che quella opinione pubblica era numerosa, pronta a mobilitarsi ed a partecipare ad un confronto duro, ma civile e aperto<br />
con il PCI, in una prospettiva “nazionale” che non escludesse a priori il Movimento Sociale”.<br />
Il giudizio di Buonocore (ma anche di Landi, Pagliuzzi e degli altri) era che invece il gruppo di Sogno avesse scelto una<br />
politica di trame, in cui una èlite spregiudicata si preparava a manovrare provocatoriamente l’opinione pubblica<br />
anticomunista, e specialmente quella estrema destra che ufficialmente diceva di combattere. Una conferma di questa<br />
posizione emergerà nel comunicato “di fondazione” dei centri di Resistenza Democratica, pubblicato nel Corriere della<br />
Sera del 19 settembre 1971: “Il nostro comitato, il Centro di Resistenza Democratica – diceva il comunicato – vuole creare<br />
un baluardo contro le manovre dell’estrema destra e dell’estrema sinistra. Ponendosi al centro dell’arco democratico e<br />
puntando sui valori e sugli uomini che hanno partecipato in altri tempi alla opposizione e alla resistenza contro il<br />
nazifascismo dando vita alla democrazia in Italia. Il CRD vuole unire tra loro partiti democratici, dal PSI al PLI (. . .). Il<br />
Comitato si batterà contro il frontismo delle cosiddette “maggioranze unitarie anticomuniste” alle cui marcette silenziose<br />
hanno aderito, in buona e cattiva fede, elementi democratici di destra”. “Insomma – concludono Pagliuzzi e Buonocore –<br />
si voleva mantenere aperta l’artificiale divisione del Paese, alimentando odi e rancori che già le folle della “Maggioranza<br />
Silenziosa” avevano ricomposto e dimenticato nelle piazze. A Milano, la Milano di piazzale Loreto, ex partigiani avevano<br />
marciato affiancati ad ex fascisti, uniti nella volontà di combattere l’unica minaccia reale alle nostre libertà civili: il<br />
partito comunista, e il “braccio illegale” dell’estremismo marxista rappresentano dalla sinistra extraparlamentare e dalle<br />
nascenti Brigate Rosse.<br />
La nostra idea era di fare della “Maggioranza Silenziosa” un potente strumento di pressione politica di massa, capace di<br />
indurre, attraverso continue mobilitazioni popolari, i partiti politici anticomunisti a unirsi in Parlamento e formare una<br />
stabile maggioranza del governo, anche assieme al MSI”. “Questa visione – dice il liberale Pagliuzzi – nasceva in noi, da<br />
una parte, dalla convinzione che non si potesse fare una politica anticomunista emarginando il Movimento Sociale che,<br />
con tutti i suoi difetti, costituiva un punto di riferimento tradizionale dell’anticomunismo militante, e la cui importanza<br />
era divenuta cruciale in quel momento in cui, sgretolatasi la politica centrista un tempo incarnata dalla DC, agiva una<br />
forte polarità nei due sensi: a destra gli anticomunisti (MSI compreso), a sinistra gli “antifascisti” (compreso il PCI).<br />
Dall’altra parte, questo tentativo avrebbe anche dovuto aiutare, e in qualche modo costringere, il Movimento Sociale ad<br />
abbandonare le sue connotazioni “nostalgiche” (lo stesso Almirante del resto aveva dato segno di volerlo fare nel<br />
congresso dell’Eur del 1970), per ricostituirsi come partito di una destra moderna, senza tentazioni dittatoriali, capace di<br />
entrare a pieno diritto nel libero gioco democratico”. “Ciò avrebbe anche significato la fine dell’utilizzo del MSI da parte<br />
della DC, come “partito-taxi”, da strumentalizzare per operazioni-sottobanco – aggiunge Luciano Buonocore –<br />
Paradossalmente, la persecuzione organizzata, la sottrazione violenta di spazi al Movimento Sociale comincia proprio<br />
quando questo partito, dopo il congresso dell’Eur, mostra la sua massima apertura politica, la volontà di abbandonare i<br />
saluti romani e i gagliardetti per impegnarsi sui temi politici della difesa delle libertà occidentali; prima di allora, al<br />
contrario, il partito “sporco”, “fascista”, era stato lasciato vivere indisturbato e utilizzato. Era chiaramente l’idea di questa<br />
nuova aggregazione quella che spaventava la DC (che vedeva in questa un concorrente elettorale temibile); non è un caso<br />
se il procuratore generale di Milano, Bianchi D’Espinosa, aperse proprio allora – dopo anni d’inerzia – un’istruttoria per<br />
“ricostituzione del partito fascista” contro i responsabili del MSI”.<br />
EDGARDO SOGNO E <strong>LA</strong> <strong>MAGGIORANZA</strong> <strong>S<strong>IL</strong>ENZIOSA</strong><br />
Nell’autunno del 1971, quando tutti tornarono a Milano, la lacerazione all’interno del gruppo che originariamente ha<br />
promosso la “Maggioranza Silenziosa” è ormai cosa fatta. Per aderire ai Comitati di Resistenza Democratica di Edgardo<br />
Luciano Buonocore – La Maggioranza Silenziosa e il Progetto Tecnocratico 22
Sogno si è ritirato, in particolare, il gruppo dell’ingegner Nodali; e poiché era quello il gruppo che finanziava la sede del<br />
C.C.A. di via San Luca, quelli che restano debbono venire ospitati nella sede della Federazione del partito Monarchico in<br />
porta Genova. Lì il gruppo resterà fino al febbraio 1972, quando un altro simpatizzante, l’ingegner Arnaldo Chierici,<br />
fornirà al gruppo alcuni suoi locali in via Cornalia, nei pressi del grattacielo Pirelli. La prima uscita “pubblica” del CRD di<br />
Sogno avviene il 9 ottobre 1971, in occasione di un annunziato comizio di Almirante in piazza Castello. DC, PCI, PSI e<br />
PSIUP chiedono alle autorità, al Prefetto e la Questore, che il comizio venga vietato; e il CDR – composto, si badi, da<br />
quelle stesse persone che fino a pochi mesi prima avevano sfilato per Milano nelle manifestazioni della “Maggioranza<br />
Silenziosa” accanto a simpatizzanti missini – si associa alla richiesta, con un comunicato in cui dice: “A 20 anni dalla fine<br />
del conflitto e dalla conclusione della tragica avventura fascista il MSI organizza a Milano, città che tanto si è esposta e<br />
sacrificata nella lotta di Liberazione, una manifestazione che, nell’interno dei suoi organizzatori, dovrebbe segnare il<br />
rilancio del fascismo nell’Italia settentrionale. (sic)”<br />
Il Comunicato anticomunista, o ciò che ne rimaneva in quell’occasione deplorò pubblicamente “le pressioni per la<br />
proibizione del comizio” di un partito politico che, ricordava, “è rappresentato legalmente in Parlamento”. Il monarchico<br />
Landi, il liberale Pagliuzzi e il missino Buonocore, uniti all’avvocato Adamo Degli Occhi, avevano stilato questo<br />
comunicato. Il Comitato Cittadino Anticomunista si trovò dunque a operare in un clima di crescenti difficoltà. Venivano<br />
meno appoggi essenziali, che anzi trasformavano in ostilità, mentre non decrescevano le aggressioni e le intimidazioni<br />
della sinistra parlamentare e no: in quel periodo molti giovani che s’erano messi in luce nella “Maggioranza Silenziosa”<br />
furono aggrediti. Lo stesso Pagliuzzi, studente di Architettura, il 22 ottobre 1971 fu riconosciuto all’interno della Facoltà<br />
da gruppi di estremisti di sinistra, sequestrato, “processato” e percosso. Un altro indizio delle difficoltà e della confusione<br />
di quel periodo si trova nei giornali di quel periodo, e riguarda il comizio tenuto l’11 marzo in piazza Castello dal senatore<br />
missino Mario Tedeschi. Nei quotidiani, questo comizio viene etichettato come “un’iniziativa della Maggioranza<br />
Silenziosa”: in realtà, quell’etichetta era spuria. Si trattava invece dell’unica iniziativa pubblica del secondo gruppo dei<br />
transfughi del Comitato Cittadino Anticomunista, quello che faceva capo ad Elena Manzoni e Giorgio Muggiani. Di fatto,<br />
per quello stesso giorno di marzo l’autentico Comitato Cittadino Anticomunista (quello di Pagliuzzi, Landi e Buonocore)<br />
aveva indetto una manifestazione per protestare contro due atti di violenza: il grave ferimento dello studente Marco Gino,<br />
18 anni, lasciato con il cranio sfondato sui pavimenti dell’Istituto “A. Volta” da una pattuglia armata di “Katanghesi”, e il<br />
sequestro dell’ingegner Idalfo Macchiarini, direttore della Sit-Siemens, sottoposto dalle Brigate Rosse ad un “processo<br />
politico”: lo stesso gruppo terrorista aveva diramato ai giornali una foto del Macchiarini, con i segni della percosse sul<br />
volto, e mani legate davanti ad una bandiera rossa su cui campeggiava l’emblema, destinato a divenire tristemente noto,<br />
della stella a cinque punte. La manifestazione del C.C.A. era stata tuttavia vietata dalla Questura; la quale invece non<br />
aveva voluto o potuto vietare (si era in tempi di campagna elettorale) il comizio di Tedeschi. Come già detto, i giornali<br />
parlarono in questo caso di un comizio della “Maggioranza Silenziosa”; di fatto, all’appuntamento di piazza Castello si<br />
ritrovò una piccola folla di militanti e simpatizzanti del MSI, determinati anche a correre il rischio di uno scontro fisico:<br />
perché bisogna dire che la Questura aveva autorizzato, alla stessa ora e all’incirca nello stesso luogo (in piazza Cairoli, a<br />
cinquanta metri da piazza Castello) un comizio dei più pericolosi gruppi dell’estremismo extraparlamentare:<br />
“Avanguardia Operaia”, “Lotta Continua”, e “Potere Operaio”. Il tentativo di dissuasione intimidatoria verso il comizio<br />
missino era più che evidente. In verità, il Corriere del giorno seguente accrediterà la tesi che la Questura avesse tentato di<br />
vietare il comizio degli estremisti rossi; ma questi, ricordando in un loro comunicato “che ai fascisti non deve essere<br />
concesso alcun diritto di agibilità politica”, sostenevano che, “essendo già in atto una larga mobilitazione”, avrebbe tenuto<br />
il comizio in ogni modo. Alle 16 dell’11 marzo, a separare i due gruppi, quello rosso e quello “nero”, c’era solo un cordone<br />
di poliziotti in assetto di guerra. Bisogna dire che questi fecero egregiamente il loro dovere, impedendo che i due gruppi<br />
venissero a contatto: cosa che non fu facile. Gli ultrà di sinistra, infatti, diedero immediatamente inizio ad una serie di<br />
scontri violentissimi, evidentemente pianificati, che coinvolsero una larga zona del centro. Decine di auto furono date alle<br />
fiamme, ammassate per farne barricate; sulle pattuglie di agenti piovvero bottiglie incendiarie, pietre, biglie di acciaio;<br />
numerosissimi gli scontri corpo a corpo; decine i feriti, un moribondo (era innocente passante); la stessa sede del<br />
Corriere della Sera fu assalita con bottiglie Molotov. Per ore la città, da piazza Cairoli a piazza Cavour fu in preda al fumo<br />
dei lacrimogeni e degli incidenti; ma incredibilmente il comizio missino si svolse indisturbato, e i partecipanti al termine<br />
di esso si dispersero disciplinatamente sparendo negli imbocchi della metropolitana, senza partecipare agli scontri.<br />
Certo è che, da allora la “vera” Maggioranza Silenziosa non potè più raccogliersi in una manifestazione: ogni tentativo in<br />
questo senso si scontrò contro i divieti della pubblica autorità. Era arrivata la necessità di mantenere vivo il movimento,<br />
inceppato nella libertà fondamentale di riunione, con altri mezzi più indiretti: il manifesto murale, il volantino, la<br />
stampa. Il C.C.A. datosi come presidente onorario Adamo Degli Occhi e come segretario Luciano Buonocore (un sodalizio<br />
che rimarrà unito fin oltre la persecuzione e il carcere), intraprese dunque quest’ultima via. E’ di quei giorni la nascita di<br />
“Lotta Europea, l’organo ufficiale della Maggioranza Silenziosa”. “Per far nascere il giornale – ricorda Buonocore – io e<br />
Landi ci indebitammo per un milione e mezzo a testa, la cifra necessaria per pagare la tipografia per i primi numeri.<br />
Firmammo parecchie cambiali, la prima “redazione” del giornale si installò nella cucina di casa mia, dove passammo<br />
notti e notti a scrivere e impaginare”. Il numero di Lotta Europea reca in frontespizio l’elenco con i nomi dei redattori e<br />
dei collaboratori, fatto che già in sé, dati i tempi, richiedeva una buona dose di coraggio. Adamo Degli Occhi, Piero<br />
Bianchi, Giovanni Fermi, Cristiano Fiore, Anna Gastel, Antonio Imperatore, Giovanni Monastra, Antonio De Felip,<br />
Gianpaolo Landi costituivano il “Comitato di redazione”. Margherita di Soragna e Maria Grazia Gasperini erano le<br />
segretarie di redazione; responsabili dell’ufficio diffusione Alberto Dubini, Roberto Tafani, Enzo Cuciniello, Costantino<br />
Nitti. Non mancavano i corrispondenti da Roma, Napoli, Torino, Genova, Messina, Bergamo, Piacenza, Modena e perfino<br />
da Parigi. “Questa rivista – diceva l’editoriale del primo numero – nasce da quel gruppo di persone, di diverse tendenze<br />
politiche, che costituirono nel febbraio ’71 il comitato cittadino anti-comunista, organizzatore delle tre manifestazioni<br />
della “Maggioranza Silenziosa”. Queste persone, senza nessuna intenzione di costituire un nuovo raggruppamento<br />
politico, hanno sentito come un dovere l’esigenza di dare un certo ordine a quella larga corrente d’opinione che in Italia,<br />
come d’altra parte in Europa, con fenomeni talvolta paralleli, si sta schierando su nuove posizioni; tale situazione porta<br />
inevitabilmente al superamento di fatto della normale prassi politica, che tende a etichettare arbitrariamente i cittadini in<br />
genere, superamento che nasce dalla constatazione del fallimento di tutte le vecchie ideologie (. . .). Conquistare pochi,<br />
Luciano Buonocore – La Maggioranza Silenziosa e il Progetto Tecnocratico 23
ma precisi punti saldi, contribuire nei limiti oggettivi alla creazione di una strategia a livello europeo contro tutti i nemici<br />
dell’Occidente; questo è il nostro unico e pur ambizioso scopo”. L’ambizione certo non mancava. I titoli del primo<br />
numero lo rivelano: “La fine di un sistema – di Alberto Rendine, indicava che – un solco profondo divide ogni giorno di<br />
più il Paese reale da quello politico – e vedeva nella – presa di coscienza di quanti non hanno ancora rinunciato alla<br />
propria libertà (. . .) poveri e ricchi, vecchi e giovani, operai, studenti, imprenditori” il “coraggio di battere nuove strade”.<br />
In “Aspetti di una strategia”, di Luciano Buonocore, c’era un appello a “quella maggioranza, sia pure eterogenea<br />
socialmente e ideologicamente, di cittadini che rifiutano il comunismo, in cerca di qualcosa che non conoscono ancora”.<br />
E, quasi a riprova che tale maggioranza esisteva, l’articolo seguente, “I lavoratori contro i sindacati”, di Fabio Steni,<br />
elencava recenti casi di cronaca in cui operai di diverse fabbriche avevano opposto una resistenza a volte assai forte alla<br />
politica dell’unità sindacale sotto l’egemonia della CG<strong>IL</strong>. E alle violenze e alle intimidazioni a cui avevano dovuto<br />
ricorrere i sindacalisti per far passare la loro linea in molti posti di lavoro: un aspetto della storia recente assai poco noto,<br />
questo, che pure nel 1971 vide 7000 metalmeccanici di Bologna, appartenenti a 9 aziende, contestare i sindacati “unitari”,<br />
costituendo una organizzazione autonoma. Il secondo numero di Lotta Europea riportava un lungo, complesso studio del<br />
celebre istituto Max Plank sulla crisi dei partiti politici: un discorso che per i suoi risultati – lo studio giungeva alla<br />
conclusione che l’opinione pubblica europea non sentiva più i partiti come espressione autentica della società, ma come<br />
organizzazioni volte ad assicurare favori e poteri ai suoi adepti – sembrava confermare profondamente la strategia dei<br />
promotori della “Maggioranza Silenziosa”. Presto, la rivista potè contare su oltre 500 abbonamenti, che ne garantivano la<br />
sopravvivenza economica. Sul periodico apparve un’intervista al rettore della Statale, prof. Schiavinato, e molte copie del<br />
giornale erano vendute all’interno dell’Università, a studenti e docenti, nonostante la “vigilanza” violenta degli estremisti<br />
rossi. Proprio a causa della sua collaborazione a Lotta Europea il rettore Schiavinato fu un giorno sequestrato da un<br />
foltissimo gruppo di energumeni guidati da Maria Capanna, sottoposto a “processo politico” (secondo la prassi<br />
instaurata dalle Brigate Rosse), malmenato, coperto di sputi mentre gli ultrà documentavano la scena con una cinepresa.<br />
Al processo che seguì mesi dopo e nel quale, beninteso, fu assolto, Capanna negò ogni addebito, limitandosi a dire che<br />
nella calca dei suoi fedeli aveva sollevato sotto la testa del docente due numeri “della rivista nazifascista Lotta Europea<br />
per far vedere cosa leggesse il rettore”. A metà aprile anche un giovane iscritto a Chimica Industriale, Vittorio Galiano di<br />
22 anni, fu percosso selvaggiamente all’Università perché accusato di collaborare a Lotta Europea. In quell’occasione il<br />
C.C.A. riuscì a creare all’interno dell’Università un Comitato Studenti Anticomunisti, che con grave rischio dei suoi<br />
componenti, lanciava appelli alle autorità accademiche e di pubblica sicurezza “perché avesse fine il clima di violenza<br />
creato da una minoranza che non vuole altro che il caos”.<br />
Era solo l’inizio di una battaglia che avrebbe avuto momenti di gravissima tensione. Il 7 maggio del 1972, intanto, si<br />
tennero, in un clima di crescenti violenze di sinistra, le elezioni: il MSI ebbe un’affermazione eccezionale, raccogliendo il<br />
massimo storico dei suoi voti. “Voti in libera uscita”, com’ebbe a dire Andreotti che, di lì a poco, formava un governo<br />
bicolore con i liberali: voti che, intendeva, sarebbero stati presto fatti tornare alla DC. La strategia della tensione doveva<br />
ancora giocare le sue mosse più sanguinose. Il clima di violenza e di intimidazione non era certo prossimo a placarsi.<br />
LO SCIOPERO CONTRO <strong>IL</strong> “CORRIERE DEL<strong>LA</strong> SERA”<br />
Il giorno 15 novembre del 1973, la “Maggioranza Silenziosa” denuncia all’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 323 del<br />
Codice Penale, il Questore di Milano Allitto Buonanno. “Il Questore autorizza e permette tutte le manifestazioni dei<br />
guerriglieri di sinistra – spiega un manifesto della “Maggioranza Silenziosa” affisso in quei giorni sui muri di Milano - del<br />
Movimento Studentesco dei sindacalisti comunisti, degli anarchici e dei teppisti di ogni colore che spaccano vetrine,<br />
intimidiscono i commercianti e aggrediscono i passanti (. . .) ma nega sistematicamente alla “Maggioranza Silenziosa”,<br />
per motivi di “ordine pubblico”, i cortei e i comizi (. . .). Il Questore di Milano ci ha negato l’autorizzazione ad un corteo di<br />
solidarietà con gli intellettuali russi incarcerati o chiusi nei manicomi (. . .). Tale divieto è l’ultimo anello di una catena di<br />
abusi di potere, di illegali e partigiane discriminazioni ideologiche ai danni dei liberi cittadini”.<br />
Il manifesto è uno specchio abbastanza fedele del clima della cittadella assediata in cui era ormai ridotta la<br />
“Maggioranza Silenziosa” in quei giorni. Il 17 gennaio 1973, mentre usciva dalla sua abitazione alle tre del pomeriggio, il<br />
presidente della Maggioranza, Adamo Degli Occhi, veniva selvaggiamente sprangato, e ridotto quasi in fin di vita da una<br />
banda di picchiatori rossi.. Dal suo letto di ospedale, l’avvocato dichiarò agli inquirenti di aver riconosciuto alcuni dei<br />
suoi aggressori (fece il nome fra l’altro di Luca Cafiero, uno dei leader più violenti del Movimento Studentesco ). Invano. I<br />
denunciati non furono mai perseguiti. In precedenza, erano del resto rimaste impunite altre aggressioni ad esponenti del<br />
Comitato Cittadino Anticomunista: al segretario giovanile del C.C.A., Marco Falchetti, all’assistente di Chimica<br />
Barazzetti, aggrediti alla Statale; a Domenico Siena, redattore-capo di Lotta Europea, massacrato a sprangate da trenta<br />
estremisti mentre, in piazza Piola, affiggeva manifesti, e ridotto in fin di vita. Qualche mese prima era stato assassinato il<br />
commissario Calabresi. Un omicidio che aveva sconvolto l’opinione pubblica moderata: ai funerali del commissario<br />
ucciso, mentre i muri di Milano si coprivano di scritte inneggianti all’omicidio, una folla strabocchevole aveva partecipato<br />
in silenzio. Era stata l’ultima manifestazione pubblica – completamente spontanea questa, senza organizzazione<br />
consapevole – di quella “Maggioranza Silenziosa” di cittadini cui il C.C.A. aveva dato espressione e voce.<br />
Ma erano, quelli, anche i giorni in cui il segretario del PCI, Enrico Berlinguer, lanciava apertamente la politica del<br />
“compromesso storico” verso la DC: una politica che doveva fondarsi sulla repressione e demonizzazione del dissenso di<br />
destra e moderato. “Doveva”: in primo luogo perché l’accordo fra comunisti e democristiani poteva celebrarsi soltanto in<br />
nome del cosiddetto “antifascismo”; ma in secondo luogo, probabilmente, pareva necessario agli artefici del<br />
compromesso togliere all’opinione pubblica moderata gli spazi dove esprimere una protesta legittima, per esasperare una<br />
situazione e spingere i meno responsabili e i meno consapevoli a reagire alla repressione con “fughe in avanti” di<br />
carattere estremistico e violento: in tal modo si sarebbe creato o favorito il nascere di quel “pericolo fascista” che avrebbe<br />
Luciano Buonocore – La Maggioranza Silenziosa e il Progetto Tecnocratico 24
giustificato ulteriori repressioni, e la chiamata all’ordine di un futuro governo “antifascista” all’insegna del compromesso<br />
storico.<br />
In questo clima machiavellico, la “Maggioranza Silenziosa” non rinuncia ad agire usando gli strumenti legali, che<br />
possono parere patetici in una situazione in cui, di fatto, lo stato di diritto non esiste più. Così, il 17 marzo, il C.C.A.<br />
denuncia alla magistratura “per associazione a delinquere” e per violazione della legge Scelba (!), il Movimento<br />
Studentesco e Potere Operaio, per continue aggressioni perpetrate. Denuncia che, ovviamente, come tutte le altre già<br />
presentate, non avrà alcun seguito. Negli stessi giorni di marzo, la “Maggioranza Silenziosa” si fa promotrice di una<br />
originale forma di protesta civile, chiedendo con manifesti ai suoi simpatizzanti di non acquistare, in giorni determinati,<br />
il Corriere della Sera, in cui era stato recentemente assunto come redattore-capo il giornalista comunista Salvatore<br />
Conoscente, ex redattore dell’Unità. Quest’appello non rimase senza effetto: il Corriere accusò un calo delle vendite fino<br />
al 25-30% in certe zone della città, soprattutto nel centro. Così, quando alcune settimane dopo il C.C.A. ripetè l’appello<br />
allo “sciopero della lettura”, Piero Ottone, direttore del Corriere si preoccupò al punto da scrivere una lettere al Comitato.<br />
“In seguito alle vostre insinuazioni – scriveva Ottone – il collega Conoscente ha ricevuto lettere minatorie (. . .); su di Voi<br />
ricada ogni responsabilità morale qualora qualcuna delle minacce sia eseguita”. L’Unità, Il Giorno, e poi la Federazione<br />
Nazionale della Stampa al completo, espressero la loro “solidarietà” al Corriere: si profilava anche nel mondo del<br />
giornalismo quel “fronte antifascista” che doveva preparare il terreno al compromesso prossimo venturo. Ma nello stesso<br />
Corriere, questi fatti determinarono una forte tensione, un’area di dissenso sempre più aperto e franco contro l’ambigua<br />
linea ottoniana, fiancheggiatrice del PCI. Alcuni giornalisti del Corriere vollero perfino incontrare – attraverso i buoni<br />
uffici dell’industriale Isolabella e del presidente della Vortice, e del presidente dell’ordine dei medici Passaretti – Luciano<br />
Buonocore. Vi furono vari incontri, tenuti presso l’Assolombarda, durante i quali si progettò addirittura di dar vita ad un<br />
nuovo giornale, che si sarebbe chiamato Sera. I finanziamenti sarebbero stati assicurati da un gruppo di imprenditori, tra<br />
cui spiccava Duchène De Vère. Si arrivò fino a chiedere un preventivo alla Same, la tipografia di piazza Cavour. Direttore<br />
del nuovo giornale sarebbe stato Nuccio Barbieri, un ex redattore del Mondo che Benedetti aveva licenziato, proprio<br />
perché aperto simpatizzante della “Maggioranza Silenziosa”. Le trattative si prolungarono fino al 1974, quando il progetto<br />
si gonfiò per il sorgere di un fatto del tutto nuovo: la fronda anti-Ottone del Corriere, trovato il suo leader di grido in<br />
Indro Montanelli, si coagulò in aperta definizione; in pochi mesi – grazie anche ai finanziamenti di quegli stessi<br />
industriali che stavano trattando con Buonocore, e che furono pronti a dirottare i fondi verso la nuova testata – vide la<br />
luce Il Giornale montanelliano. Nel dicembre, al consiglio comunale, il sindaco Aldo Aniasi respinse una proposta<br />
avanzata dal consigliere democristiano Giuseppino Bossi: conferire, a nome della città, una medaglia d’oro alla memoria<br />
di Calabresi. Anche questa volta la “Maggioranza Silenziosa” fece sua l’idea. Consegnò alla vedova del commissario una<br />
medaglia a ricordo del marito, defensor civitatis. Una manifestazione, anzi una fiaccolata, che avrebbe dovuto<br />
accompagnare la consegna della medaglia, fu vietata come al solito dalla Questura.<br />
L’ultima manifestazione pubblica della Maggioranza dovette tenersi al chiuso – nel teatro Dal Verme gremito fino<br />
all’inverosimile – ai primi del 1974. Parlarono in quell’occasione, con Buonocore e Degli Occhi, il deputato democristiano<br />
Agostino Greggi, che in seguito aderirà, ma per breve tempo, al Movimento Sociale. Ancora il 30 marzo 1974 il C.C.A.<br />
chiedeva alla Questura l’autorizzazione ad organizzare una manifestazione di protesta dei ceti medi contro l’inflazione e<br />
la pressione fiscale. Ancora una volta il Questore rifiutò il permesso, motivandolo così: “La polizia, per proteggere i<br />
partecipanti ad eventuali manifestazioni anticomuniste, dovrebbe far quadrato intorno ad essi con le armi puntate per<br />
proteggerli dalle aggressioni armate cui fatalmente andrebbero incontro. Arriveremmo al Quadrato di Villafranca (. . .).<br />
Vi sparerebbero addosso, sarebbe la guerra civile”. Era la resa, esplicita, non già agli “opposti estremisti” , ma all’unico<br />
estremismo veramente violento, di cui la polizia riconosceva la pericolosità: quello rosso. Sabato 30 marzo, nel giorno in<br />
cui la manifestazione della “Maggioranza Silenziosa” avrebbe dovuto aver luogo, il Movimento Studentesco fu autorizzato<br />
a tenere una propria manifestazione a cui parteciparono i soliti Katanghesi armati e mascherati. Mentre questa si<br />
svolgeva, agenti di polizia sorvegliavano le case dei più noti esponenti della “Maggioranza Silenziosa”, fermandoli<br />
all’uscita e perquisendoli alla ricerca di armi. Non un’arma fu, beninteso, trovata. Anche Luciano Buonocore fu fermato;<br />
al suo rifiuto di lasciarsi perquisire, fu condotto a forza in Questura.<br />
DODICI ANNI DOPO<br />
23 marzo 1987. Quando si apre il processo ai suoi assassini, Sergio Ramelli è morto da 12 anni. Ne aveva 17 quella sera<br />
del 13 marzo 1975, quando incontrò sotto casa sua i due che lo sprangarono a morte; altri 10 “presidiavano” la zona. Sua<br />
madre trovò Sergio a terra, nel suo sangue, tornando dalla spesa; il ragazzo morì dopo 47 giorni di agonia, familiari ed<br />
amici dovettero vegliarlo in ospedale, perché gli infermieri minacciavano di togliere al “fascista Ramelli” i tubi d’ossigeno<br />
che lo tenevano appeso alla vita. Per anni, poi, la famiglia fu perseguitata da telefonate di minaccia, il padre ne morì di<br />
crepacuore. La giustizia arrivava tardi. Tardi per Sergio, che non avrà mai trent’anni; tardi per suo padre e sua madre.<br />
Tardi, senza efficacia e senza forza, sulle spalle dei colpevoli diretti del massacro e sui loro complici innumerevoli. Tardi<br />
anche per ristabilire la verità di quegli anni di piombo: ma, almeno in questo, non invano. Perché la verità che emerge dal<br />
processo Ramelli conferma con impressionante puntualità sia il “rapporto Mazza”, sia le ripetute denunce levate dalla<br />
“Maggioranza Silenziosa”: Il rapporto del Prefetto Mazza aveva detto – suscitando la furente reazione del l’Unità e di tutti<br />
i “progressisti” di quei giorni – che all’Università Statale, tra i contestatori del Movimento Studentesco, s’era formata<br />
un’organizzazione paramilitare forte migliaia di individui, armati, dotati di servizi d’informazione, con lo scopo di<br />
esercitare la violenza politica di massa e quella individuale contro singoli avversari. La “Maggioranza Silenziosa” aveva<br />
aggiunto, di suo, che questa formazione non era una creazione autonoma e spontanea di un gruppo di estremisti; no,<br />
faceva parte di un progetto sostenuto e appoggiato da settori insospettabili e “rispettabili” del mondo politico. La<br />
collusione democristiana-comunista nel “compromesso storico” – tale l’analisi della “Maggioranza Silenziosa” – non<br />
poteva avvenire che con la scusa e all’ombra del cosiddetto “antifascismo”. L’antifascismo e la “resistenza”, infatti, erano<br />
stati il “mito d’origine” della prima storica collusione ciellenistica, in cui DC e PCI s’erano trovati fianco a fianco. Per<br />
giustificare la rinnovata alleanza, bisognava che essa fosse fatta in nome della comune opposizione al “pericolo fascista”.<br />
Luciano Buonocore – La Maggioranza Silenziosa e il Progetto Tecnocratico 25
Se questo pericolo non c’era, bisognava crearlo, o crearne la psicosi, il “clima” di caccia al fascista, l’atmosfera rovente del<br />
’45 in cui s’era sanguinosamente composta, per pochi mesi, la “solidarietà antifascista”.<br />
Quest’analisi appare confermata in modo addirittura stupefacente dalle deposizioni degli accusati al processo Ramelli.<br />
Anch’essi si giustificano, invocando “il clima di quegli anni”; ma quel che evocano, forse involontariamente, è il progetto<br />
da cui nacque quel clima, progetto elaborato o assecondato dalle scrivanie dei giornali e dalle stanze del Palazzo. “La<br />
campagna per il MSI fuorilegge – pagliucola ad esempio Antonio Belpiede, oggi capogruppo del PCI a Cerignola, allora<br />
membro del “gruppo Medicina” di Avanguardia Operaia – non fu decisa da quattro straccioni che passavano per la<br />
strada. Era appoggiata da vasti settori del PCI, del PSI, di Magistratura Democratica”: e cita famosi interventi alla<br />
Camera del ’73, ricorda gli ex partigiani illustri che scendevano n piazza con gli estremisti “per la gioia di partecipare alla<br />
nuova resistenza”. Lui, ad ogni buon conto, non era tra quelli che sprangarono Sergio Ramelli: era al compleanno della<br />
sorella a Cerignola, ha l’alibi. Non si pente, invece, Saverio Ferrari, oggi membro della segreteria di Democrazia<br />
Proletaria e responsabile del settore stampa e propaganda, ai tempi del delitto Ramelli, capo del servizio d’ordine degli<br />
sprangatori di AO. “Erano tempi di grandi ideali – dice – una parte consistente della popolazione credeva giusto assaltare<br />
le sedi del MSI”. Fra tali “forze popolari”, cita “i padri della Resistenza”, Parri, Terracini. Cita Eugenio Scalfari, che con<br />
“Giorgio Bocca e Camilla Cederna aprirono uno dei primi cortei di studenti medi”.<br />
Molti testimoni o imputati che finisco per descrivere l’organizzazione nient’affatto spontanea, ma al contrario<br />
consapevolmente preparata e diretta, della azioni di Avanguardia Operaia. Francesco Cremonese, imputato per l’assalto<br />
al bar Porto di Classe, descrive la centralizzazione del servizio d’armamento: le chiavi inglesi custodite in un armadietto<br />
della Facoltà di Medicina, “distribuite e ritirate a cura dell’organizzazione”. La decisione di ammazzare Ramelli, racconta,<br />
“deve essere stata presa a livello di Città Studi, e le informazioni sulla vittima dovevano venire da ambiti esterni alla<br />
squadra. E’ impossibile – aggiunge – che una faccenda così, con tanta gente, potesse essere organizzata senza direttive<br />
politiche chiare”. Sul “referente politico”, sull’”istanza superiore” che prendeva simili decisioni, non ha dubbi Walter<br />
Cavallai, ex capo della “squadra di Medicina” di AO: era Basilio Rizzo, oggi capogruppo DP a Palazzo Marino. La linea<br />
politica, dice, era precisa: “C’è la campagna per il MSI fuorilegge ed alcune persone di destra devono ricevere lezioni,<br />
essere intimidite. – Sostiene che – a decidere l’azione contro Ramelli poteva essere stato Grassi (il capo del servizio<br />
d’ordine di AO), ma con quel che successe poi deve averne parlato con le istanze superiori”, cioè con Rizzo, “responsabile<br />
politico di Città Studi”. Lui, personalmente, non c’era, sia chiaro: ricorda solo che i compagni, tornati dall’azione<br />
commentarono che “era andato tutto bene”,e che alcuni posero il problema di pulire le chiavi inglesi, sporche di sangue.<br />
In breve, durante il processo Ramelli vengono fuori verità che fanno impallidire, come generico e ottimista, il “rapporto<br />
Mazza”. Salta fuori la storia del “covo” di via Bligny, in cui vengono fortunosamente trovate cinquemila schede di<br />
avversari politici con nomi, indirizzi, abitudini (“Sale in auto sempre dalla parte sinistra”). Le schede rivelano che AO ha i<br />
suoi infiltrati a destra: come un certo Giliberto, che firma un rapportino (trovato in via Bligny) per l’intelligence del<br />
gruppo, o quell’Ettore, non meglio identificato, che fa da tramite per un foglio firmato Nico Azzi: squarcio inquietante su<br />
possibilità di provocazioni e di delitti possibili da attribuire ai “fascisti”, nonché rivelatore di un modu operandi fin<br />
troppo professionale, dietro cui si sente la mano di vecchie e sempre attive cellule staliniste. Saverio Ferrari, a quel tempo<br />
responsabile di tutto quel materiale informativo, naturalmente “non ricorda” come esso sia stato formato, con quali<br />
mezzi e quali uomini. Poco importa: fu forse con l’ausilio di tipi come Brunella Colombelli, che nel ’73 fu fermata dalla<br />
polizia su richiesta di Lotta Europea, dopo che la suddetta ragazza era entrata nella redazione con una scusa, ed era stata<br />
vista più volte spiare nei dintorni.<br />
Poco importa: conta di più la testimonianza di Anita Ramelli, la mamma del povero Sergio, il suo resoconto della gelida<br />
escalation di intimidazione contro il suo ragazzo, rivelatrice di un progetto premeditato. “Quindici, venti giorni prima del<br />
delitto apparvero scritte sui muri: “Ramelli fascista sei il primo della lista”. In casa arrivavano telefonate a tutte le ore, ci<br />
facevano sentire “Bandiera Rossa”. Anche la sera dei funerali di Sergio, cinquanta giorni dopo, le stesse telefonate:<br />
telefonate d’insulti, continuarono a chiamare fino alle 22”. Undici anni dopo, quando ormai i nomi dei colpevoli sono noti<br />
alla Magistratura, costoro scriveranno alla signora Ramelli: “Non avevamo niente di personale contro suo figlio . . .”. Ma<br />
non si provano a spiegare il perché, allora, di quell’odio accanito, senza resipiscenza. Dovrebbero spiegare che la loro<br />
coscienza era come accecata dal vasto appoggio propagandistico, psicologico, che veniva da più alto, e dall’impunità di cui<br />
godevano e sapevano di godere. Luigi Ramelli, fratello di Sergio, racconterà anche questo episodio, che la dice lunga<br />
sull’impunità sulla quale i colpevoli contavano: una sera durante l’agonia di Sergio, mentre Luigi torna a casa<br />
dall’ospedale, viene inseguito fin nel portone da un gruppo appostato all’angolo della casa. Lui scappa, perde perfino il<br />
portafoglio, gli aggressori si bloccano in portineria, vi affliggono un manifesto: “Ramelli Luigi, fascista, 48 ore per sparire,<br />
altrimenti farai la fine di tuo fratello”. E intimano al portiere di non staccare il cartello. Questa crudeltà bestiale, questo<br />
sadismo insaziabile, è esso stesso rivelatore: i persecutori si sono liberati dalla loro coscienza personale, la coscienza cui<br />
si riferiscono è quella delle “forze popolari” che li appoggiano, che sfilano alla loro testa nei cortei, e che hanno nomi e<br />
cognomi. In breve, essi sono puri e semplici, ancorché feroci, strumenti omicidi del Progetto. Di questa atroce eterogenesi<br />
dei fini, del ruolo strumentale che fu fatto loro giocare, alcuni degli estremisti di allora sembrano acquistare<br />
faticosamente, tortuosamente consapevolezza. “Cose brutte, bruttissime sono accadute quegli anni, s’è sbagliato molto da<br />
entrambe le parti”: così dice Domenico Contestabile, oggi penalista di grido, allora consigliere comunale del PSIUP.<br />
Intervistato da Luciano Buonocore il 25 marzo 1987, nell’aula stessa dove si svolge il processo Ramelli, Contestabile dice:<br />
“Non fu solo uno scontro fra giovani; tutto il Paese aveva perso la testa”. “Miravate davvero alla presa del potere?” gli<br />
chiede Buonocore. “La lotta di classe non si fa col fioretto, si fa come detta la storia: e la storia in quegli anni dettava<br />
forme violente. Sicuramente vi era la volontà di conquista del potere da parte della sinistra, ed è anche ingenuo, oggi,<br />
definire velleitarie tali speranze. Trotski e Lenin tentarono due rivoluzioni, una nel 1905 che gli andò male, e una nel ’17<br />
che gli andò bene. Chi nel 1906 aveva accusato Trotski e Lenin di velleitarismo non aveva capito che in realtà esistevano<br />
potenzialità rivoluzionarie. Negli anni Settanta è andata male, ma non bisogna dimenticare che anche in quegli anni<br />
c’erano realtà di massa. . .” “Ma allora – incalza Buonocore – l’antifascismo, la lotta antifascista, la “vigilanza antifascista,<br />
per voi era un alibi?”. “La lotta antifascista era in realtà una lotta di maniera, con contenuti e forme di maniera;<br />
l’antifascismo è stato utilizzato come strumento per altri fini. Tutta la sinistra fa da tempo autocritica di questi metodi”.<br />
Luciano Buonocore – La Maggioranza Silenziosa e il Progetto Tecnocratico 26
Forse un barlume di comprensione? Forse i fantaccini del Progetto di allora, che allora erano stati così pronti a sostituire<br />
la loro responsabilità personale con quella che “dettava la storia”, così docili nell’agire in nome della “masse”, stanno<br />
cominciando a capire che quelle “realtà di massa” al cui servizio si misero, erano state provocate da fredde oligarchie?.<br />
Forse. Al colloquio fra Contestabile e Buonocore è presente anche Fabio Treves, allora uno dei capi del Movimento<br />
Studentesco, oggi consigliere DP. “Adesso siamo qui a parlare lealmente fra noi, non abbiamo niente da nasconderci –<br />
dice rivolto a Buonocore – Ma tu ed io abbiamo pagato. Se abbiamo sbagliato, abbiamo pagato. Altri non hanno pagato<br />
mai”.<br />
LE PERSECUZIONI CONTRO I DUE PROTAGONISTI<br />
Il racconto di Luciano Buonocore<br />
“Alla metà di giugno del 1974 mi trovavo in vacanza in Calabria, con la mia famiglia. Ero molto stanco ed amareggiato,<br />
teso per il clima di persecuzione che sentivo montare contro noi dirigenti della “Maggioranza Silenziosa”. Il 19 seppi dal<br />
telegiornale, dell’arresto di Degli Occhi e del mandato di cattura contro di me. Per un attimo pensai di costituirmi, e di<br />
dimostrare l’assurdità delle accuse che mi venivano mosse. Ma una riflessione un po’ meno affrettata bastò a farmi<br />
considerare quello che mi sarebbe successo, se avessi fatto così: l’atteggiamento della stampa, della magistratura, dei<br />
politici in quei giorni era fin troppo istruttivo. Così presi la risoluzione di rifugiarmi all’estero, per il momento, in modo<br />
da esaminare con più calma il da fare. Da Tropea diressi in auto verso il nord. Varcai la frontiera svizzera senza problemi,<br />
a Porto Ceresio, dove i controlli erano minimi. A Lugano, il località Paradiso, presi alloggio in una camera ammobiliata; lì<br />
vicino abitava l’ingegner Piero Volpi BASSANI; milanese, sostenitore della “Maggioranza Silenziosa” e collaboratore, fra<br />
l’altro, della rivista Lotta Europea per i problemi economici. Fu lui ad aiutarmi per primo. Pochi giorni dopo, l’Unità<br />
segnalò la mia presenza in territorio ticinese, sostenendo che da oltreconfine “cospiravo contro la democrazia italiana”.<br />
La notizia – rimbalzata immediatamente alla televisione svizzera, fu anche ripresa dal Corriere del Ticino. Mi posi il<br />
problema di presentarmi alle autorità elvetiche per chiedere asilo politico. Chiesi un appuntamento all’avvocato<br />
Bernasconi, un legale noto in tutta la Svizzera come tradizionale difensore di perseguitati politici; già durante la guerra, e<br />
subito dopo, aveva imparzialmente difeso partigiani e fuoriusciti fascisti. Gli raccontai i fatti. Accettò di assistermi nella<br />
richiesta di asilo politico. Per non farmi correre rischi inutili, Bernasconi si consultò prima con il tribunale di Lugano e<br />
poi con il responsabile del locale ispettorato di polizia. Ottenne assicurazioni sul fatto che non sarei stato arrestato. Solo<br />
allora accettò un anticipo sull’onorario. Poi, mi fissò un appuntamento con le autorità della polizia elvetica. In<br />
commissariato, dove mi recai il giorno dopo, fui ricevuto gentilmente. Mi spiegarono che avrei dovuto adempiere ad<br />
alcune formalità burocratiche, dopo di che mi sarebbe stata indicata la località in cui avrei dovuto risiedere, in attesa<br />
dell’esilio della mia richiesta di asilo. In realtà, le “formalità” si rivelarono un interrogatorio, della durata di oltre tre ore.<br />
Il responsabile della polizia stava per congedarmi, alla fine, quando ricevette una telefonata, e mi fece cenno di restare.<br />
La telefonata fu brevissima. Poi il funzionario riattaccò il microfono e, rivolto a me con la stessa, immutabile gentilezza di<br />
prima, mi pregò (senza alcuna ironia) di accettare per qualche giorno (“per la sua stessa sicurezza”, mi disse) l’”ospitalità<br />
del governo svizzero”. Sarei stato “trattenuto” a “La Stampa” mi spiegò: che era un carcere – aggiunse subito – ma il<br />
carcere più confortevole e moderno della Confederazione, appena costruito, in cui avrei avuto una cella singola. Così mi<br />
ritrovai detenuto. Nel “modernissimo” carcere, e nella mia “confortevole” cella singola, restai chiuso tre giorni, senza che<br />
nessuno si preoccupasse di darmi una qualunque informazione, nemmeno di notificarmi un ordine di arresto. Al terzo<br />
giorno, di mattina, alla guardia che portava la colazione comunicai che da quel momento non avrei più accettato cibo fino<br />
a quando non avessi potuto parlare con il mio avvocato. L’avvocato Bernasconi fu avvertito e arrivò nel pomeriggio<br />
stesso, accompagnato dall’ispettore di polizia. Bernasconi mi mise al corrente di quel che era avvenuto, e mi chiarì il<br />
senso della telefonata al commissariato, che aveva cambiato d’improvviso la mia situazione: i socialisti ticinesi, mi spiegò,<br />
avevano protestato con il governo federale contro la mia presenza in territorio elvetico; per questo, mentre io venivo<br />
interrogato dal poliziotto, s’era riunito in gran fretta il consiglio cantonale a Bellinzona, aveva deliberato il mio arresto<br />
“cautelativo”, ed aveva fatto telefonare d’urgenza al commissariato perché l’arresto fosse eseguito. In conclusione,<br />
l’ispettore mi spiegò che, se avessi rinunciato a far domanda di asilo politico, sarei stato liberato. L’avvocato Bernasconi<br />
aggiunse che, se fossi rimasto fermo nella mia richiesta, avrei dovuto restare “ospite” del carcere fino a quando il governo<br />
federale non avesse deciso sul mio caso; altrimenti avrei potuto scegliere, fin dal quel momento, la frontiera alla quale<br />
essere accompagnato. Accettai subito di rinunciare alla richiesta d’asilo; anche perché la prospettiva di restare al lungo<br />
nel “moderno” carcere luganese – che in realtà assomigliava un po’ troppo ad un carcere di massima sicurezza, di quelli<br />
che l’Italia ancora non conosceva – non mi sorrideva affatto. L’avvocato e l’ispettore, contentissimi, si precipitarono al<br />
telefono, per comunicare a chi di dovere la mia decisione. In tanto, fui riportato in cella. Non chiusi occhio per tutta la<br />
notte; preparai i miei pochi effetti personali e attesi l’alba e l’annuncio della liberazione.<br />
Il mattino dopo, la guardia mi aprì la porta della cella. Fui tradotto in tribunale, davanti al giudice istruttore, nel cui<br />
ufficio trovai un signore a me sconosciuto. E mi comunicò che Bernasconi aveva rinunciato alla mia difesa (avrei saputo<br />
in seguito che l’avvocato Bernasconi, il cui figlio è magistrato della Confederazione, aveva ricevuto “pressioni” per<br />
rinunciare). Credevo che il giudice istruttore mi comunicasse la mia liberazione; invece mi notificò che le autorità italiane<br />
avevano chiesto la mia estradizione per reati di rapina in banca e sequestro di persona. Protestai con forza: ricordai che il<br />
mandato di cattura italiano contro di me parlava non già di reati comuni, ma di “cospirazione politica”, “sovversione” e<br />
“guerra civile”: reati che in Svizzera non sono contemplati dai codici. Aggiunsi che ero disposto a rinunciare alla richiesta<br />
di asilo, e a consegnarmi alla polizia italiana, se dall’Italia fosse arrivata anche una minima documentazione dei reati<br />
comuni di cui mi si accusava. Il mio avvocato si associò alla mia richiesta, e il giudice si apprestò a richiedere alle autorità<br />
italiane la documentazione dei nuovi reati contestatimi. Nel frattempo, fui rimandato “La Stampa”. Nel carcere, mi<br />
accorsi subito che l’atteggiamento delle guardie ed anche dei detenuti verso di me era cambiato: l’ostilità era palpabile.<br />
Qualcuno mi apostrofò come “fascista” e “assassino”. Era successo che la radio del Canton Ticino aveva diffuso la notizia<br />
secondo cui, in Italia, ero ricercato per la strage di Brescia, per rapine e sequestri. Il direttore del carcere, per evitare<br />
Luciano Buonocore – La Maggioranza Silenziosa e il Progetto Tecnocratico 27
aggressioni contro di me (a “La Stampa” erano chiusi alcuni detenuti svizzero di estrema sinistra) mi tenne segregato in<br />
cella per una settimana. Restai in galera per tre mesi, allo spirare dei quali il giudice istruttore mi convocò per<br />
comunicarmi quanto segue: la magistratura italiana aveva chiesto una proroga di 40 giorni per presentare la<br />
documentazione a mio carico, riguardante i reati comuni. Passarono i 40 giorni, e il giudice elvetico mi convocò di nuovo:<br />
le autorità italiane avevano chiesto altri 10 giorni di proroga. Trascorsero i 10 giorni, e finalmente il giudice di Brescia<br />
fece sapere in Svizzera che la richiesta di estradizione conteneva un “errore”, in quanto contro di me erano stati imputati<br />
soltanto reati di “natura politica”: cospirazione, guerra civile, e così via. La richiesta italiana di estradizione fu così<br />
respinta dal governo federale. Me lo comunicò, di li a pochi giorni, un funzionario giunto appositamente da Berna, il<br />
quale mi spiegò qual’era, a quel punto, la mia situazione. “Se lei insiste nella richiesta di asilo politico – mi disse –dovrà<br />
restare in carcere: non possiamo rilasciarla, perché abbiamo fondati motivi per credere che i servizi segreti italiani<br />
vogliano rapirla”. Proprio in quei giorni il governo federale aveva protestato per la presenza a Lugano del capitano La<br />
Bruna del SID, che – secondo le accuse svizzere – stava organizzando il sequestro di Remo Oraldini, un ricercato per<br />
cospirazione politica. Dissi che ero disposto a rinunciare. Mi fecero firmare una dichiarazione secondo cui lasciavo la<br />
Svizzera “di mia volontà” e mi richiusero in cella. Alle quattro di notte, in gran segreto, fui liberato e portato a Basilea, da<br />
dove fui accompagnato al posto di frontiera francese. Il passaggio del confine non presentò problemi. Presi il primo treno<br />
per Parigi.<br />
Nella capitale francese, preso alloggio nel Quartiere Latino, la mia prima preoccupazione fu di avvicinare giornalisti e<br />
uomini politici europei per far conoscere il clima di persecuzione che contro la nostra posizione s’era creata in Italia. A<br />
questo scopo feci anche più di un viaggio nella Germania Federale. In Assia, potei stabilire un buon rapporto con il locale<br />
capo della Democrazia Cristiana tedesca. A Monaco fui ricevuto dal Ministro degli Interni bavarese, Bruno Mecht, il quale<br />
mi garantì asilo politico in Germania “in qualunque momento ne avessi avuto bisogno”. La difficoltà della lingua tedesca,<br />
tuttavia mi consigliava di restare in Francia, dove tra l’altro – grazie ai buoni uffici della segretaria della “Maggioranza<br />
Silenziosa”, Margherita di Soragna – ero diventato amico di Francesca Filo Della Torre, che aveva a sua volta molte<br />
importanti relazioni a Parigi. Fu per suo tramite che conobbi Marié Helène De Montrichard, la moglie di Olivier Giscard<br />
D’Estaing, fratello dell’allora presidente della Repubblica francese. Ero senza lavoro: Marié Helène mi raccomandò ad un<br />
suo zio, che era ai vertici degli uffici parigini dell’OCSE. Li venni assunto, con un contratto a termine, nel reparto<br />
spedizioni delle pubblicazioni dell’organismo internazionale. Un reparto alla dipendenza del Dott. De Simone che avevo<br />
conosciuto una sera a casa di amici. Lavoravo all’OCSE.<br />
Poi, un giorno, il Corriere della Sera e L’Eurospeo pubblicarono una foto che mi ritraeva accanto a monsignor Bourget,<br />
un prelato vicino alle posizioni del tradizionalismo cattolico, di cui ero diventato amico: la mia presenza a Parigi divenne<br />
così ufficialmente nota. L’Ambasciatore italiano presso l’OCSE, Luciano Conti, ed il viceconsole Pietromarchi – i quali mi<br />
conoscevano benissimo, perché ci incontravamo spesso a cena in case di amici comuni chiesero (a seguito di una richiesta<br />
del governo italiano) il mio licenziamento dall’organizzazione. All’OCSE, si noti, lavoravano diversi rifugiati politici<br />
antifranchisti, e la Spagna, membro dell’OCSE, non aveva mai protestato. Per me le cose andarono diversamente. Fui<br />
costretto a lasciare il lavoro. Tirai avanti come potevo per qualche mese. Ma alla fine dovetti prendere in considerazione<br />
l’idea di costituirmi alle autorità italiane. Del resto, nel frattempo s’era aperto il processo al Mar di Fumagalli, in cui la<br />
magistratura mi aveva coinvolto: non correvo più il pericolo di subire anni di carcerazione preventiva. Mi presentai al<br />
valico del Monte Bianco il 14 gennaio del 1978. Fui tradotto a Brescia, nel carcere: lì finalmente, conobbi per la prima<br />
volta le persone - Fumagalli e gli altri – con le quali ero accusato di aver cospirato. Al processo, fu lo stesso p.m. Trovato,<br />
che aveva spiccato contro di me il mandato di cattura 4 anni prima, che dovette chiedere la mia assoluzione, mancando<br />
ogni minimo indizio sulla mia partecipazione ai fatti imputati! Nonostante questo, dovetti restare in carcere altri sei mesi.<br />
Nei quattro anni della mia latitanza, infatti, erano stati celebrati due processi contro di me, per scontri di piazza avvenuti<br />
nel 1969 e 1970 ( molto prima dunque della fondazione della “Maggioranza Silenziosa”), e a cui avevo preso parte come<br />
responsabile giovanile del MSI. Il mio avvocato non s’era presentato ai dibattimenti e, essendo io contumace, il giudice<br />
aveva designato un avvocato d’ufficio “pescato” nei corridoi del Palazzo di Giustizia, il quale non si era neppure<br />
preoccupato di interporre appello contro le condanne.<br />
Scontata anche quella pena, uscii dal carcere e riuscii a trovare lavoro come rappresentate prima, e poi come dirigente<br />
alle vendite in una ditta di articoli da regalo. Ma un mattino bussò alla mia porta un ufficiale giudiziario: aveva una<br />
convocazione per un ennesimo processo, riguardante una richiesta di confino contro di me. Ad elevare la richiesta era la<br />
DIGOS di Milano, che proponeva di mandarmi in un paesetto della provincia di Enna per 4 anni perché – recitava<br />
testualmente la richiesta – “il Buonocore non ha mutato le proprie idee politiche”. Nel rapporto di polizia figuravano<br />
anche tutta una serie di reati che avrei commesso all’età di 9 anni! Che fare? Il mio avvocato mi consigliava la prudenza,<br />
suggerendomi una difesa puramente giudiziaria, in sede di dibattimento. Ma io capivo ormai che contro questa ennesima<br />
persecuzione nei miei confronti, la sola difesa efficace era di renderla nota il più largamente possibile; bisognava far<br />
rumore, creare il caso, non subire in silenzio. Scrissi lettere a vari giornali, raccontando il mio caso: Indro Montanelli, sul<br />
suo “Giornale”, pubblicò la lettera, facendola seguire da un coraggioso commento. “Il Tempo”, “La Notte”, “Il<br />
Settimanale” scrissero articoli sulla mia vicenda; un paio di televisioni private a Roma e a Napoli, mi intervistarono.<br />
Intervenne pubblicamente in mia difesa il repubblicano Bucalossi. Molte lettere di solidarietà arrivarono a me<br />
personalmente, altre ai giornali. Il giorno del dibattimento, in Tribunale, risultò che il magistrato che avrebbe dovuto<br />
giudicare sulla richiesta di confino era stato sostituito all’ultimo momento con un altro, il dottor Corbetta. Il funzionario<br />
di polizia che avrebbe dovuto sostenere, per conto dell’autorità di P.S., la richiesta di confino, si scusò sostenendo che tale<br />
richiesta “era stata una svista” dovuta ad un maresciallo scritturale. Corbetta respinse dunque la richiesta”.<br />
Il racconto di Adamo Degli Occhi<br />
“Alle ore 6.30 del 19 giugno 1974 venni arrestato nella mia casa di via San Pio V da una schiera di carabinieri che la<br />
circondavano con mitra e telecamere. Esibirono un mandato di cattura – emesso dal pubblico ministero Trovato di<br />
Brescia – dove si parlava di “cospirazione politica, guerra civile, attentato alla Costituzione”. Fui portato alla caserma di<br />
Luciano Buonocore – La Maggioranza Silenziosa e il Progetto Tecnocratico 28
via Moscova e , di li, alle carceri di Canton Mombello a Brescia. Fui cacciato in una cella piccolissima, sette passi in giù e<br />
sette passi in su. Le inferiate davano sui bastioni. Potevo vedere le cime di due alberi verdi. Faceva un caldo asfissiante, e<br />
io non avevo diritto all’”aria”. Me ne stavo per ore sdraiato seminudo, sulla branda sfondata. L’unico diversivo, gli<br />
interrogatori. Non erano i primi, del resto, che subivo. Già un mese e mezzo prima, a Brescia, ero stato interrogato, in<br />
relazione all’incidente sul Mar di Fumagalli. E poi anche a Padova, in relazione alle indagini sulla “Rosa dei Venti”, dal<br />
giudice Tamburino. Erano stati mesi allucinanti. Una campagna di stampa contro di me, che mi collegava a quei gruppi<br />
(ero avvocato difensore di alcuni degli imputati in quelle inchieste), montava sui giornali. Il mio arresto imminente era<br />
preannunciato giorno dopo giorno. Giorgio Zicari, il giornalista del Corriere, mi telefonò la sera prima di quel 19 giugno<br />
per avvertirmi che il giorno dopo mi avrebbero arrestato. L’aveva saputo disse, in Questura. Arrivò a consigliarmi la fuga;<br />
mi indicò persino un albergo di Lugano dove avrei potuto prendere alloggio. Declinai l’invito. Seppi solo più tardi che<br />
quell’albergo era stato il rifugio del “bombardiere nero” Angelo Angeli. L’ambiente, gli interrogatori mi sfiancavano. La<br />
mia pressione salì a 200. Il giudice Trovato insisteva che io me la facevo salire con appositi esercizi fisici. Finalmente mi<br />
concesse di fare alcuni esami clinici; seppi poi che i risultati di quegli esami lo allarmarono. Il 13 o 14 ottobre, fui spedito<br />
a Milano per sottopormi ad una biopsia al fegato. Cominciò la mia peregrinazione fra i vari ospedali. Mi portarono al<br />
Fatebenefratelli,, al Policlinico, a Niguarda: dovunque venivo rifiutato, nessuno voleva curare “il fascista Degli Occhi”.<br />
Per impedire il mio ricovero, medici ed infermieri scendevano in sciopero. Quanto alle direzioni sanitarie, accampavano<br />
che la mia presenza in ospedale poteva provocare”incursioni di commandos”, che avrebbero avuto lo scopo di liberarmi.<br />
Respinto da tutti, fui richiuso a San Vittore, nell’infermeria. Le guardie, e anche il cappellano don Curioni, furono gentili<br />
con me, e mi aiutarono molto moralmente. Ma fu il rag. Fenaroli (di cui ero stato difensore) a sfamarmi: perché per 5<br />
giorni nessuno mi diede da mangiare. L’infermiera di San Vittore aveva sessanta letti e solo due gabinetti: questi erano<br />
praticabili soltanto per una o due ore dopo la pulizia, che avveniva alle 17. Subito dopo, si riempivano di escrementi. C’era<br />
merda letteralmente spalmata sulle pareti. E gli scorpioni correvano sul pavimento.<br />
Dopo 5 giorni – e 5 notti insonni – fui ricoverato al San Giuseppe una clinica privata. Rimasi là un mese per un<br />
completo ciclo di controlli. Indi fui portato all’improvviso all’ospedale di Brescia. Anche lì gli infermieri fecero alcuni<br />
giorni di sciopero contro il “fascista”. Io non sapevo nulla dello sciopero, anche perché mi era vietata la lettura dei<br />
giornali, e non potevo guardare la TV. Constatavo solo che nessuno mi curava. Decisi di fare una prova: mi punsi un dito<br />
e lasciai cadere numerose gocce di sangue nella mia urina raccolta per essere analizzata. Pochi giorni dopo mi<br />
comunicarono il “risultato” dell’esame: non si accennava alla presenza di sangue tutto era regolare. L’esame non era stato<br />
fatto. Fui di nuovo rinchiuso a Canton Mombello il 9 dicembre, in una cella dove c’erano altri tre detenuti, di cui uno<br />
epilettico. L’assenza di riscaldamento, e il fatto che un vetro della finestra era rotto, ci costringeva a passare a letto anche<br />
le giornate, sotto le coperte. Una volta protestai con violenza: gridai che io malato, a 54 anni, dovevo stare in una simile<br />
condizione mentre tutto il carcere parlava di Andrea Arcai, il figlio diciassettenne del mio giudice istruttore che –<br />
nonostante fosse fra gli accusati della strage di Brescia – era a piede libero. Per questa protesta, il 26 dicembre – il giorno<br />
dopo Natale, nel pomeriggio, fui scosso dal sonno in cui ero caduto e trasferito. “Ordine del giudice istruttore”, mi fu<br />
detto. La mia destinazione: il manicomio criminale di Castiglione delle Stiviere. Vi giunsi di notte nella nebbia, con una<br />
scorta di 5 automobili piene di carabinieri armati, ammanettato. E poiché il giudice Arcai aveva raccomandato per me la<br />
più stretta vigilanza, fui richiuso in una delle cellette destinate ai pazzi agitati: dove c’era si e no posto per il letto. Da uno<br />
spioncino, un occhio mi fissava ogni quarto d’ora. La celletta si apriva su un altissimo corridoio con una dozzina di celle<br />
per parte, illuminato da una spettrale luce al neon. Spesso, da quel corridoio, udivo urla, accorrere di infermieri, rumori<br />
di colluttazioni. Nelle giornate interminabili, udivo i vaneggiamenti di questo o quel malato. Furono due medici del<br />
reparto, come seppi poi, a protestare per la mia reclusione. Le loro attenzioni, le loro visite del resto alleviarono un poco<br />
quei 15 giorni passati al manicomio. Fu grazie a loro se, infine, fui rimandato a Canton Mombello. Avevo sempre la<br />
pressione altissima, la mia salute non era affatto buona. Mi logoravano, soprattutto, i continui, lunghissimi interrogatori<br />
cui venivo sottoposto in carcere, all’ospedale, dovunque: i giudici volevano sapere da me di certi carri armati, che<br />
sarebbero stati sepolti in Valtellina. In attesa di essere consegnati a fantomatiche armate che io avrei dovuto comandare.<br />
Poi ci furono i processi pubblici, i dibattimenti: che sono come grandi malattie. Credo che proprio allora ponessero le<br />
condizioni fisiche e spirituali per i diversi infarti che mi hanno colpito”. L’avvocato Adamo Degli Occhi, muore d’infarto il<br />
14 marzo del 1986.<br />
APPENDICE<br />
Alcune considerazioni sulla tesi di laurea della Dott.ssa E. Cattini<br />
Nel marzo 1985, Elisabetta Cattini, 25enne laureata in Scienza Politiche all’Università di Milano, dedica la sua tesi di<br />
laurea a “Una esperienza originale della destra italiana: la Maggioranza Silenziosa (1971-1974)”. La tesi ha come relatore<br />
il professor Roberto Chiarini, noto studioso della destra italiana. La Cattini, dopo aver rifiutato sia la “visione riduttiva”<br />
(la destra è un fenomeno effimero e slegato dalla società), sia la “visione allarmante” (la destra, pericolosissima, cerca di<br />
abbattere la democrazia), proprie, ambedue, alla pubblicistica antifascista, osserva come esista a destra “un cosmo non<br />
omogeneo, animato da soggetti che hanno diverse radici culturali, diversi referenti sociali, diversi progetti politici.<br />
L’analisi deve essere attenta alle differenze e alla specificità di ogni aspetto del cosmo nero più che procedere cercando i<br />
tratti comuni di questa vasta area”. Così viene implicitamente sconfessata la canagliesca teoria dietrista, segno del<br />
peggior guerrocultismo, secondo cui a destra esisterebbero solo marionette mosse da pochi manovratori, al servizio di<br />
una oscura trama.<br />
Per l’autrice l’analisi della destra condotta in chiave militante dell’antifascismo “è strumentale, nella misura in cui essa<br />
giustifica posizioni e scelte politiche”. “Questa finalità spesso soffoca la voce dell’oggetto studiato, il “neofascismo”, con il<br />
che ci riallacciamo alla necessità, da noi prima evidenziata (per quanto sia addirittura elementare), di una analisi di tutti i<br />
fenomeni svolta anche dall’interno. Mediante questo approccio “aperto” la Cattini riesce a comprendere ed evidenziare il<br />
sincero sforzo degli animatori della Maggioranza Silenziosa reso a creare e mantenere un movimento apartitico,<br />
Luciano Buonocore – La Maggioranza Silenziosa e il Progetto Tecnocratico 29
autonomo, socialmente incisivo e capace di agire con efficacia temi di notevole rilevanza, come la libertà, stimolando, così<br />
tra l’altro, i partiti anticomunisti a svolgere il loro ruolo più decisamente. Ma all’autrice non sfuggono altri aspetti, più<br />
profondi: ad esempio, gli intenti di costruzione cultura duratura e radicale, specie tramite numerosi interventi pubblicati<br />
su Lotta Europea, dedicati a tematiche quali la critica di molti aspetti del mondo moderno, lontana, però dal moralismo<br />
dei benpensanti, il richiamo alla vera spiritualità, non solo cristiana, la dottrina “organica” dello stato, l’analisi critica dei<br />
fenomeni culturali contemporanei, ecc. Accanto a tutti i meriti, dobbiamo rilevare gli aspetti negativi presenti nello<br />
studio. Tra questi osserviamo un certo indulgere in una vetero-demagogia, laddove, ad esempio, si attribuisce una<br />
funzione di “polo” culturale alla classe operaia, specie dopo l’autunno caldo. Ancora: risulta inaccettabile il sociologismo<br />
con cui vengono infarcite certe analisi, viziate di classismo e di economicismo, elementi che, inevitabilmente, finiscono<br />
col fare trascurare, in certi momenti, le idealità che animavano, insieme ad altre esigenze di materiale, i vari ceti sociali e<br />
che spinsero molti verso l’anticomunismo e la Maggioranza Silenziosa. Legata a questi limiti nella tesi traspare spesso<br />
l’incapacità a comprendere la piena legittimità dell’anticomunismo, ritenuto quasi una fissazione maniacale! Ma<br />
nonostante le ambiguità e i tentennamenti, la parabola della Maggioranza Silenziosa, nata nel 1971 e finita nel 1974, viene<br />
ben delineata, uscendo finalmente dalle cronache per divenire oggetto di studio e di analisi, specchio di un mondo che<br />
non voleva seguire passivamente il “corso della storia”, a cui, tutto sommato, non riconosceva alcun senso, ma che voleva,<br />
nel suo piccolo contribuire a cambiarlo. Pubblichiamo alcuni capitoli della sua Tesi.<br />
della Dott.ssa E. Cattini<br />
UNA ESPERIENZA ORIGINALE DEL<strong>LA</strong> DESTRA ITALIANA:<br />
<strong>LA</strong> <strong>MAGGIORANZA</strong> <strong>S<strong>IL</strong>ENZIOSA</strong> (1971-1974)<br />
La presente ricerca si è posta l’obiettivo di delineare il percorso della “Maggioranza Silenziosa” milanese, esperienza<br />
“originale” della destra italiana negli anni ’70. L’analisi è un tentativo di ricostruire l’evoluzione delle iniziative e delle<br />
linee programmatiche di una componente di quella vasta area della destra verso la quale l’impegno degli storici è sempre<br />
stato più propenso ad innalzare la pregiudiziale dell’antifascismo, piuttosto che affrontare storicamente il problema.<br />
Molto spesso infatti la storia ha guardato alla destra del dopoguerra con un atteggiamento di sufficienza considerandola<br />
una sorta di “residuo del passato” non abbastanza degno di interesse storico. Solo recentemente si è risvegliata una certa<br />
attenzione verso il mondo della destra e si è cominciato a guardare ad esso come ad un fenomeno con radici non effimere<br />
nella nostra storia, anzi sempre profondamente legato alle condizioni di sviluppo della società, ai problemi che essa deve<br />
di volta in volta affrontare, alle peculiarità della sua cultura. Da parte degli storici più attenti si è consolidata la<br />
consapevolezza che è possibile affrontare il fenomeno del neofascismo, e più in generale della destra italiana, con un<br />
metodo di indagine che metta a fuoco lo specifico di ciascuna esperienza storica. Solo una analisi differenziata dei<br />
movimenti e dei gruppi compresi nell’ampia categoria della destra porta ad una visione più appropriata del fenomeno. Da<br />
qui, l’importanza delle ricerche locali per ricostruire il puzzle del grande “cosmo nero”.<br />
Sotto questa nuova spinta, l’indagine storica ha cominciato a mettere in luce l’estrema varietà della componenti della<br />
destra, varietà che rende assai difficile precisare concettualmente il fenomeno. Alla luce di questi recenti sviluppi<br />
storiografici, i primi capitoli di questa ricerca tentano il bilancio critico della tradizionale storiografia del neofascismo,<br />
evidenziandone le carenze e i limiti. Ben lontani dalla pretesa di formulare una analisi concettuale esaustiva, si è cercato<br />
di definire i confini della destra radicale, per dimostrare come il termine “neofascismo”, costretto a comprendere realtà<br />
così articolate e diverse tra loro, dilatando la propria area semantica rischi di perdere pregnanza e significato. Sulla base<br />
di queste riflessioni, la presente ricerca ha cercato di far luce sul rapporto tra la “Maggioranza Silenziosa”, che tutta la<br />
storiografia relega in questo ambiguo spazio del “neofascismo”, e il mondo della destra radicale, sottolineando i punti di<br />
contatto della esperienza milanese con altre innumerevoli realtà della destra, ma anche l’”originalità” della sua<br />
espressione e della sua storia.<br />
Per capire il fenomeno della “Maggioranza Silenziosa”, abbiamo ritenuto indispensabile tracciare il quadro del suo<br />
“terreno di cultura”. Il capitolo sugli anni ’70, che certo non vuol essere uno studio esauriente della complessa situazione<br />
italiana di quegli anni, coglie alcuni aspetti essenziali della società, che costituiscono le coordinate dello sviluppo della<br />
“Maggioranza Silenziosa”. Da un lato, si è posta l’attenzione al clima degli anni ’70, che, soprattutto a causa del fallimento<br />
del centrosinistra e della crisi generata dall’”autunno caldo”, è caratterizzato da un profondo senso di incertezza per il<br />
futuro e di sfiducia verso le istituzioni. Dall’altro, si è sottolineato il fatto che tra la fine degli anni ’60 e l’inizio degli anni<br />
’70, in virtù del nuovo corso del MSI di Almirante, si colloca un vero e proprio punto di svolta nella storia della destra,<br />
tanto da determinare una sorta di rigenerazione della sua identità politica. Infine si comprende il fenomeno della<br />
“Maggioranza Silenziosa” collocandolo nel contesto cittadino di Milano, metropoli industriale dalle specifiche<br />
caratteristiche. All’interno di queste linee generali di sviluppo, la nostra ricerca ricostruisce la storia del movimento della<br />
“Maggioranza Silenziosa” dal 1971 al 1974.<br />
Tuttavia l’indagine si è trovata di fronte a molteplici problemi, tra cui in primo luogo la difficoltà di reperire una<br />
documentazione soddisfacente. Dal momento che non esistono sulla “Maggioranza Silenziosa”, è stato necessario un<br />
ampio ricorso a materiale inedito. Abbiamo raccolto e analizzato volantini, ciclostilati, manifesti murali, carte private,<br />
manoscritti. Questo tipo di indagine ha incontrato varie difficoltà. Innanzi tutto, si affaccia il problema della<br />
“completezza” del materiale utilizzato. Può darsi che parte dei volantini, dei manifesti, delle carte private riguardanti la<br />
“Maggioranza Silenziosa” siano andati perduti. Inoltre quasi tutto il materiale documentario inedito preso in visione ci è<br />
stato fornito direttamente da coloro che furono i promotori della “Maggioranza Silenziosa”. Non è escluso che parte di<br />
questo materiale non sia stato versato oppure sia stato materialmente distrutto, perché ritenuto in qualche modo<br />
imbarazzante. Un altro problema di peso non indifferente è il problema della datazione delle fonti. Spesso volantini e<br />
manifesti non sono datati. In tal caso se è stato possibile stabilire con certezza l’anno della pubblicazione di un<br />
documento, non è sicura l’attribuzione del mese e tanto meno quella del giorno. Tale impossibilità di avere esatte<br />
Luciano Buonocore – La Maggioranza Silenziosa e il Progetto Tecnocratico 30
coordinate cronologiche ha determinato in molti casi imbarazzo e difficoltà nella ricerca della linea evolutiva della<br />
“Maggioranza Silenziosa”. Infine, il materiale inedito considerato ha determinato difficoltà interpretative di non scarso<br />
rilievo. Il linguaggio dei volantini e dei manifesti è spesso aggressivo, sarcastico, retorico. Più che affrontare<br />
razionalmente e logicamente un problema, in questo tipo di materiale si predilige il messaggio incisivo, colorito, laconico,<br />
alternando attacchi, polemiche e inviti. E’ allora necessario interpretare i contenuti sotto questa “scorza” formale,<br />
cogliere, al di là di formule ripetitive e di toni simili, il significato di ogni documento nella sua articolazione con altri<br />
documenti. Tale lavoro consente di mantenere un indispensabile, stretto collegamento tra lo sviluppo del dibattito<br />
interno alla “Maggioranza Silenziosa” e tutto ciò che nel contempo si verifica nella città, sia pure tracciato solo a grandi<br />
linee. Oltre a queste fonti edite, la ricerca si è servita anche di fonti inedite. Soprattutto per quanto riguarda le<br />
manifestazioni della “Maggioranza Silenziosa” , sia quelle svolte, sia quelle indette dal Comitato Cittadino Anticomunista<br />
della “Maggioranza Silenziosa” e poi vietate dal Questore, è stato indispensabile lo spoglio delle pagine di cronaca dei<br />
quotidiani più importanti. Anche questo ha segnato alcuni limiti alla nostra ricerca.<br />
Riguardo alla “Maggioranza Silenziosa”, i giornali mettono in luce solo l’aspetto “clamoroso”, cioè il momento in cui<br />
vengono annunciati o vengono fatti i cortei e i comizi, oppure quando in consiglio comunale sorgono polemiche sulle<br />
attività del movimento o nel caso in cui si verifichino incidenti. Rimane tutta da scrivere la storia delle idee e dei progetti<br />
della “Maggioranza Silenziosa”, l’analisi dei suoi comportamenti politici e del suo paradigma culturale. Oltre ai giornali,<br />
la ricerca si è servita di un’altra fonte edita: la rivista “Lotta Europea”, organo ufficiale della “Maggioranza Silenziosa”.<br />
Essa uscì dal ’72 al ’74 e vi collaborarono quasi tutti i membri del Comitato Cittadino Anticomunista. Infine, per chiarire<br />
alcuni aspetti è stata molto utile la fonte orale. Gentilmente, alcuni tra coloro che hanno dato vita alla “Maggioranza<br />
Silenziosa” hanno concesso interviste che in certi casi si sono rivelate preziose. La non contemporaneità delle<br />
testimonianze orale rispetto all’oggetto dell’indagine comporta non pochi problemi di attendibilità. A parte i problemi<br />
connessi al carattere selettivo della memoria ed alle possibili deformazioni connaturate al processo di memorizzazione,<br />
c’è il rischio di una datazione errata o ancora che il ricordo venga viziato da suggestioni o influenze subite in momenti<br />
successivi. In tal caso si potrebbero attribuire alla “Maggioranza Silenziosa” progetti, motivazioni, ideologie e scelte che in<br />
realtà vengono gestite e partorite in altri periodi storici.<br />
L’iniziale ipotesi che la ricerca voleva verificare è questa: la “Maggioranza Silenziosa” non è stata soltanto uno dei<br />
molteplici aspetti della politica del “doppio binario” di Almirante, ma al di là di indubbi legami con il MSI e di una<br />
altrettanto indubbia appartenenza al mondo culturale e politico della destra, la “Maggioranza Silenziosa”presenta sue<br />
caratteristiche specifiche, tali da legittimare l’attribuzione di “originalità” al fenomeno e da giustificare l’attenzione che, a<br />
nostro avviso, merita. I dati che sono emersi dall’indagine sono complessi e il rapporto tra la “Maggioranza Silenziosa” e<br />
il MSI non è così stretto né così costante come la stampa del tempo presupponeva. Per capire la dialettica tra i due, è<br />
necessario innanzi tutto stabilire una divisione all’interno della storia della “Maggioranza Silenziosa”. La prima fase di<br />
questo movimento va dalla fondazione del Comitato Cittadino Anticomunista alla fine del ’71; la seconda fase comprende<br />
il successivo periodo, dal ’72 al ’74. Tra la prima e la seconda fase c’è un salto qualitativo sia per quanto riguarda il<br />
rapporto con il MSI, sia per quanto riguarda programmi e modalità d’intervento. Durante il primo periodo la<br />
“Maggioranza Silenziosa” privilegiò la prassi dell’intervento in piazza: siamo nella stagione delle grandi manifestazioni. I<br />
“protagonisti” di questa prima fase sono forze politiche e sociali molto diversificate, sia nella composizione del Comitato<br />
Cittadino Anticomunista, sia nella formazione dei cortei. Infatti all’interno del C.C.A. insieme a missini e a monarchici<br />
furono presenti uomini legati al PSDI, alla DC, al PLI. Del resto, i leaders stessi della “Maggioranza Silenziosa” fecero di<br />
tale eterogeneità il punto di forza del loro movimento.<br />
Uno dei principali organizzatori del gruppo, Luciano Buonocore, che nel ’71 era il coordinatore regionale giovanile del<br />
MSI, afferma: “Per la prima volta, dal dopoguerra in poi, c’era il tentativo, a nostro avviso riuscito, da parte di noi giovani<br />
di destra, di uscire da quel mondo chiuso del MSI e del FdG, che si era sempre contrapposto globalmente all’avversario –<br />
cioè al democristiano, al liberale, al socialista . . . – senza alcun rapporto dialettico, e di aggregarsi, anche a livello di<br />
amicizia, con forze politiche e persone diverse da noi”. Anche nelle manifestazioni di piazza la gente che formò i cortei<br />
aveva provenienza eterogenea. A parte certe “code” di estremisti di destra, che inneggiavano al Duce ed erano spesso<br />
causa di disordini, la folla dei cortei non assunse mai una netta colorazione politica. Gli slogan, gli striscioni e gli inni<br />
cantati non facevano riferimento né al MSI, né ad altro partito, ma si appellavano ad un generico quanto profondo<br />
anticomunismo, contro il quale contrapponevano il senso della dignità e della libertà di ogni italiano.<br />
Nella seconda fase, la “Maggioranza Silenziosa” acquistò caratteristiche diverse. In primo luogo, mutarono le sue<br />
modalità d’intervento nella società. Non potendo più organizzare mobilitazioni di piazza, che dal maggio ’71 furono<br />
sempre sistematicamente vietate dal Questore di Milano, attraverso un rinnovato linguaggio propagandistico fatto<br />
tramite volantini, manifesti murali e ciclostilati, la “Maggioranza Silenziosa” precisò l’oggetto dei suoi massicci attacchi,<br />
di volta in volta rivolti al “Corriere della Sera” , al Questore, al Sindaco, al governo. In questo secondo periodo, la<br />
“Maggioranza Silenziosa” si avvicinò al MSI. Vuoi per i divieti del Questore, vuoi per un mutato clima generale, in cui<br />
l’eco dell’”autunno caldo” perdeva ogni giorno il suo effetto allarmante e suonava sempre più smorzato, il movimento<br />
della “Maggioranza Silenziosa” assottigliò le sue file, mentre vennero meno adesioni e consensi. Numerose personalità<br />
che avevano aderito alla “Maggioranza Silenziosa” nel primo periodo ora se ne distaccavano e quasi tutti i partiti dell’arco<br />
costituzionale – DC, PSDI, PLI – ne presero le distanze. Benché i leaders del movimento continuassero a proclamarsi “al<br />
di sopra” dei partiti, tale linea apartitica fu più volte contraddetta. Non solo ad un certo punto venne proposta la<br />
creazione di un partito vero e proprio, ma, in occasione delle elezioni del ’72, sulla rivista “Lotta Europea” si invitavano<br />
esplicitamente i lettori a votare MSI-DN. Altrettanto significativa è la dichiarazione rilasciata nel maggio ’73 dal senatore<br />
missino Gastone Nencioni: “Oggi alla “Maggioranza Silenziosa” ha dato un volto e la voce il MSI”.<br />
Luciano Buonocore – La Maggioranza Silenziosa e il Progetto Tecnocratico 31
Neofascismo e destra radicale nella storiografia<br />
a) Un bilancio critico<br />
L’attuale successo editoriale delle pubblicazioni, dei convegni e delle ricerche sulla “nuova destra” e sul neofascismo sono<br />
la prova di una risvegliata attenzione verso la destra. Alla luce di questo nuovo interesse sono apparse quanto mai<br />
evidenti la carenza della produzione storiografica del neofascismo e la profondità dello “scompenso” tra le ricerche sul<br />
fascismo, numerose e continuamente rinnovate, e quelle sul neofascismo, poche e inadeguate (1). La storiografia sul<br />
neofascismo si muove tra due poli estremi: quelle che potremmo chiamare da un lato “visione riduttiva” del fenomeno;<br />
dall’altro, “visione allarmante”. Quando la ricerca si muove attorno al polo della “visione riduttiva”, il neofascismo viene<br />
fotografato come un fenomeno effimero e slegato dalla società, una sorta di revival nostalgico del fascismo storico. Il<br />
neofascismo, secondo questo tipo di interpretazione, manca di un proprio spessore culturale ed è incapace di organizzare<br />
progetti politici per il futuro (2). Esso, benché responsabile di atti terroristici ha di per sé una pericolosità ben circoscritta<br />
e soprattutto arginabile. Se la storiografia si sposta invece verso l’altro polo, verso la “visione allarmante” del<br />
neofascismo, l’attenzione cade sulla possibilità di crescita di questo fenomeno, sulla pericolosità che scaturisce dai valori<br />
anti-democratici su cui esso si fonda, sulla necessità di una immediata risposta democratica. In quest’ottica, il<br />
neofascismo è il tessitore di una occulta e intelligente “trama nera” che percorre il nostro Paese e a volte ne oltrepassa i<br />
confini, per entrare in un “quadro internazionale” di misteriose collusioni e di pericolosi progetti eversivi. In qualsiasi<br />
tipo di interpretazione, il neofascismo è comunque visto come il non-ideale contrapposto ad altri ideali affermati, che<br />
possono essere di volta in volta ideali di giustizia, di democrazia, di socialismo. A questo proposito, scrive Chiarini:<br />
“L’assunto di partenza, da tutti condiviso, è il rigetto del fascismo e, per contaminazione, della destra. E questo non solo e<br />
non tanto perché rappresentano esperienze storiche superate o, magari, definitivamente seppellite, ma soprattutto<br />
perché sono considerati “non ideali” e come tali passibili di indagine scientifica semplicemente come pietre d’inciampo<br />
nel percorso della democrazia”.<br />
Sia che venga visto come minaccia all’ordine costituito, sia che venga visto come un fenomeno poco preoccupante, il<br />
neofascismo è un bersaglio da colpire, un fenomeno da registrare e da descrivere nelle sue manifestazioni più evidenti,<br />
più che una realtà storica da capire e da studiare nelle sue profondità. Spesso il neofascismo è stato considerato come un<br />
fenomeno slegato dal contesto politico, economico e sociale in cui nasce e si sviluppa; la ricerca sul suo radicamento e sui<br />
suoi legami con la società è stata superficiale. Gran parte della storiografia si è mobilitata per cercare il neofascismo e per<br />
denunciarlo, ma sempre guardandolo come un “bubbone esterno”, da studiare in sé e per sé, senza chiedersi quale fosse il<br />
tessuto sociale a cui era attaccato e che rapporti avesse con esso. Avulsa dal contesto storico a cui era legata da fili visibili<br />
e invisibili, l’analisi del neofascismo (come di ogni problema) perde le precise coordinate che lo spazio e il tempo della<br />
storia danno ai fatti studiati. Si slitta allora su un piano metastorico, verso una dimensione astratta che non è più storia.<br />
Non basta riconoscere nel “bubbone” del neofascismo il sintomo della “malattia antidemocratica”; non è neppure<br />
corretto, su questa base, accumunare fascismo, neofascismo, eversione, destra radicale . . . Occorre scavare più a fondo.<br />
Occorre osservare e capire perché e, soprattutto, in quali momenti storici il corpo sociale divenga pericolosamente privo<br />
di anticorpi fino alla vulnerabilità.<br />
Lo studio della destra deve essere allora lo studio dei problemi politici, economici e sociali, che una democrazia ha in un<br />
preciso momento e che determinano precise modalità di sviluppo della destra stessa. Muovendosi da questa base, lo<br />
studio del neofascismo porta a scoprire un cosmo non omogeneo, animato da soggetti che hanno diverse radici culturali,<br />
diversi referenti sociali, diversi progetti politici. L’analisi deve essere attenta alle differenze e alla specificità di ogni<br />
aspetto del”cosmo nero” più che procedere ricercando i tratti comuni di questa vasta area. Per quanto già la scelta<br />
dell’argomento di studio implichi una propria interpretazione, lo storico deve sforzarsi di mantenere una “dualità<br />
necessaria” tra l’oggetto da conoscere e l’interprete che conosce. Deve quindi preoccuparsi di dare all’oggetto una forte<br />
presenza, una propria configurazione, affinché la “voce” dell’interprete non soverchi quella dell’oggetto studiato. A volte<br />
invece, sotto il peso della pregiudiziale dell’antifascismo, la ricerca storica sul neofascismo ha dato poca “autonomia” al<br />
fenomeno studiato. L’analisi è stata spesso strumentale, volta a rinsaldare l’opinione pubblica intorno ai valori<br />
democratici oppure a sostenere proprie strategie politiche. Non a caso tra la storiografia del neofascismo prende posto<br />
una vasta letteratura militante, per la quale la conoscenza del problema è strumentale, nella misura in cui essa giustifica<br />
posizioni e scelte politiche. Questa finalità spesso soffoca la “voce” dell’oggetto studiato, il neofascismo. Inoltre, la<br />
letteratura militante si avvale soprattutto di lavori di cronaca e di inchieste basate su fonti giornalistiche. Il giornale tende<br />
per sua natura a mostrare l’occasionale, l’abnorme, ciò che fa colpo, più che il quotidiano, il compresente. Il prevalente<br />
uso delle fonti giornalistiche porta ad una sorta di “storia evenemetielle”, tesa a scandire i tempi storici mettendo a fuoco<br />
il “fatto diverso”, che colpisce in quanto è inaspettato e inconsueto. Le analisi sul neofascismo basate su fonti<br />
giornalistiche sono infatti “cronache nere” delle imprese terroristiche, degli attentati, degli episodi di violenza di marca<br />
neofascista. Ne risulta un puzzle assolutamente incompleto: il neofascismo è anche nella dimensione terroristica di<br />
queste “cronache nere” , ma sicuramente non solo qui. Lo storico di oggi ben conosce le insidie e i pericoli di questo tipo<br />
di indagine. Egli ha recepito un nuovo modo di fare storia, che non si ferma agli eventi superficiali, ma scende nelle<br />
pieghe nascoste della società, al di sotto della “crosta” degli avvenimenti, per cogliere un fenomeno anche nei suoi silenzi,<br />
in quel modo di essere o di agire che al giornalista non appare rilevante (10).<br />
Una corretta analisi storica del problema del neofascismo porta allora a considerare non solo le attività di terrorismo di<br />
destra che attacca dall’esterno la società secondo modalità inconsuete ed abnormi, ma un più vasto mondo culturale e<br />
sociale convivendo ogni giorno con altre parti sociali e divedendo con esse gli stessi spazi vitali. Si torna dunque al<br />
problema trattato precedentemente: quello della necessità di cogliere i nessi e le connivenze tra il neofascismo e il tessuto<br />
sociale. Per questo tipo di analisi del problema, uno degli strumenti più efficaci è la ricerca locale (11). Limitando nello<br />
spazio il raggio di interesse, infatti, risulta più facile mettere in luce i legami del “cosmo nero”, con la realtà economica,<br />
politica e sociale, evitando di scivolare sul piano dell’astrattezza. Inoltre, una ricerca locale è più idonea a descrivere un<br />
problema, in quanto la realtà globale del nostro Paese si presenta eccessivamente articolata per poterla ricondurre ad un<br />
Luciano Buonocore – La Maggioranza Silenziosa e il Progetto Tecnocratico 32
quadro unitario sufficientemente completo. In questo senso, le ricerche locali sono utilissime per ricostruire una mappa<br />
precisa del neofascismo.<br />
b) L’approccio al tema della “Maggioranza Silenziosa”<br />
Inquietudine delle classi medie, senso di incertezza e crisi di fiducia verso le istituzioni, da un lato. Dall’altro, rilancio<br />
del neofascismo e rinvigorimento dell’MSI. E’ proprio alla luce di questi due aspetti della società italiana dei primi anni<br />
’70 che acquista rilievo uno studio sul fenomeno della “Maggioranza Silenziosa”. Innanzi tutto, manca da parte della<br />
storiografia un approfondimento serio sul fenomeno milanese della “Maggioranza Silenziosa”, che riconosca pienamente<br />
la specificità di questo movimento che, al di là di legami con l’MSI, al di là di collusioni con le forze più diverse del Paese,<br />
ha avuto una originalità sia nell’organizzazione, sia nel tentativo di creare una propria base ideologica. I brevi accenni<br />
che si possono trovare sulla “Maggioranza Silenziosa” si collocano per lo più all’interno della storiografia sul neofascismo.<br />
Già questo è significativo della predominante interpretazione data al fenomeno milanese, che mette innanzi tutto in luce<br />
il legame che la “Maggioranza Silenziosa” ha con il neofascismo, presentandola addirittura come una delle tante<br />
maschere sotto cui il partito di Almirante ha agito. Fra gli altri, Gaddi ha chiaramente espresso questa interpretazione.<br />
Secondo questo autore, che dedica qualche riga alla “Maggioranza Silenziosa” nella sua opera sul neofascismo in Europa,<br />
essa si colloca sulla linea ambigua e ambivalente del “doppiopetto e tritolo” tenuta dall’MSI di Almirante. Non solo la<br />
“Maggioranza Silenziosa” ha un carattere neofascista e aggressivo a tal punto che durante la prima manifestazione<br />
pubblica che si tenne a Trapani il 7 marzo 1971 qualcuno disse che quelli della “Maggioranza Silenziosa” erano “pronti a<br />
sparare”. Ma addirittura, alla manifestazione celebrativa del 25° anniversario dell’MSI, Almirante proclamò che “M.S.I.”<br />
non significava più “Movimento Senza Importanza”, ma era diventato “Maggioranza Silenziosa Italiana”. Con ciò egli<br />
ammetteva anche la paternità del MSI nei confronti del movimento qualunquistico-fascista comparso poco prima a<br />
Milano appunto con il nome di “Maggioranza Silenziosa”. Un’interpretazione simile è quella di Rossella, il quale afferma<br />
che la “Maggioranza Silenziosa” è la maschera dietro cui si è celato l’MSI, che, mentre ovunque scoppiavano bombe e<br />
avvenivano attentati di chiara marca fascista, indossava il “doppiopetto dei benpensanti” per convincere e coinvolgere i<br />
ceti medi. Dunque la “Maggioranza Silenziosa” è una operazione volta a “impostare una offensiva moderata, perbenista,<br />
egemonizzata però dal Movimento Sociale”.<br />
La studiosa tedesca Rosenbaum, che ha condotto una ampia ricerca sul neofascismo italiano, definisce la “Maggioranza<br />
Silenziosa” il “volto falsamente perbenista” dell’MSI. Ma oltre a sottolineare questa stretta parentela con l’MSI, lo studio<br />
della Rosenbaum coglie l’immagine più dilatata e più complessa della “Maggioranza Silenziosa”. Dietro ad essa si<br />
coprono settori della DC, del PSDI, del PLI, pronti a scendere in piazza con richieste di ordine e di pace. Sono, secondo la<br />
Rosenbaum, gli stessi “settori americani” che appoggiavano nello stesso tempo la strategia della tensione al fine di<br />
spostare più a destra l’asse politico del Paese e che spesso, per far questo, trovavano tra i fascisti gli organizzatori e gli<br />
esecutori. Rosenbaum vede dunque nella “Maggioranza Silenziosa” anche uno dei tanti esempi delle collusioni esistenti<br />
tra neofascismo e una parte dei partiti moderati DC, PLI, PSDI. Proprio su questa caratteristica Bocca ha posto l’accento:<br />
la “Maggioranza Silenziosa” è un movimento reazionario che ha raccolto cattolici di destra, fascisti, moderati e “borghesia<br />
dell’ordine”. Barbieri inquadra la “Maggioranza Silenziosa” nel più ampio tentativo del 1971 di riorganizzare una “grande<br />
destra”. In questa convergenza dovevano confluire i fascisti dichiarati da una parte, e la destra politica, economica e delle<br />
forze armate dall’altra. La “Maggioranza Silenziosa” è stata uno degli aspetti di tale convergenza. Essa infatti è nata per<br />
organizzare una piazza di destra in cui fossero presenti anche strati sociali moderati ed esponenti dei partiti antifascisti.<br />
Nell’ambito della storiografia sul neofascismo, si privilegia dunque l’interpretazione della “Maggioranza Silenziosa” come<br />
espressione dell’estrema destra, cogliendone il profilo ambiguo, non nettamente delineato, ma soprattutto<br />
evidenziandone i diretti legami con l’MSI. Rimane più sfuocato l’aspetto per così dire sociologico della “Maggioranza<br />
Silenziosa” . Essa infatti esprime la crisi delle classi medie nella società milanese nei primi anni ’70. La “Maggioranza<br />
Silenziosa” rappresenta innanzi tutto la reazione della borghesia che impaurita dalla “piazza rossa”, vuole rispondere<br />
organizzando la “sua” piazza d’ordine. La parola d’ordine diventa allora “anticomunismo”, e il suo partito comunista il<br />
principale bersaglio. Inoltre le manifestazioni e le iniziative della “Maggioranza Silenziosa” sono il segno della crisi di<br />
fiducia delle classi medie verso le istituzioni, al punto che essa muove un attacco diretto non solo contro i partiti di<br />
sinistra, ma anche contro le forze governative e lo Stato. Infine la “Maggioranza Silenziosa” si fa interprete della crisi di<br />
identità culturale che investe il ceto medio degli anni ’70. Soprattutto in una seconda fase, dal ’72 al ’74, essa cerca di<br />
risolvere questa crisi creando una propria base ideologica da cui muoversi, che fornisca al ceto medio un comune quadro<br />
di riferimento.<br />
Dal “fascismo storico” al “neofascismo”: quale continuità?<br />
Un problema che lo studio sul variegato “cosmo nero” si deve porre è quello della legittimità dell’applicazione dei<br />
termini “fascista” o “neofascista” a movimenti, gruppi e organizzazioni attuali. Spesso con il termine “fascismo” o<br />
“neofascismo” (che etimologicamente si lega al primo) si è designata un’area che esplicitamente si richiama al fascismo<br />
storico. Altre volte questi stessi termini sono stati riferiti ad esperienze, aspetti, organizzazioni che non possono essere<br />
ricollegati automaticamente al fascismo storico, perché essi stessi non ne fanno richiami espliciti o addirittura ne<br />
dichiarano la distanza, oppure perché operano in Paesi che non hanno vissuto l’esperienza del fascismo come forza al<br />
potere, o ancora perché il gap generazionale rende difficile affermare una continuità diretta.<br />
Cosa si intende allora per “fascismo”? Che legame c’è tra “fascismo”, “neofascismo”, e “fascismo storico”? Al termine<br />
“fascismo” si collega il duplice significato che ha assunto nella nostra cultura. Da un lato, esso indica un periodo<br />
storicamente ben delineato nel tempo e nello spazio, una realtà con precise caratteristiche economiche, politiche e sociali.<br />
In questo senso, il termine “neofascismo” individua tutto ciò che cerca di riprodurre l’esperienza storica del fascismo.<br />
Dall’altro lato, lo stesso termine “fascismo”è entrato a far parte del nostro linguaggio e della nostra cultura come una<br />
categoria politica con cui si individuano certi valori e certe caratteristiche comportamentali che evocano una dimensione<br />
politica non concreta del fascismo. Con i termini “fascismo” o “neofascismo” ci si riferisce allora anche a movimenti,<br />
Luciano Buonocore – La Maggioranza Silenziosa e il Progetto Tecnocratico 33
gruppi o individui che, pur in assenza di espliciti richiami al fascismo storico o addirittura rinnegando ogni legame con<br />
esso, agiscono in base a principi e secondo modalità di comportamento che fanno capo a quel sistema di valori che è<br />
apparso in tutta la sua completezza appunto durante il periodo del fascismo storico. Definire il rapporto tra<br />
“neofascismo” e “fascismo storico” nelle varie congiunture diventa allora complesso. Non si tratta soltanto di cogliere<br />
l’eredità che il fascismo ha lasciato individuando una sorta di “genesi fisica”. Oltre che da un rapporto di “padre e figlio”,<br />
“fascismo storico” e “neofascismo” sono legati da nessi profondi e nascosti, che vanno al di là dell’esperienza storica. Per<br />
cogliere queste intime connessioni è necessario dilatare l’indagine a tutti i livelli e cercare il “fascismo” anche sotto<br />
etichette fuorvianti.<br />
Il problema del rapporto tra “neofascismo” e “fascismo storico” è stato affrontato dagli storici attraverso una griglia<br />
interpretativa piuttosto varia. I poli estremi che delimitano il campo di indagine sono quelle che potremmo denominare<br />
“tesi della continuità” e “tesi della discontinuità”. Secondo il primo modello interpretativo, tra “fascismo storico” e<br />
“neofascismo” esiste una specie di cordone ombelicale che si è mantenuto integro grazie alla continuità delle strutture<br />
economiche, politiche, amministrative, sia alla sopravvivenza fisica di persone. Uno dei sostenitori di questa tesi<br />
interpretativa è Guazza. Egli, mettendo in rilievo la continuità tra “fascismo storico” e “neofascismo”, ha scritto: “Solo<br />
l’occhio alla durata “oggettiva” permette di cogliere in tutta la sua decisiva portata la misura della continuità, della<br />
permanenza di molti, di troppi elementi sostanziali del processo storico italiano, dalle strutture di potere nell’economia ai<br />
componenti di gruppo nel sociale, dai metodi e dal personale nell’amministrativo all’apparato coercitivo e a parte del<br />
telaio istituzionale nel politico”. Sulla stessa linea, Ferretti spiega il “ritorno del fascismo” sottolineando la continuità,<br />
rispetto al passato, in cui è avvenuto. Si tratta della continuità di un sistema di grandi interessi economici consolidati che<br />
non si è sostanzialmente trasformato; della continuità giuridica e istituzionale, che ha contribuito a mantenere nella vita<br />
democratica italiana “un clima e una pratica che ogni giorno contraddice e suona secca smentita dei valori democratici<br />
ufficiali”; infine, della “continuità culturale” garantita da una intera generazione tuttora vivente di italiani, in cui per<br />
vent’anni i valori del fascismo sono stati inculcati e si sono radicati profondamente fino in fondo, spesso fino allo stato<br />
inconsapevole. Analogamente Foa mette in luce la continuità del “neofascista” con il passato storico del Paese. “La<br />
continuità – egli ha scritto – è stata verificata non tanto nel colore nero dei gagliardetti e nelle azioni squadristiche, cioè<br />
nel folklore dell’estremismo di destra, quanto nella continuità dell’apparato statale all’interno di quella democrazia che è<br />
stata costituita con la Resistenza, diciamo nonostante la Resistenza, nella continuità dei vecchi strumenti di mediazione,<br />
di controllo e di oppressione non solo della società fascista, ma anche di quella prefascista.”. A proposito, Rossella, nella<br />
sua introduzione alla ricerca sulla violenza fascista promossa dalla Regione Lombardia, ha affermato che tale indagine<br />
“intende testimoniare, giorno per giorno, le tappe della provocazione e della strategia della tensione, individuare i<br />
protagonisti, metterne a nudo quei temi propagandistici e i sottili mascheramenti teorici e ideologici di cui il nuovo<br />
fascismo si serve (. . .) Così l’indagine mira a dimostrare in maniera inequivocabile che non esiste differenza tra il<br />
fascismo del ventennio e quello in doppiopetto della <strong>Destra</strong> Nazionale”.<br />
L’altra direzione verso cui si sposta la storiografia è quella della tesi di una “rottura” , per cui fascismo e neofascismo<br />
appaiono come fenomeni qualitativamente diversi. Questa “soluzione di discontinuità” è stata indicata da più punti di<br />
vista. Molti storici vedono l’elemento della discontinuità tra “fascismo storico” e “neofascismo” all’esterno di questi<br />
fenomeni. Individuano cioè la frattura nel fondamentale mutamento delle condizioni storiche (sociali, politiche,<br />
economiche ed anche internazionali) in cui matura il neofascismo, rispetto a quelle in cui si è sviluppato il fascismo<br />
storico. Su questa linea interpretativa si pone Santarelli, secondo il quale tra “neofascismo” e “fascismo storico” c’è un<br />
profondo iato perché negli ultimi decenni, in tutta Europa il quadro complessivo è completamente mutato. Il neofascismo<br />
presenta così una ambivalenza di fondo, per cui “vecchio” e “nuovo” coesistono: la “sopravvivenza di idee e di uomini che<br />
nel ventennio fra le due guerre avevano rappresentato un elemento tanto attivo della controrivoluzione” si intreccia con il<br />
“momento della fondazione o rigenerazione dei programma e dei movimenti”. Pur affrontando solo marginalmente il<br />
problema, Farneti ha messo in luce la diversità tra la situazione che ha originato il “fascismo storico” e quella in cui nasce<br />
e cresce il “neofascismo”. Dopo la seconda guerra mondiale, infatti, sono intervenute modifiche tali da trasformare<br />
profondamente il sistema politico. Mentre il fascismo aveva potuto aggregare i ceti moderati, nel nuovo contesto creatosi<br />
questa operazione è assai più difficile per il neofascismo, perché il centrodestra, rafforzandosi, ha assunto il monopolio<br />
della rappresentanza politica dell’area moderata ed essa ha cessato così di considerare l’estremismo di destra come suo<br />
interlocutore. Questo ha determinato caratteristiche diverse tra fascismo vecchio e nuovo. Alcuni autori si muovono sulla<br />
linea interpretativa della discontinuità mettendo a fuoco soprattutto un aspetto dei diversi contesti del “fascismo storico”<br />
e del “neofascismo” : la mutata forza del fronte antifascista e delle forze democratiche: Tra gli altri, Secchia, dopo aver<br />
rilevato molteplici analogie tra “fascismo” e “neofascismo” (come la capacità comune a entrambi di muoversi sia sul<br />
piano democratico sia su quello antidemocratico della sovversione; l’appoggio del capitale della grande industria; il<br />
riparo di molte complicità interne e internazionali), sottolinea che “le differenze con la situazione di cinquant’anni fa<br />
sono ancora più grandi. Diversa è la forza, l’ampiezza, la coscienza del movimento operaio e delle forze democratiche. C’è<br />
maggior unità nella classe operaia, nei movimenti democratici e tra i giovani e gli anziani”.<br />
Altri storici, tra cui De Felice, trovano l’elemento di discontinuità tra “fascismo” e “neofascismo” all’interno dei<br />
fenomeni stessi, cioè nella diversità della loro natura. De Felice è uno degli autori che più si è soffermato sul rapporto tra<br />
“fascismo storico” e “neofascismo”. Secondo questo studioso la distinzione tra i due fenomeni, più che per il MSI-DN, è<br />
netta per i gruppi della destra extraparlamentare. Questi non si possono chiamare né fascisti né neofascisti, ma fanno<br />
parte del “radicalismo di destra” o “neonazismo”. Essi infatti non si rifanno a Mussolini o alla cultura del fascismo<br />
storico, ma a Evola, a Codreanu, ai nazisti veri e propri. Al radicalismo di destra mancano l’ottimismo vitalistico,<br />
l’esaltazione della giovinezza, l’idea di progresso e di rivoluzione, elementi tipici della cultura del fascismo-movimento. Il<br />
MSI-DN fa parte invece di quel “fascismo nostalgico”, che sta scomparendo con il ricambio generazionale e sopravvive<br />
solo in forme organizzate tipo “Maggioranza Silenziosa” o, appunto, MSI-DN. Ma neppure quest’ultimo può, secondo De<br />
Felice definirsi fascista vero e proprio, sia perché nella sua linea programmatica manca il nazionalismo, che è l’elemento<br />
essenziale per il fascismo storico, sia perché, mentre il fascismo classico “non era un movimento che combatteva i valori e<br />
le istituzioni borghesi”, il neofascismo cerca di sovvertirli.<br />
Luciano Buonocore – La Maggioranza Silenziosa e il Progetto Tecnocratico 34
Sempre all’interno della problematica del rapporto tra neofascismo e fascismo storico, si è sviluppato un nuovo filone di<br />
ricerca che studia un’altra relazione: quella tra “nuovo fascismo” e “neofascismo”. Lo storico che più approfonditamente<br />
si è soffermato su questa tematica è De Luna. Mentre con il termine “neofascismo” individua “l’insieme dei movimenti<br />
politici organizzati che esplicitamente si rifanno, nelle loro motivazioni programmatiche e nel loro retroterra ideologico,<br />
al fascismo storico”, De Luna utilizza le definizioni di “nuovo fascismo” o anche “radicalismo di destra” per alludere “ad<br />
una realtà più complessiva in cui coesistono, accanto alle forze neofasciste vere e proprie, altre organizzazioni, partiti,<br />
movimenti, settori istituzionali”. Al nuovo fascismo “manca ogni ipotesi su formule istituzionali che ricordino quel<br />
regime reazionario di massa, fondato sul binomio partito-Stato, che fu una caratteristica saliente del fascismo storico. La<br />
definizione ha però una sua indubbia validità politica sottolineando il loro comune obbiettivo strategico: la gestione<br />
politica e militare dell’offensiva controrivoluzionaria della borghesia in una fase in cui la crisi economica rende<br />
particolarmente pericolosa l’iniziativa rivoluzionaria ed alimenta un generale acutizzarsi delle tensioni sociali”. Come De<br />
Luna stesso ha notato, il “nuovo fascismo” in parte finisce per coincidere con il “radicalismo di destra” di Galli. Galli<br />
indica il “radicalismo di destra” come un filone che esiste da sempre nella cultura occidentale e che ciclicamente riaffiora<br />
come alternativa al filone dello “illuminismo riformista”. Fascismo e neofascismo non sono fenomeni qualitativamente<br />
diversi tra loro e neppure escrescenze anomale del “corpo” della cultura occidentale. Sia il fascismo che il neofascismo<br />
sono piuttosto manifestazioni legate a congiunture diverse, ma appartenenti al medesimo filone del “radicalismo di<br />
destra”. Questa valutazione articolata dei rapporti tra “neofascismo” e “fascismo storico” si sovrappone all’altro dibattito<br />
di cui abbiamo parlato precedentemente, circa la “visione riduttiva” o la “visione allarmante” secondo cui il neofascismo<br />
viene studiato. L’intreccio e soprattutto la combinazione di questi due tipi di giudizio creano le coordinate che<br />
individuano le possibilità di espansione e di sviluppo del neofascismo nella nostra società.<br />
A volte l’interpretazione della “continuità” tra “neofascismo” e “fascismo storico” è legata alla “visione riduttiva” del<br />
cosmo nero. In quest’ottica, il neofascismo viene presentato come una sorta di coda di una esperienza storica già<br />
conclusa, un fenomeno destinato a scomparire con il ricambio generazionale in un tempo relativamente breve, senza la<br />
possibilità di trovare un seguito di massa che gli consenta di espandersi. Altre volte, l’interpretazione della “continuità” si<br />
combina con la “visione allarmante” del neofascismo. Una parte della storiografia antifascista, sollevando il dito d’acqua<br />
contro il sistema sostiene che proprio la continuità delle strutture e delle istituzioni che sono nate nel ventennio fascista e<br />
che non sono state fondamentalmente rinnovate in senso democratico può consentire la sopravvivenza ed anche il<br />
crescere dell’estremismo di destra. A questo proposito, si leva la voce del filone più direttamente legato all’antifascismo<br />
militante per sottolineare come adesso, rispetto al periodo del fascismo storico, le forze democratiche e antifasciste del<br />
proletariato siano cresciute; sono queste forze profondamente antifasciste a costruire l’argine all’espansione della destra<br />
radicale. Pur muovendosi sostanzialmente nell’ambito di una “visione allarmante” , questa parte della storiografia<br />
individua nel contempo la soluzione per impedirne lo sviluppo. In tal modo l’”allarme” risulta smorzato: non c’è nulla di<br />
inevitabile, basta solo mobilitare queste forze democratiche e antifasciste, e il neofascismo italiano perde ogni prospettiva<br />
politica.<br />
a) Delimitazione e definizione della “destra radicale”<br />
Per indicare la vasta area culturale e politica che, grosso modo, collochiamo a destra e che si fonda sui valori<br />
dell’autoritarismo, della gerarchia, dell’antiegualitarismo e dell’anticomunismo, viene usata dalla storiografia una vasta<br />
gamma di definizioni terminologiche. Si oscilla da “neofascismo” a “radicalismo di destra”, a ”destra eversiva”, a<br />
“neonazismo”, a “nuovo fascismo”, a “parafascismo”, spesso senza riuscire a delineare con precisione l’area semantica del<br />
termine usato, i suoi specifici referenti, le sue denominazioni ideologiche e culturali. Tutte queste denominazioni, non<br />
esattamente equivalenti, fanno riferimento a tratti o dimensioni diversi, ma sempre appartenenti al medesimo “cosmo<br />
nero”. La stessa molteplicità e varietà dei termini sono indice dell’imbarazzo dello storico nel cercare un’unica definizione<br />
di fronte alle numerose e diverse realtà che compongono quel cosmo. Se alcune di esse sono facilmente identificabili per<br />
il fatto stesso di essere incompatibili con il sistema democratico e perciò da questo denunciate e bandite, altre convivono<br />
con la democrazia in un rapporto dialettico ambiguo e sotterraneo, costituendo un’area sfrangiata di cui è ben più<br />
complesso tracciare i contorni. In secondo luogo, proprio la consapevolezza della varietà del cosmo nero rende<br />
impossibile costringere realtà così diverse nella stessa categoria di “neofascismo” , che, a forza di dilatare i confini del suo<br />
spazio concettuale, rischia di perdere la sua pregnanza.<br />
Per una buona parte del mondo di estrema destra; insomma, il termine “neofascismo” è un abito troppo stretto. Esso<br />
sembra adeguatamente individuare e riferirsi come unico denominatore, senza perdere il suo significato e il suo spessore,<br />
a frazioni terroristiche, a gruppi dalla tendenza eversiva, persino all’MSI stesso. Ma appare inadatto a definire quelle<br />
espressioni politiche che si muovono in ambiti legali, che accettano talune regole del gioco democratico e, nel contempo,<br />
condividono con il neofascismo vero e proprio parte del suo terreno ideologico e delle sue scelte politiche. I problemi<br />
relativi all’applicazione del termine “neofascismo” per designare l’intero “cosmo nero” sono particolarmente evidenti<br />
nello studio storico della metà degli anni ’60 in poi. Infatti, a partire da questo periodo, tutto il mondo dell’estrema destra<br />
ha subito profonde trasformazioni, che hanno rigenerato la sua identità politica. In seguito a questo processo la destra<br />
radicale ha fornito di sé un quadro più complesso e più articolato. Mentre in un primo tempo questi mutamenti sono stati<br />
lenti e sotterranei, alla fine degli anni ’60, sotto la spinta di eccezionali processi catalizzatori – quali la crisi del centrosinistra,<br />
la contestazione del ’68 e il nuovo corso dell’MSI inaugurato con la segreteria di Almirante – si è arrivati non<br />
solo alla ridefinizione di nuove strategie politiche di radicalismo di destra, ma, soprattutto, ad un’eterogeneità di linee e<br />
di orientamenti, ad una molteplicità di livelli, di dimensioni, e di legami anche con ambienti e settori della società che<br />
preparavano progetti eversivi e, per attuarli, contattavano e convivevano con il neofascismo militante.<br />
All’inizio degli anni ’60 l’intera area della destra radicale è stata attraversata da una profonda crisi. “Il MSI è in declino<br />
– scrive Galli – sembra addirittura sul punto di scindersi, i gruppetti alla sua destra sono isolati. La protesta<br />
conservatrice si traduce nel nome e nel successo di Malagodi. Non c’è spazio per il radicalismo di destra”. Non soltanto il<br />
partito di Michelini appariva completamente paralizzato di fronte all’apertura a sinistra che si andava consolidando nel<br />
Luciano Buonocore – La Maggioranza Silenziosa e il Progetto Tecnocratico 35
Paese, ma tutto il radicalismo di destra stentava a trovare lo spazio d’azione. Accanto a questa impasse politica, nella<br />
prima metà degli anni ’60 era altrettanto evidente la crisi culturale della destra radicale. Fino ad allora, nella sua cultura<br />
politica era stato di estrema importanza il riferimento al “passato eroico” del fascismo storico. Adesso tale riferimento<br />
risultava sempre più un mito no pagante, ingombrante e inadatto a costituire le fondamenta di un sistema culturale. Di<br />
fronte all’affermarsi di una società “moderna” che necessitava di una cultura altrettanto “moderna” , capace di recepire<br />
problemi legati al suo sviluppo economico e sociale, lo “sguardo nostalgico” che la destra volgeva al passato non riusciva a<br />
mantenere in vita un sistema culturale in grado di polarizzare intorno a sé la parte moderata e conservatrice della società.<br />
L’indice più significativo di questa crisi culturale è stata la perdita dell’influenza dell’MSI nell’Università di Roma, da<br />
anni roccaforte del neofascismo. Ma dalla seconda metà degli anni ’60 nel mondo della destra estrema qualcosa cominciò<br />
a cambiare. Innanzi tutto si avviò uno sforzo di rinnovamento sul piano culturale. Secondo un processo di evoluzione che<br />
si esplicherà completamente quando nel ’69 Almirante diverrà segretario dell’MSI, gruppi e organizzazioni dell’estrema<br />
destra, consci della necessità di uscire dall’immobilismo a cui si sentivano incatenati, cominciarono ad elaborare un<br />
nuovo sistema di valori. Abbandonando i gesti, le ritualità, i simboli cari ai nostalgici del fascismo storico, si cominciò a<br />
delineare una cultura che, oltre all’antiegualitarismo e ai valori antidemocratici, assumesse come valori fondanti il rifiuto<br />
della civiltà moderna e del materialismo, proponendosi come sistema alternativo sia rispetto al modello americano, sia al<br />
modello sovietico. Inoltre, contemporaneamente il radicalismo di destra tentò di uscire dall’immobilismo cercando una<br />
nuova dimensione sul piano politico.<br />
A questo proposito, appare di rilevante interesse il convegno di Roma promosso dall’Istituto Pollio nel ’65. Dai dibattiti<br />
di questo convegno sono emerse le linee di quella strategia che si configurerà definitivamente alla fine del decennio. Al<br />
centro del dibattito venne analizzato il problema della “guerra rivoluzionaria” condotta dai comunisti per conquistare il<br />
mondo. Di fronte a questa minaccia veniva prospettata la necessità di rendere consapevole del pericolo l’opinione<br />
pubblica e di spingerla a reagire urgentemente contro il comunismo avanzante. Il nodo centrale, che permette di<br />
comprendere la portata di questo convegno, è costituito dal principio di legittimazione dell’uso di qualsiasi messo per<br />
debellare la minaccia comunista, avvertita con una ossessione quasi patologica. Il comunismo è respinto al di fuori della<br />
società umana, diviene una specie di “razza extraterrestre”, e per ciò va combattuto senza le remore etiche che<br />
normalmente limitano le modalità d’azione all’interno di una comunità umana. E’ importante sottolineare alcuni aspetti<br />
che emergono dal dibattito di questo convegno. Da un lato, il fatto di legittimare a priori la lotta contro l’imminente<br />
pericolo rosso, “sbarazzando il campo sia dal pregiudizio politico del rispetto della regola democratica sia da quello<br />
morale dell’illegittimità di una guerra preventiva”, pose le premesse di quelle “sollecitazioni eversive” che in seguito si<br />
esplicheranno nei fatti di Reggio Calabria e, soprattutto, in quel terrorismo di destra protagonista degli attentati, degli<br />
episodi di violenza e delle stragi di una intera stagione nella storia del nostro Paese. Dall’altro, nella nuova prospettiva<br />
delineata dal convegno romano, come ha opportunamente scritto Chiarini, che ha dato un notevole rilievo a questo<br />
appuntamento, “Viene mutando il rapporto tra neofascismo e Stato. Negli anni precedenti tale rapporto si era giocato su<br />
una pratica di latice connivenze e talora anche di esplicite aperture, favorito dalle ampie aree di consonanza culturale e<br />
politica e regolato per lo più da una logica di scambio (. . .). Ora emerge invece un dato insospettato. E’ dall’interno dello<br />
Stato che si coltivano spinte e progetti antidemocratici, e con una capacità di iniziativa autonoma, il che, per certi versi,<br />
riduce le forze neofasciste al ruolo di truppa di manovra, nel contempo offre loro la possibilità di un raccordo stretto con<br />
centri di potere e apparati statali dall’esplicita vocazione eversiva”.<br />
Dalla metà degli anni ’60 in poi, sulle linee già tracciate durante il convegno dell’Istituto Pollio, si vennero dunque<br />
ridefinendo vari rapporti di equilibrio e di scambio. Innanzi tutto, in un ambito più generale, si crearono nuove modalità<br />
di convivenza e di comunicazione tra settori dello Stato, destra radicale, neofascismo. Poi, nel più circoscritto ambito<br />
dell’estrema destra, si fece più complessa e delicata la dialettica tra una destra radicale intesa in una accezione allargata e<br />
quel neofascismo in senso stretto, che alla fine degli anni ’60, con la strategia della tensione, sfociava nel terrorismo.<br />
Inoltre, la “guerra totale” al comunismo, prospettata al convegno, configurò una strategia in cui, mentre il partito perdeva<br />
il suo ruolo centrale, si creava spazio per l’azione diretta di gruppi organizzati. Contemporaneamente si cercava<br />
l’appoggio determinante della parte della società rimasta indenne dalla contaminazione ateo-materialista del comunismo<br />
e di quelle istituzioni dello Stato garanti dell’ordine nazionale. Tutto questo emerse chiaramente dopo una “fase<br />
incubazione” di cinque anni, tanto da dare al neofascismo e alla destra radicale degli anni ’70 nuovi connotati. Per quanto<br />
riguarda il primo aspetto sul finire degli anni ’60 si fece più fitto l’intreccio tre il neofascismo e settori dello Stato, uomini<br />
del mondo economico finanziario, politico e culturale, che con il neofascismo condividevano la paura causata dalla<br />
contestazione del ’68, la preoccupazione che l’asse politico del paese scivolasse a sinistra, la necessità di rispondere con<br />
urgenza alla “grande minaccia”. Sulla base di questa comune percezione della realtà, si strinsero i legami tra il<br />
conservatorismo reazionario e il mondo della destra estrema, e le mire eversive di certi settori dello Stato. Mentre la<br />
contestazione dilagava nel Paese a macchia d’olio, scardinando i valori fondanti della società, settori dell’ambiente<br />
militare e dei servizi segreti cominciarono a prospettare interventi al fine di supplire alla debolezza e alla carenza della<br />
classe politica. La parola d’ordine divenne quella della salvaguardia dell’ordine e della legge minacciati: era il medesimo<br />
terreno su cui si muovevano le forze della destra radicale. Questi rapporti rendono assai difficile tracciare i contorni del<br />
cosmo nero. Appare quanto mai inadeguato indicare il quadro risultante semplicemente sotto l’etichetta del<br />
“neofascismo”.<br />
Nella seconda metà degli anni ’60, si verificò il rilancio e la formazione di gruppi di estrema destra, che vivevano<br />
nell’ombra prediligendo l’azione diretta e l’organizzazione clandestina paramilitare. Alla fine del decennio molte di queste<br />
organizzazioni eversive firmeranno gli attentati e le stragi sanguinose del terrorismo di destra. Indubbiamente c’è il filo<br />
che lega questi atti terroristici alla teorizzazione della “contromobilitazione” prospettata al convegno dell’Istituto Pollio<br />
del 1965. Sulla scia del dibattito che ne era sorto, infatti si era organizzata tutta un’area che rifiutava la linea politica di<br />
Michelini e che progettava cambiamenti radicale del sistema. Lo stesso richiamo all’azione diretta era stato lanciato<br />
proprio durante il convegno. Oltre al nuovo rapporto tra destra radicale e settori dello Stato ed alle forti sollecitazioni<br />
eversive che approderanno ad un terrorismo vero e proprio sul finire degli anni ’60 si assisté allo sviluppo di un’altra<br />
tessera del cosmo nero. Il mutamento di rotta dell’MSI sotto la nuova segreteria di Almirante segnò una tappa importante<br />
Luciano Buonocore – La Maggioranza Silenziosa e il Progetto Tecnocratico 36
nella storia di tutta la destra estrema. Con la “strategia della tensione” l’MSI non si configurò più come satellite ruotante<br />
interno alla DC; presentandosi come partito dell’ordine, estese la sua influenza sulle forze moderate e benpensanti e su<br />
uomini chiave del mondo politico, economico, culturale e militare. In definitiva, oltre ad un’area che si stava formando<br />
sulla base dei legami con settori dello Stato e del governo, oltre ad una realtà che assumeva connotati eversivi,<br />
antidemocratici, terroristici, c’era anche un altro tratto che andava a comporre il puzzle della destra estrema. Prendeva<br />
forza e entrava nel mondo della destra radicale tutto quel fronte di forze borghesi che, indignato e allarmato, richiedeva la<br />
restaurazione dell’ordine scosso. Nonostante l’MSI non proponesse di ergersi esplicitamente come portavoce di tale<br />
corrente d’opinione politica, fu sull’onda della sua propaganda e delle sue sollecitazioni che parte della borghesia<br />
moderata e conservatrice assunse posizioni politiche sempre più radicali.<br />
E’ in questa dimensione della destra radicale che dobbiamo collocare il fenomeno della “Maggioranza Silenziosa”, che<br />
appunto nasceva e si muoveva sulla base della richiesta di ordine e di pace. Da un lato, tutto un comune retroterra<br />
culturale legava questo movimento all’MSI e al neofascismo: le parole d’ordine dell’anticomunismo e della restaurazione<br />
dell’ordine minacciato, la difesa della “civiltà Europea” come modello alternativo sia alla civiltà consumistica american,<br />
sia alla società materialistica sovietica, infine la fiducia e l’appello alle forze dell’ordine. Oltre a questi comuni riferimenti<br />
culturali, è significativo il fatto che molti degli organizzatori della ”Maggioranza Silenziosa” pervenissero dall’MSI e da<br />
altre organizzazioni legate al partito, di inequivocabile stampo neofascista. Ma per altri aspetti, dire che la “ Maggioranza<br />
Silenziosa”è neofascismo, è alquanto riduttivo, se non erroneo. Innanzitutto, sia per le modalità di azione della<br />
“Maggioranza Silenziosa”, che sostanzialmente sono pacifiche (il fatto stesso di dichiararsi “silenziosa” è emblematico),<br />
sia per il suo programma ideologico, essa prendeva le distanze dalle tendenze eversivo-terroristiche di una certa parte del<br />
neofascismo. Inoltre, se è vero che l’MSI ha cercato di monopolizzare questo gruppo e di fare una propria pedina, e se è<br />
vero che indubbiamente la “Maggioranza Silenziosa” ha subito l’influenza di questa manovra, è altrettanto vero che uno<br />
studio approfondito rivela tra la “Maggioranza Silenziosa”e il neofascismo un rapporto tutt’altro che chiaro ed univoco.<br />
Sia i legami che la “Maggioranza Silenziosa” ha intessuto con l’area democratica, coagulando intorno a sé ampi settori del<br />
PLI e della DC milanesi, sia l’esplicita vocazione di muoversi con indipendenza dai partiti, per dilatare a piacimento i<br />
propri confini, rendendo complessa la collocazione stessa della “Maggioranza Silenziosa” nel panorama culturale e<br />
politico dei primi anni ’70. Collegandosi essa per certi aspetti al filone apartitico-qualunquista presente nella cultura<br />
politica italiana, è forse più corretto e soddisfacente definire la “Maggioranza Silenziosa” non tanto come “neofascismo” ,<br />
quanto come una tessera del puzzle della composita ed eterogenea destra radicale italiana.<br />
Lo studio della “Maggioranza Silenziosa” necessita poi di coordinate per così dire sociali, con cui individuare i contorni<br />
di questo movimento. La sua nascita e il suo sviluppo hanno ricevuto infatti suggestioni, riflessi, condizionamenti dal<br />
clima di incertezze e di sfiducia che dalla fine degli anni ’60 investì il ceto medio e lo spinse a cercare un paradigma<br />
culturale alternativo cui fare riferimento, nel momento in cui i valori tradizionali apparivano coinvolti da una crisi<br />
generale e profonda. Quest’ultimo aspetto è particolarmente evidente nella seconda fase della vita della “Maggioranza<br />
Silenziosa” , quando nasce “Lotta Europea”. Su questa rivista, trovano posto analisi politiche e sociali legate agli<br />
avvenimenti e ai problemi contingenti, ma anche a riflessioni generali di tipo morale, spirituale, artistico, scientifico.<br />
b) I nuovi destinatari<br />
L’aspetto più interessante del Comitato Cittadino Anticomunista della “Maggioranza Silenziosa” dopo una prima fase<br />
iniziale, è lo sforzo che viene concentrato sugli spazi culturali. Tali sforzi rivelano l’intima esigenza della “Maggioranza<br />
Silenziosa” di trovare connotazioni ideologiche che le fornissero un’identità più precisa. Attraverso nuovi strumenti,<br />
come i centri studio e la rivista “Lotta Europea”, il C.C.A. cercò inoltre di dilatare il più possibile l’area sociale dove<br />
attingere consensi. Rivolgendosi alle scuole e agli ambienti culturali, il C.C.A. non mirava soltanto ad ottenere le adesioni<br />
dei singoli cittadini, ma ad entrare in istituzioni vere e proprie per ottenere, almeno in arte il controllo. Accanto alla<br />
rivista, che è la massima espressione della dimensione culturale della “Maggioranza Silenziosa” nel ’72 nascono i centri<br />
studi “Lotta Europea”, cui sopra abbiamo accennato.<br />
Il termine “Lotta Europea” quindi, con cui spesso vengono firmati volantini e ciclostilati insieme alla sigla C.C.A., non<br />
indica soltanto la rivista ma un più generico ambito di riflessione di attività politica. In una dispensa culturale ciclostilata<br />
dal titolo “Cos’è Lotta Europea-settore propaganda” dall’ottobre del ’72, si affermava che Lotta Europea era una<br />
organizzazione politica vera e propria, che aveva funzione critica nei confronti del sistema e che mirava “a costruire una<br />
valida e concreta alternativa politica, culturale e sociale”. Lotta Europea era intesa come qualcosa di essenzialmente<br />
diverso dalle forze politiche esistenti: era addirittura sentita come “un modo di concepire la vita”, al di sopra dei “giochi<br />
meschini” dei partiti. Il terreno prediletto di Lotta Europea fu la scuola, in particolare l’Università. I motivi di questa<br />
scelta sono ovvi. Innanzi tutto, l’Università è uno dei luoghi culturalmente più vivi di una città e perciò più aperto a<br />
ricevere stimoli ed idee sempre nuove. Ma soprattutto, l’Università di quegli anni rappresentava il nodo centrale della<br />
contestazione studentesca. Per Lotta Europea era particolarmente importante colpire il Movimento Studentesco<br />
dall’interno dell’istituzione in cui esso operava e trovarvi consensi a svantaggio della contestazione stessa. Lo scopo che si<br />
proponeva Lotta Europea era quello di riprodurre un sistema culturale di valori cui gli studenti, stanchi e nauseati dalla<br />
cultura del marxismo, potessero rivolgersi. Per incidere e per inserirsi nel tessuto scolastico, Lotta Europea propose<br />
soluzioni a problemi pratici immediati. Tra i principali problemi universitari, essa individuò il mancato controllo sulla<br />
quantità e qualità dei cibi della mensa e l’insufficienza dei locali di quest’ultima; la carenza dei posti letto per gli studenti<br />
che venivano da fuori; il clientelismo e gli interessi mafiosi e personali nell’assegnazione dei sussidi; le tasse, le more, i<br />
diritti d’urgenza da pagare per qualunque cosa. Per questi problemi, Lotta Europea indicò alcune soluzioni, come la<br />
gestione diretta delle mense per garantire il controllo sui cibi, la stipulazione di convenzioni per assicurare alloggi decenti<br />
al maggior numero di studenti possibile, il controllo sui prezzi dei libri di testo, etc.. Sia i problemi considerati, sia le<br />
soluzioni proposte si muovono sul piano, per così dire, delle strutture “esterne” dell’Università stessa. Mentre il<br />
Movimento Studentesco metteva in discussione il rapporto professori-allievi, l’autoritarismo, la validità del voto il<br />
nozionismo attaccando frontalmente il tipo di cultura universitaria esistente e proponendo modelli sostitutivi, Lotta<br />
Luciano Buonocore – La Maggioranza Silenziosa e il Progetto Tecnocratico 37
Europea puntava al ritorno di un insegnamento tradizionale, basato proprio su quell’ordine meritocratico e quella<br />
disciplina scolastica che il Movimento Studentesco aveva contestato e scosso dalle fondamenta.<br />
In un volantino distribuito nel novembre del ’72 Lotta Europea invitava gli studenti a manifestare contro il Movimento<br />
Studentesco (un “nucleo di picchiatori stipendiati che presidiano l’Università Statale”, fagocitato e strumentalizzato dal<br />
PCI): ”STUDENTI, respingiamo gli ulteriori tentativi di cinica strumentalizzazione politica e partitica.<br />
RISTAB<strong>IL</strong>IAMO l’ordine e i valori finora compromessi rifiutando la sovversione e la violenza nella e al<br />
di fuori della scuola”. In una dispensa ciclostilata nell’ottobre del ’72 Lotta Europea parlava dell’organizzazione dei<br />
gruppi politici nelle scuole e precisava le disposizioni alle quali ogni aderente doveva attenersi scrupolosamente. Stabilito<br />
che “scopo immediato di “Lotta Europea” è costituir in ogni scuola della città un’organizzazione capillare”, tale<br />
organizzazione doveva fare capo ad un “coordinatore di istituto” con l’incarico di formare all’interno della scuola stessa<br />
nuclei di corso e di classe, affinché “Lotta Europea” fosse presente ovunque in misura massiccia. Per ottenere questo,<br />
“Lotta Europea” riteneva opportuno almeno in una prima fase, che coordinatori e aderenti non fossero politicamente<br />
individuabili. Operando nell’ombra, essi dovevano iniziare un’opera di “agganciamento individuale” e di “catalogazione”,<br />
identificando nel proprio ambito avversari politici, studenti politicamente impegnati e chi fosse in teoria disponibile.<br />
Oltre all’anonimato cui erano invitati gli aderenti, è particolarmente significativo l’invito a “cogliere l’avversario di<br />
sorpresa nel momento in cui dalla fase organizzativa si fosse passati a quella operativa”.<br />
Il punto risulta non del tutto chiaro, perché nel documento non veniva spiegato in che cosa consistesse esattamente il<br />
“salto” tra le due fasi. Il linguaggio suggerisce comunque una immagine quasi militare, una sotterranea volontà di scontro<br />
“operativo”, che pare andare ben oltre uno scontro verbale o di modelli culturali proposti. Del resto, nel maggio ’72<br />
Buonocore e Degli Occhi mandarono una lettera al Questore di Milano, Allito Bonanno, per chiedergli se volesse<br />
“finalmente liberare l’Università Statale dalle bande armate comuniste che ne hanno fatto una specie di caserma”. “Se<br />
non ci penserà entro breve tempo- aveva detto allora Buonocore - ci penseremo noi!”. Tutto questo contrasta, o meglio<br />
convive, con una sorta di doppia personalità, con l’atteggiamento più civile e più cauto tenuto in altre occasioni da Lotta<br />
Europea nei confronti della contestazione universitaria. Un esempio di questa “saggia prudenza” è il comunicato<br />
rilasciato dal C.C.A. in occasione di una manifestazione tenutasi il 23 giugno 1972 in piazza Castello, in segno di protesta<br />
per una precedente irruzione della Polizia nell’Università Statale. Affermava il comunicato del C.C.A. che “non i<br />
comunisti del Movimento Studentesco devono essere cacciati dall’Università bensì è la manifestazione di tutte le<br />
componenti politiche che deve maggiormente responsabilizzarsi e fare politica nell’Università. I problemi universitari<br />
proseguiva il comunicato- non si possono certamente risolvere con l’intervento della polizia, sempre che non vi sia reato”.<br />
Quest’ultimo messaggio sembrava però contraddirsi con un manifesto uscito solo pochi giorni prima (il 18 giugno), che<br />
costituisce una specie di “inno alla vittoria” per i fatti successi il 16 giugno alla Statale. “Le forze dell’ordine –vi si afferma<br />
– come era nei voti di questo Comitato Cittadino Anticomunista, sono fermamente intervenute a liberare l’università<br />
Statale. Un fatto nuovo si è verificato: la volontà disciplinata ed espressa con fredda determinazione con la voce più<br />
autorevole dei cittadini, quelli del C.C.A. della “Maggioranza Silenziosa” ha determinato civilmente le autorità, a riprova<br />
che, se si ha voglia, la giustizia e la legalità trionfano in giusta prospettiva politica e in nobile lealtà d’intenti. VIVA<br />
MI<strong>LA</strong>NO ANTICOMUNISTA!!! VIVA LE FORZE DELL’ORDINE!!”.<br />
In realtà Lotta Europea assunse questo ambiguo atteggiamento perché da un lato il comportamento cauto e tollerante<br />
nei confronti del Movimento Studentesco dava all’opinione pubblica l’immagine di un gruppo pacifista, pronto al dialogo<br />
più che allo scontro, garante di soluzioni “civili” ai problemi che la contestazione aveva posto. Dall’altro, Lotta Europea<br />
vedeva nell’intervento della polizia nelle scuole e nello scontro tra le forze dell’ordine e studenti la possibilità che il<br />
malcontento e la paura crescessero tra i docenti, parte degli studenti e i genitori. Questo gli avrebbe creato un ampio<br />
spazio di manovra e un grande serbatoio di consensi. Una politica simile pareva in qualche modo ricalcare la linea del<br />
“doppio binario” attuata nello stesso periodo su scala nazionale da Almirante.<br />
Per un intervento attivo<br />
a) Il programma di rinnovamento<br />
Nel corso del ’73, il C.C.A. e i Centri Studio “Lotta Europea” si sforzarono di comporre un programma organico di<br />
rinnovamento, che fornisse la soluzione ai problemi più scottanti della società. In primo luogo, Lotta Europea analizzò la<br />
situazione economica, dove il problema maggiore era visto nell’inflazione, “marea” inesorabile, accompagnata dallo<br />
spettro della conseguente inevitabile crisi. Di fronte al dilagante fenomeno dell’inflazione, secondo i Centri Studio “Lotta<br />
Europea”, il potere politico si era dimostrato incapace di attuare misure correttive opportune, essendo ormai un corpo<br />
corrotto, malato, senza più vita. Tra le cause che determinarono l’inflazione, l’analisi di “Lotta Europea” individuava in<br />
primo piano le ragioni psicologiche che “sono fondamentalmente le più importanti, anche se quelle economico-politiche<br />
internazionali e quelle social-politiche internazionali sono le sole generalmente prese in seria considerazione dai<br />
commentatori”. Prima ancora che un fenomeno di tipo economico, l’inflazione è un sorta di malattia mentale dell’uomo,<br />
tipica della società occidentale capitalistica: “questa malattia consiste essenzialmente nella convinzione oramai radicata<br />
che l’umanità intera deve assolutamente mutare senza sosta il suo modo di vita, che deve esserci senza requie uno<br />
sviluppo, che deve eternamente essere adorato il cosiddetto progresso(. . .). La gente è semplicemente insoddisfatta<br />
perché ad essa vengono continuamente offerte cose nuove, mentre l’umanità starebbe meglio se non fosse perennemente<br />
assillata dall’offerta di cose nuove; e se il mondo potesse procedere con quello che ha oggi a disposizione, si<br />
eliminerebbero gli squilibri economici e sociali”. Il rimedio proposto, una volta individuate le cause dell’inflazione, era<br />
quello di opporsi al processo di industrializzazione della nostra società. Si trattava cioè di “rallentare lo sviluppo<br />
industriale, far della vera ecologia spirituale, contrastare l’urbanizzazione, indirizzare la ricerca scientifica verso il<br />
mantenimento della vita animale e vegetale, rallentare lo spreco delle risorse naturali, incoraggiare con ogni mezzo<br />
possibile il ritorno alla terra. Il sogno sano per l’umanità dovrebbe essere quello di piccoli nuclei, il più possibile<br />
Luciano Buonocore – La Maggioranza Silenziosa e il Progetto Tecnocratico 38
autosufficienti, non quello di megalopoli abitate da trogloditi meccanizzati”.<br />
Il rifiuto del processo accelerato di industrializzazione, nell’interpretazione del C.C.A., è un punto al tema del rifiuto<br />
della grande metropoli in cui l’uomo vive sradicato dalle tradizioni, sempre più sofisticato dal progresso. Balza in primo<br />
piano, dunque, il problema dell’agricoltura. Per uno sviluppo economico equilibrato, agricoltura e industria devono<br />
svilupparsi, secondo l’ottica dei gruppi studio “Lotta Europea”, adeguandosi alle caratteristiche del territorio e alla<br />
tradizione. E’ chiaro che l’economia del nostro Paese debba basarsi soprattutto sulla agricoltura. “E’ assurdo – afferma<br />
Adamo Degli Occhi – industrializzare un Sud che è refrattario per natura e mentalità alla società industriale, come è stata<br />
assurda questa superindustrializzazione del Nord. Noi siamo per l’abolizione di tutte quelle industrie che ci costringono a<br />
dipendere dai Paesi stranieri”. Invece di rivalutare e migliorare l’economia agricola, questo settore della vita economica è<br />
stato assolutamente trascurato dal governo. Si è assistito giorno per giorno allo spopolamento delle campagne e al<br />
continuo chiudersi degli allevatori zootecnici, con la triste prospettiva di rimanere senza carne e senza latte.<br />
“CITTADINI – invita la “Maggioranza Silenziosa” – esprimiamo la nostra solidarietà con tutto il nostro<br />
appoggio ai coltivatori diretti in lotta (. . . ). BASTA CON <strong>LA</strong> DEMAGOGIA DEL CENTRO-SINISTRA! NO<br />
AL<strong>LA</strong> COLLETTIVIZZAZIONE DELLE TERRE! LOTTIAMO UNITI E SALVIAMO <strong>IL</strong> PAESE DAL<br />
DISASTRO ECONOMICO! W LE LEGITTIME RIVENDICAZIONI DEGLI AGRICOLTORI IN LOTTA!” Il<br />
problema dell’agricoltura è avvertito sensibilmente da tutta la cultura di destra, che vede nella campagna la sede naturale<br />
dell’uomo, l’impero della tradizione e della gerarchia, il luogo dove più difficilmente che nel tessuto urbano vi sono<br />
mutamenti improvvisi capaci di sovvertire ordini precostituiti. La rivalutazione delle campagne e dell’agricoltura si pone<br />
all’interno di un generale rifiuto del progresso e, in particolare, della città moderna, che ne è simbolo.<br />
Ma è soprattutto in campo politico che il C.C.A. si sforzò di elaborare un programma di rinnovamento, reso necessario<br />
dalla crisi che investiva la democrazia, dall’impotenza dello Stato di fronte ai “partiti social-comunisti”, dall’immoralità<br />
della partitocrazia, dai gravi problemi economici che colpivano le strutture del nostro Paese. Lo scopo della nuova<br />
riforma era quello di “dare forte autorità all’esecutivo (. . .) Il sistema partitico parlamentare comporta infatti governi di<br />
coalizione, cioè composti da forze con idee diverse, quindi condannate all’immobilismo”. Per porre rimedio a questi mali,<br />
il C.C.A. proponeva un esecutivo formato da dieci ministri al massimo e un parlamentare rappresentativo delle varie forze<br />
produttive con funzioni di consiglio d’amministrazione.<br />
Nel progetto del C.C.A., si prevedeva che il Parlamento, per salvaguardare i principi fondamentali di politica economica<br />
e di giustizia sociale, emanasse leggi per la tutela dei lavoratori. Le stesse leggi avrebbero anche sancito “il principio che<br />
l’assunzione e il licenziamento dei dipendenti sono un diritto inalienabile della direzione aziendale”. Inoltre il Parlamento<br />
avrebbe stabilito una tabella perequativa per le retribuzioni dei lavoratori dipendenti: determinando il livello delle<br />
retribuzioni, il Parlamento si sostituiva responsabilmente alle dannose lotte sociali. E’ chiaro che, in questa ottica, non<br />
c’era posto per il diritto allo sciopero: esso infatti sarebbe stato proclamato “crimine contro lo Stato”. La nuova<br />
Costituzione avrebbe affermato inoltre il principio che l’uguaglianza non esiste in natura che essa”costituirebbe quindi<br />
nei rapporti sociali la più grande delle ingiustizie, atta ad essere dannosa perché deprime l’iniziativa individuale”.<br />
In questa Costituzione sarebbe stato istituito poi un apposito organo dello Stato alla tutela delle moralità delle<br />
istituzioni e dei diritti civili dei cittadini; l’immunità parlamentare sarebbe stata abolita. Infine, dalla nuova Costituzione<br />
sarebbe nata una repubblica presidenziale, per assicurare governi stabili e democraticamente efficienti. Accanto a questa<br />
riforma istituzionale, i gruppi di studio di “Lotta Europea” e il C.C.A. prevedevano anche una riforma burocratica,<br />
accompagnata dalla liquidazione di tutti quegli enti parastatali “inutili”; una riforma della scuola “dove si dovrà studiare<br />
e non fare riunioni ed elucubrazioni politiche”; una riorganizzazione completa del servizio ospedaliero, sanitario e delle<br />
assicurazioni sociali. Si prevedeva inoltre una giurisdizione rapida, ma “severa e inflessibile” per criminali; infine, una<br />
“razionalizzazione delle festività e delle ferie che ci fanno attualmente apparire un popolo incosciente sempre in allegria,<br />
e che vive al di sopra dei mezzi di cui dispone”.<br />
Si profila dunque l’immagine di uno Stato autoritario, fortemente attaccato alle tradizioni, con struttura accentrata del<br />
potere; attraverso il presidenzialismo, si sarebbe rafforzato l’esecutivo e si sarebbe superato il sistema partitico. Infine,<br />
nell’ambito di una generale prospettiva di rinnovamento il C.C.A. proponeva il rafforzamento dell’esercito. “E’ una<br />
vergogna – afferma Adamo Degli Occhi – che una nazione come l’Italia in posizione delicatissima da un punto di vista<br />
strategico e in grave pericolo per la presenza sovietica nel Mediterraneo, abbia un esercito abbandonato, svirilizzato e<br />
reso ogni giorno di più, con colpevole premeditazione, inetto alle funzioni eminenti che gli competono. Anche questo è<br />
uno dei frutti marci della proletarizzazione delle strutture (. . .). Ormai difficilmente (entrano) nelle accademie militari<br />
quei giovani che per nascita, benemerenze patriottiche delle famiglie ed educazione sono i soli che potrebbero alimentare<br />
il culto di quelle tradizioni che sono il vero nerbo di una forza armata. E si capisce, se si pensa che ormai, in nome di un<br />
pazzesco democraticismo, si vedono nominati ufficiali figli di portinai di condomini o il figlio di un bombolaio che sposa<br />
poi la figlia di un macellaio”. Secondo Adamo Degli Occhi, occorreva invece puntare su un esercito professionale,<br />
agguerritissimo, guardandolo all’esempio israeliano. E questo valeva anche per le forze di polizia, “che devono<br />
raggiungere un altissimo grado di efficienza per ristabilire l’ordine inesistente e salvaguardare i diritti dei cittadini”.<br />
E’ interessante vedere i mezzi con cui i leaders della “Maggioranza Silenziosa” ritenevano di poter attuare questo loro<br />
programma di trasformazione delle istituzioni, programma che tra l’altro ricalca quasi totalmente le impostazioni del<br />
MSI e dell’estrema destra del nostra Paese. Sempre secondo Adamo Degli Occhi, non si sarebbe arrivati ad attuare il<br />
programma di rinnovamento attraverso un colpo di stato militare, anche se riconosceva all’esercito “il diritto di<br />
intervenire nel momento in cui la nazione si trova nel pericolo di soccombere ad una dittatura comunista”. Piuttosto,<br />
l’elemento risolutore sarebbe stato una sorta di “uomo della provvidenza”. “Sempre la storia, nei momenti più<br />
drammatici ne ha materializzato uno. E noi stiamo vivendo uno dei quei momenti drammatici”. Ed ancora: “Noi della<br />
“Maggioranza Silenziosa” siamo qui, (. . .) siamo una massa di manovra a disposizione di un uomo che voglia opporsi a<br />
tutta questa situazione frontalmente, con una reazione colossale (. . .). Ciò capisca chi deve capire e si serva di noi come di<br />
Luciano Buonocore – La Maggioranza Silenziosa e il Progetto Tecnocratico 39
un rullo vendicatore, Perché noi siamo la maggioranza, noi il vero popolo e insieme l’elite di domani”. Queste ultime frasi<br />
sono a nostro avviso particolarmente significative. Pur tenendo conto di certe caratteristiche tipiche del linguaggio di<br />
Adamo Degli Occhi, che costituiscono un tratto specifico della sua bizzarra ed eccentrica personalità, tuttavia non si può<br />
sottovalutare il significato di tali affermazioni. Da un lato, la prospettiva di un esercito agguerrito e professionale, unita al<br />
diritto di intervento che gli viene riconosciuto in caso di “pericolo”, suggerisce velatamente l’ipotesi del colpo di Stato<br />
come estremo ma legittimo “mezzo risolutore”. Bisogna notare infatti che nelle affermazioni di Adamo Degli Occhi non<br />
veniva chiarita la soglia oltre quale l’esercito avrebbe potuto legittimamente assumere il diritto d’intervento. Dall’altro<br />
lato, altrettanto oscura ed ambigua appare l’attesa dell’”uomo della provvidenza”, alla cui completa disposizione si<br />
sarebbe subito messo quel grandissimo numero di cittadini che rappresentava la “Maggioranza Silenziosa”. L’”uomo<br />
provvidenziale”, in grado di guidare un’”ondata travolgente” per abbattere il “teatro dei burattini”, sembra avere le carte<br />
in regola, a nostro parere, non tanto per dar vita ad una repubblica presidenziale, quanto ad una vera e propria dittatura.<br />
Rimane comunque significativo il fatto che nessun altro fra i leaders della “Maggioranza Silenziosa” abbia mai rilasciato o<br />
scritto informazioni simili a quelle di Adamo Degli Occhi. E’ allora difficile stabilire fino a che punto e in quali termini le<br />
idee stravaganti di quest’ultimo fossero condivise dagli altri componenti del C.C.A. Può darsi che, per il semplice motivo<br />
di non smentirle, anche gli altri approvassero ciò che diceva Adamo Degli Occhi. In tal caso è arduo concepire come<br />
esponenti e militanti del partito liberale, così come uomini iscritti alla DC e al PSDI potessero convivere con le idee di<br />
Adamo Degli Occhi, tanto più che egli non era un personaggio in secondo piano, ma una delle voci principali del<br />
movimento della “Maggioranza Silenziosa”. Nell’ipotesi contraria, ammettendo cioè che all’interno del gruppo<br />
organizzatore e fra gli aderenti molti non condividessero le estremistiche posizioni di Adamo Degli Occhi, rimane allora<br />
da chiarire perché mai personaggi rilevanti come Massimo De Carolis abbiano aspettato fino alla metà del ’73 per<br />
prendere le distanze dalla “Maggioranza Silenziosa”.<br />
Una risposta a questi interrogativi ci viene dalla voce stessa di alcuni degli organizzatori del C.C.A., In una intervista<br />
rilasciata il 22 Maggio 1985, Luciano Buonocore spiega come Adamo Degli Occhi entrò a far parte della “Maggioranza<br />
Silenziosa”. “Nel settembre del 1971, finito il ciclo delle manifestazioni, ci siamo trovati a doverci organizzare<br />
politicamente. Eravamo tutti giovani, perciò avevamo bisogno per il Comitato Cittadino Anticomunista di un presidente<br />
con un certo nome e con un certo prestigio. Fra le persone disponibili, la scelta cadde su Adamo Degli Occhi. Egli<br />
proveniva da famiglia antifascista ed era un ex partigiano decorato, però nello stesso tempo già nel ’47 era stato avvocato<br />
difensore dei fascisti. Perciò Adamo Degli Occhi rappresentava il tentativo di “conciliazione” tra le forze democratiche e la<br />
destra del Paese. Era questo l’aspetto più significativo di Adamo Degli Occhi. Il fatto che fosse scelto come presidente<br />
onorario del nostro Comitato non significa che noi ci identificassimo con tutte le sue posizioni”. Gabriele Pagliuzzi<br />
aggiunge: “Adamo Degli Occhi non ha mai avuto né un ruolo di direzione politica né di direzione ideologica all’interno del<br />
C.C.A. Durante la prima fase della “Maggioranza Silenziosa”, cioè nella primavera del 1971, la stampa parlò molto di<br />
Adamo Degli Occhi utilizzando la sua immagine “folkloristica” e la sua notorietà nella città. In realtà, in questo periodo,<br />
in cui si andavano chiarendo le posizioni politiche della “Maggioranza Silenziosa”, la personalità di Adamo Degli Occhi<br />
non è assolutamente influente. Diventa semmai più significativa nel periodo successivo, quando già il C.C.A. aveva perso<br />
alcune delle sue componenti, come quella dei liberali. Adamo Degli Occhi rappresentava il velleitarismo di una certa<br />
generazione anticomunista, ma ideologicamente molto confusa, di cui facevano parte anche personaggi come Edgardo<br />
Sogno (21). Il dar spazio anche ad espressioni (come quelle di Adamo Degli Occhi), pur non condividendole, rispecchiava<br />
la volontà del C.C.A. di rappresentare posizioni diverse, ma comunque appartenenti al mondo della destra. Ritenevamo<br />
importante aggregare e coagulare tutte queste forze. Non potevamo dividerci, anche perché la strada della divisione è<br />
sempre stata estremamente perniciosa per la destra”. Per quanto riguarda i rapporti tra Adamo Degli Occhi e uomini<br />
come Massimo De Carolis e Vittorio D’Ajello, Pagliuzzi afferma che in pratica non vi furono problemi di “convivenza”,<br />
perché si tratta di tempi diversi: “le adesioni di De Carolis e D’Ajello infatti appartengono alla prima fase, quando ancora<br />
Adamo Degli Occhi non era ancora presidente del C.C.A. e la sua personalità non aveva peso determinante”.<br />
b) L’attacco al “Corriere della Sera”<br />
I vistosi manifesti del C.C.A. comparsi il 12 febbraio 1973 sui muri di Milano segnarono l’inizio di una lunga polemica<br />
contro il “Corriere della Sera”, che la “Maggioranza Silenziosa” portò avanti fino alla fine dell’anno. Fu una delle<br />
campagne del C.C.A. – “Maggioranza Silenziosa” – che ebbe più risonanza nell’opinione pubblica e negli organi di<br />
stampa. I manifesti del 12 febbraio invitavano la popolazione milanese a non comperare per due giorni (cioè il 15 e il 16<br />
febbraio) il “Corriere della Sera”. Il giornale, definito “il quotidiano indipendente della sovversione nazionale”, che con le<br />
sue 650 mila copie di tiratura al giorno era allora il più diffuso giornale italiano e che era stato finora il rappresentante<br />
per eccellenza della borghesia milanese, veniva accusato di essere divenuto il “portavoce compiacente della sovversione<br />
nazionale”. In particolare, si accusava il “Corriere” di manipolare, a favore dell’estrema sinistra, le notizie sugli episodi di<br />
violenza politica e sugli scontri civili che ormai da anni turbavano la città. Si esortavano i cittadini ad una campagna<br />
antiacquisto come quella che era stata fatta contro i tabacchi venduti dall’oppressore austriaco, il feldmaresciallo<br />
Radetzsky: come i nostri predecessori avevano sabotato la regia dei tabacchi, “sapremo noi sabotare il “Corriere della<br />
Sera”?. Il 12 febbraio, giorno in cui furono affissi i primi manifesti, non fu che l’inizio. Da allora, la campagna di<br />
intimidazione contro il “Corriere” divenne sempre più aggressiva. Milano fu inondata da manifesti murali e volantini,<br />
non solo firmati dal C.C.A. – “Maggioranza Silenziosa”-Ma anche dal FdG e dal FUAN.<br />
A provocare l’ira e lo sdegno della borghesia milanese più retriva, di cui il C.C.A. e i gruppi della destra si erano fatti<br />
interpreti, avevano contribuito due fatti. In primo luogo, nel marzo del ’72 Giulia Maria Mozzoni Crespi, comproprietaria<br />
del “Corriere della Sera” (chiamata la “contessina rossa” negli ambienti della “Milano bene”, a causa di un certo suo<br />
anticonformismo), aveva affidato la direzione del giornale a Piero Ottone. Sotto la direzione di questo, il “Corriere”, pur<br />
senza staccarsi dalla sua linea tradizionale, aveva cominciato a fornire le notizie in modo nuovo. Invece di riferire solo la<br />
voce dell’autorità, dando una interpretazione univoca dei fatti, si iniziò a riportare separatamente le diverse versioni che<br />
su incidenti, episodi di intolleranza e violenza politica danno le varie fonti. Questo fece guadagnare al “Corriere della<br />
Sera” nuovi giovani lettori ma si alienò le simpatie di quanti lo consideravano portavoce del ceto borghese - conservatore<br />
Luciano Buonocore – La Maggioranza Silenziosa e il Progetto Tecnocratico 40
e volevano che il giornale ritornasse alla sua vecchia linea. Il secondo fatto che aveva contribuito a scatenare l’attacco al<br />
“Corriere della Sera” era stato l’arrivo alla direzione di cronaca di Salvatore Conoscente, proveniente dal settore della<br />
stampa comunista. Da quando Conoscente era diventato capocronista, la cronaca del “Corriere” era cambiata: mentre<br />
veniva dato meno spazio alla cronaca nera della città, si guardava con più attenzione a tutto ciò che si agitava nella vita<br />
milanese. Tutti questi cambiamenti allarmarono parte dei lettori tradizionali del “Corriere”: proprio di questa irritazione<br />
si fece interprete la “Maggioranza Silenziosa”. Il 27 febbraio sui muri di Milano venne affisso un altro manifesto,<br />
anch’esso come il primo, aperto dalla vistosa scritta “Corriere della Sera, quotidiano indipendente della sovversione<br />
nazionale”. In questo manifesto, tra l’altro si affermava: ”Il 25 febbraio il “Corriere della Sera”, il quotidiano della<br />
sovversione nazionale, ha avuto il primo tangibile e legale segno del discredito in cui è caduto nell’opinione pubblica<br />
nazionale grazie a tutti quei cittadini che, liberamente, ci hanno ascoltato e seguito”. In realtà, i gestori delle principali<br />
edicole del centro di Milano avevano confermato vendite del Corriere del tutto normali. Lo scopo del manifesto del 27<br />
febbraio, similmente al precedente manifesto, era quello di invitare la popolazione di Milano a non comprare il “Corriere”<br />
per il giorno 1 marzo 1973. Rivolgendosi ai milanesi, il manifesto, affermava: “il Corriere non è più il nostro giornale, del<br />
quale andavamo tanto fieri. Le sue pagine sono diventate “rosse” e l’obiettività di informazione ha ceduto il passo<br />
all’ambiguità, alla faziosità. Perché mai i “padroni del Corriere” hanno dato il loro giornale nella mani di un capocronista<br />
comunista?. Pensavano forse il via Solferino 28 che tutti i milanesi siano rimbecilliti? Si sbagliano di grosso!”.<br />
“L’obiettivo della stampa – proseguiva il manifesto – è uno dei fondamenti della democrazia. Noi rispettiamo le opinioni,<br />
ma non è legale, sotto la testata di un “giornale indipendente” nascondere la bacchetta di direttore di orchestra<br />
comunista. Ecco perché dobbiamo nuovamente e nello stesso modo civico, legale corretto ripetere quel segno<br />
ammonitore: giovedì primo marzo non compriamo il Corriere!”.<br />
La polemica proseguì, anche se in modo meno serrato, per tutto l’anno, fino a che in dicembre l’attacco contro il<br />
“Corriere della Sera” si riaccese improvvisamente. Il 3 dicembre un gruppo di persone non identificate si introdusse<br />
nell’edificio del “Corriere” in via Solferino e lanciò manifestini firmati dal C.C.A. che denigravano e diffamavano il<br />
giornale e i suoi giornalisti. Il “Corriere della Sera” del 4 dicembre, in seguito a questi fatti pubblicò un documento<br />
sottoscritto dal Comitato di Redazione e dal Consiglio di Fabbrica, in cui denunciava l’intimidazione volta a colpire la<br />
libertà di espressione dei giornalisti stessi. Cogliendo come pretesto queste dichiarazioni, il C.C.A. riaprì la polemica<br />
contro il giornale. Pubblicando e diffondendo manifesti e volantini rivolti alla categoria dei giornalisti, il C.C.A. li invitava<br />
a ribellarsi alla “censura”, ormai presente in quasi tutti i periodici e i quotidiani. Erano accusati di appoggiare i “censori”<br />
della stampa i Comitati di Redazione, i Consigli di Fabbrica e molti editori che si erano accordati con “centrali sindacali<br />
paracomuniste”. Si trattava quindi di combattere una censura imposta dalle forze comuniste. “Oggi – si affermava – un<br />
giornalista non è più in grado di esercitare liberamente la professione, se vuole conservare il proprio posto, si deve<br />
assoggettare ad una censura che in molti casi capovolge la realtà dei fatti (. . .). Assumendo un atteggiamento critico nei<br />
confronti della censura “di regime”, che Le impedisce di scrivere la verità e di portarla a conoscenza dei suoi lettori,<br />
eviterebbe di sentirsi nei panni del mercenario che le vorrebbero imporre tutta la vita, ed eserciterebbe un suo sacrosanto<br />
diritto: quello di informare liberalmente l’opinione pubblica”. I toni della polemica si fecero più accesi quando in<br />
occasione della manifestazione anticomunista del 2 dicembre al teatro Dal Verme, il “Corriere della Sera” ne dette notizia<br />
“in quattro righe” nell’edizione nazionale, mentre non ne parlò affatto nell’edizione milanese. In un volantino stampato il<br />
9 dicembre, il C.C.A. riportò l’articolo pubblicato sull’edizione nazionale del “Corriere della Sera” del giorno prima<br />
accusando lo stesso giornale di aver ignorato la manifestazione della “Maggioranza Silenziosa” nell’edizione milanese per<br />
calcolo politico, “così una notizia che riguarda la loro città i cittadini non possono leggerla”. “Cittadini!!! – concludeva il<br />
volantino - è ora di dire basta al tentativo di sovietizzare l’informazione. Il compagno Conoscente, militante del PCI e<br />
capocronaca del “Corriere della Sera”, ha instaurato all’interno della cronaca cittadina un servizio di controllo politico che<br />
va a danno dei giornalisti liberi esaltando la sinistra, giustificando la violenza dei gruppuscoli comunisti e ignorando nello<br />
stesso tempo le notizie politiche riguardanti l’anticomunismo milanese”. Infine, il 21 dicembre il C.C.A. stampò un altro<br />
volantino in cui si rivolgeva alla categoria dei giornalisti con chiari riferimenti ai fatti già citati nel volantino del 9<br />
dicembre. Si accusava il “Corriere della Sera” di dare risalto ad ogni comunicato proveniente dai “gruppuscoli comunisti”,<br />
mentre i comunicati della “Maggioranza Silenziosa” non venivano mai pubblicati. Si ribadiva che il “Corriere della Sera”,<br />
essendo ormai un organo del PCI, non poteva più chiamarsi “indipendente e democratico”. Il volantino terminava con il<br />
solito appello ai giornalisti a ribellarsi al tentativo di soffocare la libertà di espressione. “Denunciate con noi la collusione<br />
in atto fra il grosso capitale e l’imperialismo sovietico ai danni della nostra democrazia”. Si profilava così ancora una volta<br />
lo spauracchio del grosso “orso rosso” che viene da lontano…<br />
L’attacco al “Corriere della Sera” rientrava nella più ampia battaglia che il C.C.A. – “Maggioranza Silenziosa” aveva<br />
intrapreso nella convinzione di tutelare ogni forma di libertà. In realtà, dietro la campagna contro il giornale, mossa dalla<br />
“Maggioranza Silenziosa” in sintonia con altri gruppi di destra, non c’era soltanto il malumore di una certa parte dei<br />
lettori del “Corriere della Sera” che non trovavano più in questo giornale lo specchio delle loro opinioni conservatrici.<br />
Dietro a questa battaglia si nascondeva ancora un gioco di manovre economiche e politiche ben più complesso, con cui si<br />
voleva spingere i proprietari del “Corriere della Sera” a vendere il giornale, confidando nel fatto che le sue condizioni<br />
finanziarie non fossero del tutto rosee. Fra i nomi dei potenziali acquirenti che premevano sui proprietari del “Corriere”<br />
per ottenerne la vendita, compariva Attilio Monti, che controllava già “Il Giornale d’Italia” di Roma “Il Telegrafo” di<br />
Livorno, “La Nazione” di Firenze, il “Resto del Carlino” di Bologna. Appare molto più che una coincidenza il fatto che sia<br />
“Il Giornale d’Italia”, sia il “Resto del Carlino” in quel periodo attaccassero con veemenza il “Corriere della Sera”. Colpito<br />
dalla stampa conservatrice e di destra, che si scagliò contro il giornale (41) facendo il gioco della “Maggioranza<br />
Silenziosa” , del FUAN, del FDG, il “Corriere della Sera” manifestò tutto il suo sdegno per questa campagna diffamatoria.<br />
Il Comitato di Redazione e il Consiglio di Fabbrica, coma abbiamo già accennato denunciarono le intimidazioni<br />
provenienti dalla “Maggioranza Silenziosa” tese a soffocare la libertà di espressione e di scelta dei giornalisti. Per quanto<br />
riguarda, in particolare, la campagna diffamatoria ai danni del capocronista Conoscente, il Comitato di Redazione e il<br />
Consiglio di Fabbrica del “Corriere della Sera” dichiararono: “Nell’esprimere la più completa solidarietà al compagno di<br />
lavoro oggetto di una inqualificabile campagna denigratoria, giornalisti, operai, impiegati di tutte le testate dell’azienda<br />
riconfermano il proprio vigilante impegno antifascista e ricordano ai lettori che tali minacce si rifanno a metodi già usati<br />
Luciano Buonocore – La Maggioranza Silenziosa e il Progetto Tecnocratico 41
una volta per togliere la libertà al popolo italiano e per instaurare un regime antidemocratico che oggi pochi squallidi<br />
eredi rimpiangono”. La risposta del “Corriere della Sera” agli attacchi della “Maggioranza Silenziosa” fu dunque molto<br />
decisa, fino ad accusare implicitamente questo movimento di usare metodi “fascisti” per soffocare le libertà<br />
democratiche. Questo costituì indubbiamente un atto di accusa molto pesante soprattutto considerando che compariva<br />
sulle pagine del giornale italiano più diffuso. Di fronte ai ripetuti attacchi al “Corriere” e al suo capocronista, anche il<br />
presidente dell’Associazione Lombarda dei Giornalisti, il Comitato di Redazione de “Il Giorno” e il presidente del Gruppo<br />
Cronisti inviarono al giornale attestazioni di solidarietà e lanciarono pesanti accuse contro la “Maggioranza Silenziosa”.<br />
Roberto Renzi, presidente dell’Associazione Lombarda dei Giornalisti, telegrafò al “Corriere della Sera”: “Esprimo più<br />
completa solidarietà condannando inqualificabile campagna denigratoria contro “Corriere” e i suoi redattori, retaggio di<br />
non più accettabile sistemi antidemocratici”. La Redazione de “Il Giorno” comunicò: “Questo attacco contro il “Corriere”<br />
vi fa onore perché dimostra come la campagna democratica che il “Corriere della Sera” ha intrapreso stia toccando nel<br />
vivo chi cerca con ogni mezzo di ricacciare il nostro Paese verso forme di Governo che gli uomini liberi sperano per<br />
sempre superate. Infine anche Fulvio Vischi, presidente dei Cronisti, telegrafò la sua solidarietà al “Corriere” e definì le<br />
attività della “Maggioranza Silenziosa” ” antidemocratiche”e “lesive” alla libertà di stampa”. Sia gli attestati di solidarietà<br />
al “Corriere della Sera” sia il fatto stesso che la campagna antiacquisto ai danni del giornale non avesse avuto tangibili<br />
risultati furono la prova che buona parte della società milanese era pronta a reagire e a rifiutare i metodi usati dalla<br />
“Maggioranza Silenziosa”. Ciò nonostante questo movimento con la campagna denigratoria contro il “Corriere” raggiunse<br />
un obiettivo importante: essere al centro dell’opinione pubblica di Milano e far parlare di sé attraverso uno dei più<br />
importanti canali di informazione: la stampa.<br />
(N.B.: Le NOTE di questa parte della Tesi, verranno inserite in seguito – N.d.R.)<br />
La battaglia giornalistica di “LOTTA EUROPEA”<br />
Nel febbraio del 1972, annunciato da una vasta campagna pubblicitaria, esce il primo numero di “Lotta Europea”,<br />
diretto da Luciano Buonocore, che verrà pubblicato fino a maggio del ’74. Come viene chiarito nel primo numero, la<br />
rivista nasce da quello stesso gruppo “di persone di diverse tendenze politiche, che costituirono nel febbraio del ’71 il<br />
Comitato Cittadino Anticomunista, organizzatore della “Maggioranza Silenziosa”. Queste persone, senza nessuna<br />
intenzione di costituire un nuovo raggruppamento politico, hanno sentito come dovere di dare un certo ordine a quella<br />
larga corrente di opinione che in Italia, come d’altra parte in Europa, si sta schierando su nuove posizioni”(1). “Lotta<br />
Europea” quindi rappresenta il tentativo di una certa parte della borghesia milanese di fornire un quadro di riferimento<br />
in alternativa alla cultura del nostro tempo, in crisi sotto tutti gli aspetti. “Lotta Europea” si profila inoltre come una<br />
rivista “di battaglia e di avanguardia”: “di battaglia, perché vorremmo che essa divenga un valido contributo alla<br />
preparazione di un’organica lotta anticomunista anche a livello europeo; di avanguardia, intendo con questo termine non<br />
un fenomeno di progressismo sovversivo e in sé vuoto ma laurea di coscienza su problemi concreti e attuali”(2).<br />
Perfettamente allineata con le parole d’ordine del C.C.A. e della “Maggioranza Silenziosa” anche “Lotta Europea” si<br />
propone come principale obiettivo la lotta contro il comunismo, il cui successo impone una strategia unitaria, al di sopra<br />
di ogni spirito di parte (3). Gli argomenti trattati nella rivista sono vari. Abbiamo cercato di suddividere per temi i<br />
numerosi articoli di “Lotta Europea” in base al loro contenuto, privilegiando questo tipo di impostazione ad una<br />
sistemazione di tipo cronologico degli articoli stessi, che ci è sembrata di irrilevante interesse (4). I temi principali<br />
affrontati nella rivista riguardano i problemi di politica, analizzati nella pessimistica ottica della crisi generale della<br />
società italiana; poi, il “concetto Europa”, la cui importanza è sottolineata dal titolo stesso della rivista;<br />
l’antiamericanismo, l’antiegualitarismo, l’antimarxismo che caratterizzano il pensiero di Lotta Europea, e, di contro la<br />
centralità e l’importanza del ruolo culturale della destra; infine l’atteggiamento della rivista nei confronti della scuola,<br />
della contestazione, della religione e delle scienze. Spesso il linguaggio usato da chi scrive sulla rivista è retorico e<br />
soprattutto ripetitivo. L’idea di una crisi assoluta e generalizzata che investe tutto il tessuto sociale, e di un marxismo<br />
inesorabilmente avanzante è ripetuta ossessivamente in ogni articolo, a tal punto che nella nostra analisi rischia di essere<br />
ridondante. La rivista rimane comunque un momento fondamentale per comprendere l’area culturale in cui la<br />
“Maggioranza Silenziosa” si muove.<br />
a) La politica interna<br />
Nell’affrontare i problemi di politica italiana, le linee programmatiche su cui si muove “Lotta Europea” si ispirano<br />
costantemente ad un sostanziale sentimento anticomunista, per cui l’obiettivo politico principale è l’attacco al Partito<br />
Comunista, il “colosso dai piedi d’argilla” che si è inserito sempre più prepotentemente in vari settori della vita sociale.<br />
Ancora più allarmante di questo dilagare comunista a macchia d’olio, appare, per il nostro Paese, la crisi che sconvolge e<br />
paralizza gli altri partiti, rendendoli assolutamente incapaci di reagire adeguatamente. Le formazioni politiche infatti,<br />
secondo “Lotta Europea”, sono sempre meno rappresentative delle aspirazioni dei cittadini. Il distacco ogni giorno più<br />
profondo tra il cittadino e il partito non deriverebbe dalla mancanza di interessi verso i problemi politici, ma dal fatto che<br />
i partiti stessi, mancando di vera e autentica democrazia, non consentirebbero l’effettiva partecipazione alle decisioni (5).<br />
“L’attuale classe politica – scrive Degli Occhi – è morta. E’ morta perché è vile. E’ vile perché è ladra (. . .). Non vive di<br />
idee a di formule” (6).<br />
Perseverando sulla linea di un costante compromesso e concependo la politica soltanto come “conquista del potere” , i<br />
partiti vanno perdendo sempre più credibilità. Se da un lato il cittadino si allontana dalla vita politica sentendosene<br />
escluso, dall’altro l’uomo politico riesce in tal modo a sottrarsi a scomodi controlli da parte del cittadino stesso (7).<br />
Gestori troppo impegnati a ricercare formule con cui conservare una sorta di “potere senza autorità”, in trent’anni di<br />
malgoverno i politici hanno portato lo Stato in una condizione di impotenza e di corruzione, fra i problemi enormi che si<br />
affacciano, come l’infittirsi dell’inurbamento, la crisi economica, la crisi sanitaria, i problemi del Sud, ecc. Deboli e<br />
“ammalati”, i partiti sono soprattutto colpevoli di non attuare una politica più intransigente verso il PCI e le sinistre in<br />
genere. Il centro-sinistra che avrebbe dovuto “staccare” i socialisti dai comunisti, ha causato esattamente il contrario: “Il<br />
Luciano Buonocore – La Maggioranza Silenziosa e il Progetto Tecnocratico 42
PSI rappresenta sempre il “cavallo di Troia” marxista in seno alla democrazia italiana, e i comunisti, invece di indebolirsi<br />
e di entrare in crisi, secondo le previsioni dei padri coscritti del centro-sinistra, si sono rafforzati più che mai (. . .), sono<br />
entrati quasi senza colpo a ferire in tutta una miriade di associazioni e organizzazioni collaterali facendo la parte del<br />
leone” (8). Mentre l’azione dei comunisti cloroformizza la popolazione e prepara il terreno per l’avvento del suo potere<br />
seminando panico e terrore in tutto il Paese (9), nessuno ha più il coraggio di aprire bocca. “L’azione di terrorismo<br />
psicologico accompagnato da una ben orchestrata compagnia di stampa e televisione infine immobilizzando anche i<br />
partiti anticomunisti. La classe politica dei partiti anticomunisti, per il terrore di essere tacciata di fascismo, non riesce a<br />
dare una risposta unitaria a questa aggressione comunista (. . .). Sembra quasi di assistere al ripetersi di un nuovo<br />
Aventino” (10).<br />
Ma ciò che detesta maggior allarme è il configurarsi del compromesso storico. Analogamente alla campagna contro il<br />
compromesso storico tra il PCI e DC intrapresa dal C.C.A. (11), “Lotta Europea” attacca la prospettiva di una repubblica<br />
conciliare definendola una vera e propria minaccia alla libertà. Secondo la visione politica di “Lotta Europea”, accettando<br />
questa manovra del PCI, la DC andrebbe incontro al più vergognoso dei cedimenti: “se la “Grande Prostituta” arriverà al<br />
compromesso storico con il PCI ciò sarà quanto di più putrido infame e … democristiano poteva concepirsi ed attuarsi”<br />
(12). Parallelamente a quanto succede nei partiti, “Lotta Europea” ravvisa sintomi di grave crisi anche nella Magistratura,<br />
che, sotto i colpi dell’”uragano rosso”, vacilla, è minata; i magistrati sono divenuti “soggetti attivi di oltraggio, soggetti<br />
passivi di tempestive lettere anonime. Privata dei suoi mezzi più rapidi di intervento, vilipesa nelle leggende filmistiche o<br />
librarie degli adoratori del sistema giudiziario sovietico, incrinata dalle crisi dell’Organo Politico, sovrappostole per<br />
garantire la . . . indipendenza, essa combatte le sue gloriose battaglie di retroguardia: fin quando lo potrà?” (13). Oscilla<br />
quindi un altro pilastro dello Stato, un’altra garanzia delle libertà dei cittadini.<br />
A questo tetro quadro, “Lotta Europea” aggiunge, nella cornice di una dilagante crisi economica, la disastrosa dialettica<br />
sindacale portata avanti dalla CISL, CG<strong>IL</strong> e U<strong>IL</strong>. Non è un mistero, secondo “Lotta Europea”, che l’unità sindacale di cui<br />
tanto si parla serva soltanto ai comunisti. In realtà la CG<strong>IL</strong>, “quinta colonna” del PCI, strumentalizza CISL e U<strong>IL</strong>, per<br />
poterli utilizzare opera come massa d’urto e pressione politica contro lo Stato. Questi sindacati, asserviti ai comunisti,<br />
sempre più spesso si sostituiscono al padrone e lo superano di molto con le loro sopraffazioni e intimidazioni,<br />
“anticipando un assaggio di quello che potrebbe diventare il nostro Paese se venisse definitivamente domato da un<br />
sistema comunista simile a quelli instaurati in Russia, in Cina, e nei vari satelliti europei e asiatici, compresi nel grande<br />
impero della bandiera rossa” (14). Attraverso un uso incontrollato dello sciopero, i sindacati hanno cercato di paralizzare<br />
il sistema produttivo del Paese, “sono riusciti a realizzare la loro rivoluzione sovvertendo e annullando le norme della<br />
Costituzione e spostando di fatto l’asse del potere politico” (15). Assumendo un potere immenso, i sindacati con la loro<br />
sottile e subdola attività di persuasione e di intimidazione rischiano di soffocare e annullare ogni garanzia di libertà.<br />
“Lotta Europea” invita perciò i lavoratori a diffidare di queste organizzazioni sindacali che, con le loro famose assemblee<br />
democratiche, “vere e proprie orge di esaltazione collettiva”, li influenzano fino a renderli privi di capacità decisionale.<br />
L’ossessione della lotta di classe permanente non può portare ad altro che ad una sovversione e ad una instabilità che<br />
danneggiano in primo luogo i lavoratori stessi: l’attuale aumento della disoccupazione ne è la prova.<br />
Di fronte alla crisi totale della società moderna, “Lotta Europea” prospettava in alternativa ai partiti politici, che per<br />
loro natura racchiudono l’insidia della faziosità (16), una ristrutturazione globale della società fondata sul<br />
corporativismo. Come è noto, per corporazione si intende l’unione dei datori di lavoro e dei lavoratori per ogni singolo<br />
ramo di produzione. Il primo effetto di questa organizzazione del lavoro è secondo chi sostiene tale teoria, il superamento<br />
della conflittualità permanente, ottenendo una “concreta armonia tra le classi non più opposte e rivali secondo l’ottica<br />
marxista, ma unite dal comune fine della produzione, senza nessuna coercizione artificiosa” (17). Ma l’aspetto più<br />
importante sottolineato da “Lotta Europea” è che il concetto corporativo non è solo economico e sociale: la corporazione<br />
assume anche una “dimensione etica e spirituale”. Essa infatti esprime l’idea di una società armonica che si fondi<br />
sull’oggetto di lavoro in sé e per sé, al di là del suo valore economico effettivo. Il lavoro viene concepito come un valore<br />
intrinseco di formazione interiore. Andando oltre l’interesse puramente economico del “fattore produzione”, tra datore di<br />
lavoro e lavoratori si creano, oltretutto, vincoli “metaeconomici” assai più saldi. “Il corporativismo – si afferma su “Lotta<br />
Europea” – si fa interprete della necessità, avvertita da sempre in ogni ordinamento sociale, di una strutturazione<br />
organica e completa della società” (18).<br />
Appare allora un altro aspetto, indissolubilmente legato al corporativismo nell’interpretazione di “Lotta Europea”: il<br />
concetto di Stato organico. Lo “Stato organico” si presenta “differenziato, articolato su base pluralista, ma retto da una<br />
legittima Autorità che sia espressa da una èlite, la quale (. . .) sia prima di ogni cosa esempio di coerenza assoluta e<br />
modello a cui volgersi suscitando nel popolo un clima di positiva “tensione” verso l’alto” (19). Essendo concepito come un<br />
grande organismo, e non come una macchina, lo Stato ha un’anima, affonda le sue radici in una realtà spirituale. Avendo<br />
il diritto di fare leggi e di giudicare autonomamente certi settori della vita nazionale, responsabilizzando al massimo, così,<br />
i corpi sociali, le corporazioni diventano esse stesse freno allo strapotere del vertice. Quindi, secondo “Lotta Europea”,<br />
non è accettabile l’equivalenza che molti fanno tra corporativismo e totalitarismo. Poiché inoltre, le corporazioni sono<br />
organismi aperti e dinamici, non è neppure fondata l’accusa al corporativismo di bloccare la mobilità sociale. Per evitare<br />
prevaricazioni e rivalità, “”Lotta Europea” prevede sulle corporazioni una sorta di controllo operato dal potere politico, il<br />
quale, stando al di sopra delle parti, può con sufficiente giustizia intervenire per armonizzare controversie e<br />
salvaguardare l’interesse generale della Nazione da eventuali settorialismi. L’alternativa dello Stato organico-corporativo<br />
è una prospettiva tipica della destra. E’ infatti soltanto nella <strong>Destra</strong> (20) che “Lotta Europea” colloca una reale presa di<br />
coscienza, la volontà di progredire e di essere uomini liberi. La <strong>Destra</strong> rappresenta l’ordine nel caos, il ritorno di valori<br />
tradizionali perduti e, soprattutto, la realizzazione concreta del tanto auspicato “fronte articolato anticomunista” (21).<br />
Luciano Buonocore – La Maggioranza Silenziosa e il Progetto Tecnocratico 43
) il concetto di “Unità europea”<br />
Come il titolo stesso della rivista annuncia, uno dei principali temi affrontati è la “rinascita dell’Europa”. Di questo<br />
argomento si occupa esclusivamente Giovanni Davoli, che firma una serie di articoli sui primi numeri di “Lotta Europea”.<br />
L’obbiettivo dell’autore è di sensibilizzare l’opinione pubblica al problema di una unione europea resa necessaria e<br />
urgente dal momento che, dalla seconda guerra mondiale in poi, le “pseudo-civiltà” sovietica e americana hanno spezzato<br />
l’unità storica, culturale e politica del nostro continente. USA e URSS, applicando in Europa il principio divide et impera<br />
e praticando una sfruttatrice politica nazional-imperialista, si sono resi responsabili dell’agonia degli Stati nazionali<br />
occidentali odierni, che non sono più né liberi né sovrani come un tempo. L’Europa è stata trasformata in un “finto”<br />
campo di battaglia dove americani e russi “recitano” la parte di acerrimi nemici, gli uni dichiarandosi “paladini della<br />
libertà”, gli altri proclamandosi fautori del socialismo internazionale. Ma in realtà i due popoli si sono stretti “la mano<br />
sulle rovine fumanti e tragiche del nostro continente” (23), nel comune disegno di spartirsi l’Europa come terra di<br />
conquista. Di fronte a questo sfacelo, l’Europa deve recuperare la libertà e l’indipendenza che ha perduto. Questo è<br />
possibile, secondo Davoli, se l’Europa saprà trovare la propria unità. Non si tratta soltanto di unità sul piano economico,<br />
che, essendo legato ad “interessi materiali e fluttuanti”, è “accessorio”, e non essenziale. Bisogna cercare il comune<br />
denominatore del popolo europeo scandagliando più in profondità, nella tradizione spirituale, nella storia, nella<br />
mentalità che i secoli hanno sedimentato. “L’Europa – scrive Davoli – ha il compito consacrato dalla storia di non essere<br />
solo una terza Potenza, ma essenzialmente una terza Civiltà”(24); per essere tale, essa deve rifiutare gli schemi politici e<br />
sociali importati da sistemi stranieri.<br />
In una parola, l’Europa deve porsi “oltre il capitalismo e il comunismo”, due ideologie apparentemente contraddittorie,<br />
ma congiunte in uno spirito che distrugge la civiltà. L’Europa deve organizzare le sue strutture in base ad una concezione<br />
che tenda a superare il comunismo di marca sovietica e la “pseudo-democrazia” di stampo occidentale, perché esse<br />
importano un tipo d’uomo estraneo alla cultura europea. E’ “l’uomo-robot, che consuma-produce-vota”, contro il quale la<br />
cultura europea rivendica l’uomo europeo, “libero nella sua personalità e fiero dei propri valori universali” (25). L’invito<br />
di Davoli è dunque volto a fermare la rapida decadenza verso cui si è avviata da decenni la civiltà del nostro continente e,<br />
di conseguenza, a dare vita immediatamente ad una Europa-Nazione, che sorga come un grande spazio nato dal<br />
superamento degli Stati nazionali. La lotta che porterà a questa Europa nuova sarà “di popolo” e non di “classe”, giacchè<br />
lo sfruttato è tutto il popolo d’Europa. Negando ogni realtà alla lotta di classe, si prospetta uno Stato nazionale europeo,<br />
in cui e differenze esistenti tra categorie produttive vengono fuse in un quadro di unità nazionale a vari livelli (26). La<br />
concezione europeistica che “Lotta Europea” ci propone non è quindi la negazione o l’antitesi del nazionalismo. E’<br />
piuttosto la trasposizione del concetto di nazione su scala diversa (27). C’è di più. Non soltanto attraverso l’unità Europea<br />
deve riacquistare peso come potenza e come civiltà. Addirittura, a lei spetta il diritto storico di riassumere il ruolo<br />
centrale nella cultura mondiale, perché solo il continente europeo ha una civiltà autentica. La civiltà americana e<br />
sovietica, infatti, sono gli epigoni di quella europea, anzi non sono che “distorsioni e deviazioni” di quella. Dunque,<br />
dall’europeismo si è passati alla vecchia anacronistica tesi dell’eurocentrismo, nella convinzione che l’Europa sia l’anima<br />
del mondo.<br />
Ma il fine essenziale e ultimo della “rivoluzione europea” è quello di creare un nuovo tipo d’uomo. E’ chiaro allora che il<br />
“problema Europa” non trova il suo spessore nella dimensione politica, ma in quella etica e spirituale. Ciò che sta<br />
veramente a cuore a “Lotta Europea” è salvare l’uomo che “annega nel materialismo, nella mediocrità, nell’anonimato”; è<br />
di ridare all’homo economicus alienato dal consumismo, vittima del progresso tecnico, la sua espressione più vera, quella<br />
spirituale (28). Questo non significa rinnegare del tutto i progressi della tecnica e della scienza, ma comporta comunque<br />
un ridimensionamento di tali progresso, affinché non venga mai meno una sorta di “equilibrio tra materia e spirito”. Tale<br />
equilibrio, l’uomo lo trova se non si lascia travolgere dalla società di massa: “di fronte all’uomo medio, all’uomo-massa –<br />
scrive Davoli – dobbiamo creare un tipo di uomo che “viva” i valori spirituali; l’uomo che non si abbandona nella massa,<br />
ma cerca sempre di distinguersi e differenziarsi qualitativamente da essa, e che quindi rifiuta la sua attuale dimensione di<br />
atomo amorfo”(29). Ecco che sono emerse tematiche diverse e complesse, che cercheremo di analizzare meglio.<br />
c) Spiritualismo, antiegualitarismo e antimarxismo<br />
La lotta contro la concezione materialistica della vita e della società dell’uomo è una delle battaglie più accese intraprese<br />
da “Lotta Europea”. Fin dal primo numero della rivista, Luciano Buonocore, il direttore responsabile, afferma: “Noi<br />
vogliamo una cultura che tende a formare l’uomo nella sua parte spirituale, nella sua anima e nel suo corpo”, e, in stretta<br />
simbiosi, una azione politica che non si fermi all’aspetto puramente sociale ed economico, ma che contenga “in potenza<br />
una finalità atta a permettere oltre al godimento materiale anche, come ultimo fine, una possibile estrinsecazione<br />
spirituale della persona” (30). Nella visione di “Lotta Europea” la dimensione spirituale è dunque essenziale per la<br />
formazione della personalità. Se quella viene a mancare, l’uomo si allontana dalla sua vera natura e viene travolto in<br />
“tragici sconvolgimenti esistenziali”. E’ quanto è successo alla nostra società moderna. Gli attacchi sempre più organizzati<br />
del “materialismo” e il miraggio sempre più intenso del “consumismo” hanno portato fatalmente l’umanità al rifiuto della<br />
dimensione spirituale della propria vita, alienandola così dalla sua essenza.<br />
La principale responsabilità della crisi esistenziale dell’uomo di oggi è ravvisata dunque nelle forme che, attraverso il<br />
progresso tecnico e scientifico ha assunto la moderna società. Tale progresso infatti ha eclissato nell’uomo “quella<br />
spiritualità che per millenni, simile alla stella polare, lo aveva guidato sulla strada della realizzazione interiore” (31). “Il<br />
prodotto della civiltà industriale è un essere amorfo senza individualità né responsabilità, accorto nell’evitare ogni<br />
responsabilità, convinto di sapere ciò che non sa, rotella, in definitiva, di quell’immenso ingranaggio che è la società<br />
contemporanea”, una sorta di “burattino” che forze occulte dominano e dirigono (32). La società industriale, con le sue<br />
teorie illuministiche e con la sua “folle corsa al benessere e al progresso scientifico indiscriminato”, con irresponsabile<br />
incoscienza ha spezzato l’equilibrio naturale tra l’uomo e l’ambiente (33). Ed ecco allora che, accanto alla denuncia della<br />
società industriale “Lotta Europea” pone il rimpianto nostalgico della società preindustriale, l’unica vera “società<br />
Luciano Buonocore – La Maggioranza Silenziosa e il Progetto Tecnocratico 44
naturale” in cui l’uomo possa realizzarsi. Il progresso ha sostituito ad essa “plebi informi e anonime dei superbi”, città che<br />
stanno rendendo l’uomo sempre più rotella di un ingranaggio, sempre più “uomo-massa”. Sradicato dalle società<br />
naturali, privato dei valori della tradizione, l’uomo non ha più stabilità ed equilibrio: perde la sua personalità per<br />
annullarsi nella massa ed è sempre più solo. Entro la cupa e pessimistica cornice della crisi abissale che ha travolto<br />
l’uomo, da un lato dunque “Lotta Europea” lancia una accusa al progresso così grave da legittimare il rifiuto stesso della<br />
modernità. Dall’altro, indissolubilmente intrecciato a questo tema, affiora quello del rimpianto del “paradiso perduto”. Il<br />
rifiuto del progresso, la nostalgica evocazione della società precedente e dei suoi valori tradizionali, la ricerca della<br />
dimensione spirituale dell’uomo, sono tematiche non nuove, che da sempre caratterizzano il pensiero delle classi<br />
conservatrici e reazionarie (34). L’incapacità, o meglio, la paura nell’affrontare il “nuovo” che l’evolversi di una società<br />
sostituisce al “vecchio”, è una peculiarità della “cultura di destra” (35).<br />
Un altro bersaglio colpito da “Lotta Europea” è il culto dell’”uniformiamo”, che oggi caratterizza la nostra società. “La<br />
pretesa che gli uomini debbano essere sempre più simili tra loro – si legge in “Lotta Europea” – si fa costantemente più<br />
presente. L’ammirazione, la passione per l’uniformità è quasi accettata come un dogma (. . .). Si mira in sostanza al<br />
gregge, parola che dai teorici di sinistra viene cortesemente sostituita con quella più edulcorata di “eguaglianza” (36). E’<br />
la mediocrità, tipica di ogni società materialista, che porta al mito dell’uniformismo, a quelle “tendenze livellatrici e<br />
identitarie che sempre hanno animato gli spiriti mediocri”. L’idea di uguaglianza, espressa in questi termini, viene<br />
dunque concepita come una sorta di inevitabile trasformazione imposta dalla società democratica per fare di ogni uomo<br />
soltanto un numero di massa. Paradossalmente, uguaglianza diventa antitesi e negazione di libertà personale. Perché<br />
sopravviva la libertà individuale, sommo valore della vita umana, bisogna non solo rifiutare l’uguaglianza, ma addirittura<br />
negarne l’esistenza. “Questa società – afferma infatti Davoli – ha creato il mito dell’uguaglianza. Ma non è vero che siamo<br />
tutti uguali. Siamo tutti. . .egualmente diseguali. Ognuno dovrebbe rispettare e riconoscere la disuguaglianza degli altri”.<br />
Ed ancora: “E’ la forma peggiore di dittatura quella che sottopone il pensiero dei migliori sul piano dei più meschini e<br />
reputa entrambi uguali” (37).<br />
Il veicolo conduttore dell’ugualitarismo e del materialismo va ricercato nell’ideologia marxista, che si è infiltrata nella<br />
cultura occidentale moderna e che la sta portando inesorabilmente verso la decadenza. Ancora oggi, le “invecchiate<br />
utopie e infamie” di Marx ed Engels, “sepolte dal loro fallimento sociale laddove furono applicate, vivono e prosperano<br />
tra le grasse elites dei buoni borghesi intellettuali, teorizzanti di droga e sesso e pornografia e aborti e divorzio (. . .) e tra<br />
le smaliziate elites sindacaliste”. E mentre si prepara il “finale collasso” del nostro mondo europeo, “le teorie marxiste<br />
ostentano la loro pomposa miseria sui labbruzzi di latte dei nuovi nati al verbo e sui labbroni avvizziti dei furbi di<br />
sempre” (38). Il marxismo, nella visione di “Lotta Europea” è il non valore, la negazione dei valori umani, perciò l’attacco<br />
contro di esso deve essere totale, violento, senza alcuna remora. Nelle metafore di “Lotta Europea”, la fede marxista<br />
diventa la teoria dell’assassino e del ladrocinio organizzato. E Marx, con il suo odio intellettuale “dalla semitica tristezza”,<br />
è il discendente di Lutero e di Calvino, che hanno appestato il XVI secolo; è il discendente di Voltaire e degli<br />
Enciclopedisti, che hanno appestato il XVIII secolo; è l’untore che diffonde il contagio e appesta il XX secolo. E’ Caino che<br />
uccide il fratelli, anzi è Lucifero in persona, il principe del male…(39)<br />
Al di là di queste immagini, a volte eccessivamente colorite, l’interpretazione che “Lotta Europea” dà al marxismo<br />
oscilla tra due posizioni estreme. Da un lato, la rivista fornisce ai lettori una immagine riduttiva e minimizzante del<br />
problema, come se il marxismo fosse un corpo agonizzante senza nessuna possibilità di sviluppo. La volontà marxista di<br />
“annientare la realtà naturale”, si basa su utopie “teorizzate con ragionamenti astratti - il mondo nuovo”, le “società senza<br />
classi” che non hanno né possono avere alcun aggancio con la realtà stessa. (40) Dall’altro lato più spesso, “Lotta<br />
Europea” inverte i termini della questione: il marxismo è il grande orso rosso in agguato, nei confronti del quale è<br />
legittimo l’uso di qualsiasi arma difensiva. Il problema della difesa è tanto più complesso, in quanto non si ha a che fare<br />
con un nemico normale, ma con un nemico “patologico”. Il marxista infatti “più che uno il quale effettivamente agisce<br />
sulla realtà, è, a livello personale, un rivoluzionario: cioè, un individuo in cui i normali procedimenti di pensiero e la<br />
presa di coscienza di fronte alla realtà hanno subito una deviazione rivoluzionaria. Egli non ragiona più secondo la logica<br />
di sempre – che è in fondo – quella di Aristotele e S. Tommaso (. . .), ma secondo le categorie della dialettica marxista e<br />
dell’utopia”. E a riprova di questa “patologia” esistente nel corpo del marxismo, si nota che “nel militante di sinistra non è<br />
raro che si esprima palesemente una certa deviazione mentale. Chi d’altra parte non ha osservato le reazioni tipicamente<br />
da nevrotico dei giovani marxistelli che costituiscono oggi le avanguardie della rivoluzione?” (41). Nella “deviazione” dei<br />
marxisti dai meccanismi normali di pensiero, “Lotta Europea” ravvisa l’impossibilità di un qualsiasi dialogo. “Discutere”<br />
con loro secondo “Lotta Europea” è assurdo perché il loro obiettivo, al di là di ogni logica, è abbattere la società nel senso<br />
fisico del termine. Perciò, più che al dialogo, è quanto mai necessario prepararsi al contrattacco: “da teorie che sono<br />
prassi omicide, come quelle di Marx, rivedute e corrette da buone lane e fini pensatori come Lenin e Stalin, occorre trarre<br />
una logica forza della difesa (. . .). Ci vogliono distruggere come attività fisica, politica, morale, tradizionale?<br />
Impediamolo! (. . .) Vogliono il duello rusticano? Lo abbiano! Ma stabilire un “discorso”, fingere una “discussione”,<br />
giocare una partita insieme a chi gioca con il manifesto e manifestato proposito di barare e di sparare su chi protesta; e<br />
accettare di discutere e di discorrere con chi dice (. . .) di voler mettere alle nostre trippe fuori è da dementi!!!” (42).<br />
Una prova della legittimità di questo profondo, viscerale antimarxismo è la condizione dei dissidenti sovietici. A questo<br />
problema, “Lotta Europea” dedica diversi articoli (43). Si tratta soprattutto di interviste, lettere e testimonianze dirette<br />
del dissenso sovietico (44); di fronte a queste voci, l’antimarxismo non è soltanto una scelta, ma il dovere civile di ogni<br />
società.<br />
d) Il ruolo della cultura di destra<br />
La causa che ha determinato la crisi della società moderna è dunque, secondo l’interpretazione di “Lotta Europea”, la<br />
cultura del progresso, che ha portato con sé materialismo e annientamento dei valori spirituali. In questa situazione, c’è<br />
un’unica via d’uscita: il recupero della cultura di destra, la sola in grado di porre argine alla crisi dilagante. L’appello alla<br />
Luciano Buonocore – La Maggioranza Silenziosa e il Progetto Tecnocratico 45
cultura di destra è necessario e inevitabile, nel momento in cui sia la sinistra, sia il centro non sono capaci di offrire validi<br />
riferimenti culturali. Infatti, da un lato, secondo “Lotta Europea”, i fallimenti del centro-sinistra non segnarono soltanto<br />
la crisi di un certo disegno politico, ma una globale incapacità di fornire risposte adeguate alle moderne esigenze della<br />
società. Dall’altro, la Chiesa cattolica stessa, avvilendo la sua funzione, “lasciando spegnere ogni impeto mistico e<br />
contemplativo, ogni impulso all’intransigenza assoluta contro le forze materialistiche”, non riesce a soddisfare la “sfera<br />
spirituale” moderna (45). Ecco allora che si crea lo spazio per la cultura di destra: “mentre le forze di sinistra e di centro<br />
vanno infilandosi in un vicolo cieco, parallelamente sta prendendo forma e sostanza una nuova destra che, per la prima<br />
volta in questo dopoguerra, si è ritrovata e ha avuto il coraggio di riconoscersi come tale, ed anzi ne ha tratto titolo di<br />
vanto “(46).<br />
L’anima della cultura di destra è, secondo “Lotta Europea”, il tradizionalismo, che non è una ideologia come tante, ma è<br />
concepita come qualcosa di assai più profondo: E’ “la voce stessa della esigenza fondamentale e insopprimibile dell’essere<br />
umano; l’esigenza della spiritualità”(47), motore immobile del tutto, ente metafisico e sovrarazionale. Solo il<br />
tradizionalismo della cultura di destra è in grado di ridare ad ogni singolo uomo il senso perduto di una certezza<br />
interiore. Gli ideali verso cui la cultura di destra inneggiata da “Lotta Europea” conduce sono l’Onore, la Religione, la<br />
Famiglia, il Lavoro, lo Stato, la Tradizione, al di sopra del contingente e del materiale. Ma soprattutto, la destra intende<br />
propugnare un nuovo Ordine Sociale facendo leva su diverse modalità di partecipazione: “Se l’attuale sistema demoparlamentare<br />
esplode, noi crediamo nella Corporazione, se il mondo del lavoro è in continuo fermento noi proponiamo la<br />
socializzazione, se taluni professano utopie internazionalistiche, noi ci battiamo per l’idea Nazione: se l’anarchia<br />
distrugge ogni cosa, noi vogliamo riedificare lo Stato”(48).<br />
Corporativismo, socializzazione dei mezzi di produzione e idea di nazione sono quindi i perni su cui si fonda il sistema<br />
di valori proposto da “Lotta Europea”. Essi sono da sempre nella storia delle principali caratteristiche di tutte le correnti<br />
culturali della destra. Costituendo questi valori una sorta di “ponte” gettato alle spalle, il richiamo al passato diventa<br />
tappa obbligatoria. Non si tratta di espliciti riferimenti all’organizzazione cultura politica e sociale del fascismo storico,<br />
ma piuttosto all’esperienza della RSI(49). Con particolare riferimento alla socializzazione dei mezzi di produzione, si<br />
afferma infatti sulla rivista che già il dodicesimo punto del Manifesto di Verona sanciva la partecipazione di tutti i<br />
lavoratori alla gestione della aziende (50). Inoltre, il richiamo al passato, per quanto caro, è ritenuto un momento<br />
importante per il recupero dei valori umani: “la sinistra è utopia, la destra è realtà” – leggiamo ancora su “Lotta Europea”<br />
– realtà che (. . .) affonda le sue radici nell’esperienza di un passato che non può e non deve essere ripristinato, ma al<br />
quale bisogna fare riferimento per staccarsi una volta per sempre da ciò che rappresenta il contingente, per attualizzare<br />
infine ciò che rimane valido”(51).<br />
Infine, una precisazione. Mentre, come abbiamo visto precedentemente nei primi documenti, il C.C.A. rivendicava la<br />
sua identità “borghese” (52), gli autori della rivista rifiutavano questa etichetta (53). Essi infatti si pongono in una ottica<br />
che supera la dicotomia comunista/borghese, che è la restrittiva logica a due valori (o comunista o borghese) imposta<br />
dall’avversario di sinistra. L’uomo di destra, cadendo in questo “trabocchetto dei comunisti” si è spesso erroneamente<br />
autodefinito “borghese” (54): In realtà il vero uomo di destra, secondo “Lotta Europea” deve porsi al di là di questa fittizia<br />
opposizione, perché “essere di destra” designa il patrimonio interiore di una persona, mentre i termini “borghese” e<br />
“proletario”, in questo senso equivalenti, “rispecchiano in essenza il momento mercantilistico ed economistico della vita,<br />
che se preso assolutisticamente, è l’antitesi della vera destra, elemento prettamente spirituale e metaeconomico nei suoi<br />
principi basilari”(55). La destra, quindi, prima che un sistema organico di concetti o una definitiva linea politica, è uno<br />
“stato interiore”, “una scelta aristocratica, cioè nobiltà spirituale”(56).<br />
e) La scuola e la contestazione<br />
Nella generale crisi di ideali e di strutture che ha colpito la società, “Lotta Europea” ravvisa, in primo piano, la crisi delle<br />
istituzioni scolastiche. I primi autori dell’attacco alla scuola sono stati i numerosi professori marxisti, come Dal Pra,<br />
Geymonat, Salinari ed altri, che hanno introdotto nell’ambiente scolastico i “germi infettivi” di quella crisi che verrà poi<br />
approfondita e allargata dai loro allievi. Sotto la pressione di occulte forze marxiste, è avvenuto l’attacco alla tradizione<br />
umanistica, che è l’essenza stessa della scuola italiana, attacco che si è attuato tramite il “disconoscimento del valore<br />
formativo del latino, la progressiva unificazione e massificazione degli studi primari, la lotta alla selezione e al merito, la<br />
sterile polemica contro il voto, il tentativo insomma di sostituire la quantità alla qualità”(57).<br />
Il colpo finale alla scuola è venuto infine dalla contestazione studentesca, che è stata particolarmente vissuta all’interno<br />
delle strutture universitarie. Episodi di violenza ad opera di “una piccola minoranza di studenti comunisti del<br />
“Movimento Studentesco” paralizzano da anni l’Università Statale di Milano. Il loro capo, Capanna, è la “longa manus del<br />
PCI”, nonostante le apparenti e artificiali discordie che lo dividono da questo”(58). Se da un lato “Lotta Europea”<br />
denuncia questa minoranza di studenti violenti e sovversivi, dall’altro l’accusa viene rivolta anche contro l’abulia e<br />
l’assenteismo di buona parte dei docenti, che non ha saputo impedire che la situazione degenerasse fino a questo punto.<br />
In un articolo firmato da Barazzetti, assistente di analisi all’Università di Milano, si afferma infatti che “con l’aiuto di una<br />
costante tecnica intimidatoria, i docenti sono stati ridotti al silenzio: un silenzio compatto, globale capace di vedere tutto<br />
senza notare nulla”(59). Una grave atmosfera di timore e di inebetimento politico ha compenetrato tutti gli ambienti<br />
scolastici, ha portato al trionfo dell’anarchia dilagante e ha cancellato la dignità di studenti e insegnanti. Secondo<br />
l’interpretazione di “Lotta Europea” tale fenomeno di crisi non è tanto un fatto economico, sociale o politico, quanto una<br />
“questione morale”, o meglio una sorta di “ribellione morale”, che affonda le radici “nel deserto di idee e di sentimenti,<br />
tipico delle società avanzate tecnologicamente”(69). I giovani, cioè, avvertono sensibilmente le profonde contraddizioni<br />
del moderno sistema di vita, talmente lanciato nella corsa al progresso da precludere ogni spazio alle “esigenze interiori”<br />
dell’uomo. La contestazione rappresenta uno degli aspetti più violenti, più disperati della ricerca di un senso da<br />
imprimere alla vita (61). La matrice della contestazione è da cercare nel fallimento delle filosofie (e dei regimi che da esse<br />
Luciano Buonocore – La Maggioranza Silenziosa e il Progetto Tecnocratico 46
traggono ispirazione) “sorte all’insegna dell’uguaglianza, della democrazia, della giustizia, idee correntemente tradite<br />
nella pratica quotidiana del governo”(62).<br />
Di fronte al crollo di questi miti, di fronte alla “inconsistenza ideale” dell’epoca moderna, i giovani hanno reagito con<br />
violenza. La situazione è stata subito strumentalizzata, dalla sinistra, responsabile di aver operato una sistematica<br />
distruzione dei “pilastri spirituali ed esistenziali” sui quali poggiava l’equilibrio dell’individuo. Di fronte a questa<br />
profonda crisi, “Lotta Europea” si propone come difensore della scuola. “Difendere” la scuola non significa soltanto porre<br />
argine alle violenze marxiste, ma soprattutto salvaguardare le istituzioni scolastiche come il luogo privilegiato della<br />
formazione spirituale della nostra civiltà, “il luogo in cui un tempo si forgiavano gli uomini migliori, il luogo che custodiva<br />
e difendeva i valori fondamentali di tutto un mondo che il marxismo sta cercando di abbattere (. . .). Da quando la<br />
sovversione sta trasformando la scuola di tutto ciò rimane ben poco”(63). Per impedire il collasso, la “Maggioranza<br />
Silenziosa” invita i docenti e i professori ad una azione più coraggiosa ed intransigente, senza mai venire a compromessi<br />
con la contestazione. Ma soprattutto, di fronte alla “minoranza comunista” bisogna che la “maggioranza” degli studenti<br />
prenda “coscienza delle proprie possibilità di determinarsi una volta per sempre contro queste minoranze sovversive”.<br />
“Lotta Europea” tende sempre più ad interpretare questa maggioranza di studenti anticomunisti “nella loro lotta per una<br />
rinnovata scuola italiana, libera dai ricatti e dalle minacce del comunismo e dei suoi alleati”(64). Il tipo di cultura<br />
scolastica che “Lotta Europea” propone è un insegnamento che vada oltre un sistema di nozioni definite e numerabili; la<br />
cultura deve essere una “qualità dello spirito” che permetta allo studente la conquista di metodo e di pensiero personale,<br />
che gli renda la mente duttile e aperta, che lo responsabilizzi (65).<br />
f) La religione<br />
Nel quadro di insoddisfazione di apatia, di sgretolamento dei valori, dipinto da “Lotta Europea” con toni cupi e tetri<br />
(66) si colloca inevitabilmente anche la crisi della Chiesa e della fede stessa. In primo luogo, dunque, si parla delle<br />
istituzioni religiose. Il Concilio Vaticano II è visto come il frutto “tardivo ma non meno amaro” di quella “eresia<br />
modernista” che fa capo a Lutero, al “libero esame”, al “tiranno Calvino”; di questa eresia “coloro che furono già<br />
condannati da S. Pio X, combattuti da Benedetto XV, da Pio XI e da Pio XII, sono ora ai vertici della Gerarchia<br />
Ecclesiastica per anzianità, intinti di quella pace: Lutero tedesco come Marx, quindi consequenziale. Lutero, sacerdote<br />
rinnegato, quindi tanto più esperto in menzogna. I vecchi Eretici, dissimulati, ma non cambiano”(67). La tendenza<br />
all’eresia di chi è ai vertici della Chiesa affiora sempre con più evidenza. Il fatto stesso che la lingua universale della<br />
Chiesa, il latino, “formatore di menti e coscienze”, sia relegato in soffitta testimonia tale propensione (68). Più in<br />
generale, “”Lotta Europea” accusa la Chiesa di esprimersi “ad un mediocre livello parrocchiale, moralistico,<br />
puritaneggiante, mentre nelle Gerarchie non si è capito tutto ciò, o per lo meno non si è fatto nulla per risollevarsi”(69).<br />
In secondo luogo, la crisi investe la fede e il senso religioso di ogni persona. Ciò è dovuto sia al fatto che secolarizzazione<br />
e materialismo avvizziscono la spiritualità dell’uomo e lo rendono incapace di elevarsi ad una “dimensione superiore”; sia<br />
al fatto che la Chiesa non offre un adeguato punto di riferimento. Estromettendo ogni giorno di più il “sacro” della<br />
propria azione, la Chiesa tende infatti ad assumere, secondo “Lotta Europea”, il ruolo di apparato assistenziale a scopi<br />
puramente sociali, quindi materiali. Questa totale assenza del “sacro” caratterizza la crisi che investe il mondo moderno.<br />
L’errore della Chiesa è stato quello di “forzare la modernizzazione e di volersi adeguare ai tempi, pretendendo di mutare<br />
ciò che è per sua stessa natura, eterno e assoluto”(70). Diventando “moderna e permissiva”, la Chiesa è caduta in un<br />
terreno di incertezze, perdendo ogni capacità di dare ai giovani effettivi valori, a cui votarsi e in cui credere.<br />
g) Le scienze<br />
Infine “Lotta Europea” dedica alcuni articoli ad argomenti scientifici. Uno dei temi trattati è l’evoluzionismo. Contro di<br />
esso “Lotta Europea” intraprende una polemica battaglia, definendolo il “nuovo Vangelo” della mentalità sovvertitrice<br />
dell’uomo moderno. Ciò che nelle teorie evoluzionistiche “Lotta Europea” condanna è la fondamentale matrice<br />
materialistica, dal momento che secondo tali teorie l’uomo sarebbe l’ultimo prodotto di una lunga metamorfosi secondo<br />
una serie di passaggi che avvengono “per semplici diversità di combinazioni quantitative dettate ora dall’ambiente ora dal<br />
caso, a seconda della teorie (71), al di fuori di un reale ordine divino”(72).<br />
Proprio in questa assenza di un principio sovrumano, “Lotta Europea” ravvisa la prova della “stortura mentale”<br />
dell’uomo moderno. Perdendo la capacità di vivere la dimensione metafisica e religiosa della conoscenza, la sete di sapere<br />
dell’uomo di oggi ha preso un indirizzo materiale, legato esclusivamente al sensibile e all’empirico. “Eliminata la validità<br />
delle conoscenze metafisiche e religiose che affermano la sostanziale parentela uomo-Dio – si legge sulla rivista – agli<br />
occhi dell’uomo è apparsa solo la scienza nelle sue varie specializzazioni, come unico mezzo per spiegare la realtà”(73).<br />
Un altro aspetto della scienza che “Lotta Europea” confuta è il concetto di caso, presente nelle teorie evolutive come la<br />
“mutazione genetica casuale” che permette l’evoluzione della stessa specie. La dimostrazione “scientifica” con cui la<br />
casualità viene rifiutata è che “c’è troppa complessa perfezione in una cellula, in un fiore, in un uomo, per pensare che il<br />
caso possa esserne l’artefice”(74). Infatti per arrivare all’universo attuale sarebbe stato necessario un altissimo numero di<br />
eventi casuali (tenendo anche presente che alcuni possono provocare “effetti negativi”, da correggere poi con altri eventi<br />
casuali). “In totale questi eventi raggiungerebbero un numero talmente grande che, la statistica ce lo insegna, la<br />
probabilità che essi siano potuti accadere in tale ordine è zero”(75). Quindi ogni teoria basata sul caso non è degna di<br />
fede; essa fa parte di un piano con cui si vuol distruggere tutto ciò che è Trascendenza, Fede, Tradizione e Legge, per far<br />
spazio soltanto alla scienza materialistica.<br />
Infine, un argomento scientifico trattato da “Lotta Europea” è la medicina. In un articolo non firmato troviamo<br />
affermazioni interessanti, per quanto sconcertanti. Anche la medicina attuale è attaccata da “Lotta Europea” come il<br />
frutto del materialismo moderno che ha reso l’uomo incapace di cogliere la natura nella sua complessità. La medicina<br />
Luciano Buonocore – La Maggioranza Silenziosa e il Progetto Tecnocratico 47
moderna, infatti studia l’organismo umano suddividendo le sue parti fino alla dimensione microscopica, “sul presupposto<br />
che, per studiare un fenomeno vitale, si debba sempre risalire alle più fini strutture della materia, con la convinzione che<br />
solo a questo livello sia possibile una spiegazione della natura”(76). L’antica medicina cinese, del resto, è riuscita a creare<br />
un efficace metodo terapeutico, l’agopuntura, partendo da principi generali metafisici. Questo esempio dimostra come sia<br />
possibile “costruire una ottima medicina senza bisogno di conoscere non soltanto le strutture microscopiche, ma neppure<br />
l’anatomia macroscopica”(77).<br />
NOTE<br />
(N.B.: Le seguenti NOTE sono quelle parziali del Cap. “La battaglia giornalistica di “LOTTA EUROPEA”.<br />
Prossimamente verranno inserite le restanti – N.d.R.)<br />
(1) Il nostro impegno, Lotta Europea, 1, 1972.<br />
(2) Ibidem.<br />
(3) Lotta Europea rivista della Maggioranza Silenziosa, manifesto murale, s.d. (1972), firmato Lotta Europea.<br />
(4) Nel corso dei due anni, infatti, nelle linee programmatiche della rivista, non si notano mutamenti importanti.<br />
(5) Cfr. F. MAR., la crisi dei partiti politici, Lotta Europea, 1, 1972.<br />
(6) A. DEGLI OCCHI, I politici, Lotta Europea, 4/5, 1972.<br />
(7) Cfr. R. MENONI, Della politica: ovvero il gioco del potere, Lotta Europea, 6/7, 1972.<br />
(8) L. BUONOCORE, il vero volto del Centro Sinistra, Lotta Europea, 13/14, 1973.<br />
(9) Lotta Europea attribuisce al PCI la paternità diretta sia delle azioni delle Brigate Rosse, sia della “strategia della<br />
tensione”. Secondo la rivista, infatti, la “strategia della tensione” “serve a far cadere il governo Andreotti per<br />
dimostrare che è impossibile nel nostro Paese governare senza il PSI e contro il PCI”. Cfr. L. BUONOCORE, la<br />
strategia della tensione, Lotta Europea, 8/9, 1973, ed anche Id., l’Aventino dei partiti anticomunisti, Lotta<br />
Europea, 15/16, 1974.<br />
(10) L. BUONOCORE, L’Aventino dei partiti anticomunisti, Lotta Europea, 15/16, 1974.<br />
(11) Per questo argomento, vedere cap. VI.<br />
(12) A. DEGLI OCCHI, Tecnica del sistema, Lotta Europea, 15/16, 1974.<br />
(13) A. DEGLI OCCHI, La congiura degli Empi, Lotta Europa, 1, 1972.<br />
(14) F. STENI, I lavoratori contro i sindacati, Lotta Europea, 1, 1972.<br />
(15) F. MAR, Sindacati: i veri padroni d’Italia, Lotta Europea, 10, 1973.<br />
(16) M. TULLIO, attualità del sistema corporativo, Lotta Europea, 2, 1972.<br />
(17) Lo Stato organico-corporativo, Lotta Europea, 4/5, 1972.<br />
(18) Ibidem.<br />
(19) Ibidem.<br />
(20) In previsione dell’appuntamento elettorale del 1972, in febbraio i monarchici di Covelli si unirono all’MSI,<br />
dando vita alla nuova etichetta MSI-<strong>Destra</strong> Nazionale. Cfr. P.ROSENDAUM, Il nuovo fascismo da Salò ad<br />
Almirante. Storia del MSI, Milano, Feltrinelli, 1975, pg.141.<br />
(21) A. RENDINE, Per un fronte articolato anticomunista, Lotta Europea, 3, 1972.<br />
(22) Ibidem.<br />
(23) G. DAVOLI, per la rinascita d’Europa, Lotta Europea, 2, 1972.<br />
(24) Ibidem.<br />
(25) Oltre il capitalismo e il comunismo, Lotta Europea, 3, 1972.<br />
(26) Su questo argomento, vedere il concetto del “corporativismo” nel paragrafo precedente.<br />
(27) L’applicazione della ideologia nazionalistica alla dimensione europea è una posizione tipica del “cosmo nero”. A<br />
questo proposito, vedere volantini di “Riscossa”, dell’”ANSAN-Giovane Italia”, dei “Giovani del MSI”; ed anche<br />
gli articoli di A. ROMUALDI sulla rivista “La <strong>Destra</strong>”, e di P. RAUTI su “Riscossa” (in particolare sono<br />
interessanti gli articoli di Romualdi sul “nazionalismo europeo”, dove ritroviamo concetti simili a quelli esposti<br />
da “Lotta Europea”). Cfr. L. V. MAJOCCHI, (a cura di), Rapporto sulla violenza fascista in Lombardia, cit., pg.<br />
155-197.<br />
(28) G. DAVOLI, Per la rinascita dell’uomo europeo, Lotta Europea, 4/5, 1972.<br />
(29) Ibidem.<br />
(30) L. BUONOCORE, Aspetti di una strategia, Lotta Europea, 1, 1972.<br />
(31) R.TAJANI, L’uomo.<br />
Luciano Buonocore – La Maggioranza Silenziosa e il Progetto Tecnocratico 48