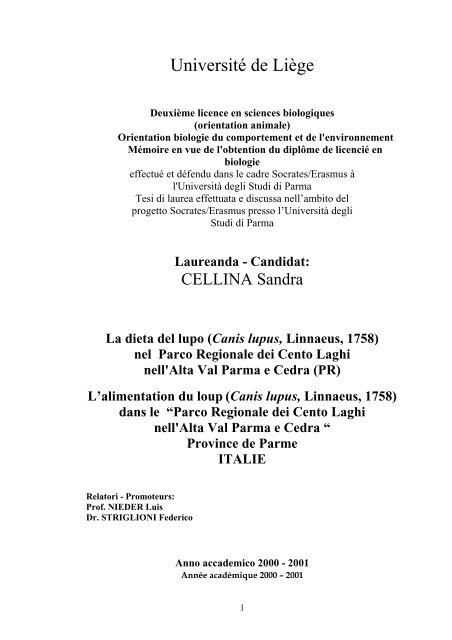La dieta del lupo (Canis lupus) nel Parco dei Cento Laghi
La dieta del lupo (Canis lupus) nel Parco dei Cento Laghi
La dieta del lupo (Canis lupus) nel Parco dei Cento Laghi
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Université de Liège<br />
Deuxième licence en sciences biologiques<br />
(orientation animale)<br />
Orientation biologie du comportement et de l'environnement<br />
Mémoire en vue de l'obtention du diplôme de licencié en<br />
biologie<br />
effectué et défendu dans le cadre Socrates/Erasmus à<br />
l'Università degli Studi di Parma<br />
Tesi di laurea effettuata e discussa <strong>nel</strong>l’ambito <strong>del</strong><br />
progetto Socrates/Erasmus presso l’Università degli<br />
Studi di Parma<br />
<strong>La</strong>ureanda - Candidat:<br />
CELLINA Sandra<br />
<strong>La</strong> <strong>dieta</strong> <strong>del</strong> <strong>lupo</strong> (<strong>Canis</strong> <strong>lupus</strong>, Linnaeus, 1758)<br />
<strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> Regionale <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
<strong>nel</strong>l'Alta Val Parma e Cedra (PR)<br />
L’alimentation du loup (<strong>Canis</strong> <strong>lupus</strong>, Linnaeus, 1758)<br />
dans le “<strong>Parco</strong> Regionale <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
<strong>nel</strong>l'Alta Val Parma e Cedra “<br />
Province de Parme<br />
ITALIE<br />
Relatori - Promoteurs:<br />
Prof. NIEDER Luis<br />
Dr. STRIGLIONI Federico<br />
Anno accademico 2000 - 2001<br />
Année académique 2000 – 2001<br />
1
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
Una particolare menzione per il prezioso aiuto e la pazienza<br />
spetta a Prof. Poulicek Mathieu Coordinateur Erasmus<br />
Biologie à lULg, Mme D’Arripe du Service Erasmus de<br />
l’ULg, Prof. Bedulli Daniele Coordinateur UniPr, Mme<br />
Hansen vum CPOS/CEDIES Lëtzebuerg<br />
Relatori Prof. Luis Nieder e Dr. Federico Striglioni: grazie<br />
per avermi assistito <strong>nel</strong> mio marathon-sprint, soprattutto<br />
queste ultime settimane (anche se con il gesso è un po’più<br />
difficile ;-))<br />
Grazie <strong>La</strong>ura per la collaborazione e le ricerche che avevi<br />
già prestabilito da settembre 2000.<br />
Ringrazio Christian, Giovanni (anche per il Teerink!) e Dr.<br />
Filippo per aver reso possibile la raccolta <strong>del</strong>le fatte e per i<br />
loro preziosi suggerimenti.<br />
Prof.ssa Cinquetti e Prof. Triulzi per avermi lasciato usare<br />
gli indispensabili microscopio e forno.<br />
Ringraziamenti a Gianna e Licia per consigli e correzioni,<br />
Marcello, Valentina, e Tom, fa bene avere un caro amico.<br />
Merci à celles qui me sont restées proches (via e-mail) pour<br />
me tenir informée des choses qui se sont passées à Liège…<br />
Villmools Merci Noi, dats de den Jammy versuergt hues!<br />
An, Thier, mär gin däfnetli een huelen!<br />
Mengen Elteren en groussen Merci fier hier Ënnerstëtzung<br />
E finalmente, grazie a Titti per il tuo campione di peli!<br />
2
Indice<br />
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
1 Introduzione p 1<br />
2 Distribuzione, stato <strong>del</strong>l’arte e conservazione <strong>del</strong> Lupo p 2<br />
2.1 L'evoluzione <strong>del</strong>la distribuzione <strong>del</strong> Lupo in Europa<br />
2.2 L'evoluzione <strong>del</strong>la distribuzione <strong>del</strong> Lupo in Italia<br />
2.3 L'evoluzione <strong>del</strong>la ricerca sul Lupo in Italia<br />
2.4 Status<br />
3 Caratteristiche generali <strong>del</strong> Lupo p 7<br />
3.1 Morfologia<br />
Peso e dimensioni<br />
Colorazione<br />
3.2 Alimentazione<br />
3.3 Habitat<br />
3.4 Sistematica<br />
4 Area di studio p 10<br />
4.1 Il <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
4.2 Geomorfologia<br />
4.3 Clima<br />
4.4 Aspetti vegetazionali<br />
4.5 Composizione <strong>del</strong>la comunità teriologica<br />
5 Materiali e metodi p 15<br />
5.1 Analisi <strong>del</strong>la <strong>dieta</strong><br />
5.1.1 Analisi degli escrementi<br />
A- Raccolta <strong>dei</strong> campioni<br />
B- Selezione <strong>dei</strong> campioni<br />
C- Preparazione <strong>dei</strong> campioni<br />
C 1 Essiccazione <strong>dei</strong> campioni<br />
C 2 Conservazione <strong>dei</strong> campioni<br />
3
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
C 3 <strong>La</strong>vaggio<br />
C 4 Separazione <strong>dei</strong> materiali organici indigesti<br />
D-Identificazione <strong>dei</strong> componenti<br />
E-Stima <strong>del</strong> volume relativo <strong>dei</strong> componenti nei campioni<br />
5.1.2 Resti di predazione<br />
5.2 Censimento <strong>del</strong> Lupo<br />
E 1 Percentuale di frequenza di comparsa<br />
E 2 Volume percentuale relativo<br />
5.2.1 Censimento <strong>del</strong> Lupo su neve<br />
A- Descrizione <strong>del</strong>la tecnica<br />
B- Impronte<br />
C- Applicazione <strong>del</strong> metodo<br />
5.2.2 L'ululato come strumento di censimento <strong>dei</strong> lupi (wolf-howling)<br />
Applicazione <strong>del</strong> metodo<br />
5.3 Censimenti degli ungulati<br />
A- Metodo d'indagine<br />
B- Applicazione <strong>del</strong> metodo<br />
6 Risultati p 43<br />
6.1 Analisi <strong>del</strong>la <strong>dieta</strong><br />
6.1.1 Analisi degli escrementi<br />
6.1.2 Resti di predazione<br />
6.2 Censimenti <strong>del</strong> Lupo<br />
6.2.1 Censimenti su neve<br />
6.2.2 Ululati<br />
6.3 Censimenti degli ungulati<br />
7 Discussione p 60<br />
8 Conclusioni p 63<br />
9 Bibliografia p 64<br />
4
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
1 Introduzione<br />
Dall’autunno 1999 fino alla primavera 2001, <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> Regionale <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong><br />
<strong>La</strong>ghi, è stato condotto dal Dipartimento di Biologia Evolutiva e Funzionale<br />
<strong>del</strong>l’Università di Parma, il progetto “Carnivori”. Questa ricerca intendeva dare un<br />
contributo alla conoscenza <strong>del</strong>lo status <strong>dei</strong> piccoli carnivori (Mustelidi) e <strong>del</strong> Lupo<br />
<strong>nel</strong> territorio <strong>del</strong> pre-parco e <strong>del</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi.<br />
Dopo aver accertato la presenza <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi attraverso<br />
diverse tecniche di censimento, ci si è posti l’obiettivo di approfondire alcuni aspetti<br />
<strong>del</strong>la sua ecologia. Il presente studio è il primo lavoro scientifico con l’obiettivo di<br />
fornire una base di conoscenze sulla presenza e l’alimentazione <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong><br />
<strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi.<br />
Lo studio è stato realizzato <strong>nel</strong>l’ambito di uno scambio Socrates/Erasmus tra<br />
l’Università di Liegi in Belgio e l’Università degli Studi di Parma in Italia.<br />
Il tempo per effettuare la ricerca è stato molto limitato: meno di sei mesi, dalla<br />
raccolta <strong>dei</strong> primi dati fino alla presentazione <strong>del</strong> lavoro, con quattro mesi di raccolta<br />
e un mese di analisi.<br />
Proprio per questo motivo, <strong>nel</strong>la stesura <strong>del</strong> presente lavoro, sono anche stati<br />
utilizzati dati rilevati precedentemente per il progetto “Carnivori”.<br />
<strong>La</strong> conoscenza <strong>del</strong>la <strong>dieta</strong> <strong>del</strong> Lupo è un fattore molto importante per coloro che sono<br />
preposti alla gestione (anche venatoria) <strong>del</strong>la popolazione di ungulati sottoposta alla<br />
predazione da parte di questo Carnivoro.<br />
Ma la conoscenza <strong>del</strong>la <strong>dieta</strong> <strong>del</strong> <strong>lupo</strong> riveste un’importanza fondamentale<br />
soprattutto per la popolazione locale, legata ancor oggi ad una percezione fantastica e<br />
mitologica di questo grande predatore e non ad una conoscenza reale <strong>del</strong>l’animale<br />
che, dopo un lungo periodo di assenza, è ormai tornato sui monti emiliani.<br />
1
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
2 Distribuzione, stato <strong>del</strong>l’arte e conservazione <strong>del</strong> Lupo<br />
2.1 L'evoluzione <strong>del</strong>la distribuzione <strong>del</strong> Lupo in Europa<br />
Il Lupo è una tipica specie legata agli ecosistemi forestali, la cui area di<br />
diffusione è diminuita dopo la riduzione <strong>del</strong>le aree boschive e <strong>del</strong> numero di ungulati<br />
selvatici. <strong>La</strong> persecuzione sistematica che ha subito ne ha accelerato l'estinzione<br />
(Okarma 1995).<br />
Nel diciottesimo secolo, l'uomo ha provocato l'estinzione <strong>del</strong> Lupo in Gran Bretagna,<br />
Irlanda, e in diverse regioni <strong>del</strong>l'Europa centrale e settentrionale.<br />
Nell'Europa occidentale e meridionale, i lupi vivono in condizioni ecologiche<br />
degradate, a causa <strong>del</strong>la distruzione degli habitat e <strong>del</strong>la ridotta densità di ungulati; in<br />
tali circostanze spesso, sono sopravissuti grazie a risorse trofiche di origine<br />
antropica, quali bestiame domestico e rifiuti di discariche non gestite.<br />
Negli anni sessanta, la distribuzione <strong>del</strong> Lupo era limitata a piccole popolazioni in<br />
Portogallo, Spagna, Italia, Grecia, Ex-Yugoslavia e Scandinavia; consistenti<br />
popolazioni di Lupo erano ancora presenti solo in Europa orientale.<br />
Oggi, partendo da questi nuclei, il Lupo sta ricomparendo in Francia, Germania,<br />
Svizzera e Repubblica Ceca, grazie alla sua plasticità ecologica e comportamentale,<br />
all'emanazione di norme di protezione <strong>del</strong>la specie, al progressivo abbondano<br />
<strong>del</strong>l'allevamento e <strong>del</strong>l'agricoltura montana e pedemontana e all'incremento di molte<br />
specie di ungulati selvatici (Genovesi e Dupré 2000).<br />
2.2 L'evoluzione <strong>del</strong>la distribuzione <strong>del</strong> Lupo in Italia<br />
Ampiamente diffuso sull'intera penisola fino alla metà <strong>del</strong> secolo scorso<br />
(Brunetti 1984, in Boitani 1992), la scomparsa <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong>la maggior parte <strong>del</strong>l'arco<br />
Alpino risale alla fine <strong>del</strong> 1800, fino ad arrivare all'uccisione <strong>del</strong>l'ultimo esemplare<br />
<strong>nel</strong>le Alpi Piemontesi avvenuta all'inizio <strong>del</strong> '900.<br />
In Sicilia, il Lupo è stato sterminato dopo la Seconda Guerra Mondiale; l'ultimo<br />
gruppo sopravissuto fu eliminato, infatti, negli anni ’50.<br />
Il Lupo non è mai stato presente in Sardegna (Boitani 1992).<br />
Prima degli anni settanta, il numero e la distribuzione <strong>dei</strong> lupi <strong>nel</strong>l'Appennino non<br />
erano conosciuti. Stime sommarie sul numero di esemplari presenti, effettuate da<br />
Simonetta (1968, 1971) e Tassi (1971) riportano una consistenza di 200-300 lupi.<br />
2
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
Nei primi anni settanta l'area di distribuzione <strong>del</strong> <strong>lupo</strong> in Italia appariva frammentata<br />
e limitata a pochi comprensori montani localizzati <strong>nel</strong>le aree più impervie<br />
<strong>del</strong>l'Appennino centrale e meridionale (Ziemen e Boitani 1975).<br />
<strong>La</strong> specie è attualmente distribuita sull'intera catena appenninica, dall'Aspromonte<br />
fino alle Alpi Marittime (Ciucci e Boitani 1998a); l'espansione settentrionale<br />
<strong>del</strong>l'areale <strong>del</strong> Lupo ha recentemente comportato l'inizio <strong>del</strong>la ricolonizzazione<br />
<strong>del</strong>l'arco alpino occidentale (Alpi Marittimi), con nuclei stabili in Francia fin dal<br />
1992 (Poulle et al. 1997).<br />
Considerando il processo di espansione <strong>del</strong>la specie, osservato negli ultimi anni<br />
lungo la catena appenninica è probabile, <strong>nel</strong> immediato futuro, una graduale<br />
ricolonizzazione <strong>del</strong>le Alpi <strong>del</strong>la parte <strong>del</strong> Lupo (Ciucci e Boitani 1998a).<br />
È utile precisare che in Europa, Italia inclusa, non sono mai stati pianificati né<br />
effettuati interventi di reintroduzione, ripopolamento o introduzione di lupi in<br />
ambiente selvatico. Il recente processo d'espansione <strong>del</strong>la specie in Italia è il risultato<br />
di una serie di fattori di natura storica, ecologica e di conservazione che hanno<br />
cambiato la situazione ambientale in Italia, e ai quali il Lupo si è facilmente adattato<br />
(Ciucci e Boitani 1998b).<br />
3
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
Areale di distribuzione <strong>del</strong> Lupo in Italia<br />
Nel 1973 – linea near (Ziemen e Boitani 1975)<br />
Nel 1998 – retinato (Corsi et al. 1999)<br />
4
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
2.3 L'evoluzione <strong>del</strong>la ricerca sul Lupo in Italia<br />
Nel 1970 il Lupo non era ancora stato studiato in modo scientifico in Italia;<br />
esistevano solo pochi articoli che avvertivano <strong>del</strong>la possibilità <strong>del</strong>l'estinzione di<br />
questa specie che era ancora ampiamente cacciata e stava sopravvivendo solo in<br />
ambiente montano.<br />
Nel 1972, il World Wildlife Fund (WWF) lanciava una ricerca con l'obiettivo di<br />
capire lo status reale <strong>del</strong> Lupo in Italia e i mezzi per assicurare la sua conservazione.<br />
Alla fine <strong>del</strong> 1973 iniziò un altro progetto articolato <strong>nel</strong>le seguenti fasi:<br />
• uno studio intenso <strong>del</strong>la biologia <strong>del</strong> Lupo;<br />
• la reintroduzione di caprioli e cervi - le prede selvatiche <strong>del</strong> Lupo - in aree<br />
selezionate per la presenza <strong>del</strong> Lupo;<br />
• una vasta campagna di educazione, informazione e attività di relazione<br />
pubblica per cambiare la percezione <strong>del</strong> pubblico nei confronti <strong>del</strong> Lupo.<br />
I censimenti su neve evidenziavano la presenza costante <strong>dei</strong> lupi vicino ai<br />
paesi e alle discariche durante il periodo invernale; la maggior parte <strong>del</strong>le orme<br />
rilevate apparteneva, infatti, a singoli animali o a coppie: questo indicava, sia la<br />
chiara differenza tra i lupi italiani e quelli <strong>del</strong>l'America <strong>del</strong> Nord, dove erano stati<br />
effettuati la maggior parte degli studi, sia gli adattamenti <strong>del</strong> Lupo alle particolari<br />
condizioni ambientali italiane.<br />
Le dimensioni <strong>dei</strong> territori variavano tra 200 e 400 km². L'attività era esclusivamente<br />
notturna e dipendeva <strong>del</strong>la durata dalla luce <strong>del</strong> giorno. I movimenti si limitavano a<br />
uno spostamento da una tranquilla zona di foresta alle discariche vicino ai paesi,<br />
dove il Lupo trovava all'epoca dal 60% al 70% <strong>del</strong> suo cibo (Boitani 1992).<br />
Meriggi et al. (1991) hanno contribuito all'acquisizione di dati sul uso <strong>del</strong> habitat e<br />
sulla <strong>dieta</strong> in Appennino settentrionale; Mattioli et al. (1996) si sono in fine<br />
interessati <strong>del</strong>le abitudini alimentari <strong>del</strong> Lupo in relazione alla disponibilità degli<br />
ungulati <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> Nazionale <strong>del</strong>le Foreste Casentinesi. Successivamente, dati<br />
importanti sulle dimensioni <strong>del</strong> home-range e sui ritmi di attività sono stati ottenuti in<br />
Abruzzo da Ciucci et al. (1997).<br />
I problemi maggiori esistenti all'epoca tra il Lupo e il suo ambiente sono gli stessi<br />
identificabili oggi:<br />
5
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
la persecuzione diretta a cui il Lupo è sottoposto per limitare la predazione sul<br />
bestiame domestico, la competizione con i cani ed il possibile incrocio tra lupi e<br />
questi ultimi, la disponibilità di cibo e di habitat (Boitani 1992).<br />
2.4 Status<br />
<strong>La</strong> CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of the<br />
Wild Fauna and Flora) include il Lupo <strong>nel</strong>l’Appendice II (04/02/1977) per tutti paesi<br />
firmatari e <strong>nel</strong>l’Appendice I per le popolazioni di Bhutan, India, Nepal e Pakistan<br />
(28/06/1979) (CITES 2001, Ciucci e Boitani 1998a).<br />
L’Unione internazionale per la conservazione <strong>del</strong>la Natura e <strong>del</strong>le Risorse<br />
Naturali (IUCN) include il Lupo come specie “Vulnerabile” <strong>nel</strong>la Lista Rossa (MSW<br />
1993).<br />
In Italia, la specie è stata legalmente cacciata fino al 23 luglio 1971, data in<br />
cui con Decreto Ministeriale <strong>del</strong> Ministro <strong>del</strong>l'Agricoltura e <strong>del</strong>le Foreste veniva<br />
temporaneamente vietata la caccia alla specie. Nel 1973, un secondo Decreto vietava<br />
la caccia per altri tre anni. Il 22 novembre 1976, un terzo decreto dichiarò la specie<br />
protetta permanentemente e rese illegale l'uso di esche avvelenate.<br />
Le Leggi nazionali 968/77 e 157/92 hanno definitivamente dichiarato il Lupo specie<br />
pienamente e particolarmente protetta (Ciucci e Boitani 1998a).<br />
Con questa legge e grazie all'aumento degli ungulati selvatici ed alla crescente<br />
tolleranza <strong>del</strong>l'uomo nei confronti <strong>del</strong> Lupo è ipotizzabile che la specie possa, in<br />
futuro, ricolonizzare la sua originale area (Corsi et al. 1999).<br />
Nonostante il regime di protezione, dal 1984 al 1990, in Italia sono stati raccolti 60<br />
animali morti, di questi il 46,7 % è stato ucciso con arma da fuoco, mentre il 25 % è<br />
stato avvelenato (Guberti e Francisci 1991).<br />
6
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
3 Caratteristiche generali <strong>del</strong> Lupo<br />
3.1 Morfologia<br />
Peso e dimensioni<br />
In Italia, il peso <strong>del</strong> Lupo oscilla in media tra 25 e 35 kg per i maschi adulti,<br />
non superando valori massimi di 40-45 kg. Le femmine sono leggermente ridotti d<br />
dimensioni e peso rispetto ai maschi..<br />
<strong>La</strong> lunghezza di un adulto va da circa 110 a 148 cm, dalla testa alla base <strong>del</strong>la coda,<br />
la quale misura in media circa 30-35 cm e comunque meno di un terzo <strong>del</strong>la<br />
lunghezza <strong>del</strong> corpo. L'altezza al garrese varia tra 50 e 70 cm. Le orecchie sono a<br />
base larga e misurano da 10 a 11 cm, con un ridotto margine di variabilità.<br />
<strong>La</strong> corporatura <strong>del</strong> Lupo appare s<strong>nel</strong>la e robusta con arti relativamente lunghi, torace<br />
possente, fianchi stretti, testa larga, muso ampio e appuntito, collo corto e robusto.<br />
<strong>La</strong> formula dentaria è I 3/3, C 1/1, P 4/4, M 2/3. Nei cuccioli, la dentatura definitiva<br />
rimpiazza quella da latte tra la 16a e la 26a settimana di vita (Ciucci e Boitani<br />
1998a).<br />
Colorazione<br />
<strong>La</strong> colorazione <strong>del</strong> Lupo in Italia è prevalentemente grigio-fulva, con tonalità<br />
tendenti al marrone-rossiccio più tipicamente durante i mesi estivi. Bandeggi scuri<br />
tendenti al nero sono particolarmente evidenti <strong>nel</strong>la regione dorsale, sulla punta <strong>del</strong>la<br />
coda e <strong>del</strong>le orecchie e, spesso, lungo gli arti anteriori. Le zone ventrali e addominali<br />
(incluse le superfici interne degli arti) appaiono più chiare e con tonalità tendenti al<br />
crema, così come l'evidente mascherina facciale che si estende ai lati <strong>del</strong> muso.<br />
Il ricambio <strong>del</strong> pelo si verifica una volta l'anno, con caduta in primavera e ricrescita<br />
<strong>del</strong> pelo invernale già nei primi mesi autunnali.<br />
Dimensioni, peso e colore <strong>del</strong> pelo possono variare significativamente in base<br />
a differenze individuali, all'età, alla stagione, alle condizioni nutritive e di salute<br />
<strong>del</strong>l'individuo (Ciucci e Boitani 1998a).<br />
7
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
3.2 Alimentazione<br />
Il Lupo dimostra un’ecologia alimentare opportunistica non necessariamente<br />
composta solo di carne, ma la sua <strong>dieta</strong> infatti può includere, in misura variabile,<br />
altre categorie alimentari, quali per esempio frutta o rifiuti di origine antropica.<br />
Da studi condotti in Nord America è stato calcolato che un <strong>lupo</strong> in natura consuma in<br />
media 3-5 kg di carne al giorno, anche se gli eventi di predazione si possono<br />
alternarsi frequentemente a estesi periodi di digiuno, lunghi a volte fino a due<br />
settimane (Ciucci e Boitani 1998a).<br />
3.3 Habitat<br />
Grazie alle sue capacità d'adattamento, il Lupo occupa, dopo la volpe che<br />
arriva fin in Africa, l'area di distribuzione più ampia tra i carnivori. Lo possiamo<br />
trovare in tutti i climi estremi: dalle regioni fredde artiche fino ai deserti tropicali e<br />
alle foreste monsoniche <strong>del</strong>l'India, con tutte le transizioni: boschi, foreste, steppe e<br />
lande dalle regioni temperate, dal livello <strong>del</strong> mare fino a più di 5.000 metri<br />
d'altitudine <strong>del</strong> Himalaia (De Beaufort 1987).<br />
3.4 Sistematica<br />
Nel 1921, Altobello, uno zoologo italiano ha pubblicato la descrizione di una<br />
sottospecie distinta per la penisola italiana: <strong>Canis</strong> <strong>lupus</strong> italicus.<br />
Oggi, questa distinzione non può più essere accettata, anche se il Lupo Italiano ha<br />
sviluppato specifici adattamenti ecologici e comportamentali in relazione<br />
all'ambiente particolare d'Italia. Questo dovrebbe essere sufficiente per giustificare<br />
gli sforzi per mantenere l'integrità genetica di questa piccola popolazione (Boitani<br />
1992).<br />
L'analisi <strong>del</strong> DNA mitocondriale di 101 lupi rinvenuti morti in 15 anni ha confermato<br />
la specificità <strong>del</strong> Lupo Italiano che può essere considerato come un ecotipo <strong>del</strong> Lupo<br />
Europeo, dal quale è rimasto isolato per 150-200 anni (Randi 2000).<br />
Dal punto di vista sistematico, il Lupo rappresenta una singola specie (<strong>Canis</strong> <strong>lupus</strong> L.<br />
1758) che appartiene all’ordine <strong>dei</strong> Carnivori, famiglia <strong>dei</strong> Canidi, genere <strong>Canis</strong>.<br />
8
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
Il genere <strong>Canis</strong> (Linnaeus, 1758) comprende:<br />
- il Lupo grigio o comune (<strong>Canis</strong> <strong>lupus</strong>, Linnaeus, 1758);<br />
- il Lupo rosso degli Stati Uniti sud-orientali (<strong>Canis</strong> rufus, Bailey, 1905);<br />
- Lupo d’abissino (<strong>Canis</strong> simensis, Rüppel, 1869);<br />
- il Coyote (<strong>Canis</strong> latrans, Say, 1832);<br />
- gli Sciacalli:<br />
o lo Sciaccallo dorato (<strong>Canis</strong> aureus, Linnaeus, 1758);<br />
o lo Sciaccallo striato (<strong>Canis</strong> adustus, Sundevall, 1847);<br />
o lo Sciaccallo <strong>del</strong>la gualdrappa (<strong>Canis</strong> mesomelas, Schreber, 1755);<br />
- il cane domestico (<strong>Canis</strong> <strong>lupus</strong> familiaris, Wilson e Reeder, 1993),<br />
(FEDERHEN et al. 2001, Ciucci e Boitani 1998a).<br />
Il cane domestico era stato descritto come <strong>Canis</strong> familiaris (Linnaeus, 1758),<br />
ma una recente revisione tassonomica ha riconosciuto che il cane domestico è<br />
una sottospecie <strong>del</strong> Lupo (MSW 1993).<br />
9
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
4 Area di studio<br />
4.1 Il <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
Il <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi occupa un'area di circa 12.600 ettari (8.000 <strong>dei</strong> quali<br />
compresi <strong>nel</strong> pre-parco) nei territori di due Comuni: Corniglio e Monchio <strong>del</strong>le Corti,<br />
in Provincia di Parma. Il <strong>Parco</strong> si trova in un'area di grande interesse naturalistico<br />
comprendente il crinale spartiacque tra il bacino <strong>del</strong> Po e <strong>del</strong> Magra, ed include le<br />
valli <strong>del</strong> Parma e <strong>del</strong> Cedra.<br />
4.2 Geomorfologia<br />
Le tracce di antichi fenomeni glaciali costituiscono l'elemento che<br />
maggiormente caratterizza la morfologia di tutta l'area compresa <strong>nel</strong> parco. Le<br />
evidenze morfologiche sono quasi esclusivamente riferite all'ultimo periodo glaciale,<br />
verificatosi <strong>nel</strong> Pleistocene Superiore, noto col nome di Würm. In particolare sono<br />
riconducibili a <strong>del</strong>le fasi definite stadiali, corrispondenti ad episodiche oscillazioni<br />
positive <strong>del</strong>le masse glaciali <strong>nel</strong> periodo <strong>del</strong> definitivo ritiro. Sulla base <strong>del</strong>le<br />
ricostruzioni i ghiacciai avevano dimensioni piuttosto ridotte e durante la massima<br />
espansione scendevano a quote raramente inferiori ai 1000-900m. Proprio in Val<br />
Parma e Val Cedra abbiamo gli esempi più spettacolari con ghiacciai definiti vallivi<br />
caratterizzati da lingue che si insinuavano <strong>nel</strong> fondovalle anche per alcuni chilometri.<br />
Gli elementi che ricordano maggiormente la presenza <strong>dei</strong> ghiacciai sono i circhi e gli<br />
archi morenici. I circhi sono costituiti da grandi nicchie di forma semicircolare<br />
scavate nei fianchi rocciosi <strong>dei</strong> rilievi, con prevalente esposizione verso N e NE, con<br />
fondo sub-pianeggiante, di solito parzialmente sbarrato verso valle da una soglia<br />
rocciosa sulla quale sono frequentemente depositati materiali detritici. Questi<br />
sbarramenti danno spesso origine a laghi, paludi o torbiere, ambienti che<br />
caratterizzano fortemente tutta l’area <strong>del</strong> <strong>Parco</strong>. Gli archi morenici sono riconoscibili<br />
per la tipica forma ad arco o festone e sono costituiti da depositi glaciali derivanti<br />
soprattutto dai frammenti rocciosi caduti dalle pareti che marginano il ghiacciaio o<br />
strappati dal fondo. <strong>La</strong> disposizione caotica <strong>dei</strong> frammenti rocciosi con grossi massi<br />
assieme a sabbie e limi, è dovuta alla mancanza di selezione granulometrica durante<br />
il trasporto glaciale.<br />
10
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
Il paesaggio di questa zona è caratterizzato anche da fenomeni periglaciali<br />
tipici <strong>dei</strong> climi freddi, dovuti soprattutto all’azione <strong>del</strong> gelo e disgelo, i più antichi<br />
<strong>dei</strong> quali potrebbero essere corrispondenti o immediatamente successivi all’ultima<br />
glaciazione. Tra le varie tipologie geomorfologiche, le più importanti e diffuse sono<br />
sicuramente le cosiddette falde detritiche o “macereti” (Vignali et al. 1998).<br />
4.3 Clima<br />
L’altitudine, l’esposizione prevalente a Nord-Est e l’azione <strong>dei</strong> venti<br />
dominanti, che creano effetti differenti in base alla provenienza, sono i fattori<br />
principali che determinano le peculiari caratteristiche climatiche <strong>del</strong>la zona.<br />
I venti che provengono dall’entroterra parmense portano aria secca e fredda mentre<br />
quelli dal Tirreno, che soffiano da Sud-Ovest, trasportano masse d’aria calda e umida<br />
verso la Pianura Padana. Queste ultime, a causa <strong>del</strong>la obbligatoria risalita lungo il<br />
versante sud-occidentale <strong>del</strong>l’Appennino, provocano copiose precipitazioni di tipo<br />
orografico durante tutto l’anno. Le rilevazioni <strong>del</strong>la stazione pluviometrica situata<br />
<strong>nel</strong>la Piana di <strong>La</strong>g<strong>dei</strong>, registrano circa 122-123 giorni piovosi l'anno concentrati in<br />
prevalenza nei periodi primaverile e autunnale. Le precipitazioni medie annuali<br />
mantengono valori superiori a 2600 mm. Si hanno inverni lunghi e freddi ed estati<br />
brevi e calde. Se si fa riferimento alla classificazione <strong>del</strong> Koppen, il clima di questa<br />
zona è da definirsi temperato freddo (microtermico) con la temperatura media <strong>del</strong><br />
mese più freddo (gennaio) inferiore a –3°C e la temperatura media <strong>del</strong> mese più<br />
caldo (luglio) superiore a 10°C (Vignali et al. 1998).<br />
11
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
12
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
4.4 Aspetti vegetazionali<br />
Lo stato attuale <strong>del</strong> paesaggio di quest’area è il risultato <strong>del</strong>l’azione<br />
<strong>del</strong>l’uomo che per secoli ha trovato <strong>nel</strong> bosco una fondamentale risorsa. Fino ad<br />
alcuni decenni fa, si potevano vedere solo montagne assolate quasi prive di<br />
vegetazione, con pascoli estesi ovunque si potesse trovare erba da brucare. Oggi, in<br />
varie località, si trovano boschi discretamente sviluppati, ombrosi, a volte<br />
lussureggianti, anche se in varia misura risentono ancora <strong>dei</strong> tagli effettuati alla fine<br />
<strong>del</strong> 1800 e <strong>nel</strong> dopoguerra. Il governo a ceduo portato avanti negli ultimi decenni ha<br />
portato la maggior parte di questi boschi ad essere bassi, radi, giovani, uniformi,<br />
poveri di specie e di suolo.<br />
L’area interessata dalla ricerca è compresa prevalentemente <strong>nel</strong>la zona fredda <strong>del</strong><br />
“Fagetum” che presenta una flora tendenzialmente microterma. <strong>La</strong> presenza di specie<br />
erbacee come Geranium nodosum, Euphorbia dulcis, Melica uniflora, Sanicula<br />
europea, Dryopteris felix-mas, Cardamine bulbifera, Aqsarum europaeum,<br />
Epilobium montanum, Daphne mezzereum, Dentaria digitata, <strong>nel</strong>le aree di preparco,<br />
indica che questi boschi sono di tipo mesofilo.<br />
Al di sopra <strong>del</strong> limite vegetazionale <strong>del</strong> faggio è presente una brughiera subalpina a<br />
mirtilli (Vaccinium sp.) e ginepri (Juniperus nana); inoltre si trovano specie erbacee<br />
come Anemone narcissiflora, Pulsatilla alpina, Pulsatilla montana, Potentilla aurea,<br />
Potentilla reptans, Gentiana campestris, Gentiana cruciata e Trifolium alpinum. In<br />
queste praterie dominano le graminacee come Sesleria sp. e Nardus striata (Vignali<br />
et al. 1998).<br />
4.5 Composizione <strong>del</strong>la comunità teriologica<br />
In studi ulteriori (Nolli 1997, Sicorello 1999, Ferrari 2000) sono stati<br />
segnalati:<br />
- Capriolo (Capreolus capreolus, Linnaeus, 1758);<br />
- Cinghiale (Sus scrofa, Linnaeus, 1758);<br />
- Donnola (Mustela nivalis, Linnaeus, 1766);<br />
- Faina (Martes foina, Erxleben, 1777);<br />
- Martora (Martes martes, Linnaeus, 1758);<br />
- Lepre (Lepus europaeus, Pallas, 1778);<br />
- Lupo (<strong>Canis</strong> <strong>lupus</strong>, Linnaeus, 1758);<br />
13
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
- Puzzola (Mustela putorius, Linnaeus, 1758);<br />
- Riccio (Erinaceus europaeus, Linnaeus ,1758);<br />
- Scoiattolo (Sciurus vulgaris, Linnaeus, 1758);<br />
- Talpe (Talpa ssp., Linnaeus 1758);<br />
- Tasso (Meles meles, Linnaeus, 1758);<br />
- Toporagno d'acqua (Neomys fodiens, Pennant, 1771);<br />
- Volpe ( Vulpes vulpes, Linnaeus, 1758);<br />
Piccoli mammiferi di cui 2 insettivori:<br />
- Toporagno nano (Sorex minutus, Linnaeus, 1766);<br />
- Toporagno comune (Sorex araneus, Linnaeus, 1758);<br />
e 7 roditori:<br />
- Arvicola <strong>del</strong>le nevi (Chionomys nivalis, Martins, 1842);<br />
- Arvicola rossastra (Clethrionomys glareolus, Schreber, 1780);<br />
- Topo selvatico (Apodemus sylvaticus, Linnaeus, 1758);<br />
- Topo selvatico dal collo giallo (Apodemus flavicollis, Melchior, 1843);<br />
- Arvicola di Fatio (Microtus (Pitymys) multiplex, Fatio, 1905);<br />
- Ghiro (Glis glis, Linnaeus, 1766);<br />
- Moscardino (Muscardinus avellanarius, Linnaeus, 1758).<br />
14
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
5 Materiali e metodi<br />
5.1Analisi <strong>del</strong>la <strong>dieta</strong><br />
5.1.1 Analisi degli escrementi<br />
A-Raccolta <strong>dei</strong> campioni<br />
<strong>La</strong> raccolta <strong>del</strong> materiale organico è stata effettuata lungo una rete di sentieri (scat-<br />
trails) segnalati all’interno <strong>del</strong>l'area di studio e che in base ai sopralluoghi<br />
preliminari, risultavano essere utilizzati frequentemente dai lupi. Per rendere più<br />
probabile la raccolta di escrementi, la scelta <strong>dei</strong> percorsi, si è basata sul ritrovamento<br />
di tracce (indicazione <strong>del</strong> passaggio di uno o più lupi) lungo sterrate e sentieri<br />
percorsi durante la stagione invernale.<br />
Tutti gli scat-trails sono stati perlustrati a piedi, eccetto il circuito <strong>del</strong> passo <strong>del</strong>la<br />
Colla, che è stato percorso a bassa velocità, utilizzando un mezzo fuoristrada con due<br />
persone a bordo che controllavano ciascuna il proprio lato <strong>del</strong>la strada.<br />
Le fatte raccolte sono state collezionate, catalogate con un proprio numero<br />
progressivo ed inserite in un sacchetto di plastica, <strong>nel</strong>l’attesa di essere<br />
successivamente analizzate in laboratorio. Ad ogni escremento collezionato, è stata<br />
fatta corrispondere una scheda di raccolta ed una di analisi.<br />
<strong>La</strong> scheda di raccolta ha fornito indicazioni sulle condizioni <strong>del</strong> ritrovamento<br />
<strong>del</strong>l’escremento e sul sito di deposizione. Ad ogni fatta è stata attribuita una<br />
presumibile data di deposizione, in base all’aspetto esteriore, allo stato di<br />
dilavamento e di mucosità, alle condizioni meteorologiche <strong>dei</strong> giorni precedenti il<br />
ritrovamento e alla data <strong>del</strong>l’ultima volta in cui il sentiero era stato percorso.<br />
Sono stati registrati i seguenti dati:<br />
• località di ritrovamento;<br />
• codice/nome <strong>del</strong>lo scat-trail in questione;<br />
• descrizione particolareggiata <strong>del</strong> sito in cui è avvenuta la deposizione, in<br />
modo da favorire il ritrovamento in futuro di altri escrementi, anche da parte<br />
di chi non era presente al momento <strong>del</strong>la raccolta e per raccogliere<br />
informazioni sulle caratteristiche <strong>dei</strong> siti di marcatura.<br />
15
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
Per definire esattamente la localizzazione <strong>del</strong> ritrovamento, per ogni singolo<br />
reperto organico sono state rilevate le coordinate <strong>del</strong> sito di deposizione, tramite il<br />
sistema di coordinate geografiche U.T.M. (Universale Trasversa di Mercatore) su<br />
carte topografiche (Carta Tecnica Regionale) in scala 1: 10 000.<br />
B-Selezione <strong>dei</strong> campioni<br />
Per ottenere un campione <strong>del</strong>la <strong>dieta</strong> <strong>del</strong>la specie, senza rischi d’inquinamento<br />
dovuti a materiale organico attribuibile a specie diverse (cani e volpi), è stato<br />
necessario ricorrere ad una strategia di campionamento critica e selettiva poiché non<br />
esiste di fatto, eccetto l'odore, alcun criterio diagnostico che renda sicura la<br />
distinzione tra un escremento di Lupo e quello di un cane (o di una volpe).<br />
Poiché esiste una certa variabilità e sovrapposizione <strong>nel</strong>le dimensioni tra gli<br />
escrementi <strong>dei</strong> lupi e quelli di volpe, animale ampiamente diffuso in tutto il territorio,<br />
è stato fissato un diametro minimo di 15 mm per l'attribuzione <strong>del</strong>l'escremento al<br />
Lupo. In relazione a questo, fatte di dimensioni inferiori sono state escluse se non<br />
presentavano il caratteristico odore.<br />
<strong>La</strong> raccolta d'escrementi è stata eseguita operando una selezione basata su un insieme<br />
di caratteristiche, in modo che l’eventuale errore incluso <strong>nel</strong> campione, dovuto alla<br />
potenziale confusione con le fatte rilasciate da cani e volpi, se presente, avesse<br />
proporzioni minime e ininfluenti ai fini <strong>del</strong>la successiva analisi <strong>del</strong>la <strong>dieta</strong>.<br />
Per ogni fatta raccolta e collezionata, sono state considerate simultaneamente più<br />
caratteristiche riassunte nei punti seguenti:<br />
• dimensioni generali;<br />
• diametro;<br />
• odore;<br />
• uso <strong>del</strong> sito di marcatura;<br />
• associazione con segni di presenza (peli, impronte).<br />
Nell'area di studio non sono stati effettuati avvistamenti di cani vaganti, né da<br />
parte degli studenti impegnati in altre osservazioni, né da parte <strong>del</strong>la popolazione<br />
locale, né dai cacciatori; possiamo concludere, per questo, che molto probabilmente<br />
<strong>nel</strong>la zona non vi sia rilevante presenza di cani vaganti o inselvatichiti.<br />
16
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
<strong>La</strong> possibilità che un cane padronale, temporaneamente vagante, abbia trovato una<br />
carcassa e dopo abbia lasciato un escremento su uno <strong>dei</strong> nostri scat-trails, è pertanto<br />
da considerarsi molto bassa.<br />
C-Preparazione <strong>dei</strong> campioni<br />
Il campione di fatte raccolte e collezionate è stato sottoposto ad una<br />
preparazione per permettere l’identificazione e la quantificazione <strong>del</strong> contenuto <strong>del</strong>le<br />
feci.<br />
C 1 Essiccazione <strong>dei</strong> campioni<br />
Il materiale organico indigesto è stato essiccato in forno, a 75°C, per almeno<br />
otto ore, per prevenire la formazione di muffe ed uccidere eventuali parassiti.<br />
L’operazione d'essiccamento ha avuto una durata variabile, secondo lo stato di<br />
conservazione <strong>del</strong>la fatta. <strong>La</strong> durata temporale ideale <strong>del</strong>l’essiccamento è stata<br />
determinata secondo i risultati <strong>del</strong> test d'essiccamento effettuati da Artoni (1999).<br />
C 2 Conservazione <strong>dei</strong> campioni<br />
I campioni sono stati conservati a temperatura ambiente in scatole di plastica<br />
dove è stato aggiunto <strong>del</strong> paradiclorobenzolo.<br />
C 3 <strong>La</strong>vaggio<br />
Le fatte sono state reidratate in una soluzione d'acqua e detergente per un<br />
periodo che va da quattro a ventiquattro ore, secondo la loro consistenza e volume.<br />
Successivamente, le fatte sono state lavate in un setaccio con maglia di 1 mm di lato,<br />
per trattenere solo i macroresidui ed eliminare la sostanza amorfa.<br />
C 4 Separazione <strong>dei</strong> materiali organici indigesti<br />
<strong>La</strong> parte macroscopica <strong>del</strong>l’escremento rappresenta i resti indigesti <strong>del</strong> pasto<br />
<strong>del</strong> Lupo ed è stata separata manualmente nei suoi componenti, in base alla diversa<br />
tipologia che li caratterizzava:<br />
• peli;<br />
• ossa;<br />
17
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
• resti vegetali;<br />
• altri<br />
Quando gli escrementi contenevano più di una specie di mammifero e laddove la<br />
separazione <strong>dei</strong> resti indigesti <strong>del</strong>le singole specie è risultata impossibile, sono stati<br />
prelevati casualmente ciuffi di peli, che sono stati esaminati in dettaglio al<br />
microscopio ottico, attribuendo alle diverse specie di mammiferi le proporzioni<br />
relative per ogni prelievo e stabilendo quindi una media generale <strong>del</strong>le proporzioni<br />
relative <strong>del</strong>le specie stesse.<br />
I macrocomponenti così separati sono stati rimessi in forno per asciugarli e<br />
permetterne la conservazione.<br />
D-Identificazione <strong>dei</strong> componenti<br />
Per ciò che concerne i peli <strong>dei</strong> mammiferi ritrovati <strong>nel</strong>le fatte, si è proceduto<br />
ad un’identificazione al microscopio ottico, utilizzando principalmente due<br />
ingrandimenti (40x; 412x), in modo da avere la possibilità di osservare il pelo <strong>nel</strong>le<br />
sue parti principali, la radice e la punta, e di osservarne globalmente il contorno,<br />
quindi, con l’ingrandimento più spinto, è stato verificato la forma e la grandezza<br />
<strong>del</strong>le singole cellule <strong>del</strong>la medulla in ogni parte <strong>del</strong> pelo. L’identificazione <strong>del</strong>le<br />
specie presente è stata effettuata confrontando i peli ritrovati <strong>nel</strong>l’escremento con<br />
peli di riferimento. I peli di riferimento sono stati raccolti sul campo per completare<br />
la casistica riportata dal manuale per l’identificazione <strong>dei</strong> peli <strong>dei</strong> mammiferi europei<br />
(Hair of West-European mammals, Teerink 1991) utilizzato in questa ricerca.<br />
Per l'identificazione <strong>dei</strong> peli sono state utilizzate tre tecniche:<br />
• L’identificazione macroscopica <strong>del</strong> pelo, osservando la lunghezza, lo<br />
spessore, il colore, la bandeggiatura, l’ondulazione e la consistenza.<br />
• L’osservazione microscopica <strong>del</strong>la medulla in trasparenza, considerando<br />
che ogni specie ha uno specifico disegno <strong>del</strong>le cellule che compongono la<br />
medulla, in ogni tratto <strong>del</strong>la lunghezza <strong>del</strong> pelo, dalla radice alla punta.<br />
18
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
• L’osservazione <strong>del</strong> disegno <strong>del</strong>le scaglie cuticolari di un pelo si effettua<br />
sull'impronta impressa su uno strato di smalto, apposto su un vetrino portaoggetti<br />
(Teerink, 1991).<br />
<strong>La</strong> cuticola di un pelo ha caratteristiche specie-specifiche <strong>nel</strong>la<br />
disposizione <strong>del</strong>le scaglie cheratinizzate lungo la lunghezza <strong>del</strong> pelo. Con una<br />
pinzetta, i peli sono stati disposti uno ad uno sullo smalto; dopo 30 minuti, i<br />
peli sono stati tolti usando un ago e <strong>del</strong>le pinzette, evitando danni ai 3 mm<br />
distali e prossimali <strong>del</strong> pelo poiché le zone maggiormente diagnostiche, ai fini<br />
<strong>del</strong> riconoscimento specifico, si trovano proprio in prossimità <strong>del</strong>la radice e<br />
<strong>del</strong>la punta <strong>del</strong> pelo.<br />
Se la medulla risultava trasparente, si poteva osservare direttamente al<br />
microscopio le scaglie <strong>del</strong>la cuticola, senza ricorrere allo stampo.<br />
Tra la cuticola e la medulla si trova una terza parte <strong>del</strong> pelo che può aiutare<br />
<strong>nel</strong>l’identificazione <strong>del</strong>la specie; tale zona (corteccia o cortex), si può definire come<br />
uno strato più o meno sottile, composto di una massa informe di cellule corneificate,<br />
che separa la medulla dallo strato più esterno <strong>del</strong> pelo, vale a dire dalla cuticola.<br />
Stando alle indicazioni <strong>del</strong> Teerink (1991), la corteccia non rappresenta in sé uno<br />
strato diagnostico ai fini <strong>del</strong> riconoscimento specifico, ma, se rapportata alla medulla,<br />
può fornire importanti indicazioni sulla conferma <strong>del</strong>l’identificazione <strong>del</strong>la specie.<br />
Dato che il livello di riconoscimento <strong>dei</strong> peli <strong>dei</strong> mammiferi è risultato soddisfacente<br />
con l‘osservazione <strong>del</strong>la medulla e <strong>del</strong>la cuticola, la tecnica <strong>del</strong>la sezione circolare e<br />
longitudinale <strong>del</strong> pelo non è stata utilizzata.<br />
Si è sempre cercato di osservare più peli appartenenti ad una fatta, prelevati da varie<br />
zone di essa ed in modo casuale, in modo da evitare di osservare peli spezzati o<br />
danneggiati lungo il percorso attraverso l’apparato digerente <strong>del</strong> Lupo e quindi poco<br />
utili ai fini <strong>del</strong> riconoscimento specifico.<br />
19
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
Il riconoscimento è stato effettuato sul pelo di guardia (giarra) che compone la<br />
pelliccia visibile <strong>del</strong> mantello <strong>dei</strong> mammiferi, scartando da principio il sottopelo<br />
(borra), che forma la lanugine con funzione termoregolatrice sottostante la pelliccia<br />
vera e propria, perché considerato poco diagnostico ai fini <strong>del</strong> riconoscimento<br />
specifico (Teerink 1991).<br />
In certi casi, per via <strong>del</strong>l’eccessiva frammentazione <strong>dei</strong> pochi peli presenti<br />
<strong>nel</strong>l’escremento, non si è riusciti a determinare con esattezza il mammifero<br />
d'appartenenza, attribuendo il codice ad una classe denominata "non identificato".<br />
Il materiale vegetale non è stato identificato, dato che la raccolta degli escrementi è<br />
stata effettuata tra fine inverno e primavera, stagioni in cui non sono presenti<br />
alimenti vegetali che possano essere ingeriti volontariamente dal Lupo.<br />
20
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
21
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
22
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
23
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
E-Stima <strong>del</strong> volume relativo <strong>dei</strong> componenti nei campioni<br />
Resti di pasti precedenti possono rimanere all’interno <strong>del</strong>l’intestino <strong>del</strong><br />
predatore a causa <strong>del</strong>la loro struttura; per esempio le lunghe setole <strong>del</strong> cinghiale<br />
adultorisultano spesso associate a categorie alimentari differenti all’interno <strong>del</strong>lo<br />
stesso escremento. Tali resti sono stati quantificati <strong>nel</strong>la misura <strong>del</strong>l'1%, così da<br />
minimizzare la loro influenza sul valore <strong>del</strong> volume percentuale ma senza eliminarle<br />
però dalle frequenze percentuali di comparsa.<br />
Nel calcolo <strong>del</strong>le categorie alimentari non sono state considerate le ricorrenze<br />
vegetali, sebbene il Lupo tenda ad ingerire volontariamente <strong>del</strong>le graminacee (Mech<br />
1974). Non è stato possibile distinguere questi vegetali da quelli raccolti casualmente<br />
prelevando le fatte sul campo.<br />
Per ciascun metodo di quantificazione adottato, ogni classe o categoria alimentare è<br />
stata associata ad un rango in base alla sua quantificazione relativa.<br />
I risultati ottenuti dai ranghi <strong>del</strong>le categorie alimentari sono stati poi confrontati per<br />
evidenziare eventuali concordanze o differenze tra metodi.<br />
In particolare sono state utilizzate le seguenti metodologie di quantificazione<br />
<strong>del</strong>la <strong>dieta</strong>:<br />
E 1 Percentuale di frequenza di comparsa<br />
Secondo Lockie (1959) (in Poulle et al. 1997) per descrivere la <strong>dieta</strong>, i dati<br />
possono essere espressi in percentuale di frequenza di comparsa; questo metodo, che<br />
è uno <strong>dei</strong> più usati, procura velocemente una descrizione qualitativa <strong>del</strong>la <strong>dieta</strong> ed è<br />
di facile e rapido utilizzo (Ciucci et al.1996 in Poulle et al. 1997).<br />
<strong>La</strong> frequenza relativa è la percentuale di frequenza di comparsa di ogni classe di cibo<br />
rispetto alla frequenza totale di comparsa di tutte le classi di cibo.<br />
<strong>La</strong> frequenza assoluta è la percentuale di comparsa d'ogni classe di cibo rispetto al<br />
numero totale di fatte analizzate.<br />
<strong>La</strong> frequenza relativa sarebbe, secondo Ciucci et al. (1996) (in Poulle et al. 1997) più<br />
rivelatrice in termini di composizione <strong>del</strong>la <strong>dieta</strong>.<br />
Questo metodo di frequenza presenta il problema che il numero di fatte<br />
collezionabile per kg di prede consumato decresce con l'aumento <strong>del</strong> peso <strong>del</strong>la<br />
preda. Questa relazione inversa (r² = 0,97) indica anche che le prede piccole o più<br />
leggere sono composte di più materia indigeribile, aumentando il rapporto<br />
superficie/volume. In termini di peso, le piccole prede sono sovrastimate <strong>nel</strong>le<br />
24
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
frequenze di comparsa. Floyd et al. (1978) propongono una formula di conversione<br />
per risalire alla biomassa consumata:<br />
y = 0,38 + 0,02 x<br />
y essendo il peso (kg) di prede per fatta collezionabile<br />
x essendo il peso medio <strong>del</strong> tipo di prede<br />
(Floyd et al. 1978)<br />
Questa formula è stata rivista da Weaver (1993) che propone di usare sul<br />
campo la formula: y = 0,439 + 0,008x, valida per prede di peso variabile tra quello di<br />
una lepre e quello di un alce (Weaver 1993).<br />
Queste equazioni sono state stabilite per lupi americani in cattività, basandosi su<br />
prede di peso compreso tra 1,16 e 75,4 chili. L'ecotipo italiano <strong>del</strong> Lupo, invece, è<br />
più piccolo e più leggero (25-35 kg) di quello americano (60-80 kg); <strong>nel</strong> presente<br />
lavoro, sono state identificate prede con dimensioni variabili tra quelle di<br />
micromammiferi e quelle di cinghiali e ciò lascia supporre che le equazioni<br />
summenzionate debbano essere riconsiderate per poter essere applicate allo studio<br />
<strong>del</strong>la <strong>dieta</strong> <strong>del</strong> Lupo in Italia.<br />
In accordo con quanto affermato da Corbett (1989), l’applicazione <strong>del</strong>le equazioni<br />
precedenti non è stata necessaria in studi che, come il presente, sono volti a<br />
determinare la composizione qualitativa <strong>del</strong>la <strong>dieta</strong> e le quantità relative di animali<br />
consumati.<br />
E 2 Volume percentuale relativo<br />
Il volume percentuale relativo, inteso come la proporzione di tutti i<br />
componenti all’interno <strong>del</strong>l’intero volume <strong>del</strong>l’escremento esaminato, espressa in<br />
percentuale, è stato stimato con metodo occhiometrico, ed è stato calcolato per ogni<br />
specie consumata (Kruuk e Parish 1981). Tutte le percentuali d'ogni componente<br />
sono state sommate fra loro per ottenere il volume percentuale relativo totale per<br />
quella determinata specie in relazione alle altre (Smietana e Klimek 1993).<br />
25
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
5.1.2 Resti di predazione<br />
Quando sono state rinvenute carcasse di animali all'interno <strong>del</strong>l'area di studio,<br />
interpretando le tracce nei pressi <strong>del</strong> sito di ritrovamento, si è tentato di stabilire se si<br />
trattasse di reali eventi di predazione oppure <strong>del</strong> semplice consumo di animali, morti<br />
precedentemente per altre cause.<br />
In occasione di ogni ritrovamento di carcasse, si è tentato di ricostruire la dinamica<br />
<strong>del</strong>l'aggressione mediante il rilevamento di impronte ed altri segni di predazione; è<br />
stata ricercata la presenza di ematomi <strong>nel</strong>lo strato sottocutaneo in corrispondenza <strong>dei</strong><br />
morsi, sicuro indice <strong>del</strong> fatto che la preda era viva al momento <strong>del</strong>l'aggressione.<br />
Il riconoscimento <strong>del</strong>le cause di morte <strong>del</strong>la specie preda e <strong>del</strong> predatore coinvolto<br />
possono risultare difficoltose (se non impossibili <strong>nel</strong> caso di Lupo e cane) e<br />
comunque fortemente dipendenti dal grado di consumo e di conservazione di ciò che<br />
rimane <strong>del</strong>la preda (Ciucci e Boitani 1998a). Sebbene si tende a credere che il <strong>lupo</strong><br />
attacchi la preda preferenzialmente con il tipico morso alla regione laringo-tracheale<br />
a differenza <strong>del</strong> cane che tenderebbe a ferire più disordinatamente ed in diverse<br />
regione <strong>del</strong> corpo, non si hanno a riguardo indicazioni certe e non esiste quindi un<br />
criterio diagnostico affidabile (Fico 1996).<br />
26
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
5.2 Censimento <strong>del</strong> Lupo<br />
Ciucci (1999).<br />
Per le metodologie relative al censimento <strong>del</strong> Lupo si è fatto riferimento a<br />
Il Lupo, data la sua elusività, la bassa densità e gli ambienti forestali in cui vive, è<br />
uno tra i mammiferi terrestri più difficili da censire.<br />
Tra i metodi diretti si passa dalle stime effettuate tramite ululato indotto<br />
(wolf-howling) a campionamenti aerei <strong>del</strong>le tracce su neve ed a stime ottenute<br />
tramite radiotelemetria.<br />
Più spesso sono applicati i metodi indiretti che rappresentano indici di<br />
abbondanza da confrontare tra zone e periodi diversi.<br />
Si tratta <strong>del</strong>le statistiche degli esemplari abbattuti, <strong>del</strong> numero di lupi osservato o<br />
degli ululati ascoltati dai cacciatori, <strong>del</strong> numero di cacciatori che hanno riscontrato<br />
escrementi e/o tracce di Lupo, <strong>del</strong> numero di escrementi raccolti per settimana su<br />
strade forestali.<br />
In Italia i censimenti <strong>del</strong> Lupo a livello locale sono stati effettuati principalmente<br />
attraverso due tecniche: la conta <strong>del</strong>le tracce su neve e il "wolf-howling".<br />
5.2.1 Censimento <strong>del</strong> Lupo su neve<br />
In Italia, la conta <strong>del</strong>le tracce su neve si <strong>del</strong>inea come una <strong>del</strong>le poche<br />
modalità di censimento <strong>del</strong> Lupo utilizzabili in ambiente montano. <strong>La</strong> conta degli<br />
individui può essere realizzata all'interno di una o più aree campione considerate<br />
rappresentative. Per specie quali i grossi ungulati si deve necessariamente procedere<br />
con una stima per aree campione, mentre per i grossi carnivori, come l'orso, la lince e<br />
il Lupo, che hanno ampi territori e vivono a densità molto basse, generalmente si<br />
effettuano censimenti veri e propri.<br />
A-Descrizione <strong>del</strong>la tecnica<br />
Sono definiti su base opportunistica, includendo preferenzialmente le zone di<br />
massima possibilità di presenza e di passaggio <strong>dei</strong> lupi, i settori e i circuiti di<br />
campionamento. Il numero di operatori è la variabile critica che limita il numero di<br />
27
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
settori e circuiti realizzabili, ed è direttamente correlata con la rappresentatività e<br />
affidabilità <strong>dei</strong> risultati finali.<br />
Ciascun circuito è assegnato ad una squadra d'operatori che lo percorrono a<br />
piedi, con racchette da neve o con sci da fondo dopo una nevicata estesa e trascorso<br />
un periodo da 36 a 48 ore. Tale intervallo è un compromesso:<br />
Periodi d'attesa più brevi non lascerebbero ai lupi il tempo sufficiente per compiere<br />
gli spostamenti estesi di un ciclo di attività.<br />
Periodi più lunghi complicherebbero l'interpretazione <strong>del</strong>le tracce e la loro<br />
assegnazione a individui e/o branchi esclusivi a causa degli spostamenti di andata e<br />
ritorno da parte <strong>dei</strong> lupi stessi o di altra fauna.<br />
<strong>La</strong> percorrenza <strong>dei</strong> circuiti di rilevamento deve avvenire contemporaneamente in tutti<br />
i circuiti e in tutti settori prestabiliti.<br />
<strong>La</strong> profondità media <strong>del</strong>la neve adatta per l'effettuazione <strong>dei</strong> censimenti<br />
dovrebbe essere di 8-20 cm. In neve troppa profonda, lo spostamento <strong>dei</strong> lupi può<br />
essere limitato, prevalentemente alle quote più basse e gli operatori riscontrano <strong>del</strong>le<br />
difficoltà <strong>nel</strong>l'incedere. <strong>La</strong> nevicata deve interessare l'area intera da censire e coprire<br />
interamente le tracce preesistenti sul territorio o perlomeno renderle illeggibili.<br />
Il vento, la temperatura elevata, la pioggia e la nebbia possono rendere illeggibili le<br />
tracce fresche anche <strong>nel</strong>l'arco di una sola giornata.<br />
Le tracce di Lupo intercettate devono essere seguite per un tratto variabile da<br />
100 a 500 m, sufficiente a rilevare le informazioni necessarie. Per evitare di<br />
disturbare i lupi, avvicinandosi troppo, è buona regola seguire le tracce, sopratutto<br />
quelle fresche, in senso opposto alla direzione di marcia.<br />
Dopo la lettura di tutti i circuiti, vengono confrontati i risultati relativi ai circuiti tra<br />
settori adiacenti. Viene stabilita o meno la continuità <strong>del</strong>le tracce, per arrivare ad un<br />
numero minimo e conservativo degli individui e <strong>dei</strong> branchi oggetto di censimento. È<br />
generalmente impossibile la distinzione degli individui e/o branchi in base alle sole<br />
impronte o alla distanza <strong>dei</strong> settori, perciò la copertura simultanea di più settori tra<br />
loro è un requisito fondamentale. Tracce seguite da operatori diversi in settori non<br />
contigui e distanti più di 20-30 km in linea d'aria possono appartenere allo stesso<br />
branco.<br />
28
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
Se risultano dubbi in fase di sintesi <strong>del</strong> censimento, come per esempio incertezze<br />
relative all'assegnazione <strong>del</strong>le tracce, è importante procedere il più presto possibile<br />
con sopralluoghi mirati, il cui scopo è di seguire il più possibile le tracce, senza<br />
percorrere interamente il circuito prestabilito.<br />
Secondo la strategia, lo sforzo di campionamento e le condizioni ambientali,<br />
il livello di dettaglio raggiunto può variare dalla possibilità di stabilire la presenza o<br />
meno <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong>l'area di studi, identificare le zone in cui il Lupo è maggiormente<br />
presente, stimare la dimensione e la composizione di alcuni branchi locali fino ad<br />
effettuare, <strong>nel</strong> caso ideale, un censimento vero e proprio.<br />
Dopo l'interpretazione e la discussione <strong>dei</strong> risultati ottenuti <strong>nel</strong>l'ambito di una<br />
giornata di studi conclusiva a cui partecipano idealmente tutti gli operatori impiegati<br />
è prodotta una relazione finale, contenente oltre ai risultati, il sistema di<br />
campionamento utilizzato e <strong>del</strong>le mappe allegate.<br />
B-Impronte<br />
<strong>La</strong> postura <strong>del</strong> Lupo è digitigrada, che significa che la zampa prende contatto<br />
con il terreno non con l'intera superficie <strong>del</strong> piede, ma esclusivamente a livello <strong>del</strong>le<br />
dita e <strong>del</strong> cuscinetto plantare. I segni <strong>del</strong>le unghie sono ben visibili e il cuscino<br />
plantare è in posizione centrale, di forma triangolare lobata. Nell'impronta sono<br />
visibili solo quattro dita, il relitto <strong>del</strong> primo dito (lo "sperone") si trova solo sugli arti<br />
anteriori e in posizione sopraelevata rispetto al cuscinetto plantare, non entrando in<br />
contatto col terreno. (Ciucci e Boitani 1998a)<br />
L'impronta <strong>del</strong> Lupo è simile per la forma a quella di altri canidi selvatici presenti in<br />
Italia, come la volpe o lo sciacallo dorato, sebbene abbia dimensioni maggiori.<br />
L'impronta di una grossa volpe può misurare 5 x 4 cm, mentre quella di un Lupo<br />
adulto può raggiungere i 10-12 x 8-10 cm, con l'impronta posteriore leggermente più<br />
piccola <strong>del</strong>l'anteriore.<br />
Cani di taglia media-grossa lasciano impronte pressoché indistinguibili da quelle <strong>del</strong><br />
Lupo. L'impossibilità è stata definitivamente dimostrata da accurati studi specifici, in<br />
cui sono state confrontate statisticamente forma e dimensioni <strong>del</strong>le impronte sia di<br />
Lupo, sia di diverse razze canine di taglia simile (Ciucci 1999).<br />
29
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
<strong>La</strong> pista <strong>del</strong> Lupo può essere distinta da una pista di cane, perché è caratterizzata da<br />
una direzione di viaggio assai costante, con pochissimi ritorni, deviazioni,<br />
conversioni, indecisioni o scarti laterali (Ciucci 1999).<br />
30
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
C-Applicazione <strong>del</strong> metodo<br />
Per attuare un censimento, mediante ricerca <strong>dei</strong> segni di presenza <strong>del</strong> <strong>lupo</strong> su<br />
neve <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi, sono state messe in atto le seguenti attività:<br />
- ricerca e mappatura di un sufficiente numero di itinerari percorribili dopo<br />
una nevicata, la cui distribuzione coprisse <strong>nel</strong> modo più omogeneo possibile<br />
l’intera area di studio;<br />
- formazione degli operatori di campo;<br />
- organizzazione logistica;<br />
- effettuazione <strong>del</strong> censimento;<br />
- verifica sul campo <strong>del</strong>le situazioni dubbie (sopralluoghi mirati).<br />
Quarantotto ore dopo la nevicata (altezza neve circa 20 cm) <strong>dei</strong> giorni 23<br />
gennaio 2000 e 20 gennaio 2001, sono stati effettuati due censimenti basati sulla<br />
ricerca e la mappatura di segni di presenza di <strong>lupo</strong>.<br />
Durante tali censimenti, sono stati effettuati contemporaneamente 17 percorsi sui<br />
crinali principali e secondari presenti tra il Passo <strong>del</strong>la Cisa e il Passo <strong>del</strong> <strong>La</strong>gastrello,<br />
ricercando tracce ed escrementi (tabella 1). L'operazione è stata resa possibile grazie<br />
alla partecipazione di 31 studenti universitari e di volontari che sono stati preparati<br />
<strong>nel</strong> corso di due incontri preliminari. Le segnalazioni di incerta attribuzione sono<br />
state verificate il giorno seguente dai coordinatori.<br />
Durante il censimento <strong>del</strong> 2001 non è stato possibile completare tutti i transetti a<br />
causa di condizioni meteorologiche sfavorevoli.<br />
31
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
Numero <strong>del</strong><br />
percorso<br />
Località iniziale Località finale<br />
1 Groppo <strong>del</strong> Vescovo Passo <strong>del</strong> Cirone<br />
2 Berceto Passo <strong>del</strong> Cirone<br />
3 Passo <strong>del</strong> Sillara Graiana<br />
4 Rifugio <strong>La</strong>g<strong>dei</strong> Monte Tavola<br />
5 Rifugio <strong>La</strong>g<strong>dei</strong> <strong>La</strong>go Pradaccio<br />
6 <strong>La</strong>go Scuro Capanne di Badignana<br />
7 Passo <strong>del</strong>la Colla Valditacca<br />
8 Monte Navert Groppo Fosco<br />
9 Grammatica Groppo Fosco<br />
10 Poggio <strong>del</strong> Tesoro Poggio <strong>del</strong>lo Zucchero<br />
11 Poggio <strong>del</strong>lo Zucchero Monte Navert<br />
12 Prato Spilla <strong>La</strong>go Verde<br />
13 Rigoso <strong>La</strong>go Verdarolo<br />
14 Cima Nuda Monte Ronco Bora<br />
15 Selvapiana<br />
16 Poggio <strong>del</strong> Tesoro Passo Zibana<br />
17 Agna Monte Caio<br />
Tabella 1:<br />
Itinerari percorsi durante il censimento <strong>del</strong> 23/01/00<br />
32
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
33
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
5.2.2 L'ululato come strumento di censimento <strong>dei</strong> lupi (wolf-howling)<br />
L'ululato è costituito da 2 a 12 armonici, e il suono fondamentale ha una<br />
frequenza da 150 a 640 Hz. (Theberge e Falls 1967)<br />
Un ululato individuale può durare da 0,6 a 8,2 secondi e una sessione di ululati da<br />
meno di 10 secondi ad alcuni minuti per un individuo isolato. (Harrington e Mech<br />
1978)<br />
Si definisce ululato corale quando tre o più individui di un branco ululano insieme.<br />
(Klinghammer e <strong>La</strong>idlaw 1975) Un coro può durare da 30 a 123 secondi (Harrington<br />
e Mech 1978).<br />
Gli ululati in coro sono iniziati da un animale (di alto rango) e dopo uno o due<br />
ululati, due o tre individui si avvicinano al primo <strong>lupo</strong> e iniziano a ululare uno dopo<br />
l'altro. Il resto <strong>del</strong> branco si unisce all'ululato <strong>dei</strong> primi, "en masse"; questo spiega la<br />
difficoltà di determinare con precisione il numero d'individui di un branco con la<br />
tecnica <strong>del</strong> wolf-howling (Harrington e Mech 1982).<br />
Alcune sessioni possono succedersi, sia per gli ululati individuali, sia per gli ululati<br />
in coro.<br />
L'ululato <strong>dei</strong> lupi è udibile a 6,2 km per gli umani e a più di 10 km per i lupi in<br />
ambiente boschivo e a più di 16 km per gli umani in ambiente aperto (Harrington e<br />
Mech 1978).<br />
Nel 1960, Pimlott ha proposto una nuova tecnica per localizzare i lupi: dopo<br />
aver limitato la zona dove si possono trovare i lupi vengono emessi degli ululati<br />
preregistrati e si ascoltano le risposte <strong>dei</strong> lupi.<br />
I primi risultati non sono stati soddisfacenti, in considerazione <strong>del</strong>la limitata capacità<br />
degli apparecchi <strong>del</strong>l'epoca per riprodurre i suoni.<br />
Nel 1961, Joslin ha cominciato ad utilizzare questa tecnica, ma si è accorto che<br />
otteneva <strong>dei</strong> risultati migliori ululando direttamente a voce.<br />
Da questo momento in poi, la tecnica è stata diffusamente applicata per valutare il<br />
numero <strong>dei</strong> branchi di lupi, stabilire il loro home-range e i loro spostamenti. Usando<br />
solo il wolf-howling è impossibile contare gli individui con precisione, perché gli<br />
ululati <strong>dei</strong> lupi giovani e degli adulti subordinati consistono in modulazioni rapide di<br />
frequenza che aumentano la complessità <strong>del</strong> coro e rendono l'individualizzazione <strong>dei</strong><br />
34
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
soggetti impossibile, anche usando sonogrammi di registrazioni d'alta qualità<br />
(Harrington e Mech 1982).<br />
Filibeck et al. hanno usato un analizzatore di frequenza che forniva uno spettro degli<br />
ululati di due lupi, un ibrido Lupo x cane e un cane: hanno così dimostrato che è<br />
possibile distinguere e contare gli individui che partecipano ad un ululato in coro, se<br />
è esclusivamente composto di adulti (Filibeck et al. 1982).<br />
D'altra parte, certi individui subordinati possono stare silenziosi mentre gli altri<br />
membri <strong>del</strong> branco ululano. Sopratutto d'estate è molto probabile che alcuni degli<br />
animali siano assenti. Siccome individui solitari non rispondono quasi mai agli<br />
ululati, il loro conteggio è quasi impossibile con questa tecnica (Harrington e Mech<br />
1982).<br />
Boscagli (1982) ha suggerito di limitare l'uso <strong>del</strong> wolf-howling ai mesi di maggior<br />
disponibilità di risposta, che vanno da ottobre a fine febbraio, per non rischiare di<br />
disturbare inutilmente questa specie già tanto minacciata in Europa.<br />
<strong>La</strong> tecnica può invece essere applicata durante tutto l'anno, in regioni <strong>nel</strong>le quali<br />
l'assenza <strong>del</strong> Lupo è stata confermata, per studiare il fenomeno <strong>dei</strong> cani randagi<br />
(Boscagli 1982).<br />
In Canada, alcuni Parchi Nazionali hanno aperto le sessioni di wolf-howling<br />
al pubblico, creando momenti ed occasioni di educazione ambientale per turisti e<br />
appassionati e di sensibilizzazione <strong>del</strong>l'opinione pubblica in generale. Nella stessa<br />
occasione, il personale <strong>del</strong> parco ha potuto osservare le reazioni <strong>del</strong> pubblico (Carbyn<br />
1975).<br />
Applicazione <strong>del</strong> metodo<br />
Al fine di coprire uniformemente il territorio <strong>del</strong> <strong>Parco</strong>, sono stati individuati<br />
12 punti di monitoraggio per l’emissione di ululati pre-registrati.<br />
Per riuscire a monitorare in una stessa notte tutti i 12 punti stabiliti, sono stati scelti<br />
siti raggiungibili in macchina; in corrispondenza d'ogni punto di rilevamento, sono<br />
stati emessi tre ululati <strong>del</strong>la durata di un minuto e mezzo, intervallati da pause di pari<br />
lunghezza durante le quali si ascoltavano eventuali risposte.<br />
Per localizzare i siti riproduttivi, sulla base <strong>del</strong>le maggiori probabilità di risposta<br />
(Ciucci e Boitani 1998a), e per l’impossibilità di percorrere in macchina tutte le<br />
35
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
strade <strong>del</strong> <strong>Parco</strong> durante il periodo invernale, è stato scelto il periodo che va da luglio<br />
ad ottobre.<br />
Nei mesi di luglio, agosto ed ottobre 2000 e di giugno e luglio 2001 sono state<br />
effettuate complessivamente 5 notti di wolf-howling.<br />
<strong>La</strong> rete di strade percorribili da un automezzo è, <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi, piuttosto<br />
limitata e non consente di raggiungere con l’emissione degli ululati pre-registrati<br />
alcune aree molto boscate, poco disturbate e di difficile accesso; in tabella 2 vengono<br />
elencati i siti utilizzati per le emissioni degli ululati pre-registrati e per l’ascolto <strong>del</strong>le<br />
risposte <strong>dei</strong> lupi.<br />
Sito di emissione/ascolto n° Località<br />
Tabella 2:<br />
Siti di emissione degli ululati pre-registrati<br />
1 Cancelli<br />
2 <strong>La</strong>go Pradaccio<br />
3 Rifugio <strong>La</strong>goni<br />
4 Passo <strong>del</strong>la Colla<br />
5 Fontanabona<br />
6 Prato Spilla<br />
7 Monte Bastia<br />
8 Poggio <strong>del</strong> Tesoro<br />
9 Groppo Torsello<br />
10 Sivizzo<br />
11 Passo <strong>del</strong> Cirone<br />
12 Passo <strong>del</strong> Sillara<br />
36
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
37
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
5.3 Censimento degli ungulati<br />
Nel corso degli ultimi anni si è assistito ad un incremento <strong>del</strong>le popolazioni di<br />
capriolo e cinghiale e ad una loro espansione territoriale soprattutto <strong>nel</strong>la fascia<br />
collinare e montana <strong>del</strong>la Provincia di Parma. <strong>La</strong> forte riduzione di alcune attività<br />
agro-silvo-pastorali <strong>nel</strong>le zone montane, la quasi totale assenza di predazione<br />
naturale legata alla scomparsa <strong>dei</strong> grandi carnivori, unitamente ad un prelievo<br />
venatorio più attento, hanno reso possibile l’espansione spaziale e numerica <strong>del</strong>le due<br />
specie. Nel caso <strong>del</strong> cinghiale, va aggiunto che è stato oggetto di massicci<br />
ripopolamenti con individui provenienti da popolazioni alloctone, caratterizzate da<br />
maggiori dimensioni e più elevata prolificità.<br />
Nel 1998 il <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi ha incaricato l'Università di Parma di valutare la<br />
consistenza numerica degli ungulati <strong>nel</strong> pre-parco, in particolare <strong>del</strong> capriolo. I<br />
risultati ottenuti sono stati oggetto di una relazione in cui si evidenziano <strong>del</strong>le<br />
marcate differenze fra le densità di caprioli in Val Parma (25,5 capi/100 ha), in Val<br />
Bratica (1,3 capi/100 ha) ed in Val Cedra (8,3 capi/100 ha). Dai dati raccolti emerge<br />
che le maggiori densità sono riscontrabili a ridosso <strong>dei</strong> confini <strong>del</strong> <strong>Parco</strong>, suggerendo<br />
una sua funzione di serbatoio (source) faunistico.<br />
Il proseguimento <strong>del</strong>le indagini <strong>nel</strong> 2000 ha permesso di valutare l'effettiva densità<br />
attuale <strong>del</strong>le popolazioni di ungulati ed ha dato indicazioni quantitative per una<br />
corretta gestione <strong>del</strong>l’attività venatoria, fornendo inoltre un dato confrontabile con gli<br />
anni scorsi e con quelli futuri. Il monitoraggio ha, infine, evidenziato come la<br />
dinamica <strong>del</strong>le popolazioni di ungulati selvatici sia conseguenza <strong>dei</strong> diversi tipi di<br />
gestione venatoria attuati nei diversi comprensori di gestione faunistica-venatoria.<br />
A-Metodo d'indagine<br />
L'elevato indice di boscosità (circa il 70%, dato ISTAT) rilevato <strong>nel</strong> preparco<br />
è stato il principale fattore che ha indirizzato la scelta verso la predisposizione<br />
e la realizzazione di metodologie standard di censimento <strong>del</strong> capriolo e cinghiale<br />
basate sull’utilizzo di battute in aree campione (Strandgaard 1972; C.E.M.A.G.R.E.F.<br />
1984; Lovari 1989) <strong>La</strong> tecnica <strong>del</strong>la battuta viene ritenuta comunemente la più<br />
affidabile in ambienti forestali, fatta eccezione per il metodo Lincoln-Petersen che<br />
però è estremamente impegnativo, sia sotto l’aspetto operativo, che economico, in<br />
38
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
quanto richiede la cattura e marcatura di almeno il 60% <strong>del</strong>la popolazione. In genere<br />
altre metodologie tendono, in tali ambienti, a sottostimare fortemente la densità <strong>del</strong><br />
capriolo.<br />
L'applicazione <strong>dei</strong> censimenti in battuta su aree campione (mantenendo <strong>nel</strong> tempo le<br />
stesse aree di censimento) rende invece possibile la standardizzazione <strong>dei</strong> rilevamenti<br />
annuali e la valutazione dinamica <strong>dei</strong> risultati. Il principale fattore limitante per<br />
l'applicazione di questo metodo è la necessità di un elevato numero di volontari per<br />
l'esecuzione <strong>dei</strong> censimenti.<br />
Il metodo <strong>del</strong>le battute campione ha permesso di definire una densità media sui dati<br />
ricavati da più aree di battuta. L’estrapolazione <strong>dei</strong> dati ha consentito di definire la<br />
densità degli animali sull’intera area di studio.<br />
Il metodo consiste <strong>nel</strong> circondare con gli operatori un'area boscata disponendoli su<br />
quattro lati, uno <strong>dei</strong> quali mobile. Gli animali vengono spinti tramite il movimento<br />
degli operatori <strong>del</strong> lato mobile verso gli osservatori. I battitori sono disposti lungo un<br />
fronte rettilineo; è necessario che esso rimanga allineato e che ciascun battitore non<br />
perda mai il contatto visivo con quelli che si trovano ai suoi lati. Gli osservatori<br />
(poste) sono disposti su tre lati a chiudere la zona coperta dalla battuta. Le poste sono<br />
preferibilmente disposte in una zona dove siano presenti buone condizioni di<br />
visibilità (un sentiero, una tagliata, una strada, ecc.).<br />
Sia il numero di osservatori fissi, che quello <strong>dei</strong> battitori, dipendono dalla topografia<br />
<strong>del</strong> luogo. <strong>La</strong> distanza fra i battitori deve in generale essere compresa fra i 5 e i 10<br />
metri, mentre la distanza fra le poste è generalmente maggiore ed è compresa fra i 25<br />
e i 50 metri. Complessivamente sono necessarie da 1 a 3 persone per ettaro di<br />
superficie da censire.<br />
Le osservazioni sono state registrate su apposite schede consegnate ai battitori ed agli<br />
osservatori prima <strong>del</strong>l’inizio <strong>del</strong>la battuta. Sono stati contati tutti gli animali che sono<br />
usciti dall’area di battuta passando tra un operatore e l'altro; l'annotazione è stata<br />
effettuata solo dall'operatore alla cui sinistra è passato l'animale. Non sono stati<br />
annotati gli animali che sono stati visti transitare all'interno <strong>del</strong>la battuta. In tal modo,<br />
confrontando anche gli orari in cui sono stati annotati gli avvistamenti, sono stati<br />
evitati i doppi conteggi e conseguenti sovrastime.<br />
Le battute sono state effettuate <strong>nel</strong>le aree boscate <strong>del</strong> pre-parco tenendo conto <strong>del</strong>le<br />
condizioni di visibilità e <strong>del</strong>la distribuzione degli animali sul territorio, che deve<br />
essere tendenzialmente omogenea. Queste due esigenze vengono soddisfatte, per il<br />
39
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
capriolo, tra metà Aprile e primi di Maggio. In questo periodo i caprioli sono<br />
distribuiti omogeneamente sul territorio (territorialità e scioglimento <strong>dei</strong> gruppi<br />
invernali), la vegetazione è in ripresa (primo verde), ma non ancora lussureggiante e<br />
non è ancora il periodo <strong>dei</strong> parti.<br />
Per il cinghiale, il metodo <strong>del</strong>le battute su aree campione risulta meno<br />
attendibile rispetto al capriolo, in quanto si tratta di animali gregari e non<br />
omogeneamente distribuiti sul territorio; essi vivono in gruppi, talvolta numerosi e<br />
sono caratterizzati da elevata vagilità. Tuttavia tale metodo rimane l'unico applicabile<br />
per ambienti di questa natura. Un censimento di questo tipo ha permesso di stimare il<br />
numero di animali presenti <strong>nel</strong>la zona, ha fornito indicazioni sul rapporto tra giovani<br />
ed adulti, utili informazioni per l'elaborazione di un eventuale piano di abbattimento<br />
e consentirà un'analisi <strong>dei</strong> trend demografici <strong>nel</strong> corso degli anni.<br />
B-Applicazione <strong>del</strong> metodo<br />
Al fine di poter utilizzare la stessa area di battuta per censire entrambe le<br />
specie, le sue dimensioni devono essere comprese tra 80 e 100 ha; infatti, per il<br />
capriolo, che all’inizio <strong>del</strong>la primavera è uniformemente distribuito sul territorio,<br />
sono sufficienti 30 ha di area di battuta, ma per il cinghiale, che è una specie<br />
gregaria, è necessaria una superficie di battuta non inferiore a 80 ha. Inoltre l'utilizzo<br />
di aree di battuta estese presenta il vantaggio di evitare che, durante le operazioni di<br />
posizionamento degli operatori, gli animali, allertati, abbandonino l'area di battuta,<br />
provocando una sottostima <strong>del</strong>la consistenza numerica.<br />
Ogni area è stata individuata e <strong>del</strong>imitata su carta topografica in scala 1:10.000 e<br />
successivamente sono stati individuati e contrassegnati sul campo, con appositi<br />
segnali in materiale plastico, i punti di appostamento per gli osservatori e quelli di<br />
partenza per i battitori. Queste operazioni sono state eseguite con almeno tre<br />
settimane di anticipo rispetto allo svolgimento <strong>del</strong>le battute, dopo di che, gli animali<br />
non sono più stati disturbati.<br />
Nelle settimane precedenti allo svolgimento <strong>del</strong> censimento, sono stati eseguiti alcuni<br />
incontri con rappresentanti <strong>del</strong> mondo venatorio al fine di illustrare loro le aree<br />
campione e di coinvolgerli maggiormente <strong>nel</strong>l'attività. All'Università si è svolto un<br />
incontro con gli studenti volontari al fine di fornire loro nozioni riguardo al metodo<br />
ed al riconoscimento degli animali oggetto di censimento. In tal modo si è venuto a<br />
creare un gruppo preparato e motivato al corretto svolgimento <strong>del</strong>le battute.<br />
40
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
L'esecuzione <strong>del</strong> censimento in battuta ha comportato le seguenti fasi:<br />
• appello <strong>dei</strong> volontari presenti;<br />
• distribuzione di una scheda di rilevamento e di una cartina <strong>del</strong>la zona<br />
campione ad ogni volontario;<br />
• assegnazione <strong>dei</strong> volontari presenti ai gruppi <strong>dei</strong> battitori e <strong>del</strong>le poste;<br />
• disposizione degli osservatori lungo il perimetro <strong>del</strong>l'area di battuta, <strong>nel</strong><br />
massimo silenzio possibile;<br />
• disposizione <strong>dei</strong> battitori lungo il fronte di battuta;<br />
• svolgimento <strong>del</strong>la battuta, utilizzando almeno tre ricetrasmittenti (una al<br />
centro e due agli estremi <strong>del</strong> fronte) per meglio coordinare i movimenti <strong>dei</strong><br />
battitori. È, infatti, di fondamentale importanza mantenere l'allineamento e<br />
procedere ad una velocità costante lungo tutto il fronte di battuta, in modo da<br />
evitare la formazione di "buchi" o di "sacche" che permettano a qualche<br />
animale di rompere il fronte senza essere avvistato.<br />
Al termine <strong>del</strong>la battuta si è proceduto alla raccolta di tutte le schede per una<br />
prima verifica <strong>dei</strong> dati sul posto. Gli operatori che hanno segnato degli avvistamenti,<br />
sono stati intervistati singolarmente e messi a confronto con gli altri operatori e con i<br />
coordinatori. <strong>La</strong> consultazione immediata degli operatori ha permesso di individuare<br />
ed eliminare immediatamente gli eventuali doppi conteggi e di correggere eventuali<br />
errori di compilazione <strong>del</strong>le schede. I dati così corretti sono stati, successivamente,<br />
rielaborati ed analizzati.<br />
Gli unici dati sulla boscosità disponibili sono i dati ISTAT (Comunità Montana<br />
Appennino Parma Est, 1998) relativi ai comuni di Corniglio e Monchio <strong>del</strong>le Corti.<br />
Questi dati riportano l'indice di superficie boscata <strong>del</strong>l'intera area comunale. Da<br />
osservazioni sul campo si può ragionevolmente supporre che l'area <strong>dei</strong> due comuni<br />
compresa <strong>nel</strong> pre-parco possieda un indice di boscosità più alto di quello medio<br />
riferito a tutto il comune; tale indice è stato valutato pari al 70%. Siccome l'area <strong>del</strong><br />
pre-parco è pari a circa 8.000 ha totali, la superficie boscata risulta pari a circa 5.600<br />
ha.<br />
41
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
Pur essendo il cinghiale l’ungulato più difficile da censire, in quanto specie<br />
fortemente gregaria, mobile e non uniformemente distribuita sul territorio, due fattori<br />
consentono di estrapolare i dati:<br />
- la scelta di estese aree di battuta (81 ha in media);<br />
- la rilevante percentuale (8,7%) <strong>del</strong>l’intera superficie boscata <strong>del</strong> area di<br />
studio, che è stata oggetto di censimento.<br />
E' stata positiva anche la cooperazione che si è venuta progressivamente a<br />
creare tra persone d'estrazione sociale anche molto distante: cacciatori e studenti. Il<br />
censimento è stato anche occasione per socializzare, per scambiare idee ed opinioni<br />
tra studenti e cacciatori, tra cacciatori di valli ed organizzazioni diverse. Si ritiene<br />
che il censimento effettuato con il metodo <strong>del</strong>le battute per aree campione<br />
rappresenti un momento di aggregazione sociale molto importante, un momento di<br />
buona visibilità <strong>del</strong> <strong>Parco</strong> sul territorio, un momento educativo che può compensare i<br />
limiti indicati in precedenza (difficoltà organizzative, onerosità, ecc.) (Rossi 2001).<br />
1998 2000<br />
Area totale battuta 240 ha 488 ha<br />
Percentuale area battuta sulla superficie totale 3% 6,1%<br />
Percentuale area battuta sulla superficie boscata 4,3% 8,7%<br />
Numero di zone campione 10 6<br />
Superficie media aree campione 23,8 ha 81,3 ha<br />
Giornate necessarie 6 3<br />
Operatori intervenuti (media) 32 96<br />
Tabella 3:<br />
Dati riassuntivi <strong>del</strong>le aree di battuta<br />
42
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
6 Risultati<br />
6.1 Analisi <strong>del</strong>la <strong>dieta</strong><br />
Da gennaio a fine maggio 2001 sono stati trovati complessivamente 58<br />
escrementi di Lupo lungo 26 sentieri diversi, percorsi una o più volte, in relazione<br />
alla probabilità di rinvenimento di escrementi. Durante la ricerca sono stati<br />
complessivamente percorsi a piedi 227 km (Tabella 4).<br />
N°<br />
Descrizione <strong>del</strong> percorso <strong>del</strong><br />
sentiero<br />
km<br />
totali<br />
Numero di<br />
Altitudine media<br />
fatte<br />
(m.s. l. m)<br />
trovate<br />
1 Passo di Cirone 8,80 1325 13<br />
Passo di Cirone – Monte<br />
1351<br />
2 Borgognone – Groppo <strong>del</strong> 8,88 5<br />
Vescovo<br />
Passo di Cirone – Monte Corno –<br />
3 12,25 1331 5<br />
Prati <strong>del</strong> Tavola<br />
4 <strong>La</strong>g<strong>dei</strong> – <strong>La</strong>go Pradaccio 6,00 1273 0<br />
5 <strong>La</strong>g<strong>dei</strong> – <strong>La</strong>go Santo 7,00 1417 0<br />
6 <strong>La</strong>g<strong>dei</strong> – Monte Tavola 5,00 1391 0<br />
Passo Sillara – Monte Polo –<br />
7 32,25 1134 10<br />
Groppo Nuovo – Passo Sillara<br />
8 Passo Sillara – Monte Castagnole 1,50 1225 1<br />
Grammatica – Monte Quadro –<br />
9 14,63 1253 0<br />
Riana<br />
Passo <strong>del</strong>la Colla – Groppo Fosco<br />
10 10,88 1432 0<br />
– Monte Quadro – Grammatica<br />
11 <strong>La</strong>goni – Passo Fugicchia 1,88 1434 0<br />
Passo <strong>del</strong>la Colla – Monte Navert<br />
12 3,00 1458 0<br />
– <strong>La</strong> Posa<br />
Poggio <strong>del</strong> Tesoro – Passo di<br />
13 6,30 1186 2<br />
Casarola – Poggio Maslini<br />
14 Poggio <strong>del</strong> Ferro – Monte Caio 12,30 1400 0<br />
43
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
Schia – Corno di Caneto – Monte<br />
15 3,88 1410 3<br />
Caio<br />
Schia – Corno di Caneto – <strong>La</strong>latta<br />
16 5,00 1410 10<br />
<strong>del</strong> Cardinale<br />
Prato Spilla – <strong>La</strong>go Ballano –<br />
17 14,63 1391 0<br />
Prato Spilla<br />
<strong>La</strong>go Verde – Prato Spilla – <strong>La</strong>go<br />
18 4,75 1481 0<br />
Ballano<br />
<strong>La</strong>go Ballano – <strong>La</strong>go Verde-<br />
19 2,50 1505 0<br />
Cagnin<br />
Rigoso – <strong>La</strong>go Verdarolo – Prato<br />
20 9,75 1306 0<br />
Spilla<br />
Rigoso – <strong>La</strong>go Squincio – <strong>La</strong>go<br />
21 4,63 1226 0<br />
Scuro<br />
22 Selvapiana 16,00 802 4<br />
23 Valditacca – Passo <strong>del</strong>la Colla 5,38 1220 0<br />
Cima Nuda – Monte Palera –<br />
24 7,13 1263 0<br />
Monte Ronca Bora<br />
Berceto – Monte Tesa – Monte<br />
25 13,00 1134 0<br />
Borgognone – Passo di Cirone<br />
26 Prato Spilla – Monte Sillara 10,00 1730 5<br />
Media 8,43 1274 2<br />
Somma 227,28 58,00<br />
Tabella 4<br />
Caratteristiche <strong>dei</strong> transetti percorsi e numero di escrementi rinvenuti<br />
44
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
45
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
Mese Fatte trovate<br />
Gennaio 4<br />
Febbraio 11<br />
Marzo 11<br />
Aprile 21<br />
Maggio 11<br />
Totale 58<br />
Tabella 5<br />
Distribuzione mensile <strong>dei</strong> ritrovamenti di escrementi<br />
Quota km percorsi Fatte trovate<br />
(m.s.l.m.)<br />
1000 m<br />
206 54<br />
Tabella 6<br />
Escrementi trovati sopra e sotto i 1000 m di quota<br />
250<br />
200<br />
150<br />
km<br />
100<br />
50<br />
0<br />
Figura 7<br />
Fatte trovate sopra e sotto i 1000 m<br />
1000 m<br />
Altitudine<br />
km percorsi Fatte trovate<br />
46
km<br />
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
Categoria km percorsi Fatte trovate<br />
(m/s.l.m.)<br />
1(
Fatte trovate<br />
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
-5<br />
Figura 10<br />
Correlazione tra km percorsi <strong>nel</strong>le diverse classi di quota e<br />
escrementi raccolti<br />
R=0,95; n=8; p
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
49
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
6.1.1 Analisi degli escrementi<br />
Animale consumato numero % sulle fatte totale<br />
Capriolo Capreolus capreolus 35 38,89<br />
Cinghiale Sus scrofa 31 34,44<br />
Micromammiferi 8 8,89<br />
Vacca Bos taurus 6 6,67<br />
Cavallo Equus caballus 6 6,67<br />
Lepre Lepus europaeus 3 3,33<br />
Cane <strong>Canis</strong> familiaris 1 1,11<br />
Tabella 11<br />
Frequenza di comparsa <strong>del</strong>le diverse specie consumate<br />
Negli escrementi sono anche stati trovati coleotteri, ma la determinazione di questi<br />
ha evidenziato che si trattava di Scarabeidi Coprofagini <strong>del</strong> genere Ontofagus sp.,<br />
che sono coprofagi. Di conseguenza non sono stati ingeriti dal Lupo, ma hanno<br />
colonizzato l’escremento dopo la deposizione.<br />
Animale consumato % di comparsa totale % <strong>del</strong> volume totale<br />
Capriolo Capreolus capreolus 38,89 45,01<br />
Cinghiale Sus scrofa 34,44 28,65<br />
Micromammiferi 8,89 9,06<br />
Vacca Bos taurus 6,67 4,24<br />
Cavallo Equus caballus 6,67 4,85<br />
Lepre Lepus europaeus 3,33 7,58<br />
Cane <strong>Canis</strong> familiaris 1,11 0,61<br />
Tabella 12<br />
50
% <strong>del</strong> volume totale<br />
%<br />
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
50,00<br />
40,00<br />
30,00<br />
20,00<br />
10,00<br />
0,00<br />
50,00<br />
45,00<br />
40,00<br />
35,00<br />
30,00<br />
25,00<br />
20,00<br />
15,00<br />
10,00<br />
5,00<br />
0,00<br />
Figura 13<br />
Confronto tra frequenza di comparsa e volume percentuale<br />
Capriolo<br />
Cinghiale<br />
Micromammifero<br />
Vacca<br />
Cavallo<br />
Lepre<br />
% di comparsa <strong>nel</strong>le fatte totale % <strong>del</strong> volume totale<br />
Cane<br />
Figura 14<br />
Correlazione tra le percentuale di frequenza di comparsa e<br />
volume <strong>del</strong>le diverse specie consumate<br />
R = 0,97 n = 8; p < 0,001 R² = 0,9386<br />
0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00<br />
% di frequenza di comparsa<br />
51
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
9%<br />
Figura 15<br />
Volume in percentuale <strong>del</strong>le diverse specie consumate<br />
6% 5% 3% 1%<br />
31%<br />
45%<br />
Capriolo<br />
Cinghiale<br />
Micromammifero<br />
Lepre<br />
Vacca<br />
Cavallo<br />
Cane<br />
Dall'analisi degli escrementi si evidenzia che, sia utilizzando la frequenza di<br />
comparsa, sia il volume percentuale, il capriolo e il cinghiale <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong><br />
<strong>La</strong>ghi costituiscono la base alimentare <strong>del</strong> Lupo (Figura 15).<br />
Con il metodo <strong>del</strong>la frequenza di comparsa, gli animali con pelo più lungo e<br />
setoloso, quali il cinghiale, la vacca e il cavallo, tendono ad essere leggermente<br />
sovrastimati, ma in misura non-significativa (Tabelle 12, 13 e 14).<br />
Classe % volume consumato<br />
Selvatici 91,06<br />
Domestici 8,94<br />
Tabella 16<br />
Percentuali di animali selvatici e domestici consumati<br />
Sono classificati come “selvatici”:<br />
- Capriolo<br />
- Cinghiale<br />
- Micromammiferi<br />
- Lepre<br />
Sono classificati “domestici”:<br />
- Vacca<br />
- Cavallo<br />
- Cane<br />
52
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
Figura 17<br />
Animali selvatici e domestici consumati<br />
Domestici<br />
8,94<br />
Selvatici<br />
91,06<br />
<strong>La</strong> figura 17 evidenzia come, <strong>nel</strong> periodo invernale e primaverile, più <strong>del</strong><br />
90% degli alimenti consumati dal Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi è composto da<br />
animali selvatici.<br />
53
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
6.1.2 Resti di predazione<br />
Data<br />
<strong>del</strong>l'osservazione<br />
Specie Resti trovati Località<br />
20/02/00 1 cinghiale carcassa con segni di Guadine Pradaccio,<br />
predazione,<br />
orme ed escrementi di 3 lupi<br />
di fianco alla sassaia<br />
20/02/00 1 cinghiale morto probabilmente<br />
scappando lungo la sassaia,<br />
03/03/00 capriolo<br />
maschio<br />
carcassa ancora tiepida con<br />
morsi sul collo e accenno di<br />
sbranamento di una zampa<br />
posteriore<br />
Tracce di 2 grossi Canidi<br />
Guadine Pradaccio,<br />
di fianco alla sassaia<br />
Guadine Pradaccio,<br />
il lungo la strada<br />
06/03/00 capriolo Pelle, ossa, escrementi freschi<br />
di <strong>lupo</strong>, tracce di sangue e pelo<br />
già trovati il 03/03/00<br />
seguendo la pista partendo<br />
dalla carcassa trovata quel<br />
giorno<br />
Guadine Pradaccio<br />
16/11/00 capriolo pelle, ossa, viscere, orme, fatte Vicino a costale, San<br />
di faina e volpe<br />
Branato, Monchio<br />
10/05/01 capriolo pelle, viscere, orme, orme di<br />
grosso canide<br />
03/07/01 capriolo pelle, viscere, orme, orme di<br />
grosso canide<br />
Tabella 18<br />
Resti di predazione rinvenuti <strong>nel</strong> 2000-2001<br />
54<br />
Piana <strong>dei</strong> Germi c/o<br />
Briglia sul torrente<br />
Parma di Francia<br />
sotto strada da<br />
Cancelli verso<br />
<strong>La</strong>goni
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
Resti di predazione<br />
Carcassa di capriolo<br />
Carcasse di cinghiali<br />
55
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
6.2 Censimenti <strong>del</strong> Lupo<br />
6.2.1 Censimento su neve<br />
Durante il censimento <strong>del</strong> 2000, lungo il percorso n° 10 (dal Poggio <strong>del</strong><br />
Tesoro al Poggio <strong>del</strong>lo Zucchero), sono state rilevate le tracce fresche di due lupi. Le<br />
tracce sono state seguite a ritroso per circa 4 km fino ad un bosco di conifere senza<br />
neve al suolo, da cui probabilmente erano partiti gli animali. Sia <strong>nel</strong> censimento <strong>del</strong><br />
2000 che in quello <strong>del</strong> 2001, nei pressi <strong>del</strong> Passo <strong>del</strong> Cirone e <strong>del</strong> Passo di Sillara,<br />
sono state osservate le tracce di due lupi e sono stati trovati escrementi di <strong>lupo</strong><br />
contenenti pelo di cinghiale.<br />
Nel censimento <strong>del</strong> 2001 sono infine state osservate tracce di due lupi, con<br />
escrementi molto freschi, in località Selvapiana.<br />
In entrambi gli anni di monitoraggio sono stati conteggiate due coppie di lupi in<br />
settori <strong>del</strong> <strong>Parco</strong> sufficientemente distanti da far ritenere che si possa trattare di<br />
esemplari diversi.<br />
L'esperienza condotta in questo primo anno di attività, ha dimostrato<br />
l'efficacia <strong>dei</strong> censimenti su neve effettuati contemporaneamente da più operatori su<br />
aree ampie costituiscano una base alimentare importantissima per il <strong>lupo</strong>.<br />
6.2.2 Ululati<br />
L'indagine mediante richiamo acustico non ha, purtroppo, ad oggi, permesso<br />
di confermare la presenza accertata tra gli altri metodi all’interno <strong>del</strong> territorio <strong>del</strong><br />
<strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi.<br />
Purtroppo la tecnica <strong>del</strong> wolf-howling, per fornire buoni risultati, necessita di notti<br />
caratterizzate da una quasi totale assenza di vento, condizione questa molto rara <strong>nel</strong><br />
<strong>Parco</strong>.<br />
56
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
6.3 Censimenti degli ungulati<br />
Battuta Densità caprioli/100 ha<br />
Paduli di Cima* 23,6<br />
Tre fiumi 23,1<br />
<strong>La</strong>g<strong>dei</strong>** 18,7<br />
Passo Sisa** 17,3<br />
Sillara 10,7<br />
Sivizzo 16,6<br />
Tabella 19<br />
Densità <strong>del</strong> capriolo su superficie boscata <strong>nel</strong> 2001<br />
* Territorio compreso in AFV Alta Val Cedra<br />
** Territorio compreso in AFV Alta Val Parma<br />
Capriolo<br />
Densità media di caprioli sull’area di battuta totale 19,4/100 ha<br />
Consistenza numerica su superficie boscata totale 1.086<br />
Densità di caprioli su superficie totale <strong>del</strong> pre-parco 13,6/100 ha<br />
Cinghiale<br />
Densità media di cinghiali sull’area di battuta totale 5,9/100 ha<br />
Consistenza numerica su superficie boscata totale 332<br />
Densità di cinghiali su superficie totale <strong>del</strong> pre-parco 4,15/100 ha<br />
Tabella 20<br />
Dati riassuntivi <strong>dei</strong> risultati per l'area di pre-parco <strong>nel</strong> 2001<br />
Le battute di censimento, effettuate <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi, hanno permesso di<br />
evidenziare un’elevata densità <strong>del</strong> capriolo e <strong>del</strong> cinghiale, ma come si può<br />
riscontrare in tabella 20, il capriolo ha una densità tre volte superiore a quella <strong>del</strong><br />
cinghiale.<br />
57
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
CAPRIOLO CINGHIALE<br />
Percentuale <strong>del</strong> volume totale <strong>del</strong>le fatte 45,20 30,77<br />
Densità su superficie totale <strong>del</strong> pre-parco<br />
(animali/100ha)<br />
Tabella 21<br />
Consumo <strong>del</strong>la prede in confronto alla sua densità<br />
50,00<br />
40,00<br />
30,00<br />
20,00<br />
10,00<br />
0,00<br />
Tabella 22<br />
Consumo <strong>del</strong>la prede in confronte alla sua densità<br />
13,60 4,15<br />
CAPRIOLO CINGHIALE<br />
Percentuale dal volume <strong>del</strong>le fatte<br />
Densità su superfice totale <strong>del</strong> pre-parco n°/100ha<br />
Il consumo effettuato <strong>del</strong> Lupo su cinghiale e capriolo appare congruente alla loro<br />
densità.<br />
58
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
59
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
7 Discussione<br />
Il confronto tra i risultati <strong>del</strong>la presente ricerca, ed analoghi studi effettuati in diverse<br />
aree di studio europee (Tabella 23), permettono di rilevare come <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong><br />
<strong>La</strong>ghi, la proporzione di animali selvatici consumati dal Lupo sia paragonabile con<br />
quella rilevata, ad esempio, <strong>nel</strong>le Foreste Casentinesi che sono caratterizzate da una<br />
comunità di ungulati selvatici molto abbondante e diversificata. Analogamente si può<br />
rilevare come, in paragone a studi effettuati negli anni settanta, i dati più recenti<br />
evidenziano un sempre più preponderante contributo <strong>del</strong>la fauna selvatica, ed in<br />
particolare degli ungulati, alla <strong>dieta</strong> <strong>del</strong> Lupo.<br />
Area di studio Autori<br />
Periodo di<br />
collezione<br />
Frequenza di<br />
occorrenza di<br />
ungulati selvatici<br />
Arada e<br />
Portogallo*<br />
Peneda-Gerês,<br />
Vos 2000 1996 0<br />
Mercantour Mountains,<br />
France<br />
Poulle et al.<br />
1997<br />
1994-1995 80<br />
Foreste Casentinesi,<br />
Italia<br />
Mattioli et al.<br />
1995<br />
1988-1992 94,6<br />
Appennino settentrionale,<br />
Italia<br />
Meriggi et al.<br />
1991<br />
1987-1989 18<br />
<strong>Parco</strong> Nazionale <strong>del</strong>l'Abruzzo, Patalano e<br />
Italia<br />
Lovari 1993<br />
1981-1983 43,4<br />
Umbria, Valnerina,<br />
Italia<br />
Ragni et al.<br />
1982<br />
1977-1982 0<br />
Majella, Abruzzo,<br />
Italia<br />
Boitani 1982 1974-1977 0<br />
León Province,<br />
Spagna<br />
Salvador e<br />
Abdad 1987<br />
1984-1986 35,3<br />
Asturies,<br />
Spagna<br />
Secondo Meriggi et al 1996<br />
*Secondo Vos 2000<br />
Brana et al.<br />
1982<br />
ca 1980 39,8<br />
Sono solo stati considerati studi nei quali la <strong>dieta</strong> è stata determinata in base al<br />
contenuto <strong>del</strong>le fatte e i dati analizzati erano le frequenze assolute di occorrenza.<br />
Tabella 23<br />
Paragoni tra diversi studi<br />
<strong>La</strong> presente ricerca contribuisce a mettere in evidenza come, analogamente a quanto<br />
sta accadendo in molte aree <strong>del</strong>l’Appennino, anche negli ecosistemi forestali <strong>del</strong><br />
60
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
<strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi e <strong>del</strong>le aree ad esso circostanti, il Lupo è tornato ad occupare<br />
il ruolo di predatore di mammiferi selvatici, riducendo moltissimo gli attacchi al<br />
bestiame domestico. In corrispondenza con quanto si è verificato in altre regioni<br />
europee, il Lupo sembra in grado di indirizzare il suo sforzo di caccia ai danni <strong>del</strong>le<br />
prede più accessibili e più abbondanti; <strong>nel</strong>la Foresta Primaria di Bialowieza infatti,<br />
<strong>nel</strong> periodo compreso tra il 1946 ed il 1985, la <strong>dieta</strong> <strong>del</strong> <strong>lupo</strong> è cambiata<br />
drasticamente in relazione all’aumentata presenza <strong>nel</strong>la foresta degli ungulati<br />
selvatici (Jedrzejewska et al. 1996a, in Okarma 1995).<br />
Recentemente, in Europa sud-occidentale, la densità degli ungulati è aumentata e<br />
l'importanza <strong>del</strong> bestiame domestico <strong>nel</strong>la <strong>dieta</strong> <strong>del</strong> Lupo è diminuita<br />
significativamente; in Romania, infatti, <strong>nel</strong> periodo 1954 - 1967, gli animali<br />
domestici costituivano il 75% <strong>del</strong>la <strong>dieta</strong> <strong>del</strong> Lupo, mentre i selvatici solo il 25%.<br />
Nel 1991, le proporzioni si erano invertite, con un consumo di domestici <strong>del</strong> 22% ed<br />
una predazione sui selvatici <strong>del</strong> 78% (Alasman et al. 1970 e Ionescu 1992, in<br />
Okarma 1995).<br />
Nel <strong>Parco</strong> Regionale <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi la base alimentare <strong>dei</strong> lupi è risultata costituita<br />
principalmente da caprioli e cinghiali; queste due prede principali sono consumate in<br />
proporzione alla loro abbondanza <strong>nel</strong>la zona, solo occasionalmente, circa <strong>nel</strong> 10%<br />
<strong>dei</strong> casi, il Lupo ha utilizzato, per la sua alimentazione, prede di origine domestica.<br />
Studi condotti <strong>nel</strong> sud e nord Europa hanno dimostrato che le perdite di bestiame<br />
domestico dipendono in alcuni casi soprattutto dalle tecniche di protezione <strong>del</strong>le<br />
greggi attuate dai pastori, e dalla loro localizzazione nei confronti <strong>del</strong>le aree di<br />
distribuzione <strong>del</strong> Lupo (Nieminen et al. 1988, Banco et al. 1992, in Okarma 1995,<br />
Patalano e Lovari 1993, Meriggi e Lovari 1996).<br />
<strong>La</strong> sopravvivenza <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> parco <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi è garantita dalle buone densità<br />
di caprioli e cinghiali, mentre il bestiame domestico, presente solo in quantità molto<br />
limitata nei pascoli e <strong>nel</strong>le aree aperte in genere, non viene predato in maniera<br />
consistente perché è una preda poco abbondante.<br />
È dunque di estrema importanza che, <strong>nel</strong> programmare i piani di prelievo a carico di<br />
caprioli e cinghiali, si consideri che per tenere bassa la predazione sui pur pochi<br />
domestici <strong>del</strong>la zona, è importante mantenere le popolazioni di caprioli e cinghiali a<br />
livelli di densità tali da consentire al <strong>lupo</strong> di reperire cibo a sufficienza.<br />
D’altro canto, la presenza <strong>del</strong> <strong>lupo</strong> in Val Parma e in Val Cedra, può contribuire a<br />
mantenere sane e naturalmente selezionate le popolazioni di ungulati, evitando la<br />
61
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
diffusione di parassitosi ed altre patologie che affliggono le comunità di ungulati non<br />
sottoposte a predazione naturale.<br />
Studi condotti in Europa <strong>del</strong>l’est hanno messo in luce come l’impatto <strong>del</strong> <strong>lupo</strong> su<br />
caprioli e cinghiale possa assumere caratteristiche differenti: i caprioli infatti,<br />
soprattutto quando sono numerosi possono essere limitati dal Lupo, ma molto più<br />
difficile sembra essere una reale diminuzione <strong>del</strong> cinghiale a causa <strong>del</strong>la predazione<br />
(Litvinov 1981, in Okarma 1995).<br />
Pur se, secondo Rusakov et al. (1984, in Okarma 1995), la preferenza per un tipo di<br />
prede può essere perpetuata tra diverse generazioni ed una certa “inerzia”<br />
<strong>nel</strong>l’utilizzare nuove prede e nuovi alimenti può essere riscontrata <strong>nel</strong> <strong>lupo</strong>, gli studi<br />
condotti in Italia dimostrano che, da una quasi totale dipendenza <strong>del</strong> <strong>lupo</strong> da alimenti<br />
di origine antropica (rifiuti) riscontrata negli anni settanta (Boitani 1982), il <strong>lupo</strong> è<br />
stato in grado, in tempi relativamente brevi, di riacquisire l’originario ruolo di<br />
predatore di grossi e medi mammiferi.<br />
62
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
8 Conclusioni<br />
Il presente lavoro ha permesso di confermare la presenza <strong>del</strong> <strong>lupo</strong> <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong><br />
<strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi ed ha permesso inoltre di attribuire al Lupo il suo status di predatore<br />
selvatico, almeno per il periodo <strong>del</strong>lo studio (inverno e primavera).<br />
In considerazione degli estesi home range utilizzati dalla specie, sarebbe importante<br />
che in futuro le attività di censimento (snow tracking e wolf howling) venissero<br />
attuate su aree di dimensioni maggiori in collaborazione con gli enti territoriali<br />
competenti (<strong>Parco</strong> <strong>del</strong> Gigante, Province di Parma, di Massa e di <strong>La</strong> Spezia).<br />
L’aumento in termini di densità e distribuzione <strong>del</strong>le popolazioni di ungulati<br />
selvatici, risultato di reintroduzioni e <strong>del</strong>l’abbandono <strong>del</strong>le aree rurali, sono il<br />
presupposto che ha permesso il recupero recente <strong>del</strong> Lupo in diverse aree<br />
<strong>del</strong>l’Europa meridionale, da cui era scomparso <strong>nel</strong> secolo scorso. Mentre in passato il<br />
Lupo era accettato <strong>dei</strong> pastori come parte <strong>del</strong>l’ambiente rurale, la sua lunga assenza<br />
ha abbassato la tollerabilità degli allevatori verso questo animale.<br />
<strong>La</strong> reintroduzione simultanea di alcune specie di ungulati selvatici sembra essere una<br />
<strong>del</strong>le strategie migliori per diminuire la predazione <strong>del</strong> Lupo sul bestiame, e dunque<br />
per la conservazione <strong>del</strong> Lupo (Meriggi e Lovari 1996) ma, <strong>nel</strong> caso <strong>del</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong><br />
<strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi, dove esistono già comunità di ungulati sufficientemente abbondanti e<br />
diversificate, un contributo importante a far sì che il <strong>lupo</strong> venga accettato e rispettato,<br />
potrà essere fornito da ulteriori studi sulla sua ecologia e da un capillare sforzo di<br />
educazione ed informazione <strong>del</strong>le persone che ancora vivono in montagna.<br />
63
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
9 Bibliografia<br />
ARTONI L.M., 1999<br />
Ecologia alimentare <strong>del</strong> <strong>lupo</strong> (<strong>Canis</strong> <strong>lupus</strong>) in un area <strong>del</strong>le crete senesi. Tesi<br />
di <strong>La</strong>urea in Scienze Biologiche, Università degli studi di Parma<br />
BOITANI L., 1992<br />
Wolf research and conservation in Italy, Biological Conservation 61, p 125-<br />
132<br />
BOSCAGLI G., 1982<br />
Il censimento <strong>del</strong> <strong>lupo</strong> con la tecnica <strong>del</strong> wolf-howling : Possibilità e limiti.<br />
Atti <strong>del</strong> convegno nazionale "Gruppo Lupo Italia", Camerino 1985, p 7-14<br />
CAGNALORO L., ROSSO D., SPAGNESI M., VENTURI B., 1974<br />
Inchiesta sulla distribuzione <strong>del</strong> <strong>lupo</strong> (<strong>Canis</strong> <strong>lupus</strong> L.) in Italia e nei cantoni<br />
Ticino e Grigioni (Svizzera). Ricerche di biologia <strong>del</strong>la selvaggina 59, 91 p<br />
CARBYN L.N.,1975<br />
Wolf howling as a technique to ecosystem interpretation in national parks, p<br />
458-470. KLINGHAMMER E. (ed.): The behavior and ecology of wolves.<br />
Symposium on the behavior and ecology of wolves, Wilmington, N.C., 1975;<br />
Garland STPM Press, New York & London. ISBN 0-8240-7019-4<br />
C.E.M.A.GR.E.F., 1984<br />
Méthodes de recensement des populations de chevreuil. Note technique n° 51,<br />
Nogent sur Vernisson<br />
CITES, 2001<br />
CITES - listed species database : Fauna. Convention on International Trade<br />
in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. www.cites.org<br />
CIUCCI P., 1999<br />
Il censimento <strong>del</strong> <strong>lupo</strong> su neve. Projetteo Life natura Legambiente, 18 p<br />
CIUCCI P., BOITANI L., 1998a<br />
Il <strong>lupo</strong>. Elementi di biologia, gestione, ricerca. Istituto Nazionale per la fauna<br />
selvatica "Alessandro Ghigi. Documenti tecnici, 23. 114 p; ISSN 1121-4120<br />
CIUCCI P., BOITANI L., 1998b<br />
Wolf and dog depredation on livestock in central Italy. Wildlife society<br />
bulletin 26 (3), p 504-514<br />
CIUCCI P., BOITANI L., FRANCISCI F., ANDREOLI G., 1997<br />
Home range, activity and movements of a wolf pack in central Italy. Journal<br />
of Zoology, London 243, p 803-819<br />
COMUNITÀ MONTANA APPENNINO PARMA EST, 1998<br />
Piano di sviluppo socio-economico, annualità 1998-2000<br />
64
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
CORBETT L.K., 1989<br />
Assessing the diet of dingoes from feces: a comparison of 3 methods. Journal<br />
of wildlife management 53 (2), p 343-346<br />
CORSI F., DUPRE E., BOITANI L., 1999<br />
A large-scale mo<strong>del</strong> of wolf distribution in Italy for conservation planning.<br />
Conservation biology 13 (1), p 150-159<br />
DE BEAUFORT F., 1987<br />
Le Loup en France: éléments d'écologie historique. Encyclopédie des<br />
carnivores de France, SFEPM, 32 p<br />
FEDERHEN S., HARRISON I., HOTTON C., LEIPE D., SOUSSOV V.,<br />
STERNBERG R., TURNER S., 2001<br />
Taxonomy Browser, National Center for Biotechnology Information.<br />
www.NCBI.nlm.nih.gov, consultato il 29/06/01<br />
FERLONI M. E SIMONETTA A. M., 1998<br />
Cervidi. Principi e Tecniche di Gestione Faunistico-venatoria. Greentime.<br />
FERRARI U., 2000<br />
<strong>La</strong> comunità microteriologica nei macereti <strong>del</strong> <strong>Parco</strong> Regionale <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong><br />
<strong>La</strong>ghi. Tesi di <strong>La</strong>urea in scienze Naturali, Università degli Studi di Parma<br />
FICO R., 1996<br />
L'accertamento <strong>dei</strong> danni al bestiame causati da predatori. Atti <strong>del</strong> convegno<br />
"Dalla parte dal Lupo". WWF ItaliaSerie atti e studi. Cecere F.(ed.) 10, p 42-<br />
53<br />
FILIBECK U., NICOLI M., ROSSI P., BOSCAGLI G., 1982<br />
Metodologia per l'individuazione, mediante l'uso <strong>del</strong>l'analizzatore di<br />
frequenza, <strong>del</strong> numero di lupi che ululano in un coro. Atti <strong>del</strong> convegno<br />
nazionale "Gruppo Lupo Italia", Camerino 1985, p 14-19<br />
FLOYD T.J., MECH L.D., JORDAN P.A., 1978<br />
Relating wolf scat content to prey consumed. Journal of wildlife management<br />
42(3), p 528-532<br />
GENOVESI P., DUPRE E., 2000<br />
Strategia nazionale di conservazione <strong>del</strong> <strong>lupo</strong> (<strong>Canis</strong> <strong>lupus</strong>): indagine sulla<br />
presenza e la gestione <strong>dei</strong> cani vaganti in Italia. Biologia e conservazione<br />
<strong>del</strong>la fauna, INFS 104, 33 p<br />
GUBERTI V., FRANCISCI F., 1991<br />
Cause di mortalità di 60 lupi raccolti in Italia dal 1984. Supplementi Ricerche<br />
di biologia <strong>del</strong>la selvaggina vol. XIX, p 599-603<br />
65
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
GUBERTI V., STANCAMPIANO L., FRANCISCI F., 1993<br />
Intestinal helminth parasite community in wolves (<strong>Canis</strong> <strong>lupus</strong>) in Italy.<br />
Parassitologia 35, p59-65<br />
HARRINGTON F. H., MECH L. D., 1978<br />
Wolf and man. New York, San Francisco, London: Academic Press, Inc.,<br />
Wolf Vocalization, p 109-131.<br />
HARRINGTON F. H., MECH L. D., 1982<br />
An analysis of howling response parameters useful for wolf pack censusing.<br />
Journal of Wildlife Management 46 (3), p 686-693.<br />
KLINGHAMMER E., LAIDLAW L., 1975<br />
Analysis of 23 months of daily howl records in a captive grey wolf pack<br />
(<strong>Canis</strong> <strong>lupus</strong>), p 153-181. KLINGHAMMER E. (ed.): The behavior and<br />
ecology of wolves. Symposium on the behavior and ecology of wolves,<br />
Wilmington, N.C., 1975; Garland STPM Press, New York & London.<br />
ISBN 0-8240-7019-4<br />
KRUUK H., PARISH T., 1981<br />
Feeding specialisation of the european badger Meles meles in Scotland.<br />
Journal of animal ecology 50, p 773-788<br />
LOVARI C., MATTIOLI L., MAZZARONE V., PEDONE P. e SIEMONI N., 1989<br />
Confronto di due metodi di censimento <strong>del</strong> capriolo in ambiente montano<br />
appenninico. Atti II Seminario sui Censimenti Faunistici <strong>dei</strong> Vertebrati,<br />
Brescia<br />
MATTEUCCI C., MONTI F., CICOGNANI L., BERZI D., 1994<br />
<strong>La</strong> <strong>dieta</strong> <strong>del</strong> <strong>lupo</strong> in relazione alla disponibilità di prede <strong>nel</strong>l'Appennino toscoromagnolo.<br />
Riass. 1° Cong. Ital. Teriol., 27-29 Ottobre 1994, Pisa<br />
MATTIOLI L., APOLLONIO M., LAZZARONE V., CENTOFANTI E., 1995<br />
Wolf food habits and wild ungulate availability in the Foreste Casentinesi<br />
National Park, Italy. Acta Theriologica. 40, 387-402.<br />
MATTIOLI L., STRIGLIONI F., CENTOFANTI E., MAZZARONE V., SIEMONI<br />
N., LOVARI C., CRUDELE G., 1996<br />
Alimentazione <strong>del</strong> <strong>lupo</strong> <strong>nel</strong>le Foreste Casentinesi: relazioni con le popolazioni<br />
di ungulati selvatici e domestici. Atti <strong>del</strong> convegno "Dalla parte dal Lupo".<br />
WWF ItaliaSerie atti e studi. Cecere F.(ed.) p 100-112<br />
MERIGGI A., ROSA P., BRANGI A., MATTEUCCI C., 1991<br />
Habitat use and diet of the wolf in northern Italy. Acta Therologica 36, (1-2)<br />
p 141-151<br />
MERIGGI A., LOVARI S., 1996<br />
A review of wolf predation in Southern Europe: does the wolf prefer wild<br />
prey to livestock? Journal of applied ecology 33, p 1561-1571<br />
66
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
MSW, 1993<br />
Scientific name list. Mammal Species of the World, Smithsonian Institution.<br />
www.nmnh.si.edu, consultato il 29/06/01<br />
NOLLI P., 1997<br />
Il genere Apodemus (Rodentia) <strong>nel</strong>l’Alta Val Parma: Morfologia, struttura e<br />
dinamica <strong>del</strong>le popolazioni. Tesi di <strong>La</strong>urea in scienze Naturali, Università<br />
degli Studi di Parma<br />
OKARMA H., 1995<br />
The trophic ecology of wolves and their predatory role in ungulate<br />
communities of forest ecosystems in Europe. Acta Therologica 40(4), p 335-<br />
386<br />
PATALANO M., LOVARI S., 1993<br />
Food habits and trophic niche overlap of the wolf <strong>Canis</strong> <strong>lupus</strong>, L. 1758 and<br />
the red fox Vulpes vulpes (L. 1758) in a mediterranean mountain area. Revue<br />
écologique (Terre et vie) 48, p 279-294<br />
POULLE M.-L., CARLES L., LEQUETTE B., 1997<br />
Significance of ungulates in the diet of recently settled wolves in the<br />
Mercantour Mountains (Southeastern France). Revue écologique (Terre et<br />
vie) 52, p 357-368<br />
RANDI E., LUCCHINI V., CHRISTENSEN M.F., MUCCI N., FUNK S.M., DOLF<br />
G., LOESCHCKE V., 2000<br />
Mitochondrial DNA variability in Italian and East European wolves:<br />
Detecting the consequences of small population size and hybridization.<br />
Conservation biology 14 (2), p 464-473<br />
REGGIONI W., MERIGGI A., ALIERI F., 1998<br />
Effetti <strong>del</strong>la predazione <strong>del</strong> Lupo sulle popolazioni di Capriolo e Muflone <strong>nel</strong><br />
<strong>Parco</strong> Regionale <strong>del</strong>l’Alto Appennino Reggiano (<strong>Parco</strong> <strong>del</strong> Gigante). II<br />
Congresso Italiano di Teriologia, 28-30 Ottobre 1998, Varese.<br />
ROSSI P., 2001<br />
Relazione <strong>del</strong> censimento degli ungulati <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> cento <strong>La</strong>ghi<br />
SALVADOR A., ABAD P.L., 1987<br />
Food habits of a wolf population (<strong>Canis</strong> <strong>lupus</strong>) in Leòn province, Spain.<br />
Mammalia51 (1), p 45-52<br />
SICORELLO L., 1999<br />
Organizzazione sociale <strong>del</strong>l’Arvicola <strong>del</strong>le Nevi Chiomys nivalis (Martins<br />
1842). Tesi di <strong>La</strong>urea in scienze Naturali, Università degli Studi di Parma<br />
SMIETANA W., KLIMEK A., 1993<br />
Diet of wolves in the Bieszczady Mountains, Poland. Acta Therologica 38<br />
(3), p 245-251<br />
67
Université de Liège - Università degli Studi di Parma, a.a. 2000-2001, Cellina Sandra<br />
Dieta <strong>del</strong> Lupo <strong>nel</strong> <strong>Parco</strong> <strong>dei</strong> <strong>Cento</strong> <strong>La</strong>ghi<br />
STRANDGAARD H., 1972<br />
The roe deer population (Capreolus capreolus L. 1758) at Kalo and the<br />
factors regulating its size. Danish Reviews of Game Biology.<br />
TEERINK B.J., 1991<br />
Hair of West-European mammals. Cambridge University Press,<br />
ISBN 0-521-40264-6<br />
THEBERGE J. B., FALLS B. J., 1967<br />
Howling as a means of communication in timber wolves. American Zoologist<br />
7, p 331-338.<br />
VIGNALI G., PIOVANI P., ARDUINI F., 1998<br />
Appenino foresta d'Europa. Projetteo Life natura Regione Emilia-Romagna,<br />
183 p<br />
VOS J., 2000<br />
Food habits and livestock depredation of two Iberian wolf packs (<strong>Canis</strong> <strong>lupus</strong><br />
signatus) in the north of Portugal. Journal of zoology, London 251, p 457-462<br />
WEAVER J.L., 1993<br />
Refining the equation for interpreting prey occurrence in dry wolf scats.<br />
Journal of wildlife management 57 (3), p 534-538<br />
ZIEMEN E., BOITANI L., 1975<br />
Number and distribution of wolves in Italy. Zeitschrift für Säugetierkunde 40,<br />
p 102-112<br />
68