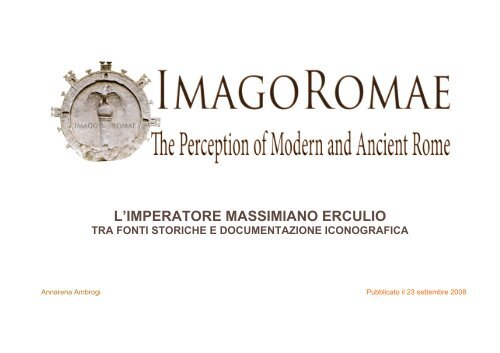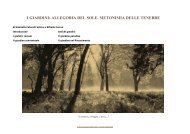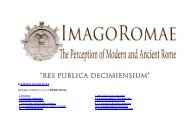L'IMPERATORE MASSIMIANO ERCULIO - Imago Romae
L'IMPERATORE MASSIMIANO ERCULIO - Imago Romae
L'IMPERATORE MASSIMIANO ERCULIO - Imago Romae
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
L’IMPERATORE <strong>MASSIMIANO</strong> <strong>ERCULIO</strong><br />
TRA FONTI STORICHE E DOCUMENTAZIONE ICONOGRAFICA<br />
di Annarena Ambrogi Pubblicato il 23 settembre 2008
Annarena Ambrogi L’imperatore Massimiano Erculio tra fonti storiche e documentazione iconografica<br />
Tra i nostri ricordi scolastici non può certo mancare quello relativo all’intricata e affascinante storia della crisi in cui precipitò l’impero romano nel III<br />
secolo d.C. e all’incredibile numero, particolarmente difficile da memorizzare, di imperatori, che si avvicendarono sul trono, a volte regnando solo per<br />
pochi mesi. Chi non ricorda che a introdurre un nuovo sistema di governo, la tetrarchia (il regno congiunto di quattro imperatori, due Augusti e due<br />
Cesari), in grado di risolvere i secolari problemi economici, sociali e difensivi di un impero ormai troppo vasto, fu il geniale Diocleziano?<br />
Di lui ricordiamo anche le Terme, i cui resti ancora dominano il paesaggio urbano di Roma. Esse, pur recando il suo nome, furono fatte erigere da un<br />
altro illustre romano, collega e amico di Diocleziano, spesso dimenticato o lasciato in secondo piano dagli storici antichi e moderni, ma che in realtà<br />
svolse un ruolo fondamentale nella storia di quegli anni. Egli, infatti, affiancò Diocleziano nella difficile impresa di risollevare le sorti di un impero ormai<br />
logorato da mille problemi interni e insidiato dalla sempre più forte pressione delle popolazioni barbariche dislocate lungo i confini.<br />
Si tratta di Gaius Aurelius Valerius Maximianus, noto più semplicemente come Massimiano Erculio, il cui appellativo dipende dallo stretto legame cultuale<br />
con il suo parens Ercole[1].<br />
La maggior parte delle nostre informazioni su Massimiano si ricava dai due<br />
panegirici che Mamertino compose in suo onore, il 21 aprile 289 e il 21 luglio (?)<br />
291; pur essendo per loro stessa natura tendenziosi, costituiscono una fonte<br />
preziosa, che riflette il punto di vista ufficiale della cancelleria imperiale[2].<br />
Tra le fonti cristiane, il De mortibus persecutorum di Lattanzio (250-325 ca.) può essere<br />
utile soprattutto per gli ultimi anni di Massimiano, mentre la Historia Ecclesiastica di<br />
Eusebio di Cesarea (265-340), è una fonte essenziale per la storia delle persecuzioni.<br />
Gli autori antichi mettono in risalto il carattere rozzo e la feroce brutalità di<br />
Massimiano, sottolineando che la sua indole rude e crudele si rispecchiava<br />
perfettamente nei tratti del volto. Soltanto le più tarde indicazioni di Malalas<br />
offrono un quadro diverso, tracciando un ritratto piuttosto idealizzato, che gli<br />
attribuisce capelli lisci, barba piena, carnagione scura, bel naso e begli occhi.<br />
Nominato Cesare nel 285 da Diocleziano, con il quale aveva condiviso le imprese<br />
militari giovanili, fu proclamato poco dopo, probabilmente già nel dicembre dello<br />
stesso anno, Augusto. Le sue grandi capacità militari e la necessità di difendere il<br />
limes renano, respingendo gli attacchi dei Franchi, avevano convinto Diocleziano a<br />
sceglierlo come collega e ad affidargli il governo della parte occidentale dell’Impero,<br />
con capitale a Milano.<br />
Massimiano, come abbiamo detto, aveva avuto una formazione prettamente militare:<br />
nato (tra il 241-246 oppure il21 luglio del 250: certamente era più giovane di<br />
Diocleziano) nelle vicinanze di Sirmium in Pannonia, da umili contadini, aveva fatto<br />
www.imagoromae.com<br />
Fig. 1 A - Medaglione aureo coniato a Roma nel 287,<br />
Diocleziano alla nostra sx., Massimiano a dx<br />
2
Annarena Ambrogi L’imperatore Massimiano Erculio tra fonti storiche e documentazione iconografica<br />
una rapida carriera nell’esercito, al comando degli imperatori Aureliano e Probo.<br />
Prima del 278 aveva sposato la siriana Galeria Valeria Eutropia (nata prima del 260?-<br />
330 d.C.), dalla quale poco dopo ebbe Massenzio e nel 292 circa Fausta.<br />
Famoso per la rapidità delle sue imprese, appena eletto Cesare riuscì a sconfiggere le<br />
bande armate dei Bagaudi, che infestavano la Gallia; successivamente combattè<br />
contro i Germani (286-288), ristabilendo una certa sicurezza lungo il limes renano, e<br />
contro la sollevazione di Carausio, che si era impadronito della Britannia,<br />
assumendo la porpora imperiale.<br />
Ma è nella primavera-estate del 289 che arrivò il primo eclatante insuccesso: la flotta<br />
romana, sotto il comando di Massimiano, fu miseramente distrutta, permettendo a<br />
Carausio una impunità di sette anni. Tale perdita inferse un colpo durissimo alla<br />
fama dell’Augusto minore e la sua carriera ne risultò per sempre compromessa.<br />
Diocleziano, infatti, volse le spalle all’antico amico e collega, convincendosi della sua<br />
incapacità a reggere da solo l’Occidente, cosicchéa Milano il 1 marzo del 293<br />
Massimiano fu costretto a conferire a Costanzo Cloro il titolo di Cesare: a<br />
quest’ultimo furono assegnate Gallia e Britannia (e la difficile impresa di sconfiggere<br />
Carausio).<br />
Contemporaneamente o poco più tardi, Galerio assunse la porpora imperiale a<br />
Nicomedia, alla presenza di Diocleziano: era nata la tetrarchia.<br />
www.imagoromae.com<br />
Fig. 1 B - L'altra faccia del medaglione aureo<br />
3
Annarena Ambrogi L’imperatore Massimiano Erculio tra fonti storiche e documentazione iconografica<br />
Fermo restando il principio che l’impero era patrimonium indivisum sotto la guida di<br />
Diocleziano, furono assegnate a Massimiano l’Italia (con la Sicilia e la Sardegna) e<br />
l’Africa e probabilmente anche la Spagna. Tra gli Augusti e i Cesari non c’era<br />
distinzione di competenze, ma solo divisione di compiti; infatti, mentre Costanzo si<br />
accingeva a sferrare l’attacco decisivo contro la Britannia, Massimiano accorse lungo<br />
il Reno, nella primavera inoltrata del 296, per guardargli le spalle ed impedire<br />
ulteriori incursioni barbariche.<br />
Le vittorie conseguite nel 298 da Massimiano sulle tribù maure della Cesariense,<br />
feroci, ma politicamente poco pericolose, concessero all’Africa un periodo di pace e<br />
di restaurazione politico-sociale. All’inizio del 299 l’Augusto d’Occidente giunse per<br />
la prima volta a Roma, ben accolto dal popolo e dal senato, e lì si incontrò, dopo<br />
otto anni, con Diocleziano.<br />
Gli anni seguenti furono macchiati dalle feroci persecuzioni cristiane: è nel 303 e<br />
304 chefurono emanati gli Editti anticristiani, la cui responsabilità è attribuita dalle<br />
fonti a Galerio, ma che certamente Massimiano si impegnò a far applicare con rigore<br />
in Occidente, mentre Costanzo in Britannia fu certamente più clemente.<br />
Il 20 novembre del 303 si celebrarono a Roma i vicennalia degli Augusti e i<br />
decennalia dei Cesari, contemporaneamente al dies imperii di Diocleziano, con una<br />
forzata anticipazione di quasi un anno rispetto al dies imperii di Massimiano, che<br />
sarebbe dovuto cadere nel 304.<br />
Si creò così una concordanza cronologica artificiosa, che con un preciso intento<br />
politico voleva sanzionare solennemente il sistema costituzionale tetrarchico,<br />
fondato sulla unità, sulla concordia e sulla successione pacifica al trono di coppie<br />
omogenee di Augusti e di Cesari. Infatti il 1 maggio del 305 avvenne la<br />
cerimonia congiunta dell’abdicazione dei due Augusti con la restituzione delle<br />
insegne del potere, davanti alla statua di Giove: Diocleziano a Nicomedia e<br />
Massimiano a Mediolanum.<br />
Quest’ultimo abdicò sotto la pressione di Diocleziano: le fonti menzionano<br />
apertamente il suo malcontento. Egli, allora, pur ritirandosi a vita privata, si stabilì<br />
non lontano da Roma per poter all’occorrenza intervenire: probabilmente al confine<br />
tra Campania e Lucania, nella zona di Salerno.<br />
www.imagoromae.com<br />
Fig. 2 A e Fig. 2 B (pag. successiva)<br />
Due aurei coniati (uno nella zecca di Roma) nel 288-293<br />
4
Annarena Ambrogi L’imperatore Massimiano Erculio tra fonti storiche e documentazione iconografica<br />
La successione pacifica vagheggiata da Diocleziano si dimostrò subito un’utopia: la<br />
scelta di Severo, Cesare d’Occidente, e di Massimiano Daia, d’Oriente, fu un errore<br />
di valutazione politica, che provocò il subitaneo deterioramento dei rapporti tra i<br />
tetrarchi. Inoltre, i figli di Massimiano e di Costanzo Cloro, Massenzio e<br />
Costantino, si sentivano in diritto di vantare diritti di successione, secondo il<br />
principio dinastico radicato tra i militari, in pieno contrasto con il principio<br />
adottivo preferito da Diocleziano.<br />
Presto gli eventi precipitarono: in seguito alla morte ad Eburacum (York), il 25 luglio<br />
306, di Costanzo Cloro, suo figlio Costantino fu acclamato Augusto dalle truppe,<br />
ignorando il Cesare Severo. Galerio allora elevò Severo al ruolo di Augusto<br />
d’Occidente, riconoscendo a Costantino il ruolo di Cesare.<br />
A Roma Massenzio, considerato il legittimo erede al trono, il 28 ottobre del 306,<br />
assunse il titolo di princeps invictus, richiamando a Roma il padre in qualità di<br />
imperator Caesar Augustus.<br />
Severo, fallito il tentativo di assediare Roma nel marzo del 307, si rifugiò a Ravenna,<br />
dove, dopo aver restituito la porpora, morì nell’autunno del 307, ormai inutile<br />
intralcio ai vincitori.<br />
Intanto, all’inizio di aprile del 307, Costantino aveva sposato Fausta, la figlia minore<br />
di Massimiano, a lui promessa già da bambina: ciò avrebbe legato, secondo il<br />
principio dei matrimoni incrociati tra le famiglie dei tetrarchi, Costantino a<br />
Massimiano.<br />
Quest’ultimo, dopo un inutile tentativo di strappare la porpora imperiale dalle<br />
spalle del figlio Massenzio, strenuamente difeso dai soldati e dai pretoriani, fu<br />
costretto a fuggire da Roma e a rifugiarsi in Gallia dal genero Costantino, che, pur<br />
ospitandolo, considerò il suocero come homo privatus e non sostenne mai la sua<br />
causa: si limitò alla deferenza formale, senza i sostanziali aiuti militari, necessari per<br />
consolidarne la posizione.<br />
Per trovare una soluzione alla crisi dell’Occidente, nel novembre del 308, fu indetto<br />
un congresso a Carnuntum (Illirico), in cui Diocleziano, accordatosi con Galerio,<br />
costrinse Massimiano ad abdicare nuovamente. Poco dopo, Licinio fu proclamato il<br />
nuovo Augusto dell’Occidente.<br />
www.imagoromae.com<br />
5
Annarena Ambrogi L’imperatore Massimiano Erculio tra fonti storiche e documentazione iconografica<br />
La sollevazione dei Franchi fornì a Massimiano l’occasione per un nuovo tentativo<br />
di rivolta: mentre Costantino era occupato a sedare la rivolta, Massimiano ad Arles<br />
assunse per la terza volta la porpora. Rimasto, però, senza appoggio militare, fuggì<br />
alla volta di Marsiglia, dove Costantino lo raggiunse con le sue truppe.<br />
Furono i militari stessi a tradire Massimiano, aprendo le porte della città e<br />
consegnandolo al suo destino. Massimiano cercò fino all’ultimo di non arrendersi,<br />
arrivando perfino ad ordire un attentato contro il genero con l’aiuto della figlia<br />
Fausta, ma avvertito da quest’ultima, Costantino si fece sostituire da un eunuco,<br />
cogliendo il suocero sul fatto.<br />
Queste ultime tragiche vicende sono piuttosto confuse: certamente si può<br />
confermare la partecipazione di Fausta e l’estremo, disperato, tentativo di<br />
Massimiano. Poco dopo (agli inizi del 310 a Marsiglia), fu trovato appeso alla trave<br />
della sua camera: si uccise (o fu ucciso), impiccandosi.<br />
Costantino probabilmente si trovò nella necessità di eliminare il suocero per<br />
mettersi al sicuro da qualsiasi altro complotto. Forse alla fine ci fu anche un<br />
riavvicinamento tra Massimiano e Massenzio, avendo entrambi come nemico<br />
comune Costantino. Secondo l’autore dell’Epitome de Caesaribus morì all’età di<br />
sessant’anni.<br />
Qualche tempo dopo la morte, Massenzio proclamò Massimiano divus, attribuendo<br />
la responsabilità della sua tragica fine a Costantino. La damnatio memoriae venne<br />
decretata più tardi, quando Costantino scese in Italia per lo scontro decisivo contro<br />
Massenzio. Sembra anzi che sia stato proprio il Senato di Roma a sancire, dopo la<br />
vittoria di Ponte Milvio (28 ottobre 312), in omaggio al vincitore, la condanna di<br />
Massenzio e quella di suo padre.<br />
www.imagoromae.com<br />
Fig. 3 - Rappresentazione dei Tetrarchi sulle coppie di colonne porfiretiche,<br />
inserite nell’angolo sud-ovest della facciata meridionale della Basilica<br />
di S. Marco, a Venezia. .<br />
6
Annarena Ambrogi L’imperatore Massimiano Erculio tra fonti storiche e documentazione iconografica<br />
Fig. 4 A - Diocleziano e Galerio<br />
www.imagoromae.com<br />
Fig. 4 B - Costanzo Cloro e Massimiano<br />
7
Annarena Ambrogi L’imperatore Massimiano Erculio tra fonti storiche e documentazione iconografica<br />
Fig. 5 A - Costanzo Cloro<br />
www.imagoromae.com<br />
Fig. 5 B - Diocleziano<br />
8
Annarena Ambrogi L’imperatore Massimiano Erculio tra fonti storiche e documentazione iconografica<br />
Solo in un secondo momento probabilmente il corpo di Massimiano fu traslato a<br />
Milano, sua residenza preferita, dove è probabile che si fosse fatto costruire un<br />
mausoleo. Dalle fonti sappiamo che, in conseguenza della condanna alla damnatio<br />
memoriae, furono abbattute le statue e i ritratti di Massimiano e le iscrizioni che lo<br />
menzionavano: questo è un dato importante per la ricostruzione dell’identità storica<br />
ed iconografica dell’Augusto di Occidente.<br />
In effetti le uniche immagini certe di Massimiano sono quelle monetali, mentre dei<br />
ritratti scultorei attribuitigli, nessuna identificazione risulta sicura ed accettata con<br />
unanimità dalla comunità scientifica.<br />
Le difficoltà di identificazione sono aggravate dalla nuova temperie formale<br />
tardoantica, che nella costruzione dei volumi prediligeva forme stereometriche, a<br />
massa compatta, e nella resa fisionomica semplificava ed affievoliva i tratti facciali<br />
sulla superficie del blocco, disponendoli secondo le regole della simmetria e<br />
dell’uguaglianza, intorno al punto focale costituito dallo sguardo.<br />
I ritratti imperiali tetrarchici, perciò, ci appaiono come immagini spersonalizzate: gli<br />
imperatori diventano tutti uguali, in perfetta sintonia con il programma politico<br />
dioclezianeo, che pone alla base della costruzione tetrarchica la concordia e l’unità<br />
imperiale, entrambe dipendenti dalla perfetta similitudo dei tetrarchi, poiché la<br />
somiglianza è l’immagine stessa della loro concordia. Inoltre, in questo periodo al<br />
fenomeno della similitudo si affianca quello dello scambio di effigie tra i tetrarchi;<br />
alcune zecche creano perfino tipi generici (le cd. effigi banali) copiati da altre<br />
monete e adattabili ad ogni dinasta.<br />
Nonostante ciò, le immagini monetali di riferimento per Massimiano rimangono<br />
quelle coniate nelle zecche occidentali dell’Impero, in quella parte cioè sotto il suo<br />
diretto governo: esse appaiono più individualizzate e attendibili.<br />
In questi ritratti Massimiano è rappresentato sempre in età avanzata e, nelle ultime,<br />
già con aspetto senile. Egli si caratterizza, distinguendosi da Diocleziano (FIGG.1A e<br />
1B), per la sagoma più massiccia e pesante, per gli occhi rotondi, il mento forte e<br />
prominente, le guance ricoperte da un collare di barba, il collo possente e massiccio.<br />
La fronte è bassa e rugosa, leggermente svasata verso l’alto, il naso breve e all’insù,<br />
mentre gli occhi hanno la palpebra superiore molto arcuata.<br />
www.imagoromae.com<br />
Figg. 6 / 7A / 7B - Coppia di tetrarchi (Diocleziano e Massimiano).<br />
Gruppo scultoreo conservato presso la Biblioteca Vaticana<br />
9
Annarena Ambrogi L’imperatore Massimiano Erculio tra fonti storiche e documentazione iconografica<br />
I tratti rivelano un aspetto brutale e rozzo, concordante con la descrizione lasciataci<br />
dai cronisti e in armonia con il carattere rude descritto da Lattanzio (FIGG.2A e<br />
2B). Gli stessi principi di uniformità fisionomica e di forte astrazione geometrica<br />
caratterizzano anche la ritrattistica plastica tetrarchica.<br />
Per simboleggiare la coesione di tutto l’impero, pur nella divisione territoriale, i<br />
tetrarchi si fanno rappresentare in gruppo, allacciati in uno stretto abbraccio, come<br />
sulle coppie di colonne porfiretiche conservate a Venezia, inserite nell’angolo sudovest<br />
della facciata meridionale della Basilica di S. Marco (FIGG. 3), e nella<br />
Biblioteca Vaticana. Le prime provengono dal complesso monumentale del<br />
Philadelphion di Costantinopoli (come rivela il ritrovamento del piede mancante di<br />
una figura del gruppo), da dove furono prelevate dai Veneziani durante la IV<br />
Crociata nel 1204.<br />
Esse presentano i quattro personaggi in un identico costume militare, composto dal<br />
paludamentum e dalla corazza attraversata da una ricca cintura gemmata, e reggono<br />
ognuno nella mano sinistra una lunga spada con manico a testa di aquila e fodero<br />
tempestato di gemme.<br />
Indossano il pileus pannonicus, il tipico cappello cilindrico che Eutropio (storico del<br />
IV secolo) ci dice introdotto da Diocleziano. I visi, simili l’uno all’altro, sono<br />
costruiti geometricamente, con volti ovali, occhi a mandorla, pesantemente delineati<br />
e sormontati da sopracciglia drammaticamente arcuate. Rughe profonde solcano<br />
con linee orizzontali la fronte, verticali la radice del naso.<br />
www.imagoromae.com<br />
10
Annarena Ambrogi L’imperatore Massimiano Erculio tra fonti storiche e documentazione iconografica<br />
I capelli sono a calotta unitaria liscia, con netta demarcazione sulla fronte e sulle<br />
tempie. La barba corta, con brevi tratti incisi, è portata solo dal tetrarca di sinistra:<br />
quello più anziano, l’Augusto. Nuova è l’iconografia dell’abbraccio: con tale gesto,<br />
oltre al concetto di Concordia augustorum e di fratellanza, si vuole alludere<br />
all’ordinato equilibrio delle successioni, al regolare trapasso dei poteri dagli Augusti<br />
ai Cesari, su cui si basa la stabilità dell’impero.<br />
Gli studiosi hanno proposto di riconoscere nel gruppo del lato est: Galerio, glabro, e<br />
Diocleziano, barbato; nell’altro gruppo sul lato nord, invece, Costanzo Cloro e<br />
Massimiano (FIGG. 4A / 4B e 5A / 5B): l’immagine, con l’ovale corto e di forma<br />
larga e appiattita, la fronte bassa, il collo tozzo e massiccio e la mascella quadrata,<br />
riflette abbastanza da vicino le fattezze di Massimiano sulle monete occidentali.<br />
Collegato al gruppo di Venezia è l’analogo gruppo conservato nella Biblioteca<br />
Vaticana (FIGG. 6 e 7A / 7B): probabile è la provenienza delle due colonne gemelle<br />
dal tempio del Sole di Aureliano (tra piazza S. Silvestro e via del Corso) a Roma.<br />
Secondo la maggioranza degli studiosi una coppia raffigura i due Augusti, l’altra i<br />
Cesari. Nel gruppo vaticano l’unico elemento distintivo non è la barba, essendo tutti<br />
e quattro i personaggi barbati, ma la presenza in una coppia di rughe profonde sulla<br />
fronte, probabilmente connotanti la loro maggiore età ed esperienza: si tratterebbe<br />
allora degli Augusti, Diocleziano e Massimiano.<br />
www.imagoromae.com<br />
Fig. 8 - Testa barbata di marmo bianco attribuita a Massimiano<br />
11
Annarena Ambrogi L’imperatore Massimiano Erculio tra fonti storiche e documentazione iconografica<br />
Altri ritratti sono stati attribuiti a Massimiano anche dalla critica più recente, ma,<br />
nonostante i numerosi tentativi, le uniche testimonianze certe, escludendo le teste<br />
generiche dei gruppi porfiretici, rimangono soltanto quelle monetali, poiché nessun<br />
ritratto plastico del rude, ma tenace tetrarca di Occidente sembra potersi identificare<br />
con assoluta certezza.<br />
Tutti e quattro i personaggi recano una corona di alloro e stringono un globo nella<br />
mano sinistra. I corpi, tozzi e cubici, sono rappresentati frontalmente e senza<br />
riguardo per le forme anatomiche.<br />
Una testa barbata di marmo bianco, rinvenuta nella villa gallo-romana di Chiragan<br />
(Alta Garonna, Francia) e conservata nel Museo di Toulouse, è stata attribuita da<br />
alcuni a Massimiano: essa appartiene ad un gruppo di quattro ritratti, tutti di grandi<br />
dimensioni, che raffigurano, oltre all’uomo barbato, una donna, un bambino e una<br />
bambina: rispettivamente Massimiano (FIG. 8), Galeria Valeria Eutropia (FIG. 9),<br />
Massenzio (FIG. 10) e Galeria Valeria Massimilla (FIG. 11), figlia di Galerio, che<br />
sposò Massenzio nel 293.<br />
L’identificazione che più di qualsiasi altra ha riscosso il consenso degli studiosi è<br />
quella con il ritratto conservato nelle Civiche Raccolte Archeologiche di Milano<br />
(inv. A 1158) (FIG. 12), sebbene anche in questo caso non manchino pareri<br />
discordi. Si tratta, comunque, di un capolavoro della ritrattistica tardoantica, che<br />
rappresenta un uomo di età matura, ma ancora nel pieno vigore fisico.<br />
La qualità pregevole del modellato naturalistico del viso, le sue dimensioni maggiori<br />
del vero indicano che si tratta del ritratto di un imperatore, sebbene dobbiamo<br />
ricordare che le grandi dimensioni in questo periodo costituiscono un dato<br />
importante, ma non esclusivo della ritrattistica imperiale, essendo il formato<br />
monumentale un privilegio anche delle persone di alto rango.<br />
L’intensa espressività del volto, sottolineata dalla sobria rugosità di guance e fronte,<br />
si concentra nella zona oculare con lo sguardo rivolto obliquamente. La cronologia<br />
del pezzo oscilla tra il III e il V secolo; è stato anche considerato un falso moderno.<br />
Animata è la discussione sull’identificazione del personaggio raffigurato: secondo<br />
alcuni si tratterebbe di Massimino Trace (235-238), ma la maggioranza degli studiosi<br />
vi riconosce Massimiano Erculio.<br />
www.imagoromae.com<br />
Fig. 9 - Galeria Valeria Eutropia<br />
12
Annarena Ambrogi L’imperatore Massimiano Erculio tra fonti storiche e documentazione iconografica<br />
Quest’ultima proposta è confortata dalla provenienza del pezzo dai dintorni di<br />
Milano, dove era la residenza dell’Augusto di Occidente e dalla congruenza con le<br />
sue immagini monetali.<br />
ANNARENA AMBROGI<br />
NOTE<br />
[1] Per le notizie storiche ed iconografiche ricordiamo in particolare: Paulys<br />
Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft, XIV, 2, s.v. Maximianus<br />
Herculius, cc. 2486-2516 (Ensslin); Enciclopedia dell’Arte Antica, IV, s.v. Massimiano<br />
Erculio,pp. 921-923 (F.Panvini Rosati); R. Calza, Iconografia imperiale romana, Roma<br />
1972, pp. 119-131; A.Pasqualini, Massimiano Erculio. Per un’interpretazione della figura<br />
e dell’opera, Roma 1979.<br />
[2] Brevi cenni su Massimiano, ma di particolare valore, essendo le uniche<br />
narrazioni organiche sulla tetrarchia, sono contenuti nella Origo Constantini, da<br />
porre intorno al 337-360, e nei classici breviari di Aurelio Vittore (fu praefectus urbi<br />
nel 389, pubblicò le sue Historiae abbreviatae nel 360), di Eutropio (nei suoi Breviarii<br />
ab Urbe condita, dedicati all’imp. Valente (364-378) e dell’anonima Epitome de<br />
Caesaribus, sempre del IV secolo. Tra i bizantini dobbiamo ricordare Malalas (491-<br />
578), un siro ellenizzato del sec. VI, che compose un compendio di storia universale,<br />
però, spesso privo di senso critico.<br />
www.imagoromae.com<br />
13
Annarena Ambrogi L’imperatore Massimiano Erculio tra fonti storiche e documentazione iconografica<br />
Fig. 10 - Massenzio Fig. 11 - Galeria Valeria Massimilla<br />
www.imagoromae.com<br />
14
Annarena Ambrogi L’imperatore Massimiano Erculio tra fonti storiche e documentazione iconografica<br />
Fig. 12 B - Massimiano Erculio<br />
Questo/a opera è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons<br />
www.imagoromae.com<br />
15