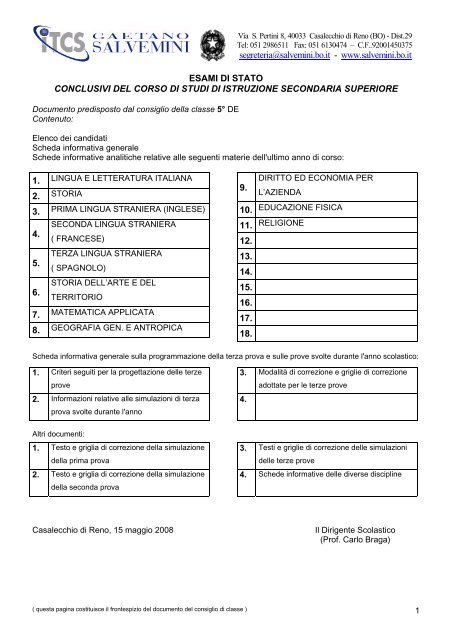You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Via S. Pertini 8, 40033 Casalecchio di Reno (BO) - Dist.29<br />
Tel: 051 2986511 Fax: 051 6130474 – C.F..92001450375<br />
segreteria@salvemini.bo.it - www.salvemini.bo.it<br />
<strong>ESAMI</strong> <strong>DI</strong> <strong>STATO</strong><br />
CONCLUSIVI DEL CORSO <strong>DI</strong> STU<strong>DI</strong> <strong>DI</strong> ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE<br />
Documento predisposto dal consiglio della classe 5° DE<br />
Contenuto:<br />
Elenco dei candidati<br />
Scheda informativa generale<br />
Schede informative analitiche relative alle seguenti materie dell'ultimo anno di corso:<br />
1. LINGUA E LETTERATURA ITALIANA<br />
2. STORIA<br />
3. PRIMA LINGUA STRANIERA (INGLESE)<br />
SECONDA LINGUA STRANIERA<br />
4.<br />
( FRANCESE)<br />
5.<br />
6.<br />
7.<br />
8.<br />
TERZA LINGUA STRANIERA<br />
( SPAGNOLO)<br />
STORIA DELL’ARTE E DEL<br />
TERRITORIO<br />
MATEMATICA APPLICATA<br />
GEOGRAFIA GEN. E ANTROPICA<br />
( questa pagina costituisce il frontespizio del documento del consiglio di classe ) 1<br />
9.<br />
<strong>DI</strong>RITTO ED ECONOMIA PER<br />
L’AZIENDA<br />
10. EDUCAZIONE FISICA<br />
11. RELIGIONE<br />
12.<br />
13.<br />
14.<br />
15.<br />
16.<br />
17.<br />
18.<br />
Scheda informativa generale sulla programmazione della terza prova e sulle prove svolte durante l'anno scolastico:<br />
1. Criteri seguiti per la progettazione delle terze<br />
prove<br />
2. Informazioni relative alle simulazioni di terza<br />
prova svolte durante l'anno<br />
Altri documenti:<br />
1. Testo e griglia di correzione della simulazione<br />
della prima prova<br />
2. Testo e griglia di correzione della simulazione<br />
della seconda prova<br />
3. Modalità di correzione e griglie di correzione<br />
adottate per le terze prove<br />
4.<br />
3. Testi e griglie di correzione delle simulazioni<br />
delle terze prove<br />
4. Schede informative delle diverse discipline<br />
Casalecchio di Reno, 15 maggio 2008 Il Dirigente Scolastico<br />
(Prof. Carlo Braga)
Documento del Consiglio di Classe Elenco dei candidati interni ed esterni<br />
Classe: 5D ERICA<br />
Anno Scolastico: 2007/2008<br />
Numero candidati interni: 22 Numero candidati esterni: 0<br />
Cognome e Nome Provenienza Annotazioni<br />
1. BARONE MORENA ITC <strong>Salvemini</strong><br />
2. BERTI ENRICO ITC <strong>Salvemini</strong><br />
3. BERTI VERONICA ITC <strong>Salvemini</strong><br />
4. CAMPEGGI<br />
FRANCESCA<br />
ITC <strong>Salvemini</strong><br />
5. COLOMBARI ALICE ITC <strong>Salvemini</strong><br />
6. <strong>DI</strong> STASIO LIA ITC <strong>Salvemini</strong><br />
7. DON<strong>DI</strong>NI ANDREA ITC <strong>Salvemini</strong><br />
8. FANTONI VALENTINA ITC <strong>Salvemini</strong><br />
9. FIORI FRANCESCA ITC <strong>Salvemini</strong><br />
10. GHERAR<strong>DI</strong> ROBERO ITC <strong>Salvemini</strong><br />
11. LAZZARINI STEFANO ITC <strong>Salvemini</strong><br />
12. MATAROZZI STEPHANIE ITC <strong>Salvemini</strong><br />
13. MAZZA GABRIELE ITC <strong>Salvemini</strong><br />
14. MAZZOLI AMANDA ITC <strong>Salvemini</strong><br />
15. MIROTTA VALENTINA ITC <strong>Salvemini</strong><br />
16. MORALES LUDMILA ITC <strong>Salvemini</strong><br />
17. ROCCHETTA<br />
FRANCESCO<br />
ITC <strong>Salvemini</strong><br />
18. ROVATTI KALINKA ITC <strong>Salvemini</strong><br />
19. SAMPIERI RICCARDO ITC <strong>Salvemini</strong><br />
20. SERRA FEDERICA ITC <strong>Salvemini</strong><br />
21. VIGNOLI NICOL ITC <strong>Salvemini</strong><br />
22. VURCHIO VERONICA ITC <strong>Salvemini</strong><br />
2
Documento del Consiglio di Classe Scheda Informativa Generale<br />
1. Docenti del Consiglio di Classe<br />
Docente Materia Classe/i<br />
Membro Interno<br />
(SI/NO)<br />
GIORGINI MASSIMO ITALIANO E STORIA NO<br />
SBARRA PATRIZIA PRIMA LINGUA INGLESE SI<br />
ROSSI GIULIANA SECONDA LINGUA FRANCESE SI<br />
GUISE SOPHIE CONVERSAZIONE FRANCESE NO<br />
PEZZUOLI ALESSANDRA TERZA LINGUA SPAGNOLO SI<br />
VAL<strong>DI</strong>VIA CONVERSAZIONE SPAGNOLO NO<br />
PELAGATTI LAURA STORIA DELL’ARTE E DEL TERRITORIO NO<br />
FACCIOLI FABIO MATEMATICA APPLICATA NO<br />
CORTICELLI ANDREA GEOGRAFIA GEN. E ANTROPICA SI<br />
GIORGI FRANCO <strong>DI</strong>RITTO ED ECONOMIA PER L’AZIENDA SI<br />
ACERBO SILVIA EDUCAZIONE FISICA NO<br />
MARCHINI GIANSTEFANO CAMILLO RELIGIONE NO<br />
2. Storia della Classe ( situazione iniziale ed evoluzione nel corso del Triennio )<br />
La classe è composta da 22 alunni tutti provenienti dalla classe 3DErica di questo istituto nella<br />
quale hanno iniziato la frequenza del triennio . La classe ha avuto continuità didattica nel<br />
triennio nelle discipline Italiano, Inglese, francese, matematica e storia dell’Arte . Economia e<br />
spagnolo dal quarto anno e geografia ha cambiato insegnante nel quinto anno. Il percorso del<br />
triennio è stato regolare e il gruppo classe non ha subito variazioni. Nel complesso gli studenti<br />
hanno dimostrato motivazione nello studio e interesse alla propria riuscita scolastica. Il profitto e<br />
la continuità nello studio personale appaiono eterogenei e diversificati nelle materie. Nel corso<br />
del triennio diversi studenti hanno consolidato un metodo di studio che denota autonomia e<br />
organizzazione e che ha portato a risultati positivi e in alcuni casi eccellenti ;la maggior parte<br />
della classe ha raggiunto nelle varie discipline gli obiettivi previsti con un profitto sufficiente,<br />
discreto e in diversi casi eccellente. Permangono alcune situazioni di incertezza nel metodo di<br />
lavoro che non hanno sempre permesso di raggiungere un sicuro livello di rendimento.<br />
La partecipazione e la concentrazione durante le lezioni non hanno sempre corrisposto alle<br />
attese e alle buone potenzialità della classe che ha spesso dimostrato eccessiva vivacità di<br />
comportamento e talvolta mancanza di autogestione e di autocontrollo soprattutto nei momenti<br />
di lezione interattiva o di assenza degli insegnanti. Questo comportamento ha in alcuni casi<br />
reso più difficile e meno proficuo lo svolgimento delle lezioni.<br />
Per quanto riguarda lo svolgimento dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi previsti<br />
nelle singole discipline si rimanda alle schede informative delle singole materie.<br />
3
3. Attività pluridisciplinari svolte durante l’anno in corso e obiettivi raggiunti<br />
Non sono state previste specifiche attività pluridisciplinari nel corso dell’anno. Gli insegnanti<br />
hanno comunque sempre tenuto in considerazione il programma dell’ultimo anno nelle diverse<br />
discipline, sottolineando o realizzando quando possibile riferimenti e collegamenti anche in<br />
considerazione dei percorsi individuali da presentare al colloquio di esame e dello svolgimento<br />
del colloquio stesso.<br />
4. Attività di recupero svolte durante l’anno in corso e obiettivi raggiunti<br />
• Recupero in itinere in tutte le discipline.<br />
• Per le altre attività di recupero si vedano le schede informative delle singole materie.<br />
5. Attività svolte durante l’anno scolastico nell’area di progetto e obiettivi raggiunti<br />
Titolo<br />
Argomenti trattati<br />
e/o materie<br />
coinvolte<br />
Obiettivi<br />
Un secolo di storia tra letterature e arte<br />
Coordinatrice prof.ssa Giuliana Rossi<br />
Periodo storico dal 1850 al primo dopoguerra: quadro storico-sociale.<br />
Grandi movimenti letterari ed artistici.Presentazione ed analisi di<br />
alcuni temi fondamentali : scenari di città,le classi sociali,la<br />
donna,l’artista,immagini dell’altro e le culture diverse, la guerra.<br />
L’argomento scelto e i temi trattati hanno coinvolto diverse discipline :<br />
storia, letterature italiana, inglese, francese, spagnola, storia dell’arte,<br />
geografia.<br />
La realizzazione dell’area di progetto ha permesso di acquisire una<br />
certa consapevolezza nella consultazione delle fonti, nella fase di<br />
ricerca e di realizzazione del prodotto di ogni gruppo e della classe.<br />
6. Metodi utilizzati durante l’attività didattica, utilizzo di laboratori e strumentazioni<br />
didattiche<br />
Sono stati adottati i seguenti metodi didattici:<br />
• Lezione frontale<br />
• Lezione interattiva<br />
• Lavoro a coppie/gruppi<br />
• Discussione in classe, con interventi spontanei o sollecitati<br />
• Problem Solving<br />
Sono stati utilizzati seguenti strumenti:<br />
• Manuale e/ fotocopie<br />
• Laboratorio di Lingue<br />
• Laboratorio di Informatica<br />
• Registratore, videoregistratore<br />
• Lavagna luminosa<br />
4
7. Criteri e strumenti di valutazione<br />
Strumenti per la verifica<br />
Strumenti utilizzati per la verifica formativa:<br />
Strumenti utilizzati per la verifica<br />
sommativa:<br />
Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale<br />
• Raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari<br />
• Metodo di studio<br />
• Partecipazione all’attività didattica<br />
• Impegno<br />
• Progresso nell’apprendimento<br />
• Livello della classe<br />
• Domande flash<br />
• Rapida sintesi della lezione precedente<br />
• Esercizi alla lavagna e/o in gruppo e<br />
correzione immediata<br />
• Discussione lavori di gruppo<br />
• Esposizione orale di un testo<br />
• Interrogazione lunga<br />
• Interrogazione breve<br />
• Tema<br />
• Prove strutturate/semistrutturate<br />
• Questionario a domande aperte<br />
• Relazione<br />
• Problemi/esercizi<br />
• Lettura e analisi di testi con questionario<br />
relativo ( lingue straniere )<br />
• Corrispondenza turistica e commerciale,<br />
itinerari ( lingue straniere )<br />
5
Criteri per la corrispondenza fra voti e livelli di conoscenza e abilità: (secondo quanto definito<br />
nel POF)<br />
Livello<br />
Gravement<br />
e<br />
insufficient<br />
e<br />
Insufficient<br />
e<br />
Sufficiente<br />
Buono<br />
Distinto<br />
Ottimo<br />
Quando lo studente:<br />
Non dà alcuna informazione sull’argomento proposto;<br />
Non coglie il senso del testo;<br />
La comunicazione è incomprensibile.<br />
Quando lo studente:<br />
Riferisce in modo frammentario;<br />
Produce comunicazioni poco chiare;<br />
Si avvale di un lessico povero e/o improprio.<br />
Quando lo studente:<br />
Individua gli elementi essenziali dei problemi affrontati;<br />
Espone con semplicità, sufficiente proprietà e<br />
correttezza;<br />
Si avvale, soprattutto di capacità mnemoniche.<br />
Quando lo studente:<br />
Coglie la complessità dei problemi affrontati;<br />
Sviluppa analisi corrette;<br />
Espone con lessico appropriato e corretto.<br />
Quando lo studente:<br />
Possiede conoscenze complete;<br />
Sviluppa abilità applicative e di rielaborazione autonoma;<br />
Espone con linguaggio tecnico puntuale.<br />
Quando lo studente:<br />
Definisce e discute con competenza i termini della<br />
problematica;<br />
Sviluppa sintesi concettuali organiche ed anche<br />
personalizzate;<br />
Mostra proprietà, ricchezza e controllo dei mezzi<br />
espressivi;<br />
Apporta contributi originali.<br />
8. Modalità di gestione del colloquio orale e criteri di valutazione<br />
Per lo svolgimento del colloquio vengono individuate le seguenti modalità:<br />
1° fase:<br />
Valutazione<br />
in decimi<br />
fino a 4,5<br />
4,5 < voto <<br />
6<br />
6 ≤ voto < 7<br />
7 ≤ voto < 8<br />
8 ≤ voto < 9<br />
9 ≤ voto ≤<br />
10<br />
Presentazione e discussione di un percorso pluridisciplinare proposto e<br />
presentato dal candidato, collegato agli argomenti di studio dell’anno in corso,<br />
illustrato attraverso mappe concettuali o materiale documentario di<br />
approfondimento, anche in forma multimediale.<br />
2° fase: Esposizione di argomenti di interesse disciplinare e interdisciplinare attinenti al<br />
lavoro didattico svolto nell’ultimo anno, proposti dai docenti.<br />
3° fase: Discussione delle prove di esame.<br />
6
Criteri di valutazione per lo svolgimento del colloquio:<br />
• Conoscenza dei contenuti<br />
• Capacità di applicazione delle conoscenze teoriche<br />
• Capacità di operare collegamenti<br />
• Capacità di rielaborare<br />
• Capacità espressive<br />
• Conoscenza e uso dei linguaggi tecnici specifici<br />
9. Attività integrative ed extracurriculari svolte nell’ambito della programmazione<br />
attività di orientamento Orientamento post-diploma :<br />
• Presentazione delle facoltà universitarie il 07/02/08<br />
• Incontri con esperti aziendali :<br />
- introduzione al colloquio di lavoro e simulazioni<br />
- rapporti fra banche e imprese per lo sviluppo di<br />
un business plan<br />
- “Aziende e studenti 2007 “ convegno<br />
viaggio di istruzione Siviglia<br />
visite guidate Museo MAMBO, Museo MORAN<strong>DI</strong><br />
incontri nell'ambito del progetto Salute e sessualità: malattie sessualmente trasmesse,<br />
salute<br />
altre attività (tirocini estivi,<br />
laboratori, stage all'estero,<br />
ecc.)<br />
prevenzione oncologica.<br />
Spettacolo teatrale e film in lingua inglese<br />
Visione del film In questo mondo libero di K. Loach<br />
Incontro con CEFA ( ONG) sul tema del sottosviluppo<br />
Corsi ed esami di certificazione linguistica Inglese , Francese,<br />
livelli B1 e B2<br />
__________________________________________________<br />
____<br />
Terzo anno : viaggio di istruzione a Vienna<br />
Quarto anno : stage linguistico a Versailles-Parigi<br />
7
Documento del Consiglio di Classe Scheda Informativa Generale relativa alle simulazioni<br />
1. Simulazioni delle prime due prove d'esame<br />
data di svolgimento tempo di<br />
svolgimento<br />
Simulazione delle prima prova 29 aprile 2008 8-13.30 5.30 h<br />
Simulazione della seconda<br />
prova<br />
28 aprile 2008 8-13.30 5.30 h<br />
2. Criteri seguiti per la progettazione delle simulazioni di terza prova<br />
La terza prova coinvolge potenzialmente tutte le discipline dell’ultimo anno di studi. Il Consiglio<br />
di Classe tuttavia, tenuto conto del curriculum di studi, degli obiettivi generali e cognitivi definiti<br />
nella programmazione didattica, ha individuato come oggetto delle 2 simulazioni in<br />
preparazione della Terza Prova scritta degli Esami di Stato le seguenti discipline:<br />
Prima simulazione ( 27 febbraio 2008)<br />
A. Matematica<br />
B. Storia dell’Arte<br />
C. Geografia<br />
D. Inglese<br />
E. Francese<br />
Seconda simulazione ( 28 aprile 2008)<br />
F. Matematica<br />
G. Economia<br />
H. Storia<br />
I. Inglese<br />
J. Spagnolo<br />
8
3. Informazione relative alla simulazione di terza prova svolte durante l’anno<br />
Durante l’anno scolastico, in coerenza con quanto sopraindicato, sono state effettuate 2<br />
simulazioni di Terza Prova i cui testi vengono allegati a titolo esemplificativo.<br />
Simulazione n° 1<br />
Data di<br />
svolgiment<br />
o<br />
Tempo<br />
Assegnat<br />
o<br />
27/2/2008 5 ore<br />
Simulazione n° 2<br />
Data di<br />
svolgiment<br />
o<br />
Tempo<br />
Assegnat<br />
o<br />
28/472008 5 ore<br />
Materie coinvolte nella prova<br />
Tipologie di verifica<br />
( Tip. A, B, … )<br />
Matematica B 2<br />
Storia dell’Arte B con immagine 2<br />
Geografia B 2<br />
Inglese B 2<br />
Francese B con breve testo 2<br />
Materie coinvolte nella prova<br />
Tipologie di verifica<br />
( Tip. A, B, … )<br />
Matematica B 2<br />
Economia B 2<br />
Storia B 2<br />
Inglese B con breve testo 2<br />
Spagnolo B con breve testo 2<br />
4. Modalità di correzione e criteri di valutazione adottati per le prove<br />
N° quesiti<br />
per materia<br />
N° quesiti<br />
per materia<br />
Dopo che ogni insegnante ha corretto la parte riguardante la propria materia utilizzando griglie<br />
differenziate, per la valutazione complessiva della prova è stata usata la griglia allegata.<br />
Esiti delle simulazioni della Terza Prova riportati dal gruppo classe:<br />
Simulazione n° 1<br />
Data Materia Valutazione<br />
complessiva<br />
Matematica<br />
27/02/2008<br />
Storia dell’Arte<br />
Geografia<br />
Inglese<br />
Francese<br />
10.1<br />
9
Simulazione n° 2<br />
Data Materia Valutazione<br />
complessiva<br />
Matematica<br />
28/04/2008<br />
Economia<br />
Storia<br />
Inglese<br />
Spagnolo<br />
11.5<br />
10
Il presente documento è condiviso all’unanimità dal Consiglio di Classe della 5° DE in<br />
tutte le sue parti.<br />
Docente Firma<br />
ACERBO SILVIA ________________________________________<br />
CORTICELLI ANDREA ________________________________________<br />
FACCIOLI FABIO ________________________________________<br />
GIORGI FRANCO ________________________________________<br />
GIORGINI MASSIMO ________________________________________<br />
GUISE SOPHIE ________________________________________<br />
MARCHINI GIANSTEFANO CAMILLO ________________________________________<br />
PELAGATTI LAURA ________________________________________<br />
PEZZUOLI ALESSANDRA ________________________________________<br />
ROSSI GIULIANA ________________________________________<br />
SBARRA PATRIZIA ________________________________________<br />
VAL<strong>DI</strong>VIA MAYA ________________________________________<br />
Casalecchio, 15 maggio 2008<br />
11
Griglia di correzione della 1^ prova<br />
SIMULAZIONE PRIMA PROVA<br />
studente:_______________________________ tema: _________<br />
indicatori descrittori punteggio<br />
contenuto<br />
sviluppo<br />
aspetto<br />
formale<br />
voto in<br />
10.mi<br />
voto in<br />
15.mi<br />
pertinenza, qualità e<br />
Mancato rispetto delle consegne e<br />
contenuti per lo più inadeguati<br />
Rispetto parziale delle consegne e<br />
quantità dei contenuti contenuti superficiali o non sempre<br />
(tip. B) rispetto delle adeguati<br />
consegne, conformità del Complessivo rispetto delle consegne e<br />
testo con il titolo contenuti essenziali ma pertinenti<br />
assegnato e con la Completo rispetto delle consegne e<br />
destinazione indicata contenuti puntuali e approfonditi<br />
Completo rispetto delle consegne e<br />
contenuti puntuali, approfonditi e arricchiti<br />
da conoscenze personali<br />
Evidenti contraddizioni<br />
nell’argomentazione e totale mancanza di<br />
organizzazione, linearità rielaborazione<br />
d’argomentazione, Elaborazione superficiale con sviluppo<br />
coerenza<br />
incoerente o poco lineare<br />
approfondimento Argomentazione semplice ma lineare e<br />
capacità di analisi e di fondamentalmente coerente<br />
rielaborazione<br />
Sviluppo abbastanza approfondito,<br />
coerente e con elementi di rielaborazione<br />
personale<br />
Sviluppo approfondito, coerente e con<br />
apprezzabile rielaborazione personale<br />
Linguaggio molto elementare e con errori<br />
correttezza<br />
gravi<br />
scorrevolezza<br />
Linguaggio semplice ma<br />
adeguatezza lessicale fondamentalmente corretto<br />
ed espositiva Linguaggio corretto, appropriato e<br />
scorrevole<br />
punteggi<br />
o<br />
attribuito<br />
1<br />
2-3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
1<br />
2-3<br />
totale 15<br />
tabelle di conversione<br />
1 1.5 2 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 7 7.5 8 9 10<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15<br />
voto in 3<br />
10.mi<br />
4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10<br />
voto in 9<br />
35.mi<br />
14 16 18 20 22 24 26 27-28 29 30-31 32 33-34 35<br />
4<br />
5<br />
6<br />
1<br />
2<br />
3<br />
12
1 - TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO<br />
Con quale inflessione di voce e quale atteggiamento d'occhi e di mani, curvandosi, come<br />
chi regge rassegnatamente su le spalle un peso insopportabile, il magro giudice D'Andrea<br />
soleva ripetere: «Ah, figlio caro!» a chiunque gli facesse qualche scherzosa osservazione per il<br />
suo strambo modo di vivere!<br />
Non era ancor vecchio; poteva avere appena quarant'anni; ma cose stranissime e quasi<br />
inverosimili, mostruosi intrecci di razze, misteriosi travagli di secoli bisognava immaginare per<br />
giungere a una qualche approssimativa spiegazione di quel prodotto umano che si chiamava il<br />
giudice D'Andrea.<br />
E pareva ch'egli, oltre che della sua povera, umile, comunissima storia familiare, avesse<br />
notizia certa di quei mostruosi intrecci di razze, donde al suo smunto sparuto viso di bianco eran<br />
potuti venire quei capelli crespi gremiti da negro; e fosse consapevole di quei misteriosi infiniti<br />
travagli di secoli, che su la vasta fronte protuberante gli avevano accumulato tutto quel groviglio<br />
di rughe e tolto quasi la vista ai piccoli occhi plumbei, e scontorto tutta la magra, misera<br />
personcina.<br />
Cosí sbilenco, con una spalla piú alta dell'altra, andava per via di traverso, come i cani.<br />
Nessuno però, moralmente, sapeva rigar piú diritto di lui. Lo dicevano tutti.<br />
Vedere, non aveva potuto vedere molte cose, il giudice D'Andrea; ma certo moltissime ne<br />
aveva pensate, e quando il pensare è piú triste, cioè di notte.<br />
Il giudice D'Andrea non poteva dormire.<br />
Passava quasi tutte le notti alla finestra a spazzolarsi una mano a quei duri gremiti suoi<br />
capelli da negro, con gli occhi alle stelle, placide e chiare le une come polle di luce, guizzanti e<br />
pungenti le altre; e metteva le piú vive in rapporti ideali di figure geometriche, di triangoli e di<br />
quadrati, e, socchiudendo le palpebre dietro le lenti, pigliava tra i peli delle ciglia la luce d'una di<br />
quelle stelle, e tra l'occhio e la stella stabiliva il legame d'un sottilissimo filo luminoso, e vi<br />
avviava l'anima a passeggiare come un ragnetto smarrito.<br />
Il pensare cosí di notte non conferisce molto alla salute. L'arcana solennità che acquistano i<br />
pensieri produce quasi sempre, specie a certuni che hanno in sé una certezza su la quale non<br />
possono riposare, la certezza di non poter nulla sapere e nulla credere non sapendo, qualche<br />
seria costipazione. Costipazione d'anima, s'intende.<br />
E al giudice D'Andrea, quando si faceva giorno, pareva una cosa buffa e atroce nello<br />
stesso tempo, ch'egli dovesse recarsi al suo ufficio d'Istruzione ad amministrare - per quel tanto<br />
che a lui toccava - la giustizia ai piccoli poveri uomini feroci.<br />
Come non dormiva lui, cosí sul suo tavolino nell'ufficio d'Istruzione non lasciava mai<br />
dormire nessun incartamento, anche a costo di ritardare di due o tre ore il desinare e di rinunziar<br />
la sera, prima di cena, alla solita passeggiata coi colleghi per il viale attorno alle mura del paese.<br />
Questa puntualità, considerata da lui come dovere imprescindibile, gli accresceva<br />
terribilmente il supplizio. Non solo amministrare la giustizia gli toccava; ma d'amministrarla cosí,<br />
su due piedi.<br />
Per poter essere meno frettolosamente puntuale, credeva d'ajutarsi meditando la notte.<br />
Ma, neanche a farlo apposta, la notte, spazzolando la mano a quei suoi capelli da negro e<br />
guardando le stelle, gli venivano tutti i pensieri contrarii a quelli che dovevano fare al caso per<br />
lui, data la sua qualità di giudice istruttore; cosí che, la mattina dopo, anziché aiutata, vedeva<br />
insidiata e ostacolata la sua puntualità da quei pensieri della notte e cresciuto enormemente lo<br />
stento di tenersi stretto a quell'odiosa sua qualità di giudice istruttore.<br />
Il testo sopra riportato è l’inizio della novella La patente, di Luigi Pirandello, pubblicata per la<br />
prima volta sul “Corriere della sera” nel 1911.<br />
13
1. Comprensione del testo<br />
Riproponi brevemente, con parole tue, la descrizione del personaggio del giudice D’Andrea<br />
2. Analisi del testo<br />
a) Quali elementi vengono messi in evidenza da Pirandello nella descrizione del<br />
personaggio? E quali informazioni importanti vengono taciute? formula qualche ipotesi<br />
sul perché di queste scelte d’autore<br />
b) Nella parte iniziale del brano la descrizione sembra usare il linguaggio tipico di un<br />
preciso movimento culturale (“mostruosi intrecci di razze”, “prodotto umano”): sei in<br />
grado di identificare quella tradizione culturale e i suoi derivati in campo narrativo?<br />
c) Che cosa significa: “L'arcana solennità che acquistano i pensieri produce quasi sempre,<br />
specie a certuni che hanno in sé una certezza su la quale non possono riposare, la<br />
certezza di non poter nulla sapere e nulla credere non sapendo, qualche seria<br />
costipazione. Costipazione d'anima, s'intende”<br />
d) Per quale ragione, secondo te, al giudice D’Andrea, “pareva una cosa buffa e atroce<br />
nello stesso tempo, ch'egli dovesse recarsi al suo ufficio d'Istruzione ad amministrare -<br />
per quel tanto che a lui toccava - la giustizia ai piccoli poveri uomini feroci”?<br />
e) Soffermati sull’espressione “una cosa buffa e atroce”: è un concetto ricollegabile alla<br />
poetica di Pirandello?<br />
3. Interpretazione complessiva e approfondimenti<br />
a) Come viene rappresentato, in Pirandello, il rapporto fra intime aspirazioni e/o desideri<br />
dell’individuo e doveri sociali?<br />
b) Il brano riportato contiene in gran parte la descrizione di un personaggio: come cambia il<br />
personaggio letterario nella narrativa del Novecento? quali nuovi tipi umani e sociali si<br />
affacciano sulla scena?<br />
14
2- TIPOLOGIA B - REDAZIONE <strong>DI</strong> UN “SAGGIO BREVE” O <strong>DI</strong> UN “ARTICOLO <strong>DI</strong><br />
GIORNALE”<br />
(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti)<br />
CONSEGNE<br />
Sviluppa l’argomento scelto o in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale”, utilizzando i<br />
documenti e i dati che lo corredano.<br />
Se scegli la forma del “saggio breve”, interpreta e confronta i documenti e i dati forniti e su<br />
questa base svolgi,argomentandola, la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue<br />
conoscenze ed esperienze di studio.<br />
Da’ al saggio un titolo coerente con la tua trattazione e ipotizzane una destinazione editoriale<br />
(rivista specialistica,fascicolo scolastico di ricerca e documentazione, rassegna di argomento<br />
culturale, altro).<br />
Se lo ritieni, organizza la trattazione suddividendola in paragrafi cui potrai dare eventualmente<br />
uno specifico titolo.<br />
Se scegli la forma dell’ “articolo di giornale”, individua nei documenti e nei dati forniti uno o più<br />
elementi che ti sembrano rilevanti e costruisci su di essi il tuo ‘pezzo’.<br />
Da’ all’articolo un titolo appropriato ed indica il tipo di giornale sul quale ne ipotizzi la<br />
pubblicazione (quotidiano,rivista divulgativa, giornale scolastico, altro).<br />
Per attualizzare l’argomento, puoi riferirti a circostanze immaginarie o reali (mostre, anniversari,<br />
convegni o eventidi rilievo).<br />
Per entrambe le forme di scrittura non superare le quattro o cinque colonne di metà di foglio<br />
protocollo.<br />
1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO<br />
ARGOMENTO: I luoghi dell’anima nella tradizione artistico-letteraria.<br />
Chiare, fresche e dolci acque,<br />
ove le belle membra<br />
pose colei che sola a me par donna;<br />
gentil ramo ove piacque<br />
(con sospir mi rimembra)<br />
a lei di fare al bel fianco colonna;<br />
erba e fior che la gonna<br />
leggiadra ricoverse non poria<br />
co l’angelico seno;<br />
aere sacro, sereno,<br />
ove Amor co’ begli occhi il cor m’aperse:<br />
DOCUMENTI<br />
date udïenza insieme<br />
a le dolenti mie parole estreme.<br />
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<br />
La morte fia men cruda<br />
se questa spene porto<br />
a quel dubbioso passo:<br />
ché lo spirito lasso<br />
mai in piú riposato porto<br />
né in piú tranquilla fossa<br />
fuggir la carne travagliata e l’ossa.<br />
F. PETRARCA, Il Canzoniere, CXXVI, 1345<br />
Frate Lorenzo: Tu sei esiliato di qui, da Verona; pazienza, il mondo è grande e vasto.<br />
Romeo: Non esiste mondo fuori delle mura di Verona: non c’è che purgatorio, supplizio,<br />
l’inferno stesso.<br />
Essere esiliato di qui, vuol dire essere esiliato dal mondo e l’esilio dal mondo è la morte: l'esilio<br />
è dunque una morte sotto falso nome.<br />
W. SHAKESPEARE, Giulietta e Romeo, atto III, scena III<br />
15
Te beata, gridai, per le felici<br />
aure pregne di vita, e pe' lavacri<br />
che da' suoi gioghi a te versa Apennino!<br />
Lieta dell'aer tuo veste la Luna<br />
di luce limpidissima i tuoi colli<br />
per vendemmia festanti, e le convalli<br />
popolate di case e d'oliveti<br />
mille di fiori al ciel mandano incensi:<br />
e tu prima, Firenze, udivi il carme<br />
che allegrò l'ira al Ghibellin fuggiasco,<br />
e tu i cari parenti e l'idïoma<br />
Sempre caro mi fu quest'ermo colle,<br />
e questa siepe, che da tanta parte<br />
dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.<br />
Ma sedendo e mirando, interminati<br />
spazi di là da quella, e sovrumani<br />
silenzi, e profondissima quïete<br />
io nel pensier mi fingo, ove per poco<br />
il cor non si spaura. E come il vento<br />
désti a quel dolce di Calliope labbro<br />
che Amore in Grecia nudo e nudo in Roma<br />
d'un velo candidissimo adornando,<br />
rendea nel grembo a Venere Celeste;<br />
ma piú beata che in un tempio accolte<br />
serbi l'itale glorie, uniche forse<br />
da che le mal vietate Alpi e l'alterna<br />
onnipotenza delle umane sorti<br />
armi e sostanze t' invadeano ed are<br />
e patria e, tranne la memoria, tutto.<br />
U. FOSCOLO, I Sepolcri, 1806<br />
odo stormir tra queste piante, io quello<br />
infinito silenzio a questa voce<br />
vo comparando: e mi sovvien l'eterno,<br />
e le morte stagioni, e la presente<br />
e viva, e il suon di lei. Così tra questa<br />
immensità s'annega il pensier mio:<br />
e il naufragar m'è dolce in questo mare.<br />
G. LEOPAR<strong>DI</strong>, L’Infinito, dai «Canti», 1819<br />
«Addio, monti sorgenti dall'acque, ed elevati al cielo; cime inuguali, note a chi è cresciuto tra<br />
voi, e impresse nella sua mente, non meno che lo sia l’aspetto de' suoi più familiari; torrenti, de'<br />
quali distingue lo scroscio, come il suono delle voci domestiche; ville sparse e biancheggianti<br />
sul pendìo, come branchi di pecore pascenti; addio! Quanto è tristo il passo di chi, cresciuto tra<br />
voi, se ne allontana!...Addio, casa natìa, dove, sedendo, con un pensiero occulto, s’imparò a<br />
distinguere dal rumore de’ passi comuni il rumore d’un passo aspettato con un misterioso<br />
timore…Addio, chiesa, dove l’animo tornò tante volte sereno, cantando le lodi del Signore;<br />
dov’era promesso, preparato un rito; dove il sospiro segreto del cuore doveva essere<br />
solennemente benedetto, e l’amore venir comandato, e chiamarsi santo; addio!»<br />
A. MANZONI, I promessi sposi, VIII, 1840<br />
Sempre un villaggio, sempre una campagna<br />
mi ride al cuore (o piange), Severino:<br />
il paese ove, andando, ci accompagna<br />
l'azzurra vision di San Marino:<br />
sempre mi torna al cuore il mio paese<br />
cui regnarono Guidi e Malatesta,<br />
cui tenne pure il Passator cortese,<br />
re della strada, re della foresta.<br />
Là nelle stoppie dove singhiozzando<br />
va la tacchina con l'altrui covata,<br />
presso gli stagni lustreggianti, quando<br />
lenta vi guazza l'anatra iridata,<br />
oh! fossi io teco; e perderci nel verde,<br />
e di tra gli olmi, nido alle ghiandaie,<br />
gettarci l'urlo che lungi si perde<br />
dentro il meridiano ozio dell'aie;<br />
…………………………………….<br />
G. PASCOLI, Myricae, 1882<br />
16
«…si udiva il mare che russava lì vicino, in fondo alla straduccia, e ogni tanto sbuffava, come<br />
uno che si volti e rivolti pel letto…. Le stelle ammiccavano più forte, quasi s'accendessero, e i<br />
Tre Re scintillavano sui fariglioni colle braccia in croce, come Sant'Andrea. Il mare russava in<br />
fondo alla stradicciuola, adagio adagio, e a lunghi intervalli si udiva il rumore di qualche carro<br />
che passava nel buio, sobbalzando sui sassi, e andava pel mondo il quale è tanto grande che<br />
se uno potesse camminare e camminare sempre, giorno e notte, non arriverebbe mai, e c'era<br />
pure della gente che andava pel mondo a quell'ora, e non sapeva nulla di compar Alfio, né della<br />
Provvidenza che era in mare, né della festa dei Morti; così pensava Mena sul ballatoio<br />
aspettando il nonno.»<br />
G. VERGA, da I Malavoglia, 1881<br />
Quella, che tu credevi un piccolo punto della<br />
terra,<br />
fu tutto.<br />
E non sarà mai rubato quest’unico tesoro<br />
ai tuoi gelosi occhi dormienti.<br />
Il tuo primo amore non sarà mai violato.<br />
Virginea s’è rinchiusa nella notte<br />
come una zingarella nel suo scialle nero.<br />
Stella sospesa nel cielo boreale<br />
eterna: non la tocca nessuna insidia.<br />
Giovinetti amici, più belli d’Alessandro e<br />
d’Eurialo,<br />
per sempre belli, difendono il sonno del mio<br />
ragazzo.<br />
L’insegna paurosa non varcherà mai la<br />
soglia<br />
di quella isoletta celeste.<br />
E tu non saprai la legge<br />
ch’io, come tanti, imparo,<br />
- e a me ha spezzato il cuore:<br />
fuori del limbo non v’è eliso.<br />
E. MORANTE, L’Isola di Arturo, Dedica,<br />
1957<br />
«Faceva un caldo che non era scirocco e non era arsura, ma era soltanto caldo. Era come una<br />
mano di colore data sul venticello, sui muri gialletti della borgata, sui prati, sui carretti, sugli<br />
autobus coi grappoli agli sportelli. Una mano di colore ch’era tutta l’allegria e la miseria delle<br />
notti d’estate del presente e del passato. L’aria era tirata e ronzante come la pelle di un<br />
tamburo…Tutto un gran accerchiamento intorno a Roma,…ma pure dentro Roma, nel centro<br />
della città, magari sotto il Cupolone: sì proprio sotto il Cupolone, che bastava mettere il naso<br />
fuori dal colonnato di Piazza San Pietro, verso Porta Cavalleggeri, e èccheli llì, a gridare, a<br />
prender d’aceto, a sfottere, in bande e in ghenghe intorno ai cinemetti, alle pizzerie, sparpagliati<br />
poco più in là, in via del Gelsomino, in via della Cava, sugli spiazzi di terra battuta delimitata dai<br />
mucchi di rifiuti dove i ragazzini di giorno giocano a palla.»<br />
P. P. PASOLINI, Ragazzi di vita, 1955<br />
Dove sono Elmer, Herman, Bert, Tom e<br />
Charley,<br />
l'abulico, l'atletico, il buffone, l'ubriacone, il<br />
rissoso? Tutti, tutti, dormono sulla collina.<br />
Uno trapassò in una febbre,<br />
Uno fu arso nella miniera,<br />
Uno fu ucciso in rissa,<br />
uno morì in prigione,<br />
uno cadde da un ponte lavorando per i suoi<br />
cari -<br />
tutti, tutti dormono, dormono, dormono sulla<br />
collina.<br />
E. L. MASTERS, La collina, dall’«Antologia<br />
di Spoon River», trad. F. Pivano, 1943<br />
17
Marc CHAGALL, Il violinista sul tetto, 1912<br />
Vitebsk, che compare sullo sfondo, è il<br />
villaggio natale di Chagall, il “luogo<br />
dell’anima” a cui il pittore fa riferimento in<br />
tutta la sua esperienza di vita, anche nel<br />
fortunatissimo periodo parigino.<br />
Il violinista sul tetto suggerisce la condizione<br />
dell’Ebreo nel mondo, instabile come quella di<br />
un musicista che cerca di suonare il suo<br />
strumento restando in equilibrio in cima ad<br />
una casa.<br />
2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO<br />
ARGOMENTO: Alle basi della convivenza civile e dell’esercizio del potere: giustizia,<br />
diritto, legalità.<br />
DOCUMENTI<br />
«…l’uomo solo, tra gli animali, ha la parola:…la parola è fatta per esprimere ciò che è giovevole<br />
e ciò che è nocivo e, di conseguenza, il giusto e l’ingiusto: questo è, infatti, proprio dell’uomo<br />
rispetto agli altri animali, di avere, egli solo, la percezione del bene e del male, del giusto e<br />
dell’ingiusto e degli altri valori: il possesso comune di questi costituisce la famiglia e lo<br />
stato…quand’è perfetto, l’uomo è la migliore delle creature, così pure, quando si stacca dalla<br />
legge e dalla giustizia, è la peggiore di tutte…Ora la giustizia è elemento dello stato; infatti il<br />
diritto è il principio ordinatore della comunità statale e la giustizia è determinazione di ciò che è<br />
giusto.»<br />
ARISTOTELE, Politica, I, Cap.1,2<br />
«Osservate che la parola diritto non è contraddittoria alla parola forza, ma la prima è piuttosto<br />
una modificazione della seconda, cioè la modificazione più utile al maggior numero. E per<br />
giustizia io non intendo altro che il vincolo necessario per tenere uniti gl’interessi particolari, che<br />
senz’esso si scioglierebbono nell’antico stato d’insociabilità; tutte le pene che oltrepassano la<br />
necessità di conservare questo vincolo sono ingiuste di lor natura. Bisogna guardarsi di non<br />
attaccare a questa parola giustizia l’idea di qualche cosa di reale, come di una forza fisica, o di<br />
un essere esistente; ella è una semplice maniera di concepire degli uomini, maniera che<br />
influisce infinitamente sulla felicità di ciascuno; nemmeno intendo quell’altra sorta di giustizia<br />
che è emanata da Dio e che ha i suoi immediati rapporti colle pene e ricompense della vita<br />
avvenire.»<br />
C. BECCARIA, Dei delitti e delle pene, Cap. II, 1764<br />
«Chi richiede una definizione della giustizia cerca di solito un concetto normativo, ossia un<br />
criterio che sia utile a distinguere il giusto dall’ingiusto. Per definire un tale concetto è possibile<br />
innanzi tutto riallacciarsi alle opinioni correnti. Questo modo di procedere…si trova però dinanzi<br />
a una difficoltà: le opinioni su ciò che è giusto o ingiusto divergono ampiamente…limitandosi ai<br />
giudizi di giustizia ben ponderati, si osserva che sul piano dei fondamenti, sul piano dei principi<br />
della giustizia, si danno palesi divergenze di opinione. “A ognuno secondo le sue prestazioni”,<br />
18
afferma il liberalismo economico; “a ognuno secondo i suoi diritti legali”, si dice nello stato di<br />
diritto; “a ognuno secondo i suoi meriti”, si dice in molte aristocrazie; e il socialismo esige che si<br />
dia “a ognuno secondo i suoi bisogni”.»<br />
O. HÖFFE, Giustizia politica, Bologna, 1995<br />
«La domanda che ora dobbiamo porci è: ci sono principi chiari in base ai quali possiamo<br />
stabilire una distribuzione idealmente giusta dei diritti e dei privilegi, degli oneri e dei dolori, da<br />
assegnare agli esseri umani in quanto tali? C’è una posizione ampiamente diffusa secondo cui<br />
per rendere giusta una società si devono concedere certi diritti naturali a tutti i membri della<br />
comunità, e il diritto positivo deve come minimo incorporare e proteggere questi diritti,<br />
indipendentemente da quali altre regole esso possa poi contenere. Ma è difficile individuare nel<br />
senso comune il consenso sull’elenco preciso di questi diritti naturali, e ancor meno chiari sono<br />
quei principi da cui è possibile dedurli in modo sistematico.»<br />
H. SIDGWICK, I Metodi dell’etica, Milano, 1995<br />
«La giustizia è la prima virtù delle istituzioni sociali, così come la verità lo è dei sistemi di<br />
pensiero. Una teoria, per quanto semplice ed elegante, deve essere abbandonata o modificata<br />
se non è vera. Allo stesso modo, leggi e istituzioni, non importa quanto efficienti e ben<br />
congegnate, devono essere riformate o abolite se sono ingiuste. Ogni persona possiede<br />
un’inviolabilità fondata sulla giustizia su cui neppure il benessere della società nel suo<br />
complesso può prevalere. Per questa ragione la giustizia nega che la perdita della libertà per<br />
qualcuno possa essere giustificata da maggiori benefici goduti da altri…Di conseguenza, in una<br />
società giusta sono date per scontate eguali libertà di cittadinanza; i diritti garantiti dalla giustizia<br />
non possono essere oggetto né della contrattazione politica, né del calcolo degli interessi<br />
sociali…un’ingiustizia è tollerabile solo quando è necessaria per evitarne una ancora maggiore.<br />
Poiché la verità e la giustizia sono le virtù principali delle attività umane, esse non possono<br />
essere soggette a compromessi.»<br />
J. RAWLS, Una teoria della giustizia, Milano, 1982<br />
«Che l’idea di giustizia non si esaurisca nel fatto storico o positivo, ci è dimostrato dal suo<br />
perpetuo rinascere nella coscienza come esigenza assoluta…Senza cotesta vocazione e<br />
attività inesausta della coscienza, neppure si spiegherebbe la vita storica del diritto; poiché<br />
appunto da quella attitudine originaria ed insopprimibile dipende il plasmarsi e riplasmarsi<br />
continuo dei rapporti sociali e delle regole che li dominano…Chi viola leggermente le leggi<br />
scuote le basi stesse della vita civile, e vulnera le condizioni dalle quali dipende la rispettabilità<br />
della sua persona. Ma il culto della giustizia non consiste solo nell’osservanza della legalità, né<br />
vuole esser confuso con essa. Non coll’adagiarci supinamente nell’ordine stabilito, né<br />
coll’attendere inerti che la giustizia cada dall’alto, noi rispondiamo veramente alla vocazione<br />
della nostra coscienza giuridica. Questa vocazione c’impone una partecipazione attiva e<br />
indefessa all’eterno dramma, che ha per teatro la storia, e per tema il contrasto tra il bene e il<br />
male, tra il diritto e il torto. Noi non dobbiamo solo obbedire alle leggi, ma anche vivificarle e<br />
cooperare al loro rinnovamento…Chi dice giustizia, dice subordinazione ad una gerarchia di<br />
valori; e nulla è più contrario a un tale principio che l’arbitraria rimozione dei limiti che separano<br />
il lecito dall’illecito, il merito dal demerito…Solo la giustizia risplende, guida sicura, sul vario<br />
tumulto delle passioni…Senza di essa, né la vita sarebbe possibile, né, se anche fosse,<br />
meriterebbe di essere vissuta.»<br />
G. DEL VECCHIO, La Giustizia, Roma, 1959<br />
«B...In una qualsiasi società, e dunque anche in una società democratica, la funzione<br />
fondamentale del diritto è quella di stabilire le regole dell’uso della forza. Le regole dell’uso della<br />
19
forza vuol dire: chi deve esercitare l’uso della forza (non chiunque, ma solo coloro che sono<br />
autorizzati ad esercitarla); come (con un giudizio regolato); quando (non in un qualsiasi<br />
momento, ma quando sono state completate le procedure definite dalla legge); quanto (non<br />
puoi punire un furtarello nello stesso modo in cui punisci un omicidio). In uno Stato di diritto una<br />
delle grandi funzioni delle leggi è quella di stabilire come deve essere usato il monopolio della<br />
forza legittima che lo Stato detiene.»<br />
N. BOBBIO e M. VIROLI, Dialogo intorno alla Repubblica, Roma – Bari, 2001<br />
3. AMBITO STORICO - POLITICO<br />
ARGOMENTO: La nascita della Costituzione repubblicana: il laborioso cammino dalla<br />
dittatura ad una partecipazione politica compiuta nell’Italia democratica.<br />
DOCUMENTI<br />
«Il fascismo aveva condotto il paese alla catastrofe, come gli antifascisti avevano previsto. Ma<br />
la resistenza,<br />
contrariamente alle loro speranze, non fu una palingenesi. Non occorsero molti mesi...per<br />
accorgersi che il fascismo, nonostante la guerra sanguinosa che aveva scatenato, era stato una<br />
lunga parentesi, chiusa la quale la storia sarebbe cominciata più o meno al punto in cui la<br />
parentesi era stata aperta…La Resistenza non fu una rivoluzione e tanto meno la tanto attesa<br />
rivoluzione italiana: rappresentò puramente e semplicemente la fine violenta del fascismo e<br />
servì a costruire più rapidamente il ponte tra l’età postfascista e l’età prefascista, a ristabilire la<br />
continuità tra l’Italia di ieri e quella di domani.»<br />
N. BOBBIO, Profilo ideologico del Novecento, Milano, 1993<br />
«…Lo Statuto albertino fu fatto in un mese, dal 3 febbraio al 4 marzo 1848…fu una carta<br />
elargita da un sovrano il quale sapeva fino a che punto voleva arrivare; i suoi collaboratori,<br />
coloro che furono incaricati da lui di redigere quello Statuto, sapevano perfettamente quello che<br />
il sovrano voleva: non avevano da far altro che tradurre in articoli di legge le istruzioni già<br />
dosate da quell’unica volontà di cui lo Statuto doveva essere espressione… invece qui, in<br />
questa assemblea, non c’è una sola volontà, ma centinaia di libere volontà, raggruppate in<br />
diecine di tendenze, le quali non sono d’accordo su quello che debba essere in molti punti il<br />
contenuto di questa nostra carta costituzionale; sicché essere riusciti, nonostante questo, a<br />
mettere insieme, dopo otto mesi di lavoro assiduo e diligente, questo progetto, è già una grande<br />
prova, molto superiore a quella che fu data dai collaboratori di Carlo Alberto, in quel mese di<br />
lavoro semplice e tranquillo...È molto semplice, quando è avvenuto un rinnovamento<br />
fondamentale, una rivoluzione, insomma, di carattere sociale, in cui le nuove istituzioni sociali<br />
vivono già nella realtà, in cui la nuova classe dirigente è già al suo posto, prendere atto di<br />
questa realtà e tradurre in formule giuridiche questa realtà… Noi invece ci troviamo qui non ad<br />
un epilogo, ma ad un inizio. La nostra rivoluzione ha fatto una sola tappa, che è quella della<br />
repubblica; ma il resto è tutto da fare, è tutto nell’avvenire.»<br />
P. CALAMANDREI, Discorso all’ Assemblea Costituente del 4 marzo 1947<br />
«Nel corso del dibattito per la elaborazione della costituzione fu assai discusso il problema del<br />
rapporto che sarebbe dovuto intercorrere tra la nuova carta costituzionale e la società<br />
italiana:… da varie parti venne sottolineato come le nuove costituzioni tendano a codificare gli<br />
effetti di profondi sconvolgimenti sociali, generalmente conseguenti a rivoluzioni e come questo<br />
non fosse il caso dell’Italia postbellica. In tali condizioni, la costituzione non poteva non avere<br />
20
un carattere composito ed eterogeneo ed anche, per taluni aspetti, necessariamente<br />
programmatico… la più importante novità dell’Italia repubblicana rispetto a tutta la precedente<br />
storia unitaria consist(e) proprio nell’accordo su di un metodo di lotta politica e su alcuni principî<br />
generali, riassumibili nell’antifascismo, tra i partiti, e in modo particolare tra i partiti di massa. Ed<br />
è all’interno di questo quadro che dovranno essere viste non solo le trasformazioni strutturali<br />
veramente imponenti della società italiana nel secondo dopoguerra, ma anche la crescita civile<br />
realizzata<br />
attraverso la partecipazione dei cittadini, in quanto lavoratori, alla formazione della volontà<br />
generale.»<br />
E. RAGIONIERI, La storia politica e sociale, in “Storia d’Italia”, Einaudi, Vol. IV***, Torino, 1972<br />
«Nell’Italia del dopoguerra non vi erano le premesse reali di una democrazia fondata sulle<br />
autonomie e su un diffuso autogoverno; le intuizioni acute e generose in questo senso di<br />
ristrette élites intellettuali e politiche non potevano certo riempire il vuoto di una evoluzione<br />
secolare di segno opposto. Le ricerche fatte sull’area culturale liberal-democratica sono molto<br />
esplicite nel riconoscere il carattere élitario e perfino accademico di quegli apporti, per giunta<br />
profondamente divisi fra tradizioni diverse;…Oggi avvertiamo che la società politica è più ampia<br />
e più ricca della società partitica: avvertiamo che le grandi manifestazioni che riempiono le<br />
piazze, in cui si realizza ancora il magico rapporto di immedesimazione delle grandi masse con<br />
i capi carismatici – i capi e non più il capo, per fortuna – non esauriscono la domanda di<br />
partecipazione politica di cui il paese è capace… La partecipazione delle classi lavoratrici alla<br />
vita dello Stato, che è condizione essenziale della democrazia, non si esprime meccanicamente<br />
e stabilmente nei governi di unità popolare:… può benissimo esprimersi nelle forme<br />
dell’alternanza classica al potere di partiti che rappresentino forze sociali e tradizioni diverse.<br />
Ma le condizioni di questa alternanza in Italia non c’erano prima del fascismo e non sono state<br />
create nel breve periodo della collaborazione dei partiti antifascisti:…Non si può dunque<br />
considerare l’esito della fase costituente, per quanto riguarda gli equilibri politici, come la<br />
realizzazione di un<br />
modello.»<br />
P. SCOPPOLA, Gli anni della Costituente, fra politica e storia, Bologna, 1980<br />
«Se seguiamo il cammino percorso dai diritti di libertà, dalle prime «dichiarazioni» americane e<br />
francesi, fino alle formulazioni legislative ch’essi hanno avuto nelle più recenti costituzioni<br />
europee, assistiamo a un processo graduale di arricchimento e di specificazione di queste<br />
libertà: la tendenza della personalità umana ad espandersi nella vita politica, che inizialmente<br />
sembrava soddisfatta da poche libertà essenziali, sente il bisogno di conquistare sempre nuove<br />
libertà o di precisare sempre meglio quelle già ottenute, via via che le forze sociali oppongono<br />
in nuove direzioni nuovi ostacoli alla sua espansione. L’elenco dei diritti di libertà è pertanto un<br />
elenco aperto… Il cammino dei diritti di libertà si identifica col cammino della civiltà. Come è<br />
potuto dunque avvenire che questo movimento secolare di arricchimento spirituale della<br />
persona umana, e insieme di partecipazione sempre più attiva del cittadino alla vita sociale,<br />
abbia subìto nell’ultimo ventennio, più che un arresto, un brusco regresso, proprio quando<br />
pareva che alla fine della prima guerra mondiale esso avesse conquistato il mondo?»<br />
P. CALAMANDREI, Costruire la democrazia. Premesse alla Costituente, Firenze, ottobre 1945<br />
21
4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO<br />
ARGOMENTO: «Sensate esperienze» e «dimostrazioni certe»: la nascita della scienza<br />
moderna.<br />
DOCUMENTI<br />
«La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi a gli<br />
occhi (io dico<br />
l’universo), ma non si può intendere se prima non s’impara a intender la lingua, e conoscer i<br />
caratteri, ne’ quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son triangoli, cerchi,<br />
ed altre figure geometriche, senza i quali mezi è impossibile a intenderne umanamente parola;<br />
senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto.»<br />
G. GALILEI, Il Saggiatore, 1623<br />
«Siamo in uno dei grandi momenti dello spirito umano. Galileo scopre le immense possibilità<br />
offerte dalla<br />
modellizzazione matematica della realtà fisica, traducendo la sua meraviglia in queste frasi<br />
rimaste celebri [quelle riportate nel brano precedente]. Il fatto che la natura si esprima in<br />
linguaggio matematico, o, per utilizzare termini meno immaginosi, che concetti matematici<br />
collegati tramite equazioni e calcoli possano permettere di riprodurre e di prevedere il<br />
comportamento di oggetti fisici nel mondo reale resta ancor oggi, quattro secoli dopo Galileo,<br />
una fonte inesauribile di stupore…»<br />
I. EKELAND, Il migliore dei mondi possibili. Matematica e destino, Torino, 2001<br />
«I tentativi intesi a decifrare il grande romanzo giallo della natura sono altrettanto antichi quanto<br />
il pensiero umano. Tuttavia sono trascorsi appena più di trecento anni dacché gli scienziati<br />
cominciarono a comprendere il linguaggio in cui quel romanzo è scritto. Da allora in poi,<br />
dall’epoca cioè di Galileo e di Newton, la sua lettura ha proceduto speditamente. Mezzi e<br />
metodi d’indagine, volti a scoprire e a seguire nuovi indizi, vennero sempre più accresciuti e<br />
perfezionati. Fu così possibile risolvere alcuni degli enigmi della natura; tuttavia in non pochi<br />
casi le soluzioni proposte inizialmente sono apparse effimere e superficiali, alla luce di ulteriori<br />
indagini.»<br />
A. EINSTEIN e L. INFELD, L’evoluzione della fisica, 1938<br />
«Il progresso della civiltà non presenta una spinta uniforme verso le cose migliori…Le epoche<br />
nuove emergono relativamente improvvise, se consideriamo i millenni che la storia percorre…Il<br />
sedicesimo secolo della nostra era ha visto la scissione della cristianità dell’Occidente e<br />
l’avvento della scienza moderna…La Riforma fu un’insurrezione popolare e, per un secolo e<br />
mezzo, immerse l’Europa nel sangue. L’inizio del movimento scientifico non interessò invece<br />
che una minoranza dell’aristocrazia intellettuale…La tesi che intendo sviluppare è che il calmo<br />
sviluppo della scienza ha virtualmente dato un nuovo stile alla nostra mentalità, così che modi<br />
di pensare eccezionali in altri tempi sono ora diffusi in tutto il mondo civile. Ma il nuovo stile ha<br />
dovuto progredire lentamente per vari secoli tra i popoli europei prima di sbocciare nel rapido<br />
sviluppo della scienza, che quindi, con le sue sempre più esplicite applicazioni, lo ha<br />
ulteriormente consolidato…Questa nuova sfumatura dello spirito moderno sta appunto<br />
nell’interesse appassionato e risoluto nel ricercare le relazioni tra i princìpi generali e i fatti<br />
irriducibili e ostinati. Nel mondo intero e<br />
in tutte le epoche sono esistiti uomini di mentalità pratica, occupati nell’osservazione di tali fatti;<br />
nel mondo intero e in tutte le epoche vi sono stati uomini di temperamento filosofico intenti a<br />
tessere la trama dei princìpi generali.<br />
22
È proprio dall’unione dell’interesse appassionato per i particolari materiali con una non minor<br />
passione per le<br />
generalizzazioni astratte che scaturisce la novità caratteristica della nostra attuale<br />
società…Questo equilibrio dello spirito è ormai diventato una tradizione che caratterizza il<br />
pensiero colto. È il sale, il sapore della vita…L’altra caratteristica che distingue la scienza…è la<br />
sua universalità. La scienza moderna è nata in Europa, ma il suo ambiente naturale è il mondo<br />
intero.»<br />
A. N. WHITEHEAD, La scienza e il mondo moderno, 1926<br />
«…fare della fisica nel nostro senso del termine…vuol dire applicare al reale le nozioni rigide,<br />
esatte e precise della matematica e, in primo luogo, della geometria. Impresa paradossale, se<br />
mai ve ne furono, poiché la realtà, quella della vita quotidiana in mezzo alla quale viviamo e<br />
stiamo, non è matematica…Ne risulta che volere applicare la matematica allo studio della<br />
natura è commettere un errore e un controsenso. Nella natura non ci sono cerchi, ellissi, linee<br />
rette. È ridicolo voler misurare con esattezza le dimensioni di un essere naturale: il cavallo è<br />
senza dubbio più grande del cane e più piccolo dell’elefante, ma né il cane, né il cavallo, né<br />
l’elefante hanno dimensioni strettamente e rigidamente determinate: c’è dovunque un margine<br />
di imprecisione, di “giuoco”, di “più o meno”, di “pressappoco”…Ora è attraverso lo strumento di<br />
misura che l’idea dell’esattezza prende possesso di questo mondo e che il mondo della<br />
precisione arriva a sostituirsi al mondo del “pressappoco”.»<br />
A. KOYRÉ, Dal mondo del pressappoco all’universo della precisione, Torino, 1967<br />
«L’interrogazione della natura ha preso le forme più disparate…La scienza moderna è basata<br />
sulla scoperta di una forma nuova e specifica di comunicazione con la natura, vale a dire, sulla<br />
convinzione che la natura risponde veramente all’interrogazione sperimentale…In effetti, la<br />
sperimentazione non vuol dire solo fedele osservazione dei fatti così come accadono e<br />
nemmeno semplice ricerca di connessioni empiriche tra i fenomeni, ma presuppone<br />
un’interazione sistematica tra concetti teorici e osservazione…Arriviamo così a ciò che<br />
costituisce secondo noi la singolarità della scienza moderna: l’incontro fra tecnica e teoria…Il<br />
dialogo sperimentale con la natura, che la scienza moderna ha scoperto, non suppone<br />
un’osservazione passiva, ma una pratica. Si tratta di manipolare, di «fare una sceneggiatura»<br />
della realtà fisica, per conferirle un’approssimazione ottimale nei confronti di una descrizione<br />
teorica…La relazione fra esperienza e teoria viene dunque dal fatto che l’esperimento<br />
sottomette i processi naturali a un interrogatorio che acquista significato solo se riferito a<br />
un’ipotesi concernente i principî ai quali tali processi sono assoggettati.»<br />
I. PRIGOGINE e I. STENGERS, La nuova alleanza, metamorfosi della scienza, Torino, 1981<br />
«Che la scienza sia una lenta costruzione non mai finita alla quale ciascuno, nei limiti delle sue<br />
forze e delle sue capacità, può portare il suo contributo;…che la ricerca scientifica abbia come<br />
fine non il vantaggio di una singola persona o razza o gruppo, ma quello dell’intero genere<br />
umano; che in ogni caso lo sviluppo o la crescita della ricerca stessa sia qualcosa di più<br />
importante delle persone singole che la pongono in atto: queste, oggi diventate verità di senso<br />
comune, sono alcune fra le componenti essenziali di una considerazione della scienza che ha<br />
precise origini storiche. Essa è assente nelle grandi concezioni religiose dell’Oriente,<br />
nell’antichità classica, nella Scolastica medievale. Viene alla luce in Europa, come il più tipico<br />
prodotto della civiltà occidentale moderna, fra la metà del Cinquecento e la metà del Seicento.»<br />
P. ROSSI, I filosofi e le macchine (1400-1700), Milano, 1976<br />
23
3 - TIPOLOGIA C - TEMA <strong>DI</strong> ARGOMENTO STORICO<br />
La fine del colonialismo moderno e l’avvento del neocolonialismo tra le cause del fenomeno<br />
dell’immigrazione nei Paesi europei.<br />
Illustra le conseguenze della colonizzazione nel cosiddetto Terzo Mondo, soffermandoti sulle<br />
ragioni degli imponenti flussi di immigrati nell’odierna Europa e sui nuovi scenari che si aprono<br />
nei rapporti tra i popoli.<br />
4 - TIPOLOGIA D - TEMA <strong>DI</strong> OR<strong>DI</strong>NE GENERALE<br />
«L’industrializzazione ha distrutto il villaggio, e l’uomo, che viveva in comunità, è diventato folla<br />
solitaria nelle megalopoli. La televisione ha ricostruito il «villaggio globale», ma non c’è il<br />
dialogo corale al quale tutti partecipavano nel borgo attorno al castello o alla pieve. Ed è cosa<br />
molto diversa guardare i fatti del mondo passivamente, o partecipare ai fatti della comunità.»<br />
G. TAMBURRANO, Il cittadino e il potere, in “In nome del Padre”, Bari, 1983<br />
Discuti l’affermazione citata, precisando se, a tuo avviso, in essa possa ravvisarsi un senso di<br />
“nostalgia” per il passato o l’esigenza, diffusa nella società contemporanea, di intessere un<br />
dialogo meno formale con la comunità circostante.<br />
Durata massima della prova: 6 ore.<br />
È consentito soltanto l’uso del dizionario italiano.<br />
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.<br />
Sessione ordinaria 2007<br />
(per tutti gli indirizzi: di ordinamento e sperimentali)<br />
Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte.<br />
Tipologia B: quesiti a risposta singola<br />
SIMULAZIONI TERZA PROVA<br />
GRIGLIA <strong>DI</strong> CORREZIONE TERZA PROVA<br />
Indicatori Descrittori Punteggio<br />
Inesistente 0<br />
Frammentaria e confusa/errata 1 2<br />
Conoscenza dei Generica/incompleta 3<br />
24
contenuti*<br />
Competenze disciplinari,<br />
pluridisciplinari e capacità<br />
di collegamento*<br />
Competenze logico<br />
espressive<br />
Punteggio attribuito<br />
( espresso con un numero<br />
intero)<br />
voto in<br />
10.mi<br />
voto in<br />
15.mi<br />
Essenziale e manualistica 4<br />
Puntuale anche se manualistica 5<br />
Approfondita ed esauriente 6<br />
Inesistenti 0<br />
Non individua i concetti chiave 1 2<br />
Individua i concetti chiave ma non li collega 3<br />
Individua i concetti chiave e stabilisce semplici<br />
collegamenti<br />
4<br />
Individua i concetti chiave e stabilisce efficaci<br />
5<br />
collegamenti<br />
Rielabora le conoscenze anche con<br />
approfondimenti personali<br />
Non rilevabili<br />
Si esprime in modo disorganico ed usa un<br />
modesto repertorio lessicale<br />
Sa dare ordine al discorso usando un modesto<br />
repertorio lessicale<br />
Si esprime con coerenza, coesione e proprietà<br />
lessicali<br />
tabelle di conversione<br />
6<br />
0<br />
1<br />
2<br />
3<br />
…… /15<br />
1 1.5 2 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 7 7.5 8 9 10<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15<br />
voto in 3<br />
10.mi<br />
4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10<br />
voto in 9<br />
35.mi<br />
14 16 18 20 22 24 26 27-28 29 30-31 32 33-34 35<br />
25
GRIGLIA SECONDA E TERZA PROVA LINGUA STRANIERA<br />
COMPRENSIONE DEL<br />
TESTO<br />
Dettagliata<br />
Globale<br />
Parziale<br />
errata<br />
Contenuto /informazioni Pertinenti ed esaurienti, rielaborati in modo personale<br />
Abbastanza pertinenti anche se parzialmente ripresi dal<br />
testo<br />
Parzialmente pertinenti, ripresi quasi interamente dal<br />
testo<br />
Gravemente insufficiente 1 -5<br />
insufficiente 6 - 9<br />
sufficiente 10<br />
discreto 11 - 12<br />
buono 13 - 14<br />
ottimo 15<br />
4<br />
3<br />
2 – 1<br />
Banali, inaccettabili<br />
0<br />
Forma/ lessico Chiara, scorrevole, lessico vario<br />
5<br />
Abbastanza chiara ma con errori e imprecisioni 4-3<br />
Elementare, con errori che compromettono la<br />
comprensione<br />
2-1<br />
incomprensibile<br />
0<br />
Sintesi Chiara e pertinente<br />
3<br />
Pertinente ma non essenziale<br />
2<br />
errata<br />
1 - 0<br />
TOTALE __/15<br />
COMPRENSIONE DEL Dettagliata<br />
4<br />
TESTO<br />
Globale<br />
3<br />
Parziale<br />
2 – 1<br />
errata<br />
0<br />
Contenuto /informazioni Pertinenti ed esaurienti, rielaborati in modo personale 3<br />
Abbastanza pertinenti anche se parzialmente ripresi dal<br />
testo<br />
2<br />
Parzialmente pertinenti, ripresi quasi interamente dal<br />
testo<br />
1<br />
Banali, inaccettabili<br />
0<br />
Forma/ lessico Chiara, scorrevole, lessico vario<br />
5<br />
Abbastanza chiara ma con errori e imprecisioni 4-3<br />
Elementare, con errori che compromettono la<br />
comprensione<br />
2-1<br />
incomprensibile<br />
0<br />
Sintesi Chiara e pertinente<br />
3<br />
Pertinente ma non essenziale<br />
2<br />
errata<br />
1 - 0<br />
TOTALE __/15<br />
0<br />
3<br />
2<br />
1<br />
26
Materia: INGLESE<br />
Tipologia B<br />
PROVE DEL 27 FEBBRAIO 2008<br />
DATA:<br />
NOME E COGNOME:_________________________________________<br />
Answer the following questions:<br />
1) Discuss how language is used by O. Wilde in “The Importance of Being Earnest” and G.B. Shaw in<br />
“Pygmalion” to criticize the society of their time, making reference to the passages read in class.<br />
2) Who were the war poets? How did they represent modern warfare and what attitude did they have<br />
towards the war?<br />
27
GRIGLIA PER CORREZIONE TERZA PROVA (O II)<br />
LINGUA STRANIERA<br />
CAN<strong>DI</strong>DATO<br />
PRODUZIONE<br />
IN<strong>DI</strong>CATORI DESCRITTORI GIU<strong>DI</strong>ZIO PUNTI<br />
Il contenuto del testo è Originale, personale e completo Ottimo<br />
15<br />
14<br />
Abbastanza personale e completo Buono<br />
13<br />
accettabile<br />
Limitato e talvolta errato<br />
Discreto<br />
Più che sufficiente<br />
Sufficiente<br />
Insufficiente<br />
12<br />
11<br />
10<br />
6-9<br />
1-5<br />
Totalmente errato o incoerente Gravemente insufficiente<br />
Attinenza alla traccia Pertinente e pienamente aderente Ottimo 15<br />
alla traccia<br />
14<br />
Abbastanza pertinente<br />
buono 13<br />
Discreto 12<br />
Più che sufficiente 11<br />
Pertinente sufficiente 10<br />
Non sufficientemente pertinente Insufficiente 6-9<br />
Inadeguata Gravemente insufficiente 1-5<br />
L’esposizione e<br />
Chiare logiche e scorrevoli ottimo 15<br />
l’argomentazione sono<br />
14<br />
Abbastanza scorrevoli e<br />
Buono<br />
13<br />
comprensibili, talvolta un po’ involu= Discreto<br />
12<br />
te, poco/troppo sintetiche<br />
Più che sufficiente<br />
11<br />
Globalmente scorrevoli e<br />
comprensibili<br />
sufficiente 10<br />
Elementari e non sempre chiare,<br />
ricalcano la forma italiana<br />
insufficiente 6 – 9<br />
Non adeguate, incongruenti o<br />
incomprensibili<br />
Gravemente insufficiente 1 - 5<br />
Il livello morfosintattico e Corretto Ottimo 15 – 14<br />
grammaticale è<br />
Abbastanza corretto Buono<br />
13<br />
Più che sufficiente<br />
12 -11<br />
sufficiente<br />
10<br />
Con errori diffusi insufficiente 6 – 9<br />
Con errori gravi e/o molto frequenti Gravemente insufficiente 1 - 5<br />
Il lessico è<br />
Ricco adeguato e corretto Ottimo 15 – 14<br />
Globalmente corretto e adeguato, Buono<br />
13<br />
abbastanza diversificato<br />
Più che sufficiente<br />
12 -11<br />
Accettabile elementare sufficiente 10<br />
Non sempre corretto e adeguato insufficiente 6 – 9<br />
Spesso scorretto e inadeguato Gravemente insufficiente 1 - 5<br />
28
Materia: LINGUA FRANCESE<br />
COMPRENSIONE E PRODUZIONE SCRITTA. CONOSCENZA <strong>DI</strong> CONTENUTI.<br />
Leggete il testo proposto e rispondete ai quesiti. E’ consentito l’uso del dizionario monolingue.<br />
Risposte : 10-15 righe ( 180-200 parole)<br />
« Le premier caractère du roman naturaliste, dont madame Bovary est le type,est la reproduction exacte<br />
de la vie, l’absence de tout élément romanesque. La composition de l’oeuvre ne consiste plus que dans<br />
le choix des scènes et dans un certain ordre harmonique des développements. Les scènes sont ellesmêmes<br />
les prémières venues : seulement , l’auteur les a soigneusement triées et équilibrées de façon à<br />
faire de son ouvrage un monument d’art et de science. C’est la vie exacte donnée dans un cadre<br />
admirable de facture....Le romancier sera expérimentateur et son expérience sera faire mouvoir les<br />
personnages dans une histoire particulière pour y montrer que la succession des faits y sera telle que<br />
l’exige le déterminisme des phénomènes mis à l’étude» Zola, 1875<br />
1) Ces considérations ont été écrites par Zola dans un article de novembre 1875 : faites un<br />
commentaire de cet extrait en soulignant les principes du roman naturaliste que Zola<br />
propose dans son article.<br />
2) Romantisme et réalisme dans le roman de Flaubert « Madame Bovary »<br />
GRIGLIA <strong>DI</strong> VALUTAZIONE : VE<strong>DI</strong> GRIGLIA II E III PROVA LINGUE STRANIERE<br />
29
Materia: GEOGRAFIA ECONOMICA<br />
Tipo di prova: QUESITI A RISPOSTA BREVE<br />
Il candidato risponda ai seguenti quesiti in non più di 10 righe ciascuno.<br />
Le ragioni della crescita della popolazione nelle aree più povere del mondo.<br />
In che misura l’indebitamento estero dei paesi del Sud del mondo rappresenta un fortissimo<br />
ostacolo allo sviluppo economico e sociale degli stessi<br />
GRIGLIA <strong>DI</strong> CORREZIONE PER LA TERZA PROVA<br />
Cognome e nome ...........................................<br />
Disciplina: GEOGRAFIA,<br />
ELEMENTI VALUTATI GIU<strong>DI</strong>ZIO PUNTEGGIO<br />
Pertinenza e completezza della<br />
risposta<br />
(conoscenza dei contenuti)<br />
Ordine e coerenza della<br />
esposizione dei contenuti<br />
Correttezza e proprietà dei<br />
linguaggi<br />
Capacità di utilizzare e<br />
applicare le conoscenze<br />
• Decisamente lacunosa<br />
• Incompleta<br />
• Essenziale ma complessivamente<br />
pertinente<br />
• Completa e corretta<br />
• Completa e rigorosa<br />
• Disordinata e incoerente<br />
• Ordinata e sufficientemente coerente<br />
• Articolata e organica<br />
• Espressione impropria e scorretta<br />
• Espressione corretta e sufficiente<br />
padronanza del linguaggio specifico<br />
• Espressione efficace e buona<br />
padronanza del linguaggio specifico<br />
• Scarsa capacità di utilizzare le<br />
conoscenze<br />
• Uso disorganico delle conoscenze e<br />
insufficienti capacità di collegamento<br />
• Applicazione appropriata delle<br />
conoscenze pur con qualche<br />
imprecisione<br />
• Uso appropriato delle conoscenze con<br />
• buone capacità di collegamento<br />
• 1<br />
• 2<br />
• 3<br />
• 4<br />
• 5<br />
• 1<br />
• 2<br />
• 3<br />
• 1<br />
• 2<br />
• 3<br />
• 1<br />
• 2<br />
• 3<br />
• 4<br />
30
Materia: MATEMATICA<br />
Nome e Cognome:<br />
1. Il candidato illustri in massimo cinque righe cosa indica il punto di pareggio nel<br />
diagramma di redditività.<br />
2. Un'industria produce pennarelli evidenziatori per un massimo di 5.000 pezzi al giorno. Per la<br />
produzione sostiene i seguenti costi giornalieri:<br />
a) Costi fissi 20 €<br />
b) Costi variabili: 0,50 € per pennarello.<br />
c) Costi di consegna: 0,1% delle unità prodotte<br />
I pennarelli sono venduti a 1,2 € l’uno<br />
Determinare la quantità che massimizza il profitto e il suo valore e rappresentare graficamente il<br />
diagramma di redditività<br />
31
Materia: STORIA DELL’ARTE E DEL TERRITORIO<br />
Tipologia: B<br />
Nome e Cognome<br />
Classe<br />
Data<br />
1. A quali eventi s’ispira l’opera di Gericault e perché incontra critiche molto contrastanti al<br />
Salon?<br />
2. Analizza lo schema compositivo e sottolinea gli elementi di novità presenti nel dipinto,<br />
citando quelli, a tuo parere, più legati alla tradizione accademica.<br />
Risposte max 8 righe.<br />
GRIGLIA <strong>DI</strong> CORREZIONE E <strong>DI</strong> VALUTAZIONE TERZA PROVA<br />
STORIA DELL’ARTE<br />
Indicatori e relativi livelli Punteggio corrispondente Punteggio assegnato<br />
Scorretto 1<br />
Parzialmente corretto/povero 2-5<br />
Contenuto<br />
Complessivamente corretto 6<br />
Corretto approfondito 7-8<br />
Capacità di sintesi e<br />
rielaborazione<br />
Esposizione e terminologia<br />
specifica<br />
Scarsa 1-2<br />
Sufficiente 3<br />
Adeguata, apprezzabile 4<br />
Scarsa e confusa 1<br />
Chiara, comprensibile 2<br />
Appropriata 3<br />
32
Materia: INGLESE<br />
Tipologia B<br />
PROVE DEL 28 APRILE 2008<br />
DATA:<br />
NOME E COGNOME:_________________________________________<br />
Read the following text and answer the questions:<br />
Package Tours : the Pros and Cons<br />
The great reward of travelling independently on a low budget is the people you meet. Everything has not<br />
been prepared in advance and so all sorts of unpredictable things can happen. But that means that the<br />
independent traveller has a much greater opportunity to mix with local people, as well as other travellers<br />
from all over the world, than any tour group of first class traveller.<br />
People who go on package holidays are buying tranquillity. They are guaranteed no worries, no<br />
problems, an experience as close as possible to being at home. They get an hour and fifteen minutes for<br />
the guaranteed-open museum, then a two-hour sightseeing ride that catches all the picture-postcard<br />
highlights. They have lunch at a “recommended” restaurant, where the food is reasonable and ordering<br />
is easy. And as the next bus arrives they can reboard their own bus for the journey to another familiar<br />
comfortable hotel, populated with lots of other tourists, pretty much like themselves.<br />
While all travel is good for the human spirit, budget independent backpacking is the best way to<br />
experience other cultures and interact with local people. The best travel is not about a list of monuments,<br />
museums and landscapes. The best travel is about people, and if you travel well it is people that you are<br />
going to remember most. People that are strange, unique, foreign, friendly, hospitable, kind, rude,<br />
outrageous and normal. These will be the experiences that stay with you forever, that no postcard can<br />
ever reproduce.<br />
1) Does the writer like or dislike package tours? Why / Why not?<br />
2) What personal experience have you had of package tours and independent travel? Which do you<br />
prefer / would you prefer and why? Express your opinion in a short essay of about 150 – 180 words.<br />
33
CRITERI <strong>DI</strong> VALUTAZIONE TERZA PROVA<br />
IN<strong>DI</strong>CATORI<br />
Punteggio massimo<br />
attribuibile all’indicatore<br />
COMPLETEZZA<br />
DELLA RISPOSTA<br />
COMPETENZA<br />
LINGUISTICA<br />
RIELABORAZIONE<br />
PERSONALE<br />
PUNTEGGIO<br />
TOTALE<br />
LIVELLO <strong>DI</strong><br />
VALUTAZIONE<br />
6 • Completamente<br />
errata<br />
• Numerose<br />
informazioni errate<br />
• Parziale<br />
• esauriente<br />
6 • Numerosi e gravi<br />
errori<br />
• Errori che talvolta<br />
compromettono la<br />
comprensione<br />
• Alcuni errori e<br />
imprecisioni che<br />
non<br />
compromettono la<br />
comprensione<br />
• Risposta chiara e<br />
corretta pur con<br />
inesattezze<br />
3 • Disordinata e<br />
incoerente<br />
• Non rielabora ma si<br />
attiene al testo in<br />
modo a volte non<br />
sempre chiaro<br />
• Ordinata e<br />
sufficientemente<br />
coerente, rielabora<br />
cogliendo gli<br />
elementi essenziali<br />
15<br />
• Articolata, organica<br />
e approfondita<br />
PUNTEGGIO<br />
0<br />
1 -2<br />
3 -4<br />
5 -6<br />
0<br />
1 - 2<br />
3 – 4<br />
5 - 6<br />
0<br />
1<br />
2<br />
3<br />
34
Classe 5^DE – simulazione 3^ prova, 28/04/08<br />
Storia (Prof. Giorgini)<br />
1.<br />
Illustra i contenuti del Patto Molotov-Ribbentrop (max 120 parole):<br />
2.<br />
Illustra la shoa (parola che in ebraico significa annientamento), soffermandoti brevemente sui seguenti<br />
aspetti: basi ideologiche, approssimativa dimensione quantitativa, chi ne fu vittima, modalità adottate<br />
(max 120 parole):<br />
NB: ogni dieci parole scrivere il numero progressivo<br />
35
<strong>DI</strong>RITTO ED ECONOMIA PER L’AZIENDA (terza prova simulata)<br />
1. Descrivi le problematiche inerenti l’applicazione del principio di trasparenza bancaria, in<br />
particolare collegandole al significato di segreto bancario.<br />
2. Definisci il contratto d’albergo, evidenziando diritti e doveri dei soggetti coinvolti.<br />
Griglia di valutazione terza prova (diritto ed economia per l’azienda)<br />
IN<strong>DI</strong>CATORI<br />
1) Conoscenza degli elementi richiesti e pertinenza<br />
delle risposte alle domande, rispetto all’interpretazione<br />
del testo e contenuti corrispondenti.<br />
2) Capacità di applicare correttamente i contenuti<br />
appresi, capacità di elaborare confronti e collegamenti,<br />
capacità di analisi e sintesi, capacità di rielaborazione<br />
autonoma. *<br />
3) Conoscenza ed applicazione appropriata del<br />
linguaggio tecnico e degli strumenti tipici della<br />
disciplina in oggetto. *<br />
TOTALE PUNTEGGIO<br />
LIVELLI PUNTEGGIO<br />
Inesistente 0<br />
Insuff. Grave 1<br />
Insufficiente 2<br />
Sufficiente 3<br />
Discreto/Ottimo 4<br />
Inesistente 0<br />
Insuff. Grave 1<br />
Insufficiente 2<br />
Sufficiente 3<br />
Discreto/Buono 4<br />
Ottimo 5<br />
Inesistente 1<br />
Insuff. Grave 2<br />
Insufficiente 3<br />
Sufficiente 4<br />
Discreto/Buono 5<br />
Ottimo 6<br />
• Non si procede all’attribuzione del punteggio per gli indicatori 2 e 3 se le conoscenze richieste per l’indicatore 1 mancano o sono nulle<br />
(compito in bianco).<br />
36
Classe 5 D erica a.s. 2007/2008<br />
Matematica<br />
1) Il candidato illustri in massimo 15 righe le componenti del modello matematico per risolvere un<br />
problema di scelta tra due o più alternative con effetti immediati.<br />
2) Un’industria può scegliere fra due processi produttivi, A e B. I guadagni giornalieri di ciascun<br />
procedimento produttivo sono espressi dalle funzioni:<br />
A) y = 160 x - 5.000<br />
B) y = - 0.2 x 2 + 400 x – 20.000;<br />
dove x indica la quantità (in kg) prodotta giornalmente. La capacità produttiva massima giornaliera è di<br />
1.500 kg.<br />
Determinare il procedimento produttivo più conveniente in funzione della quantità prodotta.<br />
CLASSE<br />
NOMINATIVO<br />
OBIETTIVI Livelli e relativi descrittori Punte l° 2°<br />
Conoscenza dell'argomento<br />
(nozioni, concetti, regole)<br />
• Inconsistente<br />
• Confusa<br />
• Parziale<br />
• Generica<br />
• Soddisfacente<br />
• Approfondita<br />
Media<br />
O<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
Comprensione ed esposizione • Scorretta o nulla O<br />
(inerenza alla traccia, proprietà di<br />
linguaggio, uso corretto della simbologia)<br />
• Confusa<br />
• Approssimativa<br />
• Accettabile<br />
• Precisa<br />
1<br />
2,5<br />
3,5<br />
4,5<br />
• Puntuale<br />
Media<br />
5 ,<br />
Capacità operative<br />
(competenze disciplinari, capacità di<br />
analisi e sintesi, collegamenti)<br />
• Inconsistenti<br />
• Scarse<br />
• Incerte<br />
• Sufficienti<br />
O<br />
1<br />
2,5<br />
3,5<br />
• Sicure 4,5<br />
• Autonome 5<br />
Media<br />
Punteggio sommativo 15<br />
VALUTAZIONE COMPLESSIVA<br />
37
GRIGLIA <strong>DI</strong> VALUTAZIONE<br />
TERZA PROVA SCRITTA <strong>DI</strong> LINGUA SPAGNOLA<br />
CAN<strong>DI</strong>DATO: ....................................<br />
VOTO: ................................................<br />
IN<strong>DI</strong>CATORI DESCRITTORI PUNTI<br />
Comprensione del<br />
testo e competenze<br />
riferite agli argomenti<br />
Capacità di sintesi e/o<br />
di collegamento ed<br />
integrazione delle<br />
conoscenze<br />
a) dettagliata, pertinente ed esauriente, rielaborata in modo<br />
personale<br />
b) abb. esauriente e completa<br />
c) globale, sufficiente<br />
d) parziale<br />
e) errata<br />
a)Chiara e pertinente<br />
b) abb. esauriente<br />
c) globale, sufficiente, elementare<br />
d) parziale<br />
e) errata, incomprensibile, incongruente<br />
Forma / lessico a) Chiara, scorrevole, lessico adeguato con assenza di errori<br />
b) Abb.chiara ma con alcuni errori non gravi<br />
c) povera con errori gravi<br />
d) incomprensibile con molti e diffusi errori gravi.<br />
TOTALE<br />
Schede Informative relative alle materie dell’ultimo anno di corso<br />
Materia: ITALIANO<br />
Docente: Prof. MASSIMO GIORGINI<br />
Libro di Testo adottato: LA SCRITTURA E L'INTERPRETAZIONE - Edizione verde<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2/0<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1/0<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1/0<br />
/ 15<br />
39
modulare - vol. 3^<br />
Altri testi utilizzati: letture suggerite a livello individuale<br />
Altri sussidi didattici utilizzati: fotocopie, video<br />
1. Argomenti svolti nell’anno<br />
1. la narrativa del realismo<br />
obiettivo: individuare gli elementi tematici e stilistici che caratterizzano una tendenza<br />
obiettivi:<br />
inquadrare una tendenza all’interno del suo contesto storico<br />
riconoscere le tematiche e le idee che caratterizzano un periodo sul piano culturale e<br />
artistico<br />
raccordare un periodo con i periodi precedenti, individuando elementi di continuità e<br />
mutamento<br />
identificare gli elementi costituivi della poetica di un autore<br />
rapportare l'autore al suo contesto storico e culturale<br />
riassumere un testo<br />
analizzare un testo sul piano formale e tematico, anche con utilizzando una griglia<br />
contenuti (vol. 3/XI)<br />
caratteri generali del realismo (in particolare: basi materiali e sociali, area cronologica,<br />
modernità, idea di progresso, determinismo, materialismo, evoluzionismo): 9-11, 17-18, 21-<br />
22, appunti<br />
Flaubert e il realismo; Madame Bovary: riassunto, "L'educazione di Emma", "Charles", "I<br />
sogni di Emma" (22-23, appunti e fot.)<br />
Zola e il naturalismo (23-25, appunti); Germinale: riassunto, "La discesa nella miniera",<br />
"Dentro la miniera", "La festa dei minatori" (fot., appunti)<br />
Verga:<br />
− vita e produzione pre-verista; Nedda: presentazione e brano antologico: 99-104, 106-<br />
110)<br />
− caratteri generali del verismo, Dedicatoria a Salvatore Farina (la prefazione a L’amante di<br />
Gramigna), Rosso Malpelo: 114-117, 120-130, appunti)<br />
− il ciclo dei vinti e I Malavoglia: titolo, composizione e progetto; prefazione a I Malavoglia;<br />
storia, struttura, vicenda, sistema dei personaggi; lingua e stile: 176-179, 181-184, 190-<br />
191, appunti<br />
− letture antologiche da I Malavoglia: inizio del I cap., brani dai capp. III, IV e VI (189-190,<br />
fot.)<br />
− cenni su Mastro-don Gesualdo (162-163)<br />
2. Il decadentismo<br />
obiettivo: ricostruire il quadro culturale e letterario di un'epoca<br />
obiettivi:<br />
riconoscere le tematiche e le forme espressive che caratterizzano un periodo<br />
individuare il rapporto letterati-pubblico<br />
individuare l'intreccio fra fattori materiali e fattori ideali<br />
raccordare un periodo con i periodi precedenti, individuando elementi di continuità e<br />
mutamento<br />
40
contenuti (vol. 3/XII):<br />
caratteri generali del decadentismo e del simbolismo; la società di massa; Freud e Einstein;<br />
la figura dell’artista, il vate e l’esteta, poesia e narrativa nel decadentismo (appunti, 4-9)<br />
Baudelaire: Perdita d’aureola (7), L’albatro (35-36), Corrispondenze (37-38), Spleen (fot.)<br />
Verlaine: profilo (38-39), Ars poetica (41-42), Languore (fot.)<br />
Rimbaud: profilo (39), Lettera del veggente (fot.), Lacrima (fot.)<br />
Mallarmé: Sainte (fot.), I ponti (fot.)<br />
la narrativa decadente, con particolare riferimento a Controcorrente di Huysmans e lettura<br />
del brano antologico "Salomé" (58-60)<br />
d’Annunzio:<br />
− vita e opere: 142-144<br />
− Il piacere: caratteri generali e lettura dei seguenti brani "Il perfettissimo teatro", "Il<br />
popolo", "Quattrocento bruti" (162-164, fot.)<br />
− il superuomo e Le vergini delle rocce: caratteri generali e lettura del brano "Chiedevano<br />
intanto i poeti" (fot.)<br />
− presentazione delle Laudi (153-155);<br />
− Alcyone: presentazione generale (180-182); La pioggia nel pineto (185-189), Nella<br />
belletta (192), La sabbia del tempo (fot.)<br />
Pascoli:<br />
− vita (94-95); la poetica del Fanciullino: presentazione e lettura del brano "È dentro noi un<br />
fanciullio (95-98)<br />
− Myricae e Canti di Castelvecchio (98-100)<br />
− Myricae: composizione e temi (122-124, appunti); Lavandare (124-125); La via ferrata<br />
(125-126), X agosto (126-128); L’assiuolo (128-129); Temporale (130), Novembre (130),<br />
Il lampo (134-135), Dall'argine (fot.)<br />
− Il gelsomino notturno (100-101)<br />
− La grande proletaria si è mossa (fot.)<br />
3. Pirandello<br />
obiettivo: ricostruire il profilo storico-critico di un autore<br />
obiettivi:<br />
riconoscere nell'opera di un autore le fasi evolutive<br />
identificare gli elementi costituivi della poetica di un autore<br />
rapportare l'autore al suo contesto storico e culturale<br />
riassumere un testo<br />
analizzare un testo sul piano formale e tematico<br />
<br />
41
contenuti (voll. 3/XIII e 3/XVI):<br />
vita e fasi dell’attività artistica: (82-86 e appunti)<br />
i principali elementi della poetica pirandelliana (87-88, 89-91); lettura dei seguenti brani tratti<br />
dall'Umorismo: "La vita è un flusso" (92-93) e "Vedo una vecchia signora" (92-94)<br />
cenni su L'esclusa (96)<br />
i romanzi umoristici, con particolare riferimento a Uno, nessuno, centomila (96-98); lettura da<br />
questo romanzo del brano "La vita non conclude" (106-107)<br />
Il fu Mattia Pascal: presentazione, “Adriano Meis e la sua ombra”; l’ultima pagina del<br />
romanzo, "Lo strappo nel cielo di carta", "Mi vidi, in quell'istante" (134-138, 141, 142-144)<br />
La signora frola e il signor Ponza, suo genero, Così è (se vi pare) (fot., 56)<br />
La patente (fot.)<br />
Ciaula scopre la luna (fot.)<br />
Pirandello e il teatro, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: l'autonomia del<br />
personaggio e il teatro nel teatro (54-55, 60)<br />
Enrico IV: presentazione, ultime battute dell’opera (appunti, fot.)<br />
Sei personaggi in cerca d'autore: presentazione e brano antologico (54-55, 59-61, 63-66)<br />
dall'umorismo al surrealismo: C'è qualcuno che ride (121-126)<br />
<br />
4. La coscienza di Zeno<br />
obiettivo: saper leggere e capire un'opera letteraria<br />
obiettivi:<br />
individuare il costituirsi di un'opera nell'intreccio di temi e scelte espressive<br />
applicare a un testo molteplici prospettive analitiche (di tipo tematico, stilistico, narratologico)<br />
per individuarne la complessità<br />
collocare un'opera all'interno della vicenda personale dell'autore e del contesto storicoculturale<br />
contenuti (voll. 3/XIII e 3/XVI):<br />
introduzione generale al pensiero di Freud (fot.)<br />
vita, formazione e componenti culturali e letterarie (152-156)<br />
presentazione di Una vita e Senilità: 158-160, 163-165<br />
La coscienza di Zeno: caratteri generali (182-183); lettura integrale delle seguenti parti: "Lo<br />
schiaffo del padre" (184-187), "La proposta di matrimonio" (188-194); La moglie e l'amante<br />
(195); “La salute di Augusta” (204-205), “La vita è una malattia” (200-202); "Zeno sbaglia<br />
funerale" (fot.); Prefazione, Il fumo (fot.)<br />
5. La poesia italiana fra le due guerre<br />
obiettivo: individuare, relativamente a un preciso contesto spazio-temporale, le<br />
espressioni più rappresentative all'interno di un genere letterario<br />
obiettivi:<br />
individuare i temi e le scelte stilistiche che caratterizzano un genere in un ambito spaziotemporale<br />
definito<br />
rapportare le espressioni letterarie al contesto storico e culturale<br />
riconoscere, nel quadro della comunanza di temi e scelte formali, le fisionomie individuali<br />
42
contenuti (voll. 3/XIV):<br />
le avanguardie (6-7)<br />
il Futurismo: presentazione, il primo manifesto del Futurismo (8, 13-15, 16-17); esempio di<br />
poesia futurista: Sì,sì, così, l'aurora sul mare (85-87)<br />
il Crepuscolarismo: presentazione (11-12); Corazzini: profilo del poeta (59-60), Desolazione<br />
del povero poeta sentimentale, strofe 1 e 2 (61-62) e Per organo di Barberia (fot.); Gozzano:<br />
profilo dell'autore (appunti) e La signorina Felicita, vv. 1-84 (66-69)<br />
Ungaretti: vita e poetica (118-119); Allegria di naufragi: presentazione e analisi di In memoria,<br />
I fiumi, San Martino del Carso, Veglia, Mattina, Soldati, Commiato, Il porto sepolto, Fratelli<br />
(120-131); Sentimento del tempo: presentazione (132) e commento di La madre (133-134)<br />
Montale: profilo del poeta (199-201 e visione di un'intervista videoregistrata a Montale);<br />
presentazione di Ossi di seppia (appunti) e commento di Non chiederci la parola, (206),<br />
Spesso il male di vivere, (207), Meriggiare pallido e assorto (fot.), I limoni (fot.).<br />
Entro il termine dell’a.s. si prevede di proseguire lo svolgimento del modulo La poesia italiana fra<br />
le due guerre, trattando i seguenti argomenti:<br />
Montale: presentazione generale di Le occasioni e commento di Non recidere forbice e A<br />
Liuba che parte;<br />
Saba: Città vecchia, Preghiera alla madre;<br />
Quasimodo: Ride la gazza, nera sugli aranci.<br />
1. Eventuali altre discipline coinvolte<br />
Storia<br />
2. Attività scolastiche a supporto della preparazione degli studenti<br />
A supporto della preparazione degli studenti ho svolto il recupero in itinere e, per quanto<br />
riguarda una ragazza che al termine del primo quadrimestre presentava un esito<br />
parzialmente carente, ho effettuato un'attività di recupero basata soprattutto sullo studio<br />
assistito.<br />
3. Eventuali altri elementi significativi per la redazione della terza prova scritta<br />
4. Obiettivi inizialmente fissati<br />
cfr. punto 1<br />
5. Eventuale revisione degli obiettivi inizialmente fissati<br />
Nel corso dell’anno per esigenze di tempo è stato apportato qualche taglio ai contenuti dei<br />
moduli, ma senza che ciò comportasse una sostanziale revisione degli obiettivi fissati<br />
all’inizio.<br />
6. Criterio di sufficienza adottato<br />
preparazione negli argomenti disciplinari:<br />
comprensione degli elementi essenziali degli argomenti trattati<br />
capacità di applicare i principali elementi di analisi ai brani letterari<br />
43
capacità di esporre in modo chiaro e appropriato<br />
capacità di collegare e confrontare nei loro aspetti principali gli argomenti studiati<br />
produzione scritta:<br />
accettabile livello di correttezza formale<br />
espressione chiara e comprensibile<br />
pertinenza al titolo<br />
capacità di comprendere le principali richieste del tema e di trattarle in modo ordinato, coerente<br />
e fondato<br />
7. Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione<br />
Verifica della preparazione negli argomenti disciplinari:<br />
verifica formativa: domande flash<br />
verifica sommativa: interrogazione, questionari con domande strutturate e semistrutturate<br />
Per la verifica nella produzione scritta sono stati proposti titoli comprendenti tutte e quattro le<br />
tipologie presenti all’esame di stato.<br />
8. Numero delle prove svolte<br />
Per quanto riguarda la verifica della preparazione negli argomenti disciplinari, sono state svolte<br />
almeno 2 verifiche, scritte oppure orali, a quadrimestre.<br />
Per la verifica nella produzione scritta sono state svolte 2 prove nel 1^ quadrimestre e 2 prove nel<br />
2^.<br />
La seconda prova del secondo quadrimestre è stata svolta in contemporanea con le altre classi 5^<br />
dell’Istituto. Si prevede di svolgere una terza prova scritta.<br />
9. Ore assegnate per lo svolgimento delle prove<br />
Tempo dedicato alle verifica della preparazione negli argomenti disciplinari:<br />
un’ora di scuola (55 minuti) per i questionari<br />
in media 15 minuti per le interrogazioni<br />
Per lo svolgimento delle prove è stato assegnato un periodo compreso fra le 3 e le 5/6 ore. Per la<br />
seconda prova del secondo quadrimestre, che aveva l’obiettivo di simulare la situazione<br />
dell’esame, è stata concessa l’intera mattinata, dalle 8.00 alle 13.30.<br />
10. Altre indicazioni<br />
-----<br />
44
Materia: STORIA<br />
Docente: Prof. MASSIMO GIORGINI<br />
Libro di Testo adottato: STU<strong>DI</strong>ARE STORIA, di Fossati/Luppi/Zanette, vol. 3^<br />
Altri testi utilizzati: -<br />
Altri sussidi didattici utilizzati: fotocopie, video<br />
1. Argomenti svolti nell’anno<br />
ripasso del periodo relativo agli anni di governo della Destra Storica<br />
sul vol. 2^<br />
la Sinistra al governo (434-439)<br />
l'età crispina (440-443)<br />
sul vol. 3^<br />
cenni sulla situazione in Europa e nel mondo agli inizi del Novecento (12-14)<br />
il decollo industriale italiano, le lotte sociali e la crisi di fine secolo (18-20, 22-24)<br />
il periodo giolittiano (24-31)<br />
la prima guerra mondiale: cause, sviluppo, caratteri, conclusione, trattati di pace (38-44,<br />
46-52, appunti)<br />
la rivoluzione russa, dalle radici a Stalin (66-77, 93-95, 186-192)<br />
il primo dopoguerra in Italia, la nascita del fascismo, la presa del potere, il regime fascista,<br />
politica religiosa, economica ed estera del fascismo, l'antifascismo (97-113, 141-156)<br />
la repubblica di Weimar e il nazismo (87-89, 167-175)<br />
la guerra civile spagnola, fermenti negli imperi coloniali, Giappone e Cina nella prima<br />
metà del Novecento (203-212)<br />
la crisi del '29 e il New Deal (125-134)<br />
la seconda guerra mondiale: cause, svolgimento, conclusione, la guerra totale, il dominio<br />
nazista in Europa, la Shoah, la resistenza, i crimini di guerra italiani (216-229, 231-233,<br />
236-242, filmato)<br />
il mondo bipolare (258-262)<br />
Entro il termine dell’a.s. si prevede di svolgere i seguenti argomenti:<br />
la guerra fredda, l’equilibrio del terrore, i due blocchi<br />
l’Italia della ricostruzione, il miracolo economico<br />
Problemi e aspetti del mondo successivo alla seconda guerra mondiale, con particolare<br />
approfondimento dei seguenti aspetti: la decolonizzazione e il divario nord-sud, la caduta<br />
dei regimi dell'est e la fine del bipolarismo<br />
2. Eventuali altre discipline coinvolte<br />
Italiano<br />
3. Attività scolastiche a supporto della preparazione degli studenti<br />
A supporto della preparazione degli studenti ho svolto il recupero in itinere e, per quanto<br />
riguarda due ragazze che al termine del primo quadrimestre presentavano un esito<br />
carente, ho effettuato un'attività di recupero basata soprattutto sullo studio assistito.<br />
4. Eventuali altri elementi significativi per la redazione della terza prova scritta<br />
45
-----<br />
5. Obiettivi inizialmente fissati<br />
tematizzare in modo coerente un fatto storico riconoscendo soggetti, fatti, luoghi, e periodi che<br />
lo costituiscono<br />
costruire e usare schemi, mappe, diagrammi temporali<br />
mettere le conoscenze dei fatti storici in relazione con le conoscenze dei contesti socioeconomici<br />
entro i quali si svolsero<br />
riconoscere come un medesimo fatto storico può essere variamente interpretato a seconda<br />
della prospettiva ideologica<br />
selezionare le informazioni in coerenza con la tematizzazione stabilita<br />
riconoscere la funzione dei riferimenti storici nei discorsi sul presente<br />
adoperare concetti interpretativi e termini storici in rapporto a uno specifico contesto storico<br />
individuare i periodi significativi nelle ricostruzioni storiche<br />
padroneggiare gli strumenti concettuali della storiografia<br />
individuare le grandi fratture che proiettano il tempo attuale verso il futuro<br />
problematizzare le differenze di condizioni di vita, di religione, di cultura di individui e gruppi<br />
umani<br />
6. Eventuale revisione degli obiettivi inizialmente fissati<br />
La mancanza di tempo ha reso necessario apportare qualche taglio ai contenuti, in<br />
particolare per quanto riguarda la seconda metà del Novecento, ma ciò non ha comportato<br />
una sostanziale revisione degli obiettivi fissati all’inizio.<br />
7. Criterio di sufficienza adottato<br />
Per la sufficienza è stato adottato il seguente criterio:<br />
conoscere degli elementi essenziali degli argomenti trattati<br />
saper istituire rapporti fra gli argomenti, essendo in grado di collocarli secondo l’ordine<br />
cronologico e riuscendo eventualmente a collegarli secondo nessi di causa-effetto<br />
saper confrontare gli eventi, e cogliere analogie tra eventi lontani fra loro nel tempo e/o nello<br />
spazio<br />
saper esporre in modo chiaro e appropriato<br />
8. Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione<br />
Verifica della preparazione negli argomenti disciplinari:<br />
verifica formativa: domande flash<br />
verifica sommativa: interrogazione, questionari con domande strutturate e semistrutturate<br />
9. Numero delle prove svolte<br />
Per quanto riguarda la verifica della preparazione negli argomenti disciplinari, sono state svolte<br />
almeno 2 verifiche, scritte o orali, a quadrimestre. Come seconda verifica del 2^ quadrimestre sono<br />
state utilizzate le domande (Tip. B) inserite nella simulazione di terza prova svolta il 20 gennaio<br />
2005.<br />
46
10. Ore assegnate per lo svolgimento delle prove<br />
Tempo dedicato alle verifiche sommative:<br />
1 ora di lezione per i questionari<br />
in media 15 minuti per le interrogazioni<br />
11. Altre indicazioni<br />
-----<br />
47
Materia INGLESE<br />
Docente Prof.ssa PATRIZIA SBARRA<br />
Libro di testo adottato: Pozzi Lolli – Stagi Scarpa, As If<br />
Jaksetich – Marcantoni, Tourism Network, Loescher<br />
Altri testi utilizzati: Fotocopie tratte da testi autentici (brochure, leaflets etc.), da testi<br />
letterari, da diversi siti su internet ed esercizi tratti da varie fonti.<br />
Altri sussidi didattici Brani della cassetta allegata al libro di testo relativi agli argomenti<br />
utilizzati:<br />
turistici presi in esame; visione dell’opera teatrale Look back in Anger<br />
di J. Osborne in lingua originale; sequenze video tratte dai film “The<br />
Importance of Being Earnest”, “Pygmalion”, “The Great Gatsby”, “Jane<br />
Eyre”, “A Passage to India”. Visione del film in lingua originale<br />
“Elizabeth The Golden Age”.<br />
1. Argomenti svolti nell'anno:<br />
MODULO N. 1 Titolo : Reading for Fun - Revision<br />
• Revisione delle strutture linguistiche delle funzioni comunictive:<br />
• Defining and non-defining relative clauses’, present and past simple and continuous, falso<br />
negativo, frasi relative ellittiche, forme condizionali di primo, secondo e terzo tipo, verbi modali<br />
can, could, must, have to, should, may, might, would like to, be able to, be allowed to, connettori<br />
temporali e logici, ‘used to’ e would per esprimere l’imperfetto, ‘past perfect progressive’, forme<br />
passive di tutti i tempi verbali, unreal past, wishes, “must have, might have, can’t have” per le<br />
deduzioni e le conclusioni, discorso indiretto possessives, ‘phrasal verbs’più frequenti, future<br />
continuous, future perfect, inversions.<br />
• Funzioni comunicative:<br />
• Saper iniziare e concludere una conversazione; saper definire personalità e stati d’animo; saper<br />
chiedere, accordare o rifiutare permesso; saper dare, accettare o rifiutare consigli e<br />
suggerimenti; saper esprimere accordo e disaccordo; saper chiedere e dare opinioni personali;<br />
sapersi scusare ed accettare scuse; saper formulare richieste cortesi; saper parlare delle proprie<br />
esperienze passate; saper formulare ipotesi, saper esprimere rimpianto rispetto al passato, saper<br />
descrivere eventi e processi; saper riportare quanto detto da altri; saper esprimere rimpianto<br />
rispetto al passato; saper dedurre positivamente e negativamente rispetto al passato, saper<br />
parlare azioni in corso di svolgimento nel futuro e di ciò che sarà stato<br />
• Letteratura:<br />
• Letture assegnate a gruppi di lavoro da analizzare e relazionare alla classe: The Grapes of<br />
Wrath, Middlemarch, Tess of the D’Urbevilles, Heart of Darkness, The Great Gatsby, a Passage<br />
to India, The Picture of Dorian Gray, a Room with a View.<br />
MODULO N. 2 The Language of Tourism (modulo di turismo)<br />
• Accomodation (Modulo 4: Unit 1, 2, 4 e dispensa con fotocopie)<br />
• Air, Land and Sea Transport (Module 5: Unit 1, 2, 3, 4)<br />
• City Breaks, Tours and Itineraries (Module 6: Unit 1, 2, 3, 4)<br />
• Special Interest Holidays (Module 7 Unit 1 pg.170-171, 176; Unit 4 pg. 188-189; dispensa con<br />
itinerari, itinerari a tema, city breaks, crociere e descrizione di città – Ferrara, Palermo, Perugia,<br />
Gubbio, Spoleto)<br />
MODULO N. 3: Titolo : Portraits 1<br />
• La rappresentazione della città nella letteratura inglese da metà ‘800 a metà ‘900<br />
• La rappresentazione delle classi sociali nella letteratura inglese da metà ‘800 a metà ‘900<br />
48
• La guerra (war poets)<br />
• Blake : London<br />
• Dickens: Bleak House (London)<br />
• Dickens : Hard Times (Coketown)<br />
• T.S.Eliot: The Waste Land – Epigraph<br />
The Burial of the Dead (Ll. 1-7; 60 - 76)<br />
The Fire Sermon (ll.173 – 182; 207 – 252)<br />
• G. Orwell: 1984 – extract: This was London<br />
• F.S.Fitzgerald: The Gret Gatsby – New York; The Party; “She was the first nice girl…”<br />
• O. Wilde – The Importance of Being Earnest<br />
• G.B.Shaw – Pygmalion<br />
• The war poets – R. Brooke - The soldier<br />
• S. Sassoon – Glory of Women<br />
• W. Owen - Dulce et Decorum<br />
• Rosenberg – August 1914<br />
• C. Sandburg Grass<br />
• Visione di sequenze di film in lingua originale: The Importance of Being Earnest, My fair Lady,<br />
The Great Gatsby.<br />
MODULO N. 4 Titolo: Text processing, precis writing and guided production<br />
(MODULO <strong>DI</strong> RICEZIONE E PRODUZIONE SCRITTA)<br />
• Testi delle seconde prove scritte di inglese all’esame di testo degli anni precedenti.<br />
• Articoli da giornali e riviste di argomento turistico-economico<br />
MODULO N. 5 Titolo : Portraits 2<br />
• L’immagine della donna nella letteratura inglese dell’età vittoriana<br />
• C. Brontee – Jane Eyre<br />
• Virginia Wolf – To the Lighthouse<br />
• Visione di sequenze di film in lingua originale: Jane Eyre<br />
• L’immagine dell’artista nella letteratura inglese dell’età vittoriana: O. Wilde – The Picture of<br />
Dorian Gray<br />
• L’incontro- scontro tra culture / discriminazione / razzismo: E.M.Forster – A Passage to India –<br />
Chapter XXIV<br />
• Visione di sequenze del film, A Passage to India corrispondenti ai testi letti<br />
2. Eventuali altre discipline coinvolte<br />
I contenuti dei moduli di letteratura sono stati individuati tenendo presente l’area di progetto<br />
della classe e quindi trovano riscontro nei moduli corrispondenti di lingua francese, lingua<br />
spagnola e Italiano.<br />
3. Attività scolastiche a supporto della preparazione degli studenti:<br />
Il primo modulo di quest’anno ha consolidato le competenze già acquisite lo scorso<br />
anno relative agli obiettivi di analisi letteraria e di grammatica proposti nel modulo.<br />
Per il resto il recupero si è svolto con un corso di recupero all’inizio dell’anno<br />
scolastico quindi in itinere o con modalità di studio assistito tramite un corso on line<br />
con esercizi ed attività di vario tipo, che sono state poi oggetto di valutazione.<br />
4. Eventuali altri elementi significativi per la redazione della terza prova scritta<br />
49
La tipologia della terza prova è stata la tipologia B, in particolare in un caso con domande<br />
aperte relative alla letteratura e nell’altro con un breve testo turistico con domande di<br />
comprensione di produzione.<br />
5. Obiettivi inizialmente fissati:<br />
Obiettivi Formativi Disciplinari<br />
COMPRENSIONE ORALE<br />
Cogliere il significato globale di un testo orale relativo a tematiche proprie dell’indirizzo di studi<br />
prodotto a velocità normale da parlanti nativi ed è in grado di individuarne informazioni<br />
specifiche;<br />
Cogliere il messaggio globale di notizie date dai mass-media ed inferire dagli elementi linguistici<br />
ed extra-linguistici l’atteggiamento e le intenzioni dei parlanti.<br />
Comprendere una conversazione telefonica a carattere commerciale relativa agli argomenti presi<br />
in esame<br />
INTERAZIONE/PRODUZIONE ORALE<br />
Trattare in modo sufficientemente corretto argomenti di carattere generale a partire da testi<br />
ascoltati o letti.<br />
Riassumere argomenti desunti da testi relativi all’indirizzo in modo sufficientemente corretto, con<br />
l’aiuto di appunti presi precedentemente;<br />
Organizzare un discorso, rielaborando informazioni in maniera analitica e sintetica, nell’ambito<br />
del linguaggio settoriale di indirizzo,<br />
Sa ricodificare diagrammi ed altra simbologia figurativa esponendone i contenuti in maniera<br />
discorsiva sufficientemente corretta.<br />
COMPRENSIONE SCRITTA<br />
Cogliere anche con l'ausilio del dizionario monolingue il senso globale di testi di argomento sia<br />
generale sia inerente all’indirizzo comprendendone le principali informazioni esplicite e<br />
l’organizzazione del discorso<br />
Sa effettuare inferenze in base a informazioni già note o contenute nel testo e valutarne l’utilità in<br />
relazione ad un compito assegnato<br />
PRODUZIONE SCRITTA<br />
Redigere lettere commerciali e curricola personali in modo corretto<br />
Riprodurre testi di vario genere (lettere, annunci pubblicitari, commenti, itinerari turistici, relazioni,<br />
riassunti, paragrafi) e relativi all’indirizzo da e in lingua straniera, utilizzando il lessico appreso e<br />
la corretta terminologia settoriale<br />
Sa produrre paragrafi su modelli dati e brevi composizioni su traccia, utilizzando un lessico<br />
variato in maniera adeguata al contesto ed al registro linguistico<br />
Sa trascodificare, in modo sufficientemente corretto, tabelle e diagrammi in forma linguistica,<br />
comprensibili sul piano strutturale e comunicativo.<br />
Obiettivi modulari<br />
Modulo 1 Reading for Fun - Revision<br />
• Acquisizione di una competenza linguistico-comunicativa a livello intermedio avanzato allo scopo<br />
di esprimersi in modo sufficientemente corretto ed appropriato sia in sede scritta che orale.<br />
50
• Saper analizzare un testo letterario in prosa<br />
• Saper comprendere ed interpretare il senso letterale<br />
• Saper individuare il narratore / il punto di vista narrativo<br />
• Saper individuare la modalità narrativa prevalente<br />
• Saper analizzare la caratterizzazione dei personaggi<br />
• Saper riconoscere l’intenzione dell’autore<br />
• Saper fornire una interpretazione / un commento personale<br />
• Revisione delle strutture linguistiche e delle funzioni comunicative affrontate negli anni precedenti<br />
Modulo 2 The Language of Tourism (modulo di turismo)<br />
• Saper interagire linguisticamente nella situazione agente di viaggio / cliente di persona o al<br />
telefono utilizzando il lessico ed il registro linguistico appropriato.<br />
• Saper interpretare, riassumere e commentare articoli e brevi testi di argomento turisticoeconomico.<br />
• Saper scrivere lettere di richieste di informazioni, risposte a richieste di informazioni,<br />
prenotazioni, reclami, lettere in risposta ad annunci di lavoro, circolari, , leaflets e brochures<br />
• Saper spiegare e discutere oralmente e per iscritto servizi e strutture di alloggio e di trasporto.<br />
• Saper descrivere oralmente e per iscritto monumenti, luoghi di particolare interesse<br />
paesaggistico e strutture<br />
• Pianificare e promuovere vacanze, itinerari, crociere e vacanze con scopo specifico<br />
Modulo 3 Portraits 1<br />
• Saper relazionare, in forma orale o scritta, sul tema della rappresentazione della città nella<br />
letteratura inglese dell’800/900<br />
• Saper relazionare, in forma orale o scritta, sul tema della rappresentazione delle classi sociali<br />
• Saper relazionare, in forma orale o scritta, sul tema della guerra<br />
• Saper comprendere il senso letterale di un testo poetico analizzandone il linguaggio ed il layout<br />
• Saper interpretare il significato più profondo di un testo poetico, riconoscendo l’intenzione<br />
dell’autore<br />
• Saper individuare l’ironia e la sua funzione di critica<br />
• Saper individuare ed interpretare simboli<br />
• Saper individuare i caratteri fondamentali del testo narrativo e teatrale<br />
• Saper analizzare un testo letterario in prosa e un testo teatrale<br />
• Saper comprendere ed interpretare il senso letterale<br />
• Saper individuare il narratore / il punto di vista narrativo<br />
• Saper distinguere tra storia e trama<br />
• Saper individuare la modalità narrativa prevalente<br />
• Saper analizzare la caratterizzazione dei personaggi<br />
• Saper riconoscere l’intenzione dell’autore<br />
• Saper fornire una interpretazione / un commento personale<br />
• Saper confrontare diversi testi letterari centrati su uno stesso tema sottolineando somiglianze e<br />
differenze.<br />
Modulo 4 Text processing, precis writing and guided production<br />
(MODULO <strong>DI</strong> RICEZIONE E PRODUZIONE SCRITTA)<br />
• Approfondire le strategie di comprensione di un testo scritto di tipo informativo e argomentativo al<br />
fine di acquisire le competenze necessarie ad affrontare la prova d’esame.<br />
• Saper stabilire raccordi trasversali all’interno dei diversi moduli della disciplina ed interdisciplinari<br />
per recuperare le informazioni richieste dall’esercizio di produzione proposto in sede d’esame.<br />
Modulo 5 Portraits 2<br />
51
• Saper relazionare, in forma orale o scritta, sul tema dell’immagine della donna nella letteratura<br />
inglese dell’età vittoriana<br />
• Saper relazionare, in forma orale o scritta, sul tema dell’immagine dell’artista nella letteratura<br />
inglese dell’età vittoriana prendendo in esame i testi studiati<br />
• Saper relazionare, in forma orale o scritta, sul tema dell’ L’incontro- scontro tra culture /<br />
discriminazione / razzismo prendendo in esame i testi studiati<br />
• Saper individuare i caratteri fondamentali del testo narrativo<br />
• Saper analizzare un testo letterario in prosa<br />
• Saper comprendere ed interpretare il senso letterale<br />
• Saper individuare il narratore / il punto di vista narrativo<br />
• Saper distinguere tra storia e trama<br />
• Saper individuare la modalità narrativa prevalente<br />
• Saper analizzare la caratterizzazione dei personaggi<br />
• Saper riconoscere l’intenzione dell’autore<br />
• Saper fornire una interpretazione / un commento personale<br />
• Saper confrontare diversi testi letterari centrati su uno stesso tema sottolineando somiglianze e<br />
differenze.<br />
6. Eventuale revisione degli obiettivi inizialmente fissati<br />
Gli obiettivi del modulo 5 risultano leggermente diversi da quelli della programmazione<br />
iniziale, non tanto nella definizione degli stessi, quanto nella scelta e nel numero dei testi<br />
presi in esame.<br />
7. Criterio di sufficienza adottato:<br />
Fermi restando i criteri generali adottati dal Consiglio di Classe compatibilmente con gli<br />
obiettivi inizialmente fissati, si è ritenuto di adottare il seguente criterio per il raggiungimento<br />
della sufficienza: considerando anche l'impegno e la costanza nello studio si è assegnato il<br />
livello di sufficienza nel caso in cui l'allievo, pur evidenziando alcune difficoltà nel<br />
raggiungere gli obiettivi minimi fissati nei moduli, li abbia comunque raggiunti nella maggior<br />
parte di essi.<br />
8. Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione:<br />
Formative in itinere: costantemente attraverso interventi spontanei degli alunni, domande<br />
flash, monitoraggio del lavoro a coppie o a gruppi, correzione dei compiti a casa, listening<br />
comprehensions.<br />
Sommativa finale: una verifica scritta alla conclusione del modulo, in forma di prova<br />
strutturata, semistrutturata o non strutturata, oppure secondo la tipologia B della terza prova<br />
dell'esame di stato. Una verifica orale di ascolto e, in alcuni moduli, una breve verifica di<br />
produzione/interazione orale.<br />
9. Numero delle prove svolte<br />
Nel primo quadrimestre cinque prove scritte e due prove di comprensione orale, oltre ad<br />
interrogazioni orali su contenuti di letteratura e di turismo; nel secondo, tre prove scritte, due<br />
simulazioni di terza prova scritta, una simulazione di seconda prova scritta, una prova di<br />
comprensione orale ed interrogazioni orali riguardanti argomenti di letteratura e di turismo.<br />
10. Ore assegnate per lo svolgimento delle prove:<br />
Nel caso di verifica scritta fino a due unità orarie di lezione; nel caso di prova di<br />
comprensione orale dai 20 ai 30 minuti a seconda della lunghezza dell'ascolto. La<br />
simulazione della seconda prova scritta ha previsto sei ore come da indicazioni ministeriali e<br />
52
le prove di simulazione della terza prova scritta hanno previsto quarantacinque minuti circa<br />
per materia.<br />
53
Materia: FRANCESE<br />
Docente: Prof.ssa GIULIANA ROSSI<br />
Conversazione francese Prof.ssa SOPHIE GUISE<br />
Libro di Testo adottato: G.F. Bovini, M.C.Jamet “ Kaléidoscope. Littérature et<br />
civilisation françaises” vol.C Valmartina<br />
Stendhal « Le rouge et le noir » CIDEB<br />
S.Simonelli,A.Becchetti, A.Ellena,P.Pristipino<br />
“ Atelier tourisme “ SEI<br />
Altri testi utilizzati: Brani estratti da G.Flaubert “Emma Bovary” , M. Proust<br />
“Du côté de chez Swann” , Baudelaire « Les fleurs du<br />
mal »<br />
Testi e articoli di attualità e civiltà tratti da quotidiani e<br />
riviste francesi ( Le monde, Le Figaro, l’Express,<br />
Phosphore) e da ricerche su internet.<br />
Altri sussidi didattici utilizzati: audio-videoregistratore, laboratorio linguistico , laboratorio<br />
di informatica ,fotocopie, depliants, internet.<br />
1. Argomenti svolti nell’anno<br />
Si fa riferimento al piano di lavoro della disciplina per quanto riguarda obiettivi e metodologia.<br />
Corrispondenza commerciale e turistica : struttura e lessico<br />
Domanda di informazioni e di documentazione (prezzi, condizioni) e relativa risposta. ( pp.6-<br />
32)<br />
Domanda di condizioni particolari. Prenotazione. Reclamo.(pp.78-79;87-89) Boutique langue<br />
pp.210-2111;275-276)<br />
Il lavoro :.Annunci di lavoro. Curriculum vitae: Lettera di candidatura e lettera di motivazione.<br />
L’assunzione, la formazione, i contratti di lavoro. Il bac/ diploma economico-linguistico e le<br />
possibilità<br />
di lavoro. Libro di testo – fotocopie – Brochure di annunci “<br />
L’emploi”<br />
Turismo<br />
Nascita ed evoluzione del turismo. Il turismo e il turista di oggi. I diversi tipi di turismo.<br />
• Le tourisme en France . Les centres de congrés. Le tourisme durable ( pp.43-46)<br />
• Le tourisme au fil du temps . Les voyages à la carte.Quel voyageur ? Vous dites<br />
tourisme ? Quels tourismes ? (pp.224-237) Le Grand Tour.<br />
• Marc Augé « Le voyageur de l’aller-retour » ; Edgar Morin « Une culture de loisir » ;<br />
• F. Bostnavaron « Le nouveau visage du tourisme mondial » ( fotocopie)<br />
Professioni . Les métiers du tourisme en agence, à l’hôtel.<br />
Le tour-opérateur( le voyagiste), l’agence, l’office du Tourisme ( pp.204-205 ; fotocopie) ,<br />
documento video) . L’hébergement. Les hôtels pp.239-241 ;258. Boutique langue pp.275-276<br />
Itinerari- Città- Regioni. Presentazione , struttura e lessico.<br />
• Présentation de circuits/ itinéraires ( carctéristiques et public) ( pp.387-391 ; fotocopie )<br />
• Itinéraires à thèmes. A’ cheval, à bateau, à vélo . ( pp.125-127 ;130-131,433-437 ; 136-<br />
137)<br />
Proposition d’itinéraires dans les régions françaises ( pp.47-51 ; 125-127) . Scelta e<br />
presentazione di due itinerari a tema individuando il pubblico destinatario ( esempi pp.<br />
51-76; 184-187 ; 188-191 ;196-202 ; 400-410) . Redazione di un itinerario completo.<br />
• Présentation d’une ville, d’une région. ( pp.278 ; p.246) Esempi dal libro di testo. Scelta<br />
e presentazione di una città e di una regione.<br />
• Film “ Le voyage organisé” Alain Nahum<br />
•<br />
Letteratura<br />
54
Il programma di letteratura è stato svolto prendendo in considerazione anche il periodo e i temi<br />
proposti dall’Area di progetto realizzata dalla classe. Periodo 1870-1930. Temi : la nascita<br />
della città industrializzata, le classi sociali,la donna, l’artista e la visione di se stesso, l’altro e le<br />
culture diverse,la guerra.<br />
Il romanzo<br />
• Sthendal “ Le rouge et le noir “. Il romanzo dal romanticismo al realismo .<br />
Lettura e analisi del romanzo integrale ( Le contexte. Le texte: Les thèmes: Les<br />
personnages.<br />
L’écriture) Film : Il rosso e il nero ( visione di alcune sequenze del film)<br />
Libro di testo : Sthendal et la quête du bonheur . pp.81-85;88-89<br />
• Gustave Flaubert : il romanzo realista . Emma Bovary.<br />
Libro di testo : Flaubert roman et modernité pp.127-131; 140-141<br />
Estratti da Emma Bovary “ J’ai un amant – Le bonheur de Charles- L’ennui d’Emma<br />
( le bovarysme)<br />
• Il romanzo naturalista : il positivismo,les frères Goncourt, Emile Zola. Temi del<br />
romanzo naturalista.Il naturalismo francese e il verismo italiano. Evoluzione del<br />
romanzo: “ l’écrivain engagé”, ’impegno politico-sociale, la modernità, il progresso, le<br />
classi sociali, la massa. La città, le condizioni di vita.<br />
Libro di testo : le naturalisme p. 142; pp.151-153<br />
Zola pp.123-124 Les halles ( le ventre de Paris) En voilà un magasin ( Au bonheur des<br />
dames) pp.142-147 ; 154-165 : Une existence impossibile ( L’assommoir); « Quatre<br />
heures du matin chez les Maheu ; ; Le travail au fond de la mine ; Malaise chez les<br />
bourgeois ; Une masse affamée. Germinal : le sens de l’oeuvre.<br />
• Marcel Proust : il romanzo moderno. Prout e Bergson : una nuova idea della<br />
percezione del tempo . Introspezione e psicologia nel romanzo.<br />
Libro di testo pp.235-244 e fotocopia : “La petite madeleine ; C’était Venise”; “ La vraie<br />
vie”;L’art fait renaître le passé “ ( A’ la recherche du temps perdu).<br />
La poesia *<br />
Il disagio esistenziale e la poesia : Baudelaire. Verlaine.Rimbaud . Il simbolismo.<br />
Charles Baudelaire .Poète de la modernité . Temi e stile . pp.166-177 , fotocopie.<br />
Les fleurs du mal : Spleen LXXVII,SpleenLXXVIII,L’albatros, Correspondances,L’ennemi, Le<br />
chat, L’invitation au voyage . Petits poèmes en prose : L’étranger , Enivrez-vous.<br />
Verlaine et Rimbaud : un couple maudit pp.178-187<br />
Verlaine : L’art poétique , Le ciel par-dessus le toit ; Rimbaud : Le dormeur du val, L’aube,<br />
lettre du voyant.<br />
Il malessere dell’uomo moderno : le surréalisme. André Breton. Manifesto del surrealismo.<br />
Evoluzione della poesia : Apollinaire ( Calligrammes) Prévert ( lyrisme quotidien)<br />
Il modulo di poesia sarà svolto anche dopo il 15 maggio. Gli argomenti e gli autori indicati<br />
potrebbero quindi essere ridotti o variati.<br />
Attualità-Civiltà ( argomenti trattati durante l’ora di conversazione francese)<br />
• Vacances du président ( Le figaro)<br />
• Travail et contrat de travail . travail au noir : Les travailleurs de l’été / Même pour la<br />
plonge , faut être en forme ( Internet)<br />
• Sociétè : les bars à narguilé ménacent fermeture ( Le monde)<br />
• Immigration : Ma banlieue ( internet) / Faut –il encore plus d’immigrés ( L’Express) / la<br />
loi Sarkozy<br />
• La femme : le Davos féminin se tient à Deauville / Emma Marcegaglia : L’état italien<br />
casse notre croissance .( Le figaro )<br />
•<br />
Preparazione alle prove scritte<br />
Questionari, riassunti,produzioni su traccia ( corrispondenza commerciale e turistica, itinerari,<br />
presentazione di soggiorni / città/ luoghi di interesse secondo il testo proposto. Produzione<br />
personale : esprimere la propria opinione, commentare , giustificando e argomentando<br />
55
elativamente al testo proposto per la comprensione scritta. Svolgimento delle prove di esame (<br />
testo turistico e d economico) degli anni scorsi.<br />
2. Eventuali altre discipline coinvolte<br />
I contenuti svolti permettono collegamenti con i programmi di Letteratura italiana, Storia,<br />
Inglese, Spagnolo, Storia dell’Arte. La realizzazione dell’Area di progetto della classe<br />
“ Un secolo di storia fra letteratura e arte” ha proposto un lavoro di ricerca interdisciplinare.<br />
3. Attività scolastiche a supporto della preparazione degli studenti<br />
Analisi guidata di testi , realizzazione di schemi e sintesi. Svolgimento e correzione<br />
regolare di produzioni, questionari e riassunti. Recupero in itinere. Studio assistito.<br />
4. Eventuali altri elementi significativi per la redazione della terza prova scritta<br />
La terza prova di lingua francese sarà costituita da un breve testo scritto che si riferisce ad<br />
un argomento del program ma svolto ( turismo, civiltà-attualità, letteratura) a partire dal<br />
quale si dovrà rispondere a quesiti che richiederanno percorsi di espansione e di sintesi e<br />
verificheranno anche le conoscenze acquisite in merito all’argomento.<br />
5. Obiettivi inizialmente fissati<br />
Vedi anche piano di lavoro disciplinare.<br />
Comprensione di documenti orali e scritti relativi ad argomenti di civiltà e attualità e<br />
specialistici . Conoscenza dei contenuti proposti .<br />
Conoscenza dei percorsi letterari proposti : caratteristiche e temi di movimenti letterari<br />
autori. Conoscenza ed analisi dei testi : individuare temi ed espressioni rappresentativi<br />
dell’autore e della sua opera.<br />
Rielaborazione ed esposizione orale e scritta di argomenti trattati.<br />
6. Eventuale revisione degli obiettivi inizialmente fissati<br />
Nel secondo quadrimestre ci sono state alcune interruzioni dovute alle attività previste dalla<br />
programmazione didattica della classe e dell’ istituto che hanno comportato una riduzione<br />
delle ore di lezione. Alcuni argomenti di letteratura sono stati quindi svolti in tempi più<br />
limitati rispetto al previsto riducendo contenuti e testi proposti.<br />
7. Criterio di sufficienza adottato<br />
Orale : conoscenza dei contenuti , conoscenza ed analisi dei brani letterari, esposizione<br />
fluida e corretta ( pronuncia e morfosintassi corrette per trasmettere chiaramente il<br />
messaggio a chi ascolta , capacità di collegare, anche guidati, i diversi argomenti.<br />
Scritto: risposta pertinente nei contenuti e nel rispetto della traccia data. Strutture e lessico<br />
semplici ma corretti.<br />
8. Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione<br />
Orale: riproposizione autonoma di argomenti, risposte a domande aperte.<br />
Scritto: questionari a domande aperte ( conoscenza dei contenuti ) . Corrispondenza<br />
turistica e redazione di itinerari e programmi su traccia,comprensione di un testo e risposta<br />
a quesiti relativi al testo e alle conoscenze dell’argomento proposto; svolgimento di<br />
seconde e terze prove.<br />
9. Numero delle prove svolte<br />
Orale: due a quadrimestre sommative . Formative : domande brevi .<br />
56
Scritto: tre a quadrimestre. Lavori svolti a casa ( prove di esame, riassunti, produzioni,<br />
itinerari)<br />
10. Ore assegnate per lo svolgimento delle prove<br />
Orale: 15-30 minuti<br />
Scritto : 50- 110 minuti<br />
57
Materia: LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA SPAGNOLO<br />
Docente: Prof.ssa PEZZUOLI ALESSANDRA<br />
Prof.ssa<br />
spagnola)<br />
VAL<strong>DI</strong>VIA MAYA (conversatrice di lingua<br />
Libro di Testo adottato:<br />
• “Nosotros C ”, metodo de espanol para italianos, Libro del<br />
alumno y cuaderno de los ejercicios, Loescher ( più Cd relativi al<br />
testo)<br />
Altri testi utilizzati: • “ Amigo viajero” , cuaderno de español para turismo,<br />
Zanichelli.<br />
• “ Amigo de los negocios” , cuaderno de español para la<br />
economia y las ciencias sociales, Zanichelli.<br />
Altri sussidi didattici utilizzati: Laboratorio linguistico, video, registrazioni, materiale fotocopiato<br />
cartaceo.<br />
1. Argomenti svolti nell’anno<br />
• Situazioni comunicative e contenuti funzionali incontrate nel testo in adozione “Nosotros<br />
C”:<br />
Saper descrivere e riconoscere le varie parti che compongono un giornale e/o rivista, esprimere<br />
desideri, speranze, probabilità; saper descrivere le calamità che affliggono i paesi; descrivere<br />
caratteristiche personali, intenzioni, obblighi; esprimere e giustificare gusti e preferenze; saper<br />
evocare, collegare e collocare esperienze ed eventi passati, raccontare aneddoti, saper<br />
organizzare un racconto; raccontare i dati biografici di una persona; parlare di avvenimenti e progetti<br />
futuri ; saper scambiare informazioni inerenti ad interessi ed attività extrascolastiche; essere in<br />
grado di raccontare la visione di un film, il contenuto di una rappresentazione teatrale o letteraria;<br />
saper difendere le proprie opinioni; saper redigere una lettera commerciale nelle sue tre parti che la<br />
compongono, comprendere ed utilizzare la terminologia base inerente al campo semantico dell’<br />
economia; saper progettare un itinerario completo turistico, con soggiorno, visite guidate ed<br />
escursioni facoltative; saper descrivere le varie parti del corpo e riconoscere le malattie ad esse<br />
relazionate; esprimere finalità, rassegnazione, certezza e probabilità; esprimere condizioni,<br />
consigliare e saper reagire ai consigli dati e ricevuti; dare istruzioni, esprimere giudizi, esprimere<br />
accordo e disaccordo totale e/o parziale; esprimere permesso, lamentele e desideri, sensazioni,<br />
sentimenti e stati d’ animo; esprimere e dare un ordine; formulare definizioni, esprimere ipotesi,<br />
giudizi morali, criticare e difendere azioni.<br />
• Strutture grammaticali:<br />
- Le perifrastiche<br />
- La costruzione del Modo Imperativo e suo uso nella forma aff. e negativa.<br />
- Formazione ed uso del condizionale: tempo semplice e composto;<br />
- Formazione del congiuntivo presente e imperfetto e relativi tempi composti;<br />
- Sintassi del congiuntivo nelle frasi principali e subordinate;<br />
- La subordinata temporale;<br />
- La subordinata finale;<br />
- La subordinata causale;<br />
- La subordinata concessiva;<br />
- La subordinata relativa;<br />
- I verbi di opinione alla forma negativa;<br />
- Il periodo ipotetico nei suoi tre casi;<br />
- Verbi che reggono le preposizioni;<br />
- I connettori temporali e discorsivi;<br />
- La forma passiva verbale;<br />
Nel corso dell’ anno si è cercato anche di introdurre, mediante la lettura e l’ analisi collettiva e/o<br />
individuale di alcune poesie e brani tratti da libri di scrittori spagnoli , una conoscenza sommaria di<br />
58
alcuni generi letterari presenti nella letteratura spagnola.<br />
IL ROMANTICISMO El Romanticismo<br />
El Romanticismo español<br />
GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER<br />
Las Rimas: I, II, VII, XIII, XXI, XXX, XXXI, XLII<br />
EL REALISMO<br />
EL SIGLO XX<br />
EL MODERNISMO<br />
LA GENERACIÓN<br />
DEL 98<br />
NOVECENTISMO Y<br />
VANGUAR<strong>DI</strong>SMO<br />
LA GENERACIÓN<br />
DEL 27<br />
LA LITERATURA<br />
ESPAŇOLA DESDE<br />
1939<br />
EL TREMEN<strong>DI</strong>SMO<br />
PRINCIPALES<br />
NOVEDADES DE<br />
LAS TÉCNICAS<br />
NARRATIVAS<br />
Realismo y Naturalismo<br />
GALDÓS<br />
-“Fortunata y Jacinta”<br />
-“Tristana”<br />
- “Misericordia”<br />
Introducción al siglo XX<br />
El modernismo<br />
Presentación del período<br />
Del 98 a la guerra civil: la renovación de la novela<br />
en el siglo XX<br />
ANTONIO MACHADO<br />
Poema de “ Soledades” nr. LXXVII<br />
Presentación del período<br />
Presentación del período<br />
FEDERICO GARCÍA LORCA<br />
Romancero gitano:<br />
- Romance de la luna, luna<br />
- Preciosa y el aire<br />
- La monja gitana<br />
- Romance sonámbulo<br />
- Romance de la pena negra<br />
Teatro:<br />
- La casa de Bernarda Alba<br />
- Yerma<br />
Introducción a la guerra civil española<br />
CAMILO JOSÉ CELA<br />
La familia de Pascual Duarte<br />
La Colmena<br />
MIGUEL DELIBES<br />
Cinco horas con Mario<br />
Appunti<br />
Appunti<br />
Fotocopie<br />
Fotocopie<br />
Appunti<br />
Appunti<br />
Fotocopia<br />
Fotocopie<br />
Appunti<br />
Appunti<br />
Fotocopie<br />
Appunti<br />
Fotocopie<br />
In compresenza con l’ insegnante madrelingua , durante l’ anno scolastico, sono state sviluppate<br />
e rafforzate le funzioni comunicative sopra citate attraverso la conoscenza della cultura, gli usi e<br />
costumi della Spagna e la stesura di alcuni piani turistici, nonché reclami e disdette mediante l’ uso<br />
del testo “Amigo viajero” e la lettura di materiale cartaceo distribuito alla classe.<br />
Durante l’ ora di laboratorio linguistico, sono stati visionati nonché analizzati e commentati i seguenti<br />
film in lingua spagnola:<br />
- “Tierra y Libertad”<br />
- “ La casa de Bernarda Alba”<br />
59
2. Eventuali altre discipline coinvolte<br />
I contenuti svolti permettono collegamenti con i programmi di letteratura italiana, storia dell’<br />
arte, inglese, francese, storia.<br />
3. Attività scolastiche a supporto della preparazione degli studenti<br />
• Analisi guidata di testi e realizzazione di schemi e sintesi.<br />
• Lezione frontale per introdurre argomenti nuovi<br />
• Lezione interattiva per brevi dibattiti, conversazione<br />
• Lavoro di gruppo per approfondire e ripassare<br />
• Utilizzo di sussidi sonori : ascolto di cd relativi al libro di testo e materiale autentico in genere,<br />
disponibili presso l'istituto o reperiti dall'insegnante<br />
• Utilizzo di sussidi audiovisivi : visione di films seguiti da una approfondita discussione<br />
• Utilizzo di materiale strutturato per la esecuzione di esercizi grammaticali.<br />
• Svolgimento e correzione regolare di produzioni, questionari basati sulla comprenzsione dei testi<br />
presentati nel testo di adozione.<br />
4. Eventuali altri elementi significativi per la redazione della terza prova scritta<br />
Per la terza prova scritta di spagnolo è stata scelta la tipologia B costituita da un breve<br />
brano, che fa riferimento ad un argomento del programma di letteratura svolto nel corso<br />
dell’ anno scolastico, e seguita da due domande, la prima inerente alla comprensione del<br />
suddetto brano, la seconda inerente alla capacità di elaborazione personale e/o critica<br />
nella produzione scritta.<br />
5. Obiettivi inizialmente fissati<br />
Prerequisiti : conoscenza degli elementi morfosintattici e lessicali della lingua spagnola ( livello<br />
B1/B2).<br />
Obiettivi da raggiungere:<br />
• Comprensione orale: comprendere semplici messaggi di carattere generale (nell’ambito delle<br />
tematiche trattate), cogliendo la situazione, l’argomento (significato globale), le informazioni<br />
specifiche richieste, i registri utilizzati.<br />
• Comprensione scritta: leggere documenti di carattere generale comprendenti lessico parzialmente<br />
non conosciuto, cogliendone tipologia e finalità, il significato globale, le informazioni specifiche<br />
richieste formulate in modo esplicito.<br />
• Produzione orale: produrre messaggi di carattere personale attinenti al contesto di situazione e<br />
comprensibili sul piano del lessico, dell’intonazione e della pronuncia, anche se con alcuni errori di<br />
tipo formale che tuttavia non impediscono la comunicazione.<br />
• Produzione scritta: di produrre testi su argomenti noti di tipo informativo, descrittivo e narrativo<br />
(messaggi, brevi lettere informali, brevi riassunti, racconti, brani letterari), utilizzando strutture e<br />
funzioni linguistiche, lessico e forma adeguati al contesto di situazione, senza errori rilevanti che ne<br />
impediscano la comprensione.<br />
Obiettivi disciplinari<br />
- Stimolare e incentivare i ragazzi ad un sentimento di autostima delle proprie capacità e una<br />
valutazione il più possibile autocritica delle lacune.<br />
- Guidare gli studenti ad un approccio autonomo nello studio della materia sviluppando le capacità<br />
di comprensione e produzione, nonché il senso analitico nei confronti delle strutture linguistiche.<br />
- Affinare l’attenzione ai contenuti affrontati in modo da essere in grado di analizzarli ed acquisirli<br />
nel modo più attento e dettagliato possibile.<br />
6. Eventuale revisione degli obiettivi inizialmente fissati<br />
60
7. Criterio di sufficienza adottato<br />
Lo studente raggiunge una valutazione sufficiente quando:<br />
- presenta una acquisizione delle conoscenze sufficienti nel seguire lo svolgimento del<br />
programma;<br />
- presenta una elaborazione scritta non ben articolata con pochi spunti personali;<br />
- presenta delle competenze formali sufficienti nell’ espressione orale e nella lingua scritta.<br />
8. Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione<br />
Le verifiche hanno previsto prove strutturate e semistrutturate, prove di comprensione scritta,<br />
produzioni scritte, interrogazioni brevi, esercizi grammaticali, con domande aperte / chiuse.<br />
La valutazione complessiva ha tenuto conto anche della frequenza, la partecipazione, l’ interesse, il<br />
comportamento in classe e l’ impegno nello svolgimento delle attività assegnate.<br />
Tipologie<br />
Interrogazioni individuali Analisi e commento di testi<br />
Prove strutturate Saggio breve<br />
Prove semistrutturate Relazione<br />
Quesiti a risposta singola Tema su argomento di ordine generale<br />
Trattazione sintetica di argomenti <br />
Numero minimo di valutazioni orali che<br />
confluiscono nell’orale.<br />
Quantità<br />
(Possono confluire nella valutazione orale:<br />
• le verifiche di conoscenze mediante<br />
questionari<br />
• le verifiche di abilità e conoscenze<br />
mediante semplici esercitazioni o richieste<br />
di interventi a risposta immediata)<br />
Appare tuttavia non rinunciabile il momento di<br />
verifica individuale formale della produzione orale.<br />
N<br />
2<br />
Numero minimo di valutazioni<br />
che confluiscono nello scritto<br />
9. Numero delle prove svolte<br />
Per ogni Quadrimestre si è cercato di ottenere minimo per ciascun studente tre valutazioni<br />
inerenti alle prove scritte e due valutazioni inerenti all’ interrogazione orale.<br />
10. Ore assegnate per lo svolgimento delle prove<br />
Per tutte le prove scritte ( domande di comprensione e produzione) si è sempre dato un<br />
tempo di due ore; per le prove strutturate o semistrutturate si è dato un tempo massimo di<br />
una ora; per le interrogazioni il tempo impiegato varia dai 20 ai 40 minuti.<br />
N<br />
3<br />
61
Materia STORIA DELL’ARTE E DEL TERRITORIO<br />
Docente Prof.ssa LAURA PELAGATTI<br />
Libro di testo adottato: Cottimo-Dantini-Guastalla, La storia dell’arte, Archimede editore,<br />
2004, vol.3.<br />
Altri testi utilizzati:<br />
Altri sussidi didattici<br />
utilizzati:<br />
1. Argomenti svolti nell’anno<br />
1) Neoclassicismo<br />
appunti, altri libri di testo,riviste,video.<br />
La seconda metà del Settecento: scoperta e riscoperta dell’antico; il Grand Tour; Roma<br />
“scuola del mondo”; i teorici: Winckelmann e Mengs a Villa Albani; il Parnaso di Mengs; le<br />
incisioni di Piranesi ;<br />
il Neoclassicismo etico di David (Belisario riconosciuto,Il giuramento degli Orazi, La morte di<br />
Marat , Napoleone che valica il Gran San Bernardo);<br />
l’antico come ideale del bello in Canova (Teseo e il Minotauro, Amore e Psiche,<br />
Monumento funebre a Clemente XIII, Monumento a Maria Cristina d’Austria, Paolina Borghese<br />
come Venere vincitrice);<br />
cenni sull’ architettura neoclassica in Europa (Boullèe e Ledoux, Porta di Brandeburgo ) e<br />
in Italia: Piermarini a Milano (La Scala), Foro Bonaparte, Canova e il tempio di Possagno.<br />
2) Romanticismo<br />
Inquietudini preromantiche: H.Fussli (L’artista commosso dalla grandezza delle rovine<br />
antiche, L’incubo), F.Goya (Il sonno della ragione genera mostri, 3 maggio 1808) ;<br />
Sublime visionario (Blake, Elohim crea Adamo) e vedutismo nella pittura inglese (Turner,<br />
Bufera di neve:Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi, Didone costruisce Cartagine ;<br />
Constable, Il carro di Fieno);<br />
Germania: uomo e natura nella pittura di Friedrich (Viandante sul mare di nebbia, Croce in<br />
montagna) ;<br />
Francia: Géricault ( La zattera della Medusa) e Delacroix (La libertà che guida il popolo);<br />
Italia: la pittura di storia di F.Hayez (Pietro Rossi prigioniero degli Scaligeri, Il bacio); cenni<br />
sui preraffaelliti ;<br />
L’architettura: il recupero dei modelli medievali, E.Viollet-le-Duc e il restauro integrativo<br />
(Carcassonne,Pierrefonds) ;<br />
L’eclettismo e la nuova architettura degli ingegneri (Paxton, Crystal Palace; A.G.Eiffel , Torre)<br />
3) Realismo<br />
La pittura realista in Francia: cenni su Corot e sulla scuola di Barbizon;<br />
Courbet (Funerale a Ornans, Gli spaccapietre);<br />
Millet (Le spigolatrici); Daumier (Scompartimento di terza classe).<br />
In Italia: i Macchiaioli (Fattori, Campo italiano dopo la battaglia di Magenta, Diego Martelli<br />
a cavallo; T.Signorini, Pascoli a Castiglioncello; S.Lega, L’educazione al lavoro).<br />
Cenni sui rapporti tra fotografia e pittura (La musa di Courbet nell”Atelier”).<br />
4) Impressionismo<br />
62
L’arte da Salon (la tecnica accademica, i generi) , il Salon des Refusés e<br />
« Le déjeuner sur l’herbe » di Manet;<br />
il movimento impressionista:nuovi soggetti “en plein air “, ricerche : luce e colori, le ombre, le<br />
pennellate veloci ;<br />
la prima esposizione presso il fotografo Nadar, il gruppo degli Impressionisti. Monet:<br />
Impression soleil levant; La colazione sull’erba ; La grenouillère; Cattedrale di Rouen; Lo<br />
stagno delle ninfee;<br />
Degas (Esame di danza)<br />
Renoir (La Grenouillère, Ballo al Moulin de la Galette, Le grandi bagnanti).<br />
5) Postimpressionismo<br />
1886:l’ultima mostra impressionista ed il clima culturale di fine secolo;<br />
Cézanne (Veduta di Auvers, L’Estaque, Le grandi bagnanti);<br />
Seurat (Una domenica all’isola Grande-Jatte);<br />
Gauguin (La visione dopo il sermone, Autoritratto, Ia orana Maria );<br />
Van Gogh (I mangiatori di patate, Il caffè di notte, La chiesa di Auvers);<br />
Cenni sul simbolismo in Francia (G.Moreau, L’apparizione) e nella mitteleuropa (Munch,Il<br />
grido);<br />
Il Divisionismo italiano; Previati, Segantini e Pelizza da Volpedo.<br />
6) Il Novecento<br />
Cenni sulle Avanguardie storiche . Espressionismo, cubismo,astrattismo e futurismo:<br />
caratteri e temi attraverso opere esemplari (Kirchner, Cinque donne nella strada; Picasso,<br />
Demoiselles d’Avignon ; Kandinsky, Prova di copertina per “Il cavaliere azzurro”).<br />
Il Futurismo italiano: ideologia e poetica nei manifesti; Boccioni (La città<br />
che sale, Forme uniche nella continuità dello spazio).<br />
2. Eventuali altre discipline coinvolte:<br />
Parziale e solo episodico è stato nel corso dell’anno il rapporto con le altre discipline.<br />
3. Attività scolastiche a supporto della preparazione degli studenti<br />
Durante l’anno scolastico 2007-2008 sono state effettuate le seguenti uscite didattiche:<br />
Visita guidata al museo Morandi di Bologna<br />
Visita guidata al Mambo di Bologna.<br />
4. Eventuali altri elementi significativi per la redazione della terza prova scritta<br />
Gli studenti si sono esercitati soprattutto nella tipologia B della terza prova (risposte a quesiti singoli).<br />
5. Obiettivi inizialmente fissati<br />
Obiettivi<br />
• Saper analizzare le caratteristiche formali delle opere d’arte, comunicando con un<br />
linguaggio chiaro ed un lessico corretto;<br />
• conoscere gli argomenti trattati e saperli comunicare in modo efficace e comprensibile;<br />
63
• comprendere le relazioni che le opere hanno con il contesto culturale, storico,<br />
geografico in cui sono state prodotte;<br />
• saper esprimere giudizi critici ;<br />
• conoscere i caratteri del patrimonio artistico italiano e la sua importanza come<br />
elemento di identità nazionale;<br />
• saper istituire relazioni fra i contenuti specifici della disciplina e quelli di altre<br />
produzioni culturali in un dato momento storico.<br />
6. Eventuale revisione degli obiettivi inizialmente fissati<br />
Si è fatto riferimento agli obiettivi minimi.<br />
7. Criterio di sufficienza adottato<br />
Obiettivi minimi:<br />
• saper condurre l’analisi dell’opera con un certo metodo<br />
• utilizzare un lessico abbastanza preciso<br />
• conoscere nei loro contenuti essenziali gli argomenti studiati<br />
• saper riconoscere anche in opere non esaminate in classe i tratti caratteristici di un<br />
artista o corrente artistica studiata.<br />
Sono stati valutati l’interesse e l’impegno nel corso delle lezioni,la regolarità della frequenza e<br />
dell’impegno a casa e, infine, l’eventuale miglioramento rispetto alla condizione di partenza.<br />
8. Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione<br />
Verifiche orali, esercitazioni scritte (principalmente tipologia B di terza prova)<br />
9. Numero delle prove svolte:<br />
Almeno due prove a quadrimestre<br />
10. Ore assegnate per lo svolgimento delle prove<br />
50 minuti (1 ora di lezione ) per le prove scritte<br />
11 Altre indicazioni<br />
La classe ha avuto continuità nell’insegnamento della storia dell’arte .<br />
La cronica mancanza di ore della disciplina (due ore settimanali), in relazione alla<br />
vastità dei programmi, si aggrava ogni anno per l’ulteriore diminuzione determinata<br />
dalle molteplici attività che coinvolgono gli studenti (area di progetto, stage, uscite…).<br />
Questo porta ad una ulteriore riduzione delle ore effettive (quest’anno, al 15 maggio<br />
sono state 44), ad una difficoltà di approfondimento, di verifica regolare degli<br />
apprendimenti e al ritardo nello svolgimento dei programmi. Anche quest’anno,<br />
infatti, tra settembre e ottobre, sono stati trattati autori e opere relative al<br />
rinascimento e al barocco al fine di completare il programma di quarta.<br />
L’ultimo argomento in programma, sulle avanguardie del ‘900, sarà svolto in maniera<br />
assai rapida (tre ore di lezione nella seconda metà di maggio) per offrire agli studenti<br />
una visione generale, attraverso poche opere esemplificative, senza affrontare in<br />
modo specifico movimenti e artisti.<br />
64
Pochi studenti ad oggi hanno comunicato la scelta di argomenti di approfondimento<br />
per i percorsi d’esame, che devono considerarsi quindi frutto di un lavoro individuale.<br />
65
Materia MATEMATICA APPLICATA<br />
Docente Prof. FABIO FACCIOLI<br />
Libro di testo adottato:<br />
Altri testi utilizzati<br />
Baroncini – Fabbri - Grassi: Lineamenti di matematica: modulo E<br />
Altri sussidi didattici<br />
utilizzati:<br />
fotocopie<br />
1. Argomenti svolti nell'anno:<br />
Ripasso di elementi di algebra: disequazioni di primo grado e sistemi di disequazioni lineari in due<br />
variabili, disequazioni non lineari e sistemi di disequazioni non lineari in due variabili;<br />
Ripasso delle principali funzioni studiate negli anni precedenti: retta, parabola, iperbole non<br />
equilatera; determinazione del punto di massimo e di minimo di dette funzioni con metodi elementari.<br />
Richiami sulle funzioni di una variabile reale, sul dominio e codominio delle funzioni, .<br />
Funzioni economiche: funzione della domanda e dell’offerta.<br />
Equilibrio tra domanda e offerta;<br />
Funzione costi di produzione, funzione ricavo, funzione di guadagno o profitto.<br />
Analisi del punto di equilibrio economico.<br />
Problemi di scelta in condizioni di certezza e con effetti immediati:<br />
caso continuo e caso discreto;<br />
scelta tra due o più alternative rappresentate da una funzione, punti di indifferenza.<br />
Problemi di scelta in condizioni di certezza con effetti differiti: concetto di investimento finanziario,<br />
criterio della preferenza assoluta.<br />
Funzioni in due variabili: generalità e rappresentazione grafica. Funzioni lineari in due variabili<br />
sottoposti a vincoli lineari, programmazione lineare in due variabili (metodo grafico).<br />
Ricerca operativa: la gestione delle scorte: ricerca del lotto economico d’acquisto.<br />
2. Eventuali altre discipline coinvolte:<br />
Si sono fatti collegamenti con economia aziendale per argomenti quali: concetto di costo, ricavo,<br />
guadagno, punto di equilibrio, scorte.<br />
3. Attività scolastiche a supporto della preparazione degli studenti:<br />
Recupero in itinere.<br />
4. Eventuali altri elementi significativi per la redazione della terza prova scritta:<br />
Si è dato maggior rilievo all’analisi del break even point ; alla scelta in condizioni di certezza con effetti<br />
immediati; programmazione lineare in due variabili;lotto economico d’acquisto.<br />
5. Obiettivi inizialmente fissati:<br />
Conoscere in modo corretto definizioni e proprietà, applicare le nozioni acquisite a modelli relativi a<br />
situazioni teoriche e pratiche sapendoli analizzare e rappresentare in modo adeguato. Elaborare<br />
informazioni e utilizzare calcoli e strumenti per tradurre e rappresentare problemi economici, finanziari,<br />
classificarli e scegliere le alternative migliori mediante la rappresentazione grafica senza l’ausilio<br />
dell’analisi matematica.<br />
66
6. Eventuale revisione degli obiettivi inizialmente fissati<br />
7. Criterio di sufficienza adottato<br />
Si è fatto riferimento al documento “ Scheda di programmazione attività educative e<br />
didattiche” approvato dal Consiglio di Classe per cui si ritiene sufficiente la conoscenza<br />
concettuale degli argomenti con esposizione semplice e corretta.<br />
8. Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione<br />
Verifica formativa: esercizi alla lavagna ; domande dal posto;.<br />
Verifica sommativa: interrogazioni lunghe; problemi; prove semi strutturate;<br />
9. Numero delle prove svolte<br />
Quattro/cinque verifiche, una/due orali, una scritta e due simulazioni di terza prova scritta.<br />
10. Ore assegnate per lo svolgimento delle prove:<br />
Due per la verifica scritta e circa 1/2 ora per la verifica orale.<br />
11. Altre indicazioni:<br />
La classe risulta variegata per quanto riguarda il profitto: una parte degli alunni ha conseguito risultati<br />
buoni o ottimi dimostrando buone capacità di assimilazione e rielaborazione di contenuti e un<br />
metodo di studio ben organizzato; una parte degli allievi ha dimostrato di possedere una<br />
preparazione mediamente sufficiente o discreta, alcuni invece sono riusciti a raggiungere appena la<br />
sufficienza vuoi per le difficoltà pregresse nella disciplina e per un impegno saltuario finalizzato alle<br />
verifiche o per un approccio superficiale alla materia.<br />
Il comportamento è sempre stato più che corretto durante tutto l’anno scolastico.<br />
67
Materia: GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA<br />
Docente: Prof. ANDREA CORTICELLI<br />
Libro di Testo adottato: N.Garrè,C. Lanza, F.Nano, G.Merlo, SVILUPPO E<br />
SOTTOSVILUPPO, LA COMPLESSITA’ DEL SUD DEL<br />
MONDO, Milano Bompiani 2002.<br />
N.Garrè, G.Merlo, IL MONDO EXTRAEUROPEO<br />
CONTINENTI E PAESI, Bompiani Milano 2006<br />
Altri testi utilizzati:<br />
Altri sussidi didattici utilizzati: La povertà? Mettiamola in un museo<br />
Lezione italiana del premio Nobel per la pace Muhamad Yunus<br />
( 2007)<br />
Film Matrimoni e pregiudizi di Gurinder Chadha<br />
Presentazioni powerpoint prodotte dal docente su: Sud<br />
del mondo, India, Brasile, Africa del Nord e Asia Sud-Ovest<br />
1. Argomenti svolti nell’anno<br />
MODULO N. 1: Dualismo Nord-Sud<br />
(Garrè,Lanza, Nano, Merlo LA COMPLESSITA’ DEL SUD DEL MONDO mod 1 unità 1, 2 e 3)<br />
Gli indicatori statistici economici e sociali<br />
L’indice di sviluppo umano<br />
Le cause storiche ed economiche del sottosviluppo<br />
Aspetti economici e finanziari del sottosviluppo<br />
Le teorie del sottosviluppo<br />
Sviluppo autocentrato ed estrovertito<br />
Ruolo della Banca mondiale e del FMI<br />
Le organizzazioni non governative<br />
MODULO N. 2: Geografia della popolazione<br />
(Garrè,Lanza, Nano, Merlo LA COMPLESSITA’ DEL SUD DEL MONDO mod 2 unità 1 e 3)<br />
La distribuzione della popolazione sulla Terra<br />
L'evoluzione storica della popolazione mondiale.<br />
Analisi dell'andamento demografico nei paesi del Nord e del Sud del mondo<br />
I flussi migratori<br />
MODULO N. 3: L’India<br />
(Garrè,Lanza, Nano, Merlo LA COMPLESSITA’ DEL SUD DEL MONDO mod 3 unità 2)<br />
I principali elementi fisici, climatici<br />
La popolazione<br />
Economia della regione indiana<br />
La struttura regionale<br />
I principali problemi della regione indiana<br />
MODULO N. 4: il Brasile<br />
(N.Garrè, G.Merlo, IL MONDO EXTRAEUROPEO CONTINENTI E PAESI mod. 3 unità 3)<br />
Le dimensioni di un continente<br />
I principali elementi fisici, climatici<br />
Popolamento e assetto urbano<br />
Un sistema economico con forti squilibri<br />
Economia della regione<br />
I principali problemi del Brasile<br />
68
MODULO N. 5: Asia occidentale e Nord Africa<br />
N.Garrè, G.Merlo, IL MONDO EXTRAEUROPEO CONTINENTI E PAESI (mod. 2 unità 3, mod .4,<br />
unità 2 )<br />
La posizione geografica e l’ambiente<br />
Popoli culture e insediamenti<br />
L’assetto politico attuale dell’area nella sua evoluzione storica recente<br />
Economia della regione<br />
Il petrolio<br />
I problemi geo-politici dell’area<br />
2. Eventuali altre discipline coinvolte<br />
3. Attività scolastiche a supporto della preparazione degli studenti<br />
Due incontri con esperti del Cefa sulle O.n.g e su un progetto di cooperazione<br />
internazionale relativo alla produzione del caffè in Guatemala (15 e 22 febbraio 2008)<br />
4. Eventuali altri elementi significativi per la redazione della terza prova scritta<br />
5. Obiettivi inizialmente fissati<br />
Obiettivi generali<br />
1. Conoscenze.<br />
Il dualismo Nord-Sud<br />
Le principali tendenze demografiche attuali nel mondo<br />
I caratteri geografici ed economici di due regioni extraeuropee emergenti (India e Brasile)<br />
Aspetti della complessa realtà socio-economica e politica dell’area medio orientale<br />
2. Competenze.<br />
saper leggere e interpretare materiale specifico ( carta geografica, tematica, ecc.)<br />
saper collocare in una corretta sequenza temporale particolari fenomeni geografici con i relativi nessi<br />
culturali, sociali, economici<br />
saper ordinare i diversi fenomeni secondo un rapporto di causa ed effetto<br />
saper analizzare un sistema territoriale ricorrendo a semplici modelli interpretativi<br />
saper valutare le varie problematiche geografiche motivando opportunamente le proprie opinioni.<br />
saper raccogliere informazioni geografiche, organizzarle in modo sistematico e presentarle con un<br />
linguaggio appropriato.<br />
3. Capacità.<br />
saper lavorare in gruppo<br />
saper organizzare una discussione intorno ad un argomento posto<br />
Obiettivi specifici raggiunti<br />
MODULO N. 1<br />
Competenze disciplinari<br />
Conoscere gli aspetti principali del sottosviluppo<br />
Conoscere il significato dei principali indicatori statistici sociali ed economici<br />
Descrittori di competenze<br />
Saper localizzare sul planisfero le principali aree del sottosviluppo<br />
Saper utilizzare ed interpretare dati statistici appropriati per la conoscenza del fenomeno<br />
69
Saper individuare le cause e le conseguenze del fenomeno<br />
Saper indicare le vie dello sviluppo<br />
MODULO N. 2<br />
Competenze disciplinari<br />
Conoscere le principali tendenze della popolazione mondiale<br />
Descrittori di competenze<br />
conoscere il concetto di transizione demografica<br />
saper individuare le differenze principali tra i comportamenti demografici dei paesi ricchi e dei paesi<br />
poveri e le conseguenze sul piano socio-economico<br />
MODULO N. 3<br />
Competenze disciplinari<br />
Conoscere e analizzare una regione economica extraeuropea a sviluppo medio<br />
Descrittori di competenze<br />
Saper individuare i vantaggi e gli svantaggi ambientali relativi alle caratteristiche naturali della regione<br />
Saper individuare le principali caratteristiche dell'economia della regione<br />
Saper individuare le cause dei principali squilibri economici della regione<br />
MODULO N. 4<br />
Competenze disciplinari<br />
Conoscere e analizzare una regione economica extraeuropea emergente<br />
Descrittori di competenze<br />
Saper individuare i vantaggi e gli svantaggi ambientali relativi alle caratteristiche naturali della regione<br />
Saper individuare le principali caratteristiche dell'economia della regione<br />
Saper individuare le cause dei principali squilibri economici della regione<br />
MODULO N. 5<br />
Competenze disciplinari<br />
Conoscere gli aspetti specifici dell’ambiente desertico<br />
Conoscere e analizzare la complessa realtà socio-economica e politica dell’area<br />
Descrittori di competenze<br />
Saper individuare i vantaggi e gli svantaggi ambientali relativi alle caratteristiche naturali della regione<br />
Saper individuare le principali problematiche legate alla risorsa petrolifera<br />
Saper individuare le cause e le conseguenze dell’instabilità politica dell’area<br />
6. Eventuale revisione degli obiettivi inizialmente fissati<br />
Il programma è stato svolto secondo le indicazioni del piano di lavoro ad eccezione del<br />
modulo relativo all’Africa che non è stato svolto per ragioni di tempo<br />
Gli obiettivi indicati nella programmazione di inizio anno sono stato raggiunti<br />
7. Criterio di sufficienza adottato<br />
La valutazione dello studente ha tenuto conto dei seguenti elementi:<br />
1) livello di partenza;<br />
2) controllo e verifica del raggiungimento dei livelli minimi prefissati;<br />
3) partecipazione e interesse dimostrati;<br />
4) risultati di verifiche (test scritti e verifiche orali);<br />
5) progressione nel processo di apprendimento.<br />
“La soglia di Sufficienza si raggiunge mediante il raggiungimento degli standard minimi di conoscenza<br />
indicati nella programmazione iniziale per ogni classe . Si raggiunge inoltre mediante l’uso della<br />
terminologia specifica e una coerente esposizione e con una capacità di analisi e di confronto tra<br />
situazione diverse in modo autonomo per la classe quinta” (dal verbale della riunione di dipartimento).<br />
Nelle verifiche scritte a ciascuna domanda è stato attribuito un punteggio commisurato alla complessità<br />
della risposta richiesta. Gli indicatori di cui si è tenuto conto nella valutazione sono:<br />
pertinenza della risposta, ordine e coerenza della esposizione dei contenuti, correttezza e proprietà dei<br />
linguaggi, capacità di utilizzare e applicare le conoscenze<br />
70
La valutazione è stata espressa in decimi e i voti sono stati compresi tra 1 e 10.<br />
8. Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione<br />
Prove di verifica con quesiti a risposta breve<br />
Prove di verifica orale<br />
9. Numero delle prove svolte<br />
N. 4 (quattro) prove scritte<br />
N.2 (due) prove orali<br />
10. Ore assegnate per lo svolgimento delle prove<br />
Ogni prova scritta ha avuto la durata di 50 minuti.<br />
La prova orale ha avuto una durata pari a circa 20 minuti per ogni studente<br />
11. Altre indicazioni<br />
71
Materia <strong>DI</strong>RITTO ED ECONOMIA PER L’AZIENDA<br />
Docente Prof. FRANCO GIORGI<br />
Libro di testo adottato: AA.VV. a cura di Piero Della Valentina – Percorsi di diritto ed<br />
economia per l’azienda – Ed. Tramontana<br />
Altri testi utilizzati:<br />
Altri sussidi didattici<br />
utilizzati:<br />
1. Argomenti svolti nell'anno:<br />
Costituzione, Codice Civile, Accordo Interbancario, fotocopie varie,<br />
Internet<br />
LE AZIENDE <strong>DI</strong> CRE<strong>DI</strong>TO<br />
Il sistema finanziario e le banche: il risparmio, gli intermediari, l’attività bancaria. Il Testo Unico su<br />
banche e credito, il sistema europeo di banche centrali e le autorità creditizie nazionali, gli strumenti<br />
di politica monetaria comune.<br />
L’organizzazione e la gestione strategica delle banche: l’evoluzione e l’organizzazione delle banche,<br />
la gestione, l’orientamento strategico, l’informazione tecnologica e il marketing bancario.<br />
I caratteri generali delle operazioni bancarie: la classificazione e il prezzo delle operazioni bancarie,<br />
la tutela dei clienti, la trasparenza e il segreto bancario.<br />
Le operazioni di raccolta fondi: i depositi a risparmio liberi e vincolati, i certificati di deposito, i conti<br />
correnti e i servizi collegati.<br />
Le operazioni di impiego fondi e i servizi accessori: la concessione di fido, l’apertura di credito, il<br />
portafoglio sconti e sbf.<br />
IL TURISMO E LE IMPRESE TURISTICHE<br />
Il turismo nel quadro dell’economia nazionale ed internazionale: la domanda e l’offerta, il mercato<br />
turistico. Sviluppo ed evoluzione del settore dal Grand Tour ai giorni nostri. Turismo ed ambiente<br />
La legislazione turistica: la legge quadro del 1983 e la sua riforma del 2001. Direttive europee e<br />
convezioni internazionali. Enti pubblici e privati.<br />
Gli operatori turistici privati: strutture ricettive, tour operator, agenzie dettaglianti. I principali<br />
documenti degli operatori turistici.<br />
I SERVIZI E LE IMPRESE <strong>DI</strong> TRASPORTO<br />
Le imprese, la logistica e i trasporti: il contratto di trasporto, trasporto merci e trasporto persone.<br />
Caratteristiche ed evoluzione.<br />
I sistema italiano dei trasporti: ferroviario, su gomma, aereo e marittimo.<br />
LE IMPRESE ASSICURATIVE<br />
La prevenzione e l’assicurazione: assicurazioni e imprese assicuratrici, l’INPS e il sistema<br />
previdenziale italiano. Il contratto di assicurazione, ramo vita e ramo danni. Coassicurazione e<br />
riassicurazione. Franchigia e scoperto di sicurtà.<br />
Il programma assicurativo delle imprese. Le auto-assicurazioni: fondi rischi e riserve di utili e<br />
capitale. I pacchetti di copertura.<br />
LE AZIENDE <strong>DI</strong> EROGAZIONE<br />
Attività, finalità e classificazioni. Patrimonio, aspetto finanziario ed economico della gestione.<br />
Previsioni.<br />
La struttura organizzativa dello Stato e degli Enti locali.<br />
Il Bilancio dello Stato: il DPEF, la legge finanziaria, bilancio annuale e pluriennale, il rendiconto.<br />
3. Eventuali altre discipline coinvolte:<br />
Lingue straniere, geografica economica, storia dell’arte: il turismo. Lingue straniere,<br />
geografia, storia: il sistema economico in generale.<br />
72
3. Attività scolastiche a supporto della preparazione degli studenti:<br />
Lezioni informatiche interattive, esercitazioni pratiche individuali e di gruppo, analisi di problematiche<br />
aziendali concrete, analisi di documentazione originale.<br />
Incontri con esperti aziendali sulle seguenti tematiche:<br />
- simulazione di un colloquio di lavoro (all’interno del modulo di orientamento post-diploma)<br />
- rapporti tra banche e imprese in particolare per lo sviluppo di un business plan<br />
4. Eventuali altri elementi significativi per la redazione della terza prova scritta:<br />
La disciplina in oggetto è stata inserita in una sola delle simulazioni della terza prova<br />
effettuate durante l’anno per lasciare spazio a maggiori ipotesi operative.<br />
La trattazione dei vari argomenti ha tenuto conto degli obiettivi trasversali definiti in sede di<br />
programmazione: acquisizione delle competenze comunicative e della padronanza dei mezzi<br />
espressivi e utilizzo critico delle nozioni apprese.<br />
Si è privilegiata la trattazione degli aspetti teorico-culturali delle tematiche, in sintonia con gli obiettivi<br />
di formazione della figura professionale ERICA non specialistica e non ragionieristica.<br />
5. Obiettivi inizialmente fissati:<br />
Conoscere la natura e le caratteristiche delle imprese del settore terziario.<br />
Analizzare l’evoluzione, le principali problematiche e le strategie utilizzate per affrontarle.<br />
Acquisire capacità autonome nella scelta e nell’utilizzo delle informazioni per la soluzione di problemi<br />
operativi.<br />
Comprendere i collegamenti esistenti tra le varie funzioni aziendali e le interazioni esistenti tra le<br />
varie aziende, per avere una visione globale della realtà operativa.<br />
6. Eventuale revisione degli obiettivi inizialmente fissati:<br />
Si è fatto riferimento alle discrete capacità di rielaborazione autonome del gruppo classe e si<br />
sono considerati i collegamenti fondamentali.<br />
7. Criterio di sufficienza adottato:<br />
Lo studente deve saper riconoscere le caratteristiche generali delle aziende del settore terziario negli<br />
aspetti storico-evolutivi, organizzativi e gestionali, deve saper esporre correttamente gli elementi<br />
essenziali del programma trattato con semplicità e sufficiente proprietà di linguaggio, anche<br />
avvalendosi in prevalenza di capacità mnemoniche.<br />
Ad ogni buon conto si fa riferimento alla programmazione di dipartimento.<br />
8. Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione:<br />
Verifica formativa: domande flash, lavori di gruppo ed esercizi in collaborazione.<br />
Verifica sommativa: prove non strutturate, semistrutturate e strutturate: esercizi applicativi, scelte<br />
multiple, vero/falso, domande aperte.<br />
9. Numero delle prove svolte:<br />
Due verifiche scritte e due verifiche orali sia sotto forma di colloquio che di questionario per<br />
quadrimestre. Una simulazione di terza prova.<br />
10. Ore assegnate per lo svolgimento delle prove:<br />
Due ore per le prove scritte a domande aperte, dai quaranta ai settanta minuti per prove<br />
strutturate e mediamente trenta minuti per colloqui orali.<br />
73
11. Altre indicazioni:<br />
Considerato il percorso intrapreso quest’anno si può affermare che relativamente al profitto la classe si<br />
è espressa costantemente su livelli decisamente soddisfacenti: un buon numero di allievi ha<br />
conseguito risultati buoni o ottimi, confermando ottime capacità di assimilazione dei contenuti, metodo<br />
di studio ben organizzato e crescente acquisizione di competenze logico-espressive e rielaborative<br />
mentre una piccola parte non è riuscita sempre a raggiungere un livello di conoscenza e competenza<br />
sufficiente. Per questi ultimi va però sottolineato che le maggiori difficoltà si sono evidenziate<br />
soprattutto negli aspetti pratici della disciplina. Relativamente al comportamento della classe, in<br />
generale, è sempre stato apprezzabile il buon livello d’attenzione e la disponibilità e partecipazione in<br />
aula anche se il rispetto degli impegni si è manifestato principalmente in prossimità delle verifiche<br />
previste.<br />
74
Materia: EDUCAZIONE FISICA<br />
Docente: Prof.sa SILVIA ACERBO<br />
Libro di Testo adottato:<br />
Altri testi utilizzati:<br />
Altri sussidi didattici utilizzati: Fotocopie<br />
1. Argomenti svolti nell’anno<br />
• Corsa e spostamenti prolungati nel tempo<br />
• Esercizi per la tonificazione generale a corpo libero e con i sovraccarichi (circuiti)<br />
• Esercizi a corpo libero di mobilità sia attiva che passiva<br />
• Acrosport: piramidi a due, tre e più elementi<br />
• Piccoli attrezzi: funicella<br />
• Grandi attrezzi: palco di salita (pertica e scaletta di corda)<br />
• Giochi di squadra e attività sportive: pallavolo, pallacanestro, calcio a cinque,<br />
baseball,pallamano, giochi preparatori al flag-football<br />
• Teoria: le capacità motorie (la forza, la mobilità articolare)<br />
2. Eventuali altre discipline coinvolte<br />
3. Attività scolastiche a supporto della preparazione degli studenti<br />
4. Eventuali altri elementi significativi per la redazione della terza prova scritta<br />
5. Obiettivi inizialmente fissati<br />
Miglioramento delle qualità fisiche (forza, resistenza,mobilità articolare, velocità) e<br />
miglioramento della funzionalità neuromuscolare (equilibrio,ritmo, combinazione motoria,<br />
differenziazione cinestesica, organizzazione spazio-temporale)<br />
Conoscenza e pratica delle attività sportive proposte<br />
6. Eventuale revisione degli obiettivi inizialmente fissati<br />
7. Criterio di sufficienza adottato<br />
Sufficiente quando lo studente:<br />
individua gli elementi essenziali del programma, applica con semplicità, sufficiente<br />
coordinazione e correttezza, si avvale soprattutto di schemi motori precostituiti, partecipa<br />
alle lezioni con contributi pertinenti e rispetto degli impegni presi, conosce gli elementi<br />
essenziali dei contenuti disciplinari<br />
75
8. Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione<br />
Osservazione sistematica, prove pratiche, test; questionari e interrogazioni brevi per gli<br />
alunni esonerati<br />
9. Numero delle prove svolte<br />
Due prove pratiche e/o teoriche a quadrimestre<br />
10. Ore assegnate per lo svolgimento delle prove<br />
11. Altre indicazioni<br />
76
Materia: RELIGIONE<br />
Docente: Prof. MARCHINI GIAN STEFANO CAMILLO<br />
Libro di Testo adottato: S. BOCCHINI, 30 Schede per l’insegnamento della Religione<br />
Cattolica. Scuole superiori, EDB, Bologna<br />
Altri testi utilizzati: Bibbia, Documenti del Magistero Ecclesiale<br />
Altri sussidi didattici utilizzati: Materiale audiovisivo<br />
1. Argomenti svolti nell’anno<br />
• Inquadratura generale dei concetti di etica, morale, legge, libertà. Inquadratura di alcuni modelli etici:<br />
utilitaristico, soggettivistico, ecologista, tecnico-scientifico, della responsabilità, personalistico,<br />
religioso.<br />
• Elementi biblici a fondamento dell’etica dell’amore: principi universali e specificità cristiane.<br />
• Fondamenti antropologici per un’etica dell’amore: alcuni modelli ricorrenti nella cultura attuale. Il<br />
significato dell’amore sta nel dono di sé.<br />
• Etica dell’amore secondo l’ideale Biblico-evangelico. Premesse al significato umano dell’esperienza<br />
affettiva. La coscienza per l’etica secondo la Costituzione Pastorale Gaudium et Spes 16, del<br />
Concilio Ecumenico Vaticano secondo. Analisi dei passi salienti dell’enciclica Humanae Vitae (luglio<br />
1968).<br />
• Procreazione responsabile e regolazione della fertilità: la posizione della Chiesa cattolica circa la<br />
contraccezione e la regolazione naturale della fertilità<br />
• Analisi dei film:<br />
Casomai di A. D’Alatri, circa le dimensioni dell’amore coniugale.<br />
Non ti muovere di S. Castelletto.<br />
• Incontro con alcune realtà locali significative:<br />
Fiori di Strada: associazione per il recupero delle prostitute.<br />
Passo Passo: associazione per il supporto e reinserimento delle persone disabili.<br />
Incontro con la direttrice del Carcere minorile di Bologna<br />
• Scelte di vita ecclesiale: la vocazione religiosa e quella sacerdotale. Le scelte di vita celibatarie.<br />
• Elementi di Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica a partire dal Compendio della Dottrina sociale<br />
della Chiesa Cattolica.<br />
• Coscienza ed obiezione di coscienza: analisi di alcuni testi di Lorenzo Milani.<br />
77