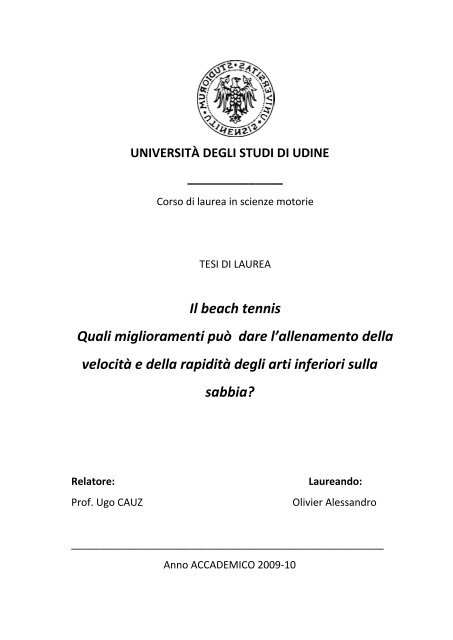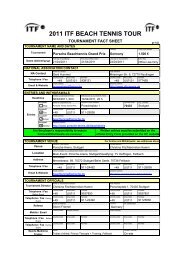Il beach tennis Quali miglioramenti può dare l ... - Beachtennis Time
Il beach tennis Quali miglioramenti può dare l ... - Beachtennis Time
Il beach tennis Quali miglioramenti può dare l ... - Beachtennis Time
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE<br />
______________<br />
Corso di laurea in scienze motorie<br />
TESI DI LAUREA<br />
<strong>Il</strong> <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong><br />
<strong>Quali</strong> <strong>miglioramenti</strong> <strong>può</strong> <strong>dare</strong> l’allenamento della<br />
velocità e della rapidità degli arti inferiori sulla<br />
sabbia?<br />
Relatore: Laureando:<br />
Prof. Ugo CAUZ Olivier Alessandro<br />
_______________________________________________________<br />
Anno ACCADEMICO 2009-10
INDICE<br />
Sommario……………………………………………………………….………………p. 3<br />
Indice delle figure…………………………………………………………………………….. .p. 5<br />
Indice delle tabelle……………………………………………………………………………..p. 6<br />
Introduzione……………………………………………………………………………………... p. 9<br />
Capitolo I<br />
LA STORIA DEL BEACH TENNIS<br />
1.1. Dove e perché nasce il <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong>…………………………………….. p. 11<br />
1.2. Dal primo regolamento alle regole ufficiali odierne……………… p. 12<br />
1.3. Evoluzione delle federazioni………………………………………………….p. 14<br />
1.4. I tornei più importanti.…………………………………………………………. p. 17<br />
Capitolo II<br />
STUDIO DELLA DISCIPLINA<br />
2.1. Caratteri e regole del gioco…………..……….…………………………….. p. 21<br />
2.1.1. Tipi di competizioni…………………………………………………………. p. 21<br />
2.1.2. Punteggio………………………………………………………………………… p. 22<br />
2.1.3. Classifica…………………………………………………………………………..p. 23<br />
2.1.4. Regolamento…………………………………………………………………… p. 26<br />
2.2. Colpi fondamentali………………………………………………………………..p. 29<br />
2.2.1. Le impugnature……………………………………………………………….. p. 29<br />
2.2.2. La volée di dritto……………………………………………………………... p. 32<br />
2.2.3. La volée di rovescio…………………………………………………………. p. 33<br />
2.2.4. La battuta………………………………………………………………………… p. 35<br />
2.2.5. La schiacciata…………………………………………………………………… p. 37<br />
2.2.6. <strong>Il</strong> bilanciere……………………………………………………………………… p. 38<br />
3
2.2.7. <strong>Il</strong> pallonetto………………………………………………………………………p. 39<br />
2.2.8. La smorzata……………………………………………………………………… p. 39<br />
2.3. La preparazione tecnico-tattica……………………………………………. p. 40<br />
2.3.1. La tecnica………………………………………………………………………… p. 40<br />
2.3.2. La tattica…………………………………………………………………………..p. 42<br />
2.4. La collaborazione e l’intesa di squadra…………………………………. p. 44<br />
Capitolo III<br />
PREPARAZIONE ATLETICA – TRAUMATOLOGIA<br />
3.1. La preparazione fisica……………………………………………………………. p. 47<br />
3.1.1. <strong>Il</strong> modello funzionale………………………………………………………. p. 48<br />
3.1.2. La programmazione………………………………………………………… p. 50<br />
3.1.3. Gli esercizi………………………………………………………………………..p. 53<br />
3.2. Traumatologia………….…………………………………………………………… p. 60<br />
Capitolo IV<br />
SCOPO DELLA TESI<br />
4.1. Soggetti……………………………………………...……………………………………. p. 65<br />
4.2. Protocollo sperimentale…………………………………………………………….p. 66<br />
4.3. Protocollo test………………………………………………………………………….. p. 66<br />
4.4. Protocollo di allenamento………………………………………………………… p. 69<br />
4.5. Statistiche………………………………………………………………………………….p. 74<br />
4.6. Discussione dei risultati……………………………………………………………..p. 79<br />
Conclusioni…………………………………………………………………….……………….. p. 80<br />
Bibliografia……………………………………………………………………………………….p. 83<br />
Ringraziamenti………………………………………………………………………………... p. 85<br />
4
Indice delle figure<br />
Fig. 1 Campi da <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong> nella spiaggia di Marina di Ravenna……………. 11<br />
Fig. 2 Foto dei campionati italiani in notturna nella piazza di Forlì.…………. 18<br />
Fig. 3 Tabellone dei vincenti e dei perdenti……………………………………………...21<br />
Fig. 4 Racchetta da <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong>……………………………………………………………….27<br />
Fig. 5 Palline da <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong>…………………………………………………………………… 27<br />
Fig. 6 Campo da gioco e relative dimensioni…………………………………………….. 28<br />
Fig. 7 Base manico della racchetta…………………………………………………………….30<br />
Fig. 8 Sequenza della volée di dritto…………………………………………………………. 32<br />
Fig. 9 Sequenza della volée di rovescio…………………………………………………….. 33<br />
Fig. 10 Fotografia di un battuta………………………………………………………………… 35<br />
Fig. 11 Fotografia del servizio…………………………………………………………………... 36<br />
Fig. 12 Fotografia di uno smash……………………………………………………………….. 37<br />
Fig. 13 Esercizi per la mobilità articolare…………………………………………………. 56<br />
Fig. 14 Esercizi di forza con palla medica………………………………………………….. 56<br />
Fig. 15 Esercizi di scioltezza muscolare e mobilità articolare……………………..57<br />
Fig. 16 esercizi di muscolazione per la parte superiore…………………………….. 57<br />
Fig. 17 <strong>Il</strong>linois Agility test………………………………………………………………………….. 68<br />
Fig.18 Star drill /Short five corner drill……………………………………………………… 71<br />
Fig. 19 X drill, long X drill………………………………………………………………………….. 72<br />
Fig. 20 Spedd ledder………………………………………………………………………………….72<br />
Fig. 21 Istogrammi comprensivi di deviazione standard sul test dei 30 m… 74<br />
5
Fig. 22 Grafici a dispersione della correlazione sui test dei 30 m..……………. 75<br />
Fig. 23 Istogrammi comprensivi di dev. standard su test dei 20m sulla<br />
sabbia...…………………………………………………………………………………………………… 76<br />
Fig. 24 Grafici a dispersione della correlazione sui test dei 20 m sulla<br />
sabbia....……………………………………………………………………………………………………77<br />
Fig. 25 . Istogrammi comprensivi di deviazione standard su test IAT..………. 77<br />
Fig. 26 Grafici a dispersione della correlazione sui test IAT..…………………….. 78<br />
Indice delle tabelle<br />
Tabella 1. categorie di partenza……………………………………………………………….. 24<br />
Tabella 2. Punteggi ottenuti per il piazzamento……………………………………… 24<br />
Tabella 3. punteggi per il valore del torneo……………………………………………… 25<br />
Tabella 4. punti assegnati in base al numero dei partecipanti………………….. 25<br />
Tabella 5. fattore di decurtazione……………………………………………………………..25<br />
Tabella 6. Caratteristiche antropometriche dei 2 gruppi di soggetti…………. 65<br />
Tabella 7. Valori riferimento IAT………………………………………………………………. 69<br />
Tabella 8. Risultati dei test……………………………………………………………………….. 74<br />
6
9<br />
INTRODUZIONE:<br />
<strong>Il</strong> lavoro qui presentato ha lo scopo di illustrare uno sport che si è diffuso<br />
molto in Italia e nel mondo negli ultimi anni. Uno sport che per la sua natura e<br />
le sue caratteristiche <strong>può</strong> essere giocato a qualunque età e da qualunque<br />
persona, senza distinzioni di sesso, uno sport nel quale si <strong>può</strong> trovare<br />
divertimento,ma senza dubbio anche salute e benessere. Uno sport<br />
estremamente facile da giocare per tutti ma diventa estremamente difficile e<br />
spettacolare mano a mano che cresce il livello dei giocatori. Per emergere<br />
nel <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong> occorre un buon rapporto con l'attrezzo, riflessi e velocità<br />
sulla sabbia: l'equilibrio fra queste doti porta a distinguersi. Questo nuovo<br />
sport ha il vantaggio che si <strong>può</strong> giocare 12 mesi all'anno, e che non <strong>può</strong> essere<br />
disturbato dalle condizioni meteorologiche. Ma soprattutto è uno sport più<br />
veloce del <strong>tennis</strong> e più dinamico della pallavolo: praticamente prende i lati<br />
migliori di questi. Con questa tesina si ha l’intenzione di portare alla luce tutti<br />
gli aspetti di questa disciplina, si porrà attenzione sui fondamenti della<br />
preparazione atletica necessaria al fine di migliorare le condizioni fisiche<br />
dell’atleta, e quindi la performance. Verrà quindi presentato un lavoro svolto<br />
negli ultimi 5 mesi con dei giocatori di <strong>beach</strong>-<strong>tennis</strong> e di <strong>tennis</strong>, che si poneva<br />
come obbiettivo il miglioramento della velocità e della rapidità degli arti<br />
inferiori. Un ulteriore parte poi sarà dedicata alla traumatologia specifica di<br />
questo sport e alla prevenzione degli infortuni.
1.1. Dove e perché nasce il <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong><br />
11<br />
1. STORIA:<br />
Ci sono molte versioni e contraddizioni riguardo la data di nascita di questo<br />
sport, c’e chi dice che sia un discendente della pallacorda e del tamburello, e<br />
attribuisce la sua nascita ai primi anni del secolo scorso, altri che invece<br />
collocano la nascita ai primi anni dopo la grande guerra, ma quasi tutti<br />
concordano nell’ affermare che le prime partite e i primi tornei si iniziarono a<br />
disputare nelle spiagge<br />
Ravennati tra la fine degli anni<br />
70 e i primi anni 80, una delle<br />
spiagge storiche e<br />
fondamentali alla quale poter<br />
ricondurre la nascita del <strong>beach</strong><br />
<strong>tennis</strong> è proprio la quella di<br />
Marina di Ravenna. Perché in<br />
questa località? Diciamo che<br />
una buona parte del merito va<br />
Fig. 1 Campi da <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong> nella spiaggia di<br />
Marina di Ravenna.<br />
alla morfologia del territorio e alle leggi che vigevano su di esso,questa<br />
spiaggia infatti,vantava di essere estremamente estesa,e per preservare la<br />
folta pineta che costeggiava la spiaggia, vi erano vincoli paesaggistici che<br />
impedivano di costruire edifici e abitazioni immediatamente dietro la<br />
spiaggia. Data la mancanza di alberghi e abitazioni private vicine agli<br />
stabilimenti balneari, per i motivi sopra citati, il tipo di turismo era
esclusivamente di tipo pendolare. I bagnanti in qualche modo dovevano<br />
passare il tempo nelle lunghe giornate al mare, e vista l’enorme larghezza<br />
della spiaggia,vi era la presenza di decine e decine di campi da <strong>beach</strong> volley,<br />
questo sport era molto faticoso, difficile e impegnativo,e necessitava di un<br />
numero “cospicuo” di giocatori per poter fare una partita, per questo motivo<br />
molti di questi campi venivano lasciati liberi, fu allora che ad alcuni bagnanti<br />
venne l’idea di costruirsi delle racchette, simili a quelle usate per giocare a<br />
<strong>tennis</strong>, ma che al posto delle corde avevano un piatto in legno o in plastica, e<br />
provare a fare degli scambi con queste utilizzando la pallina da <strong>tennis</strong>, da qui<br />
ha origine il fenomeno dei “racchettoni” o “<strong>beach</strong> <strong>tennis</strong>”.<br />
Questo gioco tuttora esistente, con tanto di federazione, ha<br />
rappresentato negli ultimi decenni lo sport da spiaggia per eccellenza lungo le<br />
spiagge Ravennati e Ferraresi, si calcola che nel litorale Emiliano Romagnolo<br />
infatti esista circa il 50% dei campi da gioco di tutta la penisola, con buona<br />
diffusione via via crescente anche nel Lazio, Puglia, Marche, Toscana,<br />
Sardegna, Veneto, Friuli, Campania e Sicilia, favorite ovviamente dalla<br />
presenza di arenili sabbiosi, mentre in altre regioni quali la Lombardia e<br />
Piemonte, un grande impulso viene dato da strutture coperte create ad hoc.<br />
1.2. Dal primo regolamento alle regole ufficiali odierne:<br />
<strong>Il</strong> gioco del <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong> come detto nel capitolo precedente sin dalle sue<br />
origini è sempre stato strettamente legato al <strong>beach</strong> volley, le prime partite<br />
infatti venivano disputate sui campi dello stesso, quindi a rete alta (oltre i<br />
due metri), possiamo ben immaginare che questo portava a un gioco molto<br />
lento, di conseguenza principalmente fatto di pazienza e grande resistenza;<br />
altre caratteristiche che manteneva dal <strong>beach</strong> volley erano: l’utilizzo del<br />
12
campo grande: 9x9m, il sistema di punteggio con il meccanismo del cambio<br />
palla, ovvero con il giocatore che rimane al servizio fino a che non perde il<br />
punto, il “net”su battuta (ovvero quando la palla tocca la rete e cade nel<br />
campo avversario) era considerato fallo, e si poteva battere solamente dal<br />
lato destro del campo. Con queste regole il numero dei partecipanti era molto<br />
ridotto, e c’erano raramente tornei, e quei pochi accoglievano scarsissima<br />
partecipazione.<br />
Una prima svolta fondamentale si ha con un intuizione di Giandomenico<br />
Bellettini, il quale capisce come non sia possibile condividere le stesse<br />
strutture con i cugini del <strong>beach</strong> volley, date le diverse peculiarità del nuovo<br />
gioco che stava nascendo, e perciò porta il primo importantissimo<br />
cambiamento: abbassa la rete fino a scendere al 170 cm. Questa intuizione è<br />
un vero e proprio cambio di marcia per il <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong>, che grazie a questo<br />
cambiamento consente scambi dotati di maggior velocità, ma comunque<br />
nemmeno scambi troppo corti, colpi alti, schiacciate, schemi e incroci, tutto a<br />
vantaggio della spettacolarità del gioco, e quindi un interesse e<br />
conseguentemente anche una partecipazione maggiore da parte della gente.<br />
Come sempre è stato sin dall’inizio è ancora una volta il <strong>beach</strong> volley a<br />
disegnare la strada per i nuovi cambiamenti, dopo essere diventato sport<br />
olimpico nel 1996 infatti, da un aggiustamento alle regole, ed il <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong><br />
segue a ruota, il nuovo regolamento prevede: net valido in battuta, e servizio<br />
valido lungo tutta la linea di fondo, non solo dalla parte destra del proprio<br />
campo, questi aggiustamenti hanno contribuito a un maggiore dinamismo, e<br />
una maggiore varietà e imprevedibilità di gioco.<br />
Bellettini, pronto a sfruttare la riduzione delle misure del campo da gioco,<br />
accorciato dagli organi preposti al <strong>beach</strong>-volley dai 9x9 metri iniziali a<br />
8x8,coglie al volo l’opportunità di un significativo cambiamento riguardante il<br />
13
punteggio: archiviato lo score del volley, si inizia a giocare seguendo quello<br />
del <strong>tennis</strong>, 15/30/40 e punto secco sul 40 pari, che, eliminando il doppio<br />
vantaggio per aggiudicarsi il gioco, regala emozioni, sofferenze e souspance<br />
fino all’ultima pallina.<br />
1.3 Evoluzione delle federazioni<br />
Per diverso tempo il gioco del <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong> non ebbe alla sua guida un vero<br />
e proprio presidente, era infatti considerato più che altro un passatempo, una<br />
moda da spiaggia, fu però con l’introduzione delle nuove regole che lo<br />
distinguevano sempre più dal <strong>beach</strong> volley, che il prima citato Giandomenico<br />
Bellettini, esperto di diritto sportivo e cultore di questo sport, nel marzo del<br />
’97, si proclamò inventore del gioco del <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong>, egli fu il primo infatti a<br />
credere di poterlo trasformare da un semplice passatempo divertente in un<br />
vero e proprio sport, con quindi un regolamento ufficiale, manifestazioni<br />
ufficiali, gare nazionali e internazionali, corsi per istruttori, arbitri e giudici.<br />
Sotto il suo impulso venne così a crearsi in ogni regione e in ogni provincia un<br />
responsabile, in poche parole stava nascendo una federazione che copriva<br />
l'aspetto assicurativo e che metteva a disposizione dei suoi associati una<br />
organizzazione! Nasce cosi la F.I.B.T. (federazione italiana <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong>). Nel<br />
contempo nasce anche una Federazione Mondiale, l’ I.F.B.T. , acronimo che<br />
sta per: International Federation Beach Tennis, dove il dott. Bellettini è uno<br />
dei Soci Fondatori e attualmente Presidente della stessa.<br />
La F.I.B.T. è stata mantenuta per diversi anni, fino a quando dopo l’anno<br />
2000 fece il suo ingresso marginale la F.I.T. ( Federazione italiana <strong>tennis</strong> ), le<br />
due però non andavano troppo d’accordo; la prima poteva vantare di un gran<br />
numero di iscritti, la seconda però era molto più espansa. Fino all’anno 2006<br />
il <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong> vive un mondo regolato da 2 entità spesso in collisione tra<br />
14
loro, IFBT capitanata da Giandomenico Bellettini, e Vision (azienda<br />
produttrice di racchette e abbigliamento per il <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong>), legata alla FIT,<br />
guidata da Geo Orsini. Quell’anno la FIT decide di investire tempo e denaro su<br />
questo gioco, assegna Orsini il compito di organizzare un circuito a livello<br />
nazionale che vede la partecipazione di quasi tutti i più forti giocatori, la<br />
maggior parte di essi vi parteciparono.<br />
Nell’anno 2007, a causa di problemi intercorsi tra la federazione<br />
italiana <strong>tennis</strong> e Vision, i quali finiscono addirittura in tribunale, c’è la prima<br />
divisione tra le due organizzazioni, la prima, si appoggia prevalentemente alla<br />
associazione Charlie Max per i tornei principali mentre la seconda confluisce<br />
verso la IFBT di Bellettini che nel frattempo aveva continuato a organizzare un<br />
suo circuito indipendente. Qui iniziano a fioccare multe e squalifiche per<br />
coloro i quali avendo giocato per la prima parte dell’anno i tornei FIT<br />
partecipano a tornei al di fuori di essa considerati “abusivi”.<br />
Questa situazione di duopolio perdura fino a fine 2008, anno in cui avviene<br />
un secondo spin - off tra Orsini e Bellettini, il primo forma un consorzio con<br />
altre 2 importanti aziende produttrici di racchette che nel frattempo hanno<br />
preso piede: Rakketone e TomCaruso, mentre il secondo continua ad avvalersi<br />
dell’appoggio di un’altra azienda: la MBT. Si arriva così alla situazione recente,<br />
con tre circuiti indipendenti , tre mondiali e tre classifiche... tirando le somme,<br />
questo non <strong>può</strong> far altro che diminuire lo spettacolo (i giocatori più forti<br />
erano divisi tra le varie federazioni, e quindi il livello del gioco era<br />
conseguentemente più basso).<br />
Questa situazione, che toglieva peso, credibilità e stimoli adeguati ai top<br />
players è stata una delle motivazioni che hanno portato alla nascita, alla fine<br />
del 2009 dell’AGB (associazione giocatori Beach <strong>tennis</strong>), un associazione<br />
quindi, non una federazione, con lo scopo di tutelare i giocatori nei vari tornei<br />
15
nazionali e internazionali, nei circoli sia outdoor che indoor, sia in estate che<br />
in inverno. Quindi si riconosce a questa associazione una funzione puramente:<br />
Informativa: informare i giocatori riguardo lo svolgimento di tutte le<br />
attività inerenti il <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong> (corsi, eventi, tornei).<br />
Giuridica: consulenza e assistenza legale ai giocatori riguardo il<br />
disbrigo di pratiche di vario genere (es. infortunistiche, contrattuali)<br />
Politica: tutela degli interessi dei giocatori.<br />
All’AGB va riconosciuto un merito importante, ovvero quello di aver riunito<br />
tutti i giocatori più forti, al posto di averli tutti sparpagliati tra le varie<br />
federazioni. La ricerca di interlocutori seri ed affidabili offerta dall’AGB ha<br />
trovato nella FIT una pronta disponibilità a recepire istanze e suggerimenti<br />
tesi a determinare un ulteriore salto di qualità del movimento <strong>beach</strong><br />
<strong>tennis</strong>tico.<br />
Questa mossa da parte della FIT ha fatto si che l’anno scorso, 2010, la<br />
stragrande maggioranza dei giocatori passassero dalla IFBT alla FIT, portando<br />
cosi ad unificare ed innalzare notevolmente il livello e la spettacolarità di<br />
questo gioco.<br />
Fino al 2010 il Beach Tennis era visto esclusivamente come uno sport<br />
amatoriale, fatta eccezione per i pochissimi campioni, che si possono contare<br />
sulle dita delle mani, quindi per i tornei era richiesto solamente il certificato di<br />
buona salute. Da quest’anno invece ci saranno due tipologie di tesseramento:<br />
Tessera agonistica: con la quale l’atleta potrà partecipare a tutti i<br />
tornei, sia agonistici che amatoriali (i primi si differenziano per la<br />
presenza di un montepremi).<br />
16
Tessera non agonistica: con la quale l’atleta potrà partecipare<br />
solamente ai tornei senza montepremi, quindi quelli amatoriali,<br />
valevoli comunque ai fini del punteggio per la classifica.<br />
Questo a dimostrazione della via via maggiore serietà che sta acquistando<br />
questo sport rispetto agli ultimi anni.<br />
La federazione ora organizza tornei non solo a livello nazionale, nel 2010<br />
infatti ha organizzato i mondiali presso il Foro Italico a Roma in concomitanza<br />
con gli internazionali d’ Italia; inoltre, ha dato inizio all’iter che ha come<br />
obbiettivo il riconoscimento del <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong> come sport olimpico già a<br />
partire, almeno in forma dimostrativa, da Londra 2012, questo sarà<br />
sicuramente un primo passo importante per la visibilità mondiale!!<br />
1.4 I tornei più importanti<br />
Uno dei tornei più famosi e prestigiosi, e con più larga partecipazione è il<br />
“torneo Fiorellini”, che si gioca sulle spiagge di Marina di Ravenna sin dal<br />
1995. Nei primi anni di competizioni questo era il torneo con montepremi più<br />
ricco e quindi con grande partecipazione di giocatori, vista anche la successiva<br />
estensione alle coppie femminili, a quelle over e alle coppie juniores. Torneo<br />
che, per la sua grossa adesione, coinvolgeva e coinvolge tuttora diversi<br />
stabilimenti balneari.<br />
Poi abbiamo il “Campionato del Mondo”, organizzato dalla IFBT, si tiene<br />
anch’esso nelle stesse spiagge del precedente,viene introdotto a partire dal<br />
2001 da Bellettini, non appena furono possibili le sfide internazionali; anche<br />
se per la verità, nei primi anni, i partecipanti stranieri erano molto pochi e<br />
pressoché turisti, solo nel giro di qualche anno (nel 2003) si iniziarono a<br />
vedere le prime squadre nazionali con gruppi abbastanza numerosi. La<br />
nazionale italiana, anche se molte volte messa in difficoltà dalla Reunion<br />
17
(isoletta vicina al Madagascar), dalla Germania e da qualche anno dal Brasile,<br />
si è sempre aggiudicata la prova per squadre piazzandosi al primo posto.<br />
Questo mondiale assegna diversi titoli, i più ambiti: doppio maschile e<br />
femminile, ma si gioca anche per il singolare, il doppio misto, categorie over,<br />
categorie giovanili e titoli riservati a specifiche categorie (medici, avvocati,<br />
militari ecc).<br />
Degni di nota anche i<br />
“Campionati Italiani in<br />
Notturna” che dal 2002<br />
si disputano ogni anno<br />
nell’affascinante piazza<br />
Saffi di Forlì nel mese di<br />
Luglio,dove ci si<br />
contende il titolo per il<br />
doppio maschile e il<br />
doppio misto.<br />
Uno dei più importanti tornei è sicuramente quello del Foro Italico,<br />
organizzato dalla FIT in contemporanea con gli internazionali di Tennis, nel<br />
2007 questo torneo ha assegnato il montepremi più alto della storia di questo<br />
sport: ben 8000 euro per la coppia che si aggiudicò il doppio maschile. Dal<br />
2009 questo torneo ha preso il nome di “Campionati mondiali” e, trovandosi i<br />
campi lungo la passeggiata che portava ai campi da <strong>tennis</strong>, hanno incuriosito<br />
molti campioni della racchetta con le corde, che si sono soffermati a fare due<br />
scambi.<br />
18<br />
Fig. 2 Foto dei campionati italiani in<br />
notturna nella piazza di Forlì.
Questo appuntamento ha avuto la sua indiscussa e indiscutibile<br />
consacrazione nel 2010, anno in cui la FIT, forte della nuova linfa portata in<br />
dote dalla stretta collaborazione con l’AGB (Associazione Giocatori di Beach<br />
Tennis), ha visto in campo davvero tutti i migliori specialisti italiani e mondiali.<br />
Come risultato, abbiamo assistito ad uno spettacolo di assoluto valore, grande<br />
lustro per la FIT e l’ITF (International Tennis Federation), con il conseguente<br />
declino della concorrente IFBT che ha perso tutti i suoi migliori giocatori<br />
nazionali e tutti gli stranieri di spicco.<br />
La FIT inoltre sponsorizza ancora il suo “Master tour” in diverse location<br />
italiane, lungo tutta la penisola, con montepremi molto alti.<br />
Per quanto riguarda L’estero invece tra i tornei più importanti possiamo<br />
citare quello di Reunion, che a partire dal 2007 organizza un torneo<br />
internazionale stabile e strutturato, dal 2010 sotto l’egida dell’ITF, (anche qui<br />
gli Italiani sono quasi sempre stati al primo posto).<br />
Altri tornei importanti, quello di Melbourne in Australia in concomitanza<br />
con gli Australian Open di Tennis. Poi in Belgio, in Spagna, in Portogallo,il<br />
torneo di Aruba dove nel 2009 si è giocata la seconda edizione con giocatori<br />
di ben 6 nazioni; ed infine, ma non per importanza abbiamo i tornei che si<br />
disputano negli States, quindi New York, Miami, California, dove sono messi in<br />
palio costantemente ricchi montepremi, dove però le regole, fino al 2009,<br />
erano leggermente diverse da quelle del resto del mondo, in questa versione<br />
del <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong> si utilizzavano racchette più simili a quelle Tennistiche, ma<br />
nonostante questo la nazionale italiana ha sempre fatto eccellenti prestazioni.<br />
Nel 2010, con l’ingresso dell’ITF e la conseguente adozione delle stesse<br />
regole e materiali usati nel resto del mondo, anche da parte di Aruba,<br />
Bermuda e USA, si è acquisita maggior credibilità a livello internazionale,<br />
anche se, ancora una volta, gli italiani hanno confermato la loro superiorità.<br />
19
2.1 Caratteri e regole del gioco<br />
2.1.1. Tipi di competizioni<br />
2. STUDIO DELLA DISCIPLINA:<br />
Come abbiamo detto in precedenza le tipologie di competizioni nel <strong>beach</strong><br />
<strong>tennis</strong> possono essere :<br />
Individuali (sia maschili che femminili).<br />
A coppie (maschili, femminili, miste).<br />
Entrambe possono svolgersi ad eliminazione diretta (tabellone d’estrazione<br />
unico, con eventuale recupero dei perdenti, o tabelloni concatenati di<br />
estrazione o di selezione) oppure, in tutto o in parte, con la formula dei<br />
gironi, tutte queste tipologie di competizioni devono essere previste dal<br />
regolamento di ogni singola competizione o manifestazione.<br />
21<br />
Fig. 3<br />
Tabellone<br />
dei<br />
vincenti e<br />
dei<br />
perdenti
In tutte le competizioni valevoli per il punteggio della classifica generale,<br />
l’inserimento dei vari giocatori nei diversi gironi viene ricavata tramite il<br />
sistema delle teste di serie, che viene tratto, a compito dell’arbitro nelle<br />
competizioni, mentre del direttore di gara in quelle non agonistiche, appunto<br />
dalla classifica nazionale. Questo per fare in modo che si classifichino alle fasi<br />
avanzate del torneo i giocatori più forti e che quindi anche la finale sia degna<br />
del suo nome, con entrambi i giocatori o le coppie che ci sono arrivate per<br />
merito e non solamente perché hanno avuto la fortuna di incontrare giocatori<br />
poco preparati nelle fasi precedenti a quelle finali.<br />
2.1.2. Punteggio<br />
Per quanto riguarda il punteggio, per tutti gli incontri delle competizioni<br />
agonistiche si possono utilizzare due formule:<br />
a) Una sola partita a nove giochi, con applicazione della regola del tie-break<br />
ai sette punti,sul punteggio di 8 giochi pari.<br />
b) Due partite a sei giochi ed eventuale tie-break a dieci punti al posto della<br />
eventuale terza partita.<br />
Si applica il sistema di punteggio “senza vantaggi” e quindi sul punteggio di<br />
parità si gioca un punto decisivo; il giocatore che vince il punto decisivo si<br />
aggiudica il gioco. Nelle gare con formula a girone e quando gli iscritti sono in<br />
numero superiore a 32, nelle prime fasi e finché il numero dei partecipanti<br />
rimasti in gara non è inferiore a tale limite, si <strong>può</strong> disputare una sola partita a<br />
sei giochi, con applicazione della regola del tie-break ai sette punti sul<br />
punteggio di sei giochi pari.<br />
22
Per tutti gli incontri delle competizioni non agonistiche invece i metodi di<br />
punteggio utilizzati sono:<br />
a) Una sola partita a sei giochi, con applicazione della regola del tie-break a<br />
sette punti, sul punteggio di sei giochi pari.<br />
b) Due partite a quattro giochi ed eventuale tie-break decisivo a sette punti<br />
al posto della terza partita.<br />
Sempre con sistema di punteggio senza vantaggi e quindi punto decisivo sulla<br />
parità.<br />
All’interno del tie-break la numerazione dei punti è quella tradizionale e non<br />
segue quindi più il punteggio <strong>tennis</strong>tico, si aggiudica il tie-break e quindi<br />
anche il set chi dei 2 giocatori/coppie per primo totalizza almeno 7 punti con<br />
un vantaggio di 2 punti sull’avversario. <strong>Il</strong> giocatore che si trova in ricezione<br />
nell’ultimo servizio prima di an<strong>dare</strong> al tie-break ha diritto di servire la prima<br />
battuta del tie-break, successivamente la battuta si cambierà ogni 2 punti<br />
giocati, continuando sempre a rispettare il turno di battuta, ogni 4 punti<br />
inoltre, nel tie-break bisogna effettuare un rapido cambio campo senza<br />
intervallo.<br />
Viene comunque concessa la facoltà agli organizzatori del torneo di<br />
decidere quale metodi utilizzare, in relazione a diversi fattori, come ad<br />
esempio il numero di campi disponibili, numero di iscritti, durata della<br />
manifestazione ecc.<br />
2.1.3. Classifica<br />
Ai fini della determinazione delle classifiche del Beach Tennis viene redatta a<br />
cura del Comitato per il Beach Tennis una graduatoria maschile ed una<br />
femminile, aggiornata più volte durante l’anno, a carattere provvisorio, che<br />
23
tiene conto di tutta la attività regolarmente approvata dalla F.I.T. Questa<br />
graduatoria è ottenuta attraverso la sommatoria dei seguenti parametri:<br />
a) Capitale di partenza<br />
b) Punteggi ottenuti nei tornei<br />
Tale punteggio si ottiene dal risultato della : (P*V*N)*D<br />
Dove P è il punteggio per il turno raggiunto, ottenuto secondo la seguente<br />
tabella:<br />
<strong>Il</strong> punteggio sopra indicato viene assegnato unicamente ai giocatori/coppie<br />
che hanno superato almeno un turno, oppure che hanno vinto un incontro<br />
nella fase a gironi.<br />
24<br />
Tabella 1.<br />
categorie di<br />
partenza<br />
Tabella 2.<br />
Punteggi<br />
ottenuti per il<br />
piazzamento
V è il valore del torneo, assegnato secondo la seguente tabella:<br />
N è il numero di partecipanti (coppie nelle gare di doppio), attribuito secondo<br />
la seguente tabella:<br />
Tabella 4. punti assegnati in base al numero<br />
dei partecipanti<br />
D è il fattore di decurtazione della gara ottenuto sulla base della seguente<br />
tabella:<br />
Tabella 3. punteggi per il valore del torneo<br />
Tabella 5. fattore di decurtazione<br />
25
Al termine della stagione delle gare ogni anno quindi, verrà resa definitiva una<br />
classifica che terrà conto dei punteggi ottenuti dai giocatori prendendo in<br />
considerazione tutti i risultati delle gare inserite nel calendario ufficiale.<br />
Classifica valevole quindi per la determinazione delle graduatorie per l’anno<br />
successivo.<br />
2.1.4. Regolamento<br />
La battuta: è così definito il gesto tecnico con il quale viene messa in gioco<br />
la pallina. Si <strong>può</strong> effettuare da qualunque posizione dietro la linea di fondo<br />
campo, per potersi aggiudicare il punto la palla deve passare sopra la rete e<br />
<strong>può</strong> cadere in qualsiasi punto del campo avversario, inoltre <strong>Il</strong> battitore ha<br />
diritto a una sola palla di battuta, se quindi la palla si ferma sulla rete il punto<br />
è avversario, se invece la palla tocca la rete e poi cade nel campo avversario è<br />
considerato punto valido, inoltre nel doppio misto, nell’effettuare il servizio<br />
l’uomo deve colpire la palla dal basso.<br />
Per quanto riguarda la battuta c’e anche da ricor<strong>dare</strong> che, vi è fallo in battuta<br />
e quindi perdita del punto quando:<br />
1. il battitore invade il proprio campo prima di toccare la palla.<br />
2. Nella traiettoria la palla tocca l’altro giocatore della stessa squadra.<br />
3. La palla servita prima di atterrare nel campo avversario tocca un<br />
arredo permanente, quali possono essere il soffitto, il muro, la rete.<br />
4. <strong>Il</strong> giocatore stacca da terra 2 volte consecutive lo stesso piede<br />
(divieto di prendere la rincorsa).<br />
Se inoltre non ci si alterna alla battuta, si commette fallo di rotazione, per cui i<br />
punti assegnati dopo il fallo devono essere cancellati ritornando al punteggio<br />
precedente l’errore.<br />
26
Durante le normali fasi di gioco un giocatore inoltre perde il punto se:<br />
a) Non riesce a rimandarla nel campo avversario, al volo sopra la rete,<br />
prima che essa abbia toccato terra.<br />
b) La rimanda in gioco in modo che essa tocchi un arredo permanente.<br />
c) Lui o la racchetta tocchi la rete, i pali o invada il campo avversario in<br />
un qualsiasi momento in cui la palla è in gioco.<br />
d) Colpisce la palla in volo prima che quest’ultima abbia oltrepassato la<br />
rete, quindi impattandola quand’è ancora nel campo avversario.<br />
Fig. 4 Racchetta da <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong><br />
La racchetta: deve avere per regolamento<br />
una lunghezza massima di 55 cm compreso<br />
il manico,ed una larghezza massima di<br />
30cm. La superficie d’impatto per la pallina<br />
(piatto) deve essere piatta, di materiale<br />
uniforme,e priva di corde. <strong>Il</strong> peso inoltre<br />
deve essere compreso tra i<br />
300 e i 500 grammi.<br />
La palla: agli inizi la pallina utilizzata per giocare a<br />
<strong>beach</strong> <strong>tennis</strong> era quella del <strong>tennis</strong>, successivamente per<br />
un periodo ogni federazione ha utilizzato la propria<br />
pallina, negli ultimi anni invece è stata adottata da tutti<br />
la MID(mediamente pressurizzata),con diametro di<br />
65mm (tolleranza 2%), e ovviamente deve essere<br />
omologata dalla federazione ufficiale.<br />
27<br />
Fig. 5 Palline da<br />
<strong>beach</strong> <strong>tennis</strong><br />
<strong>Il</strong> campo da gioco: <strong>Il</strong> campo dove viene giocato questo sport è simile a<br />
quello dove si gioca il <strong>beach</strong> volley ma con alcune differenze. Per campo da<br />
gioco ci riferiamo alla superficie rettangolare, della dimensione di 16x8 metri
per il doppio, e 16x4,5 metri per il singolo. <strong>Il</strong> campo è delimitato da delle<br />
fettucce di delimitazione che devono essere di colore uniforme, contrastante<br />
con la superficie del campo, queste devono essere costantemente messe in<br />
tensione per mezzo di elastici, evitando così che si formino curve nei lati dl<br />
campo da gioco, variandone la superficie. una linea è disposta anche tra i due<br />
pali, quale proiezione della rete al suolo. <strong>Il</strong> campo da gioco deve essere privo<br />
di ostacoli nelle aree immediatamente a contatto con i quattro lati, per uno<br />
spazio di almeno 2 metri, questo per garantire una sicurezza al giocatore nel<br />
caso di eventuali recuperi fuori campo. Tutte le misure sono prese dal<br />
margine esterno delle linee delimitanti il campo. In altezza libero da ostacoli<br />
per almeno 7 metri dal suolo, ed in profondità uno strato minimo di 40 cm di<br />
sabbia sotto la superficie, uniformemente livellata.<br />
Fig. 6 Campo da gioco e relative dimensioni.<br />
<strong>Il</strong> campo da gioco è diviso da una rete che separa le 2 metà campo(8x8 m),<br />
questa rete deve essere alta almeno 1 metro e montata in modo da riempire<br />
completamente lo spazio orizzontale compreso tra le due righe laterali, deve<br />
28
permettere una buona visibilità della metà campo avversaria ma allo stesso<br />
tempo non far passare la palla tra le sue maglie. la rete è attaccata ai due pali<br />
(posti ad un’uguale distanza di almeno cm 50 al di fuori delle linee laterali) ed<br />
è sospesa ad una corda o cavo metallico in modo che il suo margine superiore<br />
sia posto a m 1,70 di altezza per tutta la sua lunghezza. Un nastro<br />
completamente bianco deve coprire la corda o cavo metallico e l'orlo<br />
superiore della rete, per una profondità da ambo i lati non minore di cm 5 (2<br />
pollici) e non maggiore di cm 6,35 (2 pollici e ½).<br />
2.2. I colpi fondamentali<br />
La tecnica di base di questo sport si compone di 4 colpi fondamentali:<br />
2.2.1 L’impugnatura<br />
volée di dritto<br />
volée di rovescio<br />
battuta<br />
schiacciato o smash<br />
Prima di spiegare l’esecuzione dei colpi è necessario aprire una parentesi<br />
sull’impugnatura della racchetta, la base per la buona riuscita di ogni colpo.<br />
Nel <strong>tennis</strong> sono definiti molti tipi di impugnatura differenti uno dall’altro per<br />
la posizione della mano rispetto al manico della racchetta,ma qui verranno<br />
chiaramente rappresentati solo quelli utili per il <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong> e quindi per il<br />
gioco di volo, servizio e smash. Nonostante ogni tipo di impugnatura <strong>può</strong><br />
essere più o meno vantaggioso per i vari tipi di colpi che si andranno ad<br />
29
effettuare, è fondamentale che ogni giocatore scelga quella che sente più<br />
Fig. 7 Base manico della racchetta<br />
adatta a lui in base alle proprie<br />
sensazioni.<br />
Per provare a spiegare i vari tipi di<br />
impugnature proviamo rappresentare la<br />
base del manico della racchetta con un<br />
ottagono , con il piano formato dal<br />
piatto racchetta passante per i lati 1 e 5,<br />
in relazione alla “V” formata dall’angolo<br />
che c’è tra il pollice e l’indice della<br />
mano.<br />
- Impugnatura Continental (o a martello): Si effettua posizionando la V tra il<br />
pollice e l’indice della mano nel mezzo del lato 1 dell’ottagono. Impugnando<br />
in questo modo si afferra la racchetta come fosse un martello con la<br />
differenza che le dita della mano sono leggermente aperte lungo il manico, ed<br />
inoltre, anche questo a discrezione del giocatore, si <strong>può</strong> scegliere se porre il<br />
pollice sopra l’indice o fra l’indice ed il medio. Può anche essere utile sapere<br />
relativamente alle dita, che le prime tre (pollice, indice, medio) sono più utili<br />
per la sensibilità del tocco, mentre le ultime due (anulare, mignolo) ne<br />
gestiscono di più la forza. I vantaggi della Continental stanno nel fatto che ,<br />
essendo una impugnatura “intermedia” è utilizzabile sia per le volèe di diritto<br />
e di rovescio che per smash e servizio e questo consente al giocatore di non<br />
cambiarla mai tra un colpo e l’altro. Inoltre consente la flesso - chiusura del<br />
polso dopo smash e servizio facilitandone la chiusura del colpo.<br />
- Eastern di dritto: si effettua posizionando la V in corrispondenza dello<br />
spigolo tra i lati 1 e 2. E’ molto comoda per l’esecuzione del diritto poiché il<br />
piatto racchetta è già orientato per quel colpo. Utilizzarla per il rovescio è<br />
30
possibile ma sconsigliato poiché obbliga una flessione del polso per orientare<br />
correttamente il piatto verso la palla. Per quanto concerne lo smash ha il<br />
vantaggio di mettere la faccia della racchetta inclinata verso l’alto<br />
facilitandone l’esecuzione piatta, ma lo svantaggio di non consentire la flesso<br />
- chiusura del polso rendendo difficile la chiusura del finale.<br />
- Eastern di rovescio: si effettua posizionando la v in corrispondenza dello<br />
spigolo tra i lati 1 e 8. Vale lo stesso discorso a parti invertite rispetto a quella<br />
di diritto. Per lo smash facilita la “copertura” del colpo mediante il taglio<br />
(slice) della palla da sinistra verso destra.<br />
Dopo aver terminato la parte sulle impugnature, prima di passare alla<br />
spiegazione dei colpi, intendiamo fare una precisazione: quando si parla<br />
di dritto e di rovescio nel <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong> si parla sempre di volèe, visto che tutti<br />
i colpi del <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong>, ovviamente, sono eseguiti al volo.<br />
È necessario prima di tutto spiegare la differenza tra la volèe statica e<br />
quella dinamica, tale differenza consiste nell’effettuare o meno uno<br />
spostamento del corpo e quindi anche quello dei piedi nell’effettuazione del<br />
colpo. Nelle volèe dinamiche, utilizzate soprattutto per i colpi di natura<br />
offensiva, si effettua il colpo in avanzamento scaricando il peso sulla gamba<br />
destra per quella di rovescio, e sulla sinistra per la volée di dritto. Viceversa<br />
nelle statiche, molto spesso usate per colpi di opposizione come anche la<br />
risposta al servizio, non si ha il tempo per effettuare lo spostamento dei piedi<br />
quindi si colpisce con un movimento molto più breve.<br />
N.B.: Per ragioni statistiche e di praticità abbiamo considerato<br />
l’impostazione dei vari colpi in funzione di giocatori destrimani. Per i mancini,<br />
vale ovviamente l’inverso.<br />
31
2.2.2. La volée di dritto<br />
Fig. 8 Sequenza della volée di dritto<br />
Per effettuare il dritto dalla posizione di attesa, quindi con le spalle rivolte<br />
verso la rete, le gambe leggermente flesse, il tronco leggermente inclinato in<br />
avanti, l’appoggio del peso sugli avampiedi ed equamente distribuito tra i<br />
due, così da garantire una maggior reattività; si effettua l’apertura portando<br />
la testa della racchetta davanti alla spalla destra (sinistra per i mancini)<br />
mantenendo il piatto parallelo alla rete. Questo movimento di apertura deve<br />
essere fatto in anticipo rispetto all’arrivo della palla, in modo da essere pronti<br />
ad effettuare solo la parte finale del colpo quando la palla ci arriva vicino, in<br />
maniera tale da semplificare il più possibile l’esecuzione del colpo.<br />
L’esecuzione del dritto avviene portando la racchetta verso la palla con il<br />
piatto perpendicolare alla direzione in cui si vuole man<strong>dare</strong> la palla,<br />
mantenendo il gomito piegato che forma un angolo di circa 90 gradi con<br />
l’avambraccio, il più possibile davanti e vicino al corpo. <strong>Il</strong> punto di’impatto con<br />
la palla deve essere davanti al corpo con un angolo ideale di 45° alla propria<br />
32
destra. È importante tenere il polso solido durante l’impatto e non frenare la<br />
racchetta subito dopo, questo aiuta a direzionare la palla il meglio possibile.<br />
Durante l’apertura il peso del corpo viene posto sulla gamba destra.<br />
Immaginando la posizione di partenza come base di un triangolo, nella la<br />
volèe dinamica di dritto si sposta il piede sinistro in avanti sul vertice del<br />
triangolo scaricando il peso del corpo dal piede destro a quello sinistro.<br />
2.2.3. La volée di rovescio<br />
Fig. 9 Sequenza della volée di rovescio<br />
Per il rovescio, partendo dalla posizione di attesa, non si effettua l’apertura<br />
della racchetta come per il dritto, ma al contrario si porta la testa della<br />
racchetta questa volta davanti alla spalla sinistra (destra per i mancini),<br />
sempre in anticipo rispetto all’arrivo della palla. L’esecuzione del rovescio<br />
avviene portando la racchetta verso la palla con il piatto perpendicolare alla<br />
direzione in cui si vuole man<strong>dare</strong> la palla. <strong>Il</strong> punto di’impatto con la palla deve<br />
essere il più possibile davanti al corpo con un angolo ideale di 45° alla propria<br />
sinistra. La testa della racchetta non passa mai dietro la visuale degli occhi.<br />
33
L’utilizzo del polso è minimo e serve più che altro per mantenere la direzione<br />
perpendicolare alla direzione del colpo dopo l’impatto, ma non si spezza mai.<br />
Durante l’apertura il peso del corpo viene posto sulla gamba sinistra. Per la<br />
volèe dinamica di rovescio si sposta il piede destro in avanti e durante<br />
l’esecuzione si scarica il peso del corpo dal piede sinistro a quello destro.<br />
Ovviamente nel gioco del <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong> è possibile dover effettuare diritti e<br />
rovesci ad altezze diverse. Questo comporta una variazione soprattutto nel<br />
movimento preparatorio. Nelle volèe alte di dritto e di rovescio l’apertura<br />
dovrà avvenire sopra le spalle in modo da essere pronti a colpire la palla ad<br />
un’altezza superiore. L’esecuzione avverrà con una direzione leggermente<br />
verso il basso. Nelle volèe basse viceversa, la ricerca della palla viene fatta<br />
cercando di utilizzare il piegamento delle gambe alla ricerca di un impatto più<br />
basso cercando di mantenere il più possibile l’assetto braccio - racchetta ed<br />
evitando quindi un eccessivo utilizzo del polso. L’apertura sarà quindi sotto le<br />
spalle mentre l’esecuzione avverrà con una direzione verso l’alto a scavalcare<br />
la rete. In entrambi i colpi l’escursione della racchetta verso la rete è molto<br />
breve, e dipende dalla velocità con la quale arriva la palla, nella battuta per<br />
esempio, dove i colpi da ricevere sono dotati di una grandissima velocità, è<br />
spesso sufficiente indirizzare il colpo solamente aprendo il piatto<br />
perpendicolarmente alla direzione verso la quale si vuole man<strong>dare</strong> la pallina.<br />
34
2.2.4. La battuta<br />
Fig. 10 Fotografia di un battuta<br />
Colpo rubato al <strong>tennis</strong> per ovvie ragioni,<br />
si effettua partendo da una posizione<br />
nella quale i piedi sono quasi paralleli<br />
appena dietro la linea che delimita il<br />
fondo campo, tenendo la palla nella<br />
mano sinistra (destra per i mancini)<br />
mentre con l’altra mano si tiene la<br />
racchetta davanti rispetto alla linea del<br />
corpo. Entrambe le braccia scendono<br />
fino ad arrivare all’altezza delle gambe, a<br />
questo punto il braccio che tiene la<br />
racchetta segue il movimento, mentre<br />
l’altro si alza davanti agli occhi lanciando<br />
la palla sopra la testa. A questo punto il<br />
braccio destro esegue un “Mulinello” (gesto tecnico peculiare del <strong>tennis</strong>). il<br />
tronco, la spalla e il braccio quindi si proiettano verso l’alto per impattare la<br />
palla nel punto di massima estensione così da imprimergli una maggiore<br />
spinta, e da permettere alla pallina di uscire verso il campo avversario con un’<br />
angolo discendente, questa traiettoria inoltre è favorita dalla chiusura del<br />
polso al momento dell’impatto con la pallina. La potenza del servizio invece è<br />
tanto maggiore quanto più alta è la velocità della testa della racchetta in<br />
uscita dal mulinello. <strong>Il</strong> peso del corpo al momento della preparazione del<br />
servizio è spostato sulla gamba posteriore, per poi passare all’altra gamba nel<br />
momento di impatto con la palla, permettendo quindi di chiudere il colpo e di<br />
dargli grande potenza.<br />
35
Tipi di battuta: come nel servizio del <strong>tennis</strong> vi sono diversi modi per colpire<br />
la palla nel servizio: Dal semplice colpo piatto, con il quale la palla viene<br />
colpita dalla racchetta con il piatto parallelo alla rete, senza quindi ricevere<br />
alcun effetto; a quelli come lo Slice e il Lift, con i quali la pallina viene<br />
impattata in modo da darle un<br />
effetto, e quindi una traiettoria<br />
particolare. Nel particolare,<br />
l’esecuzione del servizio Slice<br />
prevede che la pallina venga<br />
impattata con un movimento da<br />
destra verso sinistra, questa<br />
tecnica trasmette alla palla una<br />
rotazione laterale in senso<br />
antiorario, poiché l’impatto<br />
avviene lateralmente sulla parte<br />
destra della palla e non solo con<br />
un movimento dall’alto verso il<br />
Fig. 11 Fotografia del servizio<br />
basso, la racchetta infatti colpisce parzialmente e di taglio la palla con un<br />
colpo spazzolato. <strong>Il</strong> servizio liftato si avvale dello stesso principio del<br />
precedente ma a differenza dell’ultimo la palla viene lanciata sopra la testa in<br />
alto leggermente verso sinistra, viene colpita dal basso verso l’alto e da<br />
sinistra verso destra, a ore 11, questo le permette di ottenere un leggero<br />
effetto top-spin.<br />
36
2.2.5. La schiacciata (o smash)<br />
Lo smash, sicuramente uno dei colpi più spettacolari ed emozionanti,<br />
certamente il più efficace. Ricorda molto più la schiacciata nella pallavolo che<br />
un colpo prettamente <strong>tennis</strong>tico come potevano essere il dritto e il rovescio. <strong>Il</strong><br />
gesto tecnico dello smash richiama quello della battuta, prevede l’esecuzione<br />
del mulinello dietro la testa, in modo che il braccio si pieghi formando un<br />
angolo di circa 90 gradi con il resto del corpo. Mentre la mano<br />
Fig. 12 Fotografia di uno smash<br />
opposta indica la pallina che ci sta arrivando, facendoci da mirino e<br />
aumentando l’equilibrio. La ricerca della pallina viene eseguita con brevi e<br />
veloci passi di avvicinamento, spesso susseguiti da un salto a piedi pari, in<br />
modo da aumentare l’esplosività del salto ma soprattutto l’equilibrio; quindi<br />
si cerca di colpire la pallina nel punto più alto possibile, permettendo così di<br />
farle avere una traiettoria discendente, poter avere un buon angolo verso il<br />
quale indirizzare il colpo,e poterla colpire con una maggiore potenza. La palla<br />
quindi viene colpita con il braccio in massima estensione facendo impattare<br />
37
prima la testa della racchetta per poi chiudere il movimento con una flessione<br />
del polso.<br />
Dopo aver spiegato i colpi fondamentali di questo gioco, apriamo una<br />
piccola parentesi su qualche altro gesto tecnico del <strong>beach</strong>-<strong>tennis</strong>, vi sono<br />
infatti altri colpi, usati con minore frequenza ma che comunque non possono<br />
mancare nel bagaglio tecnico di un buon giocatore. Tra questi troviamo:<br />
2.2.6. <strong>Il</strong> bilanciere<br />
Colpo che nasce esattamente per le esigenze che comporta questo gioco,<br />
non lo ritroviamo infatti in nessun’altra disciplina. Esso permette infatti di<br />
coprire l’intera lunghezza del campo neutralizzando gli eventuali pallonetti. In<br />
particolare quindi va utilizzato per quelle palline che vanno molto in alto, e<br />
con una traiettoria parabolica passano sopra la testa del giocatore sembrando<br />
irraggiungibili.<br />
<strong>Il</strong> giocatore dovrà quindi an<strong>dare</strong> alla ricerca della palla spostando il corpo,<br />
sempre perpendicolare alla rete, all’indietro, abbassando il suo baricentro.<br />
Con il braccio sinistro (destro per i mancini) si andrà ad indicare la palla che<br />
sta arrivando, mentre con quello destro si porta la racchetta bassa<br />
posteriormente al corpo bloccando il polso. A questo punto il braccio senza<br />
racchetta si abbassa mentre la racchetta si alza verticalmente per an<strong>dare</strong> a<br />
colpire la pallina con la testa della racchetta verticale e rivolta verso il campo<br />
avversario. Una volta colpita la pallina il giocatore si riporterà subito nella<br />
posizione di attesa a centro campo per giocarsi l’eventuale risposta<br />
avversaria.<br />
38
2.2.7.<strong>Il</strong> Pallonetto<br />
<strong>Il</strong> pallonetto è quel colpo che fa passare la palla molto al di sopra del<br />
giocatore avversario piazzato vicino alla rete. Se ben giocato, la palla<br />
dovrebbe cadere nei pressi della linea di fondo del campo avversario. È un<br />
colpo importante in risposta a un tiro d'attacco, perché permette di<br />
guadagnare tempo data la maggiore traiettoria che la palla deve compiere. <strong>Il</strong><br />
giocatore che lo esegue potrà quindi con esso riconquistare il centro campo<br />
dopo essere stati costretti in posizione di svantaggio da una volée o da un<br />
colpo piazzato dell'avversario, ed essere pronti per il colpo successivo. Se il<br />
pallonetto sarà ben eseguito infatti , l’avversario sarà costretto a retrocedere<br />
fino ai pressi della linea di fondo.<br />
2.2.8. La smorzata<br />
La smorzata (drop-shot) è un tiro con il quale si fa ricadere la palla molto<br />
vicina alla rete nel campo avversario, tanto che spesso l'avversario non è in<br />
grado di raggiungerla. La smorzata deve essere eseguita in modo perfetto<br />
altrimenti sarà una facile preda per l’ avversario. Se ben eseguita e ben<br />
piazzata, la smorzata migliora la capacità di gioco, ed è molto efficace nel<br />
<strong>beach</strong> <strong>tennis</strong> femminile e in quello dei veterani.<br />
L’esecuzione della smorzata corrisponde a quella dei colpi tagliati dalla linea<br />
di fondo. Solo che dopo l'impatto, invece di proseguire nel movimento in<br />
avanti, si fa scivolare il piatto della racchetta intorno alla palla come per<br />
avvolgerla. Per fare questo, a differenza di quasi tutti gli altri colpi nel <strong>beach</strong><br />
<strong>tennis</strong> bisogna lavorare con il polso, in questo modo si dà alla palla un effetto<br />
all'indietro. La posizione dei piedi è la stessa dei colpi da fondo campo. Ma<br />
peso del corpo rimane sul piede sinistro anche dopo aver colpito la palla.<br />
39
2.3. La preparazione tecnico-tattica<br />
2.3.1. La tecnica<br />
Prima di addentrarci nello studio di tale argomento dobbiamo definire che<br />
cosa si intende con la parola “Tecnica” applicata allo sport: con questo<br />
termine ci si riferisce ad un insieme di schemi motori utilizzati per la<br />
risoluzione di un compito sportivo, nel modo più razionale ed economico<br />
possibile, quindi la tecnica di una disciplina corrisponde ad un tipo ideale di<br />
movimento che, però, seppur mantenendo gli indici caratteristici del<br />
movimento stesso <strong>può</strong> essere soggetto a cambiamenti, adattati alle<br />
particolarità individuali di chi lo esegue. Ogni tecnica è costituita da molteplici<br />
schemi motori che a loro volta comprendono una struttura oggettiva (che<br />
rappresenta la percentuale più alta) ed una soggettiva. La struttura oggettiva<br />
è di facile individualizzazione poiché tiene conto degli elementi fisici (gravità,<br />
cinematica, energia ecc.) e dello scopo del compito.<br />
La struttura soggettiva invece tiene conto delle varianti che alcuni atleti<br />
(sempre nel rispetto della componente oggettiva), possono inserire<br />
all’interno della tecnica stessa modificandola in modo tale da aumentarne<br />
l’efficacia, o cambiandone totalmente lo stile di esecuzione.<br />
L’allenamento della tecnica forse rappresenta la base di tutti gli sport, in<br />
quanto su di essa si realizza una solida preparazione fisica, frutto di un<br />
corretto stile d’esecuzione delle singole movenze, sia esse nell’ambito di un<br />
esercizio di condizionamento che di un esercizio stilistico. L’allenamento della<br />
tecnica differisce nei vari tipi di sport, in attività che prevedono abilità chiuse<br />
o cicliche, tale allenamento diventa relativamente più semplice, poiché i<br />
fattori di disturbo sono facilmente individuabili e prevedibili (di conseguenza<br />
facilmente allenabili); ben più diversa è la situazione in tutte quelle attività<br />
40
aperte dove l’applicazione della tecnica deve tenere necessariamente conto<br />
dell’azione svolta dall’avversario, come appunto il <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong>.Prima di<br />
entrare nel dettaglio sui sistemi di allenamento della tecnica, trovo<br />
interessante spiegare brevemente i meccanismi che portano all’acquisizione<br />
di un compito motorio.<br />
<strong>Il</strong> punto di partenza per qualsiasi compito si voglia eseguire nel migliore dei<br />
modi è la sua automatizzazione, significa passare lo schema motorio dai centri<br />
corticali superiori ai centri inferiori, più nello specifico dalla corteccia motoria<br />
al cervelletto al midollo spinale, in modo tale da avere una risposta adeguata<br />
in funzione di uno stimolo (in poche parole un riflesso condizionato da un<br />
apprendimento). Tutto questo si traduce in tre passi logici quanto essenziali<br />
per un corretto apprendimento:<br />
- IMPARARE<br />
- APPLICARE<br />
- DIMENTICARE<br />
Si immagini di iniziare un corso di guida per l’automobile, in un primo<br />
momento si imparano un insieme di nozioni sia teoriche che pratiche e si<br />
cerca di metterle in pratica. La guida risulta macchinosa, tutti i sensi sono<br />
attivati e diretti ad un unico scopo, gui<strong>dare</strong>. Si ha la necessità di qualcuno che<br />
ci corregga continuamente e al momento opportuno.<br />
In un secondo momento si cerca di applicare quanto imparato, si cerca di non<br />
commettere gli errori già corretti, si pensa a quale sia la decisione giusta tra<br />
quelle studiate nelle varie situazioni, ma la guida non risulta ancora fluida,<br />
spesso si arriva in ritardo sui comandi, non si ha visione periferica.<br />
Si arriverà all’automatismo paradossalmente nel momento in cui si dimentica<br />
ciò che si è imparato. Nella realtà non si è dimenticato nulla, ma il tutto è<br />
stato trasferito ai centri corticali inferiori che dopo errori e relativi<br />
41
aggiustamenti sono in grado di svolgere il compito senza l’ausilio dei centri<br />
superiori, che nel frattempo possono occuparsi di altro. La guida risulta fluida,<br />
le scelte effettuate sono veloci, si acquisisce visione periferica, si arriva a<br />
prevedere in anticipo alcuni comportamenti.<br />
Nello sport avviene proprio questo, si impara si applica e quando si dimentica<br />
abbiamo ottenuto la risposta desiderata in termini di velocità tempo e ritmo.<br />
Un errore nelle prime due fasi porta a degli errori nella successiva che come si<br />
evince sono difficili da eliminare proprio perché il controllo cosciente non c’è<br />
(o per meglio dire è al minimo).<br />
Correggere un errore in una tecnica già acquisita a volte <strong>può</strong> risultare<br />
impossibile, ecco perché il tempo dedicato all’allenamento della tecnica deve<br />
essere sempre di qualità mai di quantità. Creare uno schema errato significa<br />
precludere la carriera di un’atleta ed un corretto sviluppo delle sue<br />
potenzialità, l’allenamento è efficace se la tecnica è efficace.<br />
Detto questo va anche ricordato che la tecnica presenta 2 facce, una<br />
dimensione innata rappresentata dalle abilità congenite di un giocatore,<br />
mentre l’altra è data dalle abilità che il soggetto apprende attraverso<br />
l’allenamento. Più queste abilità sono raffinate e più esso sarà competitivo in<br />
quello sport.<br />
2.3.2. La tattica<br />
Un altro aspetto fondamentale che si lega alla tecnica nel raggiungimento<br />
di un buon risultato è determinato dalla tattica, ovvero la capacità di fare<br />
scelte efficaci ed efficienti per affrontare una determinata situazione di gioco,<br />
l’arte di gestire l’incontro utilizzando al meglio le risorse tecniche, fisiche,<br />
42
psichiche a nostra disposizione, in relazione alle caratteristiche del nostro<br />
avversario e alla situazione di gioco. Perché questi due aspetti sono così tanto<br />
legati? Una tecnica non sufficientemente adeguata costituisce un limite<br />
all’esecuzione di scelte tatticamente corrette ed intelligenti, quindi pur<br />
facendo delle buone scelte, se non abbiamo una buona tecnica non<br />
riusciremo a metterle in pratica. Alla stesso tempo avere un buon bagaglio<br />
tecnico ma non sapere come comportarsi nelle varie situazioni di gioco, per<br />
esempio “leggere la difesa” per sferrare un attacco vincente, porterà<br />
probabilmente ad un risultato mediocre. La tattica deve essere quindi scelta<br />
in relazione alle proprie capacità tecniche, cercando di imporre il nostro tipo<br />
di gioco e quindi portarci a ricevere colpi con sui quali abbiamo una buona<br />
padronanza e una alta probabilità di successo.<br />
L’abilità tattica prevede anche cambiamenti di gioco, in modo da non <strong>dare</strong><br />
riferimenti alla difesa, cambiando spesso tipo di colpi e traiettoria della palla,<br />
creando l’effetto sorpresa: non bisogna mai fare in modo che la difesa sappia<br />
già che colpo andrò a eseguire, altrimenti avrò ben poche possibilità di<br />
portare a casa il punto.<br />
É importante ricor<strong>dare</strong> che la tecnica corretta per un gesto sportivo è stata<br />
studiata e affinata con anni di esperienza, tenendo conto di tutti i principi<br />
fisici e biomeccanici fondamentali, in modo da evitare, o comunque di<br />
diminuire il rischio di traumi ed infortuni.<br />
Gli esercizi che quindi si andranno a proporre saranno volti<br />
all’insegnamento e/o all’affinamento dei fondamentali di gioco, quali:<br />
esercizi per l’insegnamento della volèe, del servizio e della schiacciata.<br />
Una delle capacità più utili nel <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong> che la capacità di anticipazione,<br />
essa spesso si rivela l’arma vincente nella vittoria di un incontro, prescinde<br />
sicuramente da un bagaglio tecnico che già ha automatizzato una gestione<br />
43
delle situazioni di gioco, e che quindi, ci porta a prevedere già in anticipo cosa<br />
farà il nostro avversario, adeguandoci così con velocità ad una sistematica<br />
anticipazione dei colpi.<br />
2.4. La collaborazione e l’intesa di squadra<br />
Come in tutti gli sport di squadra, le capacità individuali dei singoli atleti<br />
spesso possono non bastare a rendere la squadra vincente. In questo tipo di<br />
competizioni infatti c’è un'altra variabile che gioca un ruolo fondamentale nel<br />
successo di un team, parliamo appunto dell’intesa di squadra. L’elemento<br />
fondamentale nella formazione di un team è sicuramente la fiducia e la stima<br />
del proprio compagno di squadra, cosa che non <strong>può</strong> assolutamente venire a<br />
meno, non posso infatti trovare un buon affiatamento e una buona complicità<br />
nel gioco se non lo reputo all’altezza delle varie situazioni e/o non riesco a<br />
creare un certo feeling con lui. Due eccellenti giocatori non necessariamente<br />
formano una buona coppia, spesso infatti non è cosi. Per riuscire a trovare il<br />
giusto equilibrio in campo ci vogliono due giocatori con caratteristiche<br />
diverse, che si completino a vicenda, uno più forte fisicamente e l’altro più<br />
tecnico, un leader e un “esecutore”, uno più grintoso, l’altro più razionale, per<br />
fare un paragone: uno la mente, l’altro il braccio. Due giocatori compatibili<br />
caratterialmente, e pronti sempre a stare uniti nelle situazioni difficili<br />
dell’incontro, a saltarne fuori assieme, sostenendosi, incitandosi e<br />
consigliandosi a vicenda, ma pur sempre in modo costruttivo. Senza quindi<br />
aggredirsi e perdere la concentrazione se il compagno commette degli errori,<br />
questo porterebbe ad insicurezze e nervosismo, che spesso è uno dei motivi<br />
per i quali si perde l’incontro.<br />
44
Solo con molto allenamento in coppia ed un buon dialogo riesco a<br />
conoscere fino in fondo il mio compagno di squadra, sapendo quali sono i<br />
colpi e le situazioni che sa affrontare meglio, piuttosto che quelle che<br />
prediligo io. Spesso ad alti livelli per esempio assistiamo a giocatori che<br />
prevedono già l’azione del proprio compagno, spostandosi anticipatamente<br />
per il colpo successivo, si nota un feeling nella coppia come se pensassero ed<br />
agissero con un'unica mente. Capiamo quindi come non sia affatto facile la<br />
scelta di un compagno in questo sport, e come non sia assolutamente una<br />
cosa da sottovalutare se ambiamo a dei buoni risultati.<br />
45
3. REPARAZIONE ATLETICA – TRAUMATOLOGIA –<br />
3.1 La preparazione fisica<br />
47<br />
PREVENZIONE INFORTUNI<br />
In questo capitolo si vuole delineare le caratteristiche di una preparazione<br />
atletica per un giocatore che intende raggiungere buone performances nel<br />
gioco del <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong>.i.<br />
Per programmare una preparazione atletica dobbiamo innanzitutto iniziare<br />
col porci degli obbiettivi, dobbiamo infatti chiederci su cosa è più opportuno<br />
lavorare, in che modo, e quanto tempo ho a disposizione per poter<br />
raggiungere un determinato obbiettivo. Per iniziare a <strong>dare</strong> una risposta a<br />
queste domande dobbiamo chiarire quali siano le richieste della disciplina,<br />
partendo dal modello funzionale.<br />
Come già detto in precedenza, il <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong>, è una disciplina ancora<br />
“nuova” ed in fase emergente, non vi sono perciò molti studi a riguardo. È<br />
quindi difficile poter costruire con precisione una preparazione studiata ad-<br />
hoc per un giocatore tipo, che ci permetta di pianificare con esattezza un<br />
programma allenante che favorisca lo sviluppo delle qualità atletiche del<br />
giocatore.<br />
Fatta questa premessa, guardando alcuni incontri di <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong>,<br />
informandomi e avendo avuto la possibilità di avere un dialogo e lavorare con
alcuni giocatori che da molto tempo praticano questa attività, ho potuto fare<br />
una mia analisi dalla quale poi partire nella costruzione di una preparazione<br />
atletica. DI seguito quindi verranno illustrate alcune caratteristiche dello sport<br />
del <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong>, sia dal punto di vista biomeccanico che da quello<br />
metabolico.<br />
3.1.1. <strong>Il</strong> modello funzionale<br />
<strong>Il</strong> <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong> <strong>può</strong> essere classificato come uno sport a impegno aerobico<br />
– anaerobico alternato, dove quindi l’atleta è sottoposto a fasi di gioco molto<br />
intense alternate a pause frequenti nelle quali esso ripaga l’eventuale debito<br />
di ossigeno accumulato in precedenza. L’elevato impegno nelle fasi di gioco<br />
attive è dato dalle peculiarità del gioco, in primis il terreno sabbioso, che, data<br />
la sua irregolarità rende difficoltosa la stabilità e l’equilibrio e rende ogni<br />
movimento più impegnativo, e più dispendioso in termini energetici, inoltre la<br />
disciplina di per se richiede colpi al volo, accelerazioni, spostamenti laterali, in<br />
avanti e all’indietro, tuffi per recuperare palline lontane, rialzarsi<br />
tempestivamente per recuperare lo scambio successivo, salti per colpire la<br />
pallina nel punto più alto e quindi potergli conferire maggiore velocità, e tutto<br />
questo deve essere effettuato con una rapidità unica, data l’elevata velocità<br />
delle palline mixata alle dimensioni ristrette del campo. Proprio le dimensioni<br />
del campo ci possono far capire che, il giocatore di <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong> è piuttosto<br />
statico, nel senso che, dovendo condividere un campo di 8x8 m in due<br />
giocatori, la distanza totale (in metri) coperta da un singolo giocatore sarà<br />
molto meno elevata rispetto ad esempio un <strong>tennis</strong>ta, ma sicuramente non a<br />
minore intensità. L’80% dei movimenti di un giocatore si compiono nel raggio<br />
di 2-3 metri dalla sua posizione di attesa, quindi da questa posizione,<br />
48
caratterizzata da gambe piegate, busto eretto e proteso in avanti, e braccia in<br />
avanti per tenere la racchetta alta davanti alla testa, l’atleta per ricevere la<br />
pallina dovrà eseguire una serie di piegamenti sulle gambe, affondi, salti e<br />
torsioni del busto a velocità massimali, spesso, si troverà in situazioni di<br />
equilibrio precario, date dalle condizioni del terreno e dalla velocità della<br />
palla, per far fronte a questi stimoli imprevisti e mutevoli deve essere dotato<br />
di una capacità di reazione necessariamente molto elevata e deve rispondere<br />
con azioni motorie adeguate che devono essere ben automatizzate.<br />
Tutte le azioni, sia di attacco che di difesa, per essere efficaci devono<br />
essere rapide e potenti, gli spostamenti del corpo non vanno mai oltre i due o<br />
tre passi alla massima velocità e con altrettanta velocità bisogna tornare alla<br />
posizione di attesa per non farsi cogliere impreparati all’eventuale risposta<br />
avversaria. <strong>Il</strong> gioco quindi, se praticato ad un livello competitivo, richiede si<br />
capacità tecniche, ma anche forza esplosiva, prontezza di riflessi, mobilità<br />
articolare, soprattutto a livello scapolo-omerale ma allo stesso tempo richiede<br />
di esprimere grandi quantità di forza.<br />
Per lo studio della preparazione atletica di questo sport, mi sono tornati<br />
utili anche i dati sul rapporto in termini di tempo tra azioni e pause di gioco,<br />
(Benazzi, 2010) riportati qui di seguito: un azione di gioco <strong>può</strong> avere una<br />
durata minima (scambi brevi) di 3-6 secondi, fino ad un massimo (rarissime<br />
sono le volte in cui durano più a lungo) di 7-9 secondi per gli scambi più<br />
lunghi. Le pause tra un’azione e l’altra nello stesso game hanno una durata<br />
media di 20-25 secondi, ed un tempo compreso tra i 40 e i 55 secondi tra un<br />
game e l’altro contando quindi anche il campo. La durata dei game è molto<br />
variabile, con tempi che vanno da 1 minuto e 15’’ ai 2 minuti e 30’’ nei giochi<br />
più combattuti. Durante le finali, quindi con giochi ai 9 games, la durata totale<br />
dell’incontro <strong>può</strong> anche superare l’ora. Quindi facendo gli adeguati rapporti<br />
49
possiamo dire che il giocatore dispone di circa 3-4 secondi di recupero per<br />
ogni secondo di gioco.<br />
Se a tutto questo uniamo il fatto che la stragrande maggioranza dei tornei e<br />
dei campionati si svolgono in piena estate sotto il sole, capiamo come sia<br />
difficile affrontare una partita senza avere un minimo di preparazione.<br />
3.1.2. La programmazione<br />
Una volta analizzato il modello funzionale del giocatore di <strong>beach</strong>-<strong>tennis</strong>,<br />
una delle prime cose da fare nella progettazione del piano di allenamenti è<br />
capire cosa fare e qual è il momento più opportuno per fare un determinato<br />
lavoro, in parole semplici dobbiamo porci due domande:<br />
- quali obbiettivi ho?<br />
- Quando posso lavorare su di essi?<br />
Nel rispondere a queste domande dovrò esaminare il calendario delle<br />
competizioni dell’atleta, in questo sport la stagione cruciale, dove si svolgono<br />
la stragrande maggioranza delle competizioni è l’estate, nel periodo tra<br />
maggio a settembre, dove le gare si susseguono con cadenza settimanale, e<br />
dove ogni settimana ci sono in palio i punti per la classifica generale.<br />
Pianificare allenamenti atletici in questa situazione risulta quindi piuttosto<br />
difficile. È preferibile allora in questo periodo dell’anno, <strong>dare</strong> priorità<br />
all’allenamento tecnico rispetto a quello fisico. Ne consegue che il momento<br />
migliore per costruire un fisico adeguato e recuperare eventuali infortuni è<br />
quello tra ottobre e aprile. È proprio in questo periodo infatti che si gettano le<br />
basi per la costruzione di un buon fisico, e per il miglioramento delle capacità<br />
aerobiche e motorie dell’atleta.<br />
50
Si potrà quindi suddividere tale periodo in diverse fasi, ognuna di esse con<br />
obbiettivi e tipi di lavoro differente. Io ho diviso tale periodo in due fasi:<br />
Periodo di condizionamento di base<br />
Periodo di preparazione specifica<br />
Dove nel primo periodo l’obbiettivo primario sarà quello di aumentare la<br />
capacità di lavoro, maggiore sarà questa capacità e migliore sarà l’adattabilità<br />
dell’organismo a sostenere gli sforzi fisici e psichici previsti nelle fasi<br />
successive. Quindi il lavoro sarà composto prevalentemente da esercizi<br />
aerobici, e di muscolazione per l’aumento della forza e velocità, svolgendo un<br />
lavoro globale. Questa fase sarà inoltre mirata al recupero di eventuali<br />
infortuni e al miglioramento della mobilità articolare, che in uno sport come il<br />
<strong>beach</strong> <strong>tennis</strong> viste de caratteristiche del modello funzionale non <strong>può</strong> essere<br />
trascurata.<br />
Nella preparazione fisica specifica invece, che andrà a seguire il<br />
condizionamento di base e a precedere l’inizio dei tornei, l’obbiettivo sarà<br />
quello di allenare tutte le situazioni modello gara, rinforzare quei distretti<br />
muscolari e quelle articolazioni maggiormente coinvolti nelle situazioni di<br />
gioco, e mantenere i risultati ottenuti nella preparazione generale, in questa<br />
fase si predilige alternare un volume di lavoro elevato a bassa intensità con<br />
volume di lavoro ridotto ad alta intensità, ricordiamo che capacità fisiche ben<br />
sviluppate consentono rapidi recuperi.<br />
Prima di iniziare a esaminare gli esercizi è doveroso fare una premessa: Ogni<br />
lavoro svolto per poter essere giudicato e quantificato deve potersi basare su<br />
dei dati oggettivi e reali, perciò si vede necessaria la valutazione del lavoro<br />
tramite dei test che andranno fatti fare al nostro atleta all’inizio e alla fine<br />
della preparazione (possibile farli anche a metà per vedere i progressi nel<br />
51
periodo intermedio), esaminando poi questi dati saremo in grado di valutare<br />
se il lavoro svolto è stato utile o meno; ma non solo, facendo dei test di<br />
partenza saremo in grado di vedere le reali condizioni del soggetto, al fine di<br />
pianificare una tabella di allenamento individualizzata, per correggere i deficit<br />
più evidenti dell’atleta e migliorarli.<br />
Ricordiamo inoltre che essendo il <strong>beach</strong>-<strong>tennis</strong> prevalentemente un’abilità<br />
aperta, è indispensabile allenare le capacità coordinative globali: l’intuizione<br />
delle traiettorie, la reattività agli gli stimoli visivi e la capacità di focalizzare gli<br />
spazi.<br />
Premesso che durante una partita di <strong>beach</strong>-<strong>tennis</strong> vengono coinvolti, con<br />
modalità, tempistiche ed intensità diverse, tutti i segmenti corporei,<br />
analizzando dal punto di vista biomeccanico i gesti tecnici di questa disciplina<br />
possiamo riscontrare una maggiore sollecitazione e quindi attribuirgli un<br />
maggior interesse per la programmazione della preparazione fisica specifica i<br />
seguenti muscoli:<br />
Parte superiore: Tricipite brachiale: estende dell’avambraccio. Deltoide:<br />
abduce, flette ed estende l’arto superiore. Trapezio: eleva e adduce la<br />
scapola. Muscoli della cuffia dei rotatori (Sovraspinato, Sottospinato,<br />
Sottoscapolare e Piccolo rotondo) i quali sono i principali responsabili<br />
dell’ intra ed extra-rotazione del braccio, oltre a garantire la stabilità<br />
della testa dell’omero sulla cavità glenoidea. Ed infine Estensori e<br />
Flessori della mano.<br />
Parte del tronco: Retto dell’addome: atto al mantenimento della<br />
postura e alla flessione del torace sul bacino, contribuisce anche<br />
all’espirazione. Obliqui dell’addome(interni ed esterni): flettono e<br />
ruotano il tronco. Erettore della colonna: estensione dorsale del<br />
52
achide e flessione laterale dello stesso se contratto monolateralmente.<br />
Grande pettorale: adduce ed intra-ruota l’arto superiore.<br />
Parte inferiore: Quadricipite femorale: estende la gamba, flette la<br />
coscia e flette il bacino sulla coscia. Grande gluteo: estende ed extra-<br />
ruota il femore, stabilizza l’articolazione dell’anca e si rende accessorio<br />
per il mantenimento della stazione eretta. Tricipite surale (polpaccio):<br />
flette plantarmente il piede (per intenderci è opera di questo muscolo<br />
la spinta sulle punte dei piedi) ed inoltre contribuisce alla flessione della<br />
gamba. Muscoli ischio crurali (si trovano nella regione posteriore della<br />
coscia e si distinguono in: semimembranoso, semitendinoso, bicipite<br />
femorale): essi hanno funzione di flettere la gamba sulla coscia ed<br />
estendere quest’ultima sul bacino, utili anch’essi quindi al<br />
mantenimento della posizione eretta.<br />
A questi muscoli quindi sarà dedicata una maggior attenzione, e saranno<br />
allenati in modo da aumentarne sia l’elasticità che la forza esplosiva.<br />
3.1.3. Gli esercizi<br />
Una prima parte sarà impiegata per il riscaldamento, il quale obbiettivo è<br />
favorire un aumento della temperatura corporea, provocando quindi:<br />
aumento del metabolismo cellulare, aumento dello scambio di ossigeno tra il<br />
sangue e i tessuti, aumento dell’irrorazione sanguigna, inoltre il riscaldamento<br />
favorisce all’attivazione neuromuscolare con il conseguente miglioramento<br />
della coordinazione motoria. Esso avrà una durata variabile dai 10 ai 20<br />
minuti e avrà un intensità crescente per tutta la sua durata, partendo da<br />
53
minima a relativamente elevata. Prima di passare all’allenamento vero e<br />
proprio, sarà seguito da allungamenti muscolari, in forma statica o dinamica.<br />
Condizionamento di base: riguarderà quindi un macro-ciclo di allenamento<br />
di 3 mesi ( ottobre – dicembre), con un lavoro di 2/3 sedute a settimana della<br />
durata di 90 minuti per seduta, che vanno ad aggiungersi a quelle per<br />
l’allenamento tecnico, in questi allenamenti lavoreremo sulla resistenza<br />
aerobica, sul miglioramento della potenza anaerobica, e nella costruzione del<br />
fisico per la preparazione ad esercizi con sovraccarichi, che verranno poi<br />
privilegiati nella seconda parte di questo macro-ciclo, dove si lavorerà sulla<br />
forza esplosiva, (quella utile per l’atleta di <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong>) sulla velocità, e sulla<br />
rapidità.<br />
Allenamento aerobico: Le componenti aerobiche dell’allenamento del <strong>beach</strong>-<br />
<strong>tennis</strong>, richiedono un sovraccarico di allenamento mirato a livello delle cellule<br />
muscolari e necessitano di corti periodi di recupero (“Strength and<br />
Conditioning Journal”, Ott. 2004). Capiamo quindi che il tradizionale<br />
allenamento aerobico come per esempio la classica corsa di 3 e 5 miglia (4,8 –<br />
8 Km) o l’allenamento intervallato lattacido sotto forma di ripetute di 1 – 2<br />
minuti (400 – 800m), saranno utili a migliorare la capacità aerobica, ma<br />
potrebbe non essere sufficiente per questi giocatori ai fini stretti della<br />
prestazione. In un programma di allenamento è utile per gli atleti mantenere<br />
una intensità di lavoro uguale o maggiore all’intensità sopportata durante gli<br />
incontri, quindi un rapporto lavoro/recupero che deve rispecchiare le<br />
condizioni di gara. Un rapporto accettabile in questo sport <strong>può</strong> essere quello<br />
di 2 – 4 secondi di recupero per ogni secondo di lavoro. Tutti gli esercizi che<br />
andremo a proporre per ottenere un risultato utile all’atleta dovranno<br />
rispettare queste condizioni.<br />
54
È bene in questa fase proporre esercizi che provengono da discipline sportive<br />
diverse ma che sviluppino delle caratteristiche necessarie alla disciplina<br />
praticata, questo <strong>può</strong> servire anche al divertimento, al rilassamento e al<br />
recupero. Includere questi esercizi nella fase preparatoria consente lo<br />
sviluppo multilaterale delle capacità dell’atleta e di prevenire gli infortuni in<br />
particolare nei ragazzi.<br />
Esercizi di rinforzo muscolare: Questi esercizi saranno mirati al<br />
rafforzamento dei principali gruppi muscolari delle gambe e del torace, i<br />
muscoli posturali, ed infine della spalla, articolazione molto delicata e<br />
sottoposta a un notevole stress durante il gioco. Gli esercizi che si andranno a<br />
proporre non avranno come obbiettivo primario quello di aumentare la<br />
massa, ma bensì la forza esplosiva, quella veloce e la mobilità articolare con<br />
lo scopo di prevenire gli infortuni. Nella stesura di un programma di<br />
allenamento quindi per quanto riguarda lo sviluppo della forza il carico di<br />
lavoro non sarà eccessivamente alto: dal 30 al 55 % della ripetuta massima,<br />
andranno eseguite 4/6 ripetizioni ad intensità massima (lenta in fase<br />
eccentrica in modo da non avere un accumulo di energia elastica lungo la fase<br />
discendente, e in modo rapido lungo la fase concentrica), per un totale di 6/8<br />
serie, con recuperi completi quindi almeno da 3 minuti, cosi da allenare la<br />
forza esplosiva. Utile anche qui eseguire all’inizio del programma dei test di<br />
forza massimale (es. test della ripetuta massima) così poi saremo in grado di<br />
regolare con precisione il carico.<br />
Tra gli esercizi che andremo a proporre ci potranno tornare molto utili<br />
materiali diversi da quelli utilizzati durante le competizioni, come palle<br />
mediche, elastici, bastoni, bilanciere, manubri e piani instabili.<br />
Potremo quindi suddividere gli esercizi in base al loro scopo:<br />
55
Fig. 13 Esercizi per la mobilità articolare:<br />
Fig. 14 Esercizi di forza con palla medica<br />
56
Fig. 15 Esercizi di scioltezza muscolare e mobilità articolare<br />
Fig. 16 esercizi di muscolazione per la parte superiore:<br />
57
esercizi di muscolazione per la parte inferiore del corpo:<br />
Squat con bilanciere<br />
Squat isometrico con appoggio della schiena sul muro con seguente<br />
scatto di corsa (20 metri) dopo venti secondi di tenuta.<br />
Affondi<br />
Distensioni sulle punte dei piedi con sovraccarico<br />
Balzi (da fermi, in movimento, sfalsati, lateralmente ad una panca<br />
saltando da una parte all’altra, ma anche salendo sulla panca e<br />
scendendo, partendo prima da posizione eretta poi da seduti.)<br />
Ostacoli<br />
Sprint con partenza da fermo su distanze corte (30 metri).<br />
- Esercizi muscoli posturali a corpo libero:<br />
Addominali<br />
Dorsali<br />
Torsioni ed inclinazioni del busto (anche con sovraccarico)<br />
Ecc.<br />
Preparazione Specifica:<br />
Anch’essa della durata di circa 3 mesi, con una frequenza delle sedute che<br />
rimane invariata alle 2 / 3 volte a settimana per circa 90 minuti l’una, ad<br />
aggiungersi all’allenamento tecnico. In questa fase, che andrà a precedere la<br />
stagione agonistica, la preparazione, sia dal punto di vista atletico che della<br />
tecnica si adeguerà alle modalità di gara.<br />
58
In questa fase il giocatore tornerà a cimentarsi sulla sabbia e finalmente con<br />
la racchetta, il campo da gioco in questo caso offre un grandissimo vantaggio<br />
in quanto la sabbia rappresenta un ottimo ed estremamente specifico veicolo<br />
di potenziamento per gli arti inferiori. Si mantiene comunque l’allenamento<br />
con i pesi dando importanza soprattutto alla velocità dello spostamento del<br />
sovraccarico, a questo si aggiunge la trasformazione di quanto costruito fin<br />
ora in campo, verranno quindi riproposti i vari colpi, spostamenti ecc. con<br />
sovraccarico. Gli esercizi di corsa saranno composti da scatti molto brevi con<br />
altrettanto brevi recuperi. Gli esercizi per il potenziamento, l’allenamento<br />
della resistenza e della gestione delle situazioni di disequilibrio verrà proposto<br />
applicando quindi all’atleta dei pesi (polsini, cavigliere, cinture zavorrate) per<br />
an<strong>dare</strong> ad agire nello specifico sul gesto tecnico che deve eseguire e<br />
potenziarlo. Un altro metodo con cui possiamo aumentare il carico di lavoro<br />
nel gesto tecnico specifico è attraverso l’applicazione di elastici applicati in<br />
punti strategici del corpo, quindi sulle caviglie o sul baricentro, andando a<br />
lavorare sulla velocità e sulla potenza dello spostamento del corpo. Se<br />
applicheremo questi elastici nei polsi invece, eseguendo movimenti simili a<br />
quelli con la racchetta, andremo a lavorare sul sulla resistenza della spalla. Si<br />
rende molto utile anche l’utilizzo di pedane instabili, eseguire esercizi con<br />
l’ausilio di questi attrezzi sarà molto utile per sviluppare l’equilibrio del corpo<br />
anche in situazioni dove questo si rende precario. Anche qui come detto in<br />
precedenza tutto il lavoro svolto dovrà avere un’intensità molto simile a<br />
quella di gara, quindi rispettando i tempi di recupero in proporzione ai tempi<br />
di lavoro.<br />
59
3.2. La traumatologia<br />
Prima di addentrarci in questo argomento è utile fare una importante<br />
distinzione tra i traumi acuti e traumi cronici. Parliamo di traumi acuti<br />
quando la lesione che ne deriva è riconducibile ad un evento unico ben<br />
preciso, per esempio distorsioni, fratture, contusioni, strappi ecc. questo tipo<br />
di traumi non è molto frequente nel <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong>, non essendo uno sport di<br />
contatto e essendo praticato su un terreno morbido.<br />
Parliamo invece di traumi cronici quando non possono essere ricondotti a un<br />
evento specifico, ma sono invece causati da sovraccarichi funzionali ripetuti,<br />
spesso derivanti da una tecnica non corretta e quindi, a lungo termine, con la<br />
moltitudine di ripetizioni crea sovraccarico dello specifico distretto corporeo<br />
trasformandosi poi in infiammazione.<br />
I principali infortuni cronici ai quali un giocatore di <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong> <strong>può</strong> an<strong>dare</strong> in<br />
contro sono diversi, i più frequenti li riscontriamo a livello del gomito, della<br />
spalla, del polso e a livello lombare. La parte inferiore del corpo è meno<br />
colpita, più facile che questa infatti sia soggetta a traumi di tipo acuto. In<br />
questo paragrafo tratteremo i traumi di tipo cronico, questo perché sono<br />
proprio questi a poter essere evitati con una buona preparazione, quelli acuti<br />
al contrario sono di difficile previsione, quindi è difficile fare una attenta<br />
prevenzione.<br />
Abbiamo quindi a livello del gomito due principali patologie:<br />
- Epicondiliti: meglio conosciute come “gomito del <strong>tennis</strong>ta”, si tratta di<br />
un infiammazione a livello dell’epicondilo del gomito (che si trova sulla<br />
parte esterna) a carico dei tendini dei muscoli estensori del polso e della<br />
mano. In questo sport essi hanno la funzione di opporsi alla pallina che<br />
60
impatta la racchetta nel rovescio, e quella di consentire la rigidità del<br />
polso, sinergicamente con i muscoli flessori, in tutti i colpi. Questi tendini<br />
sono fortemente sollecitati dalle vibrazioni che la racchetta nel momento<br />
di impatto con la palla gli trasmette, ed è proprio questo l’agente lesivo<br />
che porta alla loro infiammazione. Quindi maggiori probabilità di<br />
riscontrare questa patologia si avranno dall’errata esecuzione del<br />
rovescio, da una insufficiente elasticità dei muscoli estensori del gomito<br />
e della mano, ma anche dalla tipologia della racchetta o delle palline che,<br />
se sono troppo dure sollecitando in<br />
maniera più aggressiva questi tendini potranno causare epicondiliti.<br />
- Epitrocleiti: conosciute anche come “gomito del golfista”, parliamo di<br />
epitrocleiti quando siamo di fronte ad una sindrome dolorosa a livello<br />
dell’epitroclea (sulla parte interna del gomito), dovuta ad un<br />
infiammazione dei tendini dei muscoli flessori del polso e della mano.<br />
Anch’essa è scatenata dalle vibrazioni che derivano dall’impatto della<br />
pallina con la racchetta impugnata dal giocatore, e da un eccessivo<br />
lavoro dei muscoli flessori, che hanno essenzialmente 2 funzioni:<br />
opporsi alla forza della pallina con la racchetta nel dritto, nel servizio e<br />
nello smash, e come per la precedente lavorando sinergicamente agli<br />
estensori nel mantenere il polso rigido. Quindi l’infiammazione potrà<br />
facilmente comparire nel caso di tecnica errata nell’esecuzione di questi<br />
colpi, anche qui da una insufficiente elasticità dei muscoli flessori del<br />
polso e della mano e dall’uso di palline e\o racchette inadatte al<br />
soggetto oltre che da una predisposizione anatomica.<br />
- Sindrome da impingement della spalla: o sindrome da conflitto sub-<br />
acromiale, è una delle più comuni cause di dolore alla articolazione della<br />
spalla negli adulti, è il risultato della pressione sulla cuffia dei rotatori da<br />
61
una parte della scapola quando il braccio viene alzato. Possiamo<br />
affermare che l’Impingement sub-acromiale è il preludio della, assai più<br />
grave, lacerazione della Cuffia dei Rotatori.<br />
La cuffia dei rotatori è formata da quattro muscoli che coprono la testa<br />
dell’omero, e lavorano sinergicamente per sollevare e ruotare la<br />
spalla. L’Acromion (processo della scapola) che giace sopra e di fronte la<br />
testa dell’omero; non appena il braccio viene alzato, sfrega con<br />
superficie della cuffia dei rotatori. Ciò causa dolore e limita il<br />
movimento. <strong>Il</strong> dolore <strong>può</strong> essere dovuto ad una borsite (infiammazione<br />
della borsa che giace al disopra della cuffia dei rotatori) od ad una<br />
tendinite della cuffia stessa. È tipica degli sportivi che si trovano a<br />
colpire la palla direttamente con la mano o con un attrezzo, sopra la<br />
linea delle spalle. Quindi nel <strong>beach</strong>-<strong>tennis</strong> in particolare <strong>può</strong> essere<br />
causata da tecniche errate nell’esecuzione di smash o servizio, e/o da<br />
insufficiente equilibrio tra muscoli elevatori dell’arto superiore e i<br />
muscoli che stabilizzano la testa dell’omero in sede.<br />
- Cisti del polso: Si presentano come tumefazioni, più frequenti in zona<br />
dorsale ma a volte le troviamo anche dal lato palmare del polso, sono<br />
causate spesso da un uso massiccio del polso, che, comportando<br />
l’infiammazione della guaina tendinea e delle articolazioni adiacenti,<br />
scatena una eccessiva produzione di liquido sinoviale. Nel <strong>beach</strong>-<strong>tennis</strong><br />
possono essere causate da tecniche non corrette dei colpi, tipologia di<br />
racchetta e palline, e impugnatura inadeguata alle dimensioni della<br />
mano.<br />
- Lombalgia: sindrome dolorosa che colpisce la zona lombosacrale. Alcuni<br />
studi hanno evidenziato che solo il 20% delle lombalgie è provocato da<br />
un problema specifico della colonna vertebrale (patologie rachidee); il<br />
62
estante 80% è provocato da cause non specifiche quali posture e<br />
movimenti scorretti, stress psicologici, forma fisica scadente ed eccesso<br />
di peso corporeo.<br />
Esistono due tipi di mal di schiena: lombalgia acuta e lombalgia cronica.<br />
La lombalgia acuta è caratterizzata da un tipo di dolore, causato da<br />
una lesione muscolare, legamentosa, articolare e discale, che si<br />
accompagna a fenomeni infiammatori. L'infiammazione e il dolore<br />
fanno parte del processo di guarigione e cessano, quindi, a guarigione<br />
completata in massimo 30 giorni. <strong>Il</strong> dolore acuto a livello del rachide è,<br />
quindi, un segnale d'allarme per un'avvenuta lesione, una reazione di<br />
difesa, uno stimolo a cambiare posizione; ha un ruolo protettivo e<br />
adattativo, serve a impedire i movimenti che possono danneggiare<br />
ulteriormente la colonna vertebrale. La lombalgia cronica invece tende<br />
a far perdurare il dolore oltre i 3 mesi anche a fronte di una lesione<br />
inesistente. <strong>Il</strong> dolore cronico non ha una funzione protettiva, diventa<br />
autonomo, nocivo, riduce la funzionalità del rachide e favorisce la<br />
disabilità. È stato riscontrato un legame tra comparsa di questa<br />
patologia e la pratica degli sport che prevedono attività di lancio con<br />
movimenti di torsione e flessione del busto.<br />
Riconducibili in particolare al <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong> possiamo attribuire diverse<br />
cause, quali una tecnica non corretta di smash e servizio, insufficiente<br />
elasticità della catena cinetica anteriore e/o posteriore, insufficienza del<br />
tono e del controllo della muscolatura addominale e lombare.<br />
Per un adeguata prevenzione bisogna agire su più fronti, in primis acquisire<br />
una buona tecnica, un colpo eseguito scorrettamente è la prima causa di<br />
sovraccarico di un distretto corporeo. Un altro punto la scelta adeguata del<br />
materiale (racchetta, pallina), una buona preparazione fisica con lo scopo di<br />
63
preparare il fisico al carico di lavoro e agli sforzi che dovrà affrontare sia negli<br />
allenamenti che in gara. A tutto questo non <strong>può</strong> mancare una discreta<br />
elasticità muscolare delle catene cinetiche anteriore e posteriore, ed in<br />
particolare della spalla e di tutto l’arto superiore, che sono i distretti messi a<br />
più dura prova in questo sport. In fine un buon riscaldamento mirato a<br />
preparare il fisico alla prestazione, con esercizi di corsa per attivare la parte<br />
inferiore del corpo, stretching dei muscoli delle catene cinetiche e<br />
dell’avambraccio, esercizi di attivazione della muscolatura della spalla e di<br />
tutto l’arto superiore.<br />
64
65<br />
4. SCOPO DELLA TESI<br />
Premesso che nello sport del <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong> la velocità di spostamento del<br />
corpo, vista la rapidità del gioco, è un elemento indispensabile, e che molte<br />
volte <strong>può</strong> rivelarsi la chiave per mettere in difficoltà l’avversario, al fine di<br />
ottenere dei risultati significativi nell’allenamento di questa componente, si è<br />
pensato di testare gli effetti di uno stesso protocollo di allenamento per la<br />
rapidità degli arti inferiori, proposto su due gruppi di soggetti, un gruppo<br />
sperimentale che si allenerà esclusivamente sulla sabbia, ed un altro di<br />
controllo che svolgerà la preparazione a secco. Questo al fine di verificare il<br />
rendimento di una e dell’altra proposta e quindi l’efficacia.<br />
4.1 Soggetti<br />
Hanno preso parte a questo studio in maniera volontaria in totale dieci<br />
atleti, tutti quanti di livello amatoriale. Di questi dieci atleti, cinque sono<br />
giocatori di Beach <strong>tennis</strong> e cinque invece giocatori di Tennis. Tutti i soggetti<br />
praticano la loro disciplina da almeno 2 anni. Tutti inoltre sono stati<br />
preventivamente informati sul protocollo sperimentale e sull’obbiettivo dello<br />
studio.<br />
Gruppo n Età media (anni)<br />
+ d.s.<br />
Peso medio<br />
(kg) + d.s.<br />
Altezza media (cm)<br />
+ d.s.<br />
Beach <strong>tennis</strong> 5 35,65 ± 2,92 72,2 ± 4,58 167,60 ± 3,36<br />
Tennis 5 32,28 ± 3,40 75,8 ± 3,27 176,00 ± 5,96<br />
Tabella 6. Caratteristiche antropometriche dei 2 gruppi di soggetti
4.2 Protocollo sperimentale<br />
È stato proposto quindi un programma di allenamento a 10 atleti, che<br />
erano da poco usciti dalla stagione degli incontri. Questa proposta di<br />
allenamento è stata attuata per un periodo di cinque mesi (ottobre –<br />
febbraio) con frequenza di un ora alla settimana, che si andava ad integrare<br />
con 2 allenamenti tecnico - tattici che gli atleti svolgevano già da loro. <strong>Il</strong><br />
programma di allenamento per lo studio è stato presentato ai due gruppi<br />
nello stesso identico modo fatta eccezione per un particolare: il campo; il<br />
gruppo del <strong>tennis</strong> infatti ha svolto il lavoro a secco, ovvero su una superficie<br />
liscia, il gruppo del <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong> anche nel lavoro della rapidità e della velocità<br />
invece ha sempre lavorato sulla sabbia.<br />
4.3 Protocollo dei test<br />
I due gruppi di atleti prima e dopo il periodo di allenamento hanno<br />
effettuato alcuni test per la misurazione della velocità di spostamento del<br />
corpo e rapidità. Questi test sono stati spiegati e dimostrati agli atleti prima di<br />
essere fatti eseguire, e sono stati eseguiti in ambiente chiuso per evitare che<br />
le condizioni atmosferiche come il vento possa incidere sui risultati. I test<br />
sono stati eseguiti ad entrambi i gruppi nelle stesse giornate e sotto la<br />
supervisione dello sperimentatore, il quale ha preparato il materiale,<br />
misurato i tempi e controllato la correttezza di esecuzione delle prove. Per<br />
ogni atleta ognuno dei 3 test è stato fatto eseguire tre volte, il valore<br />
registrato è stato quindi il valore più basso fatto registrare dal soggetto nei tre<br />
tentativi, quindi la prestazione migliore, la misurazione è stata fatta con il<br />
cronometro. E per ognuna delle tre prove gli atleti hanno avuto a disposizione<br />
tutto il tempo necessario a garantire un recupero completo.<br />
66
I test sono stati eseguiti dopo aver effettuato un adeguato riscaldamento che<br />
comprendeva:<br />
- 8 minuti di corsa.<br />
- 10 minuti di stretching dinamico dando particolare attenzione alla parte<br />
inferiore del corpo.<br />
Abbiamo effettuato quindi 3 test:<br />
30 metri sprint: Ad ogni soggetto è stato chiesto, partendo da fermo, in<br />
posizione eretta e busto flesso in avanti, di effettuare uno scatto al segnale<br />
prestabilito, correndo alla sua massima velocità per una distanza di 30 metri.<br />
il test è stato effettuato su superficie liscia. In questo caso tra una prova e<br />
l'altra abbiamo lasciato 3 minuti di recupero per favorire il ripristino completo<br />
delle riserve energetiche di ATP e Fosfocreatina. Le qualità indagate in questo<br />
test sono la forza veloce e la capacità di accelerazione del soggetto.<br />
20 metri sabbia: Anche in questo caso si è chiesto al soggetto di effettuare<br />
uno scatto alla massima velocità partendo da fermo al segnale prestabilito,<br />
ma per una distanza di 20 metri e su una superficie sabbiosa. Tra una prova e<br />
la successiva sono stati concessi al soggetto 3 minuti di recupero.<br />
IAT: L’ <strong>Il</strong>linois Agility Test (Getchell,1979) è un test comunemente usato per<br />
l’agilità negli sport di squadra che ha come obbiettivo quello di testare l’agilità<br />
di un soggetto e l’abilità nei cambi di direzione, per la preparazione del<br />
circuito abbiamo utilizzato: una superficie piana e non scivolosa, coni,<br />
cronometro e metro.<br />
67
Fig. 17 <strong>Il</strong>linois Agility test<br />
<strong>Il</strong> “box” (vedi fig 17) presenta le dimensioni di 10x5 metri, dieci in<br />
lunghezza, e cinque in larghezza (la distanza tra i punti d’inizio e di fine).<br />
Quattro coni sono utilizzati per segnare il punto d’inizio, di fine e i due angoli,<br />
altri 4 coni sono piazzati al centro ad uguale distanza tra loro. Ogni cono al<br />
centro è distanziato di 3.3 metri dagli altri. I soggetti devono partire in piedi di<br />
fronte al cono d’inizio e con le mani vicino alle spalle. Al segnale “Go” si avvia<br />
il cronometro e l’atleta parte il più veloce possibile correndo per la corsia<br />
verso la direzione indicata, senza colpire i coni, fino alla fine del percorso<br />
quando verrà stoppato il cronometro.<br />
68
Tabella 7. Valori riferimento IAT<br />
Agility Run Ratings (seconds)<br />
Rating Males Females<br />
Excellent < 15.2 < 17.0<br />
Good 16.1-15.2 17.9-17.0<br />
Average 18.1-16.2 21.7-18.0<br />
Fair 18.3-18.2 23.0-21.8<br />
Poor > 18.3 > 23.0<br />
4.4 Protocollo di allenamento<br />
La velocità di spostamento e la rapidità nel <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong>, sono certamente<br />
caratteristiche che non possono mancare ad un atleta che vuole cimentarsi<br />
con discreti risultati in questa disciplina. Per poter essere sviluppate al meglio<br />
c’è la necessità di allenarle in modo specifico, crediamo inoltre che nel<br />
cercare di migliorare queste doti sia importante dedicare uno spazio al lavoro<br />
coordinativo, che sta alla base di tutti i movimenti che un atleta <strong>può</strong> eseguire.<br />
Nella programmazione degli allenamenti abbiamo seguito un modello di<br />
lavoro strutturato nel seguente modo, ogni seduta si componeva di:<br />
- 20 minuti di riscaldamento.<br />
- 30/45 minuti di lavoro atletico.<br />
- 10/15 minuti di allungamenti e defaticamento.<br />
La fase di riscaldamento e la fase di defaticamento è stata svolta da tutti e<br />
dieci gli atleti sul campo da <strong>tennis</strong>, quindi fuori dalla sabbia anche per gli atleti<br />
del <strong>beach</strong>.<br />
<strong>Il</strong> riscaldamento prevedeva: 6 minuti di corsa continua a velocità costante, 5<br />
minuti di stretching dinamico, poi di nuovo 4 minuti di corsa continua a<br />
69
velocità variabile (corsa blanda sul lato lungo del campo da <strong>tennis</strong> alternata<br />
ad allunghi sul lato corto), 5 minuti di stretching statico.<br />
<strong>Il</strong> defaticamento invece era composto da 3 giri di campo ad intensità blanda,<br />
seguiti da posture per l’allungamento della catena cinetica posteriore, e dei<br />
muscoli principali dell’arto inferiore.<br />
Per il lavoro sulla rapidità si sono rispettati i seguenti principi:<br />
- Gli esercizi sono sempre stati proposti ad inizio seduta di allenamento,<br />
immediatamente dopo lo stretching, per cui in assenza di stanchezza<br />
muscolare.<br />
- Tutti gli esercizi sono stati proposti a carico naturale, per permettere<br />
l’esecuzione dell’esercizio il più velocemente possibile e per non<br />
affaticare pesantemente il muscolo.<br />
- Impegno muscolare e nervoso sempre massimo in ogni ripetizione del<br />
gesto.<br />
- 6 ripetizioni per esercizio della durata massima di 6 – 8 secondi.<br />
- 6 – 8 serie per ogni gruppo muscolare (che possono prevedere anche<br />
esercizi diversi).<br />
- Recupero tra le serie completo (almeno 3 minuti).<br />
- Gli esercizi sono stati proposti in maniera graduale, dai più facili ai più<br />
complessi.<br />
Più nel dettaglio l’allenamento prevedeva a settimane alterne 2 tipi di<br />
allenamento:<br />
- Prima tipologia: nella quale si richiedeva agli atleti di eseguire:<br />
a) vari tipi di corsa: corsa a slalom tra i birilli, skip a varie altezze tra<br />
piccoli ostacoli prima frontalmente poi lateralmente, corsa calciata<br />
dietro, corsa laterale a passo incrociato su ambedue i lati, corsa<br />
70
all’indietro con varie ampiezze del passo, passo saltellato, passo<br />
stacco, galoppo laterale, andature mono-doppio appoggio, corsa<br />
balzata, balzi tra ostacoli.<br />
b) 20 minuti circa dedicati al lavoro più di velocità che prevedevano scatti<br />
a velocità massimale (ogni allenamento si utilizzava uno dei 4 diversi<br />
circuiti rappresentati nelle figure 18 e 19), per un lavoro di 2 serie da 8<br />
ripetizioni (per il <strong>tennis</strong>) e 2x6 (per quelli che lavoravano sulla sabbia),<br />
ed tempi di recupero di 3 minuti tra le 2 serie e 1 minuto tra le<br />
ripetizioni. Questi percorsi nelle varie ripetizioni venivano svolti in<br />
maniera alternata, partendo dall’esecuzione con la corsa frontale, poi<br />
corsa all’indietro, laterale, ed infine unendo i vari tipi di corsa.<br />
Fig.18 Star drill /Short five corner drill<br />
71
Fig. 19 X drill, long X drill<br />
Seconda tipologia di allenamento:<br />
a) 25 minuti circa di esercizi con la speed – ladder (scaletta) ove si sono<br />
svolti tutti esercizi di pura rapidità dei piedi e coordinazione.<br />
Fig. 20 Spedd ledder<br />
b) Secondi 20 minuti: Corsa veloce sul posto, Skip, calciata dietro,<br />
mantenere la posizione dello squat (angolo al ginocchio max 100<br />
gradi), appoggi alternati dei piedi sia sul piano frontale che sagittale,<br />
balzi a gambe tese, balzi laterali a piedi uniti, balzi laterali in appoggio<br />
72
solamente su gamba esterna; tutti questi esercizi venivano eseguiti sul<br />
posto e al segnale prestabilito (circa dopo 6 secondi) bisognava<br />
eseguire nelle prime serie di esercizi un allungo, nelle ultime invece<br />
uno scatto in 10 metri.<br />
73
4,80<br />
4,60<br />
4,40<br />
4,20<br />
4,00<br />
3,80<br />
3,60<br />
2.6 Statistiche<br />
Tutti i dati riportati nella tabella di seguito sono stati espressi come media ±<br />
deviazione standard e per quanto riguarda il livello di significatività è stato<br />
applicato il “t test” accettando come valori significativi solamente quelli che<br />
presentano t test < 0,05.<br />
RISULTATI:<br />
Si riportano ora le tabelle riassuntive con i dati espressi in secondi, ottenuti<br />
dai test utilizzati per lo studio.<br />
Tabella 8. Risultati dei test<br />
30 m gruppo b. <strong>tennis</strong><br />
Gruppo <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong> Gruppo <strong>tennis</strong><br />
PRE POST PRE POST<br />
30 m 4,39 ± 0,35 4,37 ± 0,33 4,45 ± 0,17 4,32 ± 0,22<br />
20 sabbia 3,52 ± 0,23 3,47 ± 0,19 3,45 ± 0,21 3,27 ± 010<br />
IAT 17,56 ± 0,79 17,47 ± 0,71 17,42 ± 0,78 17,08 ± 0,76<br />
Prendiamo ora in esame i risultati relativi ai singoli test descritti nel protocollo<br />
sperimentale.<br />
Test 30 metri:<br />
inizio<br />
Fine<br />
4,80<br />
4,60<br />
4,40<br />
4,20<br />
4,00<br />
3,80<br />
3,60<br />
74<br />
30 m gruppo <strong>tennis</strong><br />
*<br />
inizio<br />
fine
fig. 21(pagina precedente) Istogrammi comprensivi di deviazione standard sul<br />
test dei 30 m.<br />
Possiamo notare come in entrambi i gruppi riscontriamo dei <strong>miglioramenti</strong><br />
nell’esito del test finali rispetto all’inizio, nonostante gli effetti siano positivi in<br />
entrambi i gruppi però, nel gruppo che ha lavorato sulla sabbia i valori<br />
dall’inizio alla fine non possono essere ritenuti significativi, presentando un t<br />
test = 0,696. Nel gruppo che ha lavorato a secco invece il miglioramento è<br />
stato più evidente ed i valori possono essere ritenuti significativi (t test =<br />
0,019).<br />
30 m (s) POST<br />
30 m (s) POST<br />
5<br />
4,8<br />
4,6<br />
4,4<br />
4,2<br />
4<br />
3,8<br />
30 m gr. <strong>beach</strong> t.<br />
75<br />
y = 0,9153x + 0,3515<br />
R² = 0,9056<br />
tempi<br />
Lineare (tempi)<br />
3,6<br />
3,5 4 4,5 5<br />
30 m (s) PRE 30 m gr. <strong>tennis</strong><br />
4,7<br />
y = 1,2576x - 1,2699<br />
4,6<br />
R² = 0,9245<br />
4,5<br />
4,4<br />
4,3<br />
4,2<br />
4,1<br />
4<br />
4 4,2 4,4 4,6 4,8<br />
30 m (s) PRE<br />
tempi<br />
Lineare (tempi)
3,80<br />
3,60<br />
3,40<br />
3,20<br />
3,00<br />
2,80<br />
Fig. 22 Grafici a dispersione della correlazione sui test dei 30 m.<br />
20 sabbia b. <strong>tennis</strong><br />
20 s (s) POST<br />
3,8<br />
3,7<br />
3,6<br />
3,5<br />
3,4<br />
3,3<br />
Test 20 metri sabbia:<br />
Fig. 23 Istogrammi comprensivi di dev. standard su test dei 20m sulla sabbia<br />
Anche in questo test entrambi i gruppi hanno avuto una tendenza al<br />
miglioramento, più marcata anche questa volta per i <strong>tennis</strong>ti, ma in entrambi i<br />
gruppi non abbiamo valori significativi escludendo quelli con t. test>0,05. Nel<br />
dettaglio abbiamo calcolato, per il gruppo Beach: t test = 0,400; gruppo<br />
<strong>tennis</strong>: t test = 0,081.<br />
inizio<br />
fine<br />
20 m sabbia gr. <strong>beach</strong> t.<br />
3,2<br />
3,2 3,4 3,6 3,8 4<br />
20 s (s) PRE<br />
3,80<br />
3,60<br />
3,40<br />
3,20<br />
3,00<br />
2,80<br />
76<br />
20 sabbia <strong>tennis</strong><br />
y = 0,7304x + 0,9038<br />
R² = 0,8029<br />
tempi<br />
Lineare<br />
(tempi)<br />
inizio<br />
fine
18,70<br />
18,30<br />
17,90<br />
17,50<br />
17,10<br />
16,70<br />
16,30<br />
15,90<br />
15,50<br />
20 s (s) POST<br />
3,4<br />
3,35<br />
3,3<br />
3,25<br />
3,2<br />
3,15<br />
3,1<br />
Fig. 24 Grafici a dispersione della correlazione sui test dei 20 m sulla sabbia<br />
IAT gruppo b. <strong>tennis</strong><br />
20 m sabbia gr. <strong>tennis</strong><br />
3 3,2 3,4 3,6 3,8<br />
20 s (s)PRE<br />
<strong>Il</strong>linois agility test<br />
inizio<br />
fine<br />
18,70<br />
18,30<br />
17,90<br />
17,50<br />
17,10<br />
16,70<br />
16,30<br />
15,90<br />
15,50<br />
Fig. 25 . Istogrammi comprensivi di deviazione standard su test IAT<br />
Anche in questo test entrambi gruppi hanno avuto una tendenza al<br />
miglioramento ma, mentre per il gruppo che ha lavorato sulla sabbia i risultati<br />
non sono significativi ( t test = 0,398), abbiamo riscontrato dei significativi e<br />
77<br />
y = 0,2725x + 2,331<br />
R² = 0,353<br />
tempi<br />
Lineare (tempi)<br />
IAT gruppo <strong>tennis</strong><br />
*<br />
inizio<br />
fine
attendibili <strong>miglioramenti</strong> per il gruppo che ha svolto il lavoro a secco (t test =<br />
0,003).<br />
IAT (s) POST<br />
IAT (s) POST<br />
18,4<br />
18,2<br />
18<br />
17,8<br />
17,6<br />
17,4<br />
17,2<br />
17<br />
16,8<br />
16,6<br />
16,4<br />
16,2<br />
16 16,5 17 17,5 18 18,5 19<br />
18<br />
17,5<br />
17<br />
16,5<br />
16<br />
IAT gr. <strong>beach</strong> t.<br />
IAT (s) PRE<br />
IAT gr. <strong>tennis</strong><br />
15,5<br />
16 17 18 19<br />
IAT (s) PRE<br />
Fig. 26 Grafici a dispersione della correlazione sui test IAT<br />
78<br />
y = 0,8745x + 2,1129<br />
R² = 0,9264<br />
tempi<br />
Lineare (tempi)<br />
y = 0,9555x + 0,4378<br />
R² = 0,9786<br />
tempi<br />
Lineare (tempi)
4.6 Discussione dei risultati<br />
Dall’analisi dei risultati ottenuti si evince come entrambi i gruppi abbiano<br />
ottenuto dei <strong>miglioramenti</strong> rispetto al livello di partenza. Sicuramente una<br />
delle cose più importanti da notare è che in tutti e tre i test i risultati più<br />
evidenti li hanno raggiunti gli atleti che hanno lavorato a secco, nonostante<br />
“solo” nel test dei 30 metri e nell’<strong>Il</strong>linois agility test abbiamo ottenuto dei<br />
<strong>miglioramenti</strong> significativi. Questo ci porta inevitabilmente alla convinzione<br />
che probabilmente il lavoro svolto a secco è più redditizio per quanto riguarda<br />
l’allenamento di queste componenti, rispetto al lavoro sulla sabbia. Quindi<br />
anche nella preparazione del <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong> nell’allenamento della rapidità e<br />
della velocità sarebbe consigliabile lavorare su superfici diverse dalla sabbia.<br />
Nel esporre però una valutazione oggettiva ed il più possibile affidabile,<br />
risulta doveroso analizzare i possibili fattori, la cui influenza <strong>può</strong> aver<br />
compromesso in maniera più o meno significativa l’affidabilità dei risultati del<br />
test.<br />
Pur essendo convinti di quanto esposto sin ora circa l’efficacia del lavoro<br />
svolto, seppur una volta a settimana è da considerarsi molto ridotta ai fini<br />
dello scopo; siamo infatti indotti a credere che essendo stata questa<br />
preparazione integrata in maniera differente tra i due gruppi (gruppo di<br />
sperimentazione e gruppo di controllo), questo abbia inciso nei risultati, oltre<br />
all’allenamento citato in questa tesina infatti il gruppo de <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong><br />
effettuava regolarmente due allenamenti tecnici sulla sabbia, mentre il<br />
gruppo dei <strong>tennis</strong>ti svolgeva altrettanti allenamenti ma in maniera differente<br />
su campo.<br />
Questi allenamenti extra, data la diversità delle due discipline saranno stati<br />
sicuramente svolti in maniera più dinamica dai <strong>tennis</strong>ti, rispetto ai colleghi del<br />
79
each, che avendo meno distanza da coprire, viste le dimensioni minori del<br />
loro campo, e vista la difficoltà maggiore nello spostarsi sulla sabbia, avranno<br />
svolto questi allenamenti in maniera più statica. Siamo portati a credere che<br />
questo particolare abbia sicuramente avuto un influenza sull’ esito dei test<br />
finali.<br />
Un'altra nota da prendere in considerazione, gli atleti che hanno lavorato<br />
sulla sabbia, nonostante avessero necessità di tempi di recupero maggiori<br />
(almeno 6 minuti), e quindi le pause tra una serie e l’altra fossero maggiori, si<br />
stancavano molto più facilmente, perciò già dopo metà seduta erano più in<br />
difficoltà, dato che l’allenamento della rapidità dev’essere svolto ad intensità<br />
massimali e in assenza di affaticamento muscolare, per loro la prova essendo<br />
già compromessa prima dei tre quarti dell’allenamento pregiudicava poi la<br />
corretta esecuzione degli esercizi finali, che venivano eseguiti ad intensità più<br />
ridotte.<br />
4. 7 Conclusioni<br />
Rapidità e velocità sono concetti simili ma non identici, con il termine<br />
rapidità si fa infatti riferimento alla capacità di reagire ad uno stimolo nel<br />
minor tempo possibile e/o di eseguire con la massima velocità movimenti di<br />
singoli segmenti corporei contro scarsa resistenza. Velocità è invece un<br />
concetto fisico generalmente riferito all'intero corpo che esprime il rapporto<br />
tra la distanza percorsa (spazio) ed il tempo necessario per percorrerla<br />
(V=S/T).<br />
80
Pertanto: la rapidità è una proprietà generale prettamente legata al sistema<br />
nervoso ed è incrementabile in maniera modesta, non oltre il 18-20% del<br />
potenziale genetico. Si <strong>può</strong> affermare che "rapidi si nasce".<br />
La velocità invece è una funzione della rapidità, della forza rapida, della<br />
resistenza e della coordinazione ottimale dei movimenti in relazione<br />
all'ambiente esterno in cui si svolge l'azione. Pertanto la velocità è più<br />
facilmente incrementabile rispetto alla rapidità in quanto si <strong>può</strong> agire sul<br />
miglioramento di diverse capacità.<br />
In questa tesina, spinti dalla grande passione per questo sport abbiamo<br />
pensato di testare gli effetti dell’allenamento di alcune delle componenti<br />
essenziali nella pratica di questa disciplina, quali appunto la velocità e la<br />
rapidità degli arti inferiori. Con l’aumentare del livello delle competizioni la<br />
richiesta di queste componenti sarà sempre maggiore, quindi nasce la<br />
necessità di trovare il giusto mezzo di allenamento per poterle ottimizzare al<br />
meglio. Dai risultati del lavoro ottenuto possiamo affermare che, per quanto<br />
concerne la velocità e la rapidità, nonostante entrambi i lavori abbiano dato i<br />
suoi frutti, l’allenamento a secco dia dei risultati più soddisfacenti a secco<br />
rispetto a quello sulla sabbia; a differenza di altri ambiti, quali l’allenamento<br />
della forza, il recupero funzionale o la prevenzione degli infortuni, dove in<br />
bibliografia possiamo trovare molti riferimenti circa l’efficacia superiore del<br />
“mezzo sabbia”.<br />
Va ricordato inoltre che questo studio si è basato su atleti di basso livello,<br />
tecnico, tattico, ma anche fisico, che costituiscono quindi una categoria<br />
limitata di soggetti, bisogna considerare quindi l’ipotesi che se il campione di<br />
lavoro fosse costituito da atleti professionisti i risultati potrebbero assumere<br />
una piega diversa, dato anche che una preparazione atletica in questo sport<br />
81
sarebbe più indirizzata ad atleti di alto livello, questo studio vuole essere un<br />
punto di partenza per eventuali ricerche future in questo argomento.<br />
82
BIBLIOGRAFIA<br />
Quarantini, M. (2010). <strong>Il</strong> manuale del <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong>. Stampa grafica editoriale<br />
printing, Bologna.<br />
Cometti, G. (1998). Metodi moderni di potenziamento muscolare (parte<br />
pratica), vol. 2. CALZETTI MARIUCCI, Ponte San Giovanni, Perugia.<br />
Dal monte, A., Faina, M. (2000). Valutazione dell’atleta. Analisi funzionale e<br />
biomeccanica delle capacità di prestazione. Editrice UTET.<br />
Platonov Vladimir, N. (2004). fondamenti dell'allenamento e dell'attività di<br />
gara. CALZETTI MARIUCCI Editori, Ponte San Giovanni, Perugia.<br />
Gilles Cometti (2002). Manuale di potenziamento muscolare per gli sport di<br />
squadra. CALZETTI MARIUCCI Editori, Ponte San Giovanni, Perugia.<br />
Maes, C. (2003). Planning physical conditioning for professional players. In M.<br />
Reid, A. Quinn & M. Crespo (Eds.). ITF Strength and Conditioning for Tennis<br />
(217-225). London, ITF Ltd.<br />
83
Gilles Cometti (2000) Esercizi e circuiti per L’allenamento ed il potenziamento<br />
muscolare. I balzi secondo la teoria di Piron. Potenziamento e sport di<br />
squadra. CALZETTI MARIUCCI Editore. Ponte San Giovanni, Perugia.<br />
Mark S. Kovacs. Strength and Conditioning Journal, Ott. 2004.<br />
Brody H., Cross R., Lindsey C. (2004). The Physics and Technology of Tennis,<br />
Usrsa.<br />
www.<strong>beach</strong><strong>tennis</strong>.com<br />
www.<strong>beach</strong><strong>tennis</strong>time.net<br />
www.periartrite.eu<br />
84
RINGRAZIAMENTI<br />
Un primo doveroso ringraziamento va alla mia famiglia che mi convinto a<br />
provare e mi ha sostenuto in tutti questi 3 anni credendo sempre in me. Un<br />
altrettanto importante ringraziamento alla mia ragazza e collega Giulia, per<br />
avermi aiutato ed esserci stata in tutto. Un ringraziamento al professor Cauz<br />
per avermi seguito e consigliato nel lavoro qui presentato. Vorrei ringraziare<br />
anche Latta Massimo, per la disponibilità e tutte le informazioni che mi<br />
gentilmente mi ha fatto avere, vista la sua grandissima esperienza nel settore<br />
del <strong>beach</strong> <strong>tennis</strong>. Un ultimo ringraziamento, ma non meno importante dei<br />
precedenti, a tutti gli amici e colleghi che hanno condiviso (e non) con me<br />
quest’esperienza a scienze motorie!<br />
85