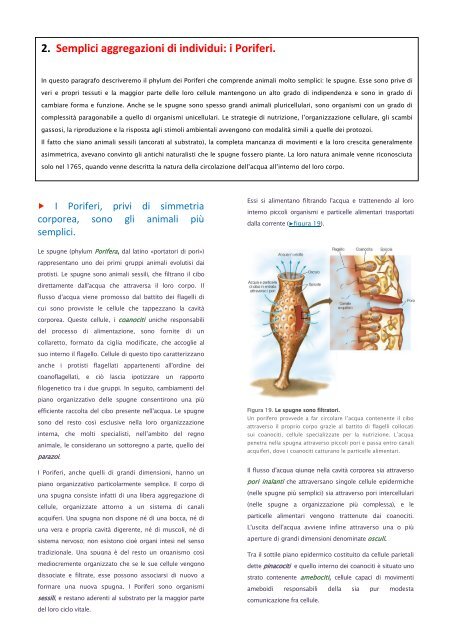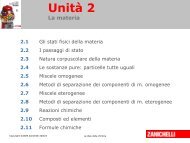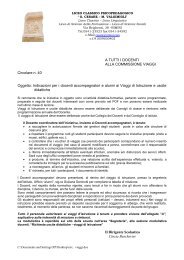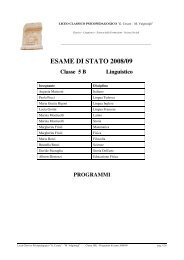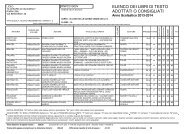Animali 2 - Liceo Classico Psicopedagogico Cesare Valgimigli
Animali 2 - Liceo Classico Psicopedagogico Cesare Valgimigli
Animali 2 - Liceo Classico Psicopedagogico Cesare Valgimigli
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
2. Semplici aggregazioni di individui: i Poriferi.<br />
In questo paragrafo descriveremo il phylum dei Poriferi che comprende animali molto semplici: le spugne. Esse sono prive di<br />
veri e propri tessuti e la maggior parte delle loro cellule mantengono un alto grado di indipendenza e sono in grado di<br />
cambiare forma e funzione. Anche se le spugne sono spesso grandi animali pluricellulari, sono organismi con un grado di<br />
complessità paragonabile a quello di organismi unicellulari. Le strategie di nutrizione, l’organizzazione cellulare, gli scambi<br />
gassosi, la riproduzione e la risposta agli stimoli ambientali avvengono con modalità simili a quelle dei protozoi.<br />
Il fatto che siano animali sessili (ancorati al substrato), la completa mancanza di movimenti e la loro crescita generalmente<br />
asimmetrica, avevano convinto gli antichi naturalisti che le spugne fossero piante. La loro natura animale venne riconosciuta<br />
solo nel 1765, quando venne descritta la natura della circolazione dell’acqua all’interno del loro corpo.<br />
I Poriferi, privi di simmetria<br />
corporea, sono gli animali più<br />
semplici.<br />
Le spugne (phylum Porifera, dal latino «portatori di pori»)<br />
rappresentano uno dei primi gruppi animali evolutisi dai<br />
protisti. Le spugne sono animali sessili, che filtrano il cibo<br />
direttamente dall'acqua che attraversa il loro corpo. Il<br />
flusso d'acqua viene promosso dal battito dei flagelli di<br />
cui sono provviste le cellule che tappezzano la cavità<br />
corporea. Queste cellule, i coanociti uniche responsabili<br />
del processo di alimentazione, sono fornite di un<br />
collaretto, formato da ciglia modificate, che accoglie al<br />
suo interno il flagello. Cellule di questo tipo caratterizzano<br />
anche i protisti flagellati appartenenti all'ordine dei<br />
coanoflagellati, e ciò lascia ipotizzare un rapporto<br />
filogenetico tra i due gruppi. In seguito, cambiamenti del<br />
piano organizzativo delle spugne consentirono una più<br />
efficiente raccolta del cibo presente nell'acqua. Le spugne<br />
sono del resto così esclusive nella loro organizzazione<br />
interna, che molti specialisti, nell’ambito del regno<br />
animale, le considerano un sottoregno a parte, quello dei<br />
parazoi.<br />
I Poriferi, anche quelli di grandi dimensioni, hanno un<br />
piano organizzativo particolarmente semplice. Il corpo di<br />
una spugna consiste infatti di una libera aggregazione di<br />
cellule, organizzate attorno a un sistema di canali<br />
acquiferi. Una spugna non dispone né di una bocca, né di<br />
una vera e propria cavità digerente, né di muscoli, né di<br />
sistema nervoso; non esistono cioè organi intesi nel senso<br />
tradizionale. Una spugna è del resto un organismo così<br />
mediocremente organizzato che se le sue cellule vengono<br />
dissociate e filtrate, esse possono associarsi di nuovo a<br />
formare una nuova spugna. I Poriferi sono organismi<br />
sessili, e restano aderenti al substrato per la maggior parte<br />
del loro ciclo vitale.<br />
Essi si alimentano filtrando l'acqua e trattenendo al loro<br />
interno piccoli organismi e particelle alimentari trasportati<br />
dalla corrente (▶figura 19).<br />
Figura 19. Le spugne sono filtratori.<br />
Un porifero provvede a far circolare l’acqua contenente il cibo<br />
attraverso il proprio corpo grazie al battito di flagelli collocati<br />
sui coanociti, cellule specializzate per la nutrizione. L’acqua<br />
penetra nella spugna attraverso piccoli pori e passa entro canali<br />
acquiferi, dove i coanociti catturano le particelle alimentari.<br />
Il flusso d'acqua giunge nella cavità corporea sia attraverso<br />
pori inalanti che attraversano singole cellule epidermiche<br />
(nelle spugne più semplici) sia attraverso pori intercellulari<br />
(nelle spugne a organizzazione più complessa), e le<br />
particelle alimentari vengono trattenute dai coanociti.<br />
L'uscita dell'acqua avviene infine attraverso una o più<br />
aperture di grandi dimensioni denominate osculi.<br />
Tra il sottile piano epidermico costituito da cellule parietali<br />
dette pinacociti e quello interno dei coanociti è situato uno<br />
strato contenente amebociti, cellule capaci di movimenti<br />
ameboidi responsabili della sia pur modesta<br />
comunicazione fra cellule.
Nelle pareti corporee dei poriferi sono inoltre presenti<br />
spicole, sottili strutture rigide prodotte dalle cellule stesse,<br />
di natura silicea o calcarea. Nel caso delle spugne di<br />
grandi dimensioni, lo scheletro di spicole può risultare<br />
assai complesso(▶figura 20).<br />
Figura 20. Sezione di una spugna.<br />
Nonostante la mancanza di veri e propri tessuti, nelle spugne si<br />
notano cellule diversificate che svolgono funzioni diverse.<br />
Il piano organizzativo di una spugna differisce da quello di<br />
ogni altro organismo animale. Una spugna non è infatti<br />
organizzata in tessuti, non possiede cavità fra i diversi<br />
piani cellulari ed è priva di piani di simmetria.<br />
Dal punto di vista strutturale si distinguono tre forme che<br />
vanno da quella più semplice (ascon) a quelle via, via più<br />
complesse (sycon) e (leucon) (▶figura 21).<br />
██ pinacociti ██ coanociti<br />
Figura 21. Struttura macroscopica dei Poriferi.<br />
(A) Tipo ascon; (B) tipo sycon; (C) tipo leucon. In giallo le cellule<br />
parietali, in rosso i coanociti. 1=spongocele, 2=osculo,<br />
3=canale radiale, 4=camera flagellata, 5=poro inalante,<br />
6=canale inalante<br />
Nel tipo ascon lo spongocele non è suddiviso, nel tipo<br />
sycon, esso presenta delle concamerazioni e nel tipo<br />
leucon una forma ancora più complessa con un sistema di<br />
ulteriori ramificazioni.<br />
Le spugne si presentano in una grande varietà di<br />
dimensioni e forme. Le differenti condizioni di agitazione<br />
dell'acqua, tipiche dei diversi ambienti marini e<br />
dulcacquicoli, hanno probabilmente influenzato<br />
l'evoluzione delle caratteristiche morfologiche dei poriferi,<br />
prima fra tutte la capacità di garantirsi un continuo ricambio<br />
d'acqua. Per tale motivo, le spugne che vivono nella zona di<br />
marea o in quella sublitorale poco profonda, dove sono<br />
esposte a un intenso e costante moto ondoso, hanno<br />
forma crostosa e presentano osculi distribuiti<br />
uniformemente sulla superficie del corpo. Molti poriferi<br />
che vivono in acque calme possiedono invece un unico<br />
osculo posto alla sommità del corpo: l'acqua può così<br />
penetrare nella cavità interna attraverso i pori situati<br />
lateralmente e uscire attraverso l'osculo superiore. Le<br />
spugne che vivono in acque turbolente, invece, non devono<br />
spendere molta energia per promuovere il flusso d'acqua<br />
attraverso il loro corpo; è sufficiente che esse siano<br />
orientate perpendicolarmente rispetto alla direzione della<br />
corrente.<br />
Le spugne si riproducono sia sessualmente che<br />
asessualmente.<br />
Per quello che riguarda la riproduzione sessuale, nella<br />
maggior parte delle specie ogni individuo è ermafrodita e<br />
produce sia uova che spermi. Gli spermatozoi vengono<br />
emessi nell’acqua e le correnti li trasportano da un<br />
individuo all'altro. La fecondazione è generalmente<br />
interna. Dallo zigote si sviluppa un embrione che rimane<br />
in genere protetto dal genitore dal quale riceve<br />
nutrimento. Ad un certo punto, esso viene emesso come<br />
larva flagellata e tale larva, dopo aver trascorso una fase di<br />
vita libera, si fissa al substrato e subisce un processo di<br />
metamorfosi che la porta a trasformarsi nella forma<br />
adulta, sessile.<br />
La riproduzione asessuale avviene invece per gemmazione,<br />
o tramite il distacco di frammenti capaci di produrre nuovi<br />
individui.<br />
Alcune spugne sono interessanti per la loro capacità<br />
rigenerative, e cioè di rifabbricare le parti lese o mancanti.<br />
E’ sorprendente con quale facilità esse si riorganizzino e<br />
crescano in una massa integrata anche dopo che le loro<br />
cellule siano state dissociate e isolate.<br />
Più di 10000 specie di poriferi sono marine, mentre<br />
soltanto un piccolo numero sono d’acqua dolce.
Le classi dei poriferi.<br />
Il phylum dei Poriferi viene suddiviso in tre classi:<br />
1) Calcispongie<br />
2) Ialospongie<br />
3) Demospongie<br />
Le Calcispongie vivono a bassa profondità, sono in<br />
genere di grandezza ridotta, sono caratterizzate dalla<br />
presenza di spicole calcaree e le spicole sono sempre<br />
isolate e di varia forma: aghiformi, a tre assi o a quattro<br />
assi (▶figura 22).<br />
Figura 22. Calcispongie.<br />
Sono dette spugne calcaree e possiedono uno scheletro formato<br />
da carbonato di calcio (CaCO3). Nella foto: Leucilla nuttingi.<br />
Le Ialospongie sono spugne tipiche delle acque<br />
profonde. Sono spugne distinguibili dalle altre per la<br />
presenza di un'impalcatura scheletrica esclusivamente<br />
di spicole silicee a simmetria triassiale. Le spicole silicee<br />
possono essere isolate o formare un reticolato. La<br />
forma più comune è cilindrica con ampia cavità atriale,<br />
munita di apertura con opercolo (▶figura 23).<br />
Figura 23. Ialosponge.<br />
Sono dette spugne vitree e possiedono strutture di sostegno<br />
costituite da spicole silicee SiO2). Nella foto: Euplectella<br />
aspergillum.<br />
Le Demospongie (▶figura 24) comprendono le spugne<br />
la cui impalcatura scheletrica è costituita da materiale<br />
corneo (spongina), di spicole o di queste ultime miste a<br />
spongina. L'organizzazione strutturale è complessa, con<br />
molte e minute camere flagellate comunicanti con i pori<br />
esalanti e inalanti tramite una fitta rete di canali. Il 95%<br />
delle specie di Poriferi appartiene a questa classe che<br />
comprende anche le ben note spugne da bagno.<br />
Figura 24. Demospongie.<br />
Possiedono strutture di sostegno costituite da spicole silicee<br />
e/o fibre di una proteina detta spongina. Nella foto:<br />
Xestospongia testudinaria.<br />
Le parole:<br />
Spugna è un termine di uso comune, ma la maggior<br />
parte degli oggetti domestici che chiamiamo spugne<br />
sono formati da materiali artificiali o da cellulosa. Solo<br />
le «spugne naturali» hanno a che fare con gli omonimi<br />
animali, sono infatti gli scheletri di un gruppo di<br />
spugne.<br />
Coanocita deriva dal greco choáne, «imbuto», e kýtos,<br />
«cavità», inteso nel senso di cellula. I coanociti sono,<br />
pertanto, «cellule a forma di imbuto».<br />
Osculo deriva dal latino os, oris, «bocca», e quindi è<br />
inteso come il diminutivo, nel senso di «boccuccia».<br />
Questo nome deriva da un’errata interpretazione,<br />
perché inizialmente si pensò che fosse un’apertura dalla<br />
quale entra qualcosa, quindi una bocca.
3. L’evoluzione degli animali diblastici: Cnidari e Ctenofori.<br />
In questo paragrafo prenderemo in considerazione due phyla di animali diblastici: gli Cnidari e gli Ctenofori.<br />
Questi sono i primi animali in cui compare per la prima volta un’organizzazione di tipo tessutale, e quindi esistono veri e<br />
propri tessuti. Si tratta di animali diblastici e quindi nell’embrione si differenziano due soli strati cellulari: l’ectoderma<br />
(esterno) e l’endoderma (interno). Manca il mesoderma ma è presente uno strato gelatinoso, amorfo e non cellularizzato<br />
interposto tra ectoderma ed endoderma: la mesoglea. Fanno la loro comparsa anche le cellule nervose e quelle muscolari e<br />
una cavità digerente. La simmetria è radiale (Cnidari) oppure è bilaterale doppia (Ctenofori).<br />
Gli Cnidari o Celenterati sono<br />
animali a simmetria radiale dotati di<br />
una cavità gastrovascolare.<br />
L'innovazione sostanziale del piano organizzativo degli<br />
Cnidari è rappresentata da particolari cellule, definite<br />
cnidociti, che contengono al loro interno strutture urticanti<br />
definite nematocisti (▶figura 25). Queste ultime possono<br />
essere espulse per la cattura di prede oppure a scopo<br />
difensivo.<br />
Figura 25. Le nematocisti costituiscono armi molto potenti.<br />
I tentacoli di questa caravella portoghese sono provvisti di<br />
numerose cellule specializzate contenenti strutture urticanti, le<br />
nematocisti, che iniettano tossine nella preda.<br />
Alcuni studiosi ipotizzano che gli cnidociti derivino dalla<br />
simbiosi di Cnidari e Protisti. Tali cellule avrebbero<br />
permesso ai primi cnidari di catturare prede di grandi<br />
dimensioni e di ottenere così un rapido successo evolutivo. I<br />
primitivi Cnidari si trasformarono infatti in un numero assai<br />
elevato di specie, che durante il primo periodo Cambriano<br />
costituivano probabilmente più di metà delle specie animali<br />
esistenti. Attualmente il phylum degli Cnidari comprende<br />
circa 10000 specie, per la maggior parte marine.<br />
Il corpo degli Cnidari è caratterizzato dalla presenza di<br />
tentacoli, sui quali di regola sono distribuite gli cnidociti. Vi<br />
sono inoltre cellule epiteliali provviste di fibre muscolari<br />
che consentono a questi animali di muoversi, ed è presente<br />
un primitivo sistema nervoso a rete diffusa costituito da due<br />
reti nervose che provvedono alla coordinazione delle varie<br />
attività vitali. In alcuni casi, sono presenti fotorecettori<br />
(per la percezione visiva) e meccanorecettori statici (per<br />
l’equilibrio).<br />
Gli Cnidari sono provvisti di un'apertura boccale che<br />
immette in una cavità digerente a fondo cieco, definita<br />
cavità gastrovascolare (o celenteron). Esiste dunque<br />
un'unica via di comunicazione con l'esterno, che funge sia<br />
da cavità boccale che anale. Tale apparato digerente,<br />
unitamente alla presenza di tentacoli armati di cnidociti<br />
attorno alla bocca, consente agli Cnidari di catturare e<br />
inghiottire una gamma di prede assai più ampia di quella<br />
disponibile per le spugne. Dopo che una preda è stata<br />
catturata, essa viene infatti avviata alla bocca tramite i<br />
tentacoli; gli cnidociti servono per paralizzare le prede e<br />
trattenerle. Tali cellule sono fra l'altro responsabili<br />
dell'azione urticante, talora intensa, che certe meduse o altri<br />
cnidari possono causare anche all'uomo. In casi limite,<br />
rappresentati dalla cosiddetta «vespa di mare» (genere<br />
Chironex) o dalla «caravella portoghese» (Physalia), gli effetti<br />
possono essere addirittura letali.<br />
Variazioni di forma negli Cnidari.<br />
La maggior parte degli Cnidari subisce una variazione della<br />
forma del corpo e del tipo di riproduzione nel corso del<br />
proprio ciclo vitale (▶figura 26).
Una di queste forme è rappresentata dal polipo, individuo<br />
caratterizzato da un corpo cilindrico, con apertura boccale<br />
e tentacoli situati all'estremità opposta rispetto a quella che<br />
aderisce al substrato. Un animale che vive attaccato a un<br />
substrato e non è in grado di muoversi si definisce sessile.<br />
La forma polipoide rappresenta lo stadio asessuale degli<br />
Cnidari, che per gemmazione da origine ad altri individui.<br />
La medusa, cioè la forma medusoide, corrisponde invece<br />
alla fase sessuale e liberamente natante e mostra il tipico<br />
aspetto a ombrello. Bocca e tentacoli sono in questo caso<br />
situati nella faccia inferiore, rivolta verso il substrato. Le<br />
forme medusoidi degli Cnidari producono uova e spermi,<br />
che vengono poi liberati nell'acqua. Quando una cellula<br />
uovo viene fecondata, essa produce una larva natante<br />
definita planula. In seguito, la planula si fissa a un substrato<br />
e si trasforma in un polipo.<br />
Figura 26. Alternanza di generazione negli Cnidari.<br />
Il piano organizzativo degli Cnidari è caratterizzato da<br />
simmetria raggiata e da due soli foglietti embrionali. Un<br />
foglietto intermedio si forma talora dall'ectoderma, ma in<br />
nessun caso esso produce complessi organi interni, come<br />
invece accade nel caso degli organismi triblastici. Sebbene<br />
polipo e medusa siano due stadi profondamente diversi per<br />
aspetto, essi corrispondono a uno stesso piano organizzativo.<br />
Una medusa è infatti un polipo privo di parte basale, e<br />
d'altra parte un polipo può essere considerato una medusa<br />
provvista di peduncolo per ancorarsi al substrato.<br />
La maggior parte delle differenze rilevabili tra polipo e<br />
medusa sono dovute al differente sviluppo della mesoglea,<br />
lo strato intermedio del corpo. La mesoglea delle forme<br />
polipoidi è di regola sottile, mentre quella delle meduse è<br />
notevolmente sviluppata.<br />
Il phylum degli Cnidari viene suddiviso in tre classi:<br />
Idrozoi, Scifozoi e Antozoi.<br />
In molti Cnidari (ma non in tutti) sono presenti sia il polipo, che rappresenta la forma sessile e asessuata, sia la medusa che rappresenta la<br />
forma natante e sessuata. Quest’alternanza di generazione è molto diversa da quella che si verifica nei protisti, nei funghi e nelle piante perché<br />
negli Cnidari entrambi gli individui sono dotati di un corredo cromosomico diploide (2n).
Gli Idrozoi sono Cnidari in cui<br />
prevale la forma polipoide.<br />
Nella classe degli idrozoi, unico gruppo del phylum<br />
comprendente specie dulcacquicole, la forma polipoide di<br />
regola prevale nel ciclo vitale degli individui. Soltanto un<br />
numero esiguo di specie risulta rappresentata da polipi<br />
solitari, come Hydra, una specie comune negli stagni e<br />
nelle pozze d’acqua (▶figura 27).<br />
Figura 27. Hydra viridis, un polipo solitario.<br />
Questo polipetto lungo pochi millimetri e diffuso nelle acque<br />
dolci di tutto il mondo è un organismo utilizzato in molti studi<br />
sulla rigenerazione. Esso, è infatti in grado di rigenerare<br />
velocemente le parti perdute.<br />
Nella maggior parte delle specie di Idrozoi, i polipi sono<br />
invece coloniali. Da una singola planula derivano infatti<br />
numerosi polipi che si organizzano a formare una colonia<br />
e condividono la stessa cavità gastrovascolare (▶figura 28).<br />
Figura 28. Obelia, una specie coloniale.<br />
Questa specie di Idrozoi è coloniale e presenta individui<br />
diversificati.<br />
Fra gli individui di una colonia esistono spesso marcate<br />
differenze morfofunzionali. Alcuni individui sono provvisti di<br />
tentacoli con nematocisti e sono in grado di procurare cibo<br />
per tutti i componenti della colonia. Altri individui sono<br />
invece privi di tentacoli, ma specializzati nel produrre le<br />
forme medusoidi del ciclo. Altri individui ancora<br />
possiedono particolari appendici digitiformi e sono<br />
devoluti alla difesa della colonia. Tutti gli individui, se pur<br />
diversi, derivano comunque da un singolo polipo<br />
fondatore originatosi da una planula.<br />
I sifonofori (▶figura 29) sono Idrozoi planctonici nei quali la<br />
forma polipoide e quella medusoide coesistono, dando<br />
spesso origine a complesse colonie polimorfe. Alcuni<br />
individui medusoidi sono ad esempio modificati per<br />
contenere gas e favorire il galleggiamento, altri per<br />
promuovere il movimento a propulsione della colonia, altri<br />
ancora per assicurarne la difesa . Vi sono infine individui<br />
specializzati per la funzione nutritiva e per quella<br />
riproduttiva. Tutti i sifonofori sono carnivori, si nutrono<br />
cioè di altri organismi animali che catturano mediante la<br />
scarica delle loro nematocisti ad azione urticante.<br />
Figura 29. La caravella portoghese.<br />
La Physalia physalis, il cui nome comune è caravella portoghese,<br />
è un sifonoforo. Viene spesso confusa con una medusa,<br />
sebbene sia una colonia costituita da 4 diversi tipi<br />
di individui reciprocamente dipendenti per la sopravvivenza. Il<br />
contatto con i suoi tentacoli può provocare la paralisi e persino<br />
l’arresto cardiaco in un uomo.<br />
Turritopsis nutricula, comunemente nota come medusa<br />
immortale è un Idrozoo in grado di tornare allo stato<br />
di polipo dopo aver raggiunto la fase di medusa adulta.<br />
A differenza delle altre specie di meduse che hanno<br />
una durata di vita relativamente fissa, questa medusa è<br />
l’unica ad aver sviluppato la capacità di ritornare ad uno<br />
stato di polipo, attraverso un processo di<br />
transdifferenziazione mediante il quale, alcune cellule<br />
subiscono una sorta di regressione ad una<br />
fase totipotente, dalla quale poi possono moltiplicarsi e<br />
differenziarsi in cellule diverse. Questa capacità di<br />
invertire il ciclo vitale (in risposta a condizioni avverse)<br />
è probabilmente unica nel regno animale, e consente<br />
alla medusa di aggirare, o perlomeno ritardare, la morte<br />
rendendo T. nutricula potenzialmente immortale.
Gli Scifozoi sono cnidari in cui<br />
prevale la forma medusoide.<br />
Tutte le varie centinaia di specie appartenenti alla classe<br />
degli Scifozoi sono marine e alcune annoverano individui<br />
di dimensioni superiori ai cinquanta centimetri. Lo strato<br />
di mesoglea risulta in questo caso particolarmente spesso<br />
e compatto e conferisce alle meduse il loro tipico aspetto.<br />
Esse hanno complessivamente la forma di una coppa<br />
capovolta (ombrella), al di sotto della quale sono situati i<br />
tentacoli provvisti di nematocisti. Il movimento è reso<br />
possibile dalla contrazione delle fibre muscolari disposte ai<br />
bordi dell'ombrella, le quali favoriscono l'espulsione<br />
dell'acqua dalla cavità gastrovascolare. Quando i muscoli<br />
si rilasciano, l'ombrella torna a espandersi e a riempirsi di<br />
acqua. Il cibo catturato mediante i tentacoli viene avviato<br />
alla bocca, e da qui nella cavità digerente. Quest'ultima è<br />
suddivisa in quattro camere gastriche, al cui interno<br />
avviene la digestione a opera di particolari enzimi. Alcune<br />
meduse appartenenti alla classe degli Scifozoi sono molto<br />
comuni nei nostri mari (▶figure 30, 31, 32, 33).<br />
Figura 30. La medusa quadrifoglio.<br />
Aurelia aurita è una delle meduse più note e diffuse. L’ ombrello<br />
è diafano e trasparente e presenta 4 strutture circolari,<br />
le gonadi, che formano una struttura a forma di quadrifoglio.<br />
Possiede corti e sottili tentacoli urticanti e 4 braccia più spesse<br />
che dipartono dal centro dell'ombrello.<br />
Figura 31. La medusa luminosa.<br />
Pelagia noctiluca presenta il fenomeno della bioluminescenza ed<br />
è comune nel Mar Mediterraneo e nell'Oceano Atlantico. Se<br />
viene sfiorata, provoca dolorose irritazioni. È pelagica, ma nel<br />
periodo autunnale e primaverile si avvicina alla costa.<br />
Figura 32. Polmone di mare.<br />
Rhizostoma pulmo, il polmone di mare.<br />
Figura 33. Cassiopea.<br />
Cotylorhiza tubercolata detta Cassiopea.<br />
Il ciclo biologico degli Scifozoi è caratterizzato dalla forma<br />
medusoide anziché da quella polipoide. Gli organi sessuali<br />
(gonadi) si sviluppano nei tessuti gastrodermali in<br />
prossimità delle camere gastriche e ogni individuo<br />
medusoide produce sia uova che spermi che vengono poi<br />
liberati in mare aperto. Dalle uova fecondate si forma una<br />
planula ciliata, che si fissa a un substrato e si trasforma in un<br />
piccolo polipo. L'individuo polipoide inizia ad alimentarsi e ad<br />
accrescersi e può formare altri polipi per gemmazione. Dopo<br />
un certo periodo di crescita, il polipo comincia a produrre<br />
piccoli individui medusoidi mediante un processo ripetuto<br />
di divisione trasversa del corpo di forma colonnare, definito<br />
strobilazione. I nuovi individui così formatisi si accrescono e<br />
si trasformano in meduse adulte. In definitiva, il polipo che<br />
si origina da un singolo uovo fecondato è in grado di<br />
produrre numerosi individui medusoidi identici<br />
geneticamente, che in seguito effettueranno il processo di<br />
riproduzione sessuale.<br />
Tra gli Scifozoi vengono spesso incluse anche le cubomeduse<br />
le cui meduse sono dotate di ombrello cuboidale e 4<br />
tentacoli. Per la maggior parte sono meduse tropicali di<br />
piccole dimensioni, ma molto velenose come le cosiddette<br />
“vespe di mare”.
Gli Antozoi sono cnidari in cui<br />
manca la forma medusoide.<br />
Le circa 6000 specie di anemoni di mare e coralli<br />
costituiscono la classe degli Antozoi. Gli appartenenti a<br />
questa classe differiscono da tutti gli altri Cnidari per la<br />
totale assenza dello stadio medusoide dal loro ciclo<br />
biologico, e per il fatto che i gameti (uova e spermi)<br />
vengono prodotti da individui polipoidi. Dalle uova<br />
fecondate si sviluppa una planula che si trasforma<br />
direttamente in un polipo. Molte specie di Antozoi possono<br />
inoltre riprodursi asessualmente per gemmazione o per<br />
scissione. Al pari di tutti gli altri Cnidari, anche gli Antozoi<br />
sono carnivori, e catturano le prede mediante la scarica<br />
delle nematocisti situate sui tentacoli. La cavità digerente<br />
degli Antozoi è invece più complessa di quella degli altri<br />
Cnidari e risulta suddivisa da numerosi setti (mesenteri) in<br />
varie concamerazioni che ne aumentano la superficie. La<br />
maggiore presenza di enzimi digestivi aumenta così<br />
l'assorbimento delle sostanze nutritive.<br />
Gli anemoni di mare (▶figure 34, 35) sono Antozoi<br />
solitari privi di strutture protettive rigide, diffusi sia nei<br />
mari freddi che caldi. La maggior parte delle specie sono<br />
sessili, vivono cioè aderenti a un substrato, ma alcune sono<br />
capaci di piccoli spostamenti dopo che la loro porzione<br />
basale (disco pedale) si è staccata dal substrato. Altre<br />
specie, infine, possono compiere brevi spostamenti<br />
nuotando.<br />
Figura 34. Antozoi solitari.<br />
Actinia equina, (pomodoro di mare).<br />
Figura 35. Antozoi solitari.<br />
Anemonia sulcata (capelli di venere).<br />
I coralli (▶figure 36, 37) sono di regola organismi sessili e<br />
coloniali. Ogni polipo della colonia secerne una matrice<br />
organica sulla quale si deposita in molti casi uno scheletro di<br />
carbonato di calcio. La struttura calcarea delle madrepore<br />
ha una forma peculiare per ogni specie, e conferisce alle<br />
colonie forme diversissime, come del resto indicano le<br />
denominazioni attribuite alle varie specie: madrepore a<br />
corna d'alce, a cervello, a ventaglio, a canne d'organo e<br />
altre ancora. Man mano che una colonia cresce, gli individui<br />
più vecchi muoiono e sui loro scheletri calcarei crescono i<br />
nuovi individui. Le barriere coralline formate dallo scheletro<br />
calcareo degli Antozoi coloniali si sviluppano soprattutto in<br />
condizioni di acque limpide e calde. Esse sono<br />
particolarmente abbondanti nell'oceano Indo-Pacifico, dove<br />
formano strutture talora imponenti a forma di anello (atolli)<br />
o nastro (barriere) (▶figure 38 e 39).<br />
Figura 36 Antozoi coloniali.<br />
Corallium rubrum (corallo rosso), una specie coloniale.<br />
Figura 37. Antozoi coloniali.<br />
Molte specie di Antozoi costituiscono le barriere coralline.<br />
La Grande Barriera Corallina che fiancheggia le coste nord-<br />
orientali dell'Australia è lunga oltre 2000 km e larga più di<br />
150 km. Una barriera corallina lunga centinaia di miglia è<br />
inoltre presente nel Mar Rosso ed è stato stimato che essa<br />
contenga più materiale calcareo di quello che forma gli<br />
edifici delle maggiori città del Nord America.
Abbiamo detto che le barriere coralline si sviluppano nelle<br />
acque calde e limpide dei mari tropicali, notoriamente<br />
povere di sostanze nutritive. Per lungo tempo gli scienziati<br />
si sono dunque chiesti come i polipi di tali colonie<br />
riuscissero a catturare zooplancton sufficiente per crescere<br />
con tanta rapidità. La risposta è venuta dalla scoperta che<br />
nei tessuti dei coralli sono presenti organismi simbionti<br />
rappresentati da dinoflagellati altamente specializzati. Si<br />
tratta di organismi fotosintetici, che forniscono ai loro<br />
ospiti carboidrati e favoriscono la deposizione del<br />
carbonato di calcio per lo scheletro delle colonie.<br />
L'esistenza di questa simbiosi tra dinoflagellati e<br />
madreporari spiega fra l'altro perché le formazioni coralline<br />
siano presenti unicamente a una profondità limitata, dove<br />
arriva abbondante la radiazione solare. In queste<br />
condizioni i dinoflagellati possono infatti effettuare la<br />
fotosintesi rimanendo protetti dai predatori all'interno<br />
dello scheletro dei coralli.<br />
Figura 38. Barriere coralline.<br />
Distribuzione geografica delle barriere coralline.<br />
Figura 39. Un atollo.<br />
Un atollo (isola corallina).<br />
Le ragioni del successo evolutivo<br />
degli Cnidari.<br />
Gli Cnidari divennero gli organismi marini predominanti<br />
durante il Cambriano, 600 milioni di anni fa, e tutt'oggi essi<br />
rappresentano un'importante componente delle comunità<br />
marine. La ragione del loro successo evolutivo va<br />
essenzialmente attribuita al peculiare piano organizzativo,<br />
che associa un tasso metabolico poco elevato con la<br />
capacità di catturare prede relativamente grandi. La massa<br />
corporea delle meduse e di molti polipi è essenzialmente<br />
dovuta al grande sviluppo della mesoglea. Da ciò deriva<br />
che anche Cnidari di grandi dimensioni come gli anemoni<br />
di mare necessitano di modeste quantità di sostanze<br />
nutritive, e possono digiunare per settimane o addirittura<br />
mesi. La presenza delle nematocisti consente inoltre agli<br />
cnidari di catturare anche prede notevolmente più attive e<br />
strutturalmente più complesse rispetto a loro stessi. Altri<br />
Cnidari, come ad esempio le madrepore e i coralli, possono<br />
inoltre nutrirsi di microrganismi e sopravvivere anche in<br />
acque povere di plancton grazie alla simbiosi con i<br />
dinoflagellati. Tutte queste caratteristiche hanno in<br />
definitiva consentito agli cnidari di colonizzare anche<br />
habitat dove le prede non sono sufficienti ad assicurare la<br />
sopravvivenza di organismi con maggiori esigenze<br />
metaboliche.<br />
Le parole:<br />
Cnidàrio deriva dal greco kníde, «ortica», il che rende<br />
bene l’idea dell’azione urticante delle nematocisti.<br />
Il suffisso -zoo (pl. zoi) deriva dal greco zôion, «essere<br />
vivente», inteso come «animale».<br />
Per gli cnidari si trova associato a:<br />
hýdor, «acqua», con allusione al fatto che<br />
gli idrozoi sono fatti per oltre il 90% di acqua;<br />
skýphos, «tazza», per la forma degli scifozoi;<br />
ánthos, «fiore», perché gli antozoi sembrano più piante<br />
fiorite che animali.
Gli Ctenofori sono animali diblastici<br />
dal corpo gelatinoso.<br />
Gli Ctenofori sono un phylum di organismi diblastici,<br />
marini, caratterizzati da un corpo gelatinoso e<br />
trasparente provvisto di file di ciglia disposte a pettine<br />
(ctenofori = portatori di pettini). Il piano organizzativo di<br />
ctenofori e cnidari può risultare in apparenza simile, ma<br />
tra i due gruppi esistono in realtà sostanziali differenze.<br />
Come gli Cnidari, essi possiedono due strati cellulari<br />
separati da una spessa mesoglea di consistenza<br />
gelatinosa e spesso tentacoli per la cattura delle prede.<br />
Mentre gli Cnidari hanno però molti piani di simmetria che<br />
passano per l’asse dell’animale (simmetria radiale), gli<br />
Ctenofori ne hanno solo due (simmetria biradiale).<br />
Mentre negli Cnidari esiste sia la forma sessile (polipo)<br />
che quella natante (medusa), negli Ctenofori esiste solo la<br />
forma natante.<br />
Gli Ctenofori hanno inoltre una cavità digerente che si<br />
apre all’esterno mediante due pori anali situati dalla<br />
parte opposta alla bocca; l'alimento si muove dunque in<br />
una precisa direzione attraverso l'intestino.<br />
Gli Ctenofori possiedono otto file di ciglia, definite pettini,<br />
responsabili del movimento degli animali.<br />
I tentacoli degli Ctenofori sono solidi e privi di nematocisti,<br />
ma sono coperti da colloblasti, cellule dotate di una<br />
superficie collosa che aderisce a piccole particelle che<br />
servono da nutrimento. I tentacoli possono inoltre essere<br />
retratti e portati alla bocca. In alcune specie, l'intera<br />
superficie del corpo è ricoperta di muco con proprietà<br />
adesive per la cattura delle prede. Tutte le oltre 100<br />
specie di Ctenofori sono infatti organismi carnivori.<br />
A differenza degli Cnidari, gli Ctenofori non possono<br />
catturare prede di dimensioni uguali o superiori a loro<br />
stessi. I loro tentacoli vischiosi possono tuttavia raccogliere<br />
grandi quantità di piccoli organismi planctonici. Gli<br />
Ctenofori hanno un tasso metabolico relativamente basso,<br />
dal momento che, al pari degli cnidari, sono<br />
essenzialmente formati da mesoglea inerte. Come gli<br />
Cnidari, anche gli Ctenofori possono dunque svolgere con<br />
successo il ruolo di predatori in mare aperto, dove la<br />
presenza di prede è spesso assai scarsa.<br />
Il ciclo vitale degli Ctenofori è semplice. Dalle gonadi<br />
localizzate nella parete della cavità gastrovascolare i gameti<br />
vengono liberati all'interno della cavità stessa e in seguito<br />
emessi all'esterno attraverso la bocca o i pori anali. Il<br />
processo di fecondazione avviene dunque in mare aperto.<br />
In quasi tutte le specie, dalle uova fecondate si sviluppa<br />
direttamente un organismo simile per aspetto all'adulto<br />
(sviluppo diretto); stadio che tuttavia verrà raggiunto<br />
gradualmente in seguito al progressivo accrescimento<br />
dell'individuo.<br />
Alcuni Ctenofori sono rappresentati nelle (▶figure 40, 41<br />
e 42).<br />
Figura 40. Ctenofori.<br />
Pleurobrachia, uno ctenoforo dotato di tentacoli.<br />
Figura 41. Ctenofori.<br />
Beroe, uno ctenoforo privo di tentacoli e dal corpo globoso.<br />
Figura 42. Ctenofori.<br />
Cestum veneris , uno ctenoforo, privo di tentacoli e dal corpo<br />
schiacciato che gli fa assumere l’aspetto di una cintura.<br />
Le parole:<br />
Ctenoforo deriva dal greco ktenís, «pettine», e foro,<br />
«porto», con il significato di portatori di pettini.