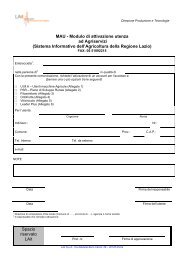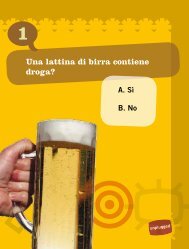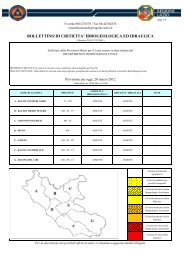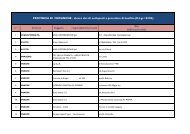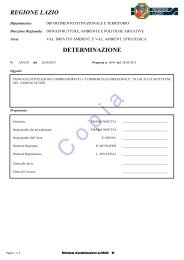Controllo biologico della Metcalfa pruinosa - Regione Lazio
Controllo biologico della Metcalfa pruinosa - Regione Lazio
Controllo biologico della Metcalfa pruinosa - Regione Lazio
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
REGIONE LAZIO PHYTOLAB S.r.l.<br />
Programma triennale di ricerca agricola, agroambientale, agroindustriale e<br />
agroalimentare del <strong>Lazio</strong> (PRAL)<br />
CONTROLLO BIOLOGICO DELLA <strong>Metcalfa</strong> <strong>pruinosa</strong> CON<br />
L’IMPIEGO DEL PARASSITA Neodryinus typhlocybae E<br />
PROVE CON PRODOTTI A BASSO IMPATTO<br />
AMBIENTALE SU ACTINIDIA NELL’AGROPONTINO<br />
RISULTATI II a ANNUALITA’<br />
RAPPORTO FINALE<br />
PROGETTO N. 2003/123<br />
STRATEGIE DI DIFESA, CON PRODOTTI A BASSO IMPATTO<br />
AMBIENTALE, PER LA SALVAGUARDIA DELLE<br />
COLTIVAZIONI DI ACTINIDIA NEL LAZIO<br />
DALLE INFESTAZIONI DI METCALFA PRUINOSA<br />
1
INTRODUZIONE<br />
La <strong>Metcalfa</strong> <strong>pruinosa</strong> (Omottero Rincote – Famiglia : Flatidae), è una cicalina dal<br />
comportamento estremamente polifago, che suscita allarme tra gli imprenditori agricoli<br />
laziali, in particolare sulle coltivazioni di Actinidia (Actinidia deliciosa var. deliziosa,<br />
famiglia Actinidiaceae ) dell’Agropontino.<br />
Nel contesto <strong>della</strong> produzione di Actinidia, l’ Italia attualmente occupa il primo posto a<br />
livello mondiale. Nel nostro Paese, e il <strong>Lazio</strong> é la regione che detiene, a livello nazionale, il<br />
primato sia in termini di superficie attualmente coltivata ad Actinidia ( circa 8.000 ettari),<br />
che in termini di produttività (1.400.000 q.li).<br />
In Italia, l’introduzione dell’Actinidia risale agli inizi del 1900, ma i primi impianti veri e<br />
propri sono apparsi tra il 1971 ed il 1974 in Emilia Romagna prima e successivamente<br />
nelle altre zone produttive italiane (Veneto, Piemonte, Trentino, Friuli, Marche e <strong>Lazio</strong>).<br />
In Italia l’introduzione dell’Actinidia ha avuto un rapido ed intenso sviluppo. Basti pensare<br />
che nell’arco di tredici anni (1978 – 1991) la superficie coltivata ad Actinidia è passata da<br />
700 a 19.000 ettari, con una produzione di oltre 2.550.000 di q.li.*<br />
* Fonte : Dati Belrose Kiwi Review - 2003 Edition<br />
La <strong>Metcalfa</strong> <strong>pruinosa</strong> (Say), originaria dal Nord America, è stato segnalata per la prima<br />
volta in Italia nei dintorni di Treviso (Zangheri e Donadini, 1980) nel 1979, e si ritiene che<br />
sia stato introdotto nel nostro Paese a seguito dell’importazione di tronchi d’albero di<br />
provenienza Nord Americana, infestati di uova di questo insetto.<br />
A distanza di 28 anni dalla prima segnalazione, ossia in un arco breve di tempo, la<br />
<strong>Metcalfa</strong> <strong>pruinosa</strong> si é diffusa su tutto il territorio nazionale, da Nord a Sud, isole comprese.<br />
Risulta, inoltre, presente nella Francia meridionale e Corsica, in Svizzera, Slovenia, Croazia<br />
e Austria (Girolami et al., 2002).<br />
Fig. 1 – Attuale distribuzione <strong>della</strong> <strong>Metcalfa</strong> <strong>pruinosa</strong> in Europa<br />
2
La rapida diffusione <strong>della</strong> <strong>Metcalfa</strong> in In Italia ed in Europa é molto probabilmente dovuta:<br />
alla scarsa presenza di antagonisti naturali e quindi scarsa pressione biotica. Nei<br />
nostri ambienti, infatti, la M. <strong>pruinosa</strong> si sviluppa quasi indisturbata e solo in rare<br />
circostanze é stata osservata la sporadica presenza di larve di Crisopidi, la cui attività<br />
predatoria é tuttavia di trascurabile interesse. Sono stati, inoltre segnalati parassiti di<br />
uova di questo flatide, identificati come Centrodora livens (Walzer) (Hymenoptera :<br />
Aphelinidae) (Raspi e Canovai – Informatore Fitopatologico 2003, nn. 7 – 8). Nei nostri<br />
ambienti spesso si assiste ad improvvise ondate di grosse popolazioni che nel volgere di<br />
pochi anni si espandono su tutta la vegetazione disponibile, con avanzamenti di decine di<br />
chilometri all’anno.<br />
In Nord America questo insetto non è dannoso, in quanto è tenuto sotto controllo da<br />
diversi nemici naturali e quindi sottoposto ad un’elevata pressione biotica.<br />
alla sua capacità di attaccare numerose specie vegetali (erbacee, arbustive e arboree)<br />
di interesse agrario, ornamentale e forestale, nonché diverse specie arbustive ed erbacee<br />
spontanee. Questo insetto è stato segnalato su oltre 330 specie appartenenti a 78 famiglie<br />
diverse evidenziando senza mezzi termini l’elevato grado di polifagia.<br />
Per quanto riguarda il ciclo <strong>biologico</strong>, la M. <strong>pruinosa</strong> compie una sola generazione<br />
annuale e sverna allo stadio di uovo. Dalle uova, che schiudono in modo scalare, da metà<br />
maggio a fine giugno, emergono le neanidi, le quali migrano velocemente sulla pagina<br />
inferiore delle foglie, dove iniziano a nutrirsi a carico delle nervature delle foglie delle<br />
piante ospiti, rivestendosi nel contempo di formazioni cerose. Le tre età neanidali, se non<br />
vengono disturbate, sono poco mobili e rimangono fissate alla nervatura delle foglie. Lo<br />
spostamento avviene in corrispondenza del cambio <strong>della</strong> muta, fino al completamento degli<br />
stadi neanidali. A partire dal quarto stadio (I° stadio ninfale), si assiste allo spostamento sui<br />
rametti, per poi ritornare sulla pagina inferiore delle foglie in corrispondenza del quinto<br />
stadio (II° stadio ninfale), dove si completa lo sviluppo, con la formazione dell’adulto. Dalla<br />
comparsa delle neanidi di prima età fino alla comparsa degli adulti occorrono circa 45/50 gg<br />
I primi adulti compaiono a partire dalla seconda decade di Giugno, raggiungendo l’apice<br />
verso la metà di Luglio, con una riduzione <strong>della</strong> densità a partire dal mese di Agosto. Gli<br />
adulti di <strong>Metcalfa</strong> si accoppiano tra Agosto e Settembre e le femmine, dopo pochi giorni<br />
dalla copula, iniziano a deporre le uova e il periodo di ovideposizione si protrae per un<br />
periodo di 10 – 15 gg, durante il quale ogni femmina può deporre fino a 90 uova (Santini e<br />
Lucchi, 2002). Le uova, deposte nei mesi di Settembre e Ottobre, nelle screpolature e fra le<br />
perule delle gemme delle diverse piante ospiti, rimangono in questa fase per tutto l’inverno<br />
schiudendo nella primavera dell’anno successivo.<br />
Per quanto riguarda i danni causati dalla <strong>Metcalfa</strong>, questo insetto risulta dannoso sia in<br />
agricoltura che nel settore del verde pubblico. In particolare, oltre all’Actinidia, la <strong>Metcalfa</strong><br />
attacca altre colture industriali di importanza economica, quali la vite, melo, pero, albicocco,<br />
susino, kaki, olivo, agrumi e girasole.<br />
I danni causati da parte <strong>della</strong> <strong>Metcalfa</strong> sono costituiti da sottrazione di linfa e imbrattamento<br />
degli organi vegetali con le abbondanti secrezioni cerose prodotte dagli stadi giovanili e<br />
l’emissione di melata escrementizia su cui si ha successivamente sviluppo di fumaggini.<br />
La presenza di fumaggini sulla parte vegetativa riduce l’attività fotosintetica , causando<br />
filloptosi anticipate, mentre sui frutti causa un ritardo nei riguardi <strong>della</strong> maturazione.<br />
I frutti (Actinidia, Pesche, Mele, Uva etc.) attaccati da <strong>Metcalfa</strong> risultano affetti da vistose<br />
macchie di fumaggini, sviluppatesi in presenza di melata prodotta da questo insetto; ciò<br />
3
provoca un deprezzamento commerciale delle produzioni con conseguenti riflessi negativi<br />
sotto l’aspetto economico per gli operatori dei diversi settori di produzione.<br />
Fig.. 2 – Attacco di M. <strong>pruinosa</strong> su Actinidia Fig. 3 – Frutti di kiwi macchiati di melata e successivo<br />
sviluppo di fumaggine<br />
Fig.. 2A – Attacco di M. <strong>pruinosa</strong> su Olivo Fig.. 3A – Attacco di M. <strong>pruinosa</strong> su Vite<br />
4
Un aspetto di grande interesse, in relazione alla preoccupante diffusione <strong>della</strong> M. <strong>pruinosa</strong><br />
in Italia, é rappresentato dal ruolo che potrebbe assumere questo flatide nel veicolare virus<br />
e fitoplasmi alle piante coltivate.<br />
Per quanto attiene i virus, prove di laboratorio hanno dimostrato che ninfe e adulti di M.<br />
<strong>pruinosa</strong> si possono infettare con i seguenti agenti virali: Grapevine Fanleaf Virus, GFLV;<br />
Grapevine Leafroll-associated Virus 3, GLRaV-3, ma nessuno dei due virus é stato<br />
trasmesso sperimentalmente dalle ninfe e adulti del flatide alle viti sottoposte alla prova.<br />
Per quanto riguarda i fitoplasmi, adulti di M. <strong>pruinosa</strong> catturati in vigneti del Veneto, con<br />
elevata percentuale di viti affette da giallumi, sono risultati positivi per:<br />
Chrysanthemum yellows (CY, gruppo 16Sr – IB)<br />
Clover phyllody (Cph, gruppo 16Sr – IC)<br />
Flavescenza dorata (EY, gruppo 16Sr – V)<br />
Stolbur (STOL, gruppo 16Sr – XIIA).<br />
Anche se gli adulti di M. <strong>pruinosa</strong> sono risultati infetti, tutte le prove di trasmissione fin’ora<br />
condotte su vite e altre piante indicatrici hanno fornito esito negativo.<br />
Studi sperimentali (Guadagnini et al., 2000) hanno evidenziato la possibilità che adulti di<br />
<strong>Metcalfa</strong>, prelevati da viti sintomatiche, possano trasmettere un fitoplasma, identificato<br />
come 16 Sr-IC, a soggetti sani ottenuti per micropropagazione.<br />
Fig.. 4 – Adulti di <strong>Metcalfa</strong> <strong>pruinosa</strong> su Robinia Fig. 5 – Uovo di <strong>Metcalfa</strong> <strong>pruinosa</strong><br />
Fig. 6 - Adulti di <strong>Metcalfa</strong> <strong>pruinosa</strong> in accoppiamento (Foto A. Lucchi)<br />
5
PRIMA ANNUALITA’ 2003<br />
Nel corso del 2003, da maggio a settembre, il progetto in questione è stato sviluppato nelle<br />
seguenti direzioni:<br />
La costituzione mappa territoriale sullo stato di diffusione <strong>della</strong> <strong>Metcalfa</strong> <strong>pruinosa</strong> nel<br />
<strong>Lazio</strong> su piante coltivate e spontanee con la segnalazione delle diverse aree infestate dal<br />
flatide.<br />
Biologia <strong>della</strong> <strong>Metcalfa</strong> <strong>pruinosa</strong> nell’Agropontino.<br />
<strong>Controllo</strong> <strong>biologico</strong> <strong>della</strong> <strong>Metcalfa</strong> <strong>pruinosa</strong> sulla vegetazione spontanea attraverso<br />
l’impiego del driinide, Neodryinus typhlocybae.<br />
Prove con prodotti a basso impatto ambientale per la riduzione delle popolazioni di<br />
<strong>Metcalfa</strong>.<br />
Costituzione mappa territoriale sullo stato di diffusione <strong>della</strong> <strong>Metcalfa</strong> <strong>pruinosa</strong> . Questi<br />
dati sono stati raccolti sia da personale partecipante al progetto (Tabella n. 1), sia attraverso<br />
dati ricevuti da aziende agricole e vivai (Tabella n. 2).<br />
Tabella n. 1 - Diffusione <strong>della</strong> <strong>Metcalfa</strong> <strong>pruinosa</strong> nel <strong>Lazio</strong> e piante ospiti<br />
Dati raccolti dal personale partecipante al progetto<br />
Periodo raccolta dati : maggio/giugno 2003<br />
Località Piante ospiti Località Piante ospiti<br />
Borgo Piave (LT) Robinia Velletri Rovo e Vite<br />
Borgo Podgora (LT) Rovo, Olmo e Sambuco Cisterna Actinidia, Rovo e<br />
Robinia<br />
Borgo Flora (LT) Actinidia e Rovo Borgo Piave (LT) Actinidia, Rovo e Olmo<br />
Le Castella - Cisterna Robinia, Rovo e Olmo Borgo Grappa (LT) Ortica, Silene, Rumex<br />
Borgo Carso (LT) Olmo, Actinidia e Ortica Borgo S. Donato (LT) Rovo<br />
Via Artemide – Borgo Flora Actinidia e Olmo Bolsena (VT) Actinidia, Rovo e<br />
(LT)<br />
Platano<br />
Doganella di Ninfa Rovo e Robinia Madonna <strong>della</strong> Salute Platano, Olmo e Ortica<br />
Borgo Carso (LT) Olmo, Actinidia e Ortica Gradoli (VT) Actinidia, Rovo e Olmo<br />
Tor tre Ponti (LT) Olmo e Rovo Borgo Isonzo (LT) Rovo e Olmo<br />
Borgo Faiti (LT) Actinidia e Olmo Canale Rio Martino Rovo<br />
Prato Cesarino (LT) Robinia e Olmo Acciarella - Nettuno Robinia e Rovo<br />
Campoleone Actinidia, Olmo e Rovo Tre Cancelli - Nettuno Robinia e Rovo<br />
Borgo Sabotino (LT) Actinidia e Olmo Borgo S. Maria (LT) Robinia<br />
Borgo Bainsizza (LT) Rovo, Olmo e Ortica Via Apriliana Rovo e Olmo<br />
Cisterna (LT) Actinidia, Rovo, Olmo e Via di Fossignano (S.S Actinidia, Rovo e Olmo<br />
Ortica<br />
Sabaudia (LT) Robinia Isola Bella - Cisterna Rovo, Olmo e Robinia<br />
Borgo Isonzo (LT) Vite Viterbo Prunus, Acero e<br />
Nocciolo<br />
(VT)<br />
148)<br />
6
Tabella n. 2 - Diffusione <strong>della</strong> <strong>Metcalfa</strong> <strong>pruinosa</strong> nel <strong>Lazio</strong> e piante ospiti<br />
Dati raccolti attraverso invio questionari ad Aziende agricole e Vivai<br />
Periodo raccolta dati : giugno 2003<br />
Località Piante ospiti Località Piante ospiti<br />
Roma Gelso, Agrumi, Ciliegio Sabaudia (LT) Equiseto, Melograno,<br />
Bosso, Agrumi,<br />
Pittosporo e Lauro<br />
Latina Vite, Agrumi, Acero,<br />
Lauro e Fico<br />
Cisterna (LT) Actinidia, Ortica e Vite<br />
Montelibretti (RM) Tiglio, Bosso e Ligustro Sutri (VT) Geranio, Cotoneaster e<br />
Pyracantha<br />
Alatri (FR) Geranio, Olivo e Ligustro Bolsena (VT) Bosso, Acero, Geranio,<br />
Lauro, Ligustro<br />
S. Marinella (RM) Mirto, Ligustro,<br />
Fiuggi (FR) Bosso, Acero,<br />
Pittosporo<br />
Pittosporo, Prunus<br />
Ceccano (FR) Pittosporo e Platano Valentano (VT) Actinidia<br />
Atina (FR) Acero e Bosso Borgo Carso (LT) Actinidia, Rovo,<br />
Robinia e Olmo,<br />
Quercia, Lauroceraso,<br />
Mirto, Ligustro e<br />
Platano<br />
Capranica Olivo e Acero Velletri (RM) Actinidia<br />
Roma Acero, Nocciolo, Geranio, Montefiascone (VT) Actinidia, Rovo, Olmo<br />
Fico, Platano<br />
e Nocciolo<br />
Aranova F. (RM) Geranio, Olivo, Quercia Bolsena (VT) Actinidia<br />
Frascati Geranio Aprilia (LT) Actinidia, Vite e Susino<br />
Nettuno (RM) Agrumi, Geranio e<br />
Campoverde Actinidia, Olmo e<br />
Solanum<br />
Ortica<br />
Bella Farnia (LT) Gelso, Lauro, Pittosporo,<br />
Olivo e Vinca<br />
Borgo Flora (LT) Actinidia<br />
Terracina (LT) Ligustro, Geranio,<br />
Melograno<br />
Ardea (RM) Vite<br />
Cori (LT) Geranio, Olivo e Vite Sabaudia Equiseto, Melograno,<br />
Bosso, Agrumi,<br />
Pittosporo e Lauro<br />
Vetralla (VT) Olivo, Prunus, Mirto, S. Cesareo (RM) Tiglio, Olmo, Lunaria,<br />
Pittosporo, Plantago,<br />
Platano, Acero e Vinca<br />
Gelso e Olivo<br />
Monterotondo - Roma Vite, Albicocco, Pesco Borgo Grappa (LT) Geranio, Mirto,<br />
Ciliegio, e Euphorbia<br />
Pittosporo, Solanum,<br />
Acero, Actinidia e Vite<br />
Ardea (RM) Acero e Bosso Cisterna (LT) Lunaria, Fico, Albizzia,<br />
Ligustro, Melograno,<br />
Cotoneaster e Tiglio,<br />
Prunus, Actinidia e Vite<br />
Terracina (LT) Pyracantha, Rubus, Sabaudia (LT) Lauro, Pittosporo e<br />
Cotoneaster, Tiglio,<br />
Prunus e Bosso<br />
Bosso<br />
Rieti Pittosporo, Acero, Bosso, Pontinia (LT) Olivo Cotoneaster e<br />
Lauro, Mirto e Nocciolo<br />
Pyracantha<br />
Sono stati raccolti dati di 74 località distribuite nel <strong>Lazio</strong>, rilevando popolazioni di M. <strong>pruinosa</strong><br />
(neanidi, ninfe e adulti) su 34 essenze diverse, sia erbacee che arboree.<br />
7
Biologia <strong>della</strong> <strong>Metcalfa</strong> <strong>pruinosa</strong> nel <strong>Lazio</strong>. Nel corso delle ispezioni in campo, effettuate<br />
nel corso del 2003, sono state eseguite delle osservazioni relativamente alla comparsa delle<br />
prime neanidi e dei primi adulti, sull’andamento sia delle forme giovanili che degli adulti,<br />
nonché indagare sul periodo di ovideposizione di questo insetto.<br />
Le prime neanidi di <strong>Metcalfa</strong> sono state osservate su Robinia nella seconda decade di<br />
Maggio, mentre i primi adulti sono stati trovati su Olmo nella seconda decade di Giugno.<br />
Le forme giovanili, neanidi e ninfe, raggiungono la massima densità a fine Giugno, primi di<br />
Luglio, mentre a fine Luglio gli stadi preimmaginali si riducono notevolmente. Per gli adulti<br />
il periodo di massima densità coincide con il mese di Luglio e i primi di Agosto, mentre a<br />
fine Agosto la densità si riduce a livello significativo.<br />
Per quanto riguarda l’ovideposizione, ispezioni condotte nella seconda e terza decade di<br />
Agosto hanno dato esito negativo e su 20 femmine sezionate soltanto una evidenziava gli<br />
ovarioli con presenza di uova.<br />
Nell’ispezione del 15 Settembre sono stati trovati uova su Olmo e su Vite e su 20 femmine<br />
sezionate, tutte evidenziavano ovaioli sviluppati e presenza di uova.<br />
<strong>Controllo</strong> Biolologico <strong>della</strong> <strong>Metcalfa</strong> <strong>pruinosa</strong>. Per quanto riguarda il controllo <strong>biologico</strong>,<br />
bisogna dire che in Italia l’azione di controllo di predatori generici non è in grado di<br />
contenere la diffusione delle popolazioni di M. <strong>pruinosa</strong>, mentre nell’area di origine (Stati<br />
Uniti) questo insetto é tenuto sotto controllo da una serie di nemici naturali: il lepidottero<br />
epipiropide, Epypiros barberiana, e gli imenotteri driinidi Thaumatodrynus danieli e<br />
Neodryinus typhlocybae.<br />
Nel 1987 l’Istituto di Entomologia dell’Università di Padova ha introdotto in Italia, dagli<br />
Stati Uniti, il driinide N. typhlocybae per mezzo di bozzoli contenenti larve svernanti.<br />
Questo parassita, anfigonico, a sessi separati, è capace di riprodursi anche per partenogenesi<br />
arrenotoca facoltativa. Infatti le femmine non fecondate danno luogo a maschi apolidi<br />
(Girolami V., Camporese, 1994). Il maschio è glicifago e vive due/tre giorni, mentre la<br />
femmina, che si nutre di melata e preda gli stadi giovanili <strong>della</strong> <strong>Metcalfa</strong> vive circa tre<br />
settimane ( Girolami, Conte, 1999).<br />
Le femmine di N. typhlocybae predano gli stadi giovanili di <strong>Metcalfa</strong>; una femmina di<br />
questo parassita preda in media due stadi giovanili al giorno con punte di quattro e nel corso<br />
<strong>della</strong> sua vita, che dura mediamente 20 giorni, con punte di quaranta, può e predare fino a<br />
circa cinquanta individui.<br />
Le femmine depongono le uova su individui di III, IV e V età e all’atto dell’ovideposizione,<br />
afferrano l’ospite mediante le chele e infiggono l’uovo all’inserzione plurale dell’abbozzo<br />
alare mesotoracico o piu’ raramente metatoracico.<br />
Gli individui di <strong>Metcalfa</strong> parassitizzati sono facilmente identificabili poiché, a distanza di<br />
giorni dalla deposizione dell’uovo, sotto l’inserzione degli abbozzi alari diventa visibile una<br />
sorta di ciste, denominata comunemente bubbone, o cisti. La larva del parassita, raggiunto<br />
l’ultimo stadio di sviluppo, uccide la forma giovanile di <strong>Metcalfa</strong>, divorandone<br />
completamente gli organi e i tessuti interni, per poi costruire al di sotto <strong>della</strong> spoglia <strong>della</strong><br />
vittima un bozzolo di natura sericea. N. typhlocybae sverna come larva matura diapausante<br />
all’interno del bozzolo, formando la pupa e lo sfarfallamento degli adulti la primavera<br />
successiva, in perfetta sincronizzazione con la presenza delle forme giovanili di <strong>Metcalfa</strong><br />
(Mazzon e Girolami, 2002).<br />
Una femmina di di N. typhlocybae è pertanto in grado di eliminare potenzialmente, con la<br />
predazione e la parassitizzazione, un centinaio di stadi giovanili di M. <strong>pruinosa</strong>.<br />
Questa valutazione è molto prudenziale, in quanto in questa fase non vengono considerati le<br />
forme giovanili predati e parassitizzati dagli adulti <strong>della</strong> seconda generazione sfarfallati nei<br />
8
mesi di Luglio e Agosto.Nel 1987 sono stati effettuati i primi lanci di N. typhlocybae in<br />
Veneto e Friuli Venezia Giulia e successivamente in Piemonte,Lombardia e altre regioni. I<br />
risultati di questi lanci sono promettenti, in quanto il parassita in questione si é acclimatato<br />
con facilità e svolge un’interessante attività di parassitizzazione, riducendo in modo<br />
significativo le popolazioni di <strong>Metcalfa</strong> in determinate aree. L’introduzione del N.<br />
typhlocybae come agente di controllo <strong>biologico</strong> è considerato il progetto di lotta biologica<br />
coi driinidi meglio riuscito (Olmi, 2000).<br />
Nel 2000 nel <strong>Lazio</strong> sono stati effettuati cinque lanci di N. typhlocybae nelle seguenti aree:<br />
Aprilia, Borgo Flora (Cisterna), Borgo Grappa (Latina), Bella Farnia (Sabaudia) e Fondi<br />
(Cacioppo 2001).<br />
Fig. 7 – Femmina di N. typhlocybae (lunghezza 4 mm)<br />
(Foto P. Giannotti<br />
Fig..8 – Ninfa di <strong>Metcalfa</strong> con<br />
tipica cisti di N. typhlocybae tra i<br />
due abbozzi alari<br />
Nell’ambito del presente progetto, per l’introduzione del N. typhlocybae, finalizzato al<br />
controllo <strong>biologico</strong> delle popolazioni di M. <strong>pruinosa</strong> sulla vegetazione spontanea a ridosso<br />
delle coltivazioni di Actinidia si è proceduto, innanzitutto alla selezione di dieci siti, tenendo<br />
presente i seguenti criteri:<br />
minimo disturbo <strong>della</strong> vegetazione spontanea, dove il parassita una volta introdotto possa<br />
svolgere la propria azione;<br />
presenza di una popolazione stabile di <strong>Metcalfa</strong>;<br />
possibilità di garantire un’area di rispetto intorno alla zona di lancio;<br />
facile accesso per poter condurre le osservazioni necessarie.<br />
I dieci siti sono stati scelti nelle seguenti aree:<br />
Un sito su Via Apriliana nel territorio del Comune di Aprilia;<br />
Un sito nella zona di Carano nel territorio del Comune di Aprilia;<br />
Due siti su Via di Nettuno nel territorio del Comune di Velletri;<br />
Tre siti nella zona di Borgo Montello nel territorio del Comune di Latina;<br />
Un sito nella zona di Borgo Flora nel territorio del Comune di Cisterna;<br />
Un sito nel territorio del Comune di Cisterna;<br />
Un sito nel territorio del Comune di Nettuno.<br />
9
Prima del lancio del parassita nei siti prescelti sono stati rilevati i seguenti parametri:<br />
Lunghezza del sito;<br />
Rilevamento delle specie di piante attaccate da parte <strong>della</strong> <strong>Metcalfa</strong>;<br />
Rilevamento <strong>della</strong> densità di popolazione <strong>della</strong> <strong>Metcalfa</strong> con l’esecuzione di campionature<br />
in ogni sito, consistenti nella scelta di sei piante tra alberi e arbusti e su ciascuna pianta sono<br />
stati esaminati 10 germogli presi a caso sulla chioma per una lunghezza di 30 cm., fino<br />
all’altezza di due metri dal suolo. Per ogni germoglio è stato rilevato il numero di <strong>Metcalfa</strong><br />
presenti, distinguendo: forme giovanili e adulti.<br />
I siti selezionati avevano una lunghezza tra i 200 e i 300 m; la vegetazione in prevalenza era<br />
composta da rovi, ortica, robinia, olmo e acero. Solo in un caso è stata Per quanto riguarda la<br />
densità delle popolazioni di <strong>Metcalfa</strong> nei siti prescelti per l’introduzione del parassita, questa<br />
è stata valutata attraverso i dati raccolti prima del lancio riportati nella tabella n. 3.<br />
Sito<br />
n.<br />
Tabella n. 3 – Neanidi e ninfe di <strong>Metcalfa</strong> rilevate prima del lancio del Neodryinus<br />
Ubicazione<br />
sito<br />
1 Via Apriliana - Aprilia<br />
(LT)<br />
2 Via di Nettuno<br />
Velletri (RM)<br />
3 Via di Nettuno<br />
Velletri (RM)<br />
4 Via Crocetta di<br />
Carano-Aprilia (LT)<br />
12,3 ± 12,5<br />
100%<br />
Rovo 1<br />
11,5 ± 8,6<br />
80%<br />
Rovo 1<br />
6,4 ± 4,8<br />
90%<br />
Olmo 1<br />
9,1± 11,4<br />
60%<br />
Olmo 1<br />
5 Via Campovivo 9,5±10,6<br />
80%<br />
Olmo 1<br />
6 Borgo Montello (LT) 8,6 ± 12,1<br />
70%<br />
7 Chimentu<br />
Borgo Montello (LT)<br />
8 Acciarella<br />
Nettuno (RM)<br />
Olmo 1<br />
2,7 ± 3,6<br />
60%<br />
Olmo 1<br />
30,9 ± 16,3<br />
100%<br />
Rovo 1<br />
9 Via Ninfina II 13,9 ± 11,8<br />
100%<br />
10 Via Reynolds<br />
Cisterna (LT)<br />
Olmo 1<br />
2,6 ± 3,4<br />
60%<br />
Sambuco 1<br />
11,5 ± 17,5<br />
70%<br />
Rovo 2<br />
6,1 ± 3,87<br />
80%<br />
Rovo 2<br />
5,5 ± 5,1<br />
80%<br />
Olmo 2<br />
7,2 ± 7,3<br />
80%<br />
Olmo 2<br />
4,9 ± 4,6<br />
90%<br />
Olmo 2<br />
48,5 ± 25,2<br />
100%<br />
Rovo 1<br />
7,5 ± 8,4<br />
70%<br />
Olmo 2<br />
54,5 ± 15,4<br />
100%<br />
Rovo 2<br />
4,1 ± 5,6<br />
70%<br />
Olmo 2<br />
3,4 ± 3,6<br />
70%<br />
Olmo 1<br />
N. neanidi e ninfe<br />
(% germogli con <strong>Metcalfa</strong>)<br />
Piante ispezionate<br />
Data ispezione : 15/06/2003<br />
7,6 ± 9,9<br />
60%<br />
Rovo 3<br />
6,4 ± 4,69<br />
90%<br />
Rovo 3<br />
6,6 ± 3,7<br />
100%<br />
Olmo 3<br />
3,7 ± 3,4<br />
90%<br />
Olmo 3<br />
4,2 ± 6,8<br />
60%<br />
Olmo 3<br />
28,2 ± 11,4<br />
100%<br />
Fico 1<br />
2,8 ± 4,8<br />
40%<br />
Olmo 3<br />
34,5 ± 20,9<br />
100%<br />
Rovo 3<br />
5,7 ± 6,8<br />
60%<br />
Olmo 3<br />
5,7 ± 6,1<br />
70%<br />
Acero 1<br />
13,3 ± 13,8<br />
90%<br />
Olmo 1<br />
12,4 ± 14,5<br />
100%<br />
Rovo 4<br />
11,7 ± 9,0<br />
80%<br />
Olmo 4<br />
55,2 ± 32,4<br />
100%<br />
Fico 1<br />
2,8 ± 4,4<br />
50%<br />
Robinia 1<br />
5,8 ± 7,5<br />
70%<br />
Vite 1<br />
31,1 ± 28,9<br />
70%<br />
Robinia 1<br />
34,5 ± 24,4<br />
100%<br />
Robinia 1<br />
,0 ± 9,2<br />
70%<br />
Rovo 1<br />
16,3 ± 18,2<br />
80%<br />
Robinia 1<br />
1,0 ± 1,8<br />
50%<br />
Olmo 2<br />
27,6 ± 12,1<br />
100%<br />
Rovo 5<br />
7,3 ± 8,9<br />
80%<br />
Olmo 5<br />
15,6 ± 11,6<br />
70%<br />
Fico 2<br />
14,2 ± 15,6<br />
100%<br />
Robinia 2<br />
15,2 ± 15,4<br />
100%<br />
Vite 2<br />
38,2 ± 27,6<br />
100%<br />
Robinia 2<br />
18,6 ± 23,6<br />
60%<br />
Robinia 2<br />
19,8 ± 12,1<br />
100%<br />
Rovo 2<br />
5,6 ± 6,3<br />
70%<br />
Rovo 1<br />
2,8 ± 4,1<br />
50%<br />
Olmo 3<br />
0,6 ± 1,3<br />
30%<br />
Olmo 1<br />
10,3 ± 7,5<br />
90%<br />
Vite<br />
2,5 ± 3,2<br />
50%<br />
Quercia 1<br />
1,1 ± 2,8<br />
40%<br />
Rovo 1<br />
10,9 ± 5,9<br />
100%<br />
Crataegus 1<br />
8,7 ± 6,2<br />
70%<br />
Robinia 3<br />
15,4 ± 11,6<br />
90%<br />
Robinia 3<br />
21,3 ± 13,2<br />
100%<br />
Rovo 3<br />
10,2 ± 8,1<br />
90%<br />
Rovo 2<br />
10
I dati <strong>della</strong> tabella n. 3 evidenziano una notevole variabilità, sia in termini di percentuale di<br />
germogli attaccati (range : 50 – 100%), sia in termini di densità di neanidi di <strong>Metcalfa</strong> sui<br />
germogli esaminati. Le piante di Rovo, Robinia e Fico hanno evidenziato un’elevata densità<br />
di forme giovanili di questo flatide, mentre sull’Olmo la densità è risultata meno elevata e<br />
più uniforme, rispetto alle specie sopra indicate. Ad ogni modo, la densità <strong>della</strong> popolazione<br />
di <strong>Metcalfa</strong> sui dei germogli esaminati è risultata sostanzialmente idonea in tutti i siti<br />
prescelti per l’introduzione del parassita Neodryinus typhlocybae.<br />
Dal 18 al 20 giugno 2003 in ogni sito è stata posizionata, ad un’altezza di m. 1,50 – 2,00 dal<br />
suolo, una confezione di bozzoli contenenti larve mature e pupe del parassita Neodryinus<br />
typhlocybae. Le confezioni, contenenti ognuna mediamente 50 femmine e 100 maschi di<br />
Neodryinus, sono state fornite da Bioplanet di Cesena, unico produttore in Italia di bozzoli<br />
di Neodryinus.<br />
Risultati<br />
Da metà Luglio a fine Settembre i dieci siti sono stati monitorati ogni 15/20 gg. sia per<br />
verificare la presenza di nuovi bozzoli di Neodryinus, sia per valutare l’andamento delle<br />
forme giovanili e adulti delle popolazioni <strong>della</strong> <strong>Metcalfa</strong>. I dati raccolti a seguito delle<br />
ispezioni effettuate sono riportati nella tabella n. 4.<br />
Tabella n. 4 - Bozzoli di N. typhlocybae ritrovati nei siti d’introduzione nel 2003<br />
Sito<br />
n.<br />
Ubicazione Sito 20/07/03<br />
1 Via Apriliana<br />
(LT)<br />
Aprilia<br />
2 Via Nettuno Velletri<br />
N. bozzoli/sito<br />
25<br />
Olmo e Rovo<br />
(RM) -<br />
3 Via di Nettuno<br />
Velletri (RM)<br />
4 Via Crocetta di Carano<br />
Aprilia (LT)<br />
5 Via Campovivo -<br />
Cisterna<br />
6 Borgo Montello (LT)<br />
7 Borgo Montello (LT)<br />
8 Acciarella – Nettuno<br />
(RM)<br />
20<br />
Olmo e Rovo<br />
3<br />
Fico e Olmo<br />
9 Via Ninfina II 5<br />
Olmo<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
05/08/03*<br />
N. bozzoli/sito<br />
63<br />
Olmo e Rovo<br />
05/08/03<br />
N. Larve di<br />
<strong>Metcalfa</strong> con<br />
“bubbone”<br />
80<br />
Olmo e Rovo 9<br />
55<br />
Olmo, Rovo 4<br />
e Vite<br />
9<br />
Olmo -<br />
25<br />
Olmo -<br />
95<br />
Vite, Crataegus<br />
e<br />
Actinidia<br />
58<br />
Olmo<br />
15/09/03**<br />
N. bozzoli/sito<br />
10 52<br />
Olmo e Rovo<br />
65<br />
Olmo e Rovo<br />
45<br />
Olmo e Rovo<br />
6<br />
Olmo<br />
8<br />
Olmo<br />
15 64<br />
Vite e Crataegus<br />
- 40<br />
Olmo<br />
6<br />
4<br />
Rovo e Robinia -<br />
Rovo e Robinia<br />
118<br />
Olmo e Rovo<br />
10 Via Reynolds- Cisterna - 75<br />
Olmo e Rovo<br />
15 90<br />
Olmo e Rovo<br />
17 62<br />
Olmo e Rovo<br />
Distanza<br />
massima dal<br />
punto di<br />
lancio ml<br />
* bozzoli <strong>della</strong> prima generazione di N. typhlocybae; ** bozzoli <strong>della</strong> prima e seconda generazione di N.<br />
typhlocybae<br />
20<br />
30<br />
30<br />
30<br />
15<br />
40<br />
20<br />
20<br />
50<br />
40<br />
11
Durante le ispezioni in campo è stato osservato per esempio che gli individui di <strong>Metcalfa</strong><br />
parassitizzati non perdono all’inizio la loro vitalità, ma continuano a nutrirsi e a spostarsi<br />
attivamente nella vegetazione. Gli individui di <strong>Metcalfa</strong> parassitizzati si riconoscono allorché<br />
sotto l’inserzione degli abbozzi alari diventa visibile una sorta di cisti, chiamata comunemente<br />
“bubbone” che contiene la larva del parassita nei primi stadi di sviluppo. Quando la larva del<br />
N. typhlocybae raggiunge l’ultima stadio di sviluppo, uccide l’ospite, divorandone gli organi e<br />
i tessuti interni., costruendo successivamente sotto i resti <strong>della</strong> vittima un bozzolo di natura<br />
sericea. E’ stato osservato che il N. typhlocybae sverna come larva matura all’interno del<br />
bozzolo, per riprendere il proprio sviluppo nella primavera successiva, sino alla formazione<br />
<strong>della</strong> pupa e allo farfallamento dell’adulto nella seconda metà di giugno. La maggioranza degli<br />
individui di questo parassita sono monovoltini. Tuttavia una parte delle larve può impuparsi<br />
nel corso <strong>della</strong> stessa estate dando luogo a una seconda generazione prevalentemente in agosto<br />
e con meno frequenza a settembre.<br />
Come riportato nella tabella n. 4, i primi bozzoli sono stati trovati a metà il 20Luglio in quattro<br />
siti, con una media di circa 14 bozzoli per sito (range : 3 – 25) . Nell’ ispezione di del 5<br />
Agosto in tutti i siti sono stati trovati bozzoli di Neodryinus, con una media di 45,9 bozzoli per<br />
sito (range : 6 – 118). In due siti sono stati trovati meno di 10 bozzoli/sito. La scarsa presenza<br />
di bozzoli riscontrata in questi siti era probabilmente dovuta all’abbondanza <strong>della</strong> vegetazione<br />
e quindi all’impossibilità di ispezionare tutta la massa vegetativa di ogni sito.<br />
Nell’ispezione Del 15 Settembre sono stati trovati nuovi bozzoli di Neodryinus, appartenenti<br />
alla seconda generazione; questi bozzoli sono stati prodotti dagli adulti di Neodryinus,<br />
sfarfallati nel periodo Luglio/Agosto.I bozzoli di Neodryinus sono stati trovati a partire dal<br />
punto di posizionamento <strong>della</strong> confezione del parassita fino ad una distanza variante tra i 15 e i<br />
50 metri. Questi primi dati indicano chiaramente che il Neodryinus è riuscito a stabilizzarsi nei<br />
vari siti, spostandosi a distanze significative rispetto al punto di lancio. Per quanto riguarda la<br />
diffusione naturale del Neodryinus, in base a precedenti esperienze in altre Regioni, si è potuto<br />
osservare che generalmente che nei primi due anni dall’introduzione la diffusione attiva del<br />
parassita é poche decine di metri e ritrovamenti più distanti sono da attribuire generalmente a<br />
fattori casuali. Solo successivamente, a partire dal terzo anno, la popolazione in crescita tende<br />
a distribuirsi nell’ambiente e a controllare in modo significativo le popolazioni di <strong>Metcalfa</strong><br />
(Sala e Foschi, 2002).<br />
Fig. 9 - Confezione di bozzoli di N. typhlocybae pronti a sfarfallare<br />
12
Fig. – 10 Bozzoli di Neodrynus su Acero Fig. – 11 Bozzoli di Neodrynus su Edera<br />
Ispezioni eseguite a metà Ottobre del 2003 dal Prof. Olmi dell’Università <strong>della</strong> Tuscia sui 10<br />
siti d’introduzione del parassita per il controllo <strong>della</strong> <strong>Metcalfa</strong>, per verificare se all’interno<br />
dei bozzoli le prepupe di N. typhlocybae fossero o meno attaccate da iperparassitoidi hanno<br />
dato esito negativo (Rif. Relazione Prof. Olmi allegata).<br />
Fig. 12 – Femmina di N. typhlocybae mentre parassitizza un individuo di <strong>Metcalfa</strong><br />
13
La lotta chimica con prodotti a basso impatto ambientale. Poiché il presente progetto ha<br />
finalità di divulgazione e non di ricerca pura, è stato previsto l’utilizzo di principi attivi<br />
registrati su Actinidia che attualmente sono:<br />
Azadiractina (Registrazione n. 10305 del 03/02/2000 del Ministero <strong>della</strong> Sanità<br />
(SIPCAM); classe tossicologica : Attenzione manipolare con prudenza (ex III<br />
classe). Intervallo di sicurezza su Actinidia: 3 gg.<br />
Suddetto principio attivo é una sostanza naturale estratta dai semi <strong>della</strong> pianta del<br />
Neem, la quale appartiene alla famiglia delle Miliaceae e risulta originaria del Nord-<br />
Est dell’India. Si tratta di un prodotto assolutamente innocuo per l’uomo e non<br />
risulta tossico per le api e per molti ausiliari e viene impiegato nell’Agricoltura<br />
Biologica.<br />
L’Azadiractina ha diverse modalità di azione : blocco dell’attività trofica<br />
dell’insetto, con riduzione sensibile dell’attività e collassamento <strong>della</strong> popolazione;<br />
azione sugli stadi giovanili come regolatore di crescita, provocando il blocco<br />
dell’attività trofica e <strong>della</strong> muta, con conseguente mortalità.<br />
Lambda-Cyhalothrin (Registrazione n. 8259 del 04/05/1993 del Ministero <strong>della</strong><br />
Sanità (SYNGENTA – ex SOLPLANT); classe tossicologica : irritante (ex III<br />
classe). Intervallo di sicurezza su Actinidia : 7 gg.<br />
Suddetto principio attivo é un piretroide di sintesi che agisce per contatto ed<br />
ingestione; si caratterizza per un rapido potere abbattente ed una persistente capacità<br />
protettiva; possiede un effetto repellente ed evidenzia la propria attività anche con<br />
piccole quantità di principio attivo.<br />
Etofenprox (Registrazione n. 8735 del 23/03/1995 del Ministero <strong>della</strong> Sanità<br />
(SIPCAM); classe tossicologica : irritante (ex III classe). Intervallo di sicurezza su<br />
Actinidia : 7 gg.<br />
L’etofenprox é un fenossiderivato che agisce per contatto ed ingestione; interferisce,<br />
inoltre, sul sistema nervoso degli insetti mediante inibizione del trasporto degli ioni<br />
Sodio lungo le terminazioni nervose. La molecola dell’etofenprox é costituita<br />
unicamente da Carbonio, Idrogeno e Ossigeno; ha una bassissima tossicità acuta nei<br />
confronti dell’uomo e dei mammiferi.<br />
Nell’ambito <strong>della</strong> lotta chimica sono stati effettuate le seguenti prove:<br />
Prove di laboratorio : infestazione artificiale di giovani piante di Actinidia con forme<br />
giovanili di <strong>Metcalfa</strong> in gabbie delle seguenti dimensioni: m. 1,20 x 1,20 x 1,80. – Prova<br />
effettuata in data 26/06/03.<br />
Principi attivi testati:<br />
Etofenprox (dose: 50 ml/hl); Lambda-Cyhalothrin (dose: 100 g/hl); Olio di Neem (dose: 150<br />
ml/hl + Bagnante alla dose di 100 g/hl) ; Testimone ( impiego di acqua).<br />
Insetti testati : Ottanta – 120 forme giovanili di <strong>Metcalfa</strong> per ogni gabbia.<br />
Replicazioni : Tre per ogni principio attivo e per il testimone. Una gabbia<br />
rappresenta unreplicazione.<br />
Monitoraggio : Registrazione individui morti dopo 24, 48 e 72 ore dal trattamento.<br />
15
Risultati<br />
I risultati ottenuti con questa prova indicano:<br />
Sul testimone, la mortalità delle forme giovanili di <strong>Metcalfa</strong> si è attestata intorno al 10%.<br />
Elevata efficacia dell’etofenprox, dove la mortalità delle forme giovanili di<br />
<strong>Metcalfa</strong> si è attestata tra il 95 e il 98%.<br />
Elevata efficacia <strong>della</strong> lambda-cyhalothrin, dove la mortalità delle forme<br />
giovanili di <strong>Metcalfa</strong> si è attestata tra il 97 e il 99%.<br />
Efficacia medio-alta dell’ olio di neem, dove la mortalità delle forme<br />
giovanili di <strong>Metcalfa</strong> si è attestata tra il 41 e il 78%.<br />
Prove di campo in condizioni seminaturali : con infestazione naturale di piante adulte di<br />
Actinidia con adulti di <strong>Metcalfa</strong>; gli adulti presenti sui rami e sui frutti di Actinidia sono<br />
stati intrappolati in manicotti di tulle <strong>della</strong> larghezza di 30 cm e lunghezza 80 cm. – Prova<br />
effettuata in data 17/07/03.<br />
Principi attivi testati:<br />
Etofenprox (dose: 50 ml/hl); Lambda-Cyhalothrin (dose: 100 g/hl); Olio di<br />
Neem (dose: 150 ml/hl + Bagnante alla dose di 100 g/hl) ; Testimone (acqua).<br />
Insetti testati : Ottanta – 120 forme giovanili di <strong>Metcalfa</strong> per ogni gabbia. Una<br />
gabbia rappresenta una replicazione.<br />
Replicazioni : Tre per ogni principio attivo e per il testimone.<br />
Monitoraggio : Registrazione individui morti dopo 24, 48 e 72 ore dal trattamento.<br />
Risultati<br />
I risultati ottenuti con questa prova indicano:<br />
Sul testimone, la mortalità degli di <strong>Metcalfa</strong> è stata inferiore del 5%.<br />
Elevata efficacia dell’etofenprox, dove la mortalità degli adulti di <strong>Metcalfa</strong> è stata del<br />
100%.<br />
Elevata efficacia <strong>della</strong> lambda-cyhalothrin, dove la mortalità degli adulti di <strong>Metcalfa</strong> è stata<br />
del 100%.<br />
Efficacia medio-alta dell’ olio di neem, dove la mortalità delle forme<br />
giovanili di <strong>Metcalfa</strong> si è attestata tra il 47 e il 72%.<br />
Prove in pieno campo :<br />
I trattamenti con i principi attivi sopra indicati sono stati effettuati in pieno campo in tre<br />
aziende:<br />
Trattamento con Etofenprox ( dose: 50 ml/hl), in una situazione di elevata presenza di<br />
adulti e forme giovanili di <strong>Metcalfa</strong> sia su Actinidia, lungo la fila esterna, sia sulla<br />
vegetazione spontanea costituita da Rovi, Urtica, Cotonaster e Vite selvatica.<br />
Trattamento effettuato, in data 07/07/03, soltanto lungo la fila esterna infestata dalflatide in<br />
questione;<br />
Osservazioni: per i primi tre giorni dal trattamento le piante di Actinidia trattate non<br />
presentavano né forme giovanili, né adulti di <strong>Metcalfa</strong>, mentre a distanza di 8/10 gg. dal<br />
trattamento, le piante di Actinidia, sempre <strong>della</strong> fila esterna, in precedenza infestate,<br />
risultavano di nuovo infestate in modo significativo. In questa situazione è risultato evidente<br />
il passaggio di nuova ondata di <strong>Metcalfa</strong> proveniente dalla vegetazione spontanea<br />
circostante, considerando che la prima infestazione era stata eliminata dall’intervento con<br />
Etofenprox. Vista la situazione l’agricoltore ha deciso di sospendere qualsiasi tipo di<br />
trattamento contro la <strong>Metcalfa</strong>, anche perché l’infestazione pesante di questo insetto era<br />
concentrata comunque in un’area limitata.<br />
16
Trattamento con Lambda-Cyhalothrin (dose: 100 ml/hl), in una situazione presenza<br />
medio-bassa di adulti e forme giovanili di <strong>Metcalfa</strong> sia su Actinidia, lungo la fila esterna, sia<br />
sulla vegetazione spontanea costituita da Rovi e Olmo.<br />
Trattamento effettuato, in data 15/07/03, soltanto lungo la fila esterna infestata dal flatide;<br />
Osservazioni: a distanza di tre giorni dal trattamento le piante di Actinidia trattate non<br />
presentavano né forme giovanili, né adulti di <strong>Metcalfa</strong>; la medesima situazione si presentava<br />
a distanza di 15/20 gg. dal trattamento. In questa situazione non si è verificato nessun<br />
ulteriore passaggio di <strong>Metcalfa</strong> proveniente dalla vegetazione spontanea circostante,<br />
considerando che la prima infestazione era stata eliminata dall’intervento con Lambda-<br />
Cyhalothrin. In questa situazione l’agricoltore ha deciso di non effettuare altri trattamenti,<br />
in quanto sulla vegetazione spontanea si notavano pochi adulti e qualche forma giovanile di<br />
<strong>Metcalfa</strong> e quindi non c’era motivo di intervenire ulteriormente con prodotti chimici.<br />
Trattamento con Olio di Neem (dose: 150 ml/hl + Bagnante alla dose di 100 g/hl) in una<br />
situazione di presenza medio-bassa di adulti e forme giovanili di <strong>Metcalfa</strong> sia su Actinidia,<br />
lungo la fila esterna, sia sulla vegetazione spontanea costituita da Rovi, Olmo e Vite<br />
selvatica.<br />
Trattamento effettuato, in data 25/07/03, soltanto lungo la fila esterna infestata dal flatide in<br />
questione;<br />
Osservazioni: a distanza di due giorni dal trattamento le piante di Actinidia trattate non<br />
presentavano né forme giovanili, né adulti di <strong>Metcalfa</strong>; la medesima<br />
situazione si presentava a distanza di 20/25 gg. dal trattamento. In questa situazione<br />
l’agricoltore ha deciso di non trattare ulteriormente, in quanto la presenza di Metcafa era<br />
confinata soltanto sulla vegetazione spontanea e quindi non c’era motivo di intervenire con<br />
trattamenti aggiuntivi.<br />
Fig. 14 – Principi attivi testati nella lotta chimica contro la <strong>Metcalfa</strong>. (Diversi autori)<br />
17
SECONDA ANNUALITA’ 2007<br />
Tenendo presente che la seconda annualità del progetto in questione doveva svolgersi, sotto<br />
l’aspetto strettamente tecnico, nel corso del 2004, il coordinatore del progetto<br />
indipendentemente dai fondi <strong>della</strong> <strong>Regione</strong> <strong>Lazio</strong> ha continuato con:<br />
l’integrazione dei dati per il completamento <strong>della</strong> mappa territoriale nel corso del<br />
2004, 2005 e 2007;<br />
l’integrazione di dati sulla biologia <strong>della</strong> M. <strong>pruinosa</strong> nel 2004, 2005 e 2007 ;<br />
monitoraggio siti d’introduzione del N. tiphlocybae nel 2004, 2005 e 2007.<br />
prove con prodotti a basso impatto ambientale nel 2005.<br />
Costituzione mappa territoriale sullo stato di diffusione <strong>della</strong> <strong>Metcalfa</strong> <strong>pruinosa</strong> . Questi<br />
ulteriori dati sono stati raccolti sia da personale partecipante al progetto (Tabella n. 5), sia<br />
attraverso dati ricevuti da aziende agricole e vivai (Tabella n. 6) nel corso del 2004, 2005 e<br />
2007.<br />
Tabella n. 5 - Diffusione <strong>della</strong> <strong>Metcalfa</strong> <strong>pruinosa</strong> nel <strong>Lazio</strong> e piante ospiti<br />
Dati raccolti dal personale partecipante al progetto<br />
Periodo raccolta dati : maggio/giugno 2004, 2005 e 2007<br />
Località Piante ospiti Località Piante ospiti<br />
Terracina (LT) Robinia Casale delle Palme (LT) Rovo e Actinidia<br />
Sperlonga (LT) Agrumi Borgo Podgora (LT) Actinidia, e Robinia<br />
Fondi (LT) Agrumi Tor S. Lorenzo (RM) Rovo e Olmo<br />
Minturno (LT) Pomodoro Lavinio (RM) Rovo e Olmo<br />
Bella Farnia (LT) Olmo e Ortica Campo di Carne (RM) Rovo<br />
Borgo Sabotino (LT) Olmo Fico e Ortica Pomezia(RM) Actinidia<br />
Doganella di Ninfa Rovo e Robinia Frascati (RM) Vite<br />
Lanuvio (RM) Olivo, Vite Cerveteri (RM) Actinidia, Rovo e Olmo<br />
Tor tre Ponti (LT) Olmo e Rovo Albano (RM) Platano<br />
Borgo Faiti (LT) Actinidia e Olmo Palestrina (RM) Platano<br />
Sezze Scalo (LT) Platano Tolfa (RM) Rovo e Ortica<br />
Campoleone Actinidia, Olmo e Rovo S. Marinella (RM) Robinia e Platano<br />
Borgo Sabotino (LT) Actinidia e Olmo Rocca Priora (RM) Platano<br />
Borgo Bainsizza (LT) Rovo, Olmo e Ortica Lariano (RM) Platano e Olmo<br />
Campoverde (LT) Actinidia, , Olmo e Ortica Castel Romano (RM) Rovo<br />
Sacramento (LT) Robinia Castel Porziano (RM) Rovo, Olmo e Robinia<br />
Bosco del Padiglione (LT) Olmo, Acero Villa Borghese (RM) Acero e Platano<br />
18
Tabella n. 6 - Diffusione <strong>della</strong> <strong>Metcalfa</strong> <strong>pruinosa</strong> nel <strong>Lazio</strong> e piante ospiti<br />
Dati raccolti attraverso invio questionari inviati ad Aziende agricole e Vivai<br />
Periodo raccolta dati : giugno 2004 e 2005<br />
Località Piante ospiti Località Piante ospiti<br />
Roma Cotoneaster, Ciliegio e Sabaudia Equiseto, Melograno,<br />
Prunus<br />
Bosso, Agrumi,<br />
Manziana Acero, Lauroceraso Cisterna (LT) Actinidia e Vite<br />
Sezze (LT) Olivo Sutri (VT) Geranio, Cotoneaster e<br />
Pyracantha<br />
Isola Farnese Geranio e Ligustro Bolsena (VT) Bosso, Acero, Geranio,<br />
Lauro, Ligustro<br />
Monte Muscolo (RM) Rovo e Pittosporo Fiuggi (FR) Bosso, Acero,<br />
Pittosporo, Prunus<br />
Grottaferrata (RM) Platano Valentano (VT) Actinidia<br />
Borgo Carso (LT) Actinidia, Rovo,<br />
Civitavecchia (RM) Platano, Ortica<br />
Robinia e Olmo,<br />
Quercia, Lauroceraso,<br />
Castelgandolfo Acero, Vite Velletri (RM) Actinidia<br />
Roma Acero, Nocciolo, Geranio, Montefiascone (VT) Actinidia, Rovo, Olmo,<br />
Fico, Platano, Albicocco<br />
Mirto e Nocciolo<br />
Montalto di Castro (VT) Olivo Bolsena (VT) Actinidia<br />
Frascati Geranio Aprilia (LT) Actinidia, Vite e Susino<br />
Nettuno (RM) Agrumi, Geranio e<br />
Solanum<br />
Campoverde Actinidia, Tiglio<br />
Bella Farnia (LT) Gelso, Lauro, Pittosporo,<br />
Olivo e Vinca<br />
Borgo Flora (LT) Actinidia<br />
Terracina (LT) Ligustro, Geranio,<br />
Melograno, Sambuco<br />
Ardea (RM) Vite<br />
Cori (LT) Geranio, Olivo e Vite Sabaudia Equiseto, Melograno,<br />
Bosso, Agrumi,<br />
Pittosporo e Lauro<br />
Vetralla (VT) Olivo, Prunus, Mirto, S. Cesareo (RM) Tiglio, Olmo, Lunaria,<br />
Pittosporo, Plantago,<br />
Platano, Acero e Vinca<br />
Gelso e Olivo<br />
Monterotondo - Roma Vite, Albicocco, Pesco e Borgo Grappa (LT) Geranio, Mirto,<br />
Ciliegio<br />
Pittosporo, Solanum,<br />
Acero, Actinidia e Vite<br />
Ardea (RM) Agrumi, Mirto, Albizzia, Cisterna (LT) Lunaria, Fico, Albizzia,<br />
Pittosporo, Acero e<br />
Ligustro, Melograno,<br />
Bosso<br />
Cotoneaster e Tiglio,<br />
Prunus, Actinidia e Vite<br />
Terracina (LT) Pyracantha, Rubus, Sabaudia (LT) Lauro, Pittosporo e<br />
Cotoneaster, Tiglio,<br />
Prunus e Bosso<br />
Bosso<br />
Rieti Pittosporo, Acero, Bosso, Pontinia (LT) Olivo Cotoneaster e<br />
Lauro, Mirto e Nocciolo<br />
Pyracantha<br />
Sono stati raccolti dati di 76 località distribuite nel <strong>Lazio</strong>, rilevando popolazioni di <strong>Metcalfa</strong><br />
(neanidi, ninfe e adulti) su 30 essenze diverse, sia erbacee che arboree.<br />
19
Biologia <strong>della</strong> <strong>Metcalfa</strong> <strong>pruinosa</strong> nel <strong>Lazio</strong>.<br />
Morfologia<br />
Adulto : lunghezza 7 – 8 mm; allo sfarfallamento presentano una livrea bianco candida che<br />
virerà, nell’arco di uno/due giorni, verso il definitivo colore grigio brunastro; ali tenute a<br />
tetto ai lati del corpo. La femmina è provvista di un ovopositore quasi rudimentale, collocato<br />
in un’apposita scanalatura del nono urosternite e costituito da tre paia di valve oblunghe. Nel<br />
maschio le gonapofisi sono associate al margine del nono urosternite e comprendono un<br />
organo intromettente, il fallo, ed un paio di stili genitali che emergono tra gli sterniti del<br />
nono e decimo segmento addominale (L. Santini e A. Lucchi, 2000).<br />
Figura n. 15 – <strong>Metcalfa</strong> <strong>pruinosa</strong> – Disegni semischematici<br />
illustranti, sopra, la tipica posizione assunta dal maschio e dalla<br />
femmina durante l’accoppiamento e, sotto, la peculiare posizione<br />
delle gonapofisi, durante l’atto medesimo (F, fallo; SG stili genitali;<br />
TAf, tubo anale <strong>della</strong> femmina; TAm, tubo anale del maschio; VA,<br />
valvole anteriori; VP valvole posteriori (Disegno L. Santini)<br />
Figura 16 – Adulti di M. <strong>pruinosa</strong> nella classica disposizione<br />
lineare<br />
Gli adulti, dotati di spiccato gregarismo, si ritrovano spesso riuniti in gruppi, sui rami più<br />
giovani delle piante, disposti in lunghe file, quasi immobili. A circa 25/30 giorni dallo<br />
farfallamento, gli adulti raggiungono la maturità sessuale, dando inizio agli accoppiamenti<br />
che di norma avvengono nelle ore notturne. Dopo l’accoppiamento ciascuna femmina<br />
depone mediamente 60 uova, inserendole singolarmente, attraverso il robusto ovopositore,<br />
in vari punti <strong>della</strong> corteccia delle piante ospiti.<br />
Uovo – L’uovo di <strong>Metcalfa</strong>, di colore bianco lattiginoso, lungo circa 1 mm e a sezione<br />
ellittica, è dotato di un corion spesso a trama sub-esagonale per quasi tutta la superficie.<br />
20
Nella parte ventrale si presenta liscio e risulta dotato di due scanalature divergenti ( L.<br />
Santini e A. Lucchi 2000).<br />
Fig. 17 – Uova di <strong>Metcalfa</strong> <strong>pruinosa</strong><br />
Stadi giovanili – Lo sviluppo preimmaginale <strong>della</strong> M. <strong>pruinosa</strong> comprende cinque stadi di<br />
cui tre di neanide e due di ninfa. Nel <strong>Lazio</strong>, in base alle osservazioni condotte dal 2003 al<br />
2007, le prime neanidi compaiono nella prima metà di maggio e proseguono scalarmene fino<br />
alla fine di giugno. Appena sgusciata dall’uovo, la neanide di primo stadio migra<br />
rapidamente su una foglia, collocandosi sulla pagina inferiore, in corrispondenza delle<br />
nervature ed inizia subito a nutrirsi, ad eliminare la melata dall’ano e a rivestirsi di<br />
abbondanti secrezioni cerose prodotte dalle ghiandole ciripare distribuite su tutto il corpo ed<br />
in particolare in corrispondenza dell’estremità addominale (8, 15). Un carattere morfologico<br />
distintivo per la determinazione delle diverse età giovanili è rappresentato dal numero delle<br />
tipiche spine, brevi e con punta di colore nero, presenti sui segmenti tibio-tarsiali <strong>della</strong><br />
zampa metatoracica. (Figura n. 12). Nelle ultime fasi dello sviluppo preimmaginale la<br />
seconda ninfa (ultimo stadio giovanile) cessa di nutrirsi e si sposta sulla pagina inferiore di<br />
una foglia per compiere la ninfosi. Il neo adulto fuoriesce attraverso una fenditura<br />
longitudinale <strong>della</strong> parte tergale <strong>della</strong> cuticola toracica. ( L. Santini e A. Lucchi 2000).<br />
Fig. 18 – Neanide di <strong>Metcalfa</strong> Fig. 19 – Ninfe di <strong>Metcalfa</strong><br />
21
ETA’ MTL MTV MTR1 MTR2<br />
I 0 4 4 0<br />
II 1 5 5 0<br />
III 1 - 2 6 6 0<br />
IV 3 6 - 7 7 1<br />
V 3 7 7 2<br />
Figura n. 20 – <strong>Metcalfa</strong> <strong>pruinosa</strong>. A sinistra disegno raffigurante il profilo <strong>della</strong> zampa metatoracica di una<br />
seconda ninfa (V a età) con la dislocazione delle spine metatibiali laterali (MTL), delle spine metatibiali<br />
ventrali (MTV), di quelle del primo (MTR1) e del secondo metatarso (MTR2). A destra tabella con il<br />
numero di spine per ciascuna delle età preimmaginali. (Disegno L. Santini)<br />
Figura n. 21 – Visione dorsale delle cinque età<br />
giovanili, rispettivamente di prima (A), seconda (B),<br />
terza (C), quarta (D) e quinta (E) – (Foto Lucchi)<br />
Figura n. 22 – Secrezioni cerose prodotte da<br />
neanidi di M. <strong>pruinosa</strong><br />
22
BIOLOGIA<br />
La M. <strong>pruinosa</strong>, insetto estremamente polifago, attualmente segnalato su circa 330 specie<br />
appartenenti a 78 famiglie botaniche, compie un'unica generazione annuale e sverna allo<br />
stadio di uovo deposto tra le anfrattuosità <strong>della</strong> corteccia e tra le perule delle gemme delle<br />
piante ospiti.<br />
Nel <strong>Lazio</strong>, in base alle osservazioni effettuate in campo nel corso del 2003, 2004, 2005 e<br />
2007, la schiusura delle uova iniziava nella prima metà di maggio e raggiungeva il valore<br />
massimo tra la fine dello stesso mese e la prima decade di giugno, per poi decrescere<br />
gradualmente fino alla fine del medesimo mese. Le prime neanidi sono comparse entro la<br />
metà di maggio, mentre a giugno erano solitamente presenti tutti gli stadi giovanili del<br />
flatide. Le neanidi appena nate si spostavano rapidamente sulla pagina inferiore delle foglie<br />
e si fissavano in corrispondenza di una nervatura secondaria, dove iniziavano a nutrirsi.<br />
Durante le età neanidali, le neanidi risultavano poco mobili e si spostavano soltanto in<br />
occasione del cambio <strong>della</strong> muta. Nella fase degli stadi ninfali, questo insetto aveva la<br />
tendenza di spostarsi dalle foglie ai giovani rametti dell’anno, per ritornare sulle foglie al<br />
momento <strong>della</strong> muta. Dalla neanide di primo stadio alla formazione e comparsa dell’adulto,<br />
di solito è intercorso un periodo di 40 – 45 giorni. I primi adulti sono solitamente comparsi<br />
tra il 15 ed il 25 giugno. Gli adulti una volta sfarfallati e assunta la colorazione definitiva,<br />
grigio brunastro, si portavano sui rametti dove si disponevano allineati, per spostarsi intorno<br />
al ramo oppure compiere rapidi voli ogni qualvolta che venivano disturbati.<br />
Per individuare il periodo dell’ovideposizione <strong>della</strong> M. <strong>pruinosa</strong> nel <strong>Lazio</strong>, in tre siti diversi,<br />
nei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre del 2003,2004, 2005 e 2007, sono stati:<br />
catturati venti femmine di <strong>Metcalfa</strong>/sito, per valutare in laboratorio, attraverso il<br />
sezionamento dell’apparato genitale, il numero di uova pronte ad essere deposte;<br />
prelevati 10 rami/matrice vegetale di specie diverse <strong>della</strong> lunghezza di 50 cm<br />
(actinidia, vite, olmo, rovo)/sito ed esaminati in laboratorio per accertarsi<br />
sull’eventuale presenza di uova di <strong>Metcalfa</strong>.<br />
Tabella n. 7 – Ritrovamento di uova negli ovarioli delle femmine di M. <strong>pruinosa</strong><br />
N. Uova/femmina<br />
N. Uova/femmina<br />
N. Uova/femmina<br />
negli ovarioli<br />
negli ovarioli<br />
negli ovarioli<br />
X±SD (n = 20) X±SD (n = 20) X±SD (n = 20)<br />
Sito n. 1 - 2003 Sito n. 2 - 2003 Sito n. 3 - 2003<br />
20/07/03 20/08/03 21/09/03 21/07/03 20/08/03 21/09/03 20/07/0<br />
3<br />
20/08/03 21/09/03<br />
- 1,4 ± 3,6 20,6 ± 12,9 - - 14,1± 11,2 - 3,6 ± 5,7 27,0 ± 19,3<br />
Sito n. 1 - 2004 Sito n. 2 - 2004 Sito n. 3 - 2004<br />
15/07/04 26/08/04 30/09/04 15/07/04 26/08/04 30/09/04 15/07/04 26/08/04 30/09/04<br />
- 3,6 ± 6,8 16,3±11,2 - 1.6 ± 3,2 17,6 ± 15,3 - - 20,7 ±16,7<br />
Sito n. 1 - 2005 Sito n. 2 - 2005 Sito n. 3 - 2005<br />
22/07/05 20/08/04 23/09/04 22/07/05 20/08/04 23/09/04 22/07/05 20/08/04 23/09/04<br />
- 3,1±5,7 32,4±19,2 - - 22,3 ± 14,6 - 2,6 ± 6,8 16,9 ± 18,2<br />
23
Tabella n. 8 – Periodo dell’ovideposizione <strong>della</strong> M. <strong>pruinosa</strong> nel <strong>Lazio</strong> (1)<br />
Sito n. 1 - 2003<br />
N. uova/ramo<br />
X ± SD (n = 10)<br />
Sito n. 2 - 2003<br />
N. uova/ramo<br />
X ± SD (n = 10)<br />
Sito n. 3 - 2003<br />
N. uova/ramo<br />
X ± SD (n = 10)<br />
Date prelievo campioni<br />
20/08/03 21/09/03 20/08/03 21/09/03 20/08/03 21/09/03<br />
Olmo 2,0 ± 3,4 9,7 ± 9,9 7,3 ± 7,1 14,7 ± 14,3 1,2 ± 3,2 20,1 ± 14,2<br />
Vite 2,3 ± 2,7 9,1 ± 8,6 - - 3,5 ± 5,2 10,7 ± 11,4<br />
Rovo - - 2,5 ± 3,3 14,5 ± 11,7 - -<br />
Actinidia 0,9 ± 1,5 5,8 ± 6,9 1,1 ± 1,5 8,5 ± 11,5 2,5 ± 37 6,5 ± 7,8<br />
Sito n. 1 - 2004<br />
N. uova/ramo<br />
X ± SD (n = 10)<br />
Sito n. 2 - 2004<br />
N. uova/ramo<br />
X ± SD (n = 10)<br />
Sito n. 3 - 2004<br />
N. uova/ramo<br />
X ± SD (n = 10)<br />
Date prelievo campioni<br />
26/08/04 30/09/04 26/08/04 30/09/04 26/08/04 30/09/04<br />
Olmo 2,5 ± 5,4 17,3 ± 16,2 5,2 ± 7,1 11,3 ± 10,4 1,2 ± 3,2 20,1 ± 14,2<br />
Vite 5,1 ± 7,4 14,3 ± 16,3 - - 3,1 ± 5,3 7,4 ± 7,2<br />
Rovo - - 3,2 ± 5,4 7,2 ± 7,8 - -<br />
Actinidia 2,5 ± 4,1 4,5 ± 7,6 2,0 ± 3,4 6,7 ± 11,3 1,3 ± 2,6 4.0 ± 4,1<br />
(1) Prelevati 10 rami/matrice vegetale di specie diverse <strong>della</strong> lunghezza di 50 cm (actinidia, vite, olmo,<br />
rovo)/sito ed esaminati in laboratorio per accertarsi sull’eventuale presenza di uova di <strong>Metcalfa</strong>.<br />
In base ai dati ottenuti nell’Agropontino, riportati nelle tabelle 7 e 8, la M. <strong>pruinosa</strong> inizia a<br />
deporre le uova a partire dalla terza decade di Agosto, per aumentare a livello significativo<br />
nel mese di Settembre e terminare verso la fine dello stesso mese, oppure i primi giorni di<br />
ottobre. nel mese di Ottobre. Sia nel 2004 che nel 2005, nel mese di Luglio, non sono state<br />
trovate femmine, tra quelle sezionate in laboratorio, con ovarioli con presenza di uova.<br />
L’olmo, la vite e il rovo si sono mostrate piante ospiti particolarmente gradite per la<br />
<strong>Metcalfa</strong> durante l’ovideposizione, mentre sui campioni di rami di Actinidia, la quantità di<br />
uova trovate è risultata sensibilmente inferiore rispetto a quella delle altre specie esaminate.<br />
Le uova sono state trovate sia sulle creste tuberose che si sviluppano su alcune varietà di<br />
Olmo, che nel nel ritidoma delle piante di viti ed in alcune parti del fusto dei rovi, mentre<br />
sull’actinidia sono state trovate nelle anfrattuosità <strong>della</strong> corteccia del fusto oppure dei rami<br />
più vecchi.I dati raccolti nel 2007 tendenzialmente rispecchiano i dati raccolti negli anni<br />
precedenti(2003, 2004 e 2005).<br />
24
Figura n. 15 – Biologia <strong>della</strong> M. <strong>pruinosa</strong> nel <strong>Lazio</strong><br />
Figura n. 16 – Attacco di <strong>Metcalfa</strong> su Acero Figura n. 17 – Attacco di <strong>Metcalfa</strong> su Melo<br />
Figura n. 18 – Attacco di <strong>Metcalfa</strong> su Pesco<br />
<strong>Controllo</strong> Biologico <strong>della</strong> <strong>Metcalfa</strong> <strong>pruinosa</strong>.<br />
25
I siti dov’è avvenuta l’introduzione del parassita N. tiphlocybae, oltre al monitoraggio<br />
riportato nella prima annualità del progetto medesimo, ulteriori controlli sono stati eseguiti<br />
negli anni 2004, 2005 e 2007, riportando per ogni sito il numero di bozzoli ritrovati nei mesi<br />
di Luglio, Agosto e Settembre, nonché le relative piante ospiti. Inoltre, nel mese di agosto, è<br />
stata prestata attenzione per ricercare le neanidi di terza età, nonché le ninfe di prima e<br />
seconda età con la presenza del cosiddetto “bubbone” (cisti), sotto l’inserzione degli abbozzi<br />
alari, segno evidente <strong>della</strong> fase iniziale <strong>della</strong> parassitizzazione degli individui di <strong>Metcalfa</strong> ad<br />
opera del N. tiphlocybae. Sono state rilevate, infine, le distanze del ritrovamento dei bozzoli,<br />
rispetto al punto d’introduzione del parassita. I dati raccolti dal 2004 al 2007 sono riportati<br />
nella sotto indicata tabella n. 9.<br />
Sito<br />
n.<br />
Tabella n. 9 - Bozzoli di N. typhlocybae ritrovati nei siti d’introduzione nel 2004<br />
Ubicazione<br />
Azienda<br />
1 Via Apriliana<br />
(LT)<br />
Aprilia<br />
2 Via Nettuno<br />
(RM)<br />
Velletri<br />
3 Via di Nettuno<br />
Velletri (RM)<br />
25/07/04<br />
N. bozzoli/sito<br />
86<br />
Olmo e Rovo<br />
35<br />
Olmo e Rovo<br />
22<br />
Olmo e Rovo<br />
10/08/04<br />
N. bozzoli/sito<br />
10/08/04<br />
N. Larve di<br />
<strong>Metcalfa</strong> con<br />
“bubbone”<br />
135<br />
Olmo e Rovo 10<br />
115<br />
Olmo, Rovo 15<br />
Actinidia<br />
93<br />
Olmo, Rovo<br />
e Vite<br />
5<br />
18/09/04<br />
N. bozzoli/sito<br />
Distanza<br />
massima dal<br />
punto di<br />
lancio<br />
ml<br />
72<br />
35<br />
Olmo e Rovo<br />
82<br />
Olmo e Rovo 42<br />
45<br />
Olmo e Rovo<br />
4 Via Crocetta di Carano<br />
Aprilia (LT) - - - - -<br />
5 Martin – Via<br />
Campovivo - Cisterna - - - - -<br />
6 Borgo Montello (LT) 56<br />
Vite e Crataegus<br />
7 Borgo Montello (LT)<br />
-<br />
175<br />
Vite, Crataegus e<br />
Actinidia<br />
28<br />
60<br />
Olmo -<br />
88<br />
Vite e Crataegus<br />
32<br />
Olmo<br />
8 Acciarella – Nettuno<br />
(RM) - - - - -<br />
9 Via Ninfina II 45<br />
Olmo e Rovo<br />
10 Via Reynolds -<br />
Cisterna<br />
30<br />
Olmo e Rovo<br />
178<br />
Olmo e Rovo<br />
129<br />
Olmo e Rovo<br />
18 93<br />
Olmo e Rovo<br />
48<br />
60<br />
30<br />
65<br />
17 56<br />
Olmo e Rovo 60<br />
Tabella n. 10 - Bozzoli di N. typhlocybae ritrovati nei siti d’introduzione nel 2005<br />
26
Sito<br />
n.<br />
Ubicazione<br />
Azienda<br />
1 Via Apriliana<br />
(LT)<br />
Aprilia<br />
2 Via Nettuno<br />
(RM)<br />
Velletri<br />
3 Via di Nettuno<br />
Velletri (RM)<br />
22/07/05<br />
N. bozzoli/sito<br />
58<br />
Olmo e Rovo<br />
37<br />
Olmo e Rovo<br />
50<br />
Olmo e Rovo<br />
13/08/05<br />
N. bozzoli/sito<br />
325<br />
Olmo e Rovo<br />
270<br />
Olmo, Rovo<br />
Actinidia<br />
119<br />
Olmo, Rovo<br />
e Vite<br />
13/08/05<br />
N. Larve di<br />
<strong>Metcalfa</strong> con<br />
“bubbone”<br />
23/09/05<br />
N. bozzoli/sito<br />
12 72<br />
Olmo e Rovo<br />
Distanza<br />
massima dal<br />
punto di<br />
lancio<br />
ml<br />
45<br />
18 158<br />
Olmo e Rovo 58<br />
10 60<br />
Olmo e Rovo<br />
4 Via Crocetta di Carano<br />
Aprilia (LT) - - - - -<br />
5 Martin – Via<br />
Campovivo - Cistern - - - - -<br />
6 Borgo Montello (LT) 72<br />
Vite e Crataegus<br />
7 Borgo Montello (LT) 20<br />
Olmo<br />
508<br />
Vite, Crataegus e<br />
Actinidia<br />
43<br />
95<br />
Olmo e Rovo -<br />
354<br />
Vite e Crataegus<br />
52<br />
Olmo e Rovo<br />
8 Acciarella – Nettuno<br />
(RM) - - - - -<br />
9 Via Ninfina II 93<br />
Olmo e Rovo<br />
10 Via Reynolds -<br />
Cisterna<br />
Sito<br />
n.<br />
385<br />
Olmo e Rovo<br />
- 242<br />
Olmo e Rovo<br />
64<br />
85<br />
40<br />
30 209<br />
Olmo e Rovo<br />
120<br />
25 156<br />
Olmo e Rovo 85<br />
Tabella n. 11 - Bozzoli di N. typhlocybae ritrovati nei siti d’introduzione nel 2007<br />
Ubicazione<br />
Azienda<br />
1 Via Apriliana<br />
(LT)<br />
Aprilia<br />
2 Via Nettuno<br />
(RM)<br />
Velletri<br />
20/07/07<br />
N. bozzoli/sito<br />
25<br />
Olmo e Rovo<br />
20<br />
Olmo e Rovo<br />
3 Via di Nettuno<br />
Velletri (RM) -<br />
18/08/07<br />
N. bozzoli/sito<br />
205<br />
Olmo e Rovo<br />
147<br />
Olmo, Rovo<br />
Actinidia<br />
119<br />
Olmo e Rovo<br />
18/08/07<br />
N. Larve di<br />
<strong>Metcalfa</strong> con<br />
“bubbone”<br />
27/09/07<br />
N. bozzoli/sito<br />
7 122<br />
Olmo e Rovo<br />
10 95<br />
Olmo e Rovo<br />
10 70<br />
Olmo e Rovo<br />
Distanza<br />
massima dal<br />
punto di<br />
lancio ml<br />
4 Via Crocetta di Carano<br />
Aprilia (LT) - - - - -<br />
5 Martin – Via<br />
Campovivo - Cisterna - - - - -<br />
6 Borgo Montello (LT) 50<br />
210<br />
23 112 110<br />
Vite e Crataegus Vite e Crataegus<br />
Vite e Crataegus<br />
7 Borgo Montello (LT) 10<br />
85<br />
5 70<br />
60<br />
Olmo e Rovo Olmo e Rovo<br />
Olmo e Rovo<br />
8 Acciarella<br />
(RM)<br />
– Nettuno<br />
- - - - -<br />
9 Via Ninfina II 61<br />
Olmo e Rovo<br />
10 Via Reynolds -<br />
Cisterna<br />
15<br />
Olmo e Rovo<br />
211<br />
Olmo e Rovo<br />
192<br />
Olmo e Rovo<br />
60<br />
70<br />
78<br />
8 145<br />
Olmo e Rovo<br />
140<br />
6 110<br />
Olmo e Rovo 85<br />
27
Figura 18 - Epoche di farfallamento di N. typhlocybae in relazione alla presenza dei diversi stadi preimmaginali di M.<br />
<strong>pruinosa</strong><br />
Nel 2004, nella seconda decade di Luglio, al momento dell’ispezione dei siti d’introduzione<br />
del parassita è stato constato che tre di questi siti (nn. 4, 5 e 8) erano da scartare perché non<br />
presentavano bozzoli di Neodryinus e la popolazione di <strong>Metcalfa</strong> si era drasticamente<br />
ridotta. In effetti nel 2003, in questi siti è stato trovato un basso numero di bozzoli del<br />
parassita in questione, segno evidente che qualche fattore ha giocato negativamente<br />
sfavorendo l’insediamento del N. typhlocybae. In particolare nel sito n. 8, dove prima<br />
dell’introduzione del parassita, (seconda decade di giugno 2003) era stata osservata<br />
un’elevata popolazione di neanidi e ninfe di <strong>Metcalfa</strong>. Sebbene le condizioni<br />
apparentemente sembravano ideali, ma sia nell’ispezione di Luglio che in quella di Agosto<br />
sono stati trovati pochi bozzoli di Neodryinus (< 10). La cosa ancora più strana di questo sito<br />
era che l’abbondante popolazione di neanidi e ninfe di <strong>Metcalfa</strong> era scomparsa nella misura<br />
del 70% circa. Ciò potrebbe significare che il sito sia stato disturbato per qualche motivo,<br />
oppure è stato effettuato qualche trattamento con agrofarmaci senza essere informati. Altra<br />
ipotesi sulla scarsa presenza di bozzoli riscontrata nel sito n. 8 potrebbe dovuta<br />
all’abbondanza <strong>della</strong> vegetazione e quindi all’impossibilità tecnica di ispezionare tutta la<br />
massa vegetativa del sito in questione.<br />
Sui siti nn. 4 e 5 abbiamo rilevato un livello di popolazione intermedio di <strong>Metcalfa</strong>, ma<br />
anche qui i bozzoli del parassita erano poco frequenti, soprattutto nelle ispezioni di Agosto<br />
e Settembre, con la conseguente conferma nel 2004 circa dell’assenza completa di bozzoli di<br />
N. typhlocybae in questi siti.<br />
Negli altri sette siti il N. typhlocybae si é insediato con successo, in grado di svernare<br />
nell’Agropontino e di mantenere il sincronismo con suo ospite, la M. <strong>pruinosa</strong>. I dati<br />
raccolti nel 2004, 2005 e 2007 sono una chiara conferma, dove come indicato nelle tabelle<br />
nn. 9 – 10 e 11, il numero di bozzoli è sensibilmente cresciuto negli anni 2004 e 2005,<br />
mentre nel 2007 il numero di bozzoli rilevato è sensibilmente diminuito. La diminuzione<br />
delle popolazioni di N. typhlocybae è coinciso con la diminuzione delle popolazioni di<br />
<strong>Metcalfa</strong>, probabilmente dovuto al fatto che durante i mesi invernali del 2007, le<br />
temperature si sono mantenute significativamente al di sopra delle medie stagionali e quindi<br />
mancanza delle ore di freddo necessarie per le uova di <strong>Metcalfa</strong> per il completamento <strong>della</strong><br />
diapausa. Per quanto riguarda le uova diapausanti, la letteratura riporta il caso <strong>della</strong> zanzara<br />
tigre (Aedes albopictus), dove viene riferito che la temperatura gioca un ruolo importante<br />
nell’induzione <strong>della</strong> diapausa, lo stesso meccanismo molto probabilmente si verifica per le<br />
uova svernanti di <strong>Metcalfa</strong>.<br />
Un importante questione sulla limitazione dell’attività del driinide negli areali del <strong>Lazio</strong> va<br />
individuata nel ritrovamento di iperparassiti del N. typhlocybae, a seguito dell’ispezione<br />
28
condotta a Ottobre del 2007 da parte del Prof. Olmi dell’Università <strong>della</strong> Tuscia, dove circa<br />
il 25 % dei bozzoli raccolti evidenziava, la presenza dell’iperparassita Cheiloneurus<br />
boldyrevi .<br />
L’attività di sperimentazione condotta nel <strong>Lazio</strong> con N. typhlocybae ha fornito risultati<br />
positivi e senza dubbio incoraggianti. Questo parassita ha mostrato complessivamente una<br />
buona plasticità di adattamento alle differenti condizioni ambientali delle diverse località<br />
d’introduzione, però la riduzione delle infestazioni delle popolazioni del flatide non è ancora<br />
apprezzabile a livello territoriale. Il fatto importante è quello dell’avvenuto insediamento,<br />
perché i programmi di controllo si inquadrano nel contesto del lungo periodo.<br />
L’insediamento stabile del driinide in una nuova area implica necessariamente sia<br />
l’ottimizzazione di diversi fattori quali la qualità e il numero degli individui introdotti, la<br />
disponibilità dell’ospite, la tecnica di lancio, sia l’individuazione di eventuali fattori<br />
depressivi che possono interferire sull’esito positivo dell’insediamento, senza comunque<br />
trascurare la protezione delle aree d’introduzione.<br />
La lotta chimica con prodotti a basso impatto ambientale. Poiché il presente progetto ha<br />
finalità di divulgazione e non di ricerca pura, è stato previsto l’utilizzo di principi attivi<br />
registrati su Actinidia che attualmente sono:<br />
Azadiractina (Registrazione n. 10305 del 03/02/2000 del Ministero <strong>della</strong> Sanità<br />
(SIPCAM); classe tossicologica : Attenzione manipolare con prudenza (ex III<br />
classe). Intervallo di sicurezza su Actinidia: 3 gg.<br />
Suddetto principio attivo é una sostanza naturale estratta dai semi <strong>della</strong> pianta del<br />
Neem, la quale appartiene alla famiglia delle Miliaceae e risulta originaria del Nord-<br />
Est dell’India. Si tratta di un prodotto assolutamente innocuo per l’uomo e non<br />
risulta tossico per le api e per molti ausiliari e viene impiegato nell’Agricoltura<br />
Biologica.<br />
L’Azadiractina ha diverse modalità di azione : blocco dell’attività<br />
troficadell’insetto, con riduzione sensibile dell’attività e collassamento <strong>della</strong><br />
popolazione; azione sugli stadi giovanili come regolatore di crescita, provocando il<br />
blocco dell’attività trofica e <strong>della</strong> muta, con conseguente mortalità.<br />
Lambda-Cyhalothrin (Registrazione n. 8259 del 04/05/1993 del Ministero <strong>della</strong><br />
Sanità (SYNGENTA – ex SOLPLANT); classe tossicologica : irritante (ex III<br />
classe). Intervallo di sicurezza su Actinidia : 7 gg.<br />
Suddetto principio attivo é un piretroide di sintesi che agisce per contatto ed<br />
ingestione; si caratterizza per un rapido potere abbattente ed una persistente capacità<br />
protettiva; possiede un effetto repellente ed evidenzia la propria attività anche con<br />
piccole quantità di principio attivo.<br />
Etofenprox (Registrazione n. 8735 del 23/03/1995 del Ministero <strong>della</strong> Sanità<br />
(SIPCAM); classe tossicologica : irritante (ex III classe). Intervallo di sicurezza su<br />
Actinidia : 7 gg.<br />
L’etofenprox é un fenossiderivato che agisce per contatto ed ingestione; interferisce,<br />
inoltre, sul sistema nervoso degli insetti mediante inibizione del trasporto degli ioni<br />
Sodio lungo le terminazioni nervose. La molecola dell’etofenprox é costituita<br />
unicamente da Carbonio, Idrogeno e Ossigeno; ha una bassissima tossicità acuta nei<br />
confronti dell’uomo e dei mammiferi.<br />
29
Nel 2007 sono testati nuovamente gli stessi principi attivi utilizzati nel 2003 con<br />
infestazioni artificiali di giovani piante di Actinidia in gabbie preparate in laboratorio<br />
seguendo le procedure utilizzate nel 2003.<br />
I risultati, sostanzialmente similari a quelli del 2003, mostrano un’elevata efficacia, però la<br />
lotta chimica contro la <strong>Metcalfa</strong> risulta difficile come di seguito spiegato in dettaglio. La<br />
lotta chimica, indipendentemente dal tipo di principio attivo impiegato risulta in diversi<br />
casi poco agevole per i seguenti motivi:<br />
la scalarità <strong>della</strong> schiusura delle uova che si protrae, a seconda delle zone, per circa due<br />
mesi, Maggio e Giugno, ed in alcuni casi anche nella prima metà di Luglio, per cui si rende<br />
necessario effettuare più trattamenti per contenere le forme giovanili;<br />
la capacità dell’insetto di infeudarsi su un numero elevato di specie vegetali;<br />
la mobilità degli adulti;<br />
la tendenza da parte <strong>della</strong> M. <strong>pruinosa</strong> di colonizzare la pagina inferiore delle foglie vicinoal<br />
terreno, per cui i trattamenti risultano poco efficaci;<br />
la protezione che la cera, prodotta dagli stadi giovanili, offre contro l’applicazione di<br />
alcunifitofarmaci;<br />
il trattamento con insetticidi può causare un notevole danno agli antagonisti naturali e agli<br />
insetti impollinatori attirati dalla melata.<br />
Per ridurre le popolazioni di <strong>Metcalfa</strong> si può intervenire, se necessario, con 1 - 2 trattamenti<br />
utilizzando i principi attivi sopra indicati in situazioni dove l’infestazione è tendenzialmente<br />
bassa. In situazioni di infestazioni elevate, dopo aver effettuato il primo trattamento e quindi<br />
ridotta e/o eliminata la popolazione di <strong>Metcalfa</strong> presente su Actinidia, interventi successivi<br />
devono essere eseguiti solo nei casi in cui si ripresenta una nuova infestazione proveniente<br />
dalla vegetazione spontanea circostante. Talvolta interventi successivi non sono necessari<br />
perché la popolazione di <strong>Metcalfa</strong> rimane legata esclusivamente alla vegetazione spontanea<br />
e non si sposta su Actinidia.<br />
Allorché si presenta un’infestazione di <strong>Metcalfa</strong> su Actinidia, si consiglia di limitare il<br />
trattamento soltanto nelle zone dell’impianto dove si osservano infestazioni di questo<br />
insetto. Con tale accortezza si ottengono due importanti obiettivi:<br />
impiego inferiori di quantità di prodotto e quindi minore esborso di danaro;<br />
inferiori quantità di prodotto distribuiti nell’ambiente significa minor tasso<br />
di inquinamento ambientale, da tenere costantemente presente se si vuole<br />
conservare un ambiente sano per noi e per le generazioni future.<br />
Sarebbe consigliabile non trattare le aree con la vegetazione spontanea, oppure se necessario<br />
effettuare i trattamenti nelle zone dove risultano presenti le popolazioni di <strong>Metcalfa</strong>, perché<br />
queste microzone rappresentano il rifugio di diverse specie di insetti, compreso quelli utili.<br />
Le monocolture, infatti, non proteggono le diverse specie legate alla flora e alla fauna. Il<br />
Professor Silvestri, eminente Professore di Entomologia dell’Università degli Studi di<br />
Napoli - Facoltà di Agraria di Portici - profondo conoscitore delle problematiche legate al<br />
controllo <strong>biologico</strong> degli insetti dannosi all’agricoltura, negli anni trenta/quaranta suggeriva<br />
di proteggere la vegetazione delle ripe e dei fossi in quanto tutelano e conservano i valori<br />
<strong>della</strong> biodiversità.<br />
30
ATTIVITA’ SVOLTA NEL 2008<br />
Poiché il progetto <strong>Metcalfa</strong> ha una durata di 18 mesi e tenendo presente che è iniziato i primi di<br />
aprile del 2007, l’attività di sperimentazione e raccolta dati si è prolungata fino alla fine di ottobre<br />
del 2008, momento di chiusura del ciclo <strong>biologico</strong> <strong>della</strong> <strong>Metcalfa</strong> <strong>pruinosa</strong> per l’anno in corso, che<br />
si è realizzato con l’ovideposizione delle uova svernanti che schiuderanno a partire dal mese di<br />
maggio 2009.<br />
Costituzione mappa territoriale sullo stato di diffusione <strong>della</strong> <strong>Metcalfa</strong> <strong>pruinosa</strong> . Per il 2008,<br />
questi ulteriori dati sono stati raccolti sia da personale partecipante al progetto (Tabella n. 12), sia<br />
attraverso dati ricevuti da aziende agricole e vivai (Tabella n. 13).<br />
Tabella n. 12 - Diffusione <strong>della</strong> <strong>Metcalfa</strong> <strong>pruinosa</strong> nel <strong>Lazio</strong> e piante ospiti<br />
Dati raccolti dal personale partecipante al progetto: maggio/giugno 2008<br />
Località Piante ospiti Località Piante ospiti<br />
Viterbo Robinia, Acero e Platano Vetralla (VT) Rovo, Olmo e Olivo<br />
Allumiere (VT) Pomodoro Bracciano (RM) Pittosporo e Robinia<br />
Pescia Romana (VT) Pomodoro e Acero I Terzi (RM) Acero e Lauroceraso<br />
Montefiascone (VT) Pomodoro Lavinio (RM) Rovo e Olmo<br />
Attigliano (VT) Olmo e Acero Cerveteri (RM) Zinnia e Rovo<br />
Tarquinia (VT) Ortica, Olmo e Vite Canino (RM) Olivo<br />
Civitavecchia (RM) Rovo e Robinia Frascati (RM) Vite<br />
S. Marinella (RM) Olivo, Vite Maccarese (RM) Robinia<br />
Tabella n. 13 - Diffusione <strong>della</strong> <strong>Metcalfa</strong> <strong>pruinosa</strong> nel <strong>Lazio</strong> e piante ospiti<br />
Dati raccolti attraverso invio questionari inviati ad Aziende agricole e Vivai : giugno 2008<br />
Località Piante ospiti Località Piante ospiti<br />
Vetralla Rovo e Pittosporo Velletri (RM) Actinidia e Vite<br />
Civitavecchia Agrumi, Geranio,<br />
Solanum e Acero Cisterna (LT) Actinidia, Vite e Olivo<br />
Minturno (LT) Olivo Geranio e Ligustro Sutri (VT) Geranio, Cotoneaster e<br />
Pyracantha<br />
Bolsena (VT) Rovo, Olmo, Mirto e Montelibretti (RM) Bosso, Acero, Geranio,<br />
Nocciolo<br />
Lauro, Ligustro<br />
Frascati Geranio, Olivo e Vite Monterotondo (RM) Bosso e Acero,<br />
Terracina (LT) Platano Moricone (RM) Pittosporo, Prunus<br />
Civitavecchia (RM) Cotoneaster,<br />
Prunus<br />
Ciliegio e Nettuno (RM) Quercia e Lauroceraso,<br />
Aprilia (LT) Acero, Vite, Actinidia Velletri (RM) Actinidia<br />
Roma Acero, Nocciolo, Geranio,<br />
Fico, Platano, Albicocco<br />
Montefiascone (VT) Rovo, Olmo, e Mirto<br />
31
Per il 2008 sono stati raccolti dati di 34 località distribuite nel <strong>Lazio</strong>, rilevando popolazioni di<br />
<strong>Metcalfa</strong> (neanidi, ninfe e adulti) su 27 essenze diverse, sia erbacee che arboree.<br />
Biologia <strong>della</strong> <strong>Metcalfa</strong> <strong>pruinosa</strong> nel <strong>Lazio</strong>. – Osservazioni condotte nel 2008<br />
Nel 2008 in base alle osservazioni effettuate in campo nelle aree in provincia di Latina, dove è stato<br />
introdotto il parassita Neodrynus typhlocybae, la schiusura delle uova è iniziata nella prima<br />
settimana di maggio, mentre le prime neanidi sono state osservate a distanza di sette/dieci giorni.<br />
All’inizio del mese di giugno è stata osservata la presenza di tutti gli stadi giovanili del flatide. Le<br />
neanidi appena nate si spostavano rapidamente sulla pagina inferiore delle foglie e si fissavano in<br />
corrispondenza di una nervatura secondaria, dove iniziavano a nutrirsi. Durante le età neanidali, le<br />
neanidi risultavano poco mobili e si spostavano soltanto in occasione del cambio <strong>della</strong> muta. Nella<br />
fase degli stadi ninfali, questo insetto aveva la tendenza di spostarsi dalle foglie ai giovani rametti<br />
dell’anno, per ritornare sulle foglie al momento <strong>della</strong> muta. Dalla neanide di primo stadio alla<br />
formazione e comparsa dell’adulto, è intercorso mediamente un periodo medio di 45 giorni. I primi<br />
adulti sono comparsi tra il 10 ed il 20 giugno. Gli adulti una volta sfarfallati e assunta la colorazione<br />
definitiva, grigio brunastro, si portavano sui rametti dove si disponevano allineati, per spostarsi<br />
intorno al ramo oppure compiere rapidi voli ogni qualvolta che venivano disturbati. Nel 2008 le<br />
prime ovideposizioni di <strong>Metcalfa</strong> sono state ritrovate a fine agosto su piante di vite ed olmo.<br />
<strong>Controllo</strong> Biologico <strong>della</strong> <strong>Metcalfa</strong> <strong>pruinosa</strong><br />
Nel 2008, nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre, sono stati monitorati i siti d’’introduzione del<br />
parassita N. tiphlocybae, oltre al monitoraggio riportato nella prima annualità del progetto<br />
medesimo, ulteriori controlli sono stati eseguiti negli anni 2004, 2005 e 2007, riportando per ogni<br />
sito il numero di bozzoli ritrovati nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre, nonché le relative piante<br />
ospiti. Inoltre, nel mese di agosto, è stata prestata attenzione per ricercare le neanidi di terza età,<br />
nonché le ninfe di prima e seconda età con la presenza del cosiddetto “bubbone” (cisti), sotto<br />
l’inserzione degli abbozzi alari, segno evidente <strong>della</strong> fase iniziale <strong>della</strong> parassitizzazione degli<br />
individui di <strong>Metcalfa</strong> ad opera del N. tiphlocybae. Sono state rilevate, infine, le distanze del<br />
ritrovamento dei bozzoli, rispetto al punto d’introduzione del parassita. I dati raccolti nel 2008 sono<br />
riportati nella sotto indicata tabella n. 14.<br />
A fine ottobre del 2008, il Prof. Olmi dell’Università degli Studi <strong>della</strong> Tuscia ha condotto<br />
un’ispezione sui siti dove erano presenti i bozzoli di Neodriynus, prelevando per ogni sito un<br />
campione di venti bozzoli per un totale di sette siti. Questi bozzoli sono stati esaminati in<br />
laboratorio, evidenziando la presenza dell’iperparassita Cheiloneurus boldyrevi. Il 28% dei bozzoli<br />
esaminati risultava attaccato da questo iperparassita.<br />
32
Sito<br />
n.<br />
Tabella n. 14 - Bozzoli di N. typhlocybae ritrovati nei siti d’introduzione nel 2008<br />
Ubicazione<br />
Azienda<br />
1 Via Apriliana<br />
(LT)<br />
Aprilia<br />
2 Via Nettuno<br />
(RM)<br />
Velletri<br />
3 Via di Nettuno<br />
Velletri (RM)<br />
28/07/08<br />
N. bozzoli/sito<br />
32<br />
Olmo e Rovo<br />
6<br />
Olmo e Rovo<br />
7<br />
Olmo e Rovo<br />
19/08/08<br />
N. bozzoli/sito<br />
45<br />
Olmo e Rovo<br />
29<br />
Olmo, Rovo<br />
Actinidia<br />
45<br />
Olmo, Rovo<br />
e Vite<br />
19/08/08<br />
N. Larve di<br />
<strong>Metcalfa</strong> con<br />
“bubbone”<br />
26/09/08<br />
N. bozzoli/sito<br />
Distanza<br />
massima dal<br />
punto di<br />
lancio<br />
ml<br />
5 18<br />
Olmo e Rovo<br />
41<br />
10 23<br />
Olmo e Rovo 36<br />
12 30<br />
Olmo e Rovo<br />
4 Via Crocetta di Carano<br />
Aprilia (LT) - - - - -<br />
5 Martin – Via<br />
Campovivo - Cisterna - - - - -<br />
6 Borgo Montello (LT) 5<br />
Vite e Crataegus<br />
79<br />
Vite, Crataegus e<br />
Actinidia<br />
7 Borgo Montello (LT) 31 44<br />
Olmo<br />
19<br />
61<br />
Vite e Crataegus<br />
5 16<br />
Olmo<br />
8 Acciarella – Nettuno<br />
(RM) - - - - -<br />
9 Via Ninfina II 31<br />
Olmo e Rovo<br />
10 Via Reynolds -<br />
Cisterna<br />
35<br />
Olmo e Rovo<br />
105<br />
Olmo e Rovo<br />
81<br />
Olmo e Rovo<br />
24 78<br />
Olmo e Rovo<br />
20 61<br />
Olmo e Rovo<br />
Rispetto agli anni precedenti nei diversi siti d’introduzione del parassita, nel 2008 è stata osservata<br />
sia una significativa riduzione delle popolazioni di <strong>Metcalfa</strong>, sia un inferiore numero di bozzoli,<br />
dovuto molto probabilmente ad una minore disponibilità di “pabulum” per il Neodriynus<br />
typhlocybae.<br />
Prove con prodotti a basso impatto ambientale contro la <strong>Metcalfa</strong> <strong>pruinosa</strong><br />
Nel 2008 non sono state effettuate prove con prodotti a basso impatto ambientale, in quanto i<br />
risultati acquisiti negli anni precedenti erano sufficienti e validi per impostare un eventuale<br />
programma di lotta, qualora risultasse necessario.<br />
CONCLUSIONI<br />
I risultati del presente progetto mettono in condizione le aziende laziali produttrici di frutti di<br />
Actinidia di applicare le medesime metodologie di controllo <strong>della</strong> <strong>Metcalfa</strong> già utilizzate in altre<br />
Regioni d’Italia, dove la <strong>Metcalfa</strong> ha fatto la sua comparsa da più tempo. I beneficiari sono<br />
41<br />
75<br />
35<br />
75<br />
80<br />
33
innanzitutto i circa 2.000 agricoltori dell’Agro Pontino che coltivano circa 8.000 ettari di Actinidia,<br />
con una produzione annua di circa 1.300.000 q.li di frutti.<br />
Anche se negli ultimi due anni (2007 e 2008), la densità delle popolazioni di <strong>Metcalfa</strong> si è<br />
notevolmente ridotta nel <strong>Lazio</strong> e gli attuali livelli d’infestazione sono meno preoccupanti rispetto a<br />
qualche anno fà, non bisogna dimenticarsi del problema, ma piuttosto approfondirlo<br />
scientificamente per meglio comprendere le possibili cause di tale fenomeno.<br />
La riduzione di densità delle popolazioni di <strong>Metcalfa</strong> potrebbe essere dovuta all’azione svolta da<br />
parte Neodriynus, che in base ai nostri dati si era ampiamente diffuso e moltiplicato nei diversi siti<br />
d’introduzione, ma per ben inquadrare l’effettiva azione dell’agente <strong>biologico</strong> introdotto sarebbe<br />
opportuno approfondire gli aspetti di seguito indicati :<br />
1. verificare se, oltre al parassita introdotto, Neodrynus typhlocybae, parassiti e/o predatori<br />
endogeni attaccano i diversi stadi di questo flatide;<br />
2. verificare attraverso analisi di finger printing, se il ceppo di provenienza è uno solo, con<br />
l’individuazione <strong>della</strong> relativa area di provenienza, oppure si tratta di introduzioni multiple<br />
con l’accertamento delle possibili diverse aree di provenienza.<br />
Negli Stati Uniti la <strong>Metcalfa</strong> <strong>pruinosa</strong> é diffusa sia in zone fredde che in zone calde, come per<br />
esempio il Texas.<br />
Se la <strong>Metcalfa</strong> introdotta in Italia, dovesse provenire da zone fredde, si potrebbe ipotizzare la<br />
possibilità negli ultimi due anni, in presenza di inverni miti, una scarsa chiusura delle uova, dovuta<br />
al mancato accumulo delle necessarie ore di freddo, che molto probabilmente non hanno consentito<br />
il corretto svolgimento del processo di diapausa.<br />
Se fosse vera tale ipotesi significherebbe che nel <strong>Lazio</strong>, il ceppo di <strong>Metcalfa</strong> <strong>pruinosa</strong> presente nel<br />
<strong>Lazio</strong> proviene da zone fredde, il quale dapprima è esploso in condizioni ambientali favorevoli e<br />
che successivamente si è bloccato in presenza di condizioni ambientali avverse, oppure per<br />
l’interferenza di nemici naturali.<br />
In linea generale un organismo esotico, introdotto in un nuovo areale, dapprima in condizioni<br />
climatiche favorevoli ed in assenza di nemici naturali, sviluppa delle sovra popolazioni e soltanto<br />
nel tempo, nel momento in cui predatori e/o parassiti endogeni, si adattano ad attaccare questa<br />
nuova entità la densità delle popolazioni dell’organismo target si riduce. Altra soluzione per ridurre<br />
l’impatto delle popolazioni dell’organismo target è quella dell’introduzione di parassiti, provenienti<br />
dalle aree dell’organismo esotico. In tal modo ristabilisce, anche se non in modo completo, il<br />
bilancio dell’equilibrio naturale.<br />
I primi risultati dell’insediamento del Neodryinus nell’area dell’Agropontino sono un esempio di<br />
sana e corretta gestione del territorio e dal momento in cui il parassita sarà in grado effettivamente<br />
di controllare una percentuale significativa delle popolazioni di <strong>Metcalfa</strong> si avrà una ricaduta<br />
positiva non solo nell’ambito dei coltivatori di Actinidia, ma anche su altre colture, come per<br />
esempio la vite e l’olivo, nonché nelle aree destinate a verde pubblico, dove ci sarà meno disagio<br />
per i cittadini sia per effetto <strong>della</strong> riduzione di melata su manufatti vari, sia perché, in presenza del<br />
parassitoide, N. typhlocybae, non é necessario intervenire con mezzi chimici.<br />
34
L’approccio del controllo <strong>biologico</strong>, rispetto ad altri mezzi di lotta, anche se all’inizio risulta più<br />
lento, in quanto il parassita introdotto richiede un certo periodo di tempo per acclimatarsi,<br />
stabilizzarsi e diffondersi sul territorio, ma superati queste fasi il parassita controlla il suo<br />
antagonista, riducendo in molti casi, la densità di popolazione dell’insetto target al di sotto <strong>della</strong><br />
soglia economica, rendendo stabili e duraturi i risultati ottenuti. Con il controllo <strong>biologico</strong> non si<br />
eradicano del tutto gli insetti dannosi, ma si riesce spesso a portare la loro densità al di sotto <strong>della</strong><br />
soglia economica e quindi ottenere risultati ecologicamente puliti.<br />
BIBLIOGRAFIA<br />
Alma A., Ferracini C. & Bugio (2005) – Development of a Sequential Plan to Evaluate Neodryinus<br />
typhlocybae (Ashmead) (Hymenopetra : Driinidae) Population Associated with <strong>Metcalfa</strong> <strong>pruinosa</strong><br />
(Say) (Homoptera : Flatidae) infestation in Northwestern Italy. Environmental Entomology, 34 (4) :<br />
819 – 824.<br />
Cacioppo O. (2001) – Strategie di difesa contro <strong>Metcalfa</strong> <strong>pruinosa</strong>. L’informatore Agrario 23/2001,<br />
pp 87 – 89.<br />
Girolami V., Conte L. (1999) – Possibilità di controllo chimico e <strong>biologico</strong> di <strong>Metcalfa</strong> <strong>pruinosa</strong>.<br />
Inf. Fitop., 49: 5,20-25.<br />
Girolami V., Camporese P. (1994) – Prima moltiplicazione in Europa di Neodryinus typhlocybae<br />
(Ashmead) (Hymenoptera: Dryinidae) su <strong>Metcalfa</strong> <strong>pruinosa</strong> (Say) (Homoptera: Flatidae). Atti XVII<br />
Congresso nazionale italiano di Entomologia, Udine 13-18 giugno 1994: 655-658.<br />
Guadagnini M., Mori N., Alberghini S., Carturan B., Girolami V., Bertaccini A. (2000) – Molecular<br />
evidence of phytoplasma transmission to grapevine by <strong>Metcalfa</strong> <strong>pruinosa</strong> (Say) in Italy. XIII Meet.<br />
“International council for the study of viruses and virus-like diseases of the grapavine (ICVG)”,<br />
Adelaide (Australia), 12 – 17 March 2000, pp. 99 – 100.<br />
Malausa J.C., Giuge L. & Fauvergue X. (2003) – Acclimation et dispersion en France de<br />
Neodryinus typhlocybae (Ashmead) (Hymenopetra : Driinidae) introduit pour lutter contre <strong>Metcalfa</strong><br />
<strong>pruinosa</strong> (Say) (Homoptera : Flatidae) Bulletin de la Société entomologique de France, 108 (1) : 97<br />
– 102.<br />
Mancini P. (2003) – Capacità di insediamento e diffusione di Neodryinus tiphlocybae (Ashmead)<br />
(Hymenopetra : Driinidae) per il controllo <strong>biologico</strong> di <strong>Metcalfa</strong> <strong>pruinosa</strong> in Campania. Tesi di<br />
dottorato in Entomologia Agraria, Università degli Studi di Napoli “ Federico II ”, Portici 66 pp.<br />
Mazzon L. e Girolami V. (2002) - Neodryinus typhlocybae (Ashmead) : Comportamento ed<br />
Impiego in Difesa Biologica Informatore Fitopatologico 7 – 8 pp27 – 31.<br />
Olmi M. (2000) – Bio-ecologia degli imenotteri driinidi e loro impiego in programmi di lotta<br />
biologica.In: A.Lucchi, La <strong>Metcalfa</strong> negli ecosistemi italiani, ARSIA <strong>Regione</strong> Toscana, pp.93-117.<br />
Santini L. e Lucchi A. (2000) – Aspetti biologici e morfo-funzionali. In: A.Lucchi, La<br />
<strong>Metcalfa</strong> negli ecosistemi italiani, ARSIA <strong>Regione</strong> Toscana, pp.29-46.<br />
35
RELAZIONE<br />
PROF. MASSIMO OLMI<br />
UNIVERSITA’ DELLA TUSCIA<br />
36




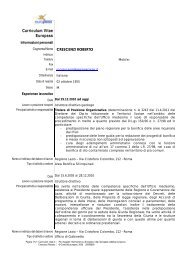

![Appendice B [.pdf 30 Kb] - Regione Lazio](https://img.yumpu.com/51120841/1/184x260/appendice-b-pdf-30-kb-regione-lazio.jpg?quality=85)