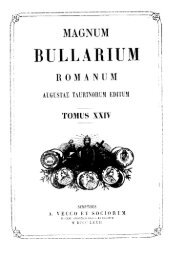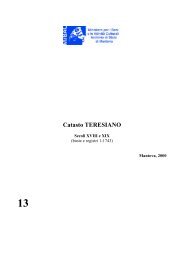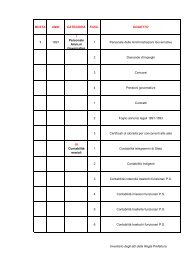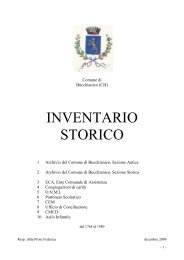Catasto delle corti camerali di Ostiglia e Sermide
Catasto delle corti camerali di Ostiglia e Sermide
Catasto delle corti camerali di Ostiglia e Sermide
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
206<br />
I catasti<br />
<strong>delle</strong> Corti <strong>camerali</strong><br />
<strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> e <strong>Sermide</strong><br />
anni 1606-1872
I catasti <strong>delle</strong> <strong>corti</strong> <strong>camerali</strong> <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> e <strong>Sermide</strong> (1606-1872)<br />
Nota introduttiva<br />
Cenni storici<br />
Il fondo <strong>delle</strong> <strong>corti</strong> <strong>camerali</strong> <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> e <strong>Sermide</strong> è costituito da 116 registri e da una sola<br />
cartella <strong>di</strong> <strong>di</strong>segni: i pezzi da 1 a 71 sono relativi ad <strong>Ostiglia</strong>, quelli da 72 a 117, comprensivi della<br />
cartella <strong>di</strong> <strong>di</strong>segni n. 77, sono relativi a <strong>Sermide</strong>; solo <strong>di</strong> questa seconda sezione è nota la data del<br />
versamento in Archivio <strong>di</strong> Stato da parte dell’Intendenza <strong>di</strong> Finanza, nel 1926 1 .<br />
Si tratta sostanzialmente <strong>di</strong> registri catastali: quanto resta, in misura assai lacunosa, della<br />
ricca documentazione stratificatasi presso gli uffici amministrativi <strong>delle</strong> due <strong>corti</strong> <strong>camerali</strong> nel corso<br />
della loro esistenza, documentata dal Me<strong>di</strong>oevo all’Ottocento.<br />
Le <strong>corti</strong> <strong>camerali</strong> <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> e <strong>Sermide</strong> sono la singolare testimonianza, nell’ambito della<br />
storia della proprietà terriera mantovana, del persistere <strong>di</strong> tra<strong>di</strong>zioni feudali fino alle soglie del XX<br />
secolo 2 .<br />
Fin dal me<strong>di</strong>oevo il territorio <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>, per lo più selvoso ed incolto, gravitava nell’orbita<br />
veronese; a seguito <strong>di</strong> successive concessioni, donativi e privilegi ripetutamente confermati<br />
attraverso <strong>di</strong>plomi imperiali, intorno al 1073 esso pervenne interamente all’abbazia <strong>di</strong> San Zeno <strong>di</strong><br />
Verona. Nel 1217, dopo che i monaci ebbero <strong>di</strong>sboscato molti terreni rendendoli adatti alla<br />
coltivazione, l’abate Riprando concesse alcuni poderi in enfiteusi perpetua a coloni <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>, in<br />
cambio dell’obbligo della corresponsione annua del terzo, del quarto, del quinto o della decima dei<br />
prodotti 3 .<br />
Nel 1290, l’abate <strong>di</strong> San Zeno investì Alberto della Scala, allora signore <strong>di</strong> Verona, del<br />
rimanente territorio ostigliese a titolo <strong>di</strong> fitto, o livello, rinnovabile ogni 29 anni.<br />
In seguito al passaggio <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> sotto il dominio mantovano, nel 1405 i territori ostigliesi<br />
detenuti dagli Scaligeri pervennero ai Gonzaga, cui i monaci <strong>di</strong> San Zeno confermarono medesimi<br />
<strong>di</strong>ritti ed obblighi. A partire dal 1456, il marchese Ludovico II cessò dall’obbligo <strong>di</strong> rinnovare ogni<br />
29 anni il fitto della porzione <strong>di</strong> terreni già in suo possesso e, <strong>di</strong>etro la corresponsione <strong>di</strong> un canone<br />
annuo fisso all’abbazia veronese, ricevette l’utile dominio ed il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> esigere le decime anche<br />
sulla porzione <strong>di</strong> terreni concessi ai coloni ostigliesi dall’abate Riprando più <strong>di</strong> due secoli prima 4 .<br />
Fino alla metà del Settecento la corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> fu <strong>di</strong> fatto posseduta prima dai Gonzaga e<br />
poi dagli Austriaci come bene demaniale e gestita dal Magistrato Ducale, in seguito denominato<br />
Camerale.<br />
Tale gestione era caratterizzata da un sistema <strong>di</strong> affittanze me<strong>di</strong>ante il quale i signori <strong>di</strong><br />
Mantova, <strong>di</strong>etro la corresponsione <strong>di</strong> un canone d’affitto annuo, appaltavano a “conduttori” il <strong>di</strong>ritto<br />
a riscuotere la terza, quarta, quinta e decima parte dei frutti prodotti dai terreni ricadenti sotto la<br />
giuris<strong>di</strong>zione della corte 5 .<br />
1 ASMn, Archivio della Direzione, busta 150, scarto atti Regia Intendenza <strong>di</strong> Finanza, 11 giugno 1926.<br />
2 M.VAINI, La <strong>di</strong>stribuzione della proprietà terriera e la società mantovana dal 1785 al 1845, Milano 1973. In<br />
particolare, per la conoscenza del sistema <strong>delle</strong> <strong>corti</strong> nel Basso Mantovano, pp. 184-188.<br />
3 Fonte per la ricostruzione <strong>delle</strong> più antiche vicende <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>, atten<strong>di</strong>bile per la dovizia <strong>di</strong> riferimenti a cronache e<br />
documenti d’epoca è: F. CHERUBINI, Notizie storiche e statistiche intorno ad <strong>Ostiglia</strong>, Verona 1933, rist. anast.<br />
dell’e<strong>di</strong>zione del 1826. In particolare per la corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>: pp. 68-72. Utile anche, benché scientificamente meno<br />
atten<strong>di</strong>bile, la ricostruzione <strong>di</strong> A. ZANCHI BERTELLI, Storia <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>, Mantova 1866.<br />
4 A. ZANCHI BERTELLI, op. cit., p. 82. Così il Cherubini spiega in cosa consistesse la corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>: “Sotto questo<br />
nome intendesi oggidì un complesso <strong>di</strong> decime e contributi che i possessori della Corte hanno <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> esigere su gran<br />
parte dei poderi e <strong>delle</strong> case ostigliesi. L’origine <strong>di</strong> questa specie <strong>di</strong> feudo e la storia sua sono le seguenti…”, op. cit., p.<br />
68.<br />
5 ASMn, Magistrato Camerale Antico, buste B. I. 9 Corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> 1512-1600, 1601-1650, 1651-1747. Da un<br />
documento datato 3 giugno 1594, relativo alle con<strong>di</strong>zioni dell’affittanza della corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> e del Paludano, si legge:<br />
“Si domanda <strong>di</strong> fitto della corte d’Hostiglia scu<strong>di</strong> seimilla d’oro in oro all’anno, la qual cossa consiste in riscotere terci,<br />
2
Non <strong>di</strong>versa è la storia della corte <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong> 6 : documentata fin dal Me<strong>di</strong>oevo, essa fu<br />
donata dagli imperatori germanici al Vescovato <strong>di</strong> Mantova prima del 997: reca infatti questa data il<br />
<strong>di</strong>ploma imperiale con il quale Ottone III confermò privilegi anteriormente concessi 7 . Nel 1090 il<br />
vescovo Ubaldo I ne investì la potente famiglia dei Visdomini 8 , ma a seguito della loro estinzione<br />
essa pervenne ai Bonacolsi intorno al 1322. Con l’avvento al potere dei Gonzaga nel 1328 le ragioni<br />
feudali della corte <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong> furono temporaneamente devolute al Vescovato, primo proprietario,<br />
ma il vescovo Giacomo Benfatti, con atto del 15 luglio 1331, ne investì a titolo <strong>di</strong> feudo onorifico<br />
Luigi Gonzaga ed i suoi ere<strong>di</strong>, investitura in seguito ripetutamente confermata dall’autorità<br />
imperiale 9 .<br />
Nel 1443 Gianfrancesco Gonzaga vendette la corte <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong> al nobile Bartolomeo<br />
Pendaglia per 1.169 ducati d’oro: all’atto <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta del notaio Giacomo Andreasi è allegato<br />
l’elenco completo degli “utilisti”, ovvero <strong>di</strong> coloro i quali, in cambio dell’uso <strong>di</strong> beni immobili,<br />
erano obbligati a versare contributi alla corte <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>. Accanto al nome <strong>di</strong> ciascuno <strong>di</strong> essi è<br />
descritta sommariamente la natura del bene goduto, terreno o e<strong>di</strong>ficio, ed è in<strong>di</strong>cata l’entità della<br />
contribuzione dovuta alla corte, sotto forma della terza, quarta, quinta o decima parte del prodotto<br />
annuo, oppure <strong>di</strong> una quota in denaro che in seguito si denominerà “fittarello” 10 . Tali forme <strong>di</strong><br />
contribuzione, destinate a perdurare fino agli inizi del Novecento, trarrebbero origine dalla<br />
concessione in proprietà <strong>di</strong> terreni paludosi ed incolti al fine <strong>di</strong> migliorarli 11 .<br />
A partire dal 1596 i Gonzaga procedettero a ricomprare la corte per lotti successivi, fino a<br />
rientrarne nel pieno possesso nel primo decennio del Seicento 12 .<br />
Nel corso del Settecento le vicende <strong>delle</strong> <strong>corti</strong> <strong>camerali</strong> <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> e <strong>Sermide</strong> procedettero<br />
parallelamente: <strong>di</strong>chiarato fellone nel 1707 l’ultimo duca <strong>di</strong> Mantova Fer<strong>di</strong>nando Carlo, esse furono<br />
confiscate e devolute alla Regia Camera austriaca; risale al 1719 il primo appalto, o “condotta”, che<br />
le accomuna 13 .<br />
Dunque le due <strong>corti</strong>, come abbiamo visto beni ecclesiastici concessi alla famiglia dominante<br />
rispettivamente dall’abbazia <strong>di</strong> San Zeno e dal Vescovato <strong>di</strong> Mantova, furono godute dai Gonzaga<br />
come titolari del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> esigere la terza, quarta, quinta o decima parte dei prodotti annuali dagli<br />
utilisti, cui le terre erano state date a livello o in enfiteusi ab antiquo dagli enti ecclesiastici <strong>di</strong>rettari<br />
<strong>di</strong> cui sopra 14 ; le terre e gli e<strong>di</strong>fici gravati da tale <strong>di</strong>ritto erano detti obnoxi (dal latino obnoxius),<br />
ovvero debitori, soggetti a tributo o tassa.<br />
quarti, quinti et decime <strong>di</strong> biade, fieno, et vini et affitti <strong>di</strong> proprietà, senza ristoro”. Le medesime carte attestano anche i<br />
rapporti della Camera Ducale con l’abbazia <strong>di</strong> San Zeno, cui venivano corrisposti, a titolo <strong>di</strong> livello o enfiteusi perpetua,<br />
404 minali <strong>di</strong> frumento l’anno, pari a 148 sacchi. Documentazione risalente alla metà del Quattrocento relativa alla<br />
corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> si ritrova anche in: Archivio Gonzaga, busta 252.<br />
6<br />
Una puntuale ricostruzione della storia del <strong>Sermide</strong>se e dei comuni vicini si deve a: G. MANTOVANI, Il territorio<br />
sermidese e limitrofi. Ricerche archeologiche, storiche ed idrografiche, Bergamo 1886. In particolare per la corte <strong>di</strong><br />
<strong>Sermide</strong>, pp. 475-479.<br />
7<br />
P. TORELLI, Regesto mantovano, Roma 1914, documento n. 41.<br />
8<br />
Per i rapporti dei Visdomini con <strong>Sermide</strong> vedasi: P. TORELLI, Un comune citta<strong>di</strong>no, Mantova 1952, vol. I, pp. 195-<br />
197, vol. II, pp. 47-51.<br />
9<br />
G. MANTOVANI, op. cit., p. 476.<br />
10<br />
ASMn, Registrazioni notarili or<strong>di</strong>narie, atto del 17 <strong>di</strong>cembre 1443, cc. 235-240. Il documento è stato integralmente<br />
pubblicato da G. MANTOVANI, op. cit., pp. 396-470 e può essere considerato il primo catasto noto della corte <strong>di</strong><br />
<strong>Sermide</strong>.<br />
11<br />
G. MANTOVANI, op. cit., p. 474.<br />
12<br />
ASMn, Magistrato Camerale Antico, busta B. I. 60, Corte <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>, 1460-1747. Le carte documentano le varie fasi<br />
del passaggio <strong>di</strong> proprietà dai Pendaglia ai Gonzaga, la perio<strong>di</strong>ca rinnovazione dell’investitura feudale della corte da<br />
parte del Vescovato a favore dei Gonzaga e le relative affittanze. Su <strong>Sermide</strong> si veda anche: Archivio Gonzaga, busta<br />
255, in cui a c. 39 è conservata una sommaria planimetria del territorio <strong>di</strong>pendente dalla giuris<strong>di</strong>zione della corte.<br />
13<br />
ASMn, Magistrato Camerale Antico, busta B. I. 9, Corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> 1651-1747: “1719, 20 <strong>di</strong>cembre. Condotta <strong>delle</strong><br />
Corti d’<strong>Ostiglia</strong> e <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong> concessa per anni cinque al Capitano Antonio Marchesini”, atto del notaio camerale<br />
Antonio Maria Pran<strong>di</strong>.<br />
14<br />
M. VAINI, op. cit., p. 184.<br />
3
Nel complesso intreccio dei rapporti giuri<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> origine feudale che caratterizza le <strong>corti</strong> <strong>di</strong><br />
<strong>Ostiglia</strong> e <strong>Sermide</strong>, i singoli beni soggetti a contribuzione erano naturalmente oggetto <strong>di</strong> transazioni<br />
private, quali compraven<strong>di</strong>te, permute, ere<strong>di</strong>tà, doti ecc. tra coloro che le avevano in uso. Un<br />
documento del 1453 relativo alla corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> or<strong>di</strong>na infatti che nessuno possa comprare o<br />
vendere beni obbligati alla corte, sotto pena della per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> ogni <strong>di</strong>ritto sia per il ven<strong>di</strong>tore che per il<br />
compratore. Viceversa è concesso il commercio, previa licenza del fattore generale, dei soli<br />
miglioramenti apportati ai suddetti beni, che si intendono dati ai coloni in affitto perpetuo, ovvero in<br />
enfiteusi o a livello 15 .<br />
Nella prima metà del Settecento la giuris<strong>di</strong>zione <strong>delle</strong> <strong>corti</strong> <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> e <strong>Sermide</strong> si<br />
estendeva rispettivamente su 3.313 e 3580 biolche mantovane. Il loro or<strong>di</strong>namento era strettamente<br />
gerarchico: al vertice erano gli enti <strong>di</strong>rettari, generalmente assenti, ed i conduttori, cui veniva dato<br />
in appalto lo jus <strong>di</strong> esigere i tributi. A capo della struttura gestionale ed amministrativa locale <strong>di</strong><br />
ciascuna corte vi era invece un fattore, assistito da una gruppo <strong>di</strong> ufficiali, tra cui i “partitori”,<br />
ovvero agenti addetti alle partizioni dei raccolti dovuti, ed i “campari”, sorta <strong>di</strong> guar<strong>di</strong>e campestri<br />
private; tutto il personale addetto alle esazioni era autorizzato all’uso <strong>delle</strong> armi, configurando una<br />
sorta <strong>di</strong> stato <strong>di</strong> polizia.<br />
La vita era regolata da un complesso <strong>di</strong> norme <strong>di</strong> sicura origine me<strong>di</strong>evale, riconducibili agli<br />
Statuti Bonacolsiani risalenti al 1313 16 , norme co<strong>di</strong>ficate in or<strong>di</strong>ni e prescrizioni che comportavano<br />
un rigido controllo <strong>di</strong> ogni possibile cambiamento dell’assetto <strong>delle</strong> campagne. Era ad esempio<br />
vietato fare legna, o tagliare rami o alberi, ancorché secchi, o piantarne <strong>di</strong> nuovi senza<br />
autorizzazione; era vietato pescare o pascolare animali, anche in terre incolte, senza licenza; ogni<br />
transazione tra utilisti doveva essere notificata ed autorizzata da apposita licenza del fattore, e<br />
parimenti ogni variazione <strong>delle</strong> colture su terre obnoxie; per ogni trasgressione erano previste<br />
pesanti sanzioni, i cui introiti spettavano per un terzo ai campari, dando origine a frequenti abusi 17 .<br />
Nel 1747 il governo austriaco, a corto <strong>di</strong> finanziamenti a causa <strong>delle</strong> campagne militari,<br />
vendette le due <strong>corti</strong>, con i rispettivi <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> esazione, per 150 mila fiorini alla compagnia detta dei<br />
Provve<strong>di</strong>tori <strong>di</strong> Campagna, costituita dai signori Mellerio, Bonanome, Finzi, Vida e Vitale.<br />
Dall’atto <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta si evince che la suddetta società vantava dallo Stato dei cre<strong>di</strong>ti a seguito<br />
dell’appalto per la fornitura <strong>di</strong> grano e biada per l’armata austriaca stanziata in Lombar<strong>di</strong>a e<br />
Piemonte 18 . La Regia Camera si riservò tuttavia il <strong>di</strong>ritto alla “recupera”, ovvero il <strong>di</strong>ritto a<br />
re<strong>di</strong>mere non appena possibile queste terre, con l’obbligo del rispetto della locazione eventualmente<br />
in atto; la condotta fu contestualmente affidata per nove anni a Leone Norsa 19 .<br />
Con nuovo rogito del 24 luglio 1765 le due <strong>corti</strong> passarono nelle mani dei Fermieri Generali,<br />
i milanesi Antonio Greppi, Giacomo Mellerio e Giuseppe Pezzoli per la medesima somma, più altri<br />
3.000 fiorini da impiegarsi a beneficio dei poveri 20 .<br />
La permanenza <strong>delle</strong> <strong>corti</strong> <strong>camerali</strong> <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> e <strong>Sermide</strong> nelle mani dei Fermieri e dei loro<br />
ere<strong>di</strong> cessò solo nel 1852, allorché con atto del notaio milanese Tommaso Grossi, il governo<br />
austriaco ne rientrò in possesso 21 .<br />
15<br />
ASMn, Archivio Gonzaga, busta 271-2, fasc. 2, c. 2r., 30 agosto 1453, Pro curia Hostilie.<br />
16<br />
A cura <strong>di</strong> E. DEZZA, A. M. LORENZONI, M. VAINI, Statuti Bonacolsiani, Mantova 2002.<br />
17<br />
M. VAINI, op. cit., pp. 186-188. Copie <strong>di</strong> or<strong>di</strong>namenti <strong>delle</strong> <strong>corti</strong> si trovano in: Magistrato Camerale Antico, busta B.<br />
I. 9, Corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> 1651-1747: “Or<strong>di</strong>ni da osservarsi per la Corte d’<strong>Ostiglia</strong> <strong>di</strong> Sua Altezza Serenissima”, s. d.;<br />
Intendenza <strong>di</strong> Finanza (1766-1867), busta 151, “Prescrizioni generali per l’amministrazione <strong>delle</strong> Regie Corti <strong>di</strong><br />
<strong>Sermide</strong> ed <strong>Ostiglia</strong> desunte dagli estratti degli Or<strong>di</strong>ni, Statuti, Gride, E<strong>di</strong>tti etc. già preesistenti ed emanate prima della<br />
ricupera 30 settembre 1852”, s. d.<br />
18<br />
ASMn, Notai Camerali, notaio Pietro Maria Mancina, 9 ottobre 1747 “Instrumento <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>delle</strong> Corti d’<strong>Ostiglia</strong> e<br />
<strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>”.<br />
19<br />
ASMn, Magistrato Camerale Antico, busta B. I. 9, Corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> 1651-1747.<br />
20<br />
ASMn, Magistrato Camerale Antico, busta B. I., Allo<strong>di</strong>ali della Camera, Corti Camerali, 1668-1771, “B . 24 luglio<br />
1765 Instromento <strong>di</strong> ricupera <strong>delle</strong> Corti d’<strong>Ostiglia</strong> e <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>, e della successiva ven<strong>di</strong>ta fatta dalla R. D. Camera ai<br />
signori Fermieri Generali”, atto del notaio camerale Pietro Maria Mancina.<br />
4
Per la verifica <strong>delle</strong> situazioni catastali e contributive dei conferenti fu istituita un’apposita<br />
commissione governativa denominata “commissione Baldoli”, dal nome del contabile Antonio<br />
Baldoli che ne fece parte assieme all’ingegnere Giuseppe Sandri, ed al <strong>di</strong>rigente Enrico Luigi<br />
Grassi: gli esiti <strong>delle</strong> verifiche sono testimoniati, per quanto riguarda <strong>Ostiglia</strong>, dai registri nn. 18-20.<br />
Abbondante documentazione relativa alla fase della recupera ed alla successiva gestione<br />
amministrativa e contabile <strong>delle</strong> due <strong>corti</strong> si conserva naturalmente negli archivi finanziari<br />
mantovani 22 .<br />
Nel corso della seconda metà dell’Ottocento, in particolare dai primi anni ’70, si assiste alla<br />
rapida contrazione dell’estensione della giuris<strong>di</strong>zione <strong>delle</strong> <strong>corti</strong>, a seguito della possibilità offerta<br />
dalla legislazione nazionale <strong>di</strong> affrancarsi dai canoni enfiteutici e <strong>di</strong> entrare nel pieno possesso del<br />
bene me<strong>di</strong>ante il pagamento <strong>di</strong> una somma pari a <strong>di</strong>eci volte il canone dovuto 23 : nel decennio tra il<br />
1873 ed il 1884 i terreni obnoxi alla corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> passarono da circa 515 a 45 ettari, quelli <strong>di</strong><br />
<strong>Sermide</strong> da circa 1136 a 421 ettari 24 . Parimenti, nuove <strong>di</strong>sposizioni governative favorirono il<br />
progressivo abbandono del sistema contributivo me<strong>di</strong>evale, consentendo la commutazione in<br />
denaro, sotto forma <strong>di</strong> fittarelli stabili o precari, dei conferimenti in natura; la <strong>di</strong>stinzione vigeva a<br />
seconda che l’accordo per il pagamento in denaro fosse raggiunto con l’amministrazione dello<br />
Stato, fittarello stabile, o con l’appaltatore, fittarello precario, perchè destinato a cessare con<br />
l’appalto.<br />
Contestualmente, il degrado degli stabili della corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> documentato nel 1870, e la<br />
ven<strong>di</strong>ta nel 1872 <strong>delle</strong> attrezzature per la produzione <strong>di</strong> acquavite nelle cantine della corte <strong>di</strong><br />
<strong>Sermide</strong>, testimoniano la definitiva decadenza <strong>di</strong> questo sistema agrario ed economico 25 .<br />
Ciò nonostante, fino ai primi anni del Novecento il sistema dell’appalto del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />
esazione dei contributi non cessò, ed i capitolati consentono <strong>di</strong> monitorare l’estensione ed il valore<br />
<strong>delle</strong> <strong>corti</strong> nel tempo 26 . Inoltre, data la possibilità <strong>di</strong> pagamenti molto <strong>di</strong>lazionati offerta agli ex<br />
contribuenti, il sistema <strong>delle</strong> affrancazioni proseguì oltre la prima metà degli anni ’30.<br />
21 ASMi, Notarile, busta 50.649, notaio Tommaso Grossi, atto n. 3999 del 30 settembre 1852. L’atto è corredato da<br />
numerosi allegati, tra cui gli elenchi dei libri, catasti, registri ed atti custo<strong>di</strong>ti nei rispettivi archivi: elenchi che hanno<br />
consentito un puntuale riscontro dei registri catastali conservati in questo fondo.<br />
22 ASMn, Intendenza <strong>di</strong> Finanza (1766-1867), in particolare buste 151, 152 e 515 sulla fase della recupera. In<br />
quest’ultima busta è conservata copia della relazione della Commissione per la recupera <strong>delle</strong> <strong>corti</strong>, datata 5 ottobre<br />
1852 a firma Grassi. Vi sono inoltre i verbali <strong>delle</strong> ricognizioni per la verifica dello stato dei terreni obnoxi basate sul<br />
sistematico raffronto con i libri <strong>delle</strong> misurazioni del 1712-1714 per <strong>Ostiglia</strong>, e con i vari catasti, dal Guarnieri del 1710,<br />
alle mappe Galeani e Simonini del 1824 per <strong>Sermide</strong> (si veda oltre nel testo). Molta altra documentazione relativa alle<br />
due <strong>corti</strong> si ritrova nelle buste 231, 242, 266, 368, 419, 512, 514, 516, 602, 603 del medesimo fondo.<br />
23 La legge sull’affrancamento dei canoni enfiteutici, n. 1636 del 24 gennaio 1864, fu estesa alle province del Veneto e<br />
Mantova con legge 3820 del 28 luglio 1867; una nuova legge, la n. 46 del 12 febbraio 1871, prorogò l’esenzione <strong>delle</strong><br />
tasse sulle affrancazioni <strong>delle</strong> enfiteusi nelle medesime province; ad essa fece seguito la circolare n. 629 del 25 marzo<br />
1871 del Ministero <strong>delle</strong> Finanze contenente norme per le commutazioni in denaro dei conferimenti in natura.<br />
24 I dati per questi raffronti sono desunti dai capitolati d’appalto <strong>delle</strong> rispettive <strong>corti</strong> negli anni citati. Il tutto, assieme<br />
ad altra abbondante documentazione su affrancazioni e commutazioni, in ASMn, Intendenza <strong>di</strong> Finanza (1868-1907),<br />
buste 20, 67-69, 79, 195-196, 207, 335-342, 438-441, 545-553, 630.<br />
25 ASMn, Intendenza <strong>di</strong> Finanza (1868-1907), busta 20.<br />
26 ASMn, Intendenza <strong>di</strong> Finanza (1868-1907), busta 550. La conclusione <strong>delle</strong> vicende <strong>delle</strong> <strong>corti</strong> <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> e <strong>Sermide</strong><br />
è documentata nella sezione più recente del fondo Intendenza <strong>di</strong> Finanza, anni 1908-1937, buste 41-43, 240-243, 335.<br />
5
I catasti della corte camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong><br />
La parte del fondo relativa ad <strong>Ostiglia</strong> consta <strong>di</strong> 71 registri, <strong>di</strong> natura prevalentemente<br />
catastale, connessi al sistema <strong>di</strong> esazione dei contributi dovuti alla corte da parte dei detentori <strong>di</strong><br />
beni obnoxi, ovvero terreni, fabbricati e case.<br />
Una prima serie, il cosiddetto “vecchio catasto”, risale al 1606: essa comprende l’enorme<br />
registro <strong>di</strong> 1000 carte n. 1 e quattro registri, i nn. 2-5, la cui numerazione progressiva arriva alla<br />
carta 1146, che contengono annotazioni ed aggiornamenti relativi ai trapassi <strong>di</strong> proprietà al 1700<br />
circa. Seguono ai nn. 6 e 7 la relativa rubrica alfabetica ed un “elenco dei particolari” che<br />
conferiscono alla corte.<br />
A questo antico sistema catastale erano connessi 18 libretti <strong>delle</strong> misurazioni, non<br />
conservatisi, eseguiti tra il 1606 ed il 1608, in cui i beni erano rappresentati anche in pianta 27 . Tale<br />
rilevazione catastale potrebbe essere ricondotta al notaio Giovanni Lodovico <strong>delle</strong> Belle <strong>di</strong> Revere,<br />
che ne ebbe l’incarico fin dal 1577 28 .<br />
Una seconda serie <strong>di</strong> registri catastali fu eseguita a partire dal 1700: si tratta del cosiddetto<br />
“catasto Bresciani” commissionato all’agrimensore senatorio Girolamo Bresciani il 28 aprile 1700<br />
al fine <strong>di</strong> “accertare li red<strong>di</strong>ti della corte d’<strong>Ostiglia</strong>” 29 . Un successivo documento del 20 novembre<br />
1705 attesta un’integrazione al contratto stipulato col Bresciani: a questi, che già aveva “consegnati<br />
otto volumi <strong>delle</strong> piante, misure de terreni o case della corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>” incompleti della<br />
“descritione della qualità del canone”, fu commissionata un’altra copia, questa volta completa, dei<br />
medesimi 30 .<br />
Sono da ricondursi a questa rilevazione catastale i sei registri dal n. 8 al n. 13: essi contengono la<br />
rappresentazione grafica, in pianta e in alzato, dei terreni soggetti alla corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> e dei relativi<br />
casamenti; altri due libri, non pervenutici, contenevano invece le misure e le piante <strong>delle</strong> case del<br />
centro abitato <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> 31 .<br />
I registri redatti dal Bresciani, da integrarsi con il n. 14 “Cattastro Rubeo” sicuramente coevo,<br />
benché rimasti inutilizzati e presto sostituiti dal catasto del Pozzi, si rivelano preziosi dal punto <strong>di</strong><br />
vista documentario per la conoscenza del territorio ostigliese, soprattutto se integrati con gli altri<br />
due superstiti della rilevazione catastale che imme<strong>di</strong>atamente seguì.<br />
Tra il 1712 ed il 1714, infatti, il fattore e notaio Felice Pozzi eseguì un nuovo catasto della<br />
corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>: esso era costituito da sei libri con i <strong>di</strong>segni in pianta ed in alzato dei terreni e <strong>delle</strong><br />
case, e da un nuovo libro mastro <strong>di</strong> 300 fogli. Superstiti <strong>di</strong> questa rilevazione sono il “Libro primo<br />
27 ASMi, Notarile, busta 50.649, notaio Tommaso Grossi, atto n. 3999 del 30 settembre 1852. L’allegato FF: “Elenco o<br />
protocollo generale, o repertorio dei libri, catastri, registri, atti, documenti, or<strong>di</strong>ni, statuti etc. esistenti nell’archivio della<br />
corte camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>”, testimonia l’esistenza dei 18 libretti <strong>delle</strong> misurazioni.<br />
28 ASMn, busta B. I. 9, Corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> 1512-1600, nota del 1° luglio 1577: “Dichiarazione del Ducal Maestrato d’aver<br />
elletto messer Giovan Lodovico <strong>delle</strong> Belle da Revere per inscrivere li Catastri della Corte d’<strong>Ostiglia</strong> …”. In mancanza<br />
<strong>di</strong> ogni altro riscontro, la datazione del catasto, molto <strong>di</strong>stante da quella d’incarico, non è comunque incompatibile con<br />
l’attività del notaio, che si protrasse fino al 1612.<br />
29 ASMn, Ingegneri Camerali, busta 4, fasc. 8: “1700, 28 aprile. Obbligazioni assuntesi dall’agrimensore Girolamo<br />
Bresciani verso la Camera Ducale circa il metodo con cui procedere alle <strong>di</strong>verse operazioni da farsi dal medesimo affine<br />
<strong>di</strong> formare un nuovo catastro per accertare li red<strong>di</strong>ti della Corte d’<strong>Ostiglia</strong>. In copia”.<br />
30 ASMn, Archivio Gonzaga, busta 252, cc. 55-56: “1705, 20 novembre. Scrittura firmata dal presidente camerale<br />
Giovanni Francesco Pullicani e Girolamo Bresciani per l’obbligo assuntosi <strong>di</strong> far copiare otto volumi riguardanti le<br />
piante e misure de terreni, e case della corte d’<strong>Ostiglia</strong>, me<strong>di</strong>ante il pagamento <strong>di</strong> scu<strong>di</strong> duecento piccioli <strong>di</strong> Mantova”.<br />
Lo stesso documento si ritrova, in copia, in Ingegneri Camerali, busta 4, fasc. 8.<br />
31 ASMi, Notarile, busta 50.649, notaio Tommaso Grossi, atto n. 3999 del 30 settembre 1852. L’allegato FF, in cui sono<br />
descritti tutti i documenti conservati nell’archivio della corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> al momento della recupera del 1852, descrive<br />
gli otto libri eseguiti dal Bresciani tra il 1700 ed il 1705, due relativi alle case, sei relativi ai terreni; li <strong>di</strong>ce inoltre privi<br />
dell’autenticazione notarile che contrad<strong>di</strong>stingue tutti gli atti compresi nella ven<strong>di</strong>ta <strong>delle</strong> <strong>corti</strong> del 1747: ciò a riprova<br />
della loro inefficacia sul piano legale a causa della mancata utilizzazione.<br />
6
<strong>delle</strong> case”, ora conservato ad <strong>Ostiglia</strong>, ed il registro n. 15, denominato “Mastro Rubeo primo”, che<br />
come si legge sul retro del frontespizio fu portato a termine da Carlo Pozzi, figlio <strong>di</strong> Felice 32 .<br />
Segue nell’or<strong>di</strong>namento un “Mastro Rubeo secondo”, registro n. 16, con annotazioni al<br />
1852, intrapreso dallo stesso Carlo Pozzi come naturale sviluppo del primo, privo<br />
dell’autenticazione notarile che contrad<strong>di</strong>stingue i registri del fondo che furono allegati all’atto <strong>di</strong><br />
ven<strong>di</strong>ta <strong>delle</strong> <strong>corti</strong> del 1747.<br />
I volumi seguenti, ad eccezione del n. 17, analogo al n. 81 relativo a <strong>Sermide</strong>, redatto tra il 1787 ed<br />
il 1788, nel contesto <strong>di</strong> un tentativo <strong>di</strong> alcuni conferenti <strong>di</strong> commutare in denaro i pagamenti in<br />
natura alla corte 33 , vennero prodotti a partire dal 1852, anno <strong>delle</strong> “recupera”, ovvero del ritorno<br />
<strong>delle</strong> <strong>corti</strong> <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> e <strong>Sermide</strong> tra i beni dello Stato, dopo circa un secolo <strong>di</strong> proprietà e gestione<br />
private.<br />
Il lavoro <strong>di</strong> verifica catastale e fiscale fu affidato alla commissione governativa che elaborò i<br />
registri n. 18-20, ed il cui membro più noto fu il contabile Antonio Baldoli, le cui annotazioni ad<br />
inchiostro rosso contrassegnano <strong>di</strong>versi volumi del fondo. Si trattava sostanzialmente <strong>di</strong> chiarire la<br />
situazione <strong>delle</strong> obnoxietà, ovvero <strong>delle</strong> tassazioni dovute dai conferenti alla corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>. In<br />
particolare, oltre alla verifica dello stato reale dei beni vincolati alle contribuzioni, si rese necessario<br />
consentire ai conferenti la commutazione in denaro <strong>delle</strong> contribuzioni in natura. La serie degli<br />
elenchi dal n. 26 al n. 71 documenta infatti i fittarelli stabili e precari concessi tra il 1852 ed il 1872.<br />
I registri n. 21-24, che non è stato possibile datare con certezza, ma il cui impianto è<br />
sicuramente successivo alla recupera <strong>delle</strong> <strong>corti</strong> da parte del governo austriaco, si configurano come<br />
registri partitari, ovvero dei passaggi <strong>di</strong> proprietà dei beni obnoxi, con annotazioni fino al 1875<br />
circa.<br />
E’ significativo comunque rilevare che fino ai primi anni ‘70 dell’Ottocento il sistema catastale <strong>di</strong><br />
riferimento per la giuris<strong>di</strong>zione della corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> continuò ad essere il catasto <strong>di</strong> Felice Pozzi.<br />
Nel 1871 venne infatti effettuata una nuova ricognizione dei conferenti: il registro n. 25, che<br />
documenta questa fase, accanto a sistematici riferimenti al noto catasto settecentesco, mostra<br />
intonse le fincature che avrebbero dovuto contenere i dati <strong>delle</strong> mappe censuarie, pure eseguite nel<br />
1854 su tutti i paesi della provincia <strong>di</strong> Mantova.<br />
Inoltre, solo a partire da questa data, accanto all’uso <strong>delle</strong> unità <strong>di</strong> misura veronesi, da secoli<br />
utilizzate nella gestione dei beni ad <strong>Ostiglia</strong>, ovvero il campo, la vaneza e la tavola, viene introdotto<br />
l’uso dell’ettaro per la misura dei terreni, e del litro, e suoi multipli e sottomultipli, per gli ari<strong>di</strong> 34 .<br />
32 ASMn, Ingegneri Camerali, busta 4, fasc. 9: “1715, 12 marzo. Relazione del prefetto Doriciglio Moscatelli fatta al<br />
Maestrato arciducale nella quale in<strong>di</strong>vidua tutte le operazioni fatte dal fattore della corte d’<strong>Ostiglia</strong> per la formazione<br />
del nuovo catastro <strong>di</strong> detta corte, e propone il suo sentimento circa la mercede che in tal opera possa essersi meritata.”<br />
33 ASMn, Intendenza Politica <strong>di</strong> Mantova, busta 378, fasc. 173.<br />
34 Il campo veronese, pari a 3000 mq, ha come sottounità la vaneza (24 vaneze per campo), pari a circa 125 mq, e la<br />
tavola (30 tavole per vaneza), pari a circa 4,23 mq. L’unità <strong>di</strong> misura utilizzata per gli ari<strong>di</strong>, pure veronese, era invece il<br />
minale, sud<strong>di</strong>viso in quarte, quartini e do<strong>di</strong>cesimi.<br />
7
I catasti della corte camerale <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong><br />
I registri dal n. 72 al n. 117 si riferiscono invece alla corte camerale <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>, i cui primi<br />
catasti documentati risalgono, come accennato, alla metà del XV secolo 35 .<br />
I volumi n. 72 e 73 sono rispettivamente l’originale ed una copia coeva del cosiddetto “catasto <strong>di</strong><br />
Madama”, fatto eseguire nel 1643 dalla principessa Maria Gonzaga al fine <strong>di</strong> ripristinare i propri<br />
<strong>di</strong>ritti sulle terre obnoxie alla corte, caduti in oblìo a causa della guerra e della peste del 1630. Tale<br />
catasto, il cui originale reca la sottoscrizione del 23 giugno 1646 del notaio Ludovico Fred<strong>di</strong>, consta<br />
della sola descrizione verbale dei beni; esso fu inoltre costituito in base alle notificazioni dei<br />
conferenti rese a seguito <strong>di</strong> una grida appositamente emanata.<br />
Il registro n. 74 è il cosiddetto “catasto Guarnieri”, eseguito nel 1710 da Giacomo (o<br />
Domenico) Guarnieri, tecnico della cui attività, come del nome <strong>di</strong> battesimo, ben poco è dato <strong>di</strong><br />
conoscere 36 . Il volume si presenta sud<strong>di</strong>viso in due parti, ciascuna corredata da rubrica alfabetica,<br />
la prima relativa ai terreni obnoxi che corrispondono in natura, la seconda relativa a beni, per lo più<br />
fabbricati, che corrispondono in fittarelli. I terreni e le case sono rappresentati in pianta e in alzato, e<br />
si riferiscono non solo a <strong>Sermide</strong>, ma anche a Moglia e Carbonara. I quinternelli n. 75 e 76 sono<br />
copie sciolte <strong>delle</strong> due rubriche alfabetiche rilegate.<br />
Nel 1765, con avviso del 19 settembre, il perito camerale Giuseppe Bisagni fu incaricato <strong>di</strong><br />
eseguire una nuova misura generale dei beni conferenti alla corte <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong> e <strong>delle</strong> alluvioni: a<br />
questa fase catastale si devono le mappe in copia ed il sommarione contenuti nella cartella n. 77,<br />
nonché i registri n. 78, 79 e 80. Le operazioni connesse al catasto Bisagni, eseguito tra il 1766 ed il<br />
1768, si protrassero oltre il 1778, ma rimasero incomplete, riguardando solo le conferenze <strong>di</strong><br />
fittarello e l’accatastamento <strong>delle</strong> restare e <strong>delle</strong> alluvioni, e non tutta la giuris<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>, <strong>di</strong><br />
cui pure il perito si era occupato 37 . Ne sono forse testimonianza le mappe n. 608 e 610 relative al<br />
territorio <strong>di</strong> Moglia, frazione <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>, del fondo Mappe Catastali dell’Archivio <strong>di</strong> Stato <strong>di</strong><br />
Mantova, riconducibili agli ultimi decenni del Settecento 38 .<br />
Il registro n. 81, risalente agli anni 1787-1788, è il corrispettivo del n. 17 relativo ad <strong>Ostiglia</strong>. Esso<br />
fu compilato a seguito del tentativo, sollecitato da una supplica dei conferenti, <strong>di</strong> trasformare in<br />
canoni in denaro tutte le contribuzioni in natura <strong>delle</strong> <strong>corti</strong> <strong>camerali</strong> <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> e <strong>Sermide</strong>:<br />
l’operazione evidentemente fallì.<br />
Il volume n. 82 è un registro giornale del dare e avere della corte <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong> tra il 1814 ed il 1853:<br />
si rivela utile per conoscerne le molteplici attività e la composizione del personale impegnato<br />
nell’amministrazione. Il giornale “dare e avere” n. 83 riguarda invece esclusivamente la contabilità<br />
dei fittarelli tra il 1825, a seguito del nuovo catasto <strong>di</strong> cui si sta per <strong>di</strong>re, ed il 1852, anno della<br />
recupera.<br />
Il registro n. 84 è l’unico superstite <strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> tre volumi dei trapassi, ovvero dei passaggi <strong>di</strong><br />
proprietà con carico e sgravio <strong>delle</strong> partite, connessi a nuove mappe catastali fatte eseguire tra il<br />
1822 ed il 1824 all'ingegnere Bassano Galeani e al perito Carlo Simonini. Tali mappe, ora<br />
conservate nel fondo Mappe Catastali dell’Archivio <strong>di</strong> Stato <strong>di</strong> Mantova, commissionate dal<br />
governo austriaco in concorso con il conte Giacomo Mellerio, <strong>di</strong>venuto unico proprietario della<br />
corte, sono corredate da due registri, rispettivamente catasto e sommario, conservati nel medesimo<br />
fondo 39 .<br />
35<br />
Vedasi nota 10.<br />
36<br />
Sul catasto Guarnieri vedasi anche: D. FERRARI, I “cabrei” come fonte per la storia dell’architettura, in Gli archivi<br />
per la storia dell’architettura, atti del convegno 1993, Pubblicazioni degli Archivi <strong>di</strong> Stato, Saggi 51, Roma 1999, pp.<br />
313-340.<br />
37<br />
Sulla cosiddetta “operazione Bisagni” utile documentazione è conservata presso l’Archivio <strong>di</strong> Stato <strong>di</strong> Milano: Fon<strong>di</strong><br />
Camerali, p. a., buste 376, 377, 378. Vedasi anche: ASMn, Intendenza <strong>di</strong> Finanza, busta 152.<br />
38<br />
ASMn, Mappe catastali, n. 608, “Territorio <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong> con Moglia”, senza data, ma post 1785, e n. 610, copia della<br />
608 con aggiunta <strong>di</strong> elementi decorativi.<br />
39<br />
ASMn, Mappe catastali, nn. 566-567, 572-600, volumi nn. 607 e 607 bis. Le mappe Galeani e Simonini, <strong>di</strong> splen<strong>di</strong>da<br />
fattura come già segnalato da M. VAINI, op. cit. p. 186, nota 151, furono versate all’Archivio <strong>di</strong> Stato <strong>di</strong> Mantova nel<br />
8
I volumi n. 85 e 86 sono strettamente connessi e registrano la situazione dei conferenti nel decennio<br />
1859-1869.<br />
Segue la serie degli elenchi dei fittarelli, nn. 87-114, dal 1855 al 1870, talvolta in più copie<br />
per uno stesso anno, ed infine una piccola serie <strong>di</strong> tre registri relativi al palatico, che si è ritenuto <strong>di</strong><br />
mettere in coda trattandosi <strong>di</strong> un’attività peculiare alla sola corte <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>.<br />
Il palatico era una tassa in natura, dovuta, sotto forma <strong>di</strong> sacchi <strong>di</strong> frumento, dai mulini natanti<br />
attraccati nel tratto del Po tra Melara e Ficarolo. I registri in questione elencano i mulini natanti nel<br />
Po attraccati alle piarde <strong>di</strong> Melara, Bergantino, Massa, Calto, Quadrelle e Ficarolo, con<br />
l’in<strong>di</strong>cazione dei nomi dei proprietari, degli eventuali passaggi <strong>di</strong> proprietà, dell’epoca e dell’entità<br />
dei pagamenti tra il 1817 ed il 1871.<br />
Conclusioni<br />
La ricognizione sistematica del fondo ha dunque evidenziato che si tratta <strong>di</strong> registri catastali<br />
locali e parziali, in quanto riferibili ai soli beni <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> e <strong>Sermide</strong> obnoxi alle rispettive <strong>corti</strong>.<br />
Essi configurano un sistema catastale più antico rispetto ai catasti ufficiali <strong>di</strong> Stato, pur<br />
anticipandone caratteristiche e modalità: il <strong>Catasto</strong> Teresiano fu eseguito tra il 1776 ed il 1777 in<br />
entrambi i comuni, mentre il <strong>Catasto</strong> Lombardo Veneto fu eseguito a partire dal 1863 per <strong>Sermide</strong>,<br />
e dal 1864 per <strong>Ostiglia</strong>.<br />
Naturalmente non compaiono tra i conferenti alle <strong>corti</strong> <strong>camerali</strong> <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> e <strong>Sermide</strong> i<br />
gran<strong>di</strong> proprietari terrieri, nobili o borghesi che, avendone i mezzi, avevano provveduto quanto<br />
prima a riscattare le terre dai tributi me<strong>di</strong>evali, ostacolo ad ogni iniziativa impren<strong>di</strong>toriale.<br />
La documentazione offrirà tuttavia nuovi utili spunti per l’indagine storica ed economica<br />
della realtà agraria del Basso Mantovano, con particolare riferimento alla formazione della piccola e<br />
me<strong>di</strong>a proprietà, alla produttività ed ai tipi <strong>di</strong> coltivazione agricola più in uso, alle tipologie<br />
architettoniche più ricorrenti ed in generale alle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> vita <strong>delle</strong> popolazioni rurali.<br />
Mantova, 30 giugno 2005<br />
a cura <strong>di</strong> Luisa Onesta Tamassia<br />
Il presente dattiloscritto è ad uso esclusivo dell’Archivio <strong>di</strong> Stato <strong>di</strong> Mantova e ne è vietata la fotoriproduzione.<br />
1917 (Archivio della Direzione, busta 150). Le mappe 566 e 567, <strong>di</strong> grosso formato, sono relative, rispettivamente, al<br />
Capo <strong>di</strong> Sotto e al Capo <strong>di</strong> Sopra <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>; le mappe nn. 572-600 costituiscono una magnifica serie <strong>di</strong> 29 pezzi<br />
formato cm 65,5 x 95,5. Infine, i volumi 607 e 607bis sono così denominati: “1824. <strong>Catasto</strong> della R. Corte Camerale <strong>di</strong><br />
<strong>Sermide</strong>” e “Sommario de’ beni soggetti alla R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>”.<br />
9
Nota integrativa<br />
In data 29/12/2006, a cura dell’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale <strong>di</strong> Mantova, è stata<br />
versata all’Archivio <strong>di</strong> Stato <strong>di</strong> Mantova una cartella rinvenuta presso l’archivio dei suddetti uffici,<br />
contenente n. 27 mappe in carta su tela, formato cm 65x97, relative ai fon<strong>di</strong> componenti la corte<br />
camerale <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>.<br />
Le mappe, datate "Milano 21 ottobre 1824", bollate e sottoscritte dagli esecutori, l’ingegnere<br />
Galeano Bassani ed il perito Carlo Simonini, si presentano in buono stato <strong>di</strong> conservazione.<br />
Si tratta <strong>di</strong> una copia (mancante <strong>di</strong> due tavole, rispettivamente la III e la V) del cosiddetto “catasto<br />
Galeani-Simonini”, la rilevazione catastale eseguita tra il 1822 ed il 1824, su commissione del conte<br />
milanese Giacomo Mellerio, ultimo proprietario della corte <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>.<br />
Una copia completa <strong>di</strong> tali mappe, pure sottoscritte dagli esecutori, è conservata nel fondo Mappe<br />
Catastali dell’Archivio <strong>di</strong> Stato <strong>di</strong> Mantova, ai numeri 572-600 (vedasi nota 39 dell’introduzione: la<br />
serie completa consta <strong>di</strong> 29 mappe). Sempre nel fondo Mappe Catastali, ai numeri 607 e 607 bis<br />
sono conservati i due registri, rispettivamente <strong>Catasto</strong> e Sommario dei beni soggetti alla corte, che<br />
furono redatti a completamento della rilevazione catastale.<br />
L’evidente pertinenza del nuovo versamento ne ha suggerito la collocazione nel fondo “Catasti<br />
<strong>camerali</strong> <strong>delle</strong> <strong>corti</strong> <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> e <strong>Sermide</strong>”: si veda pertanto la cartella n. 118 aggiunta in coda al<br />
presente inventario.<br />
Mantova, 29 <strong>di</strong>cembre 2006<br />
Luisa Onesta Tamassia<br />
10
Inventario<br />
11
I catasti della corte camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong><br />
Prospetto sintetico<br />
Registri 1-7: catasto vecchio (Giovanni Lodovico <strong>delle</strong> Belle), 1606-1608<br />
Registri 8-14: catasto <strong>di</strong> Gerolamo Bresciani, 1700-1705<br />
Registro 15: “Maestro Rubeo primo”, <strong>di</strong> Carlo Pozzi, 1718<br />
Registro 16: “Maestro Rubeo secondo”, <strong>di</strong> Carlo Pozzi, annotazioni al 1852<br />
Registro 17: tentativo <strong>di</strong> trasformare in denaro i contributi in natura, 1787-1788<br />
Registri 18-20: fase della recupera da parte del governo austriaco, 1852-1854<br />
Registri 21-24: registri dei passaggi <strong>di</strong> proprietà<br />
Registro 25: catasto del 1871<br />
Registri 26-71: elenchi dei fittarelli, 1852-1872.<br />
Registro 1<br />
<strong>Catasto</strong> vecchio della corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>, 1606.<br />
Registro <strong>di</strong> cc. numerate 1000, con annotazioni <strong>di</strong> passaggi <strong>di</strong> proprietà al 1627 circa, unica<br />
annotazione al 1680 a c. 59r.<br />
(Parzialmente in cattivo stato <strong>di</strong> conservazione).<br />
Registro 2<br />
Registro I dei trapassi del catasto vecchio della corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>, 1606.<br />
Registro <strong>di</strong> cc. numerate da 1 a 293, con annotazioni <strong>di</strong> passaggi <strong>di</strong> proprietà al 1700 circa.<br />
Rubrica alfabetica: ve<strong>di</strong> registro n. 6.<br />
Sul frontespizio è riportata una memoria relativa al crollo della torre grande della rocca <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong><br />
avvenuto il 1° febbraio 1649.<br />
Registro 3<br />
Registro II dei trapassi del catasto vecchio della corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>, 1606.<br />
Registro <strong>di</strong> cc. numerate da 291 a 584, con annotazioni <strong>di</strong> passaggi <strong>di</strong> proprietà al 1700 circa.<br />
Rubrica alfabetica: ve<strong>di</strong> registro n. 6.<br />
Registro 4<br />
Registro III dei trapassi del catasto vecchio della corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>, 1606.<br />
Registro <strong>di</strong> cc. numerate da 584 a 882, con annotazioni <strong>di</strong> passaggi <strong>di</strong> proprietà al 1700 circa.<br />
Rubrica alfabetica: registro n. 6.<br />
Registro 5<br />
Registro IV dei trapassi del catasto vecchio della corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>, 1606.<br />
Registro <strong>di</strong> cc. numerate da 882 a 1146, con annotazioni <strong>di</strong> passaggi <strong>di</strong> proprietà al 1700 circa.<br />
Rubrica alfabetica: registro n. 6.<br />
Registro 6<br />
Rubrica alfabetica riferibile ai registri dei trapassi n. 2, 3, 4 e 5, vi sono in<strong>di</strong>cizzati i nomi <strong>di</strong><br />
battesimo.<br />
Registro 7<br />
Elenco dei particolari che pagano denari contanti ed altri fitti alla Corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>, s.d.<br />
Registro <strong>di</strong> cc. numerate 214, con rubrica alfabetica rilegata in testa, ove sono annotate le<br />
tassazioni, in denaro e natura, con riferimento a pagine dei registri dei trapassi n. 2, 3, 4 e 5.<br />
(In cattivo stato <strong>di</strong> conservazione)<br />
12
I catasti della corte camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong><br />
Registro 8<br />
“Libro primo <strong>delle</strong> misure e piante de terreni, casamenti et altro sotto la Corte d’<strong>Ostiglia</strong> e sua<br />
giuris<strong>di</strong>zione”, Girolamo Bresciani, 1700.<br />
Registro <strong>di</strong> cc. numerate 49, con rubrica alfabetica rilegata in testa. Vi sono descritti terreni e<br />
fabbricati posti nelle seguenti zone <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>: San Romano, zona verso Ponte Molino.<br />
Registro 9<br />
Libro secondo <strong>delle</strong> misure e piante dei terreni, casamenti ed altro sotto la corte d’<strong>Ostiglia</strong> e sua<br />
giuris<strong>di</strong>zione, Girolamo Bresciani, 1700.<br />
Registro <strong>di</strong> cc. numerate 49, privo del frontespizio, con rubrica alfabetica rilegata in testa. Vi sono<br />
descritti terreni e fabbricati posti nelle seguenti zone <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>: contrada del Porto, contrada del<br />
Vegnale (o Vignale), contrada del Arnarolo, contrada della Restara Vecchia, contrada <strong>di</strong> San<br />
Sebastiano, contrada della Restara Nova, contrada <strong>delle</strong> Restare, sito del Capitello, contrada in<br />
Capo <strong>di</strong> Villa o sia contrada <strong>delle</strong> Cavrese, contrada detta la Via Bassa.<br />
Registro 10<br />
“Libro terzo <strong>delle</strong> misure e piante de terreni, casamenti et altro sotto la Corte d’<strong>Ostiglia</strong> e sua<br />
giuris<strong>di</strong>zione”, Girolamo Bresciani, 1700.<br />
Registro <strong>di</strong> cc. numerate 50, con rubrica alfabetica rilegata in testa. Sul retro della coperta “Dosso,<br />
Civete, Maselle, Cornale, Vignale, Arnarolo”.<br />
Registro 11<br />
“Libro quarto <strong>delle</strong> misure e piante de terreni, casamenti et altro sotto la Corte d’<strong>Ostiglia</strong> e sua<br />
giuris<strong>di</strong>zione”, Girolamo Bresciani, 1700.<br />
Registro <strong>di</strong> cc. numerate 50, con rubrica alfabetica rilegata in testa. Sul retro della coperta:<br />
“Cornale, Coregioli, Bisella, Communa”.<br />
Registro 12<br />
“Libro quinto <strong>delle</strong> misure e piante de terreni, casamenti et altro sotto la Corte d’<strong>Ostiglia</strong> e sua<br />
giuris<strong>di</strong>zione”, Girolamo Bresciani, 1700.<br />
Registro <strong>di</strong> cc. numerate 48, con rubrica alfabetica rilegata in testa. Sul retro della coperta:<br />
“Communa, Calcinare, Panzine o sia Tencarola, Cappo <strong>di</strong> Villa”.<br />
Registro 13<br />
“Libro sesto <strong>delle</strong> misure e piante de terreni, casamenti et altro sotto la Corte d’<strong>Ostiglia</strong> e sua<br />
giuris<strong>di</strong>zione”, Girolamo Bresciani, 1700.<br />
Registro <strong>di</strong> cc. numerate 20, con rubrica alfabetica formato vacchetta rilegata all’inizio. Sul retro<br />
della coperta: “S. Giovanni, Cantonata, Tencarola [“Tencarola” è cassato].<br />
Registro 14<br />
“Cattastro Rubeo”, 1700 circa.<br />
Registro <strong>di</strong> cc. numerate 288, manca la carta n. 18, con annotazioni dal 1710 (c. 121b) al 1745 circa<br />
(c. 89b), riferimenti ai quattro registri catastali nn. 2-5, a 18 libretti <strong>delle</strong> misurazioni eseguiti tra il<br />
1606 ed il 1608, (cc. 3a, 7a, 101a, 113a, ecc.) ed ai libri <strong>delle</strong> misurazioni eseguiti da Bresciani nel<br />
1700 (cc. 2a, 198a).<br />
Registro 15<br />
“Maestro Rubeo primo”, Carlo Pozzi, 1718<br />
Registro <strong>di</strong> cc. numerate 300, con rubrica alfabetica inserta, annotazioni al 1846 circa.<br />
13
I catasti della corte camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong><br />
Registro 16<br />
“Maestro Rubeo secondo”, post 1748 (dal 1753, c. 40b), con annotazioni al 1852.<br />
Registro <strong>di</strong> cc. numerate 291, la numerazione prosegue fino a c. 341 su quinternetto non rilegato<br />
intitolato “Quinternetto d’unirsi al Maestro Rubeo secondo per le partite 1834 1835”, rubrica<br />
alfabetica inserta.<br />
Registro 17<br />
“Liquidazione relativa alla redenzione implorata dai contribuenti della Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong><br />
eseguita sulla norma prescritta dalla R. Intend. Pol. <strong>di</strong> Mantova”, s. d., ma 1787-1788. (Vedasi:<br />
Intendenza Politica <strong>di</strong> Mantova, b. 378, fasc. 173).<br />
Registro <strong>di</strong> cc. numerate 49 con fincatura a stampa, cui seguono 4 cc. numerate con fincatura<br />
manoscritta, in coda prospetti riassuntivi.<br />
Registro 18<br />
“Sommarione o stato dei beni sottoposti alla Camerale Corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>”, 15 settembre 1852.<br />
Quinternetto <strong>di</strong> cc. 40, detto “sommarione del Baldoli”.<br />
Il registro pone a confronto la situazione dei beni obnoxi alla Corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> al momento della<br />
ven<strong>di</strong>ta, nel 1747 e nel 1765, con la situazione riscontrata al momento della recupera da parte del<br />
governo austriaco nel 1852.<br />
Registro 19<br />
“Catastro dell’I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>”, (1852-1854).<br />
Registro <strong>di</strong> cc. numerate 111, con elencati in or<strong>di</strong>ne alfabetico possessori conferenti, riferimenti<br />
catastali ai beni posseduti e relative tassazioni in natura e sotto forma <strong>di</strong> fittarelli stabili.<br />
Registro 20<br />
“Possessori obnoxi alla R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>”, s.d., ma 1854.<br />
Registro <strong>di</strong> cc. 53, con carattere <strong>di</strong> minuta, che elenca 420 possessori, con natura e valore capitale<br />
della obnoxietà. Inserto foglio n. 1655 <strong>di</strong> “Osservazioni emerse all’atto del confronto della Tavola<br />
Censuaria del Comune <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> colle Rubriche dei fon<strong>di</strong> obnoxi alla Regia Corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>”,<br />
datato 16 giugno 1854.<br />
Registro 21<br />
“Registro pei trapassi dei Fon<strong>di</strong> obnoxi alla I. R. Corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>”, volume I.<br />
Registro partitario <strong>di</strong> cc. numerate da 1 a 190½, possessori dalla lettera A alla C.<br />
(In cattivo stato <strong>di</strong> conservazione)<br />
Registro 22<br />
“Registro pei trapassi dei Fon<strong>di</strong> obnoxi alla I. R. Corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>”, volume II.<br />
Registro partitario <strong>di</strong> cc. numerate da 191 a 388, possessori dalla lettera C alla lettera L.<br />
(In cattivo stato <strong>di</strong> conservazione)<br />
Registro 23<br />
“Registro pei trapassi dei Fon<strong>di</strong> obnoxi alla I. R. Corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>”, volume III.<br />
Registro partitario <strong>di</strong> cc. numerate da 389 a 585, possessori dalla lettera M alla lettera R.<br />
(In cattivo stato <strong>di</strong> conservazione)<br />
14
I catasti della corte camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong><br />
Registro 24<br />
“Registro pei trapassi dei Fon<strong>di</strong> obnoxi alla I. R. Corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>”, volume IV.<br />
Registro partitario <strong>di</strong> cc. numerate da 586 a 699, possessori dalla lettera S alla lettera Z.<br />
(In cattivo stato <strong>di</strong> conservazione)<br />
Registro 25<br />
“<strong>Catasto</strong> della Regia Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> 1871”, 1871.<br />
Registro <strong>di</strong> cc. 191 con possessori conferenti in or<strong>di</strong>ne alfabetico e riferimenti al catasto <strong>di</strong> Felice<br />
Pozzi.<br />
Elenchi dei fittarelli (1852-1872)<br />
Registro 26<br />
“Elenchi B e C <strong>delle</strong> partite fon<strong>di</strong>arie che pagavano in generi in natura, e con in<strong>di</strong>cazione dei<br />
fittarelli precari stabiliti nell’anno 1852”, 1852.<br />
Registro 27<br />
“Elenco <strong>delle</strong> offerte pei fittarelli precari in surrogazione <strong>delle</strong> prestazioni dei generi in natura dei<br />
fon<strong>di</strong> obnoxi alla Cameral Corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> per l’anno 1853”, 25 maggio 1853.<br />
Registro 28<br />
“Elenco della offerte pei fittarelli precari in surrogazione della prestazione dei generi in natura dei<br />
fon<strong>di</strong> obnoxi alla Cameral Corte <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> per l’anno 1853”, 25 maggio 1853, copia.<br />
Registro 29<br />
“Elenco dei offerenti pei fittarelli stabili [“stabili” è cassato] precari in surrogazione dei generi in<br />
natura dei fon<strong>di</strong> obnoxi alla Regia Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong> per l’anno 1853”, 1853, minuta.<br />
Registro 30<br />
“I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>. Fittarelli precari anno 1854”, 25 giugno 1854.<br />
Registro 31<br />
“I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>. Fittarelli precari anno 1854”, 25 giugno 1854, copia.<br />
Registro 32<br />
“I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>. Fittarelli precari anno 1854”, 25 giugno 1854, minuta.<br />
Registro 33<br />
“Elenco dei fittarelli precari dell’anno rurale 1855. I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>”, 10 maggio<br />
1855.<br />
Registro 34<br />
“Elenco dei fittarelli precari per l’anno camerale 1855. Dell’I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>”, 10<br />
maggio 1855, copia.<br />
Registro 35<br />
“Elenco dei fittarelli precari dell’anno camerale 1856. Dall’I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>”, 10<br />
aprile 1856.<br />
15
I catasti della corte camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong><br />
Registro 36<br />
“Elenco dei fittarelli precari dell’anno camerale 1856. Dall’I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>”, 10<br />
aprile 1856, copia.<br />
Registro 37<br />
“Elenco dei fittarelli precari per l’anno camerale 1857 dell’I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>”, 20<br />
marzo 1857.<br />
Registro 38<br />
Elenco dei fittarelli precari per l’anno camerale 1857.<br />
Registro privo <strong>di</strong> copertina, copia del n. 37.<br />
Registro 39<br />
“Elenco dei fittarelli precari stabiliti per l’anno camerale 1858, e per più anni, in luogo della<br />
prestazione dei generi in natura dai fon<strong>di</strong> obnoxi all’I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>”, 1° maggio<br />
1858.<br />
Registro 40<br />
“Elenco dei fittarelli precari stabiliti per l’anno camerale 1858, e per più anni, in luogo della<br />
prestazione dei generi in natura dai fon<strong>di</strong> obnoxi all’I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>”, 1° maggio<br />
1858, copia.<br />
Registro 41<br />
“Elenco dei fittarelli precari stabiliti per l’anno camerale 1858, e per più anni, in luogo della<br />
prestazione dei generi in natura per tutti i fon<strong>di</strong> obnoxi all’I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>”, 1°<br />
maggio 1858, copia.<br />
Registro 42<br />
“I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>. Elenco dei fittarelli precari stabiliti per l’anno camerale 1859 e<br />
per più anni”, 12 giugno 1859.<br />
Registro 43<br />
“I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>. Elenco dei fittarelli precari stabiliti per l’anno camerale 1859 e<br />
per più anni”, 12 giugno 1859, copia.<br />
Registro 44<br />
“I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>. Elenco dei fittarelli precari stabiliti per l’anno camerale 1860 e<br />
per più anni”, 15 agosto 1860.<br />
Registro 45<br />
“I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>. Elenco dei fittarelli precari stabiliti per l’anno camerale 1860 e<br />
per più anni”, 29 agosto 1861.<br />
Registro 46<br />
“I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>. Elenco dei fittarelli precari per l’anno camerale 1861”, 14 giugno<br />
1862.<br />
16
I catasti della corte camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong><br />
Registro 47<br />
“I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>. Elenco dei fittarelli precari dell’anno camerale 1861”, s. d., copia.<br />
(In cattivo stato <strong>di</strong> conservazione)<br />
Registro 48<br />
“I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>. Elenco dei fittarelli precari dell’anno camerale 1862”, 20 giugno<br />
1863.<br />
Registro 49<br />
“I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>. Elenco dei fittarelli precari dell’anno camerale 1862”, 20 giugno<br />
1863, copia.<br />
Registro 50<br />
“Elenco dei fittarelli precari dell’anno camerale 1862”, 20 giugno 1863, minuta.<br />
Registro 51<br />
“I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>. Elenco dei fittarelli precari dell’anno camerale 1863”, 30<br />
novembre 1863.<br />
Registro 52<br />
“I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>. Elenco dei fittarelli precari per l’anno camerale 1863”, 30<br />
novembre 1863, copia.<br />
Registro 53<br />
“I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>. Elenco dei fittarelli precari per l’anno camerale 1863”, 30<br />
novembre 1863, minuta.<br />
Registro 54<br />
“I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>. Elenco dei fittarelli precari dell’anno camerale 1864”, 3 marzo<br />
1864.<br />
Registro 55<br />
“I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>. Elenco dei fittarelli precari dell’anno camerale 1864”, 3 marzo<br />
1864, copia.<br />
Registro 56<br />
“I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>. Elenco dei fittarelli precari dell’anno camerale 1864”, 6 giugno<br />
1864, minuta.<br />
Registro 57<br />
“I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>. Elenco dei fittarelli precari dell’anno solare 1865”, 1865.<br />
Registro 58<br />
“R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>. Elenco dei fittarelli precari dell’anno solare 1865”, 1865.<br />
Registro 59<br />
“I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong>. Elenco dei fittarelli precari dell’anno solare 1865”, “Copia per<br />
uso ufficio”, 1865.<br />
17
I catasti della corte camerale <strong>di</strong> <strong>Ostiglia</strong><br />
Registro 60<br />
“Elenco dei fittarelli precari dell’anno 1866”, 1866.<br />
Registro 61<br />
“Elenco dei fittarelli precari dell’anno 1867”, “Copia per uso ufficio”, 30 giugno 1867.<br />
Registro 62<br />
“Elenco dei fittarelli precari dell’anno solare 1868”, 1868.<br />
Registro 63<br />
“Elenco dei fittarelli precari dell’anno 1869”, 17 <strong>di</strong>cembre 1869.<br />
Registro 64<br />
“Stralcio dei debitori per fittarello precario dell’anno solare 1869”, 1869.<br />
Registro 65<br />
“Elenco dei fittarelli precari dell’anno 1870”, 8 giugno 1870.<br />
Registro 66<br />
“Estratto <strong>delle</strong> <strong>di</strong>tte che devono sod<strong>di</strong>sfare il fittarello precario e fittarello stabile dell’anno 1870<br />
settanta”, 1870.<br />
Registro 67<br />
“Elenco dei fittarelli precari dell’anno 1871”, 28 aprile 1871.<br />
Registro 68<br />
“Elenco dei fittarelli precari dell’anno 1871”, 20 luglio 1871.<br />
Registro 69<br />
“Prontuario dei fittarelli precari dell’anno solare 1871”, 1871.<br />
Registro 70<br />
“Elenco dei fittarelli precari dell’anno 1872”, 29 maggio 1872.<br />
Registro 71<br />
“Prontuario dei fittarelli precari dell’anno solare 1872 due”, 1872.<br />
18
I catasti della corte camerale <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong><br />
Prospetto sintetico:<br />
Registri 72-73: catasto fatto eseguire da Maria Gonzaga, detto catasto <strong>di</strong> Madama, 1643<br />
Registri 74-76: catasto <strong>di</strong> Giacomo Guarnieri, 1710<br />
Cartella 77: mappe del catasto <strong>di</strong> Giuseppe Bisagni, 1766-1768<br />
Registri 78-80: catasto <strong>di</strong> Giuseppe Bisagni, 1768-1778<br />
Registro 81: tentativo <strong>di</strong> trasformare in denaro le contribuzioni in natura, 1787-1788<br />
Registri 82-83: registri contabili, 1814-1853<br />
Registro 84: registro dei passaggi <strong>di</strong> proprietà, post 1824<br />
Registri 85-86: registri dei conferenti alla corte <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>, 1859-1869<br />
Registri 87-114: elenchi dei fittarelli, 1855-1870<br />
Registri 115-117: registri relativi al palatico, tassa dovuta dai mulini, 1817-1871<br />
Registro 72<br />
“1643 Originale. Catastro de beni della Corte <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong> <strong>di</strong> Madama Serenissima Duchessa <strong>di</strong><br />
Mantova”, 1643.<br />
Esemplare originale con sottoscrizione del notaio Ludovico Fred<strong>di</strong> in data 23 giugno 1646, rubrica<br />
alfabetica rilegata in coda.<br />
Registro 73<br />
“Catastro de beni della Corte <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong> <strong>di</strong> Madama Serenissima Duchessa <strong>di</strong> Mantova del 1643”,<br />
1643, copia presumibilmente coeva del registro n. 72, rubrica alfabetica inserta.<br />
Registro 74<br />
“<strong>Sermide</strong>. <strong>Catasto</strong> Guarnieri”, Giacomo Guarnieri, 1710.<br />
Sul retro della coperta: “1710 Catastro del Guarnieri”.<br />
Registro catastale sud<strong>di</strong>viso in due parti: la prima parte, <strong>di</strong> cc. numerate 219, relativa a terreni che<br />
corrispondono beni in natura alla corte <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>; la seconda parte, <strong>di</strong> cc. numerate 123, relativa a<br />
case ed e<strong>di</strong>fici che corrispondono fittarelli.<br />
In coda due in<strong>di</strong>ci alfabetici: “In<strong>di</strong>ce <strong>delle</strong> terre che pagano in natura”, “In<strong>di</strong>ce dei fittarelli”, con<br />
in<strong>di</strong>cizzati nomi <strong>di</strong> battesimo.<br />
Nel catasto sono descritte e <strong>di</strong>segnate in pianta ed in alzato terre e case <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>, Moglia e<br />
Carbonara (cc. 115-123 della seconda parte) nelle seguenti vie, contrade e località.<br />
<strong>Sermide</strong>: contrada <strong>di</strong> Porcara, contrada della via Fredda, contrada del Capitello <strong>delle</strong> Mastine,<br />
contrada della Roversella, contrada della Carossa, contrada del Forcello, contrada del Capo <strong>di</strong> Sotto,<br />
via <strong>di</strong> Santa Croce, via de Gran<strong>di</strong>, contrada <strong>delle</strong> Cabianche, contrada del Bassanello, contrada del<br />
Gorgo (o de’ Gorghi), via dell’Ospitale, contrada de’ Casoni, località Capitel Vecchio, via <strong>delle</strong><br />
Brusche, località Montine, contrada dello Zappellone, contrada dell’Argine Novo, contrada<br />
dell’Argine Vecchio, via della Corte, località Castello, via Brunella, località Schiappetta, contrada<br />
dell’Arloia, via del Dragoncello.<br />
Moglia: contrada della Ro<strong>di</strong>ana, via <strong>delle</strong> Maine, via Bolognese, via <strong>di</strong> Traverso, contrada<br />
dell’Argine, Verzenese, via <strong>delle</strong> Polle, contrada del Travessagno, Argine della Valle, contrada del<br />
Bugno, via dei Dossi, via della Brolla.<br />
Carbonara: contrada <strong>delle</strong> Basse, contrada della Chiavica <strong>di</strong> Scapino, località chiavica della Via<br />
Grande.<br />
Registro 75<br />
“Copia. In<strong>di</strong>ce de’ terreni che pagano in natura sotto la Corte <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>”, s. d. (1766)<br />
Rubrica alfabetica con aggiornamenti, riferibile alla prima parte del catasto Guarnieri (registro 74),<br />
in cui sono in<strong>di</strong>cizzati i cognomi.<br />
19
I catasti della corte camerale <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong><br />
Registro 76<br />
“Copia. 1766 In<strong>di</strong>ce de Fittarelli <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>”, 1766.<br />
Rubrica alfabetica con aggiornamenti, riferibile alla seconda parte del catasto Guarnieri (registro<br />
74), in cui sono in<strong>di</strong>cizzati i cognomi.<br />
Registro 77<br />
“Libro de’ <strong>di</strong>segni coppia <strong>delle</strong> mappe”, catasto <strong>di</strong> Giuseppe Bisagni, 1766-1768<br />
Coperta in cartone rigido e sovracoperta <strong>di</strong> tela verde contenente rilegate n. 62 mappe relative a<br />
<strong>Sermide</strong>, e due mappe slegate (nn. 64 e 65) relative a Carbonara; unità <strong>di</strong> misura in trabucchi<br />
milanesi.<br />
Si tratta <strong>di</strong> una copia del catasto eseguito dal perito camerale Giuseppe Bisagni tra il 1766 ed il<br />
1768.<br />
Il catasto Bisagni era costituito da 5 mappe, <strong>di</strong> cui una in formato minore relativa alle alluvioni, non<br />
presente tra le copie. Ogni mappa si sviluppava in più fogli detti “foglio rettangolo” (“R.°”)<br />
identificati con un numero romano; ciascun foglio rettangolo si articolava a sua volta in più tipi. Un<br />
foglio manoscritto applicato in testa alle mappe riassume la corrispondenza tra i numeri <strong>di</strong> mappale<br />
ed i singoli tipi.<br />
Inserto sommarione con in<strong>di</strong>cazione dei possessori, denominazione dei fon<strong>di</strong>, in<strong>di</strong>cazione della<br />
tassazione e corrispondenza tra i numeri <strong>di</strong> mappale del catasto Bisagni (“numero <strong>di</strong> mappa<br />
particolare”) ed i numeri <strong>di</strong> mappale del catasto Teresiano (“numero della mappa censuaria”)<br />
eseguito per <strong>Sermide</strong> nel 1777.<br />
Registro 78<br />
Coperta in cartone con scritta sulla costa “Ser Cat 1768”, contenente quattro quinternelli come<br />
segue: “N. 1 1768 Quinternello del Cappo <strong>di</strong> Sotto insino alla strada della Carossa. Corte Camerale<br />
<strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>”; “N. 2 1768 Quinternello del quarter dalla strada dalla Carossa insino alla via del<br />
Ospitalle. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>”; “N. 3 1768 Quinternello del quarter dalla strada del Ospitale<br />
insino alla via del Chiavechione e Bolognese sotto la Moglia”; “N. 4 Quinternello della Moglia del<br />
1768”.<br />
Si tratta <strong>di</strong> un libro <strong>di</strong> denunce raccolte nel 1768 relative ai fon<strong>di</strong> della Moglia, del Capo <strong>di</strong> Sotto,<br />
strada Carossa, strada dell’Ospedale al Chiavicone e via Bolognese.<br />
Registro 79<br />
“Catastro de’ fittarelli. C”, s.d. (1776).<br />
Registro <strong>di</strong> cc. numerate 300 contenente la descrizione <strong>delle</strong> proprietà che pagano fittarelli.<br />
Registro 80<br />
“Fittarelli che si pagano alla Corte <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>”, Giuseppe Bisagni, 1778, aggiornamenti al 1804.<br />
Registro <strong>di</strong> cc. numerate 282, con rubrica alfabetica rilegata in coda. Rilegato in testa quinternetto<br />
riassuntivo “Nota de’ fittarelli che annualmente si devono pagare da’ sotto<strong>di</strong>stinti alla Corte <strong>di</strong><br />
<strong>Sermide</strong>”, datato e firmato dal Bisagni, con in<strong>di</strong>cati 280 contribuenti ed entità della contribuzione in<br />
denaro. Segue ulteriore elenco dei contribuenti con sottoscrizione <strong>di</strong> Giuseppe Bisagni, 2 febbraio<br />
1778.<br />
Registro 81<br />
“61. Registro de terreni contribuenti alla Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>”, s.d., ma 1787-1788. (Vedasi:<br />
Intendenza Politica <strong>di</strong> Mantova, b. 378, fasc. 173).<br />
Registro <strong>di</strong> cc. numerate 65 con fincatura a stampa. Gli utenti sono elencati in or<strong>di</strong>ne alfabetico e<br />
numerati progressivamente fino al numero 451.<br />
20
I catasti della corte camerale <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong><br />
Registro 82<br />
“Giornale <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong> dal <strong>di</strong>cembre 1815 al”, 1814-1853.<br />
Registro <strong>di</strong> cc. numerate 189, con rubrica alfabetica e carte inserte, contenente la contabilità della<br />
corte <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong> sotto forma <strong>di</strong> “dare e avere”. La rubrica in<strong>di</strong>cizza non solo cognomi <strong>di</strong> persone,<br />
ma anche altre voci.<br />
Registro 83<br />
Giornale “dare e avere” dei fittarelli della corte <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>, 1825-1852.<br />
Registro <strong>di</strong> cc. numerate 498, contenente in or<strong>di</strong>ne alfabetico nomi dei conferenti alla corte <strong>di</strong><br />
<strong>Sermide</strong> e Carbonara (da c. 323) per fittarelli stabili e precari (da c. 347) e annotazioni dei<br />
versamenti.<br />
Inserto fascicolo privo <strong>di</strong> copertina “Fittarelli precari costituiti prima della Rettifica del Catastro e<br />
non rinnovati colle nuove scritture”, 1825-1853.<br />
Registro 84<br />
“Regia Corte <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>. Registro dei trapassi. Volume III°”, 1855-1869.<br />
Registro partitario, superstite <strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> tre volumi, relativo ai “trapassi dei fon<strong>di</strong> obnoxi all’I.<br />
R. Corte <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>” in relazione al catasto Galeani e Simonini, con fincatura <strong>di</strong> carico e sgravio.<br />
Per il catasto Galeani e Simonini vedasi: Mappe catastali, nn. 566-567, 572-600, 607-607bis.<br />
Registro 85<br />
“Volume n.° 1° Registro partitario”, 1860-1869.<br />
Registro dei conferenti alla corte <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong> elencati in or<strong>di</strong>ne alfabetico, con relativi debiti e cre<strong>di</strong>ti<br />
per fittarelli stabili, precari o per altre causali, ed annotazioni <strong>delle</strong> date dei pagamenti, con<br />
riferimento al numero <strong>di</strong> bolletta rilasciata dal fattore. La scritta sopra la fincatura “Conferente alla<br />
Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong> come al registro Trapassi al progressivo n.” rimanda ad una serie <strong>di</strong> tre<br />
registri dei trapassi dei quali si è conservato solo il terzo, ve<strong>di</strong> n. 84.<br />
Inserta rubrica alfabetica “Rubrica <strong>delle</strong> <strong>di</strong>tte debitrici per <strong>di</strong>versi titoli <strong>di</strong> ren<strong>di</strong>ta alla I. R. Corte <strong>di</strong><br />
<strong>Sermide</strong> dal Camerale 1861 in avanti” valida anche per il registro successivo n. 86.<br />
Registro 86<br />
“Registro conferenti alla Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>”, 1859-1869. Sulla costa: “Vol. n. II°”.<br />
Registro in tutto simile al precedente, con il quale con<strong>di</strong>vide la rubrica alfabetica.<br />
Elenchi dei fittarelli (1855-1870)<br />
Registro 87<br />
“Elenco dei fittarelli precari dell’anno rurale 1855. I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>”, 1° giugno<br />
1855.<br />
Registro 88<br />
“Elenco dei fittarelli precari dell’anno camerale 1856. Dall’I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>”, 10<br />
aprile 1856.<br />
Registro 89<br />
“Elenco dei fittarelli precari dell’anno camerale 1856. Dall’I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>”, 10<br />
aprile 1856, minuta.<br />
21
I catasti della corte camerale <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong><br />
Registro 90<br />
“N. 1. Elenco <strong>di</strong> fittarelli precari dell’anno Camerale 1857 dell’I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>”,<br />
20 marzo 1857.<br />
Registro 91<br />
“N. 1. Elenco <strong>di</strong> fittarelli precari dell’anno Camerale 1857 dell’I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>”,<br />
20 marzo 1857, copia.<br />
Registro 92<br />
“Elenco N. 2. Fittarelli precari dell’Anno Camerale 1857 dell’I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>”, 25<br />
maggio 1857.<br />
Registro 93<br />
“Elenco N. 2. Fittarelli precari dell’Anno Camerale 1857 dell’I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>”, 25<br />
maggio 1857, minuta.<br />
Registro 94<br />
“Elenco dei fittarelli precari dell’Anno Camerale 1858 dell’I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>”, 15<br />
maggio 1858.<br />
Registro 95<br />
“Elenco dei fittarelli precari dell’Anno Camerale 1858 dell’I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>”, 15<br />
maggio 1858, copia.<br />
Registro 96<br />
“Elenco dei fittarelli precari dell’Anno Camerale 1858”, 15 maggio 1858, minuta.<br />
Inserto fascicolo “1858. Fittarelli precari per locazione”, minuta riassuntiva.<br />
Registro 97<br />
“I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>. Elenco dei fittarelli precari stabiliti nell’Anno Camerale 1859”,<br />
1° giugno 1859.<br />
Registro 98<br />
“I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>. Elenco dei fittarelli precari stabiliti nell’Anno Camerale 1859”,<br />
maggio 1859, minuta.<br />
Registro 99<br />
“I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>. Elenco dei fittarelli precari dell’Anno Camerale 1860”, 26<br />
giugno 1860.<br />
Registro 100<br />
“I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>. Elenco dei fittarelli precari dell’Anno Camerale 1860”, 26<br />
giugno 1860, minuta.<br />
Registro 101<br />
“I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>. Elenco dei fittarelli precari dell’Anno Camerale 1861”, 25 aprile<br />
1861.<br />
22
I catasti della corte camerale <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong><br />
Registro 102<br />
“I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>. Elenco dei fittarelli precari dell’Anno Camerale 1862”, 24<br />
maggio 1862.<br />
Registro 103<br />
“I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>. Elenco dei fittarelli precari dell’Anno Camerale 1863”, 24<br />
giugno 1864.<br />
Registro 104<br />
“I. R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>. Elenco dei fittarelli precari dell’Anno Camerale 1863”, 24<br />
giugno 1865, copia.<br />
Registro 105<br />
“Elenco dei fittarelli precari 1867”, “N° 3 quinternotto”, 14 gennaio 1869.<br />
Registro 106<br />
“R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>. Elenco dei fittarelli precari per l’anno 1868”, 15 maggio 1868.<br />
Registro 107<br />
“R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>. (Elenco) dei fittarelli precari per l’anno 1868. Volume I, dal n. 1 al<br />
n. 101”, all’interno volume II, dal n. 102 al n. 236, copia.<br />
Registro 108<br />
“R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>. Elenco dei fittarelli precari 1868”, 15 maggio 1868.<br />
Registro 109<br />
“R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>. Elenco dei fittarelli precar del 1869”, 1° marzo 1871.<br />
Registro 110<br />
“ R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>. Fittarelli precari 1869”, 1° marzo 1871, minuta.<br />
Registro 111<br />
“Fittarelli precari stabiliti per locazione negli anni 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867 e<br />
1868”, senza data.<br />
Registro 112<br />
Fittarelli precari dal n. 9 al n. 167, 1864-1869, senza data.<br />
Registro 113<br />
“Fittarelli precari stabiliti per locazione negli anni 1864, 1865, 1866, 1867, 1868 e 1869”, 1° giugno<br />
1870.<br />
Registro 114<br />
“Rubrica fittarelli” ["fittarelli" è cassato], senza data.<br />
Rubrica alfabetica ottocentesca, che non è stato possibile riferire ad alcun registro del fondo, con<br />
elencati nomi <strong>di</strong> conferenti <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong><br />
23
Serie dei registri relativi al palatico (1817-1871)<br />
I catasti della corte camerale <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong><br />
Registro 115<br />
“1817 Palatico de Mulini Ferraresi in acqua Mantovana”, 1817-1854.<br />
Registro <strong>di</strong> cc. numerate 107, sul frontespizio “Elenco dei mulini ferraresi natanti in Po sulle acque<br />
mantovane quali pagano il palatico alla Regia Cameral Corte <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>”. Nel registro sono<br />
in<strong>di</strong>cati, in relazione alle piarde <strong>di</strong> Melara, Bergantino, Massa, Calto, Quadrelle e Ficarolo, n. 37<br />
mulini natanti con relativi proprietari, eventuali passaggi <strong>di</strong> proprietà, epoca ed entità dei pagamenti<br />
del palatico in sacchi <strong>di</strong> frumento. Inserto foglio “Rubrica dei Molini in Po”, con aggiornamenti al<br />
1848.<br />
Registro 116<br />
“Palatico <strong>Sermide</strong>”, 1853-1871.<br />
Registro <strong>di</strong> cc. numerate 92, a seguire bianche, con rubrica alfabetica rilegata in testa, relativo alle<br />
esazioni della tassa dovuta dai mulini natanti in Po soggetti alla giuris<strong>di</strong>zione della corte camerale<br />
<strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>.<br />
Registro 117<br />
Introiti conseguiti per il pagamento del palatico dal 1859 al 1862, 22 novembre 1862.<br />
Quinterno <strong>di</strong> cc. 14 relativo agli introiti conseguiti dall’esattore fiscale <strong>di</strong> Rovigo per conto<br />
dell’Intendenza <strong>di</strong> Mantova per il palatico dei mulini natanti sul Po in territorio ro<strong>di</strong>gino.<br />
Cartella 118<br />
N. 27 mappe del catasto Galeani – Simonini, 21 ottobre 1824.<br />
Si tratta <strong>di</strong> una copia originale, bollata e sottoscritta dagli esecutori, del catasto eseguito<br />
dall’ingenere Galeano Bassani e dal perito Carlo Simonini, tra il 1822 ed il 1824, su commissione<br />
del proprietario della corte, il nobile milanese Giacomo Mellerio.<br />
Per una consultazione completa si vedano i registri numero 607 “1824. <strong>Catasto</strong> della R. Corte<br />
Camerale <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>”e 607 bis “Sommario de’ beni soggetti alla R. Corte Camerale <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>”<br />
del fondo Mappe catastali.<br />
Risultando mancanti la mappa III e la V, si vedano rispettivamente la n. 574 e la n. 577 del suddetto<br />
fondo.<br />
Elenco dei principali toponimi in<strong>di</strong>cati nelle mappe:<br />
Tav. I: Grossine, Traversagno, Dossi, via <strong>di</strong> Traverso, Pole, fiume Po.<br />
Tav. II: Dossi, via <strong>di</strong> Traverso, Loghino Arginino, Boldrine, Brunello, palazzo Goldoni, Gan<strong>di</strong>na<br />
Magni.<br />
Tav. III (manca), vedasi n. 574 Mappe catastali: palazzo Goldoni, Boaria, Moglia, Gan<strong>di</strong>na Magni,<br />
Gan<strong>di</strong>na, Fenil Novo, Cà Ghi<strong>di</strong>ni.<br />
Tav. IV: palazzo Goldoni, Boaria, Moglia, Bugno, Chiavicone, Formigoni, Brola, Gan<strong>di</strong>na, Fenil<br />
Nuovo, Cà Ghi<strong>di</strong>ni.<br />
Tav. IV: Roso, Feniletto, Ro<strong>di</strong>ana.<br />
Tav. V: (manca), vedasi n. 577 Mappe catastali: Barche, Polesnino, Bassanello, Ospitale, Sabioni,<br />
Maruzze, Brola, Roso, Argine Nuovo, Cà Zapparoli, Boaria, Cà Cavicchini, Palazzina, Montagnola,<br />
Montine.<br />
Tav. VI: Loghino, Maine, Brusche, Sore, Zappellone, Cà Boschetti, Casoni.<br />
Tav. VI: Brola, Cà Zapparoli, Cà de Gran<strong>di</strong>, Banzone, Palazzina, Montine.<br />
24
Serie dei registri relativi al palatico (1817-1871)<br />
Segue cartella 118<br />
I catasti della corte camerale <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong><br />
Tav. VII: Banzone, Palazzina, Montine, Bellagamba, Brusche, Lanzone.<br />
Tav. VIII: Lanzone, Zappellone, Cà Boschetti.<br />
Tav. VIII: fiume Po, Polesnino, Ospitale, Sabbioni, Maruzze, Bellagamba, Colombarola, borgo <strong>di</strong><br />
<strong>Sermide</strong>, Corte Camerale.<br />
Tav. IX: Borgo <strong>di</strong> <strong>Sermide</strong>, fiume Po, Boaria, Schiappe, Colombara.<br />
Tav. X: Corte Camerale, Schiapetta, Cà Schiavi, Colombara, Brunelli.<br />
Tav. XI: fiume Po, Capo <strong>di</strong> Sotto.<br />
Tav. XII: Fredde, Strozza, San Giovanni, Polle, Boaria, Paramatte, Galle, Maccaciò, Possioncella.<br />
Tav. XIII: Cà Schiavi, Brunelli, Fredde, Casoncelli, Cà Rossa, Boaria, Paramatte.<br />
Tav. XIV: Boaria, Paramatte, Galle, Strozza, Maccacciò, Possioncella, Barco.<br />
Tav. XV: Loghino Maffei, Cà Rossa, Boaria, Paramatte, Pantirola, Forcello, Manetta, Pantera,<br />
Gorne, Gornette, Casetta.<br />
Tav. XVI: Motte, Nodare, Loghino Maffei, Forcello.<br />
Tav. XVII: Casoni, Cà Boschetti, Loghino, Rosse, Motte, Loghino Maffei, Nodare.<br />
Tav. XVIII: Ro<strong>di</strong>ana, Maine, Sore, Casoni.<br />
Tav. XIX: Gornette, Roversella, Felino.<br />
Tav. XX: Felino, Balianazza, Baliana, Paganine, Porcara, Porcarola.<br />
Tav. XXI: Dossioli, Spino Loria, Bosco Grande.<br />
Tav. XXII: Micampo, Cabianche, Cà Nova, Cà Vanini, Loghino, Ghetto, Virginia d'Arco, Motte.<br />
Tav. XXIII: Covazze, Spino, Mon<strong>di</strong>na, Dragoncello.<br />
Tav. XXIII: Orologia.<br />
Tav. XXIV: Agnese, Casoni, Bassette, Boaria <strong>delle</strong> Lorine, Contrada del Cavo, Traversagno.<br />
Tav. XXIV: continuazione <strong>delle</strong> località precedenti.<br />
25