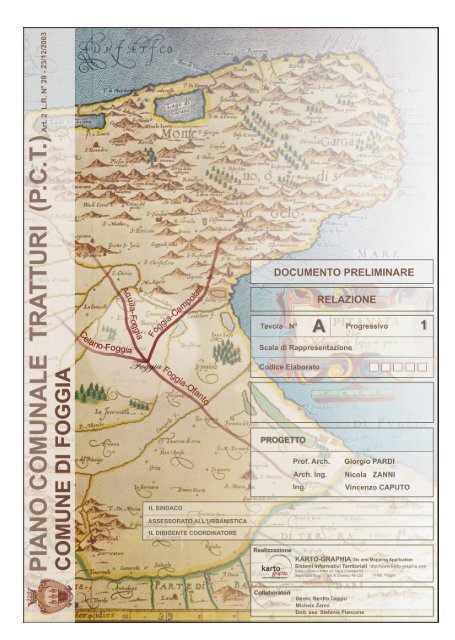RELAZIONE PIANO QUADRO TRATTURI - Urbanisticafoggia.org
RELAZIONE PIANO QUADRO TRATTURI - Urbanisticafoggia.org
RELAZIONE PIANO QUADRO TRATTURI - Urbanisticafoggia.org
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
PREMESSA<br />
IL SISTEMA DEI <strong>TRATTURI</strong><br />
Aspetti storici e archeologici<br />
La transumanza<br />
Il territorio della transumanza nella Capitanata<br />
caratteri dell’insediamento<br />
geomorfologia-geolitologia<br />
idrologia<br />
LA STRUTTURA DEL P.C.T.<br />
P.C.T. obiettivi di fondo<br />
Indagini preliminari<br />
siti di interesse naturalistico<br />
percezione paesaggistica<br />
singolaritÅ - nodo tratturale<br />
Indagine sulle concessioni<br />
Indagini sulle vendite<br />
Il sistema dei vincoli<br />
Il P.C.T. l’iter procedurale<br />
Il progetto<br />
IL PROGETTO<br />
la costruzione del territorio<br />
il sistema dei parchi lineari<br />
interventi in ambito extraurbano<br />
interventi in ambito urbano<br />
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE<br />
INDICE
PREMESSA<br />
L’Amministrazione comunale di Foggia ha provveduto in data 20 giugno 2002 a dare l’incarico<br />
per la redazione del P.Q.T. del solo ambito urbano di Foggia successivamente in data 11<br />
ottobre 2007 l’amministrazione ha allargato l’incarico per tutto il Comune di Foggia.<br />
Si Å provveduto a predisporre il presente Piano Comunale Tratturi (P.C.T.) il quale Å stato<br />
redatto in linea con quanto disposto dall’art. 2 della L.R. n. 29 del 23 dicembre 2003, inoltre la<br />
stessa Å stata effettuata nel rispetto delle “Linee guide per la redazione dei piani comunali dei<br />
tratturi” emanato della Regione Puglia, Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva,<br />
settore Demonio e Patrimonio, Ufficio Parco Tratturi – Foggia.<br />
Il P.C.T. interessa tutte le aree tratturali all’interno del territorio comunale di Foggia in<br />
particolare i tratturi Aquila – Foggia, Celano – Foggia, Foggia Campolato, Foggia – Ofanto<br />
oltre a tutti i tratturelli, individuando e perimetrando dette aree in categoria come previsti dal<br />
comma 2 art. 2 della L.R. n. 29/2003.<br />
Il P.C.T. si propone di regolamentare e disciplinare i processi di trasformazione urbanistica<br />
finalizzati alla modificazione fisica in cui sia promossa la tutela e il mantenimento dell’identitÖ<br />
stessa e culturale delle aree tratturali il tutto per avere un processo di sostenibilitÖ territoriale.<br />
Il Piano Comunale Tratturi (P.C.T.) si configura quale “Piano Urbano Esecutivo P.U.E.” ed in<br />
quanto tale, ai sensi della vigente normativa regionale urbanistica, si identifica quale variante<br />
allo strumento urbanistico generale vigente P.R.G. (comma 3 art. 2 L.R.29/2003), lo stesso<br />
apporta le necessarie modifiche e variazioni al PUTT/P di cui agli articoli 5.06 e 5.07 (comma 4<br />
art. 2 L.R. 29/2003).<br />
Il P.C.T. si propone nell’ambito della pianificazione predisposta dal Comune di Foggia, quale<br />
strumento attuativo.
IL SISTEMA STRUTTURALE DEI <strong>TRATTURI</strong><br />
Aspetti storici e archeologici<br />
Per sfuggire alla neve d’inverno e al caldo torrido d’estate, a settembre e a maggio dall’Abruzzo<br />
alle Puglie e dal mare alla montagna, per millenni la transumanza delle pecore ( in spagnolo<br />
trashumar ) ha prodotto vie naturali di transito: i tratturi.<br />
Larghi come fiumi e verdeggianti d’erba, all’inizio, forse in epoca preistorica, costituivano vie di<br />
passaggio per enormi mandrie di pecore che naturalmente inseguivano condizioni climatiche e<br />
pascoli ottimali; in seguito, divenute proprietÖ, per poter mantenere aperte le vie di percorrenza<br />
presso centri e possessi agricoli, diedero luogo a norme e a tasse di pascolo da pagare. Il<br />
primo grande popolo che gettÜ le fondamenta della civiltÖ appenninica fu quello dei Sanniti.<br />
Pastori – guerrieri, bellicosi ed esperti in guerriglia, sicuramente fin dal V secolo a.C.<br />
disturbavano con le loro cicliche discese le pacifiche cittÖ dell’Apulia, occupandone le fertili<br />
pianure. Odiati e temuti dai Romani, sconfitti alle Forche Caudine nel 321 a.C., i Sanniti,<br />
migranti e tribali, si riunivano periodicamente in luoghi di culto monumentali ( Pietrabbondante,<br />
II sec. A.C. ).<br />
In epoca storica sicuramente i tracciati originari dei tratturi sono opera dei sanniti, essi<br />
rasentano i centri abitati e sono vicinissimi ai piá imponenti luoghi sacri: i templi di<br />
Pietrabbondante, Schiavi d’Abruzzo, Sulmona.<br />
I tratturi che collegavano i monti dell’Irpinia, del Sannio, dell’Abruzzo e del Molise<br />
raggiungevano le terre di Puglia con un percorso ed uno sviluppo totale di circa 3.500 km.<br />
Cicli naturali, stagioni, variazioni climatiche, ricerca di pascolo, riproduzione ne hanno scandito,<br />
da sempre, il ritmo, costituendone peraltro, culture dalla grande significativitÖ; interessanti<br />
reperti ci offrono ancora oggi la possibilitÖ di esaminarne e misurarne la portata.<br />
I Sanniti, i Frentani, i Peligni, i Vestini, le loro capitali, Sepino, Lanciano, Sulmona sono stati<br />
chiari esempi di forme di economia e di cultura molto piá complesse rispetto ad altre di tipo<br />
specificatamente agricolo.<br />
Una ricognizione archeologica e topografica delle alte e medie valli del Biferno, del Trigno e del<br />
Sangro, anche se parziale ed incompleta, ha permesso di individuare una lunga serie di recinti<br />
poligonali considerata una delle testimonianze piá caratteristiche delle forme di insediamento<br />
nell’etÖ precedente all’espansione romana.
Non sembrerÖ azzardato collocare tali costruzioni tra il VI e IV secolo a.C., nà rilevare il loro<br />
carattere non urbano, ma prevalentemente difensivo, in quanto, anche le cinte minori, situate<br />
sempre in posizioni strategiche, appaiono, presumibilmente, come osservatori fortificati.<br />
Nel territorio dei Pentri, soprattutto a nord di Boiano, gravitano sul corso del tratturo<br />
Pescasseroli – Candela le fortificazioni sannitiche del Monte Lungo di Longano ( Isernia ), di<br />
Campochiaro – Tre Torrette, di Sepino – Torrevecchia, di Cercemaggiore, mentre gravitano sul<br />
tratturo Castel di Sangro - Lucera i centri fortificati di Carovilli, Chiauci, Civitanova del Sannio,<br />
Duronia, Castropignano, San Giovanni in Galdo. Su bracci di questo stesso tratturo troviamo le<br />
fortificazioni sannitiche di Frosolone, di Monteverde – Vinchiaturo e di Monte Vairano che<br />
appare come il solo centro denotante un consapevole progetto per la costituzione di una<br />
struttura urbana, mai del tutto realizzata, ma identificata, per i riferimenti topografici contenuti in<br />
Livio ( X, 38 – 46 ) con il sito dell’antica Aquilonia.<br />
Lungo la linea del tratturo Celano – Foggia si possono individuare i centri fortificati di Monte<br />
Miglio – San Pietro Avellana di Monte Cavallerizzo – Capracotta, di Pietrabbondante – Monte<br />
Saraceno, mentre sul tratturo Ateleta - Biferno gravita il centro fortificato di Montefacone del<br />
Sannio.<br />
Nell’alto e medio Sangro, in posizione strategica su bracci tratturali raccordati variamente alle<br />
arterie armetizie Ateleta – Biferno e Centurelle – Montesecco, si possono censire i centri<br />
fortificati di Monte – Pidocchio, Montenerodomo, Monte Maio, Liscia – palazzo, Montelapiano,<br />
Montepallano.<br />
L’interdipendenza e concatenazione di tutti questi centri fortificati e la visibilitÖ reciproca<br />
permettevano, senza dubbio, l’uso di segnali a distanza tra l’uno e l’altro.<br />
Quest’ultima considerazione avvalora l’ipotesi di una funzione fondamentale di controllo da<br />
parte di questi centri che, in caso di guerra, servivano come rifugio per gli abitanti e gli armenti<br />
degli insediamenti sparsi lungo le pianure e le valli circostanti, essendo stato dimostrato ( La<br />
Regina ) che la condizione urbana si affermÜ in questa zona, gradualmente, con la conquista<br />
romana, nel quadro della trasformazione operata dalla municipalizzazione sulla struttura socio<br />
– economica del Pagus e del vicus.<br />
La pratica del pascolo transumatico ritarda, infatti, qualsiasi concentrazione di tipo urbano,<br />
mentre assume particolare funzione in questo sistema socio-economico, la costruzione di
santuari, mantenuti dalle offerte della comunitÖ nei quali le famiglie maggiorenti avevano il loro<br />
punto di incontro con denari e opere costruttive.<br />
In realtÖ i piá antichi luoghi culturali italici furono fiumi, boschi, caverne, o semplici aree, come<br />
attestano i “ Kurtin Keriin “ ( luogo recintato in onore di Cerere ) della Tavola di Agnone, il<br />
recinto chiuso da una siepe ed uno steccato, descritto da Livio ( X, 38 ) e il Lucus Angitiae<br />
ricordato nell’Eneide ( VII, 759 ).<br />
L’area sacra chiamata hurz ( Tavola di Agnone ) o Luvko ( Iucus – Capua ) o tero ( Abella )<br />
sicuramente preesistette alle costruzioni templari italiche,<br />
giacchà gli edifici dedicati al culto sono quasi sempre costruiti su un terrazzo pianeggiante,<br />
scavato lungo il pendio di un monte o di un colle e sostenuto da muraglioni in opera poligonale.<br />
Secondo questa tipologia furono edificati vari complessi culturali, tra cui il santuario sannitico di<br />
Campochiaro ( II sec. a.C. ) a 800 m. s.l.m., alle falde del Matese, nelle immediate vicinanze<br />
del tratturo Pescasseroli – Candela, dedicato ad Ercole ( la localitÖ Å segnata nella tabula<br />
peutingeriana col nome di Herculi(s) Rani ), il cui culto sopravvive nel toponimo dell’edicola<br />
della “ Madama del Coreni “ ( epitato vicino all’Hercules Curinus di Sulmona ). Il santuario fu<br />
distrutto da saccheggi e incendi nei primi decenni del I sec. a.C. in rapporto con la guerra<br />
sociale.<br />
Non presentano tracce di distruzione i due templi rinvenuti a Schiavi d’Abruzzo. Il primo,<br />
databile alla fine del III sec. a.C., impostato su podio, presenta un notevole impegno nella<br />
costruzione, mai del tutto realizzata, il secondo piá piccolo, del I sec. a.C. reca inciso sulla<br />
soglia della cella pavimentata con signino rosso e decorazioni di tessere bianche, il nome del<br />
costruttore in lingua osca, Paapii(s).<br />
Il tempietto subâ vari rifacimenti ed adattamenti, evidenziando nella sopravvivenza anche<br />
misera, di non aver svolto propaganda ideologica antiromana. I moduli architettonici di Schiavi<br />
si ravvisano in altre costruzioni.<br />
Un podio simile a quello del tempio maggiore Å stato individuato a Quadri.<br />
Vi s<strong>org</strong>eva la chiesa medioevale, diruta, di S. Maria dello Spineto.<br />
Sulla base di un testo epigrafico incompleto ( C.I.L. IX, 2813 ) nella localitÖ gli studiosi hanno<br />
ipotizzato il sito dell’antica Trebula.<br />
Un pavimento di signino rosso, simile invece a quello del tempietto minore di Schiavi, Å stato<br />
recuperato nella cella del santuario Sannitico di S. Giovanni in Galdo ( il toponimo Å di origine
longobarda, Walde = bosco, potrebbe ricordare il lucus, l’area sacra ), datato al II sec. a.C.<br />
testimonia una sopravvivenza culturale fino al 3ä secolo dopo Cristo, intervallata dal periodo<br />
buio della guerra sociale, per l’assenza di materiali databili alla fine del I sec. d.C.<br />
Il maggior complesso architettonico sannitico preromana Å rappresentato dal santuario di<br />
Pietrabbondante ( forse Bovianum Vetus ), situato nell’alta valle del Trigno, in prossimitÖ della<br />
grande arteria armentizia Celano – Foggia. Le scoperte archeologiche attestano una attivitÖ<br />
sacrale ed edilizia sin dal IV secolo a.C., interrotta violentemente e radicalmente dalle<br />
distruzioni operate da Annibale.<br />
I resti imponenti del tempio A si riferiscono alla ricostruzione del II sec. a.C., mentre il<br />
complesso scenograficamente superbo al tempio B – teatro puÜ essere ascritto alla fine del II<br />
sec. o agli inizi del I sec. a.C.<br />
L’impegno profuso nella grandiosa opera architettonica non testimonia soltanto l’ultima impresa<br />
edilizia sannitica, cui concorre di anno in anno il medix tuticus e l’intera nazione nell’etnico “<br />
Safinim “ ( che ricomparirÖ nelle monete durante la guerra sociale, ma attesta la concezione<br />
propria dei Sanniti di potenziare la sola edilizia cultuale, trascurando, invece, al contrario di<br />
quanto avviene ad Alfedena, il decoro dei centri abitati e degli edifici a carattere civile e militare.<br />
E’ infatti significativa nel Temenos o zona sacra la presenza del teatro che non aveva soltanto<br />
motivazioni sacrali e rituali, ma poteva costituire l’equivalente del Bouleuterion o<br />
ecclesiasterion, cioÅ parlamento o luogo di adunanza dei capi, data la particolare politica dei<br />
Sanniti, con una assemblea popolare a voto individuale, detta kombennio, ed una assemblea<br />
piá ristretta e piá elevata, detta komparakion.<br />
La forte ideologia antiromana esercitata a Pietrabbondante fu duramente punita alla fine della<br />
guerra sociale, con la soppressione giuridica delle attivitÖ cultuali, la cancellazione parziale<br />
delle attivitÖ produttive, nonchà la confisca<br />
degli immobili trasferiti a privati e con l’attribuzione della zona al municipio di Terventum, dopo<br />
la sua costituzione.<br />
E’ possibile rintracciare un complesso cultuale italico anche in area Carracina, a Juvanum, giÖ<br />
S. Maria del palazzo, in tenimento di Montenerodomo, a 1000 m. s.l.m..<br />
Gli scavi archeologici condotti negli ultimi tempi hanno permesso di emendare d interpretare<br />
quanto citato dalle fonti antiche ( Plinio, Nat. Hist. III, 106; Liber coloniarum, Porreca, Moschetta<br />
ecc. ).
Ma mentre le testimonianze romane su Juvanum, che ebbe la condizione di municipium (<br />
lapide XXIX ed. Madonna ), sono piuttosto cospicue, la fase italica Å nettamente individuabile<br />
sull’arce, con i resti di due templi ed un teatro.<br />
Il complesso culturale sfrutta la naturale scenografia offerta da una collinetta, alla sommitÖ della<br />
quale restano tracce di due templi di tipo italico, con un podio, l’altro meno chiaro, perchà servâ<br />
da basamento al diruto monastero cistercensi di S. Maria di Palazzo.<br />
Alla base della collina Å situato un piccolo teatro in pietra locale, di cui sono conservati il piano<br />
dell’orchestra e otto ordini di gradini. L’intera struttura architettonica, di etÖ repubblicana,<br />
quantunque meno imponente e raffinata di Pietrabbondante, ne ripete l’impianto e si allinea al<br />
gusto costruttivo dei templi coevi di Schiavi, Quadri, S. Giovanni in Galdo.<br />
E’ chiara, nel complesso, la costruzione su una primitiva area sacra, connessa col pascolo<br />
transumatici e con ricchi scambi commerciali da esso attivati.<br />
Sopravvive nel toponimo Vectigale di una frazione di Montenerodomo l’antico istituto del<br />
pagamento della decima al santuario.<br />
Incerta, invece, la divinitÖ venerata nei templi, ma Juvanum potrebbe adombrare l’attributo a<br />
Giove, tipicamente italico e significativamente concomitante con un latro toponimo Juvanum,<br />
derivato da un probabile<br />
Juvanium che il Marino attribuisce alla piana iortonese dove s<strong>org</strong>e la cosiddetta Pietra di<br />
Morrecine , per indicare un complesso culturale dedicato a Giove.<br />
I resti archeologici di Juvanum romana, mostrano una cittÖ vasta ed imponente, collegata<br />
all’arce da una strada lastricata, con un grandioso foro di m. 62 x 27, circondato da portici, uno<br />
dei quali era forse usato come basilica o luogo di riunione al coperto.<br />
Intorno al foro botteghe, l’indicazione di una vasca, forse una fontana pubblica, con residui di<br />
condotti delle acque, dappertutto basi di statue con iscrizioni, materiale ceramico, monete, tubi<br />
in piombo e terracotta, denti di cinghiale frequentissimi, quasi a suffragare il culto a Diana, dea<br />
delle selve, attestato in una lapide ( lap. XXVIII ed. Madonna ) e sopravvissuto nel toponimo<br />
Selvagrossa, in un luogo ora spoglio di piante.<br />
Nessun rinvenimento, invece, dei quartieri residenziali, malgrado la forte concentrazione<br />
demografica che una struttura urbana municipale inevitabilmente richiedeva, data la presenza<br />
di molte magistrature e corporazioni, come quelle menzionate nella XXIX epigrafe ( ed.<br />
Madonna ); quattuoviri giusdicenti, edili, questori, prefetti dei fabbri, prefetti dei cavalieri.
Non vi sono tracce archeologiche neppure delle mura che, senza dubbio, circondavano la cittÖ<br />
romana, restaurate da Fabio Massimo, personaggio identificato col rector della provincia del<br />
Sannio ( lapide XXVII ed. Madonna ) del 352 d.C. e piá volte menzionato in lapidi scoperte a<br />
Histonium e Sepino.<br />
La vita della cittÖ sembra infatti cessare completamente alla fine del IV sec. d.C..<br />
Della grande romana, via Istonia, resta solo una colonna miliaria di forma rotonda, dedicata a<br />
Valentiniano e Valente, proveniente da Montenerodomo.<br />
Si attendono ulteriori scavi, piá ampi e circostanziati per capire la funzione di una cittÖ cosâ<br />
imponente e decentrata, nonchà la pubblicazione e divulgazione<br />
dei reperti affiorati durante la campagna archeologica del 1980, tra i quali un sarcofago in<br />
pietra locale con un coperchio a doppio spiovente e lunga iscrizione dedicatoria ad un giovane<br />
adolescente morto a 16 anni.<br />
La fortunata scoperta di due epigrafi ci permettono di ubicare la seconda cittÖ dei Carracini,<br />
Cluviae. In una iscrizione di Isernia della fine del II sec. d.C. compare un curatore rei publicae<br />
Cluviensium Carracinorum ( Castagnoli, Lavinium, I, 1972, pag. 117 ), mentre una lastra di<br />
bronzo rinvenuta a San Salvo, localitÅ Bufalara, su cui Ç inciso un decreto dell’assemblea<br />
municipale di Cluviae per il conferimento del patronato ad Aurelius Evagrius Honoris nel 384<br />
d.C., menziona, nel contesto di un linguaggio povero e scorretto, i Cluvienses Carracini ( La<br />
Regina ).<br />
Che poi il municipio di Cluviae sia da identificare con la Cluviae in Samnio, ciatata da Livio ( IX,<br />
31 ) per un episodio bellico del 311 a.C. Å cosa ancora da chiarire. Sulla base degli scarsi indizi<br />
noti, gli storici da tempo erano riusciti a delimitare la probabile ubicazione della cittÖ tra<br />
Anxanum e Juvanum. Il tentativo fatto per identificarla con Monte Pallano Ç archeologicamente<br />
inconsistente, perchÉ mancano ancora gli indizi difficilmente cancellabili della presenza di un<br />
municipio ( Sgattoni ).<br />
Le ricognizioni eseguite in vari luoghi per riconoscervi le caratteristiche di un oppidum sannitico<br />
e di un municipium romano, consentono di rilevare una consistente struttura urbana nella<br />
localitÖ detta Piano Laroma, presso Casoli, a cui giÖ si attribuiva il nome di Pagus Urbanus (<br />
C.I.L. IX, 2984 ) e in cui sopravvive una singolare testimonianza nel toponimo Fonte Carracina.<br />
La mappa archeologica del pianoro di Cluviae – Piano Laroma consente di rilevare tracce di<br />
una cinta di mura, su tre lati, nelle quali si dovevano aprire almeno cinque porte alte sui
torrenti Laio ed Avello, affluenti dell’Aventino, mentre sul lato Nord-Ovest Å stata accertata la<br />
presenza di una Necropoli.<br />
Tra i numerosi ruderi affioranti, tracce cospicue di un edificio termale, con pavimento a mosaico<br />
di periodo imperiale, mentre l’edificio piÑ chiaramente leggibile in pianta Ç il teatro, ubicato sul<br />
lato settentrionale dell’area urbana adiacente alle mura e con la cavea esposta a Nord-Est<br />
verso l’esterno ( Sgattoni ).<br />
Ovunque affiorano a Cluviae i resti di epoca romana, ceramiche, bronzetti, fibule, tegoloni,<br />
pezzi di mosaici che, per l’incuria degli enti pubblici e l’aviditÖ dei privati, vanno ad arricchire le<br />
mostre dei collezionisti, ripetendo lo scempio dei furti che, per secoli, hanno saccheggiato<br />
anche Juvanum.<br />
L’intensa romanizzazione dell’area frentana e la costituzione dei municipi penalizzarono e<br />
mortificarono i centri sannitici che avevano tradotto la propria coscienza etnica in fatti politici,<br />
linguistici ed artistici.<br />
E’ appena il caso di ricordare che la base di un donario con iscrizione dedicatoria, risalente al II<br />
sec. d.C., proveniente da Isernia, ci documenta: “ sulla <strong>org</strong>anizzazione degli aitanti originari del<br />
luogo, i Sanniti, privati di capacitÅ politica e ridotti nella condizione di stranieri residenti, incolae<br />
, cui erano riconosciuti limitati diritti civili, nella struttura politica e sociale della colonia latina “ (<br />
La Regina ).<br />
Come prospettiva culturale, il modulo ellenizzante latino si sovrappose all’arte italica che,<br />
benchà condizionata dal materiale esistente sul posto, si era modellata a contatto di culture<br />
esterne, esprimendosi come segno inconfondibile di cultura e civiltÖ.<br />
Cultura romana e cultura italica ebbero, tuttavia, una spinta unitaria attraverso una forza<br />
rilevante: la religione.<br />
La divinitÖ maggiormente rappresentata Å Giove, dio del cielo e della luce ma il suo nome Å<br />
quasi sempre accompagnato da altre determinazioni che richiamano un’altra divinitÖ o nozione<br />
divinizzabile.<br />
Il ricordo di are e culti in onore di Giove Å rimasto nella toponomastica abruzzese: Monte Giove,<br />
Campo di Giove, Fonte di Giove, Juvara ( da Iovis ara, presso Scanno ), Ara Bigiove ( presso<br />
Rocca di Corno ), Colle S. Giovenale.
La manifestazione religiosa piá antica Å perÜ connessa non a Giove ma ai totem della<br />
tradizione dei veria sacra, o migrazioni di giovani destinati ad essere sacrificati, appena nati,<br />
perchà promessi con voto sacro in casi di calamitÖ.<br />
Ricordiamo il picchio dei Piceni, l’Hirpus degli Irpini, l’orso dei Marsi. Il toro dei Sabini Sanniti,<br />
la cui radicale bus sopravvive in Boviano, Boiano, Vitulano, nel popolo dei Vitelli o Vitelli ( da<br />
cui Italia ), nel toponimo grotta del Bove, si trasformÜ nelle leggende popolari di carattere<br />
agiografico concernenti l’orma del bue di S. Raniero, venerato a Bagno.<br />
Le migrazioni dei popoli sabellici ripetono in nuce le grosse migrazioni dei popoli “ di fondo<br />
mediterraneo “ che, a piá riprese, popolarono l’occidente, rappresentando la propria epopea<br />
nel mito di Ercole ( Eracle per i Greci, Hercle per gli Etruschi, Melkart per i Fenici ) con cui<br />
appare strettamente imparentato il mito dell’eroe legato alla cattura dei buoi di Gerione in<br />
Iberia.<br />
Il nostos alla guida della mandria Å costellato di leggende italiche, favorite in Etruria, Campania<br />
o Lazio dagli innegabili influssi esercitati dalla Magna Grecia.<br />
Cosâ il carattere colto, di importazione del mito di Ercole Å ravvisabile non solo nelle<br />
sopravvivenze toponomastiche: Porto Ercole, Ercolano, il villaggio dedicato ad Ercole nella foce<br />
del Sarno, Pompei ( che, secondo Servio, era chiamata dalla pompa o corteo trionfale di<br />
Eracle ), ma anche in varie istituzioni cultuali, come quella famosa dell’Ara Maxima, a Roma,<br />
dove la vicenda del dio Å connessa con le simbologie di Caco ed Evandro (malvagitÖ e bontÖ).<br />
Il mito di Ercole Å poi notevolmente e sorprendentemente diffuso in tutto l’Abruzzo – Molise,<br />
dove sono stati rinvenuti, in numero incredibile, isolati o in stipi votive, ex voto in pietra e<br />
bronzo, raffiguranti il dio e datati lungo un arco di tempo che va dall’arcaismo ai primi secoli<br />
dell’era volgare; senza tralasciare le numerose dediche di templi al dio: Ercole Curino a<br />
Sulmona, ad Alfedena, a Campochiaro, a Montorio al Vomano ed iscrizioni varie, tra cui quella<br />
dei cultori di Ercole a Vico Stramenticio in Val Vibrata e quella di Juvanum attestante la<br />
presenza di un collegio sacerdotale degli Ercolani.<br />
Da tutte queste testimonianze e dalla costante iconografia rappresentante il dio n posizione<br />
d’assalto, con la clava nella destra e la pelle di leone sul braccio , a evidente simbolizzazione<br />
della funzione specifica del pastore attaccato al suo bastone, sterminatore di fiere ed uccisore<br />
di ladroni, ci sembra di poter ipotizzare il carattere essenzialmente locale, indigeno dell’Ercole<br />
abruzzese-molisano che, penetrato nelle nostre regioni attraverso le piste armentizie, vi si
attesta con caratteri originalissimi, bucolici, legati alla transumanza, con funzione rituale,<br />
ritmica, ciclica, prevalentemente non epica. La forza di penetrazione religiosa di questo mito Å<br />
cosâ radicale ed inconfondibile nella nostra cultura da sopravvivere nei secoli.<br />
Ci sembra, infatti, significativo che Ercole sia collegato in Abruzzo a fenomeni naturali, come<br />
avviene in Campania nei miti relativi alla lotta dei giganti nei Campi Flegrei ed alla costruzione<br />
della diga che separa il lago Lucrino dal mare, soltanto nel medioevo, quando viene identificato<br />
con Sansone, un eroe cristiano, per cosâ dire, importato, le cui leggende si possono<br />
rintracciare nel pollice, nella orma o nella pedata di Sansone, ricordati rispettivamente a<br />
Gessopalena, Torricella Peligna, Lama dei Peligni, mentre l’eroe sopravvive con singolare<br />
continuitÖ con i caratteri propri, originali, inconfondibili, espressi nella teologia della<br />
transumanza, nella tradizione medioevale dei paladini, giganteschi pastori che ogni giorno<br />
portavano le greggi al pascolo dalla Maiella alla Puglia, accumulando nei loro percorsi quei<br />
tesori che la gente credeva nascosti a Juvanum, Montorio al Vomano o nelle caverne di<br />
Monte Pallano.<br />
Vale la pena, inoltre, ricordare che la Frentania Å la zona in cui meno numerosi sono stati i<br />
ritrovamenti archeologici inerenti il mito di Ercole, forse perchà la grande via armentizia<br />
Adriatica l’Aquila – Foggia si sviluppÜ piá tardi, quando giÖ la romanizzazione aveva impresso<br />
alla zona un carattere agricolo ben definito, prima delle ville, con colture di olivi e viti, in seguito<br />
con la formazione di grosse strutture urbane, come Anxanum, Histonium, Buca.<br />
L’archeologia potrebbe ancora rivoluzionare sorprendentemente qualsiasi ipotesi, molte sono le<br />
incognite italiche o romane che la terra ancora nasconde.<br />
La vittoria di Silla sui Sanniti ( 82 a.C. ), pur distruggendo l’entitÖ etnica, politica e culturale dei<br />
sanniti, non ne mutÜ l’economia pastorale nà per importanza economica, nà per vocazione. Le<br />
loro terre confiscate ed assegnate ai soldati veterani, mantennero intatti i tracciati dei tratturi.<br />
Peraltro la pastorizia era l’unica fonte di notevole ricchezza per le Puglie, il Molise e l’Abruzzo<br />
e forse, proprio durante l’impero, la pastorizia risentâ di un nuovo e straordinario sviluppo ( Å da<br />
pecuus, pecora, che deriva il termine pecunia, denaro ); infatti Å noto come fosse contemplato<br />
nel diritto imperiale romano uno specifico regolamento riguardo ai tratturi, sia per il percorso<br />
delle greggi che per il loro relativo stanziamento.
I privilegi di passaggio furono denominati tractoria e da essi presero il nome le strade stesse:<br />
tractoria, tracturi, e infine tratturi.<br />
Sentieri pubblici ( calles publicae ) vengono chiamati da Strabone, Varrone, Plinio. Lo stesso<br />
Varrone scriveva: “io ciÜ so bene, perchÉ le mie greggi passavano le Puglie e l’estate sui monti<br />
di Rieti, giacchÉ tra questi due luoghi vi sono pubblici sentieri ( calles publicae ) che<br />
congiungono le distanti pasture, come l’arconcello riunisce le due cesta da soma “<br />
( Varrone, De Re Rustica, libro II, cap. II ).<br />
I ricchi romani e le famiglie aristocratiche di Roma investirono in greggi e questo fu, insieme<br />
all’uso dello scudo ( non a caso denominato sannitico ), e della lancia corta, ereditÖ sicura della<br />
cultura e dell’economia sannitica ed in genere abruzzese.<br />
I Vandali, il dominio bizantino e le scorrerie saracene non modificarono la rete tratturale.<br />
I tratturi rappresentavano i tronchi principali, le direttrici da cui si diramavano i tratturelli con<br />
funzione di smistamento e i bracci che, a loro volta, collegavano i tratturelli. Lungo la rete<br />
tratturale, presso corsi d’acqua e abbeveratoi si aprivano i riposi, grandi zone erbose, dove era<br />
consentito al gregge di riposare per non piá di tre giorni.<br />
Il percorso transumatico non era recintato; successivamente, in periodo medievale, i tratturi<br />
furono delimitati da pietre sulle quali era inciso il sigillo del Regio Tratturo : R.T.<br />
Per questa storia Å importante la data del 1155, data della Costituzione normanna di Guglielmo<br />
il Malo che istituâ precise norme ma anche privilegi di pascolo a favore dei pastori dell’area<br />
abruzzese, molisana e pugliese.<br />
Il Tavoliere divenuto Regio Demanio, si trasforma, nell’istituto fiscale piá vantaggioso per la<br />
corona.<br />
Sono proprio gli Svevi a dare il piá grosso impulso a tutto questo, quando Federico II istituisce<br />
una speciale commissione con un regolare apparato amministrativo, a cui dÖ il nome di Mena<br />
delle pecore in Puglia.<br />
Gli Angioini non sempre furono sensibili alla protezione delle terre dei regi Demani e solamente<br />
Giovanna II, dopo aver ricostruito il Regio Demanio, da cui molte terre erano state svincolate<br />
dai suoi predecessori, ricostituâ la Costituzione normanna e nominÜ un magistrato speciale.
Successivamente gli Aragonesi e, in particolare, Alfonso I d’Aragona, detto il Magnanimo, ne<br />
ri<strong>org</strong>anizzarono e ampliarono la relativa legislazione rurale e l’Amministrazione chiamata<br />
Dogana della Mena delle Pecore in Puglia.<br />
Siamo nel 1447 e Foggia, sede della Dogana, nodo terminale dei piá importanti tratturi,<br />
controlla, smista, censisce milioni di pecore (esse raggiungeranno quasi 6.000.000 nel 1604 ).<br />
Tutto questo assume tale importanza per il Meridione, da segnare per sempre una specifica<br />
vocazione, quella pastorale e transumatica e, una volta cessata questa, l’assoluta impossibilitÖ<br />
alla riconversione.<br />
Infatti se consideriamo che questa azienda costituiva la maggior fonte di introito del regno di<br />
Napoli, 400 mila ducati veneziani all’anno solo di fisco, ci rendiamo conto come gli interessi<br />
economici ad essa legati erano tali da incidere sull’ambiente naturale, continuamente<br />
attraversato da milioni di persone e di animali che impedirono sia il nascere di piccoli<br />
agglomerati abitativi ma soprattutto un giusto sviluppo dell’agricoltura, considerata unicamente<br />
per garantire riserve di grano per la capitale, Napoli, e la misera sussistenza per le<br />
popolazioni; per questi motivi Alfonso I, non si sa bene fino a che punto sensibile alle lamentele<br />
dei pastori, proibâ severamente il dissodamento e la coltura delle terre salde impedendo persino<br />
rarissimi tentativi di rotazione dei terreni detti di portata ( di coltura ), sottoponendoli, sempre<br />
piá spesso, alla servitá della statonica ( diritto di pascolo estivo ).<br />
La Dogana Aragonese, al contrario della Mena di Federico II, era divenuta struttura fiscale con<br />
magistratura autonoma. Altre terre furono aggregate: la zona dell’Abruzzo chietino e buona<br />
parte del teramano, dalla Pescara al Tronto, area detta rispettivamente dei Regi Stucchi e delle<br />
Poste d’Atri.<br />
I tratturi furono ampliati e il Tavoliere sottoposto a Demanio raggiunse un’estensione di circa<br />
400 mila ettari, d’estate con un clima torrido e malarico e in inverno saccheggiato e<br />
sovraffollato da uomini e animali.<br />
Di qui la necessitÖ di ricorrere ai “ ristori “, zone di pascolo, terre di privati, praticamente<br />
requisite. Obblighi di soggiorno, di soste, di passaggi, di canoni per l’erbaggio, erratico o fido ( il<br />
vectigal romano ) (1) , produssero un’eccessiva protezione per la pastorizia ma forti danni<br />
all’agricoltura impedita sia nell’ espansione che nelle necessarie motivazioni all’innovazione<br />
agronomica e agraria in senso lato.
Questo apre e lascia inalterata nei secoli una aperta conflittualitÖ fra i proprietari frontisti che<br />
tentano di sconfinare sui territori demaniali, usurpandoli, e lo Stato che, toccato profondamente,<br />
reagisce con continue reintegre.<br />
La reintegra consisteva in una misurazione e conseguente redazione di piante delle aree<br />
tratturali.<br />
Gli agrimensori o compassatori alle dipendenze della Dogana consentivano il recupero dei suoli<br />
tratturali o adibiti al riposo, illegalmente coltivati, o usati per costruzioni.<br />
Tale forma di economia pastorale, cosâ usata e sfruttata dalle strutture del potere centrale,<br />
dopo tanti secoli, inizia uno strano fenomeno, come di distacco dal territorio; costretta dal suo<br />
utilizzo indiscriminato e forzatamente incrementato, la transumanza produce una ricchezza che<br />
si accumula all’esterno delle sue specifiche funzioni, che non produce affatto miglioramenti alle<br />
condizioni sociali delle popolazioni e dei lavoratori del settore e che inoltre all’agricoltura danni<br />
enormi e alla lunga, esiziali per il destino meridionale del dopo unificazione.<br />
La monocoltura, la mancanza di strutture primarie e, di conseguenza, l’insufficienza di funzioni<br />
secondarie e terziarie, all’infuori delle vie della lana sempre piá usurpate dai baroni,<br />
saccheggiate dai briganti, maldestramente difese dagli Aragonesi con l’allestimento di squadre<br />
di cavallari (essi avrebbero dovuto assicurare una scorta alle greggi che dovevano raggiungere<br />
le montagne abruzzesi ma in effetti si mostreranno come i piá feroci autori dei furti di<br />
bestiame ); tutto questo non Å che in minima parte la sintesi di un inizio di decadenza culturale<br />
ed economica che si specificherÖ per tutto il corso dei secoli XVI, XVII e XVIII.<br />
Le speculazioni e gli investimenti su pecore o, approfittando di condizioni temporaneamente<br />
favorevoli, ritorno al potenziamento del latifundum, le terre non coltivate per secoli, perchà<br />
d’inverno luogo di pascolo per greggi, la scarsitÖ di manodopera specializzata, la mancanza di<br />
attenzione ai problemi della sostenibilitÖ ambientale, l’assenza di sistemi di drenaggio e di<br />
manutenzione, conducono ad un lento ma definitivo degrado geomorfologico ed idrografico del<br />
territorio.<br />
----------------------------------<br />
( 1 ) cfr. Natalino Paone, La transumanza, immagini di una civiltÅ, Cosmo ed., Isernia, 1987;<br />
pag. 23 e segg.<br />
Due reazioni a tutto questo si ebbero giÖ lungo il corso del 1600, modesti provvedimenti furono<br />
presi assegnando parti delle terre salde per essere avviate a coltura e costituire colonie e in
seguito piccole b<strong>org</strong>ate, insicure e dal clima, peraltro comune a gran parte del territorio ,<br />
fortemente malarico.<br />
Nel corso del ‘700 e dell’800 ( 2 ) frequenti sono i conflitti sorti per impadronirsi delle poste,<br />
luoghi messi a locazione per il ricovero e il soggiorno delle pecore durante i mesi freddi, ma<br />
anche delle terre assegnate a coltura da parte di grandi proprietari.<br />
Insigni studiosi ed economisti come il Filangieri, il Galanti, Melchiorre Delfico avvertono la<br />
gravitÖ della situazione e contestano la scelta economica di quel modello pastorale.<br />
I Borboni concessero la riduzione dei confini dei tratturi e l’ampliamento delle zone destinate<br />
alla semina e alle colture, pur predisponendo dei limiti, non potendosi superare un quinto,<br />
aumentarono l’ammontare dei canoni per proprietari e pastori, e, se da circa un secolo le<br />
assegnazioni dei pascoli avvenivano per professione volontaria, in base alla dichiarazione<br />
personale di ogni locatario circa la grandezza, in numero di capi, del proprio gregge, dal 1788<br />
in poi il regime doganale cominciÜ a cedere, Ferdinando IV consentâ la nascita, in cinque siti<br />
reali del Tavoliere, di colonie agricole; venne accolta la proposta del Filangieri di affittare i<br />
pascoli per un numero di anni relativamente lungo; 6 anni, per consentire l’avvio di migliorie,”<br />
ma l’infiltrazione degli insediamenti permanenti e l’estensione delle terre a coltura incalzavano<br />
erodendo l’area pastorale doganale che, a fine secolo, risultava fortemente ridotta<br />
territorialmente e col sistema fiscale molto indebolito sul piano dottrinario e giuridico-formale. Il<br />
declino della transumanza dapprima lento e contrastato era ormai vicino al punto di non<br />
ritorno “ ( 3 ). Solo il 21 maggio 1806, Giuseppe Bonaparte “ sciolse tutti i vincoli e le servitÑ del<br />
Tavoliere, e concesse ad enfiteusi perpetua, con diritto di affrancamento, le sole terre salde<br />
a coltura” ( 4 ). Invano i Borboni, ritornati al potere, pur con molti tentennamenti e paure,<br />
cercarono di annullare gli effetti giuridici ed economici delle avvenute enfiteusi ( legge 13<br />
gennaio 1817 ).<br />
--------------------------------------------<br />
( 2 ) Ettore D’Orazio La pastorizia Abruzzese, studio bibliografico Adelmo Polla, Avezzano;<br />
T. Runbolt, I tratturi e le trazzere, in Rivista del Catasto e dei servizi tecnici, 1959, n. 3.<br />
( 3 ) Natalino Paone, op. cit., pag. 24<br />
inoltre vedi A. Jamalio, Tratturi e trazzere, in “ annali d’Italia “, Roma 1937, pag. 420<br />
( 4 ) Ettore D’Orazio, op. cit., pag. 8
Corografia della Daunia in etÖ imperiale – rif. La Daunia Antica, dalla preistoria all’alto<br />
medioevo ( M. Mazzei )
Carta dei tratturi. I segmenti in verde indicano le coincidenze tra vie romane e tratturi.
LA TRANSUMANZA<br />
Il contesto<br />
Come abbiamo visto per i pastori la montagna e la pianura erano considerate complementari.<br />
Sfruttando questo tipo di cultura, re Alfonso, al fine di aumentare le entrate fiscali, la pratica<br />
della transumanza, che fino ad allora era facoltativa, la rese obbligatoria.<br />
I pascoli del Tavoliere consistettero principalmente nelle locazioni distinte in ventitre ordinarie<br />
( originarie ) e venti aggiunte.<br />
Le ventitre locazioni originarie erano:<br />
Andria, Apricena - Castel Pagano – Sant’Antonio, Arignano, Camarda, Candelaro, Canosa,<br />
Casalnuovo, Castiglione, Cave, Cornito, Feudo, Guardiola, Lesina, Ordona, Orta, Ponte<br />
Albanito, Salpi, San Giuliano, Sant’Andrea, Tressanti, TrinitÖ, Valle Vaccarella.<br />
Le venti locazioni aggiunte furono:<br />
San Giovanni e Rodi Garganico, San Giacomo e Monte San Nicandro, Lama Ciprana, San<br />
Chirico, Fontanelle, Versentino, Farano, San Lorenzo, Fabrica, Correa ( grande e piccola ),<br />
Siponto, Stornara, Stornarella, Camarelle, Quarto delle Torri, San Giovanni in Fonte, San<br />
Giovanni di Cerignola, Canne. Gaudiano, Parasacco.<br />
E’ stato appurato che i locati provenissero da trecentocinquanta paesi ed appartenessero a<br />
duemilatrecentoquindici famiglie.<br />
Una descrizione dettagliata di come si presentava il Tavoliere tra il 1577 e il 1579, epoca<br />
della istituzione della Dogana della mena delle pecore, Å riportata in una lettera scritta da<br />
Camillo Porzio indirizzata a don Innico Lopez de Mendoza, Marchese di Mondesciar e vicerÅ di<br />
Napoli ( 5 ):<br />
“ Di Capitanata, ovvero di Puglia piana.<br />
Distendesi la provincia di Capitanata, detta dÅ Latini Apulia Daunia, dal fiume Ofanto al fiume<br />
Trigno; tiene il primo dall’oriente et il secondo dall’occidente. E’ provincia assai giovevole alle<br />
altre del Regno, ma in quanto a sÉ Ç la piÑ inutile che vi sia; perchÉ Ç malissimo abitata, di non<br />
buona aria, priva di alberi e di legna, poverissima di acque. La state viene infettata da<br />
grandissimi caldi et innumerevoli mosche e gran copia di serpi: Gli uomini sono inetti all’arme<br />
et alle fatiche, i cavalli deboli di forze. Dall’altro canto, produce questa provincia grano, orzo, et<br />
altre biade in tanta quantitÅ che veramente si puÜ chiamare il granaio non solo di Napoli e del
Regno, ma di molte cittÅ d’Italia. Vi si fa sale e salnitro; vi si transuma nel verno, e nutrisce la<br />
maggior parte del bestiame del Regno, che da’ luoghi montuosi e freddi discende al piano, et<br />
all’aria temperata di lei , et in tanto numero che alle volte passa i milioni. Discendono anche la<br />
state in essa infinito numero di persone a mietere il grano; e la natura contra il male delle serpi<br />
l’ha anche dotata del rimedio producendo in quelle parti assai cicogne che le divorano, le quali<br />
fanno il medesimo servigio in Terra di Bari. Nascono ancora nel monte di S. Angelo erbe<br />
salutifere, che con gran diligenza si cercano dÅ regnicoli e dÅ forestieri per comporre le<br />
medicine.<br />
E’ di poi questa provincia principal membro di entrate regie rispetto della Dogana del bestiame<br />
e delle tratte del grano che in essa si esigono, per causa della quale abbondanza ed entrata<br />
puÜ essere desiderata da tutti i principi vicini e lontani.<br />
Dalla parte di terra ha poche difese, e del mare potrebbe essere grandemente offesa, se le<br />
fusse occupato monte S. Angelo che le sta di sopra, si come l’occuparono i Saraceni quando<br />
dominavano la Sicilia, e tennerlo molti anni. NÉ bastavano i regnicoli a cavarneli, se non<br />
fussero stati aiutati per mare dagli Schiavoni, che allora, et anche di presente, frequentano<br />
molto queste regioni e fannovi abitazione. ImperÜ che il monte gira piÑ di centocinquanta<br />
miglia, et ha aspre salite; e sopra di esso vi sono acque, piani e boschi et assai terre e castella.<br />
Et ha il lago di Varano di un cupo fondo e di circuito di trenta miglia, posto al lato del mare, che<br />
con poca fatica potrebbe servire per un grande e sicuro porto. Per lo quale sospetto e per<br />
avere Principi potenti intorno, come sono il Turco et i Veneziani, il Re in tempi sospetti<br />
custodisce due terre del detto monte, S. Angelo e Viesti. Corrono per la provincia, oltra il fiume<br />
Ofanto e Trigno, Fortore e Candelaro.<br />
Vi Ç il detto lago di Varano e quello di Lesina, che producono grossissime anguille, chiamati<br />
capitoni; vi Ç il lago (……) e il lago di Salpe con altri laghetti.<br />
Ha di riscontro l’isola di Santa Maria di Tremiti, giÅ detta Diomedea, et Ç posseduta dÅ Canonici<br />
regolari, che vi hanno un monastero in fortezza.<br />
E’ numerata questa provincia dalla Regia Corte fuochi 19469.<br />
Vi possiede il Re terre di demanio Manfredonia, Sansevero, Lucera, Foggia, Viesti.<br />
Vi tiene due fortezze, Manfredonia e Viesti, e ponevi anche il presidio in tempo di sospezione<br />
di armate nimiche.<br />
Vi sono soldati del battaglione 982.
Ha un arcivescovato : Siponto.<br />
I vescovati sono : Viesti, Larino, Lucera, Ascoli, Bovino, Lesina, Troja, Volturara, Termoli,<br />
Salpe. I benefici de jure patronato regio sono: a Lucera il decanato, l’arcidiaconato, tesorerato,<br />
cantorato, e l’alternativa dÉ canonicati.<br />
I baroni titolati di detta provincia sono: il Principe di Ascoli, il Principe di Cirignola, il Duca di<br />
Termoli, il Duca di Torre Maggiore, il Marchese di Vico, il Conte di Macchia, il Marchese di<br />
Deliceto.<br />
Fannovi due fiere l’anno, nella cittÅ di Lucera, et un’ altra nella terra di Foggia.<br />
Vi tiene anche il Re la razza de’ cavalli.<br />
Il governatore di questa provincia risiede nella terra di Sansevero, et ha due auditori.<br />
Vi Ç anco il doganiere di Puglia che esige nella terra di Foggia la dogana del bestiame, e tiene<br />
uno auditore che fa ragione a’ pastori.<br />
Nel soprascritto monte di S. Angelo Ç una devotissima spelonca, dove apparve l’Arcangelo<br />
Michele, e pienamente si frequenta da’ popoli vicini.<br />
E’ anco in questa provincia un tempio celebre per tutto il Regno dedicato a S. Leonardo,<br />
liberatore de’ prigioni e degli uomini posti in servitÑ. “<br />
La dogana<br />
L’ordinamento della Dogana, inizialmente fece aumentare il gettito fiscale nelle casse dell’erario<br />
dello Stato, in seguito perÜ, per disposizione del vicerÅ Toledo, il sistema di conteggio effettivo<br />
del bestiame che veniva condotto al pascolo nelle locazioni venne sostituito con quello della<br />
professazione, ovvero professione volontaria, detto anche in alia , che rappresenta anche<br />
l’inizio per la rovina del ceto dei locati. Inizialmente il locato piá professava tanto piá pascolo<br />
riceveva, in caso di insufficienza l’amministrazione della Dogana acquistava erbe dai privati,<br />
baroni e monasteri. Dalla miscela aviditÖ del governo – astuzia dei doganieri nacque un<br />
sistema di sfruttamento che spogliava anche del pensum diei i poveri pastori abruzzesi.<br />
Con la professione in alia ogni pastore, ascritto ad una locazione, aveva diritto all’erbaggio non<br />
in proporzione al numero dei capi ma a quanto professato ( dichiarato ), ovviamente chi piá<br />
professava piá pagava.<br />
----------------------------------<br />
( 5 ) cfr. Mario A. Fiore , Demani e usi civici nel regno di Napoli, 2007, ed. Comune di<br />
torremaggiore;
Di contro, se il fisco aumentava gli introiti, a paritÖ di estensione di terreno, si veniva a sottrarre<br />
terreni a pascolo a chi professava di meno costringendo i pastori a trattare erbaggi con i locati<br />
delle poste contigue e a pagare di nuovo l’erba giÖ acquistata dal fisco.<br />
Ne derivÜ che l’unica forma di difesa era quella di professare piá degli altri con il risultato di<br />
aumentare la conflittualitÖ specie nei periodi in cui vi era scarsitÖ di erba.<br />
Alfonso determinÜ che i pascoli non fossero piá oggetto di stipulazioni private, bensâ solo lo<br />
stato potesse disporne, per tali motivi prese in locazione perpetua i fondi dei privati e dei baroni<br />
( che potevano disporne solo in periodo estivo ) e divise tutto il territorio in locazioni, lasciando<br />
solo una parte del territorio adibito a masserie di campo e portate, coltivate a cereali dai<br />
proprietari originari dei luoghi. E’ facile capire come sia i baroni che i massari di campo<br />
sconfinassero abusivamente nella zona delle locazioni per aumentare a scapito dei locati<br />
l’estensione dei loro terreni. Fin dall’inizio dell’istituzione della Dogana, ancor piá durante il<br />
periodo del viceregno, la Capitanata fu teatro di abusi e violenze perpetrate dai baroni ai danni<br />
sia delle popolazioni che dei pastori, questi a mala pena protetti dai privilegi del foro doganale.<br />
Alle pressanti richieste dei locati abruzzesi che lamentavano la sottrazione di terre da parte dei<br />
baroni, re Ferrante, nei capitoli promulgati il 17 dicembre 1480, dispose una prima verifica<br />
della estensione del Tavoliere; la reintegra venne effettuata il 1483, riportando i pascoli ai<br />
provvedimenti fondativi di re Alfonso, ai tempi del primo doganiere Montluber. In poco piá di<br />
venti anni i terreni vennero di nuovo occupati ed i locati, nel 1507, si videro costretti a ricorrere<br />
a Ferdinando il Cattolico, per promuovere una nuova reintegra. L’esecuzione venne affidata al<br />
presidente della Camera della Sommaria, Antonello di Stefano, che per una serie di motivi non<br />
la portÜ mai a termine. Qualche decennio dopo, per volontÖ del vicerÅ di Toledo, si pose mano<br />
ad una nuova reintegra, affidata al luogotenente della Camera della Sommaria Francesco<br />
Revertera, al quale venne affiancato il presidente Alfonso Guerrero.<br />
La reintegra fu disposta con provvedimento del vicerÅ del 3 ottobre 1548.<br />
A fine operazioni si riscontrÜ che tutto il Tavoliere era formato di 15495 carra ( * ), di cui 9139<br />
pascolative e 6356 a coltura. La maggior parte degli studiosi di economia e finanza del Regno,<br />
consideravano il sistema Tavoliere un cancro; si andava affermando sempre piá l’idea che la<br />
sola percezione degli affitti era riduttivo rispetto alle potenzialitÖ dei terreni.<br />
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
( * ) carro – estensione agraria pari a venti versure ( Ha 24.69.00 )
Dopo qualche mese dalla conquista del Regno, Giuseppe Bonaparte, l’8 maggio 1806, entrava<br />
in Foggia e poteva rendersi conto di persona dello stato della Dogana e del Tavoliere. dopo<br />
meno di due settimane, il 21 maggio, venne emanata la legge per la censuazione del<br />
Tavoliere di Puglia, fondamentale per ogni altra normativa successiva sull’oggetto. Il testo si<br />
compone di 44 articoli, racchiusi in cinque capitoli: 1. Dell’enfiteusi delle masserie delle terre<br />
salde di Corte a coltura; 2. Della enfiteusi delle locazioni; 3. Della redenzione delle servitá sulle<br />
terre di portata; 4. Dell’enfiteusi delle terre azionali spettanti ai luoghi pii; 5. Disposizioni<br />
generali.<br />
L’intenzione del legislatore era di far decollare sia l’agricoltura che la pastorizia e di realizzare<br />
delle entrate cospicue in favore dell’erario. Venne abolito il Tribunale della Dogana ed istituita la<br />
Suprema Giunta per la censuazione.<br />
La legge del 12 dicembre 1816, sull’amministrazione civile, all’art. 189, disponeva che “ l’uso<br />
l’uso civico si esercita dai cittadini per gli animali addetti alla loro particolare industria. Ne sono<br />
quindi esclusi i negozianti di bestiame ed i censuari di Puglia giÖ detti locati. Essi possono<br />
parteciparvi nei Comuni a cui appartengono per quella sola parte di animali che serve alla loro<br />
particolare industria nella latitudine che compete ad ogni altro ricco cittadino.”<br />
Fra alterne vicende la Dogana sopravviveva fino a quando le tre leggi del Parlamento Italiano<br />
del 26 febbraio 1865, del 7 luglio 1868 e del 7 marzo 1871 non la toccarono pesantemente. “ I<br />
molteplici intricatissimi vincoli furono disciolti; il dominio diretto del Tavoliere fu convertito in un<br />
credito ipotecariamente privilegiato verso i censuarii, composto da un capitale equivalente a<br />
ventidue volte il canone che precedentemente si contribuiva, e pagabile in 15 rate annue con<br />
l’interesse del 5% decorrente dal 1 gennaio 1872; ogni altro diritto di pascolo estivo ed<br />
autunnale di promiscuitÅ o di uso civico, venne recisamente abolito “ ( 6 ); in tal modo gli<br />
affittuari divennero proprietari a tutti gli effetti di legge sia per l’utilizzazione che la destinazione<br />
delle terre.<br />
Nel 1865 le operazioni che erano di pertinenza della Dogana furono affidate alla Direzione<br />
Generale delle Tasse e del Demanio di Foggia ( poi Intendenza di Finanza, con Legge 26<br />
settembre 1869 n. 5286 ). Questa trasformazione segnÜ, in modo evidente, cambiamenti anche<br />
a carico dell’economia e dell’agricoltura in particolare ( 7 ).<br />
D’altronde le molte e ripetute reintegre non fecero altro che mettere in luce sia i dissesti dei<br />
tratturi che l’abbandono delle colture con la necessitÖ di grandi dissodamenti di terre.
I tratturi vengono sempre piá disertati; i pastori cominciarono, per questi motivi, a preferire, per<br />
la transumanza, i percorsi di induzione verso le campagne laziali e questo anche a causa dei<br />
continui furti, delitti, violenze e pericoli che i boschi di Setacciato e del Saccione, vasti e non<br />
protetti, frequentemente favorivano.<br />
Per questo studio e per meglio individuare i termini specifici dell’economia transumatica anche<br />
nel loro variare nel tempo e, per questo discorso, il loro deperire, si esamini il quadro, di seguito<br />
riportato, che riproduce il numero dei capi che attraversano il Tavoliere ( 8 )<br />
anni Numero dei capi transumanti<br />
1440 2.500.000<br />
1461 900.000<br />
1474 1.700.000<br />
1494 1.700.000<br />
1540 1.500.000<br />
1556 1.517.000<br />
1574 3.000.000<br />
1592 3.747.000<br />
1602 4.700.000<br />
1604 5.500.000<br />
1610 2.000.000<br />
1612 580.000<br />
1649 1.200.000<br />
1733 850.000<br />
1793 750.000<br />
1808 700.000<br />
1815 950.000<br />
1840 1.200.000<br />
1860 760.000<br />
1877 730.000<br />
1951 400.000<br />
1958 205.000<br />
------------------------------------------------------<br />
( 6 ) Ettore D’Orazio, op. cit., pag. 9<br />
( 7 ) per questo specifico periodo cfr., AA.VV., La misura e l’immagine del tavoliere e dei suoi<br />
tratturi – appendice al catalogo Cinque secoli, un archivio, A.S.F., Foggia 1984, pag. 159.<br />
( 8 ) M. De Martini, i tratturi demaniali e la loro liquidazione, in rivista del Catasto e dei Servizi<br />
Tecnici Erariali, n. 3, 1959, pag. 169 e segg.
I molti anni i proprietari dichiaravano un maggior numero di pecore per poter avere piá vasti<br />
pascoli in assegnazione. Alcune brusche riduzioni ( 1610 ) sono state provocate da epidemie,<br />
in questo caso dal vaiolo e quella del 1612 da un inverno rigidissimo che consentâ a pochi<br />
animali di sopravvivere.<br />
Pertanto, giÖ nella seconda metÖ dell’ ‘800, il numero sempre minore di pecore transumanti, i<br />
vasti movimenti migratori che interessano le aree limitrofe i tratturi e la conseguente<br />
espansione urbana, rappresentano tutti fenomeni tesi a restringere i limiti tratturali che<br />
diventano molto vicini a quelli di una comune strada.<br />
Oltre alla legge n.793 del 21 agosto 1862 altre ( 1865 ) consentirono ad alcuni Comuni in<br />
Provincia di Campobasso e Benevento di attiva reintegre a loro spese ed, in cambio, per<br />
compenso, di ricevere la metÖ dei tratturi la cui larghezza si ridusse a m. 5.55 ( 9 ).<br />
GiÖ agli inizi del ‘900 i tratturi, equiparati alle strade statali ( 10 ) terminano di assolvere<br />
pienamente alle loro funzioni.<br />
Sostituite dalle rotabili e dalle strade ferrate, le poste, dissodate, vengono destinate<br />
all’agricoltura e nell’area del demanio, grazie al processo di affrancamento , s<strong>org</strong>ono molti<br />
poderi privati. I nuovi proprietari riservano al pascolo piccolissime zone, spesso approfittando<br />
dell’anno di riposo o del periodo delle stoppie.<br />
Per questo, dopo che la transumanza, per secoli, ha rappresentato l’area abruzzese, molisana<br />
e pugliese, una grandissima risorsa economica, anche se con le dovute riserve<br />
precedentemente messe in evidenza, e sicuramente<br />
un tracciato dalle enormi valenze culturali, viene da questo momento in poi messa in crisi e si<br />
dubita circa l’utilitÖ stessa dei tratturi.<br />
La legge del 1908 che istituiva il Commissariato per la reintegra dei Tratturi, aliena quasi<br />
interamente l’intera rete ad eccezione dei quattro ritenuti fra i piá importanti ( L’Aquila – Foggia,<br />
Pescasseroli – Candela, Lucera – Castel di Sangro ). Uno fra i provvedimenti emessi dal<br />
Commissariato fu la vendita di alcuni tratti del suolo tratturale; in uno era compreso un intero<br />
centro urbano: quello di Raiano sul Celano-Foggia. Ma problemi procedurali e soprattutto la<br />
prima guerra mondiale bloccano la possibilitÖ di molte attuazioni.<br />
Il fascismo, negli anni che seguono, non sottovaluta e nà trascura tale problematica, anzi,<br />
approfittando della drastica riduzione del numero degli animali transumanti, della necessitÖ di<br />
bonificare ampie zone o di recuperare spazi urbani a costo zero per costruire edifici pubblici, e
della obiettiva difficoltÖ a reintegrare l’intero tracciato tratturale ormai definitivamente<br />
spezzettato da appropriazioni abusive e da colture attivate dai frontisti, dona antiche sedi<br />
tratturali e vaste aree adibite al pascolo agli invalidi di guerra e a quelli della rivoluzione<br />
fascista, o permette di costruire case per l’edilizia economica e popolare.<br />
---------------------------------------------------------------------<br />
( 9 ) M. De Martini, op. cit. Lo stesso autore fa presente che vendite sporadiche erano giÖ<br />
avvenute come quella del 1656 per il Comune di Castelfrentano e in seguito per altri venti<br />
Comuni che sorsero in parte sui tratturi.<br />
( 10 ) legge 20-03-1863, n. 2248, all. F.<br />
Tali iniziative dimostrano come anche durante il ventennio fascista permangono a carico del<br />
Sud, quelle scelte di tipo economico, estremamente nocive e comunque, sicuramente<br />
discutibili: non incentivazione delle colture<br />
intensive, una bonifica non supportata da infrastrutture secondarie, protezione politica ai grandi<br />
latifondisti, attenzione economica sensibile solo nei confronti di aziende agricole a produzione<br />
di tipo estensivo: grano.<br />
Nella tabella che segue, sono indicate le superfici vendute dai diversi Uffici dal 1656 al 1936, la<br />
superficie delle vendite eseguite dal Commissariato dal 1937 al 1958, l’area tratturale occupata<br />
dalle strade ordinarie, dalle ferrovie e dalle acque pubbliche, quella occupata in maniera<br />
abusiva e, infine, quella disponibile ( 11 )<br />
Province Totale Ha Antiche<br />
vendite<br />
Vendite del<br />
Commissariato<br />
1937-58<br />
Strade<br />
acque<br />
ferrovia<br />
Occupazioni<br />
abusive<br />
disponibile<br />
L’Aquila 1.994 57 68 166 644 1.059<br />
Pescara 640 15 26 40 60 499<br />
Chieti 2.540 180 254 212 575 1.319<br />
Campobasso 4.551 400 252 401 618 2.880<br />
Benevento 511 218 - 50 40 203<br />
Avellino 454 198 - 33 72 151
Foggia 5.826 - 874 905 970 3.077<br />
Bari 2.241 290 891 376 269 415<br />
Brindisi 46 - - 17 25 4<br />
Lecce 21 - - - - 21<br />
Taranto 796 81 12 250 274 179<br />
Potenza 1.011 - 1 208 165 637<br />
Matera 449 45 3 120 120 171<br />
totale 21.080 1.484 2.381 2.786 3.832 10.615<br />
La superficie disponibile in parte Å messa a coltura , la rimanente Å allo stato saldo a<br />
disposizione della transumanza, ma la lottizzazione della proprietÖ demaniale, con la<br />
conseguente vendita dei terreni, ha assunto, nel tempo, vaste proporzioni tanto da cancellare<br />
interi tratti della rete fratturale.<br />
I Comuni indicono aste pubbliche, in primavera, per procedere all’affitto dei pascoli estivi del<br />
demanio di loro proprietÖ.<br />
Sono interessanti le prime concessioni del 1935 per uso agricolo riguardanti i tratturi Barletta –<br />
Grumo e Canosa - Manfredonia in favore degli ex combattenti e quelle del 1941 estese ai<br />
frontisti in base all’illusoria politica della “ battaglia del grano “ condotta dal fascismo<br />
( N. Paone, op. cit. ).<br />
Esse si svolgono nelle sedi comunali con il sistema della candela vergine: il segretario<br />
comunale, presente il sindaco o il suo delegato, all’ora fissata e nota pubblicamente, accende<br />
una candela mai usata alla presenza dei pastori che hanno chiesto di partecipare all’asta, i<br />
quali, partendo dal prezzo a base d’asta fissata dal bando, la migliorano in libera concorrenza<br />
tra loro per il tempo di durata della candela accesa: l’ultima offerta al rialzo si aggiudicherÖ<br />
l’asta ( 12 ).<br />
Dalla fine della seconda guerra mondiale agli anni ’60, anni della ripresa economica, la<br />
transumanza ha definitivamente smesso di essere un fenomeno di massa; il numero giÖ esiguo<br />
di 500 mila capi migranti contati all’inizio del secolo ( 13 ) scende a 200 mila nel 1958 e in tutte<br />
le regioni interessate a questo fenomeno prevalgono, anche se evidentemente in ritardo e con
forti incongruenze, spinte verso attivitÖ agricole ed industriali, scolarizzazioni di massa, diverse<br />
aspirazioni e nuove aspettative allontanano per sempre i viaggi faticosi e i pericoli delle antiche<br />
vie, in molti tratti inesistenti a causa dello smantellamento, in altri frequentati da piccoli gruppi di<br />
proprietari che, consorziati nelle Associazioni degli Allevatori hanno del tutto trasformato a livelli<br />
industriali tale attivitÖ; i dati del passaggio delle greggi a piedi chiariscono meglio il quadro:<br />
-------------------------------------<br />
anni capi<br />
-------------------------------------<br />
1950 120.000<br />
1951 71.000<br />
1958 28.000<br />
1960 45.000<br />
1968 36.000<br />
Sprengel ricorda, inoltre, come in questi anni ( ’50 – ’70 ), gli spostamenti a piedi riguardano<br />
distanze brevi per le quali occorrono uno al massimo due giorni ( 14 )<br />
( 11 ) Le leggi piá importanti a tal proposito sono quelle del 30 dicembre 1923 n. 3244, con la<br />
quale il Commissariato con tutto il personale passava alle<br />
dipendenze del Ministero dell’Economia Nazionale e il decreto 16 luglio 1936, n.1706. Per<br />
questo e per i dati riportati cfr. M. De Martino op. cit.<br />
( 12 ) N. Paone, La transumanza, op. cit., pag. 27.<br />
( 13 ) ivi.<br />
(14) U. Sprengel, La pastorizia transumante nell’ambiente dell’Italia centro-meridionale,<br />
Marburg 1971.
Il Palasciano ha censito tutto ciÜ che rimane della rete tratturale con questi dati ( 15 ):<br />
estensione accertata: ha. 16.530, di cui 12.000 ha. reintegrati e 4530 ha. da<br />
reintegrare;<br />
dei 12.000 ha. del Demanio Regionale, solo 6.000 ha. sono occupati da strade, ferrovie<br />
e corsi d’acqua ( 3.000 ha. ) o non praticabili per eccesso di pendenza ( 3.000 ha. ) ( 16 ).<br />
Spinte sociali e di natura psicologica, proprie di generazioni sempre piá imb<strong>org</strong>hesite, insieme<br />
ad obiettive difficoltÖ ( norme piá restrittive sul rapporto fra numero di capi in migrazione e<br />
personale addetto ) ( 17 ), hanno contribuito a rendere definitivo l’abbandono di questa attivitÖ.<br />
--------------------------------------------<br />
( 15 ) I. Palasciano, Le lunghe vie erbose, Capone Editore Lecce 1981.<br />
( 16 ) Le Regioni possono decidere sul destino del Patrimonio tratturale in base all’art. 66 del<br />
D.P.R. del 24.07.1977 n. 616 e successive modiche e integrazioni oltre alle leggi, in materia,<br />
che le Regioni interessate hanno emanato in modo autonomo.<br />
( 17 ) Le nuove norme impongono 1 addetto ogni 50 capi sul tratturo e 1 addetto ogni 25 capi<br />
sulle rotabili ( il rapporto tradizionale era 8 – 10 addetti ogni 800 – 1000 capi ) - cfr. N. Paone,<br />
op. cit., pag. 29.
eintegra dei regi tratturi, dogana delle pecore, ( s.l.f. 18 anno 1651 ) – archivio di stato di Foggia<br />
reintegra dei regi tratturi. ( Alfonso Crivelli anno 1712 ) – archivio di stato di Foggia
eintegra dei tratturi. ( anno 1810 ) – archivio di stato di Foggia<br />
reintegra dei tratturi. ( atl. 43, c.8 anno 1835 ) – archivio di stato di Foggia
IL TERRITORIO DELLA TRANSUMANZA NELLA CAPITANATA<br />
I caratteri dell’insediamento<br />
Come in molti paesi mediterranei, l’agricoltura nella provincia di foggia Å un prodotto piá del<br />
clima che del suolo ed il ruolo agricolo che il primo esercita, in una varietÖ di condizionamenti, Å<br />
stato tale da determinare , fino agli inizi dell’ottocento una distribuzione produttiva<br />
prevalentemente a mezza costa; “…la coltivazione meno sensibile alle base temperature: il<br />
grano, non supera gli 800 – 900 m. s.l.m., mentre le altre due colture che hanno consentito di<br />
estendere l’agricoltura in montagna: la segala e la patata erano di troppo recente introduzione<br />
per aver giÅ determinato degli insediamenti in quota. A valle, d’altra parte, il paludiamo<br />
consigliava , agli abitanti e alle coltivazioni, di rimanere per quanto possibile in posizione<br />
elevata.” ( cit. A. Filangieri Territorio e popolazione nell’Italia meridionale ).<br />
Queste osservazioni definiscono abbastanza chiaramente la configurazione delle colture, se si<br />
tiene presente la struttura orografica, geomorfologia ed idrologica della Capitanata. “…Ma per<br />
comprendere come l’esercizio dell’agricoltura si svolgesse, occorre rifarsi alla posizione degli<br />
abitati. Il lavoro per la coltivazione, per pascolare il bestiame e per far legna, doveva essere<br />
fornito quasi ovunque da popolazioni che non risiedevano direttamente sul luogo ma che<br />
vivevano in villaggi o in b<strong>org</strong>hi agricoli.<br />
La possibilitÅ di ogni terreno di venir coltivato era dunque condizionata dalla distanza al centro<br />
abitato, distanza che doveva venir coperta su sentieri malagevoli a piedi o a dorso d’asino,<br />
recando con sÉ gli attrezzi per lavorare il terreno.<br />
Anche se percorrenze prolungate erano da considerarsi normali, pur tuttavia si aveva una forte<br />
tendenza al rarefarsi della coltura man mano che ci allontanava dai luoghi di residenza.<br />
Lontano da questi ultimi erano poi escluse le produzioni maggiormente soggette a furti ed a<br />
danneggiamenti come quelle arboree in generale.” ( op- cit. ).<br />
Da queste esigenze prendeva dunque forma una distribuzione assai vicina a quella teorizzata<br />
da Von Thunen, in cui attorno al villaggio si addensano le colture piÑ esigenti: per la<br />
sorveglianza dei prodotti ( es. i frutteti ), per la gravositÅ dei trasporti ( es. i boschi ) , per il<br />
numero di giornate di lavoro richieste ( es. i vigneti ). PiÑ oltre si distribuiscono i cerali che,
ichiedendo meno giornate di lavoro, si adattano meglio a posizioni lontane e raggiungibili con<br />
difficoltÅ ed infine piÑ lontano i pascoli.<br />
A questa distribuzione Ç legata la localizzazione degli insediamenti residenziali, d’altro canto<br />
condizionata dagli eventi storici di diversa natura ( epidemie malariche, incursioni,<br />
defeudalizzazione, terremoti ecc.) che hanno variamente caratterizzato e determinato la spinta<br />
demografica e la conseguente espansione nel territorio.<br />
In definitiva il territorio Ç caratterizzato da una serie di concentrazioni urbane immerse in una<br />
campagna scarsamente antropizzata.<br />
<strong>org</strong>anizzazione duale cittÅ-campagna ( veduta aerea )
geomorfologia e geolitologia<br />
Dalla Carta dei sub sistemi del territorio rurale aperto elaborata del PTCP della Provincia, il<br />
territorio del Comune di Foggia viene inserito nelle aree da debolmente ondulate a pianeggianti<br />
del Basso tavoliere e dei terrazzi alluvionali, a prevalente indirizzo agricolo.<br />
La spianata ha una inclinazione verso ovest, cioÅ segue l’originaria inclinazione della superficie<br />
di regressione del mare pleistocenico e dei depositi fluviali che col tempo si sono adagiati.<br />
Dalla carta geologica d’Italia si rileva che il territorio comunale Å inserito in un vasto ambito<br />
dove affiorano alluvioni terrazzate recenti, superiori agli alvei attuali, compoiste da ciottoli,<br />
sabbie argille sabbiose a volta con presenze di calcari evaporitici.<br />
Strutturalmente i terreni presentano una bassa propensione al dissesto delle litologie, con<br />
discrete caratteristiche di portanza, mentre l’area Å caratterizzata da una frequente attivitÖ<br />
sismica dovuta alla presenza di una faglia orientata in direzione E-W ( faglia di Mattinata ). Dai<br />
dati riportati dall’Istituto Sismico Nazionale la faglia risulta simicamente attiva con frequenti<br />
terremoti di magnitudo inferiore a 6. L’intero territorio comunale Å classificato zona sismica di 2^<br />
categoria.<br />
Idrologia<br />
Il territorio della capitanata Å interessato da un reticolo idrografico minore caratterizzato dai<br />
torrenti Candelaro, Cervaro e Carapelle che discendono verso est per sfociare in mare.<br />
In ogni caso i corpi idrici non si possono definire perenni, per cui il reticolo idrografico<br />
superficiale Å quasi inesistente. Caratteristica dell’area Å una duplice circolazione sotterranea<br />
da una falda profonda ed una superficiale. Quella profonda che rinviene a notevole profonditÖ,<br />
ha acque caratterizzate da un elevato contenuto salino a causa di fenomeni di contaminazione<br />
marina. Il livello della flda superficiale varia da zona a zona in dipendenza del substrato, degli<br />
emungimenti per l’irrigazione. Un elemento di criticitÖ Å rappresentato dall’alto livello di<br />
vulnerabilitÖ delle risorse idriche sotterranee determinato dal tipo e dallo spessore dei substrati<br />
del suolo. La permeabilitÖ dei terreni del medio e basso tavoliere va da bassa a media, mentre<br />
nella parte nord la permeabilitÖ diminuisce diventando da scarsa a bassa.<br />
Estratto dal DPP per la formazione del PUG – Comune di Foggia 2005
Siti di interesse naturalistico<br />
ll bosco Incoronata<br />
“ la grande moltitudine dei cafoni e dei contadini viene a piedi, taluni facendo fino a ottanta<br />
miglia per venire a visitare la Madonna dell’Incoronata. L’arrivo di queste carovane Ç<br />
singolarissimo e pittoresco; si puÜ vedere attraverso le grandi distese di grano, per parecchie<br />
miglia di distanza, i pellegrini ordinati in lunghe file; sembrano delle processioni di formiche. Si<br />
sentono in lontananza delle melodie alternate, voci di donne e voci di uomini, rinforzarsi a<br />
misura che si avvicinano al bosco delle querce, arrivano sfiniti e stanchi appoggiati al loro<br />
bastone di pellegrini. Appena giunti fanno tre volte il giro della chiesa e poi si inginocchiano<br />
davanti alla porta….”<br />
Cosâ descriveva, nei suoi appunti di viaggio, l’arrivo di pellegrini all’inizio del novecento la<br />
viaggiatrice inglese E. Ross.<br />
Il senso storico del bosco dell’Incoronata Å da ricercarsi sia nella tradizione religiosa che nella<br />
dimensione ludica.<br />
GiÖ nel 1254 Manfredi, fra le pompose feste per la sua incoronazione <strong>org</strong>anizzo una grande<br />
partita di caccia con oltre 1500 invitati col risultato di una considerevole distruzione di<br />
selvaggina.<br />
Nei secoli successivi, l’allodio dell’Incoronata, forse per la sua particolare posizione<br />
pianeggiante, Å sempre stato uno dei preferiti delle Case Regnanti dell’ Italia Meridionale fino<br />
a quando , nel 1759 Carlo III di Borbone, chiuse l’attivitÖ della caccia reale.<br />
caratteri climatologici<br />
Le precipitazioni annue variabili tra i 400 e i 500 mm. Caratterizzano il clima con temperature<br />
medie variabili tra i 10 – 20 äC, con minimi assoluti di -10 äC e massimi assoluti di +45 äC. La<br />
zona, inoltre Å soggetta ad escursioni termiche molto sensibili, in media di circa 20 äC ogni<br />
anno.
caratteri geologici<br />
Il sottosuolo Å costituito da strati composti, procedendo dal basso verso l’alto, di argille azzurre<br />
plioceniche, argille giallastre, sabbie argillose, sabbie e limo.<br />
Il rapporto tra piogge e temperature estive Å sempre largamente inferiore a 10, per cui il<br />
territorio in esame ricade nell’ambito della zona a clima caldo-arido.<br />
caratteri floro – vegetazionali<br />
Il bosco, da ultime rilevazioni effettuate, ha una estensione complessiva di 320 Ha, suddivisi:<br />
162 Ha di boschi di alto fusto<br />
115 Ha di pascoli<br />
43 Ha di seminativi.<br />
La superficie boscata puÜ essere distinta in associazione vegetale naturale ed artificiale.<br />
La prima Å caratterizzata dalle seguenti associazioni arboree spontanee:<br />
Popoletum albae<br />
associazione a Pioppo bianco compreso i canneti Ha 44.15.20<br />
Fraxinetum<br />
associazione di bosco misto di frassino Ha 8.00.00<br />
Quercetum pubescentis<br />
associazione a Roverella con molti esemplari secolari Ha 13.00.00<br />
Quercetum pubescentis<br />
associazione a Roverella costituita da gruppi piÇ o meno ampi e sparsi<br />
con radure.<br />
Ha 28.89.60<br />
Totale Ha 90.04.80
La seconda associazione Å stata impiantata artificialmente ed Å essenzialmente costituita da:<br />
Pioppeto euro-americano Ha 10.86.40<br />
Eucalitteto<br />
rostrato a densitÅ normale, sito ai lati della strada di accesso al Santuario Ha 34.67.20<br />
Eucalitteto misto a roverella Ha 02.12.80<br />
Pineto di Pino d’Aleppo<br />
Sito a destra accedendo al Santuario Ha 02.48.00<br />
Pineto di Pino d’Aleppo<br />
Sito alle spalle del Santuario, nel settore occidentale del bosco Ha 17.96.90<br />
In sintesi le specie forestali sviluppatesi autonomamente nell’ambiente sono:<br />
Totale Ha 68.11.30<br />
a. la Roverella, che costituisce la specie piá evoluta nell’ambiente forestale della<br />
provincia.<br />
b. Il Pioppo bianco, specie suscettibile di variazioni in funzione della falda freatica e della<br />
struttura del suolo, con evoluzione in Olmeti, Acereti, Fraxineti e Querceti.<br />
Attorno alle associazioni fondamentali, a Roverella ed a Pioppo bianco ruotano molte altre,<br />
alcune appena accennate, altre piá evidenti, molte delle quali indicatrici del processo<br />
innovativo a cui il bosco da anni Å soggetto.<br />
Probabilmente nel passato, quando le risorse idriche erani piá consistenti, la formazione<br />
prevalente del bosco era costituita da una quercia piá igrofila dell’attuale roverella.<br />
Ai margini del Querceto pubescensis, la dove il roverelleto appare cespuglioso e si allarga a<br />
radure piá o meno estese, compare la pseudo-macchia: un arbusteto caducifoglio<br />
comprendente oltre alla stessa Roverella, in forma cespugliosa e pulvinata anche Palivrus<br />
Spina-Cristi, Pirus amγgdaliformis, Osγris alba, Cercis siliquastrum e Caparris spinosa, specie<br />
selezionatesi nel corso di una lunga e irrazionale attivitÖ di pascolamento.<br />
Altri elementi, piá termofili e propri della macchia mediterranea si mescolano ai precedenti<br />
come: smilace, pungitopo, asparago, rosa sempreverde; altre specie, provenienti dai campi e<br />
dai pascoli circostanti, sviliscono il roverelleto e l’arbusteto xeromorfo a graminacee, a<br />
finocchio, a cardi e labiate.
Localmente il Pioppo bianco cede in favore dell’Olmo, del Frassino oxifillo e dell’Acero<br />
campestre.<br />
Il piano arbustivo Å quasi sempre continuo e compatto, comprendendo, oltre alle specie su<br />
elencate: ligustro, sanguinella, biancospino, specie lianose e rampicanti, come edera,<br />
clematide, rosa sempreverde, rovo, vite.<br />
Tuttavia, come giÖ detto, il bosco dell’Incoronata Å costituito non soltanto da roverella ed olmi,<br />
frassini, pioppi ed aceri ma anche da altre specie impiantate di recente, che hanno modificato il<br />
primitivo assetto fisionomico e culturale, allentando cosâ i legami leggendari e mistici tra bosco<br />
e santuario, motivati dal rinvenimento su un ramo di quercia del simulacro della Madonna<br />
venerata nell’adiacente santuario.<br />
Le ragioni dell’introduzione di specie esotiche ed estranee nell’ambiente vanno ricercate<br />
essenzialmente nel bisogno di ricostruire al piá presto il tessuto arboreo dell’Incoronata<br />
devastato dalla guerra, destinando quel suolo alla maggior produzione possibile di legname.
La percezione paesaggistica<br />
Percorrendo le strade tratturali si ha una comprensione immediata e complessiva dei caratteri<br />
del paesaggio: in generale, appena fuori dall’insediamento urbano lo sguardo abbraccia la<br />
campagna scarsamente popolata con qualche testimonianza sopravvissuta alle ingiurie del<br />
tempo e dell’uomo ( modeste cappelle, cippi segnaletici, poste per animali, ecc. ), che<br />
costituiscono una preziosa testimonianza storico – culturale da recuperare.<br />
Di seguito si riportano alcune immagini e simboli delle vie tratturali.<br />
o i termini lapidei<br />
I termini furono apposti in occasione delle varie reintegre succedutasi nel tempo. Essi portano<br />
sulla faccia anteriore una numerazione progressiva( da un lato del tratturo i numeri dispari,<br />
dall’altro i pari ) e su quella posteriore la scritta R.T. ( Regio Tratturo ) e l’anno in cui furono<br />
apposti.
o le poste<br />
La struttura doganale, nel 1447 venne gestita dal doganiere F. Montluber, che utilizzÜ per il<br />
pascolo del bestiame i possedimenti della Corona nel Tavoliere e altri territori di feudatari, enti<br />
ecclesiastici, comunitÖ locali.<br />
Queste proprietÖ, chiamate locazioni, a loro volta furono suddivise in porzioni minori dette<br />
poste o iacci, ovili che venivano assegnati ai proprietari del bestiame, i locati, con relativo<br />
pascolo proporzionato all'armento.<br />
La posta doveva essere riparata dal vento, orientata a sud, in leggera pendenza, dove gli ovini<br />
passavano la notte o i giorni piá freddi.<br />
L'assegnazione della posta, avveniva dopo il controllo del numero di pecore denunciato dal<br />
pastore e veniva fatta dal Doganiere che destinava al gregge, ancora nel riposo, la locazione<br />
e la posta adatta prendendo nota per la riscossione della relativa fida in maggio.<br />
transumanza e posta
o le taverne<br />
Le taverne erano delle osterie attrezzate poste lungo gli assi tratturali, dotate di servizi ricettivi<br />
sia per i pastori che per gli animali; per questi ultimi, non volendo usufruire della possibilitÖ di<br />
un ricovero al chiuso, si potevano montare dei recinti smontabili.<br />
ovini in recinti smontabili
o le chiese<br />
La religiositÖ era strettamente legata al mondo dei pastori, non Å un caso che nell’iconografia<br />
cristiana Cristo nasce in una mangiatoia con i pastori che mettono a disposizione i loro animali.<br />
Pertanto, col diffondersi del Cristianesimo, lungo le vie tratturali e/o in territori a loro correlati<br />
nascono cappelle e piccole chiese dallo stile essenziale, luoghi non solo di culto ma anche di<br />
commercio. Infatti, in determinati periodi dell’anno e in concomitanza della transumanza si<br />
svolgevano delle fiere per la promozione di prodotti tipici.<br />
chiesa di San Lorenzo i n Carmignano
o gli abbeveratoi<br />
Questi manufatti, indispensabili per la vita sia degli uomini che degli animali, sono presenti<br />
lungo tutti i percorsi tratturali e rappresenta un patrimonio archeologico assolutamente<br />
originale.<br />
o la vegetazione<br />
Lungo tutto il percorso il bestiame arricchiva il terreno di liquame per cui si sviluppava una<br />
vegetazione tipica dell’habitat legata al ciclo dei nitrati quali l’ortica, i cardi, i verbaschi.
o l’ambito extraurbano<br />
la strada<br />
il suolo
la masseria<br />
il paesaggio
o antropizzazione in ambito urbano<br />
indentificazione urbana<br />
livello di<br />
compromissione<br />
32<br />
n e l la z o n a u r b a n a i l t r a t t u re ll o c o in c i d e c o n v ia<br />
S . P e ll ic o .<br />
D a l l' in c r o c io c o n v ia M . N a t o la , c o n v e rs o u s c e n _<br />
t e d a ll a c i t t Å , c o i n c id e c o n la s t r a d a C a m p o r e a le .<br />
tratturello Foggia - Camporeale
indentificazione urbana<br />
livello di<br />
compromissione<br />
n e l la z o n a u r b a n a i l t r a t t u re ll o c o in c i d e c o n v ia<br />
A s c o li.<br />
D a l l' in c r o c io c o n l a t a n g e n t e s e t t e n t r io n a le ,<br />
c o n v e r s o u s c e n t e d a l la c it t Å , c o in c id e c o n v ia<br />
d e g li A v i a t o r i.<br />
tratturello Foggia - Ascoli - Lavello<br />
36
indentificazione urbana<br />
livello di<br />
compromissione<br />
3<br />
n e l l a z o n a u r b a n a i l tr a t tu r e l l o c o i n c i d e c o n v i a<br />
G a l i a n i , p r o s e g u e c o n v ia l e F o r to r e e c o s te g g ia<br />
i l c o m p l e s s o d e l C a m p o F i e r e d i F o g g i a .<br />
I l tr a t tu r e l l o Ç r i c o n o s c i b il e s o lo p e r l a p a r t e e x tr a -<br />
u r b a n a .<br />
tratturello Foggia-Tressanti-Barletta<br />
41
indentificazione urbana<br />
livello di<br />
compromissione<br />
n e l l a z o n a u r b a n a i l t r a t tu r e l l o c o i n c i d e p e r u n<br />
t r a t t o c o n v i a l e F o r t o r e e p e r l a p a r te r e s i d u a c o n<br />
v i a C a s ti g l i o n e .<br />
tratturello Foggia - Castiglione<br />
45
indentificazione urbana<br />
livello di<br />
compromissione<br />
35<br />
n e l l a z o n a u r b a n a i l tr a t tu r e l l o c o i n c i d e c o n v i a<br />
V . G i o b e r ti.<br />
L a i d e n ti fi c a z i o n e Ç p o s s i b i l e d a l l i m i te d i i n te r s e _<br />
z i o n e c o n l a c i r c u m v a l l a z i o n e i n p o i , c o n v e r s o<br />
u s c e n te d a l l a c i t tÅ .<br />
tratturello Foggia - Castelluccio dei Sauri
indentificazione urbana<br />
livello di<br />
compromissione<br />
n e l la z o n a u r b a n a i l t r a t t u r e ll o a t t r a v e rs a<br />
t ra s v e r s a lm e n t e l a c i t t Å e p e r la r e s id u a<br />
p a r t e c o i n c id e c o n s t ra d a e s t e r n a a l c o m p a r t o<br />
O rd o n a S u d d e ll a n u o v a z o n a 1 6 7 .<br />
L a id e n t i f i c a z i o n e Ç p o s s ib il e d a l l' in c r o c io c o n<br />
M o n s . F . F a ri n a i n p o i, c o n v e r s o u s c e n t e d a lla<br />
c it t Å .<br />
tratturello Foggia-Ordona-Lavello<br />
37
indentificazioneurbana<br />
livello di<br />
compromissione<br />
3<br />
n e l la z o n a u r b a n a i l t r a t t u r e ll o c o in c i d e c o n v ia<br />
S c i ll it a n i, c o n i l s o t t o v ia d e l v ia le F o r t o r e e c o n<br />
v ia d e l M a r e .<br />
tratturello Foggia - Zapponeta<br />
42
indentificazione urbana<br />
livello di<br />
compromissione<br />
i l tr a t t u r e l l o s i d i p a r t e d a l t r a tt u r o p r i n c i p a l e<br />
F o g g i a - L ' a q u i l a e n e l l a z o n a u r b a n a r i s u l ta<br />
o c c u p a t o d a c a s e c o s t r u i t e s i a i n e p o c a r e m o t a<br />
c h e r e c e n t e .<br />
O l t r e l a s e d e f e r r o v i a r i a F o g g i a - L u c e r a , c o n v e r s o<br />
u c e n t e d a l l a c i tt Å , e s s o c o i n c i d e c o n l a s t r a d a<br />
v i c i n a l e V i l l a n o v a .<br />
tratturello Foggia - Sannicandro<br />
86
indentificazione urbana<br />
livello di<br />
compromissione<br />
n e l l a z o n a u r b a n a i l tr a t tu r o c o i n c i d e c o n v i a<br />
S . S e v e r o .<br />
tratturo l'Aquila - Foggia
indentificazione urbana<br />
livello di<br />
compromissione<br />
n e l la z o n a u r b a n a i l t r a t t u ro a t tra v e rs a<br />
t ra s v e r s a lm e n t e i l t e s s u t o e d if ic a to , n o n Ç<br />
p o s s i b i le , q u in d i , la s u a i d e n t if ic a z io n e .<br />
o lt re i l p o n t e fe rr o v ia ri o , i l t r a t tu ro<br />
c o i n c id e c o n v i a M a n f re d o n ia .<br />
tratturo Foggia - Campolato
indentificazione urbana<br />
livello di<br />
compromissione<br />
5<br />
n e l la z o n a u r b a n a i l ta rt t u ro , n e ll a p a rt e in iz ia le<br />
a t t ra v e rs a tr a s v e rs a l m e n t e il t e s s u t o e d ific a to ,<br />
p e r u n ' a l tr a p a rt e c o in c i d e c o n v ia L u c e ra .<br />
tratturo Celano - Foggia
indentificazione urbana<br />
livello di<br />
compromissione<br />
n e l la z o n a u r b a n a i l t r a t t u ro a t t ra v e rs a<br />
t ra s v e r s a lm e n t e i l te s s u t o e d if ic a t o p e rta n t o<br />
l a s u a id e n t i f i c a z i o n e ris u lt a c o m p ro m e s s a .<br />
tratturo Foggia - Ofanto
SingolaritÖ<br />
Il nodo tratturale<br />
“ Fra il recinto della cittÅ di Foggia, dal lato est, ed un suo sobb<strong>org</strong>o giace un pianura di forma<br />
parallelogrammica la cui larghezza Ç di circa 400 palmi e la lunghezza di palmi 1.400 che<br />
chiamasi il Piano della Croce.<br />
Vien cosã denominato da una colonna sormontata da una croce di ferro sostenuta da una base<br />
circolare a diversi ripiani restringentesi a misura che si elevano dal suolo.<br />
Alcune tradizioni dicono che in quel punto cessarono di vivere i santi Guglielmo e Pellegrino<br />
antiocheni, venerati attualmente come protettori di Foggia. Altri vogliono che sia una semplice<br />
opera civica eretta al momento che fu inaugurato lo stabilimento del Piano della Croce.<br />
Questo Piano Ç un aggregato di piÑ centinaia di fosse scavate e costruite pel deposito di generi<br />
cereali degli agricoltori foggiani e forma uno stabilimento utile ad produttori e negozianti di essi.<br />
Le fosse sono profonde fino a 20 palmi e piÑ. La loro forma Ç conica slargata, la cui cima Ç<br />
troncata mercÉ un’apertura quadrata di circa tre palmi per ogni lato o circolare di tre palmi di<br />
diametro ( quale apertura si chiama il boccale ) per immettervi e per estrarre le granaglie.<br />
Nell’interno della fossa o sia del cono si fa un rivestimento a fabbrica con calce e pietre<br />
calcaree friabili dette “ cruste “; questo rivestimento giunge fino all’apertura o sia boccale e<br />
viene orlato da pietre da taglio; nel fondo poi ella fossa o sia alla base del cono i costruisce un<br />
pavimento con calce e mattoni.<br />
Sull’apertura o sia sulla bocca delle fosse si adattano dei tavoloni per chiuderle e opra di essi si<br />
gitta del terreno in modo da fare una protuberanza di circa due palmi dal livello del piano.<br />
Questo terreno serve a riconoscere il sito delle fosse che ad impedire che l’acqua delle piogge<br />
penetri e guasti il genere.<br />
Le fosse cosã costruite e cosã mantenute conservano le granaglie in buono stato per molti anni,<br />
ve ne sono delle piccole capaci di 200 e 300 tomoli ( 1 ) e altre che ne possono contenere<br />
1.000 a 2.000; ciÜ dipende dalla profonditÅ non solo, ma dalla figura piÑ aperta che si dÅ al<br />
cono.<br />
Il numero di esse Ç di circa mille……….) ( descrizione del Piano della Croce fatta dal Notaio<br />
F.P. Modula il 17 agosto 1845 ).
( 1 ) unitÖ di misura del grano: 1 tomolo ( prima del 1840 ) equivale a 55.319 litri<br />
1 tomolo ( dopo il 1840 ) equivale a 55,545 litri 46-48 kg (in funzione della qualitÖ dei grani ).<br />
Piano delle fosse<br />
incrocio fra i tratturi Foggia Campolato, Foggia – Ofanto, Aquila – Foggia e Celano-Foggia<br />
Charles Yriarte, corrispondente della rivista francese le Tour du Monde, nel 1975 scriveva : “ E’<br />
la prima volta, dopo l’Algeria e il Marocco, che io constato de visu l’abitudine che hanno gli<br />
abitanti dei paesi meridionali ricchi di grano di conservarli nei silos.<br />
Una delle porte della cittÅ dÅ su una vasta piazza. Piano della Croce o Piazza delle Fosse,<br />
sotto il cui suolo si aprono piÑ di mille fosse o pozzi di grano, a forma di tini, la cui apertura, al<br />
livello del suolo, si ricopre di un soppalco su cui si stende uno strato di terra. Una volta riportata<br />
la terra su questo impiantito, non si sc<strong>org</strong>e alcuna traccia delle fosse a tal punto che le vetture
vi stazionano, i cavalli e le bestie le percuotono; sarebbe impossibile sospettarne l’esistenza<br />
senza un tassello di pietra con un numero che le distingue.”.<br />
Allo stato attuale non vi Å nessuna traccia che ricordi il passato. Il Piano delle Fosse Å stato in<br />
parte occupato da costruzioni e le fosse residue riempite di terra.
L’istituzione post-romana delle fosse granarie ( horrea fiscalia ) si deve a Federico II che nella<br />
costituzione di Melfi del 12 giugno 1231, istituâ un tributo in natura sui cereali pari a 1 /12 della<br />
quantitÖ prodotta. Inoltre si obbligava i contribuenti a portare il tributo a proprie spese nei<br />
magazzini imperiali posti nei luoghi a prevalente attivitÖ agricola ( …ad orrea imperialia, que<br />
statuta sunt per civitates et loca, in quorum territorio agricolturam exercent…) (2)<br />
La costituzione prevedeva inoltre l’istituzione di fondachi doganali nei quali doveva essere<br />
immagazzinata la merce. Sia i fondachi doganali, che i magazzini per cereali furono fatti in<br />
prossimitÖ delle sedi degli Ufficiali della Curia imperiale: presso la porta principale della cittÖ,<br />
vicino al castello o al palazzo della Curia. Nella maggior parte dei paesi della Capitanata i<br />
depositi dei cereali erano costituiti da fosse poste in prossimitÖ di piazze adiacenti gli uffici della<br />
Curia.<br />
Le fosse resistettero anche alla crescente invadenza della Mena delle Pecore istituzionalizzata<br />
da Alfonso I d’Aragona nel 1442, l’UniversitÖ di Foggia, infatti, in considerazione che la sua<br />
terra non have altra industria che da fare campi de grani, ottenne nel 1479 da re Ferdinando il
ispetto delle mezane antique dove per lo passato solevano fare pascere et tenere li loro bovi<br />
domiti et in quelle possano fare pasculare dicti bovi.<br />
Le fosse granarie furono dimesse l’11 settembre 1937, con l’inaugurazione da parte del<br />
Principe Umberto di Savoia del grande silos granario di via Manfredonia .<br />
E. Winkelmann, Acta Imperi inedita . Innsbruck, 1880, pagg. 615/616.<br />
Altro monumento fortemente<br />
significativo Å l’Epitaffio.<br />
Esso puÜ considerarsi il<br />
monumento emblema della<br />
Transumanza.<br />
La fondazione di tale istituto<br />
determinÜ il ruolo centrale della<br />
cittÖ di Foggia quale nucleo<br />
politico ed economico<br />
nell’amministrazione della<br />
Dogana della Mena delle<br />
pecore di Puglia.<br />
L’Epitaffio fu orientato sull’asse<br />
del tratturo principale L’Aquila-<br />
Foggia, detto Tratturo del re e<br />
localizzato al suo imbocco. In<br />
origine fu posto a segnare<br />
gerarchicamente il territorio, ad indicarne la sua appartenenza alla Corona, principio e fine della<br />
prospettiva assiale del tratturo maggiore che solcava l’intero territorio demaniale.
IL <strong>PIANO</strong> COMUNALE <strong>TRATTURI</strong><br />
obiettivi di fondo<br />
La stesura del Piano Comunale dei Tratturi del Comune di Foggia riserva una serie di<br />
riflessioni sia sul metodo di approccio e sia sulla condizione culturale ed economica che tale<br />
realtÖ Å stata ed Å in grado di sviluppare.<br />
Il P.C.T. interessa tutto il territorio comunale in particolare si propone di affrontare il problema<br />
della riqualificazione delle aree dei percorsi tratturali che nel tempo hanno assunto molte<br />
caratterizzazioni lungo tutto il sito individuando alcune tipologie insediative come: l’urbano<br />
industriale, l’agrario, il naturale e il seminaturale; il tutto determinatosi dalle diverse<br />
antropizzazioni.<br />
Si Innestano cosâ una serie di valutazioni e connessioni ai fini di una riqualificazione in grado di<br />
valorizzare i vari siti incidendo sul sistema fisico percettivo.<br />
Il piano pertanto si configura come uno strumento di pianificazione e <strong>org</strong>anizzazione<br />
territoriale finalizzato a degli approfondimenti e valutazioni sulla ri<strong>org</strong>anizzazione e<br />
valorizzazione del paesaggio urbano, attraverso il principio della riqualificazione degli spazi<br />
capaci di esprimere nuove finalitÖ in continuitÖ storico patrimoniale del sistema tratturale.<br />
Pertanto questo tipo di assunzione di metodo andrÖ a favorire un’ ipotesi di recupero dei tratturi<br />
i quali si devono proporre come luogo di attivitÖ e di trasformazione capaci di esprimere una<br />
sostenibilitÖ economica e ambientale.<br />
Per rafforzare tale ipotesi poniamo un attimo la riflessione su quella che Å stato, nella storia, il<br />
sistema infrastrutturale dei tratturi e quale valorizzazione Å stata impressa ad esso e quali<br />
interventi possano consentire la conservazione di queste realtÖ fisiche che su linee fratturali si<br />
snodavano su diversi territori regionali.<br />
I tratturi interessati che si concludono sul territorio comunale di Foggia sono: Foggia-L’Aquila,<br />
Foggia-Celano, Foggia-Campolato, Foggia-Ofanto, oltre ad una serie di tratturelli.<br />
Questi hanno rappresentato un sistema infrastrutturale di collegamento mettendo in relazione<br />
fisico-economica le diverse realtÖ territoriali regionali.
Oggi nell’ottica di un progetto unitario si puÜ prevedere una loro utilizzazione che consenta,<br />
nello specifico, di restituire valori storici ed economici in dei circuiti tematici che trovano<br />
riscontro sul territorio stesso.<br />
Per questo si dovrÖ creare un parco dei tratturi che possa muovere interessi dall’area del<br />
Comune di Foggia per ampliarsi sul territorio regionale al fine di rendere il recupero un valore<br />
unitario con occasioni tematiche per l’economia di tutto il territorio.<br />
la trama tratturale
INDAGINI PRELIMINARI<br />
fonti cartografiche<br />
La procedura, cosâ come progettata e realizzata, al fine di consentire una idonea<br />
funzionalitÖ e semplicitÖ d’utilizzo, risulta essere distinta nelle seguenti fasi di lavoro:<br />
1. cartografia catastale / CASSINI - SOLDNER (CS)<br />
cs_catasto.map<br />
Cartografia catastale costituita dall’unione territoriale di n. 219 fogli di mappa, con<br />
relativi n. 24 allegati di tipo X e n. 24 allegati di tipo _X) in agro del Comune di Foggia,<br />
aggiornati al 20/12/2006.<br />
cs_prg92.map<br />
Cartografia di gestione dello strumento urbanistico vigente (Piano Regolatore Generale<br />
1992), del PUTT e del PAI ( aggiornato al 29 giugno 2006 )<br />
cs_ortofoto.map<br />
Cartografia catastale degli elementi grafici di sfondo riferiti ai fogli di mappa costituenti<br />
l’agro del Comune, aggiornati al 20/12/2006_<br />
Nello specifico, i seguenti file di lavoro comprendono la gestione delle relative banche dati:<br />
cs_catasto.map<br />
Cartografia catastale fogli di mappa costituenti l’agro del Comune.<br />
1. Gestione Acque (fiumi, torrenti e corsi d’acqua).<br />
2. Gestione Fogli Catastali ( elaborazione e ricerca dei fogli catastali utilizzati per la<br />
costituzione del sistema territoriale, con annessa la possibilitÖ di visualizzare i<br />
fogli catastali originale e di aggiornamento del sistema al 20 Dicembre 2006 ).
3. Gestione Elementi Dati Catastali ( elaborazione e ricerca degli elementi foglio di<br />
cs_prg92.map<br />
mappa / particella catastale )<br />
Cartografia di gestione dello strumento urbanistico vigente (Piano Regolatore Generale<br />
1992) completa dei seguenti elementi:<br />
4. Gestione Vincoli Territoriali (di carattere Urbanistico e Ambientale, con<br />
individuazione della denominazione della maglia territoriale gestita in sistema).<br />
5. Gestione delle Norme dello Strumento Urbanistico<br />
6. Gestione P.U.T.T. – Regione Puglia<br />
7. Gestione P.A.I. – Regione Puglia<br />
Sono attualmente gestiti i seguenti file in modalitÖ raster in entrambi i sistemi di riferimento<br />
geografici, che consentono la completa copertura del territorio denominato “Agro del Comune<br />
di Foggia”:<br />
IGM scala 1:100.000<br />
1. Foggia<br />
2. Lucera<br />
IGM scala 1:50.000<br />
1. Foggia<br />
2. Ascoli Satriano<br />
3. Cerignola<br />
4. San Severo<br />
5. Zapponeta<br />
IGM scala 1:25.000<br />
1. B<strong>org</strong>o Duanera La Rocca<br />
2. B<strong>org</strong>o Mezzanone<br />
3. B<strong>org</strong>o Segezia<br />
4. B<strong>org</strong>o Tavernola
5. Bovino<br />
6. Carapelle<br />
7. Castelluccio de’ Sauri<br />
8. Foggia<br />
9. La Camera<br />
10. Lucera<br />
11. Monte Granata<br />
12. Stazione di Orta Nova<br />
13. Tavernazza<br />
14. Villaggio Amendola<br />
Al fine di fornire un quadro esaustivo degli elementi gestiti, la procedura consente di utilizzare,<br />
in via informatizzata, i seguenti elementi topologici territoriali, aggiornati al Dicembre 2006:<br />
Territorio Comunale: 50.950 kmq.<br />
Particelle Catastali: n. 62219, di cui per ognuna Foglio – Particella – Superficie<br />
di ordine Grafico.<br />
Fogli di Mappa: n. 219 fogli di mappa con relativi n. 24 allegati_<br />
Maglie Urbanistiche: n. 1739 zone di P.R.G., P.U.T.T. e P.A.I. opportunamente<br />
inventariate e classate_<br />
Acque: n. 21, suddivisi in n. 178 settori individuati per ricaduta<br />
territoriale del foglio di mappa di appartenenza.<br />
Al fine di identificare le particelle intestate al Demanio – Ramo Tratturi della Regione Puglia e<br />
altri Demani, si Å provveduto ad interfacciare i dati numerici del catasto (elenco Ditte) con le<br />
particelle inserite nel sistema (circa 68.000).<br />
L’estrazione dei dati tramite specifiche query ha comportato la identificazione dei suoli cercati.<br />
I dati sono stati estratti nel rispetto del Dlgs n.196/2003 – codice in materia di protezione dei<br />
dati personali – e successive modifiche e integrazioni.<br />
In dettaglio la identificazione catastale dei suoli demaniali Å riportata nell’allegato “ A “.
3. ortofotogrammetria<br />
La cartografia ortofotogrammetrica utilizzata Å proveniente dalla Compagnia<br />
Generale Riprese Aeree s.p.a. di Parma con data di volo maggio 2005, riveniente<br />
dall’accordo di programma Regione Puglia – C.G.R. s.p.a. di cui il Comune di<br />
Foggia Å intestatario di sub-licenza.<br />
4. aerofotogrammetria<br />
La cartografia aerofotogrammetrica utilizzata Å stata concessa dal Comune di<br />
Foggia.<br />
indagine sulle concessioni<br />
L’indagine ha comportato una verifica puntuale di tutte le concessioni esistenti agli atti<br />
dell’Ufficio Parco Tratturi di Foggia. Per facilitare una lettura <strong>org</strong>anica dei dati a disposizione, le<br />
informazioni relative alle concessioni sono state riportate nelle tavole di analisi, ( cfr. strisciata<br />
relativa alle proprietÖ catastali ) mentre tutto ciÜ che non risulta campito Å da considerarsi<br />
come occupazione abusiva. La ricognizione dei luoghi ha completato questa fase di indagine.<br />
indagine sulle vendite<br />
Per la individuazione delle aree tratturali non piá demaniali, in quanto oggetto di atti di<br />
trasferimento a privati o ad altri Enti, si Å operato mediante la preventiva consultazione dei<br />
“Registri delle vendite”, archiviati presso l’Ufficio Parco Tratturi di Foggia.<br />
In essi sono riportati, relativamente ad ogni tratturo e per Comune interessato, gli atti di<br />
trasferimento del bene , gli estremi e gli elementi piá significativi dello stesso.<br />
Costituiti da una raccolta di modelli a due fogli contrapposti, questi venivano manualmente<br />
integrati negli anni, in concomitanza con la stipula di nuovi atti di trasferimento, dal funzionario<br />
che, al momento, era preposto alla alienazione.<br />
Poichà le vendite sono state effettuate in un arco temporale abbastanza lungo, la conclusione<br />
ovvia Å che vi Å una palese disuniformitÖ nella completezza di dati registrati a partire, per
quanto concerne le aree tratturali ricadenti nel Comune di Foggia, dal maggio 1938 sino ad<br />
oggi.<br />
Dalla consultazione dei “Registri delle vendite” si Å pervenuti alla individuazione degli atti ivi<br />
registrati che hanno interessato i tratturi del Comune di Foggia: complessivamente sono stati<br />
effettuati duecentodieci atti di trasferimento contraddistinti con un numero di repertorio.<br />
I suddetti atti sono contenuti in nä98 volumi, archiviati presso l’Ufficio Parco Tratturi, ciascuno<br />
dei quali comprende cento atti con numerazione progressiva del repertorio.<br />
Si Å proceduto, pertanto, alla consultazione di ciascuno degli atti di vendita, al fine di<br />
individuare planimetricamente la particella trasferita.<br />
L’operazione non Å semplice, poichà la particella non Å distinta, sia nei Registri delle vendite<br />
che negli atti di trasferimento, con i suoi identificativi catastali, bensâ con un codice<br />
alfanumerico che fa riferimento ad uno schizzo planimetrico allegato allo stesso atto o, talvolta,<br />
ad atti precedenti relativi a zone dello stesso tronco tratturale.<br />
Dal confronto tra detti schizzi planimetrici e l’attuale situazione catastale, con l’aiuto della<br />
descrizione riportata in atto, si Å pervenuti alla individuazione delle aree tratturali trasferite.<br />
Le tabelle poste in allegato sotto la lettera “ B “sono state cosâ distinte:<br />
Registri delle vendite<br />
In essa sono stati riportati i dati piá significativi tratti dai Registri delle vendite per<br />
ciascun tratturo che interessa il Comune di Foggia: numero d’ordine di registrazione<br />
dell’atto, numero di repertorio, identificativo dell’acquirente, data dell’atto, codici<br />
alfanumerici con i quali vengono distinte in planimetria le zone, superficie ceduta,<br />
eventuali annotazioni.<br />
Atti di vendita in archivio<br />
In tabella sono riportati gli identificativi degli atti interessanti le aree tratturali del<br />
Comune di Foggia, per numero di repertorio crescente, raggruppate per volume<br />
presente in archivio e distinte per tratturo ove esse ricadono e dal numero progressivo<br />
riportato nei Registri delle vendite, relativamente a ciascun tratturo.
Sintesi atti di vendita<br />
Conclusioni<br />
In tabella sono riportati, per ciascun tratturo, il numero progressivo dell’atto di<br />
trasferimento quale riportati nei Registri delle vendite, il numero di repertorio dell’atto, la<br />
presenza o meno di planimetria allegata all’atto, l’individuazione alfanumerica della<br />
zona, eventuali annotazioni.<br />
Il limite della ricerca risiede nel fatto che si Å potuto appurare la consistenza immobiliare<br />
venduta solo dal 1939 in poi. Per la parte antecedente a tale periodo, vale il principio di<br />
proprietÅ demaniale non attestata, ovvero la proprietÖ Å del Demanio della Regione Puglia,<br />
salvo la dimostrazione del diritto vantato da terzi.
IL SISTEMA DEI VINCOLI<br />
La conoscenza del sistema gerarchizzato dei vincoli ( Stato-Regione-Provincia-Comune )<br />
permette a qualsiasi piano di muoversi in un quadro di certezza del diritto. L’ottica dello studio<br />
Å analizzare il sistema vincolistico riguardante in qualche modo i beni culturali e ambientali.<br />
vincoli derivanti dalla pianificazione sovraordinata<br />
Piani Statali<br />
La pianificazione statale a valenza territoriale si puÜ ricondurre a :<br />
pianificazione paesaggistica, riportata nel cosiddetto “ Codice Urbani “ (Dlgs. n.42/2004)<br />
tutela dei beni archeologici e storico – culturali (Dlgs. n.42/2004)<br />
parchi e riserve<br />
piani di settore ( energetico, trasporti, PGTL 2001 – Piano Generale Trasporti e della<br />
Logistica - ecc. )<br />
Vi sono ovviamente molte altre leggi che incidono, ma non direttamente.<br />
1. D.M. dei Beni Culturali ed Ambientali del 15/6/1976.<br />
“ .. tutti i suoli di proprietÖ dello Stato siti nell’ambito della regione Molise ed appartenenti<br />
alla rete Tratturi, alle loro diramazioni minori ed ogni altra pertinenza, quali risultano<br />
dalla documentazione giacente presso il commissariato per la reintegra di Foggia, sono<br />
sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge 1/6/1939 n.1089 sulla tutela delle<br />
cose di notevole interesse storico, artistico e archeologico. “<br />
2. D.M. dei Beni Culturali ed Ambientali del 15/6/1976.<br />
“ …oltre i singoli tratturi siti nell’ambito della Regione Molise, anche quelli del territorio<br />
della Regione Abruzzo, della Regione Puglia e della Regione Basilicata, appartenenti<br />
alla rete dei Tratturi , di proprietÖ dello Stato e di altri Enti, sono sottoposti a tutte le
disposizioni contenute nella legge 1/6/1939 n.1089.” Il decreto stabilisce il principio<br />
della continuitÖ geografica, storico e culturale dei Tratturi.<br />
3. Dl.gs 22/1/2004, n. 42 “ Codice dei beni culturali e dl paesaggio, ai sensi<br />
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137 “<br />
Art. 2 - Patrimonio culturale<br />
1. Il patrimonio culturale e' costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.<br />
2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11,<br />
presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e<br />
bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze<br />
aventi valore di civiltÖ.<br />
3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti<br />
espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri<br />
beni individuati dalla legge o in base alla legge.<br />
Art. 142 – Aree tutelate per legge<br />
1. Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque<br />
sottoposti alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico:<br />
a) i territori costieri compresi in una fascia della profonditÖ di 300 metri dalla linea d<br />
battigia, anche per i terreni elevati sul mare;<br />
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profonditÖ di 300 metri dalla<br />
linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;<br />
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle<br />
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11<br />
dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150<br />
metri ciascuna;<br />
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena<br />
alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;<br />
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di protezione esterna dei<br />
parchi;<br />
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi o danneggiati dal fuoco, e<br />
quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6,<br />
del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 227;<br />
h) le aree assegnate alle universitÖ agrarie e le zone gravate da usi civici;<br />
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica<br />
13 marzo 1976, n. 448;<br />
l) i vulcani;<br />
m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del<br />
presente codice.<br />
4. D.L. 24 marzo 2006 n 157 “ Disposizioni correttive ed integrative al decreto<br />
legislativo 22 gennaio 2004, n.42, in relazione al paesaggio.”<br />
Art.2 - modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42<br />
1. Al comma 1, dell’articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, Å aggiunto,<br />
in fine, il seguente periodo “ in riferimento ai beni paesaggistici la valorizzazione<br />
comprende altresâ la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela<br />
compromessi o degradati, ovvero alla realizzazione di nuovi valori paesaggisti coerenti<br />
ed integrati.”<br />
Nota all’art. 2: si riporta il testo dell’art. 6 del citato decreto:<br />
“ art. 6 – Valorizzazione del Patrimonio culturale :<br />
1. la valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attivitÖ<br />
dirette e promuovere la conoscenza culturale e ad assicurare le migliori condizioni di<br />
utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso. Essa comprende anche la<br />
promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In<br />
riferimento ai beni paesaggistici la valorizzazione comprende altresâ la riqualificazione
degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero alla<br />
realizzazione di nuovi valori paesaggisti coerenti ed integrati.<br />
2. La valorizzazione Å attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non<br />
pregiudicarne le esigenze.<br />
3. La repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o<br />
associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale. “<br />
5. Dlgs 26 marzo 2008 n 63 “ Ulteriori disposizioni integrative e correttive del<br />
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, in relazione al paesaggio.”<br />
NUOVA DEFINIZIONE DI PAESAGGIO<br />
Il nuovo articolo 131 del Dlgs 42/2004 definisce il paesaggio “ il territorio espressivo di<br />
identitÑ il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro<br />
interrelazioni.” Si tratta di una definizione che riprende con piá precisione la definizione<br />
della Convenzione Europea del Paesaggio ( approvata a Firenze il 20/10/2000 ) che fa<br />
esplicito riferimento alla percezione del paesaggio da parte delle popolazioni da cui nella<br />
nuova definizione il riferimento al “ territorio espressivo di identitÅ “.<br />
Piani Regionali<br />
1. Piano Territoriale Tematico Paesaggio ( PUTT/p )<br />
Il piano Å stato approvato con D.G.R. del 15/12/2000 n. 1748, ed Å strumento di<br />
pianificazione territoriale sovraordinato agli strumenti di pianificazione comunale, che ha<br />
la finalitÖ primaria di promuovere la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse<br />
territoriali ed in particolare di quelle paesaggistiche. Il P.U.T.T./p. ha integrato gli<br />
ordinamenti vincolistici giÖ vigenti sul territorio ed introdotto nuovi contenuti normativi. In<br />
particolare, le cosiddette “prescrizioni di base “ sono volte a tutelare le componenti<br />
paesaggistiche “strutturanti ” l’attuale assetto paesistico-ambientale.<br />
Il PUTT/p delimita degli ambiti territoriali che denomina estesi, ed altri ambiti che<br />
denomina distinti , solo che in assenza di un adeguato supporto informativo, rinvia alla
fase di attuazione del piano, alla pianificazione comunale e ai singoli progetti di<br />
trasformazione la gran parte delle scelte ritenute possibili.<br />
Il piano riporta tra i componenti strutturanti il territorio i percorsi della transumanza e dei<br />
tratturi ( art. 3.04 ). Il PUTT/p localizza i percorsi tratturali e li inserisce fra i vincoli e<br />
segnalazioni architettonici – archeologici. In particolare i percorsi armentizi sono inseriti<br />
nell’ambito delle zone archeologiche ( art. 3.15 ) in quanto trattasi di beni culturali<br />
archeologici vincolati ai sensi della Legge 1089/39.<br />
Le prescrizioni del PUTT/p prevedono un duplice regime di tutela:<br />
Aree di pertinenza , costituite dal complesso di aree di sedime impegnate dai beni<br />
archeologici;<br />
Aree annesse, costituite dal complesso di aree che hanno avuto un rapporto culturale,<br />
storico, ambientale diretto con i beni archeologici.<br />
Alle aree di pertinenza dei percorsi tratturali sono applicabili gli indirizzi degli ambiti<br />
territoriali estesi di valore eccezionale “ A “ ( art. 2.02 p.to 11 ) con l’obiettivo di<br />
salvaguardia e valorizzazione paesaggistica – ambientale attraverso la conservazione e<br />
valorizzazione attuale, recupero delle situazioni compromesse.<br />
Alle aree annesse sono applicabili gli indirizzi di tutela degli territoriali estesi di valore<br />
distinguibile “ C “ ( art. 2.02 p.to 13 ) in essi sono perseguibili obiettivi di salvaguardia e<br />
valorizzazione dell’assetto attuale se qualificato, trasformazione dell’assetto attuale se<br />
compromesso.<br />
2. Piano di Bacino per l’Assetto Idrogeologico ( PAI )<br />
Adottato nel dicembre 2004 dal Comitato Istituzionale di Bacino Interregionale della<br />
Puglia, cosâ come previsto dalla normativa vigente in materia di difesa del suolo<br />
( L. 183/89 e successive modifiche ed integrazioni ), il piano nell’attuale<br />
configurazione, per il territorio del Comune di Foggia, Å stato approvato nella seduta del<br />
29/06/2006 n. 221 reg. delle deliberazioni.<br />
Esso produce come effetto l’adeguamento di tutti gli strumenti urbanistici alla normativa<br />
in vigore.
3. Pianificazione delle aree naturali protette ( L.R. n. 19 del 24/07/97 )<br />
La Regione Puglia si Å dotata di una propria legge in materia, conforme alla legge<br />
quadro nazionale sulle aree protette ( L. n.394/1991 ), la L.R. n. 19 del 24 luglio 1997<br />
recante norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione<br />
Puglia.<br />
Oltre al Parco Nazionale del Gargano, ricadono nella provincia di Foggia altre cinque<br />
aree naturali di pregio e di grande valenza naturalistica e ambientale. In particolare<br />
individua nel territorio del Comune di Foggia l’area del Bosco Incoronata quale “ ultimo<br />
relitto “ di bosco igrofilo del tavoliere Pugliese.<br />
Con D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U. 95 del 22/4/2000 viene istituito il Parco Naturale<br />
Regionale “ Valle del Cervaro – Bosco dell’Incoronata “ dichiarato Sito di Importanza<br />
Comunitaria.<br />
La disciplina relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora<br />
e della fauna selvatiche ( Direttiva Habitat ), Å affidata alla Direttiva Comunitaria<br />
92/43/CEE, che norma le procedure per la costituzione della rete e dei siti Natura 2000:<br />
aree contenenti habitat naturali, seminaturale e specie ( faunistiche e floristiche ) di<br />
particolare valore biologico ed a rischio di estinzione. In Puglia sono stati censiti, con il<br />
programma Bioitaly, 77 Siti di Importanza Comunitaria ( pSIC ) e sono state indicate nel<br />
dicembre 1998, 16 Zone di Protezione Speciale ( Z.P.S. ) designate ai sensi della<br />
Direttiva Uccelli n.79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.<br />
Di seguito si riporta la scheda illustrativa relativa ai dati ai dati generali del SIC valle<br />
del Cervaro – Bosco dell’Incoronata.
Il Parco Naturale Regionale del Bosco Incoronata Ä situato a circa 12 chilometri dalla cittÅ di Foggia, nel cuore del Tavoliere<br />
delle Puglie. L'area protetta, di circa 1000 ettari, custodisce un piccolo lembo di vegetazione naturale all'interno di un territorio<br />
profondamente coltivato. E' un territorio diversificato rappresentativo degli ambienti che in passato ricoprivano buona parte del<br />
Tavoliere. Il Parco Naturale Regionale comprende oltre il Bosco dell'Incoronata anche parte del Sito di Importanza Comunitaria<br />
proposto (pSIC) denominato "Valle del Cervaro - Bosco dell'Incoronata" ricadente nel perimetro del Comune di Foggia.<br />
DENOMINAZIONE: VALLE DEL CERVARO, BOSCO DELL'INCORONATA<br />
DATI GENERALI<br />
Classificazione: Sito d'Importanza Comunitaria (SIC)<br />
Codice: IT9110032<br />
Data compilazione schede: 01/1995<br />
Data proposta SIC: 06/1995 ( D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000)<br />
Estensione: ha 4560<br />
Altezza minima: m 54<br />
Altezza massima: m 71<br />
Regione biogeografica: Mediterranea<br />
Provincia: Foggia<br />
Comune/i: Orsara di Puglia, Bovino, Delicato, Panni, Castelluccio dei Sauri, Foggia.<br />
Comunita' Montane: Comunita' montana dei Monti Dauni meridionali<br />
Riferimenti cartografici: IGM 1:50.000 fogli 408-420-421.<br />
CARATTERISTICHE AMBIENTALI<br />
Il paesaggio si presenta uniforme, il tipo di clima e' tipicamente mediterraneo. Sito caratterizzato dalla presenza del corso del<br />
fiume Cervaro, bordato dalla caratteristica vegetazione ripariale di elevato valore naturalistico. Il bosco dell'Incoronata<br />
rappresenta l'ultimo lembo di foresta presente sul Tavoliere.<br />
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE<br />
Praterie su substrato calcareo con stupenda fioritura di Orchidee (*)<br />
Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-brachypodietea) (*)<br />
Fiumi mediterranei a flusso permanente e filari ripali di Salix e Populus alba<br />
Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba<br />
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II<br />
Mammiferi: Canis lupus<br />
Uccelli: Milvus milvus; Turdus philomelos; Dendrocopos major; Picus viridis; Alauda arvensis;<br />
Streptopelia turtur; Scolopax rusticola; Turdus pilaris; Turdus merula; Ficedula albicollis;<br />
Lanius collurio; Caprimulgus europaeus; Milvus migrans.<br />
Rettili e anfibi: Bombina variegata; Emys orbicularis; Elaphe quatuorlineata.<br />
Pesci: Alburnus albidus<br />
Invertebrati:<br />
SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II<br />
VULNERABILITA':<br />
Disboscamento per messa a coltura dei terreni. Prelievo idrico a monte con alterazione dell'equilibrio idrogeologico. Carico<br />
antropico rilevante per la presenza, nelle immediate vicinanze del bosco, di un santuario; pascolo eccessivo.<br />
(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Direttiva 92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati<br />
membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'.<br />
5%<br />
10%<br />
10%<br />
20%
vincoli derivanti dalla pianificazione locale<br />
Piani Comunali<br />
1. Il comune di Foggia Å dotato di Piano Regolatore Generale a firma del prof. L. Benevolo,<br />
approvato con pareri condizionati in data 11/11/97 delibera di G.R. n. 7914 e<br />
20/7/2001 delibera di G.R. n. 1005. Allo stato attuale l’Amministrazione Comunale ha<br />
ottemperato alle prescrizioni e si Å in attesa dell’approvazione definitiva.<br />
2. Il 9 marzo 2004 Å stato varato lo schema del nuovo DDL sul DRAG (Documento<br />
Regionale di Assetto Generale): “Principi, indirizzi e disposizioni per la pianificazione del<br />
territorio regionale. Il DDL avvia l’esatto quadro di conoscenze del territorio,<br />
fondamentale punto di riferimento per l’esatta pianificazione su larga scala e strumento,<br />
per tutti gli Enti Locali , per la tutela e la conservazione della identitÖ sociale e culturale,<br />
oltre che dei valori ambientali. “ Il DDL definisce per un verso gli aspetti urbanistico-<br />
procedurali relativi ai contenuti ed alla semplificazione normativa degli strumenti di<br />
pianificazione alle varie scale e, per altri versi, delinea le iniziative e i comportamenti atti<br />
a consentire sia il reale governo del territorio, sia il raggiungimento di sostenibili piá ampi<br />
obiettivi di crescita.” La necessitÖ di questo documento scaturisce dall'art. 4 della legge<br />
regionale 20/2001, relativa a "Norme generali di governo e uso del territorio" che ha<br />
inteso regolamentare la materia su tre livelli; quello regionale per mezzo del DRAG,<br />
provinciale per mezzo del PTCP e comunale con il PUG – PUE.<br />
In ottemperanza a quanto soprascritto il Comune di Foggia si Å dotato del Documento<br />
Programmatico Preliminare a firma del prof. F. Karrer, propedeutico alla formazione del<br />
PUG.<br />
3. Piano di Recupero zona Salice ( in corso di elaborazione ).<br />
4. Azioni di Bonifica Urbana–Protocollo d’intesa operativo tra AMICA e Comune di Foggia.
Altre Pianificazioni<br />
In applicazione del principio di pianificazione volontaria di recente si sono sviluppate altre forme<br />
di pianificazione. Il riferimento Å al piano di azione locale di cui all’Agenda 21 con il progetto<br />
Comunic@re e P@rtecipare , finanziato dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio,<br />
per la ComunitÖ di uno strumento di partecipazione capace di innescare sinergie sul tema della<br />
sostenibilitÅ ambientale, e a quella promossa dalla Provincia con l’Agenda 21 la Capitanata –<br />
Riflette quale processo strategico per incoraggiare e controllare lo sviluppo sostenibile.<br />
Tali paini costituiscono un utile riferimento per individuare risorse e indicare prospettive per la<br />
soluzione dei problemi.<br />
Art. 16 – Regolamento di attuazione del codice della strada.<br />
“.. la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi<br />
lateralmente alla strada, non puÜ essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per<br />
ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a m 6.<br />
La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare<br />
lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiori<br />
ad 1 m sul terreno non puÜ essere inferiore a 1m. Tale distanza si applica anche per le<br />
recinzioni non superiori a 1 m. costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e<br />
materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non<br />
oltre 30 cm dal suolo.<br />
La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare<br />
lateralmente alle strade siepi vive o piantagioni, di altezza superiori a 1m sul terreno, non<br />
puÜ essere inferiore a 3m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiori a<br />
1m sul terreno, costituite come previste al comma 7, e per quelle di altezza inferiore a 1m sul<br />
terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo. Le prescrizioni contenute nei<br />
commi 1 e 8 non si applicano alle opere e colture preesistenti.
L’ITER PROCEDURALE<br />
Il P.C.T. interessa tutte le aree tratturali all’interno del territorio comunale di Foggia in<br />
particolare i tratturi Aquila – Foggia, Celano – Foggia, Foggia Campolato, Foggia – Ofanto<br />
oltre a tutti i tratturelli, individuando e perimetrando dette aree in categoria come previsti dal<br />
comma 2 art. 2 della L.R. n. 29/2003.<br />
Il P.C.T. si propone di regolamentare e disciplinare i processi di trasformazione urbanistica<br />
finalizzati alla modificazione fisica in cui sia promossa la tutela e il mantenimento dell’identitÖ<br />
stessa e culturale delle aree tratturali il tutto per avere un processo di sostenibilitÖ territoriale.<br />
Il Piano Comunale Tratturi (P.C.T.) si configura quale “Piano Urbano Esecutivo P.U.E.” ed in<br />
quanto tale, ai sensi della vigente normativa regionale urbanistica, si identifica quale variante<br />
allo strumento urbanistico generale vigente P.R.G. (comma 3 art. 2 L.R.29/2003), lo stesso<br />
apporta le necessarie modifiche e variazioni al PUTT/P di cui agli articoli 5.06 e 5.07 (comma 4<br />
art. 2 L.R. 29/2003).<br />
Il P.C.T. si propone nell’ambito della pianificazione predisposta dal Comune di Foggia, quale<br />
strumento attuativo.<br />
Il P.C.T. Å adotatto ed approvato dal Consiglio Comunale, previo il rilascio dei pareri vincolanti<br />
della Regione Puglia, della Soprintendenza Archeologica e della Soprintendenza per i Beni<br />
Architettonici e per il Paesaggio, inoltre bisogna acquisire i pareri inerenti l’intero sistema di<br />
vincoli insistenti sulle aree oggetto del Piano.<br />
I pareri obbligatori sono:<br />
V.A.S. ( Valutazione Ambientale Strategica ):<br />
Direttiva 2001/42/CE<br />
la V.A.S., Å noto, ingegnerizza il principio di precauzione. Alla base vi Å la logica della<br />
sostenibilitÖ, non solo ambientale, ma anche sociale ed economica.<br />
D.L. n.152 del 3 aprile 2006 ( Norme in Materia Ambientale ): recepisce le prescrizioni<br />
ed indicazioni della Direttiva C.E. 2001/42.
Parere AutoritÑ di Bacino<br />
Il P.C.T. Å assoggettabile al parere preventivo da parte delle autoritÖ competenti in<br />
quanto dal Piano Stralcio per la Difesa Idrologica vi sono tratturi che attraversano zone<br />
ad alto rischio di inondazione.<br />
Parere Paesaggistico<br />
art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/p<br />
il piano Å soggetto a parere paesaggistico, per cui si dovrÖ dotare di idoneo parere da parte<br />
degli Enti preposti<br />
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
V.I. ( valutazione impatto ambientale )<br />
D.P.R. 120 /03<br />
I tratturelli Cervaro – Candela – S. Agata, Foggia – Ascoli – Lavello, Foggia – Ordona –<br />
Lavello, Foggia – Ofanto, attraversano l’area pSIC “ Valle del Cervaro – Bosco<br />
dell’Incoronata “ per cui il P.C.T. di cui all’art. 2 della L.R.29/03 Å assoggettabile a<br />
Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 120/03 per cui si dovrÖ dotare di idoneo<br />
parere da parte degli Enti preposti.
IL PROGETTO<br />
La L.R. n. 29 del 23 dicembre 2003 definisce i contenuti essenziali del Piano Comunale dei<br />
Tratturi. La perimetrazione delle aree tratturali fatta ai sensi dell’art. del comma 2 art. 2 L.R.<br />
29/2003 e l’indicazione delle aree annesse rappresenta il contenuto minimo del Piano.<br />
La legge divide le aree in tre categorie e precisamente:<br />
a) I tronchi armentizi che conservano l’originaria consistenza o che possono essere<br />
reintegrati, nonchÖ la loro destinazione in ordine alle possibili fruizioni turistico –<br />
culturali;<br />
b) I tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico,<br />
con particolare riguardo a quelle di strada ordinaria;<br />
c) I tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia.<br />
Il P.C.T. riguarda tutti i tratturi che attraversano il Comune di Foggia con la finalitÖ di<br />
suddividerli in categorie distinte:<br />
i tronchi tratturali di cui all’art. 2 comma 2 lett. a, della legge in narrativa, sottoposti a<br />
vincolo di inedificabilitÖ assoluta; per essi Å prevista la conservazione, tutela e<br />
valorizzazione da parte della Regione Puglia;<br />
i tronchi tratturali di cui all’art. 2 comma 2 lett. b e c, per i quali, previa delibera di G.R.<br />
di autorizzazione e sdemanializzazione possono essere ceduti e/o alienati a favore di<br />
enti locali , con vincolo permanente di destinazione, o a favore di soggetti privati previa<br />
valutazione del prezzo di alienazione.<br />
L’intento Å quello di<br />
o tutelare l’identitÖ storico – culturale del territorio<br />
o salvaguardare la pubblica utilitÖ<br />
o riqualificare il paesaggio.
Vi Å da dire che solo con il Documento Preliminare per la formazione del PUG si affronta il<br />
problema della salvaguardia della trama tratturale. Infatti il prof. Karrer ipotizza una<br />
pianificazione di decentramento concentrato; un decentramento che avviene all’interno<br />
dell’attuale area della cittÅ, o , con termini piÑ attuali, ci si potrebbe riferire al programma<br />
“ Smart Growth “ …. che punta sull’ equilibrio dei diversi usi del suolo allo scopo di creare<br />
senso di appartenenza e identitÅ, oltre che integrazione di funzioni, ….<br />
In merito alla rete tratturale dice:…. I tratturi sono la testimonianza dell’apertura della cittÅ verso<br />
la campagna ed i loro assi direttori potrebbero essere sfruttati per orientare l’allargamento della<br />
cittÅ verso l’esterno e verso luoghi abitativi giÅ prescelti in passato ed ora abbandonati ma<br />
comunque situati nella immediata periferia del nucleo centrale della cittÅ.<br />
Un’altra area da valorizzare nel territorio comunale Ç certamente l’identificato sito archeologico<br />
a nord del centro abitato che ancora non Ç stato sottoposto ad alcuna indagine conoscitiva….<br />
Il contributo di questo piano Å di fornire una tessera al mosaico della costruzione del territorio<br />
cercando di rispondere in maniera aderente allo spirito della legge.<br />
Il progetto dei percorsi tratturali coniuga le diverse esigenze tra antropizzazione e ambiente;<br />
esso interessa i seguenti tratturi:<br />
n. ordine<br />
( elenco dei tratturi, tratturelli, bracci e riposi estratto dalla G.U. del 23 aprile 1912 n.97. )<br />
tratturo<br />
tratturello<br />
braccio o<br />
riposo<br />
denominazione<br />
n.pianta<br />
generale<br />
COMUNI<br />
__________<br />
Km metri<br />
larghezza<br />
di fatto normale<br />
metri metri<br />
1 tratturo Aquila-Foggia 1 9 645 58-111 111 reintegra 1877<br />
2 tratturo Celano-Foggia 5 6 320 30-111 111 reintegra 1878<br />
3 tratturo Foggia-Campolato 12 10 010 111 111 reintegra 1875<br />
4 tratturo Foggia-Ofanto 14 14 009 111 111 reintegra 1876<br />
5 braccio Candelaro-Cervaro 15 11 518 111 111 reintegra 1877<br />
6 tratturello Foggia-Ciccallente 48 8 670 8,22 18,50 non reintegrato<br />
7 tratturello Foggia-Camporeale 32 5 830 3-4 27,75 non reintegrato<br />
8 tratturello Motta-Villanova 49 4 030 7,21 18,50 non reintegrato<br />
9 tratturello Foggia-Verzentino 44 7 422 8,29 27,75 non reintegrato<br />
10 tratturello Foggia-Zapponeta 42 13 595 5,27 27,75 non reintegrato<br />
11 tratturello Foggia-Tressanti-<br />
Barletta<br />
41 17 546 6,36 27,75 non reintegrato<br />
12 tratturello Foggia-Castiglione 45 11 450 6-14 18,50 non reintegrato
n. ordine<br />
tratturo<br />
tratturello<br />
braccio o<br />
riposo<br />
denominazione<br />
n.pianta<br />
generale<br />
COMUNI<br />
__________<br />
Km metri<br />
larghezza<br />
di fatto normale<br />
metri metri<br />
13 tratturello Troia-Incoronata 33 14 700 3-11,50 18,50 non reintegrato<br />
14 tratturello Foggia-Ordona-<br />
Lavello<br />
37 14 780 5-21 27,75 non reintegrato<br />
15 tratturello Foggia-Ascoli- 36 13 365 6,58 27,75 in corso di<br />
Lavello<br />
reintegra<br />
16 tratturello Cervaro-Candela-<br />
S.Agata di Puglia<br />
38 7 630 7-21 27,75 non reintegrato<br />
17 tratturello Foggia-Castelluccio<br />
dei Sauri<br />
35 15 530 7-22 18,50 non reintegrato<br />
18 tratturello Foggia-<br />
Sannicandro<br />
86 dati non disponibili non reintegrato<br />
L’elenco riporta le vie armentizie fino al nä 83 ( n. di pianta generale ) ed i riposi sino alla<br />
lettera H, pertanto non vi sono dati disponibili per i tratturelli allibrati oltre tale numero.<br />
1^ fase di studio<br />
Preliminarmente Å stata effettuata l’operazione di sovrapposizione tra le varie cartografie, con<br />
risultati attesi e per altri versi sorprendenti.<br />
Sovrapposizione catasto – aerofotogrammetria<br />
Non vi Å corrispondenza nella sovrapposizione per la filosofia di base nella costruzione<br />
della cartografia catastale; storicamente il catasto non essendo probatorio ha<br />
privilegiato l’aspetto fiscale rispetto alla precisione del disegno in termini planimetrici.<br />
Risultato atteso<br />
Sovrapposizione ortofotocarta – catasto<br />
Oltre a non corrispondere la sovrapposizione tra le due carte qui si nota come molti<br />
manufatti costruiti su suolo tratturale non sono stati accatastati, per cui nella situazione<br />
di fatto si dovranno applicare i provvedimenti previsti dalla norma………..<br />
Risultato non atteso<br />
Sovrapposizione catasto – cartografia storica dell’Ufficio Parco tratturi di Foggia<br />
Questa operazione ci ha permessi di integrare e ricostruire per altri versi percorsi non<br />
riconoscibili in area urbana antropizzata. Il risultato Å che la ricostruzione in centro<br />
urbano dei tratturi reintegrati Å stata un’operazione possibile, mentre per i tratturelli non<br />
reintegrati abbiamo ottenuto un duplice risultato:
Tratturelli in ambito extraurbano<br />
La larghezza dei tratturelli risulta differente da quanto riportato nella tabella estratta<br />
dalla Gazzetta Ufficiale ( cfr. tabella sopra riportata ) e dall’elenco dei tratturi e<br />
tratturelli esistenti agli atti dell’Ufficio Parco Tratturi di Foggia datato maggio 1984.<br />
La larghezza risulta a volte in eccesso e a volte in difetto. L’attuale situazione<br />
riportata nelle tavole allegate Å da considerarsi quale stato di fatto.<br />
Tratturelli in ambito urbano<br />
Per alcuni di essi non Å stato possibile la ricostruzione in ambito urbano per la<br />
mancanza di fonti storiche necessarie per avallare il tracciato.<br />
1 tratturello Foggia-Camporeale 32 ricostruzione parziale<br />
2 tratturello Foggia-Castelluccio dei Sauri 35 ricostruzione parziale<br />
3 tratturello Foggia-Ascoli-Lavello 36 ricostruzione parziale<br />
4 tratturello Foggia-Ordona-Lavello 37 ricostruzione totale<br />
5 tratturello Foggia-Tressanti-Barletta 41 ricostruzione totale<br />
6 tratturello Foggia-Zapponeta 42 ricostruzione totale<br />
7 tratturello Foggia-Castiglione 45 ricostruzione parziale<br />
8 tratturello Foggia-Sannicandro 86 ricostruzione totale<br />
La costruzione del territorio – il sistema dei parchi lineari<br />
Il progetto prevede il recupero delle sedi tratturali non compromesse al fine di costituire una<br />
trama di parchi lineari capaci di migliorare la visitabilitÖ e la leggibilitÖ dei tracciati e<br />
contemporaneamente promuovere un riuso compatibile del suolo ottenuto con il<br />
potenziamento del verde, dei percorsi pedonali e ciclabili.<br />
Gli interventi previsti rimandano ad un momento successivo la elaborazione di progetti di<br />
dettaglio.
I percorsi in ambito extraurbano<br />
Si possono evidenziare nell’ambito di un recupero regionale i seguenti percorsi:<br />
trama della rete storico - culturale<br />
Obiettivo di fondo di tale percorso Å di sensibilizzare la comunitÖ al valore storico-culturale<br />
esistente nel paesaggio e soprattutto del potenziale insito nei beni archeologici capaci di<br />
essere ancora una risorsa per la collettivitÖ.<br />
Il percorso collega attraverso le sole vie tratturali i parchi archeologici di Arpi, Ordona,<br />
Trinitapoli, S. Ferdinando di Puglia e Canosa . L’offerta Å variegata e va dalla scoperta di un<br />
misterioso popolo capace di realizzare sottoterra una serie di costruzioni stupefacenti, gli<br />
ipogei ( dei Bronzi, di Terre di Corte, Lagrasta , dell’Oplita e del Cerbero ecc. ), alle strutture<br />
tardoantiche del Foro di Ordona.<br />
La trama costituente tale percorso nel Comune di Foggia e formata dai seguenti tratturi:<br />
Foggia-Ciccallente ( parco Arpi ) – Foggia-Campolato – Foggia – Ordona – Lavello ( Domus<br />
Pantani e parco di Ordona )<br />
trama della rete religioso - devozionale<br />
Obiettivo di fondo di tale percorso Å di ricreare l’atmosfera mistica dei sentieri della fede che<br />
hanno accompagnato per secoli la vita dei pastori.<br />
Il percorso collega i grandi luoghi di culto della Daunia e precisamente:<br />
Santuario dell’Incoronata, Stignano, San Marco, San Giovanni Rotondo e Monte S. Angelo.<br />
In questo percorso vi sono due santuari sede dei protettori dei pastori, l’Arcangelo S. Michele<br />
e la Madonna Incoronata.<br />
La trama costituente tale percorso nel Comune di Foggia e formata dai seguenti tratturi :<br />
Si parte dal Santuario di Stignano e si prosegue sul tratturello Foggia – Sannicandro; si<br />
percorre un tartto urbano e si prosegue sul tratturello ( Foggia – Ordona – Lavello ) – al bivio<br />
si prende il tartturello ( Cervaro – Candela – S. Agata ) e si giunge al Santuario dell’Incoronata.<br />
Si puÜ proseguire sul braccio Candelaro – Cervaro per raggiungere il Santuario di Monte S.<br />
Angelo.
trama della rete ambientale<br />
Obiettivo di fondo di tale percorso Å quello di creare una coscienza ecologica, informare la<br />
comunitÖ sulla vulnerabilitÖ dei siti ( disboscamento, alterazione dell’equilibrio idrogeologico,<br />
carico antropico ecc. ) e sulle specie in via di estinzione.<br />
Il percorso collega i grandi boschi della Daunia - Faeto, bosco dell’Incoronata e il parco<br />
naturale del Gargano.<br />
La trama costituente tale percorso nel Comune di Foggia e formata dai seguenti tratturi :<br />
Si parte dal bosco di Faeto e si percorre in abito del territorio di Foggia il tratturello Troia –<br />
Incoronata. Proseguendo sul tratturello Foggia – Candela – S. Agata si immette sul tratturo<br />
Foggia – Ofanto e poi sul braccio Candelaro – Cervaro per arrivare alla foresta umbra.<br />
trama della rete insediativa<br />
Obiettivo di fondo di tale percorso Å quello di aumentare il grado di connettivitÖ viaria tra la<br />
cittÖ e i b<strong>org</strong>hi.<br />
La particolare disposizione radiale di questi ultimi favorisce i collegamenti sia con percorsi<br />
pedonali che ciclabili.<br />
La trama costituente tali percorsi si legge meglio nella planimetria di seguito riportata.
Struttura del parco lineare<br />
percorso<br />
Il parco lineare Å formato da due sedi stradali contigue e parallele; una per la bassa<br />
velocitÖ ( bici, mountain-bike, tricicli, carrozze per andicappati, carozzine ecc. ) e<br />
l’altra con sede naturale, per avvicinarsi il piá possibile ai tracciati originari detti a mazza<br />
battuta, solo pedonale.<br />
polo di scambio primario<br />
Sono spazi attrezzati con parcheggi per auto, attrezzature di ristoro, locali attrezzati per<br />
la manutenzione e il fitto di biciclette, e quant’altro occorre per un’adeguata fruizione<br />
dei percorsi. Questi in generale sono localizzati in ambito urbano in dipendenza del<br />
livello di antropizzazione del tratturo.<br />
polo di scambio secondario<br />
Sono spazi attrezzati con il solo parcheggio di auto e strutture atte a favorire<br />
l’interscambio con la fruizione pedonale, i mezzi di locomozione a bassa velocitÖ, a<br />
cavallo dei tracciati.<br />
Questi in generale sono localizzati in ambito extra urbano, in prossimitÖ dell’orbitale,<br />
poichà il segno tratturale in ambito urbano Å stato compromesso sia<br />
dall’antropizzazione che dalle alienazioni operate nel tempo.<br />
Aree attrezzate per la sosta ( riposi )<br />
Sono aree intermedie ( nodi del percorso ) poste lungo il tracciato idonee alla sosta e al<br />
ristoro. Sono costituite da uno spazio circoscritto ( piazzetta ) contornato su tre lati da<br />
muretti in materiale lapideo, sedute in pietra, pavimento lastricato , pannelli esplicativi,<br />
ombreggiatura ottenuta con alberi di alto fusto e/o con strutture lignee.<br />
Le aree verranno scelte in funzione della panoramicitÖ e delle peculiaritÖ proprie del<br />
posto ( es. incrocio fra trame ) e saranno denominate con i toponimi del posto
tratturello di 5 passi - planimetria tipo<br />
sezione tipo con pista ciclabile – percorso pedonale - riposo
Strutture per la continuitÑ dei percorsi<br />
Sono strutture tecnologiche atte a garantire la continuitÖ dei percorsi quando la<br />
discontinuitÖ Å data da intersezioni stradali, autostrade, fiumi, ecc.<br />
Normalmente si prevede una struttura a ponte, tecnologicamente realizzata con<br />
materiali naturali quali il legno lamellare e/o pietra se trattasi di piccoli manufatti. Il<br />
raggiungimento della quota avverrÖ nel rispetto delle norme per disabili e quindi con<br />
pendenza non superiore all’8%, e con rampa del tipo rettilinea o ad avvolgimento.<br />
elementi semantici<br />
Il recupero del sistema infrastrutturale Å supportato da una serie di segni, quali invarianti<br />
distintivi dei percorsi. Tra questi avremo:<br />
Marcatura dei bordi tratturali<br />
Compatibilmente con i vincoli descritti ( Art. 16 – Regolamento di attuazione del codice della<br />
strada ), i bordi tratturali verranno marcati con alberi e/o essenze tipiche dell’areale geografico<br />
( percorso visivo ). Il percorso a bassa velocitÖ verrÖ separato dal percorso pedonale con una<br />
siepe composta da cespugli misti tipo ( laurus nobilis, viburnus, mirtus, rosmarino, ecc.), tali<br />
da consentire ai non vedenti la riconoscibilitÖ del percorso dall’odore ( percorso olfattivo ) e<br />
contestualmente costituisce elemento di sicurezza rispetto alla pista ciclabile. Ove possibile i<br />
cespugli verranno impiantati anche tra il passo degli alberi.<br />
mirtus
Pavimentazione della pista ciclabile<br />
Rosmarino<br />
La pista avrÖ la larghezza minima di un passo napoletano e sarÖ trattata con asfalto<br />
pigmentato verde, al fine di non costituire un handicap e contemporaneamente<br />
mimetizzarsi con l’ambiente circostante.<br />
Trattamento del percorso pedonale<br />
Le sede pedonale sarÖ del tipo sterrato battuto e compattato ( terra salda ).<br />
Tecnologia delle aree di riposo<br />
Dimensioni dell’area: le dimensioni standard saranno 3piedi x 10piedi<br />
Muretti di ambito : sono costituiti da muretti a secco di altezza pari a 4 palmi<br />
Panchine : le sedute sono costituite da pietra bocciardata finemente<br />
Pavimento : formata da pietra locale a spacco di forma irregolare ( opus incerta )
Termine lapideo : rappresenta il punto di orientamento nello spazio aperto. Esso sarÖ<br />
costituito da un blocco in pietra di altezza pari a 2 piedi e dovrÖ riportare:<br />
o I dati dell’ente proprietario ( Parco Tratturi Regione Puglia )<br />
o Identificazione del tratturo<br />
o La distanza in unitÖ di misura vigente nel Regno Borbonico dal riferimento<br />
iniziale.<br />
Titolo lapideo : posto al’inizio e alla fine del percorso tratturale sarÖ caratterizzato da<br />
una costruzione a blocchi lapidei tipo tronco piramidale di altezza pari 7 piedi e porterÖ<br />
inciso:<br />
Sistema di misura<br />
o I dati dell’ente proprietario ( Parco Tratturi Regione Puglia ) e/o della regione di<br />
appartenenza ;<br />
o Identificazione del tratturo:<br />
o Il percorso tratturale con i dati significativi ( planimetria, larghezza, lunghezza,<br />
dislivelli ecc. )<br />
Il sistema di misura da usare nell’approccio progettuale Å lo stesso vigente nel Regno<br />
Borbonico .<br />
Di seguito si riportano i multipli e sottomultipli del sistema con l’equivalenza al sistema metrico<br />
decimale:<br />
multipli<br />
sottomultipli<br />
Miglio 1000 passi m. 1851.8521<br />
Corda 40 passi m. 74.074084<br />
Catena 10 passi m. 18.518521<br />
Passo UnitÑ di riferimento m. 1.8518521<br />
Piede * 2/11 passo cm. 33.6700<br />
Palmo 1/7 passo cm. 26.45502646<br />
Oncia ( Uncia ) 1/12 palmo = 1/84 passo cm. 2,2045<br />
* mensura huius passus est quinque pedum et dimidii.<br />
( Mario A. FIORE – Demani e usi civici nel Regno di Napoli – 2007 – ed. Comune di Torremaggiore )
CONCLUSIONI<br />
In sintesi si agirÖ con progetti mirati tenendo conto delle diverse suscettivitÖ che<br />
preliminarmente si possono individuare in:<br />
1. il parco dei tratturi<br />
2. i parchi archeologici<br />
3. recupero dei segni della civiltÖ pastorale ( masserie, abbeveratoi, poste ecc. )<br />
4. aumento del grado di connettivitÖ delle reti<br />
5. l’ambiente costruito<br />
6. la continuitÖ biotica<br />
Quello che viene in evidenza Å che la volontÖ di recupero di questo sistema infrastrutturale che<br />
ha dato vita a uno dei piá singolari insediamenti, deve confrontarsi oggi, per un’azione di tutela<br />
e di recupero compatibile in una disponibilitÖ economica in cui lo Stato non Å in grado di<br />
riversare molte risorse.<br />
Con queste premesse, si rende indispensabile, affrontare il tema del P.C.T. con un approccio<br />
di tipo sistemico dove il recupero possa essere effettuato partendo da due grosse<br />
considerazioni.<br />
La prima che tenga conto, nel recupero, di sviluppare risorse sostenibili offrendo le opportunitÖ<br />
agli operatori pubblici e privati di investire, privilegiando gli usi compatibili con le<br />
valorizzazione delle risorse locali.<br />
La seconda, per consentire una progettualitÖ coerente e veritiera, si dovrÖ affrontare il<br />
problema della perfetta identificazione dei tracciati indicandone lo stato di conservazione e il<br />
livello di compromissione al fine di avviare un processo di sviluppo coerente e sostenibile.<br />
Il progetto di dettaglio, pertanto, dovrÖ tenere conto del quadro legislativo – normativo<br />
nazionale, regionale e comunale, nonchà dei riferimenti storici.<br />
Il Piano Comunale dei Tratturi Å stato redatto con lo scopo di perimetrare le aree tratturali<br />
ricadenti tutte sul territorio comunale di Foggia le quali in parte risultano giÖ impegnate in<br />
misura consistente da interventi edilizi e di normare il loro utilizzo secondo le leggi vigenti e con<br />
l’obiettivo di tutelare e valorizzare in particolare quelle ancora libere.<br />
Le finalitÖ del P.C.T. sono perfettamente coerenti sia con quanto prescrivono i decreti<br />
ministeriali e sia con quanto prevede la pianificazione regionale
Il P.C.T. per sua natura si colloca a mezzo fra lo strumento urbanistico generale e i Piani<br />
Attuativi; pertanto gli interventi saranno definiti mediante l’attuazione di Progetti<br />
Particolareggiati.<br />
Come giÖ espresso nei punti precedenti, le finalitÖ del P.C:T. saranno quelle di adempiere alle<br />
prescrizioni provenienti dai Decreti Ministeriali e recepire quelle Regionali.<br />
Le motivazioni che spingono alla definizione di un sistema di perimetrazione delle aree<br />
interessate dal Piano sono supportate dai seguenti aspetti fondamentali:<br />
dato il particolare sistema tratturale che interessa il tessuto urbano di Foggia diventa<br />
fondamentale tutelare e valorizzare l’insieme del sistema stesso, nonostante sia evidente una<br />
eccessiva compromissione del tracciato.<br />
L’indirizzo di tutela e valorizzazione della rete tratturale deve essere sostenuta non solo<br />
dal Piano ma attraverso consistenti e puntuali atti progettuali tali da consentire una effettiva<br />
risposta .<br />
il P.C.T. dovrÖ individuare, per la tutela e la valorizzazione, azioni progettuali finalizzate<br />
alla eliminazione, per quanto possibile, degli usi impropri del sistema tratturale, di disciplinare<br />
gli usi ammissibili connessi con le attivitÖ turistico-culturali e agricole ed infine di migliorare,<br />
ove possibile, la leggibilitÖ dei tracciati e delle preesistente