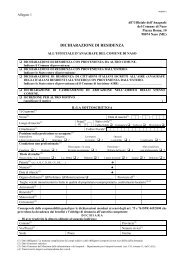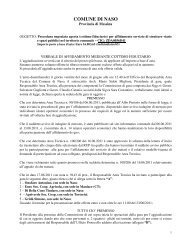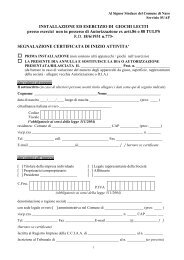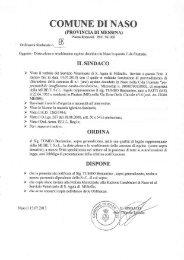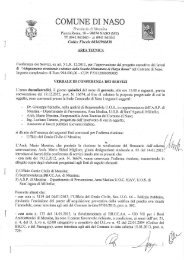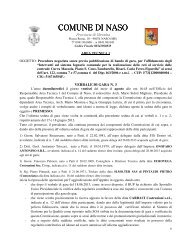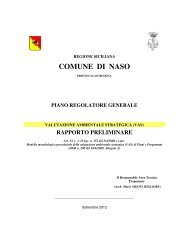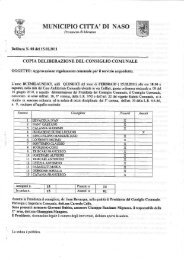l' acqua - Comune di Naso
l' acqua - Comune di Naso
l' acqua - Comune di Naso
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
CORSO<br />
INFORMATORE TURISTICO<br />
- CITTA’ <strong>di</strong> NASO -<br />
Esperienze sul Territorio<br />
A cura della Dott.ssa Vincenza MOLA
NEBRODI: ISOLA NELL'ISOLA<br />
TRIPUDIO DI COLORI.<br />
CONCERTO DI MELODIE, DI PROFUMI, DI SAPORI E<br />
DI SAPERI.<br />
UN MIX, QUESTO, CHE RENDE<br />
PERFETTO IL POLMONE DELLA<br />
SICILIA, NON UN LUOGO, MA IL LUOGO<br />
D'INCANTO, CHE ATTIRA UN TIPO DI<br />
TURISMO ALTERNATIVO, PIU'<br />
RICERCATO, SICURAMENTE<br />
CULTURALE.
LA CONSAPEVOLEZZA, LA CONOSCENZA E L’AMORE PER I TESORI<br />
ESISTENTI NEL PROPRIO PAESE E DI CONSEGUENZA PER I NEBRODI,<br />
SONO GLI ELEMENTI INDISPENSABILI PER POTER FAR AMARE ANCHE AI<br />
VISITATORI/TURISTI IL TERRITORIO.<br />
PER FAR CIO’ E’ INDISPENSABILE :<br />
• AMARE SE STESSI;<br />
• CONOSCERE LA STORIA;<br />
• CONOSCERE IL TERRITORIO ED IL TESSUTO SOCIALE;<br />
• LA CONSAPEVOLEZZA DEI BENI MATERIALI ED IMMATERIALI;<br />
• LA CONSAPEVOLEZZA DEI GIOVANI A NON ABBANDONARE IL PROPRIO<br />
PAESE, ANCHE A COSTO DI SACRIFICI, IN QUANTO SI PUO’ STARE BENE IN<br />
QUALSIASI PARTE DEL MONDO, MA LA MANCANZA DELLE RADICI E DEI<br />
FAMILIARI LASCIA UN VUOTO NEL PROPRIO CUORE.<br />
… CORAGGIO RAGAZZI DOPO UNA GRANDE DISCESA INIZIA LA RISALITA.
…SINAGRA
SINAGRA …
Il PAESAGGIO CULTURALE ovvero lo spazio, l’ambiente<br />
naturale trasformato e intessuto dalla profonda stratificazione <strong>di</strong><br />
attività <strong>di</strong> comunità umane che vi hanno impresso segni, forme,<br />
significati si manifesta con una pluriforme e multi<strong>di</strong>mensionale<br />
complessità. Non tutti gli elementi culturali che lo hanno<br />
composto nel tempo e vi persistono sono però imme<strong>di</strong>atamente<br />
percepibili e osservabili. Ciò vale soprattutto per la proiezione<br />
nel paesaggio <strong>di</strong> quelle <strong>di</strong>mensioni sacrali, simboliche, spirituali,<br />
mitiche in cui le comunità, nella profonda convinzione che la<br />
realtà non si esaurisca nel visibile, nel contingente, hanno nel<br />
corso dei secoli espresso e trasceso la loro peculiare identità.
Punto Panoramico Pizzo Corvo
Punto Panoramico Hotel Corvo
Punto Panoramico Forgia Vecchia
Punto Panoramico Zaccani<br />
Cancello Palazzo ex Salleo
1)Che percorso conoscitivo intraprendere per far riemergere allo<br />
sguardo, per decifrare nel visibile gli elementi or<strong>di</strong>nariamente<br />
invisibili del paesaggio culturale?<br />
2)Quali caratteristiche fisiche permettono talvolta ad un<br />
elemento del paesaggio <strong>di</strong> trascendere il contingente per<br />
assurgere a <strong>di</strong>mensioni trascendenti in cui la comunità alloca le<br />
proprie rappresentazioni ideologiche e spirituali ed in generale il<br />
proprio immaginario?
L’invisibile può essere colto – è la risposta che il lavoro<br />
vuole percorrere con una esperienza esemplificativa su due<br />
elementi ricorrenti nel territorio <strong>di</strong> Sinagra: le sorgenti, i<br />
palmenti,gli alberi monumentali, ecc - riconducendo le tracce e<br />
le forme fisiche non solamente alle fonti scritte ma soprattutto<br />
alla storia orale, alla testimonianza in un tentativo <strong>di</strong><br />
ricostruzione in termini <strong>di</strong>namici che faccia non solamente<br />
riemergere le generazioni <strong>di</strong> uomini, i protagonisti umili,<br />
invisibili, che il paesaggio hanno costruito in concorso con gli<br />
agenti naturali ma soprattutto far sì che il paesaggio o meglio i<br />
suoi segni tornino a parlare, a narrare storie, voci e canti <strong>di</strong><br />
donne, <strong>di</strong> uomini, <strong>di</strong> fanciulli.
La prima ricerca sul territorio ha riguardato le fontane/sorgenti <strong>di</strong> Sinagra che oggi<br />
hanno raggiunto il numero <strong>di</strong> 150. Quest’idea è scaturita in seguito al colloquio<br />
avuto con una turista romana rimasta stupita dal percorso lungo la Reggia<br />
Trazzera in C.da Patrì. Durante la passeggiata, immersa nel verde intenso dei<br />
noccioleti accompagnata dal canto delle cicale, la turista, ha raggiunto la fontana<br />
Rolletta dove poté gustare un’<strong>acqua</strong> fresca e leggera.<br />
A quel punto ho capito cosa cercano i turisti e nello stesso tempo ho pensato che<br />
anch’io mi dovevo svegliare e coinvolgere soprattutto i giovani in questi progetti.<br />
Fra i tanti, il primo esempio riguarda il Censimento, la Catalogazione e le Ricerche<br />
riguardanti le fontane <strong>di</strong> Sinagra.
Cascata in C.da Patrì<br />
(prop. Corica)
L'<strong>acqua</strong> è presente in ogni rappresentazione <strong>di</strong> uno spazio<br />
edenico. L'Acqua e la Vita che si manifesta in una vegetazione<br />
rigogliosa sono il connubio che caratterizza il Para<strong>di</strong>so<br />
terrestre, il giar<strong>di</strong>no, per eccellenza in cui la morte è assente.:<br />
"Poi il Signore Dio piantò un giar<strong>di</strong>no in Eden, a oriente [...]. Un<br />
fiume usciva da Eden per irrigare il giar<strong>di</strong>no" (Genesi, 2, 8-10).<br />
Queste forze archetipe e rigeneratrici rimarranno per secoli<br />
sino ai nostri giorni presenti presso le sorgenti e continuano<br />
ancora oggi a santificare le acque.
La <strong>di</strong>mensione dell’<strong>acqua</strong> come “sorgente <strong>di</strong> vita” è elemento<br />
tra<strong>di</strong>zionale ancora presente nella realtà <strong>di</strong> Sinagra e del più<br />
ampio comprensorio dei Nebro<strong>di</strong>.<br />
Basti pensare ai riti propiziatori e <strong>di</strong> purificazione che ancora si<br />
svolgono tra i nostri monti, esemplificativo quanto espresso dal<br />
“rito delle tre verginelle” (I tri virgined<strong>di</strong>) che richiamano in<br />
particolare nel territorio tra Ucria e Tortorici, un pellegrinaggio<br />
ad una fonte isolata tra le montagne dove – si crede – che se<br />
ci si immerge sì potrà godere <strong>di</strong> una particolare protezione<br />
sulla maternità.<br />
La festa si svolge la prima domenica <strong>di</strong> agosto presso una<br />
Chiesa nel feudo Acqua Santa, a quota 1300 m. sulla sponda<br />
destra del fiume Flascio, . A circa 600 m. più in alto si trova<br />
una cappelletta ( “a casotta”) composta <strong>di</strong> due vani. Nel primo<br />
è stato realizzato un pozzetto che contiene del<strong>l'</strong><strong>acqua</strong><br />
giallastra, verosimilmente sulfurea, che gorgoglia quando il<br />
pellegrino si inginocchia in preghiera con animo puro.
Nella seconda si trovano gli ex voto: trecce <strong>di</strong> capelli, nastri,<br />
abiti, stampelle ed altro. La casotta è stata costruita perché,<br />
come narra la leggenda, il Maligno massacrò in quel luogo tre<br />
giovani vergini uccidendone due e ferendo la terza che scampò<br />
al massacro solo per il pronto intervento del padre che si<br />
trovava poco lontano. Nel punto in cui le vergini caddero,<br />
avendo resistito alle insane voglie del <strong>di</strong>avolo, affiorò <strong>l'</strong><strong>acqua</strong><br />
miracolosa che i pellegrini, spesso, portano a casa in ampolle.<br />
Alla messa, un tempo, assistevano anche le verginelle (“i<br />
virgined<strong>di</strong>”); ragazze in numero <strong>di</strong>spari e non in età <strong>di</strong> peccato<br />
che vestivano una tunica nera e corona <strong>di</strong> fiori alla testa.
Provvedeva al loro trasporto e a fornirle <strong>di</strong> quanto<br />
necessario nella giornata colui che aveva fatto il voto, <strong>di</strong><br />
solito proveniente dai paesi <strong>di</strong> Tortorici, Randazzo,<br />
S.Domenica Vittoria, Floresta, Montalbano, Bronte,<br />
Maletto, Acireale ed altri ricadenti nel<strong>l'</strong>ambito del Parco dei<br />
Nebro<strong>di</strong> e del<strong>l'</strong>Etna.<br />
Sicché il 5 Agosto <strong>di</strong> ogni anno parte “il viaggio” per<br />
rinver<strong>di</strong>re il valore antico dell’<strong>acqua</strong> nel ruolo e nel<br />
significato che la tra<strong>di</strong>zione le riconosce e che solo la<br />
metodologia etnostorica con il suo valore interpretativo<br />
della tra<strong>di</strong>zione può mettere in evidenza.
TRE VERGINEDDI
Simbologia dell’<strong>acqua</strong><br />
L’<strong>acqua</strong> è elemento cosmogonico per eccellenza. Entità<br />
senza Forma, precede in molte tra<strong>di</strong>zioni il nostro mondo,<br />
ovvero la Forma plasmata e or<strong>di</strong>nata da Dio..Lo Spirito <strong>di</strong><br />
Dio, prima della creazione, aleggia infatti nel mondo ebraico<br />
sulle acque (Genesi, 1, 2); e allo stesso modo, nei Veda<br />
del<strong>l'</strong>induismo <strong>l'</strong>Origine <strong>di</strong> tutto è in una <strong>di</strong>stesa d'<strong>acqua</strong> senza<br />
luce. Così anche Oceano è nella cosmogonia dei greci il<br />
Principio primor<strong>di</strong>ale da cui sono generati e gli dei e gli<br />
uomini e ogni essere vivente e cosa..<br />
Quando il tempo esaurisce le forze della natura, queste per<br />
attingere <strong>di</strong> nuovo la potenza della vita devono tornare a<br />
sciogliersi nel loro principio ovvero .<strong>l'</strong><strong>acqua</strong>, che in questo<br />
modo si rivela garanzia della perennità della vita.
Strumento creatore, <strong>di</strong> rigenerazione, taumaturgico, salvifico.<br />
la proprietà <strong>di</strong> fecondare, <strong>di</strong> guarire grazie agli elementi<br />
fondamentali in essa contenuti consustanziali ad ogni processo<br />
<strong>di</strong> creazione.<br />
L'<strong>acqua</strong> purifica e rigenera,<br />
Nel Cristianesimo <strong>l'</strong><strong>acqua</strong> viene usata per purificare e<br />
rigenerare il fedele, non in una prospettiva terrestre, ma per la<br />
vita eterna Il segno sacramentale del battesimo sancisce con<br />
forza definitiva la reversibilità della morte nella vita, L'<strong>acqua</strong><br />
dona dunque la vita attraverso la morte come <strong>l'</strong>esperienza<br />
delle civiltà agricole ha insegnato per millenni.<br />
Vi è indubbiamente un ambivalenza del<strong>l'</strong><strong>acqua</strong> che si presenta<br />
come lo strumento della prosperità e anche come forza<br />
<strong>di</strong>struttiva.
Le acque” <strong>di</strong> Beniamino Ioppolo<br />
Personalità poliedrica e singolare <strong>di</strong> letterato e <strong>di</strong> artista,<br />
Beniamino Joppolo, nato a Patti ma <strong>di</strong>scendente da una<br />
famiglia dell’aristocrazia terriera <strong>di</strong> Sinagra, trascorse proprio<br />
nel centro nebroideo l’infanzia e gli anni formativi<br />
dell’adolescenza e della giovinezza prima <strong>di</strong> proiettarsi con<br />
successo nella cultura del Novecento europeo..<br />
Nella comme<strong>di</strong>a in due atti “Le acque” del 1963 l’<strong>acqua</strong><br />
assurge ad una <strong>di</strong>mensione cosmogonica che abbraccia<br />
ineluttabilmente tutti i protagonisti accomunandoli in un destino<br />
<strong>di</strong> perenne <strong>di</strong>struzione e rinascita. Para<strong>di</strong>gmatico il titolo del<br />
primo atto “L’<strong>acqua</strong> si <strong>di</strong>verte ad uccidere”.Le acque si rivelano<br />
infatti al contempo nella loro <strong>di</strong>mensione i<strong>di</strong>lliaca, “con<br />
dolcezza”, ritagliata dall’autore nel paesaggio agreste <strong>di</strong> Santa<br />
Maria Xilona da lui ben conosciuto fatto <strong>di</strong> “rocce ricoperte da<br />
muschio ed erba”, ad<strong>di</strong>rittura scherzosa “le acque arrivavano<br />
come signorine ridenti e danzanti, piano in declivio,
si buttavano tra le braccia del fiume, il fiume se le beveva tutte<br />
e andava avanti sempre più grande, finché dolcemente non<br />
allargava le braccia ed allagava tutto quello che gli capitava<br />
sotto mano”. L’<strong>acqua</strong> è però anche pericolo, preannuncio <strong>di</strong><br />
apocalisse incombente “il penultimo alluvione -cioè l’ultimo<br />
prima <strong>di</strong> questo, ha scar<strong>di</strong>nato il penultimo sostegno <strong>di</strong> questo<br />
nostro casamento. Il casamento è curvo, piegato tra terra,<br />
<strong>acqua</strong>, cielo, aria e burrone.” L’acque è infine morte e<br />
preannuncio <strong>di</strong> perenne rigenerazione del cosmo cui l’uomo<br />
deve sottomettersi rassegnato, nella convinzione nella caducità<br />
delle cose della vita e della transitorietà del suo epilogo nella<br />
morte e La morte è preferibile in ogni caso alla carità “pelosa”,<br />
<strong>di</strong>etro cui gli uomini nascondono la loro meschineria ed il loro<br />
cinismo “se fossimo sopravvissuti – <strong>di</strong>ce una nonna al termine<br />
del primo atto <strong>di</strong> Le acque-, qualche
anima pia si sarebbe preoccupata <strong>di</strong> farci pervenire<br />
qualche biglietto da mille!”. Che cosa possono essere pochi<br />
biglietti da mille <strong>di</strong> fronte all’incessante trasformazione del<br />
cosmo? Eppure le cose del mondo abbruttiscono l’uomo<br />
nelle pratiche <strong>di</strong> vessazione inutile, sor<strong>di</strong>da, meschina del<br />
proprio simile che l’autore trascende ad una <strong>di</strong>mensione<br />
universale nella narrazione nel secondo atto “L’<strong>acqua</strong> si<br />
<strong>di</strong>verte a far morire <strong>di</strong> sete” <strong>di</strong> una vicenda ricorrente nelle<br />
campagne della sua Sinagra, il topos del ricco proprietario<br />
terriero che riesce grazie al <strong>di</strong>ritto e ai tribunali , “con la<br />
protezione della santa legge dei carabinieri, dei moschetti e<br />
delle baionette…”, ad appropriarsi del bene comune<br />
costituito dall’<strong>acqua</strong>. Il <strong>di</strong>ritto piegato per sancire la vittoria<br />
del più ricco.
BENIAMINO JOPPOLO
L’ ACQUA<br />
Se si vuole affrontare il tema dell’<strong>acqua</strong> si può scrivere un grosso libro, poiché la sua<br />
avventura è nata assieme alla creazione dell’Universo e della vita sul Pianeta Terra.<br />
Per cominciare dalle origini bisogna ricorrere alla creazione.<br />
Il secondo giorno Dio creò l’<strong>acqua</strong> separando quella che sta sopra e sotto il cielo.<br />
Il terzo giorno Dio chiamò Terra l’asciutto e Mare l’<strong>acqua</strong> - sicchè le acque piovane dessero<br />
risorse alle piante fruttifere e agli animali esistenti sulla Terra -.<br />
San Francesco d’Assisi nel “Cantico delle Creature” la chiamò “Sorella Acqua”; il Carducci la<br />
decanta “Nelle fonti del Clitunno”.<br />
E’ un elemento che si presta a tutti gli usi domestici e per le esigenze della campagna. Non ha<br />
forma e colore, prende la forma dal recipiente che la contiene. Non è composta <strong>di</strong> solo liquido,<br />
ma contiene molte sostanze; è <strong>di</strong>visa in molte categorie. L’<strong>acqua</strong> che noi consumiamo<br />
proviene dall’<strong>acqua</strong> piovana che s’infiltra nella terra e fuoriesce dalle falde freatiche. Noi<br />
“Siciliani” dobbiamo, in parte, l’uso dell’ <strong>acqua</strong> agli Arabi che dominarono la Sicilia dall’827 fino<br />
al 902. Dal loro dominio la Sicilia trasse gran<strong>di</strong> vantaggi economici, per la sua posizione<br />
geografica. Non ebbe mai, nella sua storia, maggiore splendore culturale ed economico. Difatti<br />
i nomi che parlano dell’<strong>acqua</strong> sono spesso <strong>di</strong> origine araba. Dove mancavano le sorgenti, che<br />
gli arabi chiamavano “Favare”, hanno scavato dei pozzi profon<strong>di</strong> chiamati “Senia” mettendovi<br />
dentro un marchingegno composto da rulli e una lunga catena <strong>di</strong> secchi azionata da una trave<br />
<strong>di</strong> legno, che, girando portava l’<strong>acqua</strong> in superficie. La catena <strong>di</strong> secchi si chiamava “Noria”.<br />
Oggi non c’è più bisogno <strong>di</strong> questi congegni in quanto l’<strong>acqua</strong> viene portata in superficie da<br />
motori elettrici. L’<strong>acqua</strong> in passato venne definita “Siero” e “Plasma” del nostro corpo, che, in<br />
parte è anche composto d’<strong>acqua</strong> per ben il 70%.
Noi, a Sinagra, non abbiamo bisogno <strong>di</strong> questi congegni, poiché nel territorio esteso per Ha 2,392 abbondano<br />
le sorgenti che superano il fabbisogno citta<strong>di</strong>no. Sarebbe arduo pensare <strong>di</strong> contare le sorgenti da confine a<br />
confine. Bisogna ricordare che la nascita delle prime civiltà sia stata legata alla presenza <strong>di</strong> corsi d’<strong>acqua</strong>.<br />
L’uomo col progre<strong>di</strong>re della civilizzazione, della cultura e delle scienze ha riconosciuto nell’<strong>acqua</strong><br />
innumerevoli proprietà, tanto che nell’antichità le sono state attribuite virtù magiche. Prima i Greci, poi i<br />
Romani, scoperte le <strong>di</strong>verse qualità dell’<strong>acqua</strong> istituirono le “Terme” sfruttando il contenuto degli elementi<br />
positivi per curare i mali del corpo. Dall’atmosfera i flui<strong>di</strong> delle acque meteoriche si infiltrano nel terreno in<br />
profon<strong>di</strong>tà arricchendolo con <strong>di</strong>verse sostanze. Quando riemergono dalle sorgenti, se hanno particolari<br />
caratteristiche <strong>di</strong> temperatura, e <strong>di</strong> contenuto in minerali, vengono chiamate “acque termali”.<br />
Le acque vengono classificate secondo la quantità <strong>di</strong> sali <strong>di</strong>sciolte, la durezza, in funzione del contenuto <strong>di</strong><br />
sali <strong>di</strong> calcio e <strong>di</strong> magnesio. A seconda della temperatura con la quale emergono dal terreno, si <strong>di</strong>stinguono<br />
in: fredde, ipotermali, termali ed ipertermali. Le cure a cui queste acque si prestano sono <strong>di</strong>verse in base alle<br />
proprietà specifiche: idropinoterapia, balneoterapia e fangoterapia.<br />
L’<strong>acqua</strong> è un elemento fondamentale del nostro organismo. Provvede, infatti, all’idratazione dei tessuti e<br />
svolge un ruolo per il trasporto e la depurazione organica e la termoregolazione. Per svolgere queste funzioni<br />
è necessario che le sue caratteristiche <strong>di</strong> purezza e leggerezza siano abbinate ad una ridotta quantità <strong>di</strong><br />
minerali per un buon funzionamento organico. Infatti, l’apporto <strong>di</strong> minerali nel nostro organismo viene<br />
compensato da frutta e verdura che garantiscono sali in quantità facilmente assimilabili. Questo importante<br />
valore in un’<strong>acqua</strong> depurativa adatta ad enfatizzare tutti i sistemi <strong>di</strong> trasporto del corpo (sangue, linfa) e per la<br />
funzionalità dei vari organi (fegato, reni, milza, pelle) deve essere inferiore a 30/40 ml. In pratica più basso è il<br />
residuo fisso più leggero è l’<strong>acqua</strong>. A questo punto parliamo dell’<strong>acqua</strong> minerale o da tavola. Le bottiglie,<br />
apparentemente uguali possono avere contenuti molto <strong>di</strong>versi, perché ogni <strong>acqua</strong> si <strong>di</strong>stingue per origine e<br />
contenuto. La sua <strong>di</strong>stinzione si fa in base al residuo fisso, cioè agli elementi minerali presenti (per litro) nelle<br />
etichette. Si <strong>di</strong>vidono in oligominerali, con residuo fisso inferiore a 0,2 g per litro; me<strong>di</strong>o minerali da 0,2 g a 1g<br />
per litro e minerali uguale o superiore ad 1g per litro. L’<strong>acqua</strong> contiene nel suo interno piccole quantità <strong>di</strong><br />
particelle <strong>di</strong> so<strong>di</strong>o, calcio, magnesio, cloro e anche lievi tracce <strong>di</strong> metalli come ferro, rame, manganese cromo<br />
e cobalto.<br />
Vi si trovano pure piccole quantità <strong>di</strong> gas, tra i quali anidride carbonica, azoto e ossigeno. Gli esperti <strong>di</strong>vidono<br />
in otto categorie le qualità dell’<strong>acqua</strong>, che servono a curare frequenti <strong>di</strong>sturbi del nostro organismo.
L’<strong>acqua</strong> è stata sempre sfruttata dall’uomo non solo per <strong>di</strong>ssetarsi, cucinare e fare pulizia, ma il<br />
genio umano ne ha sfruttato anche la forza creando, prima <strong>di</strong> tutto, i vecchi mulini ad <strong>acqua</strong>. Poi<br />
con le gran<strong>di</strong> cascate ha creato l’energia elettrica. Nel nostro paese un tempo abbondavano i<br />
mulini ad <strong>acqua</strong>. Dal mulino <strong>di</strong> San Giovanni ai confini con <strong>Naso</strong> e Brolo vi erano 18 mulini. In<br />
questo scorcio <strong>di</strong> tempo, ci limitiamo a presentarne uno. Alcuni mulini hanno cambiato<br />
destinazione, ma alcuni sono rimasti intatti e privi <strong>di</strong> ogni cura. Da noi esiste ancora intatto il<br />
mulino <strong>di</strong> “Torretta”. Approfittiamo per <strong>di</strong>mostrare il suo antico funzionamento: l’<strong>acqua</strong> per<br />
questo mulino si prelevava dal fiume sotto la piazza del Paese e, con un lungo canalone, veniva<br />
al <strong>di</strong> sopra del mulino affluendo nella cosiddetta “Orna” affianco della quale c’era la “Saitta”, (una<br />
lunga torretta con tre alti scalini dentro la quale un lungo buco faceva scendere l’<strong>acqua</strong> sotto la<br />
sede del mulino). L’<strong>acqua</strong> si maneggiava con una trave che all’estremità aveva lo stoppino.<br />
Quando la orna era piena si apriva la saitta e l’<strong>acqua</strong> usciva veloce sbattendo su una ruota a<br />
pale nella quale vi era messa una trave che corrispondeva con la macina superiore del mulino,<br />
questa girava su se stessa e macinava il grano, o altro cereale. La farina veniva subito<br />
insaccata. Le ruote del mulino erano due: quella inferiore fissa e quella superiore semimovente.<br />
Il grano cadeva a fontanella dalla “Tremoggia”, un arnese <strong>di</strong> legno collegato con un’asta alla<br />
macina, la quale, tremolando, faceva uscire il grano. A quanto pare questo mulino è ancora<br />
esistente in tutte le sue parti e porta la data della sua costruzione. Le macine girando si<br />
consumavano e, <strong>di</strong> tanto in tanto, dovevano essere martellate per rifare le righe che<br />
permettevano “il macinato” e venivano ripassate con una speciale “martellina”.<br />
PROF. FRANCESCO MUSCA
ALLE SORGENTI DI FONTALBA E SANTALBA<br />
L’<strong>acqua</strong> liquido organico<br />
è l’opulenza della terra<br />
d’uso domestico e igienico<br />
s’usa nel giar<strong>di</strong>no e nella serra.<br />
Fu cantata dall’aedo antico<br />
dai poeti e dai santi,<br />
<strong>di</strong>sseta il terreno aprico<br />
i poveri, i ricchi e i viandanti,<br />
limpida l’<strong>acqua</strong> scroscia e suona<br />
nascendo alle falde d’un pizzo<br />
presso Montalbano d’Elicona.<br />
Nell’alveo del torrente Mellisso.<br />
Fra quei monti d’un verde faso<br />
vai alla sera o all’alba<br />
bevi alla fonte Lagrimusco<br />
alle sorgenti Fontalba e Santalba.<br />
Per la cura dei calcoli renali,<br />
il fegato e la famosa gotta<br />
bevi <strong>di</strong> queste acque oligominerali<br />
nei pressi del bosco <strong>di</strong> Malabotta.<br />
In un magnifico scenario<br />
esteso tra Nebro<strong>di</strong> e Peloritani<br />
Vedesi Tindari e il Calvario<br />
e orizzonti ancor più lontani.<br />
Qui le sorgenti conclamate<br />
siti tra boschi e noccioleti<br />
sono veramente rinomate<br />
e i consumatori fanno lieti.<br />
Sparso l’odore <strong>di</strong> fiori montani<br />
tra scampanìo <strong>di</strong> greggi e <strong>di</strong> cavalli<br />
unito alle voci dei mandriani<br />
echeggia l’eco tra le convalli.<br />
Qui la natura pro<strong>di</strong>ga profuse<br />
vedute stupende, paesaggi incantati<br />
e assieme alle acque vi profuse<br />
aperti orizzonti e luoghi incontaminati .<br />
La solubilità dell’aria quieta<br />
la purezza dell’<strong>acqua</strong> montana<br />
rendono quassù l’anima lieta<br />
a chi si <strong>di</strong>sseta alla fontana.<br />
Sinagra 10 Febbraio 1977
“ Proverbi ”<br />
Innaru siccu<br />
massaru riccu.<br />
Marzu chiovi chiovi<br />
Aprili non vinni ‘nfini<br />
a Maiu una sula<br />
pi lavari li risini.<br />
Acqua <strong>di</strong> giugnu<br />
consuma lu munnu<br />
no alivi e sorba<br />
e no castagni a furnu.<br />
Acqua d’Austu<br />
ogghiu, meli e mustu.<br />
La pioggia autunnali<br />
fa beni e non fa mali.<br />
Quannu chiovi e nivica<br />
l’omu non fa fatica.<br />
I due compari<br />
Uno era andato a visitare l’altro, si mise a<br />
piovere e lui resto dentro,<br />
allora il compare ospitante:<br />
- “ quannu chiovi e malutempu faci amaru<br />
cu ‘nta casa <strong>di</strong> l’autru ci staci.”<br />
Risponde il compare:<br />
“ quannu chiovi lassa chioviri si ssi intra<br />
non ti moviri.”<br />
E non uscì<br />
L’<strong>acqua</strong> lustrale, quale sorte<br />
con noi dal battesimo alla morte.<br />
Pa ‘Mmaculata<br />
a nivi ‘nta faddalata.<br />
Sinagra 19 Dicembre 2004<br />
Prof. Francesco Musca
VASCHE E CANALETTE<br />
Per irrigare i giar<strong>di</strong>ni dove mancavano le sorgenti i proprietari chiedevano al Demanio<br />
l’autorizzazione per usare le acque perenni dei torrenti. Autorizzati provvedevano a costruire<br />
lunghe cunette, così l’<strong>acqua</strong> arrivava nelle vasche poste sempre a monte dei giar<strong>di</strong>ni. Le<br />
vasche venivano costruite secondo l’ampiezza del giar<strong>di</strong>no sottostante. Queste opere, anche<br />
se non più usate, esistono ancora nelle nostre campagne. Richiamo appositamente un solo<br />
esempio – A Ballica o Bad<strong>di</strong>ca esiste tutt’ora una vasca lunga <strong>di</strong>eci metri, larga circa quattro<br />
metri e alta più <strong>di</strong> tre.<br />
L’<strong>acqua</strong> entrava da un lato e dall’altro usciva. Le vasche, nell’agricoltura, servivano non solo<br />
come accumulo <strong>di</strong> acque, ma anche per farle riscaldare all’aria aperta. Nelle nostre campagne<br />
ci sono, tutt’ora, vasche e cunette <strong>di</strong> tutte le <strong>di</strong>mensioni. A proposito ricordo che un tale nel<br />
suo podere aveva la fornace, e per trasportare l’<strong>acqua</strong> si fece la forma e poi appositi canalini<br />
che sfruttavano il trasporto in profon<strong>di</strong>tà. La maggior parte <strong>di</strong> questi canali erano costruiti in<br />
pietra, ma c’erano anche con le tegole, la lunghezza variava da più <strong>di</strong> un km. a poche<br />
centinaia <strong>di</strong> metri. Vicino ogni cunetta vi era un viottolo per la manutenzione .<br />
A Cura del<br />
Prof. Francesco Musca
COME SI FACEVA IL BUCATO UNA VOLTA<br />
Il bucato è sempre esistito usando i mezzi allora esistenti. Non c’era l’energia elettrica e<br />
le moderne “lavatrici!”, quin<strong>di</strong> si lavava la biancheria con <strong>acqua</strong> e sapone, poi si<br />
sistemava in un cestone <strong>di</strong> verga e sopra si metteva uno straccio, a fianco si bolliva<br />
l’<strong>acqua</strong> e si preparava una buona dose <strong>di</strong> cenere pulita. Sull’orlo <strong>di</strong> ogni vasca vi erano<br />
pietre lisce che servivano per lavare la biancheria.<br />
Quando l’<strong>acqua</strong> era pronta assieme alla cenere si versava in quel cestone e si lasciava<br />
tutta la notte. La mattina seguente si sci<strong>acqua</strong>va e si stendeva al sole.<br />
La biancheria così lavata lasciava un odore particolare .<br />
Da ricordare che la cenere contiene la “Potassa” che usata in percentuale nei concimi<br />
chimici composti come fertilizzante, ma secondo me, contiene altri elementi che vanno<br />
bene come detersivo.<br />
Prof. Francesco Musca
COME NASCONO LE SORGENTI …<br />
Parte dell’<strong>acqua</strong> piovana che giunge sulla superficie terrestre viene trattenuta (<strong>acqua</strong><br />
capillare). Quando <strong>l'</strong><strong>acqua</strong> ha riempito tutti gli spazi liberi, il terreno è saturo e <strong>l'</strong><strong>acqua</strong> che<br />
continua ad arrivare filtra negli strati sottostanti dove può incontrare un terreno <strong>di</strong> tipo <strong>di</strong>verso<br />
o uno strato <strong>di</strong> rocce. Anche le rocce possono trattenere <strong>l'</strong><strong>acqua</strong> o lasciarla filtrare. L'<strong>acqua</strong><br />
così continua a scendere in profon<strong>di</strong>tà spinta dalla forza <strong>di</strong> gravità impregnando i vari strati<br />
fino a quando incontra uno strato impermeabile. A questo punto si accumula. Se lo strato<br />
impermeabile è in pen<strong>di</strong>o <strong>l'</strong><strong>acqua</strong> scorre lentamente ma se incontra una conca la riempie ed<br />
imbeve lo strato <strong>di</strong> terreno sovrastante. Si forma così una falda acquifera che può estendersi<br />
per molti chilometri e terminare in un fiume o in un lago o <strong>di</strong>rettamente nel mare. Quando la<br />
parte superficiale della falda interseca il profilo del terreno, l’<strong>acqua</strong> emerge sotto forma <strong>di</strong><br />
sorgente. Le sorgenti sono classificate anche in base alla natura dei passaggi nei quali scorre<br />
<strong>l'</strong><strong>acqua</strong>. La composizione delle sorgenti <strong>di</strong>pende dal carattere del territorio e delle rocce<br />
circostanti, mentre la portata può venire determinata dalla stagione e dalla quantità <strong>di</strong><br />
pioggia. L’<strong>acqua</strong> <strong>di</strong> falda e <strong>di</strong> sorgente durante il contatto con le rocce del sottosuolo si<br />
arricchisce <strong>di</strong> sali grazie al suo potere solvente. Le acque provenienti da grande profon<strong>di</strong>tà<br />
sono chimicamente e biologicamente pure; spesso sono dotate <strong>di</strong> proprietà terapeutiche e<br />
vengono in<strong>di</strong>cate come acque minerali. Acque sotterranee e sorgenti rappresentano<br />
un’importante riserva <strong>di</strong> <strong>acqua</strong> potabile che deve essere gestita in modo razionale e deve<br />
essere protetta dalle varie forme d’inquinamento che la minacciano. L’<strong>acqua</strong> è un bene<br />
prezioso per la vita. Solo quando viene a mancare, e quando non è utilizzabile, solo allora si<br />
comprende la vali<strong>di</strong>tà e si scoprono il valore e l’importanza; l’<strong>acqua</strong> è essenziale, per questo<br />
deve essere rispettata, tutelata, <strong>di</strong>fesa, valorizzata, non <strong>di</strong>spersa, bene impiegata ed<br />
utilizzata.
Un tempo l’ importanza <strong>di</strong> queste sorgenti era fondamentale per lo svolgimento <strong>di</strong> tutte le<br />
attività della vita quoti<strong>di</strong>ana era grazie ad esse, infatti, che si provvedeva all’ irrigazione dei<br />
campi, all’abbeveramento degli animali, nonché all’impiego domestico. La necessità “ <strong>di</strong> iri<br />
all’<strong>acqua</strong>” nasceva dalla sua mancanza nelle abitazioni per questo era consuetu<strong>di</strong>ne riunirsi<br />
in gruppo e recarsi alla sorgente “ cu bumbulu” e “ ca quartara”.<br />
Vennero così costruite delle fontane lungo le stra<strong>di</strong>ne mulattiere che erano anche un punto<br />
<strong>di</strong> riferimento per i viaggiatori dove bere e riposarsi.<br />
Ancora oggi esistono moltissime <strong>di</strong> queste antiche fontane, sparse nelle varie contrade,<br />
quasi tutte in pietra e simili nella forma. Accanto si trovano spesso delle gran<strong>di</strong> vasche o<br />
“gibbie” fornite <strong>di</strong> lavatoio dove le donne si recavano per lavare i panni.<br />
A tutto oggi alcune <strong>di</strong> queste fontane vengono sfruttate per uso potabile e per irrigare i<br />
campi, ma è importante non <strong>di</strong>menticare che si tratta <strong>di</strong> un bene inestimabile da custo<strong>di</strong>re e<br />
rivalutare come testimonianza <strong>di</strong> un ritaglio <strong>di</strong> storia del nostro paese.
Fiume Torrente <strong>Naso</strong>
I RABDOMANTI<br />
Come si in<strong>di</strong>vidua l’<strong>acqua</strong>.<br />
Il metodo utilizzato consiste nel tenere tra le <strong>di</strong>ta una bacchetta <strong>di</strong><br />
legno non molto grande, che presenta una forma <strong>di</strong> V, questa<br />
bacchetta inizia dapprima ad oscillare e poi a ruotare velocemente<br />
quando nel terreno incontra l’<strong>acqua</strong>.<br />
Si procede lungo il tragitto seguendo i movimenti <strong>di</strong> questa bacchetta,<br />
che cessa <strong>di</strong> ruotare quando non c’è più <strong>acqua</strong> nel sottosuolo.<br />
A questo punto il sig. Stasio , misurando la <strong>di</strong>stanza percorsa e<br />
<strong>di</strong>videndo a metà la lunghezza del tragitto dove c’è l’<strong>acqua</strong>, riesce a<br />
stabilire la profon<strong>di</strong>tà dell’<strong>acqua</strong>.<br />
Posizionandosi sul punto me<strong>di</strong>o dove la corrente dell’<strong>acqua</strong> è più<br />
intensa, con un piombo collegato ad un filo lungo circa 40 cm, inizia a<br />
farlo girare e ogni giro corrisponde ad un metro <strong>di</strong> profon<strong>di</strong>tà, quando<br />
raggiunge il punto dell’<strong>acqua</strong> il piombo ruota sempre più velocemente<br />
e contando i giri si stabilisce la sua profon<strong>di</strong>tà, mano a mano che si<br />
allontana dall’<strong>acqua</strong>, il piombo perde la forza rotante fino a fermarsi.
Rabdomante Stasio Carmelo
Rabdomante Basilio Cianciana
Quando ha scoperto questa facoltà<br />
Le gallerie <strong>di</strong> captazione<br />
costruzione <strong>di</strong> muretti <strong>di</strong> spalla a secco in pietra locale, alti<br />
circa 1,80 m, su cui poggiava la copertura a cappuccina, in<br />
<strong>di</strong>aletto “a forbice”, della galleria, costituita da lastre <strong>di</strong> pietra<br />
larghe circa 40-60 cm. All’interno della galleria l’<strong>acqua</strong><br />
scorreva, se il terreno era argilloso, in un solco scavato nella<br />
terra ovvero, negli altri casi, in un canale in cemento che<br />
terminava in un pozzetto dove era inserito il tubo che portava<br />
l’<strong>acqua</strong> all’esterno.<br />
Le gallerie potevano raggiungere anche i 50 metri <strong>di</strong><br />
lunghezza e solitamente presentavano una larghezza <strong>di</strong> 1<br />
metro e un’altezza <strong>di</strong> 1,20-1,40 m
Captazione
ELENCO FONTANE<br />
Numero Nome Fontana Foglio Particella Numero<br />
Mappa<br />
C/da ARCONA<br />
1 A Funtana da Rocca FG 22 PART 532 109<br />
C/da BARONIA<br />
1 A Funtana <strong>di</strong> Cardaci FG 9 PART 630 239<br />
2 A Funtana du Baruni Salleo FG 10 PART 121 51<br />
3 A Funtana du Baruni Salleo 1 FG 10 PART 122 52<br />
4 A Funtana du Baruni Salleo 2 FG 10 PART 101 50<br />
5 A Funtana <strong>di</strong> Spiccia FG 12 PART 339 175<br />
6 A Funtana <strong>di</strong> Riolo FG 11 PART 232 172<br />
7 A Funtana <strong>di</strong> Riolo 1 FG 11 PART 232 173<br />
8 A Funtana <strong>di</strong> Benincasa FG 11 PART 272 174<br />
9 A Funtana da Baronia FG 10 PART 145 166
Fontana Da Rocca<br />
in c.da Arcona
Fontana Musca<br />
C.da Patrì
Tre fontane<br />
C.da Pizzo Corvo
Fontana Ioppo Carlo 2<br />
C.da S.Maria Xilona
ELENCO CONSENSI FONTANE<br />
Agnello Carmelo (Ficarra 09/06/1959) Residente a Parigi in Rue San<br />
Luca 13 - Fontana C. da Mulinazzo<br />
Musarra Maria in Ratto (Castell’Umberto 26/01/1940) Residente a<br />
Sinagra in C. da Rolletta 17 – Fontana Du Corvu<br />
Pullella Mario (Sinagra 02/02/1955) Residente a Sinagra in C. da<br />
Rolletta – Fontana I Tri Funtani in C. da Patrì<br />
Calalesina Basilio (Tortorici 16/05/1931) Residente a Tortorici in Via<br />
Sinagra 159 – Fontana<br />
Giuffrè Antonino (Sinagra 16/11/1954) Residente a Sinagra in C. da<br />
San Pietro – Fontana San Pietro in C. da San Pietro<br />
Ratto Michele Carmelo (Sinagra 06/01/1953) Residente a Sinagra in<br />
C. da Forte – Fontana Di Valle Agghiastru in C. da Forte<br />
Coci Giuseppe (Sinagra 27/01/1958) Residente a Sinagra in C. da<br />
Santa Lucia 3 – Fontana in C. da Pizzo Corvo<br />
Colavecchio Rosa (Sinagra 12/05/1955) Residente a Ficarra in C. da<br />
Rinella – Fontana in C. da Totoniglio<br />
Tranchita Marianna (Sinagra 01/10/1939) Residente a Sinagra in C.<br />
da Maimone 1 – Fontana Acqua <strong>di</strong> Fucili in C. da Maimone Santa<br />
Maria Xilona
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO<br />
VIA VITTORIO VENETO,N°46<br />
Tel 0941/595018 e-mail prolocosinagra@tiscali.it<br />
www.prolocosinagra.it<br />
98069 SINAGRA<br />
DENOMINAZIONE FONTANA: A FUNTANA D'ANASTASI<br />
UBICAZIONE LOCALITA': C.da MAIMONE<br />
PROPRIETARIO: REALE TINDARO<br />
RIFERIMENTO MAPPA ALLEGATA N ° 119<br />
STATO DI CONSERVAZIONE: DISCRETO<br />
REPERTO FOTOGRAFICO
NOTE:VASCHE E CANALETTE<br />
Per irrigare i giar<strong>di</strong>ni dove mancavano le sorgenti i proprietari chiedevano al Demanio<br />
<strong>l'</strong>autorizzazione per usare le acque perenni dei torrenti. Autorizzati provvedevano a costruire lunghe<br />
cunette, così <strong>l'</strong><strong>acqua</strong> arrivava nelle vasche poste sempre a monte dei giar<strong>di</strong>ni. Le vasche venivano<br />
costruite secondo <strong>l'</strong>ampiezza del giar<strong>di</strong>no sottostante. Queste pere, anche se non più usate, esistono<br />
ancora nelle nostre campagne. Richiamo appositamente un solo esempio – a Ballica o Bad<strong>di</strong>ca esiste<br />
tutt'ora una vasca lunga <strong>di</strong>eci metri, larga circa quattro metri e alta più <strong>di</strong> tre.<br />
L'<strong>acqua</strong> entrava da un lato e dal<strong>l'</strong>altro usciva. Le vasche, nel<strong>l'</strong>agricoltura, servivano non solo come<br />
accumulo <strong>di</strong> acque, ma anche per farle riscaldare nel<strong>l'</strong>aria aperta. Nelle nostre campagne ci sono,<br />
tutt'ora, vasche e cunette <strong>di</strong> tutte le <strong>di</strong>mensioni. A proposito ricordo che un tale nel suo podere aveva<br />
la fornace,e per trasportare <strong>l'</strong><strong>acqua</strong> si fece la forma e poi appositi canalini che sfruttavano il trasporto<br />
in profon<strong>di</strong>tà.<br />
La maggior parte <strong>di</strong> questi canali erano costruiti in pietra, ma c'erano anche con le tegole, la<br />
lunghezza variava da più <strong>di</strong> un km. A poche centinaia <strong>di</strong> metri. Vicino ogni cunetta vi era un viottolo<br />
per la manutenzione.<br />
A cura del Prof. Francesco MUSCA
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO<br />
VIA VITTORIO VENETO,N°46<br />
Tel 0941/595018 e-mail prolocosinagra@tiscali.it<br />
98069 SINAGRA<br />
DENOMINAZIONE FONTANA: A FUNTANA DU URGU<br />
UBICAZIONE LOCALITA': C.da PATRI'<br />
PROPRIETARIO: GIGLIA PAOLINA<br />
RIFERIMENTO MAPPA ALLEGATA N ° 284<br />
STATO DI CONSERVAZIONE: DISCRETO<br />
REPERTO FOTOGRAFICO
NOTE:<br />
U ZITAGGIU PRESSO A FUNTANA DU URGU A PATRI' DI MINICA E GIUVANNI.<br />
Erano gli anni trenta e le ragazze uscivano solo per andare a messa e lavorare.<br />
Minica era una ragazza molto bella e vivace, ed essendo la prima <strong>di</strong> sei figli, la mamma, a “Za<br />
Carmela “, la mandava spesso cu bumbulu a prendere <strong>l'</strong><strong>acqua</strong> alla fontana “ du urgu “ un po'<br />
<strong>di</strong>stante dal<strong>l'</strong>abitazione.<br />
Durante questi tragitti, una mattina d'agosto la bella Minica venne fulminata dallo sguardo <strong>di</strong><br />
Giuvanni un giovane che abitava li vicino, che avendo la mamma ammalata e non potendo<br />
andare a lavorare nei campi, si trovava anche lui vicino alla fontana.<br />
Minica dopo aver riempito la brocca(il recipiente)si sedette, come faceva <strong>di</strong> solito, vicino alla<br />
fonte a riposare.<br />
Tra la frescura del<strong>l'</strong><strong>acqua</strong> il canto delle cicale, gli odori del sottobosco, Minica inizia a<br />
fantasticare e immagina che arrivi Giuvanni <strong>di</strong> cui è segretamente innamorata.<br />
Come per incanto il giovane arriva vicino alla font, la guarda negli occhi e le <strong>di</strong>ce: “ Minica,<br />
finalmente sola, è tanto che ti guardo, mi vuoi maritare?<br />
La ragazza <strong>di</strong>ventò rossa in viso e rispose:”Tu sai che deve stabilirlo mio padre. Io ti voglio<br />
sposare!”<br />
E come per incanto i due giovani si scambiarono la promessa d'amore preso la fontana “ du<br />
urgu “testimone del loro sentimento per tanti e tanti anni fini ad arrivare alla lontana Australia.<br />
Ma quando nelle serate d'inverno si sedevano davanti al camino e raccontavano prima ai figli e<br />
dopo ai nipoti “ u zitaggiu presso a funtana du urgu a Patrì” ricordavano ancora la freschezza<br />
<strong>di</strong> quel<strong>l'</strong><strong>acqua</strong> e bene<strong>di</strong>cevano la fontana che aveva coronato il loro amore.<br />
La Presidente<br />
Vincenza Mola
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO<br />
VIA VITTORIO VENETO,N°46<br />
Tel 0941/595018 e-mail prolocosinagra@tiscali.it<br />
www.prolocosinagra.it<br />
98069 SINAGRA<br />
DENOMINAZIONE FONTANA: A FUNTANA DA ROCCA<br />
UBICAZIONE LOCALITA': C/DA ARCONA<br />
PROPRIETARIO: SPICCIA LEONE<br />
RIFERIMENTO MAPPA ALLEGATA N ° 109<br />
STATO DI CONSERVAZIONE: BUONO<br />
REPERTO FOTOGRAFICO
NOTE: Poesia<br />
ARCONI<br />
Oggi un lungo arcano,<strong>di</strong> rude selvaggia bellezza,incastonato tra i monti Nebro<strong>di</strong>.<br />
Una piccola can<strong>di</strong>da perla,incorniciato tra querce secolari,emergenti dal<strong>l'</strong>ombrosa valle <strong>di</strong> noccioli e il<br />
pianoro assolato intriso <strong>di</strong> verdeggianti ulivi.<br />
Tanti e tanti anni fa la vetusta mulattiera conduceva mamma e papà a questo nido,allora umile<br />
casolare,riparo dal caldo afoso del<strong>l'</strong>estate.<br />
Qui mi concepirono.<br />
Qui giocai bambino felice.<br />
Nella vallata <strong>di</strong> noccioli e querce un ripido viottolo,serpeggiando nel sottobosco tra frasche e origano<br />
odoroso,<br />
porta alla fonte che sgorga sotto la grande rocca,verde <strong>di</strong> muschio.<br />
Acqua fresca fluisce dalla canaletta <strong>di</strong> pietra,incavata da antico scalpellino,la foglia <strong>di</strong> nocciolo crea una<br />
gorgogliante cascatelle che invita a <strong>di</strong>ssetarsi.<br />
Acqua limpida come gli occhi <strong>di</strong> mamma,pura come sorriso <strong>di</strong> bimba,sicura come la presenza protettiva <strong>di</strong><br />
papà in questa foresta intricata <strong>di</strong> piante secolari,cosparsa <strong>di</strong> bruni massi precipitati dal monte su greto<br />
del torrente,percorsa dal fruscio d'invisibili creature,armonizzata dal canto <strong>di</strong> volatili.<br />
Il terremoto <strong>di</strong>strusse <strong>l'</strong>umile casolare.<br />
Volli ricostruirlo più bello con grande fatica, perché desiderio <strong>di</strong> mamma, perché primo immaginai <strong>l'</strong>incanto<br />
del luogo.<br />
Da Torino sogno le gran<strong>di</strong> terrazze affacciate sui Nebro<strong>di</strong> fino ai limpi<strong>di</strong> orizzonti, fin dove s'indovina<br />
<strong>l'</strong>azzurro tirreno e le isole Eolie, fin dove incombe solenne e terribile il Mongibello, fin dove il Pizzo Corvo<br />
squarcia i membri, fin dove lo sguardo riposa appagato sui declivi <strong>di</strong> Costaliva.<br />
Sogno ancora gli ombrosi pergolati, i pini, le palme, il roseto, le siepi <strong>di</strong> melograni e rosmarino, le sdraio<br />
sul solarium sabbioso, e la piccola piscina delizia dei bimbi.<br />
Sognando la mia anima affoga e si consola nella nebbia della mia amata Torino.<br />
Torino, Febbraio 1999 Spiccia Leone<br />
Sinagra li 28.10.2008 La Presidente<br />
Vincenza Mola
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO<br />
VIA VITTORIO VENETO,N°46<br />
Tel 0941/595018 e-mail prolocosinagra@tiscali.it<br />
www.prolocosinagra.it<br />
98069 SINAGRA<br />
DENOMINAZIONE FONTANA: A FUNTANA DI PUDDEDDA<br />
UBICAZIONE LOCALITA': C.da LIMARI<br />
PROPRIETARIO: BONFIGLIO CONCETTA<br />
RIFERIMENTO MAPPA ALLEGATA N° 91<br />
STATO DI CONSERVAZIONE: DISCRETO<br />
REPERTO FOTOGRAFICO
NOTE:PUDDEDDA<br />
Nella contrada Limari in fondo ad una valle e vicino alla Villa del signor Tumeosi trova la<br />
fontana denominata “ Funtana <strong>di</strong> Puddedda “ perchè nel passato i proprietari appartenevano<br />
alla famiglia Pullella. E' situata ai bor<strong>di</strong> <strong>di</strong> una strada malattiera, quasi radente al suolo<br />
perchè <strong>l'</strong><strong>acqua</strong> che <strong>l'</strong>alimenta sale dalle profon<strong>di</strong>tà del terreno. Dapprima <strong>l'</strong><strong>acqua</strong> si versa in<br />
una piccolissima vasca e poi, attraversando un solco scavato nella strada, si getta in un'altra<br />
abbastanza grande.<br />
Sinagra li 24/10/2008<br />
La Presidente<br />
Vincenza Mola
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO<br />
VIA VITTORIO VENETO,N°46<br />
Tel 0941/595018 e-mail prolocosinagra@tiscali.it<br />
www.prolocosinagra.it<br />
98069 SINAGRA<br />
DENOMINAZIONE FONTANA: A FUNTANA DI SA DIVERTI<br />
UBICAZIONE LOCALITA': C/DA COSTA OLIVA<br />
PROPRIETARIO: SICILIA ANTONINO E CARMELO<br />
RIFERIMENT MAPPA ALLEGATA N° 263<br />
STATO DI CONSERVAZIONE: BUONO<br />
REPERTO FOTOGRAFICO
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO<br />
VIA VITTORIO VENETO,N°46<br />
Tel 0941/595018 e-mail prolocosinagra@tiscali.it<br />
www.prolocosinagra.it<br />
98069 SINAGRA<br />
DENOMINAZIONE FONTANA: A FUNTANA DONNA SERAFINA<br />
UBICAZIONE LOCALITA': C.da POPULO<br />
PROPRIETARIO: AURORA PIETRO<br />
RIFERIMENTO MAPPA ALLEGATA N ° 143<br />
STATO DI CONSERVAZIONE: BUONO<br />
REPERTO FOTOGRAFICO
Ecco la romantica STORIA D’AMORE della bellissima Serafina dai tratti tipici me<strong>di</strong>terranei: mora,<br />
riccia e seducente, vissuta tra la fine dell’800 e la prima metà del 900.<br />
Sin da bambina andava con la brocca alla fontana a prendere l’<strong>acqua</strong> per uso familiare.<br />
Si narra che in giovane età, mentre si accingeva a riempire la brocca, arrivò un uomo maturo che le<br />
manifestò un grande interesse per la sua straor<strong>di</strong>naria bellezza.<br />
Ogni volta che la giovane andava a prendere l’<strong>acqua</strong>, lui arrivava,dopo le numerose insistenze dell’<br />
uomo, la ragazza si innamora dell’uomo maturo vista anche la sua ricchezza e <strong>di</strong>venta la sua<br />
donna.<br />
La fontana è <strong>di</strong>ventata il luogo d’incontro dei due amanti tant’è, che per accontentare i capricci del<br />
suo uomo la giovane cavalcava nuda un cavallo bianco per accontentare i suoi capricci.<br />
Per ricordo Bastiano lascia a Serafina la proprietà perché in quel luogo vi era anche la sorgente<br />
che rappresentava l’inizio e la continuazione del loro amore, tant’è che la stessa prende il nome <strong>di</strong><br />
“funtana <strong>di</strong> donna Serafina” in località Popolo.<br />
‘<br />
Sinagra li 24/10/2008<br />
Testimonianza del passato<br />
La Presidente<br />
Vincenza Mola
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE E TECNOLOGIE DEI BENI CULTURALI<br />
CATTEDRA DI ELEMENTI DI ETNOSTORIA E DI ETNOGRAFIA<br />
Scheda Catalografica<br />
N. 60<br />
PROVINCIA <strong>di</strong> Messina<br />
COMUNE <strong>di</strong> Sinagra<br />
LUOGO DI COLLOCAZIONE: C.da ROLLETTA<br />
DENOMINAZIONE: A FUNTANA DI RUDDETTA<br />
COORDINATE: 14°50’40,639’’E – 38°4’19,4’’N<br />
CARTOGRAFIA: C.T.R. sez. n. 599110e<br />
CATASTALE: Foglio 21 , Particella 537<br />
QUOTA 586 m s.l.m.<br />
GEOLOGIA: arenarie quarzoso-feldspatiche<br />
USO DEL SUOLO: Noccioleto<br />
TOPONIMO: ROLLETTA
TIPOLOGIA BENE: FONTANA<br />
EPOCA: XVIII sec.<br />
MATERIA:<br />
PORTATA IDRICA: 9 litri/minuto<br />
STATO DI CONSERVAZIONE: Ottimo<br />
CONDIZIONE GIURIDICA: Proprietà privata <strong>di</strong> Pullella Mario<br />
VINCOLI:<br />
DESCRIZIONE:Fuoriesce da una galleria <strong>di</strong> captazione in pietra a sezione<br />
rettangolare. Si riversa in una vaschetta in pietra da cui defluisce in una vasca e in<br />
un grande lavatoio con sette postazioni.<br />
FOTOGRAFIE:
NOTIZIE ANTROPOLOGICHE: NOVELLA.<br />
Sorgente limpida e trasparente da sempre le sue acque sono state trasportate con<br />
contenitori come il “bumbulu” o la “ quartara”. Decantata per le proprietà benefiche<br />
dalla prolificità all’intelligenza fuori dal comune sino agli effetti <strong>di</strong>uretici che il suo<br />
uso avrebbe assicurato trova popolarità per la storica vicenda della “fuiutina” <strong>di</strong><br />
Saritta e Michele. che alla fontana <strong>di</strong> Ruddetta avevano, all’insaputa dei rispettivi<br />
genitori contrari al loro amore, incontri brevi e fugaci che trovavano nell’ attingere<br />
l’<strong>acqua</strong> l’unica possibilità <strong>di</strong> incontro . La fontana complice della loro passione,<br />
<strong>di</strong>venne anche emblema dell’amore audace.<br />
COMPILATORE DELLA SCHEDA : Vincenza Mola
Registro delle Ere<strong>di</strong>tà Immateriali<br />
Alla SOPRINTENDENZA PER I BENI<br />
CULTURALI ED AMBIENTALI<br />
DI MESSINA<br />
Richiesta <strong>di</strong> iscrizione<br />
La sottoscritta MOLA VINCENZA nata a Sinagra * il 20/04/1958 ed ivi residente in Via Capuana n°7<br />
nella qualità <strong>di</strong> *3 PRESIDENTE DELLA ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO<br />
SINAGRA 4<br />
CHIEDE<br />
Al<strong>l'</strong>On. Assessore Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali e della P.I<br />
che quanto <strong>di</strong> seguito in<strong>di</strong>cato e descritto venga iscritto nel Registro delle Ere<strong>di</strong>tà<br />
Immateriali della Regione Siciliana.<br />
DENOMINAZIONE “IL PERCORSO DELLE CENTO FONTANE” nel <strong>Comune</strong> * <strong>di</strong> SINAGRA<br />
Provincia <strong>di</strong> * MESSINA.<br />
DESCRIZIONE *6 Per prendersi cura <strong>di</strong> un territorio occorre innanzitutto conoscerlo. E farlo prima che esso si<br />
degra<strong>di</strong> irrime<strong>di</strong>abilmente ed i segni impressivi dagli uomini nel corso dei secoli scompaiano. E soprattutto occorre<br />
farlo dotandosi <strong>di</strong> strumenti e meto<strong>di</strong> cognitivi innovativi, adeguati ad una realtà come quella territoriale stratificata<br />
e <strong>di</strong> pluriforme complessità.<br />
La Pro Loco <strong>di</strong> Sinagra ha dato avvio ad una operazione catalografica su piattaforma Gis degli elementi più<br />
significativi del paesaggio culturale, un bene giuri<strong>di</strong>camente riconosciuto e tutelato anche in Italia dopo la recente<br />
entrata in vigore della Convenzione Europea sul Paesaggio.<br />
L'intento è quello <strong>di</strong> contribuire ancora più efficacemente ad una conoscenza del patrimonio territoriale, storico,<br />
architettonico ed ambientale del comune nebroideo, che <strong>di</strong>venti nel tempo<br />
sempre più articolata e ricca, chiamando a raccolta in un percorso <strong>di</strong> valorizzazione e gestione delle risorse<br />
territoriali competenze e saperi più <strong>di</strong>sparati, sollecitando la consapevolezza e la partecipazione dei citta<strong>di</strong>ni. E'<br />
auspicabile al riguardo che tutte le informazioni raccolte possano confluire in un futuro non lontano in un sistema<br />
informativo pubblico per la gestione e la pianificazione del territorio e del<strong>l'</strong>ambiente.<br />
L’ inventario, organico e sistematico, delle fontane e sorgive <strong>di</strong>sseminati nel territorio è stato perfezionato da un<br />
censimento su base cartografica,utilizzando la CTR alla scala <strong>di</strong> dettaglio 1:10.000.
Motivazione della proposta * 7 le motivazioni sono varie: occorre conoscere E custo<strong>di</strong>re il patrimonio storico quin<strong>di</strong> I<br />
luoghi, le leggende E le storie che riguardano il territorio. La pro loco <strong>di</strong> sinagra ha censito 127 fontane/sorgenti,<br />
le quali rappresentano un pezzo <strong>di</strong> storia importante per il territorio.<br />
Sinagra nasce sulle sponde del torrente naso al riparo <strong>di</strong> due contrafforti, tra il verde intenso dei noccioleti e lo<br />
scrosciare <strong>di</strong> acque cristalline … le stesse acque che ancora oggi scorgano dalle numerose sorgenti nel nostro<br />
paese.<br />
Un tempo l’ importanza <strong>di</strong> queste sorgenti era fondamentale per lo svolgimento <strong>di</strong> tutte le attivita’ della vita<br />
quoti<strong>di</strong>ana. Era grazie ad esse, infatti, che si provvedeva all’ irrigazione dei campi, all’ abbeveramento degli<br />
animali, nonche’ all’ impiego domestico. La necessita’ “ <strong>di</strong> iri all’<strong>acqua</strong> “ nasceva dalla sua mancanza nelle<br />
abitazioni, per questo era consuetu<strong>di</strong>ne riunirsi in gruppo E recarsi alla sorgente “ cu bumbulu “ E “ ca quartara “.<br />
Vennero cosi’ costruite delle fontane lungo le stra<strong>di</strong>ne mulattiere che erano anche un punto <strong>di</strong> riferimento per I<br />
viaggiatori dove bere E riposarsi. Ancora oggi esistono moltissime <strong>di</strong> queste antiche fontane, sparse nelle varie<br />
contrade, quasi tutte in pietra E simili nella forma. Accanto si trovano spesso delle gran<strong>di</strong> vasche O “ gibbie “<br />
fornite <strong>di</strong> lavatoio dove le donne si recavano per lavare I panni. A tutt’oggi alcune <strong>di</strong> queste fontane vengono<br />
sfruttate per uso potabi8le E per irrigare I campi, ma E’ importante non <strong>di</strong>menticare che si tratta <strong>di</strong> un bene<br />
inestimabile da custo<strong>di</strong>re E rivalutare come testimonianza <strong>di</strong> un ritaglio <strong>di</strong> storia nel nostro paese.<br />
Libro <strong>di</strong> iscrizione 8<br />
Libro dei saperi dei luoghi x libro delle espressioni<br />
Libro delle celebrazioni libro dei tesori umani viventi<br />
Domicilio del<strong>l'</strong>in<strong>di</strong>viduo o del rappresentante del gruppo o della comunità1 da iscrivere 9<br />
Comunità1 interessata 10<br />
Gestione attuale dell 1 ere<strong>di</strong>ta 1 immateriale 11 pro loco <strong>di</strong> Sinagra<br />
Piano d'azione 12 * mantenere in vita i luoghi, le leggende e le storie che riguardano il territorio “ il percorso<br />
delle 100 fontane “.
DOCUMENTI ALLEGATI:<br />
1.Dichiarazione a firma del proponente attestante <strong>l'</strong>assunzione della responsabilità della proposta e <strong>di</strong>scarica da<br />
eventuali pretese <strong>di</strong> terzi, registrazioni au<strong>di</strong>o e video; foto e cd delle varie fontane ; cd <strong>di</strong> canzoni scritte sulla<br />
fontane; documentazioni scritte: poesie, leggende; deplians, libro e calendario; proverbi ; atti a confermare<br />
<strong>l'</strong>accordo dei depositari della specifica-Ere<strong>di</strong>tà Immateriale, della comunità <strong>di</strong> Sinagra, <strong>di</strong> cui al contenuto della<br />
proposta al punto 7 motivazioni;<br />
2. Lettera <strong>di</strong> autorizzazione alla <strong>di</strong>ffusione dei documenti allegati, comprendente la lista completa <strong>di</strong> quelli per i<br />
quali viene rilasciata <strong>l'</strong>autorizzazione, in<strong>di</strong>cando per ciascuno la leggenda completa e il nome degli aventi <strong>di</strong>ritto.<br />
DOCUMENTAZIONE EVENTUALE E AGGIUNTIVA<br />
Fonti e bibliografia;<br />
Registrazioni au<strong>di</strong>o e video; foto e cd delle varie fontane; cd <strong>di</strong> canzoni scritte sulle fontane dal cantautore Melo<br />
Ballato; documentazioni scritte dal defunto Prof. Francesco Musca; articoli <strong>di</strong> giornale; deplians, libro e calendario<br />
; poesie, e leggende <strong>di</strong> LA Cava Carmelo e Valuri Maria ; proverbi ;<br />
Elenco Fontane<br />
Fogli <strong>di</strong> mappa <strong>di</strong> localizzazioni dei siti<br />
Sinagra li FIRMA<br />
PER MAGGIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALLA SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED<br />
AMBIENTALI. INDIRIZZI E RECAPITI AL SITO www.regione.sicilia.it/beniculturali<br />
I punti segnati da asterisco debbono esser compilati obbligatoriamente.<br />
1 Soprintendenza della Provincia <strong>di</strong> appartenenza<br />
2 nome, cognome, data e luogo <strong>di</strong> nascita, residenza o domicilio<br />
3 rappresentante, amministratore, ecc.<br />
4 Ente Locale, Ente Ecclesiastico, Associazione, ecc.<br />
5 denominazione dell1 Ere<strong>di</strong>tà Immateriale che si vuole iscrivere<br />
6 descrizione sintetica della specifica Ere<strong>di</strong>tà Immateriale, contenente eventuali notizie storiche informazioni sulla<br />
funzione sociale, simbolica e culturale e dati tecnici quali materiali, funzioni, metodo <strong>di</strong> produzione, ecc., e, nel<br />
caso <strong>di</strong> TESORI UMANI VIVENTI, descrizione dei soggetti da iscrivere e delle loro capacità.<br />
7 brevi argomenti che depongono a favore del<strong>l'</strong> importanza del<strong>l'</strong>Ere<strong>di</strong>tà Immateriale<br />
8 sbarrare la casella del Libro in cui si vuole iscrivere <strong>l'</strong>Ere<strong>di</strong>tà Immateriale.
I LIBRI nei quali è <strong>di</strong>viso il Registro delle Ere<strong>di</strong>tà Immateriali sono quattro:<br />
"Libro dei Saperi", in cui vengono registrate le tecniche <strong>di</strong> produzione, le materie prime impiegate e i<br />
processi produttivi che identificano un particolare prodotto legato alle tra<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> un gruppo sociale o una<br />
località;<br />
"Libro delle Celebrazioni", in cui vengono iscritti i riti, le feste e le manifestazioni associati alla religiosità, ai<br />
cicli lavorativi, al<strong>l'</strong>intrattenimento e ad altri momenti significativi della vita <strong>di</strong> una comunità;<br />
"Libro delle Espressioni", in cui vengono iscritte le espressioni artistiche, letterarie, musicali, plastiche,<br />
visive, sceniche e le minoranze linguistiche;<br />
"Libro dei Tesori Umani Viventi", in cui sono iscritti persone, collettività e gruppi in<strong>di</strong>viduati come unici<br />
detentori <strong>di</strong> particolari conoscenze e abilità necessarie e in<strong>di</strong>spensabili per la produzione <strong>di</strong> determinati<br />
elementi del patrimonio immateriale della Regione Siciliana<br />
9 solo nel caso <strong>di</strong> Tesori Umani Viventi<br />
10 gruppo, minoranza linguistica, confraternita, ecc.<br />
11 in<strong>di</strong>care la denominazione del<strong>l'</strong>organismo che oggi si fa carico della salvaguar<strong>di</strong>a, preservazione e<br />
rivitalizzazione della specifica Ere<strong>di</strong>tà Immateriale e le eventuali misure <strong>di</strong> tipo giuri<strong>di</strong>co o economico già<br />
adottate<br />
12 in<strong>di</strong>care e proporre le azioni da attuare per la salvaguar<strong>di</strong>a, preservazione e rivitalizzazione della specifica<br />
Ere<strong>di</strong>tà Immateriale
Il secondo esempio riguarda il<br />
Censimento, la Catalogazione e le<br />
ricerche riguardanti gli alberi<br />
monumentali presenti sul territorio.
n. 2 Piante <strong>di</strong> Ulivo ultra secolari<br />
in c.da Martini (prop. Cala Lesina)
Roverella<br />
in c.da S.Venera (prop. Pinto)
Quercia<br />
in c.da Zigale (prop. Cotugno<br />
Carlo)
Fondo Agrumeto<br />
in c.da S.Leone (prop. Salleo)
Fondo Noccioleto<br />
in c.da Pizzo Corvo (prop.<br />
Carrella)
Vite Ultra Centenaria<br />
in c.da Crispo Alto (prop.<br />
Lenzo)
Castagno<br />
in c.da S.Pietro (prop. Ere<strong>di</strong><br />
Fogliani Giuseppe)
Censimento, Catalogazione e Ricerche<br />
storiche <strong>di</strong>: chiese, e<strong>di</strong>cole, palazzi,<br />
palazzi rurali, mulini, frantoi, ecc.
Chiesa Madre de<strong>di</strong>cata a S.Michele<br />
Arcangelo<br />
Via Roma
Rudere Convento dei Carmelitani<br />
in Via II Convento
Rudere Chiesa e Sarcofago<br />
in C.da Mezzagosto
Rudere Castello<br />
in Via Castello
Chiesa <strong>di</strong> San Leone<br />
in C.da San Leone
Palazzo Ere<strong>di</strong> Ioppolo Carlo<br />
in C.da San Leone
Palazzo Salleo<br />
in C.da Baronia
Palazzo Salleo<br />
in C.da Baronia
Chiesa Madre<br />
in C.da Martini
Rudere Carcere Martini<br />
in C.da Martini
Frantoio Ioppolo Achille<br />
in C.da Candelora
Frantoio Ioppolo Achille<br />
in C.da Candelora
Carcara<br />
in C.da S.Leone (prop. Ioppolo Giorgio)
Il terzo esempio riguarda il Censimento, la<br />
Catalogazione e le Ricerche riguardanti<br />
i palmenti <strong>di</strong> Sinagra.
Palmento Indaimo Leone<br />
C.da Faranò
Palmento Ioppolo Achille<br />
C.Da Zigale
A VINNIGNA<br />
A SINAGRA<br />
Erano gli anni '40, nel mese <strong>di</strong> settembre iniziava il grande lavoro nelle campagne, gli<br />
uomini e le donne andavano a raccogliere <strong>l'</strong>uva e la portavano al palmento nelle "coffe".<br />
Alcuni giorni prima, gli uomini pulivano accuratamente il palmento, che veniva utilizzato a<br />
turno da più famiglie della zona.<br />
L'uva raccolta e gettata nel palmento, veniva pigiata a pie<strong>di</strong> nu<strong>di</strong>.<br />
Terminata la pigiatura il palmento veniva tappato, ed il mosto, dal tino rigettato nel<br />
palmento e lasciato a macerare assieme agli acini per circa 24 ore.<br />
Successivamente davanti al foro veniva collocato un paniere <strong>di</strong> vimini per filtrare il mosto, e si<br />
procedeva alla seconda pigiatura. Gli acini venivano raccolti nel centro del palmento e sopra<br />
si addossavano dei pesi <strong>di</strong> legno, che tramite una catena ad anelli <strong>di</strong> ferro, appesa ad una<br />
trave, si alzava un grosso masso che nel<strong>l'</strong>arco della giornata veniva più volte stretto, e cosi<br />
<strong>l'</strong>uva si asciugava e <strong>di</strong>ventava "linizza".<br />
A fine proce<strong>di</strong>mento il mosto dal tino veniva versato in contenitori detti "utri" (ricavati da pelli <strong>di</strong><br />
capre o <strong>di</strong> pecore) <strong>di</strong> litri 40 circa, e trasportato in un magazzino terrario e versato nelle botti.<br />
Dopo quaranta giorni, finita la fermentazione le botti venivano chiuse ermeticamente.<br />
A San Martino, come <strong>di</strong>ce il proverbio, "ogni mosto <strong>di</strong>venta vino", e in questa data i<br />
vendemmiatori si riunivano a degustare il vino accompagnato dalle castagne a caldarrosto.<br />
A fine serata non mancava mai il ballo <strong>di</strong> chiusura dove spesso sbocciava un amore.<br />
Ricordo <strong>di</strong> Mola Diego<br />
Scritto dalla nipote Clara Mancuso
INDAIMO LEONE (Sinagra)<br />
“STORIA DEL MIO PALMENTO IN CONTRADA FARANO’”<br />
La storia del palmento è stata tramandata nella mia famiglia da padre in figlio. All’incirca agli<br />
inizi del XVII sec. la contrada <strong>di</strong> Faranò venne messa in coltivazione a vigneto e si decise <strong>di</strong><br />
costruire un palmento per pigiare l’uva. Nella proprietà dei miei avi, c’era un grande<br />
affioramento roccioso nel quale gli scalpellini con mazzette e punte <strong>di</strong> ferro incavarono una<br />
vasca. Imme<strong>di</strong>atamente al <strong>di</strong> sotto realizzarono nella roccia la tina con al centro una<br />
“scudedda”, un ulteriore piccola incavazione <strong>di</strong> forma semisferica in modo da permettere la<br />
raccolta <strong>di</strong> ogni residuo <strong>di</strong> mosto. Finito il palmento, i muratori, costruirono un fabbricato per<br />
proteggere sia il palmento sia per fornire un riparo ai conta<strong>di</strong>ni. Le mura del fabbricato furono<br />
costruite con pietre legate con malta <strong>di</strong> creta (tajo).<br />
Le tegole del tetto sono ancora oggi quelle del 1600, tutte realizzate nelle fornaci <strong>di</strong> Sinagra.<br />
Anche la porta è quella originale.<br />
La tina può contenere circa 1500 litri <strong>di</strong> mosto.<br />
L’uva veniva rovesciata nella vasca dalle cufine, ceste costruite in canne intrecciate, in cui era<br />
stata raccolta. Gli uomini, dopo essersi lavati i pie<strong>di</strong> in una recipiente in pietra, pigiavano l’uva<br />
scalzi con passi cadenzati, descrivendo un girotondo accompagnato spesso da canti e facezie.<br />
Il liquido si riversava attraverso un foro dalla vasca del palmento tramite un canaletta in pietra<br />
nella tina. Ciò che rimaneva dei grappoli, bucce e raspi, la vinaccia, veniva ammucchiato al<br />
centro della vasca e al <strong>di</strong> sopra venivano posti delle tavole e dei ceppi per l’ulteriore<br />
operazione <strong>di</strong> pressa.
Al <strong>di</strong> sopra della vasca, era il sistema <strong>di</strong> pressa costituito da un contrappeso in pietra e da un<br />
trave in legno <strong>di</strong> sorbo. La trave veniva inserita in un foro ricavato nella parete al <strong>di</strong> sopra della<br />
vasca. All’estremità opposta del trave erano posti in scanalature a breve <strong>di</strong>stanza fra loro due<br />
cerchi <strong>di</strong> ferro che sostenevano un altro pezzo <strong>di</strong> trave sempre <strong>di</strong> legno <strong>di</strong> sorbo chiamato<br />
“liveddu” cui era legata con una catena la pietra <strong>di</strong> contrappeso. Quest’ultimo trave veniva fatto<br />
ruotare, al fine <strong>di</strong> sollevare il contrappeso, grazie all’inserimento alternato <strong>di</strong> manovelle in ferro<br />
in due appositi fori. Sollevandosi progressivamente il contrappeso determinava la pressione<br />
del trave superiore sulle tavole e sulla sottostante vinaccia. detta “gaspo” ottenendo l’ultima<br />
spremitura. Dopo<strong>di</strong>ché, il mosto in fermentazione, raccolto nella tina, veniva trasportato alle<br />
botti grazie ad, otri (recipiente <strong>di</strong> pelle <strong>di</strong> pecora o <strong>di</strong> capra).<br />
Sinagra 15.11.2011<br />
Indaimo<br />
Leone
A PULIZIA DI UTTI<br />
Prima della vendemmia occorreva lavare “i utti”, per non rovinare il vino.<br />
Per la pulizia occorreva:<br />
• Acqua<br />
• Bicarbonato<br />
•Zolfo<br />
Si bolliva l’<strong>acqua</strong> nel “quadaruni”, si versava nella botte insieme al bicarbonato e si chiudeva.<br />
Si lasciava la botte piena d’<strong>acqua</strong> per do<strong>di</strong>ci ore, dopo averla sbattuta ripetutamente si<br />
svuotava dell’<strong>acqua</strong>. Successivamente si “sci<strong>acqua</strong>va” con <strong>acqua</strong> fredda e si metteva l’apertura<br />
girata verso terra.<br />
Infine si prendeva in po’ <strong>di</strong> zolfo, si faceva sciogliere in un piccolo recipiente e si passava nelle<br />
varie giunture.<br />
Si concludevano così le operazioni per la pulitura <strong>di</strong> “utti”.
U TRAVASU DU VINU<br />
Con la prima luna calante <strong>di</strong> Febbraio si travasa il vino.<br />
Occorreva svuotare la botte del vino e lavarla con <strong>acqua</strong> fredda per togliere “a fezza” del vino…<br />
Dopo si metteva il vino nella stessa botte e si chiudeva ermeticamente.<br />
Circa otto giorni dopo quando il vino <strong>di</strong>ventava chiaro si poteva bere.<br />
Il travaso era necessario per mantenere il vino fino alla successiva vendemmia.<br />
DETTI<br />
A settembre quannu si camminava nta campagna si sinteva u ciauru da fraula che era cacchi cosa<br />
<strong>di</strong> spiciali.<br />
A utti picciula faci u vinu bonu<br />
A utti china e a mugheri nbriaca.<br />
Tratto dalla pre<strong>di</strong>ca che faceva Padre Ficarra<br />
Carminu Carminazzo ARGA ACITU EST<br />
Carminu Bongiorno rispondeva : BIVIRI TU L’AI<br />
Ricordo <strong>di</strong> Diego Mola<br />
Scritto dalla nipote Clara Mancuso
“A farinata “<br />
Di Mamma Maria Ra<strong>di</strong>ci<br />
Siamo negli anni trenta quando i dolci si mangiavano solamente per Natale e Pasqua (esclusivamente preparati<br />
in casa).<br />
Maria, madre <strong>di</strong> quattro figli essendo una donna eccezionale preparava ed inventava dolci nuovi per i propri figli.<br />
Nel periodo della vendemmia, quando gli uomini pigiavano l’uva, Maria andava al palmento con un recipiente a<br />
prendere il mosto. Arrivata a casa metteva a bollire il liquido con della cenere contenuta in una “pezza” <strong>di</strong> lino,<br />
ermeticamente chiusa. Dimezzata la quantità del mosto si lasciava raffreddare. Dopo averlo filtrato, la giovane<br />
donna preparava “A FARINATA” , un dolce speciale, che incantava Carmela, Nicola, Nino e Concettina, i quali a<br />
fine preparazione, con un cucchiaio ciascuno gustavano le rimanenze della farinata nella pentola.<br />
Ed esclamavano: “mamma….chi ieni bona, eini appiddaveru speciali……..”<br />
RICETTA: “A FARINATA “ oggi Mostarda<br />
•Lt 1 mosto<br />
•Gr 100 farina<br />
•Cannella, pepe e buccia <strong>di</strong> un mandarino<br />
•Gr 100 <strong>di</strong> nocciole tostate e macinate<br />
PREPARAZIONE:<br />
Sciogliere in una tegame la farina, con un po’ <strong>di</strong> mosto e le bucce <strong>di</strong> mandarino.<br />
Sciolta la farina si vera il contenuto nel mosto lasciato a riposare. Il tutto si fa bollire<br />
mescolando continuamente con un cucchiaio <strong>di</strong> legno ed inserendo le essenze <strong>di</strong> cannella<br />
e pepe. A cottura ultimata si versa nei piatto aggiungendo le nocciole.<br />
Sinagra lì 7.10.2009<br />
Ricordo della figlia Concettina Di Vincenzo<br />
Scritto dalla pronipote Clara<br />
Mancuso
I PROVERBI ED IL VINO<br />
Secco <strong>di</strong> Gennaio chiude il tino e apre il granaio<br />
Se <strong>di</strong> Febbraio tuona, l’annata sarà buona<br />
A Marzo taglia e pota se non vuoi la botte vuota<br />
Aprile freddolino, molto pane e meno vino<br />
Maggio soleggiato, uva a buon mercato<br />
Per San Marcellino gia la vite pensa al tino<br />
Vino bianco a capponi <strong>di</strong> Luglio son buoni<br />
Quando arriva Agosto prepara i tini per il mosto<br />
E’ Settembre, il nono mese – per la vendemmia assai cortese<br />
D’Ottobre in cantina – da sera a mattina<br />
A San Martino ogni mosto <strong>di</strong>venta vino<br />
Nella Vigna del Signore non si giu<strong>di</strong>ca l’uva dal colore
ELENCO “LA STRADA DEI PALMENTI”<br />
N. N. LOCALITA’ COGNOME E NOME FG. PART. RILEVA<br />
MENTO<br />
1 CALDERONE EREDI SALPIETRO<br />
GIOVANNI<br />
8 188 151<br />
2 “ F.LLI NATALOTTO 8 198 152<br />
1 MEZZAGOSTO EREDI SINAGRA 8 226 159<br />
2 “ EREDI NUZZO 8 244 162<br />
3 “ EREDI NUZZO 8 278 163/164<br />
4 “ EREDI SPANO’<br />
GIUSEPPE<br />
8 204 D<br />
5 “ EREDI SPICCIA<br />
8 174 165<br />
ANTONINO<br />
1 BARONIA DI MARCO SARA 10 18 E<br />
1 FARANO’ INDAIMO LEONE 12 337 176<br />
2 “ TERRANOVA<br />
CARMELO<br />
12 160 167<br />
3 “ GIORGIO<br />
FRANCESCO<br />
12 155 168<br />
1 S.PIETRO EREDI IOPPOLO<br />
CARMELO<br />
18 180 182
DENOMINAZIONE PALMENTO:<br />
UBICAZIONE LOCALITA':ZIGALE<br />
PROPRIETARIO: IOPPOLO ACHILLE<br />
ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO<br />
VIA VITTORIO VENETO,N°46<br />
Tel 0941/595018 e-mail prolocosinagra@tiscali.it<br />
www.prolocosinagra.it<br />
98069 SINAGRA<br />
RIFERIMENTO MAPPA ALLEGATA: FG N. 20 - PART .47 - RILEV N. 98<br />
STATO DI CONSERVAZIONE: BUONO<br />
REPERTO FOTOGRAFICO<br />
NOTE: PALMENTO RISALENTE AL 1800<br />
Sinagra li 26/09/2009<br />
La Presidente<br />
Vincenza Mola
Elenco pratiche beni immateriali presentati dalla Pro Loco <strong>di</strong> Sinagra<br />
All’Assessorato dei Beni Culturali , Ambientali e delle Identità Siciliane <strong>di</strong> Palermo tramite la<br />
Sovrintendenza <strong>di</strong> Messina<br />
Festa <strong>di</strong> San Leone<br />
Il percorso delle ento Fontane<br />
La strada dei Palmenti<br />
Percorsi: Alberi Monumentali<br />
L’arte e le mani<br />
Fiera e festa <strong>di</strong> Sant’Alberto<br />
Per essere inseriti nel registro delle Ere<strong>di</strong>tà Immateriali (R.E.I.) e precisamente:<br />
LIBRO DELLE-CELEBRAZIONI<br />
LIBRO DEI SAPERI DEI LUOGHI<br />
LIBRO DELLE ESPRESSIONI<br />
LIBRO DEI TESORI UMANI VIVENTI
Una volta completato il lavoro che consiste in:<br />
Reperimento notizie<br />
Sopraluoghi fotografando il reperto e numerandolo tramite il GIS<br />
Elenco<br />
Firma del consenso del proprietario<br />
Interviste , in base al tipo <strong>di</strong> ricerca (fatti, novelle, ricette, foto antiche, aneddoti,<br />
canzoni, strumentazioni, ecc)<br />
Planimetria dei luoghi<br />
Pratica all’Assessorato dei Beni Culturali e delle Identità Siciliani <strong>di</strong> Palermo, al<br />
tramite la Sovrintendenza <strong>di</strong> Messina
La metodologia etnostorica, co<strong>di</strong>ficata dal Prof. Aurelio Rigoli<br />
fin dagli anni 80 ed evolutasi in un approccio investigativo che<br />
permette <strong>di</strong> leggere in maniera chiara le testimonianze del<br />
territorio, ha ispirato questa mia ricerca che si è rivolta a<br />
cogliere la presenza, ancora oggi numerosa nel territorio <strong>di</strong><br />
Sinagra, delle Fontane e dei Palmenti. Elementi della<br />
cosiddetta archeologia industriale che ci permettono <strong>di</strong><br />
valutare lo stile <strong>di</strong> vita, e la cultura agro-pastorale che si erano<br />
attestati a Sinagra quali elementi caratterizzanti il territorio e la<br />
sua economia, prima che si determinassero i processi <strong>di</strong><br />
modernizzazione.<br />
Questo lavoro vuole offrire attraverso l’analisi dei reperti qui<br />
catalogati – fontane, palmenti, alberi monumentali, ecc – una<br />
immagine del “Vissuto” tra<strong>di</strong>zionale sinagrese cercando <strong>di</strong><br />
offrire, proprio nella affermazione etnostorica della ricerca, il<br />
valore che questi reperti hanno, <strong>di</strong> “etnofonti/etnoreperti”.
Il rilievo delle Etnofonti è assolutamente necessario se si vuole<br />
procedere ad una ricerca <strong>di</strong> tipo etnostorico perché sono le fonti<br />
storiche a carattere antropologico che completano la visione<br />
storica degli eventi.<br />
I principi imprescin<strong>di</strong>bli nella lezione <strong>di</strong> aurelio Rigoli:<br />
1) il bisogno della tra<strong>di</strong>zione<br />
2) la compresenza necessaria.<br />
Il “bisogno della tra<strong>di</strong>zione” nasce dalla necessità <strong>di</strong> interpretare<br />
meglio – conoscendo per l’appunto il patrimonio tra<strong>di</strong>zionale la<br />
cultura del territorio espresso nei secoli. In modo da controllare in<br />
maniera compatibile i processi <strong>di</strong> modernizzazione.<br />
La “compresenza necessaria” permette <strong>di</strong> integrare le Etnofonti<br />
con le fonti ufficiali in modo da ottenere una base <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio più<br />
ampio per la valutazione della Storia dei territori.<br />
La metodologia etnostorica non a caso si fonda sul valore ed il<br />
significato della oralità quale – scrive Rigoli – strategia per<br />
leggere il vissuto popolare subalterno nel contesto <strong>di</strong> una Storia<br />
integrale per il recupero totale dell’uomo.
Di fatto il Censimento <strong>di</strong> ben 139 Fontane e 52 Palmenti,<br />
alberi monumentali, ecc da me operato nel contesto <strong>di</strong><br />
questo mio lavoro mi hanno permesso <strong>di</strong> valutare, contrada<br />
per contrada, il sistema <strong>di</strong> vita in esse operativo<br />
permettendomi <strong>di</strong> leggere attraverso le informazioni che ho<br />
potuto reperire sui Beni Tra<strong>di</strong>zionali censiti, anche taluni<br />
valori relativi alla simbologia dei luoghi interessati al mio<br />
rilevamento.<br />
Il mio lavoro vuole offrirsi come stimolo per il restauro e il<br />
recupero dei beni che appaiono degradati nel loro<br />
abbandono.
Per prendersi cura del territorio occorre innanzitutto<br />
conoscerlo. E farlo prima che esso si degra<strong>di</strong> irrime<strong>di</strong>abilmente ed<br />
i segni impressivi dagli uomini nel corso dei secoli scompaiano. E<br />
soprattutto occorre farlo dotandosi <strong>di</strong> strumenti e meto<strong>di</strong> cognitivi<br />
innovativi, adeguati ad una realtà come quella territoriale stratificata<br />
e <strong>di</strong> pluriforme complessità.<br />
Con la Pro Loco <strong>di</strong> Sinagra ho iniziato da tempo una operazione<br />
catalografica sistematica su piattaforma Gis degli elementi più<br />
significativi del paesaggio culturale, un bene giuri<strong>di</strong>camente<br />
riconosciuto e tutelato anche in Italia dopo la recente entrata in<br />
vigore della Convenzione Europea sul Paesaggio. Si tratta della<br />
Carta dei Beni culturali e ambientali <strong>di</strong> Sinagra. In particolare è<br />
stato effettuato allo scopo <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduarle puntualmente ed<br />
inequivocabilmente il censimento geo-referenziato con GPS, con<br />
successiva correzione dei dati, <strong>di</strong> tutte <strong>di</strong> tutte le strutture presenti<br />
comprendendo anche quelle scomparse <strong>di</strong> cui però si ha notizia<br />
certa.
I punti con cui le strutture sono state posizionate con precisione<br />
rapporta alla scala <strong>di</strong> Rappresentazione, in forma planimetrica e<br />
non simbolica, sono andati a costituire, sotto forma <strong>di</strong> shape file,<br />
la componente geografica della costituenda banca dati e sono<br />
stati raccordati, attraverso campi chiave, alle informazioni<br />
alfanumeriche del<strong>l'</strong>inventario già elaborato dal<strong>l'</strong>associazione e<br />
contenute in apposite schede descrittive, recanti tra <strong>l'</strong>altro dati<br />
toponomastici, sulla proprietà, le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> conservazione<br />
nonché le immagini delle strutture e dei manufatti.<br />
Ne è scaturita già una carta estremamente precisa, su una base<br />
cartografica ufficiale quale quella della regione Siciliana, CTR alla<br />
scala <strong>di</strong> dettaglio 1:10.000.<br />
circa la <strong>di</strong>stribuzione territoriale <strong>di</strong> questi elementi del paesaggio<br />
culturale che nel caso dei cosiddetti "palmenti saraceni" sono la<br />
testimonianza fossile <strong>di</strong> assetti agrari ed usi del suolo esistenti<br />
molti secoli ad<strong>di</strong>etro.
La maggior parte <strong>di</strong> queste strutture versa oggi, rischiando<br />
<strong>l'</strong>imminente scomparsa, nel più completo abbandono, ed<br />
insieme a queste, nelle medesime con<strong>di</strong>zioni, sono le<br />
moltissime chiesette rurali, come quella della contrada <strong>di</strong><br />
Mezzagosto con il suo sarcofago me<strong>di</strong>evale. Sarebbe invece<br />
auspicabile un piano <strong>di</strong> recupero e <strong>di</strong> tutela con finanziamenti<br />
ed incentivi ai proprietari coinvolti.<br />
L'intento è quello <strong>di</strong> contribuire ancora più efficacemente ad<br />
una conoscenza del patrimonio territoriale, storico,<br />
architettonico ed ambientale del comune nebroideo, che <strong>di</strong>venti<br />
nel tempo sempre più articolata e ricca, chiamando a raccolta<br />
in un percorso <strong>di</strong> valorizzazione e gestione delle risorse<br />
territoriali, competenze e saperi più <strong>di</strong>sparati, sollecitando la<br />
consapevolezza e la partecipazione dei citta<strong>di</strong>ni.
Insomma approntare dal basso, attraverso la partecipazione<br />
dei citta<strong>di</strong>ni un primo strumento in grado <strong>di</strong> rispondere alle<br />
esigenze <strong>di</strong> valorizzazione del territorio.<br />
E' auspicabile al riguardo che tutte le informazioni raccolte<br />
possano confluire in un futuro non lontano in un sistema<br />
informativo pubblico per la gestione e la pianificazione del<br />
territorio e del<strong>l'</strong>ambiente.<br />
L’iniziativa deve essere considerato una sorta <strong>di</strong> work in<br />
progress, uno stu<strong>di</strong>o per approssimazioni successive, con<br />
aggiornamenti perio<strong>di</strong>ci attraverso implementazioni della<br />
banca dati. L'indagine <strong>di</strong>retta sul terreno, fatta <strong>di</strong> continui<br />
sopralluoghi, dovrà integrarsi al<strong>l'</strong>inchiesta orale ed in<br />
particolare con lo stu<strong>di</strong>o fonti scritte. Sempre <strong>di</strong> Sinagra<br />
andranno in<strong>di</strong>viduati e schedati tutti i micro toponimi ovvero<br />
quei dei nomi <strong>di</strong> luogo con cui i residenti designano la singola<br />
porzione del territorio.
Cartografia dei beni culturali e<br />
ambientali <strong>di</strong> Sinagra
Nel ringraziarvi, mi auguro che questa mia<br />
esperienza possa esservi <strong>di</strong> aiuto nel<br />
portare avanti progetti nel vostro paese, e<br />
soprattutto a non abbandonarlo.<br />
Lì 15.06.2012<br />
Dott.ssa Vincenza Mola