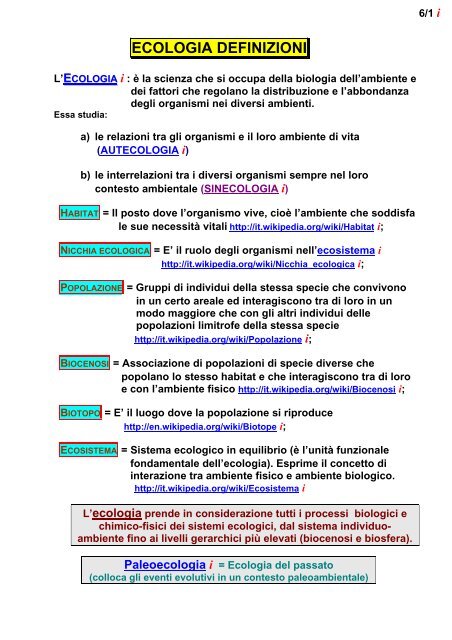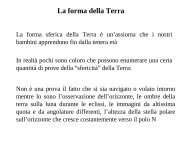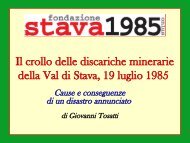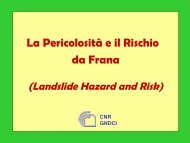6.00 Paleoecologia - Scienze della terra
6.00 Paleoecologia - Scienze della terra
6.00 Paleoecologia - Scienze della terra
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ECOLOGIA DEFINIZIONI<br />
L’ECOLOGIA ECOLOGIA i : è la scienza che si occupa <strong>della</strong> biologia dell’ambiente e<br />
dei fattori che regolano la distribuzione e l’abbondanza<br />
degli organismi nei diversi ambienti.<br />
Essa studia:<br />
a) le relazioni tra gli organismi e il loro ambiente di vita<br />
(AUTECOLOGIA i)<br />
b) le interrelazioni tra i diversi organismi sempre nel loro<br />
contesto ambientale (SINECOLOGIA i)<br />
HABITAT = Il posto dove l’organismo vive, cioè l’ambiente che soddisfa<br />
le sue necessità vitali http://it.wikipedia.org/wiki/Habitat i;<br />
NICCHIA ECOLOGICA = E’ il ruolo degli organismi nell’ecosistema i<br />
http://it.wikipedia.org/wiki/Nicchia_ecologica i;<br />
POPOLAZIONE = Gruppi di individui <strong>della</strong> stessa specie che convivono<br />
in un certo areale ed interagiscono tra di loro in un<br />
modo maggiore che con gli altri individui delle<br />
popolazioni limitrofe <strong>della</strong> stessa specie<br />
http://it.wikipedia.org/wiki/Popolazione i;<br />
BIOCENOSI = Associazione di popolazioni di specie diverse che<br />
popolano lo stesso habitat e che interagiscono tra di loro<br />
e con l’ambiente fisico http://it.wikipedia.org/wiki/Biocenosi i;<br />
BIOTOPO = E’ il luogo dove la popolazione si riproduce<br />
http://en.wikipedia.org/wiki/Biotope i;<br />
ECOSISTEMA = Sistema ecologico in equilibrio (è l’unità funzionale<br />
fondamentale dell’ecologia). Esprime il concetto di<br />
interazione tra ambiente fisico e ambiente biologico.<br />
http://it.wikipedia.org/wiki/Ecosistema i<br />
L’ecologia prende in considerazione tutti i processi biologici e<br />
chimico-fisici dei sistemi ecologici, dal sistema individuoambiente<br />
fino ai livelli gerarchici più elevati (biocenosi e biosfera).<br />
<strong>Paleoecologia</strong> i = Ecologia del passato<br />
(colloca gli eventi evolutivi in un contesto paleoambientale)<br />
6/1 i
Rellaziionii ttra biiollogiia,, palleonttollogiia e palleoecollogiia<br />
Biologia<br />
Paleontologia<br />
<strong>Paleoecologia</strong><br />
Ri iccoosst trruuzzi ioonnee<br />
Eccool looggi iccaa<br />
Ri iccoosst trruuzzi ioonnee<br />
Paal leeooeeccool looggi iccaa<br />
ii<br />
-- chi iarri isce i<br />
meccani ismi i del l prrocesso evol lutti ivo;;<br />
ii - fforrni isce la l<br />
evol lutti ivo;;<br />
ii - col ll loca gl li i eventti i<br />
pal leoambi ienttal le. .<br />
AAmbbi iieennt tee<br />
rri iccoosst trr. .<br />
ddi irreet tt taa<br />
rri iccoosst trr. .<br />
innddi i irreet tt taa<br />
documenttazi ione sttorri ica del l<br />
evol lutti ivi i in i un conttestto<br />
SSccaal llaa<br />
TTeemppoor raal llee<br />
uumaannaa<br />
ggeeool looggi iccaa<br />
LLooccaal lli iizzzz. ..<br />
ggeeooggr raaf fi iiccaa<br />
eessaat tt taa<br />
ippoot i teetti iccaa<br />
prrocesso<br />
PPr reevvaal lleennzzaa<br />
ddeeggl lli ii sst tuuddi ii<br />
aambbi ieennt ti i<br />
teerrrreesst t trri i<br />
aambbi ieennt ti i<br />
maarri innii<br />
Ricerca paleoecologica e ricerca litologica s. l. (sedimentologia,<br />
ecc.) devono essere sempre integrate nel contesto dell’ANALISI di<br />
FACIES<br />
6.1 bis i
SUDDIVISIONI dell’AMBIENTE MARINO<br />
All’interno di queste province e domini si inseriscono le diverse<br />
comunità come di seguito<br />
EPIFAUNA VAGILE<br />
(mobile)<br />
EPIBENTHOS SEMISESSILE (sedentari)<br />
EPIFAUNALI (con movimenti limitati)<br />
senza ancoraggio<br />
EPIFLORA SESSILE con ancoraggio debole<br />
(fisso) con ancoraggio rigido<br />
INFAUNA FOSSATORE<br />
ENDOBENTHOS<br />
INFAUNALI (ENDOFAUNALI)<br />
SEMI-INFAUNA PERFORANTE<br />
epibionti endobionti<br />
1<br />
6.2
ORGANISMI NECTOBENTONICI (Nectobenthos)<br />
NECTOBENTHOS<br />
ORGANISMI PELAGICI<br />
NECTON<br />
OLOPLANCTON MACROPLANCTON > 5 mm<br />
(per tutta la vita) PLANCTON MESOPLANCTON 1-5 mm<br />
MICROPLANCTON 1mm-<br />
MEROPLANCTON NANNOPLANCTON < 50 μ<br />
(solo stadio larvale)<br />
Zooplancton Fitoplancton<br />
2
AMENSALISMO<br />
Predazione<br />
AMENSALISMO Competizione<br />
Esclusione d’una<br />
specie o di un gruppo Bioturbazione (-> torbidità)<br />
di specie (o di un<br />
gruppo trofico) da una<br />
particolare comunità<br />
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv<br />
esclusive (limitate a un solo biotopo)<br />
Specie caratteristiche<br />
di un certo biotopo preferenziali (possono essere presenti<br />
in più biotopi ma sono<br />
rappresentate da un no.<br />
elevato di individui in un<br />
solo biotopo)<br />
Specie accompagnatrici Si hanno in biotopi diversi<br />
(specie euritopiche)<br />
Specie accidentali Caratteristiche di un biotopo e<br />
trovate sporadicamente in altri<br />
COMUNI ITA’ ’ = popolamento di Pérès & Picard – viene definita<br />
mediante l’elenco delle specie caratteristiche<br />
(che non sono le più abbondanti)<br />
Tra le comunità possono esservi delle zone di transizione denominate<br />
“ECOTONI” (zone sfumate)<br />
(da Raffi & Serpagli 1993-96, modificato)<br />
6.3 bis
A M B II E N T E M A R II N O<br />
Rete trofica e Gruppi trofici<br />
• PRODUTTORI PRIMARI (auttottrroffi i)<br />
Organismi in grado di compiere la fotosintesi, cioè di utilizzare l’energia solare<br />
per produrre sostanze organiche partendo da composti inorganici (Fitoplancton,<br />
Alghe bentoniche, Fanerogame)<br />
• CONSUMATORI (etterrottrroffi i)<br />
Tutti gli altri organismi al di sopra del livello dei consumatori primari.<br />
Errbi ivorri i (brucatori, raschiatori, ecc.) utilizzano tutti i tipi di<br />
vegetali marini (es. Gasteropodi)<br />
Sospensi ivorri i (prelevano il particellato alimentare dall’acqua circostante<br />
catturandolo e trattenendolo) (brachiopodi,<br />
e<br />
briozoi, vermi a ventaglio …)<br />
Fi il lttrrattorri i<br />
(devono “trattare” tutta l’acqua che entra nella cavità<br />
branchiale tramite l’apertura o il sifone inalante) (molti<br />
bivalvi)<br />
Deposi itti ivorri i (organismi infaunali le cui fonti alimentari sono costituite<br />
dalla materia organica in decomposizione e dai<br />
batteri che prendono parte a tale processo all’interno<br />
e<br />
del sedimento ) (scafopodi, oloturie, bivalvi, vermi)<br />
Dettrri itti ivorri i (organismi che prelevano il detrito alimentare sulla<br />
superficie del substrato) (molti bivalvi)<br />
Prredattorri i (organismi dotati di particolari strutture per catturare le<br />
prede) (certi gasteropodi, alcuni crostacei, ecc.)<br />
Necrroffagi i (animali che si nutrono di resti di organismi morti)<br />
(alcuni gasteropodi)<br />
Parrassi itti i<br />
(organismi che vivono nutrendosi del sangue o dei<br />
tessuti di un altro organismo vivente senza determinarne<br />
la morte)<br />
• TRASFORMATORI Organismi che trasformano i resti organici in<br />
componenti inorganici indispensabili per la vita<br />
dei vegetali (es. batteri e funghi)<br />
6.3
PIRAMIDE TROFICA<br />
III° livello livelli dei carnivori<br />
Carnivori (compresi parassiti e<br />
necrofagi)<br />
II° livello<br />
carnivori<br />
I° livello<br />
carnivori<br />
livello dei consumatori primari<br />
(erbivori - detritivori)<br />
livello dei produttori primari<br />
(piante)<br />
La piramide trofica illustra la perdita di energia ad ogni livello<br />
trofico e la corrispondente diminuzione del numero di individui<br />
vedi le frecce decrescenti di larghezza ai lati <strong>della</strong> piramide<br />
6.3 ter
1) SUBSTRATO i<br />
2) CORRENTI e<br />
TURBOLENZA<br />
FATTORI nella DISTRIBUZIONE<br />
degli ORGANISMI MARINI<br />
Duri<br />
Rocciosi<br />
Sinsedimentari<br />
Molto variabili in funzione <strong>della</strong><br />
Mobili granulometria del sedimento e<br />
dell’energia dell’ambiente<br />
3) TEMPERATURA (clicca sul testo per saperne di più) i<br />
4) SALINITÀ (clicca sul testo per saperne di più) i<br />
5) TENORE d’OSSIGENO (clicca sul testo per saperne di più) i<br />
6) NUTRIENTI (clicca sul testo per saperne di più) i<br />
(da Raffi & Serpagli, 1993-96, modificato)<br />
6.4 i
TIPO DI SUBSTRATO Prevalentemente Prevalentemente<br />
Depositivori<br />
Sabbie fini, silt, argilla INFAUNALI<br />
(in acque poco ossigenate e Detritivori<br />
con molta materia organica)<br />
Sabbie medie e grossolane Sospensivori<br />
(ciottoli) EPIFAUNALI<br />
(in genere ricche d’ossigeno e con Filtratori<br />
pochissime sostanze organiche all’in-<br />
terno)<br />
Molto particellato alimentare in<br />
sospensione<br />
(da Raffi & Serpagli, 1993-36, con modifiche)<br />
6.4a
Fauna nell’insieme Singoli individui<br />
Caratteristiche Acque calde Acque fredde Eccezioni<br />
(esempi)<br />
Spessore conchiglia per lo più ridotto Mya truncata<br />
notevole<br />
Ornamentazione ben sviluppata ridotta o assente<br />
Dimensioni per lo più non eccessiva Arctica<br />
grandi islandica<br />
Colorazioni presenti assenti<br />
vivaci<br />
Forme parassite presenti assenti<br />
Diversità elevata bassa<br />
Rapporto (R)<br />
R = epifauna R > 1 R = 1<br />
infauna<br />
Organismi a scarsi frequenti<br />
guscio siliceo<br />
Coralli costruttori presenti assenti<br />
6.4b<br />
1
Il brachiopode Terebratulina retusa popola fondali relativamente poco profondi<br />
nei mari boreali e tende a migrare verso maggiori profondità col diminuire <strong>della</strong><br />
latitudine. Questo fenomeno, conosciuto come “migrazione verticale”, è comune<br />
nelle faune ad invertebrati boreali (ad es. ostracodi e molluschi) ed è imputabile<br />
alle esigenze termiche delle specie (da Helmke in Ziegler, 1983).<br />
Distribuzione di alcune specie di bivalvi e di gasteropodi lungo le coste orientali<br />
del Nord America. La distribuzione geografica degli organismi eterotermi è<br />
regolata essenzialmente dalle esigenze termiche del ciclo di riproduzione (da<br />
Fisher, 1960).<br />
(da Raffi & Serpagli, 1993-36, con modifiche)<br />
2
E<br />
S<br />
T<br />
I<br />
N<br />
T<br />
I<br />
SALINITÁ<br />
STENOALINE EURIALINE<br />
RADIOLARI BIVALVI<br />
BRACHIOPODI GASTEROPODI<br />
CORALLI Lingula (Brachiopode)<br />
CEFALOPODI FORAMINIFERI ARENACEI<br />
ECHINODERMI<br />
OSTRACODI OSTRACODI<br />
ARCHEOCIATIDI<br />
TRILOBITI<br />
TENTACULITI<br />
GRAPTOLITI<br />
CONODONTI<br />
EURIPTERIDI<br />
Salinità in parti per 1000<br />
Acque dolci …………………………………………. 0 - 0,5<br />
Acque salmastre …………………………………… 0,5 - 30<br />
Acque marine normali …………………………….. 30 - 40<br />
Acque ipersaline …………………………………… 40 - 80<br />
Acque sovrasalate …………………………………. > 80<br />
(Brine)<br />
1<br />
6.4c
Progressiva diminuzione <strong>della</strong> diversità tassonomica in concomitanza<br />
con la diminuzione <strong>della</strong> salinità, procedendo dal Mare del Nord (D) al<br />
Golfo di Finlandia (A). (da Segerstråle, 1957)<br />
Le dimensioni d’alcune specie di molluschi<br />
marini (Mytilus edulis e Cardium edule)<br />
tendono a diminuire con l’abbassarsi<br />
<strong>della</strong> salinità. Le dimensioni di alcune<br />
specie d’acqua dolce (es. Theodoxus<br />
fluviatilis) tendono al contrario ad aumentare<br />
con la diminuzione <strong>della</strong> salinità.<br />
(da Remane, 1934).<br />
(da Raffi & Serpagli, 1993-36, con modifiche)<br />
2
TENORE d’OSSIGENO<br />
Nel Mar Nero la diversità tassonomica si riduce drasticamente con la profondità<br />
come conseguenza <strong>della</strong> riduzione del tenore d’ossigeno.<br />
Sul fondo dove esistono condizioni anossiche la vita è assente (da<br />
Rhoads & Morse, 1971).<br />
Schema dei rapporti tra l’interfaccia acqua/sedimento e l’interfaccia ossidazione/riduzione<br />
(Eh = 0); a) la superficie Eh = 0 è interna al sedimento:<br />
colonizzazione epifaunale ed infaunale; b) la superficie Eh = 0 coincide con<br />
la superficie del substrato: colonizzazione esclusivamente epifaunale; c) la<br />
superficie Eh = 0 è al di sopra del substrato: assenza di vita sul fondo (da<br />
Ricci Lucchi, 1978).<br />
1<br />
6.4d
PRODUZI IONE<br />
CONSUMO<br />
Va arri iazi ione<br />
• Direttamente dall’atmosfera per soluzione durante<br />
elevata turbolenza<br />
• Fotosintesi del fitoplancton (e delle fanerogame<br />
marine + alghe varie)<br />
• Processo di respirazione degli organismi<br />
• Ossidazione <strong>della</strong> materia organica<br />
del l<br />
ttenorre<br />
di i<br />
O22 --> Varri iazi ione del ll la di iverrsi ittà<br />
ttassonomi ica<br />
Iterazione tra produzione e consumo<br />
Concentrazione<br />
dell’ossigeno Circolazione oceanica<br />
nell’acqua<br />
Densità (salinità + temperatura) delle acque<br />
Dipende da<br />
La concentrazione dell’ossigeno tende a diminuire dalla zona fotica<br />
verso maggiori profondità<br />
(da Raffi & Serpagli, 1993-36, con modifiche)<br />
2
NUTRIENTI<br />
NUTRIENTI = Elementi indispensabili per la vita dei vegetali e la<br />
nitrati formazione dei pigmenti fotosintetici.<br />
fosfati<br />
silicati<br />
Nelle acque superficiali<br />
Concentrazione dei<br />
nutrienti<br />
PRODUTTIVITA’ PRIMARIA dipende<br />
Tasso di produzione per unità<br />
di volume di materiale vegetale Intensità luminosa<br />
a disposizione dei consumatori<br />
Nelle acque superficiali il fattore limitante più importante è<br />
dato dalla disponibilità di nutrienti in quanto la luce (salvo<br />
condizioni particolari) è sempre disponibile.<br />
PRODUTTIVITÁ TOTALE<br />
Tasso di produzione per unità<br />
di volume di materiale vegetale<br />
ed animale a disposizione dei<br />
consumatori<br />
Longevità degli<br />
organismi<br />
BIOMASSA (fitomassa e zoomassa) dipende da<br />
Quantità di materiale organico vivente<br />
per unità di volume Produttività<br />
Il calo di produttività primaria nelle acque superficiali (per<br />
discesa sul fondo degli organismi morti) è compensata da<br />
correnti ascensionali (Upwelling) (molto importante nelle<br />
acque tropicali).<br />
La produttività è più elevata sulle piattaforme continentali<br />
rispetto alle aree oceaniche:<br />
1) Upwelling costiero;<br />
2) apporto di nutrienti dai fiumi;<br />
3) i resti decomposti sul fondo tornano più facilmente in<br />
circolo<br />
(da Raffi & Serpagli, 1993-36, con modifiche)<br />
6/4e
TANATOCENOSI (“Associazione morta”) = Ciò che rimane dell’associazione<br />
vivente dopo il processo di necrolisi (vale a dire: i resti degli<br />
organismi potenzialmente fossilizzabili). (Il numero delle specie <strong>della</strong><br />
tanatocenosi è drasticamente ridotto rispetto a quello <strong>della</strong> biocenosi).<br />
Associazione di organismi viventi<br />
(corrispondente ad una biocenosi o parte di essa)<br />
morte e processi di necrolisi<br />
Tanatocenosi<br />
eventuali fenomeni di trasporto<br />
processi biostratinomici<br />
seppellimento<br />
Tafocenosi<br />
fenomeni diagenetici<br />
Associazione fossile o orictocenosi<br />
(impoverita dal processo di diagenesi)<br />
Paleocomunità Associazioni Associazioni<br />
residuali mescolate trasportate<br />
Associazione di fossili di organismi Associazione di fossili di organi- Associazione di fossili di organi-<br />
provenienti da una biocenosi, che smi provenienti da una biocenosi; smi provenienti da una o più bio-<br />
è rimasta nel suo biotopo originale. una parte più o meno importante cenosi; tutti i fossili sono stati<br />
dell’associazione non è stata spostati dal loro biotopo originale.<br />
spostata dal suo biotopo originale.<br />
(Componente autoctona + quella<br />
alloctona)<br />
Fossili rielaborati = provenienti da rocce più antiche, che possono essere<br />
presenti in qualsiasi tipo di orictocenosi<br />
Fossili rimaneggiati = fossili risedimentati in ambienti coevi (cioè riesumati<br />
da sedimenti non litificati<br />
(da Raffi & Serpagli, 1993-36, con modifiche)<br />
2.39 / 6.5
AMBIENTI RISORSE TROFICHE TIPO SELEZIONE SPECIE PREVAL. TIPO DI SPECIE<br />
Instabili Variabili in modo r – selezione Alto tasso ri- Opportuniste<br />
imprevedibile produttivo e<br />
poca specializ. Popolazioni<br />
a livello trofico. con elevate<br />
Adattate ad una fluttuazioni<br />
ampia gamma di<br />
ambienti. Specie pioniere<br />
Stabili Povere ma K – selezione Tasso riprodut- In equilibrio<br />
stabili tivo poco elevato, (fluttuazioni<br />
limitate)<br />
alta specializ- Popolazioni<br />
zazione. stabili e<br />
piccole.<br />
Specie pioniere = le prime che colonizzano un certo habitat<br />
L’individuazione di specie opportuniste o di strategie<br />
r-selettive consente di rilevare situazioni di instabilità<br />
Note: in fig. i pattern di crescita delle popolazioni (vedi testo sotto)<br />
La r- selezione (b) favorisce le popolazioni delle specie a più alto tasso<br />
riproduttivo (da cui la sua denominazione) con maggior capacità di sopravvivenza,<br />
che sviluppano adattamenti utili a superare periodi di condizioni<br />
ambientali sfavorevoli.<br />
La K- selezione (a) indica la (carrying capacity, cioè la capacità di sostentamento)<br />
e favorisce le specie a tasso riproduttivo poco elevato ad<br />
alta specializzazione, determinando una sempre più efficiente utilizzazione<br />
delle risorse.<br />
6/6
Sanders<br />
Valentine<br />
CAUSE e MODELLI <strong>della</strong> DIVERSITÀ TASSONOMICA<br />
AMBIENTI<br />
STABILI INSTABILI<br />
variazioni prevedibili variazioni imprevedibili<br />
dei parametri fisici (es. produttività primaria)<br />
molte specie ad elevata poche specie con ampia<br />
specializzazione tolleranza fisiologica<br />
molte specie poche specie<br />
(piccole popolazioni (grandi popolazioni)<br />
altamente specializzate)<br />
ricchezza elevata<br />
perlopiù generaliste<br />
dominanza assente<br />
equitabilità elevata<br />
tendenza alla DOMINANZA<br />
ambienti tropicali<br />
ambienti di mare profondo<br />
basse latitudini alte latitudini<br />
(produttività primaria continua (produttività primaria a brevi<br />
limitata e costante tutto l’anno periodi estivi)<br />
Comunità dominata da specie<br />
Opportuniste; associazioni<br />
OLIGOTIPICHE<br />
ambiente K- selettivo ambiente r- selettivo<br />
diversità tassonomica elevata diversità tassonomica bassa<br />
Il paleontologo dopo aver valutato la diversità tassonomica <strong>della</strong> comunità,<br />
in termini di ricchezza, equitabilità e dominanza, cercherà di identificare<br />
i fattori responsabili, tenendo conto di tutti gli altri dati disponibili<br />
(complessità tassonomica, trofica, ecc.)<br />
Equitabilità = elevata ricchezza e assenza di dominanza;<br />
Dominanza = poche specie rappresentate da grandi popolazioni.<br />
6.6bis
C = Popolamento del coralligeno; PE = Pop. eterogeneo (= MI di Pérès<br />
DC = Pop. dei fondi detritici costieri; & Picard, 1964);<br />
DE = Pop. dei fondi detritici infangati; VTC = Pop. dei fondi detritici costieri.<br />
DL = Pop. dei fondi detritici del largo;<br />
VP = Pop. dei fanghi profondi;<br />
LEE = Pop. eurialino ed euritermico delle lagune;<br />
SVMC = Pop. delle sabbie fangose in ambiente di bassa energia;<br />
SFHN = Pop. delle sabbie fini degli alti livelli;<br />
HP = Pop. delle praterie a posidonie;<br />
EP = Pop. delle alghe fotofile;<br />
SFBC = Pop. delle sabbie fini ben classate;<br />
SGCF = Pop. delle sabbie grossolane e dei ciottoli fini<br />
sotto l’influenza delle correnti di fondo;<br />
(da Raffi & Serpagli, 1993-96, con modifiche)<br />
6.7
EPIBIOSI<br />
(associazione casuale)<br />
MUTUALISMO<br />
(Es. Alghe dinoflagellate e coralli)<br />
SIMBIOSI COMMENSALISMO<br />
(associazione mirata)<br />
Associazione tra specie che implica<br />
un contatto corporeo benefico per<br />
almeno una delle specie<br />
Bivalve Carbonifero Naiadites<br />
PARASSITISMO<br />
Vantaggio<br />
reciproco<br />
Vantaggio per<br />
una specie<br />
senza danno<br />
per l’altra<br />
Vantaggio per<br />
una specie con<br />
danno per<br />
l’altra<br />
Nelle figure alcuni es. di Commensalismo: a) vermi Cornulites sul brachio-<br />
pode Devoniano Mucrospirifer. b) c) Spirorbis su Naiadites: tutti cementati in<br />
corrispondenza delle correnti inalanti. d) Hicetes sul tabulato Pleurodictyum.<br />
(da Raffi & Serpagli, 1993-36, con modifiche)<br />
d )<br />
6.8
Le comunità di scogliera<br />
Categorie funzionali<br />
Tab. 6.3. I principali criteri utili per l’identificazione delle diverse categorie funzionali delle<br />
comunità di scogliera sia attuali sia fossili (da Fagerstrom, 1991).<br />
Criteri Costruttori Intrappolatori Leganti<br />
(constructors) (bafflers) (binders)<br />
1) Disposizione<br />
spaziale<br />
modo di crescita eretta eretta incrostante<br />
direzione di crescita verso l’alto verso l’alto laterale<br />
2) Forma massicci, globosi cilindriformi, palmati, laminari, lentiformi,<br />
forma di crescita ramificati, colon- conformi ombrelliformi<br />
nari, foliacei<br />
3) Calcificazione<br />
resistenza e rigidi- ben calcificati poco calcificati ben calcificati<br />
tà dello scheletro robusti, rigidi in frammenti<br />
4) Volume scheletro grandi piccoli dimensione media<br />
colonialità coloniali o gregari solitari o coloniali coloniali o gregari<br />
5) Biostratinomia in posizione di vita in situ in posizione di vita<br />
tafonomia o in situ (rotti, ribaltati) incrostanti<br />
trasportabilità (rotti, rovesciati) comunemente trasportati<br />
6) Impacchettamento generalmente come altamente variabile: da come in vita<br />
densità scheletrica in vita dispersi a concentrati<br />
nota: il carattere “arbitrario” di queste categorie deve comunque<br />
essere sempre tenuto in considerazione soprattutto per quanto<br />
riguarda le scogliere fossili, dove i diversi processi biostratinomici<br />
e tafonomici possono creare non pochi problemi nell’assegnare<br />
i diversi taxa alla propria categoria.<br />
FAGERSTROM, J. A., 1991, Reef-building guilds and checklist for determining guild membership.<br />
«Coral Reefs», 10, 47-52.<br />
(da Raffi & Serpagli, 1993-96)<br />
6.9
ORGANISMI COSTRUTTORI e<br />
AMBIENTE di SCOGLIERA i<br />
Vista la complessità <strong>della</strong> materia sono state fornite molte definizioni<br />
basate sui seguenti criteri e parametri:<br />
1) Presenza di una impalcatura organica (biocostruzione),<br />
2) Posizione rilevata rispetto al fondo circostante,<br />
3) Resistenza alle onde,<br />
4) Presenza limitata alla zona fotica,<br />
5) Distribuzione in acque calde tropicali.<br />
La struttura di una scogliera corallina attuale è controllata dall’interazione<br />
di cinque processi fondamentali (Scoffin, 1987): 1) crescita e sviluppo<br />
<strong>della</strong> biocostruzione primaria (primary framework growth). 2) biocostruzione<br />
secondaria (secondary framework), 3) erosione biologica e meccanica, 4)<br />
sedimentazione interna, 5) cementazione marina; dei quali solo i primi<br />
tre rivestono importanza bio-paleontologica poiché legati all’attività degli<br />
organismi.<br />
La parte contornata <strong>della</strong> scogliera figurata verrà riportata nella pagina<br />
seguente ingrandita, per una maggior comprensione dei processi<br />
fondamentali di crescita che operano sulla struttura di una scogliera in<br />
relazione alla profondità:<br />
1<br />
6.10 i
Attualmente i principali tipi di scogliere sono tre:<br />
sulla base <strong>della</strong> loro distanza dalla costa si distinguono:<br />
1) scogliera frangente<br />
(fringing reef)<br />
e<br />
2) Scogliera a barriera<br />
(barrier reef)<br />
2
In prossimità di un isola<br />
vulcanica subsidente<br />
1° fase: la costruzione corallina inizia<br />
attorno ad un’isola vulcanica in condizioni<br />
di optimum;<br />
3) atollo 2° fase: l’isola vulcanica inizia la sub-<br />
(atoll)<br />
sidenza ad una velocità pari a quella<br />
di crescita del corallo;<br />
Parametri<br />
ambientali<br />
Latitudine<br />
intervallo<br />
optimum<br />
Salinità (%)<br />
intervallo<br />
optimum<br />
Temperatura (°C)<br />
intervallo<br />
optimum<br />
Profondità (m)<br />
intervallo<br />
optimum<br />
(massima diversità)<br />
Zona fotica<br />
100m<br />
Zona afotica<br />
Coralli<br />
zooxantellati<br />
35° N-32°S<br />
23°N-23°S<br />
27-48<br />
34-36<br />
11-40<br />
23-28<br />
fino a 150<br />
fino a 25<br />
ermatipici<br />
assenti<br />
3° fase: subsidenza e crescita corallina<br />
continuano alla stessa velocità finché rimane<br />
emerso solo un anello esterno di<br />
corallo con una laguna interna.<br />
Coralli<br />
non zooxantellati<br />
70°N-78°S<br />
?<br />
34-36<br />
1-35<br />
6-10<br />
fino a 6200<br />
60-300<br />
aermatipici<br />
ermatipici<br />
aermatipici<br />
In tabella i maggiori parametri ambientali che controllano la distribuzione dei coralli<br />
attuali zooxantellati e non-zooxantellati (da Fargerstrom, 1987).<br />
Zooxantella = stadio sessile del dinoflagellato Symbiodinium microadriaticum i<br />
3
ORGANISMI BIOCOSTRUTTORI nel TEMPO<br />
Le scogliere del passato o scogliere fossili sono presenti nella colonna<br />
stratigrafica di tutti i continenti a partire dal Paleozoico fino al Terziario<br />
più recente. Nel tempo geologico vari tipi di animali si sono avvicendati<br />
pel produrre edifici biocostruiti con le caratteristiche tipiche degli ambienti<br />
recifali (vedi lucido 6.10 i).<br />
In figura modello schematico<br />
di scogliera fossile del Miocene sup.<br />
di Mallorca, Spagna.<br />
Secondo un modello attualistico, si può<br />
identificare un tipo di scogliera a frangente<br />
(fringing reef) (da Pomar, 1991, ridisegnato da<br />
Raffi & Serpagli, 1996)<br />
6.11 i
MORFOLOGIA FUNZIONALE<br />
Struttura degli<br />
MORFOLOGIA FUNZIONALE = Studio delle Etologia organismi<br />
relazioni fra Funzione<br />
Molte funzioni biologiche di un organismo sono in stretta<br />
relazione con le strutture scheletriche fossilizzabili<br />
6/11<br />
• l’elemento filogenetico (storia evolutiva del taxon)<br />
La morfologia di<br />
un organismo • l’elemento costruttivo (meccanismi di sviluppo<br />
deriva dal dell’organismo)<br />
• l’elemento adattativo (azione <strong>della</strong> selezione<br />
naturale nel plasmare<br />
strutture efficienti per la<br />
vita nell’ecosistema)<br />
Gli studi di morfologia funzionale dei fossili sono prevalentemente<br />
basati sul confronto tra organismi fossili e viventi che presentano<br />
strutture (analoghe ed omologhe) passibili di controllo sperimentale.<br />
Es. • arto dei vertebrati (tipo di arto −►tipo di attività)<br />
• denti dei mammiferi (−► dieta −►paleoambiente)<br />
• caratteristiche morfologiche delle valve dei bivalvi<br />
(modo di vita −►specializzazioni trofiche)