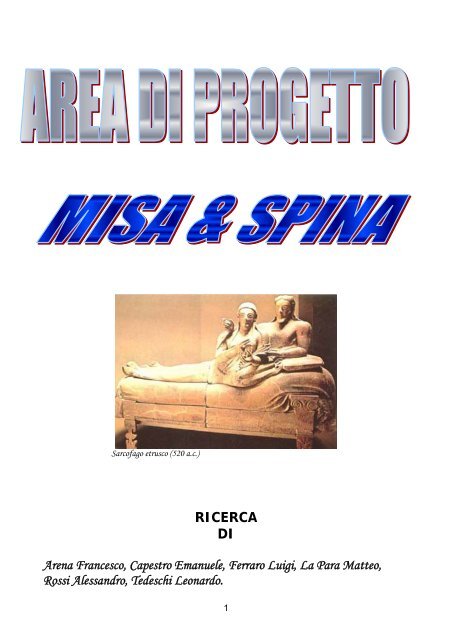NECROPOLI di MISA - iismajoranasanlazzaro
NECROPOLI di MISA - iismajoranasanlazzaro
NECROPOLI di MISA - iismajoranasanlazzaro
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Sarcofago etrusco (520 a.c.)<br />
RICERCA<br />
DI<br />
Arena Francesco, Capestro Emanuele, Ferraro Luigi, La Para Matteo,<br />
Rossi Alessandro, Tedeschi Leonardo.<br />
1
INDICE<br />
..Dalle Origini…<br />
pag. 3 - Introduzione<br />
pag. 3 - Età Arcaica<br />
pag. 4 - Età Classica<br />
pag. 4 - Età Ellenistica<br />
pag. 5 - Etruria Padana<br />
<strong>MISA</strong><br />
pag. 7 - Etruschi a Marzabotto<br />
pag. 8 - Montovolo Montagna Sacra<br />
pag. 9 - Necropoli <strong>di</strong> Misa<br />
pag. 10 - I Sepolcreti<br />
pag. 11 - Città <strong>di</strong> Misa<br />
pag. 13 - Resti della Città<br />
pag. 14 - Storia degli Scavi<br />
pag. 15 - L’ Acquedotto<br />
SPINA<br />
pag. 17 - Etruschi a Spina<br />
pag. 17 – Necropoli <strong>di</strong> Spina<br />
pag. 18 - Architettura Funeraria<br />
pag. 18 - Le Sepolture<br />
pag. 19 - Gli Scavi<br />
A spasso per Misa…<br />
pag. 20 – La Città<br />
pag. 22 - Il Sepolcreto Est<br />
pag. 24 - L’ Acropoli<br />
2
Le origini degli etruschi rimangono oscure; già nell'antichità esistevano varie ipotesi in<br />
merito: lo storico greco Erodoto asseriva che provenissero dalla Li<strong>di</strong>a, regione dell'Asia<br />
Minore occidentale. Questa ipotesi venne accolta in seguito sia da Livio sia da Polibio;<br />
Dionigi <strong>di</strong> Alicarnasso, invece, sosteneva che gli etruschi fossero una popolazione<br />
in<strong>di</strong>gena dell'Italia. La ricerca archeologica ha gettato nuova luce sulla più antica storia<br />
etrusca: è oggi opinione comune che i primi inse<strong>di</strong>amenti etruschi ebbero luogo nelle<br />
basse e paludose regioni costiere della Toscana. I primi inse<strong>di</strong>amenti stabili – Vetulonia e<br />
Tarquinia – datano dalla fine del IX secolo a.C. I ritrovamenti relativi a questa fase sono<br />
caratterizzati da nuovi tipi <strong>di</strong> camere funerarie, che si <strong>di</strong>stinguono nettamente dalle<br />
precedenti tipologie tombali e che contengono corre<strong>di</strong> funerari molto ricchi, comprendenti<br />
oggetti in ambra, argento, oro e gemme provenienti dall'Egitto e dall'Asia Minore. La<br />
particolare combinazione <strong>di</strong> originalità e imitazione nell'arte etrusca e i caratteri peculiari<br />
della loro religione hanno fatto pensare che questo popolo fosse originario <strong>di</strong> qualche<br />
regione del Me<strong>di</strong>terraneo orientale, posta tra la Siria e l'Ellesponto.<br />
INTRODUZIONE<br />
La produzione artistica etrusca manca sostanzialmente <strong>di</strong> unitarietà: non presenta<br />
caratteri costanti né nello spazio, né nel tempo, e neppure nella qualità degli esiti raggiunti.<br />
Una possibile spiegazione <strong>di</strong> tale fenomeno appare in<strong>di</strong>viduabile nella con<strong>di</strong>zione sociale<br />
degli artisti e degli artigiani i quali, asserviti alle classi aristocratiche dominanti, videro<br />
ostacolata quella stabilità nella trasmissione <strong>di</strong> tecniche e stilemi necessaria per istituire<br />
scuole locali o botteghe, e quin<strong>di</strong> per il costituirsi <strong>di</strong> una solida tra<strong>di</strong>zione artistica. Tuttavia,<br />
tale <strong>di</strong>scontinuità si associò a una costante richiesta, da parte della committenza, <strong>di</strong><br />
prodotti artistici dotati <strong>di</strong> peculiarità ben determinate, che condusse allo sviluppo <strong>di</strong><br />
laboratori locali specializzati; la destinazione principale della produzione artistica fu<br />
sempre il culto, caratterizzato da una rigida cerimonialità.<br />
L’ETA’ ARCAICA (VII-VI SECOLO A.C.)<br />
Nel corso del periodo arcaico<br />
furono in particolare le ricche<br />
città dell'Etruria meri<strong>di</strong>onale –<br />
Tarquinia, Cerveteri, Veio –<br />
quelle che svilupparono una<br />
propria tra<strong>di</strong>zione figurativa,<br />
creando scuole locali<br />
specializzate in <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong><br />
manufatti. Notevoli esiti in<br />
ambito architettonico, nella<br />
lavorazione dei metalli<br />
(oreficerie, argenterie, bronzi<br />
smaltati e fusi) e nella<br />
produzione ceramica si<br />
3
egistrano soprattutto a Cerveteri. Straor<strong>di</strong>nari esempi <strong>di</strong> pittura monumentale funeraria,<br />
realizzata con la tecnica dell'affresco, si trovano nelle tombe <strong>di</strong> Tarquinia; da Veio si<br />
<strong>di</strong>ffusero le ceramiche dei pittori etrusco-corinzi, oltre a pregevoli candelabri, specchi e<br />
statuette in bronzo. A Veio si colloca l'attività della scuola <strong>di</strong> scultura cui è legato il nome<br />
dell'unico artista etrusco a noi noto, quel Vulca che lavorò, secondo le fonti antiche, per il<br />
tempio Capitolino <strong>di</strong> Roma e al quale sono attribuite le sculture del tempio <strong>di</strong> Apollo<br />
Veiente (Museo nazionale <strong>di</strong> Villa Giulia, Roma). Chiusi, infine, registra il fiorire dell'attività<br />
<strong>di</strong> artigiani specializzati nella decorazione dei cosiddetti canopi (urne cinerarie a testa<br />
umana) e <strong>di</strong> un tipo <strong>di</strong> piccole urne che si <strong>di</strong>ffusero in seguito nell'Etruria settentrionale (a<br />
Volterra, Perugia, Fiesole). Lo splendore dell’arte in questa fase della storia etrusca<br />
costituisce il riflesso della ricchezza e del prestigio internazionale raggiunti dalle locali<br />
aristocrazie: la loro adesione ai principi della cultura greca si manifestò, oltre che nella<br />
produzione artistica, anche nell'adozione <strong>di</strong> costumi (il banchetto, la caccia, l'esaltazione<br />
delle tra<strong>di</strong>zioni gentilizie) e perfino <strong>di</strong> consuetu<strong>di</strong>ni religiose (culto degli avi, celebrazione <strong>di</strong><br />
giochi funebri) <strong>di</strong> matrice ellenica. Il linguaggio figurativo dei <strong>di</strong>versi centri dell'Etruria<br />
venne profondamente segnato dall'attività <strong>di</strong> artisti e artigiani che dal mondo greco si<br />
stabilirono permanentemente nelle ricche città etrusche: dapprima, nel VII secolo a.C.,<br />
legati alle colonie greche d'Occidente e al mondo orientale siro-fenicio e cipriota, e in<br />
seguito, nel corso del VI secolo a.C., portatori <strong>di</strong> quella cultura ionica che si venne<br />
imponendo a livello internazionale come il linguaggio figurativo comune del Me<strong>di</strong>terraneo<br />
arcaico.<br />
L’ETA’ CLASSICA (V SECOLO A.C.)<br />
Agli inizi del V secolo a.C. la società etrusca visse una profonda crisi politica, sottolineata<br />
da <strong>di</strong>fficoltà interne e dalla per<strong>di</strong>ta dell'egemonia sul Tirreno e nell'entroterra laziale: tappe<br />
cruciali <strong>di</strong> questa fase <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà furono la sconfitta navale <strong>di</strong> Cuma contro i siracusani<br />
(474 a.C.), la battaglia <strong>di</strong> Ariccia (504 a.C.) e la calata dei sabelli (metà del V secolo a.C.).<br />
La grande tra<strong>di</strong>zione dell'arte arcaica etrusca entrò definitivamente in crisi: la produzione si<br />
ridusse sia nella quantità sia nella qualità, limitandosi a una stanca ripetizione <strong>di</strong> motivi e <strong>di</strong><br />
moduli; pressoché assenti furono le ricerche e le novità espresse negli stessi anni in<br />
Grecia dallo stile severo e dall'arte classica dell'età <strong>di</strong> Pericle. Proprio da quest’epoca data<br />
il progressivo <strong>di</strong>stacco dell’arte romana da quella etrusca: la città laziale, liberatasi dai<br />
sovrani <strong>di</strong> stirpe etrusca, vide affermarsi nell’arte una progressiva autonomia espressiva,<br />
frutto <strong>di</strong> contatti <strong>di</strong>retti con il mondo greco. Nacquero a Roma importanti laboratori artistici<br />
e artigianali, specializzati nella coroplastica (lavorazione della terracotta) o nella<br />
bronzistica.<br />
IL IV SECOLO E L’ETA’ ELLENISTICA<br />
Agli inizi del IV secolo nelle città-stato dell'Etruria un nuovo tipo <strong>di</strong> aristocrazia,<br />
politicamente organizzata con magistrature <strong>di</strong> tipo repubblicano, avviò una ripresa politica<br />
e culturale che, seppure lentamente, ebbe positive ripercussioni anche nell'ambito della<br />
produzione figurativa. Ceramisti, pittori e scultori greci tornarono a stabilirsi in Etruria,<br />
contribuendo allo sviluppo <strong>di</strong> nuovi laboratori locali a Cerveteri, Tarquinia, Vulci, e anche<br />
nelle città settentrionali: statue cinerarie e urne in ceramica vennero prodotte a Chiusi,<br />
urne in alabastro a Volterra, oggetti in travertino a Perugia, mentre in ogni città fiorì una<br />
scuola <strong>di</strong> ceramografi. I modelli a cui si fece riferimento provenivano da Taranto, da<br />
Siracusa e dalla Campania, centri <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffusione delle tecniche, dei moduli figurativi e degli<br />
4
schemi decorativi della grecità d'Occidente. A partire dal III secolo a.C., le gravi sconfitte<br />
inferte dal nascente astro <strong>di</strong> Roma e la progressiva sottomissione ai nuovi padroni del<br />
Me<strong>di</strong>terraneo portarono al declino della potenza etrusca, minacciata inoltre al proprio<br />
interno da rivolte <strong>di</strong> schiavi. Le aristocrazie locali vennero gradatamente integrate<br />
all'interno della struttura sociale romana. Quelle che erano state prospere città si ridussero<br />
a centri <strong>di</strong> passiva ricezione <strong>di</strong> temi e <strong>di</strong> moduli figurativi ellenistici, in cui marcati fenomeni<br />
<strong>di</strong> conservatorismo si associarono all'isolamento culturale <strong>di</strong> una committenza ormai<br />
marginale, periferica, provocando <strong>di</strong> fatto la fine <strong>di</strong> qualsiasi forma autonoma <strong>di</strong> produzione<br />
artistica etrusca.<br />
ETRURIA PADANA<br />
Il Ponte della Ba<strong>di</strong>a<br />
sul fiume Fiora, nei<br />
<strong>di</strong>ntorni <strong>di</strong> Vulci. Di<br />
epoca etrusco-romana<br />
(I secolo a.C.),<br />
testimonia la perizia<br />
ingegneristica dei<br />
costruttori: tre arcate a<br />
tutto sesto alternate a<br />
possenti pilastri<br />
alleggeriscono la<br />
struttura nello stesso<br />
tempo in cui creano un<br />
efficace sistema <strong>di</strong><br />
spinte e constrospinte<br />
al quale si deve la<br />
longevità della<br />
costruzione.<br />
Originariamente gli Etruschi abitarono nei territori della Toscana e del Lazio settentrionale,<br />
in quella regione definita Etruria tirrenica sulla base dell'appellativo <strong>di</strong> Tyrrenoi che gli<br />
antichi Greci attribuivano a questa popolazione. Le fonti storiche, greche e latine, ci<br />
informano <strong>di</strong> un' espansione etrusca verso l'Italia meri<strong>di</strong>onale, nell' attuale Campania, e<br />
verso nord, nella valle del Po, avvenuta fin dai tempi più antichi. Nella pianura padana l'<br />
espansione portò alla realizzazione <strong>di</strong> una confederazione <strong>di</strong> do<strong>di</strong>ci città, analoga a quella<br />
che già esisteva nella madrepatria tirrenica. La fondazione <strong>di</strong> queste città, numericamente<br />
superiori rispetto a quanto è sinora noto sulla base delle testimonianze archeologiche,<br />
sarebbe avvenuta secondo alcuni autori ad opera <strong>di</strong> Ocnus, il fondatore <strong>di</strong> Perugia,<br />
secondo altri ad opera <strong>di</strong> Tarconte, l'eroe fondatore ed eponimo <strong>di</strong> Tarquinia. La<br />
documentazione archeologica suggerisce <strong>di</strong> accettare entrambe le tra<strong>di</strong>zioni, attribuendole<br />
5
a due <strong>di</strong>versi momenti <strong>di</strong> profondo mutamento del quadro politico ed economico<br />
dell'Etruria padana, dovuto all'arrivo <strong>di</strong> Etruschi dall'area tirrenica, unito ad un forte<br />
contributo apportato dalla popolazione locale. La prima "colonizzazione", riferibile a<br />
Tarconte, viene fatta risalire agli inizi dell'età del Ferro (IX sec. a.C.), e ha come finalità il<br />
reperimento <strong>di</strong> nuove terre per lo sfruttamento agricolo; la seconda, riferibile a Ocnus, è<br />
databile alla metà del VI secolo, e implica un riassetto <strong>di</strong> tutta la regione padana allo scopo<br />
<strong>di</strong> incrementare le attività commerciali.<br />
A partire dalla fine del IX secolo, il popolamento nella valle del Po, precedentemente<br />
organizzato in piccoli nuclei <strong>di</strong> capanne sparsi per tutto il territorio, si concentra nell'area <strong>di</strong><br />
Bologna, il principale centro dell'Etruria padana, e <strong>di</strong> Verucchio, fiorente inse<strong>di</strong>amento<br />
ubicato nel cuore della Romagna. I due centri, nettamente <strong>di</strong>stinti sul piano topografico, si<br />
<strong>di</strong>fferenziano anche per i <strong>di</strong>versi ruoli svolti nell'organizzazione socio economica del<br />
territorio. Bologna, grazie a numerose opere <strong>di</strong> bonifica e canalizzazione, arriva a sfruttare<br />
le risorse agricole, destinate agli scambi <strong>di</strong> tutti i territori circostanti, espandendosi sino al<br />
corso del Po verso nord, nelle aree modenesi e reggiane sino alla valle dell'Enza a est,<br />
sino ai valichi appenninici a sud, e sino alla valle del Mezzano a ovest. Accanto ad attività<br />
<strong>di</strong> sussistenza minori, come la caccia e la pastorizia, fioriscono le produzioni<br />
manifatturiere, e in particolar modo il settore metallurgico, con la lavorazione del bronzo e<br />
del ferro. La crescente ricchezza economica e lo sviluppo sociale <strong>di</strong> Bologna, apportano<br />
un importante contributo alla sua funzione <strong>di</strong> me<strong>di</strong>atrice tra l'Etruria tirrenica e l'Italia<br />
settentrionale. Tale ruolo è documentato dalla <strong>di</strong>ffusione verso il nord Italia <strong>di</strong> prodotti<br />
artigianali tirrenici (bronzi, vino e profumi) che arrivano insieme a impulsi artistici e<br />
culturali, tra i quali è fondamentale l'acquisizione dell'alfabeto e della scrittura etrusca,<br />
precocemente praticati nel centro padano e rapidamente trasmessi a settentrione. Diverso<br />
è il ruolo svolto da Verucchio, posta a controllo della valle del Marecchia e della costa<br />
adriatica, meno interessata allo sfruttamento agricolo del territorio rispetto a Bologna e<br />
de<strong>di</strong>ta principalmente ad attività commerciali.<br />
6
ETRUSCHI a MARZABOTTO<br />
Oltre che in area tirrenica (Toscana e Lazio settentrionale) gli Etruschi furono presenti<br />
anche nella Valle Padana dove, fin dal {X secolo a.C.. svolsero un'importante ruolo <strong>di</strong><br />
interme<strong>di</strong>ari tra il Me<strong>di</strong>terraneo da un lato e l'Europa continentale dall'altro e dove<br />
realizzarono, per la prima volta nella nostra regione, un sistema <strong>di</strong> città»: Bologna,<br />
l'antica Felsina; Spina, sull'Adriatico; aperto ai commerci greci, la città <strong>di</strong> Spina; a nord<br />
del Po, con funzione <strong>di</strong> testa <strong>di</strong> ponte verso l'area transalpina, la città <strong>di</strong> Mantova;<br />
sull'Appennino, lungo la valle del Reno, che costituiva la via principale <strong>di</strong> collegamento<br />
tra l'Etruria tirrenica e l'Etruria padana, la città etrusca <strong>di</strong> Marzabotto. La città etrusca <strong>di</strong><br />
Marzabotto, fondata ex-novo agli inizi del V secolo su una piana <strong>di</strong> origine fluviale<br />
pressoché privo <strong>di</strong> strutture preesistenti fu realizzata secondo rigorosi criteri urbanistici,<br />
in cui l'estrema regolarità delI'impianto risponde anche a precise esigenze <strong>di</strong> una<br />
razionale organizzazione urbana oltre che <strong>di</strong> una vera pianificazione. Strade e isolati,<br />
tracciati sul terreno in un solo momento, costituivano l'ossatura dell'impianto, all'interno<br />
del quale doveva sorgere e svilupparsi la città secondo una previsionalità inse<strong>di</strong>ativa<br />
molto larga, che non fu mai del tutto saturata. Alcuni isolati infatti, pur essendo<br />
regolarmente tracciati nei loro limiti estremi, sono vuoti perché non furono mai utilizzati.<br />
All'estremità nord ed est sono collocate le due necropoli; mentre a nord-ovest, in<br />
posizione elevata rispetto all'area urbana, è situata l'acropoli con il complesso degli<br />
e<strong>di</strong>fici sacri costituiti da templi con i rispettivi altari. AlI'interno dell'area urbana, oltre<br />
naturalmente alle case <strong>di</strong> abitazione, sono documentati impianti artigianali <strong>di</strong> un certo<br />
rilievo come fornaci per la cottura <strong>di</strong> ceramiche e laterizi destinati al fabbisogno interno;<br />
officine per la fusione del bronzo e ateliers per la lavorazione del ferro i cui prodotti<br />
erano invece destinati anche all'esportazione. È evidente che la città etrusca <strong>di</strong><br />
Marzabotto, ancora intatta nelle sue strutture, costituisce un terreno ideale per lo stu<strong>di</strong>o<br />
dell'urbanistica e dell'architettura etrusca e, più in generale. per lo stu<strong>di</strong>o della stona e<br />
della vita degli Etruschi. L'area archeologica, <strong>di</strong>slocata in un bellissimo scenario<br />
appenninico, e l'annesso Museo costituiscono infatti uno dei documenti più rilevanti <strong>di</strong><br />
questa civiltà. Ogni estate si alternano gruppi <strong>di</strong> studenti e giovani laureati che oltre ad<br />
imparare le tecniche dello scavo archeologico sono impegnati nella scoperta <strong>di</strong> nuovi<br />
materiali che vanno ad arricchire il già consistente patrimonio <strong>di</strong> questa che può<br />
legittimamente essere considerata la più importante area archeologica della Regione<br />
Emilia Romagna.<br />
7
MONTOVOLO Montagna SACRA<br />
La Pietra Ovale <strong>di</strong> Montovolo come simbolo sacro nelle Necropoli Etrusche <strong>di</strong><br />
Marzabotto.<br />
Circa 15 km da Montovolo lungo la strada che conduce a Bologna esistono i resti<br />
dell'antica città etrusca <strong>di</strong> Misa (nel comune <strong>di</strong> Marzabotto ). La sua scoperta è avvenuta<br />
nella seconda metà del 1800 e fino da allora i resti <strong>di</strong> questa antica città etrusca<br />
destarono meraviglia in tutto il mondo (gli scavi e le ricerche continuano tuttora con il<br />
contributo anche dell'Università <strong>di</strong> Bologna ). Stupiscono la regolarità della sua pianta<br />
ortogonale con strade principali larghe 15 m orientate<br />
nord-sud che si incrociano con strade più strette larghe<br />
5 m orientate est-ovest che <strong>di</strong>sponevano anche <strong>di</strong><br />
marciapie<strong>di</strong>. Stupiscono pure la vasta rete <strong>di</strong> impianti<br />
idrici e scarichi fognari e la <strong>di</strong>visione dei vari quartieri<br />
residenziali ed artigianali con particolare riguardo alla<br />
lavorazione dei metalli e produzione <strong>di</strong> ceramiche.<br />
Questa città aveva anche i suoi templi nell'Acropoli e le<br />
sue due Necropoli. La scoperta della città <strong>di</strong> Misa nella<br />
sua totale ampiezza, dava, in parte, concretezza alla<br />
leggendaria esistenza <strong>di</strong> una lega delle do<strong>di</strong>ci città a<br />
nord dell'Appennino. Se esisteva una dodecapoli<br />
doveva esserci anche la sua Montagna Sacra dove i<br />
Lucumoni si riunivano per prendere le decisioni più<br />
importanti. Le prove sono subito comparse ! La prima<br />
stranezza che compare davanti ai visitatori delle<br />
Necropoli è vedere che sopra <strong>di</strong>verse tombe vi è una<br />
grossa pietra Ovale. Alcune le più belle sono nel Museo<br />
Aria ! Ovali in marmo ( visibili nel vicino museo e<br />
descritte come peculiarità <strong>di</strong> questa zona dell'Etruria anche se alcune sono state trovate<br />
nella Necropoli Etrusca <strong>di</strong> Pisa) con incise motivi molto significativi sono stati ritrovati in<br />
tombe monumentali sempre a Marzabotto. Questo fatto ci fa intravedere che<br />
probabilmente ogni tomba aveva sopra una pietra Ovale . Oggi nei nostri cimiteri ogni<br />
tomba ha sopra il suo simbolo religioso, che per noi è la Croce . Allora il simbolo<br />
religioso <strong>di</strong> quella dodecapoli o solo città era la pietra Ovale. Se è cosi la Montagna<br />
Sacra è Montovolo che anche nel nome conserva tuttora il significato <strong>di</strong> Monte dalla<br />
pietra Ovale. Ma questa pietra Ovale, come abbiamo descritto in precedenza, era<br />
l'Omphalos o simbolo del Centro Oracolare Etrusco che si trovava a Montovolo.<br />
8
<strong>NECROPOLI</strong> <strong>di</strong> <strong>MISA</strong><br />
Appena si entra nella Necropoli detta<br />
Orientale, sembra <strong>di</strong> entrare in un<br />
nostro cimitero <strong>di</strong> campagna un poco<br />
abbandonato. Infatti c'è un'entrata a cui<br />
manca solo il cancello in ferro, che<br />
serviva come oggi per isolare la zona<br />
dei morti da quella dei vivi. Dall'entrata<br />
si notano subito tutte le tombe alcune<br />
dette a cassone e molte sepolture in<br />
terra (fosse). A queste tombe mancava<br />
solo il simbolo della "nostra" Croce ma<br />
al posto della Croce c'è una pietra<br />
Ovale, il loro simbolo religioso! Le due<br />
necropoli della città etrusca <strong>di</strong><br />
Marzabotto sono situate imme<strong>di</strong>atamente al <strong>di</strong> fuori delle porte nord e est della città e il<br />
loro attuale aspetto appare profondamente mutato rispetto all’originario a causa <strong>di</strong><br />
interventi ottocenteschi. La scelta <strong>di</strong> a<strong>di</strong>bire queste aree a sepolcreti è dettata da un lato<br />
dalla consuetu<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> seppellire i morti al <strong>di</strong> fuori dell’abitato, come nella maggior parte<br />
delle civiltà antiche, dall’altro da una relazione profonda tra le tombe e le strade <strong>di</strong> accesso<br />
alla città. Alla porta nord giungeva infatti la via proveniente da Felsina, mentre dalla porta<br />
est aveva inizio il percorso che, attraverso gli Appennini, metteva in collegamento l’Etruria<br />
padana con quella tirrenica. Questi particolari spazi destinati a necropoli, con le tombe<br />
<strong>di</strong>sposte ai due lati delle vie <strong>di</strong> accesso alla città, rappresentavano certamente un segno <strong>di</strong><br />
prestigio per la comunità che viveva a Marzabotto nei confronti <strong>di</strong> chi giungeva in città. I<br />
numerosi segnacoli funerari, la cui posizione originaria non è più ricostruibile, costituivano<br />
infatti un elemento <strong>di</strong> monumentalizzazione e stando alle ridotte <strong>di</strong>mensioni della necropoli<br />
dovevano essere comunque ben<br />
visibili. Nella necropoli est questo<br />
carattere monumentale era<br />
ulteriormente enfatizzato dalla<br />
presenza <strong>di</strong> uno spiazzo<br />
prospiciente la porta nel quale si<br />
trovava un luogo <strong>di</strong> culto a cui è<br />
riferibile il rinvenimento <strong>di</strong> alcuni<br />
bronzetti. Più vaghe sono invece le<br />
notizie riguardanti il sepolcreto<br />
settentrionale, dove la presenza <strong>di</strong><br />
una via sepolcrale, certamente<br />
esistente, è desumibile<br />
esclusivamente dalla <strong>di</strong>sposizione<br />
delle tombe in due gruppi ben <strong>di</strong>stinti<br />
ai lati <strong>di</strong> uno spazio centrale libero. La tipologia delle tombe documentata a Marzabotto è<br />
abbastanza omogenea. Ad alcune decine <strong>di</strong> inumazioni, entro fossa rivestita <strong>di</strong> ciottoli, si<br />
contrappone la prevalenza <strong>di</strong> sepolture ad incinerazione, sia entro pozzetti internamente<br />
rivestiti <strong>di</strong> ciottoli sia, nella maggior parte dei casi, in tombe a cassone costituite da gran<strong>di</strong><br />
lastre <strong>di</strong> travertino sormontate da un segnacolo. La tipologia della tomba a cassone<br />
richiama l’Etruria tirrenica settentrionale, in particolare Populonia, ma è inoltre<br />
documentata in un unico caso anche a Bologna. Elemento probabilmente riconducibile<br />
all’importante ruolo <strong>di</strong> me<strong>di</strong>azione svolto da Marzabotto nell’ambito dei rapporti tra Felsina<br />
9
e l’Etruria tirrenica. Ad un più ampio quadro topografico, comunque sempre relativo<br />
all’Etruria settentrionale e interna (Volterra, Pisa, Orvieto), sono riconducibili i pochi<br />
segnacoli particolari della città. Al <strong>di</strong> sopra delle tombe, tra<strong>di</strong>zionalmente ritenute<br />
completamente interrate, erano infatti collocati nella maggior parte dei casi grossi ciottoli <strong>di</strong><br />
fiume <strong>di</strong> forma vagamente sferica, accanto ai quali si pongono alcuni esempi <strong>di</strong> monumenti<br />
funerari più ricercati: colonne forse sormontate da una sfera, una stele con defunta<br />
eroizzata rappresentata in atto <strong>di</strong> libare e alcuni cippi a bulbo, <strong>di</strong> cui uno con scena <strong>di</strong><br />
giochi funebri, innestati su una base con angoli decorati da protomi <strong>di</strong> ariete; a questi si<br />
aggiungono tre statue frammentarie in marmo <strong>di</strong> ispirazione o ad<strong>di</strong>rittura <strong>di</strong> produzione<br />
greca, fra le quali in particolare una testa <strong>di</strong> kouros, per cui si è ipotizzata un’analoga<br />
destinazione funeraria sulla base <strong>di</strong> un confronto con Bologna, per il quale è certa la<br />
provenienza da un contesto sepolcrale.<br />
I corre<strong>di</strong> funerari sono stati smembrati, ma è comunque possibile riconoscere l’adesione<br />
profonda all’ideologia funeraria del banchetto, comune a tutte le città dell’Etruria. Vasi<br />
importati dalla Grecia (per lo più crateri, kylikes e skyphoi, appunto connessi al consumo<br />
del vino) e bronzi pregiati (vasellame e strumenti per la preparazione del vino e il rituale<br />
del banchetto) testimoniano una notevole apertura commerciale della città etrusca <strong>di</strong><br />
Marzabotto e il pieno inserimento nei circuiti più vitali, non solo dal punto <strong>di</strong> vita economico<br />
ma anche sociale e culturale.<br />
I SEPOLCRETI<br />
A Marzabotto esistono due<br />
sepolcreti: uno a Nord e l’altro a Est<br />
della città.<br />
Entrambi comprendevano alcuni<br />
principali tipi <strong>di</strong> tombe: a cassone<br />
(lastre <strong>di</strong> travertino), a fossa<br />
(rivestite a ciottoli) e a pozzetto (con<br />
cinerario). Per le tombe a cassetto il<br />
rito <strong>di</strong> norma era l’incinerazione,<br />
come per le tombe a pozzetto; le<br />
tombe a fossa raccoglievano gli<br />
inumati. Nel sepolcreto Nord<br />
esistevano circa 170 tombe, in<br />
maggior parte a cassone; ne<br />
rimangono solamente 91. Il sepolcreto era tagliato a metà da una strada. Nel sepolcreto<br />
Est si trovavano 125 tombe, <strong>di</strong> cui 62 a cassone, 55 a fossa e 8 a pozzetto. Anche in<br />
questo caso erano <strong>di</strong>stribuite ai lati <strong>di</strong> una strada che tagliava a metà il sepolcreto, e<br />
conduceva alla porta Est.<br />
Le piante <strong>di</strong> entrambi i sepolcreti rispecchiano la situazione attuale.<br />
Le tombe, interamente infossate nel terreno, erano in<strong>di</strong>cate da segnacoli che sporgevano<br />
dal suolo, per la maggior parte dei grossi ciottoli prelevati dal vicino fiume Reno e, talvolta,<br />
parzialmente levigati. Alcuni segnacoli erano costituiti però da travertino a forma <strong>di</strong><br />
colonnetta. Tutti questi segnacoli sono stati datati al pieno V secolo a.C. Le sepolture<br />
comprendono solitamente un corredo che riuniva oggetti <strong>di</strong> tipo <strong>di</strong>verso: dalle ceramiche<br />
10
CITTA’ <strong>di</strong> <strong>MISA</strong> a MARZABOTTO<br />
locali ai gran<strong>di</strong> vasi greci,<br />
dalle suppellettili <strong>di</strong> bronzo<br />
agli oggetti <strong>di</strong> pasta vitrea,<br />
d’osso, d’ambra, <strong>di</strong> alabastro<br />
e <strong>di</strong> ricca oreficeria ,tutti<br />
databili dal VI al IV secolo<br />
a.C.<br />
Molto importanti sono le<br />
ceramiche attiche importate<br />
attraverso l’emporio <strong>di</strong> Spina<br />
e trasportate via terra fino a<br />
Marzabotto che <strong>di</strong>mostrano i<br />
contatti commerciali con la<br />
Grecia.<br />
Fondata secondo un piano<br />
urbanistico regolare,<br />
proprio <strong>di</strong> una mentalità<br />
che tende a <strong>di</strong>stribuire in<br />
modo pianificato le<br />
emergenze urbane,<br />
secondo gli schemi della<br />
limitazione, Misa a<br />
Marzabotto è organizzata<br />
ortogonalmente, con<br />
strade <strong>di</strong>sposte secondo<br />
un rigido orientamento<br />
astronomico. Quelle<br />
principali (una sola in<br />
senso nord-sud, tre in<br />
senso est-ovest) sono<br />
larghe circa 15 metri e presentano una sede centrale per i veicoli e due laterali per i<br />
pedoni. Lo spazio era ulteriormente <strong>di</strong>viso in lotti rettangolari tramite strade minori,<br />
larghe circa 5 metri, parallele al grande asse viario nord-sud; le <strong>di</strong>mensioni dei lotti, non<br />
uniformi, variano da 250-280 m <strong>di</strong> lunghezza per 30 circa <strong>di</strong> larghezza. Gli isolati erano<br />
occupati sia da abitazioni, sia da impianti manifatturieri.<br />
Le case <strong>di</strong> abitazione affacciate lungo le strade, dovevano essere a un solo piano: gli<br />
ambienti si <strong>di</strong>sponevano attorno a un cortile centrale aperto, dove per solito si trova un<br />
pozzo, e la copertura del tetto doveva essere <strong>di</strong>spluviata, dati i canali <strong>di</strong> raccolta delle<br />
acque rinvenuti nelle corti. Costruite su fondamenta eseguite in ciottoli fluviali, avevano<br />
pareti realizzate con argilla pressata e intelaiatura lignea. Tutta la parte sud-orientale<br />
dell'acropoli poggia su una terrazza artificiale: la regolarità della <strong>di</strong>sposizione era stata<br />
rigorosamente osservata correggendo, se del caso, la formazione naturale del terreno<br />
con massicciate sui declivi e lavori <strong>di</strong> livellamento. Lungo l'ampio cardo si stendevano un<br />
tempo lunghe file <strong>di</strong> officine e fabbriche. Piccoli ateliers lavoravano pure nel cuore della<br />
11
città. L'artigianato artistico<br />
su base industriale, in<br />
particolare quello della<br />
lavorazione dei metalli, ebbe<br />
certo, accanto al<br />
commercio, una grande<br />
importanza.<br />
Ogni costruzione era,<br />
conformemente, dotata <strong>di</strong><br />
tutto il necessario. Un lungo<br />
corridoio portava nella corte<br />
interna, dov'era il luogo <strong>di</strong><br />
fabbricazione, dotata <strong>di</strong><br />
pozzi e impianti <strong>di</strong> lavaggio,<br />
e anche <strong>di</strong> un canale<br />
coperto per lo scarico delle<br />
acque industriali. Sul<br />
davanti, verso la strada<br />
principale, correva un<br />
marciapiede largo cinque<br />
metri, dove si esponevano le<br />
merci prodotte e gli articoli<br />
preziosi. Per le sua<br />
posizione e per le aree<br />
manifatturiere in<strong>di</strong>viduate<br />
essa appare un centro con prevalente vocazione commerciale e manifatturiera piuttosto<br />
che agricola, teso allo sfruttamento della zona (boschi, cava e forse giacimenti minerari).<br />
E' indubbio che ci troviamo <strong>di</strong> fronte ad un impianto urbano me<strong>di</strong>ato, probabilmente<br />
attraverso il porto <strong>di</strong> Spina, da modelli tipicamente greci, secondo un sistema urbano<br />
tra<strong>di</strong>zionalmente connesso ad Ippodamo <strong>di</strong> Mileto. Ciò non esclude, comunque, una<br />
certa esperienza da parte <strong>di</strong> pianificatori locali nell'applicazione <strong>di</strong> queste norme<br />
urbanistiche. Le evidenze archeologiche raccolte permettono <strong>di</strong> considerare Misa o<br />
Marzabotto come un caso <strong>di</strong> "trapianto" coloniale avvenuto per il trasferimento <strong>di</strong> gruppi<br />
proveniente dall'area centrale dell'Etruria (la scrittura in uso presenta caratteri simili a<br />
quella <strong>di</strong> Chiusi) e la ricerche, si venne alla grande sorpresa: nel profondo della terra<br />
dormivano le rovine <strong>di</strong> una città etrusca, la prima che sarebbe riemersa in tutta la sua<br />
compiutezza. La città rimase fino a poco tempo fa l'unica ricomparsa alla luce.<br />
Marzabotto, forse l’antica Misa citata sui Cippi <strong>di</strong> Rubiera, era posta nelle vicinanze della<br />
capitale dell’Etruria padana: Felsina come scrive Plinio. Per qualcuno questa città fu un<br />
posto <strong>di</strong> frontiera <strong>di</strong> Felsina, ipotesi non accettabile vista l’importanza e la <strong>di</strong>fferente cultura<br />
materiale. Infatti nonostante i pochi chilometri la cultura <strong>di</strong> Marzabotto è profondamente<br />
<strong>di</strong>versa da quella Felsinea: meno fastosa nel complesso con presenza <strong>di</strong> materiale greco<br />
ma <strong>di</strong> qualità evidentemente più modesta dato che ci chiarisce il livello sociale degli<br />
abitanti. Non ci sono le gran<strong>di</strong> Stele figurate poste a segnalare le sepolture, ma abbiamo<br />
cippi più semplici che troviamo simili ad Orvieto, Perugia e a Chiusi. Possiamo quin<strong>di</strong><br />
stabilire che a Marzabotto sorse una città coloniale fondata da coloni provenienti<br />
dall’Etruria interna, in connessione col vasto fenomeno cha va sotto il nome <strong>di</strong> 2°<br />
12
colonizzazione, quella che alla fine del VI secolo a.C. vide un’occupazione capillare <strong>di</strong> tutta<br />
la pianura Padana.<br />
RESTI della CITTA’<br />
Marzabotto sorse<br />
contemporaneamente<br />
a Spina il porto etrusco<br />
più importante da<br />
questo momento in poi.<br />
Infatti, tutti i commerci<br />
greci trovando <strong>di</strong>fficoltà<br />
nel mar Tirreno, a<br />
causa del predominio<br />
Siracusano,<br />
s’in<strong>di</strong>rizzarono verso il<br />
Mar Adriatico. Gli<br />
Etruschi che erano in<br />
<strong>di</strong>fficoltà sul Tirreno<br />
trovarono nell’Adriatico<br />
nuova forza per le attività commerciali. Marzabotto <strong>di</strong>venne importantissima, infatti era<br />
posta sulla strada che dall’Etruria conduceva alla pianura Padana, quin<strong>di</strong> un emporio, un<br />
luogo <strong>di</strong> scambio. Fu costruita in pochissimo tempo secondo le proprie esigenze. La città è<br />
organizzata su <strong>di</strong> una sola via tracciata in senso Sud-Nord (plateia) larga 15 metri e da tre<br />
strade ortogonali <strong>di</strong> eguale larghezza e fra loro equi<strong>di</strong>stanti (stenopoi), sud<strong>di</strong>videndo l’area<br />
urbana in otto settori o regioni, vie minori larghe 5 metri li sud<strong>di</strong>vidono in otto settori. Tutte<br />
le strade sono limitate da canalette, destinate insieme allo scolo delle acque a segnare il<br />
confine tra aree stradale pubbliche e quelle private. Anche i templi dell’Acropoli sono<br />
orientati come le strade e questo<br />
ci fa affermare che furono<br />
costruiti contemporaneamente.<br />
All’estremità orientale e<br />
settentrionale del pianoro sono<br />
<strong>di</strong>slocati due sepolcreti, entrambi<br />
separati dall’area urbana da una<br />
porta che nel caso del<br />
sepolcreto orientale conserva<br />
parti consistenti dell’alzato. Le<br />
necropoli si <strong>di</strong>spongono senza<br />
alcun or<strong>di</strong>ne, chiaramente<br />
destinate al seppellimento<br />
singolo e non familiare, che si<br />
riallaccia alla tra<strong>di</strong>zione<br />
villanoviana. In entrambi i<br />
sepolcreti sono documentati<br />
<strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> tombe: a fossa<br />
cineraria per i cremati; a<br />
cassone <strong>di</strong> lastre <strong>di</strong> travertino, sempre per i defunti cremati, nonostante manchi il cinerario<br />
nella maggior parte dei casi, perciò i resti della cremazione erano probabilmente raccolti in<br />
13
contenitori <strong>di</strong> materiale deperibile o in un velo <strong>di</strong> stoffa. Marzabotto è una città <strong>di</strong> tipo greco<br />
ippodamea all’incrocio delle due plateiai centrali è stato trovato ancora in posto un cippo<br />
infisso nel terreno che reca sulla sommità due tratti incisi ortogonali e perfettamente<br />
orientati: la crux dei gromatici, utilizzata per tracciare gli assi principali, secondo la<br />
Disciplina. Alle spalle dei templi su <strong>di</strong> un cuccuzzolo che costituisce ancora oggi la parte<br />
più alta <strong>di</strong> Misanello, fu rinvenuta nel secolo scorso una struttura, oggi perduta, un altare<br />
destinato all’Augure che da lassù (non c’erano gli alberi) scrutava il cielo e dava i responsi.<br />
A partire dalla metà del IV secolo a.C. la città etrusca <strong>di</strong> Marzabotto è occupata dai Celti e<br />
trasformata in un avamposto militare, questa fase è documentata da 25 tombe e da resti<br />
sparsi. Nel III secolo a.C. è abbandonata. Due secoli più tar<strong>di</strong> vi è installato un impianto<br />
rustico, caratterizzato da materiali molto modesti.<br />
STORIA degli SCAVI<br />
La prima menzione della città<br />
etrusca <strong>di</strong> Marzabotto risale al<br />
1550 quando frate Leandro<br />
Alberti nella descrizione <strong>di</strong> tutta<br />
Italia ipotizzò l'esistenza <strong>di</strong> una<br />
città in Pian <strong>di</strong> Misano in base<br />
alla presenza <strong>di</strong> strutture<br />
murarie antiche ancora in vista,<br />
mosaici e monete.<br />
Nel 1782 Serafino Calindri nel<br />
Dizionario Corografico<br />
Georgico Orittologico Storico<br />
dell'Italia osservava l'esistenza<br />
<strong>di</strong> muri <strong>di</strong> antichi e<strong>di</strong>fici nel<br />
Pian <strong>di</strong> Misano dove documentava anche lo svolgersi <strong>di</strong> attività <strong>di</strong> scavo alla ricerca <strong>di</strong><br />
preziosi materiali.<br />
I terreni del Pian <strong>di</strong> Misano vennero acquistati nel 1831 da parte <strong>di</strong> G. Aria e da questo<br />
momento in poi ebbero inizio la raccolta e la conservazione dei materiali archeologici<br />
scoperti nel corso dei lavori agricoli.<br />
Il primo rinvenimento vero e proprio risale al 1839 quando vennero portate alla luce ai<br />
pie<strong>di</strong> dell'acropoli 30 statuette <strong>di</strong> bronzo, seguite poco dopo da altri bronzetti e da alcune<br />
tombe del sepolcreto nord; nel 1856 verranno poi scoperti gli e<strong>di</strong>fici sacri dell'acropoli.<br />
Entrambe le campagne <strong>di</strong> scavo furono prontamente pubblicate dal Gozza<strong>di</strong>ni, il quale<br />
aveva maturato l'erronea convinzione <strong>di</strong> stare scavando un'enorme necropoli.<br />
In occasione del V Congresso Internazionale <strong>di</strong> Antropologia e Archeologia Preistoriche<br />
tenutosi a Bologna nel 1871 si accese il <strong>di</strong>battito scientifico sulla città: a dare una corretta<br />
interpretazione dei risultati <strong>di</strong> scavo fu G. Chierici, il quale sostenne che in Marzabotto si<br />
trovavano i resti <strong>di</strong> una città con strade, case, templi e sepolcreti.<br />
Nel 1886 fu E. Brizio a curare l'ampliamento e il rior<strong>di</strong>no <strong>di</strong> 5 sale della Villa Aria con<br />
funzioni <strong>di</strong> Museo e a <strong>di</strong>rigere anche, tra il 1888-89, la prima campagna <strong>di</strong> scavo finanziata<br />
dallo Stato e destinata al settore meri<strong>di</strong>onale della città. Nel 1933 la zona archeologica <strong>di</strong><br />
Marzabotto e la sua Collezione vennero acquistate dallo Stato e i materiali furono trasferiti<br />
da Villa Aria nel nuovo Museo: quest'ultimo, <strong>di</strong>strutto da un incen<strong>di</strong>o nel 1944, venne<br />
ricostruito e inaugurato nel 1949, mentre negli stessi anni venivano portati restauri ai<br />
templi, ai sepolcreti e alla città.<br />
14
Nel 1957 iniziò la propria attività <strong>di</strong> Soprintendente G.A. Mansuelli, a cui si devono<br />
l'ampliamento del Museo, l'e<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> una prima guida e l'avvio <strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> scavi in vari<br />
punti della città con la collaborazione dell'Università <strong>di</strong> Bologna.<br />
Il 4 novembre 1979 venne inaugurato il nuovo Museo archeologico, su progetto<br />
dell'architetto F. Bergonzoni e in base ad un or<strong>di</strong>namento curato da G.A. Mansuelli, A.M.<br />
Brizzolara, S. De Maria, G. Sassatelli e D. Vitali.<br />
Dal 1988, circa cent' anni dall'inizio degli scavi nella città, sono riprese le indagini<br />
sistematiche sul terreno, sia da parte della Soprintendenza Archeologica dell'Emilia<br />
Romagna, che da parte del Dipartimento <strong>di</strong> Archeologia dell'Università <strong>di</strong> Bologna.<br />
L’ACQUEDOTTO<br />
L'impianto urbano della città,<br />
perfettamente pianificato<br />
sotto l'aspetto della viabilità e<br />
della <strong>di</strong>stinzione tra spazi<br />
pubblici e spazi privati,<br />
prevedeva anche una<br />
complesso ed efficiente<br />
sistema idrico consistente in<br />
opere <strong>di</strong> canalizzazione delle<br />
acque piovane e pozzi per la<br />
captazione delle acque<br />
sorgive che coinvolgeva sia<br />
le abitazioni private sia le<br />
strutture pubbliche e la rete<br />
stradale. Fulcro <strong>di</strong> questo<br />
sistema era una struttura che<br />
fu indagata tra il 1870 e il 1872 da F. Sansoni, assistente <strong>di</strong> scavo <strong>di</strong> G. Gozza<strong>di</strong>ni prima e<br />
<strong>di</strong> E. Brizio poi. La struttura venne in<strong>di</strong>viduata all'estremità occidentale della plateia B, ai<br />
pie<strong>di</strong> della collina <strong>di</strong> Misanello sede dell'acropoli, a cui la stessa strada conduceva.<br />
Rinvenuta a 4,50 m <strong>di</strong> profon<strong>di</strong>tà rispetto al piano <strong>di</strong> calpestio attuale, in un settore<br />
caratterizzato dalla presenza <strong>di</strong> un consistente deposito <strong>di</strong> terreno <strong>di</strong> erosione, dopo<br />
essere stata scavata venne ricomposta poco lontano dal sito originario, dove è possibile<br />
visitarla tutt'ora. Tale ricomposizione non perfettamente in situ si dovette al desiderio degli<br />
allora proprietari del terreno <strong>di</strong> costruire proprio in quel luogo un piccolo acquedotto<br />
racchiuso in una costruzione in stile etruschizzante (o meglio egittizzante), ancora oggi<br />
esistente in prossimità della struttura antica. Tanto l'impianto etrusco quanto quello<br />
ottocentesco captavano le acque <strong>di</strong> una sorgente naturale attiva in quel luogo. L'impianto<br />
idrico antico, interamente realizzato con lastre e blocchi squadrati <strong>di</strong> travertino, si compone<br />
<strong>di</strong> un corpo centrale <strong>di</strong> forma rettangolare da cui si <strong>di</strong>partono tre canali. Il corpo centrale<br />
delle <strong>di</strong>mensioni <strong>di</strong> 1,80 x 1,20 m e con un'altezza <strong>di</strong> 0,50 m, si presenta parzialmente<br />
coperto e internamente sud<strong>di</strong>viso da un <strong>di</strong>aframma in due vasche <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferente livello. A<br />
questa struttura, attraverso un'unica imboccatura, si innestano due <strong>di</strong>stinti canali <strong>di</strong><br />
immissione delle acque provenienti dalla zona subito a monte, dove catturavano l'acqua <strong>di</strong><br />
una falda quasi affiorante per convogliarla nella prima delle due vasche, che con i suoi<br />
circa 3 metri cubi <strong>di</strong> capacità aveva evidentemente la funzione <strong>di</strong> vasca <strong>di</strong> decantazione.<br />
L'acqua, ripulita delle impurità che si depositavano sul fondo <strong>di</strong> questa prima vasca,<br />
15
immettendosi per sfioramento nella seconda vasca, attraverso un condotto <strong>di</strong> emissione<br />
veniva incanalata in <strong>di</strong>rezione Est, verso la sottostante area urbana. Si deve<br />
evidentemente ad una ristrutturazione successiva l'aggiunta <strong>di</strong> un secondo canale <strong>di</strong><br />
emissione, <strong>di</strong>retto verso Sud, che anziché innestarsi nella seconda vasca si innestava<br />
<strong>di</strong>rettamente in quella <strong>di</strong> decantazione, rimanendo <strong>di</strong> conseguenza sprovvisto <strong>di</strong> un<br />
sistema <strong>di</strong> filtraggio ma assolvendo comunque alla sua funzione <strong>di</strong> canalizzazione delle<br />
acque verso l'area urbana. Entrambi i canali <strong>di</strong> uscita sono realizzati con la medesima<br />
tecnica costruttiva, componendosi <strong>di</strong> un doppio filare <strong>di</strong> blocchi <strong>di</strong> travertino piani<br />
all'esterno e concavi all'interno in modo tale da formare un foro <strong>di</strong> 14 cm <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro,<br />
<strong>di</strong>mensione che garantiva ai canali una notevole portata. L'impianto, in antico lasciato<br />
probabilmente parzialmente a vista e dunque non privo forse <strong>di</strong> una sua monumentalità,<br />
doveva essere funzionale all'alimentazione idrica <strong>di</strong> due officine per la produzione <strong>di</strong><br />
ceramiche e laterizi poste nei due settori urbani verso cui i canali <strong>di</strong> uscita <strong>di</strong>rigevano: l'una<br />
nell'area nord-occidentale dell'abitato, nell'Insula 1 della Regio II, tuttora visibile; l'altra a<br />
Sud, nel settore della città oggi franato nel sottostante fiume Reno, dunque non più<br />
esistente ma nota attraverso appunti <strong>di</strong> scavo <strong>di</strong> E. Brizio. La fornace ancora oggi<br />
conservata e visibile nell'Insula 1 della Regio II presenta un lungo condotto realizzato con<br />
coppi incastrati l'uno nell'altro, conservato per un tratto <strong>di</strong> almeno 20 m., che sembrerebbe<br />
<strong>di</strong>rigersi proprio verso l'altura dell'acropoli.<br />
L'impianto idrico pubblico in<strong>di</strong>viduato ai pie<strong>di</strong> dell'altura <strong>di</strong> Misanello era dunque<br />
probabilmente funzionale alla fornitura <strong>di</strong> acqua corrente pulita a due importanti strutture<br />
per la produzione <strong>di</strong> ceramiche e laterizi che, sia per le <strong>di</strong>mensioni, sia per la complessità<br />
del loro impianto, sia per l'assenza <strong>di</strong> in<strong>di</strong>zi che facciano pensare ad una loro parziale<br />
destinazione residenziale, potevano avere anch'essi una destinazione <strong>di</strong> tipo pubblico.<br />
16
ETRUSCHI A SPINA<br />
Per due secoli, il V e il IV a. C., Spina è stata uno dei più importanti porti commerciali del<br />
Me<strong>di</strong>terraneo, rappresentando per quell'epoca ciò che altre città, da ultima Venezia, hanno<br />
rappresentato in momenti storici <strong>di</strong>versi: l'anello <strong>di</strong> congiunzione tra Occidente e Oriente.<br />
Poi, duemila anni fa, dopo una progressiva decadenza, la città scomparve, inghiottita dalle<br />
acque.<br />
Di lei tuttavia si continuò a<br />
parlare: della sua fondazione<br />
dovuta ai <strong>di</strong>scendenti degli<br />
Argonauti, della sua potenza<br />
marinara, della sua floridezza<br />
commerciale, del suo legame<br />
strettissimo con il mondo e la<br />
cultura greca, documentato<br />
sia dalla presenza del Tesoro<br />
<strong>di</strong> Spina a Delfi, sia dal fatto<br />
che la mitologia greca<br />
ambientò proprio nelle acque<br />
dell' Adriatico antistanti Spina<br />
miti celebri quali il volo <strong>di</strong><br />
Icaro e la caduta del carro <strong>di</strong><br />
Fetonte. Ma ciò <strong>di</strong> cui si è<br />
<strong>di</strong>sputato soprattutto, e per ben duemila anni, è stato del luogo dove sorgeva la città. Per<br />
secoli e secoli infatti l'esatta ubicazione <strong>di</strong> Spina ha rappresentato un vero e proprio giallo<br />
archeologico, la cui soluzione ha appassionato scrittori e stu<strong>di</strong>osi illustri: da Dionigi <strong>di</strong><br />
Alicarnasso a Plinio il Vecchio, da Giovanni Boccaccio a Filippo Cluverius, fino agli<br />
archeologi del primo Novecento. Come spesso succede in archeologia, fu però il caso a<br />
risolvere quel mistero. Accadde nel 1922 quando, durante i gran<strong>di</strong> lavori <strong>di</strong> bonifica delle<br />
Valli <strong>di</strong> Comacchio, in Valle Trebba venne alla luce un sepolcreto <strong>di</strong> epoca etrusca.<br />
<strong>NECROPOLI</strong> <strong>di</strong> SPINA<br />
La necropoli <strong>di</strong> Valle Trebba fu la prima ad essere scavata, negli anni 1922 - 1935,<br />
mentre gli scavi <strong>di</strong> Valle Pega, iniziati nel 1954, furono terminati nel 1965. L'abitato della<br />
Città <strong>di</strong> Spina non è stato ancora completamente scavato, dato che è consuetu<strong>di</strong>ne dare<br />
la precedenza agli scavi delle necropoli, che sono sempre fonti molto Più ricche <strong>di</strong><br />
suppellettili rispetto agli abitati. Le oltre 4.000 tombe scavate hanno restituito ingenti<br />
quantità <strong>di</strong> suppellettili non ancora completamente classificate, in particolare quelle <strong>di</strong><br />
Valle Pega, per cui non è ancora possibile riorganizzare i dati relativi ai corre<strong>di</strong> delle<br />
necropoli in modo matematicamente certo.<br />
17
ARCHITETTURA FUNERARIA<br />
Le tombe primitive hanno la forma <strong>di</strong> un semplice pozzetto circolare scavato nella roccia<br />
(VIII secolo a.C.). Le più antiche tombe a inumazione, contemporanee ai pozzetti, sono<br />
fosse allungate <strong>di</strong> forma trapezoidale, anch’esse scavate nella roccia. Il loro uso<br />
continua anche più tar<strong>di</strong> allorché il vano sepolcrale si allarga a forma <strong>di</strong> camera, con<br />
copertura <strong>di</strong> blocchi o lastre <strong>di</strong> pietra e tumulo <strong>di</strong> terra (VII secolo a.C.). Nei due secoli<br />
seguenti la tomba a tumulo assume forme monumentali, con il grande basamento ad<br />
anello, scavato o costruito, e uno o più gruppi <strong>di</strong> tombe interne, precedute a volte da un<br />
ampio vestibolo. I tumuli maggiori superano a volte i trenta metri <strong>di</strong> <strong>di</strong>ametro. Dal VI al II<br />
secolo a.C. appaiono anche le tombe a camera, fornite <strong>di</strong> un vestibolo e allungate l’una<br />
accanto all’altra ai lati delle vie sepolcrali. L’ultimo periodo (secoli IV-I a.C.) è<br />
caratterizzato da sepolcri esclusivamente ipogei, senza tumulo, costituiti da un solo<br />
ampio ambiente imitante l’interno della casa, con panchina e pilastri e decorato anche<br />
da <strong>di</strong>pinti e rilievi. Già nelle camere più antiche si nota l’imitazione delle case che si<br />
accentua in seguito sia nella planimetria che negli ambienti architettonici, negli elementi<br />
decorativi e nel mobilio. La <strong>di</strong>sposizione più comune si compone <strong>di</strong> un vestibolo <strong>di</strong><br />
accesso con due piccole camere sepolcrali; in fondo si apre la tomba principale<br />
costituita <strong>di</strong> un ambiente che immette in una, due o tre celle. Nelle tombe più recenti si<br />
ha un solo ambiente con vasto soffitto a spioventi o cassettonato e che talvolta può<br />
anche avere delle interessanti varianti strutturali o decorative, come nel caso della<br />
tomba Torlonia o in quella dell’Alcova ove, a somiglianza delle camere più antiche, sono<br />
ricavate sul fondo delle autentiche alcove per la deposizione dei coniugi, certo i membri<br />
più importanti della famiglia, mentre tutt’intorno, in loculi scavati nelle pareti o in comparti<br />
ricavati sul piano <strong>di</strong> larghe banchine, trovano posto i vari componenti della gens, poiché<br />
<strong>di</strong> gens si deve ora parlare. Nel IV secolo, contemporaneamente alla presenza <strong>di</strong><br />
camere sepolcrali <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> proporzioni con vaste banchine e con numerosissime<br />
deposizioni, compare in Caere un nuovo tipo <strong>di</strong> sepolcro cosiddetto rupestre. Presso<br />
queste sepolture <strong>di</strong> epoca tarda erano posti cippi in peperino o in marmo, <strong>di</strong> forma<br />
cilindrica per l’uomo e <strong>di</strong> casetta per la donna, recanti incisi o <strong>di</strong>pinti il nome della gens o<br />
del defunto e la sua età.<br />
Le SEPOLTURE<br />
Per la maggioranza si tratta <strong>di</strong> inumazioni <strong>di</strong> un unico defunto, quin<strong>di</strong> tutte tombe<br />
monosome tranne un caso <strong>di</strong> inumazione bisoma, ma sono presenti anche molte<br />
incinerazioni. Varie le <strong>di</strong>sposizioni del corredo funerario, che viene trovato in parte o<br />
completamente sia all'interno che all'esterno del cinerario, a volte contenuto insieme al<br />
cinerario all'interno <strong>di</strong> una cassa <strong>di</strong> legno, in rari casi contenuto unitamente al cinerario<br />
in un'urna marmorea all'interno <strong>di</strong> una cassa <strong>di</strong> legno. La <strong>di</strong>sposizione delle tombe nelle<br />
necropoli segue il cordone <strong>di</strong> paleodune prospiciente l'antica linea <strong>di</strong> costa, con<br />
orientamento Nord Ovest - Sud Est, con il capo dell'inumato rivolto a Nord Ovest. I<br />
corre<strong>di</strong> funerari sono per la maggiori parte composti da oggetti <strong>di</strong> uso comune, come<br />
vasellame da cucina e da mensa, utensili da cucina, elementi d'arredo, come candelabri<br />
e sgabelli, oggetti legati alla cura della persona, come balsamari ed altri contenitori per<br />
unguenti, pigmenti, essenze, ed alcuni gioielli. Per quanto riguarda il vasellame, in<br />
particolare gli elementi destinati alla miscelazione e mescita del vino sono talvolta <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>mensioni tali da escluderne tassativamente un possibile uso effettivo; si tratta quin<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
produzioni destinate esclusivamente ad uso funerario. Frequente è la presenza <strong>di</strong><br />
elementi con connotazione scaramantica, o comunque destinati ad aiutare il defunto<br />
nella vita oltre la morte, come i da<strong>di</strong>, l'aes rude cioè il frammento <strong>di</strong> bronzo che aveva<br />
18
funzione <strong>di</strong> moneta (l'obolo per Caronte), astragali utilizzati anche come da<strong>di</strong>, protomi<br />
femminili, probabili rappresentazioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>vinità che avevano funzione essenzialmente<br />
benaugurale. La presenza <strong>di</strong> anfore, quasi tutte da vino, per la maggior parte <strong>di</strong><br />
produzione attica ed alcune <strong>di</strong> produzione locale, in<strong>di</strong>cano lo status sociale piuttosto<br />
elevato del defunto, dato che il consumo <strong>di</strong> vino era in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> ricchezza. Una parte delle<br />
suppellettili è attualmente esposta, nel Museo Archeologico Nazionale .<br />
GLI SCAVI<br />
Gli scavi, in Valle Trebba, iniziarono subito e proseguirono fino al 1935; poi ripresero nel<br />
1954, interessando soprattutto la Valle Pega e in minor misura le valli a<strong>di</strong>acenti. Ciò che si<br />
era venuti <strong>di</strong>cendo nel corso <strong>di</strong> due millenni, a proposito <strong>di</strong> Spina, ha potuto così trovare<br />
finalmente riscontro o smentita nella realtà dei fatti e tra questi, in primo luogo, nello<br />
straor<strong>di</strong>nario patrimonio <strong>di</strong> materiali greci ed etruschi <strong>di</strong> straor<strong>di</strong>naria bellezza ritrovati nelle<br />
oltre quattromila tombe e nella parte dell'abitato scavati a tutt' oggi: ori, argenti, ambre,<br />
paste vitree, ceramiche attiche a figure nere e a figure rosse, e ancora bronzi, ceramiche<br />
iscrizioni etrusche. Un nucleo ricchissimo <strong>di</strong> materiali rari e preziosi <strong>di</strong> cui questa mostra<br />
presenta una scelta quanto mai ampia ed esauriente, in parte ad<strong>di</strong>rittura ine<strong>di</strong>ta.<br />
19
La CITTA’<br />
All’incrocio tra le strade principali era<br />
sotterrato un grosso ciottolo sul quale<br />
erano incisi gli assi, orientati secondo i<br />
punti car<strong>di</strong>nali,nel rigoroso rispetto dei<br />
quali si sviluppava la città.<br />
20<br />
I resti della città: tra l’ erba alta si<br />
possono intravedere le fondamenta degli<br />
e<strong>di</strong>fici della città stessa.
Il Santuario Fontile era un piccolo tempio<br />
suburbano de<strong>di</strong>cato al culto della salute e<br />
della acque.<br />
Le fondamenta degli e<strong>di</strong>fici viste da più<br />
vicino.<br />
21<br />
La sorgente naturale in prossimità del<br />
Santuario Fontile.
IL SEPOLCRETO EST<br />
L’Ovolo, un grosso ciottolo fluviale,<br />
veniva posto in cima al sepolcro per<br />
facilitarne l’ identificazione e,<br />
probabilmente, rivestiva un carattere<br />
religioso.<br />
In genere, all’ interno delle tombe, non<br />
venivano riposte le spoglie del defunto,<br />
ma le sue ceneri custo<strong>di</strong>te in un’ urna,<br />
insieme ad alcuni oggetti, <strong>di</strong> uso comune<br />
e preziosi,a lui appartenuti.<br />
Sepolcro con in cima l’Ovolo.<br />
22
L’intero sepolcreto Est visto dalla porta <strong>di</strong><br />
entrata.<br />
23<br />
La Porta Est che funge da entrata al<br />
corrispondente sepolcreto.
L’ACROPOLI<br />
L’altare dove venivano effettuati i<br />
sacrifici agli dei. In una fossa al<br />
centro dell’altare sono state ritrovate<br />
alcune ossa <strong>di</strong> animali, probabilmente<br />
sacrificati.<br />
Vista del tempio dell’Acropoli da un’altra<br />
angolazione.<br />
24<br />
Il tempio dell’Acropoli, il punto più alto<br />
della città,dove venivano svolti i riti<br />
religiosi.
25<br />
L’acquedotto della città situato ai<br />
pie<strong>di</strong> dell’ Acropoli.